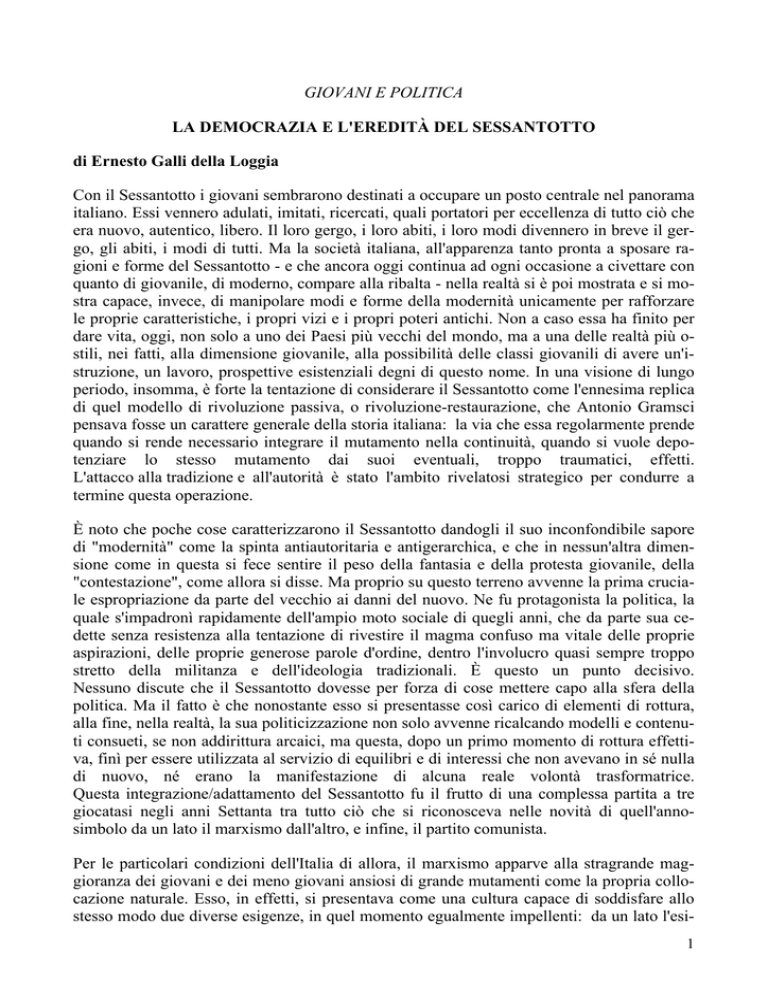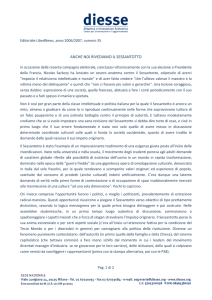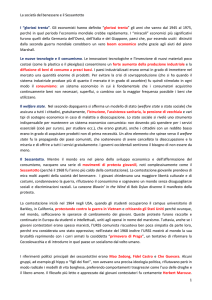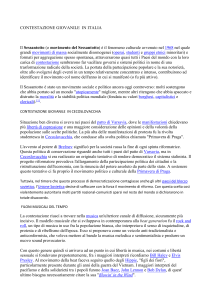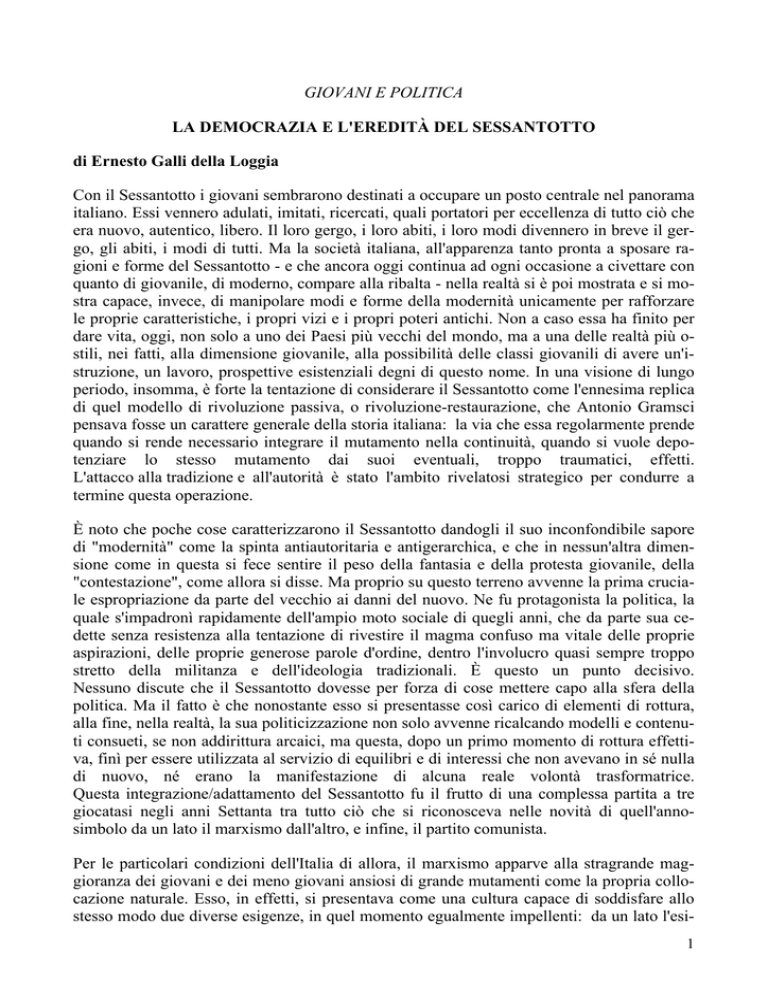
GIOVANI E POLITICA
LA DEMOCRAZIA E L'EREDITÀ DEL SESSANTOTTO
di Ernesto Galli della Loggia
Con il Sessantotto i giovani sembrarono destinati a occupare un posto centrale nel panorama
italiano. Essi vennero adulati, imitati, ricercati, quali portatori per eccellenza di tutto ciò che
era nuovo, autentico, libero. Il loro gergo, i loro abiti, i loro modi divennero in breve il gergo, gli abiti, i modi di tutti. Ma la società italiana, all'apparenza tanto pronta a sposare ragioni e forme del Sessantotto - e che ancora oggi continua ad ogni occasione a civettare con
quanto di giovanile, di moderno, compare alla ribalta - nella realtà si è poi mostrata e si mostra capace, invece, di manipolare modi e forme della modernità unicamente per rafforzare
le proprie caratteristiche, i propri vizi e i propri poteri antichi. Non a caso essa ha finito per
dare vita, oggi, non solo a uno dei Paesi più vecchi del mondo, ma a una delle realtà più ostili, nei fatti, alla dimensione giovanile, alla possibilità delle classi giovanili di avere un'istruzione, un lavoro, prospettive esistenziali degni di questo nome. In una visione di lungo
periodo, insomma, è forte la tentazione di considerare il Sessantotto come l'ennesima replica
di quel modello di rivoluzione passiva, o rivoluzione-restaurazione, che Antonio Gramsci
pensava fosse un carattere generale della storia italiana: la via che essa regolarmente prende
quando si rende necessario integrare il mutamento nella continuità, quando si vuole depotenziare lo stesso mutamento dai suoi eventuali, troppo traumatici, effetti.
L'attacco alla tradizione e all'autorità è stato l'ambito rivelatosi strategico per condurre a
termine questa operazione.
È noto che poche cose caratterizzarono il Sessantotto dandogli il suo inconfondibile sapore
di "modernità" come la spinta antiautoritaria e antigerarchica, e che in nessun'altra dimensione come in questa si fece sentire il peso della fantasia e della protesta giovanile, della
"contestazione", come allora si disse. Ma proprio su questo terreno avvenne la prima cruciale espropriazione da parte del vecchio ai danni del nuovo. Ne fu protagonista la politica, la
quale s'impadronì rapidamente dell'ampio moto sociale di quegli anni, che da parte sua cedette senza resistenza alla tentazione di rivestire il magma confuso ma vitale delle proprie
aspirazioni, delle proprie generose parole d'ordine, dentro l'involucro quasi sempre troppo
stretto della militanza e dell'ideologia tradizionali. È questo un punto decisivo.
Nessuno discute che il Sessantotto dovesse per forza di cose mettere capo alla sfera della
politica. Ma il fatto è che nonostante esso si presentasse così carico di elementi di rottura,
alla fine, nella realtà, la sua politicizzazione non solo avvenne ricalcando modelli e contenuti consueti, se non addirittura arcaici, ma questa, dopo un primo momento di rottura effettiva, finì per essere utilizzata al servizio di equilibri e di interessi che non avevano in sé nulla
di nuovo, né erano la manifestazione di alcuna reale volontà trasformatrice.
Questa integrazione/adattamento del Sessantotto fu il frutto di una complessa partita a tre
giocatasi negli anni Settanta tra tutto ciò che si riconosceva nelle novità di quell'annosimbolo da un lato il marxismo dall'altro, e infine, il partito comunista.
Per le particolari condizioni dell'Italia di allora, il marxismo apparve alla stragrande maggioranza dei giovani e dei meno giovani ansiosi di grande mutamenti come la propria collocazione naturale. Esso, in effetti, si presentava come una cultura capace di soddisfare allo
stesso modo due diverse esigenze, in quel momento egualmente impellenti: da un lato l'esi1
genza di un radicale mutamento sociale e politico, proprio di una cultura per antonomasia
rivoluzionaria e quindi ritenuta capace di mobilitare adeguatamente gli agenti sociali
del mutamento stesso; e dall'altro l'esigenza di una profonda modernizzazione della mentalità e del costume, propria di una cultura d'impianto storicista, quindi ritenuta in grado come
nessun'altra di leggere e di interpretare il proprio tempo.
Oggi è facile per noi giudicare tutto ciò evidentemente superficiale e sbagliato, ma per capirne il senso e il rilievo basta che ricordiamo quale fascino il richiamo del marxismo allora
esercitò pure su ampli settori del mondo cattolico - non solo italiano - i quali giunsero talora
a vedervi una sorta di traduzione laica del messaggio spirituale cristiano con cui immaginare
addirittura un'eventuale possibile integrazione.
Ma nell'Italia del tempo dire marxismo non poteva che voler dire il partito comunista. Forte
anche del prestigio derivantegli dal suo tradizionale ruolo di oppositore e di partito di riferimento del maggiore sindacato del Paese, il Pci si trovò ad essere il naturale collettore politico della rottura sessantottesca.
Nel corso del decennio successivo esso accrebbe enormemente la propria influenza e il proprio insediamento nel tessuto sociale del Paese e vide aumentare i propri voti fino a sfiorare
la maggioranza relativa. Il resto del sistema politico, a cominciare dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista, finì sostanzialmente per adeguarsi, non volendo e non potendo essere insensibile alle richieste di cambiamento e di rinnovamento che il Sessantotto aveva
messo in moto e che conquistavano udienza sempre più vasta. Accadde così che in Italia l'ispirazione del nuovo e l'aspirazione al nuovo - che nel frattempo erano state fatte più o meno acriticamente proprie dall'intero mondo della cultura e dei media - diventassero in certo
senso patrimonio comune di tutte le principali forze politiche: per giunta nel momento in
cui tra queste si stabiliva una sostanziale convergenza - il "compromesso storico" - ed essendone dunque una causa e ricevendone al tempo stesso alimento.
Tradotte in ambito politico, insomma, le novità messe all'ordine del giorno dalla cultura del
Sessantotto principalmente sul piano dei diritti individuali e di cittadinanza, ebbero il singolare destino di non trovare quasi nemici, o, se li trovarono, furono nemici pro forma, pronti
in pratica ad arrendersi senza combattere. (...)
Accadde così che il Sessantotto, proprio a causa del suo totale successo presso l'establishment istituzionale di ogni colore finì inevitabilmente per perdere ogni individualità. Adottato a furor di voti dal Parlamento, per non dire dei media, diventò il nuovo gergo della politica e, va da sé, il nuovo conformismo delle maggioranze à la page.
E tuttavia, a quaranta anni di distanza è impossibile non pensare a quel periodo come quello
in cui fu realmente fondata nei fatti, l'attuale democrazia italiana. O se si vuole in cui le sue
fondazioni furono ampliate, dal momento che al primo stabilimento delle forme "politiche"
della democrazia, avvenuto nel 1948-1953, si aggiunse ora la più o meno compiuta instaurazione delle forme "sociali" della democrazia.
Che quello del Sessantotto sia stato un autentico momento fondativo, uno di quei momenti
cioè in cui la storia sembra fissare per sempre nell'animo di un gruppo di individui emozioni
e sensibilità che poi diventeranno un ricordo e un tratto indelebili, si ricava anche da un e2
lemento all'apparenza secondario ma in realtà decisivo. E cioè dall'importanza che quegli
anni e la loro temperie hanno avuto nelle biografie di tanta parte della nostra attuale classe
dirigente, specie politica, la quale - proprio com'era accaduto con la Resistenza alla generazione che l'aveva preceduta - da lì ha tratto esperienze, amicizie, modi agire e di pensare,
destinati a durare nel tempo.
Dunque, il Sessantotto come un momento di fondazione della democrazia italiana. Dovremmo almeno retrospettivamente rallegrarci. E certamente lo facciamo; sennonché, pur
facendolo, ciascuno di noi, credo, avverte però che quella fondazione avvenne in un modo
per nulla lineare, spesso equivoco, che essa fu quasi sempre un ibrido che cercava di mettere
insieme cose che insieme non potevano stare, che vi mancò qualcosa di essenziale.
Sono convinto che sia andata proprio così, e se cerco di comprenderne la ragione credo che
ciò sia dovuto precisamente all'origine sessantottesca, a questa sorta di Dna ideologicopolitico, e prima ancora antropologico, che la democrazia italiana rifondata si porta con sé
da allora. Il Sessantotto è stato una fonte non rinnegabile di tale democrazia. Ma insieme esso ne ha rappresentato un limite, un vincolo sempre più stringente, un peso che diviene ogni
giorno più pesante. E quando dico Sessantotto voglio naturalmente dire il sentire diffuso che
da lì prese le mosse, il senso comune, gli stereotipi culturali, i modelli di riferimento, che si
formarono intorno a quella data e che in buona sostanza sono arrivati fino a noi avendo modellato in misura decisiva il passato che ci sta immediatamente alle spalle. (...)
La cultura del Sessantotto ebbe un fortissimo tratto transnazionale. Fu allora opinione comune che "modernità" e "industrialismo capitalistico" fossero ormai divenute il nostro orizzonte obbligatorio, destinato a omologare ogni specificità. Un orizzonte magari da rovesciare con la lotta, ma comunque ineludibile perché acquisito una volta per sempre. Sembrò naturale, in questa ottica, importare idee e libri dall'universo mondo credendoli in qualche modo confacenti a noi. L'esperienza psichiatrica inglese o il modello delle lotte studentesche
giapponesi, la riflessione sociologica fiorita a Francoforte o i raffinati modelli macroeconomici elaborati in qualche università americana, per non dire delle più varie esperienze del
socialismo e del comunismo internazionali e dei movimenti di liberazione del Terzo mondo,
così come il catechismo dei cattolici olandesi o la teologia latinoamericana, diventarono il
normale cibo intellettuale del pubblico italiano.
Fu certamente una grande e meritoria opera di svecchiamento culturale. Ma è anche vero
che in questo modo era destinato a depositarsi nella coscienza del Paese l'idea che ormai
quella italiana fosse diventata una delle tante società mature dell'Occidente capitalistico, inserita, nel bene e nel male, nei suoi processi di sviluppo.
Accadde così che la consapevolezza dei grandi nodi problematici della nostra vicenda nazionale (...) impallidisse progressivamente nella coscienza del Paese e delle classi dirigenti
che allora stavano vedendo la luce.
Non a caso, quando da lì a un paio di decenni il sistema dei partiti della prima Repubblica
sarebbe stato travolto, e altre formazioni sarebbero venute alla luce, il loro profilo politico
avrebbe del tutto o quasi ignorato quei nodi problematici di cui ho appena detto, e solo con
il tempo, dopo molte occasioni perdute, l'opinione pubblica li avrebbe pian piano riscoperti
e sentiti come questioni ancora brucianti della propria storia e del proprio presente.
Ma ormai una mutazione certo assai significativa era avvenuta nella mentalità comune, se
3
nel discorso pubblico e nella prassi politico-istituzionale del Paese l'unità nazionale era ormai divenuta una dimensione sempre più incerta e problematica, o se poteva sembrare la cosa più normale di questo mondo - e invece era un caso unico in tutta Europa - sentire risuonare ripetutamente in qualche congresso di partito italiano e nella sua campagna elettorale
slogan in inglese tratti da lontani scenari transatlantici.
Ma oltre che per essere all'origine di questa rimozione della dimensione nazionale (...) l'eredità del Sessantotto ha pesato, e pesa, sulla vita pubblica italiana per un altro effetto. Perché
da lì ha preso le mosse e lì si è radicata nella nostra mentalità un'ostilità molto precisa verso
una certa idea della democrazia. Ostilità cioè verso l'idea che la democrazia più che sulla
partecipazione dal basso e sulla diffusione del potere è fondata sul controllo degli atti del
potere; verso l'idea che per funzionare la democrazia deve essere capace di creare spazi sociali sottratti ai meccanismi della politica; che ad un regime democratico è necessaria non
meno ma più meritocrazia, non un minore ma un diverso principio d'autorità; verso l'idea
che in una democrazia l'indulgenza verso chi abusa dei diritti inietta il veleno mortale
dell'impossibilità di fondare i doveri.
Questa idea della democrazia stenta tuttora a farsi strada da noi perché in Italia a partire dal
Sessantotto ha preso crescente vigore una visione diversa, per molti versi opposta. Sullo
sfondo di un'opzione ideologica che amava presentarsi come antirepressiva e spaziava su
amplissima latitudine - dall'ingenuo vitalismo dei "figli dei fiori" alla dura protesta evangelico-classista di don Milani verso le bocciature comminate dalle maestre dei "pierini" - si è
sviluppata, infatti, una concezione diciamo così easy, assai sciolta, "liquida", per un verso,
ma per l'altro tendente all'iper-regolamentazione, dei rapporti intraindividuali e tra gli individui e le istituzioni. (...)
Forse quanto sono venuto dicendo è apparso a più di uno tra voi come improntato a un eccesso di pessimismo. Ma non è pessimismo; è solo l'obbligatoria severità del bilancio di una
generazione, la generazione a cui appartengo, la quale, se guarda indietro al cammino percorso, non mi sembra che abbia da menare troppo vanto. Nati al tempo della rovina bellica,
della disfatta e della guerra civile, abbiamo più o meno la stessa età della Repubblica e dunque abbiamo accompagnato il nostro Paese sulla via della democrazia e della modernizzazione. Potremmo forse accontentarci. Ma rimane troppo forte, almeno a me rimane troppo
forte, la sensazione - se mai abbiamo appartenuto a qualcosa che si possa definire come la
classe dirigente - la sensazione, dicevo, di non aver saputo capire e vedere a sufficienza, di
non aver saputo guidare e governare, di non esser stati capaci di opporci, com'era invece necessario, agli errori che portava con sé il nostro tempo. Come forse accade a tutte le generazioni al tramonto, ci rimane insomma la sensazione che qualcosa di essenziale sia ancora da
fare per veder nascere quel Paese che tanti anni fa un giovane fucino, Teresio Olivelli, partigiano delle Fiamme Verdi, massacrato di percosse nel lager di Flossenbug per un gesto di
solidarietà verso un compagno di sventura, affidava all'invocazione della sua "Preghiera di
un ribelle": "un'Italia severa e generosa". Il mio augurio è che possiate essere voi tra coloro
cui toccherà di costruire e di vedere quell'Italia.
(©L'Osservatore Romano - 9 maggio 2008)
F:\Rivista (giugno 2008)\04 - Art.doc
4