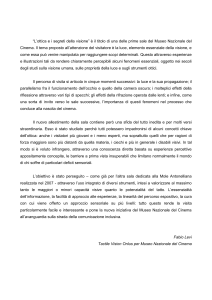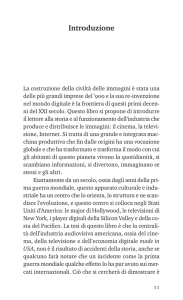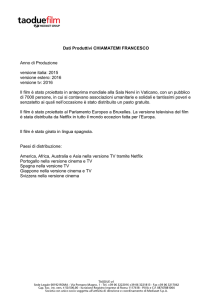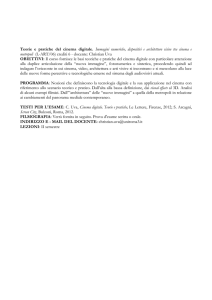LDB
Frédé
MAIN
Comes
unsuc
planeta
laguer
deime
Feltrinelli
TraduzionediMatteo
Schianchi
©Giangiacomo
FeltrinelliEditore
Milano
Primaedizionenella
collana“SerieBianca”
novembre2010
ISBNedizione
cartacea:
9788807171987
Notadell’editore
Questolibrosibasasufonti
precise. Le note a piè di
pagina e la bibliografia –
che non figurano nel libro
–, la lista dettagliata delle
1250 persone intervistate
in trenta paesi, l’indice dei
nomiedellesocietàcitatie
i numerosi dati statistici
sono disponibili in rete sul
sito, in francese, che è il
prolungamento naturale di
questo libro volutamente
“bimediale”, cartaceo e
digitale (vedi le Fonti e il
sito
www.fredericmartel.com).
Inoltre,leparoleininglese,
arabo, giapponese ecc. più
utilizzate nel testo sono
spiegate nel glossario alla
finedellibro(vedip.427).
Prologo
Non esiste forse
luogo
meno
“mainstream”
dell’Harvard
Faculty
Club,
il
ristorante
riservato ai docenti
all’interno del campus
della
prestigiosa
università di Harvard,
Massachusetts, negli
Stati Uniti. Qui Henry
James era di casa e
anche oggi vengono a
conversarciipiùillustri
docenti universitari di
Harvard; vi si continua
a respirare un certo
spirito
protestante,
tipicamente maschile e
dallapellebianca,fatto
di
puritanesimo
e
pietanze semplici (si
mangiapiuttostomale).
Nella sala da pranzo,
seduto a un tavolo
copertodaunatovaglia
bianca,
incontro
SamuelHuntington.
Negli anni in cui ho
vissutonegliStatiUniti
e ho fatto ricerche per
scrivere questo libro,
ho incontrato più volte
Samuel
Huntington,
universalmente
conosciutoperilsuoLo
scontrodelleciviltà.La
sua tesi è nota: le
civiltà
dell’epoca
attuale sono ormai in
lotta fra loro sul
terreno dei valori, per
affermare la propria
identità e la propria
cultura, e non solo per
difendere
i
propri
specifici
interessi
economici. Si tratta di
un libro opinionated,
comesidiceininglese,
fortemente schierato e
in cui sono messi a
confrontol’Occidentee
il“restodelmondo”:da
una parte c’è un
Occidente monolitico,
dall’altra una pluralità
di
paesi
non
occidentali.Huntington
sostiene il fallimento
della
democratizzazione dei
paesi musulmani a
causa dell’islam. Il
testo
è
stato
commentato, e spesso
criticato, in tutto il
mondo.
Durante il pranzo
consumato a Harvard
pongo alcune domande
a Huntington sulla sua
teoria, sulla cultura di
massa,
sul
nuovo
ordine internazionale
dopo l’11 settembre e
su come vede la
situazione attuale. Mi
risponde
in
modo
banale,
con
voce
tremula, senza avere
molto da dire sulla
cultura
globalizzata.
Poi è lui a chiedere a
me dove mi trovassi
l’11 settembre, forse
senza rendersi conto
che questa è la solita
domanda che tutti
fanno negli Stati Uniti.
Rispondo che quella
mattina
ero
all’aeroportodiBoston,
proprionelmomentoin
cui i dieci terroristi si
imbarcavano sui voli
American Airlines 11 e
UnitedAirlines175che
si sarebbero schiantati
poco dopo contro le
due torri del World
Trade Center. L’uomo
anziano che ho di
fronte – ha ottant’anni
– si fa pensieroso. L’11
settembre per gli Stati
Unitièstatounincubo,
mentre per Huntington
è stato il momento
della
consacrazione,
poiché le sue tesi sulla
guerra
culturale
mondiale già sostenute
in precedenza si sono
improvvisamente
rivelate profetiche. Sul
finire del pranzo ho
l’impressione che stia
quasi per appisolarsi
(morirà qualche mese
dopo le interviste che
mi ha rilasciato). Resto
insilenzioecomincioa
guardare
i
quadri
d’autoreappesiaimuri
dell’Harvard
Faculty
Club. Mi chiedo cosa
possapensareunuomo
elitario
come
lui,
simbolo
dell’alta
cultura, della posta in
gioco della guerra tra
diverse culture. Avrei
voglia di chiedergli se
ha mai visto Desperate
Housewives, la serie
televisiva che tutti
guardano negli Stati
Uniti,
le
cui
protagoniste
si
chiamanoKyalaeNora
Huntington. Decido poi
di
non
fargli
la
domanda, consapevole
che, con la sua rigidità
puritana,
Samuel
Huntington non nutre
certo grande interesse
per
l’entertainment,
che è invece il tema di
questolibro.
Qualche
settimana
dopo mi trovo invece
nell’ufficio di Joseph
Nye,
all’epoca
presidente
della
Kennedy School, la
prestigiosa scuola di
scienze politiche e
diplomazia,
ugualmente
ubicata
all’interno del campus
di Harvard. Nye è un
uomo di settant’anni,
pieno di energia, è
stato viceministro alla
DifesadiBillClintoned
è anch’egli coinvolto
nella guerra culturale
mondiale.Maseleidee
di Huntington hanno
preparato l’epoca di
Bush, quelle di Nye
sono il preludio della
diplomazia di Obama.
Nye è un sostenitore
delle
“complesse
interdipendenze” che
governano le relazioni
tra nazioni nell’era
della globalizzazione e
hainventatoilconcetto
di “soft power”. La sua
idea
è
che
per
influenzare gli affari
internazionali
e
migliorare la propria
immagine, gli Stati
Uniti
debbano
utilizzare anche la loro
cultura e non solo la
forza
militare
ed
economica
(“hard
power”). “Soft power
significa esercitare un
potere attrattivo e non
coercitivo,” mi dice Joe
Nyenelsuoufficio.“La
cultura americana sta
al centro di questo
potere di influenzare e
nelle
sue
diverse
versioni, high o low,
chesitrattidiarteodi
intrattenimento,
che
sia
prodotta
da
Harvard
o
da
Hollywood.”
Quantomeno Nye mi
parla di cultura di
massa globalizzata e
sembra ben informato
sulle questioni e le
dinamichedeigruppidi
media internazionali.
“Ma
soft
power,”
prosegue
Nye,
“significa
anche
esercitare un’influenza
attraverso valori come
libertà,
democrazia,
individualismo,
pluralismo
della
stampa,
mobilità
sociale, economia di
mercato, modelli di
integrazione
delle
minoranze negli Stati
Uniti. Il potere può
essere
soft
anche
attraverso
norme
giuridiche,
con
il
sistema del copyright,
con nuove parole, con
le idee che siamo in
grado di diffondere in
tutto il mondo. E poi,
naturalmente, il nostro
poterediinfluenzaoggi
è
rafforzato
da
internet, da Google,
YouTube,
MySpace,
Facebook.” Nye ha
inventato
alcuni
concetti di successo e
ha sostenuto che la
nuova diplomazia di
Barack Obama, che
ben conosce, deve
essere in stile “smart
power”, deve unire
persuasione e forza,
softehard.
Le celebri teorie di
Huntington e Nye, per
quanto opposte tra
loro, sono davvero
pertinenti in termini di
geopolitica
della
cultura
e
dell’informazione? Le
civiltà sono davvero
inesorabilmente
entrate in una fase di
guerra mondiale sui
contenuti,
oppure
dialogano tra loro
molto di più di quanto
si possa immaginare?
Perché
il
modello
americano
dell’intrattenimento di
massa
domina
il
mondo? Si tratta di un
modello
fondamentalmente
americano, oppure può
essere
riprodotto
altrove? Quali contromodelli
stanno
emergendo? Come si
costruisce
la
circolazione
dei
contenuti in tutto il
mondo? La diversità
culturale,
che
è
l’ideologia
della
globalizzazione,
è
davvero reale, oppure
si rivelerà ben presto
una trappola che gli
occidentali hanno teso
a se stessi? Il libro
affronta
simili
questioni legate alla
geopolitica
della
culturaedeimedia.
SullaspiaggiadiJuhu
a Mumbai – nuovo
nome di Bombay in
India – Amit Khanna,
amministratore
delegato di Reliance
Entertainment,
una
delle
più
potenti
società
indiane
di
produzione di film e di
programmi
televisivi
recentemente entrata
nel
capitale
della
DreamWorks di Steven
Spielberg, mi spiega
quale
strategia
perseguono gli indiani:
“Qui ci sono 1,2
miliardi di abitanti.
Abbiamo
soldi.
Abbiamoconoscenze.
Con
il
Sud-est
asiatico
rappresentiamo
un
quarto
della
popolazione mondiale,
con la Cina un terzo.
Vogliamo svolgere un
ruolo da protagonisti,
sul
piano
politico,
economico, ma anche
culturale.Crediamonel
mercato globale e
abbiamo valori da
promuovere,
quelli
dell’India,
vogliamo
affrontare Hollywood
sul suo terreno. Non
solo per guadagnare
soldi,maperaffermare
i nostri valori. E sono
profondamente
convintochesaremoin
grado di riuscirci.
Dobbiamo
contare
anzituttosudinoi”.
Qualche mese dopo
mispostotral’Egitto,il
Libano e i paesi del
Golfo
insieme
ai
dirigenti del gruppo
Rotana. Rotana è una
società fondata dal
miliardario saudita Al
Waleed con l’obiettivo
di creare una cultura
araba: la sede si trova
a Riyadh, gli studi
televisivi a Dubai, il
settore musicale a
Beirut, la divisione
cinemaalCairo.Anche
per Rotana al centro
della
strategia
culturale
basata
sull’impiego di diversi
media c’è una sorta di
panarabismo
che
significa difendere e
sostenere alcuni valori
e una specifica visione
del mondo. La sua
forza sono i miliardi di
dollari
provenienti
dall’Arabia saudita e
una
potenziale
“audience” di 350
milioni di arabi (che
potrebbero diventare
1,5 miliardi se si
contano
tutti
i
musulmani, soprattutto
nell’Asia del Sud e del
Sud-est). “Condurremo
questa battaglia,” mi
confermano
i
proprietari del gruppo
Rotana.
Nel corso di un altro
viaggio,
al
diciannovesimo piano
di un grattacielo di
Hong Kong incontro
Peter Lam, dirigente
comunistaepresidente
del
gruppo
eSun,
colosso del cinema e
dellamusicanellaCina
continentale e a Hong
Kong. “Abbiamo 1,3
miliardi
di
cinesi,
abbiamo
denaro,
abbiamol’economiapiù
dinamica del mondo;
abbiamo
esperienza:
riusciremo
a
conquistare i mercati
internazionali e faremo
concorrenza
a
Hollywood.
Diventeremo la Disney
dellaCina.”
Nei cinque anni in
cui ho condotto questa
inchiesta ho sentito
discorsi
simili
nel
quartier generale di Tv
GloboaRiodeJaneiro,
nella
sede
della
multinazionale Sony a
Tokyo, nelle sedi di
Televisa a Città del
Messico e di Telesur a
Caracas, nella sede di
Al Jazeera in Qatar,
pronunciati
dai
dirigenti del primo
gruppo indonesiano di
telecomunicazioni
a
Giacarta, nella sede di
China Media Film e di
Shanghai Media Group
in Cina. Oggi in Cina,
India e Messico si
inaugura in media un
nuovo
schermo
al
giorno all’interno dei
multisala.Oltrelametà
degli abbonati alle
televisioniapagamento
viveinAsia.Difatto,la
guerra
culturale
mondiale è già stata
dichiarata.
Con
l’emergere di nuove
potenze
all’interno
dell’economiaglobale–
Cina,India,Brasile,ma
anche
Indonesia,
Egitto, Messico, Russia
– aumenta anche la
loro
capacità
di
produrreprodottiperil
divertimento
e
l’informazione.
La
cultura
dei
paesi
emergenti
comincia
dunqueafarsispazio.
Questi nuovi flussi
mondiali di contenuti
iniziano ad avere un
certo
peso
e
a
contrapporsi
all’industria americana
dell’intrattenimento e
alla cultura europea.
Siamo di fronte alla
costruzione di una
nuova mappa degli
scambi culturali. Tutto
ciò ormai è una realtà,
benché le statistiche
dellaBancamondialee
del Fondo monetario
internazionale
non
riescanoamisurarnela
portata, nonostante il
silenzio dell’Unesco in
questo campo (quando
non riprende i dati
della
propaganda
cineseorussa),benché
il Wto renda conto di
questi scambi culturali
annoverandoli tra le
categoriedeibeniedei
servizi. Non siamo
ancora
consapevoli
dellaportatadeigrandi
cambiamenti
attualmente in corso, e
non sono ancora state
condotte inchieste per
dar conto della nuova
battaglia
su
scala
mondialesuicontenuti.
Questi nuovi soggetti
emergenti
rappresentano
per
l’Occidente un nemico
sul piano culturale? È
corretto parlare di
“scontro di civiltà”? Il
lento affermarsi di
potenti industrie nel
settore audiovisivo e
dell’informazione
in
Asia,inAmericalatina,
in Medio Oriente pone
nuove questioni che
rendonoormaiobsolete
le vecchie chiavi di
lettura. Peraltro, in
questa sede preferisco
impiegare
anche
un’altra terminologia.
Mi pare più opportuno
parlare di “industrie
creative” e di industrie
“dei
contenuti”,
espressioni che non
solo includono tutti i
tipi di media compreso
il digitale, ma che
ritengo certamente più
pertinenti
della
vecchia, connotata, e
oggi
inesatta,
denominazione
“industrie
culturali”.
Non si tratta più,
infatti, solo di prodotti
culturali, ma anche di
servizi.Ingiocononc’è
più solo la cultura, ma
anche i contenuti e i
formati. In questo
scenario non ci sono
solograndiaziende,ma
figurano anche governi
incercadisoftpowere
piccole aziende alla
ricerca di innovazione
nei media e nella
creazionevirtuale.
Osservando i gruppi
di comunicazione su
scalaplanetaria,spesso
diretti
da
nuove
generazionidimanager
e di artisti la cui
giovane
età
è
sconcertante,
è
possibile cogliere i
complessi problemi di
interdipendenzacongli
Stati
Uniti,
le
dinamichediattrazione
e repulsione suscitate
dal loro paradigma, le
tensioni
tra
un’affermazione
identitaria su scala
regionale e la ricerca
del successo mondiale,
le
difficoltà
nel
difendere
valori
specifici all’interno di
un mondo in cui i
contenuti
stanno
assumendo
una
dimensione
globale.
Vengono
alla
luce
anche
numerose
disuguaglianze
tra
paesidominantiepaesi
dominati, alcuni paesi
emergono
come
produttoridicontenuti,
altri sono sommersi da
flussi
culturali
mondiali. All’interno di
questo
scenario,
perché Egitto e Libano
riescono a emergere e
il Marocco no? Perché
Miami e non Buenos
Aires, perché Città del
MessicoenonCaracas,
perché Hong Kong e
Taiwan e non Pechino,
perché il Brasile e non
il Portogallo? Perché
sempre di più i
cinquanta
stati
americani e sempre
meno i ventisette paesi
dell’Europa?
Per
comprendere
questedinamicheeper
tentarediabbandonare
risposte semplicistiche
mi è parso necessario
condurre un’inchiesta
sul campo. Per questo,
per cinque anni ho
attraversato il pianeta
facendo il giro delle
capitali
dell’entertainment,
intervistando
oltre
1250 persone operanti
in queste industrie
creative, in trenta
paesidituttoilmondo.
Neèemersounquadro
nel contempo inedito,
affascinante
e
inquietante.
È
un’inchiesta
sulla
guerra mondiale sui
contenuti. E questa
guerra
è
già
cominciata.
Questo è un libro di
geopolitica
della
culturaedeimedianel
mondo.Èuntestosulla
globalizzazione
dell’intrattenimento e
si occupa di ciò che
fanno
le
persone
quando non lavorano,
di
quelli
che
si
chiamano svaghi o
divertimenti–spessosi
parla di “industrie
dell’intrattenimento”.
Nel concentrarmi su
queste industrie che
producono contenuti,
servizi
e
prodotti
culturali, mi interessa
anche fare l’analisi
numerica
e
quantitativa di queste
merci, non solo della
loro qualità. I temi
trattati sono i film di
successo,iblockbuster,
le hit e i bestseller,
dunque non quella che
sichiamapropriamente
“arte”,
pure
se
Hollywood e Broadway
producono anche arte,
ma quella definita
“cultura di mercato”.
Infatti,questeindustrie
creative fanno sorgere
questioni interessanti
in termini di contenuti,
di marketing e di
capacità di influenza,
anche quando le opere
che producono non lo
sono. Studiare questi
soggetti è utile per
capire
il
nuovo
capitalismo culturale
contemporaneo,
la
battaglia mondiale per
icontenuti,lestrategie
per
acquisire
soft
power, l’ascesa dei
mediadelSudeillento
cambiamento di civiltà
che si sta profilando
sotto la spinta di
internet. In questo
modo vorrei cercare di
cogliere quello che
Francis
Scott
Fitzgerald
definì,
parlando di Hollywood,
“the whole equation”,
l’insiemedelproblema:
la matematica dell’arte
e del denaro, il dialogo
tra contenuti e reti, la
questione
del
paradigma economico
e della creazione per
un pubblico di massa.
Mi occupo di business
dello show business.
Cercodicapirecomesi
parla, nel contempo, a
tutte le persone e in
tuttiipaesidelmondo.
Le industrie creative
oggi non sono più
un’entità
esclusivamente
americana, hanno una
domensione
globale.
Questa inchiesta mi ha
dunque
portato
a
Hollywood,maanchea
Bollywood, a Mtv, a Tv
Globo, nelle periferie
americane
alla
scoperta di un gran
numero di multisala e
nell’Africa
subsahariana dove ci
sono davvero pochi
cinema,aBuenosAires
alla
ricerca
della
musica “latina” e a Tel
Aviv
per
capire
l’americanizzazione di
Israele.
Mi
sono
occupato del piano di
conquista di Rupert
Murdoch in Cina e
della
strategia
di
guerra dei miliardari
indiani e sauditi contro
Hollywood. Ho cercato
di capire come si
diffondono il J-Pop e il
K-Pop,
il
pop
giapponese e coreano
in Asia, e perché le
serie
televisive
si
chiamano “drama” in
Corea, “telenovelas” in
America
latina
e
“teleromanzi
del
Ramadan”inEgitto.Ho
seguito i lobbysti delle
agenzie culturali e
degli studios americani
nelle loro audizioni al
Congresso e ho visto
RobertRedforddavanti
al Senato americano.
Ma ho passato più
tempo
ancora
nei
grandighettineridegli
Stati Uniti. Ho seguito
la produzione di Re
Leone a Broadway con
il patron di Disney e le
riprese di un film di
Bollywood a Mumbai
interrotte
da
scimpanzé. Ho fatto
inchieste nei territori
occupati
della
Cisgiordania e di Gaza
per capire il ruolo dei
media e dei cantanti
arabi
in
questo
contesto
e
ho
incontrato
l’addetto
stampa di Hezbollah
per poter visitare Al
Manar, il suo network
televisivodiBeirutsud.
Intervistando
i
capiufficiodiAlJazeera
a Doha, Beirut, Il
Cairo,
Bruxelles,
Londra, Giacarta e
Caracas ho voluto
capire se il fondatore
dell’emittente, l’emiro
del
Qatar,
avesse
ragionequandodiceva:
“Crediamo all’unione
delle civiltà, non al
conflittodiciviltà”.
Il tema affrontato in
questo libro è molto
vasto e comprende per
i cinque continenti, nel
contempo, l’industria
del cinema e della
musica, gli spettacoli
televisivi, i media, ma
anche l’editoria, il
teatro commerciale, i
parchi d’attrazione, i
videogiochi e i manga.
Per
capire
i
cambiamenti
fondamentali
attraversati da questi
settori, il libro affronta
anche lo scenario del
digitale. Tuttavia, per
scelta, non mi occupo
diGoogle,nédiYahoo,
né di YouTube (di
proprietà del primo),
né di MySpace (di
proprietà di Murdoch).
Ciò che mi interessa
non è internet in
quanto tale, ma come
internet
abbia
rivoluzionato e stia
rivoluzionando,
in
profondità, il settore
delleindustriecreative.
Ovunque, in Arabia
saudita, India, Brasile,
Hong
Kong,
ho
incontrato persone che
costruiscono
le
industrie
creative
digitalididomani.Sono
imprenditori ottimisti e
spesso
giovani,
considerano internet
una
fonte
di
opportunità,
di
mercato,
una
possibilità, mentre in
Europa e negli Stati
Uniti
i
miei
interlocutori,
spesso
più
vecchi,
lo
considerano
una
minaccia. Siamo di
fronte a un radicale
cambio di generazione,
eforsediciviltà.
Di fronte a un tema
così ampio, la scelta di
questo libro è di
concentrarsi
sull’inchiesta
sul
campo: sulle persone
che
ho
realmente
intervistatoesuiluoghi
che ho visitato. Da qui
la scelta, a me poco
familiare,
di
una
narrazione in prima
persona capace di
rendere
conto
dell’indagine
sviluppata e diventata
a sua volta uno dei
temi del libro. Parlo di
ciò che ho visto.
Utilizzo
soprattutto
fonti di prima mano, e
non
informazioni
raccoltedailibriodalla
stampa.
Sono
consapevole
ovviamente
delle
difficoltà che implica
questo tipo di scelta e
ho
deciso
di
privilegiare una serie
di
problematiche
originali e ricorrenti
emerseall’internodelle
industrie su cui ho
fatto
inchieste
piuttostocheun’analisi
esaustiva.Peresempio,
sviluppo l’analisi di
alcuni casi attraverso
leinchiestecondottesu
Disney e Rotana, mi
soffermo su Motown,
Televisa e Al Jazeera e
le reti di Rupert
Murdoch
e
David
Geffen perché sono
rappresentative
dell’intrattenimento e
della
cultura
commerciale, ma mi
soffermo
solo
di
sfuggita
su
Time
Warner,
Viacom,
Vivendi o la Bbc, che
sono
altrettanto
importantiesullequali
ho
condotto
altre
indagini. Si tratta di
una scelta difficile che
riguarda soprattutto il
formato
e
la
metodologia di ricerca
di questo libro. Penso,
peraltro, che l’analisi
delle industrie creative
acquisisca
maggior
profondità se non ci si
limita unicamente alle
questioni economiche.
Nutro
grande
ammirazione per la
sociologia americana
degli anni sessanta,
basata
sulla
valorizzazione
della
rigorosa osservazione
sul campo e su un
vasto
numero
di
interviste. Infine, ho
voluto scrivere questo
testo
sull’intrattenimento in
modo “divertente”, per
fare eco al tema stesso
dellibro.
Il
libro
propone
dunque
un’indagine,
ma anche elementi di
riflessione. I diversi
capitoli hanno la forma
delracconto,mentrele
analisi sono raccolte
nelle conclusioni; le
fonti e i numerosissimi
dati statistici figurano
invece sul sito web.
Spesso gli specialisti
delle industrie creative
che ho incontrato mi
hanno comunicato le
loro intuitions; tra
questi professionisti,
comehocapito,cisono
molte persone che
hanno chiaro cosa si
deve fare. Ho invece
incontrato
poche
persone che, in epoca
di globalizzazione e di
cambiamento digitale,
avevano una visione:
nelle conclusioni cerco
invece di fornire una
visione
geopolitica
globale.
Nel corso di questa
indagine
mi
sono
dovuto scontrare con
un
problema
fondamentale:
l’accesso
alle
informazioni.
Immaginavo che le
fonti fossero rare in
Cina per via della
censuradistato,maho
capito
velocemente
quanto fosse difficile
risalirelagerarchia,un
appuntamento
dopo
l’altro,aMumbai,Rioe
Riyadh.
Non
immaginavo, tuttavia,
chesarebbestatotanto
difficile fare ricerche
negli Stati Uniti, tra le
major
dell’industria
discografica e negli
studios di Hollywood.
Ovunque ho dovuto
formulare
numerosissime
richieste di interviste e
la
mia
“fedina”
giornalistica è stata
attentamente vagliata
dagliufficidipubbliche
relazioni, i famosi “PR
people”.
Spesso
l’informazione veniva
bloccata
all’interno
dalla
divisione
“comunicazione”
e
all’esterno dall’agenzia
specializzata alla quale
venivo inviato. Mi ci è
voluto del tempo per
capire che questi PR
people, che un po’
ingenuamente credevo
fossero persone utili a
facilitare
la
comunicazione,
avevano di fatto il
compito di impedirla:
non
diffondono
informazioni,
le
trattengono.Sonostato
accolto meglio da Al
Jazeera e Telesur – la
televisionediChávezin
Venezuela–chedaFox
eAbc.
Di fronte a tutta
questa omertà, chi
parla allora? Tutti,
naturalmente:
i
dirigenti delle major
parlano
dei
concorrenti,
gli
indipendenti
delle
major, gli uni in “off”,
gli altri attraverso un
dialogo
background
informationonly,senza
possibilità di farne il
nome
(tutte
le
interviste utilizzate in
questo libro sono di
prima mano e le
dichiarazioni
a
microfoni spenti sono
stateomesse,trannein
casi
giustificati
e
precisati nel testo). I
sindacalisti parlano, i
creativi parlano, le
agenzie
di
talent
scouting parlano, i
banchieri e le agenzie
di controllo parlano
(quando si tratta di
società quotate in
Borsahoavutoaccesso
anche ai dati reali).
Tutti
parlano
per
egocentrismo, per farsi
pubblicità, soprattutto
quando si riescono a
trovare buoni canali
d’accesso,
evitando
così i PR people. In
fondo, se la Cina
censura l’informazione
perragionipolitiche,le
major lo fanno per
ragioni
commerciali,
dal momento che un
filmoundiscosonoun
prodotto strategico del
capitalismoculturale.Il
risultato è lo stesso:
unaculturadelsegreto
e
spesso
della
menzogna – e questo
paralleloconlaCinadi
stampo comunista non
va a gloria degli Stati
Uniti.
Tuttalamiaindagine
è
attraversata
da
alcune
domande
fondamentali: qual è
l’incidenza del modello
americano? Qual è il
ruolo specifico degli
Stati Uniti nei settori
dell’intrattenimento e
dei media in tutto il
mondo?Illoropotereè
evidente e, per il
momento, hanno una
macchina
culturale
imbattibile sui flussi di
contenuti mondiali. È
ciò che si potrebbe
chiamare, ribaltando
un’espressione di Che
Guevara,
“l’America
con la A maiuscola”.
Perquestosièimposta
la
necessità
di
cominciare
questa
inchiesta proprio dagli
StatiUniti,percercare
di
capire
come
funziona
l’intrattenimento
a
HollywoodeNewYork,
ma
anche
a
Washington attraverso
le
sue
lobby,
a
Nashville e a Miami
nell’industria
discografica, a Detroit
dove ha cominciato a
diffondersi la musica
pop,
nelle
grandi
periferie dove sono
stati
inventati
i
multisala e nei campus
universitari dove si fa
ricerca e sviluppo per
Hollywood. Prima di
descrivere
la
globalizzazione della
cultura e la nuova
guerra mondiale dei
contenuti nei cinque
continenti – la seconda
parte del libro – mi è
sembrato
opportuno
comprendere
l’incredibile macchina
americanacheproduce
immagini
e
sogni,
quella
dell’intrattenimento e
della
cultura
che
diventamainstream.
Ero negli Stati Uniti,
su un aereo che mi
portavadaLosAngeles
a Washington, quando
ho avuto l’idea di
intitolare questo libro
Mainstream.Iltermine,
difficile da tradurre,
significa letteralmente
“dominante” o “grande
pubblico”,
viene
utilizzatogeneralmente
per un media, un
programmatelevisivoo
un prodotto culturale
che ha come obiettivo
un vasto pubblico.
Mainstream
è
il
contrario
di
controcultura,
sottocultura, nicchia; a
torto o a ragione è il
contrario di arte. Per
estensione, il termine
riguarda
anche
un’idea, un movimento
ounpartitopolitico(la
corrente dominante),
che
intende
conquistare tutti. A
partire
da
questa
inchiesta
sulle
industrie creative e i
media attraverso il
mondo,
Mainstream
puòdunquepermettere
di analizzare anche la
politica e il business
che,
di
sicuro,
“vogliono parlare a
tutti”.
L’espressione
“cultura mainstream”
può peraltro avere
anche
una
connotazionepositivae
non elitaria, nel senso
di“culturapertutti”,o
più negativa nel senso
di“culturadominante”,
o di cultura formattata
e uniformata. Mi piace
anche l’ambiguità del
termine, il fatto che
abbia
diversi
significati;
è
un
termine che ho sentito
pronunciare
da
centinaia
di
interlocutori in tutto il
mondo: tutti vogliono
produrre una cultura
mainstream, “come gli
americani”.
Mentre riflettevo sul
titolo di questo libro,
sono
arrivato
a
Washington
per
intraprendere questa
lunga indagine sulla
circolazione
dei
contenuti e qui ho
conosciuto uno dei più
celebri promotori della
cultura
mainstream,
JackValenti.
Primaparte
L’ENTERTAINM
AMERICANO
1.
JackValentielalobby
diHollywood
“Guardi da questa
parte. Sulla destra di
Johnson
e
Miss
Kennedy,nell’angolodi
sinistrainbasso,quello
lì con un’aria triste e
inquieta sono io.” Jack
Valentiindicailvoltodi
un giovane castano,
dall’espressionetimida,
su una grande foto in
biancoeneromessasu
unleggio.Èlui.
Da quando è stata
scattata quella foto
sono ormai passati
quarant’anni.Valentisi
passa
nervosamente
una mano nella sua
leggendaria chioma di
capelli
bianchi
e
vaporosi. È abbronzato
e raggiante. Ho di
fronte a me uno dei
giganti di Hollywood,
indossa
stivali
da
cowboy ed è alto un
metro e settanta. Sono
nel suo ufficio di
Washington, il quartier
generale della Mpaa.
La famosa Motion
Picture Association of
America è la lobby e il
braccio politico degli
studios di Hollywood.
Ha sede al civico 888
della
Sedicesima
Strada, a meno di
duecento metri dalla
Casa
Bianca.
Jack
Valenti
è
stato
presidente della Mpaa
per trentotto anni, dal
1966al2004.
La fotografia che mi
ha mostrato è storica.
È stata scattata a
bordo dell’Air Force
One, ritrae Lyndon
Johnson con la mano
alzataeJackieKennedy
con il volto livido. In
quel preciso istante, il
22 novembre 1963,
Johnson
presta
giuramento e diventa
presidente degli Stati
Uniti. Sul fondo della
carlinga
dell’aereo,
anchesenell’immagine
non si vede, sotto la
bandiera a stelle e
strisce, c’è il corpo di
John
Fitzgerald
Kennedy, assassinato
dueoreprimaaDallas.
Valenti era nel corteo
ufficiale, ha sentito i
tre colpi di arma da
fuocoedèstatoportato
via
dagli
agenti
dell’Fbi. Come in un
film, quel giorno la
vicenda personale di
Valenti incontra la
grande storia. Accade
tutto in brevissimo
tempo e, qualche ora
dopo, su quell’aereo,
diventa
consigliere
speciale del nuovo
presidente degli Stati
Uniti.
Di fronte a me, quel
mattino a Washington
Valenti prende tempo.
È stato uno degli
uomini più potenti di
Hollywood, per quattro
decenni è stato il
portabandiera
del
cinema americano in
tutto il mondo e si
apprestaaraccontarmi
la sua storia. Ormai è
in pensione e ama
parlare di sé. È nato
nel 1921 in Texas e
proviene
da
una
famiglia di ceto medio
di origini siciliane che
gli ha insegnato ad
amare gli Stati Uniti,
quasi come l’inizio del
film Il padrino di
Coppola in cui si dice:
“I believe in America”.
È
appassionato
di
cinemadegliannid’oro
diHollywoodedurante
le vacanze scolastiche
lavora all’apertura di
una sala a Houston.
Durante la Seconda
guerra mondiale è un
coraggioso pilota dei
bombardieri B-25; poi
consegue un master a
Harvard cui accede
grazie alla legge che
favorisce
l’accesso
all’università degli ex
combattenti nei gruppi
speciali di intervento.
In seguito torna in
Texas e si mette in
affari,
prima
nel
settore petrolifero, poi
in quello della carta
stampata. È in questo
ambito che conosce
LyndonJohnson.
Per tre anni Jack
ValentilavoraallaCasa
Bianca: scrive per il
presidente, gli fa da
consigliere in ambito
politico, diplomatico e
nella comunicazione.
Sempre in modo leale.
A fianco di Johnson
impara come si fa
attivitàdilobbyadalto
livello. Impara come si
fa
pressione
per
riuscireafarapprovare
dal Congresso le leggi
sostenute
dal
presidente.
Impara
come negoziare con i
capi di stato stranieri.
Durante la presidenza
Johnson, Valenti dirige
le
operazioni
parlamentari a favore
della Casa Bianca,
costruendo coalizioni e
accordando favori. È
una
strategia
che
funziona. Alcune delle
leggi più audaci della
storia degli Stati Uniti,
in
campo
sociale,
educativo e culturale,
la
legge
sull’immigrazione che
ha cambiato il volto
dell’America e le più
celebri leggi sui diritti
dei neri sono state
votate
durante
la
presidenza Johnson (e
non Kennedy). Valenti
diventa “padrone del
Senato”maattirasudi
sé anche le critiche di
quelli
che
lo
considerano
semplicemente
un
lacchè al seguito di
Johnson.Il“WallStreet
Journal” irride il suo
servilismo.
La
fedeltà
ha
comunque dei limiti.
Nella fase in cui la
Guerra del Vietnam
mina
il
credito
dell’amministrazione
Johnson, Valenti si
allontana dalla Casa
Bianca e nel 1966, con
quell’aura
da
gentleman e patriota,
accetta di candidarsi
alla presidenza della
potente lobby degli
studios di Hollywood.
Dopo aver conosciuto i
corridoidellapoliticasi
ritrova dunque per la
prima volta nel cuore
dell’industria
del
cinema.
Jack Valenti si scusa
con me e risponde a
una telefonata che
sembra urgente. Lo
stanno chiamando da
Hollywood.
Il
suo
successore mi rivelerà
che ha sempre diretto
la Mpaa in questo
modo: con un numero
infinito di telefonate e
appuntamentipersonali
più che con riunioni
ufficiali. E non ha
egualinellacapacitàdi
mettere d’accordo il
repubblicano più a
destra e il cineasta più
di sinistra. Lo ascolto
sbrigarelaquestionein
pochi minuti, è un
uomo vivo ed energico
nonostante
i
suoi
ottantadue
anni,
trattiene l’impazienza,
quella
dell’uomo
sempre
di
fretta,
dissimulataafaticacon
una gentilezza tutta
diplomatica. Dopotutto
di fronte a sé ha un
francese – sono un
ospitedatrattareconil
riguardo con cui si
trattano i peggiori
nemici della Mpaa – e
Valenti mi mostra con
fierezza la medaglia
della Legione d’onore
assegnatagli
dal
ministro della Cultura
francese Jack Lang.
Alla guida di un vero e
proprio
corpo
diplomatico
di
Hollywood con sede a
Washington come la
Mpaa,Valentièstatoil
primo ambasciatore e
diplomatico
della
culturaamericana.
In tutto il mondo, da
Seul a Rio de Janeiro,
da Mumbai a Tokyo,
dal Cairo a Pechino, la
Motion
Picture
Association
(per
sembrare
meno
americana, all’estero,
la Mpaa si scrive con
unasolaA,Mpa)veglia
sugli
interessi
di
Hollywood. In tutte
queste
città
ho
incontrato
i
suoi
rappresentanti,
personaggi dediti alla
causa, spesso ottimi
conoscitori della realtà
locale.
Questa
importante lobby di
professionisti
degli
studiosènatanel1922
all’epoca del cinema
muto, su iniziativa di
Louis Mayer (quello
della Metro Goldwyn
Mayer).OggilaMpaaè
diretta da un consiglio
d’amministrazione
composto
da
tre
rappresentanti
per
ciascuna
delle
sei
principali
case
cinematografiche
(Disney,
SonyColumbia, Universal,
Warner
Brothers,
Paramount e 20th
Century
Fox).
Il
presidente “esecutivo”
di
un’organizzazione
davvero
potente
coordina il lavoro di
pressione
sul
Congressoamericanoe
veglia sui controlli del
settorepubblico;segue
le
trattative
più
delicate con i sindacati
di
Hollywood
e
pianifica la strategia di
conquista mondiale. È
una lobby che agisce
nell’ombra all’estero e
alla luce del sole in
territorioamericano.
La prossimità di
questo
organismo
senza scopo di lucro,
ufficialmente
indipendente, con il
potere
politico
americanoèunsegreto
di
Pulcinella.
Il
percorso
di
Jack
Valenti lo dimostra.
Dalle finestre del suo
ufficio di Washington
vedolaCasaBianca–è
qualcosa di più di una
semplice
questione
simbolica. Il Congresso
non è molto più
lontano: “Quando c’era
unparlamentareunpo’
recalcitrante, andavo a
incontrarlo portando
conmeClintEastwood,
Kirk Douglas, Sidney
Poitier
o
Robert
Redford”,
mi
dice
Valenti.“Avevasempre
un
effetto
molto
positivo.”
Nel 2008 ho avuto
l’occasione
di
accompagnare Robert
Redford a un’audizione
al
Congresso.
Ho
potuto
constatare
direttamente l’impatto
della sua presenza così
familiare sui senatori
americani: erano tutti
molto entusiasti di
averedifrontealoroa
difendere la cultura
americana il celebre
attore di Tutti gli
uomini del presidente,
incarneeossasottola
bandiera a stelle e
strisce.“Hofattoilmio
dovere.Pertuttalamia
vita, in tutti i miei film
e oggi alla guida del
Sundance film festival
homilitatoafavoredel
cinema. E quando c’è
bisognodimerispondo
presente,” mi ha detto
Redford, nel lungo
corridoio del Senato,
dopo la sua audizione,
prima di riprendere un
aereoperLosAngeles.
Jack
Valenti
è
coerente con le sue
idee. Per rafforzare la
sua influenza, durante
glianniottantahafatto
omaggio a Ronald
Reagan di una sala
cinematografica
all’interno della Casa
Bianca.Tuttiglistudios
di Hollywood hanno
dato
il
proprio
contributo affinché il
cinema presidenziale
fosse,
secondo
l’espressione
di
Valenti,stateoftheart
(ultramoderno).
Fa
predisporre un servizio
Vip: i film richiesti dal
presidente, spesso in
anteprima,
sono
immediatamente
mandati da Hollywood
con un aereo speciale,
in versione 35mm. Il
presidente Reagan e i
suoi successori hanno
trascorso molte serate
in
questo
cinema,
facendosi portare hot
dog e popcorn – come
inunveromultisala.
Quando il lavoro di
pressione
su
Washington non è
sufficiente,
Valenti
utilizzailsuoassonella
manica: Los Angeles e
il suo potere di
fundraising. Comincia
allora a invitare i
membri influenti del
Congresso
e
i
consiglieri
del
presidente alle serate
degli Oscar, oppure a
pranzi di lavoro nella
sua lussuosa suite
privata
dell’Hotel
Peninsula di Beverly
Hills (Valenti è uno dei
lobbysti meglio pagati
di Washington, il suo
stipendio
annuale
supera 1,3 milioni di
dollari). “Quando si
dirige la Mpaa si
rappresentano
gli
studios, ma si deve
lavorare anche con gli
indipendenti,
i
sindacati, le società
degli autori,” aggiunge
Valenti. “È come se si
facesse tutti i giorni
una
campagna
elettoraleperdiventare
sindaco.”
In che senso una
campagna elettorale?
Valenti non lo dice, ma
bisogna sapere che è
stato uno dei più
importanti fundraiser
della
politica
americana. A titolo
personale, o a nome di
altri
magnati
di
Hollywood,
ha
organizzato numerose
raccolte
fondi
per
finanziare le campagne
elettorali di candidati,
democratici
o
repubblicani,
che
avevano atteggiamenti
“simpatici”
verso
l’industria del cinema.
È questo il segreto del
potere di un gruppo di
pressione come la
MpaanegliStatiUniti.
In
campo
internazionale
il
braccio politico degli
studios si affida al
Congresso anche per
favorire l’esportazione
dei film hollywoodiani
e, con il costante
sostegno del ministero
del Commercio estero,
del dipartimento di
Stato
e
delle
ambasciate americane,
esercita pressioni sui
governi
per
liberalizzare i mercati,
eliminare le quote di
riserva e i diritti
doganali
e
per
ammorbidire
la
censura.
Attraverso
una decina di uffici e
uncentinaiodiavvocati
sparsi in tutto il
mondo,
la
Mpaa
sostiene dunque, sulla
scena internazionale,
pratiche
anticoncorrenziali
e
concentrazioniverticali
vietate invece in terra
americana dalla Corte
suprema. Fuori dagli
Stati
Uniti
questi
metodi
sono
stati
spesso accusati invano
diusare“duepesi,due
misure”.
La
strategia
internazionale di Jack
Valenti
è
spesso
discreta.Sibasasuuna
visione d’insieme delle
necessitàdiHollywood.
In Italia, per esempio,
laMpahaincoraggiato
gli studios a investire
sui multisala, a creare
proprie
catene
di
distribuzione locale e
aumentare
le
coproduzioni con gli
italiani.
“È
una
strategia
a
trecentosessanta
gradi,”
dice
il
responsabile
dell’Associazione dei
produttori
italiani,
Sandro
Silvestri,
intervistato a Roma.
“La Mpa e Jack Valenti
sonostatimoltofurbia
spingerelegrandicase
cinematografiche
a
introdursi
nel
contempo
nella
produzione,
nella
distribuzione e nella
gestione dei film in
Italia. In questo modo
ricavano
una
percentuale
sugli
incassidituttalafiliera
dell’industria
del
cinema.”
Questa
strategia
globale
funziona
bene
in
Europa e in America
latina, ma conosce una
battuta d’arresto di
fronte alle percentuali
imposte dalla Cina e
dai paesi arabi. Per
cercare di ovviare a
questi
problemi,
Valentispingeovunque
affinché sia eliminata
la censura, sostituita
da
un
codice
deontologico promosso
direttamente
dall’industria
del
cinema. Come accade
negliStatiUniti.
“Sono i professionisti
a dover stabilire le
regole, non i governi,”
mi conferma nel suo
ufficio di Washington
Jack Valenti. “Oggi,
negli Stati Uniti, il
cinemanonhacensura,
e questo grazie a me.”
Da quando nel 1966 è
diventato
presidente
della Mpaa, infatti,
Jack
Valenti
ha
realizzato,anomedella
sua organizzazione, un
nuovo
sistema,
il
“rating system”, per
classificare
i
film
secondo categorie in
relazione al livello di
violenza, alle scene di
nudo, di sessualità
(scenedifilmincuic’è
qualcuno che fuma è
uncriterioaggiuntonel
1997).Èstatouncolpo
damaestro.Conquesto
codice, Valenti ha dato
un nuovo significato
allelettereG,P,N,CeX:
unfilmidentificatocon
“G” si rivolge a tutti i
tipi di pubblico, “PG”
invita i genitori alla
vigilanza, “PG-13” è un
film sconsigliato ai
minori di tredici anni;
infine“NC-17”èunfilm
strettamente vietato ai
minori di diciassette
anni,edunqueproibito
nelle sale commerciali
(questa categoria ha
sostituito nel 1990
quelladella X).“Questo
sistema di codici ha
grande influenza in
tuttoilmondo.Dicerto
ha
una
matrice
spiccatamente
americana perché la
mia intenzione,” mi
spiega Valenti, “era
chefosseHollywoodad
autoregolarsi: è stata
una
decisione
dell’industria
del
cinema e non del
governo
o
del
Congresso. Non si
tratta di una censura
politica, ma di una
scelta
fatta
direttamente
dagli
studios.” In realtà, il
codice
di
classificazione dei film,
che è stato presentato
come strumento per
proteggere le famiglie,
ha
preservato
soprattuttogliinteressi
economici delle case
cinematografiche,
all’epoca
sotto
la
minaccia
del
Congresso.
Mentre
ascolto Valenti parlare,
mi viene in mente la
formuladiPeterParker
inSpider-Man:“Conun
grande potere ci vuole
una
grande
responsabilità”.
In
effetti, non mi sbaglio,
poiché
Valenti
aggiunge: “Negli Stati
Uniti, la libertà va di
pari passo con la
responsabilità”.
Valenti conosce bene
la storia delle case
cinematografiche Rko,
Orion, United Artists e
Metro Goldwyn Mayer
e sa che gli studios
sono
vulnerabili.
Proteggerli è stato
l’obiettivo della sua
professione.
Per
questo, il lavoro della
Mpaa è andato ben
oltre la missione di
lobbying.
Jack Valenti non
riesce a capire dove
voglioandareaparare.
Gli
faccio
alcune
domande
sul
calendario delle uscite
dei film, questione
ormai di rilevanza
planetaria. Ci sono
davvero accordi tra i
principali
studi
di
produzione
cinematografica
per
evitare
di
farsi
concorrenza tra loro?
Valenti continua a non
capire il senso della
domanda.
Negli Stati Uniti, i
dueperiodicrucialiper
fare uscire un film
mainstream,
commerciale,
sono
piuttosto
definiti:
anzitutto l’estate, tra il
Memorial Day (ultimo
lunedì di maggio) e il
Labor Day (festa del
lavoro, primo lunedì di
settembre). In seconda
battuta c’è il periodo
dellefestedifineanno,
trailThanksgivingDay
(il quarto giovedì di
novembre) e Natale.
Anche se di minor
importanza, un altro
periodo interessante è
quello delle vacanze
scolastiche, che però
variano spesso da uno
stato all’altro e a
secondadelgradodelle
scuole.
In
questi
periodi dell’anno esce
la maggior parte dei
film di cassetta, i
famosi
blockbuster,
come Harry Potter,
Shrek, I pirati dei
Caraibi e Avatar. Più
raramente le uscite
sono in primavera, il
periodo più fiacco del
botteghino
statunitense, quello in
cui i produttori sanno
di non poter ambire ad
alcunOscareincui,in
tutto
il
mondo,
aumenta la quota del
cinemanonamericano.
Tuttavia, le date di
uscitadeifilmogginon
si giocano più solo su
scala nazionale ed è
qui che le cose si
complicano. Valenti mi
spiega
questo
rompicapo di portata
internazionale.
Anzituttoc’èquelloche
nel nostro incontro
chiama “domestic boxoffice”
che,
stranamente, oltre agli
Stati Uniti comprende
anche i biglietti del
cinema venduti in
Canada, paese che
Hollywood ha annesso
al territorio americano
in termini economici.
In Canada le date di
uscita sono diverse,
soprattutto perché la
festa
del
Ringraziamento cade il
secondo
lunedì
di
ottobre e le vacanze
sono organizzate in
altromodo.InMessico,
paese
cattolico,
fondamentale per la
sua
vicinanza
geografica, le cose si
complicano
ulteriormente poiché
non esiste la festa del
Ringraziamento.
In Europa, mercato
cruciale
per
gli
americani,ilcalendario
è
ancora
più
complicato
poiché
bisognatenercontodei
diversi paesi, delle
vacanze
scolastiche,
delle ferie lavorative,
ma anche delle partite
deiMondialidicalcioe
del clima – che hanno
un forte impatto sul
botteghino. In Asia, le
date ideali per fare
uscire i film sono
nuovamente diverse.
Per avere successo in
Cina, è necessario
essere in sala a San
Valentino, per la festa
nazionale cinese (1°
ottobre),ilgiornodella
Festa del lavoro o
durante l’estate – ma
proprioperevitareche
i
film
americani
possano dominare il
botteghino cinese, la
censura
proibisce
generalmente l’uscita
di film stranieri in
questedate.InIndia,il
momento ideale si
colloca attorno alla
grande festa di Diwali,
inautunno,cheinIndia
è come il Natale in
Europa. Nei paesi
arabi,invece,ilperiodo
miglioreperdistribuire
film di cassetta è
l’estate; in questo
periodo
escono
generalmentelegrandi
commedie
egiziane.
Bisogna invece evitare
assolutamente
il
Ramadan,
che
impedisce
di
programmare qualsiasi
film – il Ramadan
cambia data ogni anno
e talvolta cade in
estate. Per riuscire a
raggiungere un ampio
pubblico nei paesi
arabi,
è
meglio
orientarsiversoledate
cruciali della fine del
Ramadan(lafestadella
interruzione
del
digiuno, Aid el Fitr), la
festadelSacrificio(Aid
el Kebir, la festa più
importante dell’islam,
che segna la fine del
pellegrinaggio e in cui
avviene il sacrificio del
montone),
o
più
generalmente i fine
settimana (che cadono
da giovedì a venerdì
sera in Arabia saudita,
madavenerdìasabato
sera nel Maghreb). Un
filmcheesceduranteil
Ramadan o tra le due
feste dell’Aid ha poche
possibilità
di
conquistare un largo
pubblico.
Per
Hollywood, tuttavia, il
botteghino dei paesi
arabi non conta e
dunque
il
piano
commerciale di uscita
di un film americano
può non tenere conto
di queste date del
mondo arabo. “La
seasonability
della
nostraprofessioneèun
fattore decisivo,” mi
conferma
qualche
settimana dopo, a Los
Angeles, Dennis Rice,
unodeipresidentidella
casa cinematografica
UnitedArtists.
Proprioperfarfronte
a questo complesso
calendario
internazionale,laMpaa
ha
inventato
un
sistema
anticoncorrenza
con
l’obiettivo, segreto, di
permettere alle sei
principali major di
accordarsisulledatedi
uscita
nazionali
e
internazionali dei film
piùmainstream.Sedue
film
di
cassetta
rischiano
di
farsi
concorrenza poiché è
prevista la stessa data
di uscita, si organizza
una
riunione
di
conciliazione e l’uscita
di una delle due
pellicole è posticipata.
Queste “intese” sono
organizzate sotto gli
auspici della Mpaa.
Jack
Valenti
mi
garantisce che simili
pratichenonhannomai
avutoluogo.
Dan
Glickman
scoppia a ridere. “Non
ha proprio capito,” mi
dice dopo che mi sono
permesso di fargli
notare che secondo me
ha sbagliato “job”.
Glickman
è
un
deputato democratico
del Kansas, è stato
ministro
dell’Agricoltura
durante la presidenza
Clintonerecentemente
ha
sostituito
Jack
Valenti alla presidenza
della
Mpaa.
Il
passaggio
dall’agricoltura
alla
cultura è quantomeno
sorprendente.
Ironicamente
faccio
questa osservazione a
Glickman.“Quandoero
ministro di Clinton mi
occupavo di quote
agricole, soprattutto di
mais.Adessoinvecemi
occupo di cinema. E sa
qual
è
l’elemento
centrale dell’economia
del cinema? I popcorn.
Prima mi occupavo
della
coltivazione,
adesso della vendita.
Dal corn al popcorn, a
me sembra proprio la
stessa
identica
professione!” Adesso
sono io a scoppiare a
ridere.
Daquando,nel2007,
Valenti è morto, Dan
Glickman tiene da solo
leredinidellaMpaa.Lo
incontro nel suo ufficio
di Washington e mi dà
l’impressionediessere,
nel
contempo,
un
fedele erede di Valenti
e il suo contrario, non
cercadieluderetroppo
le domande, è franco e
diretto. È nato nel
Kansas e proviene da
unafamigliaimmigrata
di origini ucraine, è
stato
eletto
al
Congresso dove si è
specializzato
sulle
quote agricole e sulle
barriere
doganali
internazionali (è stato
anche presidente della
Commissione
parlamentare
di
controllo dei servizi
segreti americani al
Senato) e, rispetto al
suo predecessore alla
testa della Mpaa, si
prende meno sul serio.
È un po’ smorto, con
una personalità non
molto marcata, mentre
Valenti era un tipo
caloroso e piuttosto
schiamazzante,
di
quelli che negli Stati
Uniti si dice siano
dotati
di
un
“Texassized ego” (un
ego delle dimensioni
del Texas). Glickman
sembra
invece
tormentato, addirittura
ansioso,
con
una
tensione che cerca di
compensare
con
un’apparente
disinvoltura,
con
un’etica del lavoro e
soprattutto un gran
senso dell’ironia di cui
mi dà prova nel nostro
incontro.
Dan
Glickman
conosce i confini del
suo impero. Dall’inizio
degli anni novanta le
industrie
dell’intrattenimento
sono al secondo posto
nelle
esportazioni
americane dopo il
settore aerospaziale.
Dalmomentoche,negli
Stati Uniti, il mercato
del cinema ristagna e
dato l’aumento dei
costi di produzione, gli
studios
sono
condannati
a
perseguire
una
strategia commerciale
su scala mondiale. Su
questo
fronte,
Glickman può restare
ottimista poiché il
botteghino
internazionale
di
Hollywood è in forte
crescita (è aumentato
del 17 per cento tra il
2004 e il 2008).
Glickman peraltro è
consapevolechequesto
mercato globale è
ampiamente
sbilanciato: i film di
Hollywood
vengono
proiettati
in
circa
centocinque paesi, ma
pergliintroitipuòfare
affidamentosoprattutto
su
otto
di
essi:
Giappone, Germania,
Regno Unito, Spagna,
Francia,
Australia,
Italia e Messico (per
ordine di importanza,
in media, escluso il
Canada).
Solo
gli
incassi in questi paesi
rappresentano tra il 70
e il 75 per cento del
botteghino
internazionale
di
Hollywood.
Glickman, tuttavia,
pensagiàallaprossima
mossa. Sa che negli
ultimi anni è in
costante
aumento
l’esportazione di film
verso il Brasile e la
Corea. Per questo
viaggia più spesso
diretto a Città del
Messico, Seul, San
Paolo,
ma
anche
Mumbai e Pechino. Il
suo obiettivo sono i
paesi emergenti dove
leentratedell’industria
cinematografica
americana
stanno
attualmente
facendo
registrare una crescita
a doppia cifra. Per il
momento,ilnumerodei
biglietti aumenta più
velocemente di quello
degli incassi in termini
di dollari, ma il futuro
di Hollywood si colloca
in questi orizzonti.
Glickman sa che tra
non molto non si potrà
più contare sui vecchi
mercati europei, ma su
quelli dei paesi appena
entrati nel G-20, sui
paesi Bric (Brasile,
Russia, India, Cina) e
sugli altri paesi del
Sudest asiatico. Si
disegna dunque una
nuova
cartografia
mondiale del mercato
delcinemaamericano.
Nello stesso tempo
Glickman mette un
freno
al
proprio
ottimismo. Le case di
produzione
hollywoodiane corrono
il rischio di diventare
“attivi non strategici”
all’interno di grandi
multinazionali
come
Sony. Le situazioni di
monopolio,
in
precedenza fortemente
regolamentate
negli
Stati Uniti, oggi non
hanno più alcun limite;
dall’epoca reaganiana
gli studios sono stati
autorizzatiadacquisire
reti
televisive
e
possono inoltre avere
proprie
sale
cinematografiche,
situazione
invece
proibita dalla Corte
suprema dal 1948. C’è
poi il problema della
pirateria,un’ossessione
per Glickman e la
Mpaa.Segiàconidvd
alcuni mercati come la
Cina
facevano
registrare il 95 per
cento
di
prodotti
contraffatti,
la
situazione
è
ulteriormente
peggiorataconinternet
che
permette
di
scaricare qualsiasi film
addirittura
prima
dell’uscita negli Stati
Uniti.
Infine
c’è
l’aumento vertiginoso
dei costi di Hollywood.
Oggi, solo il settore
trucco di un film
supera
spesso
i
cinquecentomila
dollari.
Dan Glickman mi
enumera i punti di
forza e i limiti del
sistema hollywoodiano.
Al centro di questa
equazione economica
complessa ci sono
soprattuttolestar.Solo
la presenza di un
numero ristretto di
attori – Johnny Depp,
BradPitt,MattDamon,
Tom
Cruise,
Tom
Hanks, Leonardo Di
Caprio, Nicole Kidman,
Julia Roberts, Harrison
Ford, George Clooney,
Will Smith soprattutto
– può consentire a un
film di uscire ovunque
nel mondo. Il cachet di
queste grandi star
rappresenta una quota
sempre crescente nel
budget dei film, anche
perché
comprende,
generalmente, anche
una percentuale sugli
incassi.
Tutto
il
dilemma
è
qui:
realizzare un film di
carattere
internazionale
senza
grandi nomi comporta
un’assunzione
di
rischio elevata, ma
avere
una
star
conosciuta in tutto il
mondo implica costi
esorbitanti.
La Mpaa all’assalto
dell’Americalatina
In Brasile l’uomo
della Mpa si chiama
Steve Solot. Dal suo
ufficiodiRiodeJaneiro
organizza le operazioni
degli studios in tutta
l’America latina. Lo
incontro proprio a Rio
emispiegache“perla
Mpaa,
l’importanza
dell’America latina non
è
tanto
per
il
botteghino,
ma
in
termini di influenza e
di numero di biglietti
venduti. La quota di
cinema americano al
botteghino brasiliano
supera l’80 per cento,
come spesso accade in
America latina. Anche
sul restante 20 per
cento non bisogna
dimenticare
che
numerosifilmbrasiliani
sono coprodotti con gli
americani.
Nel
complesso, si supera
dunquel’85percento”.
L’ufficio della Mpa di
Rio
analizza
le
evoluzioni del mercato
cinematografico:
televisioni,
emittenti
satellitari, lotta contro
la pirateria su internet
e stretto controllo per
evitare ogni misura
protezionista
dell’industria
brasiliana.
Daquestabaseviene
sorvegliata
tutta
l’America
latina:
quando il Messico ha
cercato di mettere in
campo misure per
proteggere la propria
industria,SteveSolotsi
è trasferito in Messico
per coordinare una
strategia
controffensiva.
Con
l’appoggio,
a
Washington, di Jack
ValentiedelCongresso
americano, la Mpa è
riuscita a far fallire il
progetto
di
legge
messicano
e
ad
annullare le misure
inizialmente previste.
“Gli americani sono
statimoltoabili.Hanno
condotto una doppia
offensiva: anzitutto sul
fronte del governo
messicano,innomedel
Nafta,
l’accordo
nordamericano per il
libero scambio, poi
hanno
esercitato
attività di pressione
direttasuigestoridelle
sale,comeme,affinché
mostrassimo la nostra
contrarietà
alle
percentualiimpostedal
governo. Ai messicani
piacciono i grandi film
di cassetta americani e
con quelle misure il
nostro giro d’affari
sarebbe diminuito. Per
questo
ci
siamo
opposti,” afferma il
messicano
Alejandro
Ramirez
Magana,
direttore
generale
dell’importante rete di
sale Cinepolis, che
sono
riuscito
a
intervistare a Città del
Messico.
Per molto tempo il
rappresentante della
Mpa in America latina
è stato Harry Stone.
Stando alle parole di
Jack Valenti: “Era una
sorta di ufficiale di
cavalleria
inglese,
grande
e
baffuto,
parlava perfettamente
spagnolo e portoghese.
E chiunque fosse il
presidente del Brasile,
Harry era suo amico”.
(Non ho incontrato
Stone
poiché
è
decedutoallafinedegli
anniottanta.)
A Rio faccio allora
qualche domanda a
Steve Solot sul suo
predecessore.
Per
quarant’anni,
Harry
Stone ha fatto attività
di
pressione
alla
vecchia maniera: in
grande stile, con feste
mondane. Conosceva i
presidenti di tutti i
paesi
dell’America
latina.
Organizzava
sontuosi
ricevimenti
con
champagne
franceseecavialenelle
ambasciate
e
nei
consolati degli Stati
Uniti. Le élite di
Brasile e Argentina si
precipitavano
per
venire a vedere in
anteprima, in un’epoca
in cui film americani
impiegavano
diverse
settimane per arrivare
da queste parti, 2001.
Odissea nello spazio, Il
padrino, Taxi Driver.
Questa strategia si
basava
sulla
promozionedeivalorie
dellaculturadegliStati
Uniti per incentivare il
commercio.
Alberto
Flaksman,
dell’agenzia
governativa
di
promozione del cinema
americano, conferma il
ruolo determinante di
HarryStoneinAmerica
latina: “Era noto che
Harry
fosse
omosessuale, ma era
sposato
con
una
facoltosa
signora
brasiliana.Inqualitàdi
presidente della Mpa
per l’America latina
davagrandiricevimenti
cuiinvitavaibanchieri,
il jet set, gli uomini
d’affari,
le
grandi
famiglie, ma anche i
militari delle dittature,
cosa che dava alle
serate un’atmosfera un
po’ viscontiana. Negli
anni settanta, la Mpa
lavorava bene durante
la dittatura in Brasile,
quella di Pinochet in
Cile, mentre aveva
qualche difficoltà in
Argentina con Perón,
che era fortemente
antiamericano. Harry
Stonefrequentavapoco
invece le personalità
del
cinema
dell’America latina; le
trovava
troppo
di
sinistra
o
troppo
nazionaliste. Senza di
loro,maconidittatori,
lanciava
i
film
hollywoodiani
di
successo–eilsuccesso
arrivava. L’oligarchia
brasiliana e cilena
amava
il
cinema
americano e si è
sempre venduta alla
Mpa”.Questavicinanza
con i poteri locali ha
permesso alla Mpa di
ottenere vantaggi per
la diffusione di film
come l’abolizione delle
tasse di esportazione
sulle copie, un miglior
tassodicambioperfar
rientrare negli Stati
Uniti gli incassi del
botteghino, e talvolta,
quando esistevano, la
mancata applicazione
delle quote percentuali
nazionali.
Ho incontrato gli
emissari della Mpa che
difendono il cinema
americano a Rio de
Janeiro, Buenos Aires,
Città del Messico e
ancheCaracas.Ingran
parte
sono
i
sudamericani a gestire
le reti di distribuzione
sostenendo i grandi
film di cassetta di
Hollywood. Ma perché
lo fanno? Per denaro,
risponde a Rio Alberto
Flaksman. “È un po’
come accade con la
Coca-Cola:ovunquevoi
andiate nel mondo, nel
più piccolo villaggio
dell’Asia e dell’Africa,
troverete una bottiglia
fresca di Coke. Sul
piano
locale,
la
maggior parte dei
distributori di film non
è americana. Qui ci
sono dei brasiliani che
promuovono il cinema
americano non per
ragioniideologiche,ma
semplicemente
per
interesse
commerciale.” Questi
emissarilocalilavorano
spesso
in
contemporanea
per
diverse
major
hollywoodiane.
In
America latina, infatti,
gli studios non sono in
concorrenza tra loro,
ma si sostengono.
Esistono accordi di
distribuzione
tra
Disney e 20th Century
Fox, tra Warner e
Columbia e soprattutto
tra Viacom e Universal
che, addirittura, in
Brasile
gestiscono
insieme alcuni cinema.
Le
leggi
che
proteggono il libero
gioco
della
concorrenza negli Stati
Uniti non si applicano
in
America
latina.
Alberto
Flaksman
sospira: “Di fronte a
questa
formidabile
macchina da guerra,
noisudamericanisiamo
molto
divisi.
Non
abbiamo nessuna rete
di
distribuzione
comune.
E
non
abbiamo un cinema
‘latino’dadifendere”.
Incontro in Messico
Jaime
Campos
Vásquez, un uomo con
un percorso di vita
singolare.
“Sono
peruviano
e
per
venticinque anni ho
lavorato per i servizi
segreti del mio paese.
Oggi lotto contro la
pirateria per conto
della Mpa,” mi dice
appena lo incontro,
parlando in spagnolo
(stranamente Vásquez
non parla inglese). Lo
incontro nella sede
dell’Mpa di Città del
Messico. È tutto tirato,
porta una cravatta a
losanghe malva in stile
Vasarely, un pacchiano
orologio dorato, ha
capelli pettinati alla
perfezione,
è
un
personaggio
che
difficilmentesiriescea
classificare e, contro
ogni attesa, è un tipo
simpatico.
“Venticinque anni di
servizisegretièlungo,”
ripete
sorridendo,
pieno
di
sé,
mostrandomi
con
insistenza i capelli
bianchi. Dietro quella
giovialitàscorgoitratti
di un uomo temibile.
“La pirateria dei film è
un
crimine
più
leggero,”midice.“Qui,
in Messico, è un
commercio
illegale
sostenuto dal crimine
organizzato, dalle reti
mafiose.Lavoriamocon
la polizia locale, alle
dogane, e la mia
esperienza nei servizi
segreti mi aiuta molto
in termini di analisi
dell’informazione,
d’investigazione e di
intelligence
tecnologica.”
Gli chiedo se non sia
una
contraddizione
lavorare
per
gli
americani.
Vásquez
sorride: “Non ho alcun
problema a lavorare
per i gringos. Io lotto
contro
la
contraffazione e contro
l’economia sommersa
illegale. Tutto ciò che
indebolisce il crimine
organizzato in America
latinaèpositivo.Siamo
per la tolleranza zero”.
Poi esita, si raddrizza
sulla
poltrona
e
riprende il discorso,
visibilmente
imbarazzato dal fatto
che un francese gli
abbia
mosso
un’osservazionesulsuo
lavorare per conto
degli americani: “Di
certo saprà che in
Messicoilcinemadeve
molto agli americani.
Quindici anni fa non
c’erano più cinema,
non si proiettava più
alcun
film.
Oggi,
invece,sicostruisceun
nuovo multisala al
giornoeinMessicoc’è
il doppio dei cinema
del Brasile, mentre la
popolazione è la metà.
Tuttociòvienedaifilm
commerciali americani
che permettono al
cinema
di
essere
nuovamente redditizio
ealpubblicoditornare
nelle sale. Inoltre, gli
americaniincoraggiano
e
finanziano
la
produzione
locale.
Formano
registi
ispanici
nelle
loro
università e danno loro
una possibilità a Los
Angeles.Oggiilcinema
messicano
sta
rinascendo”.
(Hollywood controlla il
90 per cento del
botteghino in Messico,
il cinema messicano
menodel5.)
La sede della Mpa di
Città del Messico è
discreta, è una casa di
famiglia
borghese,
senza alcun cartello
all’ingresso, al centro
di
un
quartiere
residenziale. Al suo
interno non c’è alcun
segno
distintivo
particolare, eccetto un
magnificovecchiojukebox.
Vi
lavorano
venticinque persone,
assunte da diverse
società. Jaime Campos
Vásquez, per esempio,
non
risulta
ufficialmente
come
dipendente della Mpa:
è il direttore della
Apcm, Associazione di
sostegno a cinema e
musica.
Questa
associazione è stata
creata congiuntamente
dalla
Mpa
e
dall’industria
discografica americana
per lottare contro la
pirateria. “Mpa è lo
sbirro buono e noi
quello cattivo,” dice
Vásquez. “Li ospitiamo
nella nostra sede, ma
non vogliamo apparire
direttamente
come
responsabili
del
programma
di
repressione,” conferma
l’avvocato
Rita
Mendizaal Recanses,
responsabile della Mpa
in Messico, che mi
riceve negli stessi
uffici. Infatti, l’Acpm è
il settore di polizia
della Mpa ed è legata
direttamente a Los
Angeles, dove dipende
da Bill Baker, un ex
responsabile dell’Fbi,
poidellaCia,chefada
supervisore alla lotta
contro la pirateria e
dipende direttamente
dal presidente della
MpaaaWashington.
Jack Valenti aveva
già
oltre
settantacinque
anni
quando incontrò il
peggior nemico della
sua carriera, peggiore
anche della Guerra del
Vietnam che aveva
posto fine alla carriera
del
suo
mentore
Lyndon Johnson. Il
grande
nemico
è
internet.All’internodel
suo
ufficio
di
Washington, Valenti si
scalda
improvvisamente
quandoaffrontoquesto
tema, su cui so essere
sensibile. Internet è il
suo nemico personale,
lasuaossessione,ilsuo
incubo. Di fronte a me
Valenti sbarra i grandi
occhi, le sue braccia si
alzano:sipotrebbedire
che è diventato un
personaggio
esageratamente
animatodellaPixar.
Per condurre questa
battaglia, Jack Valenti
è tornato sotto i
riflettori. Alla vigilia
della
pensione
si
comporta come i divi
cheannuncianosempre
l’ultimatournéeperpoi
fareuninattesoritorno
sulla
scena.
Nelle
avversità dà il meglio
disé.SacheHollywood
ha bisogno di essere
amata,maanchechela
Mpaa non deve avere
pauradiesseretemuta.
All’inizio del nuovo
millenniotornainsella,
in pratica ricomincia a
fare
politica.
Organizza, in modo
metodico,
la
lotta
contro
la
contraffazione di film,
avvia la guerra contro
le nuove tecnologie,
mobilita il Congresso,
tutti gli ambasciatori
degliStatiUnitietutte
le polizie, esagerando
sui
dati
delle
statistiche e facendo
assurgere
la
propaganda
degli
studios
contro
la
pirateria
a
causa
nazionale americana.
“È stata la battaglia
dellamiavita,”midice
Valenti. Ma in questo
modo
sottovaluta
l’avversario, si perde
un cambio epocale e,
con la sua battaglia
contro
internet,
riproduce lo storico
errore
commesso
dall’industria
discografica quando,
alla fine degli anni
dieci,volevaproibirela
radio per timore della
concorrenza.
Ancora
unavoltalabattagliaè
persainpartenza.
A pensarci bene,
peraltro, si tratta di
unagrandeinvoluzione
strategica
per
Hollywood: dopo aver
fatto di tutto, per
decenni,perdiffondere
il cinema americano
ovunque nel mondo e
con tutti i mezzi, la
Mpaa è ferocemente
passata
dalla
promozione
alla
repressione,
dalla
cultura alla polizia.
Bisogna
tuttavia
riconoscere che la
contraffazione
di
videocassette e dvd in
Asia rappresenta una
veraepropriaindustria
(il 90 per cento del
mercato in Cina, il 79
in Thailandia, il 54 a
Taiwan, il 29 in India,
secondo le stime della
Mpaa), in Africa, in
Medio
Oriente,
in
America latina (il 61
per cento del mercato
in Messico) e in Russia
(il 79). La Mpaa stima
oggi che Hollywood
perda 6,1 miliardi di
dollariall’annoacausa
della pirateria. Questo
dato dipende ancora in
gran
parte
dalla
contraffazione
di
videocassette
e
soprattuttodidvd(il62
per cento del totale) e
in parte inferiore, ma
crescente, a causa di
internet.
Tuttavia,
Valenti
ha
immediatamente colto
ilproblema:lapirateria
di prodotti culturali
“materiali” finora non
hacolpitogliincassidi
Hollywood perché si
concentravasumercati
poco redditizi; ma con
la smaterializzazione
dei film si diffonde la
pratica di scaricare
film in modo illegale in
Europa,inGiappone,in
Canada e in Messico e
anche negli Stati Uniti.
Questa volta il pericolo
èincasa.
La Mpaa ha dunque
fatto della lotta alla
piraterialasuapriorità
mondiale, è nata una
nuova strategia che ha
rovesciato gli equilibri
e
provocato
cambiamenti
di
alleanze. Si ritrova
dunque alleata con i
governi francese e
tedesco, mentre questi
ultimi
erano
in
precedenza reticenti a
collaborarci
poiché
difendevano le proprie
cinematografie
nazionali.
Nel
contempo è nata una
crescente
incomprensione con i
paesi emergenti e i
paesi del Sud del
mondo, che si rifiutano
di
sanzionare
la
pirateria per ragioni
economicheepolitiche.
La Cina, per esempio,
non
condivide
la
filosofia americana sul
copyright e la Russia
non intende favorire le
esportazioni
statunitensi.
Il paradosso sta nel
fatto
che,
nel
frattempo, la Mpaa ha
dimenticato la lotta
contro le percentuali
nazionali. “L’abolizione
delle quote percentuali
ediriservanonèpiùla
nostra
priorità
d’insieme,”
mi
conferma
Dan
Glickman,
l’attuale
presidente della Mpaa,
nel suo ufficio di
Washington. Piuttosto
che lanciarsi in una
guerra
globale,
la
Mpaa negozia caso per
caso, ora con il
Messico, ora con la
Corea.
La
nuova
diplomazia americana
del cinema non segue
una
politica
multilaterale,
ma
rincorre
una
“multipartnership”.
Attraverso i canali
diplomatici, attraverso
il suo dialogo con il
Congresso e le polizie,
la Mpaa, per quanto
affermi
di
essere
indipendente,èdifatto
un’agenzia americana
“quasi
governativa”.
Non bisogna tuttavia
cadere nella teoria del
complotto. Nulla di
tuttociò,ilegamiconil
governo, né quelli con
la Cia o l’Fbi, spiegano
realmente la potenza,
né
la
crescente
importanza del cinema
americanonelmondo.
Per comprendere il
monopolio
internazionale
degli
Stati
Uniti
sulle
immagini e sui sogni è
necessario risalire alle
origini
di
questo
potere,
non
a
Washington, ma a Los
Angeles,
non
alla
Mpaa, ma agli studios
di
Hollywood.
È
necessario
anzitutto
occuparsi del pubblico
americano: milioni di
spettatori che ogni
anno acquistano circa
1,4 miliardi di biglietti
d’ingresso al cinema
per una spesa di oltre
diecimiliardididollari.
Oggi consumano film
soprattutto nelle sale
cinematografiche delle
grandi periferie degli
Stati Uniti. Tutto è
cominciato qui: nei
centri commerciali ai
bordi delle autostrade,
nei
drive-in,
negli
exurbseneimultisala.
2.
Multisala
“Le toilette sono
talmente belle che mi
chiedo se un giorno
non si verrà al cinema
solo per andarle a
vedere.
Inizialmente
volevano
addirittura
farne pagare l’uso ai
turisti.”
Sorride
Mohammed
Ali,
manager dei multisala
di City Stars, uno dei
più
grandi
centri
commerciali del Medio
Oriente, a Nasr City –
città di Nasser – vicino
Eliopoli,
venticinque
chilometri a est del
Cairo,inEgitto.
Aldisopradeicubiin
cemento
che
compongono i sette
piani dello “shopping
mall” svettano tre
piramidi
di
vetro
illuminate.
Esclusa
quest’ultima
caratteristica in stile
egiziano, questo è un
luogo simile a tutti i
centri commerciali del
mondochehovisitato–
aOmahanelNebraska,
aPhoenixinArizona,a
Singapore, Shanghai,
Caracas e Dubai. City
Stars è stato finanziato
dal Kuwait, ha aperto i
battenti nel 2004 ed è
la risposta araba al
benessere
e
al
consumismo.Nonsose
rappresenti
un’operazione
di
cattivo gusto, ma dal
punto
di
vista
commercialeCityStars
funziona a meraviglia.
Èluogodiapprodoper
tutto il Medio Oriente,
la gente ci viene per
comprare le maggiori
marche internazionali
e,
come
ovunque,
anche un po’ di sogno
americano.
All’interno del centro
commerciale, una via
di mezzo tra un
progetto faraonico e
una cattedrale nel
deserto, ci sono due
multisala che, stando a
quanto
mi
dice
Mohammed Ali, fanno
registrare un quarto
degli
incassi
del
botteghino egiziano (il
dato reale è il 20 per
cento, che comunque è
una percentuale già
considerevole). Il più
grande dei due cinema
ha tredici sale alle
quali si accede da una
grande hall il cui
pavimentoècopertoda
una moquette decorata
in stile Guerre stellari,
mentre i muri e il
soffitto sono ornati con
“astrazioni
colorate”
proiettate da riflettori
simili a quelli della
20th
Century
Fox
primadeititoliditesta.
All’interno della hall
c’è una lunga serie di
postazionichevendono
piramidi di popcorn.
“Mangiare popcorn fa
parte dell’esperienza
dell’andare al cinema,”
commenta il manager.
Poi aggiunge: “Contro
ogni attesa, il segreto
del nostro successo è
dato da due cose che
poco hanno a che fare
con il cinema in senso
stretto:
l’aria
condizionata
e
la
sicurezza”.Questoèun
luogo sicuro per i
giovani e per le
famiglie
–
fattore
decisivoperilsuccesso
dei multisala in tutto il
mondo, dall’Egitto al
Brasile, dal Venezuela
agli
Stati
Uniti.
Naturalmente anche la
programmazione
è
importante
ed
è
pianificata secondo un
sottile
compromesso
tra
proiezione
di
commedieegizianeedi
film
commerciali
americani. “Anche se i
giovani,
in
realtà,
vogliono vedere solo
film
americani,”
constata Mohammed
Ali.
Paradise 24 è un
altro multisala in stile
tempio egiziano. Ha
aperto da poco i
battenti,ècompostoda
ventiquattro sale e
somiglia anch’esso a
una piramide, con
tanto di colonne e
geroglifici. È stato
concepito
secondo
quello che oggi si
chiama
“theming”,
ovvero la pratica di
dare un’ambientazione
a
uno
spazio
commercialeattraverso
un trionfo di stereotipi
cherealizzanounluogo
immaginario. Questo
tempio egiziano si
trova
a
Davie,
sull’Interstate 75, in
Florida, negli Stati
Uniti. Nel corso del
2010 verrà inaugurato
un
altro
grande
multisala: il cinema
Muvico, all’interno di
un centro commerciale
del New Jersey, il più
grande
multisala
americano in assoluto,
anch’esso decorato in
stileegiziano.
Per
comprendere
l’intrattenimento e la
cultura di massa negli
Stati Uniti – ma anche
nelrestodelmondo–è
necessarioripercorrere
le tappe più importanti
della
grande
rivoluzione che ha
portato dal drive-in al
multisala, dal suburb
all’exurb, dai popcorn
alla
Coca-Cola.
Si
tratta
di
una
rivoluzione tutta a
stelle
e
strisce,
cominciata nel cuore
dell’America
mainstream.
Dal
drive-in
multisala
al
Negli Stati Uniti,
primadeimultisala(ne
ho visitati oltre un
centinaio
in
trentacinque
stati)
c’erano
i
drive-in,
frutto di un’idea, tanto
geniale
quanto
duratura, di aprire un
cinema sullo spiazzo di
unparcheggio.
Oggi, negli Stati
Uniti, i drive-in non
esistono quasi più. Ne
ho
visti
alcuni,
abbandonati,
trasformati
in
mercatini delle pulci
delladomenica,oppure
aperti solo in estate a
San Francisco, a Los
AngeleseinArizona.Il
primo drive-in è stato
inaugurato nel 1933
nel New Jersey, nel
1945 se ne contavano
meno di cento, ma
pochi anni dopo erano
quattromila. Nel corso
degli anni ottanta sono
scomparsi quasi tutti.
Cosa
ha
dunque
portato alla fine del
fenomeno del drive-in,
che costituisce una
delle matrici della
cultura
di
massa
americana
del
dopoguerra?
Scottsdale, Arizona.
In questa periferia di
Phoenix, ancora oggi
esiste lo Scottsdale
Drive-in, dotato di sei
schermi a cielo aperto.
È stato realizzato nel
1977 e inizialmente si
chiamava
“Desert
Drive-in”, poiché si
trovava nel deserto.
Oggi,
invece,
è
all’interno del tessuto
urbano e vi si accede
percorrendo una larga
strada a otto corsie
costruita
appositamente per il
drive-in. Le sei “sale”
sono una di fronte
all’altra, occupano un
grande spiazzo che di
giorno
sembra
abbandonato, mentre
di notte è illuminato e
affollatodacentinaiadi
auto. Il drive-in è
aperto
trecentosessantacinque
giorniall’anno,“rainor
shine” (che piova o
faccia bello), mi dice
Ann
Mari,
una
dipendente
dello
Scottsdale
Drive-in.
Può ospitare fino a
1800 auto. “Bisogna
venire
con
una
macchina
comoda,
perché si passa la
serata seduti sui sedili
della propria auto,”
precisa Ann Mari.
“Bisogna avere anche
una buona autoradio,
poiché l’audio del film
arriva
direttamente
nell’auto
attraverso
una stazione radio in
frequenza Am. Meglio
avere anche l’aria
condizionata.”
I drive-in ancora
esistenti ai bordi delle
autostrade americane
conservano l’atmosfera
di una volta. Tutti
hanno fluorescenti luci
al neon con colori
vivaci e sono ben
visibili da lontano: il
Rodeo-Drive, a Tucson
inArizona,siriconosce
perlaluminosacowgirl
che fa ruotare il lazo
per aria; il New Moon
Drive, a Lake Charles
in Louisiana, per una
luna fluorescente in
cielo; il Campus Drive
di San Diego per una
fiammeggiante ragazza
pon-pon.
Nel 1956, negli Stati
Uniti, c’erano oltre
quattromila
drivein
che,
peraltro,
vendevano più biglietti
deicinematradizionali.
Il drive-in era un
fenomeno giovanile e
stagionale. Il prezzo
d’ingresso era basso:
due dollari per auto,
indipendentemente dal
numero di persone che
c’erano a bordo; poi è
stata introdotta una
quota per ciascun
passeggero(equalcuno
ha
cominciato
a
nascondersi
nei
bagagliai, prima che
venisseroregolarmente
ispezionati).
Con il biglietto si
aveva diritto a due
proiezioni. La qualità
delle immagini era
mediocre, ma era poco
importante:
sullo
schermo si vedevano
belleragazzee,lontano
dai genitori, si poteva
baciare la propria
fidanzata
all’interno
dell’auto. In inglese si
dice: “to ball” – che è
qualcosa di più del
semplice baciare. Il
drive-in ha avuto un
ruolo importante nelle
prime
esperienze
sessuali
degli
adolescentiamericani.
La rapida esplosione
deidrive-inèdovutaal
fatto che sono attività
estremamente
redditizie. Non tanto
per
i
biglietti
d’ingresso
per
assisterealleproiezioni
dei film, ma grazie alle
concessioni
e
al
sistema “pop & corn”
(Coca e popcorn). Gli
americanicomincianoa
prendere l’abitudine di
mangiare al cinema
proprio sui parcheggi
dei drive-in. Di lì a
poco, le auto familiari
si trasformeranno in
veri e propri fast-food
conleruote.
Inoltre, non c’è più
bisogno di badare al
vestito per uscire, al
cinemacisipuòandare
semplicemente
in
jeans. Si può restare
informali, liberi, senza
ghingheri. Ovunque ci
sono colori vivi, jukebox scintillanti, belle
cameriere su pattini a
rotelle vestite in rosa
caramella
o
blu
turchese, il cielo è
solcato da luci al neon
e la serata si chiude
con qualche fuoco
artificiale – questa è la
felicitànell’Americadel
dopoguerra.
Oggi,
mentre
percorro le strade
nordamericane,faticoa
comprendere come i
sogni di cinema delle
classi medie abbiano
potuto passare dalle
grandi sale degli anni
trenta,immensipalazzi
in marmo e con belle
moquette rosse, alle
proiezioni su un muro
di cemento in un
parcheggio
cui
si
assiste all’interno della
propria auto. Ma per
capire è sufficiente
guardarsi
un
po’
meglio
attorno.
I
giovani, le famiglie, la
nuova classe media, in
realtà, non si sono poi
allontanati molto da
quei parcheggi. Con i
nuovi shopping-mall,
gli
americani
continuano ad andare
al
cinema
nei
parcheggi, non più i
drive-in,maimultisala.
Omaha, Nebraska. A
una
trentina
di
chilometri dal centro
città, in mezzo a un
vecchio campo di mais
ha appena aperto un
multisala. Si potrebbe
pensare
che
l’imprenditore
americano
che
ha
costruito
questo
multisala abbia fatto
una pazzia. “Macché
pazzia,
questo
è
business,” mi dice
Colby S., manager del
VillagePointCinema.
I
lavori
di
realizzazione
del
multisala sono stati da
pocoultimati,ilcinema
sorgerà in mezzo a un
immenso
centro
commerciale, il Village
Point Mall, ancora in
costruzione. Mi trovo
in una zona rurale dal
nome
imprecisato:
qualche
settimana
prima non c’era nulla,
solo
mucche.
Per
identificare la zona si
dice
semplicemente
West Omaha. Come
spesso accade nelle
periferie americane, i
centri abitati sono
individuati con i punti
cardinali, con il nome
dell’autostrada vicina
oppure, molto spesso,
con il nome del
principale
centro
commerciale
di
riferimento.
Non è un caso che i
promotori immobiliari
abbiano voluto creare
Village Point Mall in
questo posto lontano e
“alla fine della città”,
sanno
infatti
che
Omaha
si
estende
verso
ovest.
Le
autostrade non sono
ancorastateterminate,
i semafori ancora non
esistono, ma è già
chiarocheprestoquici
vivranno centinaia di
migliaia di persone. A
dominare il centro
commerciale c’è il
multisala. È il cinema
che “fa la città”: dà
queltocco“culturale”a
questo
spazio.
Il
multisala
significa
l’avventodellacittà.
In questo grandioso
multisala si respira
un’atmosfera
piacevole,glispettatori
sonoindirizzativersole
sale attraverso linee
sul pavimento, un po’
come negli aeroporti.
“La
cosa
più
importante,”
spiega
Colby, sono le toilette
“in particolare per le
famiglie e le persone
anziane.”
Ci
sono
infatti
numerosi
e
spaziosibagni,comein
tutti i multisala. Il
numero
è
stato
scientemente calcolato
secondopreciseregole.
“È necessario in media
un
gabinetto
per
quarantacinque donne
presenti nel cinema,”
mi spiega il manager.
Due belle scale mobili
conducono
gli
spettatori verso le sale
dei piani superiori e,
allafinedellaserata,la
loro
direzione
è
invertita,
così
il
pubblico
può
comodamente dirigersi
versol’uscita.
Come
dappertutto
negliStatiUniti,lesale
sono
organizzate
secondo il cosiddetto
modello
dello
“stadium”, con una
forte pendenza in cui
ogni settore è più
elevato rispetto al
precedente in modo da
offrire
una
vista
perfetta in ogni ordine
di posti. I posti a
sedere sono larghi, i
corridoi spaziosi. Il
multisalaècompostodi
sedici
sale
da
ottantotto a trecento
posti.
Da dove nasce l’idea
di fare un cinema con
diversesale?Èforseun
modo per favorire una
programmazione
diversificataeproporre
nel contempo film di
successo e film di
nicchia? Colby: “Nulla
di
tutto
ciò.
Semplicementepernon
lasciarci
sfuggire
neanche un teenager”.
Qui i film commerciali
e di successo, i
blockbuster,
sono
proiettati in diverse
sale in contemporanea:
“nelle ore di punta” le
proiezioni cominciano
ogni quindici minuti,
prima di venire al
cinema non è neanche
più
necessario
consultare gli orari.
Per ogni spettacolo ci
sono1300persone,che
vuol dire 7000 persone
al giorno. Qui gli
spettatori sono tutti al
caldo e in tutta
sicurezza: all’ingresso
del
multisala
c’è,
infatti, un cartello che
ricorda che è vietato
introdurviarmi.
La programmazione
del multisala di Omaha
è
tipicamente
mainstream – SpiderMan 3, Shrek 2, Gli
incredibili, Io, Robot,
mentre si punta poco
suifilmrated,vietatiai
minori di tredici o
diciassette anni. Anche
il sabato non ci sono
proiezioni dopo le
ventidue. Le famiglie
rappresentano
una
parte importante del
pubblico, tra cui anche
un 30 per cento di
anziani.
La
programmazione non
prevede film stranieri
sottotitolati:“Leggerei
sottotitoli
significa
chiedere di fare uno
sforzo. Qui il pubblico
viene per divertirsi e
non per tornare a
scuola”, mi spiega il
manager.
Il
ragionamento sembra
logico.
Perché il multisala
collocato nel cuore del
centro commerciale è
diventatoilsimboloper
eccellenza
dell’esperienza
del
cinema negli Stati
Uniti, e ben presto in
tutto il mondo? I
gestori delle sale e i
distributori americani
sono stati lungimiranti
ehannocapitoprimadi
altri che il centro
commerciale
è
diventatoilcentrodelle
periferie
americane.
Ha preso il posto della
famosa main street
delle piccole città e di
downtowndellegrandi.
Nel 1945, negli Stati
Uniti esistevano 8 di
quelli che all’epoca si
chiamavano “shopping
center”,nel1958erano
3000, nel 1963 erano
oltre 7000, nel 1980
erano 22.000 e oggi
sonooltre45.000.
Quando, nel corso
degli anni settanta, si
sono resi conto che
negli Stati Uniti si
apriva in media un
nuovo
centro
commerciale
ogni
quattro
giorni,
i
proprietari di General
Cinema,
American
Multi-Cinema e poi di
Cineplex-Odeon – i tre
inventori del multisala
– hanno capito che
dovevano aprire i loro
cinema in periferia e
non più in città. Il
multisala rappresenta,
nel
contempo,
un
cambiamento
di
posizione geografica e
unmutamentodiordini
di grandezza. Il primo
cinema con due sale è
nato nel 1963 (il
Parkaway Twin in un
centro commerciale di
Kansas City, creato da
General Cinema). Nel
1966 aprono le quattro
sale del Metro Plaza
Complex (sempre a
Kansas City, creato dal
concorrente American
Multi-Cinema,
detta
Amc). Nel 1969, nasce
il “sixplex” a Omaha,
poièlavoltadelprimo
“eightplex”, nel 1974,
ad
Atlanta.
Aumentando il numero
delle sale all’interno di
uno stesso cinema di
periferia, gli inventori
del multisala, in realtà,
non inventano nulla:
riutilizzano
semplicemente
una
formula di successo,
quella dei vicini centri
commerciali,
che
ospitano i negozi e i
fast-food delle diverse
catene per soddisfare
tutti
i
gusti
del
pubblico. Ben presto
Amc, che nel 1972
possiede già 160 sale,
inaugura la pratica di
dare il nome del
cinema con il numero
delle sale, criterio oggi
ormai
generalizzato
(Empire-4, Midland-3,
Brywood-6). Alla fine
degli anni settanta,
questo gruppo estende
ulteriormente
il
concetto di multisala
con impianti dotati di
10, 12 e addirittura 14
sale, spesso collocate
nel
sottosuolo,
separate
semplicementedamuri
in cartongesso (con il
triste effetto di seguire
i dialoghi di Io e Annie
con in sottofondo la
musica
di
Guerre
stellari). Il multisala è
moderno,
efficace,
vicino al posto in cui
vivono gli americani e,
fattointeressante,èun
fenomeno che negli
Stati Uniti è sempre
stato valorizzato, sia
dalla stampa sia dal
mondo di Hollywood,
che ha considerato lo
sviluppo
di
questi
complessi come un
alleato e non come un
nemico del cinema.
Siamobenlontanidalle
critiche formulate in
Europa sull’uniformità
delle periferie e sulla
deculturalizzazione
prodotta dai multisala
all’interno dei centri
commerciali.
Ma
questo
successo
popolare
doveva
ancora trovare il suo
modelloeconomico.
Quando sono i popcorn
afarvivereicinema
Alcivico401diSouth
Avenue a Bloomington,
diciotto chilometri a
sud di Minneapolis, si
trova l’Amc Mall of
America 14. Mall of
America è stato aperto
nel 1992, ha 520
negozi, 50 ristoranti e
12.000 posti auto ed è
uno
dei
centri
commerciali più grandi
almondo.Perquestolo
si chiama “megamall”
(con
i
relativi
“megacasini” dovuti al
ritardo dell’avvio delle
attività).Èunimmenso
rettangolo,
piuttosto
brutto, di tre piani. Al
centro c’è un immenso
parco
d’attrazione
interamente
coperto
con le giostre e una
ruotapanoramica.Ogni
anno, è meta per 40
milioni di persone, in
gran parte ovviamente
clienti e consumatori,
macisonoanchemolti
turistiattrattidallasua
grandezza e dal suo
valore storico, come
quando si va a visitare
ilLouvreolePiramidi.
Rispetto
alle
dimensioni del centro
commerciale, il suo
multisala,l’AmcMallof
America 14, appare
piuttosto modesto. Qui
Avatar può essere
proiettatosoloventidue
voltealgiorno(davvero
poco
rispetto
alle
quaranta
proiezioni
giornaliere disponibili
all’Amc Empire 25 a
Times Square, New
York).Questoimpianto,
tuttavia,
appartiene
alla nuova generazione
di multisala ideata
neglianniottantadalla
retecanadeseCineplex
Odeon:
un’efficace
combinazione tra il
numero di schermi dei
multisala di prima
generazioneelegrandi
dimensioni dei palazzi
che
ospitavano
i
cinema prima della
guerra. Le sale sono
più
grandi,
sono
collocatesupiùpianie
non
ricavate
nei
sotterranei
come
avveniva
in
precedenza; ci sono
grandi vetrate che
permettono di vedere
la città-periferia che si
estendeall’infinito.
Contrariamente
a
quanto
fanno
i
responsabili delle case
di
produzione
di
Hollywood,chetalvolta
si assumono rischi
incredibili, i gestori
delle
sale
cinematografiche
sanno perfettamente
cosa
devono
fare:
sannocheillorolavoro
èvenderepopcorn.
L’arrivo dei popcorn
nei cinema americani
risale
alla
Grande
depressione del 1929.
In
quest’epoca
di
recessione nazionale, i
proprietari delle sale
cinematografiche,
spesso
ancora
indipendenti, sono alla
ricerca di nuove forme
diincasso.Lasoluzione
sta nelle abitudini del
pubblico che, prima di
vedere
un
film,
acquista dolciumi e
caramelleaibaracchini
eaichioschinellazona
attornoalcinema.Così
i gestori decidono di
cominciare a vendere
caramelle e bottiglie di
Coca-Coladirettamente
alle casse. È una
scommessa,
ma
il
pubblico reagisce a
meraviglia.
Un prodotto magico
comeipopcorndiventa
popolare nel corso
degli anni trenta. Il
vantaggio offerto dai
popcorn è duplice:
facile da produrre e
con
costi
minimi
rispetto ai guadagni
poiché il 90 per cento
dell’incasso è puro
guadagno. Per questo i
drive-in
e
poi
i
multisala costruiscono
la
propria
fortuna
attorno ai popcorn. I
cinema cominciano a
comprare
mais
all’ingrosso,
direttamente
dalle
industrie
agroalimentari addette alla
raffinazione.
In
commercio si trovano
buone
macchine
automatiche per la
produzione di popcorn.
Nel
contempo
l’industria del mais,
concentrata
nel
Midwest, si sviluppa e
aumenta la propria
produzione di venti
volte tra il 1934 e il
1940. Gli Stati Uniti
diventano,
e
sono
tuttora,
il
primo
produttore mondiale di
mais. La lobby del
“corn” getta radici al
Congresso
a
Washington
ed
è
sostenutadalministero
dell’Agricoltura e da
quello della Guerra. In
breve
tempo
il
granoturco invade tutti
i prodotti, spesso sotto
forma di corn syrup e,
a partire dagli anni
settanta,
di
high
fructuose corn syrup
(una sorta di sciroppo
zuccherato di mais che
contiene più fruttosio
rispetto allo zucchero
di canna). È contenuto
negli
yogurt,
nei
biscotti, nel ketchup,
nel pane per hot-dog e
hamburger
e
ovviamente nella Coca-
ColaenellaPepsi.Èun
vero fiore all’occhiello
dell’agricoltura
nazionale americana e
ogni tentativo, secondo
ragioni
ecologiche,
sanitarie o dietetiche,
di limitare l’invasione
degli zuccheri del mais
e dei derivati del
“corn” si è infranto
contro i costi ridotti di
questa produzione e
contro la potenza della
lobby del granoturco.
Tutto ciò nonostante
sia dimostrato che il
corn syrup e l’high
fructuose corn syrup
siano tra i fattori
aggravanti dell’obesità
della
popolazione
americana.
Negli anni cinquanta
l’agro-business
del
mais individua nelle
sale cinematografiche
un potenziale sbocco
persmaltireglieccessi
di
produzione.
Comincia
allora
un’offensiva
commerciale verso i
gestori dei cinema che
vengono incentivati a
venderepiùpopcornin
cambio di campagne
pubblicitarie
fatte
apposta per le loro
sale. Si tratta in realtà
di
campagne
per
promuovereipopcorn.
Se erano già diffusi
nei
drive-in,
nei
multisala i popcorn
diventano la regola. I
banconi dove si fa la
vendita diventano più
grandi,
aumentano
anche le porzioni – e
ovviamente i prezzi.
Uno dei manager di
Amc Mall of America
14, che ho intervistato
a
Minneapolis,
mi
spiega
che
la
redditività del cinema
non è data tanto dai
biglietti d’ingresso, ma
soprattutto
dalle
concessioni,
i
cui
introiti
vanno
totalmente al gestore.
Secondo i suoi calcoli
ogni spettatore spende
in media due dollari in
popcorn.
“I
film
d’azione
ne
fanno
vendere più porzioni,”
dice. Il 90 per cento
degli incassi si fa
all’inizio del film, il 10
per cento durante il
filmedènulloallafine.
“Gli spettatori non
consumanomaiquando
vanno
via,”
dice
dispiaciutoilmanager.
Una delle principali
reti
di
multisala,
Cineplex
Odeon,
acquisirà a breve una
marca di popcorn,
Kernels
Popcorn
Limited. In questo
modo potrà vendere i
propri popcorn nei
propri cinema e gli
incassi saranno ancora
maggiori.Comemidice
una
dipendente
dell’Amc
Mall
of
America 14, quasi sul
tono della battuta: “Il
proprietario
di
un
cinema deve anzitutto
individuare una buona
posizioneperlavendita
dei popcorn, poi ci
costruisce attorno il
multisala”.
Dalsuburball’exurb
Edwards
Metro
Pointe
12,
posto
all’incrocio
tra
le
autostrade 405 e 55, è
un tipico multisala del
gruppo
Regal
Entertainment.Siamoa
Orange County, a sud-
est di Los Angeles, tra
il
Pacifico
e
le
montagne di Santa
Ana, in quello che oggi
negli Stati Uniti si
chiama exurb (termine
che deriva da “extraurbia”, si parla anche
di
fenomeno
dell’exurbia).L’exurb è
la città all’infinito, la
città che continua a
estendersi. In questi
luoghi, non lontano
dalle autostrade a
diciottocorsiepostesu
più
livelli
che
disegnano anelli nel
cielo, ci sono le chiavi
del successo della
cultura
di
massa
americana.
In
origine
c’era
anzitutto il suburb, la
periferia. Tra il 1950 e
il 1970 la popolazione
delle città americane è
aumentata di dieci
milioni di abitanti, le
periferie
di
ottantacinque milioni.
È sufficiente sfogliare
le pagine dei vecchi
numeri della rivista
“Life”
per
avere
un’idea di quanto il
suburb fosse una delle
massime
aspirazioni
della classe media
americana degli anni
cinquanta: lavatrici di
grosse
dimensioni,
frigoriferi giganti e
passeggini per due e
addirittura tre gemelli,
prati
verdi
impeccabilmente
rifiniti. Questi sono gli
anni in cui nasce il fai
date,èl’epocaincuile
famiglie
trasportano
cucine
componibili
interamente
da
montare sul tetto di
piccoleFord,primache
Home Depot cominci a
trasformare i suburbs
in immensi empori
permanenti. I genitori
sognano famiglie con
due o tre figli (con il
baby boom, invece, ne
avranno quattro o
cinque). All’interno di
questi nuovi spazi si
vive
anche
una
dimensione
comunitaria attraverso
lo sport, le scuole e le
chiese.Certo,ilsuburb
nonènéunkolkotz,né
un kibbutz, ma evoca
ancora qualcosa di
vagamente“socialista”,
che scompare poi con
l’exurb.
Per i gestori dei
cinema il suburb è
stato il grande affare
degli anni cinquanta,
grazie
ai
drive-in,
mentrel’exurbèquello
dell’America
contemporanea, grazie
ai multisala. Il suburb
era il primo anello
periferico
costruito
attorno alle città, che
continuava a essere il
polo d’attrazione. Le
persone continuavano
ad andare nel centro
dellacittàperlavorare,
per
andare
al
ristoranteealcinemae
poi
tornavano
in
periferia la sera. Il
suburb era la città-
dormitorio. L’elemento
di novità dell’exurb, e
in un certo senso
l’elemento strutturale
che
lo
contraddistingue, sta
nello spostamento del
mercato del lavoro.
Nell’exurb,
diversamente
dal
suburb,gliamericanici
vivono e ci lavorano. E
naturalmente
ci
passano anche il loro
tempo
libero.
Per
questo allo sviluppo
degli
exurbs
corrisponde anche la
progressiva apertura
delle
sale
cinematografiche.
Questo fenomeno è
cominciato negli anni
quaranta,
si
è
ulteriormente
accentuato negli anni
settanta
e
si
è
definitivamente diffuso
negli anni ottanta e
novanta grazie alle
nuove tecnologie che
hanno accelerato e
semplificato
le
comunicazioni. È il
modellodiLosAngeles:
la città, invece di
crescere in altezza,
come New York, dove
lo spazio era limitato,
siestendeesisviluppa
in
larghezza.
Generalmente, l’exurb
nasce lontano dalla
città, all’incrocio tra
due autostrade, una in
direzione
nord-sud
(sempre indicata con
un numero dispari
negli Stati Uniti) e
l’altra
est-ovest
(numero
pari).
Ovunque, a Phoenix,
Denver,
Houston,
Miami, Dallas, Austin,
Atlanta, ho visto città
distesepercentinaiadi
chilometri
e
pluricentriche. Spesso
mi
sono
sembrati
luoghi completamente
uniformi e tutti uguali:
gli stessi magazzini
culturali (Barnes &
Noble, Borders, Hmv,
Blockbuster), le stesse
marche (Sears, Kmart,
Saks,
Macy,
Gap,
Banana
Republic),
spesso le stesse catene
di ristorazione per un
pubblico di massa
(BurgerKing,Popeye’s,
McDonald’s, Wendy’s,
Subway, The CheeseCake Factory e le tre
cateneinfranchisingdi
Pepsi-Cola: Kentucky
Fried Chicken, Taco
Bell e Pizza Hut).
Naturalmente,
quasi
ovunquehovistoluoghi
perfettamente identici,
i caffè Starbucks e i
supermercati
Wal-
Mart.
Uniformità,
automobile e centri
commerciali: l’America
credeva di avere una
grande eterogeneità e
si
riscopre
invece
uniforme.
Questa
apparente
omogeneità nasconde
tuttavia
realtà
sorprendenti.
Negli
exurbs ho trovato,
infatti, tutto e il
contrario di tutto:
librerie
giapponesi,
studi dentistici per
lesbiche, teatri latinoamericani, negozi di
sandali
tunisini
e
ceramiche
africane,
lavanderie cinesi che
fanno pubblicità in
mandarino, un Trader
Joe’s per vegetariani,
un
fast-food
che
propone ovviamente il
“Usa n. 1 Donuts”, un
negozio di dvd di
Bollywood e ristoranti
con piatti di carne
kosher o halal. Ho
trovato più diversità di
quanta se ne possa
immaginare,
meno
conformismo,
mediocrità culturale e
omogeneità di quanto
dicano gli intellettuali
newyorkesi che, dagli
anni cinquanta, hanno
cominciato
a
considerare prima il
suburb, poi l’exurb
come il responsabile di
tutti i mali. Oggi,
ormai, le città con più
schermi
cinematografici
per
numero d’abitanti non
sono più New York e
Boston, ma Grand
Forks (Dakota del
Nord), KilleenTemple
(Texas) e Des Moines
(Iowa). Ovvero, degli
exurbs.
Quando si arriva ad
Atlanta,peresempio,la
città di Coca-Cola e
Home
Depot,
percorrendo
l’autostrada I 75, si
attraversano
per
cinquanta
chilometri
exurbs in cui si
succedono multisala,
centri
commerciali,
fast-foodehotelabuon
mercato, poi si arriva
incentrocittà,cheèun
ghetto,
deserto,
abbandonato
e
a
maggioranza
nera
(Martin Luther King è
natoesepoltoqui).Nel
corso
degli
anni
novanta, Atlanta ha
avutounincrementodi
popolazione di 22.000
abitanti,ilsuoexurbdi
2,1milioni.
Con l’exurb, una
sorta di periferia della
periferia, gli abitanti si
sono trasferiti dalla
prima
cerchia
dei
suburbs alla seconda o
alla terza cerchia, e –
cosa importante – non
passano più per la
città. Ci si allontana e
tutto cambia. Di fronte
alla congestione di
auto, ai problemi di
parcheggioincittà,alla
mancanza di scuole, ai
costi
degli
appartamenti e delle
babysitter, di fronte
all’inquinamento, ma
anche alla droga e alla
violenza, gli americani
sono
scappati
dal
centro città. Sembra
pertinente
l’affermazione
del
filosofo
George
Santayana
quando
diceva: “Gli americani
non risolvono i loro
problemi, se li lasciano
allespalle”.
La nuova frontiera
americana,l’exurb,non
ha più bisogno della
città, non è neanche
più una periferia, ma
una nuova città. Se, di
fatto,ilsuburbrafforza
il bisogno della città e
neaffermanuovamente
la sua supremazia,
l’exurb,
semplicemente,negala
città. Il 90 per cento
degli uffici costruiti
negli Stati Uniti negli
anni
novanta
è
collocato negli exurbs,
soprattutto negli office
parks,
lungo
le
autostrade,enonpiùin
centro.
Anche
la
culturasièinsediatain
queste
lontane
periferie alla Steven
Spielberg:ilmultisalaè
ilcinemadell’exurb.
Coca-Cola
acquisisce
Columbia
A tremila chilometri
daAtlanta,versoovest,
si trova Mesa, in
Arizona. È una città
con mezzo milione di
abitanti, ma è poco
conosciuta. Qui ho
incontrato
Gerry
Fathauer,direttricedel
nuovo centro culturale
della città. Mesa è il
tipicoexurb.Èanchela
terza città dello stato,
dopoPhoenixeTucson.
“Fra dieci anni saremo
laseconda,”pronostica
Gerry Fathauer. Mesa
si espande verso est,
dove c’è il deserto. A
qualche chilometro di
distanza ci sono le
riserve indiane, quelle
degli apache. Fathauer
mi dice: “Mesa è una
città che si sviluppa
alla velocità di un
cavallo al galoppo”. Da
allora
sono
ossessionato da questa
espressione.
“Daunpuntodivista
culturale, siamo stati
spesso accusati di
essere una periferia
constradeampieeuna
mentalità
ristretta,”
prosegue
Gerry
Fathauer.
“Noi
vogliamo
dimostrare
che qui possiamo fare
cultura e anche arte.
Nel contempo, però,
dobbiamo adattarci ai
desideridellacomunità
e ai suoi gusti. Qui a
Mesa c’è una tipica
popolazione da classe
media.Elagentevuole
i multisala.” A Mesa ci
sono tre multisala, tra
cui un immenso Amc
Grand
24,
accortamente collocato
– è diventata ormai
un’abitudine
–
all’incrocio tra due
loops
autostradali,
autostrade
che
somigliano
a
tangenziali attorno alle
città, identificate negli
Stati Uniti con numeri
a tre cifre (qui siamo
all’incrocio
tra
la
Beltway 202 e la
Beltway101).
L’Amc Grand 24, a
duepassidaldeserto,è
a mia insaputa uno
degli
oggetti
del
contendere di una
“guerra”
inimmaginabile,
la
guerraperlaconquista
dell’American
mainstream.
Due
colossi
tradizionalmente
nemicicomeCoca-Cola
e
PepsiCola
si
contendono, infatti, il
controllodeimultisala.
La contesa per il
controllo delle sale
cinematografiche
risale, in realtà, agli
anni cinquanta. Prima
di allora, né Coca né
Pepsi avevano come
obiettivoilmercatodei
giovani: erano ancora
marchi indifferenziati
che si rivolgevano alle
famiglie,
semplicemente
orientati
verso
un
consumo di massa. Del
resto, i palaces, i
grandiosi cinema degli
anni
venti,
non
vendevanobibite.
Nel
dopoguerra,
l’azienda di Atlanta, la
Coca-Cola, avvia per la
prima volta campagne
pubblicitarie
nelle
radio e nelle sale
cinematografiche.
Il
suo obiettivo sono in
particolare i drive-in,
conicelebrispotincui
si vede la coppia felice
seduta
su
un’auto
decappottabile mentre
guarda un film e beve
Coca-Cola. Gli slogan
sono celebri: “Sign of
good taste”, “Be really
refreshed”e“Gobetter
refreshed”. I gestori
dei drive-in stanno al
gioco e istituiscono
l’intervallo tra il primo
e il secondo tempo del
film per poter vendere
più popcorn e Coca.
Queste
campagne
pubblicitarie
sono,
tuttavia,
ancora
generaliste
e
si
rivolgonoatuttiitipidi
pubblico. Il cinema è
ancora uno spazio
pubblicitario come un
altro.
Solo a partire dagli
anni sessanta i giovani
sono considerati una
fascia
di
mercato
fondamentale
per
l’industria delle bibite:
è il momento in cui i
teenager
diventano,
per la prima volta, un
gruppo distinto dagli
altri in termini di
consumi, portatore di
culture
e
codici
specifici.
A
intraprendere questa
nuova strada è Pepsi,
eternosfidante,quando
lancia una delle più
celebri campagne della
storia della pubblicità
americana: la “Pepsi
Generation” (ne Il
maschio e la femmina
di JeanLuc Godard
anche Chantal Goya
affermadifarneparte).
Questa campagna fa
registrare un successo
incredibile
(“Come
alive! You’re the Pepsi
Generation”, 1963) e
celebra lo spirito della
gioventù che si ribella
contro l’establishment
(rappresentato
ovviamente da CocaCola). Sul piano del
marketing,
questa
campagna
va
in
controtendenza
rispettoaunastrategia
di massa e introduce
l’idea di rivolgersi a
mercati specifici, nella
fattispecie i giovani e i
modi di vita dei
teenager (“Now it’s
Pepsi, for those who
thinkyoung,”1961).La
cosafunziona.
La campagna Pepsi
Generation inonda le
nuove
emittenti
radiofoniche
e
i
cinema. Di lì a poco
Pepsi
differenzia
ulteriormente i propri
spot e decide di
puntare sui giovani
neri, si moltiplica così
l’effetto della “Pepsi
Generation”associando
la bibita, proprio nel
momentoincuilacasa
discografica Motown
diventa celebre per la
musica
pop
nera,
all’idea di “hip” e di
“cool”.
Coca-Cola
non
risponde
immediatamente alla
nuova strategia di
Pepsi, resta assestata
sull’idea di un mercato
generalista, teme di
lanciarsi in campagne
pubblicitarie
mirate
per paura di perdere il
mercato di massa.
Decidepoidigiocarela
carta dell’autenticità
del suo marchio contro
Pepsi, implicitamente
accusata di essere una
bibita
usurpatrice.
(“It’s the real thing”,
1969; “Can’t beat the
real
thing”,
1990;
“Always
Coca-Cola”,
1993). Nel multisala di
Mesa, attorno a me, i
muri
sono
letteralmente invasi da
manifesti con lo slogan
“CocaColaReal”.
Sullo sfondo della
battaglia tra Pepsi e
Coca ci sono accordi
realizzati in esclusiva
con le società che
gestiscono
le
sale
cinematografiche.
A
condizione che Pepsi o
Coca diventi la “bibita
ufficiale”all’internodei
multisala,
queste
società riescono ad
avere
accordi
pubblicitari stimati in
milioni di dollari e
riduzioni
importanti
sull’acquisto di altri
prodotti delle due
multinazionali (Coca-
Cola controlla anche i
marchi Fanta, Sprite,
Minute Maid, Canada
Dry, Schweppes e
l’acqua Dasani, mentre
Pepsi-Cola
controlla
PepsiOne,PepsiTwist,
Tropicana, Slice e
l’acqua Aquafina). A
Mesa c’è dunque un
multisala che vende
solo Coca e l’altro solo
Pepsi
(tra
le
autostrade,
anche
servendomi
di
un
navigatore satellitare
nonsonomairiuscitoa
trovare
il
terzo
multisala).
IlconfrontotraPepsi
eCoca-Colahasegnato
la storia degli Stati
Uniti – e naturalmente
anche
quella
di
Hollywood.Labattaglia
si è giocata sulle
dimensioni e sulla
forma delle bottiglie
delle due bibite, sul
prezzo(Pepsisirivolge
sempre a un pubblico
più popolare e con
prezzi più bassi), sulle
lattine in metallo e poi
in polietilene, oppure
sul gusto nuovo contro
quello classico. È una
guerra che si inserisce
nel
già
indicato
scenario del mais: i
gestori dei drive-in
erano già abituati a
mettere molto del
cosiddetto
"sale
Morton" nei popcorn
per far aumentare la
sete – e dunque
incentivare il consumo
di bibite. I gestori dei
multisala
fanno
addirittura
meglio:
aggiungono ai popcorn
il
famoso
golden
flavored butter, un
burro salato versato
caldo, dal forte odore,
in
grado
di
far
aumentare ancora di
piùlasete.Labattaglia
si è giocata anche sul
terreno delle bibite
dietetiche,PepsiDiete
poi
Diet
Coke
(CocaCola Light in
Europa). Ovviamente
anche i cinema sono
coinvoltinellestrategie
di marketing delle due
multinazionali e in
breve
tempo
la
battaglia
coinvolge
anche le star. La
campagna “Pepsi, the
choice of a new
generation” è fatta con
duecelebrivideoclipdi
Michael Jackson nel
1984. Poi è la volta di
Lionel Richie e Tina
Turnernel1985,diRay
Charlesnel1990(“You
got the right one baby,
uh-huh!”) e di Aretha
Franklin nel 1999,
sempre in stile pop,
black e giovane. Le
campagnepubblicitarie
al cinema seguono
tuttequesteevoluzioni.
A partire dagli anni
cinquanta i cinema
sono
diventati
il
terreno
privilegiato
della
storica
concorrenzatraCocae
Pepsi. Il mercato in
gioco è esorbitante se
si pensa che, secondo
alcune stime, oggi,
Coca-Cola vende ogni
giorno, in tutto il
mondo, un miliardo di
pezzi
delle
quattrocentomarchedi
bibite che controlla.
Per rendersi conto fino
a che punto è arrivato
ilpericolosolegametra
Hollywood e Coca-Cola
(che con un gioco di
parole si potrebbe
definire“soda-maso”)è
sufficiente
ricordare
che il marchio di
Atlantahaacquisitonel
1982
gli
studios
Columbia,poirivenduti
a Sony. Nello stesso
tempo Pepsi è stata
proprietaria
per
qualche
tempo
di
Universal. In entrambi
i casi si è trattato di
operazioni difficili che
non hanno dato i
risultatisperati.Lereti
di distribuzione hanno
fatto
invece
un
percorso
inverso:
General
Cinema,
colosso
con
oltre
quattrocento schermi
di multisala prima di
essere acquisita da
Amc nel 2002, ha
diversificato la propria
attività lanciandosi fin
dal
1968
nel
commercio di bibite e
aprendo industrie di
imbottigliamento per
Pepsi-Cola.
Dal
secondo dopoguerra in
poi,
il
cinema
americano vive dunque
astrettocontattoconil
mercato delle bibite.
Stranodestino!
I multisala, come gli
exurbs,
non
sono
tuttavia
fenomeni
limitati agli Stati Uniti.
In Cina, nel 2010, si
inaugura in media un
nuovo schermo da
multisala al giorno. In
Messico, solo la rete
Cinepolis
ha
inaugurato nel 2008
trecentonuovischermi.
In India, grazie a
incentivi fiscali del
governo, il numero
degli
schermi
di
multisala
dovrebbe
passare da 700 a 4000
tra il 2008 e il 2010
(per il momento le
12.000 sale principali
sono ancora cinema
tradizionali, dotati di
un solo schermo per i
grandi
film
di
Bollywood).InEgittosi
costruiscono numerosi
multisala
nelle
periferie delle due
principali grandi città,
Il Cairo e Alessandria.
È inoltre probabile,
secondo i distributori
locali, che il numero
degli
schermi,
attualmente attorno ai
500,possaraddoppiare
nelgirodicinqueanni.
In Brasile, dove il
numerodeglischermiè
ancoralimitatoa2200,
un dato basso per una
popolazione di quasi
duecento milioni di
abitanti, l’aumento dei
multisala è rapido e la
frequentazione
in
rialzo,
grazie
all’accresciuto potere
d’acquisto di questo
paese
emergente.
Ovunque, il numero di
multisala è aumentato:
in Italia con le sale
Warner-Village
(100
per cento Pepsi) e
quelle della rete Uci
(100 per cento Coca),
in Medio Oriente con i
cinema Showtime, a
Singapore con la rete
Cathay,nelQatarconi
Grands Cinecentres, in
Indonesia
con
Blitzmegaplex,
in
Venezuela
con
il
circuito Cinez Unidos,
in
Giappone
con
multisala che in modo
divertente i giapponesi
chiamano
cinema
“complex”.
Il
fenomeno
dei
multisala ha raggiunto
la piena maturazione
nelsuopaesed’origine,
gli Stati Uniti: 40.000
schermi ripartiti in
6300 cinema (di cui
1700 con un solo
schermo, 2200 mini
multisala tra 2 e 7
schermi,
1700
multisala con schermi
tra 8 e 15 e 630 mega
multisala con oltre 16
schermi). Dopo aver
invaso
i
paesi
occidentali
e
industrializzati,
il
fenomeno diventa oggi
internazionale
e,
ovunque, nei paesi
emergenti, come in
quelli del Sud del
mondo, i multisala
modificano
profondamente
le
abitudini
del
divertimento. Sotto il
segno
della
modernizzazione
americana in corso,
l’esperienzadelcinema
si trasforma e diventa,
nel bene e nel male,
intrinsecamente legata
al centro commerciale,
ai popcorn, all’exurb e
almultisala.
3.
GlistudiosDisney
Sette
nani
giganteschi
mi
accolgono
con
le
braccia alzate e grandi
sorrisi.Sononellasede
della
Walt
Disney
Company a Burbank,
exurb a nord di Los
Angeles.
I
nani,
disegnati sulla facciata
principale dell’edificio,
sono più che un
simbolo. È necessario
avere tutte le carte in
regola
per
poter
varcare la soglia del
civico numero 500,
all’estremo sud di
Buena Vista Street, a
fianco dell’autostrada
134.
Gli
studios,
dominati dall’edificio
dell’emittente
Abc,
sono circondati da una
cancellatacompostada
una miriade di stanghe
in ferro su cui sono
fissate immagini di
Topolino. Mi trovo a
Team
Disney,
il
quartier generale della
Disney.
“Qui la regola è lo
spirito di squadra, per
questo l’edificio si
chiama‘TeamDisney’,”
dice
la
mia
accompagnatrice.
A
occuparsi di me è
l’équipe
di
Public
RelationsDepartement,
che gestisce il settore
della comunicazione e
controlla anche i miei
movimenti all’interno
degli studios, sempre
più
limitati.
“Dopotutto,” prosegue
il mio angelo custode,
“Disneynonhasegreti.
È
possibile
fare
qualsiasi
domanda.”
Poi
aggiunge:
“Naturalmente, come
abbiamo convenuto, lei
non può citare il nome
di
nessun
collaboratore”.
Nelquartiergenerale
della Disney, in realtà,
ci sono poche persone:
idirigenti,gliimpiegati
degli
studios,
del
network Abc e della
distribuzione,cheporta
il nome della via in cui
mi trovo, Buena Vista
International, anche se
non sono riuscito a
capire se è Disney ad
aver ribattezzato la
strada, oppure se è la
strada ad aver dato il
nome al settore della
distribuzione
della
major. Con una certa
sorpresa scopro che
per accedere alla torre
di Abc è necessario
percorrere un ponte
che passa al di sopra
dell’autostrada. Sono
ancora più stupito del
fatto che molti degli
edifici
Disney
che
intendo visitare si
trovino al di fuori del
“lot”,cosìèchiamatoil
complessodeglistudios
diHollywood.
All’interno di un
edificio rosso su due
piani, un po’ più
lontano, c’è il celebre
Disney Imagineering.
Qui
lavorano
gli
imagineers di Disney,
gli innovatori, quelli
che creano i nuovi
design e c’è anche la
divisione ricerca e
sviluppo. Qui vengono
“immaginati”
nuovi
personaggi,attrazionie
parate per i parchi,
nuove ambientazioni.
Tutta la progettazione
è fatta in digitale. Le
persone che lavorano
qui hanno funzioni che
mifannosorridere,per
esempio
principal
creative executive e
chief creative officier.
Disney ha da poco
acquisito l’editore di
fumetti Marvel, con
cinquemila personaggi
che vanno da SpiderManaX-Menpassando
per Thor e Iron Man,
questi
imagineers
avrannodicertolavoro
per i prossimi decenni
poiché dovranno far
figurare
questi
supereroi in prodotti
derivati, attrazioni e
serie
di
prodotti
commerciali.
Poco
dopo
ho
appuntamento
con
Anne Hamburger (non
è uno pseudonimo), al
1326diFlowerStreeta
Glendale, non lontano
daTeamDisney.Lascio
l’auto nel parcheggio,
dietrounedificiobludi
un
unico
piano,
talmente discreto che
credo di aver sbagliato
indirizzo.
Anne
Hamburger
è
presidente di Disney
CreativeEntertainment
e si definisce una
“creative
producer”.
Parla con più libertà
rispetto
agli
altri
dirigenti
che
ho
incontrato e accetta di
essere
menzionata,
benché coadiuvata da
una sospettosa addetta
allepubblicherelazioni
(che ha messo un
apparecchio sul tavolo
perregistrarelanostra
conversazione). Anne
Hamburger proviene
dal
teatro
d’avanguardia ed è
stata ingaggiata da
Disney per sviluppare
la
creatività
dell’azienda. Mi fa
visitareilocaliincuisi
possono
vedere
centinaia di disegni,
prove,
modellini,
progetti su computer
che serviranno per gli
spettacoli, e per i
product tie-ins, così
sono chiamati negli
Stati Uniti i prodotti
derivati.
Con stupore scopro
che qui, come in un
vero teatro, si prepara
la maggior parte degli
spettacoli dei parchi
d’attrazione e delle
parate dei “resort” del
tutto compreso (un
resort non è solo un
parco d’attrazione, ma
un luogo di vacanza e
di divertimento in cui
ristoranti e alberghi
diventano la principale
fontediincasso).Quisi
preparano anche gli
spettacoli degli undici
Disney on Ice e per le
quattro
navi
da
crociera Disney con
oltre
mille
posti
ciascuna,
di
cui
ignoravo
completamente
l’esistenza.
Anne Hamburger mi
fa
una
buona
impressione, ha una
parlantina sciolta e sa
sempre mettere le
parole al posto giusto.
“Dirigo il più grande
teatro
degli
Stati
Uniti,” mi dice con
umiltà (avrebbe potuto
dire “del mondo”).
“Con le nostre migliaia
di spettacoli, di parate
e di show, abbiamo un
pubblico di milioni di
personeognimese,non
qualche
decina
di
individui come accade
con
il
teatro
sperimentale. Questa è
una
grande
responsabilità. Il mio
compito
è
sensibilizzare all’arte il
pubblicodimassa.Una
cosa
completamente
diversa rispetto al
teatro sperimentale, in
cui il pubblico era già
interessatoall’arte.”
Lastrategiaculturale
dellaDisneysifocalizza
soprattutto
sul
“crossover”.
Alla
Disney
Creative
Entertainment
si
mescolano
continuamente arte e
cultura di massa. “Il
nostro
obiettivo
è
scompaginare
la
frontiera tra arte e
intrattenimento.
Qui
sono
ideati,
contemporaneamente,
veri spettacoli teatrali,
parate, spettacoli di
marionette,
fuochi
artificiali ed eventi
larger
than
life.”
“Largerthanlife”èuna
bellissima espressione
che ben sintetizza il
lavoro
di
Anne
Hamburger:
ideare
singoli
personaggi
capaci di andare oltre,
essere attraenti per
diversefasced’etàein
diversipaesieingrado
di diventare universali
emainstream.
“Nello stesso tempo,
tuttavia,
il
nostro
compitoèesseremolto
site specific,” precisa
Hamburger.
“Ogni
spettacolo, infatti, è
rappresentato in un
paese diverso, come
Giappone,
Cina,
Francia:
dobbiamo
dunque adattarci a
culture molto diverse
tra loro. A Hong Kong,
i nostri ‘ospiti’ parlano
trelinguediverseedal
momento che con i
bambini i sottotitoli
non
funzionano,
cerchiamo
di
fare
spettacoli
senza
parole.” Alla Disney
nonsidicemaiclientio
consumatori:siparladi
guests(ospiti)comeBe
our guest, la celebre
canzone del film La
BellaelaBestia.
Grazie
ad
Anne
Hamburger
posso
visitare
l’avamposto
della creazione del più
grande
teatro
del
mondo e scopro in
esclusiva che Nemo
verrà completamente
riadattato per farne
una
commedia
musicale nei parchi
d’attrazione e che Toy
Story
durerà
solo
cinquantacinqueminuti
nella versione per le
crociere (contro le due
ore del film). Anne
Hamburger dirige una
squadra di trentasei
creatori e produttori
che
coordinano
l’insieme
delle
operazioni.
Ogni
progetto implica il
coinvolgimento
di
centinaia di persone
(assunteconcontrattia
tempo
determinato)
che
preparano
gli
spettacoli. Una volta
pronti, gli spettacoli
sono rappresentati in
tutto il mondo, con
migliaia
di
artisti
reclutati in loco. Il
numero di persone è
davvero elevato poiché
le
diverse
équipe
devono garantire una
decina
di
rappresentazioni
al
giorno, sette giorni su
sette,perdiversiannie
naturalmente ci sono
anchegliunderstudies,
i sostituti in caso di
malattia o di assenza.
“Diamo
lavoro
a
migliaia di artisti che
possono così essere
occupati
a
tempo
pieno. Siamo uno dei
principali datori di
lavoro per gli attori
negli
Stati
Uniti,”
sottolinea
la
mia
interlocutrice.
Nella
nostra
conversazione
il
terminechericorrepiù
spesso è “creazione”.
Anne Hamburger fa
capo al Cco (Chief
creative officer) di
Disney Imagineering e,
come mi continua a
ripetere,ilsuolavoroè
produrre
creative
entertainment.
Il principio attorno a
cui
si
struttura
commercialmente
Disney è quello del
media franchise, che
consiste nello sfruttare
un film per realizzare
diversi tipi di prodotti.
I film Disney sono
utilizzati per produrre
nuovi prodotti secondo
un ordine piuttosto
immutabile: anzitutto
c’è la parata, dove
vengono introdotti e
presentati al pubblico i
nuovi personaggi, poi
ci sono le commedie
musicali, infine gli
spettacoli per le navi
da crociera. “La invito
avedereunodeinostri
spettacoli,” mi dice
improvvisamente Anne
Hamburger.
Avrei
dovuto pensarci prima.
Dovevo
per
forza
vedereunospettacolo.
A un’ora di strada a
sud-est di Los Angeles,
due
giorni
dopo,
incontro
John
McClintock, direttore
delle
pubbliche
relazioni del parco
Disney di Anaheim.
Qui,il17luglio1955,è
stato aperto il primo
parco a tema Disney,
nell’immenso exurb di
Orange
County.
Insieme
a
John,
piacevole
senior
publicist,
visito
il
parco:
l’inevitabile
main street Usa, gli
spazi
Frontierland,
Adventurland
e
Tomorrowland,
la
giungla, il battello a
vapore“MarkTwain”a
grandezzanaturaleche
naviga su un fiume
artificiale, mentre uno
strabiliante
pupazzo
che raffigura Abramo
Lincoln
proclama,
parlando
e
gesticolando, i valori
della
democrazia
costituzionale.
Arriviamo poi al
luogo dello spettacolo.
Oggi,
all’Hyperion
Theatre,
è
in
programma
Aladino.
John è sempre al mio
fianco.Glichiedoseha
già visto lo spettacolo.
“Sì, una decina di
volte.” Resto stupito.
Mi dice che questo
spettacolo gli piace
davvero ed è felice di
poterlo vedere insieme
a un francese. “E poi,
c’è
molta
improvvisazione,
dunque ogni volta è
diverso.” Insieme a noi
ci
sono
duemila
bambini che assistono
allospettacolo“live”di
quarantacinque minuti.
Tra le file degli
spettatori
spuntano
cammelli e tappeti che
volano
davvero.
Aladino è sorridente,
magnifico. È un attore
asiatico, poiché Disney
ha una politica di
assunzioni
intenzionalmente
rivolta alla diversità.
All’improvvisocompare
una torre Eiffel, poi
una piramide egiziana.
Inaspettatamente,
Aladino pronuncia il
termine “MySpace”. “È
una
novità,”
mi
sussurra
John
all’orecchio, “di solito
non parla di MySpace.
Per questo adoro lo
spettacolo,ognivoltaè
diverso.”
Quando ci si trova a
Disneyland, nel grande
exurb di Anaheim, si
afferra
immediatamente
il
significato del termine
“sinergie”: si trova
Aladino sotto forma di
commediamusicale,Re
Leone proiettato su
uno
schermo,
Ratatouille
nella
caffetteria,Toy Story e
Gli incredibili nella
parata,
Pirati
dei
Caraibi in cd, Grey’s
Anatomy in dvd, Nemo
ingioco,CarsalDisney
Store e ovunque ci
sono pubblicità dei
prossimi film Disney,
Miramax
e
Pixar.
Questa
filosofia
continua
anche
al
parcheggio: ho lasciato
lamiaautoalPippo8F
(ho
evitato
Simba
Parking e Pinocchio
Parking Lot, erano
troppo lontani). “I
prodotti derivati, gli
alberghi e i ristoranti
rappresentano la parte
fondamentale
degli
incassi del parco,” mi
confermaRobert(detto
Bob)
Fitzpatrick,
fondatore
ed
ex
amministratore
delegatodiEurodisney,
che ho intervistato a
Chicago. Mi comunica
anche che i parchi e i
resort hanno fruttato
alla Disney, l’anno
scorso, 10,6 miliardi di
dollari.
Anche Robert Iger ci
tiene a farsi chiamare
“Bob”(negliStatiUniti
è un diminutivo molto
diffuso);èunmodoche
gli permette di dare di
sé
un’immagine
informale.
Ho
appuntamento con lui
per un pranzo veloce
all’Hotel George V di
Parigi,inoccasionedel
lanciodiReLeone – in
versione
commedia
musicale di Broadway,
che ha raddoppiato i
già
considerevoli
introiti dell’omonimo
film.
Bob Iger è una
persona
affabile,
scherza e sorride. È il
presidente di una delle
principali
multinazionali
dell’intrattenimento,
The
Walt
Disney
Company. Si trova a
capo di un impero che
comprende, oltre agli
studios
Disney,
l’emittente Abc, diversi
parchi
d’attrazione
conosciuti in tutto il
mondo,
le
major
Touchstone,Miramaxe
Pixar,
l’editore
di
fumetti
Marvel
Entertainment,
numerosi
canali
satellitari, il teatro
New Amsterdam a
Broadway e centinaia
diDisneyStoreintutto
ilmondo.
Non è stato Bob Iger
a fondare l’impero
Disney,
lui
è
semplicementeunoche
lo
gestisce.
La
multinazionale è stata
creata dallo stesso
Walt Disney e da
Michael Eisner, che ha
trasformato una casa
cinematografica
indipendente e molto
specializzata, simbolo
del
capitalismo
protestante familiare
americano,inunveroe
proprio conglomerato
multinazionale
nell’epoca
della
finanziarizzazione
dell’economia.
In
questo modo Disney è
diventato
l’emblema
della
cultura
mainstream
globalizzata.
Ben dopo il vecchio
zio
Walt,
Michael
Eisner
diventa
amministratore
delegato di Disney nel
1984. Fino a quel
momento non ha mai
visto un film Disney,
neancheBiancaneveei
sette nani, né è mai
andato a Disneyland.
Per mettersi nei panni
del direttore della
società, come vuole la
tradizione aziendale,
accetta dunque di
trascorrere
una
giornata intera vestito
da Topolino nel parco
d’attrazione
Disneyland.
Nel
frattempo
Michael Eisner ha già
firmato il contratto,
accompagnato dai suoi
avvocati.
L’accordo
prevede uno stipendio
annuale
di
settecentocinquantamila
dollari, più un bonus
dello stesso valore alla
firma del contratto, e
naturalmente una gran
quantitàdistockoption
– punto centrale del
contratto e fattore che
lo renderà miliardario.
Si aggiungono poi un
bonus annuale del 2
per cento su tutti i
profitti della Disney,
clausole
rescissorie
esorbitanti e, ciliegina
sulla torta, un prestito
di 1,5 milioni di dollari
senza
restituzione.
Come in Cenerentola,
dove i sogni diventano
realtà, Michael Eisner
diventa l’uomo meglio
remunerato di tutta la
storiadiHollywood.
È di certo un uomo
molto ben pagato, ma
Eisner non pensa in
grande solo per se
stesso:lesueambizioni
riguardano
anche
Disney,
vuole
che
diventi immensa. I
risultati che ottiene
sono proporzionali al
suo
stipendio:
in
vent’anni
Disney
diventaunadelleprime
multinazionali
dell’intrattenimento,
con novecento film in
catalogo,
centoquaranta Oscar
vinti,epermetteaisuoi
azionisti di realizzare
plusvalenze
astronomiche. Inoltre,
si diverte e dice di
trarne “a lot of fun”!
Eisner
dichiara
in
un’intervistadidirigere
laDisneycomesefosse
in un negozio di
giocattoli:“Laseranon
soqualegiocoportarmi
a casa, perché sono
tutti meravigliosi e
funzionano
tutti
magnificamente. Sono
talmente eccitato che
non riesco a prendere
sonno”. (Dopo le mie
ripetute richieste di
ottenere un’intervista
per
questo
libro,
l’assistente di Eisner
mi ha detto che non
desiderava parlare di
Disney dopo le sue
dimissioni.)
Come ha fatto Eisner
arisvegliareDisneydal
suo
torpore?
Innanzitutto,“tornando
al Dna di Disney”, mi
ha
detto
in
un’intervista
Jeffrey
Katzenberg,
ex
direttore
di
Walt
Disney Studios. “Back
to basics”: Eisner è
ripartito dai punti forti
di Disney e si è
concentrato sui film di
successo rivolti alle
famiglie.Avevatuttele
competenze
di
marketing necessarie
al progetto, poiché, in
precedenza, era stato
direttorediParamount.
Sotto
la
sua
supervisione
erano
stati lanciati La febbre
del
sabato
sera,
Grease,
Flashdance,
Beverly Hills Cop e
soprattutto il primo
Indiana
Jones.
Il
metodo
Eisner
è
semplice: privilegiare
la qualità della storia
rispetto agli attori, gli
effetti della messa in
scena
rispetto
al
regista.Inquestomodo
si possono evitare
agenti e star molto
costosi che, per di più,
vogliono
una
percentuale
sugli
incassi (l’acquisizione
di Marvel da parte di
Disney segue la stessa
strategia: un celebre
personaggio
dei
fumetti è spesso più
efficace
per
promuovere un film ed
è meno costoso di una
star in carne e ossa).
Secondo
Eisner
il
progetto di un film si
deve
fondare
soprattutto su una
storia
solidamente
costruita(story-driven),
con animaletti carini,
una trama semplice e
un efficace happy end.
Il “pitch”, l’argomento,
deve
poter
essere
sintetizzato in poche
semplici frasi, una sola
sepossibile.
Il metodo Eisner si
basapoisuldettagliato
controllo dei costi di
produzioneperlimitare
tutto ciò che si chiama
“overhead”,
spese
generali di gestione e
funzionamento. Infine,
segue interamente il
processodipromozione
del
prodotto
costruendo
una
macchina
del
marketing capace di
agire
in
tutti
i
continenti e utile per
incrementare
notevolmente
il
merchandising. Poco
dopo
il
suo
insediamento, Eisner
decide di aprire i
Disney Store: anzitutto
negli Stati Uniti, in
centinaiadiexurbs,nei
centri commerciali e
negli
aeroporti
e,
ovviamente, il negozio
portabandiera
nel
cuorediTimesSquare,
poi in tutti gli altri
paesi del mondo. Oggi
cenesono742.
La
strategia
internazionale
di
Disney è l’altra grande
priorità
di
Eisner:
trasformare un’azienda
californiana in una
multinazionale. Andy
Bird, amministratore
delegatodiWaltDisney
International,
mi
confida che l’obiettivo
della
società
è
raggiungere il 50 per
cento di introiti al di
fuori degli Stati Uniti
per il 2011 (oggi sono
soloil25percento).
Da un punto di vista
imprenditoriale,
Michael Eisner ha
privilegiatolastrategia
di
integrazione
verticale di Disney.
Tuttiidipartimentiele
filiali devono lavorare
di concerto per la casa
madre,anchelacasadi
produzione
cinematografica.Tuttii
contenuti
culturali
devono essere prodotti
dal gruppo che ne
detieneilcopyright,poi
vengono
riadattati
all’infinito per tutti i
tipi di formato, dal
lungometraggio
alla
parata, e attraverso
tutti i media: emittenti
televisive,
canali
satellitari come EspnStar in Asia e Utv in
India.
Questa
diversificazione
avviene,
parallelamente,sututti
i supporti: home video,
dvd, libri pubblicati da
Disney (con il marchio
Hyperion),
dischi
dell’etichetta
Hollywood
Records,
prodotti derivati con
l’unità Walt Disney
Consumer
Products,
negozi Disney Store.
Naturalmente ci sono
anche
le
infinite
possibilità offerte oggi
da
internet
per
diversificare,
quello
che si chiama “global
media”.MichaelEisner
crede dunque alle
sinergie, termine cult
degli anni novanta che
consiste nel pensare
economie di scala e
strategie di marketing
comuni all’interno di
ungruppo.
Alla guida di Disney
Eisner privilegia la
strategia
del
versionning, modalità
che
permette
di
aumentareilpubblicoe
le vendite di un unico
contenuto adattato per
molteplici
versioni.
Eisner è anzitutto e
soprattutto un uomo
interessato
ai
“contenuti”. È convinto
che i programmi e la
loro
distribuzione
debbano
restare
all’interno di un’unica
azienda al servizio di
contenuti
che
poi
vengono diffusi, non
considera
la
distribuzioneunfinein
sé. A questa stessa
strategia rispondono la
messa in opera di un
efficace settore di
distribuzione
internazionale, Buena
Vista, e l’acquisizione
dell’emittente
televisiva Abc, che
serve a trasmettere i
contenuti prodotti da
Disney e non per
avviare
una
distribuzione
di
contenuti
indifferenziata. Fedele
a questa linea, Eisner
ha
avuto
grandi
reticenze
ad
allontanarsi dal core
businessdiDisneyche,
a suo avviso, deve
continuare a produrre
intrattenimento
mainstream rivolto alle
famiglie.Nonhavoluto
avventurarsi, come ha
fatto
invece
Time
Warner,
nella
distribuzione
su
internetpertimoreche
l’intera infrastruttura
costruita con tanta
cura venisse sostituita
da
tecnologie
più
performanti.
Ha
rischiato
di
dover
collaborareconunodei
più grandi fornitori di
internet,
l’operatore
Comcast,
quando
quest’ultimo
ha
lanciatoun’Opaostilea
Disney, ma Eisner non
hamaicredutocheuna
simile
operazione
avrebbe portato alla
creazione di un gruppo
coerente (nel 2009
Comcast
ha
poi
acquisito
NbcUniversal all’interno di
GeneralElectric).
L’obiettivo di Eisner
nonèfarediDisneyun
gruppo con un’ampia
diversificazione: vuole
giocare a tutto campo,
ma all’interno di un
settore
commerciale
ben
definito.
Si
concentra dunque su
alcune
tipologie
professionali
attorno
alle quali costruisce
collaborazioni
e
sinergie, ma non va
oltre. È restio a
incoraggiare
la
concorrenza
interna
non controllata, come
accade invece in molti
conglomeratimediatici,
per
esempio
l’americano Viacom, il
tedesco Bertelsmann e
il francese Vivendi. È
un tipo “hold media”,
non crede nemmeno
alla “convergenza” di
contenuti e tecnologie
e, come la maggior
parte dei patron di
Hollywood degli anni
novanta e duemila, ha
un
atteggiamento
sospettoso, disdegnoso
eostileneiconfrontidi
internet. Ha imposto
che il gruppo Disney
restasse “pure player”
(un’azienda focalizzata
nel
suo
settore
principale) e anche
quando
ha
fatto
investimenti in settori
contigui, non ha mai
pensato
di
far
diventare Disney un
gruppo
generalista
lanciato
in
settori
diversi da quello dei
“contenuti”. Il suo
obiettivo
non
è
somigliare a Sony,
Orange, Reliance o
General
Electric,
conglomerati in cui
l’industria
dei
contenuti
costituisce
una quota limitata
degli introiti accostata
all’informatica per un
pubblico di massa, al
settore elettrico e
telefonico.
Secondo
Eisner, la missione di
Disney è il content, i
contenuti.
In parte, questa
strategia gli è stata
imposta dal consiglio
d’amministrazione
e
dagli azionisti, dal
momento che Disney è
quotata
in
Borsa.
Tuttavia, nel corso
degli anni, attraverso
un abile gioco di
nomine,
Eisner
è
riuscito a neutralizzare
ilprimoeaemarginare
i secondi, pur restando
sensibile ai risultati
trimestrali del gruppo.
Le industrie creative
americane oggi sono
ampiamente finanziate
dai
fondi
d’investimento. Sono
dunque molto sensibili
alle
variazioni
di
mercato. Eisner si
assume
comunque
pochi
rischi:
fa
investire
i
fondi
speculativi nei film più
audaci,
ma
fa
finanziare al 100 per
centodaDisneyifilmil
cui successo è più
prevedibile.
Pur
promettendo ai suoi
azionisti profitti del 20
per
cento
annuo,
Eisner non perde di
vista che la sua
missione
consiste,
secondolasuaformula,
nel “renderli felici”. È
dunque diventato un
maestro nel gestire la
contabilità del gruppo
acolpidimagia–quasi
fossero effetti speciali
dei film di Disney. Per
esperienza
sa
che
l’industriadelcinemaè
sempre stata un buon
business,mauncattivo
investimento.
Per Eisner resta da
affrontare
un
problema.Dal1984,da
quando è diventato
amministratore
delegato,
Disney
incarna una cultura
familiare
un
po’
retrograda che fatica a
rinnovarsi. La casa
cinematografica
ha
perso
il
treno
dell’emancipazione
delle
donne,
del
movimentoneroedella
liberazione
omosessuale(Eisnerha
rifiutato per molto
tempo il Gay Day a
Disneyland
e
ha
permesso tardi che
coppie
omosessuali
danzassero a Disney
World,
solo
dopo
centinaia
di
manifestazioni
e
petizioni).
È
una
strategia motivata da
questioni di principio,
dalla
necessità
di
proteggereilmarchioe
daragionieconomiche:
dalmomentochesonoi
film a portare i
maggiori incassi a
Disney, la produzione
deve mantenere un
profilo mainstream e
non si può dunque
correre il rischio che
unfilmvengavietatoai
minori di tredici o
diciassette anni. Certo,
in queste condizioni,
alla fine del Ventesimo
secolo è difficile avere
appeal su teenager e
giovani
adulti
appassionati di film
d’azione e privi di
qualsiasitabùsessuale.
Per salvare capre e
cavoli,
l’immagine
familiare di Disney e il
bisognodiallargaregli
orizzonti, con abilità e
inventiva,
Eisner
decidediprodurrefilm
“vietati” con altre case
controllate da Disney,
prima
Touchstone
PicturesepoiMiramax
acquisitanel1993.
Da Toy Story a Re
Leone
MichaelEisnerèuna
superstar del business
americano e per lungo
temporiesceadirigere
Disney
come
accadrebbe all’interno
di
un
racconto
fantastico in cui le
zucche si trasformano
in stock option. A un
certo punto, però, le
cose si complicano, a
cominciaredaPixar.
Per il momento Pixar
è ancora una giovane
aziendaspecializzatain
tecnologie
grafiche
innovative, nata dal
genio dell’inventore di
Guerre stellari, George
Lucas, ormai non più
particolarmente legato
a questo progetto che
comincia a costare
troppo. Nel contempo,
Roy Disney, nipote di
Walt abilmente messo
alla testa degli studios
di
animazione
da
Eisner per via del
prestigio che il suo
nomeportaall’azienda,
identifica Pixar come
importante luogo di
innovazione
e
potenziale concorrente
per Disney. È infatti
consapevole che, alla
Disney, il settore dei
cartoni
animati
comincia a essere in
recessione e guarda
versoilfuturo.Ilfuturo
si chiama Pixar. Roy
Disney
incontra
segretamente gli amici
di George Lucas, visita
l’azienda,
resta
sbalordito
dalle
possibilità
di
rivoluzionare il cinema
d’animazione
attraverso il digitale e
il 3D, mentre Disney
realizzaancoraipropri
film d’animazione a
mano. Poi, Roy Disney
viene a sapere che
Lucas ha bisogno di
soldi e che è pronto a
venderelesuequotedi
Pixar, così ne sostiene
l’acquisizione da parte
della Disney. Eisner
rifiuta
categoricamente, “non
siamo una società di
ricerca e sviluppo”,
avrebbe detto, volendo
affermare
che
la
sperimentazione e il
settore
ricerca
e
sviluppo non fanno
parte
delle
sue
strategie. Si lascia così
sfuggire un’occasione
storica, quella che, nel
1985,
gli
avrebbe
permesso di acquisire
Pixar a basso costo.
Poco dopo Steve Jobs,
che ha appena lasciato
la presidenza di Apple,
e ha a disposizione un
certo capitale, compra
Pixaralsuoposto.
Jeffrey Katzenberg,
sessant’anni,
testa
rasata (dovrei dire
calvo), occhiali piccoli,
vestito di marca, è una
delle figure chiave di
Hollywood. Gli piace
parlare,
senza
scomporsi, seduto su
un divano bianco in
riva
al
mare.
L’impressione che mi
suscitacorrispondealle
descrizioni che mi
erano state fatte sul
suo conto: educato,
divertente,
preciso
nelle risposte, tenace,
capace
di
dire
menzogne come se
fosseroverità,racconta
la sua vita come se
fosse un romanzo e
cerca di sedurre il suo
interlocutore, a costo
diimbrogliarelecarte.
Katzenberg
ha
accettato
di
concedermi
un’intervista
per
parlare del nuovo film
Shrek 3, di nuove
tecnologie
e
dell’innovazione
a
Hollywood. Chiarisce
subito di non voler
parlare di Pixar (ormai
un concorrente), né di
Disney
(che
ha
rumorosamente
lasciato dopo aver
intentato una causa).
Mi dice di non aver
letto il libro Disney
War,
un
recente
bestseller sulla fine
della
sua
collaborazione
con
Disney. So che sta
mentendo.Perciòglielo
dico. Lui ride. “Per me
Disney è una vecchia
storia. Sono proiettato
verso il futuro, non
verso
il
passato,”
ribatte Katzenberg. Il
futuro è DreamWorks
Skg da lui fondata. È
stata
un’operazione
realizzata
per
vendicarsi
di
aver
dovutolasciareDisney?
Katzenberg
sorride
nuovamente,
senza
rispondere.
Katzenberg è stato
l’arteficedellarinascita
di
Disney
e
dell’avvicinamento
a
Miramax e Pixar. Alla
testadeglistudiosWalt
Disney dal 1984 al
1994 ha supervisionato
tutti i film che hanno
permessoall’aziendadi
diventare una delle
principali major di
Hollywood.
“Sono
sempre stato nel cuore
del
cinema
mainstream, prima alla
Paramount, poi per
dieci anni alla Disney,
oggi
con
la
DreamWorks. Faccio
film rivolti a tutti i tipi
di pubblico e per tutte
le fasce d’età; i miei
film
devono
poter
facilmente essere visti
intuttoilmondo.Oggi,
generalmente,
li
produciamo in ventotto
lingue e il nostro
obiettivo
è
che
diventino big events
movie, negli Stati Uniti
eall’estero.Osereidire
che li pensiamo, li
costruiamo
affinché
siano global big-event
movies. Credo di aver
lavorato tutta la vita
per un pubblico di
massa. Per avere un
impatto
sugli
spettatori. Lavoro per
avere spettatori. Vado
fiero di questo. E direi
che il pubblico è una
buona guida, un buon
padrone.Inognicasoè
lui il mio datore di
lavoro.”
In realtà, quando
lavorava per Disney, il
superiore di Jeffrey
Katzenberg era Eisner.
Hannolavoratoinsieme
per una decina d’anni,
Eisner alla testa della
multinazionale
e
Katzenberg
degli
studiosDisney.
Come prima di lui
Roy
Disney,
Katzenberg ha capito
quanto Pixar fosse
all’avanguardianeifilm
d’animazione e, da
buon mediatore, ha
stretto relazioni con
John Lasseter, che è
diventato la figura
artistica
principale
dell’innovativa start-up
di San Francisco. Il
ruolo
ufficiale
di
Lasseter alla Pixar è
chiefcreativeofficer.
Fra i vari progetti in
corso
di
sviluppo,
Lasseterhafralemani
un film in cui cerca di
darelavitaaunaserie
di pupazzi giocattolo,
Toy Story. Ne parla a
Katzenberg che trova
l’idea geniale, ma allo
script mancano una
narrazione coerente e
unveroepropriostorytelling, stando alle sue
parole è un mess (un
casino).
Propone
dunque a Lasseter di
lavorare nuovamente
sulla storia e, a suo
dire, gli consiglia di
ispirarsi ai “classic
buddy movies”, i film
che
raccontano
la
storia di due amici.
Così Toy Story diventa
la prima coproduzione
tra Disney e Pixar, mi
dice
Thomas
Schumacher,
ex
presidente
degli
studios d’animazione
Disney, incaricato da
Eisner e Katzenberg di
fare da tramite tra
DisneyePixar.
Realizzato da John
Lasseter, prodotto da
Pixar, finanziato e
distribuito da Disney,
Toy Story batte tutti i
record al botteghino
nella settimana della
sua uscita nel 1995,
incassa 191 milioni di
dollari negli Stati Uniti
e 356 in tutto al
mondo. Lasseter vince
un Oscar. Con Toy
Story
il
cinema
d’animazione diventa
nonsolounodeisettori
più
redditizi
di
Hollywood, ma anche
uno dei più creativi. In
termini di prodotti
derivati, il film – il cui
concetto stesso è il
gioco
–
è
particolarmente
redditizio. Una delle
ragioni del successo di
Toy Story, oltre alle
innovazioni
tecnologiche, a una
sceneggiatura
avvincente
e
appassionante basata,
come
voleva
Katzenberg,
sulla
storiadidueamici,èla
scelta degli attori che
doppiano
i
personaggigioco. Tom
HanksdàvoceaWoody
in Toy Story di Pixar,
così
come
Eddie
Murphy,
Justin
Timberlake e Rupert
Everett presteranno la
loro voce alla serie di
Shrek di DreamWorks.
L’idea di fondo è la
seguente:filmrivoltiai
bambinieancordipiù,
come se si trattasse di
un altro film, al
bambino che c’è in
ciascun
genitore.
Essere giovane non è
più un fatto di età, ma
un’attitudine. Già Walt
Disney diceva che i
suoifilmeranopertutti
perché “tutti siamo
stati bambini e in
ciascuno di noi c’è
qualcosa che resta
dellanostrainfanzia”.
Michael
Eisner
stavolta ha capito la
lezione. Ma è ormai
troppo
tardi
per
acquisire Pixar. Chiede
alloraaSchumacher,il
responsabile
dello
studio d’animazione, di
negoziare un contratto
di collaborazione con
Pixarsupiùanni:sette
film, incassi divisi, a
Disney
l’intero
controllo dei prodotti
derivatiedelfranchise.
In poco tempo grazie a
questo contratto, la
quota di Pixar negli
introiti dello studio
d’animazione
Disney
raggiunge la soglia del
97 per cento. Tuttavia,
progressivamente, la
relazionetralamajore
lo
studio
“indipendente” diventa
poco
produttiva.
Aumentano le tensioni
sulla
libertà
di
creazione, soprattutto
per via dei veti imposti
da Eisner a diversi
progetti di Pixar. La
situazione peggiora e
nonostante gli sforzi
del presidente degli
studios d’animazione
Schumacher, Disney e
Pixarsiallontanano.
Incontro
Thomas
Schumacher al terzo
pianodelcivico1450di
Broadway, negli uffici
della
Disney
a
Manhattan.Daqualche
tempo non si occupa
più
di
film
d’animazione ma di
commedie musicali e
dirige
il
Disney
TheatricaldiNewYork.
È il nostro terzo
appuntamento e Tom,
contravvenendo
alle
regole di riservatezza
che Disney impone ai
suoi dirigenti, parla in
libertà (mi fornisce
anche
numerosi
contattiefadatramite
per
alcuni
appuntamenti con i
responsabili
della
DisneyaBurbank).
Sulla sua scrivania ci
sono due figurine di
Bianca e Bernie. “È il
primo film che ho fatto
per
Disney,”
si
giustifica Schumacher.
Ci
sono
anche
marionette, locandine
di film e, ben in vista,
una fotografia in cui
posa con Bill Clinton
(Schumacher è un
importante fundraiser
dei democratici e ha
ampiamente
contribuito
alla
campagna di Barack
Obama negli ambienti
del cinema nel 2008).
C’è
anche
una
riproduzione
in
miniatura di una scena
diReleoneenonposso
impedireamestessodi
cercare il logo di
Burger King, memore
dellagrandecampagna
pubblicitaria fatta per
Re Leone insieme ai
magazziniToys“R”’Us
che
hanno
creato
duecento nuovi giochi
ispirati al film e
appositamente allestito
una giungla all’interno
deinegoziperospitarli,
mentre il panino “Lion
King” era diventato
oggetto di una grande
promozionedapartedi
BurgerKing.
L’idea di investire a
Broadway è nata nel
1991, dopo il successo
del film d’animazione
La Bella e la Bestia.
Quando il principale
critico di teatro del
“New York Times”,
Franck Rich, elogia il
film paragonandolo ai
musical di Broadway,
Jeffrey Katzenberg ha
una rivelazione, deve
farne una versione per
Broadway! L’idea è
originale, anche se
nessuno
sembra
afferrarne la portata
poiché rappresenta un
elemento di rottura
all’interno
della
tradizionedellacultura
dimassaamericana:un
tempo si riadattavano
le commedie musicali
di
successo
di
Broadwayperfarnedei
film, oggi avviene il
contrario.
È
un
ribaltamentostorico.
Il
problema
è
convincere
Michael
Eisner, che reagisce
d’istinto
bocciando
l’idea: “Non dobbiamo
rinvigorire il nostro
narcisismopensandodi
poter fare i produttori
di
Broadway”.
L’amministratore
delegatodiDisney,che
non è un creativo, si è
circondato di manager
e direttori finanziari
assillati dall’idea di
mettere
paletti
ai
creatori e di ridurre i
costi e secondo loro
sbarcare a Broadway è
una follia. Poco dopo,
Eisner torna sui suoi
passi
e
Thomas
Schumacher
viene
trasferito a New York
per creare la divisione
“teatro”diDisney.
Improvvisamente
sento l’urlo di Tarzan.
Thomas Schumacher
continua,
imperturbabile,
il
discorso. Ogni ora, nel
suo
ufficio,
la
marionetta di Tarzan
lancia un urlo. Per
Disney, l’adattamento
diTarzanaBroadwayè
stato un fallimento nel
2006.
“Non
riesco
a
spiegarmi
perché
Tarzan sia stato un
fallimento mentre Re
Leone sia stato un
successo.
Lavoriamo
all’interno
di
un’industria creativa e
il successo non è mai
garantito.Itrionfisono
rari,mentreifallimenti
sono
frequenti.”
Mentre
lo
ascolto
parlare osservo una
lianadiTarzanlasciata
sullascrivania.
AllabasediReLeone
in versione musical c’è
ilsuccessodelfilm:nei
tre
anni
di
distribuzione
tra
cinema, home video e
prodotti derivati ha
fruttato
oltre
un
miliardo di dollari.
“Eisner sapeva che le
industrie
creative
devono continuamente
rinnovarsi. Non voleva
che Disney diventasse
un museo, era dunque
necessario continuare
a
evolversi,
ogni
giorno. Per questo
motivo, dal momento
che avevo fatto il film
per Disney, mi ha dato
il via libera per farne
unmusicalper
Broadway,”
spiega
Schumacher.
L’avventura comincia
in grande stile e con
importanti
mezzi
finanziari:
per
sperimentare
il
progetto,
Disney
investe
immediatamente
34
milioni di dollari. In
secondo luogo, rileva
un celebre teatro sulla
Quarantaduesima
Strada, l’Amsterdam,
un
gioiello
di
architettura in stile art
nouveau,del1903,con
affreschi
allegorici,
fregi, mosaici, ormai
caduto
in
disuso
mentre
sexy-shop,
prostituzione, droga e
bande hanno invaso il
quartiere.
Schumacher coglie
all’istante il problema:
comeriuscireaportare
le famiglie in una zona
invasa da pornofilm
tipo Gola profonda e
dagli spacciatori di
crack? Il terzo punto
del
progetto
è
bonificare il quartiere.
Disney si allea con il
sindaco repubblicano
di New York, celebre
sostenitore
della
“tolleranza zero”, per
rivitalizzare Broadway
attraverso un progetto
basato su controlli
della
polizia,
investimentieconomici,
intrattenimento per le
famiglie.
Su
disposizione comunale,
tutti i sexy-shop sono
chiusi, vengono aperti
negozi
turistici
sovvenzionati da fondi
pubblici (tra cui il più
grande
Virgin
Megastore al mondo,
un negozio Gap e un
immenso
Hotel
Marriott) e le sedi di
grandi multinazionali
dell’intrattenimento e
di emittenti televisive
sono incentivate a
insediarvisi attraverso
riduzionifiscali.Disney
diventa
così
la
“mascotte”
dell’operazione
di
bonifica della nuova
Times Square: il solo
nome
della
multinazionale
di
Topolino è garanzia di
attenzione da parte
delle famiglie. In un
incrocio
strategico
come
quello
tra
Broadway
e
la
Quarantaduesima
Strada viene aperto un
DisneyStore.
La produzione di Re
Leone è preparata
minuziosamente.
A
questo punto Tom
Schumacher, che ha
personalmente
prodotto il musical,
decide di affidare la
regiaaJulieTaymor.
“Sono un’artista che
diverte,” mi dice Julie
Taymor, grande figura
delteatrosperimentale
diNewYork,quandola
intervisto nella suite di
unhoteldicuièospite.
“L’artista con la A
maiuscola non riesce a
capire
il
valore
dell’intrattenimento, si
accontenta
di
un
pubblico limitato così
non compromette la
propria arte facendola
diventarecommerciale.
Questo
è
un
atteggiamento elitario,
un po’ snob. Io mi
ispiro a figure come
Aaron
Copland,
Leonard Bernstein. Mi
piace
mescolare
i
generi.” Julie Taymor
ha trascorso gli anni
della sua formazione,
gli anni settanta, a
contatto
con
la
compagnia
radicale
Bread and Puppet,
partecipando
agli
scioperi degli affitti,
alle lotte contro la
GuerradelVietnamea
difesa della gratuità
degli
spettacoli.
Progressivamente, nel
corso
degli
anni
ottanta, dopo un lungo
soggiorno in India, ha
cominciato
a
interessarsi alle forme
originali
di
divertimento per il
grande pubblico e alle
marionette,
pur
continuandoafarearte
– di recente ha messo
in scena Il flauto
magico al Metropolitan
OperadiNewYork.
Cade dunque dalle
nuvole quando un
giorno
riceve
la
chiamata
di
Schumacher, il patron
di Disney a Broadway.
Schumacherlepropone
di pensare a un
adattamentoteatraledi
ReLeone.JulieTaymor
nonhamaivistoilfilm,
acquistaildvdevapoi
a incontrare il suo
interlocutoreinFlorida
e suggerisce l’uso di
marionette e maschere
africane, in modo che
gli
attori
possano
interpretare
i
personaggi del film
d’animazione.
L’elemento dominante
dovrebbe essere la
musica. “Ciò che al
cinema doveva essere
visto,
a
teatro
dev’essere
sostituito
dalla musica africana,”
suggerisce.
Jeffrey
Katzenberg,
invece,
che ha investito altre
decine di milioni di
dollari
per
avere
apparati
scenici
straordinari, ha una
rivelazione nel suo
ufficio di Team Disney:
la trama di Re Leone
deve somigliare ad
Amleto…
Ilcolpodigeniodello
spettacolo di Julie
Taymor per Disney è
tutto qui: mescolare i
generi,
mettere
insieme il mainstream
con il raffinato, high e
low,arteeculturapop.
“In Re Leone,” mi dice
Julie Taymor, “ci sono
situazioni per un gusto
tipicamente popolare.
Inoltre, le marionette
non sono state pensate
per i bambini, ma per
gli adulti. C’è anche
molta eleganza, molta
ricerca.
È
uno
spettacolochenonèné
arte pura né semplice
divertimento–nonèné
l’una né l’altro. Io sto
altrove.”
Lo spettacolo creato
nel 1998 è splendido,
di
una
bellezza
fiabesca.Sirestarapiti
dalle
marionette
giganti
e
dalle
mascheremeravigliose,
si vedono volatili in
movimento invadere il
cielo e decine di
antilopi correre per
riuscire a salvarsi, con
una
coinvolgente
musica
africana
e
bellissime
ambientazioni
della
savana. La commedia
musicale
lascia
trasparire
qualcosa
dell’ingenuità e della
generosità del primo
Walt
Disney.
Il
successoèeccezionale,
la stampa è unanime
nel sostenere che si
tratta della più bella
commedia musicale “di
tutti i tempi”. Gli
addetti
ai
lavori
tributano lo spettacolo
conferendogli sei Tony
Awards – il principale
premio di Broadway.
Ma c’è di più: il
successo di Re Leone
nel cuore di una Times
Square
rivitalizzata
porta a Disney milioni
di dollari. “Un musical,
quando
funziona
davvero,comenelcaso
diReLeone, è davvero
molto redditizio in
termini
economici.
Proporzionalmente, il
teatro fa registrare
incassi maggiori sugli
investimenti rispetto al
cinema,” mi confida
Schumacher nel suo
ufficio. (Il costo della
produzionediReLeone
non
è
noto
e
Schumacher rifiuta di
comunicarmelo;
probabilmente supera i
venti milioni di dollari,
se
così
fosse
si
tratterebbe
dello
spettacolo più costoso
mai
prodotto
a
Broadway.)
Ilsuccessoottenutoa
New York è niente
rispetto
a
quello
riscosso altrove: da
dodici
anni
lo
spettacolo è portato in
giro per gli Stati Uniti
e in tutto il mondo, è
rimasto in cartellone
peranniinmoltipaesi,
spesso
ha
fatto
registrare
il
tutto
esaurito, nonostante il
costo del biglietto,
cento dollari (senza
riduzione
per
i
bambini). Re Leone è
già stato visto da oltre
cinquanta milioni di
persone e ha incassato
oltre un miliardo di
dollari in tutto il
mondo. “Stasera, in
tutto il mondo, ci sono
dodicirappresentazioni
di Re Leone,” mi dice
Schumacher.
Resta
comunque
uno
spettacolo solo per
paesi ricchi: non è
statoincartellonenéin
Africa, né in America
latina né in Medio
Oriente. “È troppo
costoso
produrre
questo spettacolo al di
fuori
dei
paesi
sviluppati,”
precisa
Schumacher, che poi
aggiunge, senza ironia:
“In quei paesi sarebbe
di sicuro un successo,
ma
non
necessariamente
un
goodbusiness”.
Solo
una
multinazionale
come
Disney, con capitali e
un settore logistico
immensi,
può
permettersi di avere in
cartellone Re Leone in
contemporanea in tre
diversi
continenti.
L’avventura
della
Disney nel teatro è poi
proseguita con Aida,
Mary
Poppins,
La
Sirenetta,
mentre
Tarzan è stato un
fallimento e il progetto
su Pinocchio è stato
abbandonato. “Siamo
dei
creativi,
degli
artisti, ma facciamo
anche intrattenimento
di qualità,” aggiunge
Schumacher.“Creareè
la nostra caratteristica
principale.Equandole
persone mi dicono che
creare significa fare
arte,
e
non
intrattenimento, a me
sembra
un
atteggiamento molto
aristocratico e molto
presuntuoso.
Molto
europeo.Nonlepare?”
Miramax
e
DreamWorks:lacaduta
Per l’amministratore
delegato della Disney,
Michael
Eisner,
Broadway è di certo
una
questione
accessoria,
dal
momento che dirigere
una
multinazionale
significa dover gestire
questioni
ben
più
importanti. Anzitutto
c’è il settore televisivo,
diventato
ormai
strategico
dopo
l’acquisizione
dell’emittente
nazionale
Abc.
L’obiettivo di questa
operazione era creare
sinergie tra studios e
televisione: Abc può
produrre
serie
televisive
con
il
sostegno degli studios
Disney
e
può
trasmettere anzitutto i
filmdellamajor(Eisner
inizialmente avrebbe
voluto acquisire Nbc
ma è stato preceduto
da General Electric).
Questa acquisizione è
stata possibile grazie a
unalleggerimentodelle
regole
federali
americane negli anni
della
presidenza
ReaganeClinton:trail
1985 e il 1995 è stata
favorita
la
concentrazione
verticale dei gruppi di
media negli Stati Uniti
(Disney ha acquisito
Abc, Universal si è
associata a Nbc, Time
Warner a Cnn e Hbo,
NewsCorphaestesola
rete Fox e, nonostante
la recente scissione,
sono nate importanti
relazioni tra il gruppo
Viacom e Cbs). Eisner
si concentra dunque
sulla produzione dei
contenuti televisivi e si
lancia in mercati fino
ad allora considerati
secondari,l’homevideo
e le pay tv satellitari.
Rafforza
Disney
Channel, creato nel
1983,
investe
in
programmi educativi e
per la famiglia (Abc
Family, The History
Channel) e nello sport,
un’altra
forma
di
intrattenimento
secondo
Eisner
(acquisiscetuttalarete
televisiva sportiva a
pagamento Espn). Per
raccogliere liquidità, il
patron di Disney avvia
anche
un’abile
operazione
di
riedizione in video e
dvd di celebri film del
catalogo. Anche questa
strategia segue logiche
precise:
i
classici
Disney sono riproposti
al cinema in media
ogni
sette
anni,
intervallo calcolato per
coinvolgere ogni volta
una nuova generazione
di bambini, dunque
Eisner pianifica la
distribuzione
di
prodotti home video in
periodi utili per non
fare concorrenza ai
filminsala.Ilsuccesso
è grandioso: nel 2003,
il primo giorno di
messa in vendita del
dvd di Nemo, sono
venduti otto milioni di
esemplari.
Lecosevannounpo’
meno bene nel settore
cinema. Con Pixar la
crisisiaggravaeledue
case
rompono
il
sodalizio.
Disney
rimane così priva dello
studio
d’animazione.
Apparentemente
le
cose vanno meglio con
Miramax,
etichetta
indipendente, nota per
il tocco “indie” e
provocatore, non tanto
per film come Nuovo
CinemaParadiso,cheè
stato
un
grande
successo,
ma
per
Sesso,
bugie
e
videotape di Steve
Soderbergh. Disney ha
acquisito Miramax nel
1993 per solo un
centinaio di milioni di
dollari.
Importanti
successi confermano la
lungimiranza di Eisner
e il genio dei fratelli
Weinstein, che sanno
promuovere i loro film
indipendenti come se
fosserofilmdicassetta:
Pulp Fiction, nel 1994,
incassa da solo 108
milioni di dollari, solo
al
botteghino
americano, cioè di più
di quanto non sia
costata l’acquisizione
di Miramax. Seguono
poi successi come
Shakespeare in Love,
Gangs of New York e
TheHours. Tuttavia, la
situazione cambia in
breve tempo: Eisner è
verticista
e
riesce
difficilmenteatenerea
frenolapersonalitàdei
fratelli Harvey e Bob
Weinstein ai quali
cominciaastareunpo’
stretta l’alleanza con
Disney. In regime di
“indipendenza
controllata”, imposto
da Disney, la rottura si
consuma
quando
Eisner rifiuta loro di
fare
l’adattamento
cinematografico
del
Signore degli Anelli
(realizzato poi con il
noto successo con il
concorrente
Time
Warner), riscrive al
ribasso il budget di
Ritorno
a
Cold
Mountain e soprattutto
quandocensural’uscita
di Fahrenheit 9/11 di
Michael Moore (il film
costato 6 milioni di
dollari, distribuito con
circuito indipendente
nel 2004 con incassi di
220 milioni in tutto il
mondo).
I
fratelli
Weinstein
lasciano
Disney
(che
resta
proprietaria
del
marchio)efondanouna
nuova etichetta, la
WeinsteinCompany.
Una
disavventura
simile tocca anche a
Jeffrey
Katzenberg,
vulcanico patron degli
studiosDisney.
“Mi pare di essere
statochiaro,nonvoglio
parlare di Disney, per
me è acqua passata,”
mi
ripete
Jeffrey
Katzenberg,
sorridendo,
quando
torno alla carica sul
tema. La questione
peraltro è semplice,
ancheseèdiventatala
più celebre telenovela
diHollywoodneglianni
novanta. Quando il
numero
due
della
Disney, il presidente
Frank Wells, muore in
un
incidente
in
elicottero, l’ambizioso
Katzenberg, che dirige
gli studios Disney ed è
artefice dei successi
cinematografici
del
gruppo degli ultimi
anni, è convinto che
quel posto spetti a lui
di diritto. Se lo si
accusa di aver voluto
fareilrealpostodelre
lui si difende, ma è
indubbiocheambissea
quel posto. Secondo i
suoi avvocati, questi
erano gli accordi con
Eisner quando era
stato reclutato dalla
Disney.
Eisner
smentisce e, di sicuro,
gli
nega
questa
promozione e lo invita
a dimettersi. Ne segue
una lunga cronaca
giudiziaria
attorno
all’indennizzo richiesto
da Katzenberg, che è
sostenuto
da
personaggi di spicco di
Hollywood,
in
particolare da Steven
Spielberg
e
dal
produttore
musicale
David
Geffen.
Katzenberg vince in
appello, intasca 208
milioni di dollari, che
reinveste creando una
casa cinematografica
concorrente a Disney,
DreamWorks
Skg
(quest’ultima
sigla
indica le iniziali dei tre
fondatori,
Spielberg,
Katzenberg, Geffen).
Arrivano
anche
grandiosi
successi
comeAmericanBeauty,
KungFuPanda, Shrek,
Minority Report
e
Madagascar.
Katzenberg non ha
molta voglia di aprirsi
durantel’intervistache
mi concede. Ripete
semplicemente
cose
che ha già detto
ovunque, ovvero che
“Shrek è ugly-cute
(terribile ma carino) e
non
ugly-scary
(terribile
e
spaventoso)” e questo
spiega il successo del
film.
Sibillino,
aggiunge inoltre di
essere un uomo di
passioni: “La passione
è l’unica cosa che
riesca a spiegare il
fattochemileggadieci
o
quindici
sceneggiatureognifine
settimana
nella
speranza di trovarne
una formidabile. La
passione è l’unica cosa
che mi fa trascorrere
sessanta
ore
alla
settimanaaglistudiose
che mi fa andare a
vedere tre film di fila
nelfinesettimana”.
Incontro Bob Iger,
nuovo amministratore
delegato di Disney dal
2005,
e
mentre
facciamo
colazione
insiemeglichiedoquali
spiegazioni riesce a
dare alla violenza della
guerra avvenuta nel
regno di Topolino, la
Disney
War
minuziosamente
raccontata da un libro
di successo, in seguito
alla quale il suo
predecessore, Michael
Eisner,
è
stato
costretto a rassegnare
le dimissioni. Bob Iger
mi dice di non aver
letto il libro. Certo che
idirigentidiHollywood
leggono pochi libri, ho
pensato
immediatamente.
Ho poi chiesto se
considerasse un buon
affare l’acquisizione di
Pixarper7,4miliardidi
dollari
nel
2006,
mentre Steve Jobs
l’aveva acquistata da
George Lucas nel 1986
a 10 milioni. “Sì,” è
stata la risposta. Infine
glihochiestoseilfatto
di avere nuovamente
stretto rapporti con i
fratelli
Weinstein,
fondatori di Miramax e
allontanatidaEisner,e
di aver fatto entrare
Steve Jobs, geniale
patron
di
Apple
dall’umore mercuriale,
all’internodelconsiglio
di amministrazione di
Disney rappresentasse
una rottura rispetto
all’epocadiEisner.Bob
Iger mi ha detto che
“era
necessario
inaugurare una nuova
epoca e fare nuove
scelte”. Avrei voluto
chiedere
a
questo
punto se fosse vero,
secondo alcune voci,
che è così ossessionato
dal
controllo
dell’informazione
e
dallafugadinotizienei
media da tenere una
televisione anche nella
doccia
–
ma
ho
preferito
tacere
sull’argomento.
Per
esperienza ero ormai
consapevole
che,
quando si intervista il
dirigente d’una grande
multinazionale
come
Disney,
non
si
apprendonomaigrandi
cose.
La caduta di Michael
Eisner, l’uomo che ha
permesso a Disney di
diventare
un
conglomerato
mediatico di caratura
internazionale,
è
davvero
indicativa
poiché
rivela
che
l’intrattenimento non è
un settore industriale
come
gli
altri.
L’incapacità di gestire
le
personalità
dei
creatori,illorobisogno
di libertà, ha portato
Eisner
a
essere
spodestato da una
coalizione creatasi in
nome dello zio Walt e
capeggiata da Roy
Disney, che egli stesso
aveva
portato
all’interno
della
società. In ogni caso, il
successo commerciale
diMichaelEisnernonè
in discussione. Gli utili
netti
di
Disney
ammontavano a circa
100 milioni di dollari
l’anno in cui è arrivato
alla presidenza della
multinazionale e sono
schizzati a 4,5 miliardi
quando si è dimesso.
Nel 1984 un’azione
della Disney valeva
1,33 dollari, vent’anni
dopo ne vale 25. Utili
di questo calibro sono
stati ottenuti grazie
alla crescita di cinque
settori
considerati
marginali nel 1984: la
vendita dei dvd, le
emittenti televisive a
pagamento,soprattutto
quelle
sportive,
i
prodotti
derivati,
Broadway e infine i
parchi d’attrazione, in
particolare con gli
alberghi
collocati
all’interno dei parchi
stessi.Rispettoaquesti
settori
sono
decisamente
meno
redditizi gli incassi del
botteghinoegliintroiti
dell’emittente gratuita
Abc,
benché
il
copyright
sui
film
produrrà introiti e
prodotti derivati sul
lungoperiodo.
MichaelEisner,conil
suo aereo privato,
guardiedelcorpo,nota
spese illimitata e un
tenore di vita da capo
di stato, non è stato
sufficientemente
accortonelprenderele
misure
sull’unico
settore in grado di
minacciarlo,
la
creazione. Le industrie
creative, infatti, non
sono paragonabili a
quelle
del
settore
automobilistico
o
dell’agro-alimentare,
sono ambienti in cui si
deve
diffidare
dei
creative
people,
personalità
come
Steven
Spielberg,
Jeffrey
Katzenberg,
George Lucas, John
Lasseter,
Michael
Moore, Harvey e Bob
Weinstein; se li si
maltratta,
se
si
minaccialalorolibertà
artistica, loro se ne
vanno. L’indipendenza
è la regola non scritta
e,anchequandoquesta
indipendenza
viene
acquisitapercontratto,
le apparenze devono
essere salve. Quando
non gli piacevano un
film o una scena,
Eisner
diceva
semplicemente: “This
has to be edited”
(questo deve essere
“rivisto”)
ovvero,
“tagliato”.
Oppure,
interamente
rifatto.
Una simile gestione,
all’antica,
risultava
inaccettabile per gente
come i creatori di Toy
Story e i colleghi di
Tarantino.
La caduta di Eisner,
che non ha saputo
giocare di squadra
all’interno del Team
Disney,
preferendo
invece controllare il
lavorodegliartisti,può
essere
brevemente
spiegata
riconsiderando
il
significato
dell’espressione
“industrie creative”, in
cui il termine più
importante
è
il
secondo, quello che ha
a che fare con la
“creazione”.
4.
LanuovaHollywood
“Salga sulla golfcart,” mi dice il
responsabile
delle
relazioni
pubbliche
incaricato di farmi
visitare gli studios
della
Columbia
PicturesaLosAngeles.
Mi trovo a Culver City,
un quartiere a sud di
Hollywood,tralaSanta
Monica Freeway 10,
che attraversa la città
daestaovest,elaSan
Diego Freeway 405, la
via di scorrimento
veloce a ovest di Los
Angeles.
Negli
studios
hollywoodiani anche le
golf-cart, le piccole
autousatesuicampidi
golf,
sono
ormai
diventate
un’attrazione. Solo alla
Columbia Pictures ne
ho viste centinaia,
lungo i viali e le
stradine degli studios.
“È un mezzo poco
rumoroso, è elettrico,
non è pericoloso e
permette di spostarsi
velocemente
tra
i
diversi luoghi delle
riprese,
questo
è,
infatti, uno dei più
grandi
studios
di
Hollywood,” spiega il
mioaccompagnatore.
Tutti conoscono il
logo
di
Columbia
Picture che compare
all’inizio dei suoi film,
quello della donna
longilinea avvolta nella
bandiera
americana
conunatorciainmano
cheilluminailcielo,ma
qui a Culver City è
poco visibile. Resta il
fattochequestistudios
sono sorprendenti per
le loro dimensioni. Li
attraversadaunaparte
all’altra
una
main
street piena di luci al
neon,
billboards,
marquees e vertical
blades (i frontoni e le
insegne tipici delle
vecchie
sale
cinematografiche), su
cui si affacciano i
ventidue
principali
teatridiposa,ciascuno
dei quali è identificato
con il nome di una
delle personalità che
ha fatto la storia della
Columbia:
Poitier,
Kelly, Astaire, Capra,
Garbo,
Garland,
Hepburn, Gable… Più
lontano ci sono gli
edifici
della
postproduzione
e
dell’amministrazione; i
prati
sono
perfettamente tagliati,
gli alberi danno un
tocco bucolico. C’è poi
il resto della “città”,
attraversata da una
rete
di
cabine
telefoniche
gratuite
collegate al centralino
interno, con ristoranti,
studi medici, banche,
palestre, un ufficio
postale,
negozi
di
souvenir, un’agenzia di
viaggi e un cinema
Loews.
Il nome Columbia
non figura da nessuna
partepoichélamajorè
stata acquisita nel
1989 da Sony (prima
era rimasta a lungo
indipendente, poi era
stata comprata da
Coca-Colanel1982).Ci
sono una Sony Police,
un
Sony
Mail
Department, un Sony
Family
Center
e
addirittura
una
caserma dei pompieri,
la Sony Fire. Di fatto,
non mi trovo alla
Columbia, ma alla
Sony.
“Gli
studios
banche”
“Questi
storici
sono
sono gli
studios
Columbia, però oggi
tutto appartiene a
Sony.
L’intero
complesso
viene
chiamato Sony Lot,
proprio come vengono
chiamati
l’Universal
Lot e il Paramount
Lot.” La vicepresidente
di
Sony
Pictures,
France Seghers, mi
accoglie
offrendomi
caffè italiano e dolcetti
prelibati all’interno di
unlussuosoedificiodel
campus,
il
Jimmy
Stewart
Building.
Parliamo
a
lungo.
Inoltre,
sono
autorizzato a visitare
gli
studios
e
a
incontrare
altri
dirigenti di Sony, a
condizionedinonfarne
i nomi (alla Sony vige
la regola che non si
possono
esprimere
opinioni pubblicamente
sullequestioniinterne).
Sony
è
una
multinazionale molto
decentralizzata.
La
sede è a Tokyo. I
contenuti
culturali,
cinema e musica, sono
gestiti
da
Sony
Corporation
of
America,
società
americana quotata alla
Borsa di New York, il
cui unico azionista è la
giapponese
Sony
Corporation. A Los
Angeles
c’è
Sony
Pictures Entertainment
cheproducelamaggior
parte dei film di
successo che escono
con i marchi Sony
Pictures,
Columbia
Pictures e Tri-Star
Pictures.Sonypossiede
anche
un’etichetta
indipendente,
Sony
PictureClassics,chedi
indipendente
ha
ovviamente solo il
nome.
“Qui ci sono gli
studios,manonsempre
i nostri film sono girati
daquesteparti;inoltre,
quando
le
nostre
équipe
sono
‘disoccupate’
gli
studios
vengono
affittati ad altre major
come
Paramount,
Warnere20thCentury
Fox. Spesso la nostra
funzione si limita ad
affittare gli studios,
ricoprire il ruolo di
banca e dare green
light ai progetti,” mi
dice un dirigente di
SonyPictures.
A Hollywood, green
light è un’espressione
fondamentale.
Gli
studios danno “luce
verde” ai progetti che
vengono
loro
sottoposti, sotto forma
di pitch o di script.
Luce verde è il via
libera che permette di
cominciare
lo
“sviluppo” di un film e
la sua messa in
produzione. “Il green
light
è
il
fulcro
dell’intera macchina, è
il momento in cui la
major esercita più
chiaramente il proprio
potere,” mi conferma
France Seghers. In
realtà non esiste un
unico via libera, ce n’è
uno a ogni tappa del
progetto:
quando
un’idea viene proposta
e testata, quando lo
script è accettato e
messo in lavorazione,
quando
parte
la
produzione. Talvolta, il
progetto di un film su
cui si è lavorato per
diversi
mesi
non
ottiene “luce verde” e
chi detiene i diritti,
spesso il produttore,
può andare a proporlo
a un’altra casa di
produzione
(per
esempio, Shakespeare
in
love
è
stato
progettato per tre anni
all’interno di Universal
Pictures, ma non ha
ottenuto il “via libera”,
è stato poi prodotto da
Miramax e ha vinto
settepremiOscar).
Le cose, tuttavia,
sono
ben
più
complicate. All’interno
della
complessa
trattativacheportaalla
realizzazionediunfilm
non figurano solo la
major e il produttore:
nella nuova Hollywood
sono
molti
gli
interlocutori
e
i
soggettiingioco.
Nell’epoca
d’oro
degli studios, tra gli
anni venti e la fine
degli anni quaranta,
Hollywood
era
un
sistema centralizzato,
compattoeorganizzato
secondo una rigida
gerarchia verticale. Le
case di produzione
organizzavano l’intero
processo
di
realizzazione di un
film:dallastesuradello
scriptalladistribuzione
insala.Iproduttori,ma
anche
gli
sceneggiatori,itecnici,
i registi e la maggior
partedegliattorierano
stipendiati
con
contratti
a
lungo
termine. Il cinema era
anzitutto un’industria
in cui, in un certo
senso, tutti lavoravano
alla
catena
di
montaggio.
Con
il
1948, quando la Corte
suprema degli Stati
Uniti ha vietato i
processi
di
concentrazione,
gli
studios hanno subìto
un
contraccolpo
perdendo la posizione
di monopolio e il
controllo della rete
delle
sale
cinematografiche (che
hannodovutovendere),
costringendole
a
limitare la produzione.
A partire dalla metà
degli anni cinquanta, il
sistema industriale e
centralizzato
di
Hollywood scompare e
comincia ad assumere
una dimensione meno
rigida.
Oggi, nella nuova
Hollywood, i film sono
sostenuti da major che
finanziano,
danno
green light, ma sono
estranee al processo di
realizzazione.
La
lavorazione è affidata,
sotto il permanente
controllo di agenzie di
talenti remunerate a
percentuale a ogni
transazione, a migliaia
disocietàindipendenti:
case di produzione,
start-up che affrontano
le questioni tecniche,
piccole
e
medie
aziende specializzate
nel casting, nella post-
produzione,
negli
effetti speciali e nella
realizzazionedeitrailer
promozionali.
Le
diverse fasi del film
sono subappaltate ad
aziendespecializzatein
Asia, ad artigiani che
lavoranoaLosAngeles,
ad
agenzie
di
comunicazione
globalizzateeasocietà
specializzate
nella
distribuzione di film in
determinatipaesi.Tutti
sono indipendenti, ma
legati per contratto a
un
sistema
infinitamente
più
complesso di quello
degli studios di una
volta. Secondo alcune
stime,
l’economia
americanadelcinemae
della televisione vede
la partecipazione di
115.000 aziende, la
maggior parte delle
quali ha meno di 10
lavoratori,
coinvolge
complessivamente
770.000 dipendenti e
indirettamente
1,7
milioni di impieghi. Al
contrario della vecchia
Hollywood in cui tutti
erano dipendenti, nella
nuova Hollywood tutti
sonoindipendenti.
Ogni film è dunque
un’azienda autonoma.
Per gestire l’intero
processo, in genere
viene
creata
appositamente
una
società di produzione,
un’entità
giuridica
autonoma. La società è
diretta
da
un
produttore ingaggiato
dalla major per gestire
un unico film. Si dice
che il produttore è
work
for
hire
(abbreviato in Wfh),
espressione
fondamentale
negli
Stati Uniti per definire
la natura del contratto
di lavoro tipico di
Hollywood:
un
contratto in cui la
persona non è assunta
atempoindeterminato,
come
avveniva
all’epoca d’oro degli
studios, ma per un
unico progetto; inoltre
il
contratto,
come
avveniva prima del
1948,
prevede
la
cessione del copyright
dapartedelproduttore
allamajor.
Con
la
stessa
modalità del work for
hire,
lo
stesso
produttore (detto line
producer) mette sotto
contratto il regista, gli
attori e le centinaia di
persone e di aziende
che contribuiranno alla
realizzazione del film –
tutti i contratti hanno
la clausola di cessione
del
copyright
alla
major.“Perfarlabreve,
siamounabanca,”dice
FranceSeghers.
In realtà, il ruolo
degli studios è, nel
contempo, più e meno
complicato di quello di
una semplice banca.
Come accade per gli
istitutifinanziari,quote
ingenti del denaro di
cui dispongono non
appartengono
direttamente
agli
studios: sono costituite
da
fondi
versati
anticipatamente
da
decine di coproduttori,
ditelevisionidelmondo
intero che fanno una
prelazione sui diritti
televisivi, sono l’esito
di accordi con le case
di
produzione
di
videogiochi
e
di
trattative
con
compagnie aeree e
catene di alberghi che
diffonderanno i film, ci
sono
inoltre
le
sovvenzioni pubbliche
dei singoli stati per le
riprese fatte in terra
americana (ce ne sono
inognistatofederalee
bisogna
aggiungere
anche
importanti
crediti sulle imposte e
riduzioni fiscali che
corrispondono
alla
tecnica di sostegno
pubblico più frequente
al
settore
cinematografico negli
Stati Uniti). Gli studios
si avvalgono anche dei
flussi
finanziari
provenienti da puri
investitori,
in
particolarehedgefund,
fondi pensione, equity
partner,
prestiti
bancari e altri fondi
d’investimento
diversificati. Possono
inoltre contare sugli
apporti finanziari di
ricchiprivaticittadini,i
famosi civilians. Questi
civilians,
filantropi
americani, miliardari
indianioricchisceicchi
arabi,intervengononel
finanziamento del film,
non tanto per investire
denaro,
ma
per
condividere un po’ del
glamour
hollywoodiano:
sono
invitati alle riprese,
assistono
alle
anteprime, mangiano
insieme agli attori.
Figurano nei titoli di
coda,perquantoilloro
apporto non sia per
nulla secondario, e
soprattutto
possono
dedurre
questo
“investimento”
dalle
tasse
sui
redditi
(spesso
grazie
a
riduzioni
fiscali
all’estero).
Gli studios, tuttavia,
sonoanchequalcosadi
piùdiunabanca.Oltre
a
fornire
capitali,
gestiscono anche il
copyright del film, di
cui sono proprietari, e
dal
valore
spesso
inestimabile.Unaparte
importante dell’attività
delle
major
è
concentrata
sulle
vendite internazionali,
suidirittiderivati,sugli
adattamenti per la
televisione; gli studios
sono dunque anche
banche di prodotti
sottocopyright.Inoltre,
si
occupano
di
regolamentazioni, per
esempio negoziano con
la Mpaa per evitare
l’attribuzione di un
“rating” sfavorevole ai
film e, naturalmente,
coordinano
la
distribuzione nazionale
e internazionale. “In
termini generali, tutte
le
questioni
internazionali
sono
seguite direttamente
dalla
casa
di
produzione,
dal
momento che oltre il
50 per cento degli
incassi di un film viene
spesso
dall’estero,”
conferma
France
Seghers.IlfilmdiSony
Spider-Man 3, per
esempio, costato 380
milionididollari,neha
incassati
890
al
botteghino globale, di
cui 336 sul mercato
interno
americano
(Canada incluso) e 554
all’estero in 105 paesi
nel 2007. “Ormai ci
muoviamo
secondo
un’otticainternazionale
di business,” prosegue
France
Seghers.
“Abbiamo sempre di
più la consapevolezza
che quando facciamo
unfilm,lofacciamoper
il mondo intero. È una
realtà con una serie di
conseguenze.
Per
esempio, i film sono
concepiti fin dall’inizio
in funzione dei mercati
internazionali su cui
vogliamo
andare.
Ovunque nel mondo i
nostri prodotti devono
essere desiderati e
questo desiderio deve
essere preparato; farlo
è un mestiere.” France
Seghers
percepisce
una certa sorpresa da
partemiadifrontealla
pianificazione di cui
parla. Allora batte il
chiodo: “Qui stiamo
parlando di un settore
industrialeenonsipuò
capire Hollywood se
non se ne misura
interamente la portata.
Non
facciamo
artigianato,voifrancesi
siete degli artigiani.
Voi
volete
avere
successo nel mondo,
ma non fate le cose in
grande. Siete diffidenti
verso gli studios, verso
il denaro, verso il
pubblico, temete che
possano
compromettere
la
vostra
arte.
Siete
sospettosi verso il
successo e dubitate
della sincerità del
pubblico. Noi invece
amiamoilpubblicocon
passione, lo amiamo
cosìtantochevogliamo
conquistarlo in massa,
ovunque si trovi, in
tutto il mondo. Questo
è il cinema”. Conclude
poi la sua requisitoria
citando una celebre
frasedell’imperatoredi
Hollywood
Samuel
Goldwyn:
“Questa
industria non è stata
chiamata show-art, ma
show-business”.
Qualche ora dopo,
continuando la mia
visita all’interno degli
studios Sony Pictures,
resto sorpreso da una
serie di piccoli edifici
che, mi si dice, sono
quelli dei “produttori
indipendenti”. Davvero
non mi capacito di
vedere
produttori
indipendenti all’interno
di Sony Pictures. “Sì,
abbiamo tutta una
serie di produttori
indipendenti legati alla
nostra società, come
accade per tutte le
altre major,” mi dice
France Seghers. “Sono
nostri dipendenti o
lavorano
su
commissione e questo
ci dà il diritto di
esercitarequellochesi
chiama ‘first look’, nel
sensochesiamoiprimi
a valutare il progetto e
abbiamo il diritto di
prelazione,
ma
se
rifiutiamo,ilproduttore
è libero di andare a
proporloaltrove.”
Alla caffetteria di
Sony pranzo insieme
all’équipe
di
Imageworks, il settore
effetti speciali di Sony
Pictures. Il cibo è
sorprendentemente
buono
e
raccolgo
numerose informazioni
sul
digitale
e
l’evoluzione
delle
tecnologie.
Nel
pomeriggio visito con
loro
l’unità
specializzataemiviene
regalata una maglietta
da riprese, di quelle
chesiindossanosulset
e con grosse scritte
come
“Regista”,
“Ingegnere del suono”,
“Capo
macchinista”.
Sulla mia c’è scritto
“Writer”,
scrittore.
Raramente sono stato
accolto
con
tanta
gentilezza
negli
stabilimenti di una
major americana. Già,
americana
o
giapponese?
“Sony Pictures è di
proprietà
di
una
multinazionale
giapponese. Ma siamo
una major americana,”
conferma
France
Seghers. “I giapponesi
ci hanno acquisito
proprio
perché
restassimo americani.
Non hanno voluto che
facessimo
film
giapponesi. Del resto,
non saremmo capaci di
farli.”Restostupitonel
vedere
nel
suo
immenso ufficio una
grande locandina di
Spider-ManIII.Èpiùdi
un simbolo, è il poster
in versione giapponese
di uno dei film più
costosi della storia,
prodotto da una casa
americanapercontodi
ungruppogiapponese.
“Non abbiamo dato
green light a SpiderMan”
Sony City. Qualche
settimana dopo mi
trovoallasedecentrale
di Sony, nel quartiere
Shingawa nella zona
sud-ovest di Tokyo. La
casamadredelgruppo,
in
Giappone,
è
compostadatretorridi
vetro, la più alta delle
quali è nota per essere
quella che ospita il
consiglio
d’amministrazione
della multinazionale.
Tutte
le
decisioni
strategiche di Sony
sono prese qui: quelle
sull’elettronica
destinataaunpubblico
di massa, sui telefoni
cellulari Sony-Ericson,
sui computer, sulla
Playstation e la Psp,
sulle
televisioni
a
pagamento via satellite
di SkyPerfect Jsat in
Giappone, ma anche le
decisioni
sui
“contenuti”. In sintesi,
Sony possiede due
delle principali major
mondiali del cinema e
della musica, Sony
Pictures Entertainment
e
Sony
Music,
disseminate
in
numerose
filiali
americane: gli studios
Columbia,
TriStar
Pictures, Sony Pictures
Classics e il 20 per
cento
di
Metro
Goldwyn
Mayer;
mentre per la musica,
Cbs Music, Columbia
Records,Arista,Rcaed
Epic. Nel complesso,
dalla casa madre di
Tokyo dipendono mille
società e filiali. Se in
Europa e negli Stati
Uniti Sony è nota per
essere un’azienda di
elettronica che ha
intrapreso la via del
cinema e della musica,
in Giappone è una
grande azienda di
fondamentale
importanza
che
fornisce ai giapponesi
numerosi prodotti e
servizi, dai servizi
bancari
alle
pile
elettriche e addirittura
foiegras.
Quando arrivo nel
suo ufficio di Tokyo,
Iwao Nakatani sta
lavorando
a
un
computer
Sony
all’ultimo grido. Iwao
Nakatani ha studiato a
Harvard,
è
stato
consulente economico
del primo ministro
giapponese, è rettore
di
un’importante
universitàdiTokyo,dal
1999 è membro del
“board” di Sony ed è
stato presidente del
consiglio
di
amministrazione
dell’intera Sony dal
2003 al 2005. È lui ad
aver nominato il nuovo
amministratore
delegato
di
Sony,
l’inglese sir Howard
Stringer, ex manager
di Cbs. Dopo il piacere
del solito scambio di
biglietti da visita e i
reciproci ossequi, Iwao
Nakatanientranelvivo
dell’argomento.
“Il
compito di Sony è
offrire alle persone di
tuttoilmondoilmeglio
del divertimento, per
questo diamo loro, nel
contempo, hardware,
dispositivi,
software,
programmi
e
contenuti,” mi dice
Nakatani parlando in
giapponese (non ha
voluto
parlare
in
inglese e con me c’è
un’interprete).
Perché
vi
siete
lanciatisulmercatodei
contenuti, se i settori
storici di Sony erano
l’elettronica
e
l’informatica per un
mercato di massa?
“Bella
domanda,”
risponde
Nakatani.
“Qui a Tokyo siamo
molto
legati
all’hardware, mentre i
contenuti
sono
soprattutto
appannaggio
degli
americani, per questo
abbiamo acquisito una
major come Columbia.
Avevamo bisogno di
contenuti, è stata una
scelta
puramente
economica e dovevamo
gestire il gruppo in
modo
verticale,
secondo una strategia
che tenesse insieme
dispositivi, contenuti,
cinemaemusica.Tutto
ciò è accaduto prima
che io arrivassi alla
Sony. Ma il problema
di Sony sta proprio
nell’articolazione tra la
sede di Tokyo e le
numerose filiali che
controlla,
che
appartengono a Sony
madevonoavereanche
una
certa
libertà.
Comprare una società
è facile, difficile è
gestirla
e
farla
funzionaredalontano.”
Il
problema
principale di Sony,
infatti,
riguarda
essenzialmente
i
contenutiperilcinema
e la musica, mi
conferma
qualche
giorno dopo a Tokyo
Shuhei
Yoshida,
amministratore
delegato
di
Sony
Computer
Entertainment
Worldwide
Studios.
Secondo l’uomo che
coordina la produzione
diunamiriadedigiochi
perlaPlaystationIII,la
questionedeicontenuti
varia a seconda dei
settori:“Nelcinema,la
trama è fondamentale;
nei videogiochi le cose
più importanti sono la
funzionalità e il grado
di interattività. Questo,
in Giappone, sappiamo
farlo. Facciamo ‘focus
group’ e ‘play testing’
fino a quando non
abbiamo trovato la
soluzione migliore. Gli
americani sanno fare
meglio
musica
e
cinema,
noi
i
videogiochi”.
Affermare
valori
giapponesi è parte
dellastrategiadiSony?
Vuole
fare
imperialismoculturale?
“Non credo,” mi dice
IwaoNakatani.“Sonyè
percepita come una
società apolide, senza
nazionalità.
Le
circostanze
hanno
voluto che avesse sede
in Giappone, ma non
abbiamo mai avuto la
volontà di imporre i
nostri valori o di
dominare attraverso i
nostri contenuti. Non è
nella nostra mentalità.
Del resto, diamo carta
bianca agli americani,
loro
gestiscono
liberamente i settori
cinemaemusica.”
Per capire meglio
come funziona la casa
madre, chiedo a Iwao
Nakatani
(all’epoca
presidente di Sony)
quando la direzione
giapponese di Sony è
stata informata da
Sony
Pictures
americana
della
decisione di fare i tre
film Spider-Man, tra i
piùcostosidellastoria,
e quando è stata data
luce verde. Nakatani
mi
risponde
con
precisione:
“Dal
Giappone non è stata
maidataluceverdeper
Spider-Man.
Non
abbiamo né visto né
approvatoilbudgetdel
film. È stata una
decisione interamente
presa da Sony Pictures
Entertainment
negli
Stati Uniti. Da Tokyo
non siamo in grado di
fare
considerazioni
ponderate in materia,
ci fidiamo delle nostre
équipe
negli
Stati
Uniti”.
Questa
dichiarazione
è
cruciale
per
comprendere
le
industrie internazionali
deicontenuti.
Ho appreso poi da
Takashi
Nishimura,
direttorediUnijapan,e
da Junichi Shinsaka,
direttore della Motion
Picture Producers of
Japan (Eiren), due dei
principali
organismi
professionali
di
regolazione del cinema
giapponese che, “nelle
statistiche
dell’industria
del
cinema
giapponese,
Sonyèconsideratauna
società ‘straniera’ e
non ‘nazionale’. Per
comprendere
meglio
questo dato essenziale,
è necessario sapere
che il settore cinema
dà un apporto scarso
agli introiti globali di
Sony (19 per cento nel
2003,
quota
non
lontana dagli altri
conglomeratimediatici:
Paramount incassa il 7
per cento degli introiti
di
Viacom,
20th
Century Fox il 19 per
cento di News Corp,
Warner il 18 per cento
di
Time
Warner,
Universal aveva meno
del 2 per cento degli
introiti di General
Electric
prima
di
essere acquisita da
Comcast e il cinema
rappresenta il 21 per
cento
in
Disney
Corporation).
Intervisto allora l’ex
presidente di Sony per
sapere se accade la
stessa cosa con la
musica. Nakatani mi
dice: “Qui a Tokyo non
abbiamo competenze
néperilcinemanéper
la
musica.
Non
decidiamoenondiamo
luce verde finanziaria,
né sui progetti di Sony
Music né su quelli di
Sony Pictures negli
StatiUniti”.
Queste risposte sono
significative
e
attestano che la casa
madreSony,perlesue
società,
svolge
semplicemente
la
funzione di una banca,
nulla di più. Iwao
Nakatani non contesta
questo tipo di analisi.
Ma allora Sony deve
continuare a occuparsi
di
contenuti?
In
Giappone non si dice
mai “no”. Nakatani
esita
prima
di
rispondere: “È una
cosa che continuo a
chiedermi. Fin quando
ci sono guadagni non
abbiamo urgenza di
cambiare, ma se il
gruppo avesse bisogno
di
liquidità,
forse
dovremmo pensare di
vendere il settore del
cinema o della musica.
Dal mio punto di vista
credo
che
Sony,
lanciandosi
nei
contenuti, abbia perso
potenza e specificità.
Inoltre, contrariamente
a quanto pensavamo
all’inizio, gli addetti
dell’hardware e quelli
dei
contenuti
non
riescono a lavorare
insieme. L’esperienza
di Sony-Bmg in ambito
musicale
è
fallita
perchénonsiriuscivaa
lavorare con l’azienda
tedesca Bertelsmann.
Tra Giappone, Europa
e Stati Uniti c’è troppa
distanza, non solo
geografica, ma anche
culturale, e ciò non
facilitalecose”.
In Giappone, Sony
non ha divisioni per il
cinema e c’è solo un
modestoufficiodiSony
Music che si occupa
esclusivamente
di
musica giapponese. Ho
visitato gli uffici di
Sony negli Stati Uniti,
in Giappone, ma anche
a Singapore, Hong
Kong,Giacarta,IlCairo
e la maggior parte dei
miei interlocutori, che
lavorassero per la
musica o il cinema, mi
ha confermato queste
informazioni. Peraltro,
tutti mi hanno detto di
dipendere da Sony
americana,
non
giapponese.
Sony
Music è una vera e
propria
major
discografica
americana, come Sony
Pictures è una casa
cinematografica
americana.
Da Culver City a
Century City, dagli
studios americani di
Sony alla torre della
Metro Goldwyn Mayer
ci sono meno di cinque
chilometri in linea
d’aria,maperarrivarci
in auto ci si può
impiegare
anche
un’ora, dato il traffico
di Los Angeles. A
Century City ogni cosa
evoca il cinema. Le
strade si chiamano
Avenue of the Stars,
Fox Hills e Mgm Drive
e gli studios della 20th
Century Fox occupano
tutta la zona sud del
quartiere. Il Fox Plaza,
che abbiamo visto
esplodere in film come
FightClub e Die Hard,
è un grattacielo di
trentacinque piani ben
riconoscibile
da
lontano.
Altrettanto
ben
visibile
è
l’immenso
edificio
bianco
dell’agenzia
Creative
Artists
Agency, costruito sul
terreno
precedentemente
occupato dalla torre
della catena televisiva
Abc (oggi situata nella
valley a Burbank, nel
Nord di Los Angeles,
all’internodellasededi
Disney
che
l’ha
acquisita).
Al
civico
1999
dell’Avenue of the
Stars si trova la torre
della
banca
J.P.
Morgan. Mentre salgo
al ventiseiesimo piano,
mi rendo conto che in
questatorrecisonogli
uffici di altre banche,
Lazard
Frères
all’undicesimo, Morgan
Stanley
al
ventitreesimo, Ubs al
trentaquattresimo. Mi
trovo
nel
quartier
generale che finanzia
Hollywood
e
ho
appuntamento con Ken
Lemberger.
KenLembergerèl’ex
vicepresidente di Sony
Pictures Entertainment
e uno dei patron di
Hollywood.Oggilavora
nel
settore
di
finanziamento
del
cinemaedirigel’ufficio
“Entertainment” della
banca J.P. Morgan in
qualità di “J.P. Morgan
Entertainment
Advisor”.
L’obiettivo di questo
incontro è cercare di
capire se le banche
investono a Hollywood
o
se
sono
semplicemente agenzie
di credito. “Le banche
sono
un
soggetto
importante
del
finanziamento
di
Hollywood, ma restano
un
soggetto
marginale,” chiarisce
subito Ken Lemberger.
“Le vere banche sono
gli stessi studios che
investonoillorodenaro
per realizzare i film. Il
nostro
ruolo
è
soprattutto quello di
apportare
loro
la
liquidità
necessaria,
ovvero
garantire
credito, a partire dal
denaro che è stato
promesso
loro
da
numerosissimi partner,
ma che non hanno
ancora incassato. Non
si tratta dunque di
investimenti a fini
speculativi,
ma
di
prestiti di liquidità a
partner deboli. Il mio
lavoro è fare da
consulente
a
J.P.
Morgan
in
queste
attività.
Tutte
le
banchehannoreclutato
come consulenti ex
managerdellemajordi
Hollywood.”
Ken
Lemberger prende da
un tavolo in vetro un
volume di duecento
pagine, uno studio
statistico sul mercato
della televisione in
India per mostrarmi la
complessità del settore
che deve analizzare.
Sultavolocisonopoiil
“WallStreetJournal”,il
“Financial Times”, ma
non il “Los Angeles
Times”.Sologiornalidi
finanza, nessuno di
cinema.
All’interno
dell’economia globale
del cinema americano,
e tra la moltitudine di
soggetti
che
contribuiscono a far
funzionare Hollywood,
mi chiedo chi sia,
allora, il vero padrone:
lebanche,glistudioso
leagenzieditalenti?
Ormai a Hollywood è
calata
la
sera.
Comodamente seduto
inunosplendidodivano
inpelle,alcentrodiun
ufficio gigantesco i cui
muri sono coperti di
celebri opere d’arte
provenienti
da
collezioni private della
banca e con alle sue
spalle una magnifica
vista di Los Angeles
illuminata all’infinito,
Ken Lemberger mi
risponde
in
modo
categorico:
“Contrariamente
a
quanto si crede, a
Hollywoodc’èunsoloe
unico padrone. Non
sono le banche, né i
produttori,
né
le
agenzieditalenti,néle
star
multimilionarie,
sono
gli
studios.
L’unica domanda che
ha senso fare è la
seguente:chisiassume
i rischi? La risposta,
senza esitazioni, per
tutti i principali film
mainstream, è: gli
studios. Gli studios
sono i risk-takers. In
questosistema,tuttigli
altri soggetti, e sono
numerosi, sono pagati
e riescono sempre a
sfangarla
indipendentemente dal
risultato al botteghino.
Gli unici ad assumersi
rischi finanziari sono
gli studios. Forse li si
può rimproverare di
essere troppo prudenti
nel dare green light, li
si
può
trovare
eccessivamente
prudenti,
troppo
mainstream o troppo
innovativi. Ma la verità
è che tutti alla fine
vengono pagati e gli
unici ad assumersi dei
rischi sono gli studios.
Trovo dunque normale
che siano loro a
detenereilpotere”.
Il ragionamento non
fa una piega, ma non
mi convince del tutto.
Le banche sono un
soggetto periferico sul
fronte del cash flow,
ma sono un soggetto
importante
sul
versante “speculativo”,
tema di cui Ken
Lemberger ha taciuto
nel nostro incontro.
Con
la
finanziarizzazione
dell’economiaavvenuta
negli anni ottanta e
novanta,iconglomerati
mediatici sono oggi
fortemente soggetti a
unalogicacapitalistica,
soprattuttoattraversoi
fondi pensione, gli
hedge fund e i mutual
fund. La ripartizione
del capitale all’interno
di
queste
multinazionali
è
dunque una questione
di grande portata e
tutte queste complesse
operazioni di Borsa
sono realizzate dalle
banche,
come
J.P.
Morgan, e dai suoi
consulenti, come i “J.P.
Morgan Entertainment
Advisors”.
Il marketing, ovvero la
transumanza
tra
i
media
Rimango all’interno
di
Century
City,
attraverso il quartiere
apiediperraggiungere
la Mgm Tower. Dal
2001, questo palazzo è
la sede della Metro
Goldwyn Mayer ed è
ben riconoscibile da
lontano per il leone, il
celebreleoneruggente.
La torre, tuttavia, non
ospita solo la major
hollywoodiana,
molti
uffici sono affittati a
societàesterneofiliali.
All’undicesimo piano
della
Mgm
Tower
incontro Dennis Rice,
che mi riceve negli
uffici della United
Artists.
“Il
nostro
azionista principale è
Mgm, ma detengono
quote di United Artist
ancheSonyeComcast,
20 per cento ciascuna,
e tra i nostri azionisti
di minoranza ci sono
anche cinque fondi di
investimento e Tom
Cruise,”midiceDennis
Rice, uno degli uomini
di
marketing
più
rinomati di Hollywood
e
copresidente
di
United Artists. Ua era
ilpiùpiccolodeigrandi
studios hollywoodiani.
Apparteneva un tempo
a Charlie Chaplin e
D.W.Griffithedèstato
a lungo indipendente.
Ha prodotto film come
Scarface, High Noon,
West Side Story, la
saga di James Bond e
Rocky e di recente
BowlingaColumbinedi
Michael Moore. Dalla
fine
degli
anni
sessanta,
United
Artists
è
stata
dichiarata, di volta in
volta,
clinicamente
mortaocompletamente
rinata, in relazione a
quando era acquisita o
rivenduta (per esempio
dalla banca francese
Crédit Lyonnais, nel
1992).
“Contrariamente
a
quanto pensa la gente,
lanazionalitàdeinostri
azionisti conta poco.
Facciamo sempre film
americani, ovvero film
universali,” obietta il
mio
interlocutore.
Dennis Rice dirige il
marketing su scala
mondiale di una major
importante che oggi
produce o distribuisce
una ventina di film
all’anno e descrive in
questo modo la sua
strategia
internazionale: “Ogni
film è un pezzo unico,
non siamo un’industria
ordinaria come Ford o
Coca-Cola,
siamo
un’industria creativa.
La particolarità di
Hollywood
sono
i
prodotti unici, anche
quando
produciamo
serie come quella di
James Bond. Per ogni
film
bisogna
ricominciare
tutto
daccapo. La pubblicità
di chi vende Coca-Cola
ha
un
effetto
immediato, ma anche
più
duraturo;
la
pubblicità di un film
invece viene usata una
solavolta”.
Anche il marketing
deifilmèdunqueunico
e ormai ha raggiunto il
50 per cento delle
spese complessive. La
produzione di SpiderMan 3 è costata 380
milionididollari,dicui
260 milioni per il film
(detto negative cost) e
120 milioni per il
marketing
globale.
Date le cifre, è lecito
pensare
che
la
promozione del film
vada spesso meglio
dello
stesso
film.
Almeno, così è stato
scrittodallemalelingue
per
il
remake
americanodiGodzilla.
“La
campagna
internazionale
di
marketing è finanziata
principalmente
dalla
major,” spiega Dennis
Rice, “ma il marketing
per un film è deciso
sempre a livello locale,
dalle persone che sono
sul
posto.
Guardi
questa tabella.” Mi
mostra una previsione
del
budget
del
marketing paese per
paese per il film
Truman Capote. A
sangue freddo, con la
quota della major e la
quota locale finanziata
da distributori, gestori
di sale e aziende
partner che curano il
merchandising. “Come
vede, si tratta di cifre
moltodiversetraloroe
all’estero si spende
davvero poco rispetto
agli Stati Uniti, anche
quandositrattadifilm
di
successo.
Soprattutto, i capitali
investiti
sono
concentrati
su
un
numero ristretto di
mercati, in prevalenza
Giappone, Germania,
Regno Unito, Spagna.
In una sessantina di
altri paesi non si
investequasinulla.”
Durante il nostro
incontro Dennis Rice
ha
l’aplomb
del
professionista,dauomo
di marketing fornisce
dati, risponde con
cortesia
alle
mie
domande,vadrittoalle
questioni
essenziali,
non fa trapelare né
sensazioni di fastidio
né entusiasmo, tranne
che in un’occasione.
Quando gli parlo di
Cina e India, Dennis
Rice s’infiamma: “Ma
leiriesceaimmaginare
i potenziali introiti per
Hollywood in Cina e in
India!”. Con dispiacere
mi spiega poi le attuali
difficoltà dovute alla
censura,
alle
percentuali
sugli
incassi
e
alla
distribuzione,allequali
deve far fronte in
questi
paesi.
SpecialmenteinCina.
Oggi, United Artists,
come gli altri studios,
ha un forte impatto sul
box-office
internazionale,cheèin
continuo aumento. Nel
2000ilmercatointerno
americano
fruttava
circa il 50 per cento
degli introiti (l’altra
metà proveniva dal
mercato
internazionale). Oggi,
secondo i dati che mi
fornisce,
la
quota
interna è del 40 per
cento,quellaesteradel
60
per
cento.
L’inversione
delle
proporzioni
tra
mercato interno ed
esterno è avvenuta di
recente, tra la metà
degli anni novanta e i
primianniduemila.“La
globalizzazione
del
cinema hollywoodiano
sta
trasformando
profondamente i film
che facciamo, persino
la scelta dei nostri
attori.Perarrivareagli
spettatori di tutto il
mondo,
abbiamo
bisogno di star di
primo piano e di storie
con un valore più
universale.
Noi
facciamo
già
intrattenimento,maqui
si tratta di fare
intrattenimento
globale,”
constata
Dennis
Rice.
Poi
aggiunge:
“Siamo
pronti ad accettare la
sfida. Continuiamo a
pensare di poterci
espandere in Cina,
India,Brasile,Messico,
MedioOriente,Europa.
Da tempo ormai non
facciamo
più
film
strettamente
americani,maogginon
abbiamopiùscelta:per
riuscire a parlare al
mondo intero, la nuova
Hollywood,
talmente
globalizzata, deve fare
film universali. (Dopo
l’intervista,
Dennis
Rice ha dato le
dimissioni da United
Artists in seguito a un
disaccordo con Tom
Cruiseelasuasociain
affariPaulaWagner.)
La
campagna
commerciale di un
lungometraggio
hollywoodiano è un
vero e proprio piano di
battaglia organizzato
su diversi continenti. È
la tappa fondamentale
di
ogni
film
mainstream.
Negli
ultimi
trent’anni,
queste campagne sono
diventate sempre più
complesseeilorocosti
sono raddoppiati (circa
2 milioni di dollari in
media per un film di
unamajornel1975;39
milioni in media nel
2003, ma si è arrivati
anche a oltre 100
milioni per grandi film
commerciali
come
Matrix e Pirati dei
Caraibi). I direttori del
marketing
che
ho
incontrato
nei
principali studios di
Los Angeles e i
pubblicitari intervistati
sulla Madison Avenue
(quartiergeneraledelle
agenzie di pubblicità a
New York) mi hanno
descritto il loro piano
di
conquista
del
pubblicodimassa.
Prima di dare il via
liberaaunfilm,lacosa
più
importante
è
determinare il suo
potenziale
pubblico.
NegliStatiUnitiquesta
operazione
si
fa
generalmente
seguendo tre criteri:
l’età (più o meno di
venticinque anni); il
genere
(uomo
o
donna); infine il colore
della pelle (bianchi e
“non-bianchi”).
A
partire
da
queste
categorie, si fissa il
target del potenziale
pubblico, per esempio
“gli uomini bianchi di
meno di venticinque
anni”.
L’ideale
consiste, naturalmente,
nel produrre ciò che si
chiama “four-quadrant
film”, pellicole con un
pubblico potenziale di
uominiedonneattorno
ai venticinque anni; il
rischiomaggioreèfare
un film che possa
piacere
solo
alle
ragazze di meno di
venticinque
anni,
poiché tutti gli studi di
mercato
dimostrano
che queste ragazze in
genere accompagnano
ifidanzatiavederefilm
d’azione, mentre i
maschi non vanno mai
alcinemaavederefilm
da
“ragazze”
(che
dunquesonorari).
Si fanno poi i focus
group, strumento per
eccellenza
del
marketing
hollywoodianoapartire
dagli anni ottanta. Si
tratta
di
studi
qualitativi
che
consistono nel porre
domande approfondite
a un numero ristretto
di persone selezionate,
invece di domande
superficiali a un ampio
campione di persone. I
focus
group,
accompagnati da test
screening e completati
da
sondaggi
quantitativi
per
affinare il pubblico
mirato,
aiutano
i
responsabili
del
marketing a prendere
le
decisioni.
Si
intervistano gruppi di
persone
che
appartengono
potenzialmente
al
target per capire ciò
chepensanodelfilm,e
generalmente,aquesto
stadio, si racconta loro
latrama,gliattori,esi
mostranoiprimitrailer
per studiare le loro
reazioni. In base ai
risultati si avvia una
pre-campagna
nei
cinema per annunciare
il film, mentre le
trasmissioni televisive
a grande audience e i
talk-show delle reti di
proprietà delle major
sono utilizzati per
lanciare il “buzz”, il
passaparola.
A partire da queste
prime campagne, sono
avviati nuovi focus
group per valutare il
livello generale di
informazione sul film e
la sua presa nella
memoria del pubblico
dimassa(aHollywood,
un
direttore
di
marketing mi parla di
stickness del film, se
“resta
ben
appiccicato”). Si fanno
poi i test screening,
proiezioni del film,
anche se incompiuto,
davanti a nuovi focus
group. Si elabora così
un
indice
di
soddisfazione
e
si
affina
il
pubblico
potenziale. A questo
stadio, i direttori del
marketing sono in
grado di prevedere il
successo del film con
uno scarso margine di
errore,secondoloro.In
relazione ai risultati di
questostudio,èancora
possibile modificare la
data d’uscita e ridurre
la durata del film
(“oltre l’ora e venti i
minuti valgono doppio,
e triplo dopo l’ora e
trenta,” mi dice un
produttore).
Inoltre,
alcune scene possono
essere
tagliate,
attenuateotrasformate
(a partire dai rushes –
cioèleprimescenenon
editate di un film – si
aggiunge per esempio
una scena d’azione se
si tratta di un film
estivoperigiovani,dal
momento che tutti gli
studi
sul
pubblico
confermano
che
i
giovani
maschi
preferiscono
scene
d’azione a scene di
dialogo). Anche il lieto
fine
può
essere
modificato,
se
necessario.
Queste
operazioni di postproduzione
sono
delicate: in inglese si
dicechedevonoessere
fine tuned, regolate
con precisione, poiché
si tratta di dare al
prodotto
la
sua
identità,lasuapotenza
mainstream,
senza
farlo diventare troppo
banalenétroppobland
(insulso e monotono,
come spesso si dice
della cultura popolare
americana).Ilfilmdeve
essere nel contempo
per un ampio pubblico
(sidicecrowd-pleasero
crowd-puller, cioè che
attira le masse), ma
anchenuovoeunico,la
storia
deve
dare
l’impressione che si
tratti di qualcosa di
“speciale”.
Quel
“qualcosa di speciale”
è fondamentale: è dato
dallatrama,dagliattori
e dagli effetti speciali,
malapostproduzionee
il marketing hanno la
funzione di accrescerlo
e
moltiplicarlo.
In
questo modo, un film
diventa un feel-good
movie (un film che dà
allo
spettatore
la
sensazione di stare
bene), accelera il suo
ritmo, diventa più
energico o upbeat
(ottimista
e
combattivo). Talvolta,
sipuntasulfattocheil
filmsiabasedonatrue
history, oppure sul
protagonista
bigger
than
life,
per
accentuare
l’identificazione
del
pubblico. Si cerca in
definitiva
di
trasformare
un
semplice prodotto in
ricordi, esperienze e
stilidivita.
A partire da qui si
fanno i piani e gli
stanziamenti
della
promozione,
si
stabiliscono
il
contenuto dei trailer e
il numero delle copie
editate, che per il film
di una major può
oscillare tra novecento
per i cinquanta stati
americani e diverse
migliaia (Batman. Il
cavaliere oscuro, nella
prima
settimana
d’uscita era su 4366
schermi negli Stati
Uniti).
Per i film più
mainstream,
queste
campagne e i focus
group sono organizzati
molto prima della data
di uscita del film (i
primi tesears, video
promozionali,
di
Spider-Man erano in
sala un anno prima).
Nella
strategia
di
marketing ci sono
anche i “prodotti tieins”,iprodottiderivati,
che accompagnano in
negozi
e
fast-food
l’uscita
di
film
mainstream
come
Guerrestellari,Shreke
La nascita dei cobra.
Sono
prodotti
che
contribuiscono
al
finanziamento dei film,
garantiscono
un’ulteriore
mediatizzazione
e
hanno il vantaggio di
essere integralmente
pagati dalle catene di
negozi e fast-food. Per
il ritorno sugli schermi
di Guerre stellari, nel
1999, ciascuna delle
tre catene controllate
da Pepsi-Cola (Kfc,
Taco Bell e Pizza Hut)
ha propagandato un
pianetadiversoeisuoi
personaggi.
L’ultimo stadio della
campagna
è
comunemente
chiamato “drive” – da
cattle
drive,
la
transumanza
del
bestiame
nell’Ovest
americano.
Consiste
nel martellare il nome
del film e degli attori
con tutti i mezzi
possibili, su tutti i
supporti e in diversi
continenti nello stesso
tempo,
nelle
due
settimane
che
precedono l’uscita del
film per motivare il
pubblico ad andare a
vederlo. Diversamente
dalla diffusione dei
trailer, che è gratuita
inseguitoaunaccordo
che risale all’epoca in
cui le major erano
proprietarie delle sale,
queste campagne sono
estremamente onerose.
Tanto più che si fanno
soprattutto
acquistando
spazi
televisivi, e queste
sono
le
uniche
pubblicità realmente
efficaci nel coinvolgere
il pubblico di massa
che può diventare
potenzialmente
spettatore al cinema,
secondo tutti i miei
interlocutori
a
Hollywood(nel2003gli
studios hanno speso
3,4miliardididollariin
spazi
televisivi
di
grandi network come
Nbc, Cbs, Abc o di
emittenti
specifiche
come Hbo o Mtv, che
appartengono proprio
aglistessiconglomerati
deglistudios).
Senza giri di parole,
James
Schamus,
amministratore
delegato
di
Focus
Entertainment,
è
categorico: “La cosa
decisiva è il battage
televisivo. È triste a
dirsi, ma è ciò che non
hanno
capito
i
giapponesi.
In
Giappone, Hollywood è
riuscita a imporre il
cinema
americano
attraverso la pubblicità
intelevisione,inquesto
modo è stato ucciso il
cinema
giapponese.
Abbiamo
investito
unicamente
sulla
televisione,
abbiamo
speso milioni di dollari
in marketing e i
giapponesi non sono
riusciti a stare al
nostropasso”.
La densità della
campagna finale, un
vero e proprio attacco,
è tipica della nuova
Hollywood in cui il
successo di un film è
decretato spesso dal
botteghino del primo
fine settimana (detto
opening-weekend
gross). In precedenza,
un film aveva tempo di
farsi vedere e le
campagne
potevano
durare diversi mesi, in
relazione alle critiche
della stampa e al
passaparola;
oggi
invece tutte le spese
sono concentrate nella
settimana dell’uscita,
decisiva e in grado di
determinare – con il
sostegnodialcunistudi
sulle uscite dalla sala,
che ricordano molto i
sondaggi che si fanno
all’uscita dalle urne
duranteleelezioni–,la
duratadivitadelfilme
la data d’uscita in
versionedvd.
La
macchina
di
Hollywood non deve il
suo
successo
unicamente
alla
ricchezza delle case di
produzione, ma anche
alla professionalità e
allacomplessitàdelsuo
sistema, capace di
adeguare
continuamente i suoi
mezzi in funzione del
pubblico. L’offerta si
adatta costantemente
alla
domanda
e
viceversa. Il marketing
è al centro della
fabbricazione
mainstream.
del
Queste campagne di
marketing, tradizionali
e di massa, erano ben
rodate fino all’avvento
di internet, che ha
cambiato
completamente
lo
scenario.
Ieri
il
pubblico
era
dipendente
dalle
informazioni fornite e
controllatedallemajor;
oggi
invece
può
informarsiliberamente,
èpiùdiffidentee,come
mi dice un infastidito
importante direttore di
marketing:
“Con
internet il pubblico è
diventato
più
sospettoso rispetto al
marketing, ma riesce a
riconoscere,
indipendentemente
dalle nostre strategie,
ilbuonfilmdalcattivo,
in pratica il pubblico
oggi è intelligente”.
Inoltre, la fuga di
immagini
è
ormai
ordinaria in rete. Le
immagini delle riprese
sonomessesuYouTube
e rovinano piani di
comunicazione
ben
costruiti. Gli stessi film
sono ormai spesso su
internet ancor prima
dellaproiezioneinsala.
Il mercato dei dvd è
fortemente messo in
discussione e molti
prevedono
la
sua
scomparsa a breve
termine.
Dopo aver dichiarato
guerra
a
internet
all’inizio del nuovo
millennio – guerra
ovviamente persa con
una sonora sconfitta –
gliaddettialmarketing
di Hollywood si sono
infinemessiadialogare
con la rete invece di
combatterla.
Sono
passati
dal
confezionare prodotti
di massa a campagne
non
tradizionali
condotte da decine di
tecnici specializzati del
marketingonline.Oggi,
la
campagna
di
promozione dei film
include completamente
la dimensione web.
Vengono
utilizzati
strumenti
ormai
classici
come
la
creazione
di
siti
specializzati o il lancio
di
forum
online,
vengono scritte pagine
wikipedia dagli stessi
servizi marketing (cosa
poco conforme alle
regoledelweb2.0).Le
nuove
strategie
comprendono anche la
diffusione “illegale” di
spezzoni di film su siti
come YouTube, un
modoperraggiungerei
giovani, suscitare il
“buzz” e il marketing
virale.Quasisemprein
ritardo rispetto alla
realtà,
gli
studios
hanno cominciato a
credere in MySpace,
quando una parte dei
suoi
membri
era
emigrata su Facebook,
hanno
privilegiato
Second Life quando il
sito era già stato
disertato, e alla fine si
sono riconvertiti a
Facebook,
dimenticando Twitter
nel momento in cui gli
iranianilorivelavanoal
mondo. Inizialmente, i
blogger
che
diffondevano le voci e
svelavanosegretierano
minacciati di denuncia,
poi sono stati presi sul
serio: per esempio
Nikki Finke, autore del
blog
Deadline
Hollywood, oggi è
vezzeggiato come le
più grandi firme del
“LosAngelesTimes”.
È stato adattato al
web ciò che esisteva
già in precedenza. Per
esempio,iblurbs,brevi
citazioni
a
fini
promozionali richieste
a un critico o a un
personaggio
famoso
prima dell’uscita di un
film o di un libro, sono
oggi messi sui blog o
diffusi
su
internet
attraverso l’acquisto di
spazi pubblicitari. Il
marketing
del
passaparola (“word-ofmouth marketing”) è
stato adattato alla rete
attraverso
società
specializzate
come
Buzzmetrics (acquisita
da Nielsen), che lancia
campagne passaparola
sulweb.Altristrumenti
come
BuzzTracker,
BuzzAudit,
MediaPredict e Homescan
Online, permettono di
valutare lo stato del
“passaparola” di un
film
in
rete,
di
conoscere
le
“conversazioni”
in
corso sul tema su
internet e di seguire in
direttatuttiicommenti
postatisualcunibloge
alcuni forum. Quando
questobuzzsifacritico
e mette in pericolo il
“buon” passaparola (il
sito
specializzato
BuzzThreatTracker
sorvegliaquestotipodi
minaccia) attiva una
controffensiva
con
nuove campagne. Con
questi contatti diretti
tra
marketing
e
pubblico,
internet
restituisce un senso
alla classica formula di
un
produttore
di
Hollywood: il pubblico
è il coautore del film
(“The audience as coauthor”).
Globalmente,
la
strategiadelmarketing
internet degli studios
consistenelconfondere
la
linea
di
demarcazione
che
separa pubblicità e
informazione in modo
che
l’intrusione
pubblicitariasiameglio
tollerata
e
forse
addirittura desiderata.
Questo, in fondo, è
diventato il buzz: il
passaparola diventato
marketing.
Il
monopolio
sindacati
dei
Al civico 7920 di
Sunset Boulevard nel
cuore di Hollywood ho
appuntamento qualche
giorno dopo con i
responsabili
della
Directors Guild of
America
(Dga),
l’onnipotente sindacato
dei registi. Anche in
questo caso, internet
ha
provocato
importanti
sconvolgimenti. Negli
ultimiannicisonostati
scioperi a ripetizione
per
imporre
agli
studios di inserire nei
contrattiremunerazioni
relativeainuovimedia.
“AllaDirectorsGuildof
America pensiamo che
il regista sia un
‘autore’.
Il
nostro
compito è proteggere i
suoi diritti in quanto
creatore, anche su
internet. Per questo
nonsiamounsindacato
vero e proprio, ma una
guild, una sorta di
corporazione
degli
autori,” mi dice Kathy
Garmezy, direttrice di
Dga. I sindacati e le
guildssonounsoggetto
importante del sistema
hollywoodiano. E per
quanto possa risultare
sorprendente in un
paese ultracapitalista
come gli Stati Uniti,
Hollywood
è
un’industriatotalmente
regolamentata, in cui i
sindacati
hanno
il
monopolio
sulle
assunzioni.
Da John Ford, uno
dei fondatori, a Steven
Spielberg,
passando
per Martin Scorsese o
Steven Soderbergh, la
maggior parte dei
registi del cinema e
della tv americani (con
la rara eccezione di
George
Lucas
e
Quentin Tarantino) ha
aderitoallaGuild.Ilpiù
celebrediquestiregisti
è Alan Smithee: “È lo
pseudonimo ufficiale,
inventatodallaDgaper
un regista quando non
è soddisfatto del film
perché è in disaccordo
sul final cut con la
major o il produttore.
In questo caso, il
membro della Dga
chiede di apparire con
lo pseudonimo Alan
Smithee”,
sorride
Kathy Garmezy. Sono
invece novecento i
registi in carne e ossa
che hanno lavorato per
il
cinema
e
la
televisione americani
iscrittiallaDgaeKathy
Garmezy insiste su
questopunto:“Ilfuturo
di Hollywood è nel
resto del mondo”. (Ma
invece non dice nulla
del lavoro che, su
pressionedeisindacati,
rende di fatto difficile
per
gli
stranieri
lavorare a Hollywood,
unsistemachesivanta
di
non
essere
protezionista.)
Per i suoi tesserati,
Dga si occupa di tutte
le
questioni
economiche e sociali
della professione, in
particolare
della
questione del salario
minimo,
della
coperturamedica,delle
condizioni di lavoro e
delle
pensioni,
negoziando
regolarmente e, se
necessario, duramente,
questeregolecollettive
conlemajorelaMpaa.
“Non facciamo per
nulla il lavoro degli
agenti o dei manager:
cioccupiamodituttoil
settore,
collettivamente,
in
modomutualistico,non
dei
contratti
individuali. Definiamo
gli
standard
della
professione,
obbligatoriamente
applicabili a tutti i
contratti ed è a partire
da
questi
minimi
sindacali
che
gli
avvocati e gli agenti
negoziano i contratti
individuali,”
spiega
KathyGarmezy.
Nessun contratto di
tutte le persone che
lavoranoperglistudios
o per la maggior parte
dei film indipendenti
sfugge alle regole
salariali e previdenziali
negoziate dai sindacati
e dalle società di
autori. Questa è la
particolarità
di
Hollywood:
è
nel
contempo un modello
interamente
commerciale
e
un
sistemacompletamente
sindacalizzato. La Dga
ha,
di
fatto,
il
monopolio
nelle
assunzioni dei registi.
Le
major
devono
passare per questa
organizzazione,
così
come devono passare
per la potente Screen
Actors Guild (Sag,
presiedutaasuotempo
da Ronald Reagan) per
scritturare un attore,
attraversolaProducers
Guild of America (Pga)
per i produttori, o per
la Writers Guild of
America (Wga) per
scritturare
uno
sceneggiatore.
La
stessa cosa accade per
i tecnici delle luci, del
suono, i direttori del
casting, le indossatrici,
i parrucchieri: sono
tutti
sindacalizzati.
“Probabilmente
Hollywood è il settore
piùsindacalizzatodegli
Stati Uniti,” conferma
Chuck Stocum, alla
direzione della Writers
Guild of America, che
raccoglie
la
quasi
totalità
degli
sceneggiatori
di
cinema e televisione
americani.
“Questo
monopolio
dell’assunzione si è
costruito nel tempo
grazie a un doppio
meccanismo
molto
efficace
da
noi
inventato.
Da
una
parte, imponiamo a
tutti i nostri membri di
lavorare solo per le
case cinematografiche
che hanno firmato un
accordo generale con
noi; dall’altra, i nostri
contratti
prevedono
una
clausola
obbligatoria per cui gli
studios
devono
scritturare unicamente
i nostri sceneggiatori,”
racconta
Chuck
Stocum.
Attraverso
questo
duplice
meccanismo,
gli
studios
sono
stati
progressivamente
obbligati a prendere
solo i membri della
Wga alle condizioni
sociali
e
salariali
minime fissate dalla
guild. La stessa cosa
accade con tutte le
professioni
dell’industria
del
cinema
e
della
televisione negli Stati
Uniti.
“In
questo
regime così vincolato,
una
major
non
potrebbe più avere
alcun attore e regista
se prendesse una sola
persona al di fuori di
questo sistema. Ecco
come si è costruito il
monopolio,” conclude
Stocum. Decine di
sindacatipartecipanoa
queste trattative che si
estendono al settore
della televisione, della
radio e persino a
Broadway, come mi
conferma a New York
Alain Eisenberg, il
celebre direttore del
sindacato degli attori.
“Cinema, televisione e
teatro sono tre settori
completamente
sindacalizzati
negli
StatiUniti,poichétutti,
nel corso della loro
carriera sono stati
‘fottuti’
da
un
produttore, dunque la
lealtà
dei
nostri
membri è totale. In
generale, peraltro, un
attore è iscritto a tre
sindacati: quello degli
attori di Hollywood,
quello della radiotelevisione
a
Los
Angeles e da noi,
l’Actors’ Equity per
Broadway
e
New
York.” Anche in questo
caso, le regole sono
numerosissime
e
davvero complesse, ma
ilsindacatodegliautori
ha un monopolio sul
mercato del lavoro in
tuttigliStatiUniti,per
i teatri disciplinati
secondo le regole di
Broadway (sale oltre i
499 posti) e quelli Off
Broadway(saletra100
e 499 posti) e continua
a
essere
molto
influente,
senza
monopolio, nelle sale
Off-Off Broadway (sale
con meno di 99 posti).
Ma tutto ciò ha un
costo. Ogni persona
che aderisce a un
sindacatoounasocietà
di autori deve pagare
un’adesione
iniziale
elevata, una quota
annuale
e
una
percentuale su tutti i
suoi cachet (2,25 per
centopergliautoriSag
ediActors’Equity).
“In effetti è costoso,
ma è obbligatorio se si
vuole
lavorare
a
Hollywood
o
alla
televisione negli Stati
Uniti. È il prezzo da
pagare per essere
difesi
dal
proprio
sindacato in trattative
articolate
e
complesse,” aggiunge
Chuck Stocum. “Si
tratta di trattative
complicate. Facciamo
fronte comune con le
società dei registi, i
sindacati degli autori e
le agenzie di talenti
contro gli studios, ma
siamo contro i registi
per
difendere
gli
sceneggiatori;
infine
controlliamo le agenzie
di talenti, per esempio
siamo stati noi ad aver
limitato
la
loro
percentuale al 10 per
cento
di
tutti
i
contratti,
per
proteggere i nostri
membri.”
Stocum
conclude: “In questo
settore industriale tutti
sono con tutti, ma è
anche vero che tutti
sono contro tutti. Tutti
isoggetticoinvoltisono
legatiallemajoresono
anche indipendenti”.
Quest’ultima
espressione
mi
colpisce. Comincio a
capire che nella nuova
Hollywood il ruolo
degli indipendenti è
diventatocentrale.
5.
Tutti“indies”,anche
IndianaJones
Congrandesorpresa,
nell’ufficio di David
Brooks,
all’interno
degli studios NbcUniversal
di
Los
Angeles vedo un tavolo
da ping-pong. Brooks è
il
direttore
del
marketing di Focus
Features, uno degli
studi di Universal.
Dalla
California
controlla la strategia
mondiale di marketing
dellamajor.
Il “lot” di Universal
occupa diversi ettari
lungo l’autostrada I
101, lontano, a nord di
Hollywood. La zona
occupata da questi
studios è così grande
che viene chiamata
come se fosse una
città, Universal City.
Giro in auto, cartina
alla mano, percorro
strade che si chiamano
James Stewart Avenue,
Steven Spielberg Drive
e Universal Studios
Boulevard. L’ufficio di
Brooks è al civico 100
diUniversalCityPlaza.
Negli uffici di Focus
Features c’è un clima
disteso. Quasi ovunque
cisono“openspaces”e
“cubicles”,
spazi
individuali all’interno
di un unico ambiente.
Appeso al muro c’è un
piccolo cartello con
scritto
“Permanent
change” (continuare a
cambiare).
Brooks mi riceve in
jeans,
maglietta
e
scarpe da ginnastica.
Provienedallacostaest
(prima
dirigeva
il
marketing di Miramax
a New York) e si è
vestito
“casual”,
informale,
in
stile
CaliforniadelSud.Alla
direzione di Focus
Features, lo studio di
Universal, coordina il
marketing
della
comunicazionesuscala
mondiale
di
una
ventina di film l’anno.
Sono tutti film di
“medio
budget”,
pellicolechestannotra
il
commerciale
e
l’indipendente.
Per
esempio,
Focus
Features ha prodotto
Lost in Translation, Il
pianista, Che Guevara,
Broken Flowers, I
segreti di Brokeback
Mountain,MilkeHotel
Woodstock.
Iltavolodaping-pong
serve per le riunioni
dei responsabili del
settoremarketingdella
major, molti di loro
sono
in
videoconferenza
dai
diversi
continenti.
“Lanciare
una
campagna
internazionale
di
marketing,”
dice
Brooks,“èunpo’come
giocare a ping-pong in
tuttelegrandicittàdel
mondo. Però, si gioca
unapartitasola,nonsi
puòsbagliare.”
La
cosa
più
interessante,
all’internodeglistudios
Universal, è che David
Brooks
e
Focus
Features
sono
“indipendenti”.
Ho
impiegato
qualchetempoacapire
perché a Hollywood
tutti
erano
in
condizione di essere in
parte “studio” e in
parte “indipendenti”.
Inuncertosenso,sono
tutti“indies”,compreso
IndianaJones.
Anche se controllata
da Universal, Focus
Features è una di
quelle che si chiama
“unitàspecializzate”(si
dice
anche
“indie
studio” o divisione
“film d’autore” di una
casa cinematografica).
A partire dagli anni
novanta, tutti i grandi
studios di Hollywood
hanno acquisito minimajor esterne, oppure
hanno creato ex novo
al loro interno studios
“indipendenti”,
che
compongono
quel
settore
chiamato
talvolta
“little
Hollywood”, per non
confonderloconla“big
Hollywood”.
Questi
studios
sono:
Fox
Searchlight
Pictures
all’interno di 20th
Century Fox, Sony
Pictures
Classic
all’interno di Sony,
Paramount
Vintage
all’interno
di
Paramount,
Warner
Independent Pictures e
New
Line
Cinema
all’interno di Warner,
mentre tra gli studios
ci sono Miramax e
Pixar
acquisiti
da
Disney e, in una certa
misura, DreamWorks
Skg, ieri acquisita da
Paramount
e
oggi
nell’orbitadiDisney.
“Tutte queste unità
specializzate
sono
differenti, ma il loro
compito
è
generalmente produrre
film
meno
costosi
rispetto
ai
film
commerciali
e
di
successo,destinatiaun
pubblico
più
specializzato e spesso
più
internazionale.
Sono
queste
caratteristiche a dargli
la
veste
di
film
indipendenti,”
mi
spiega
qualche
settimana dopo a New
York James Schamus,
cofondatore
e
amministratore
delegato
di
Focus
Features (Schamus è
anche sceneggiatore di
film come La tigre e il
dragone, Lussuria e
Hotel Woodstock di
AngLeeemiconfessa,
purchéiononloscriva,
che è stato anche
cosceneggiatore de I
segreti di Brokeback
Mountain, anche se
non ha voluto apparire
neititoli).
Ci sono altri motivi
che
spiegano
l’esistenza di questi
sotto-studios
“indipendenti”.
Per
Focus Features è un
modo per differenziare
la proposta, per non
cercare di rivolgersi
necessariamenteatutti
i tipi di pubblico
contemporaneamente.
La strategia è fare film
a
medio
budget,
destinati
soprattutto
agli adulti e con
l’obiettivo di dare a
Universal un’immagine
menomainstream,utile
ad attirare il plauso
della critica e, spesso,
a
ottenere
Oscar.
Disneyinvecepersegue
l’obiettivo di evitare di
danneggiare il proprio
marchio associato a
film per la famiglia e
per un pubblico di
massa:
il
settore
indipendente è un
modopernonprodurre
con il proprio marchio
film vietati ai minori di
diciassette
anni
a
causa di immagini
troppo violente o con
scene di sesso troppo
esplicite.
Disney
producequestifilmcon
il nome di unità
specializzate
come
Touchstone Pictures e
Miramax. Peraltro è
anche un modo per
favorire la creatività
compiacendo
produttori e cineasti
che
vogliono
mantenere l’immagine
di “indipendenti”, ma
che hanno bisogno dei
soldi degli studios. “È
unmodoperfidelizzare
gli artisti,” mi dice
James
Schamus.
Spesso, la minimajor
permette di assumere
maggiori rischi, o di
scritturare un attore
per una paga inferiore
rispetto a quella che
prenderebbe con una
grandemajor.Inalcuni
casi
è
addirittura
possibile sfuggire ad
alcune
regolamentazioni
sindacali,
mentre,
talvolta, è soltanto un
modo
per
aprirsi
ulteriormente
sul
fronte internazionale
attraverso un marchio
apparentemente meno
americano (i film dello
spagnolo Almódovar,
del
cinese
Zhang
Yimou, del taiwanese
Ang
Lee
o
del
messicano
Alejandro
González Iñárritu sono
stati
prodotti
o
coprodotti da Focus
FeaturesenondaNbcUniversal).
Talvolta
l’artificio funziona a
meraviglia:nel2005,la
stampa francese si è
esaltata per Broken
Flowers, la commedia
di
Jim
Jarmusch,
perché rappresentava
la “quintessenza del
cinema indipendente”,
il “completo controllo
dell’artista su film a
scarsobudget”e“l’arte
contro il denaro degli
studios”, nessuno si è
reso conto che si
trattava di un film
prodotto da Focus
Features,
ovvero
Universal. Si trattava
dunque di un bel film,
ma
interamente
finanziatodaunamajor
hollywoodiana.
“Le
unità
specializzate
si
occupano di film di
varia natura. Grazie a
loro,
gli
studios
possono rivolgersi al
futuro, incoraggiano la
diversificazione
e
offronolapossibilitàad
artisti indipendenti di
accedere
a
una
miglioredistribuzione,”
mi
spiega
Jeffrey
Katzenberg, presidente
di
DreamWorks
Animation.
Geoffrey
Gilmore, direttore del
Sundance
Film
Festival, intervistato a
Los Angeles conferma:
“Queste
unità
specializzate
si
assumono dei rischi,
sono molto coraggiose,
molto creative, per
esempio Miramax, ma
ciò non toglie nulla al
fattochefaccianoparte
degli studios. Sono
indipendenti in termini
di creatività, sono più
focalizzate sul regista,
ma restano comunque
degli studios”. Gilmore
precisa:
“Quentin
Tarantino,
per
esempio, è un regista
indipendente, ma è
anche un uomo degli
studios. A Hollywood,
indipendente è una
categoria estetica che
non spiega nulla sulla
natura finanziaria del
film”. Il Sundance Film
Festival di Robert
Redford e Geoffrey
Gilmore è stato spesso
considerato una valida
alternativa
a
Hollywood,
ma
recentemente è stato
screditato poiché ha
perso
la
propria
indipendenza ed è
diventato
una
macchinacheseleziona
i film degli studios.
Gilmore recentemente
ha
rassegnato
le
dimissioni
per
dedicarsiadattivitàpiù
“indipendenti”.
Tra
l’unità
specializzataelostudio
che
la
controlla
intercorrono relazioni
simili a quelle tra
major ed etichette
nell’industria
discografica,
oppure
tra conglomerati e
imprints nell’editoria.
Lo studio si occupa
della
gestione
complessiva e delle
questioni finanziarie:
aspettigiuridicielegali
soprattutto
con
la
negoziazione
dei
contratti, distribuzione
mondiale, detenzione
del
copyright
e
dell’Intellectual
Property(dettodatutti
negli Stati Uniti “Ip”).
Al mini-studio spettano
le scelte artistiche, la
produzione e le riprese
(“raramente realizzate
negli studios della
casa-madre,” afferma
James Schamus), la
strategia
del
marketing,lepubbliche
relazioni e l’ufficio
stampa. Tra le due
entità,
l’ordine
gerarchico è variabile:
alla Disney qualsiasi
film deve ottenere luce
verde
dall’amministratore
delegato, mentre alla
Universal
le
cose
sembrano meno rigide:
James Schamus mi
garantisce che a Focus
Features, di cui è
direttore, decide tutto
lui.
“Sehobencapito,lei
vuole sapere a partire
da quale momento la
major esercita uno
stretto controllo sul
budget.Èunacosache
varia a seconda degli
studios, dipende dalle
situazioni
e
dagli
uomini, ma direi che
oltre un budget di 1520milionididollariper
un film, ottenere luce
verde dalla major è
quasi inevitabile. Mi
pare in ogni caso una
cosa normale che il
diritto di decidere
spettiachisiassumeil
rischio
finanziario,”
sostiene
Ken
Lemberger,
ex
vicepresidente di Sony
Pictures
Entertainment.
“Icontenutisiamonoi”
“Tutte
le
sceneggiature,
gli
script,
i
progetti
arrivano qui.” Nicholas
Weinstock mi mostra
alte pile di cartelline
colorateedidocumenti
rilegati posti su un
lungo
mobile
che
costeggia
un’intera
parete del suo ufficio.
Poi dice: “I contenuti
siamonoi”.
Anche
Nicholas
Weinstock
è
un
indipendente. È uno
degli
associati
di
Apatow
Productions.
Mi trovo al civico
11788 West Pico Bld.,
zona ovest di Los
Angeles. L’edificio è
modesto, su due piani,
senza
nulla
di
particolare, collocato
tradueautostrade.Per
accedervi
bisogna
prendere una scala in
legno sul lato, poco
visibile
dalla
via
principale.
Apatow Productions,
come
Imagine,
Overbrook
Entertainment, Section
Eight
(di
Steven
Soderbergh e George
Clooney),
o
come
centinaia di altre case
di
produzione,
costituisce ormai il
cuore di Hollywood.
“Oggi, gli studios sono
solo delle banche,” mi
dice
Nicholas
Weinstock, come mi è
giàstatodettodamolti
altri interlocutori a
Hollywood. Weinstock
è un uomo sulla
quarantinaeallespalle
ha già una carriera di
successo. Ha lavorato
perFoxeperilgruppo
News
Corp
dove
scriveva i discorsi per
Rupert
Murdoch
relativi
alla
20th
Century Fox. Era nel
cuore di una major
dell’intrattenimento.
Oggi invece è in una
piccola azienda con
dodicidipendenti.
Apatow Productions
è
una
società
indipendente il cui
lavoro
consiste
nell’identificare
progetti, svilupparli e
poi
sottoporli
agli
studios o alle reti
televisive – talvolta
sono la stessa entità –
affinchésianorealizzati
se
ottengono
luce
verde.
All’inizio la casa di
produzione lavora con
scrittori, attori, registi
eagenzieditalentiper
creare i progetti. La
piccola
azienda
beneficia
di
un
sostegno
economico
importante da parte
degli
studios
per
realizzare
queste
sperimentazioni
e
assumersi dei rischi
(chiamati
“Slush
Fund”). In seguito, i
progettisonosottoposti
agli
studios,
che
possono accettarli o
meno,
e
spesso
chiedono una nuova
rielaborazione. Apatow
produce
circa
sei
lungometraggi all’anno
per gli studios e una
quindicina di film o di
serieperlatelevisione.
Iconfinitrastudiose
società
indipendenti
non sono netti. Si
capisce dunque perché
il
concetto
di
indipendente oggi non
voglia dire granché a
Hollywood:
molti
studios ricorrono a
case di produzione
autonomeperprodurre
e realizzare i loro film,
mentre tutti questi
“indipendenti” hanno
bisogno del denaro
degli
studios
per
realizzare
i
loro
progetti. “È come un
matrimonio
combinato,” mi dice
Nicholas
Weinstock.
“Si
capisce
subito
perché
tutti
gli
indipendenti
sono
finanziati dagli studios
o quantomeno dalle
emittenti televisive. È
davvero
molto
semplice. Noi abbiamo
bisogno dei loro soldi,
loro hanno bisogno dei
nostri
progetti.
Il
problema degli studios
èl’assunzionedirischi,
la sperimentazione, il
periodo di sviluppo
iniziale. Chi si assume
questo rischio, come
innovare,comecreare?
Hollywood
ha
gradualmente trovato
la
soluzione
esternalizzando
completamente queste
funzioni a centinaia di
case di produzione
indipendenti che, con
lalorodiversità,laloro
capacità di innovare e
il loro bisogno di
denaro, innovano per
vocazione – e per
obbligo. Il principio
dellaconcorrenzagioca
apieno.”
Maperchéglistudios
non
possono
fare
queste operazioni al
loro
interno?
“Mettendo
in
concorrenza tra loro
numerosi produttori,
gli studios riescono a
cogliere meglio le
evoluzionidelmomento
e possono diversificare
i loro progetti. Hanno
più
scelta
e
risparmianodenaro.Gli
studios non sanno più
fare queste operazioni
al loro interno (‘in
house’).Nonhannopiù
gentechefacciaquesto
lavoro,”
spiega
Nicholas Weinstock. È
dunquelecitochiedersi
a cosa servono gli
studios.“Afarelacosa
più importante: per
farla breve, gli studios
sono
una
banca
d’affari, una banca
diritti, uno studio
avvocati d’affari
un’agenzia
distribuzione
mondiale.”
di
di
e
di
Il giorno dopo mi
trovo alla Overbrook
Entertainment
sulla
Roxbury
Drive,
a
Beverly
Hills.
Overbrook è stata
creatadaWillSmith,il
celebre rapper – noto
come Fresh Prince – e
attore nero americano
(ha recitato in Men in
Black,IndipendentDay
eIo, Robot). La sede è
al
quarto
piano
dell’edificio e gli uffici
sono certamente più
lussuosi rispetto a
quelli
di
Apatow
Productions, ci sono
anchepiùcollaboratori.
Uno di loro, un
produttore (che mi
chiede di rimanere
anonimo per via delle
regole
fissate
dall’azienda) mi fa
visitare la sede. La
maggior parte dei
dipendenti lavora sullo
“sviluppo” dei film. In
questo
momento
stanno lavorando allo
sviluppo di quaranta
progetti.
Overbrook
Entertainment
si
occupa appunto di
“sviluppo”. Si tratta di
un lungo processo che
va dal pitch (l’idea
iniziale sintetizzata in
poche frasi) all’uscita
del film, passando per
la
redazione
dello
script, la revisione e
spesso
il
rimaneggiamento
completo prima delle
riprese. “Il pitch è la
primissima tappa di un
film,” mi spiega il
produttore
di
Overbrook. “È ciò che
sipresentaalleagenzie
ditalentieaglistudios,
i
primi
affinché
segnalino
uno
sceneggiatore,
un
regista e gli attori, i
secondi
affinché
decidano di investire
nella fase iniziale dello
sviluppo del film. Il
pitch va meglio ed è
più efficace se può
essere ridotto a una
solacatchphrase,cheè
ciò che a Hollywood
chiamiamo,
senza
ironia,
un
high
concept.” (Spesso si è
ironizzato, a ragione,
sui pitch come sintomo
della morte e della
commercializzazione
del cinema, ma il
produttore
di
Overbrook,
cinefilo
incallito, mi cita a
memoria la frase del
criticoSergeDaneyper
giustificare il concetto
di pitch attorno a
un’unicaidea:“Icattivi
registi – peccato per
loro–nonhannoidee.I
buoniregisti–equesto
è il loro limite – ne
hanno troppe. I grandi
registi – soprattutto
quelli innovativi – ne
hannounasola”.)
Overbrook è una
società di produzione
“indipendente”,
ma
grazie alla notorietà di
Will Smith ha un
“rapporto
preferenziale”
con
Sony per una serie di
film. Secondo alcune
stime,
gli
studios
hollywoodianieleunità
specializzate
hanno
complessivamente, e
continuamente, circa
2500 film in corso di
sviluppo,adiversistadi
di produzione. Molti di
questi progetti – nove
sudieci–nonverranno
mai realizzati. Un film
può essere messo in
produzione solo dopo
aver ricevuto luce
verde dagli studios. Da
quel momento, la casa
indipendente riceve un
anticipo
che
può
ammontare a diversi
milioni di dollari. “Un
film realizzato è in
realtà un’eccezione,”
constata
il
mio
interlocutore. “Ci sono
tanti film in progetto e
tante idee in fase di
sviluppo
che
non
arrivano
a
essere
realizzate,pernondire
delledecinedimigliaia
di script che girano
ovunque
(flying
around) a Hollywood.
Quando un film viene
girato è un miracolo.”
L’espressione “flying
around” è divertente,
manonpossoimpedire
a me stesso di pensare
alle
migliaia
di
sceneggiature nate già
morte e all’incredibile
spreco di talenti e di
idee
che
contraddistinguono la
nuovaHollywood.
A Beverly Hills, alla
Overbrook
Entertainment, ci sono
centinaia di script e
sceneggiature impilati
gliunisuglialtri,come
hovistoinaltrecasedi
produzione. Ma come
giungono a voi? Il
produttore
di
Overbrook
sembra
stupito
dalla
mia
domanda. “No, non
sonoglisceneggiatoria
portarceli facendo la
fila davanti ai nostri
uffici!Celimandanole
agenzieditalenti.”
Agentisegreti
Al numero 2000
dell’Avenue of the
StarsaLosAngelesc’è
il sontuoso edificio
bianco di dodici piani,
tutto vetro e marmo e
con un parco di alberi
esoticidell’agenziaCaa
(Creative
Artists
Agency,
i
cui
responsabili
hanno
declinato
la
mia
richiesta
di
un’intervista
per
questo libro). A una
decina di strade di
distanza, a Beverly
Hills, ci sono gli edifici
tutti neri della William
Morris Agency. Mi
trovo al civico 1 di
William Morris Place –
l’agenzia ha una via e
una piazza con il
proprionome.
Cassian Elwes mi
offre
un
caffè
americanoinunatazza
con inciso “XXXX”, il
logo
composto
da
quattro X di William
Morris. A guardarle
bene,
le
X
rappresentano
le
lettere “W” e “M”,
iniziali
dell’agenzia,
sovrapposte. È una
cosa
magica
e
magnifica vedere il
logo a lettere dorate
stagliarsi
sulle
immense facciate nere
diWilliamMorris.
Cassian Elwes ha
accettato
di
incontrarmi–fattoraro
per
un’agenzia
di
talenti,aziendacheper
natura vive vendendo
informazioni
e
mantenendo
segreti.
Cassian è un veterano
del content: è stato
produttore di film,
agente artistico e ha
appena
cofondato
William
Morris
Independent, il ramo
“indipendente”
della
casa madre. Non sono
autorizzato a riportare
le sue argomentazioni,
mi dice il suo PR – che
mi guarda con aria
inquieta e partecipa al
nostro incontro – in
virtù di una regola
interna che “vieta ogni
discussione
pubblica
sugli
affari
dell’agenzia”.
Le “Big Four”, così
vengono chiamate le
quattro
principali
agenzieditalenti(Caa,
International Creative
Management, United
Talent Agency, William
Morris e Endeavor,
queste ultime due
hanno
avuto
una
fusione nel 2009),
controllano
complessivamenteil70
per cento dei contratti.
ALosAngeles,tuttavia,
ce ne sono altre
duecento.L’agenziaèil
principale
intermediariopertuttii
contratti stipulati a
Hollywood. Si occupa
dimettereincontattoi
creatori, che sono i
suoi clienti, con i
produttorieglistudios.
È dunque in posizione
strategica
tra
i
“talenti” e il business.
In pratica è un’agenzia
dilavorodialtolivello.
Le
agenzie
si
occupano degli attori
ma anche dei registi,
deglisceneggiatoriedi
tutti
i
tipi
di
professione richiesti a
Hollywood
(questo
sistema è simile a
quello della musica,
dell’editoria,
della
televisione e anche
degli atleti). Per ogni
contratto
siglato
l’agenzia
incassa
sistematicamente il 10
per cento. Spesso si è
fatta ironia su questa
percentuale rispetto al
poco lavoro svolto, al
punto che una battuta
frequente a Hollywood
ricorda che “gli agenti
non prendono mai
succo di pomodoro al
bar per timore che si
possa pensare che
bevono il sangue dei
loro clienti”. In realtà,
all’interno
di
un
sistema composto da
migliaia di aziende
come
la
nuova
Hollywood, hanno un
ruolo decisivo. “Le
agenzie,
soprattutto,
sono
indipendenti
poiché
esistono
controlli molto stretti
attorno
a
questa
indipendenza.
In
questo modo possiamo
limitare il monopolio
delle industrie dei
contenuti e forniamo
così al sistema un
arbitro indispensabile,”
spiega Michel Vega,
altro agente di William
Morris che lavora a
Miami.
Mi
trovo
sull’immenso terrazzo
della Williams Morris
Agency, di fronte alle
spiagge
di
Miami
Beach.
“Abbiamo
aperto
un
ufficio
‘latino’ qui a Miami
perché ovunque ci sia
intrattenimento,
ci
sonocontratti.Ilnostro
lavoro è trattarli.” Nel
suo ufficio c’è una
locandina gigante di
Easy Rider in versione
spagnola.
Generalmente,
un’agenzia tratta non
solo il contratto di
produzionedelfilm,ma
anche
i
contratti
relativi
alla
distribuzione in sala,
quelli
televisivi
e
internet,
le
commissioni sui dvd o
il
botteghino
internazionale
e
numerose
altre
prestazioni.
“Le
trattative sui diritti
televisivi sono le più
complesse e le più
redditizie,”
spiega
Michel Vega a Miami
(per un’agenzia come
William Morris il 40
per cento degli introiti
proviene dai contratti
televisivi e solo il 25
percentodaifilm).Per
la pellicola Matrix, per
esempio, il contratto
discusso da William
Morris a Los Angeles
era composto di ben
duecentosessantaquattro
paginerelativeaidiritti
del film, a quelli dei
videogiochi,
del
fumetto, dello show
televisivoedeiprodotti
derivati e dei giochi su
internet. “Non è un
contratto,
è
un
package,” mi conferma
un
responsabile
dell’agenzia
International Creative
Management a Los
Angeles.
Una delle novità dei
contratti, nella nuova
Hollywood,
rispetto
all’epoca degli studios,
è la percentuale che
spetta agli attori più
celebrisugliincassidel
film. Si chiama “profit
participation” ed è un
sistema simile a quello
delle stock option per i
dirigenti delle aziende
che ricevono utili dalla
propria azienda. Si
tratta peraltro di una
pratica che risale al
1950quandounagente
aveva contrattato una
percentuale
sugli
incassi di due film con
James Stewart poiché
laUniversalnonvoleva
pagare l’anticipo che
l’attore chiedeva. Le
star più celebri, oggi,
non guadagnano solo
tra i venti e i trenta
milionididollariafilm,
ma hanno anche una
percentuale
sugli
introiti totali del film,
dedottiicostireali,esi
può arrivare a una
quota del 20 per cento
su tutti gli incassi,
compresa la vendita di
dvd e di prodotti
derivati. Sul totale di
queste cifre, l’agenzia
di talenti prende il 10
percento.
Siaccusanospessole
agenzie
di
aver
contribuito
all’inflazione
astronomica
dei
contratti degli attori e
deiregistiaHollywood.
Sicuramente è vero
poiché l’agenzia ha
interesse a questo
rialzo delle tariffe dato
che le sue commissioni
aumentano
in
proporzione. Eppure,
dal momento che la
relazione
con
un
cliente si costruisce
sulla durata, l’agente
non necessariamente
ha
interesse
a
rincorrere
denaro
facile.
Soprattutto
perché, a muoversi
sullo stesso terreno, ci
sono
anche
altri
soggetti, non meno
importanti. Anzitutto il
manager
dell’artista
che, a sua volta,
prende circa il 10 per
cento del contratto per
gestire la sua carriera,
occuparsi dell’agenda
del
suo
cliente,
parteciparealleriprese
o ai concerti e seguire
la
pubblicità.
Poi
bisogna aggiungere gli
avvocati
che,
in
generale,prendonoil5
per cento su tutti i
contratti.Ancoraprima
di prendere anche solo
undollaro,unattoreha
dunquegiàcedutoil25
per cento dei suoi
diritti all’agente, al
managereall’avvocato.
Come mi è stato
spiegato da diversi
agenti a Hollywood,
l’importante per un
artista “non è sapere
quanto gli frutterà un
contratto, ma quanto
tratterrà per sé dopo
chetuttihannopresola
loropercentuale”.
“Shark-infested
waters,”
David
Boxerbaum ripete la
frase. “Hollywood è un
sistema infestato da
squali. Non le sembra
una bella formula?
Credodipotermeritare
diesserecitatonelsuo
libro
per
averla
pronunciata.”
Boxerbaum, con quel
nome da eroe di film e
uncompletoArmaniun
po’troppolargo,lavora
per
un’altra
nota
agenzia di talenti, Apa
Inc. L’agenzia ha sede
sulla South Beverly
Drive e non ha il
prestigio delle grandi
consorelle
Caa
e
William Morris – ma
cometuttiichallengers
di Hollywood vuole
ingrandirsi
per
mangiare i concorrenti
più grossi. A essere
uno squalo è proprio
Boxerbaum.
Sono
seduto di fronte a lui e
mi chiede cosa voglio
bere.
Chiedo
una
Perrier. “Un segno di
distinzione
molto
francese,” mi dice. Fa
venire un cameriere e
ordina un succo di
pomodoro.
Boxerbaum
lavora
per i lungometraggi e
la televisione, ma si
occupa soprattutto del
settore
letterario
poiché tutti i progetti
cominciano da qui. “La
divisione letteraria è
quella che ci porta le
storie.Èlaprimatappa
del film. Con gli
scrittori facciamo lo
stesso lavoro che si fa
con gli attori. Li
incontriamo,
li
incitiamo, li facciamo
lavorare, leggiamo i
loro
progetti,
li
rendiamofelici.”Anche
Boxerbaum
mi
fa
vedere una pila di
sceneggiature e di
script
sulla
sua
scrivania. Ne prende
uno, per farmi un
esempio, e lo getta via
con violenza: “Questa
non è roba che fa per
me”. Prosegue: “Tutto
il
nostro
lavoro
consiste nel trovare il
buonautoreperilbuon
attore, per il buon
regista, per il buon
film, per la buona
major. Da una parte ci
sono talent e content,
dall’altra c’è la major
con i soldi. Noi
facciamodatramite”.
Boxerbaum
mi
mostra una scheda. Mi
spiega che si tratta di
un
“Breakdown
Express”, una lista con
una serie di nomi. Per
undeterminatoscripto
una
storia,
sono
indicate le persone
potenzialmente
in
grado di partecipare al
progetto.Contattapoii
produttori indipendenti
o direttamente gli
studios per piazzare lo
script.Unavoltachelo
“sviluppo” è accettato,
lo script può essere
rielaborato
dallo
scrittore e l’agente si
metteallaricercadegli
attori
giusti
contattando
i
loro
manager.Sullascheda,
vicino al nome Disney
figuranolecinqueosei
case di produzione
indipendenti
che
potrebbero fare il film
per Disney, lo stesso
vale
per
Fox
e
Paramount.
Come
riesce
a
identificare le persone
giuste e fare i buoni
abbinamenti?“Sonosul
campo tutti i giorni,
esco tutte le sere,” mi
dice David Boxerbaum.
“Sono molto hand on.”
Come si può tradurre?
Ha le mani in pasta?
Nella
fossa
degli
squali? Nel succo di
pomodoro?
AncheMollyLopataè
un’indipendente
e
lavora da casa. La
incontro non lontano
dalla sua abitazione, in
un semplice bar, Pane
Dolce,
a
Sherman
Oaks, un “villaggio” in
quella che a Los
Angeles si chiama “la
valley”.
Siamo
all’estremo Nord della
città,
a
est
dell’Interstate405,non
lontano dalla celebre
MulhollandDrive.
Molly è direttrice di
casting. Il suo compito
è selezionare gli attori
di un film a partire
dallo script. È scelta e
pagata
da
un
produttore
indipendentesullabase
di
un
progetto,
generalmenteunfilmo
una serie. Di regola, il
suo nome deve essere
approvatodallamajoro
dall’emittente
televisiva.
“Fornisco
solo
indicazioni,”
spiega Molly Lopata.
“In genere, per ogni
ruolo,propongodiversi
nomi, sono poi i
produttori a fare la
sceltafinale.Inpratica,
posso dire di ‘no’ a un
attore, ma non posso
dirgli di ‘sì’. Spesso gli
attori
detestano
i
direttori del casting
proprio per questo
motivo.”
Anche lei mi mostra
un
“Breakdown
Express”,
su
due
colonne:asinistrac’èil
ruolo dei film in
progetto e, a destra, i
potenziali attori da
contattare
per
interpretare
il
personaggio.
Molly
discute poi con gli
agenti per verificare la
disponibilità
degli
artisti,inbasealledate
delle
riprese
e
all’interesse per il
progetto. Vicino al
nome di una nota
attrice
ha
scritto:
“Tecnicamente
disponibile, ma rischia
di
non
essere
interessata
al
progetto”; vicino a un
altro attore c’è scritto
“He
is
attached”.
“Significa
che
è
interessato,masicorre
il rischio che non sia
disponibile,”
spiega
Molly.
Pane Dolce è un
tipico bar californiano.
È una “coffee house”
per le persone del
quartiere, vagamente
ecologista
e
indipendente, in cui il
proprietario tratta tutti
i clienti come se
fossero vecchi amici.
C’èlaconnessionewi-fi
gratis e i muffin sono
fatti in casa. Molly ha
tempo da dedicarmi e
sembra intrigata dal
fatto che un francese
sia venuto fin lì per
intervistarla.
“Mi
occupo
anche
dell’inizio
della
contrattazione
finanziaria
per
identificare il possibile
margine di manovra,
ma sono i produttori a
negoziare
il
vero
contratto
con
gli
agenti.
Il
nostro
compito è aiutarli a
trovare soluzioni. Qui
ci
chiamano
middlemen,
intermediari.”
Le
chiedo
come
identifichi
i
nuovi
attori. “Seguo l’istinto.
Homoltoaffettopergli
attori,
gli
voglio
veramente bene. È un
mestiere
molto
creativo.Faccioprovini
qui a Los Angeles agli
studenti che escono
dalle grandi scuole di
recitazione come la
Julliard School di New
York,lescuolediteatro
di Yale e Harvard.
Partecipo anche agli
showcase che queste
scuole
organizzano
ogni anno, in aprile o
maggio, a Los Angeles:
ogni attore ha a
disposizione
due
sessioni da due minuti
ciascuna per mostrare
il proprio talento ed è
spesso
in
queste
occasionichegliagenti
li ‘scritturano’. Inoltre,
vedo i film degli
studenti
nelle
università, nei festival.
Non ci vado con un
obiettivo preciso, ma
solo per conoscere gli
attori, eventualmente
per poi contattarli in
seguito quando cerco
qualcuno per un ruolo
specifico.” Molly è
pagataconunfee(una
cifra accordata) e non
prende percentuali sui
film. Come per gli
agenti, il suo nome
figuraneititolidicoda.
Molly è seducente e
cerca
di
sedurre.
Appartiene
alla
categoria dello squalo
sorridente. Da giovane
è stata attrice e si è
riconvertita al casting
per restare “vicina agli
attori”. Le chiedo cosa
pensa di un sistema
così ingiusto che offre
apochiattorilafamae
condanna tutti gli altri
a fare i camerieri nei
bar di Los Angeles.
Molly mi guarda con
dolcezza. “Sa, anch’io
hofattol’attrice.Come
nei film di Wong Kar-
Way, so che l’amore e
l’affetto
sono
fondamentali per la
vita delle persone.
Lavoro duramente, ma
cerco di essere gentile
con gli attori. E le dirò
che sono sempre stata
affascinatadalmodoin
cuigliattoririesconoa
emergere all’interno di
un sistema terribile.
Non ci sono regole,
moltoèdovutoalcaso.
È tutto imprevedibile.
Ma
hanno
grande
inventiva e grande
creatività. Non può
immaginare quanto gli
attorisianocreativi.”
“To Break”. John
Dewis utilizza questo
verbo con deferenza.
Negli Stati Uniti vuol
dire
“sfondare”,
“essere riconosciuti”,
“passare
dall’anonimato
alla
popolarità”.
È
l’obiettivo
principale
perunattore.
John Dewis è un
attore professionista di
teatro.
L’avevo
incontrato a Harvard
quando era studente
dell’American
Repertory Theater, la
prestigiosa scuola di
teatro dell’ateneo, e
recitava in spettacoli
alternativi. Insegnava
fotografia,
è
stato
assistente
della
fotografa Nan Goldin
ed è stato a sua volta
fotografo di American
Apparel, la marca di
magliette semplici e
colorate
“made
in
California” (John non
veste mai American
Apparel).
È
stato
segnalatoanchedauna
giornalista di “Vanity
Fair”
che
lo
ha
nominato “il ragazzo
più sexy della sua
generazione”.
Oggi
Dewis vive a Los
Angeles per cercare di
“sfondare” nel cinema
edèquicheloincontro
nuovamente.
“Cisonodiversimodi
per
sfondare
a
Hollywood,
ma
se
sapessi qual è quello
giusto, smetterei di
darecorsielezioniper
pagarmi l’affitto,” mi
spiega
John
una
domenica sera nella
casa che ha in affitto
vicinoaLaurelCanyon.
Siamo su una terrazza,
in mezzo al verde di
unodeiquartieripiùin
vista di Hollywood. Ha
invitato a casa sua una
decina di amici per
aiutarmi nelle mie
ricerche, la maggior
parte di loro sono,
comelui,attori“wouldbe”, attori in divenire
che
cercano
di
sfondareaHollywood.
Per quanto iscritto
alla Sag, il sindacato
degli attori, John non
ha
un’assicurazione
sanitaria, né pensione.
“Il problema è, nel
contempo, entrare nel
sistema e restarci.
Quando si è attori
sindacalizzati, si può
beneficiare
dell’assicurazione
sanitaria del sindacato.
Bisogna però avere dei
contratti in corso. Non
lavorare un numero
sufficiente
di
ore
significa non riuscire a
sbarcare il lunario, si
perdono le prestazioni
della
previdenza
sociale. Io sono in
questa situazione, ho
perso la copertura e
sonoormaiunodei‘più
di cinquanta milioni’ di
americani
non
assicurati.”Lacosache
mi piace in questa
formula, spesso usata
negliStatiUniti,èquel
“più”.
John non è capace di
vendersi e si rifiuta di
recitare
in
serie
televisive di seconda
categoria.
“Davvero
non so. Ho recitato nel
teatro d’avanguardia e
lì ho incontrato gente
di quella cricca di
sinistra piena di soldi
che irrideva la cultura
trash di Hollywood;
erano così presuntuosi
che
ho
lasciato
perdere. Talvolta mi
chiedo se non sia
megliorecitareinserie
trash e programmi
televisivi
cheap.
Peraltro, il paradosso
di Hollywood è che
spesso è più difficile
recitareinunapessima
serie televisiva che in
un
buon
film.
Comunquehodeclinato
un’offerta per un ruolo
all’interno di un reality
dating show in cui
dovevo
passare
il
tempo a cercare di
rimorchiare. Molti mi
hanno detto che sono
stato coraggioso a
rifiutare questo ruolo,
con il denaro e la
riconoscenza
che
comportava. La verità,
invece,èchenonavevo
abbastanza
coraggio
perfarlo.”
Johnsièaffidatoaun
manager e un agente,
ma quando la cosa ha
assunto
proporzioni
che
definisce
“washout” (che va a
monte), ha tolto loro
l’incarico. “Si può
sfondare
facendo
doppiaggio.
Oppure
attraverso
il
giornalismo.
Oppure
legando il proprio
nome a uno script,
come ha fatto Matt
Damon, facendo quello
che si chiama ‘scriptvehicle’: scrivere un
buono script e porre
come condizione di
esserne l’attore, se lo
script è accettato. Si
può sperare di essere
scritturati in occasione
diuncasting.Nefaccio
unoasettimana.Nonsi
samai:JohnMalkovich
lavoravainunalibreria
eDavidMametguidava
i taxi. Io resto invece
fedele alla vecchia
scuola,ilteatro.Recito
in spettacoli per farmi
vedere
in
scena,
sperandocosìdiessere
scritturato
per
il
cinema.” John Dewis
prosegue sorridendo:
“Ma la maggior parte
degli attori in divenire
fa il cameriere nei
ristoranti
di
Los
Angeles sperando che
un
giorno
un
produttore venga a
sedersi al loro tavolo e
gli
proponga
di
scritturarlo”.
Qualchegiornodopo,
incontro John al caffè
Coast,sullaspiaggiadi
SantaMonica,unluogo
esclusivoall’internodel
magnifico
Hotel
Shutters on the Beach.
John Dewis mi dice:
“Guarda
questi
camerieri, sono sicuro
che vorrebbero fare
tutti gli attori. Hanno
tutti
un
project
fantastico. Ma per il
momento continuano
tuttiafareicamerieri”.
Allora mi viene in
mente Mary Jane, la
ragazzadiPeterParker
inSpider-Man2:anche
lei vuole fare l’attrice,
ma continua a servire
aitavoli.
A Los Angeles, i
camerieri
sono
il
principale esercito di
riserve degli attori di
Hollywood. Tutti quelli
che non sono riusciti a
lavorarenellecentinaia
di
società
di
produzioneaudiovisiva,
nelle
agenzie
di
pubblicità, nelle decine
di
televisioni
via
satellite, nelle start-up
che fanno prodotti
derivati,
nei
videogiochi
o
nei
software
artistici,
hanno un side job, un
lavorettodacameriere.
Quando
il
settore
paraculturale
resta
inaccessibile,
Los
Angeles offre ancora
migliaia di occasioni di
lavoretti, spesso al
salario minimo di otto
dollari all’ora. Con le
mance, i camerieri
sono pagati meglio e
sono più valorizzati,
l’illusione del successo
personaleèrinviata.
È calato il buio e
dalle vetrate dell’Hotel
Shutters on the Beach,
sulla spiaggia di Santa
Monica, si vedono
immense onde. Attorno
a noi alcuni camerieri
lavorano.
“Piuttosto
che lavorare nella
ristorazione,”
dice
John, “si può scegliere
di fare una scuola di
cinema. Usc, Ucla,
CalArts: molti sognano
di entrare in una di
queste università. È
prestigioso. Ma anche
molto costoso, spesso
trentamila
dollari
l’anno.”
JohnDewis,aspirante
attore, fa una pausa,
guarda la notte calare
e, tranquillamente, ma
ancherecitandounpo’,
tra il deluso e l’ironico
dice:“EaLosAngeles,
il peggio è quasi
sempre
sicuro:
il
rischio è to loop the
loop (girare in tondo)”.
Glichiedocosaintende
dire: “Non si è mai
sicuri di nulla, dopo
aver frequentato una
costosissima scuola di
cinema, non è detto
che non ci si possa
ritrovare ancora al
punto di partenza, di
nuovo
a
fare
i
camerieri”.
6.
L’invenzionedellapop
music
Alnumero2648West
Grand
Boulevard,
Detroit, c’è Hitsville
Usa, storica sede della
casa
discografica
Motown–la“cittàdelle
hit”.
Rimango
immediatamente
di
stucco
di
fronte
all’angustia del luogo.
Si tratta di una
modesta casa collegata
con un sotterraneo a
un’altra
casa,
ugualmentemodesta,il
cui sottosuolo è stato
trasformatoinstudio.È
il celebre “Studio A”.
Qui si dice sia stata
inventata la musica
pop.
BlackDetroit.Ancora
oggi, il centro di
Detroitèunodeighetti
più “sensibili” degli
Stati Uniti. Qui è il
contrario dell’exurb, è
l’altra faccia delle
periferie abitate da
ricchiebianchi.Detroit
è un’immensa inner
city, una città in cui si
concentrano
grande
povertà, violenza e
segregazione sociale; è
un luogo che i bianchi
hannoabbandonatoper
andare in periferia
dopo le sommosse del
1967 (43 morti, 467
feriti, 7200 persone
arrestatee2000edifici
distrutti). Negli Stati
Uniti questo fenomeno
è chiamato “white
flight”, la fuga, l’esodo
deibianchi.
Nel
1967,
la
popolazione della città
era in maggioranza
bianca, oggi è per l’83
per cento nera. Si ha
l’impressione di un
ghetto,
un
ghetto
grande come una città
intera. Attraversandola
si incontrano strade
dissestate,
semafori
difettosi,negoziabuon
mercato in cui i
venditori stanno al
bancone protetti da
una grata attraverso
cui servono i clienti; si
vedono insalubri motel
che
sopravvivono
grazie
alla
prostituzione;
parcheggi abbandonati
trasformati
in
rivenditori
di
automobili in cui si
possonocomprareauto
d’occasione, di certo
rubate, quando quella
che si aveva è stata
bruciata;
ci
sono
tossicodipendenti che
vagabondano da un
posto
all’altro;
centinaia di case e di
edifici
interamente
murati;
si
vedono
volontari
neri
che
offronosoupkitchenad
altri neri senza fissa
dimora; niente cinema,
né multisala, pochi bar
e ristoranti. Questo è
ciòcherestadellacittà
che è stata la capitale
mondiale
dell’automobile.
Naturalmente
c’è
un’autostrada
sotterranea,
l’Interstate
75,
attraversata a tutta
velocità da bianchi sui
loro suv, diretti verso
laperiferianord,quella
ricca e bianca, oltre la
celebre 8 Mile Road,
chesegnailconfinedal
ghetto
nero,
dalla
miseria,daDetroit.
Motown si raggiunge
prendendo
l’uscita
Grand Boulevard verso
ovest, dall’autostrada
75.Aduepassisitrova
la
catena
d’assemblaggio
di
General
Motors,
l’ospedale Henry Ford
eigiardiniRosaParks.
“Vedrà, il quartiere è
semi-depressed,”
mi
aveva detto qualche
ora prima, con un
eufemismo,
Karen
Dumas, attivista nera
impiegata nei servizi
culturali della città di
Detroit e incontrata al
municipio. “Dopotutto
c’è peggio di Grand
Boulevard, guardi il
mio ufficio,” mi dice
Karen Dumas. “Anche
lui è completamente
depresso. Qui tutto è
disorganizzato,
abbiamoappenasaputo
che i servizi culturali
chiudono
e
sto
preparando
gli
scatoloni. Non so dove
andrò.”
Nel
1959
Berry
Gordy ha trent’anni.
Non è andato a scuola,
è senza soldi – si
considera un loser, un
perdente. Coltivava il
sogno di diventare
campione di boxe, ma
ha fallito. Ha fatto il
militare e la Guerra di
Corea, ma soprattutto
si è annoiato. Ha
cercato di fare il
protettorediprostitute,
ma ha abbandonato
perché, così dice, non
sapeva “picchiare le
ragazze”. Si è sposato
e il suo matrimonio è
sull’orlo del fallimento.
Ma ha tre figli e
dunque ha bisogno di
un minimo di entrate.
Gli piace fare hanging
out, frequentare la
scena jazz di Detroit
degli anni cinquanta e
decide di aprire un
negozio
di
dischi
specializzato nel jazz.
Ha
una
passione
particolare per Billie
Holiday, comincia a
sfogliare assiduamente
“Billboard” (la rivista
americana
con
le
tendenze e i risultati
della hit parade) e
sostiene gli artisti che
apprezza. Il negozio in
pocotempofallisce.Ha
fattounerroredibase:
BerryGordyhacercato
di vendere musica jazz
in un quartiere in cui i
giovani ascoltano solo
rhythmandblues!Peri
giovani neri di Detroit,
negli anni cinquanta, il
jazz era diventato un
genere
istituzionalizzato,
troppo
serio
e
presuntuoso.
Preferiscono
invece
quello che chiamano
“R&B”(dapronunciare
“are and bi”). Per
l’industria del disco
questo
genere
è
qualificato come “race
music”,
mentre
“Billboard” lo inserisce
nella sezione Race
MusicChart.
Il punto cruciale è la
questione
razziale.
Berry
Gordy
è
disgustatodalfattoche
la musica nera sia
prodotta da bianchi e
che sia marginalizzata
all’interno
di
una
specifica hit parade. È
consapevole
che
i
bianchisonoriuscitiad
apprezzareanchecerta
cultura nera: Frank
Sinatra era un italiano
affascinato
dalla
musica nera ed Elvis
Presley era un giovane
camionista
bianco
proveniente dal Sud
che cantava come un
nero. Perché, allora,
nonpossonoessercidei
verinerinelR&B?
Berry Gordy cerca
dunque di ritagliarsi
uno spazio all’interno
diquestonuovogenere
musicale e decide di
favorire gli autori sugli
interpreti: ha capito in
fretta che i ricchi,
nell’industria
discografica,
sono
quelli che detengono i
diritti sulla musica.
Uno degli elementi
centrali della storia
della casa discografica
Motown si costruisce,
infatti, su un modello
ormai tradizionale e
nato
alla
fine
dell’Ottocento: la netta
separazione tra editore
(publisher) da una
parte,
e
marchio,
manager e produttore
dall’altra. Il primo
gestisce
canzoni,
compositori e parolieri
(si
occupa
del
repertorio), il secondo
gestiscegliinterpretie
produce gli artisti. Gli
standard del jazz, da
Billie Holiday a Ella
Fitzgerald, il rhythm
and blues degli inizi,
compresoElvisPresley,
e la musica country si
fondano su questo
sistema.
Per
ogni
canzone
ci
sono
sempreduecontratti,e
spesso sono coinvolte
due
major:
una
publishingcompany (le
principali
sono
attualmente
Emi,
WarnerChappellMusic
Publishing e Bmg) e
unarecordcompany(le
principali major sono
oggi Universal, Emi,
Warner
e
Sony).
Questosistemasièpoi
indebolito con figure
come Bob Dylan, i
Beatles, i Bee Gees,
con il rock e il pop
degli anni settanta. Da
quel momento, infatti,
le rockstar e i gruppi,
mossi da uno spirito
più
individualista,
hanno cominciato a
fare sia i compositori
siagliinterpreti.
“All’inizio del 1957,
la
musica
era
letteralmente ovunque
a
Detroit,”
ha
raccontatoBerryGordy
nelle sue memorie
(nonostante i tentativi
non sono riuscito a
intervistarloperquesto
libro).
Motown
ingaggia i compositori
sulla base di un
contrattodiesclusività,
affinché
producano
continuamente
canzoni. Nel contempo
Gordyassoldamusicisti
di strada: cantanti di
gospel che non sono
mai usciti dalla loro
chiesa,
talenti
dell’anteguerra ormai
dimenticati e perfino
due
musicisti
del
gruppo del jazzman
Dizzy Gillespie. Infine,
ha il dono di scoprire
nuove
voci,
a
cominciare da quella
della sua più celebre
amante, Diana Ross.
BerryGordyfalavorare
autori, musicisti e
interpreti
separatamente e ci
costruisce attorno un
vero
prodotto
commerciale. Nasce la
Motown
–
abbreviazione di Motor
Town, soprannome di
Detroit.
Perché tutto ciò è
avvenuto a Detroit?
“Eranosolomonelliche
gironzolavano per le
vie di Detroit,” dice
Gordy
dei
suoi
principali artisti. La
realtà però è più
complessa. Detroit è
una delle destinazioni
dei grandi esodi dei
neri, che tra le due
guerre emigrano dal
Sud al Nord e si
insediano, risalendo il
Mississippi o seguendo
la Highway 61, a
Memphis, Kansas City,
St. Louis, Chicago,
Minneapolis, Detroit.
La maggior parte dei
cantanti di Motown,
così come di altre case
concorrenti
(Otis
Redding per Stax e
Aretha Franklin per
Atlantic),
sono
immigrati di seconda
generazione
che
dall’età di cinque o sei
anni cantano nel coro
delle chiese battiste
nere,esperienzacheha
dato loro una ricca
formazione musicale. I
padri
di
Aretha
Franklin e di Marvin
Gaye erano minister
whoopers, pastori neri
che improvvisano con
grandetrasporto;idue
futuri cantanti, già
dall’età di sei anni,
cantano nel coro della
chiesa. Otis Redding si
forma
in
una
parrocchia
della
Georgia,RayCharlesin
una chiesa battista
della Florida, Donna
Summer in una chiesa
del ghetto nero di
Boston,
Whitney
Houston
nel
coro
gospel della chiesa di
Newark,IsaacHayes(il
compositore
della
celebre canzone Shaft)
inunachiesaruraledel
Tennessee.
Ho
incontrato il reverendo
Al Green nella sua
chiesa
di
South
Memphis,
dove
continua a fare il
pastore nonostante sia
una delle più grandi
star viventi del soul.
“ArethaFranklinènata
qui,sullaLucyAvenue,
cantavanelcorogospel
di quella chiesa che si
vede laggiù. Poi è
andata a Detroit, è
entrata alla Atlantic, la
casa
discografica
concorrente
di
Motown,” mi spiega,
nel Sud di Memphis,
Nashid
Madyun,
direttore dello Stax
Museum of American
SoulMusic.
Il
successo
di
Motown
nasce
da
un’originale strategia
di marketing: Berry
Gordyintendeprodurre
una
musica
“crossover”, fatta e
controllata dai neri e
destinata ai bianchi.
Gordy vuole sfondare
nella
cultura
americana, non vuole
restare defilato come è
accaduto
a
molti
musicisti neri che fino
alla fine degli anni
cinquantasuonavanoin
salesegregatedoveera
vietato l’ingresso al
pubblico
nero.
“Crossing over” è una
delle
espressioni
feticciodiGordypoiché
per lui significa, nel
contempo, una tecnica
per
superare
le
frontiere
musicali,
mischiare i generi e
arrivare ai vertici delle
hitparade.
Gli artisti e i gruppi
di Motown saranno
quasi esclusivamente
dei neri. L’obiettivo di
Berry Gordy non è
mischiare le etnie, né
fare quella che dalla
fine degli anni settanta
negli Stati Uniti si
chiama
“diversità
culturale”: lui vuole la
difesa della comunità
nera in stile Black
Power, orgoglio nero.
Peraltro,
la
casa
discografica
ha
realizzato una poco
nota
produzione
militante:itestipolitici
dei neri, dei Black
Panthers e i discorsi di
Martin Luther King,
pubblicati su disco da
Motown (li ho scoperti
nelle collezioni della
MotownaDetroit).
I suoi dipendenti
sononeri,mentreilsuo
obiettivoèraggiungere
un pubblico di bianchi:
i teenager americani
degli anni sessanta, i
giovanicheabitanonei
suburbs
e
che
cominciano
a
frequentare in massa i
club, che non si
chiamano
ancora
discoteche,
i
frequentatori di drivein e tutti quelli per cui
la musica di Motown
diventa hip. Berry
Gordy fa incidere sulle
copertine dei dischi
“The Sound of Young
America”, slogan che
ricorda molto quello
della
campagna
pubblicitaria di PepsiColanel1961.
La cosa funziona.
Gruppi come Miracles,
Marvelettes, Supremes
(con Diana Ross, e
composto
da
sole
donne),
Temptations
(con David Ruffin e
composto
da
soli
uomini), Commodores
(con Lionel Richie)
concretizzano l’idea di
Berry Gordy: creare
artisticrossover.
Gordy non risparmia
sulla
promozione.
Investe ampiamente su
una rete di radio nere
inpienosviluppo,suun
network di club e sale
da concerti in cui
presenta la Motortown
Revue,
inaugurando
così una strategia di
marketing
adottata
anche da numerose
altre
case:
per
raggiungere i giovani
bianchi è necessario
cominciare a far sì che
quella
musica
sia
considerata hip dai
giovanineri.
Ripercorro la storia
di
Motown
al
FaboulousFoxTheater,
un’immensa sala da
cinquemila posti nel
centro di Detroit. Greg
Bellamy, direttore del
teatro Fox, mi mostra
lo spettacolare edificio
in
cosiddetto
stile
“cambogiano-gotico”,
con all’ingresso un
leone gigante i cui
occhi si aprono e si
chiudono. Mi conferma
che su questa scena “i
Miracles,
le
Marvelettes,
le
Supremesesoprattutto
la Motortown Revue
erano grandi eventi
negli anni sessanta e
radunavano migliaia di
neri”. E prosegue: “I
neri, che venivano
ancora
chiamati
‘negroes’, venivano da
tutte le chiese di
Detroit, gente di tutti i
tipi, operai della Ford,
barbieri. Sulla scena
c’era musica dal vivo,
non in playback, anche
se spesso i musicisti
erano invisibili, nel
backstage.
Gli
spettatori cantavano e
ballavano.
Erano
spettacoli coinvolgenti.
Poi ci sono state le
sommosse e la città ha
cominciato
il
suo
declino.Nel1968ilFox
ha chiuso. Era già
quasi
la
fine
di
Motown”.
Il fatto che esistesse
un vasto pubblico di
bianchi per la musica
deinerinonèstatauna
scoperta di Motown:
prima dell’impresa di
BerryGordyloavevano
già dimostrato i casi di
Kind of Blue di Miles
Davis e My Favorite
Things
di
John
Coltrane, due album
mainstream dell’inizio
degli anni sessanta. La
novità di Motown sta
nell’idea di una musica
nera intenzionalmente
creata
e
deliberatamente
venduta per i bianchi,
proposta come musica
popolare
americana.
L’ideadifondoèchela
musica nera cessi di
esseredinicchia,come
lo è tradizionalmente il
jazz,
oltrepassi
la
“color
line”
per
diventare mainstream
per tutti i bianchi.
Berry Gordy non vuole
essere in testa alle
vendite del jazz, né ai
vertici
delle
race
records chats dove è
relegata la musica
nera: vuole essere in
testa alla Top 100 e
anche alla Top 10. È
nero e non vuole
diventareilleaderdella
musica nera, ma, pur
essendo nero, vuole
diventare il leader di
tutta
la
musica
americana. Così è
diventato uno degli
inventori della musica
pop.
Per Gordy, diventare
mainstream significa
pensare a un pubblico
di massa. Per questo è
necessario privilegiare
l’emozionerispettoallo
stile, la struttura della
canzone
più
che
l’inventiva
musicale.
Occorre anche avere
un suono Motown,
costruito con caratteri
di somiglianza tra i
diversi gruppi e con
melodie riconoscibili,
come se si trattasse di
canzoni già sentite (i
neri hanno talvolta
considerato
questo
stile un po’ troppo
“bianco”
eccessivamente
“poppy”
e
non
autenticamente
“nero”). Berry Gordy
decidedimetteretuttii
suoi effetti sul groove
(battente, ritmo) e
sull’hook,
l’accordo
musicale, il leitmotiv
catchy che “prende”
all’orecchio.
Raccomanda
di
utilizzare sempre il
tempo
presente
all’interno di canzoni
brevi e si orienta sul
formato di singoli della
durata di due minuti e
quarantacinque
secondi per raccontare
una storia semplice, il
grande amore o la
ricerca della felicità in
famiglia. Naturalmente
mette sulla scena belle
ragazzeobambinineri,
figure
meno
minacciose
per
la
classe
media
americana,quelladelle
periferieinespansione,
che è il suo target.
Ogni settimana, alla
riunione di produzione
e marketing della casa
discografica, si vota
per decidere quale
canzone
meriti
di
essere
commercializzata,
in
relazione
alla
sua
possibilità di diventare
una hit. In queste
occasioni, Berry Gordy
invita alle riunioni kids
incontrati per strada
affinché diano il loro
parere – si tratta di
focus
group
ante
litteram. Motown è
un’industria,
una
fabbrica di successi
discografici,laversione
musicale delle catene
di montaggio Ford e
General Motors del
distretto di Detroit. In
pratica, Berry Gordy
non produce canzoni,
producehit.
Negliannisessantae
settanta
Motown
produce alcuni dei più
grandi
artisti
dell’epoca:
Marvin
Gaye, che Berry Gordy
renderàsensualeperle
donnedelmondointero
(la canzone What’s
Going
On
diventa
numero
1
nelle
classifiche
R&B
e
numero2inquellepop
nel 1971); il giovane
“Little Stevie” (è il
nome che vedo sui
primi album Motown
appesi ai muri di
Hitsville Usa, prima di
diventare
Stevie
Wonder)
e
naturalmente i Jackson
Five,ilcuipiùgiovane,
Michael,
con
i
voluminosicapelliricci,
hasolinoveanni.
Trail1960eil1979,
Motown compie un
vero
exploit,
ineguagliato da una
casa
indipendente:
oltre cento titoli nella
Top 10 “Pop” di
“Billboard”
–
l’hit
parade di riferimento
per il pubblico bianco,
quella che conta in
termini economici per
l’industriadiscografica.
Come
aveva
già
previsto lo scrittore
Norman Mailer con il
jazz, l’artista nero è
diventato ormai hip
(Mailer parlava di
“white
negro”,
il
giovane bianco che
vuole essere alla moda
facendo il nero e che
adora la musica nera
perché è più hip di
quellabianca).
L’avventura
di
Motown dura solo
vent’anni. Berry Gordy
abbandona Detroit per
andare a Los Angeles
dopo le sommosse dei
neri da cui è rimasto
molto impressionato.
Nel contempo, Stevie
Wonder, Diana Ross e
Marvin
Gaye
abbandonano
l’etichetta che li ha
lanciatiperandarealle
major; i Jackson Five
passano
alla
Epic
Records (all’epoca un
marchio Cbs e oggi
Sony).
Nel
1979
Michael
Jackson
pubblica da solo con
Epic l’album Off the
Wall,scrittoconStevie
Wonder
e
Paul
McCartney e prodotto
da
Quincy
Jones.
“Michael è riuscito a
emanciparsi
dalla
disco-music per creare
quella che si chiama
pop music,” commenta
Quincy Jones. Con i
singoliel’interoalbum,
JacksonentranellaTop
10 di tre categorie:
R&B, pop e dancedisco. Dieci canzoni
dell’album diventano
hit mondiali. Tre anni
dopo, con Thriller, i
singoli Billie Jean e
Beat It arrivano al
primo posto di R&B,
pop e dance. La
strategia crossover di
Berry Gordy ha avuto
successo oltre ogni più
roseaaspettativa.
Oggi,lacasaHitsville
Usa, al civico 2648
West Grand Boulevard
di Detroit, è stata
trasformata in museo.
È
un
monumento
storico tutelato dallo
stato del Michigan.
Intorno ci sono edifici
murati, devastati e
Grand Boulevard è
ormai un quartiere in
rovina.
Gordy
ha
venduto a un fondo di
investimento di Boston
la
sua
etichetta
discografica,
poi
passata a Polygram e
successivamente
a
Universal Music. Oggi
il marchio e il catalogo
Motown appartengono
alla società francese
Vivendi.
Qualche strada a
nord
di
Grand
Boulevard, in una zona
ancorapiùdevastata,si
trova l’Avenue 8 Mile.
In questo quartiere è
stata scritta un’altra
pagina della storia
della
musica
pop,
quella del rap. In
particolare con la casa
discografica
Rock
Bottom Entertainment,
Mc “Royce 5’9”, e
ovviamente
con
il
rapper
Eminem
–
“white kid” in un
mondodi“blackkids”–
che ha fatto conoscere
atuttoilmondo8Mile.
Passaggioditestimone.
“La generazione mp3
ha vinto, ma non è la
miagenerazione”
Forse la pop music è
stata inventata su
Grand Boulevard a
Detroit, con Motown.
Oppure a New York,
con
la
casa
discografica
concorrente, Atlantic,
quelladiRayCharlese
Aretha
Franklin.
Oppure a Hollywood,
qualche anno prima o
qualche anno dopo, a
Nashville e Miami.
Oppure con Frank
Sinatra, i Beatles e i
Beach Boys. Oppure
con altri artisti neri
come James Brown,
Stevie Wonder, Chic,
Barry White, Donna
SummereTinaTurner.
Oppure
è
stata
inventata negli anni
ottanta con la nascita
di Mtv. In realtà, la
questione
della
primogenitura
è
irrilevante. La pop
music,infatti,nonèun
movimento, non è un
genere musicale, è
qualcosachesiinventa
e
si
reinventa
continuamente
(l’espressione
“pop
music” è apparsa negli
anni sessanta negli
Stati Uniti ed è
diventata rapidamente
una formula confusa).
È solo una scorciatoia
per dire “popolare”, è
una
cultura,
una
musica rivolta a tutti e
che si presenta fin da
subito
come
mainstream.
“In questo settore,
l’obiettivo di tutti è il
mainstream. Ma ci
sono diversi modi per
farlo,ilnostroèl’adult
pop music, ovvero un
poprivoltoagliadultie
non solo ai ragazzini.
Credo che Motown
abbia fatto soprattutto
pop per i giovani.
Esistono due mondi
molto
diversi:
Los
Angeles da una parte,
oggi con l’hip-hop, e
New York dall’altra,
soprattutto con il pop
per adulti,” mi dice
BruceLundvall.
Lundvall oggi ha
settantaquattroannied
è
un
veterano
dell’industria
discografica.Hadiretto
una delle più celebri
etichette del jazz, Blue
Note,
è
stato
presidente di Elektra e
ha vinto due Grammy
Awards
prima
di
diventare
vicepresidente di Emi,
unadellequattromajor
della musica, acquisita
da
un
fondo
di
investimentoinglese.
Mi trovo a New York
al numero 150 della
Fifth Avenue, nella
sedeamericanadiEmi.
Nell’elegante ufficio di
Bruce Lundvall, al
sesto piano, ci sono un
pianoforte Steinway e
decine di foto di artisti
che ha avuto sotto
contratto, da Herbie
Hancock a Stan Getz,
passando per Quincy
Jones, John Coltrane e
Wynton Marsalis. C’è
anche una televisione
su
cui
scorrono
videoclip prodotti da
Emi, in quel momento
stava
passando
il
rapper Usher, che fa
una molto adult pop
music.
Sui
muri
dell’ufficio di Lundvall
cisonodecinedidischi
d’oro
(che
corrispondono a una
vendita di almeno
cinquecentomila copie)
ediplatino(almenoun
milione), tra cui quelli
di Norah Jones –
l’artista di riferimento
della divisione da lui
presieduta.
“Norah Jones è la
tipica artista crossover
che cerchiamo. Al pari
di Usher, Al Green,
DianneReevesriescea
raggiungere
tutti
grazie
all’originalità
della sua voce. Ha
venduto
quaranta
milioni di album in
tuttoilmondo,”gioisce
Bruce Rundvall. Blue
Note è un’etichetta
all’interno
di
una
major,
Emi.
Tutta
l’industria
musicale,
ma anche quella del
cinema (con le sue
unità specializzate) e
quella editoriale (con i
suoi marchi) oggi si
struttura attorno a
questo modello: una
major
possiede
numerose
etichette,
che
danno
l’impressione di essere
indipendenti.
“Un
marchio
è
anzitutto un’identità,
che si perderebbe
all’interno
di
una
grande major,” spiega
Lundvall. “La major ha
come
obiettivo
di
ricoprire
tutto
lo
spettro dei gusti del
pubblico,
tutta
la
gamma; l’etichetta si
occupa invece di un
unicogenere.Lemajor
possiedono
diverse
etichette, distinte per
generiestilimusicalie
con regimi di gestione
molto diversi, spesso
improntati
dalle
persone
che
le
dirigono. Alla Blue
Note, per esempio, c’è
molta autonomia e
possometterequalsiasi
artista sotto contratto
senza dover chiedere
luce verde a nessuno,
almenosenonsuperai
cinquecentomiladollari
di cachet. Oltre devo
otteneregreenlightda
partedellamajor.”
Con una certa ironia
chiedoaLundvallcome
siapassatodalbebope
la “fusion”, nell’epoca
in cui Blue Note era
una
delle
migliori
etichette del jazz, a
NorahJoneschefauna
sorta di smooth jazz
commerciale. Lundvall
mi
risponde
gentilmente,
senza
rancore: “Quando sono
diventato
direttore,
Blue Note aveva un
eccellentecatalogo,ma
l’etichettaeraassopita;
non si produceva quasi
più nulla di nuovo. Io
l’ho
completamente
rivitalizzata
e
progressivamente Blue
Note
è
diventata
un’etichetta pop, in
gran parte grazie a
Norah Jones. Quando
ho
cominciato
a
lavorare con Norah, lei
era un’artista jazz e
voleva assolutamente
restareconnoi,perché
aveva passione per
questo tipo di musica,
mentre avrebbe potuto
farsi mettere sotto
contratto da etichette
più mainstream come
Manhattan o Emi. A
pocoapocoèdiventata
piùpop.Cosìnoisiamo
diventatipopinsiemea
lei. E più mainstream”.
Bruce Lundvall fa una
pausa e aggiunge: “E
sa, poi ho distribuito
negli Stati Uniti anche
le hit dei Pet Shop
Boys”. Sorride e poi
aggiunge con una voce
più dolce: “Mi piace la
musica, adoro tutti i
tipi di musica, sono
fatto così. Sono forse
l’unico oggi in questa
industria?”.
Bruce Lundvall sta
all’industria
discografica americana
comeJackValentistaa
quella del cinema, a
partire dall’attività di
lobbying. Alla guida
della Record Industry
Association of America
(la
lobby
che
rappresenta le major
dell’industria
discografica e certifica
le vendite degli album)
ha
moltiplicato
le
pressionisulCongresso
americano,
anzitutto
per lottare contro la
pirateria
delle
audiocassette, poi dei
cd e più recentemente,
ma ancora invano, ha
tentato
di
salvare
l’industria musicale da
internet.Difronteame
ho un uomo distrutto
dalle recenti mutazioni
dell’industria
discografica – “non la
si può più nemmeno
chiamare così perché
ben presto non ci
saranno più dischi”,
dice
rattristato
Lundvall. Considera la
pratica di scaricare
musica
illegalmente
una “degenerazione”
venuta a distruggere
tutta la sua carriera,
brillante e condotta
scrupolosamente.
Ma non c’è solo
internet.
Bruce
Lundvallnonriescepiù
a fare i conti con il
mondo
attuale
dell’industria
della
musica. Quando gli si
dice che una casa
discografica
deve
ormai
proporre
in
Giappone quattrocento
versioni
delle
sue
canzoni per adattarsi a
vari apparecchi resta
stupefatto:
suonerie
per
cellulari,
per
videogiochi, copertine
degli
album
trasformate in sfondo
per il display dei
telefoni cellulari. E i
cambiamenti
non
finiscono qui. Dopo
essere stata acquisita
nel 2007, Emi deve
sottostare alle logiche
di
un
fondo
di
investimento inglese:
“Oggi,
i
vincoli
finanziari sono molto
forti
e
si
è
maggiormente
concentrati sul denaro.
A
livello
‘top
management’
della
major, i dirigenti e i
loro staff cambiano
costantemente;
sul
fronte delle etichette,
invece, c’è maggiore
stabilità,
ma
non
sappiamo mai ciò che
può
accadere
e
facciamofaticaastarci
dietro,”
sospira
Lundvall.Poiaggiunge,
facendo
riferimento
alla
complessa
operazione finanziaria
di acquisizione di una
società
per
indebitamento, com’è
stato recentemente il
caso per Emi: “Ho
l’impressione che i
nostri padroni siano
piùinteressatiaqueste
specifiche tecniche di
acquisizione
delle
società, i Lbo, che alla
musica”.
Solo quattro major
controllano ormai il 70
per cento circa della
musicavendutaintutto
il mondo e una sola di
queste
major,
contrariamente
a
quantospessosicrede,
è americana. Universal
Music,
leader
del
mercato, è francese;
Sony
Music
Entertainment
è
giapponese; Emi è
inglese; Warner Music
Group, infine, è l’unica
a
essere
ancora
americana
(è
comunque quotata in
Borsa a Wall Street ed
è indipendente dal
gruppo Time Warner).
Ma le nuove aziende
del
settore,
a
cominciare da Apple,
stanno fagocitando le
vendite
(con
la
piattaforma
per
scaricare
musica
iTunes, Apple controlla
unquartodellevendite
di musica negli Stati
Uniti,
su
tutti
i
supporti). In breve
tempo
il
digitale
sopravanzerà i cd,
ormai
destinati
a
scomparire.
Bruce Lundvall mi
guarda uscire dal suo
ufficio,
nella
sede
americana
dell’Emi
nellaFifthAvenue,alla
fine
della
lunga
intervista.
Improvvisamente
mi
ferma, mi tiene il
braccio e a mo’ di
addio
aggiunge
delicatamente:
“La
generazione mp3 ha
vinto, ma non è la mia
generazione”.
Prima della grande
rivoluzione di internet,
lo scenario musicale
americano
era
profondamente
cambiato
sotto
l’impulso di una serie
di
fenomeni
concomitanti e di un
certo
rilievo:
il
consolidamento delle
radio, la playlist, la
syndicationelapayola.
Il rafforzamento del
settore radiofonico è
un
esito
della
deregolamentazione
economica.
La
concentrazione
delle
radio nelle mani di un
numero ristretto di
soggetti è cominciata
nel 1987, quando le
amministrazioni
Reagan, Bush padre e
Clinton,
insieme
all’istanza federale di
regolazione del settore
audiovisivo, la Federal
Communications
Commission,
hanno
liberalizzato
questo
settore, fino ad allora
fortemente vincolato.
Inprecedenza,nessuno
poteva controllare più
di
sette
stazioni
radiofoniche,inseguito
il limite è stato
spostato a dodici e poi
a diciotto. Nel 1996 è
avvenuta la completa
liberalizzazione. Così,
un
gruppo,
Clear
Channel, è riuscito a
passare in meno di
cinque
anni
dal
controllo di 43 stazioni
a1200,diventandocosì
il
simbolo
dell’uniformazione
della programmazione
radiofonica negli Stati
Uniti.
A San Antonio e
Houston, in Texas,
dove si trovano il
quartier generale e la
direzione
delle
pubbliche relazioni di
Clear Channel, ho
cercatodiintervistarei
responsabili di questo
gruppo.Sapevogiàche
erano stati spesso
criticati
poiché
si
rifiutanodicomunicare
e per i loro metodi
decisamente
poco
trasparenti,cosachefa
a pugni con il loro
nome. Come previsto,
l’operazione
di
aggancio si è rivelata
difficoltosa. Per oltre
un anno sono passato
da un addetto stampa
all’altro, da un’agenzia
di comunicazione a
un’agenzia
di
pubbliche relazioni, ho
subìto anche alcune
minacce e non sono
mai riuscito a farmi
fissare
un
appuntamento. Per vie
traverse sono riuscito
infine a intervistare
due dirigenti di alcune
divisioni del gruppo, a
condizione
dell’anonimato.
Il successo senza
eguali
di
Clear
Channel, e ciò che gli
ha procurato la critica
di aver realizzato una
sorta
di
“mcdonaldizzazione”
dellaradio,èilfruttodi
una
complessa
strategia che unisce
nuove
tecniche
di
programmazione e di
marketing.
Anzitutto
l’uso di playlist e
syndication, che non
sono
strumenti
inventati da Clear
Channel, ma esistono
giàdatempo.Lanovità
sta nel fatto che il
gruppo
texano
ha
diffuso
queste
procedure alle migliaia
di radio che controlla.
La playlist consiste nel
determinare una lista
di
brani
musicali
limitata, spesso meno
diunacinquantina,che
vengono riproposti in
continuazione in tutte
le radio del gruppo e
messi in rotazione
ventiquattro ore su
ventiquattro.
La
syndication, frequente
anche in televisione, è
un sistema tipicamente
americanocheconsiste
nel
riutilizzare
e
trasmettere
nuovamente
un
programma, creato per
una specifica stazione,
innumerosealtreradio
che lo acquistano.
Inizialmente un simile
sistema era imposto
dalle
dimensioni
geografiche degli Stati
Uniti, divisi in una
serie di fusi orari, e
dalle regolamentazioni
che proibivano a un
gruppo di possedere
stazioni
radio
in
diversezonedelpaese,
oppure su mercati
identici.
L’aspetto
innovativo di Clear
Channel è questo: per
le proprie radio e le
radio
affiliate
costruisceunabancadi
programmiinregimedi
syndication diffusi via
satellite e rivenduti da
unastazioneall’altra.
Si tratta di un
sistema
sicuramente
efficace sotto il profilo
commerciale,maanche
politico. Il gruppo
Clear Channel è stato
infatti criticato per i
suoi
programmi
conservatori(quellodel
commentatore
ultrarepubblicanoRush
Limbaugh è ancora
oggidiffusoinseicento
stazioni),
che
avrebbero contribuito
alla doppia elezione di
George W. Bush nel
2000 e nel 2004. Uno
dei miei interlocutori,
intervistato
alla
direzione di Clear
Channel,
nega
categoricamente
questopuntoeafferma
che il gruppo diffonde,
in syndication, altri
talk-show,“comequelli
del democratico Al
Franken”.
Resta
comunque il fatto che
questo
sistema
di
“pilotaggioautomatico”
delle radio in tutti gli
Stati Uniti a partire da
una
control
room
situatainTexasèstato
diffuso
da
Clear
Channel negli anni
novanta. Quando si
ascolta una radio di
Clear
Channel
su
un’autostrada
dell’Arizona
o
del
Kentucky, l’ascoltatore
non sa che la voce del
conduttoreètrasmessa
automaticamente
a
partire da una banca
dati in Texas, anche
quando fa riferimento
al meteo locale, una
prodezza tecnologica
possibile grazie a un
aggiornamento
automatizzato
e
geolocalizzato
delle
informazioni.
L’uso
di
questa
pratica, tuttavia, è
nulla
rispetto
alla
diffusione
generalizzata di un
sistemacomelapayola.
Si tratta di un sistema
illegale, detto anche
“pay-for play”, avviato
dalle
grandi
case
discografiche fin dagli
anni cinquanta, che
consiste nel pagare, di
nascosto,
le
radio
affinché diffondano i
lorodischi.Sembrache
Clear Channel abbia
diffusoquestapraticaa
tutte le sue radio negli
anni
novanta,
istituzionalizzandola
sul piano finanziario,
contribuendo, anche in
questo caso, a una
crescente
uniformazione
della
programmazione
musicale
(il
mio
interlocutore di Clear
Channel
contesta
questo punto e nega
qualsiasi
coinvolgimento
del
gruppo in favore della
payola). “È avvenuta
una
clearchannelizzazione
degli
Stati
Uniti,”
scherzaJohnVernilledi
Columbia
(benché
anche Columbia-Sony,
come le altre major,
abbia adottato questo
sistema).
A Los Angeles faccio
la conoscenza di Tom
Callahan al MusExpo
2008,
la
riunione
annuale mondiale dei
direttori artistici delle
case
discografiche.
Callahan è stato un
manager influente alla
Sony e poi alla Emi,
dove era incaricato
proprio
della
“programmazione
radio”. Seduto a un
tavolo del club House
of Blues sul Sunset
Boulevard accetta di
concedermi
un’intervista.
Oggi
dirige un’agenzia di
talenti autonoma, ha
cambiato settore ed
egli stesso è diventato
un
indipendente,
vittima del sistema al
quale
aveva
partecipato
in
precedenza: “Le case
discografiche
non
volevano sporcarsi le
mani con la payola.
Hanno dunque affidato
questo lavoro sporco a
società intermediarie.
Si spendevano milioni
perlaradiopromotion,
cioè
per
pagare
segretamente
questi
intermediari
che
giravanopoiisoldialle
radio affinché i nostri
brani fossero inseriti
nella
playlist
e
venissero
così
trasmessi a rotazione
sucentinaiadiradio.Si
diceva sobriamente a
un artista: ‘I will get
you air play’, ti farò
passareallaradio,eciò
significava
che
si
sarebbero pagati dei
soldi per metterlo in
rotazione”. Dopo una
pausa, in cui lo trovo
inquieto per l’audacia
del
suo
racconto,
Callahan
prosegue:
“Per
comprendere
questo
sistema,
è
necessario sapere che
unpassaggioallaradio
era, allora, l’unico
modo,
insieme
al
passaggio
di
un
videoclip su Mtv, per
vendere dischi. Per far
decollare un artista e
farlo conoscere, la
radio
rimane
lo
strumento più efficace.
Tuttociòhacontribuito
anche, indirettamente,
a
manipolare
le
classifiche che, con un
effetto a catena, sono
determinate
dalla
programmazione
radiofonica. Le quattro
major del disco hanno
abusato
di
questo
sistema
e
Clear
Channelneèstatouno
dei
principali
beneficiari”.
Anche Stan Cornyn,
ex vicepresidente di
Warner Music Group e
veterano dell’industria
discografica
americana,
in
un’intervista fattagli a
Los Angeles riconosce
queste pratiche. “È un
sistema diffuso in tutte
lemajorapartiredagli
anni cinquanta. Si
basava su liquidità di
denaro, ma anche
offrendo viaggi, carte
di credito, ragazze,
cocaina…
Nell’industria
discografica si può
facilmente disporre di
denaro contante grazie
ai concerti. L’unico
problema è che queste
somme non erano, per
definizione, dichiarate.
Noncisipagavaalcuna
tassa.
Per
questo
motivo la giustizia ha
cominciato
a
controllare il sistema
dellapayola.”
A dichiarare guerra
alla payola, attorno al
2005, è stato Eliot
Spitzer,
iperattivo
attorney general dello
statodiNewYork(una
sorta di ministro della
Giustizia dello stato
federale). A partire da
una roboante inchiesta
di polizia, ha portato
alla luce un sistema
diffuso di corruzione
generalizzata
–
le
canzoni di Jennifer
Lopez erano al centro
dell’inchiesta – e ha
inflitto ammende di
decine di milioni di
dollari alle principali
major. Nel 2006 il
gruppo Clear Channel,
sorvegliato
dalla
giustizia e minacciato
di essere perseguito
per
comportamenti
anticoncorrenziali,
è
stato
costretto
a
vendere 280 delle sue
radio e suddividere le
proprie attività in tre
società: Clear Channel
Outdoor
(che
con
800.000 pannelli in 66
paesi è uno dei primi
gruppi
al
mondo,
insieme al francese J.Cl.
Decaux,
per
l’affissione
urbana),
Clear
Channel
Communications (che
controlla ancora oggi
900 radio negli Stati
Uniti,mahavendutole
sue televisioni) e Live
Nation (agenzia di
promozionediconcerti,
spettacoli e sport che
controlla 125 sale
“live” in sette paesi e
che
firma
ormai
contratti come una
normale
casa
discografica con artisti
come Madonna, U2,
Jay-Z o la cantante
colombiana Shakira).
Nonostante
questa
scissione, le tre nuove
società
di
Clear
Channel, tutte quotate
in Borsa, restano sotto
il controllo indiretto di
un’unica
famiglia
texana.
Qualche
settimana
dopo ho appuntamento
a
Encino,
nella
California del Sud, con
Ken
Ehrlich,
il
produttoredeiGrammy
e degli Emmy Awards,
gli Oscar della musica
e della televisione. Nel
suo ufficio ci sono
scatole intere di dischi
della
Motown,
un
immenso poster di Ray
Charlesedecinedifoto
in cui è ritratto con
Bob
Dylan,
Bruce
Spingsteen, Prince e
Bill
Clinton.
Ken
Ehrlich proviene dal
blues e dal jazz, ma mi
parla di Motown, rock
e rap con un senso
dell’eclettismo molto
americano.
“Continuano
a
piacermi,” mi dice
mostrandomi centinaia
di
trentatré
giri
ordinati
meticolosamente.
“Sono cresciuto in una
famiglia
ebrea
dell’Ohio, della tipica
classe media, ma la
musica nera è stata
fondamentale per la
mia formazione. Come
un
ragazzino
di
quindici anni bianco
dell’Ohio
potesse
identificarsi con i neri
per me è ancora oggi
un mistero. Forse si
spiega
perché,
in
realtà, la musica è
semplicemente
un
flusso unico che va da
Otis Redding a Usher
passando per Michael
Jackson e Tina Turner.
L’unica cosa che non
mipiaceèl’opera.Non
riescoacapirla(‘Ican’t
getit’).”
I
Grammy
strutturano il mondo
del pop e permettono
lasuaunità,aldilàdei
generiedelleetichette.
Sono stati creati nel
1958 e sono diventati
uneventoimportantea
partire
dalla
loro
diffusione sulla rete
televisiva Abc (oggi su
Cbs). Si svolgono ogni
anno, a febbraio, in
diretta
da
Staples
Center, uno stadio
sportivo nel centro di
Los
Angeles.
Ken
Ehrlich è il produttore
della manifestazione e
cerca ogni volta di
creare un evento forte,
che resti impresso
nella
memoria
collettiva, per esempio
mettendo
insieme
Eminem ed Elton John
per
annullare
l’immagine
omofoba
del rapper, facendo
suonare dal vivo Bruce
Springsteen
per
puntare
sulla
sua
natura di “animale da
palcoscenico” (mi dice
Ehrlich),
oppure
mettendo a cantare
insieme
Paul
McCartney e Jay-Z,
Madonna e i Gorillaz o
James Brown e Usher
per mescolare i diversi
generimusicali.“Ilmio
intento, ai Grammy, è
mostrare
agli
americani che non
esistono frontiere nella
storiadellamusica.”
Il
giorno
dopo
incontro
a
Santa
Monica Neil Portnow,
chepresiedequellache
nell’industria del disco
si
chiama
The
Recording
Academy.
Questa associazione ha
il
compito
di
organizzare
la
selezione dei Grammy
in circa centodieci
categorie.
“Siamo
un’organizzazione
indipendente,
al
servizio dell’industria
discografica,” spiega
Neil Portnow. “I nostri
uffici sono a Los
Angeles perché qui si
concentra
questa
industria, anche se
parte del mercato pop
e jazz è a New York, a
Miami per la musica
latina, a Nashville, nel
Tennessee,
per
la
musica
country
e
christian.”
I Grammy per la
musica,comegliOscar
per il cinema, i Tony
per Broadway e gli
Emmy
per
la
televisione, attestano
l’importanza
delle
selezioni e delle hit
parade negli Stati
Uniti. Per l’industria
dell’intrattenimento,
queste specie di serate
“elettorali”
rappresentano sia un
momento
di
condivisionedituttoun
settore, al di là dei
diversi generi e dei
singoli individui, sia
uno
strumento
estremamente potente
di
promozione
internazionale
degli
artisti americani. In
tutto il mondo, questi
concorsi
sono
la
bussola
del
mainstream.
“Ilcoolèunhipcheha
in più il successo
commerciale”
I
grandi
nomi
dell’industria
dell’intrattenimento
provengono
spesso
dalla finanza, dalle
banche, di frequente
dallatelevisioneodalle
agenzie di talenti,
talvoltadalcinema,ma
quasimaidall’industria
discografica.
Per
questo, David Geffen
rappresenta
un’eccezione.
Se con Motown,
Berry Gordy è riuscito
avenderelapopmusic
ai teenager bianchi,
facendo diventare la
musica nera hip, David
Geffen riesce a fare
ancora meglio, poiché
riesce a trasformare il
rock in genere soft e il
pop
in
cool.
Il
passaggio dall’hip al
cool è di capitale
importanza
per
l’industria
dell’intrattenimento.
Se Berry Gordy è
nato
nero,
David
Geffen è nato povero.
“In
America,
la
maggior parte dei
ricchiavevacominciato
da povera.” Questa
celebre
frase
di
Tocqueville ben si
addice a David Geffen
che proviene da una
famiglia ebrea europea
immigrata da Tel Aviv
(allora
ancora
in
Palestina)
ed
è
cresciuto negli anni
quaranta nel quartiere
ebraico di Brooklyn a
New York. È stato
autodidatta e non ha
mai finito gli studi
universitari, anche se
dice
di
avere
conseguito un diploma
alla Ucla, l’università
pubblica
della
California, e si è
procurato il primo
impiego a vent’anni
presso William Morris,
una delle agenzie di
talenti di Hollywood.
Comincia facendo il
fattorino interno e,
passando da un ufficio
all’altro, osserva i
dipendenti dell’agenzia
nelleloroconversazioni
telefoniche.
“Li
ascoltavo parlare e mi
sono detto: sono in
grado anch’io di fare
quello che fanno loro,
parlarealtelefono.”
A motivare Geffen è
lamusica,soprattuttoil
rock,cheèancorapoco
diffuso.Ottienedunque
unapromozioneeviene
impiegatocomeagente
dalla William Morris.
Ma un agente è
semplicemente
un
intermediario: Geffen
devetrattareicontratti
degli artisti con i loro
manager. A lui, invece,
piaceilcontattodiretto
con gli artisti. Così,
dopo qualche anno
abbandona la William
MorrisAgencyegrazie
a buoni contatti riesce
a diventare il manager
di alcuni artisti del
mondo del rock e del
soul. Nel 1970, dopo
aver acquisito una
certa sicurezza grazie
ad
alcuni
primi
successi,
crea
la
propria
etichetta
indipendente, Asylum
Records. Si lancia
dunque nell’Artist &
Repertory (abbreviato
A&R),
che
nell’industria
discografica significa
individuare
talenti,
compositori
o
interpreti,scritturarlie
poi “farli crescere”. In
questi
anni,
i
responsabili A&R delle
case
discografiche
hanno ancora grande
poteredecisionalesugli
artisti e sui loro
manager: scelgono i
produttori, gli studi di
registrazione,
gli
ingegneri del suono,
talvolta i musicisti e
hanno voce in capitolo
sulle uscite dei dischi
(poterechediminuiràa
vantaggio dei manager
e degli agenti, ma
anche a vantaggio dei
direttori
marketing
delle major durante gli
anninovanta).
David
Geffen
è
fortunato
con
la
propria
casa
discografica. Più che
scoprire talenti, riesce
a lanciare gli artisti
verso
il
successo.
Produce
Jackson
Browne, Joni Mitchell,
Tom
Waits
e
soprattutto gli Eagles
che,
con
Hotel
California, diventano
l’emblemadiungenere
country-soft-rock che
farà furore in tutto il
mondo.
Il
gruppo
inventa un efficace
suono
californiano
(anche
se
nessun
membro del gruppo,
tantomeno Geffen, è
californiano) in cui si
uniscono la tranquilla
ballata in stile country,
il soft rock e l’easy
listening. Geffen riesce
anche a produrre Bob
Dylan nel 1974 che
registra con lui lo
splendido
Placet
Waves, che contiene il
bel singolo Forever
Young.
LastrategiadiGeffen
è rendere cool gruppi
che, senza di lui,
avrebbero un suono
eccessivamente hardrock o risulterebbero
troppoalternativiperil
pubblico di massa.
Come
produttore,
trasforma
il
rock
acusticoequellochesi
chiama Alt-Rock (rock
alternativo),
o
ironicamenteRedState
Rock(ilrockdeglistati
repubblicani), spesso
caratterizzato
da
tonalità
troppo
“grungy”
e
voci
eccessivamente
“raspy”,inunasortadi
rock educato, meno
duro,
meno
loud
(rumoroso)
e
più
elettrico,ungenerenel
contempo più cool e
più commerciale. Con
Geffen, l’hard (rock)
diventa soft. Il suo
colpo di genio sta
nell’aver reso possibile
la commercializzazione
senzauccidereilcool–
al contrario, facendolo
vendere. “Il cool è un
hip che ha in più il
successo
commerciale,” scriverà
un critico del “New
Yorker”.
Naturalmente,
di
fronte
a
questo
appiattimento i puristi
storcono il naso, ma
Geffenconoscebenela
storia della musica
americana e non resta
impermeabile
alle
polemiche, preludio di
grandi
successi
commerciali.
Da
sempre la storia della
musica
popolare
americana
ruota
attorno
al
solito
ritornello della perdita
di indipendenza e del
suo
diventare
commerciale. Quando
Elvis Presley parte per
il servizio militare, per
molti si tratta della
mortedelrock.Quando
Miles Davis sta a
cavallo tra fusion e un
ibrido jazz-rock e poi
jazzfunk, per molti
suona l’ora della fine
del jazz (infatti è
l’inizio
della
diversificazione
del
jazz, che è tutt’altra
cosa). E naturalmente
quando Bob Dylan
lascia
la
chitarra
acustica
per
imbracciarne
una
elettrica al Festival di
Newport del 1965 (con
Like a Rolling Stone,
titolo
emblematico),
per molti si tratta del
triste annuncio della
finedelmondo!
Il
passaggio
al
mainstream è ciò che
artisti in cerca di
pubblico, e ancor più
major in cerca di soldi,
vogliono
e,
nel
contempo, è oggetto
della critica ricorrente
che i puristi fanno
quando
si
diventa
commerciali e quando
si fanno operazioni di
sellingout,espressione
che negli Stati Uniti
rappresentailmassimo
dell’insulto (to sell out
significavendersi).
David Geffen non si
fa grandi scrupoli,
dopotutto
il
suo
obiettivo è vendere.
Crede che non ci sia
più grande differenza
tra musica creata con
un’idea artistica e
musica creata per fare
denaro – tutto ormai si
mescola.
Il
suo
successo
nasce
dall’aver compreso che
la musica popolare
americanastaentrando
in una nuova fase: non
sono più importanti le
radici, il genere, la
storia, ma l’immagine,
l’atteggiamento,
la
sensibilità e lo stile (il
cool).
Geffen
è
letteralmente
affascinato
da
quell’atteggiamento
funky dei quindicenni
che vede per strada,
fatto
di
grande
malleabilità culturale e
completamente privi di
scale di valori e di
gerarchie
culturali
tipicamente europee.
Geffen
diventa
un
coolhunter, ovvero un
cacciatoredicool.
Soprattutto, Geffen
noncredecheildenaro
corrompa
il
rock.
Questo è uno dei
rimproveri che gli
viene mosso: “Quando
DavidGeffenèarrivato
nelle
acque
della
California per fare il
manager, gli squali
sono rientrati nella
laguna”,haspiegatoun
produttore. “Prima si
diceva:
facciamo
musica, il denaro è un
by-product
(un
derivato). Con Geffen
questo
motto
è
diventato:
facciamo
denaro, la musica è un
by-product,”
ha
ironizzato un altro
produttore.
Per
difendersi, a Geffen
piace parlare di sé
come un uomo onesto
in un mondo di
disonesti. Credo che
anche
lui
faccia
dell’ironia.
Il suo modo di
lavorare consiste nel
coinvolgersitotalmente
nella carriera dei suoi
artisti, ma non fa “vita
darock”comeaccadea
moltiinquestosettore;
non diventa hippy
quando produce Dylan
e non si mette ad
assumere
droghe
insieme agli Eagles né
intrattiene
relazioni
intimeconlestarcome
facevaBerryGordycon
Diana
Ross
(è
apertamente gay e
comunque si vocifera
una
relazione
con
Cher). È un uomo
d’affari
che
adora
sinceramentelamusica
senza
viverne
la
mitologia. Uno dei suoi
biografi ha scritto più
severamente: “Geffen
intraprendeilcammino
più breve verso il
registratoredicassa”.
David Geffen ha
avuto diverse vite. Nel
1975 abbandona la
propria
casa
discografica che vende
alla major Warner e va
inpensione.Losicrede
finito. Conduce una
vita
laid-back
(tranquilla),frequentai
suoi amici, viaggia tra
la costa est e quella
ovest degli Stati Uniti,
sempre
educato,
facilmente
annoiato,
insecure (sempre un
po’ angosciato). Lo si
potrebbe paragonare a
unpersonaggiodeifilm
di Woody Allen, l’uomo
tormentato di Io e
Annie,
oppure
al
protagonista di Un
uomo da marciapiede
di John Schlesinger. In
ogni caso lavora in
continuazione,comeha
sempre fatto, su nuovi
progetti. Nel 1980
torna
alla
carica
aprendo gli uffici della
Geffen Records su
SunsetBoulevardaLos
Angeles e organizza il
ritorno sulle scene a
John Lennon e Yoko
Ono
con
l’album
DoubleFantasy,unflop
nelle
prime
tre
settimane,
fino
all’uccisione di Lennon
quando
diventa
immediatamente
un
successo
mondiale
(soprattutto con la
canzone Woman). Ecco
dunque
Geffen
diventare un uomo
d’affari: “Negli anni
settantanoneropiùun
uomo d’affari. Ero
semplicemente un fan.
Giravo a destra e a
mancae,ohmygod,mi
capitava di incontrare
un tipo eccezionale
come Tom Waits e
facevoundiscoconlui.
Neglianniottantasono
invece diventato un
vero
businessman”.
Con la sua nuova
etichetta,
Geffen
produce Cher, Sonic
Youth,
Beck,
Aerosmith,
Peter
Gabriel, Neil Young e
soprattutto il gruppo
underground di Kurt
Cobain, i Nirvana.
Siamo agli inizi degli
anni novanta. Anche in
questo caso fa bingo.
Geffen riesce a far
apprezzare
da
un
pubblico di massa un
gruppo grunge in stile
DIY (Do It Yourself),
che vorrebbe essere
l’emblema del rock
alternativo, facendo di
Kurt Cobain, con i suoi
jeans
strappati,
il
portavoce di un’intera
generazione. Sperava
chel’albumNevermind
vendesse duecentomila
copie e riesce invece a
venderne oltre dieci
milioni. Esaltato dalla
criticaedalsuccesso,il
gruppo è adottato
controvoglia da Mtv
che
trasforma
immediatamente Kurt
Cobain in una star
mondiale. Geffen vince
la scommessa: rendere
i Nirvana popolari pur
conservando la propria
autenticità di base. I
Nirvana,
emblema
dell’anti-cultura
mainstream diventano
mainstream
(Kurt
Cobain,
noto
eroinomane, si suicida
dopoilterzoalbum).
Il successo di Geffen
nell’industria
discografica è notevole
alpuntodaportarload
avventurarsi in altri
ambiti:
coproduce
alcuni film con il
marchio
Geffen
Pictures come Fuori
orario
di
Martin
Scorsese e Intervista
col
vampiro,
che
decretalacelebritàdel
suo protagonista Tom
Cruise, e investe con
altrettanta intuizione e
successo
nelle
commedie musicali di
Broadway
(Cats,
Dreamgirls)
introducendo il genere
rock all’interno dei
musical.
Ancora una volta,
Geffenvendelapropria
etichetta, in questo
caso alla Mca (oggi la
francese
Universal
Music),
diventa
ulteriormente
miliardario e va in
pensione.
All’inizio
degli anni novanta
tiene
alcune
conferenze a Yale,
ospita a casa propria il
nuovo presidente Bill
Clinton, frequenta i
club più cool di quegli
anni. Poi si converte
alla
filantropia
e
diventa
collezionista
d’arte. Nella sua casa
sulla
spiaggia
di
Malibu
ha
una
collezione di opere di
Jackson Pollock, Mark
Rothko e una bandiera
americana di Jasper
Johns
dal
valore
inestimabile (che tiene
in camera sua). Aiuta
anche il suo amico
Calvin Klein, sull’orlo
del
fallimento,
lo
finanzia e lo spinge a
prendere il cantante
Mark Wahlberg come
modello per le sue
pubblicità di indumenti
intimi (le fotografie di
Mark in boxer di Herb
Ritts e Annie Leibovitz
rilanciano Calvin Klein
nelmondointeroconil
noto
successo).
A
Geffen piacciono, nel
contempo,
Jackson
Pollock e Calvin Klein,
Mark Rothko e gli
Eagles,JasperJohnsei
Nirvana; una buona
sintesi
della
mescolanza di generi
culturali negli Stati
Uniti.
“David è uno standupguy,”midiceJeffrey
Katzenberg, quando gli
chiedo di David Geffen
(uno affidabile, sempre
pronto quando c’è
bisogno di lui). Geffen
tiene
alle
proprie
amicizie e sostiene
l’amico
Katzenberg
nella causa contro
Michael
Eisner,
l’amministratore
delegato di Disney, e
dopo
avergli
fatto
incassare280milionidi
dollari di indennizzo,
fonda insieme a lui e
Steven Spielberg una
nuova
casa
cinematografica
nel
1994. Come abbiamo
già visto, si tratta di
DreamWorks
che
produce
American
Beauty,
Shrek,
Dreamgirls
(su
Motown), Kung Fu
Panda e diversi film di
Spielberg (Salvate il
soldato Ryan, Minority
Report,
in
coproduzione).
Naturalmente Geffen
crea
in
parallelo
l’etichettaDreamWorks
Records.
“David
è
probabilmente uno dei
rari
uomini
della
cultura
americana
moderna
a
essere
riuscito colpo su colpo
nelle tre industrie
chiave
dell’intrattenimento: la
musica
pop,
le
commedie musicali di
Broadway e il cinema
hollywoodiano. È un
caso unico,” mi dice
Jeffrey Katzenberg (si
può
estendere
il
complimento
allo
stesso Katzenberg che
nella sua carriera alla
Disney, a Broadway
con Re Leone ed Elton
John
e
poi
alla
DreamWorks ha fatto
ancorameglio).
Nel 2008 Geffen è
andato in pensione per
la terza volta e ha
venduto le proprie
quote di DreamWorks.
Ma
continua
a
frequentare
i
produttori, i banchieri
e i mogul di oggi, i
grandi
patron
di
Hollywood – ieri figure
come Harry Cohn,
William
Fox,
Carl
Laemmle,LouisMayer,
Adolph Zucker, Jack e
HarryWarner–dicuiè
uno
degli
eredi.
Peraltro,
a
simboleggiare questo
stretto rapporto con
Hollywood, vive nella
casa di Jack Warner a
Malibu,
che
ha
compratoapesod’oro.
Nashville,
l’altra
capitale musicale degli
StatiUniti
“Il blues è la musica
delle classi popolari
nere tanto quanto il
country è la musica
delle classi popolari
bianche,”
mi
dice
Shelley
Ritter,
direttrice del Delta
Blues
Museum,
a
Clarksdale,
piccola
città a nord-ovest del
Mississippi.
Della
storia del blues oggi
non resta più molto, a
partequestomuseo.Mi
trovo nel cuore del
Delta, zona soggetta a
inondazioni e dunque
all’epoca ricca per via
delle coltivazioni di
cotone,tral’Arkansase
il Mississippi e così
chiamata perché forma
una conca, le foci del
fiume sono infatti a
New Orleans, ben
lontano da qui. A
Clarksdale c’è ancora
qualche juke joints, i
tradizionalibarincuisi
canta ancora il blues
delDelta,masoloperi
turisti. “Il blues ha
sempre avuto uno
spirito e un pubblico
rurale, mentre il jazz è
decisamente urbano,”
aggiunge
Shelley
Ritter.
CosteggiandoilDelta
si riesce a immaginare
gli elementi attorno a
cui è nata la musica
nera americana: il
cotone,
i
piccoli
villaggi,
le
chiese
cristiane. Seguendo la
strada che parte da
New Orleans si passa
perClarksdale,Oxford,
Tupelo (città natale di
Elvis Presley, dove la
sua minuscola casa è
oggi un museo) prima
di arrivare a Nashville.
Si capisce perché, con
una storia simile a
portata di chitarra, la
principale città del
Tennessee
sia
diventata, insieme a
Los Angeles e Miami,
una
delle
capitali
dell’industria
discografica
americana.
Le
sale
di
registrazione, le sedi
delle major e gli uffici
delle
televisioni
musicali, a Nashville,
hanno sede a Music
Row. Music Row è un
piccolo quartiere tra la
Sedicesima
Avenue,
detta Music Square
East,
e
la
Diciassettesima
Avenue, detta Music
Square West, dove si
incrociano
le
autostradeI60eI45a
nord-ovest di Nashville
nelTennessee.
Sono
venuto
a
Nashville per cercare
di capire perché due
settori
importanti
dell’industria
discografica prodotti
da queste parti, il
country e la musica
“christian”, non siano
stati ancora esportati
nel mondo. (Il soul e il
R&Bsonostatiprodotti
nel Tennessee negli
anni cinquanta, ma
dagli anni settanta le
etichette sono a Los
AngelesoNewYork.)
Nella mia vita ho
ascoltato poco country,
se si escludono i dischi
di Hank Williams e di
Johnny Cash. Per me è
vagamente una musica
per americani con il
“cappello da cowboy”.
Non di questo avviso è
John
Grady,
l’onnipotente
amministratore
delegatodelladivisione
Country di Sony a
Nashville: “La musica
country è il genere
americano delle classi
popolari
e
degli
agricoltori del Sud”.
Luke Lewis, presidente
di Universal Music a
Nashville,conferma:“Il
country è la musica
tradizionaleamericana,
quella dei villaggi del
Sud, è una musica di
paese,
country
appunto”.
Lewis
aggiunge: “Il country è
una
musica
molto
radicata nella vita
locale.Lasiascoltaper
radio, ma la si suona
anche negli honky
tonks, i piccoli bar
tradizionalideibianchi,
un po’ come accade
con il blues nei juke
joints, i piccoli bar
rurali dei neri. Per
questo è difficile da
esportare. Si vende un
po’ in Canada, in
Australia, in Nuova
Zelanda, in Irlanda,
nelle città popolari del
Nord del Regno Unito,
ma è quasi tutto qui.
Nonsiriesceavendere
musica
country
a
Londra, quello è un
ambiente
troppo
urbano”.
Passando da una
casa
discografica
all’altra su Music Row,
aNashville,scoproche
all’internodellamusica
country
esistono
numerosi
generi:
appalachianfolkmusic,
country rock, cowboy
songs, southern rock,
mountain
music,
americana. Tutti questi
stili
raccolgono
un’ampia gamma di
tonalitàmusicalitraun
“alt-country”, uno stile
alternativo,
e
un
country
mainstream
criticato perché troppo
commerciale.
“Nel
primo caso si tratta di
un country troppo
roosty, nel secondo
invece è un country
eccessivamente pop e
troppo rootless (troppo
radicato
o
senza
radici),” mi spiega
Luke Lewis. “È tra
questi due estremi che
si colloca oggi tutta la
musica
country
e,
generalmente, non è
quella che vorrebbe
essere più alternativa,
ma quella che da
queste parti è meno
popolare
e
meno
mainstream, ad avere
più
successo
nei
festival
popolari
all’estero.” John Grady
spiega
questo
paradosso: “Il country
mainstream non è una
musica internazionale.
Abbiamo cercato di
fareversionipiùdance,
piùveloci,perrompere
l’apparente monotonia
del country e per
coinvolgere
un
pubblicopiùampio,ma
non ha funzionato
granché.
Bisogna
arrendersiall’evidenza:
oggi negli stati Uniti il
countryèpoesia,itesti
hanno un linguaggio e
parolemoltoradicatiin
questi luoghi. E la
poesia non si può
esportare”. Negli Stati
Uniti il mercato del
country
è
stimato
attornoal10percento
dellevenditedidischie
deldigitale.Èilgenere
musicale più diffuso
alla radio in termini di
stazioni,oltre1400.
A Nashville si passa
facilmente dal genere
country alla musica
christian
(cristiana).
Tutte
le
case
discografiche
hanno
sede nel medesimo
quartiere, attorno a
Music
Row;
sono
distanti meno di un
chilometro.
Eppure,
queste due industrie
discografiche sono due
mondi
separati.
Quando visito gli uffici
delle
major
che
producono
musica
christian,
resto
sorpresodaunagrande
differenza: non c’è
alcuna sensualità, sulle
copertine dei dischi
non ci sono ragazze
procaci, né l’immagine
di uomini maturi tutta
durezza e linguaggio
gergale come vedevo
invece poco distante
negliufficidellamusica
country.
Sulle
copertine dei cd, noto
con
sorpresa
che
spesso
tra
i
ringraziamenti
c’è
scritto:Gesù.
“In
fondo,
noi
facciamo parte della
musica gospel,” mi
spiegaDwayneWalker,
direttore A&R di Light
Records,
etichetta
specializzata in musica
cristiana. “Si pensa
spessocheilgospelsia
una musica nera, ma
anzitutto è musica
cristiana. Noi facciamo
musica cristiana che è
semplicemente
bianca.” John Styll,
presidente di Gospel
Music
Association,
lobby ufficiale sia di
gospel nero sia di
christian
bianca
conferma:
“Statisticamente,
la
musica gospel è per il
99 per cento nera, e la
musica christian è per
il 99 per cento bianca.
Ma nelle strategie di
marketingdellamusica
cristiana si preferisce
usareilterminegospel,
invece di christian che
è
più
connotato.
Peraltro, per mettere
tutti
d’accordo,
ultimamentesiparladi
‘southern gospel’ e di
‘blackgospel’”.
Ancora una volta, a
Nashville mi vengono
regalati
dischi
di
generi
musicali
differenti:
christian
gospel,
southern
gospel, Jesus-rock (più
vecchio),
God-rock,
gospel-rock, christian
rap e anche rock
inspirational
(che
dovrebbe ispirarmi ed
essere edificante). Ho
l’impressione
che
esistano tanti generi
musicali quante chiese
cristiane – Nashville è
la città americana in
cui ci sono più chiese
per
chilometro
quadrato. Mi trovo nel
cuore di quella che
chiamano “Bible Belt”,
letteralmentelacintura
dellaBibbia.
Come accade per il
country,
e
come
abbiamo visto anche
con Motown, anche la
musica christian si
basa
sulla
netta
separazione
tra
compositori
che
scrivono le parole e
interpreti. In questo
senso, Nashville è un
luogo singolare, da
sempre è una città in
cui si scrive musica
ancor
prima
di
suonarla.
“L’editore
è
l’elemento
centrale
dell’industria
di
Nashville e le case
discografiche
possiedono anzitutto, e
soprattutto,
il
repertorio.
Spesso
vendiamolecanzoniad
altre case,” mi spiega
Eddie
de
Garmo,
amministratore
delegato
di
EmiChristian
Music
Group. “Nashville è
una
città
di
compositori,” aggiunge
Tony
Brown,
ex
pianista
di
Elvis
Presley, attualmente a
capo
di
Universal
South, la divisione di
Universal con sede a
Nashville che raccoglie
alcune etichette di
musica country, gospel
echristianrock.
ConstatocheaMusic
Row, a Nashville, sono
presentilesediditutte
le major: più in piccolo
è lo stesso scenario
presenteaLosAngeles
e New York. “Qui ci
sono soprattutto le
etichette, ciò significa
che
ci
occupiamo
soprattutto
degli
artisti,
della
loro
crescita e della loro
promozione.
A
occuparsi del backoffice,deiservizilegali,
delle risorse umane,
della
distribuzione
nazionale
e
internazionaleèlacasa
madre,direttamenteda
New York o da Los
Angeles.
Chi
è
indipendente
è
soggetto alle banche e
agli
investitori,
io
invece dipendo dal
direttorediSonyMusic
Entertainment
per
l’America del Nord, un
tipo che conosce la
musica e apprezza gli
artisti. Contrariamente
aquantosidicespesso,
preferisco
la
mia
situazione rispetto a
essere
un
indipendente,”
si
giustifica John Grady,
amministratore
delegatodiSonyMusic
aNashville.
Dal Sud degli Stati
Uniti,
le
etichette
christian cercano di
esportare
la
loro
musica? “La christian
music,comeilcountry,
sono generi basati più
sulle parole dei testi
che
sulla
musica,
diversamentedalpope
dal rock. Questi tipi di
musica sono legati a
specifici valori e modi
di vita, cose molto
difficili da esportare,”
spiega
Ric
Pepin,
vicepresidente
di
Compendia Music, una
mini-major
che
controlla
diverse
etichette
country,
gospel e christian. Poi
precisa: “Secondo me
la musica cristiana di
Nashville si svilupperà
molto
in
America
latina,
in
Africa,
quando diventerà più
matura. È un genere
ancora
giovane,
contrariamente
al
countrychequihauna
storiamoltoantica”.
Eddie de Garmo,
amministratore
delegato dell’etichetta
christiandellaEmi,non
condivide questo punto
di vista: “La christian
esiste
da
almeno
venticinque anni a
Nashville, anche se è
diventata famosa solo
durante la presidenza
di George W. Bush. È
una musica cristiana
che
somiglia
alla
religione
degli
americani, mi sembra
troppo protestante e
troppo lirica per poter
piacere ai cattolici.
Non credo si riuscirà a
esportare facilmente,
se
non
riducendo
drasticamentel’aspetto
della
predica
e
camuffando la propria
identità. Invece, il
pubblico può crescere
ancora
negli
Stati
Uniti,
dove
siamo
passatiinquindicianni
da un mercato di
nicchiaalmainstream”.
Intervistando decine
di produttori e di
musicisti di musica
christian non solo a
Nashville, ma anche a
Memphis, Denver e
Colorado Springs, mi
rendocontochetuttila
considerano
una
controcultura pronta a
fare il salto nel
mainstream.
“La
cultura christian è a
una svolta, a un
momento di cesura,
quello che nella Bibbia
si
chiama
effetto
Gedeone:Gedeoneèda
solo? Sono migliaia?
Siamo come Gedeone,
esistiamo, ci sentiamo
soli
nella
nostra
comunità,masiamogià
migliaia.
Stiamo
entrando
nel
mainstream,
ma
facciamo ancora parte
di una controcultura.
Siamo come Bob Dylan
e Joan Baez negli anni
sessanta,
controcultura,
antimainstream,
una
nicchiadelfolkchesta
ingrandendosi, sempre
di più, fino a quando
tutti
abbracceranno
questa musica,” mi
dice in tono un po’
acceso Ross Parsley,
celebre pastore della
New Life Church a
Colorado Springs (la
domenica in cui l’ho
incontrato ho assistito
alla
cerimonia
di
questa “mega-church”:
cinque
gruppi
di
christian rock erano
davanti all’altare, un
coro con centinaia di
partecipanti e venti
pastori che officiavano,
con microcravatte, le
loro immagini erano
riprodotte su decine di
schermi
giganti,
attorno
a
Parsley,
davanti
a
oltre
settemilafedeli).
La musica christian
rappresenta oggi circa
il 7 per cento delle
venditedimusicanegli
StatiUniti(gospelnero
e
bianco
messi
insieme), ha classifiche
proprie,
il
suo
barometro,
Nielsen
Christian Sound Scan,
lasitrovanegliscaffali
dei supermercati e
spesso fa da colonna
sonora
in
film
hollywoodiani
come
Matrix e Le cronache
di Narnia di Disney. È
utilizzata anche in
commedie musicali a
Broadway come !Hero,
the Rock Opera (il
punto
esclamativo
iniziale fa riferimento
al nome di Gesù nella
Bibbia e il musical è
ambientato
a
Bethlehem, vero nome
di una città della
Pennsylvania). Si è
sviluppata una vera e
propria
industria
cristiana nella musica,
nelteatrocommerciale,
nell’editoria, le librerie
hanno nuovi scaffali di
christian books, ma
anche nel cinema,
come ha dimostrato
l’inatteso successo di
PassiondiMelGibson.
MusicTelevision
Appeso al muro c’è
unoskateboardbianco.
Negli
uffici
dei
dirigentidelleindustrie
creative avevo visto
copertine di album
dischi
di
platino,
talvoltaquadrioriginali
di Warhol o di David
Hockney, ma mai uno
skateboard.
Nell’ufficio di Brian
Graden, presidente del
network
Mtv,
su
Colorado Avenue a Los
Angeles,sullascrivania
cisonoancheimmagini
firmate da celebri
rapper; ci sono una
fotodiBarackObamae
molti poster di show
televisivi
noti
universalmente.
Contemplo
questa
scenaalungo,mitrovo
da solo. L’assistente di
Brian Graden, un “Mtv
kid” in sneaker, viene
ad avvisarmi che Brian
si è sentito poco bene
nella notte e che è a
letto nel suo condo di
West
Hollywood.
Comunque non c’è da
preoccuparsi,
potrò
discutere
con
lui
attraverso un sistema
efficace
di
audioconferenza; posso
accomodarmi sulla sua
poltrona e sentirmi a
mio agio. Mentre va a
telefonare per stabilire
ilcollegamentotranoi,
non posso evitare di
pensare che, in un
postocomeMtv,invece
di un’audioconferenza
ci si sarebbe aspettati
unavideoconferenza.
Brian
Graden
è
presidente di Mtv,
dirige
la
programmazione
e
inoltre
coordina
diverse
emittenti
tematiche del network.
Stando
alla
sua
biografia, che mi è
stata
fornita,
è
abbastanza giovane –
sulla quarantina – ed è
passato per il famoso
Mba
di
Harvard.
Attraverso il sistema
audio posto sul tavolo
della sua scrivania gli
chiedo in cosa consista
il
suo
lavoro.
Dall’amplificatore esce
forte e chiara la sua
voce, in una sola
parola,
“entertainment”. “La
mia
professione,”
continua Graden, “è
l’intrattenimento, far
contente le persone,
fare in modo che ai
giovani piaccia ciò che
glisipropone.”Unodei
capitoli della biografia
di Graden si intitola:
Presidente
per
l’intrattenimento
di
Mtv. Faccio una critica
diretta sul fatto che
Mtv trasmetta un tipo
di musica formattato.
“Caro Frederic,” mi
risponde Graden, con
voce dolce, “sono fiero
del mio pubblico. Vado
fiero dei gusti del mio
pubblico. Adoro il mio
pubblico. I giovani. È
importanteamarli.”
Mtv
(Music
Television)
ha
cominciato
le
trasmissioni
il
1°
agosto 1981. “Ladies
and gentleman, rock
and roll” è stata la
prima
frase
pronunciata
dall’emittente,lettadal
presidente dell’epoca
con lo sfondo di
immaginidell’Apollo11
che si posava sulla
Luna. Da allora, Mtv
non ha più trasmesso
rock and roll, ma soft
rockepopmainstream,
ed è tornata sulla
Terra. Nell’epoca del
digitale,
l’emittente
fatica a trovare una
propria collocazione,
subisce la concorrenza
diretta di YouTube e
quella, indiretta, di
numerose
emittenti
musicali via satellite
negli Stati Uniti e in
tutto il mondo. In poco
tempo l’audience si è
abbassata,
il
giro
d’affari
si
è
assottigliato
e
l’azionista
di
riferimento,Viacom,ha
fatto pulizia. Quando
ho
incontrato
i
dirigenti di Mtv negli
StatiUniti,inEuropae
in Asia o America
latina, ho percepito
sempre
una
certa
inquietudine.PerMtvè
tempo di crisi, di nuovi
abbandoni. Ma non è
semprestatocosì.
Nella hall della sede
di Mtv a Los Angeles
c’è un camper. “È un
vecchio modello degli
anni cinquanta,” mi
dice la persona che mi
favisitareglistudi.Nel
camper
c’è
una
televisione
rossa
accesa, un tostapane,
sedie verdi di plastica.
Sembra il camper di
Ozzie e Harriet, i
personaggi di una
famosa sitcom degli
anni cinquanta, in
partenza
per
le
vacanze. Mi sembra
uno
scenario
nostalgico, fatto forse
per ricordarsi che
un’emittente televisiva
nonpuòessereeterna.
Mtv, all’inizio, ha
rischiato,
ma
poi
l’emittente
musicale
con
una
programmazione
ventiquattro ore su
ventiquattro
è
rapidamente riuscita a
imporre
un
nuovo
genere, il videoclip,
costringendo
così
l’industria discografica
a ricalibrare se stessa
nell’era del video.
Come
è
sempre
accaduto, prima con la
radio,poiconillettoreregistratore di cd, oggi
coninternet,l’industria
discografica fatica ad
accettare
immediatamente
le
novità tecnologiche e,
inizialmente,
ha
rifiutato
anche
i
videoclip. Poi è stata
costretta a ripensare
aglisviluppidelproprio
settoreindustrialeeha
cominciato a utilizzare
le immagini. Il primo
videotrasmessodaMtv
nel
1981
aveva
qualcosa di profetico,
era Video killed the
radioStardeiBuggles.
All’inizio, il formato
pensato da Mtv era
quello di diffondere a
rotazione canzoni della
Top 40 (sul modello
della hit parade che
dalla metà degli anni
sessanta domina negli
Stati Uniti). Si trattava
dunque, soprattutto, di
musica
pop,
per
esempio Duran Duran,
Eurythmics,
Culture
Club e, ben presto,
Madonnachestavaper
essere lanciata proprio
da Mtv per diventarne
l’artista emblema. A
presentare lo show,
generalmente c’erano i
vj, video-jockey che
Mtv ha reso popolari,
sulmodellodeldj(discjockey). Fin dall’inizio
Mtv è stata criticata
per
essere
semplicemente
un
“rubinetto
di
videoclip”.
In
realtà,
intervistando
i
dirigenti, si scopre che
ilsistemasceltodaMtv
era più precario di
quanto il successo
abbia fatto credere.
All’inizio, Mtv ha avuto
molte
difficoltà
a
trovare un numero
sufficiente di videoclip
per
alimentare
ventiquattro ore di
programmi quotidiani,
e
ciò
spiega
la
frequente
rotazione.
Filmati di concerti,
rudimentali
video
promozionali
e
diffusione
continua:
tutto era utile per
compensare
la
mancanza di contenuti.
Il
successo
dell’emittente ha fatto
capire
all’industria
discografica i benefìci
che poteva trarre dalla
collaborazione:
dopotutto i videoclip
corrispondono
a
pubblicità gratuita per
la musica. Inoltre, con
Mtv
un
artista
diventava commerciale
più velocemente. I
videoclipsonodiventati
sempre più elaborati,
audacieprofessionalie
Mtv ha assunto un
posto
centrale
all’interno
delle
strategie di marketing
delle
grandi
case
discografiche.
Mtv
ricopre
un
ruolo
fondamentale
nella
storia della cultura
pop.
Come
stava
facendo nello stesso
periodo anche David
Geffen,
Mtv
crea
l’anello mancante tra
cultura e marketing,
tra musica pop e
musica
“ad”
(pubblicitaria),
tra
cultura di nicchia e
cultura
di
massa,
unisce due mondi che
siritenevanoseparatie
che invece scoprono di
poter
andare
a
braccetto:
quello
dell’arte e quello del
commercio. Dopo la
nascita di Mtv sarà
sempre più difficile
separare nettamente
questiduemondi.
In
ogni
caso,
l’emittente ha avuto
alcune difficoltà agli
inizi a trovare la
proprialineaedèstata
salvata da quel che
all’iniziosierarifiutata
di
promuovere:
la
musica
nera.
Per
quantopossasembrare
strano, vent’anni dopo
la nascita di Motown,
nel
1981,
Mtv
considerava la musica
nera
un
ghetto,
qualcosa
non
abbastanzacrossovere
pocomainstream.Peri
dirigenti
bianchi
dell’emittente,
la
musica nera era un
genere, una nicchia.
Anche Michael Jackson
eramessoalbando.Un
giornol’amministratore
delegato di Cbs, che
attraverso l’etichetta
Epic aveva Jackson
sotto
contratto,
è
andatosututtelefurie
minacciando
di
boicottare
completamente
l’emittente con tutto il
suocatalogoseJackson
avesse continuato a
essere boicottato (poi
Mtv è stata acquisita
da Viacom-Cbs). Billie
Jeanèmandatainonda
nel 1983, seguita da
Beat It. In un balletto
in stile West Side
Story, Michael Jackson
figuracomepacieretra
due bande rivali e
cerca di convincere
entrambe a cessare le
rivalità. È vestito con
una giacca di cuoio
rosso
e
calzette
bianche. Per il video
sonostatireclutativeri
membri delle gang. Un
successo
mondiale.
Quando nel dicembre
1983 Mtv manda in
onda il videoclip, della
durata di quattordici
minuti, di Thriller,
remake del film di
paura, con un ritmo di
messa in onda di due
volte
all’ora,
l’emittente cablata e
ancoramarginaleentra
nel
mainstream.
Abbandona il rock per
il pop e il R&B. E si
apre definitivamente ai
neri.
Dieci anni dopo, Mtv
affronta
lo
stesso
dibattito interno sul
gangsta
rap,
considerato
troppo
violento e con allusioni
sessuali
troppo
esplicite.
L’amministrazione
Clinton minaccia di
censurare gli eccessi e
Mtv esita. Dopo aver
consultato
avvocati
specializzati,
la
direzione
dell’emittentedecidedi
rischiare mandando in
onda a ripetizione i
videodiunodeigruppi
rap più estremi, più
misogini,
più
intolleranti
nei
confronti dei gay e più
tolleranti sull’uso della
droga.
Dal
1998
gangsta rap salva Mtv
che ritrova così una
solidità economica e
unisce
alla
sua
programmazione per
un pubblico di massa
una
musica
nera
comunitaria radicale in
forte espansione. In
quell’anno, l’hip-hop fa
segnare una vendita di
ottantuno milioni di
dischi negli Stati Uniti,
acquistati
da
un
pubblico bianco per il
70 per cento. Anche il
rap, a sua volta,
diventamainstream.
Negli uffici e negli
studi di Mtv a Los
Angeles e a New York,
nella sede del gruppo
(simbolicamente
situata all’angolo tra
Broadway
e
la
Quarantaquattresima
Strada) e negli studios
di Black Entertainment
Television,
che
appartiene al gruppo,
ho incontrato giovani
neri, asiatici, latinos.
Parlando con questi
artisti e con altri
giovani delle stesse
etnie incontrati nei
ghetti americani ho
cominciatoadafferrare
una cosa importante
per
comprendere
l’intrattenimento e la
cultura mainstream di
oggi.Epiùfrequentavo
gli uffici di Mtv, più
parlavo
con
Brian
Graden, o con il suo
vice Jeff Olde, che ho
rivistopiùvolteneibar
di West Hollywood, più
cominciavo a pensare
che i confini che
separano
arte
e
intrattenimentosonoin
gran parte il risultato
di
valutazioni
soggettive. Il posto in
cui si pone questa
frontiera è spesso
indice dell’anno in cui
siete nati o del colore
dellavostrapelle.
BrianGradenèanche
presidente di Logo, il
canale“gayfriendly”di
Mtv. Il suo obiettivo è
ricostruire Mtv con i
giovani gay, i giovani
neri, latinos e asiatici.
Attualmente internet,
YouTube
e
Daily
Motion fanno grande
concorrenza ai canali
musicali. La diffusione
divideoclipgratuiti,ciò
che ha decretato il
successodiMtveilsuo
modello economico, si
è
rivoltata
contro
l’emittente. Nell’epoca
del digitale i videoclip
sono, infatti, gratuiti
anche per i potenziali
concorrentiedesistono
ormai
numerose
emittenti simili a Mtv
in tutti i continenti.
Così, Graden è stato
incaricato, insieme ad
altri,dellarifondazione
di Mtv attraverso una
strategia di grande
impatto. Dunque, Mtv
ha
nel
contempo
riaffermato la propria
vocazione
generazionale
concentrandosi
sulla
fascia
quindicitrentaquattro anni, ha
voltato le spalle ai
videoclip, diffusi su
internet, per preferire
formati più interattivi,
larealitytv,lastand-up
comedy e il talk-show.
“Abbiamo ripreso il
controllodeicontenuti:
non siamo più un
rubinetto di videoclip,”
spiega Graden. La
priorità è data alla
diffusione
dei
programmi esclusivi, il
contrario di quanto
faceva in precedenza
Mtv, che continua
comunque a chiamarsi
Music
Television.
“Proporrepiùcontenuti
su più supporti, con
una
maggiore
esclusivitàeprodottiin
premium, questa è la
nuova Mtv,” commenta
Graden,checontinuaa
pensareanuoviformati
su tutti i supporti
immaginabili.
“Testiamo migliaia di
formati e di pilots, ma
alla
fine
ne
selezioniamo
molto
pochi.” Visitando “il
motel”, l’edificio in cui
sono testati questi
progetti
pilota,
sull’altro
lato
di
Colorado Avenue, sono
sorpreso dalla capacità
di
innovare
e
abbandonare,
senza
preoccupazione,
la
maggior parte dei
prototipi.
Tutto
il
lavoro consiste nel
continuare
a
immaginarecosenuove
in ogni direzione per
poi abbandonare l’idea
e
pensarne
altre
ancora: la creazionedistruzione
è
una
dimensione
fondamentale
dell’innovazione delle
industriecreative.
Questo è stato solo
l’inizio di una strategia
diriconquistamondiale
resa possibile grazie
alla ricchezza della
casa
madre,
il
conglomerato
mediatico
Viacom,
proprietario di Mtv. È
stata inoltre fatta la
scelta di entrare con
forza nel settore del
digitale e di seguire i
nuovi usi dei giovani.
Mtvcontinuaaoperare
nel
campo
della
sperimentazione
tecnologica:
attualmente sono attivi
oltre trecentonovanta
siti
web,
vengono
creati
migliaia
di
contenuti esclusivi per
l’applicazione Mtv su
iPhone e sono stati
siglati
accordi
di
collaborazione
internazionale con siti
come MySpace (che
appartiene al gigante
News Corp). Tutto ciò
per
cercare
di
avvicinare
la
generazione internet
che vuole tutti i
contenuti,
in
ogni
momento e su tutti i
supporti – è quella che
a Mtv Brian Graden
chiama la generazione
“on-demand”. Tra gli
elementi centrali di
questa nuova strategia
c’è il forte interesse di
Mtv per il settore dei
videogiochiesuquesto
fronte l’emittente ha
acquisito a man bassa
start-up sperimentali e
case di produzione più
affermate
come
Harmonix
e
Atom
Entertainment.
Da
queste sperimentazioni
sono nati videogiochi
popolari come Rock
Band, che ha venduto
oltre sette milioni di
esemplari.
La
questioneèsapereseil
grupposaràingradodi
cambiare rapidamente,
di essere abbastanza
flessibile,
per
adeguarsi
alle
aspettativeeagliusidi
internet
che
ogni
giornosiaccelerano.
Il gruppo Mtv si è
allontanato
dal
mainstream
unico
attraverso
una
segmentazione del suo
pubblico realizzata con
una diversificazione di
programmi, di siti e di
canali televisivi. Mtv si
è
lanciata
nel
mainstream
plurale.
Oggi, l’emittente non
hapiùununicocanale,
ma
centocinquanta
canali tematici. In
Europa, per esempio,
Mtv Base è il canale
hip-hop
(ovvero
il
canalediriferimento,il
più mainstream), Mtv
Pulseèilcanalerocke
Mtv Idol quello di
musica internazionale.
A seconda dei vari
paesi, Mtv propone
canali
destinati
a
diversitipodipubblico,
quelli appassionati di
digitale
(Mtv
GameOne), i latinos
(Mtv Latin), gli asiatici
(Mtv Asia), i gay
(Logo),
i
giovani
appassionati
di
commedie
(Comedy
Central) e anche i
bambini
attraverso
un’offerta specializzata
per questa fascia d’età
(Mtvn Kids & Family
Group).
Questi
programmi,
spesso
ideati a Los Angeles,
MiamieNewYork,non
alimentano solo le
televisioni del gruppo
negli Stati Uniti, ma
l’intero “pianeta Mtv”,
che oggi ha uffici in
centosessantadue
paesi. “Mtv è una
pipeline che viene
approvvigionata
di
continuo,”
conferma
Thierry
Cammas,
amministratore
delegato del gruppo
MtvinFrancia.
Infine,
Mtv
ha
adottato, dopo diversi
fallimenti in Europa e
in America latina, una
strategia
su
scala
locale che propone
un’efficace miscela di
programmiamericanie
diprogrammilocali.“Il
DnadiMtvèlamusica
mainstream
americana,” prosegue
Thierry
Cammas.
“Siamo un media di
divertimento
internazionale. Questa
è la nostra identità,
non possiamo negarla.
Ma bisogna calare i
nostri programmi nella
realtà locale in cui
trasmettiamo.Questoè
il
compito
dei
programmi di realitytv, dei talk-show e
dell’intrattenimento i
cui contenuti sono
sempre realizzati dalle
divisioni locali di Mtv.
Per esempio, non si
parla mai inglese su
MtvFrancia.Dobbiamo
comunicare
con
il
nostro
pubblico
costantemente,
in
francese, e su tutti i
supporti, poiché nel
mondo del digitale è
difficile
avere
un
pubblico
sempre
fedele,mentreeravamo
imbattibili nel mondo
dell’analogico.”
Mtv
ormai trasmette in
trentatrélingue.
Mtv è dunque in
piena rivoluzione. Judy
McGrath,
amministratore
delegato del gruppo, a
New York e Brian
Graden a Los Angeles
cercano di difendere la
linea.Eperfarequesto
bisogna restare hip.
Come fanno questi
amministratori
delegati, che hanno il
doppio dell’età del loro
pubblico,arestarehip?
“Noi dobbiamo essere
taste-makers,”
mi
rispondeBrianGraden,
sempre
in
audioconferenza. “La
gentechelavoraaMtv
è
convinta
che
all’interno di questo
gruppo sia come stare
in La fuga di Logan (il
film
e
la
serie
televisiva), dove tutti
gli ‘over thirty’, quelli
di oltre trent’anni,
spariscono. Quelli che
restano sono come
PeterPan,nonvogliono
diventare
grandi.
Lavorano
dunque
continuamenteaffinché
Mtvdiventiunnetwork
con
una
programmazione fatta
per un kid hiphop di
sedici anni, un giovane
black in sneaker.”
Thierry
Cammas
confermainaltromodo
questa filosofia: “Non
dico di conoscere i
giovani.
Corro
semplicementedietroa
lorotuttoilgiorno”.
Come
è
potuto
accadere che giovani
kids neri, gay o latinos
siano
riusciti
a
diventarealoromodoi
trendsetter
e
i
tastemakers di Mtv,
quelli che dettano la
moda e definiscono il
gusto?
Quelli
che
frequentano l’hip e
ratificanoilcool?Cos’è
successo alla critica
americana se oggi a
stabilire i dettami sono
giovani sedicenni in
sneaker e skateboard
fieri di amare la
controcultura
tanto
quanto la cultura popcommerciale? Non ho
cessato di pormi simili
domande dopo questa
intervista a Mtv. Ho
capito in fretta che era
successo qualcosa di
importante
nella
cultura americana, tra
arte e intrattenimento,
traéliteemasse,anche
traculturaeminoranza
nera
e
questa
trasformazione è stata
decisiva
come
propulsore
delle
industrie
creative
americane ovunque nel
mondo.
Allora
ho
capito
perché,
all’interno
di
un’emittente così pop
come Mtv, ci fosse uno
skateboard appeso al
muro nell’ufficio di
Brian Graden. Era il
simbolo
della
controcultura,
dell’indipendenza e del
cool, nel cuore della
macchina
del
mainstream.
7.
Pauline,Tina&Oprah
Pauline Kael è morta
il 3 settembre 2001
nella sua casa nel
Massachusetts,
il
giorno stesso in cui mi
sono trasferito negli
Stati Uniti. Non sono
dunque mai riuscito a
intervistarla, eppure è
una delle figure della
cultura americana di
cui
ho
sentito
maggiormente parlare.
Da Boston a San
Francisco, da Chicago
a
Memphis,
ho
incontrato
ovunque
suoi fan che mi
citavano a memoria
frasi che aveva scritto.
Spesso ho incontrato
anche i suoi eredi
spirituali, quelli che,
negli Stati Uniti, si
fanno
chiamare
“Paulettes”. La cosa
piùstranaancoraèche
Pauline
Kael
è
famosissima negli Stati
Uniti, ma quasi del
tutto sconosciuta in
Europa. Tuttavia, mi
sono progressivamente
reso conto che per
capire la rivoluzione
avvenuta negli Stati
Uniti nel rapporto tra
élite e cultura, tra arte
e intrattenimento, era
necessario conoscere
Pauline
Kael
e
diventare a mia volta
un “Paulette”. Kael
incarna forse, insieme
a Tina Brown e Oprah
Winfrey – le tre donne
acuièdedicatoquesto
capitolo – una sintesi
delle evoluzioni che
hanno fatto scivolare
l’America verso la
culturamainstream.
Pauline Kael era
semplicemente
un
criticocinematografico.
Non si occupava di
“film”, poiché a Kael
non è mai piaciuto
questo termine che, in
inglese,
suona
presuntuoso, artistico
ed elitario, ma di
“movies”. Era nata nel
1919 in una fattoria
della California da una
famiglia di immigrati
polacchi ebrei. Nella
piccola città in cui è
cresciuta negli anni
venti–ilgrandeOvest,
lo spirito dei pionieri,
laculturamiddlebrown
diunafamigliadelceto
medio – l’arte era
inesistente,
ma
il
cinema onnipresente.
In quegli anni, gran
parte degli americani
andava al cinema una
volta alla settimana e
anche la famiglia Kael
vedevatuttiifilm.Non
ha mai abbandonato
quell’ottimismo della
gente
dell’Ovest
americano,
quel
bisogno di aria, spazio
e
libertà,
l’atteggiamento
del
“don’t-fenceme-in”
(non volersi chiudere,
limitare).
La
sua
famiglia cade in rovina
durante la Grande
depressionedel1929e
deve abbandonare la
fattoria, specializzata
in polli e uova, per
trasferirsi
a
San
Francisco. Si sposa e
divorzia
tre
volte
(quattrosecondoalcuni
biografi), è sempre a
caccia di lavoro per
poter
crescere
la
propria figlia, molto
cagionevole di salute.
Hafattolacamerierae
la cuoca in piccoli
ristoranti e anche la
sarta;
ha
fatto
marketing telefonico a
domicilio per 75 cent
l’ora; ha fatto da
ghostwriterdimediocri
romanzi polizieschi e
ha partecipato alla
scrittura
di
guide
turistiche di paesi in
cui non è mai andata.
La sua passione sono
peròifilme,neglianni
quaranta, comincia a
lavorare in un cinema
d’essai
di
San
Francisco, prima come
cassiera poi come
manager, e scrive già
brevi recensioni dei
film proiettati. Negli
anni
cinquanta,
continua
a
fare
recensionidifilm,sulla
stampa popolare, alla
radio, e in qualche
rivista intellettuale, ma
non ha ancora trovato
unpropriostile.
“Go West, young
man,andgrowupwith
thecountry”(Va’verso
ovest, giovane uomo, e
cresci con il paese):
questa celebre parola
d’ordine
dell’editore
del
“New
York
Tribune” pronunciata
alla
fine
del
Diciannovesimo secolo,
Pauline Kael la prende
alla lettera e, in
controtendenzastorica,
la ribalta a proprio
favore.Quandoèormai
una donna di mezza
età,parteperl’Est,per
New York, diventa
critico cinematografico
e trova la propria
strada.
Pauline Kael lavora,
pagata a cartella, per
alcuni giornali popolari
femminili,oltrecheper
“Life” e “Vogue”, dove
tratta seriamente film
alla portata di tutti e
incensa
Jean-Luc
Godard e la nouvelle
vague francese. Critica
severamente
sulla
stampa
mainstream
film di successo come
Lucidellaribalta,West
Side Story, Lawrence
d’Arabia
e
Dottor
Zivago, dà prova di
grande indipendenza
nelle
sue
considerazioni
e
dimostra
un
certo
coraggio nei confronti
di
Hollywood.
Si
verifica così la prima
incomprensione: viene
infatti accusata di
essere troppo severa
con i film mainstream
ed è licenziata dal
giornale femminile per
cuilavora.
Nel
1968
viene
assunta,
come
dipendente fissa, alla
redazione
del
settimanale
“New
Yorker” e qui comincia
acostruirerealmenteil
propriopersonaggio.Si
produce, tuttavia, la
seconda
incomprensione – sulla
scia della precedente.
Il settimanale per cui
lavora è letto dall’élite
americana, raffinata e
cinefila. I critici sono
solo uomini, eleganti,
ossessionati
dalla
qualitàcinematografica
europea,
diffidenti
rispetto al sesso e alla
violenza, che invadono
i film americani degli
anni
sessanta
e
settanta.
L’unico
dettamedaprenderein
considerazione è l’arte
– e di certo non i gusti
dimassa.
Rispetto a questo
scenario, Pauline Kael
decide di andare in
controtendenza.
Pur
avendo a sua volta
magnificato Godard in
articoli per la stampa
popolare, sul “New
Yorker” comincia a
considerareseriamente
i
film
di
intrattenimento e dà
così uno scossone ai
valori dell’élite. Il suo
primo articolo è una
recensione di Bonnie
and Clyde: il film di
Arthur
Penn
(con
Warren Beatty) è stato
irriso dalla stampa
intellettuale, ma la sua
critica
è
invece
smaccatamente
positiva.
Pauline
sostiene, infatti, che
Bonnie and Clyde è
arte. Mentre tutti i
grandi
critici
cinematografici
impiegano toni eruditi
per ripudiare i film
prodottidallamacchina
hollywoodiana
ed
elogiano i film d’essai
europei e del cinema
straniero, Pauline Kael
inverte il giudizio. Nei
film, a lei piace il
crescendodiviolenzae
di scene di sesso. Non
si
vergogna
di
apprezzare film come
Lo squalo, La febbre
delsabatosera,iprimi
dueIlpadrino(“Forsei
migliori
film
mai
prodotti negli Stati
Uniti”),
Batman,
Indiana Jones, Shining
e
successivamente
Magnolia e Matrix.
Questifilmlepiacciono
davvero.
È
molto
affascinata da Fred
Astaire,
Barbara
Streisand,
John
Travolta, Tom Waits e,
prima di tutti, da Tom
Cruise. Di quest’ultimo
è
addirittura
innamorata – e lo
scrive.
È
un’intellettuale
anti-intellettuale,
le
piacciono i film messy
(confusionari), i film
cheap sovversivi, che
danno un tocco di
erotismo al cinema.
Arriva
perfino
a
frequentare un cinema
alucirosse,circondata
da persone che si
masturbano, per poter
parlare dei film erotici.
Deduce che un film è
realmente
erotico
quando
provoca
l’erezione. L’attrazione
viscerale per il cinema
si riassume per lei in
quattro parole: “Kiss
Kiss
Bang
Bang”.
Bastano una ragazza e
una pistola per fare un
grandefilm.Peraltro,il
titolo del suo primo e
piùcelebrelibrounisce
il cinema e la sua
verginità
con
un’espressione
considerata
osé
all’epoca:Ilostitatthe
movies (“L’ho persa al
cinema”).Ilcinemaèil
proseguimento
della
vitainaltromodo.
Kael fa registrare
una
rottura
fondamentale
nel
giudizio sui film, e non
solo,
nell’apprezzamento
della cultura popolare.
Fa a pezzi l’educato
linguaggio in stile
“costaest”chevenerai
film raffinati, “che con
tutta
quella
raffinatezza vi fanno
addormentare,” scrive.
Esalta invece il cinema
americano
che
racconta
la
vita
dell’uomo comune e,
con uno stile tutto suo,
celebra l’energia, la
velocità, la violenza
presentinellepellicole.
Le piace l’elemento
popdiunfilm.
Qual è, allora, il
criterio per giudicare
una pellicola? Secondo
lei: l’emozione che si
sente all’istante, il
piacerechesiprova–e
cheproveràilpubblico.
PaulineKaelvedeifilm
una sola volta, al
cinema, come gli altri
spettatori, non va a
quelle
proiezioni
esclusive per critici
privilegiati e da circolo
chiuso. Per lei si tratta
di
un
aspetto
fondamentale: bisogna
giudicare un film al
primo impatto, non
bisogna mai rivederne
uno – anche se lo
abbiamo adorato. La
sua concezione della
cultura non è né
borghese,
che
presupporrebbe
un’accumulazione delle
opere, né accademica,
con il bisogno di
decriptare all’infinito
una scena. In fondo
rifiuta che il cinema
diventi “cultura”: per
lei
un
movie
è
intrattenimento
nel
senso più profondo del
termine, un momento
della nostra vita che
passa e non torna più.
Che piaccia o meno, a
un film non bisogna
mai dare una seconda
possibilità.
Kael è un critico
profondamente
americano. Le piace la
natura democratica del
cinema “made in Usa”,
la sua grande capacità
di far divertire le
masse,
la
sua
accessibilità.
Soprattutto, detesta il
paternalismo dei critici
colti e l’accademismo
degli universitari che
costruiscono
fantomaticheteorieper
nasconderegustielitari
diclasse.Perquantodi
cultura ebraica, non
apprezza Woody Allen;
anche se ha una vita
sentimentale
molto
avventurosa, considera
Antonioni troppo lento.
È tutta una questione
di velocità: “Non c’è
alcun dubbio sul fatto
che molti di noi
reagiscano a un film in
funzione della propria
sensibilità
e
della
corrispondenza che vi
trova, ciascuno ha la
propria
sensibilità”,
scrive.
Poi Pauline Kael
irride la presunzione
deifilm“indipendenti”,
fatti
di
limitate
ambizioniesteticheedi
illimitati
precetti
morali.
Non
le
piacciono per nulla
Ingmar Bergman e Jim
Jarmusch e apprezzerà
tardivamente i fratelli
Coen. Critica con forza
il film di Claude
Lanzmann,
Shoah,
sostenendo che il tema
di un film non deve
impedire la critica e il
giudizio;bocciaPauline
à la plage di Eric
Rohmer: “Ascoltate i
personaggi discutere,
leggeteisottotitolievi
sentitecivilizzati”.
Soprattutto,
è
crudele con i film
stranieri
considerati
profondie“disinistra”,
ma che si limitano a
parlare a un pubblico
d’élite attraverso un
linguaggio codificato e
sono
incapaci
di
interessare il popolo di
cui
pretendono
di
parlare.“C’èbisognodi
qualcosa di più che
buoni sentimenti di
sinistra per fare un
buon film.” Un buon
film è anzitutto un film
chealeipiace.
A seconda dei suoi
gusti,
celebra
o
demolisce
completamente
le
pellicole. Con i film ha
un rapporto molto
incestuoso
e
non
utilizza il verbo “like”,
ma il termine “love”
(non ama i film, li
adora). I suoi giudizi
sono spicci, inattesi,
eccessivi.
L’unica cosa che
conta è il lettore: gli
racconta a lungo la
tramadelfilm,descrive
con precisione clinica i
personaggi
e
la
recitazionedegliattori,
giudica la musica,
evoca i dettagli che
aiutanoacapire.Scrive
per trasmettere, non
per giudicare. “La
critica di un film è
un’arte
d’equilibrio:
cercare di suggerire
chiavi di lettura e dare
un senso alle emozioni
che il pubblico prova.”
Dà fiducia ai gusti del
pubblico e li tiene
seriamente
in
considerazione, un po’
come fa l’industria del
cinema con i focus
group.Neisuoiarticoli,
infatti, descrive anche
lereazionidelpubblico
che ascolta e osserva
all’interno dei cinema:
leinteressanoimodiin
cui si spaventa, è
sessualmente eccitato,
ride. “Spesso sono
stata
accusata
di
scrivere
di
tutto,
tranne di film,” dice
conironia.
Ciò
che
la
caratterizza
è
soprattutto il suo stile,
inimitabile
e
sorprendente. È uno
stile nel contempo
ricercato, slangy e
crudo (usa spesso il
gergo
e
utilizza
facilmente parolacce).
Èunostilepiùvicinoal
jazzcheallamusicada
camera, nello stesso
tempo
controllato,
spontaneo
e
improvvisato, con un
ritmo
e
velocità
singolari. Più di ogni
altra cosa somiglia al
linguaggio
parlato.
Scrivesempreinprima
persona e si rivolge ai
lettori dandogli del
“voi” invece di usare il
“si” impersonale, più
tradizionale
nella
critica: “Molte persone
mi hanno rimproverato
questo
uso
senza
rendersi conto che era
semplicemente
un
modo
di
essere
americana e di non
essere inglese, che
dice:‘Sipensache…’”.
Il
lettore
ha
l’impressione
di
dialogare con Kael.
Diràspessochicivuole
molto tempo e molto
lavoro per scrivere con
semplicità.
“Ho
lavorato tanto per
perdereilmiostile,per
abbandonare il tono
pomposo dei docenti
universitari.Volevoche
le
mie
frasi
respirassero,
che
avessero il suono della
voceumana.”Nellesue
critiche Kael parla
anche di se stessa,
delle
proprie
esperienze,
talvolta
dellapropriavita.Parla
dei film che l’hanno
“accompagnata”
poiché,allafine,perlei
il
cinema
è
un
“qualcuno”.
“Qualcuno” e non “una
cosa qualsiasi”, come i
video, la televisione e
poiimultisala,chenon
apprezza. In questo è
più cinefila di quanto
credesse lei stessa. E
non è neanche tanto
americana.
Pauline
Kael
è
un’elitariapopulista.In
un’intervista
poco
prima di morire ha
affermato:
“La
grandezza del cinema
sta nel fatto che può
combinare l’energia di
un’arte popolare e le
possibilità
dell’alta
cultura”. Pauline Kael
sa anche mostrarsi
molto erudita: sono
celebri le sue analisi
delle tecniche filmiche
di D.W. Griffith e Jean
Renoir, le sue sottili
critiche dei film di
Godard, la sua analisi
di Quarto potere di
Orson
Welles.
Soprattuttoèstatauna
delle prime persone a
prendere sul serio il
cinema commerciale e
l’intrattenimento da un
punto di vista critico.
Rendendo
il
rispettabile accessibile
a tutti e l’accessibile
rispettabile per l’élite,
avrebbe contribuito a
modificare
completamente
lo
status
del
cinema
americano.
Eppure, non le piace
ciecamente il cinema
commerciale e non si
accontenta di criticare
il cinema d’autore.
Contrariamente
a
quantosièdettodilei,
non è anti-intellettuale
e,
soprattutto,
è
indipendente. È stata
una delle prime a
riconoscereiltalentodi
Martin
Scorsese,
Francis Ford Coppola,
BrianDePalma,Robert
Altman e Bernardo
Bertolucci. Le piace
David
Lynch
(in
particolare
Velluto
blu); le piace la
recitazione di Robert
De Niro in Taxi Driver
o la sua inaudita
trasformazione in Toro
scatenato. Non esita a
mettere severamente
in luce il successo
commerciale di film
che giudica sospetti –
quello che chiama “il
richiamo del trash” –,
oppureasgonfiarefilm
che, immeritatamente,
hanno fatto fortuna;
insiste sul narcisismo
del pubblico e sulle
profonde
tendenze
negative della società
americana
in
cui
l’irrazionale
sentimentalismo
impedisce le facoltà di
giudizio.Èuncriticodi
sinistra
e
una
newyorkeseelitariasuo
malgrado
–
beve
bourbon
liscio
all’infinito–,dileiresta
famoso il commento
dopo la vittoria di
Richard Nixon nel
1968:
“Non
posso
credere che Nixon
abbia vinto perché non
conosco nessuno che
abbiavotatoperlui”.
Conosceinvecemolte
persone, a New York,
che adorano Jean-Luc
Godard,conilqualeha
sempre avuto una
relazione di amoreodio.DifendeilGodard
degli anni sessanta e,
come lui, pensa che i
film fatti all’epoca
d’oro degli studios,
quandogliartistierano
interamente sotto il
controllo dell’industria
e stipendiati senza
alcun
margine
di
manovra artistica, né
final cut, potevano
essere opere d’arte.
Dopotutto,
Godard
aveva
portato
al
successo Douglas Sirk!
Durante
gli
anni
sessanta Pauline Kael
ha elogiato i film di
Godard
–
Les
Carabiniers Il maschio
elafemmina,Lacinese
– che considera fin da
subito
un
grande
cineasta. Comincia poi
a malsopportare la
tendenza del regista
francese a mettersi ai
margini e le sue
crescenti sofisticazioni;
è esasperata dalle sue
digressioni e dalle
autocitazioni. Critica i
suoi film politici che
considera ingenui e
“politicamente
inefficaci” e giudica il
suo cinema “minority
art”.Dopoil1967-1968
comincia ad attaccare
severamenteilcineasta
per la sua presunzione
e il suo cinema
mortifero. Comunica il
proprio smarrimento
versounregistacheha
amato e in nome delle
critiche positive degli
anni di Fino all’ultimo
respiro direttamente di
fronteaGodardeinun
dibattito pubblico lo
chiama
per
nome
replicandogli:
“JeanLuc,piùisuoifilmsono
diventati marxisti, più
ilsuopubblicoèquello
delleclassiagiate”.
Attaccando Godard
attacca
anche
la
“teoria dell’autore” di
stampo francese: è
infastiditadalcultoche
icriticicinematografici
hanno per il regista e,
senza
arrivare
ad
affermare che devono
cedere il final cut ai
produttori
e
agli
studios, è convinta che
la
politica
“degli
autori”,chesottovaluta
la narrazione, ucciderà
il cinema, e ha già
ammazzato
la
creatività
francese.
Con abilità critica
ancheilfeticismodegli
intellettuali
che
“speculano oggi sulla
vita dei registi, tanto
quanto
il
popolo
speculavaierisullavita
delle star”. Per lei un
film è una storia con
degli attori – e solo
dopoconunregista.In
questo senso è molto
lontana
dai
“film
studies” americani che
si sono fortemente
sviluppati negli anni
settantaeottanta.Ogni
voltachecriticaunfilm
“d’autore”, i docenti
universitari
specializzatireagiscono
innervositi. “I film
europei, in questo
paese,
hanno
una
rispettabilità
non
all’altezza dei loro
meriti,”replicaKael.
Simili opinioni hanno
suscitato passione e
odio. I lettori del “New
Yorker” e i docenti
universitari che fanno
capo
ai
“cultural
studies” chiedono le
sue dimissioni con
migliaia di lettere che
arrivano in sacchi
postali pieni zeppi. Le
rimproverano
di
scrivere con “stivali da
cowboy”elainvitanoa
tornare
nella
sua
fattoria
dell’Ovest
“insieme
alle
sue
galline”, la pregano di
darsi al giornalismo
sportivoelasupplicano
di prendere lezioni di
inglese letterario. In
tono provocatorio, lei
risponde che il cinema
deveancheessere,fino
a un certo punto, una
forma
di
entertainment:
“Se
l’arte
non
è
intrattenimento, cosa
dev’essere allora? Una
punizione?”ironizza.
Ma
Kael,
vista
l’autonomia dei suoi
giudizi, è inattaccabile.
E
le
critiche,
nell’America dei postsixties, non portano a
nulla.
È
difficile
accusarladinonessere
colta: ha una memoria
eccezionale e riesce a
descrivere
minuziosamente scene
intere
rendendo
ridicolo
anche
il
docente più colto di
film studies e grazie
alle sue conoscenze
enciclopediche
in
un’epoca in cui non
esistono né IMDb, né
Wikipedia.
È
una
lettrice
vorace
e
appassionata di teatro
ediopera,èinsaziabile
poiché la sua cultura
superaildualismodelle
categorie high e low,
che ancora oggi usano
gli
intellettuali
americani.PaulineKael
può parlare per ore di
Duke Ellington, delle
“big band” (da giovane
facevapartediunajazz
band
composta
unicamente
da
ragazze), di rock e di
Aretha Franklin per la
quale ha una vera e
propria
venerazione.
“Adoro l’energia del
pop, è ciò che spesso
manca nella musica
classica,” scrive. Negli
ultimi anni della sua
vita,
superati
i
settantacinque
anni,
confessa
la
sua
passioneperilrap.
Negli anni ottanta,
tuttavia, il suo sguardo
cambia – poiché il
cinema americano è
cambiato.
Se
in
precedenza apprezzava
il cinema mainstream,
ora si mostra più
critica
verso
Hollywood, dispiaciuta
del maggior potere
assunto dagli studios e
dal marketing. Aveva
già criticato Guerre
stellari, adesso critica
Rambo,RockyIVeStar
Trek III e tutti i film
familisti di Disney
rivolti “a tutti gli
americani”.
Come
reazione, gli studios la
minaccianoalorovolta
e più i suoi giudizi su
Hollywood
si
induriscono,
più
ritiranopubblicitàperi
film dal “New Yorker”.
George Lucas notifica
la sua cattiveria dando
il suo nome al cattivo
del film Willow (il
generale Kael). Anche
Spielberg,
che
lei
aveva apprezzato per
Lo squalo, I predatori
dell’arca perduta e
soprattutto
Et,
cominciaanonpiacerle
più.
Denuncia
“l’infantilizzazione del
cinema”.
Pauline Kael è stata
al centro di profondi
cambiamenti che si
sono amplificati dopo
di lei. Ha reso i film
mainstream
intellettualmente
rispettabili
e
ha
accompagnato
la
desacralizzazione del
libro a vantaggio del
film. Kael ha incarnato
una mutazione del
pubblico del cinema,
unamutazionechenon
solo lei stessa ha
contribuito
a
provocare, ma di cui è
stataportavoceproprio
nel momento in cui le
gerarchie
culturali
cominciavano
a
tentennare:ilmovieha
rimpiazzato il libro
come oggetto culturale
di riferimento, e il
cinema è diventato
sempre di più la
matrice delle altre arti
negliStatiUniti.
Poi, un giorno, sono
state
messe
in
discussione tutte le
gerarchie e in seguito
sonosaltate.
Inorigine,negliStati
Uniti la cultura si
distingueva piuttosto
semplicemente
tra
cultura d’élite (“high
culture”) e cultura
popolare
(“low
culture”). La maggior
parte
dei
critici,
segnati dall’approccio
europeo all’arte, aveva
il compito di difendere
il confine tra i due tipi
di
cultura
e
di
difendere
l’arte
dall’intrattenimento.
Negliannicinquantain
particolare,
l’élite
intellettuale,
spesso
composta di immigrati
europei, comincia a
spaventarsi di fronte
all’ascesa della cultura
di massa e denuncia,
sulla scia della filosofa
Hannah Arendt, la
“crisi della cultura”. Il
sociologo
tedesco
esiliato negli Stati
Uniti, Theodor Adorno,
va oltre e prende
posizioni
particolarmente
critiche contro il jazz,
che rifiuta di chiamare
musica
poiché
lo
considera “roba da
radio”, dando prova di
un certo disprezzo
snob, che qualcuno ha
qualificato
come
razzista. Da buoni
marxisti, Adorno e la
Scuola di Francoforte
considerano
l’industrializzazione
della
cultura
una
catastrofe artistica e
insistono abilmente sul
fatto
che
questa
cultura di massa non è
autentica
cultura
popolare,
ma
il
prodotto
di
un
capitalismo
monopolistico. Adorno
contribuisce allora a
diffondere il concetto
di “industrie culturali”
e soprattutto la sua
critica.
Riviste
come
“Partisan
Review”,
emblematica
per
l’atteggiamento
dell’epoca rispetto alla
cultura di massa, nella
metà
degli
anni
cinquanta, di fronte
allarapidaascesadella
televisione (nel 1954
oltre il 50 per cento
delle
famiglie
americane ne possiede
una) sono colte da
un’ondata di panico
verso la cultura di
massa.La“OldLeft”,la
vecchia
sinistra
americana,
nata
nell’antitotalitarismo,
antinazista e in quegli
anni antistalinista, è
spaventata da quanto
vede
profilarsi
all’orizzonte
della
nuova
cultura
americana: gli articoli
prefabbricati
di
“Reader’s Digest”, la
mediocrità culturale e
il conformismo delle
periferie materialiste,
Moby Dick in versione
ridotta “che ci vuole
metà del tempo per
leggerlo”, la nuova
edizione del dizionario
Webster che cerca di
semplificare
l’americano,
le
antologie
e
le
compilazionideigrandi
testi, la musica di
Copland e le sinfonie
classiche diffuse sulla
radiodiNbc,itascabili
di Penguin e il Book of
the Month Club (il
grandelibrodelmese).
Gli
intellettuali
newyorkesi continuano
a scrivere articoli per
criticare la pratica
delle classi medie di
appendere
in
sala
riproduzioni dei quadri
diVanGogheWhistler,
occasione per queste
mediocrifamigliediun
selfaggrandizement
(espressione usata dal
grande critico della
letteratura
Dwight
Macdonald, all’epoca
con molto seguito).
Attaccanosoprattuttoil
cinema,
che
non
considerano arte, e
criticano in particolare
i film hollywoodiani
degli anni sessanta,
anzitutto
Charlton
Heston, irriso per le
sue interpretazioni in
Ben Hur e Il pianeta
delle
scimmie.
E
naturalmente
ironizzano
su
romanzieri come John
Steinbeck,PearlBucke
Hemingway (quello de
Il vecchio e il mare)
che sfruttano cliché
sentimentaliecriticano
i giornalisti che, su
riviste
come
“Harper’s”,
“The
Atlantic” e “Saturday
Review”, mischiano i
generi e difendono il
pop all’interno della
stampad’élite.
C’è
qualcosa
di
piuttosto disperato in
questo timor panico
contro la cultura di
massa (la grande mass
panic
degli
anni
cinquanta),
che
peraltro non offre altra
alternativa se non il
ritorno alla cultura
aristocratica.
Negli
annitrentaequaranta,
la critica della cultura
di massa, quantomeno,
analizzava, in chiave
marxista,laproduzione
delle
industrie
culturali; poi questa
critica è degenerata in
una sorta di satira dal
gustopopolare.
“Poi un giorno le
cose hanno cominciato
a cambiare, e tutto è
vacillato,”
racconta
Bob Silvers, celebre
direttore della “New
YorkReviewofBooks”,
che incontro nel suo
ufficio di Manhattan.
“La novità sta nel fatto
che gli intellettuali
della ‘Old Left’ si sono
fatti
superare
da
sinistra dalla ‘New
Left’,” spiega Silvers.
Nel
giro
di
un
decennio,
gli
intellettuali newyorkesi
hanno abbandonato le
gerarchie culturali che
avevanotantovenerato
e hanno abbracciato la
culturadimassa.
Questo nuovo tipo di
discorso, in antitesi al
precedente,
meriterebbedasoloun
libro.
L’analisi
si
concentrerebbe
sul
difficile
lavoro
di
ricollocazione
delle
riviste di sinistra, sul
lento
ribaltamento
della
classe
intellettuale,
sulle
prudenze degli uni e le
stravaganze degli altri.
La
cosa
più
interessante è che
questo nuovo tipo di
discorso non viene
dalla stampa popolare,
né
dalle
industrie
culturali,
né
dalla
destra conservatrice:
viene dagli studenti di
Harvard, dai neri di
Harlem,dalmovimento
chicano e dagli hippy
della California. Per
tappare i buchi della
loro barca ideologica
chefaacquadatuttele
parti, non tutti gli
intellettuali seguono la
stessa via, non tutti
hanno
la
stessa
audacia. Alcuni fanno
curiosamente
riferimento a un astro
morto come Trotskij,
altri sono accecati dal
pensierodelpresidente
Mao, al punto da non
vedere che il maoismo
è
uno
stalinismo
antisovietico,
altri
infine si appassionano
a Fidel Castro e Che
Guevara,
il
cui
marxismo ha ancora il
fascinodeiTropici.
Nelfrattempocisono
stati il 1968, Berkeley,
Columbia,ilmovimento
studentesco,
Bob
Dylan,lacontrocultura,
la Guerra del Vietnam.
Questavolta,lavecchia
élite si rende conto di
essere
in
ritardo
rispetto ai tempi che
corrono. Si è già persa
il jazz e Jack Kerouac,
non
vuole
allora
sbagliarsi con il rock,
Hollywood
e
la
sessualità dei giovani.
È tempo di cambiare
chiavidilettura.
Una
giovane
intellettualedell’epoca,
Susan
Sontag,
abbraccia il rock e la
fotografia come arti ed
èvotataalcultodiJohn
Wayne nei suoi articoli
sulla
“Partisan
Review”. Si occupa
soprattutto del “camp”
e del “kitsch” per
superare le gerarchie
culturalihighelow.Gli
intellettuali neri, gli
attivisti
ispanici,
indiani,
asiatici
rivendicano, già allora,
la fine del monopolio
culturale considerato
“eurocentrico”.
Le
femministeeimilitanti
gay
denunciano
il
dominio
maschile.
L’uomo bianco è il
bersaglio di tutte le
critiche, così come la
cultura
europea.
L’esito
di
questa
rivoluzione
è
un
ulteriore
distanziamento
dalla
cultura del Vecchio
continente
e
la
valorizzazione
della
cultura
popolare
americana. Riponendo
le vecchie pretese
artistiche
e
legittimando la cultura
di massa negli Stati
Uniti, gli intellettuali
americani sacrificano
l’Europa
sull’altare
della
fine
dell’aristocrazia. E da
allora
sussistono
grandi difficoltà per
tenere a bada l’onda
d’urto
di
questi
cambiamenti.
In pochi anni, l’élite
cede le armi e alza
bandiera bianca, senza
aver
minimamente
condotto la battaglia a
favore dell’arte. La
critica della cultura di
massa, che era di
sinistra negli anni
cinquanta, negli Stati
Uniti va verso destra e
rafforzerà negli anni
ottanta i sostenitori di
Ronald Reagan. La
“vecchia
sinistra”,
invece, rappezza il suo
credoperproteggerele
proprie
illusioni,
comincia a leggere
Jack
Kerouac,
ad
ascoltare Bob Dylan e
assume come maître à
penser il leader della
controcultura
hippy
Abbie
Hoffman.
Sostituisce così il suo
vecchio marxismo con
un nuovo anarchismo
antiautoritario.
Gli
intellettuali che, fino a
ieri, difendevano la
cultura d’élite wasp,
maschile e bianca si
scoprono
improvvisamente
caucasian:
ora
si
vergognano di essere
bianchi. Questa white
guilt – vergogna dei
bianchi
–
è
fondamentale
nella
svolta. Ben presto, i
cultural
studies
studieranno
Guerre
stellari e Matrix e
parleranno
della
“nobiltà
del
mainstream”.
Questocambiamento,
sintetizzato per grandi
linee, che mi è stato
confermato
dalla
maggior parte degli
intellettuali “Old” e
“New Left” che ho
intervistatoaNewYork
e Boston – da Susan
Sontag
a
Michael
Walzer,
da
Paul
Berman a Michael
Sandel, da Nathan
Glazer
a
Stanley
Hoffmann –, ha avuto
effetti
importanti.
Soprattutto sui critici
della cultura della
generazione di Pauline
Kael. Tutti cominciano
a prendere sul serio la
cultura commerciale,
non
solo
economicamente come
un’industria potente,
ma
come
arte.
Contrariamente
ad
Adorno, i nuovi critici
deljazzdimostranoche
si tratta di un genere
musicaleveroeproprio
che sta diventando
addirittura la musica
classica del “secolo
americano”.Icriticidel
rock
acquisiscono
rispettabilità
e
influenza, a scapito dei
critici letterari. Sul
“New York Times” si
affrontanoconlastessa
serietà le commedie
musicalidiBroadwaye
ilteatrod’avanguardia.
Al contrario dei loro
predecessori, i nuovi
critici della cultura
americani
non
difendono più la linea
di demarcazione tra
arte e intrattenimento,
cercano, invece, di
mescolare le carte e di
abolire questi confini
considerati elitari, di
stampo
europeo,
aristocratici
e
addirittura
antidemocratici.
Come lo scrittore
Norman
Mailer,
l’intellettuale
Susan
Sontag,
il
critico
letterario
Dwight
Macdonaldetantialtri,
Pauline Kael è stata
una
delle
figure
simbolo
di
questa
spaccatura. Da allora,
la
desacralizzazione
dellacultura“alta”ela
commistionedeigeneri
è andata ben oltre:
PaulineKaele,dopodi
lei, Tina Brown e
naturalmente
Oprah
Winfrey annunciano il
futuro di una vita
culturale priva della
figuradell’intellettuale.
Ebenprestoancheuna
vita culturale senza la
figuradelcritico.
Tina Brown e il nuovo
giornalismoculturale
Junior’s
è
un
ristorante emblematico
dellacittàdiNewYork.
Fino agli anni settanta
era
un
locale
tipicamente ebreo, poi
questa sorta di “diner”
ha
cominciato
ad
accogliere un pubblico
essenzialmente nero e
daalloraènotointutta
la regione per il suo
World’s Most Fabulous
Cheesecake.
Ho
appuntamento
in
questo locale, a Times
Square,
sulla
Quarantacinquesima
Strada di New York,
conTinaBrown.
Tina
Brown
è
un’affascinante donna
di cinquantasei anni
dall’eleganza
britannica (è di origini
londinesi)euncarisma
contenuto che la rende
ancora più irresistibile.
Mentre discuto con lei,
sono rapito dal suo
fascino e mi dico che
dall’America
ha
mutuato l’ottimismo e
dall’Europa l’umanità.
La osservo e capisco
subitocomesiariuscita
a stregare alcuni dei
più
celebri
attori,
giornalisti e scrittori
inglesi
degli
anni
settanta – il che ha
contribuito a farne una
leggenda.
È
stata
anche un’amica della
principessa Diana, su
cui di recente ha
scritto una biografia,
diventata un bestseller
mondiale.
Tina Brown chiede a
un
cameriere
del
Junior’s di portarci
caffè americano (è
imbevibile e spesso il
refill è servito a
volontà), ne approfitto
anche per ordinare dei
pancake, mentre lei
cominciaaraccontarmi
la sua vita. È arrivata
negli Stati Uniti per
seguire
il
marito,
l’influente giornalista
Harold Evans, che ha
diretto
il
“Sunday
Times” e il “Times” a
Londra. Presto è stata
assunta
a
“Vanity
Fair”.Conilmarito,nel
frattempo promosso a
presidente della casa
editrice
Random
House,formaunadelle
coppiepiùinvistadella
NewYorkmediatica.
In breve tempo le
cose
cambiano
radicalmente.
Nel
1984, grazie alla rete
di
conoscenze,
al
talento e al fascino
diventa caporedattore
di
“Vanity
Fair”.
Ristruttura il magazine
americano
cui
riconferisce
una
dimensione
hip
proponendo di volta in
volta temi popolari e
intellettuali. Da una
parte,
azzarda
proponendo copertine
“people” – spesso con
fotografie di Helmut
Newton –, creando
rubricheeaumentando
le interviste alle star.
Dall’altra, fa scrivere
articoli seri di politica
estera
a
noti
intellettuali, invita un
celebre scrittore a
descrivere
minuziosamente la sua
depressione
e
fa
scrivere rubriche ad
autoridiqualità.
Sottolasuadirezione
“Vanity Fair”, il cui
editore è Condé Nast,
passa da duecentomila
a un milione di copie
vendute al mese. Nel
1992 l’amministratore
delegatodiCondéNast
le chiede di diventare
direttore di un’altra
rivista del gruppo, il
“New Yorker”. Il suo
arrivo
nel
tempio
ovattato della cultura
americana
è
uno
schiaffopermolti.Tina
Brown ha trentotto
anni e anche in questa
nuova
veste
resta
fedele al proprio stile
fatto di commistioni
varie,
per
metà
popolare e per metà
intellettuale. “Al ‘New
Yorker’
ho
semplicemente voluto
fare giornalismo in
modo
moderno:
inchieste,
intrattenimento,star.Il
punto di vista del
giornalista-editorialista
lascia
il
posto
all’informazione, alle
idee, si spazzano via le
vecchie
gerarchie
culturali, ma in modo
intelligente, si fanno
compromessi, ma in
modo intelligente,” mi
spiega Tina Brown da
Junior’s,
con
un
accento british molto
discreto. Cultura e
intrattenimento,
che
prima del suo arrivo
erano separati, ora
sono
uniti.
Gli
argomenti alla moda,
fino ad allora tenuti a
distanza, indicano la
nuova
linea
della
rivista. La lentezza,
valore
colto,
è
sostituita
dalla
rapidità.
Il
sensazionale,finoaieri
solo allusivo, diventa
materia d’analisi. La
pauradelcommerciale,
una religione per il
vecchio “New Yorker”,
è dimenticata: Tina
Brown chiede alla sua
squadradidecodificare
l’Americacorporate.
“Ho avviato una
rubrica intitolata ‘gli
annali
della
comunicazione’
per
seguire le evoluzioni
più importanti degli
studios,
della
televisione
e
in
particolare
delle
industrie
dell’intrattenimento,”
mi spiega Tina Brown.
Al
posto
dell’arte
europea
e
della
letteratura d’élite, ci
sono servizi di una
decina di pagine su
Rupert Murdoch di
News Corp, Michael
Eisner di Disney, Bill
Gates di Microsoft e
Ted Turner di Cnn.
Secondo la linea “arte,
media
e
intrattenimento”, Tina
Browninventaal“New
Yorker”
anche
la
biografiadelleaziende:
fa raccontare la vita
dell’operatore
di
telecomunicazioni
Comcast, dello studio
Paramount
o
del
gruppo Viacom. I toni
sono seri, le inchieste
irreprensibili, ma i
lettori abituati a un
giornalismo raffinato
sono
leggermente
contrariati nel trovarsi
di fronte pagine intere
sulla fusione tra Time
Warner e Aol, sul
gangsta rap o sugli
accordi nel settore
audiovisivo americano.
Passi ancora che il
“New Yorker” analizzi,
come una volta, le
poesie sulla droga
scritte
da
Allen
Ginsberg; ma l’analisi
dei videoclip di Mtv
sfiora
l’intollerabile.
“Eppure, le vendite del
‘New Yorker’ sono
esplose,” mi dice con
tranquillità
Tina
Brown.
Va addirittura oltre.
Non si accontenta di
parlare di star, parla
anche di star’s people,
le persone che creano
le
star,
e
dei
middlemen,figuretrail
creatoreeledinamiche
commerciali che, come
gli agenti, i manager, i
PR people, producono
il buzz. “Il ‘New
Yorker’ doveva parlare
di
quello
di
cui
parlavano le persone,”
aggiunge Tina, con il
tono dell’ovvietà, un
po’ come se avesse
inventato il trampolino
di lancio per far
diventare famose le
persone.
“Ho cambiato anche
lo stile del giornale. E
siccome sono inglese,
non mi si poteva
accusare di attentare
alla
purezza
della
lingua,” spiega Tina
Brown. Le parolacce,
finoadalloramoderate
all’interno
di
una
rivista
pudica
e
protestante
(lo
scrittore
Norman
Mailer
non
aveva
voluto scrivere per il
“New Yorker” poiché
non aveva la libertà di
usare il termine “shit”
nei
suoi
testi),
diventano un modo
normale di scrivere. In
poco
tempo
settantanovegiornalisti
abbandonano
la
redazioneenearrivano
altri cinquanta. Per la
prima
volta,
nell’austero
“New
Yorker”
entra
la
fotografia, e con un
grande nome: viene
infattiassuntoinpianta
stabileRichardAvedon,
chehagiàlavoratoper
“Vogue” e “Life” ed è
specializzato
nella
fotografia di moda e di
rock. Opinionisti tra i
più polemici e i più
pacati sono reclutati
per descrivere non più
le opere di Hannah
Arendt e Woody Allen,
ma l’hip, il cool e la
pop culture (il “New
Yorker”
pubblica
regolarmente
una
rubrica
chiamata
“Department
of
popular
culture”).
Ormai
il
giornale
prende molto sul serio
l’ultimo
film
commerciale e il nuovo
bestsellerletterario.La
strategia
di
Tina
Brown, ereditata da
PaulineKael,ètrattare
seriamente la cultura
popolare e scrivere in
modo divulgativo di
“alta cultura”. “Ho
imparato molto da
Pauline Kael e sono
stata molto influenzata
dalla sua esperienza al
‘New
Yorker’.
Ho
voluto che si scrivesse
di Hollywood come se
fosse una storia. La
narrazione è diventata
fondamentale,”
conferma Tina Brown,
che è generalmente
accreditata per aver
inventato negli Stati
Uniti
il
celebrity
journalism.
IpredecessoridiTina
Brown alla direzione
del
“New
Yorker”
avevano un compito:
tenertestaai“barbari”
emantenerelalinea,la
frontiera che separa il
gusto dalla mediocrità,
l’élite dalla massa, la
cultura
dall’intrattenimento,
high da low. Ora
scopro che Tina Brown
è lei stessa una
“barbara”. In questo
ristorante
ebreo
diventato di neri – il
che è già sufficiente a
colpire, in generale,
l’élite e gli intellettuali
diNewYork–miparla
di
Philippe
de
Montebello(ildirettore
del
Metropolitan
Museum of New York,
di origini francesi e
molto elitario) e di
Guerre stellari nei
multisala,
di
Shakespeare
e
di
Monthy Python, dello
scrittore John Updike
che ha mantenuto al
suo posto al “New
Yorker” e dei ritratti
che ha ordinato di
Madonna
e
Tom
Cruise. Mi dice di
trovare cool queste
mescolanze.
Un altro giorno, alla
caffetteria del “New
Yorker”,
magnificamente
disegnata
dall’architetto
Frank
Gehry, quella in cui
Meryl Streep ne Il
diavolo veste Prada
viene
a
pranzare,
incontro
l’elegante
Henry
Finder,
caporedattore
della
rivista.
Con
i
suoi
cinquantadue piani, la
sede del gruppo Condé
Nast, al civico 4 di
Times Square, domina
Broadway. Qui sono
editati
“Vogue”,
“Glamour”,
“Gq”,
“Architectural Design”,
“Wired”, “Vanity Fair”,
“New Yorker”, ma
anche la rivista “Bon
Appetit”
–
e
quest’ultima
mi
rassicura sul pranzo.
Nelcorsodeglianniho
incontrato molte volte
HenryFinderinquesta
celebrecaffetteriaeho
imparato a conoscerlo.
Henry è sempre un po’
stupito e “insicuro”, ha
una gentilezza e una
discrezione elevate ad
arte del vivere e
prende come al solito
un piatto vegetariano,
senza antipasto né
dessert e una Coca
Light. Ci sediamo nella
sala“retro”e“kitschy”
del
ristorante
dell’azienda, che dà
l’impressione di essere
all’interno
di
un
acquario.
Henry
è
stato
ingaggiato da Tina
Brown
nel
1994
anzitutto
come
caporedattore
aggiunto, poi come
responsabile
delle
critichedeilibri,infine,
dal1997,comeunodei
caporedattori – carica
che ricopre ancora.
“Tina Brown è nel
contempounaspeciedi
saccentona di Oxford
per
la
sua
sofisticazione
intellettuale, e un vero
e proprio impresario
americano
poco
paziente di fronte alle
smanie
intellettuali.
Come gli studenti più
originali della sua
generazione,
usciti
come lei da Oxford o
Cambridge, Tina ha
cominciato a sentirsi
infastidita dallo spirito
stretto della ‘piccola
Inghilterra’, la sua
raffinatezza, la sua
distinzione, la sua
lingua castigata, la sua
paura della volgarità
sono state a poco a
poco
conquistate
dall’ambizione
americana. Tina è
sospettosa verso le
gerarchie
culturali
europee,” dice Henry
Finder.
“Ambizione
americana”, una bella
espressione – davvero
moltosignificativa.
Henry
Finder
sottolinea anche che
Tina Brown ha portato
algiornalelacopertura
dell’attualitàcheprima
mancava. E ricorda,
cercando
di
relativizzare in parte
gli elementi di novità
introdotti
dalla
giornalista,
che
l’unione
di
generi
diversi era già una
caratteristica del “New
Yorker”,
che
per
esempio
pubblicava
articoli
su
Marlon
Brando
e
Truman
Capote,enaturalmente
ancheipezzidiPaulina
Kael.
Qualche
settimana
dopo incontro Tina
Brownesuomaritoper
una serata mondana,
nella loro sontuosa
casa
della
Cinquantasettesima
Strada
Est,
a
Manhattan.
Improvvisamente, tra
una
coppa
di
champagne e l’altra,
Tina mi dice, con quel
tono di superiorità
dellapersonanavigata:
“A New York non si
fanno
amicizie,
si
stabiliscono contatti”.
Durante
la
serata
nell’Upper East Side,
nel magnifico giardino
privato vedo gli editori
noti di New York, i
direttori
delle
principali riviste, e
ancheHenryKissinger,
l’ex segretario di Stato
diNixon,visibilmentea
proprio agio in questo
contesto. Di fronte a
me ho un quadro
vivente di ciò che è
diventato
il
“New
Yorker” durante il
regnodiTinaBrown.
Contrariamente
a
quanto si crede spesso
in Europa, il “New
Yorker” non è più il
periodico
dell’élite
newyorkese
senza
vergognaperlapropria
presunzione.
È
il
giornale d’élite che se
ne vergogna. I termini
“Europa”,“snobismo”e
“aristocrazia”, spesso
sinonimi
tra
loro,
vengono adoperati solo
conironia.
Ormai,
la
cosa
importante non sono
più
le
gerarchie
culturali, ma il cool. Il
“New
Yorker”
si
propone
come
termometro del cool e
come
“trendsetter”,
quello che stabilisce le
mode. Tina Brown non
è mai a corto di idee e
ha inoltre lanciato i
celebri numeri speciali
del
“New
Yorker”
chiamati “Next Issue”,
una sorta di previsione
delle
mode
che
verranno e l’“oroscopo
del
cool”
che
pronostica ciò che
diventerà hip in un
prossimo futuro. Tina
Brown ha un raro
istinto per identificare
the next big thing, ciò
dicuituttiparleranno.
In questo modo, il
ruolo
del
critico
culturaleècambiato,al
“New Yorker” come
ovunque negli Stati
Uniti. I nuovi critici
hanno il compito di
valutare la cultura non
solo in relazione alla
qualità
–
valore
soggettivo – ma anche
alla popolarità – valore
più quantificabile. Non
giudica più, ma entra
in conversation con il
pubblico, come mi dice
Tina Brown, senza
rendersicontodicitare
un’espressione
di
Pauline Kael. Arte,
sesso, star, moda,
prodotti,
film,
commercio,
uomini
politici (“Anche loro
sono delle celebrità,”
mi
dice
Tina),
marketing,
grande
letteratura,
nuove
tecnologie, tutto è
mischiato all’interno di
un giornale in cui, fino
a ieri, tutto era
presentato
secondo
una gerarchia ed era
distinto
per
compartimenti stagni.
Se
proprio
deve
esistere una gerarchia
culturale, i pioli di
questanuovascalanon
risalgono dal popolare
al qualitativo, ma dal
molto “hot” al molto
“squame”
(scarso,
contrario di cool). Tina
Brown
inventa
la
gerarchia
della
“hotness”.
Prima degli altri e
prima di internet, la
direttrice del “New
Yorker” ha capito le
regole
dell’intrattenimento in
espansione:
passaparola, velocità,
hip,
cool.
Questi
elementi
sono
la
matrice del nuovo
capitalismo culturale –
e contribuiranno a
diffondere la cultura
americana ovunque nel
mondo.
Mi è tornata alla
mente un’espressione
di
Tina
Brown,
pronunciata durante il
nostro
incontro
al
Junior’s e ripetuta a
casa sua nell’Upper
East Side: “New York
fakery” (il lato falso e
fittizio di New York). È
l’impostura
della
vecchia élite della
costa est, con valori
snob, europei, fatta di
artificiali
distinzioni
culturali. Contro questi
atteggiamenti si sono
scagliati una piccola
donna
dell’Ovest
americano,
Pauline
Kael,
e
un’inglese
diventata
il
primo
impresario
culturale
degli Stati Uniti, Tina
Brown.
Ho
recentemente appreso
che
l’inglese
Tina
Brown ha chiesto e
ottenutolacittadinanza
degliStatiUniti.Siamo
sempre nel campo di
quella
“ambizione
americana”.
Tuttavia,
i
cambiamenti
fatti
registrare in questo
periodo sono ben poca
cosa rispetto a quelli
successivi
che
si
profilano quando a
entrare in scena, dopo
Pauline e Tina, c’è
OprahWinfrey.
IlmarchioOprah
Lagrandeinvenzione
della donna dei media
più potente del mondo,
Oprah Winfrey, è il
“talk-show”.
Questa
donna è nata nel 1954
nelMississippiruralee
in un contesto di
grande povertà – in un
appartamento
senza
acqua né elettricità –
da una madre che
faceva la donna delle
pulizie e un padre
minatore,
diventato
barbiere. Trascorre poi
l’adolescenza
nel
ghetto
nero
di
Milwaukee,
nel
Wisconsin.
Recentemente
ha
rivelato di essere stata
violentata da giovane,
di aver assunto droghe
“per amore di un
uomo”ediesserestata
incinta a quattordici
anni(ilbambinoènato
morto e non avrà altri
figli). Grazie ai buoni
risultati
scolastici,
riesce a entrare in
un’università pubblica
a maggioranza nera e
comincia a condurre
programmi radiofonici
per una stazione locale
di
Nashville,
nel
Tennessee. La sua
spigliatezza, il suo
parlareconfranchezza,
il modo diretto di
intervistare gli ospiti
sulla loro vita privata,
la sua ironia rendono
popolari i suoi primi
talk-show. In seguito è
assunta
da
una
televisione locale di
Nashville,
poi
di
Baltimora, e nel 1983
arrivaaunatelevisione
di Chicago con un
grande
seguito
di
pubblico.
In
poco
tempo, The Oprah
Winfrey Show da lei
condotto diventa la
trasmissione
più
guardata in città. La
consacrazione
del
successo
avviene
grazie alla syndication,
il sistema americano
che permette a una
radio o una televisione
locali di vendere un
programma a centinaia
di altre emittenti del
paese. Nel 1986, il suo
talk-show pomeridiano,
trasmesso “coast to
coast” diventa un vero
e proprio fenomeno, è
guardato da milioni di
americani in centinaia
di città. Nasce il
fenomeno“Oprah”.
Certo, il talk-show,
con
vari
formati,
esisteva già. La novità
di Oprah sta nell’aver
datoaquestogenereil
formato di “tabloid
talk-show”,unasortadi
versione
televisiva
mutuata
delle
interviste
“terapeutiche”
della
stampatabloid.Intutto
il mondo, Cina, India,
Brasile,Camerunefino
inEgitto,hoincontrato
presentatrici televisive
che imitavano Oprah.
AnchenegliStatiUniti,
nel giro di pochi anni,
Oprah
Winfrey
è
diventata una delle
donne più note e più
ricchedegliStatiUniti,
è l’unica miliardaria
neraamericana.Deveil
suo
eccezionale
successoalformatodei
talk-showcheleistessa
ha
inventato.
Fa
parlare le star, i
rapper, gli ufficiali di
polizia, i capi di stato
stranieriothegirlnext
door (la ragazza della
porta accanto) dei loro
problemi,
ottenendo
così
confessioni
pubbliche.Èunanuova
forma
di
intrattenimentoincuiil
pubblico
diventa
privato (Bill Clinton
invitato a parlare della
sua vita privata) e il
privato
diventa
pubblico (un anonimo
individuo è invitato a
raccontare come ha
picchiatolamoglie).La
sua
intervista
a
Michael Jackson nel
1983 è stata una delle
trasmissioni
più
guardate nella storia
della
televisione
americana,
cento
milioni
di
telespettatori. Oprah
sostiene
il
selfimprovement:
responsabilità
personale, benessere,
pensiero
positivo,
successo individuale,
salute, buona armonia
di
coppia,
decoro
d’interni, ricette di
cucina. “In pratica, il
mio
messaggio
è
questo: voi siete gli
artefici della vostra
vita,” spiega Oprah
Winfrey. Ai suoi talkshow
invita
i
parrucchieri delle star,
Bill Gates, le escort e
Nelson
Mandela,
medici specializzati in
chirurgia estetica e un
senatore repubblicano.
Con finezza sa anche
uscire dal semplice
mainstream
per
affrontare
temi
sensibili: è femminista,
molto favorevole ai
gay,
attenta
alle
questioni della droga e
dell’abuso di farmaci,
offre visibilità agli
argomenti tabù. Lei
stessa si fa scappare
spesso qualche lacrima
di fronte a situazioni
descrittedaisuoiospiti
–
sinceramente
commossa. Il suo show
è una tribuna per
l’autoaffermazione di
sé: parla degli abusi
sessuali di cui è stata
vittima e lancia una
campagna contro le
violenze sessuali sui
bambini
(diventata
legge al Congresso e
soprannominata
“Oprah
Law”).
Si
occupa di diete e parla
dell’ossessione
della
sua obesità (ha scritto
un libro con il suo
“coach” per spiegare
come era dimagrita,
come faceva sport e
descriveva
la
sua
passione
per
gli
esercizi noti come
pilates – un bestseller
immediato).
Quando
tra i suoi ospiti ci sono
uomini
che
si
esprimono
in
toni
misogini, omofobi o
razzisti può anche
diventare
incredibilmente
violenta in nome della
sua storia personale di
ex colored girl –
espressione che usa
per ricordare che una
ragazza come lei era
considerata
una
“persona di colore”. Di
fronte a un uomo che,
in studio, in una delle
sue
numerose
trasmissionidedicateal
matrimonio
omosessuale dice di
“essereesasperato”dai
gay, dati i rischi che
fanno
correre
ai
ragazzi, Oprah replica:
“Sa, io invece sono
esasperata
dagli
uomini
eterosessuali
che
violentano
e
sodomizzano
le
ragazze; questo mi
esaspera”.Eilpubblico
in studio si alza per
decretarle
una
standingovation.
Al
1058
West
Washington Boulevard
di Chicago si trovano
gli
studios
Harpo
(Oprah al contrario).
Sono in quello che si
chiama West Loop, un
exquartiereindustriale
ormaianonimo,aovest
del centro della città,
qui
hanno
sede
numerose società di
servizi. Il quartier
generalediOprahèun
largo
edificio
di
mattoni beige e grigi
su due piani, che
occupa
un
intero
blocco tra le vie
Carpenter e Aberdeen.
Sono
colpito
dall’apparente
discrezione del luogo e
da una lunga fila
composta soprattutto
da
donne
che
attendono di poter
entrare per assistere a
una
registrazione.
Sopra
l’ingresso
principale si legge
“OprahWinfreyShow”,
una scritta semplice
con lettere bianche,
immagino in antitesi
con l’ego smisurato di
Oprah.
Harpo Productions è
un’attività ben rodata
con 221 impiegati (di
cui 70 donne), studios
televisivieunapalestra
in cui sembra si possa
vedere la star fare il
suo “work out” ogni
mattina alle sette.
Oprah passa diversi
giorni della settimana
nel
suo
quartiere
generale e vive il resto
del tempo in una
lussuosa residenza a
Santa
Barbara
in
California. (Ho visitato
gli studios di Chicago
conildivietodicitarei
miei
interlocutori,
mentreidiversiaddetti
stampa
di
Oprah
Winfrey non hanno
risposto alle domande
dellemieinterviste.)
Harpo Productions è
il vettore principale
della macchina Oprah
Winfrey,
è
una
struttura che spiega i
motivi
della
sua
ricchezza ed è anche
unabuonasintesidiciò
che è diventato il
settore
audiovisivo
americano.
È
una
società privata, di cui
Oprah è l’azionista
principale e che più
volte ha rifiutato, per
mantenerne il pieno
controllo, di rendere
“pubblica”,
ovvero
quotatainBorsa.
I programmi dei
principali
network
televisivi
americani
sonoideati,sviluppatie
creati da case di
produzione
indipendenti,
come
Harpo, che poi le
“syndicano”vendendoi
dirittiintuttoilpaesea
emittenti che hanno
l’esclusiva su un certo
numerodi“mercati”(in
generale una città o
una
precisa
zona
geografica).
Il
principale
talk-show
quotidiano di Oprah
(ne conduce diversi) è
diffuso principalmente
dalle 215 antenne
locali affiliate alla rete
Cbs e alla rete Abc. È
visto da circa sette
milioniditelespettatori
ogni giorno negli Stati
Uniti (nel 1998 erano
14 milioni ma resta il
talk-show più popolare
della
televisione
americana) e dai 15 e
ai20milionidipersone
in 132 paesi. Su altri
mercati,
altre
reti
diffondono
gli
spettacoli di Oprah,
talvolta nello stesso
momento in “prime
time”,
talvolta
in
replica in “late time”,
in relazione a contratti
complessi,
negoziati
generalmente per più
anni.
Harpo
Productionsmantieneil
copyright e subappalta
la distribuzione. A
differenza di star della
televisione che hanno
spesso un contratto
work for hire, per il
quale il copyright è
ceduto alla rete di
distribuzione,
Oprah
Winfrey mantiene il
controllo totale sulle
sue
trasmissioni.
Peraltro ha da poco
annunciato che dal
2011 cesserà il suo
show principale per
andare su un canale
satellitare,
chiamato
Own (Oprah Winfrey
Network).
Dopo
ventisei anni, Oprah
prende
atto
dell’indebolimento dei
principali
network
televisivi
classici,
abbandonaCbsecerca
di raggiungere il suo
pubblico via satellite e
attraverso
internet.
Realizzando un altro
canale con il proprio
nome,
riuscirà
a
rilanciarsi
in
un
universo televisivo più
frammentato? Riuscirà
ad avere un nuovo
pubblico mantenendo
lozoccoloduro?
Tra le sue diverse
residenze
e
uffici,
Oprah Winfrey dirige
anche “O”, il suo
magazine, e diversi
altri giornali femminili
(in joint-venture con il
gruppo
editoriale
Hearst), gestisce un
sito web di successo
mondiale, oprah.com,
produce
commedie
musicali per Broadway
e film per Hollywood
(harecitatoneIlcolore
viola
di
Steven
Spielberg e prodotto
Beloved, dal romanzo
di Toni Morrison – un
fallimento).
Fa
filantropia,
presiede
una propria fondazione
e
si
impegna,
utilizzando
denaro
proprio
e
le
trasmissioni,
in
battaglie contro l’Aids,
la
povertà,
l’analfabetismo, per il
sostegno ai rifugiati
dell’uragano Katrina a
New Orleans, finanzia
una scuola per ragazze
in Sudafrica – azioni
generose di grande
impatto,
talvolta
criticate per la loro
ingenuità o la relativa
inefficacia.
Tutte queste attività
di varia natura sono
unite tra loro dal
carisma e la natura
self-centred di Oprah
Winfrey
che,
intervistando gli altri,
parla quasi sempre di
sé. Oprah è diventata
unmarchio.
Oprah
Winfrey
è
diventata anche un
critico letterario. Alla
fine del 1996 ha
introdottonelsuoshow
televisivo
del
pomeriggiounarubrica
settimanale sui libri
intitolata The Oprah’s
Book Club. “Nel mio
Mississippi natale, i
libri
mi
hanno
trasmesso l’idea che
esisteva una vita oltre
la povertà,” spiega
Oprah.
Questo
“incontro” con i libri
l’avrebbe salvata dalla
miseria.Bastacheoggi
nel suo talk-show parli
di un classico, di un
romanzo, di un libro di
letteratura
più
raffinato che subito
diventa un bestseller.
Quasi sempre, il libro
entra nella “New York
Times Bestseller list” e
vende un milione di
copie (Oprah Winfrey
non
ha
interessi
economici sul successo
deilibricheseleziona).
Gli editori e i librai si
rallegrano dell’“effetto
Oprah”sullevendite,in
un periodo in cui gli
studi mostrano che la
lettura di fiction è in
declino negli Stati
Uniti,malarubricache
Oprah dedica ogni
settimana ai libri è
quella il cui ascolto è
minore rispetto agli
altri suoi talkshow
quotidiani.
John
Steinbeck,
Gabriel
García
Márquez, Tolstoj, Pearl
Buck, Elie Wiesel,
Cormac McCarthy (La
strada),
Jonathan
Franzen
(Le
correzioni),
Oprah
Winfrey fa di tutta
l’erba un fascio. Mette
insieme
romanzi
d’appendice e grande
letteratura,
saggi
sofisticati e manuali
pratici.
Cerca
soprattutto gli hot
books – quelli di cui
tutti parleranno e che
faranno
il
buzz
mediatico. È anche
fedele nelle sue scelte,
seleziona in modo
ossessivo la maggior
parte
dei
romanzi
dell’amica
Toni
Morrison, che avrà di
certo venduto più libri
grazieaOprahchenon
con il Nobel per la
letteratura.
Durante
l’estate
2005, Oprah Winfrey
recensisce tre romanzi
di Faulkner, tra cui
L’urlo e il furore,
invitando centinaia di
migliaia di suoi fan –
soprattutto donne tra i
quaranta
e
i
sessant’anni
–
a
leggere questi romanzi
generalmente
considerati
inaccessibili per un
pubblico di massa.
L’esito
è
molto
inferiore rispetto ad
altre sue selezioni, ma
trecentomila persone
avranno
comunque
letto grazie a lei,
quell’estate, i romanzi
di Faulkner. Oprah ha
una missione, forse
ingenua,
ma
non
ipocrita:
rendere
accessibili le piccole e
le grandi opere a un
ampiopubblico.
Se
qualcuno
ha
contribuito
a
rimescolare i confini
tra
arte
e
intrattenimento,
tra
high culture e low
culture in America, tra
questi
c’è
proprio
Oprah Winfrey con la
sua
trasmissione
letteraria. “Ho voluto
usare il mio talk-show
siapereducarecheper
divertire,
per
permettere
alle
persone di guardare la
propria vita con occhi
diversi,” dice Oprah in
un’intervista.Inoltreha
lanciato il Book Club,
un vero e proprio
fenomeno di società:
ovunque in America, in
città e villaggi, i suoi
fedeli l’hanno imitata
creandoilloroclubdel
libropercondividerele
loro esperienze di
lettori (il suo sito web
offre
consigli
per
creare questi club e
pubblica schede di
approfondimento per
facilitare la lettura).
“Voglio che i libri
faccianopartedeimodi
divitadelmiopubblico
e che la lettura diventi
un’attività normale per
loro, in modo che non
sia più un big deal.”
Ovunque,
nei
supermercati Wal-Mart
del New Mexico, nelle
librerie Borders del
Wisconsin, nei Barnes
&Nobledell’Alabamae
negli Starbucks del
Texas, e anche nelle
biblioteche pubbliche
del Mississippi, ho
incontrato gruppi di
donne
che
si
incontravano a leggere
e discutere insieme a
partire dalla selezione
letteraria del mese del
Book Club di Oprah
Winfrey. “Ogni mese
c’èungruppodidonne
che
si
dà
appuntamento
nello
spazio bar della nostra
libreriaperdiscuteredi
unlibrodellaselezione
diOprah.Discutonotra
loro e contribuiscono a
creare un’atmosfera di
lettura che è molto
importante per noi.
Talvolta, quando è
l’anniversario
della
nascitadiShakespeare,
per esempio, portano
una
torta
per
festeggiare!” mi dice a
Austin, nel Texas, Dan
Nugent, responsabile
della
libreria
indipendente
Book
People.
È il genio di Oprah
Winfrey di aver saputo
dare
a
una
trasmissione
“didattica”
e
unilateralmente
top
down
(dall’alto
al
basso) una funzione
interattiva grazie a
migliaia di Book Club
creati spontaneamente
dal suo pubblico in
tutta l’America. Spesso
considerato un piacere
individuale, il libro ha
ritrovato negli Stati
Uniti una dimensione
collettiva, se non una
funzionesociale.Oprah
è,
letteralmente,
un’animatrice culturale
e una book crosser,
unapassatricedilibri.
Inuovicritici
Pauline,TinaeOprah
sonotredonnesimbolo
accomunate tra loro
dall’essere
state
protagoniste di una
fase
di
profonde
trasformazioni. Tra il
1968 e oggi la figura
del critico culturale
negli Stati Uniti ha
modificato la propria
natura
in
modo
irreversibile. Con la
fine delle gerarchie
culturali
e
la
mescolanza di generi
tra
arte
e
intrattenimento,
il
critico
diventa
un
“passatore”, non è più
un giudice. Prima era
un gatekeeper, un
guardiano del confine
tra
arte
e
intrattenimento e un
tastemaker, colui che
definisce il gusto. Oggi
è invece diventato un
gran
“mediatore
dell’intrattenimento”,
un trendsetter, quello
che fissa la moda e il
buzz accompagnando i
gusti del pubblico. I
nuovi
critici
privilegiano il cool e,
piùdiognialtracosa,il
cool
detesta
le
distinzioni culturali. E
una volta abolite le
classificazioni
è
difficile
ristabilire
qualsiasi
gerarchia.
Peraltro,
chi
la
desidera?
Per realizzare la mia
inchiesta
ho
intervistato
un
centinaio di giornalisti
culturali
in
trentacinque
stati
americani e mi è
sembrato che il modo
concuiconcepisconola
loro professione oggi è
moltodiversodaquello
dei
loro
colleghi
europei. Naturalmente
ci sono ancora i
guardianideltempioin
riviste come “Film
Comment” e “Chicago
Reader”; ma nella
grande
maggioranza
dei casi, il mestiere di
giornalista culturale è
profondamente
cambiato.Nonsitratta
più di critici, ma di
professionisti
che
fanno
interviste,
raccontanolavitadegli
attori, si occupano di
rumors e di buzz. I
nuovi critici devono
mettersi al livello dei
lettori, essere “easy”
(“I’m easy”, sto col
pubblico, mi dice un
critico
a
Miami).
Giudicano il piacere
(“having fun”, mi dice
un critico del “Boston
Globe”). Parlano delle
novità e delle neverbefore-seen images, le
immagini che non si
sono ancora viste, per
esempio:
il
primo
episodio di Guerre
stellari,
i
corpi
galleggianti
nell’oceano in Titanic,
la scena iniziale di Toy
Story e Matrix, le
immagini in 3D di
Avatar.
I
critici
pronosticano
le
impressioni che avrà
una
determinata
comunità rispetto a un
film che la coinvolge: i
cristiani con Passion, i
gay con I segreti di
Brokeback Mountain, i
latinos con l’ultimo
albumdiShakira,ineri
conl’ultimofilmdiWill
Smith, gli ebrei con la
pièce di Tony Kushner
AngelsinAmerica.“C’è
una
specificità
americanacheconsiste
nell’andareavedereun
film in base alla
propria vita, un film in
cui riconoscersi e che
richiama la propria
comunità,”constataJoe
Hoberman,ilprincipale
critico di cinema del
“Village Voice” a New
York. “Oggi il critico è
un consumer critic:
come il critico di
automobili
o
gastronomico, dice al
consumatore
come
spendere
bene
il
proprio denaro nel
divertimento, mentre
ieri il critico del
‘repertorio’
era
al
servizio dell’arte,” mi
conferma
Robert
Brustein,
critico
teatrale di “The New
Republic” e influente
uomo di teatro. “La
realtà è che i critici,
che erano sempre più
corrotti, sparivano ed
erano
sostituiti
dall’attività
di
promozione, che è
sempre
più
manipolatrice. Ecco a
chepuntosiamo!Tutto
ciòhaun’unicacausa:i
critici
hanno
cominciato a pensare
che l’audience e il
botteghino
fossero
buoni
criteri
di
giudizio. Per dirla in
modo più neutro, direi
cheilcriticoamericano
ha una scala di valori
calcata su quella dello
spettatore rispetto ai
suoi colleghi europei,”
mi confida, a Chicago,
Jonathan Rosenbaum,
uno
degli
ultimi
veterani negli Stati
Uniti della critica del
cinema“all’europea”.
Al “Boston Globe”,
“San
Francisco
Chronicle”, “Chicago
Tribune”, “Los Angeles
Times”igiornalistiche
ho incontrato scrivono
sempremenocritichee
fanno
sempre
più
reportage, la cultura è
dunque trattata come
attualità da scoprire e
non più come arte da
giudicare. La maggior
parte dei quotidiani ha
un servizio Arts &
Entertainment,
che
comprende
generalmente
televisione,
cinema,
musica pop (raramente
la musica classica) e
divertimenti.
“Molte
persone credono che il
nostro
supplemento
‘Art and Life’ sia
guidato
dalla
pubblicità.
Si
sbagliano.
Siamo
guidati
dai
nostri
lettori,” spiega Joanna
Connors,
giornalista
culturale al “Plain
Dealer” a Cleveland,
nell’Ohio.
Anche nei giornali
della costa est, che si
presume siano più
elitari,
i
critici
contemporanei hanno
un’autentica passione
perlaculturapopolare,
molto visibile, per
esempio, al “New York
Times”.
A
Times
Square John Rockwell,
già critico di rock poi
di musica classica del
giornale e attualmente
critico di danza – un
percorso
davvero
emblematico in quanto
a
commistione
di
generi–,constata:“C’è
una sorta di fede, di
entusiasmo
per
la
cultura popolare al
‘New York Times’. Si
dà per esempio molto
spazioallesitcomealla
televisione. Ci si mette
al livello della gente: il
critico è un regular
guy,
un
ragazzo
normale, che parla di
filmemusicaaregular
people,
a
gente
normale. E chi si
occupava solo di high
culture e aveva un po’
di disprezzo per la
cultura popolare oggi
verrebbe visto come
una
persona
che
tradisce
lo
spirito
popolare democratico
dell’America”.
Il
concetto
di
commistionedeigeneri
non ha peraltro sintesi
migliore della sala per
concerti che ospita la
Los
Angeles
Philarmonic: la Walt
DisneyConcertHall.
Nella sede del “New
York
Times”
ho
incontrato
anche
l’editorialista di terza
paginaFrankRich,che
èinvecedispiaciutoper
questa
situazione:
“Sono diventato critico
teatralenel1980.Sono
riuscito a ottenere il
lavoro che sognavo,
proprio
quando
il
sognostavafinendo”.È
un critico considerato
sofisticato, eppure fa
ciò che fanno gli altri:
commenta
l’attualità
basandosi sulla cultura
americana popolare e
rende settimanalmente
conto di “cultura nelle
news”. “Scrivere di
Debussy e di hip-hop,
questa è l’America. Un
criticodevescriveresu
tutto. Mettere insieme
cultura
e
opere
commerciali è una
vecchiatradizionedegli
Stati Uniti. Ciò che è
nuovo
è
che
il
marketing, il denaro, il
business interessano
tanto i critici quanto le
opere.”
A Miami, incontro
Mosi
Reeves,
un
giovane
nero
caporedattore
del
settore“popmusic”del
giornale
alternativo
“Miami New Times”.
Secondo
lui,
la
gerarchia high e low è
ormaiprivadisenso,“è
stataabolitadaPauline
Kael”, mi dice. Poco
dopo bevo qualcosa in
un bar all’aperto, con
un
sottofondo
di
“tropical
pop”
(in
particolare
Gloria
Estefan,
artista
cubano-americana
crossover
per
eccellenza), nella notte
calda di Miami Beach,
con due giornalisti del
“Miami Herald”, il
quotidiano
per
un
ampio pubblico della
FloridadelSud.Evelyn
McDonnel si definisce
un critico pop culture
mentre Jordan Levin
segue la musica latina.
“Un punto di vista
troppo netto, troppo
impegnato è sempre
meno opportuno nella
stampa mainstream,”
mi dice Evelyn. “È
meglio
dare
informazioni
che
formulare giudizi. Noi
ci basiamo molto su
sondaggi che chiedono
ai lettori ciò che si
aspettano
da
un
giornalecomeilnostro.
E noi diamo loro ciò
che
vogliono:
interviste, anteprime
che annunciano gli
eventi, profili di star e
sempre meno critiche.
Le persone vogliono
farsi
un
proprio
giudizio, non vogliono
conoscere il nostro.”
Jordan
Levin
fa
osservare invece che
“molti
abitanti
di
Miami non parlano
inglese, dunque le
recensioni di libri e
film
a
loro
non
interessano.
Ci
si
occupadipiùdimusica
e cinema. È meno
snob”.
Evelyn
mi
informa che al “Miami
Herald”
c’è
un
giornalista
che
si
occupa, nel contempo,
sia
di
settore
immobiliare sia di
intrattenimento.
“Segue i due ambiti,”
aggiunge sorridendo.
Trovo
questa
informazione sublime e
gli prometto di darla
nelmiolibro.
La critica dei libri è
dunque sempre più
rara. Peraltro non si
parla
più
di
“letteratura” ma di
“fiction”, non più di
storia o di filosofia, ma
di “non-fiction”. “Il
termine
letteratura
evoca la scuola, dà
un’immagine di serietà
e non di fun, leggere
fiction
è
più
divertente,” mi spiega
un
giornalista
del
“Boston
Globe”
(quotidiano che in ogni
caso continua ad avere
un buon supplemento
letterarioladomenica).
Se ormai sui giornali
americani non ci sono
molti articoli di critica
letteraria, tutti hanno
invece professionisti di
critica
“digitale”
all’interno delle pagine
Art & Entertainment,
che parlano di cultura
digitale e dei relativi
prodotti tecnologici –
uno dei più letti è
Walter Mossberg del
“Wall Street Jornal”. Il
web ha accentuato
questeevoluzionie,sui
siti internet dei media,
l’unionedeigeneriela
fine delle gerarchie
culturali sono ormai la
regola.
Ciò che conta è
l’argomento
dei
numeri. È la stessa
cosa che accade come
per le guide Zagat [il
corrispettivo
americano della guida
Michelin in Europa,
N.d.T.] per i ristoranti
che devono il successo
delle
loro
offerte
culinarie
non
alle
impressioni di critici
gastronomici, ma alle
migliaia di lettori che
danno il loro parere
attraverso questionari.
Nelle pubblicità per
film e libri all’interno
dei giornali, i giudizi
dei
critici
sono
sostituiti dai blurbs:
“The Best Family Film
This Year”, “Holiday
Classic”,
“Wow!”,
“Absolutely Brilliant!”,
“Hilarious!”, “One of
theBestMoviesEver!”,
“Laugh-Out-LodFunny”
o le famose quattro
stelle.
I due più celebri
critici cinematografici
negli Stati Uniti sono
Robert Ebert e Gene
Siskel
della
trasmissione At the
MoviessuAbc(loshow
èstatocreatonel1986
ed è di proprietà di
Disney).
Hanno
inventatoilsistemadel
“TwoThumbsUp”,due
pollici in alto. Ebert e
Siskel giudicano i film
semplicemente con i
loro pollici, ovvero con
un totale possibile di
solitrevoti:duepollici
in alto se entrambi
hanno apprezzato il
film, due pollici in
basso se non gli è
piaciuto e un pollice in
alto e uno in basso se
sono discordi. Così lo
spettatore può sapere
seilfilmèunmust-seefilm(unfilmdavedere)
oppure un turkey (una
pizza). Dopo la morte
di
Siskel
e
il
pensionamento
di
Ebert, lo show è stato
ripresonel2009dadue
giornalisti del pop, uno
dei
due
è
il
caposervizio
cinema
del “New York Times”,
A.O. Scott. Ora tocca a
luialzareoabbassarei
pollici.
Al posto dei critici
d’arte, i giornalisti che
vanno per la maggiore
oggi negli Stati Uniti
sono
quelli
dell’intrattenimento.
Alcuni
giornali
primeggianoneisettori
cinema e televisione:
“Premiere”,
“Entertainment
Weekly”,
“The
Hollywood Reporter” e
“Variety”. I primi due
sono riviste per un
pubblico di massa,
parlano di star, film di
successo, buzz. La
parte riservata alle
critiche
è
molto
limitata
(bisogna
arrivare a pagina 96 di
“Entertainment
Weekly” per leggerle e
terminano a pagina
103). Gli ultimi due,
soprattutto “Variety”,
sono
giornali
per
addetti ai lavori che
pubblicano i risultati
dettagliati del boxoffice e informazioni
spesso “prive di fonte”
a partire da fughe di
notizie trasmesse da
Hollywood.
A Los Angeles vado
negli uffici di “Variety”
su Wilshire Boulevard.
Ci si può abbonare sia
all’edizione quotidiana,
che
leggono
religiosamente tutti i
responsabili del mondo
del cinema e della
televisione (su carta
patinata e non di
giornale:
siamo
a
Hollywood), sia alla
selezione settimanale
diffusa
soprattutto
all’estero. Ciò che mi
ha sempre colpito di
“Variety” è lo stile
rapido, il linguaggio
specializzato, anche se
poco artefatto, con
molte abbreviazioni e
per
questo
poco
accessibile per lettori
pocoespertiinmateria.
“Si dice spesso che noi
scriviamo in ‘Variety’s
lingo’
una
lingua
nostra,” mi spiega
nell’immensasaladella
redazione in open
space alla sede del
giornale,
Steve
Chagollan,cheèsenior
editor a “Variety”. Mi
regala
anche
lo
Slanguage Dictionary,
un dizionario di slang
utilizzato da “Variety”.
In ogni caso, “Variety”
è
una
necessità
quotidiana non per il
suo stile, né per le
informazioni segrete,
ma per le decine di
tabelle dei risultati del
botteghino
hollywoodiano,
nazionale
e
internazionale, per i
Nielsen Tv Ratings
sull’audience televisiva
del giorno prima, per i
pareri
dei
critici
cinematografici della
stampa
nazionale
(riassunti in sole tre
categorie,
“per”,
“contro”, “moderato”)
e per le molte brevi
notizie sui progetti in
corso e le riprese
annunciate. È presente
anche il teatro di
Broadway
(chiamato
“Legit”)
con
una
propria sezione che
riporta, ancora una
volta,gliincassidiogni
commedia musicale, il
numerodispettatoriei
risultati di Broadway
“on the road”, ovvero
le repliche in tutto il
paese.
Questo culto per i
dati
non
è
una
prerogativa solo di
“Variety”; anche il
magazine “Billboard”
segue la stessa linea
per la musica a partire
dai dati compilati da
Nielsen SoundScan e
diffusi tutti i mercoledì
verso le due del
mattino. Tutte queste
classifiche
contribuiscono
a
legittimare il successo
di un artista o di uno
scrittore attraverso le
vendite. Ripresi da
televisione, radio e in
tempo
reale
da
numerosi siti web,
questi numeri, negli
Stati
Uniti,
sono
considerati come una
sorta di giudizio del
pubblico,criterioincui
si uniscono successo
commerciale
e
legittimità
democratica.
Il
mercato mainstream,
spesso guardato con
sospetto in Europa
come nemico della
creazione artistica, ha
acquisito negli Stati
Uniti
uno
status
elevato
poiché
è
considerato il risultato
di scelte reali del
pubblico. In un’epoca
di valori relativi, e
allorché tutti i giudizi
critici sono considerati
frutto di pregiudizi di
classe,ilsuccessodelle
vendite sembra un
criterio neutro e più
affidabile.
Si
può
semprediscuterediciò
cheèbelloobrutto,ma
nonsipuòdirenulladi
fronteaidatidiNielsen
SoundScan,“Variety”o
“Billboard”.
Eppure, ci sarebbe
moltodadiscutere.Per
esempio, il botteghino
detto del “premier
weekend”perilcinema
è
pubblicato
da
“Billboard” il lunedì
mattina, mentre i dati
del fine settimana,
ovviamente, non sono
stati
ancora
tutti
contabilizzati. Inoltre,
questi dati provengono
daglistudios,chefanno
delle estrapolazioni a
partire dai dati reali
ricevuti dai distributori
il sabato. In seguito, i
dati pubblicati sono
corretti con i dati
aggiornati (detti “the
actuals”), ma tutti
ricorderanno che il
secondo episodio di
unasagaavràbattutoil
primo, anche quando
nonèvero.
Sul
fronte
dell’editoriaamericana,
è noto oggi, grazie a
un’inchiestadettagliata
pubblicata dal “New
York Times”, che tutte
le selezioni e le
disposizioni dei libri
all’internodellagrande
distribuzione,
tipo
Barnes&Nobleosugli
scaffali dei libri negli
ipermercati Wal-Mart,
ma anche nelle grosse
librerie indipendenti,
sono “programmate”
con gli editori, che
pagano i negozi per
mettereinrilievoiloro
libri. La stessa cosa
accade con le famose
“teste di gondola”, la
selezione
proposta
verticalmente in testa
ai
reparti
dei
supermercati. Anche i
tavoli e gli stepladders
(espositori) all’entrata
dei negozi, in cui si
trovano le novità, i
“migliori” libri e le
“migliori”vendite,sono
“sovvenzionati” a caro
prezzo
dalle
multinazionali
dell’editoria.
Questi
successi sono dunque
fasulli, la selezione è
fatta dal denaro, senza
alcun legame con le
sceltedeilibraioidati
reali delle vendite. Sul
piano
finanziario,
questosistemadelpayfor-display (pagare per
essere mostrati) non si
quantifica
generalmente
in
pubblicità, in acquisto
di
spazi,
ma
in
percentuale per le
librerie sulle vendite
realizzate (dal 3 al 5
per cento in più
secondo gli accordi
stipulati, spesso in
segreto, a latere delle
leggi anticoncorrenza).
Il gigante americano
Amazon, sul suo sito,
ricorre ampiamente a
questo sistema e tutti i
libri proposti sulla
home
page
gli
permettono
di
raggranellare incassi
superiori. Al posto
degli articoli delle
critiche
letterarie,
sempremenofrequenti
negli Stati Uniti, i
lettori si fidano ormai
delle “selezioni”, che
hanno la pretesa di
essere
indipendenti,
ma che sono di fatto
acquistate
dalle
multinazionalidellibro.
In inglese è stato
trovato
un
bell’eufemismo
per
definire
questo
marketingtravestitoda
spirito
critico
realizzatotranegozied
editori:
cooperative
advertising agreement.
Nell’ambiente si parla
semplicemente
di
accordi“co-Op”.Suona
meglio.
Sono al ristorante
Odeon, nel quartiere
Tribeca di New York.
Ho appuntamento con
Steven Erlanger che
dirige
le
pagine
culturalidel“NewYork
Times” (poi ha assunto
la direzione dell’ufficio
diTelAviveinseguito
di Parigi). Mi fa un
breve quadro delle
tappe della rivoluzione
avvenuta. La fine delle
gerarchie
culturali,
l’ascesa delle industrie
dei
contenuti,
l’indebolimento degli
indipendenti
uniti
ormai alle major, il
dominio
del
cool,
dell’hip e del buzz, la
cultura trasformata in
commodity
(merce).
Ma insiste anche sulla
diversità culturale che
haavutosecondoluiun
ruolo
importante
nell’indebolimento del
modello
europeo:
“Diventiamo
sempre
piùcolorful”,dice.
Secondo
Steven
Erlanger siamo solo
all’inizio di questo
processo. “Assumere
realmenteilruolodella
diversità, l’ascesa di
internet
e
l’affermazione
della
globalizzazione
possono
rafforzare
questa dinamica.” Si
riferisce al processo di
deintermediazione
prodotto dal web che
elimina
gli
intermediari. Evoca i
paesi emergenti che
rovescerannoancoralo
scenario. Tutto ciò
contribuisce, secondo
lui,
a
rafforzare
l’americanizzazione
della cultura in tutto il
mondo. Gli Stati Uniti
sono il paese per
eccellenzadiinternete
quello che accoglie le
minoranze dei paesi
emergenti. E l’Europa?
“Non
occupandosi
abbastanza di culture
popolari,
intrattenimento,
industrie
creative,
mercato e diversità
etnica, l’Europa sta
vivendo una grande
stagnazione culturale,”
conclude il capo dei
servizi culturali del
“New York Times”, al
ristoranteOdeon.
Attornoanoi,cisono
i bus boys messicani,
quelli che portano i
piatti,
ma
non
prendono ordinazioni.
In cucina vedo i neri, i
nostri camerieri sono
bianchi: mi dico che
probabilmente
sono
attori in “divenire”. In
questa brasserie hip
del quartiere cool di
Tribeca a New York,
sono tra Europa e
America. Un critico
gastronomicodel“New
YorkTimes”hadefinito
l’Odeon
con
una
formula:
“European
sophistication,
American Abondance”.
Atmosfera
raffinata,
cibo
abbondante;
qualità e quantità;
Europa e America.
Sempre la famosa
ambizioneamericana.
Steven Erlanger mi
dice che “in questa
brasserie,
Jay
McInerney
ha
ambientato il celebre
romanzo Le mille luci
di New York”. È un
libro
tipicamente
americano, orgoglioso
e
sofisticato,
che
PaulineKaeldetestava,
Tina Brown adorava e
di cui Oprah Winfrey
nonhamaiparlato.
8.
Usc,l’universitàdegli
studios
“Reality ends here.”
Su
un
edificio
all’ingresso
della
University of Southern
California
di
Los
Angeles si trova scritto
l’ambizioso motto “La
realtà finisce qui”. La
scritta che sancisce il
passaggio dalla vita
veraallafinzionesegna
l’ingresso del campus
dell’Usc, la scuola di
cinema più famosa
degliStatiUniti.
“George
Lucas,
Steven
Spielberg,
Jeffrey
Katzenberg,
David Geffen lavorano
tutti qui da noi, fanno
da
consulenti,
insegnanti,
sono
membri del nostro
consiglio
d’amministrazione.
Fanno tutti parte della
comunità
dell’università,”midice
conuntoccodifierezza
Elizabeth Daley, che
ricopre il prestigioso
ruolo di dean di Usc
(l’equivalente
del
rettore).
All’incrocio tra la
Santa Monica Freeway
eHarborFreeway,due
autostrade a sud del
centro di Los Angeles,
il campus di Usc si è
allargato su diversi
ettari. Ormai è un
luogo amalgamato con
la città, è attraversato
dal traffico locale e ha
perso il fascino del
campus “chiuso” come
quelli di Princeton,
Yale, Duke, Harvard,
Dartmouth, Stanford e
della
vicina,
e
principale concorrente,
Università
della
California, Los Angeles
(Ucla). Ma Usc ha una
rinomanza che queste
altre
università
le
invidiano: gli stretti
legami che intrattiene
conHollywood.
“Siamo una scuola
che crea professionisti,
qui hanno studiato
Frank Capra, Francis
Ford Coppola, George
Lucas e molti altri e
ogni anno almeno uno
dei nostri ex allievi
riceve una nomination
agli Oscar. Ma la
nostra filosofia non si
basa su un lavoro
strettamente
individuale
d’autore.
Fare un film è un
lavoro
collettivo,”
spiegaElizabethDaley.
Nel
suo
spazioso
ufficio,
identificato
come “Lucas 209”,
situato nel vecchio
edificioGeorgeLucase
le cui finestre danno
sul
nuovo
George
Lucas Building, decine
di
fotografie
la
ritraggono con grandi
nomi e con le star di
Hollywood. Usc non è
alla
periferia
di
Hollywood,
centro.
ma
al
Per comprendere la
potenza delle industrie
creative negli Stati
Uniti, nel cinema come
nella
musica,
nell’editoria
o
in
internet, è necessario
studiare le università
americane. Negli Stati
Uniticisonooltre4000
istituti
di
studi
superiori, tra cui 1400
università; a questo
settore è destinato
circa il 3 per cento del
Pil, mentre in Europa
l’insegnamento
secondario è un terzo
di quello americano e
riceve, in media, l’1,5
per cento del Pil.
Contrariamente
a
quantospessosicrede,
il sistema universitario
americano non ha un
mercato
legato
al
settore privato: il 77
per
cento
delle
università statunitensi
sono
pubbliche
e
generalmente
finanziate da uno dei
cinquanta stati (è il
caso della Ucla, di
Berkeley
e
dell’Università
del
Texas di Austin). Gli
altri atenei non sono
aziende
con
fini
commerciali,
ma
associazioni
senza
scopo
di
lucro
(Harvard,
Yale,
Stanford, Usc). Tutte
queste
università,
pubbliche o gestite
senza scopo di lucro,
sonoinognicasomolto
onerose
per
gli
studenti che devono
accollarsi
rette
esorbitanti,trai20.000
e i 40.000 dollari
l’anno, per esempio
alla
Usc
(escluso
l’alloggio, la cifra varia
a seconda dei titoli e
dei livelli di studi). Gli
studenti
hanno
comunque accesso a
borse di studio e
impieghi
remunerati
(“work-studies”),
questo
spiega
il
paradosso
delle
università americane
che
sono,
nel
contempo, più costose
e
socialmente
più
diversificate
delle
equivalenti
europee.
L’82 per cento dei
giovani accede agli
studi superiori negli
Stati Uniti (mentre la
percentuale stagna al
59 per cento in
Inghilterra, al 56 per
centoinFranciaeal48
percentoinGermania).
Al
contrario,
se
l’accesso all’università
èpiùapertonegliStati
Uniti che altrove, il
numerodistudentiche
escono diplomati dopo
tre anni è in declino,
soprattutto
nelle
università pubbliche e
nei corsi brevi dei
community
colleges
(menodel50percento
in media attualmente,
uno dei tassi più
negativi tra i paesi
industrializzati, esclusa
l’Italia che fa anche
peggio). Le graduate
schools, di secondo e
terzo ciclo, mostrano
risultatimigliori.
È sempre difficile
fare un confronto a
partire
da
dati
stastistici, ma un fatto
è incontrovertibile: i
campus
americani
hanno una vitalità
culturale eccezionale.
Allorointernoospitano
complessivamente
2300 sale di teatro e
musica, 700 musei
d’arte e gallerie di
professionisti,
centinaia di festival di
cinema,
3527
biblioteche (di cui 68
con oltre 2,5 milioni di
libri, tra cui quella di
Harvard che è la
secondaalmondodopo
la
biblioteca
del
Congresso), 110 case
editrici, circa 2000
librerie, 345 sale per
concertirock,oltre300
radio universitarie e
altrettante etichette di
musica indipendente.
Questo
contesto
generale
crea
un
ambiente
favorevole
alla
creazione
e
relazionicostanticonle
industrie
creative,
comeaccadeallaUsc.
“Tra i nostri docenti
ci
sono
solo
professionisti
dell’industria
del
cinema
e
della
televisione,” prosegue
Elizabeth Daley, “e gli
studenti
sono
continuamente spinti a
lavorare all’interno di
queste industrie. Chi
viene alla Usc ama
Hollywood. Non ha
paura, non ha alcuna
reticenza a lavorare in
uno degli studios, al
contrario è il suo
obiettivo.
Qui
i
professionisti
vanno
incontro agli studenti.
Talvolta, uno studente
ottiene
improvvisamente, nel
corso
degli
studi,
poiché
è
stato
individuato
da
un
docente, uno stage o
un impiego alla Disney
o DreamWorks: allora
lo lasciamo andare, e
l’anno dopo torna da
noi.
Siamo
molto
flessibili.”
La scuola di cinema
Usc, che conta 1500
studenti, non è una
scuola di attori. Le più
prestigiose sono quelle
di Harvard, Yale e
Columbia.
Le
specializzazioni di Usc
sono
soprattutto
l’economia, la regia, il
digitale,ilmontaggio,il
suono.
Solo
nel
dipartimento
“produzione di film” ci
sono150docenti,dicui
50 a tempo pieno, per
soli
600
studenti.
Visitando il campus, si
ha subito un’idea dei
mezzi a disposizione
deglistudenti:ciascuno
ha un ufficio personale
accessibile
ventiquattr’ore
su
ventiquattro.
L’università
è
organizzata come una
vera e propria casa di
produzione, teoria e
pratica vanno sempre
di pari passo, e
vengono
impiegate
risorse interne per
realizzare veri e propri
film:
lo
studente
addettoallaproduzione
coordina un progetto
realizzato
dallo
studentediregiaincui
recitano
attori
professionisti
e
le
riprese sono fatte da
giovanichestudianoda
cameraman ecc. Sotto
il profilo tecnico, tutta
lastrumentazionedegli
studi, dalle sale di
montaggio fino alle
mix-rooms, passando
per le editing rooms, è
all’avanguardia ed è
stataregalataaUscda
Sony, Hewlett Packard
eIbm.
Sulla sinistra del
campus si succedono
gli
edifici:
Steven
Spielberg
Music
Scoring Stage (sala di
registrazione
per
colonne
sonore),
Carlson
Television
Center,
Jeffrey
Katzenberg Animation
Building
(studio
riservato
ai
film
d’animazione),
Usc
Entertainment
Technology Center e,
un po’ oltre, Stanley
Kubrick
Stage.
Al
centro, vicino agli
edifici della direzione,
c’è il “magazzino” in
cuiglistudentipossono
liberamenteprenderea
prestito
e
senza
autorizzazione
una
delle 80 cineprese
Arriflex 16mm, una
delle 50 cineprese
Mitchell 16mm, o una
delle 300 telecamere
digitali.
Nel
cuore
del
campus, vanto degli
studenti, c’è il nuovo
edificio intitolato a
George
Lucas.
Offrendo175milionidi
dollari nel 2008 per la
realizzazione di questo
prestigioso
edificio,
Lucas, proprio come
Luke Skywalker alla
fine del primo episodio
di Guerre stellari che
compie il suo destino
diventando uno jedi, è
stato nominato padrino
principale di Usc. Per
spiegare questo dono
filantropico di grande
impatto, velocemente
definito a Los Angeles
un “blockbuster gift”,
George
Lucas
ha
risposto
semplicemente:
“Ho
scoperto
la
mia
passione per il cinema
negli anni sessanta
quando ero studente
alla Usc, le mie
esperienze al campus
hanno forgiato tutta la
mia carriera. Sono
molto felice di poter
aiutare oggi la Usc a
continuare a formare i
registididomani,come
Usc ha fatto con me”.
(Oltre a Lucas, anche
gli studios Warner
Brothers, Fox e Disney
hanno
finanziato
questo edificio, con
sale per corsi di
montaggio, per cifre
pari a 50 milioni di
dollari.) Più lontano,
all’interno del campus,
visito
la
Doheny
Memorial Library, la
biblioteca della Usc,
checontienegliarchivi
di numerosi cineasti,
produttori
e,
per
esempio,
tutti
gli
archivi
di
Warner
Brothers. Molti edifici
sono imponenti, hanno
mantenuto parte della
“grandeur”
delle
Olimpiadidel1984,che
sono state disputate
all’interno di questo
campus.
Al dipartimento di
Scrittura
delle
sceneggiature,
mi
riceve il direttore, Jack
Epps Jr., anche lui un
professionista(èautore
della sceneggiatura di
Top Gun). “Qui si
insegna agli studenti a
essere scrittori prima
di
diventare
sceneggiatori. Non ci
sono
regole
per
scrivere un buono
script,nonaiutiamogli
studentiasvilupparele
tecniche,
ma
li
lasciamo anche molto
liberi.” Alla Usc, i
percorsi di formazione
hanno
un’ottica
spiccatamente
interdisciplinare e i
futuri
sceneggiatori
ricevono
una
formazione anche sulla
produzione
e
la
realizzazione affinché
si rendano conto, mi
spiega Jack Epps, di
cosa
significhi
concretamentegirareil
film che hanno scritto.
Il
loro
compito
principale è realizzare
pitchtelevisiviepilotes
cinematografici, come
accade nel mondo
reale.Conserietà,eun
briciolo d’ironia, Jack
Epps
aggiunge:
“Abbiamo anche un
corso specializzato in
re-writing, in cui gli
studenti riscrivono le
sceneggiature di altri
studenti
considerate
insoddisfacenti.
Può
essere utile, poiché a
Hollywood il re-writing
è un mestiere vero e
proprio”.
Gli
sceneggiatori di serie
comeGrey’sAnatomye
The Sopranos, insieme
ad altri, sono ex allievi
dell’università
e
intervengono
regolarmente
docentiall’Usc.
come
I film realizzati al
campus
sono
numerosissimi e tutti
gli esami e i diplomi
consistono
nella
presentazione di un
prodotto
culturale
professionale finito. Gli
studenti ottengono un
budget
per
girare
questi film: in media,
ciascuno riceve 80.000
dollariperfareunfilm,
finanziato
dal
dipartimento Business
di Usc in cui gli
studenti-produttori
raccolgono fondi per
studenti-registi.
La
maggiorpartediquesti
film è girata con attori
professionisti e, grazie
a un agente della
WilliamMorrisAgency,
sono
proiettati
in
alcuni festival per
addetti
ai
lavori,
soprattutto
al
Sundance, l’alternativa
“indipendente”
di
Hollywood.“Ognianno,
ricevo centinaia di film
provenienti da queste
scuole
di
cinema,
alcuni
sono
film
collettivi, altri molto
personali, raccontano
storie sorprendenti e
diverse, spesso scritte
da latinos, neri, gay.
Qui c’è nuova linfa per
il cinema americano,”
conferma
Geoffrey
Gilmore, ex direttore
del Sundance Film
Festival, intervistato a
LosAngeles.
Questi scambi tra
università e mondo
culturale reale sono
continui sia nel cinema
sia nella musica e
nell’editoria.Quandosi
visitalaUscolescuole
concorrenti, come la
Ucla e la Tisch School
di Nyu, si resta colpiti
dall’energia,
dalla
costante innovazione e
dalla creatività degli
studenti. Una delle
chiavi del sistema
culturale americano è
la moltiplicazione dei
contatti tra queste
università e la cultura
underground che le
circonda: le piccole
gallerie
d’arte
universitarie,
le
centinaia di radio e
televisioni libere dei
campus, le migliaia di
festival
di
cortometraggi in tutti
gli Stati Uniti, gli
showcase di teatro
sperimentale di off-off
Broadway,lemiriadidi
club e di cabaret più o
meno loschi con gli
“open mic session”, i
laboratori di “creative
writing” nel vicino
incubatore
d’arte.
Ovunque, vicino ai
campus, ci sono bar
“arty” che propongono
proiezioni di film e
ristoranti vegetariani
con un retrosala in cui
si
fanno
concerti
alternativi di rock
ibrido o rap latino.
Spesso ho trovato
piccoli negozi che
vendonodvdamatoriali
o librerie che, per
sopravvivere, si sono
trasformate
in
caffetterie
e
propongono letture di
sceneggiatureepoesie.
Questa vita artistica è
chiamata “street-level
culture”, in essa si
fatica a distinguere il
professionista
dall’amatore,
il
partecipante
attivo
dall’osservatore,
omogeneitàediversità,
arte e commercio. In
tutti i campus ho visto
questo
dinamismo
culturaleincredibile:la
cultura
è
messy
(incasinata), off hand
(disinvolta),
fuzzy
(confusa) e sempre
indie(indipendente).
Il mercato invece sa
sempre
recuperare
perfettamente
a
proprio
vantaggio
questenicchieculturali
e
comunitarie:
a
dispetto, forse, delle
loro stesse intenzioni,
moltidiquestistudenti
“indipendenti”
contribuiscono in fin
dei conti a nutrire le
industrie
creative,
saranno introdotti nel
commercio e, a partire
da un’arte autentica
senza scopo di lucro,
finiranno per produrre
cultura
mainstream.
L’America ci prova che
spessoèdifficileessere
commerciali solo a
metà.
Ricercaesviluppo
La
questione
principale tuttavia è
un’altra. Negli Stati
Uniti, le università non
sonosoloiluoghiincui
emerge
la
cultura
alternativa, ma fanno
ormai parte del settore
Ricerca e Sviluppo
(R&D) delle industrie
dei contenuti. Nei
campus gli studenti
assumono
rischi,
innovano,
fanno
sperimentazioni
che
saranno poi riprese e
sviluppatedaglistudios
e
dalle
emittenti
televisive.
In
un’efficace
divisione
dei compiti nel campo
dell’R&D, gli studenti
seguono l’ambito “R” e
le major il “D”. Questi
legami con le industrie
non sono fortuiti, ma
vengonoincoraggiati.
Un Office of Student
Industry Relations, nel
campus
di
Usc,
organizza
questi
rapporti con l’industria
del cinema e della
televisione per tutto
l’anno,
attraverso
stage, lavori estivi, ma
anche master classes,
“guest lectures” e
offerte di lavoro. La
maggior parte degli
studenti di Usc che ho
incontrato sono già
stati D-Man o D-Girl,
espressione
spesso
usata
per
dire
“Development-People”
(una sorta di aiuto
regista o assistente di
produzione).Glistudios
eletelevisionipossono
così
reclutare
all’interno del campus
studenti
che
corrispondono meglio
alle loro attese e farli
lavorare, durante la
loro formazione, sulle
sperimentazioni di cui
hannobisogno.
Le regole per la
collaborazione con le
industrie
sono
comunque
molto
precise.Ilcopyrightdei
film e i brevetti
innovativi realizzati nel
campus dagli studenti
restano di proprietà
della Usc e non dello
studio che li ha
finanziati. Nonostante
le apparenze, la Usc
continua a essere un
ambito senza scopo di
lucro, non inserita nel
mercato.
Questo
aspetto è decisivo ed
emerge quando si
discute a lungo con gli
studenti di Usc e con
quellidellealtrescuole
di cinema (ce ne sono
oltre 1500 negli Stati
Uniti). Tra le più
famose, c’è la Ucla
nella zona ovest di Los
Angeles, che si occupa
più
di
cinema
indipendente che di
studios; la scuola CalArts
(California
Institute of Arts) nel
Nord di Los Angeles
che forma soprattutto
artistidelcinema(John
Lasseter di Pixar, ex
allievodellaCal-Arts,è
il
creatore
di
riferimento); la Tisch
School alla New York
University,
che
si
interessa di cinema
indipendente
ed
europeo (e il cui
cineasta di riferimento
non è George Lucas,
ma Spike Lee); o
ancora l’Università del
Texas a Austin, che
cerca di specializzarsi
nel cinema digitale. “Il
nostroobiettivononèil
mercato,
ma
l’esperienza dei nostri
studenti, che peraltro
da noi continuano a
detenere il copyright
deilorofilm,”conferma
Tom
Shartz,
intervistato in Texas,
dove
dirige
il
dipartimento di Film,
radio e televisione
dell’Università
del
Texas a Austin (ma
questa
ha
recentemente
fatto
accordiconunasocietà
di produzione privata,
Burnt
Orange
Productions,
per
mettereincommercioi
lavorideglistudenti).
Tutte le scuole di
cinema hanno studi
digitali
professionali
tanto quanto quelli
delle
major
di
Hollywood perché le
attrezzature sono state
finanziate
dagli
studios, per esempio
quellidiUscdaGeorge
Lucas, quelli di CalArts da Disney, quelli
di
Ucla
da
DreamWorks.
Ma
queste
università
hanno anche numerosi
legami con le start-up
dell’intrattenimento e
del digitale: quelle
della California sono
vicine
alla
Silicon
Valley;HarvardeilMit
sono costantemente in
contatto con le società
del
“corridoio”
dell’innovazione
tecnologicadellaRoute
128; Duke University è
situata in prossimità
dell’“hub” tecnologico
di Raleigh in Carolina
del Nord. Più spesso
ancora, gli studenti,
che sono persuasi che
siamo
vicini
alla
smaterializzazione del
cinema, continuano a
fare
sperimentazioni
all’interno
dei
laboratori
It
delle
università e girano i
loro film con piccole
telecamere
in
Dv
(Digital Video) il cui
prezzoabbordabileela
grande facilità d’uso
contribuiscono
all’aumento
dei
progetti e a una nuova
creatività.
Tutti conoscono il
film The Blair Witch
Project che metteva in
scena alcuni studenti
americani di cinema
che si sono persi nella
foresta proprio mentre
giravano il loro film.
Realizzato con una
telecamera
rudimentaleper35.000
dollari, il film è stato
presentatoalSundance
Film
Festival
e
promosso soprattutto
attraverso internet – il
primo caso decisivo di
marketing
quasi
interamente online. Ha
fatto registrare 248
milioni al botteghino
mondiale nel 1999.
Quell’anno i dirigenti
degli studios hanno
finalmente
capito,
grazie
a
questo
modesto progetto fatto
da studenti, che la
rivoluzione di internet
avrebbe
sconvolto
Hollywood. “Con The
Blair Witch Project
l’incertezza e la paura
ci hanno sconvolto,
letteralmente – e da
alloranoncihannopiù
lasciato,” mi conferma
un
dirigente
della
Universal
a
Los
Angeles.
Nel
cuore
delle
scuole
di
cinema
americane si fa anche
ricerca
nell’ambito
della
creazione
digitale. L’It-Arts, per
esempio, è al centro
dei programmi della
Usc così come della
Ucla.
“Il
nostro
insegnamento
è
completamente
flessibileeciadattiamo
ogni
anno
alle
evoluzioni dei media.
Cambiamo i nomi dei
nostri
corsi
in
continuazione, in modo
da essere sempre in
anticipo sugli studios
sul fronte delle nuove
tecnologie,”
dice
Elizabeth Daley, la
preside di Usc. Ancora
una volta, anche nel
campo del digitale, le
università
si
configurano come il
settore
ricerca
e
sviluppodeglistudios.
All’Interactive Media
Division e al Robert
Zemeckis Center for
Digital Arts, un po’
all’esterno verso nord
dal campus di Usc,
Kathy
Smith,
responsabile
del
digitale, mi mostra le
sale
di
montaggio
digitale e le sale 3D.
“Ogni studente, alla
fine del Master of Fine
Arts, deve fare una
Digital Dissertation,”
mispiegaKathySmith.
“Per
esempio,
gli
studenti realizzano il
designdiunsitowebo
contribuiscono
allo
sviluppo di un nuovo
software per Pixar,
DreamWorks o Sony.
Gli
studios
li
sponsorizzano
e
finanziano
le
loro
ricerche.” All’ingresso
dell’edificio del centro
digitale di Usc c’è la
lista dei donatori che
l’hanno
finanziato:
George
Lucas
e
Lucasfilm,
come
ovunque nel campus,
ma
anche
Steven
Spielberg,
20th
CenturyFox,leagenzie
William Morris e Caa,
ElectronicArts,Warner
Bros, Sony Pictures
Entertainment, David
GeffenFundation.
All’interno
dell’edificio principale
visito la Trojan Vision,
una vera e propria
emittente
televisiva
attiva nel campus che
raggiunge i 29.000
studenti e i 18.000
lavoratori
dell’università
(“Trojan”, dal nome di
Troyens, è la mascotte
dell’università).
La
cinemateca
dell’Usc,
un po’ più lontano, ha
sei sale e raccoglie
migliaia di film in 35 e
16mm e ospita un
cineforum permanente
gestitodastudenti,che
programmano i film e
organizzano
diversi
festival.
Ho trascorso diversi
giorni nel campus di
Usc e ho impiegato
intere settimane per
visitare
una
cinquantina di campus
negli Stati Uniti. Ciò
che mi ha colpito di
più,oltreallaricchezza
di queste università, al
loro
livello
professionale
e
ai
legami permanenti con
le industrie e il mondo
professionale reale, è
la
diversità
degli
studenti che vi ho
incontrato.
Questa
diversità
etnica
e
culturale,chenascesia
dall’interno degli Stati
Uniti
rendendo
possibile l’accesso alle
università
delle
minoranze di asiatici,
latinos e neri, sia dal
fronte internazionale
attraversounacapacità
eccezionale
d’attrazionedistudenti
del mondo intero, è
sicuramente uno degli
elementi centrali, e
spesso sottovalutato,
del modello culturale
americano.
Ladiversitàculturale
La Whistling Woods
International School,
all’interno
del
complesso della Film
City, si trova a un’ora
di strada a nordest di
Mumbai, in India. Per
arrivarci,
bisogna
attraversare decine di
mercati e di bidonville,
chiedere diverse volte
indicazioni sulla strada
da percorrere prima di
trovare la Film City
Road, in effetti la
segnaletica è davvero
carente. Chi sbaglia
strada si ritrova nella
giungla, vicino ai laghi
all’interno
dell’immenso
parco
nazionale di Sanjay
Gandhi, circondati da
scimpanzé che saltano
sul tetto del taxi, come
èaccadutoancheame.
Una volta arrivati al
campus, all’interno dei
ventiquattro edifici che
lo
compongono
si
scoprono
strumentazioni
moderne, studi e sale
di montaggio di livello
professionale.
In
questa
scuola
di
cinema
ci
sono
trecento
studenti,
soprattutto
indiani.
Indossano
tutti
la
stessa maglietta nera
con il nome della
scuola, sul modello dei
campus
americani,
molti di loro hanno
sotto il braccio un
computer
portatile
MacBook
Pro
con
installatoilprogramma
per eseguire montaggi
Final Cut studio e un
iPhone. Al ristorante
(dove come tutti gli
altri mangio con le
mani),
il
mio
interlocutore, Somnath
Sen,docentedicinema
in questa scuola, ha
con sé “Wired” e, al
tavolo di fianco, una
studentessa
legge
“Variety”.
“Quilamaggiorparte
degli studenti ha un
unico sogno: andare a
studiare negli Stati
Uniti,” mi spiega John
J.Lee,ildirettoredella
scuola.
John
è
americano e si è
trasferito da queste
parti
per
dirigere
questa
scuola
di
cinema, tra le più
importanti
del
continente asiatico. È
un uomo di Hollywood,
è stato produttore di
una trentina di film di
studiosehapubblicato
un libro sul tema, The
Producer’s
Business
Handbook(vendutonel
campus).
“Ci
concentriamo
sui
mercati emergenti e
globalizzati. Così, il 76
per cento dei nostri
studenti trova lavoro
appena uscito dalla
scuola.
Tuttavia,
l’attrazione per gli
Stati
Uniti
è
irresistibile.”
Qualche ora dopo
incontro Ravi Gupta,
presidente della scuola
di cinema. È indiano
ma
è
ugualmente
affascinato dagli Stati
Uniti. “Tutti i nostri
corsisonoininglese.È
l’unica lingua davvero
comune agli indiani. E
poivogliamopreparare
i nostri studenti a
essere competitivi sui
mercati asiatici, a
Singapore,HongKong,
inGiapponeeinCinae
il linguaggio comune è
l’inglese,
ma,
soprattutto, restiamo
molto
sull’inglese
poiché in tutte le
tecniche del cinema, il
linguaggio,
i
programmi,
la
strumentazione
digitale,
tutto
è
americano.”
Proprio in India, in
Cina, in Corea, a
Taiwan
si
capisce
perché l’attrazione per
gli Stati Uniti è così
forte nei settori delle
industrie creative in
generale e nel cinema
in
particolare.
È
sufficiente visitare il
dipartimentodiCinema
e
televisione
dell’Università
di
Pechino o quello delle
“industrie
culturali”
[sic] dell’Accademia di
scienze
sociali
di
Shanghai per capire
perché
i
migliori
studenticinesivogliono
–sepossono–studiare
negli Stati Uniti. La
povertà dei mezzi è
nulla a confronto della
gravosa cappa indotta
dalla
paura
del
cambiamento
e
dell’innovazione.
Inoltre,
i
giovani
professionisti
sono
sotto
permanente
controllo affinché non
creino in piena libertà.
Quando ho visitato
questidipartimentinon
sono
minimamente
riuscito a entrare in
contatto e comunicare
con gli studenti (il
responsabile
delle
relazioni internazionali
controllava
per
impedire ogni dialogo).
I
principali
presentatori
dei
telegiornali
delle
emittenticinesiègente
uscita dalla famosa
Università
della
comunicazione
della
Cina, una scuola di
stato centralizzata in
cui si insegnano per
quattro
anni
propaganda
e
politichese.
“Si pensava che la
cultura
fosse
uno
strumento
per
contenere
l’esodo
rurale,” mi spiega
Germain Djel, direttore
del centro culturale
Boulevard des arts,
intervistato a Yaoundé,
in Camerun. “Ma di
fattotuttociòsiritorce
controdinoipoiché,in
realtà, la cultura e
soprattutto
l’intrattenimento
contribuiscono
all’esodo. Non appena
sono un po’ brillanti e
raggiungono un po’ di
successo, i giovani
africani
vogliono
partire verso nuovi
mondi.
Vogliono
anzitutto andare nelle
capitali,
Douala
e
Yaoundé, poi verso
Dakar, poi verso Parigi
e
Londra.
E
naturalmente
tutti
vorrebbero
andare
negliStatiUniti.”
Altrove, nel Sud-est
asiatico, in America
latina e in Europa
centrale, la pressione
politica oggi è meno
forte, ma l’attrazione
resta viva. Gli Stati
Uniti approfittano di
questa richiesta per
rinnovare
i
loro
creatori
e
trarre
profitto
dalle
innovazioni
pensate
dagli
studenti
più
brillantiprovenientidai
paesi emergenti. Nel
cuore della macchina
americana ci sono,
ancora una volta, le
università e la loro
diversitàculturale.
Negli Stati Uniti
vivono 45 milioni di
ispanici legali (di cui
26
milioni
di
messicani), 37 milioni
di neri e 12 milioni di
asiatici(dicui3milioni
di cinesi, 2,6 milioni di
indiani, 2,4 milioni di
filippini, 1,5 milioni di
vietnamiti, 1,3 milioni
di coreani e 800.000
giapponesi).
Nei
campus delle scuole di
cinema, a Usc come
Ucla
o
Nyu,
i
rappresentanti
di
queste
etnie
sono
visibili e numerosi,
sono stranieri venuti a
studiare negli Stati
Uniti,
oppure
americani
figli
dell’immigrazione.
Negli Stati Uniti si
stimalapresenzadi3,3
milioni gli studenti
ispaniciedi1,3milioni
distudentiasiatici.
“Hollywood
è
un’industria
globalizzata, dobbiamo
dunque essere una
scuola
globalizzata,”
conferma
Elizabeth
Daley, rettore di Usc.
“Siamo molto attivi nel
cercare di reclutare
studenti
americani
molto diversi tra loro,
provenienti da tutte le
minoranze,
inoltre
cerchiamo,
ovunque
nel mondo, i migliori
studenti
o
professionisti
stranieri.”
Tra
gli
studenti accolti dalla
Usccisonoquellidella
Whistling
Woods
International
School
che ho visitato a
Mumbai.
Gli
Stati
Uniti
riescono a rinnovarsi
grazie alla diversità
culturale interna ed
esterna. Dal momento
in cui sono stati
selezionati
da
un’università,
gli
studenti
stranieri
beneficiano
di
procedure accelerate
per la concessione del
permesso di soggiorno.
Così si spiega la
percentuale elevata di
studenti internazionali
sul suolo americano,
nell’ordine del 3,4 per
cento di tutti gli
studenti
(ovvero
573.000 studenti di cui
356.000
provenienti
dall’Asia).
Questa
percentuale aumenta
fortemente
se
si
contano gli studenti
americani
nati
all’estero(10percento
nei due primi cicli, 18
per cento nel terzo
ciclo).
La
quota
aumenta ancora se si
considerano
gli
studenti nati all’estero
o i cui genitori sono
nati all’estero (22 per
cento nei primi due
cicli, 27 per cento nel
terzo ciclo). Sono cifre
senza
uguali
nel
mondo.
Ma non si tratta solo
di
statistiche.
La
diversità
culturale
americana è visibile
anche nei film di
Hollywood,dovenonsi
conta più il numero di
registi e attori neri,
latinos e asiatici. È
lontano il tempo della
commedia Indovina chi
viene a cena in cui
un’americana porta il
suo nuovo fidanzato
nero (Sidney Poitier) a
casa dei genitori ricchi
e bianchi (Spencer
Tracy e Katherine
Hepburn) suscitando il
loro
risentimento
(quandoèuscitoilfilm,
nel 1967, i matrimoni
interrazziali
erano
ancora
proibiti
in
diciassette
stati
americani). Oggi ci
sono spesso attori di
colore, anche nei film
commerciali e nelle
serietelevisive.Anchei
registi di Hollywood
provengono dal mondo
intero, dal canadese
James Cameron al
taiwanese Ang Lee.
Ovunque,
questa
diversità
è
un
formidabile motore di
promozione
e
di
identificazione con il
cinemaamericano.
Ciò che vale per
Hollywood, vale anche
per l’industria della
musica, l’editoria e il
teatro commerciale. In
questi ultimi anni, gli
attori più premiati a
Broadway sono stati il
drammaturgo
nero
August Wilson (due
Pulitzer), l’ebreo-gayamericano
Tony
Kushner
(diciannove
Tony
Awards
per
Angels in America e
CarolineorChangeeil
premio Pulitzer), il
cinoamericano David
Henry Hwang (Tony
Award
per
M.
Butterfly) e il cubanoamericano Nilo Cruz
(Pulitzer per Anna in
the Tropics). Inoltre, a
Broadway,
recentemente Denzel
Washington
ha
interpretato Bruto in
GiulioCesare.
Gli artisti stranieri
accoltinegliStatiUniti
sono numerosi, talvolta
sono
arrivati
illegalmente,
spesso
sono
regolarmente
accolti
grazie
a
procedureacceleratedi
assegnazione di visti,
permessi di soggiorno.
Per i professionisti
della
cultura
e
dell’intrattenimento,
l’amministrazione
americana
concede,
infatti,
ogni
anno
44.000 visti speciali
detti “O-1” (visto non
valido
per
l’immigrazione
e
limitatoatreanni),che
sonoassegnatitenendo
conto, per ciascun
candidato,
della
rassegna stampa, dei
premi internazionali,
dei contatti e dei
contratti nel settore
delleindustriecreative.
I tecnici di queste
industrie
possono
beneficiare di un visto
“H-B1”,egliinvestitori
in questi settori di un
visto “E-1” o “E-2”.
Questa reale apertura
agli artisti stranieri
avviene in ogni caso
all’interno
di
un
sistema
di
forte
protezionismo
del
mercato del lavoro che
rendeilsuccessoraroe
ancora più aleatorio
per i professionisti
stranieri.
Tutto
il
sistema culturale degli
Stati Uniti è, in effetti,
costruito
sulla
protezione dei posti di
lavoro americani, in
particolare attraverso
l’adesione ai sindacati
degli autori e alle
società di registi e
sceneggiatori.
È
dunque
necessario
avere
molta
perseveranza e grande
talento
per
poter
sfondare
in
terra
americana.
Sitrattadifilantropia
americana?
Questa
capacità di accogliere
talentistranierioffredi
fatto a Hollywood un
vantaggio eccezionale
sulla
concorrenza.
“Tutti i nostri attori,
registi sono scritturati
negli Stati Uniti. È
un’opportunità
per
loro,
ma
questo
annienta
completamente
la
creativitàlocale.Così,i
film
di
cassetta
americani funzionano
beneinAmericalatina,
ma le cinematografie
nazionali, private dei
loro migliori attori e
cineasti, sono state in
poco tempo indebolite,
quando
non
sono
interamente
scomparse,”
dice
dispiaciuto Alejandro
Ramírez
Magaña,
direttoregeneraledella
principale rete di sale
messicane, Cinépolis,
intervistato a Città del
Messico.
“Gli eroi di Il ribelle
dell’Anatolia, il film di
Elia
Kazan,
oggi
sarebbero
asiatici,
latinos e non più
eureopei;
arriverebbero a Los
Angeles e non più a
New York,” mi dice
Mark
Valdez,
animatore
culturale
dello
spazio
comunitario
Cornerstone di Los
Angeles. Lo incontro
nella
sede
dell’associazione,
a
downtown LA, nel
centrodellacittàchein
realtà non ha un
centro. È anche una
città
chiamata
“minority-majority-
city”, cioè dove le
minoranze sono la
maggioranza
della
popolazione.
A ovest si trovano i
negozi di dischi J-Pop
del
quartiere
giapponese di Little
Tokyo;
a
est
il
quartiere della musica
reggae
di
Boyle
Heights
attorno
all’avenue
César
Chávez (ieri quartiere
ebraico, oggi per il 95
percentoispanico);più
lontano ancora a est,
East Los Angeles, il
quartiere messicano in
cui è possibile trovare
tuttiidvdditelenovele
di Televisa, e Diamond
Bar,
il
quartiere
indianodovesipossono
trovare tutti i film di
Bollywood per due
dollari; a nord, le
decine
di
gallerie
d’arte e opere popolari
in
mandarino
e
cantonese di Chung
King Road, il quartiere
cinesehipdidowntown
LA; a sud-ovest, Korea
Towneinegozidicde
dvdchevendonoK-pop
e “drammi” coreani; a
sud comincia South
Central Avenue che
porta verso gli studios
hip-hop del quartiere
nerodiSouthCentrale
le
centinaia
di
associazioni
comunitarie di Watt,
ieri a maggioranza
nera,oggiispanica.
Se Los Angeles ha
soppiantato New York
come primo luogo
d’ingresso
degli
immigrati negli Stati
Unitieselacittàèuna
dimostrazione vivente
delladiversitàartistica,
questo è solo un
esempio fra tanti di
una
viva
diversità
culturale
che
ho
riscontrato
ovunque
nei
quartieri
di
Houston,
di
Des
Moines, a Jackson o
Denver,
ad
Albuquerque o Fort
Apache.
Oggi
Los
Angelesèlapiùgrossa
città coreana dopo
Seul, la più grande
città iraniana dopo
Teheran, la più grande
città polacca dopo
Varsavia, una delle più
grandi città thailandesi
e vietnamite al mondo.
Altre capitali regionali
americane
hanno
primati
equivalenti.
Chicagoèunadellepiù
grandi città greche al
mondo e Newark una
delle più grandi città
portoghesi; Miami è
una capitale di Haiti,
Minneapolis
è
un’importante
città
somala e Colorado è la
regionealmondoincui
vivono più mongoli
dopo la Mongolia.
Invece, gli arabi sono
poco numerosi negli
Stati
Uniti
e
i
musulmani
rappresentano solo lo
0,55 per cento della
popolazione americana
e
sono
originari
soprattutto
dell’Asia
delSudedell’Iran.
Gli Stati Uniti non
sonosemplicementeun
paese, e neanche un
continente: sono il
mondo, quantomeno il
mondo in miniatura.
Nessun paese ha una
simile
diversità
e
nessuno,
neanche
l’Europa
dei
27,
potrebbe
rappresentare meglio
unanazioneuniversale.
Questo elemento è un
fattore che spiega in
modo determinante il
dominiocrescentedelle
industrie
creative
americane, dell’arte e
dell’intrattenimento,
del mainstream e dei
settori di nicchia, in
tuttoilmondo.
L’americanizzazione
culturale del mondo si
è trasformata nella
seconda
parte
del
Ventesimo secolo in un
monopolio
sempre
crescente
sulle
immagini e sui sogni.
Oggi,
questa
americanizzazione
è
oggetto di concorrenza
e di contrasti da parte
dei
nuovi
paesi
emergenti, Cina, India,
Brasile e paesi arabi,
ma anche dei paesi
come il Giappone o la
vecchia Europa: tutti
cercano di difendere la
propria cultura e forse
intendono lottare ad
armi pari con gli Stati
Uniti. Sotto i nostri
occhi si sta profilando
una nuova geopolitica
dei
contenuti.
Si
annuncia l’inizio di
guerreculturali.
Secondaparte
LAGUERRA
CULTURALE
MONDIALE
9.
KungFuPanda:Cina,
lanuovafrontieradi
Hollywood
Mi trovo nella valley,
vicino a Hollywood,
nell’ufficio
del
vicepresidente di uno
deiprincipalistudios.Il
miointerlocutorecerca
di parlare un po’ in
francese,manonvuole
che sia rivelata la sua
identità. L’intervista si
svolge
in
modo
informale,
ma
le
argomentazioni
che
emergono sono banali.
Su temi come mercato
internazionale dei film,
nuovastrategiaglobale
degli
studios
e
globalizzazione
del
cinema americano non
apprendonullachenon
abbia già letto decine
di volte sulla stampa
specializzata.
Nell’ufficio di questo
patron di Hollywood,
tuttavia, c’è qualcosa
che mi intriga, tre
orologi che segnano
ore diverse: “Japan
Time”, “China Time” e
“India
Time”.
Gli
studios
americani
hanno gli occhi puntati
sull’Asia. È la nuova
frontieradiHollywood?
Li Chow è direttrice
di Sony e di Columbia
in
Cina.
Ho
appuntamento con lei
al BookWorm, una
libreria-caffetteria
americana
nel
quartierediChaoYang
di Pechino. Li Chow è
originaria di Taiwan, è
figlia di un diplomatico
e parla un inglese
perfetto
–
cosa
piuttosto rara in Cina.
Sony
Pictures
ha
aperto un ufficio a
Pechino nel 1996 con
l’obiettivodifavorirela
distribuzione dei film
della major nippoamericana nel paese.
Poi le ambizioni sono
cresciute e la major si
è lanciata anche nella
produzione.
Sulla
carta,
la
strategia
cinese di Sony è
perfetta. “Fare tutto
nello stesso tempo,
tutto
ciò
che
è
possibile,” precisa Li
Chow.
La
realtà,
tuttavia, si è rivelata
benpiùcomplicata.
Il
potenziale
dell’industria
cinematograficacinese,
mercato
emergente
all’interno di un paese
emergente, sembra di
primoacchitounpozzo
inesauribile data la
popolazione di 1,3
miliardi di abitanti. Da
una decina d’anni in
modo
particolare,
insieme
a
una
eccezionale
crescita
economica (8-9 per
centoall’annonel2008
e 2009), anche il boxoffice è in costante
aumentoogniannocon
dati a doppia cifra.
Inoltre,
in
questo
periodo, si costruisce,
in media ogni giorno,
un nuovo schermo di
multisala. Di contro, la
reale produzione della
cinematografia
nazionale si attesta su
livellimoltobassi,circa
50 film l’anno, un dato
ben lontano da quello
fornito
dalla
propaganda
ufficiale
cinese (circa 400). Gli
americani
hanno
dunque
intravisto
subito
grandi
opportunità e hanno
cominciato a sognare
scenari
mirabolanti:
1,3 miliardi di cinesi,
con carte di credito
Bank of America, auto
General Motors, iPod e
iPhone,
programmi
Windows
e
naturalmente
2,6
miliardi di mani pronte
ad applaudire i film di
Hollywood.
Questa
volta l’America ha
puntato verso l’Oceano
Pacifico. Tuttavia, per
le major, introdursi in
questo mercato si è
rivelato un’operazione
moltoardua.
Ilprimoostacolo,non
di poco conto, è la
censura. Gli americani
hannoinfatticercatodi
conquistareunmercato
all’interno di un paese
in
cui
il
Partito
comunista cinese, dal
momento
del
suo
insediamentonel1949,
esercitauncontrollodi
ferro su tutti i mass
media. La Rivoluzione
culturale
ha
ulteriormente
accentuato
questa
censura e il cinema è
diventato
semplicemente oggetto
di propaganda. Ogni
parola pubblicata, ogni
informazione
trasmessa via stampa,
radio o televisione,
ogni libro stampato,
ogni testo recitato a
teatro, ogni parola
della canzone di un
disco sono sottoposti a
rigidocontrollo.Questa
sorveglianzapreventiva
si
basa
su
un’incredibile rete di
decine di migliaia di
funzionari addetti alla
censura e di poliziotti
alledipendenzenondel
potere esecutivo, come
gli altri ministeri, ma
stranamentedelPartito
comunista cinese. Il
cinema è considerato
un settore strategico e
dunque
non
fa
eccezione,
anzi
al
contrario. Così, ciò che
è già difficile per un
produttore cinese è
ancora più complicato
perchièstraniero.
Per distribuire un
film in Cina, una major
internazionale
deve
ottenere diversi via
libera da parte delle
autorità
cinesi,
in
particolare dai diversi
servizi dell’ufficio della
censura,
altra
emanazione
del
ministero
della
Propaganda. Per poter
ottenere
l’autorizzazione
alla
distribuzione, il film
deve essere sottoposto
a
censura
già
sottotitolato.
La
censura
è
un
complesso
apparato
fatto
di
controllo
politico,
controllo
piccoloborgheseinstile
vittoriano
e
protezionismo.
Sessualità,
violenza,
politica,
islam,
“distorsioni”
sulla
storia
cinese
e,
ovviamente,
ogni
allusione agli eventi di
piazza Tienanmen, al
Dalai Lama, al Tibet,
all’indipendenza
di
Taiwan,
alla
setta
Falun
Gong,
all’omosessualità e più
ampiamente ai diritti
umani sono argomenti
tabù e possono portare
a un divieto immediato
di distribuzione del
film. Disney si è
pesantemente
scontrata con questo
sistema quando ha
prodotto Kundum di
Martin Scorsese, film
che rendeva omaggio
alla
battaglia
non
violenta
del
Dalai
Lama, la major ha
infatti rischiato di
vedersi proibire la
distribuzioneinCinadi
tutto
il
catalogo;
inoltre, il progetto di
realizzare un parco
tematico a Shanghai è
stato
respinto
per
diversi
anni.
La
censura colpisce anche
atteggiamenti
critici
nei confronti degli
alleati
della
Cina
(Russia,
Venezuela,
Cuba e alcuni dittatori
africani) e l’elogio di
potenze poco amate
comeGiapponeeIndia.
In fin dei conti, dato
l’ampio
spettro
di
divieti,sonomoltiifilm
che possono contenere
scene su uno di questi
temi
sensibili.
“In
realtà, non esistono
vereeproprieregoledi
censura,” spiega Li
Chow. “Un film è stato
rifiutato
perché
mostravadeitatuaggie
un attore aveva un
piercing,
un
altro
perché
conteneva
scene
di
grande
povertà,
un
altro
ancora
perché
di
stampo ‘nichilista’, un
altro perché aveva
troppe
scene
di
suspense.
Spesso,
peraltro, la censura
non fornisce alcuna
spiegazione
sulle
proprie scelte.” Si è
verificato anche il caso
di film vietati dalla
censura e autorizzati
dopo
essere
stati
nuovamente presentati
con un altro titolo.
Isabelle
Glachant,
produttrice
indipendente
incontrata a Pechino, è
ancora più severa: “La
censura è paranoica e
chi fa film è sempre in
posizione
di
autocensura. Per le
autorità
cinesi,
le
questionipolitichesono
in realtà secondarie:
l’unica cosa che conta
è il patriottismo. Il
governo
cinese
è
semplicemente
impegnato a tenere il
botteghino dei film
cinesi
superiore
a
quello americano. Per
raggiungere
questo
scopo è pronto a tutto:
censurare film che non
dovrebbero
essere
censurati, introdurre
periodi di blackout
totale o, più spesso
ancora,daredatifalsi”.
Altre
persone
intervistate in Cina
forniscono
interpretazioni
più
sfumate sulla censura.
A
Shanghai,
per
esempio, Chen Sheng
Lai,expresidentedella
radio (ufficiale) della
città, difende l’idea
secondo cui la Cina
deve avere il diritto a
una quota percentuale
sugli incassi, come
accade in tutti gli altri
paesi.Ritieneovvioche
la
Cina
debba
proteggere la propria
cultura
nazionale.
Anche altre persone
intervistateaPechinoe
Shanghai condividono
questo punto di vista.
Ciò che gli occidentali
chiamano “censura” è
semplicemente
un
sistema di regole per
proteggere i valori
cinesi, diversi da quelli
occidentali,
ma
ugualmente validi. “I
valori
dell’Occidente
sono forse buoni, ma
non sono universali,”
mi dice Hua Jian,
docente universitario,
direttore del Cultural
Industry
Research
Center all’interno di
un’istituzione
molto
ufficiale
come
l’Academy of Social
Science di Shanghai.
“La
libertà
d’associazione,
la
libertà di stampa, la
libertà d’opinione e di
religione non sono
necessariamente valori
universali,” prosegue
Hua Jian, poi termina
abilmente il discorso
dicendo: “La qualità
artistica dei film si
sviluppa
spesso
a
partire
da
questo
scontroconlacensura.
Il
contrasto
tra
repressione e libertà
produce anche in Cina,
come accadeva nel
sistema degli studios
americani degli anni
venti,grandecreatività
e fa nascere un certo
glamour”.
Lacensuraufficialeè
solo uno dei tanti
ostacoli istituiti dai
cinesi per proteggersi
dal cinema straniero.
Dopo avere ottenuto
l’autorizzazione,
un
film deve superare lo
scoglio
della
distribuzionenellesale.
Tutti
i
cinema
appartengono
allo
stato, il monopolio
della distribuzione è
detenuto da China
Film,
ufficio
cinematografico
anch’esso direttamente
legato al ministero
della
Propaganda.
China Film, attraverso
un complesso sistema
di quote di riserva a
favore della propria
cinematografia,
autorizza
solo
la
distribuzione di una
ventinadifilmall’anno.
Di fatto, i film di
successo hollywoodiani
costituiscono sempre il
50 per cento dei film
distribuiti, il sistema di
diritti
percentuali
produce un paradosso:
favorisce
i
film
mainstream per un
ampio pubblico di
massa.
È questa una buona
sintesi del capitalismo
di stato cinese, un
capitalismo autoritario,
definito
con
una
celebre espressione in
voganegliannidiDeng
Xiaoping
come
“economia socialista di
mercato”. Si tratta di
un sistema che mette
insieme
in
modo
originale un’economia
di mercato vera e
propria, dinamica e
anche
selvaggia,
piccole
aziende
piuttosto autonome e
rivolte al consumo
internoe,alvertice,un
sistema di comando
ancoraleninistaconun
controllo
politico
totale.
Tutto
ciò
contribuisce a creare
quello
che
viene
chiamato
miracolo
economicocinese.
A
condizione
di
restare anonimo, il
responsabile di una
major americana in
Cina mi ha spiegato
che
gli
studios
hollywoodiani
si
ripartiscono tra loro
preventivamente
la
distribuzionedeifilmdi
successo ancor prima
diesseresottopostialla
censura, contro ogni
elementareregoladella
concorrenza – regole
che invece cercano di
imporre
alla
Cina
attraverso
il
Wto.
Questi accordi illegali
si fanno a Washington
con gli auspici della
Mpaa, la lobby di
Hollywood: ogni major
sceglie
due
film
all’anno,
poi,
generalmente,
le
autorità
cinesi
approvano
queste
scelte.
Viene
spontaneo
chiedere
perché
i
cinesi,
che
ben
conosconoleintenzioni
e
i
metodi
anticoncorrenza degli
americani,continuinoa
stare al gioco. “Perché
questifilmdisuccesso,
i
blockbuster
americani,
fruttano
loro molto denaro e
perché riempiono i
cinema,” mi dice un
responsabile di Disney
in Cina, sempre a
condizione di restare
anonimo. Resta il fatto
cheèmoltodifficileper
un film americano non
prodotto dalle grandi
case, o per un film
europeo, introdursi in
questo
mercato.
Quando le autorità
cinesi sono vittime
delle
operazioni
capitalistiche fatte con
gli studios, soprattutto
quando il botteghino
dei film americani
rischia di superare
quello cinese, vengono
decretati periodi di
“black-out”totaleincui
tutti i film stranieri
scompaiono dalle sale.
Durante le vacanze di
Natale, in occasione
del nuovo anno cinese
e durante le vacanze
del primo maggio, si
proiettano solo “grandi
kolossal” cinesi in
costume. Nonostante
tutto, i blockbuster
americani,
semplicementeconuna
ventina
di
film
autorizzati all’anno, da
Iron Man a Pirati dei
Caraibi,passandoperil
successo della saga di
Harry
Potter
o
recentemente
di
Transformers2,2012e
Avatar (ma Batman. Il
cavaliereoscuroèstato
vietato), raggiungono
quasi il 50 per cento
del botteghino cinese
ogni anno. Si tratta di
cifre
astronomiche,
tenuto conto delle
quotediriservaedella
censura.
Il sistema cinese si
completa
con
la
censurafinanziariaela
pirateria. Quando un
film è autorizzato e
distribuito
–
e
generalmente questo
accade solo per i film
di successo rivolti alla
famiglia e inoffensivi –,
il produttore straniero
prende royalty sul 13
per
cento
del
botteghino, una quota
ridicolmente bassa. Lo
studio
DreamWorks
Animation ne ha fatto
le spese con Kung Fu
Panda. Il film è stato
inizialmente
accolto
freddamente in Cina
dalle autorità e dalla
critica, che hanno
accusato la major di
aver
indebitamente
usato
il
tesoro
nazionale cinese, il
panda, e uno sport
particolarmente
adorato come il kung
fu.
Nonostante
le
controversie,
il
pubblico
ha
favorevolmente accolto
la storia di questo
panda in sovrappeso
che vuole diventare
maestrodikungfuedè
arrivato
anche
il
successo. Eppure, la
major americana di
Jeffrey Katzenberg non
ha potuto raccogliere i
proventi
del
botteghino,limitatialla
percentuale del 13 per
cento
versato
ai
produttori
stranieri.
Per quanto ridotta in
termini di dollari, la
quota di mercato degli
americani in Cina è in
forte crescita, tenuto
conto
della
progressione
del
botteghino cinese, che
raddoppia ogni tre
anni.
La
pirateria
è
talmente diffusa e così
visibile che davvero
non si riesce a capire
perché le autorità
cinesi non riescano a
sanzionarla, eppure si
sono impegnate in tal
senso
con
l’Organizzazione
mondiale
del
commercio. Ieri le
videocassette, oggi i
dvd pirata e la diffusa
pratica di scaricare da
internet
(nonostante
velocità di connessione
ancora mediocri in
Cina): ogni mezzo è
buono per rendere il
cinema e la musica
gratuiti e alla portata
di
tutti.
Questa
contraffazione
generalizzata è ancora
più
grave
perché
l’offerta
cinematografica
è
ancora
molto
insufficiente(intermini
di film distribuiti e in
numero di schermi) e
perché la censura
contribuisce
naturalmente
ad
aumentare a dismisura
la richiesta di dvd
piratati. “Quando è
uscito Casino Royale,”
mi dice Li Chow, “alla
sede Sony di Pechino,
siamo stati sbalorditi
dal fatto che i cinesi
conoscessero
il
personaggio
e
la
musica del film, era
infatti il primo film di
JamesBondautorizzato
in Cina. Avevano visto
tuttiglialtrifilmindvd
piratati. Questo ha
facilitato
molto
il
nostro marketing. Per
la prima volta ho
apprezzato
la
pirateria.”
Per avere un’idea di
questo mercato nero
alla luce del sole, ho
chiesto
ai
miei
interlocutori cinesi di
indicarmi l’indirizzo di
un’industria illegale in
cui vengono fabbricati
cd e dvd pirata per
poter
andare
a
visitarla. Mi hanno
detto, anzitutto, che si
trovavanonellaregione
di Canton, nel Sud
della Cina, ma andarci
è
complicato
e
addirittura rischioso.
Le persone incontrate
negli studios americani
mi hanno detto di aver
cercato a lungo di
capire i segreti di
questo mercato nero
che
ostacola
fortemente
i
loro
interessi nel cinema e
nella
musica.
In
mancanza di indirizzi
precisi, sono entrato in
alcuni delle migliaia di
negozi di cd e dvd
diffusissimi nelle vie di
Pechino, Shanghai e
Hong Kong. Alla fine,
discutendo con un
venditoredicdedvda
Shanghai, ho capito
perché i dvd piratati
somigliassero
così
tanto a quelli originali:
“Non sia ingenuo”, mi
dice il venditore (che
vuole restare anonimo
e tradotto dal mio
interprete). “I dvd
originaliequelliillegali
sono prodotti dalla
stessa
fabbrica.
È
esattamente
come
accade per le penne
Montblancegliorologi
Rolex.” Poi mi ha fatto
vedere nel suo negozio
dvd “veri” mischiati
con quelli “falsi” – e
viceversa. Anche gli
americanihannocapito
l’inganno e lo hanno
trovato molto meno
divertente di me. Con
alcune operazioni di
controllo, modificando
alcune immagini di un
film preso a campione,
hanno
addirittura
constatato che sul
mercato
nero
si
trovavano
film
sottoposti alla censura
cinese e rifiutati –
situazione incredibile
che dice molto sullo
stato di corruzione
nella Cina comunista.
Così, hanno attaccato
laCinadifrontealWto
per mancato rispetto
delle
leggi
internazionali
sul
copyright
e
per
denunciare il lassismo
sulla pirateria. “Non si
può
fermare
la
pirateria,” minimizza
Gary Chan Chi Kwong,
patron di East Asia
Media incontrato a
Hong Kong. “I cd
originalieglialtrisono
prodotti
all’interno
delle stesse fabbriche.
Chiudiamo un occhio:
daunapartecerchiamo
dilottarecontroqueste
pratiche,
dall’altra
lasciamo
correre.
Infatti,èassolutamente
impossibile fermare la
pirateria.”
Vicino
a
piazza
Tienanmen, nel cuore
dellacensuracinese
“Questo è il Wild
Wild East.” Con questa
espressione,
che
ricalca
l’appellativo
Wild Wild West per la
California,
Barbara
Robinson definisce in
quali termini per gli
americani fare cinema
inCinarappresentiuna
sfida.
Dal
trentaduesimo
piano
della celebre torre di
Bank
of
China
progettata
dall’architetto I.M Pei,
Barbara contempla le
colline di Hong Kong
che le ricordano quelle
di Hollywood. La mia
interlocutrice
americana
dirige
ColumbiaPicturesFilm
Production Asia, di
proprietà di Sony. La
distribuzione dei film è
gestita da Pechino,
città della censura e
del potere politico, ma
Sony ha collocato a
HongKongilsettoredi
produzione del cinema
e le reti audiovisive.
Lontano dal potere
cinese, lontano dalla
censura.
“‘Location, location,
location’ e ‘Cheap,
cheap, cheap’ sono il
nostro
motto
per
produrrefilmdaqueste
parti,” spiega Barbara
Robinson,
“i
posti
migliori
ai
costi
migliori.” E funziona.
Sony produce circa
quattro film all’anno in
lingua
cinese
(soprattutto
il
mandarino), per un
pubblico
soprattutto
cinese. Nel suo ufficio
c’èappesalalocandina
diLatigreeildragone
di Ang Lee, il successo
internazionale
di
questofilmnel2000ha
confortato la strategia
di
Sony
che
ha
cominciatoasognareil
potenziale mercato di
film cinesi. “Per la
gentediSonychestaa
Hollywood,
la
principaleragionedella
nostra presenza qui è
favorire
la
distribuzionedeifilmdi
SonyinCina.Ma,peril
momento ciò non è
assolutamente
possibile.
Allora
aspettiamo.Tuttisanno
che la Cina si aprirà:
‘Open
Up’
è
l’espressione
che
abbiamo tutti in testa.
Maperilmomentonon
è
aperta.
Dunque
siamo
qui
ad
aspettare.”
Ancheinquestocaso,
ilmercatocinesenonè
particolarmente
accogliente,
persino
con i film realizzati a
livello locale. Anche se
produceiproprifilmin
Cina, in lingua cinese,
anche se fa commedie
cinesi, il semplice fatto
che Sony, una major
straniera, abbia sede a
Hong Kong impedisce
una
normale
distribuzionenelpaese.
Ancora una volta, il
film è soggetto a una
percentuale sui diritti
impostadallostato.Per
aggirarequestoscoglio
(e
ottenere
una
percentuale di introiti
dell’ordine del 40 per
cento, quota molto
superiore rispetto a
quella consentita ai
film stranieri), Sony ha
creato partenariati con
societàprivatecinesidi
Pechino abilitate a
coprodurre film. Lo
scopo
di
queste
coproduzioni non è
cercare finanziamenti
per rimpinguare il
budget dei film (Sony
nonhasimiliproblemi),
maaggirarelacensura
e
i
diritti
di
percentuale. Anche in
questocasolastradaè
irta di ostacoli. Ci si
imbatte infatti nella
China
Film
Coproduction
Corporation, che è il
passaggio
obbligato
per ogni forma di
coproduzione in Cina.
Perquestohodecisodi
andare a trovare gli
uffici
di
istituzione.
questa
All’interno di un
bunker
protetto
dall’“esercito
del
popolo” a Pechino,
leggermente a ovest di
piazza Tienanmen, ho
appuntamento
con
Zhang Xun, presidente
di
China
Film
Coproduction
Corporation. Fa un
freddo glaciale, un
freddo accentuato da
un
terribile
vento
mentre
entro
nel
compound
ufficiale
della
censura
cinematograficacinese.
Mi viene fornito un
permesso
e
sono
accompagnato da una
guardia
impassibile.
Passiamo davanti ad
auto ufficiali, dai vetri
oscurati, alcune con il
lampeggiante – fatto
strano per un ufficio
che si occupa di
questioni
cinematografiche. Ci
sono decine di edifici
che ospitano numerosi
network televisivi, tra
cui la famosa Central
China
Television
(Cctv),
televisione
ufficialeinunmondodi
televisioni ufficiali. Per
arrivare a destinazione
bisogna
camminare
alcuni minuti. Gli uffici
sono
un
mortorio
popolato
da
un
personale
pletorico
completamente
inattivo;
alcuni
guardiani
sono
letteralmente
addormentati, altri mi
guardano come se
venissi da un altro
pianeta.
Vengo
portato
nell’immensa
sala
riunioni insieme alla
miainterprete,afianco
di un bouquet di fiori
finti è stata issata una
bandiera cinese di
fronte a una francese.
Istintivamentemisiedo
sul lato francese, forse
ZhangXunsiaspettadi
incontrare il console
francese.
Poco dopo arriva la
presidente
dell’istituzione
internazionale
che
gestisce
tutte
le
coproduzioni in Cina e
negozia con gli studios
di tutto il mondo. Non
saunaparoladiinglese
(e
tantomeno
di
francese).
Parla
a
lungo. Mi dice quanto
la Cina sia favorevole
alle
coproduzioni,
quanto
il
sistema
cinematografico cinese
siaproduttivoconoltre
400
film
all’anno
(mentre, come si è
detto, il dato reale è
inferiore a 50), quanto
sia
una
industria
ancora più influente di
Bolly wood (altra cosa
non vera, né per la
produzione, né per la
diffusionenazionale,né
per le esportazioni),
come gli incassi al
botteghino
siano
raddoppiati nel 2008
(però non dice che è
solo il 50 per cento di
quello della Corea del
Sud,
paese
infinitamente
meno
popolato), quanto il
presidente
della
Repubblica
popolare
cinese,
Hu
Jintao,
creda nel cinema. Poi
mi aspetto di sentire
qualcosa
sulla
“reciproca
collaborazione,
sull’amicizia
e
sul
rispetto tra Francia e
Cina”. Infatti, anche
queste parole arrivano
puntualmente.
ZhangXunèdavvero
convinta di quanto mi
dice? Tutte le sue frasi
sono vuote, i dati che
fornisce sono falsi, ma
lei lo sa? Ha il volto
dolce, quasi sincero,
della censura. Parla
con sicumera e finezza
ed è brillantemente
assecondata da un
efficace
interprete
(dopo l’incontro la mia
traduttrice mi dice che
infiorettava il discorso
in politichese della
burocrate).
Quando
parla di “coproduzioni”
è subito chiaro come
quel prefisso “co” sia
completamente
inappropriato: si tratta
di
produzioni
autorizzate dal regime
e
che
dunque
diventano
cinesi,
mentre per definizione
le
“coproduzioni”
coinvolgono due paesi.
Chiedo
poi
la
procedura usata per
stabilire la nazionalità
di un film, dato che
esistono
spesso
investimenti fatti da
più
produttori
internazionali. La sua
risposta
mi
lascia
perplesso: si basa su
Imdb, la banca dati
cinematografica
americana!
Capisco
allora che tutto questo
sistema non ha come
obiettivo la difesa di
valori specifici o la
tutela delle famiglie
cinesi, ma è anzitutto
una potente macchina
di
protezionismo.
Pongopoiunatimidae
banale domanda sulla
censura nel cuore
dell’edificio
per
eccellenza
della
censura
cinese:
“Ciascun paese ha un
sistema di censura”,
risponde
molto
delicatamente
senza
scomporsi Zhang Xun.
“Negli Stati Uniti è
ancora
più
rigido
rispetto alla Cina.
Abbiamo il diritto di
proteggere i nostri
giovanidallaviolenzae
dallapornografia.”
La sera stessa mi
trovo all’Hotel Konlun
di Pechino. Vale la
penaandarcisoloperil
bar del ventinovesimo
piano, circolare, che
offre
una
vista
incredibile
sulla
capitale cinese. Ad
aspettarmi c’è Peter
Loher, direttore della
Caa per la Cina. La
CreativeArtistsAgency
è una delle principali
agenzie
di
talenti
americane,
il
cui
compito è scritturare
gli attori del cinema,
ma anche i registi, gli
sceneggiatori,
i
cantanti, gli scrittori,
tutticinesi.PeterLoher
è sinologo, vive in Asia
da vent’anni ed è a
Pechino da tredici. È
un americano davvero
appassionato
della
Cina, e tra l’altro ha
sposatounacinese.
La strategia della
Caaèdiversadaquella
degli studios, per i
quali
comunque
l’agenzialavora,poiché
si
concentra
sugli
uomini e non sui
mercati. Il compito di
Peter Loher è siglare
contratti con il top dei
talenti cinesi e su
questo
fronte
l’operazione
è
perfettamente riuscita,
così come è riuscita ai
suoicolleghidiWilliam
Morris, l’altra agenzia
americana insediata a
Shanghai.
Contrariamente
agli
studios, che hanno
affrontato il sistema
dellaproduzionecinese
e
poi
della
distribuzione
trovandosi di fronte un
muro,
le
agenzie
stringono accordi con i
talenti locali. Non si
occupano di censura e
di quote di riserva, si
concentrano
sulle
persone che accettano
di legarsi a loro in
esclusiva
con
la
speranza
di
una
carriera
più
internazionale e la
promessa di contratti
più remunerativi (il
celebre metodo del
“packaging” di Caa
permetteaunattoredi
avere percentuali su
tutti i prodotti derivati
da un film). Dal canto
suo, l’agenzia intasca
inmediail10percento
di tutti i contratti
dell’artista. All’interno
di un mercato in cui
europei,
indiani
e
giapponesi
sono
assenti, gli americani
hanno
progressivamente
scritturato la maggior
parte
degli
artisti
cinesi che contano.
“Onestamente, non è
molto
complicato
lavorare
qui,”
commenta con aria
gioviale Peter Loher
(nondirànulladipiùa
registratore acceso, on
the record, non vuole
essere menzionato). In
Cina, le poche agenzie
di management degli
artisti sono spesso
legate agli studios e
allecasediscografiche,
e ciò produce notevoli
conflitti d’interessi di
cui le prime vittime
sono gli artisti stessi.
Questa è una delle
ragioni per le quali i
talenticinesitendonoa
legarsi a un’agenzia
americana.
Il lavoro certosino di
CaaeWilliamMorrisè
davveroefficacepoiché
gli agenti continuano a
lavorare sul campo per
preparare il mercato
perilmomentoincuila
Cina si aprirà. E gli
europei dove sono?
Nonnehomaivisti.
Resta dunque la
produzione
locale.
Felice Bee è una
bellissima
taiwanese
cresciuta in Indonesia,
indossa un lungo abito
nero che la protegge
dal freddo glaciale che
attanaglia
Pechino,
sorbisceuntèraffinato
all’interno del coffeeshop in cui mi ha dato
appuntamento.
Le
chiedosubitocomemai
siavenutainCinadopo
aver lasciato Taiwan.
“Perché
qui
c’è
mercato,”
risponde
senza esitazioni. “La
Cina è un sistema
culturale nuovo, non
c’ènulladifossilizzato,
tutto si muove, tutto è
possibile. Qui si scrive
il futuro.” Parliamo
della
strategia
di
Disney in Cina, poiché
halavoratoalungoper
Buena
Vista
International, il settore
di distribuzione di
Disney,
ma
voglio
sentirla
raccontare
soprattutto
della
produzione
locale,
poiché ha lavorato per
uno
dei
principali
produttori privati, il
gruppo Huayi Brothers
Pictures. In teoria,
giacché si tratta di un
gruppocineseconsede
a Pechino, non è
sottoposto ai vincoli
riservati agli stranieri.
“No,” corregge Felice
Bee,
“il
controllo
politicorestaintuttele
tappedelfilm,anchese
è prodotto da una
società
cinese:
è
necessario ottenere il
permesso sullo script,
ottenerne di nuovi per
ogni
modifica
e
naturalmente
sono
necessari permessi per
fare le riprese nelle
città in cui il film è
girato.” Fino a questo
momento,
i
miei
interlocutori americani
avevano
lasciato
intendere
che
i
produttori
cinesi,
anche
con
buoni
contatticongliufficiali
del governo, avevano
cartabiancaall’interno
del
sistema
neocapitalista cinese.
Ora, invece, mi rendo
conto
che
l’intera
industria
cinematograficaèsotto
controllo poiché è
considerata un settore
strategico dall’ufficio
della propaganda. Il
controllo,
per
definizione, si esercita
sulla trama. “In uno
script,”
prosegue
Felice Bee, “bisogna
far emergere il fatto
che un poliziotto è
sempre buono e un
delinquente è sempre
cattivo. Il primo non
può mai essere un
pessimo
padre
di
famiglia ed è fuori
discussione
che
il
secondo possa essere
un
padre
accorto.
Inoltre, dal momento
che non esiste un
rating system, come
negli Stati Uniti, tutti i
filmdevonorivolgersia
un pubblico di massa.
Questo
facilita
la
censura cinese e le
permette di proibire
qualsiasiscenadisesso
odiviolenza.”
Si possono prendere
dei rischi controllati
nel
campo
della
produzione
locale?
Universal e i fratelli
Weinsteinsisonomossi
su
questa
strada.
Questi ultimi, dopo i
gloriosi
anni
di
Miramax,
hanno
investitoinunufficioa
Hong
Kong
per
coprodurre
film
a
livello
locale
e
soprattutto acquisire i
diritti
di
film
promettenti. L’ufficio
asiatico di Weinstein
Company è diretto da
Bey Logan, un tipo
strano,
un
po’
sbruffone,
una
caricatura
dell’americano,
ma
parla cantonese. Lo
incontrosottocasasua,
al bar Lavande, nel bel
quartiere
Prince
Terrace di Hong Kong.
“Harvey Weinstein ha
sempre avuto un love
affair con l’Asia,” mi
dice Bey Logan. A
partire da successi
negli Stati Uniti di film
come La tigre e il
dragone di Ang Lee,
Infernal
Affairs
di
AndreiLaueAlanMak,
Hero e Il segreto dei
pugnali
volanti
di
Zhang
Yimou,
la
strategia dei fratelli
Weinstein ha portato
ad acquisire i diritti
internazionali
di
numerosi film cinesi e,
per
finanziare
l’acquisizione, hanno
creatounfondo“Asia”,
gestito dalla banca
Goldman Sachs. A
partire
da
questo
catalogo scelgono, a
seconda del pubblico
cuisiindirizzano,difar
uscireilfilmnegliStati
Uniti
oppure
di
limitarsi al mercato
regionalepoichéhanno
una buona rete di
distribuzione in tutta
l’Asia.
Sul
fronte
della
produzione locale, i
fratelli
Weinstein
hanno avuto meno
fortuna. “Il denaro non
è un problema in Cina
e a Hong Kong. Il
problema è trovare le
sceneggiature
di
qualità
capaci
di
conquistare un ampio
pubblico, scritturare le
star
con
forti
potenzialità,trovareun
buon
coproduttore
locale e poi riuscire a
lavorareconlacensura
a Pechino.” Bey Logan
sospira.
Per
il
momento, i fratelli
Weinstein
si
sono
limitati a produrre
Shanghai: film con un
budget di 45 milioni di
dollari,
distribuzione
interamente
cinese,
regista cinese, le cui
riprese
avrebbero
dovuto aver luogo a
Shanghai. In questi
piani, tuttavia, non era
stata
contata
la
censura che all’ultimo
momentoharifiutatodi
rilasciare il certificato
di
coproduzione
costringendo così la
troupe, già sui luoghi
delle
riprese,
ad
abbandonarelaCina.Il
film dunque è stato
spostato a Bangkok,
dove è stata ricreata
un’ambientazione che
dovrebbe richiamare la
Shanghai degli anni
quaranta. “Harvey è
rimasto sconvolto dalle
procedure cinesi, era
furioso,” conferma Bey
Logan.
“In
questo
affare abbiamo perso
3,4 milioni di dollari.”
L’uomo dei fratelli
Wenstein non sembra
dispiaciuto. È pronto a
lanciarsi in un nuovo
progetto. “Tutti gli
studios
americani,
grandi
e
piccoli,
vengono in Cina per
prendere una fetta
dell’immenso mercato
cinese e con strategie
che hanno senso sulla
carta, come la guerra
in Vietnam o in Iraq,
mainrealtàsirivelano
molto più complicate
quando ci si trova sul
campo.Peròilmercato
è così ampio e ha un
valore così strategico
che continuiamo a
provare, provare e
ancoraprovare.”
Un altro pretendente
al mercato cinese,
Universal, ha avuto
ancora meno fortuna.
La major si è lanciata
nella produzione del
film Lust, Caution del
regista taiwanese Ang
Lee, attraverso la sua
divisione
“indipendente” Focus
Features. Inizialmente,
gli
ufficiali
cinesi
hanno visto di buon
occhioilritornoinAsia
di
un
cineasta
importante
di
Hollywood, che ha
vinto l’Orso d’oro e
l’Oscar
con
Il
banchetto di nozze, La
trigre e il dragone e
piùrecentementeconI
segreti di Brokeback
Mountain.
Le
autorizzazioni per le
riprese erano state
rilasciate
dall’ufficio
della censura, che era
stato meno rigido sullo
script poiché i cinesi
eranofieridelsuccesso
mondiale de La tigre e
il dragone. Peraltro,
Universal
correva
rischi limitati poiché il
produttore locale era
noto ed era stato
suggerito dallo stesso
Ang Lee in quanto
sapeva
gestire
gli
“ufficiali”. Ma nelle
alte sfere, le cose non
sono andate così lisce.
Dopo essere stato
autorizzato, il film è
stato
ferocemente
condannato per le
scene di sesso troppo
esplicito e le allusioni
considerate “sensibili”
sui giapponesi. Alla
protagonistasonostate
vietateleintervisteeil
film è stato censurato.
Quella che avrebbe
dovuto
essere
la
consacrazione di un
figliodiTaiwantornato
inCinaèpoidiventata,
nonostante il clamore
della
comunità
internazionale,
una
dimostrazione
della
peggior
censura.
Inoltre ha suscitato un
inasprimento
delle
autorità di cui pagano
ancora oggi il prezzo i
cineasti indipendenti.
“È stata una vera e
propria Tienanmen per
l’industriadelcinema,”
conclude
in
tono
fatalistaFeliceBee.
Ancora
peggiore
delle disavventure in
CinadiColumbia,Sony
e Universal è stato il
caso
degli
studios
Warner.
Il furto dei multisala
Warner
Mentre discuto con
Ellen Eliasoph, penso
che
Warner
abbia
mandato in Cina la
migliore “sino-giurista”
in circolazione. Ellen
Eliasoph vive in Cina
da vent’anni ed è
sinologa,
parla
mandarino
e
cantonese, ed è una
navigata avvocatessa
specializzata in diritto
d’autore. Dirige gli
uffici di Warner Bros
nellaCinacontinentale,
mentresuomaritoèun
importante diplomatico
americano. Siamo al
ventitreesimo piano di
una
torre,
nel
complesso
ultramoderno
che
ospita anche il celebre
Grand Hotel Hyatt di
Pechino la cui piscina
zen
permette
di
rigenerarsi sotto un
“cielo virtuale” che
somiglia alla Via lattea
e con un sottofondo di
musica
sottomarina
detta
“neotropicale”
(come spesso accade
negli alberghi di lusso
asiatici, è un brano del
dj
Stephane
Pompougnac
tratto
dall’album
Hotel
Costes).
“Inizialmente, Time
Warner
era
molto
ottimista rispetto al
mercato
cinese,”
spiega Ellen Eliasoph.
“La nostra strategia
erainvestirenellesale,
distribuireinostrifilm,
organizzare
un’imponente vendita
dei nostri dvd e
reinvestire gli utili in
nuovi film coprodotti
localmente. In teoria si
trattava
di
una
strategia inamovibile.”
Il passo successivo
sarebbe
stato
l’insediamento
delle
emittenti televisive del
gruppo (Cnn, Hbo, i
canalicablatiTurner)e
ovviamente
la
diffusione delle più
importanti hit della
casa
discografica
Warner,
all’epoca
ancora di proprietà di
TimeWarner.
Il
settore
della
produzione locale di
WarnerhasedeaHong
Kong e fa circa un film
all’anno da una decina
dianni,ingranpartein
lingua mandarina. “Il
paradosso sta nel fatto
che in Cina non si può
produrre
un
film
cinese, allora viene
prodotto
a
Hong
Kong,” spiega Hsia
Mia, una giovane di
Hong Kong che ha
studiato alla Cornell
University negli Stati
Uniti e attualmente è
direttrice di Warner a
Hong
Kong.
Astutamente, Warner
gioca
su
diversi
mercati: il mercato di
Hong Kong, moderno,
occidentale,sesitratta
di un film a basso
budget; il mercato che
parte da Taiwan, se il
film
è
più
internazionale e punta
a un pubblico più
ampio su tutto il
continente; infine, il
mercato della Cina
continentale, quando
Warner punta su film
ad alto budget, con un
registafamosoealcune
star. “Si tratta di tre
settori di mercato
molto diversi tra loro.
Oggi
tendono
ad
avvicinarsi
e,
ovviamente, l’obiettivo
di Warner è giocare su
tutti
e
tre
contemporaneamente,”
conferma Hsia Mia,
durante una prima
colazione
in
un
ristorante alla moda al
pianoterra della torre
HsbcdiHongKong.
La
cosa
più
interessante, e la più
pericolosa, è stata in
ogni caso la strategia
di Warner per la
distribuzionenellaCina
continentale. Invece di
rimanereostaggiodelle
catene ufficiali che
gestiscono
le
sale
pubbliche,
Time
Warner ha avuto la
brillanteideanel1994,
nel momento in cui la
Cina si impegnava nel
processo di adesione
all’Organizzazione
mondiale
del
commercio e sembrava
aprirsi definitivamente,
di
investire
direttamente
nei
multisala.Percostruire
questesaleèraggiunto
un
accordo
con
l’organismo
ufficiale
China Film. Viene
creata
una
jointventure,
con
una
ripartizione
del
capitale
e
degli
investimentinell’ordine
del70percentopergli
americani e del 30 per
cento per i cinesi.
Nell’affare,
tuttavia,
erano
stati
sottovalutatiicinesi.
Anzitutto,ifunzionari
di
Pechino
hanno
comunicato a Warner
che aveva il permesso
di costruire multisala
in Cina, ma non era
automatico
che
vi
potesse proiettare i
suoi
film
poiché
vincolati dalla censura
edallequotediriserva.
Primadocciafredda.
Qualche mese dopo
arriva la ripartizione
del capitale delle sale
costruite:il70e30per
cento
pattuito
tra
americani e cinesi
viene modificato al
ribasso: 51 e 49 per
cento a beneficio degli
americani.
A
Los
Angeles, i dirigenti di
Warner lo trovano
strano.
Tuttavia,
accecati dalle loro
stesse illusioni, hanno
pensato che fosse una
questione “culturale”,
poichéicontratticinesi
erano molto “vaghi” e
quelli americani molto
“specifici”. Così hanno
continuato a costruire
cinema,
che
sono
dunque diventati otto.
Improvvisamente,
le
autorità cinesi hanno
deciso di cambiare di
nuovolaleggeehanno
decretato che una
società straniera non
può
avere
sale
cinematografiche
proprie
e
la
percentuale
del
capitale
è
stata
nuovamente cambiata:
49 e 51 per cento,
questa
volta
a
vantaggiodeicinesi.
“L’amministratore
delegato di Warner
Brothers,
a
Los
Angeles, è rimasto
letteralmente crushed
(annichilito),” confessa
Ellen
Eliasoph.
Nell’ufficio di questa
torre di Pechino in cui
parliamo da oltre due
ore cala un pesante
silenzio. Questa donna
forte, calma, bella, che
immagino
particolarmente
accanita
nelle
trattativefinanziarieha
le lacrime agli occhi.
“Abbiamo fatto tutto:
ideato
multisala,
progettato il design,
abbiamo speso milioni
di dollari, abbiamo
formato dei cinesi per
dirigerlie…lorohanno
cambiato la legge!
Tutto ciò per nulla. È
solo un brutto sogno.
Gli
studios
di
Hollywood sono stati
troppo ingenui con i
cinesi. Loro sono stati
più furbi, ci hanno
spinto ad aprirci, a
dargli il massimo e poi
si sono presi tutto per
sé. Sono stati molto
smart. Oggi non c’è
alcuna possibilità di
penetrare in questo
mercato.” Ritrovata la
calma aggiunge: “Non
bisogna scrivere un
libro sul cinema in
Cina, ma un libro sulla
corruzione del Partito
comunistacinese”.
Non ci sarà un nono
multisala Warner in
Cina. A Hollywood è
stato deciso di ritirarsi
completamente.
Le
altre major americane
hannoseguitodavicino
l’avventura e sono
rimaste
costernate.
L’esempio serva loro
dalezione.LaMpaa,la
lobby delle major a
Washington, comunica
quanto è avvenuto al
Congressoenelgirodi
breve tempo gli Stati
Uniti attaccano la Cina
di
fronte
all’Organizzazione
mondiale
del
commercio per aver
ostacolato il mercato
internazionale.
Alla
fine
dell’intervista
Ellen
Eliasoph è distrutta:
“Non ho nulla contro i
cinesi, sono un popolo
formidabile.
Ho
dedicato loro la mia
vita. Provo solo molta
amarezza contro il
potere”. Quantomeno
può
avere
una
soddisfazione: essendo
stata la prima a
costruire dei multisala
in Cina, Warner ha
lanciato una moda che
ha
cambiato
per
sempre lo scenario
cinematograficocinese.
Ormai, ogni giorno in
Cina si inaugura un
nuovo multisala. È una
consolazione
per
Warner?
Hong
Kong,
Hollywoodasiatica
la
“Abbiamo
1,3
miliardi
di
cinesi;
abbiamo
denaro;
abbiamol’economiapiù
dinamica del mondo;
abbiamo
esperienza:
riusciremo
a
conquistare i mercati
internazionali e faremo
concorrenza
a
Hollywood.
Diventeremo la Disney
della
Cina.”
Al
diciannovesimo piano
dellatorredivetroAig,
al
civico
1
di
Connaught Road a
HongKong,mitrovoin
unsaloneconmobilidi
lusso e tele d’autore
appese sui muri di
fronte a un’enorme
vetrata con vista su
Hong Kong e sul delta
del Fiume delle Perle.
Peter Lam, uno degli
uomini più potenti di
Hong Kong, mi riceve
con
cortesia
e
professionalità. Parla
chiaramente,
articolando
ogni
sillaba, quasi come se
avesse
imparato
l’inglese con uno di
quei
corsi
con
audiocassette,
tipo
Berlitz.
Lam proviene da una
delle grandi famiglie
della
città
ed
è
presidentedieSun,una
grande società molto
attiva
sul
fronte
cinematografico
e
musicale. Per quanto
siadiHongKong,parla
a nome della Cina, poi
ho saputo che è
membrodelCppcc,una
delle
componenti
politichepiùimportanti
della Cina comunista a
Pechino (una sorta di
Senatocinese).
È pronto a partire
all’assalto dei mercati
culturali occidentali. Il
suoobiettivoprincipale
è difendere “contenuti
cinesi”, secondo le sue
parole.“HongKongèil
porto dal quale la
cultura cinese può
partire alla conquista
del mondo,” conferma.
PeterLamènotoperle
sue buone relazioni
politiche a Pechino e
ha grandi ambizioni
perilsuogruppoeper
il suo paese. Mi
conduce in una sala
cinematografica
interna nella quale mi
mostra un breve film
aziendale per darmi
un’idea della potenza
economica del suo
gruppo (il film è
ridicolo,
di
pura
propaganda,
ma
efficace).
“Gli
americani non possono
più
continuare
a
svilupparsi.
Dove
possono raggiungere
una crescita a doppia
cifra?Danessunaparte
se non in Cina, ma in
Cina hanno fallito. Noi
invece
riusciremo.”
PeterLamdimenticadi
dire
che
per
il
momento il cinema
cinese e di Hong Kong
fa fatica a raggiungere
un
pubblico
non
asiatico e a superare i
cosiddetti
mercati
cinesi
“tradizionali”,
come Taiwan, Macao,
Singapore e i paesi del
Sud-est asiatico. Gli
faccio
questa
osservazione
e
mi
risponde
citando
Infernal Affairs, la
trilogia prodotta dal
suo gruppo, che ha
ottenuto un discreto
successointernazionale
nel 2002 e 2003 (ma
dimentica ancora di
direcheilremakefatto
da Martin Scorsese,
The Departed con
Leonardo Di Caprio e
Matt Damon, ha avuto
un successo molto più
ampio quattro anni
dopo).
Gli chiedo se sia
preoccupato
dalla
censura cinese che
rischiadicolpireanche
Hong Kong, ormai
ritornata alla Cina. “In
tutto il mondo c’è la
censura. Chi vuole
lavorare in Cina deve
accettarne le regole,”
spiega semplicemente
senza
la
minima
esitazione né il minimo
sorriso.
Gli
faccio
notare che la Cina si è
riappropriata di Hong
Kongnel1997,mache
la
sua
produzione
continua
a
essere
considerata
“straniera”, come se il
territorio fosse rimasto
indipendentesoloperil
cinema. Invece della
formula“unpaese,due
sistemi”, si tratta di
una politica del “due
pesi, due misure”.
Peter Lam annuisce
leggermente
senza
tornare
più
sull’argomento.
Il
gruppo
eSun,
grazie a importanti
studi che producono
una
decina
di
lungometraggi
all’anno, un settore di
distribuzione e centri
commerciali, decine di
negozi che vendono
dvd, è uno dei soggetti
chiave
dell’industria
cinematografica
in
Asia. È presente anche
nelsettorediscografico
con quattro etichette,
un’agenzia
di
management di artisti
e
un
settore
di
produzione
di
commedie
musicali.
“Hong Kong è la
capitale
dell’intrattenimento in
Asia,” spiega Gary
Chan Chi Kwong, che
dirige
la
divisione
musicale e le quattro
etichette del gruppo
eSun.
“Il
nostro
obiettivo
è
fare
sfondare i nostri artisti
qui a Hong Kong
perchéapartiredaqui
possano raggiungere
tuttoilSud-estasiatico.
Gliobiettivisonoanche
il mercato di Taiwan,
della
Malesia,
di
Singaporeesoprattutto
dellaCinacontinentale.
La cosa più difficile è
raggiungere
il
Giappone ed è quasi
impossibile arrivare in
India.” Gary Chan Chi
Kwong
prosegue:
“HongKongèunluogo
in cui si creano le
mode, un trendsetter
dell’Asia: chi vuole
avere successo, sia
esso della Cina, di
Taiwan o di Singapore,
devevenirequiaHong
Kong, questa è la
Hollywoodasiatica”.
È vero che Hong
Kong è riuscita a
mantenere
una
cinematografia
influente che produce,
con una popolazione di
7 milioni di abitanti,
tanti film quanti quelli
della Cina, che di
abitanti ne ha invece
1,3 miliardi. È una
città-regione con una
grande eterogeneità di
popolazione e di lingue
parlate;
vi
sono
tantissimi asiatici di
ogni nazionalità che ci
vivono senza permesso
di
soggiorno
(a
cominciaredaicittadini
di Taiwan che devono
transitarci per entrare
in Cina). A Hong Kong
c’è
davvero
la
sicurezza bancaria, la
Borsa è più debole
rispetto a quella di
Shanghai o Shenzhen,
le regole giuridiche
sono conformi alle
norme internazionali, i
diritti doganali e le
regolazioni
sono
limitate, è quasi una
zonafranca.Atuttociò
si aggiunge una rete
mediatica capace di
generare
un
passaparola in tutto il
continente asiatico e
leggi sul copyright
piuttosto
rigide,
mentreidirittid’autore
sono
costantemente
ignoratiinCina.Infine,
Hong Kong, secondo i
numerosi professionisti
che ho intervistato,
sembra non avere
conosciuto un aumento
significativo
della
censura dopo essere
tornatacinesenel1997
(invece l’autocensura è
più forte soprattutto
poiché l’obiettivo è
quello di conquistare il
pubblico della Cina
continentale, da qui la
particolarità dei film
prodottialivellolocale:
ne
esistono
due
versioni: la versione
Hong Kong e la
versione
“continentale”). Tutto
ciò contribuisce a fare
di questa singolare
città
una
capitale
dell’intrattenimento.
HongKongèunasorta
di Asia in miniatura –
così come Miami è
l’America latina in
miniatura e Il Cairo il
mondo
arabo
concentrato.
È chiaro che le
ambizioni della Cina e
di Hong Kong sul
frontedellaproduzione
dei “contenuti” sono
enormi. Ascoltando i
miei
interlocutori
all’interno del gruppo
eSun a Hong Kong ho
avutolasensazioneche
per loro fosse una
questione di orgoglio,
di
nazionalismo
culturale tanto quanto
una
questione
economica. La guerra
culturale è dichiarata,
ma in Cina nessuno sa
bene quali siano gli
obiettivi. La testata
culturalecineseèstata
lanciata, ma il regime
autoritario non ne ha
ancora
fissato
la
traiettoria. Per ora si
spinge a testa bassa,
per gli obiettivi si
vedràinseguito.
Di tutt’altra natura è
la
strategia
della
concorrenza,
ugualmente bellica e
sostenuta da un altro
grande signore del
capitalismo,
Rupert
Murdoch.
Come Murdoch ha
perso milioni in Cina e
trovatomoglie
“Just
imagine.”
Sembra lo slogan di
Nike, “Just do it”. È la
scritta incisa a lettere
dorate, all’americana,
su una parete di vetro
nel grande e lussuoso
salone d’ingresso della
sede
asiatica
del
gruppoStar,alcivico1
di Harbourfront, a
Kowloonb
(Hong
Kong).
Con
tutte
queste luci, le stelle di
“Star”chebrillanoele
scale in vetro, sembra
quasi di essere in uno
studio
di
Mtv.
Dall’ottavo
piano
dell’edificio, c’è una
vista incredibile su
Victoria Harbor e sul
Mar
Cinese.
Sono
invitato a prendere
posto all’interno di
un’immensa
sala
riunioni. Davanti a me
ci sono sette schermi
giganti e un grande
mappamondo.
Penso
che Rupert Murdoch
abbia sempre voluto
dominare il mondo.
“Justimagine.”
PaulAielloèilnuovo
uomo di Murdoch in
Asia, è un banchiere di
New York che vive a
Hong Kong da quindici
anni
ed
è
vicepresidente
della
banca First Boston, ha
lavorato per Morgan
Stanley,
è
stato
consulente
per
la
Banca mondiale. Mi
accoglie nel quartier
generale di Star Tv, di
cui è amministratore
delegato dal 2006. Ha
un’aria
un
po’
sospettosa di fronte a
me che vengo a fare
un’inchiesta sulla sua
azienda, ogni tanto
traffica con il suo
Blackberry all’ultimo
gridoedèaffiancatoda
Laureen Ong. Di primo
acchito, questa signora
mipareantipatica,una
diqueiPRcerbero.Poi,
invece,
nel
corso
dell’intervista si rivela
gentile e collaborativa,
proviene da “National
Geographic” e ha fatto
il resto della sua
carriera nel settore
della
televisione
sportiva negli Stati
Uniti ed è ormai
numeroduedelgruppo
Star.
Star
riunisce
sessanta
emittenti
televisive
in
sette
lingue che a partire da
Hong
Kong
trasmettono in tutta
l’Asia. “Potenzialmente
possiamo raggiungere
3miliardidipersonein
53 paesi dell’Asia,
quasi
metà
della
popolazione mondiale,”
spiega Paul Aiello,
riprendendo
una
famosa formula di
Murdoch (in realtà il
gruppo
Star
può
raggiungere solo, e
potenzialmente,
300
milioni di persone).
Star, che ha sede a
Hong
Kong,
rappresenta
per
Murdoch,
patron
globalizzato
della
multinazionale News
Corp, il corrispondente
asiaticodelgruppoSky
in Inghilterra e di Fox
negli Stati Uniti. È una
delle scommesse nel
settore audiovisivo più
audaci degli ultimi
vent’anni.
L’avventuracinesedi
Rupert
Murdoch
cominciaall’iniziodegli
anni novanta con un
semplice
obiettivo:
possedere una rete
televisiva in Cina. Il
miliardarioaustralianoamericano in questo
progetto ha investito
molto denaro, il suo
senso del pragmatismo
in affari e tutta la sua
guanxi
(termine
cruciale in Cina per
definire buoni legami
politici con il Partito
comunista
cinese).
Strada facendo ha
persomilionididollari,
hafallitoe,tuttavia,ha
trovatomoglie,Wendi.
“Dopotutto, il Partito
comunistacinesenonè
forse la più grande
camera di commercio
del mondo?” Siamo nel
1997. Rupert Murdoch
è fiero del suo “joke”
chefailsuobell’effetto
inunpranzoaPechino.
È sicuro di sé e ha
investitoinCinaconun
piano ben preciso.
Conquistare a suon di
denaroicomunistiche,
dall’epoca di Deng
Xiaoping,
vogliono
arricchirsi.Edidenaro
Murdochneha.
Murdoch punta su
Star, le cui iniziali
significano
Satellite
Television for the Asia
Region. Il gruppo è
stato creato a Hong
Kong nel 1991 e ha
cinquecanaliininglese
(tra cui Mtv Asia e il
segnale di Bbc World
Service). Star lo ha
velocemente
portato
alla notorietà ma è
stato un fallimento in
termini
finanziari.
Murdoch
versa
a
partire dal 1993 quasi
525 milioni di dollari
peracquisireilgruppo.
Asseconda
le
inquietudini
delle
autorità cinesi dando
loro
garanzie
e
accettando dal 1994 di
ritirare Bbc World
Service dall’offerta dei
suoi
programmi
satellitari, poiché il
governo cinese trova
che, dagli eventi di
piazza
Tienanmen,
l’emittente inglese non
sia abbastanza “giusta,
equilibrata e positiva”
quando
tratta
le
questioni
politiche
della Cina. Poco dopo
Murdochimponeanche
al suo gruppo inglese
Sky
maggior
“equilibrio” sulla Cina:
chiededidarelaparola
al
governo
cinese
quando è attaccato per
farsentireilsuo“punto
di vista”. Non è più il
caso di far vedere in
Inghilterra le immagini
del“TankMan”,l’uomo
che si è opposto ai
carri
armati
sulla
piazza Tienanmen e di
cui Sky, giustamente,
chiede notizie. Oppure
bisogna
essere
equilibrati e lasciare
che il governo cinese
possafornirelapropria
versione dei fatti. In
seguito,
per
compiacere il Partito
comunista
Murdoch
critica il Dalai Lama
con una celebre frase,
“Un vecchio monaco
chefailpoliticoevain
giroconscarpeGucci”,
e definisce la società
tibetana “autoritaria e
medievale”. In questo
modo,Murdochmostra
un tratto fondamentale
del suo personaggio:
pragmatismo assoluto
quandocisonoingioco
gli affari, anche a
scapito delle sue idee
politiche. In fondo, è
disposto ad accettare i
vincolicinesi,persinoil
controllo politico sui
suoi giornali e sui suoi
programmi,
a
condizione di poter
guadagnare denaro. È
più attento ai dollari
che alle idee e più
interessato ai profitti
che ai conflitti. Questa
filosofia,
le
sue
affermazioni e le sue
decisioni
suscitano
levate di scudi in
Inghilterra.
Per quanto possa
essere
prudente,
Murdoch
rischia,
tuttavia, di mettere in
pericolo tutto il suo
impero con una sola
frase. In occasione di
una festa a Londra per
lanciare una nuova
offerta del suo gruppo
Sky, nel 1993, in un
breve passaggio del
suo discorso, quasi
inavvertitamente,
si
mette a fare l’apologia
delle
televisioni
satellitari contro i
regimi totalitari: “I fax
hanno permesso ai
dissidentidiaggirareil
controllodapartedegli
stati sui media scritti;
le televisioni satellitari
permetteranno
alle
popolazioni dei paesi
chiusi,
avidi
di
informazione,
di
aggirare le televisioni
pubblicheufficiali”.
Questo messaggio,
rivolto alla piccola
cerchia di élite dei
media
inglesi,
fa
ovviamente il giro del
mondo in qualche ora,
e arriva anche a
ottomila chilometri di
distanza a Li Peng,
primo ministro cinese.
Quest’ultimo sa meglio
di chiunque altro che i
fax sono stati utilizzati
daglistudentidipiazza
Tienanmen per fissare
segretamenteipuntidi
ritrovo da cui far
partire
le
manifestazioni e da
questo momento cerca
di
prevedere
gli
obiettivi in Cina del
miliardario
occupandosi
personalmentedelcaso
Murdoch. Di fronte ai
colossali
mezzi
finanziari del magnate,
icinesireplicanoaloro
modoconarmipesanti.
Anzitutto, il primo
ministro
firma
direttamente
un
decreto, solo un mese
dopoildiscorsosu“fax
e satelliti” di Murdoch,
e proibisce le parabole
per captare televisioni
satellitari su tutto il
territoriocinese.Perla
diffusione
delle
emittenti televisive in
Cina,
da
questo
momento
viene
privilegiatoilviacavoe
non il satellitare. Poi
incarica
il
capo
dell’ufficio
della
propagandadiPechino,
direttamente legato al
Partito
comunista
cinese, di aprire un
fascicolo “Murdoch” e
di seguire i movimenti
e i progetti di questo
uomo d’affari a Hong
Kong e in Cina.
L’obiettivo è impedire
la spiritual pollution
(nel
linguaggio
di
partito sono i valori
antisocialisti
che
possono minacciare la
cultura cinese). Quel
giorno, Murdoch, come
dirà egli stesso, passa
dalla “watch list” alla
“blacklist”.
Il
fascicolo
su
Murdoch si riempie
poiché è un uomo i cui
mezzi sono all’altezza
delle ambizioni. Ha già
finanziato con grandi
investimenti un “new
media
center”
a
Pechino
e,
per
impressionarli,
ha
mandato decine di
persone
dell’establishment
cinese a visitare le
infrastrutture di Fox a
New York e di Sky a
Londra. Acquisisce poi
un
importante
quotidiano in lingua
inglese a Hong Kong,
finanzia
case
cinematografiche nella
città di Tanjin e per
compiacere la famiglia
presidenziale
fa
pubblicare negli Stati
Uniti le memorie di
Maomao, primogenita
di
Deng
Xiaoping
(attraverso
HarperCollins,
il
settore editoriale del
gruppo News Corp,
invitato a pubblicare il
libro senza badare a
spese – si dice che
Maomao
avesse
ricevuto un anticipo di
un milione di dollari).
La
tournée
promozionale
che
Murdoch
fa
organizzare
per
Maomao negli Stati
Uniti ricorda quella
organizzatadall’Unione
Sovietica per André
Gide.
La
stampa
americananonsilascia
tuttavia impressionare:
il “New York Times”
ridicolizza
l’autobiografia
non
appena
viene
pubblicata
considerandola
“un
testo di propaganda
indigesta,conunostile
letterarioscadente”.
Murdoch persegue
metodicamente i suoi
obiettivi. Si prende
affettuosamente cura
del figlio più piccolo di
Deng Xiaoping – una
persona con disabilità.
Finanzia
la
sua
associazione,
la
Federazione cinese per
le persone disabili e lo
accogliecontuttiisuoi
collaboratori per una
crociera sul suo yacht,
con trasporto gratuito
in
aereo
privato.
Murdoch prosegue poi
nel suo slancio: nel
1993
decide
di
trasferirsi
con
la
moglie e i figli in uno
dei palazzi più belli di
Hong Kong (ma sei
mesidopotornerannoa
LosAngeles).Nel1997
mette il veto alla
pubblicazione,daparte
di HarperCollins, delle
memorie critiche di
Chris
Patten,
ex
governatore di Hong
Kong,
per
non
contrariare le autorità
cinesi dopo la fine del
mandato
inglese
sull’isola e il ritorno
sotto
il
controllo
cinese.
Questa campagna di
compiacimento
a
trecentosessanta gradi
per un certo periodo
funziona, ma quando
Deng Xiaoping viene
allontanato dal potere
e gli succede Jiang
Zemin, Murdoch si
ritrova senza guanxi.
Nel frattempo, i cinesi
hanno cominciato a
confiscare oltre mezzo
milione di parabole,
cercando di limitare
l’influenza
delle
televisioni straniere in
generaleediStarTvin
particolare.
La controffensiva di
Murdoch si sviluppa
conunastrategiaintre
fasi.Anzituttodecidedi
dare a Star una veste
internazionale.
Non
riuscendo
a
raggiungereicinesisul
continente, si rivolge
agli asiatici di tutto il
mondo. Apre dunque
uffici in diverse zone
dell’Asia e oltre. Per
esempio, a Dubai ho
scoperto con sorpresa
all’interno della Dubai
Knowledge City un
ufficio di Star. “Star si
è insediata nel Golfo
per raggiungere gli
immigrati
cinesi,
indiani e pakistani che
qui sono numerosi. I
nostri
canali
trasmettono in lingua
hindi, mandarino e
inglese e tenuto conto
del numero di asiatici
emigrati hanno un
buon seguito. Ma qui a
Dubai non facciamo
nessun
programma,
abbiamo solo un sale
office per l’acquisto di
spazi
pubblicitari.
Questa è stata una
scommessa
di
Murdoch. È stato lui a
voleraprireunufficioa
Dubai per seguire la
zona del Golfo,” mi
spiega
Alis
Terb,
consulente
del
direttore di Star Tv a
Dubai.
Il secondo punto
della sua strategia
riguarda la musica, un
settore meno sensibile
rispetto
all’informazione.
Lanciando Channel V
all’interno dell’offerta
di Star, Murdoch ha
voluto creare in Asia
l’equivalente di Mtv. Il
piano è efficace ed è
giocato
sulla
promozione
di
contenuti locali per
conquistare un gruppo
eterogeneo.
Esiste
anche una versione di
Channel V destinata
alla Cina continentale,
prodotta in mandarino
a Taiwan, e con una
programmazione molto
locale, sotto stretto
controllopolitico.Peril
resto
del
mondo,
Channel V ha creato
una
versione
internazionale fatta in
inglese da Hong Kong,
a base di canto pop, e
più libera nei suoi
programmi. Le diverse
versioni hanno un
notevolesuccesso.
Il terzo punto della
strategiadiMurdoch,il
più
ambizioso,
è
avviato nel 1996 e ha
un nome significativo,
Phoenix. Con Phoenix
Murdoch
spera
di
rinascere dalle sue
ceneri.
Dall’ottavo
piano
degli uffici di Star a
Hong Kong si può
salire con una bella
scala di vetro al nono
piano dove ci sono gli
uffici di Phoenix. Le
due
emittenti,
simbolicamente
separate da questa
scala, si scambiano
contenuti, condividono
gli studi e testano
strategie differenti. Il
gruppo
Phoenix
trasmette oggi via
satellite da Hong Kong
trecanaliinmandarino
verso la Cina, frutto di
una joint-venture tra
Murdoch e l’uomo
d’affari cinese Liu
Changle.
I
suoi
detrattoriironizzanosu
questajoint-venture.
Nel 1996, la nuova
trovata di Murdoch è
pronta. Per Phoenix
deve però trovare un
partner con buoni
legami con il governo
cinese
per
poter
ottenere le necessarie
autorizzazioni
in
cambio
di
infrastrutture
satellitariedenaro.Liu
Changlesembraessere
l’uomo giusto. È figlio
di
un
influente
dirigente comunista ed
è stato nell’esercito
cinese,
il
famoso
People’s
Liberation
Army, dove è riservista
con
il
grado
di
colonnello.Inoltre,èun
autentico
uomo
d’affari, appassionato
di media (è stato un
giornalistamilitarealla
Radio centrale del
popolodiPechino)edè
un temibile mediatore
finanziariochehafatto
fortuna
piuttosto
misteriosamente con
raffinerie di petrolio a
Singapore
poi
nel
settore
immobiliare,
con autostrade, porti e
alberghi nella Cina
continentale.
Liu
Changle è la prova
persino
caricaturale
del
fatto
che,
all’interno
dell’“economia
socialista di mercato”
cinese, è possibile
avere ampie possibilità
commerciali quando si
hanno buoni legami
politici. Deciso ad
affrontare questo “Far
East”,
Murdoch
conoscel’importanzadi
avere una buona rete
dicontattiesapuntare
sugli uomini giusti.
Vede in Liu Changle
l’espressione
delle
tendenze della nuova
élite cinese: è un
ferventebuddhistaeun
imprenditore
multimilionario, è un
uomo frustrato dal
partito e nel contempo
è legato al sistema
comunista, è un uomo
d’affari senza scrupoli
e ha fatto studiare le
figlie in un’università
americana, è un uomo
di partito che esiste
graziealregimeenello
stessotempovuolefare
un giornalismo che
mina questo sistema
dall’interno:
queste
sono le condizioni del
suo
successo
personale. Murdoch si
impegna
affinché
Phoenix
resti
“politicamente neutra”.
Liu Changle è pronto a
collaborare per creare
la rete privata Phoenix
Satellite
Television.
L’affare
è
fatto:
MurdocheLiuChangle
hanno ciascuno il 45
per cento del nuovo
gruppo con sede a
HongKongequotatoin
quella
Borsa,
il
rimanente10percento
è
regalato
come
omaggio alla buona
volontà del governo a
Cctv, la televisione
ufficialecomunista.
Dal 1996, Phoenix
ottiene
le
autorizzazioni
necessarie per una
diffusione nella Cina
continentale,
per
ragioni non ancora
abbastanza chiare, ma
probabilmente relative
alritornoanticipatonel
1997 della regione
autonoma di Hong
Kong sotto il controllo
comunista cinese. Nel
giro di qualche mese,
con diversi canali in
mandarino, Phoenix fa
registrare un grande
successoinAsia.Èuna
televisione che con
talk-show, news live e
presentatori che fanno
veredomandeainvitati
“onair”sicontrappone
ai polverosi format
delle
televisioni
pubbliche cinesi. Good
Morning
China,
Phoenix
Afternoon
Express,
Newsline,
sono
alcune
delle
trasmissioni
di
successo della nuova
emittente, che prende
esempio dalla stazione
televisiva Fox negli
Stati Uniti, sempre di
Murdoch.
Il governo, ancora
unavolta,sipreoccupa
di limitare i rischi. Il
segnale di Phoenix è
autorizzato nella Cina
continentale solo negli
albergi dalle tre stelle
in su, nelle ambasciate
e in alcuni edifici
governativi.
Soprattutto,
Liu
Changle controlla che
Murdoch non diriga i
programmi
nella
redazione
dell’emittente. Per la
prima volta nella sua
vita, Murdoch è messo
in secondo piano e
accetta di disattendere
la regola che l’ha
guidatopertuttalasua
carriera:maigestireun
business che non si
controllainteramente.
Con l’11 settembre
2001, Phoenix diventa
indispensabile
come
era accaduto con le
due Guerre del Golfo
che
hanno
reso
indispensabili Cnn e Al
Jazeera. Mentre le
televisioni
ufficiali
cinesi si limitano a un
breve annuncio sugli
attentati terroristici di
New York in attesa
delle posizioni ufficiali
del partito e della sua
autorizzazione
a
diffondere le immagini
–
ci
vorranno
ventiquattr’ore prima
di essere mandate in
onda
–
Phoenix
trasmette
continuamente
le
immagini e rivoluziona
il palinsesto per essere
in diretta per cinque
giorni da New York.
Migliaia di cinesi si
precipitano
negli
alberghiperseguiregli
avvenimenti.
Nonostante il divieto,
l’acquisto di parabole
illegali
aumenta,
cominciano a spuntare
dappertutto in Cina, e
piùcisiallontanadalla
capitale
politica
Pechino,
più
sono
numerose. Nel corso
delle mie inchieste in
Cina,
ho
potuto
constatare che era
possibile
acquistare
una buona parabola
per circa 3000 yuan
Rmb (intorno ai 300
euro). Secondo i miei
diversi
interlocutori,
milioni di cinesi hanno
accesso alle televisioni
straniere via satellite.
Talvolta, viene messa
sopra un edificio una
parabola più grande
che fornisce tutti gli
appartamenti
del
quartiere
–
un
fenomeno
completamente illegale
e
visibilmente
generalizzato. Spesso,
in modo del tutto
legale, le reti locali
cablate,
che
sono
pubbliche, intercettano
il segnale di Phoenix
via satellite e lo
ritrasmettono
all’interno della loro
offerta
per
avere
un’audience maggiore.
Per il momento le
autorità di Pechino
lasciano fare e anche
Phoenix tollera questa
pirateria
senza
chiedere contropartite
per aumentare il suo
pubblico e la sua
influenza.
Con Phoenix, con la
strategia
della
decentralizzazione, con
il
commercio
di
parabole illegali, con
accordi obsoleti e con
la fame di denaro del
“capitalismo di stato”
cinese, Murdoch ha
fatto grandi passi in
avanti, ma non ha
ancoravintolaguerra.
“In Cina, ogni giorno
abbiamo 180 milioni di
telespettatori.”
Il
vicepresidente
di
Phoenix, Roger Uren,
un affabile australiano
che mi fa visitare gli
studi
dell’emittente
nella sede di Hong
Kong, mi rivela con
calcolata noncuranza
un dato prezioso: “180
milioni”. È la prima
volta
che
sento
pronunciare un dato
così preciso. Nessuno
sasesiavero,neanche
Roger Uren. Di sicuro,
la direzione di Phoenix
ha interesse a fornire
dati elevati del proprio
pubblico
per
alimentare il mercato
pubblicitario, ma può
anche
volerlo
diminuire, per evitare
misure di ritorsione da
parte della censura.
Traquestidueestremi,
il dato è comunque
plausibile.
Ufficialmente,
naturalmente, Phoenix
Television raggiunge
solo
centinaia
di
migliaia
di
turisti,
diplomatici e ufficiali,
poiché si limiterebbe a
una diffusione negli
alberghi
e
nelle
ambasciate.
Tutti
sembrano stare al
gioco
di
questa
illusione.
Incontrando
i
giornalisti,
i
presentatori
e
il
personale di Phoenix,
tutti
indaffarati
all’interno di locali
sovrappopolati, capisco
il
successo
dell’emittente. Phoenix
è
una
televisione
moderna e giovane,
innovativa e audace,
nonostante i rischi
politici che corre e i
pochi mezzi finanziari.
Wang
Ruolin,
per
esempio, si appresta a
presentare
una
trasmissione quando la
incontro nella sala
truccocheèdifrontea
uno dei tre studi di
Phoenix.
Ha
soli
venticinque
anni,
indossa una maglietta
bianca aderente e ha
un taglio di capelli che
ricorda
quello
dei
presentatori hip hop di
Mtv,emidicediessere
specializzata
nel
“infotainment”; Sally
Wu, invece, reclutata a
Taiwan,
è
un’annunciatrice
del
telegiornale
particolarmente
telegenica,impeccabile
e magra, ha una voce
soave che la rende
incredibilmente
affascinante, mi dicono
che milioni di studenti
cinesi sono innamorati
di lei; infine Dou, che
vedo in un ufficio open
space,midicediessere
assistente del primo
talk-showtelevisivogay
mai prodotto in Cina.
Siamo ben lontani da
“presentatori
dinosauri” e da un
politichese monotono e
austero di emittenti
ufficiali fatto di “no
sex, no violence, no
news”, la regola d’oro.
Ma la gioventù e la
libertà hanno alcuni
limiti.
“Si
fanno
molte
concessioni per non
urtare
troppo
direttamente
la
censura,”
confessa
Roger Uren. “Ci si
concentrasuifatti,non
si provoca il regime,
siamo
un’emittente
cinese.AncheseStarè
un
canale
molto
occidentale,
siamo
attestatisoprattuttosul
locale.”
Queste
concessioni hanno un
costo:
talvolta
su
Phoenix si vedono
programmi che fanno
l’apologia delle misure
economiche prese da
alcune province (anche
se
unanimemente
screditate); si racconta
la meravigliosa vita di
Deng
Xiaoping;
si
intervista il ministro
della Sanità qualche
ora prima di essere
dimesso
per
aver
nascosto l’epidemia di
Sars; si accusa il Dalai
Lama e non viene fatta
alcuna menzione di
piazza Tienanmen. I
detrattori di Murdoch
considerano
Phoenix
un’emittente la cui
propaganda
è
semplicemente
più
sottile di quella delle
trasmissioni
ufficiali
cinesi.
Anche se articolata,
lastrategiadiMurdoch
comincia a risultare
chiara: con Star, il
magnate dei media ha
giocato sul terreno
dell’intero continente
asiatico tentando di
aprire, dall’esterno, il
paese alle influenze
internazionali
e
prendendo in parola la
Cinasulsuobisognodi
modernizzarsi;
con
Phoenix, ha giocato sul
terreno
interno,
cercando
di
compiacere le autorità
cinesi, ed è riuscito a
penetrare nel mercato
giocandosullesuezone
d’ombra e aumentando
il suo pubblico nelle
“chinatown”delmondo
intero che preferiscono
Phoenix alle emittenti
ufficialidellaCctv.
Negli uffici di Star,
l’amministratore
delegato Paul Aiello
naturalmente
non
confessa ciò che il
vicepresidente
di
Phoenix mi ha detto al
piano di sopra. Il mio
interlocutore parla con
prudenza, senza dire
né troppo, né troppo
poco. “Dato ciò che
siamo e ciò che
rappresentiamo,
possiamo agire in Cina
solo in modo legale
(through the front
door). Non possiamo
lavorare nella zona
grigia (the grey area)”.
In Cina, la zona grigia
è il territorio opaco tra
legale e illegale, tutto
ciòcheètolleratodalle
autorità cinesi senza
essere
formalmente
messo
al
bando.
Phoenix
gioca
su
questo
terreno
tentando di spostare
più in là i confini della
zonagrigia.AncheStar
fa lo stesso gioco, ma
senza
riconoscerlo
ufficialmente (come se
le parabole potessero
permettere di captare
Phoenix e non Star).
Nessuna delle due
strategie è realmente
sufficiente,macercadi
prendere la Cina dai
due lati, in e out, e in
questo modo Murdoch
ha
ottenuto
dei
risultati,
che
generalmente i suoi
detrattori
non
gli
riconoscono.
Ma,
soprattutto,
strada
facendo ha trovato una
nuovamoglie.
Wendi Deng, cinese,
alta,
attraente
ed
entusiasta,nel1997ha
ventinove anni, ha
conseguito un Mba
(Master in Business
Administration) a Yale
e da qualche mese sta
facendounostagenella
sede di Star a Hong
Kong. Parla un inglese
fluente e la sua lingua
madre è il mandarino
(mentre la maggior
parte dei dipendenti di
Star parla cantonese,
la lingua di Hong
Kong).Perunaseriedi
circostanze
diventa
l’interprete di Rupert
Murdoch. In questo
periodo il magnate sta
vivendo una crisi nel
suo
secondo
matrimonio.
Trova
questa giovane cinese
affascinante e confida
al
suo
principale
assistente: “Quando si
comincia ad avere una
certa età, è importante
circondarsi di persone
giovani, gente con
nuove idee, piene di
energia
e
di
entusiasmo. Fa bene,
rivitalizza”. Poco dopo
comincia una relazione
con
Wendi
che
diventerà presto la sua
terzamoglie.
Wendi
Deng
Murdoch
ha
un’influenza decisiva
su Murdoch e lo
sostiene
nella
sua
nuova – e ultima –
avventurainCinadallo
strano
nome
di
ChinaByte. Il magnate
dei media spera di
vincerelasuabattaglia
in Cina attraverso
internet e, ancora una
volta, prende tutti in
contropiede,
a
cominciare dai cinesi.
Ancor
più
delle
televisioni satellitari,
internet ha subito
costituito un grande
problema
per
le
autorità comuniste per
la sua capacità di
mettere in pericolo il
controllo assoluto del
partito. Inizialmente, il
governo ha pensato di
“vietare il web”, ma si
è poi reso conto che le
misure
tecniche
e
repressive erano poco
efficaci sul controllo
dei
contenuti.
Soprattutto le autorità
hanno
dovuto
affrontare un dilemma
impossibile
da
risolvere:
frenare
internet
significava
frenare l’economia e
significava
dunque
perderelapossibilitàdi
giocare ad armi pari
conStatiUniti,Europa,
Giappone e India. Per
la
prima
volta,
controllo politico e
sviluppo
economico
sembrano avere strade
opposte. Nel corso di
un decennio, internet
in Cina ha raggiunto
200 milioni di utenti e
50milionidiblog.
Murdoch
sfrutta
queste contraddizioni
con incredibile abilità.
Dal 1995 decide di
investire sul web in
Cina e lo fa alla sua
maniera,
bluffando.
Ormai
sa
come
compiacere gli uomini
del sistema e prende
accordi
con
i
responsabili
del
quotidiano ufficiale del
Partito comunista per
creareunajointventure
per avviare un sito
comune per il quale
assicuraleautoritàche
sarà tecnologicamente
all’avanguardia
e
affidabile sul piano
politico.
A
queste
condizioni il governo
cinese accetta, ma
impone che il sito di
Murdoch passi per un
fornitore
d’accesso
ufficiale
cinese,
Chinanet. All’epoca il
numero
dei
frequentatori
di
internet in Cina era
meno
di
duecentocinquantamila.
Murdoch
coglie
l’opportunità, ma non
riesce a ottenere la
connessionepoiché,nel
frattempo, nel gennaio
1996, il primo ministro
cinese annuncia la
proibizione assoluta di
internet con il motivo
ufficiale di “lottare
contro la pornografia”
(sembra
che
un
“compagno” dell’ufficio
della propaganda che
aveva
installato
Windows95acasasua
fosse capitato su un
sito pornografico). I
controlli aumentano e
le società di internet
devono ottenere nuove
autorizzazioni speciali.
Dopo alcuni mesi di
trattative,
Murdoch
ottiene la licenza per
avviare
il
sito
chinabyte.com, tuttavia
siponesubitounnuovo
problema: il progetto
economico del sito si
basa sulla pubblicità e
la sua società non è
autorizzata
a
commercializzare spazi
pubblicitari poiché non
ci sono soci cinesi al
suointerno.
A un anno dalla
nascita, il sito ha
finalmente tutte le
autorizzazioni formali
per essere avviato, ma
continua
a
non
ottenerelaconnessione
di accesso a internet.
Doponuovetrattativee
sette mesi più tardi,
Murdoch ottiene una
connessione di 28 K
pagando
un
abbonamento mensile
di ventiduemila dollari.
IdetrattoridiMurdoch
sogghignano di questa
disavventura
e
sostengono che, a
questi costi, stava
sovvenzionando
lo
sviluppo di internet in
tuttalaCina.
Nel gennaio 1997,
chinabyte.com
è
ufficialmente avviato
con le felicitazioni del
governo cinese e una
straordinariacopertura
mediatica
internazionale.Nelgiro
di
qualche
mese
diventa il primo sito
cinese.
Ormai
sostenuto dalla nuova
moglie, ufficialmente
responsabile
di
internet all’interno del
gruppo Star, Murdoch
cominciaamoltiplicare
le partecipazioni – e
ancheirischi.
Crede più che mai
alle sinergie all’interno
del
suo
gruppo
interamente costruito
sul
modello
della
concentrazione
verticale: di un film,
tratto da un libro edito
da
HarperCollins,
prodotto dalla 20th
CenturyFox,trasmesso
dalla televisione Fox
negli Stati Uniti, da
Sky in Inghilterra e
Star in Asia, riesce ad
avere una copertura
importante
con
il
“Time” e il “Sun” a
Londra e il “New York
Post”negliStatiUnitie
nelladecinadimediae
di compagnie raccolte
sottoNewsGroup.Con
Titanic nel 1997, a
Murdoch
riesce
un’impresa da maestro
–inCina,èuncolpodi
genio.
Con l’aiuto di Wendi,
Murdoch riesce infatti
a
convincere
il
presidentecineseJiang
Zemin ad assistere a
una proiezione privata
di Titanic, prodotto
dalla sua 20th Century
Fox.
Il
leader
comunistaèaffascinato
dalle avventure di
questo
adolescente
poverochesiinnamora
di una ragazza ricca e
muore per salvarla;
apprezza gli effetti
speciali del film e
ancora di più il suo
successo commerciale
planetario.
Qualche
giornodopo,fattoraro,
firma lui stesso una
critica del film sul
quotidiano comunista
ufficiale: “Invito i miei
compagni dell’ufficio
politicoavedereilfilm,
non per promuovere il
capitalismo, ma per
aiutarci
ad
avere
successo.
Non
dobbiamo credere di
essere gli unici a
sapere come si fa
propaganda”. Murdoch
considera l’articolo un
complimento, ma si
tratta di fatto del
programmastabilitoda
Jiang Zemin per i
quadri “culturali” del
partito: la Cina deve
mettersi al lavoro,
ricostruire
le
sue
obsolete
industrie
culturali e battere
Hollywood sul suo
stesso terreno. La
critica al film ha il
valorediundecretoeil
presidentecinesedàgli
ordiniperaccoglierela
sfida e costruire una
potente
industria
cinematografica.
Cogliendo l’invito del
presidente
cinese,
Murdochorganizzauna
serie di proiezioni per
l’intero ufficio politico
del Partito comunista
cinese e invita anche i
responsabili
della
censura.Tremesidopo
ottiene il permesso di
far uscire Titanic in
Cina con un numero
elevato di copie, cosa
che
sarebbe
stata
impossibile
senza
l’articolo
di
Jiang
Zemin. Titanic diventa
così il più grande
successo
cinematografico
straniero di tutta la
storiadellaCina.
Murdoch crede di
essersi riconquistato le
grazie in Cina. Spera
così di ottenere in
cambio l’abrogazione
del
divieto
sulle
parabole e più libertà
per internet. Ormai,
Murdoch
dice
pubblicamente
che
Star, fino a ieri un
networkditelevisionia
pagamento, diventerà
la prima piattaforma
multimediale asiatica.
Chiede a Wendi e al
figlio James Murdoch,
diventato responsabile
diStaraHongKong,di
acquistare una ventina
di siti internet cinesi e
indiani, acquisiti per
circa 150 milioni di
dollari.
Ancora una volta
hanno fatto i conti
senza
l’oste.
Le
autorità
comuniste
autorizzano
la
trasmissionenellaCina
continentale
della
versione in mandarino
di Star, ma il canale è
accessibile solo sulla
rete cablata di una
lontana
provincia
cinese in cui gli
abitanti
parlano
soprattutto cantonese.
In cambio, Murdoch
deve
concedere
l’accesso di tutto il
pacchetto
di
reti
cablate
americane,
aprire
alla
nuova
emittente
ufficiale
dell’informazione
continua in inglese,
una sorta di Voice of
China. L’offerta non è
negoziabile.
C’è
di
peggio.
Murdoch
si
rende
conto che la maggior
parte dei programmi
televisivi di successo
trasmessi da Star e da
Phoenix è clonata e
ritrasmessa,
talvolta
semplicemente tradotti
in mandarino e a
dispetto delle leggi
contro la pirateria,
dalle
televisioni
nazionali
che
li
rivendono
facendo
concorrenza a Star. In
caso di controversie
legali, i tribunali cinesi
danno sempre ragione
alle
televisioni
governative.
Un
problema simile si
propone anche con il
sito
internet
di
Murdoch. I siti pirata
sono
addirittura
realizzati da persone
assunte
dal
proprietario di News
Corp e nei suoi stessi
uffici. Così, il sito
originale ha qualche
centinaia di migliaia di
visite, mentre il sito
clonato, pubblicizzato
da televisioni e stampa
ufficiali,
supera
i
diversi milioni. Con
l’esplosione di internet
e le tensioni con i
partner ufficiali cinesi
di altri siti web,
Murdoch decide di
ritirarsi da questo
mercato. E ben presto
anchedallaCina.
“Murdoch ci chiama
ancora spesso,” mi
spiega Paul Aiello.
“Talvolta alle quattro
del mattino perché
dagli Stati Uniti si è
sbagliato
sul
fuso
orario.
La
cosa
formidabilediMurdoch
è il suo entusiasmo.
Non guarda mai al
passato e agli errori.
Mi dice ‘what’s next?’.
Ormaiinternetèlasua
ossessione.
Pensa
sempre al futuro. Non
accettamaichelecose
stianoferme.”
Eppure è proprio in
una situazione di stallo
con Star in Cina.
Rupert Murdoch, che
PaulAiellomidefinisce
“hands
on”,
direttamente coinvolto
negli affari, sembra
aver abbandonato il
suogiochinocineseper
preferirglialtresfide:il
“Wall Street Journal” o
MySpace,
recentemente acquisiti
negli Stati Uniti, e
soprattutto l’India che
sembra preferire alla
Cina.
Oggi, se il gruppo
Star ha una reale
influenzainIndia,dove
realizza il 70 per cento
delsuogirod’affariea
Taiwan, in cui le sue
emittenti
sono
dominanti,deveancora
sfondare sul mercato.
ConStar,Murdochnon
è riuscito ad avere
l’emittente televisiva
che
sognava;
di
Phoenix non ha né il
controllo finanziario,
né quello editoriale
(per questo di recente
ha venduto metà delle
sue quote all’operatore
telefonico
pubblico
cinese).“Sevuolefarmi
dire che il nostro
ingresso sul mercato
cinese è stato un
fallimento, dico che è
stato un fallimento,”
afferma Aiello. Anche
Murdoch, in occasione
di una conferenza, non
nasconde
le
sue
perplessità di fronte
all’avventura
cinese:
“Non è andata molto
bene
in
Cina.
Dobbiamoesseremolto
umili. Tutto ciò che
posso dire è che
nessuno, dico nessuno,
dei gruppi di media
americani o inglesi è
riuscitoaconquistareil
mercato cinese. È un
mercato molto vasto,
maèunmercatomolto
sensibile,
davvero
molto sensibile. È un
mercato molto difficile
perglioutsider”.
Nell’agosto2009,con
una decisione molto
attesa,
l’Organizzazione
mondiale
del
commercio,
spinta
dagli Stati Uniti nel
2007, ha decretato a
Ginevra la violazione
da parte della Cina
delle
regole
del
commercio
internazionale
limitando
l’importazione di libri,
materiale
multimediale, dischi e
film. Il lassismo cinese
sulla pirateria e il
mancato rispetto delle
leggi internazionali sul
copyright sono stati
sanzionati.
Ma
indipendentemente
dalle
conseguenze
della
decisione
–
Pechino
ha
fatto
ricorso –, sembra che
gli americani abbiano
per
il
momento
dimenticatolaCina.
In questi ultimi mesi
gliufficidellaWarnera
Pechino e di Columbia
a Hong Kong hanno
chiuso.Disneycontinua
ad aspettare il via
libera per costruire il
suo parco tematico a
Shanghai.
Google
minaccia di ritirarsi
dalla Cina. L’ex patron
di Warner di quella
area,EllenEliasoph,fa
l’avvocato per una
società americana e
vive sempre a Pechino.
Barbara Robinson ha
abbandonato Columbia
e continua a vivere a
Hong Kong. Peter
Loher
continua
a
scritturare artisti locali
in attesa che la Cina si
apra.
Paul
Aiello,
amministratore
delegato di Star, ha
annunciato
le
sue
dimissioni
da
presidenteeunripiego
strategico del gruppo
da Hong Kong verso
Mumbai.
Scossi dai ripetuti
fallimentiinCina,dalla
censura, dalle quote di
riserva, dai diritti di
percentuale
e
dal
capitalismo autoritario
del “due pesi e due
misure”, gli americani
hanno un nuovo piano:
dirottare
gli
investimenti nell’Asia
dell’Est e nell’Asia del
Sud.
In
pratica,
abbandonano la Cina
per dirigersi su un suo
concorrente,
l’India.
Invecediunmercatodi
1,3 miliardi di cinesi,
gli americani sono
prontiadaccontentarsi
di un mercato di 1,2
miliardi di indiani.
Dopo tutto, è sempre
unpaese,comedicono,
la cui popolazione è
nella categoria “Billion
+”(oltreunmiliardo).
Nel marzo 2009, la
Motion
Pictures
Association ha aperto
un ufficio in India. Gli
studios Disney, Warner
Bros,20thCenturyFox
e Paramount hanno
aperto uffici a Mumbai
e
cominciano
a
produrre
film
localmente.
Mtv
decolla in India. Le
serie
prodotte
da
Colors, emittente di
Viacom, hanno un
grande
successo.
Perchéallora,invecedi
Kung Fu Panda non
fare The Millionnaire?
Gli americani sono
sempre alla ricerca di
una nuova frontiera e
di un nuovo mondo, la
nuova Cina ormai si
chiamaIndia.
10.
ComeBollywoodvaalla
conquistadelmondo
“Se
per
una
settimana
non
mi
faccio vedere all’Hotel
Marriott,
la
gente
pensa che io abbia
smesso di lavorare,”
dice con ironia Uday
Singh,ilpatrondiSony
India. “Quando sono al
Bbc, uno dei bar del
Marriott, tutti sanno
che sto preparando un
film, sanno con quali
attori e con quale
regista girerò,” spiega
dal canto suo il
produttore
indiano
BobbyBedi.
A Bollywood, ogni
generazione del mondo
del cinema ha il
proprio
hotel
di
riferimento.
Prima
c’era il Juhu Hotel,
ormai scalcinato, sulla
spiaggia di Juhu, a
Mumbai, capitale del
cinemaindianoenuovo
nome di Bombay; in
seguito la “scena” si è
spostataalSun-n-Sand,
unlussuosohotelpiùa
nord.Lemodesonopoi
cambiateancoraeoggi
la
passione
dei
professionisti
del
cinema per i meeting,
delle star di Bollywood
per le feste e le
esigenze dei giornalisti
di intervistare le star,
hanno portato tutti
all’Hotel Marriott, un
palazzoacinquestelle,
ultrachic,
anonimo,
collocato a Juhu tra il
quartiere alla moda di
Santa Cruz, a sud, e
FilmCity,glistudiosdi
Bollywood, a nord di
Mumbai. Nei sette bar
e
ristoranti
del
Marriottc’èunafolladi
produttori, distributori,
agenti e attori che si
agitano per dar vita ai
prossimi
film
commerciali
di
Bollywood.
Tutti
parlano in inglese su
un
sottofondo
di
musicaloungeBuddha-
Bar.
Amit Khanna mi ha
invece
dato
appuntamento
a
MumbaialSun-n-Sand,
a cui resta legato, e
lontano dal mondo
delle feste. Questo
hotelcheraccoglievail
mondo di Bollywood
offre una vista sulla
spiaggia
di
Juhu
decisamente più bella
di quella offerta dal
Marriott,epuressendo
un edificio desueto e
un
po’
vecchiotto
continua
a
essere
frequentato
dalle
storiche famiglie della
città.Mentreattendoal
bar dell’hotel, le casse
diffondono di continuo
l’ultimo album dei
Coldplay.
Improvvisamente
arriva
Khanna,
in
ritardo,
con
due
telefoni cellulari a cui
risponde sempre in
quindici secondi a ogni
telefonata che riceve.
Amit Khanna indossa
un abito all’antica, è
calvo, è serio e
risponde velocemente
alle domande, con
autorità, senza alcuna
giovialità
e
senza
fornire dettagli. Le sue
parole
sono
centellinate. “Qui ci
sono 1,2 miliardi di
abitanti.Abbiamosoldi.
Abbiamo conoscenze.
Con il Sud-est asiatico
rappresentiamo
un
quarto
della
popolazione mondiale,
con la Cina un terzo.
Vogliamo avere un
ruolo da protagonisti,
sul
piano
politico,
economico, ma anche
culturale.Crediamonel
mercato globale e
abbiamo valori da
promuovere,
quelli
dell’India,
vogliamo
affrontare Hollywood
sul suo terreno. Non
solo per guadagnare
soldi,maperaffermare
i nostri valori. E sono
profondamente
convintochesaremoin
grado di riuscirci.
Dobbiamo
contare
anzituttosunoistessi.”
Da quando sono
arrivato
in
India,
nessuno mi aveva mai
parlato
in
questi
termini. Finora i miei
interlocutori avevano
mostrato
grande
cortesia
nei
miei
confronti e spesso, per
via del fatto che fossi
un occidentale, forme
di rispetto e di umiltà
per
me
sempre
imbarazzanti.
Amit
Khanna, invece, non si
fa alcuno scrupolo. Ha
uno sguardo sicuro, di
chiosservaunfrancese
come me come se fossi
ilmembrodiunpiccolo
popolo in via di
estinzione,
ha
lo
sguardo del dominante
sul dominato, l’esatto
contrario di quello che
hanno i guidatori dei
risciò, i barbieri, i
lustrascarpe, i chai
wallahs(servitoriditè)
che si incontrano in
India, gente sempre
intimidita che continua
adirti“Yes,sir”.
Amit
Khanna
è
l’amministratore
delegato di Reliance
Entertainment,
una
delle
multinazionali
indiane più potenti nel
settore delle industrie
creative e dei media. Il
gruppo appartiene al
multimiliardario Anil
Ambani, cinquant’anni,
sestouomopiùriccoal
mondo, imprenditore
nella distribuzione di
gas ed elettricità e nel
settore
delle
telecomunicazioni,
mentre suo fratello
Mukesh Ambani – con
il quale è in guerra –
mantiene il controllo
delle
aziende
di
famiglia
centrate
sull’industria pesante:
settore petrolchimico,
raffinerie di petrolio e
grande distribuzione.
Dei due fratelli, Anil è
quello più “culturale”,
è amico della star
AmitabhBachchaneha
sposato un’attrice di
Bollywood,
facendo
vacillare i codici della
castaacuiappartiene–
quella dei mercanti, i
banias.
“La nostra strategia
si
basa
sulla
costituzione
di
un
gruppo
interamente
indiano, integrato, di
nuova
generazione,”
spiega Amit Khanna.
“Ciò
significa
che
intendiamo
essere
presenti,nelcontempo,
sututtiglischermiein
tutti i settori. Grazie al
controllo di Reliance
Telecommunications,la
prima in India nella
telefonia mobile con
sessanta milioni di
abbonati, controlliamo
gli schermi più piccoli,
mentre con la nostra
catena di multisala,
una
delle
più
sviluppate in India,
disponiamo
degli
schermi più grandi.
Possiamo
dunque
produrre contenuti per
tutti questi tipi di
schermi.
Inoltre,
forniamo l’accesso a
internet a ventimila
città
e
quarantacinquemila
villaggi indiani dove
possiamo far arrivare
musica
e
cinema.
Hollywood è l’industria
cinematografica
del
Ventesimo secolo, noi
stiamo
invece
costruendo quella del
Ventunesimo.”
Il gruppo Reliance è
già uno dei colossi
dell’industria
dei
contenuti e dei media.
Controlla, infatti, una
delle principali case
cinematografiche
di
Hollywood, una rete di
venti canali televisivi e
quarantacinque
stazioni radio (Big Tv,
Big Fm), una delle
principali
reti
di
multisala in India (Big
Cinemas), una casa
discografica
specializzata
nelle
canzoni di Bollywood e
siti web in posizione
monopolistica. In India
è un gruppo “Big”, del
resto in questo paese
tutto ha proporzioni
“giganti”. Anzitutto il
Pil.L’Indiahaunadelle
economie
più
dinamiche al mondo,
con un incremento
annuo tra il 6 e l’8 per
cento. La crescita è
ancora maggiore nel
settore delle industrie
creative e del cinema,
in cui raggiunge un
risultato ancora più
ragguardevole, oltre il
18percentol’anno.“Il
futuro è nostro e
inoltresiamoilsecondo
paese più popolato al
mondo,” insiste Amit
Khanna
che
vuole
voltar pagina con il
cinema indiano degli
anni
sessanta
e
settanta, amato dalla
critica e nei festival
internazionali,mapoco
considerato
come
settore economico e in
terminidimercato.
La
strategia
di
Reliance dunque è
pensare in grande:
controllando già 240
sale cinematografiche
negli Stati Uniti, il
gruppo ha deciso, nel
2008, di sbarcare a
Hollywood acquistando
quote degli studios
DreamWorks Skg di
Steven Spielberg per
unvaloredi600milioni
di dollari. Inoltre, ha
promesso altri 600
milioni per produrre
una decina di film a
budgetelevatoconotto
case di produzione, tra
cui quelle di Brad Pitt,
Jim Carrey, Nicolas
Cage, Tom Hanks e
GeorgeClooney(questi
accordi
sono
stati
siglati dall’ufficio di
Pechino
dell’agenzia
americana
Creative
Artists Agency). È la
prima volta che un
paeseemergentearriva
concosìtantodenaroa
Hollywood.
L’investimento è stato
favorevolmente
salutato dalla stampa
americana e Bollywood
ha
trionfalmente
accolto la notizia. “Gli
indiani mettono sul
piatto milioni di dollari
per un contratto che
darà
loro
solo
l’occasione di sedersi
alla prima del film
vicino
a
Steven
Spielberg,”
un
importante produttore
intervistato
a
Los
Angeles ha detto per
sminuire.
Riporto
questa provocazione al
mio
interlocutore
indiano.
Amit Khanna sorride.
“Non siamo mai stati
ad alcuna prima. A noi
non
interessa
il
glamour,ciinteressano
le
opportunità
economiche. Siamo i
partner di un progetto
in termini finanziari,
ma anche sotto il
profilo artistico. Gli
studios americani sono
invecchiati,
hanno
bisogno di nuova linfa.
Noi abbiamo questa
nuova linfa e siamo in
grado di fornire una
‘nuova
sensibilità’
investendo
direttamente
sugli
uominiesuitalentiper
creare grandi film. I
nostri punti di forza
sono i numeri della
nostra popolazione, i
nostrigiovani,lanostra
tradizione
cinematografica e i
nostri modi di narrare
storie.” L’obiettivo è
dunque
fare
film
indiani a Hollywood?
“Alla Reliance siamo
convinti
che
l’intrattenimento
sia
molto etnocentrico. Se
volessimo esportare i
valori
indiani
andremmo certamente
incontro
a
un
fallimento.
Qui
a
Bollywooddifendiamoi
nostri valori, mentre a
Hollywood intendiamo
fareuncinemadiverso,
mainstream:
film
hollywoodiani per un
pubblico di massa.
Vogliamo
fare
concorrenza
a
Hollywood con diversi
tipi di contenuti e su
diverse piattaforme.”
Dopo
una
pausa
riprende:
“Nel
contempo, siamo il
primo paese anglofono
al mondo e abbiamo la
massa
critica
necessaria
per
diventare
uno
dei
giganti mondiali del
futuro.
Dobbiamo
conquistare attraverso
la nostra creatività e
solo dopo con il nostro
modello economico”. A
questo punto, Khanna
depone i suoi cellulari,
ovviamente Reliance, e
sembra più tranquillo.
Accetta di parlare un
po’ di sé e del proprio
percorso di vita. Mi
dice di abitare in una
piccola casa vicino alla
spiaggia di Juhu a
Mumbai e di non
essere sposato. Le sue
grandi passioni sono
comporre
musica,
leggere e scrivere.
Molti degli indiani
incontrati a Mumbai e
a
New
Delhi
lo
descrivono come una
“libreria
vivente”,
completamente dedito
al suo lavoro e alla
lettura.
“Cerco
di
conoscere
il
più
possibile e forse un
giorno scriverò le mie
memorie,” mi dice. Ha
scritto
articoli
sui
media per un grande
giornale
indiano,
decine
di
sceneggiature per film,
ha prodotto numerosi
lungometraggi
e
diretto
diverse
emittenti
televisive
prima di fondare la
divisione
“Entertainment”
del
gruppo Reliance. È
anche
presidente
dell’Associazione dei
produttori indiani di
cinema.
“Di
solito
mi
considerano quello che
ha inventato il termine
Bollywood,” mi dice
Amit
Khanna.
Bollywood è il cinema
prodotto in hindi a
Mumbaieogniannofa
uscire circa 250 film,
cioè solo un quarto
della
produzione
indianastimatainoltre
mille film all’anno. “È
però il cinema che
conta
al
boxoffice
indiano
e
internazionale. È il
cinema
mainstream
indiano.”
Quando
Khanna mi parla di
Bollywood sento che il
suo orgoglio nazionale
si gonfia. Sorride, per
la seconda volta. Ora è
un fiume in piena,
mentre all’inizio la sua
assistente mi aveva
avvertito che avrebbe
avuto poco tempo da
dedicarmi
per
l’intervista.
Mi
racconta la storia di
Bollywood e delle sue
star, personaggi che
non appena compaiono
inunaviadiMumbaio
nelpiùpiccolovillaggio
indiano
provocano
fenomeni
di
identificazione, isterie
collettive, parapiglia.
Sono
gli
attori:
Amitabh
Bachchan,
Abhishek
Bachchan,
Shah
Rukh
Khan,
Aamir Khan, Salman
Khan, Saif Ali Khan,
Akshay
Kumar
e
Hrithik Roshan (per
quest’ultimo gli indiani
sarebbero pronti a
tutto per vedere se
davvero ha sei dita a
una mano). Le attrici
sono invece Aishwarya
Rai Bachchan, Kajol
Devgan, Rani Mujerij,
KareenaKapoor,Preity
Zinta e tante altre.
“Molti di questi attori
sono
musulmani,”
aggiunge Khanna per
fare
notare
nuovamente
l’eterogeneità
del
cinema indiano. È un
sostenitore di quello
chedefinisceunasorta
di “Bollywood masala”,
che è il contrario di
Hollywood. Negli Stati
Uniti
si
diventa
mainstream puntando
su un denominatore
comune capace di
conquistare
tutti,
mentre a Bollywood si
fa il contrario, si
mescolano i diversi
generi – drammatico,
commedia,
azione,
musical, thriller, danza
tradizionale,
danza
contemporanea – per
conquistare sensibilità
e gusti diversi uniti
dall’interesse
per
queste mescolanze. Si
tratta di una sorta di
“mainstream
tutti
frutti”.
Khannasposaapieno
la
mitologia
di
Bollywood: i bambini
povericheconosconoa
memorialecanzoniele
cantano all’interno di
cinema a un solo
schermo
nelle
bidonville di Dharavi;
donne delle pulizie al
cinemachesialzanoin
piedi e cominciano a
ballare;ilcinemacome
strumento
di
unificazione
degli
indiani,
con
lo
straordinario potere di
trascendere le classi
sociali e le caste.
“Bollywood
ha
la
straordinaria funzione
di
costruire
integrazione nazionale,
di unire la scala
regionale alla scala
nazionale, di unire
culturapopolareearte,
è la lingua comune di
un paese che di lingue
ufficiali
ne
ha
ventidue.” Con queste
sueargomentazioni–in
realtà
molto
hollywoodiane
–,
Khanna tace sulle zone
d’ombra di questo
settore: i noti legami
tramondodelcinemae
mafia (legami che il
viceministro
alla
Cultura con delega al
cinema incontrato a
New Delhi mi ha
confermato
personalmente);
Bollywood
come
industriadelriciclaggio
del denaro sporco
durante il periodo del
governo di simpatie
socialiste tra gli anni
cinquanta e gli anni
novanta. Amit Khanna
respinge
completamente queste
accusedicendochedal
1991 l’India non è più
socialista e che dal
1998 il governo ha
riconosciuto Bollywood
comeunveroeproprio
settore economico al
quale ha consentito
accessi
legali
a
finanziamenti, prestiti
bancari, assicurazioni,
dunque a un sistema
legaledifinanziamento
che
rende
ormai
obsoletiilegamiconla
mafia.
Più che parlare di
riciclaggio di denaro,
Khanna
preferisce
soffermarsi
sulle
canzoni. Lui stesso
deve infatti la sua
notorietà
alle
quattrocento canzoni
per Bollywood di cui è
autore. Oggi, il suo
obiettivo è costruire
sinergie tra cinema e
musica all’interno di
Reliance. “La chiave
del nostro successo sta
nel
fatto
che
a
Bollywood ci sono
figure polivalenti che,
nel contempo, sanno
fare gli attori, i
ballerini e i cantanti.
Per avere successo, è
necessario possedere
queste
tre
caratteristicheinsieme,
quantomeno le prime
due…”dicesenzafinire
la frase e lasciando
intendere
che
a
Bollywood spesso gli
attori sono doppiati e
cantano in playback.
Con
fierezza
per
Bollywood e per il
proprio paese, Amit
Khanna mi dice che in
India si usano le
canzoni di Bollywood
nei matrimoni, alle
feste e ai funerali. Le
citazioni dai film fanno
partedellaquotidianità
e tutti, anche nella più
remota
e
povera
bidonville del paese,
conoscono a memoria
lecanzonipiùfamose.
Gli chiedo, allora, se
teme la concorrenza
degli
altri
paesi
emergenti nel settore,
per esempio quelli del
Golfo. “Loro hanno
denaro ma non hanno
talenti. Noi invece
abbiamo entrambi. Per
questo
avremo
successo.” Dopo una
mia domanda sulla
Cina si concede una
pausa, esita, poi mi
dice: “Seguiamo ciò
cheaccadeinCinacon
moltaattenzione”.
Nel
corso
della
nostra
discussione
all’Hotel Sun-n-Sand,
capisco allora che il
vero
concorrente
dell’India non sono gli
Stati Uniti, con i quali
Reliance
sta
costruendo partnership
e
collaborazioni
a
lunga scadenza, come
lasciava
intendere
all’inizio
della
discussione,
ma
proprio la Cina. Di
fatto, gli indiani hanno
bisogno
degli
americani per fare da
contrappeso alla Cina,
mentre gli Stati Uniti
hanno
bisogno
dell’India per sfondare
in Asia poiché hanno
fallito in Cina. Amit
Khanna
non
mi
descrive chiaramente
questa
nuova
geopolitica
dell’intrattenimento,
ma mi dice quanto
apprezzi il cinema
americano e quanto
preferisca
il
caos
indiano di Bollywood
all’ordine cinese e alla
rigidità di China Film.
“L’India
è
una
democrazia, la Cina
invece no. L’India è un
mercato in cui gli
stranieri
possono
venire
a
investire
liberamente, la Cina
no. Qui non abbiamo
paura di nessuno. Se
vogliono
venire
a
investire dalle nostre
parti, gli americani
sono i benvenuti.” Più
chiaro di così! Sulla
spiaggia di Mumbai ho
dunque capito che
l’India si sta alleando
con gli Stati Uniti
contro la Cina, in
termini diplomatici si
direbbe
che
sta
avvenendo
un
rovesciamento
di
alleanze.
LanuovaBollywood
Lascio la spiaggia di
Juhu in risciò, i
motocarri neri e gialli
che permettono di
circolare
più
rapidamente
a
Mumbai.
Ho
fatto
capireagestidiessere
in ritardo e Saga, il
conducente, si lancia a
tutta
velocità
nel
traffico
pazzesco,
intanto ascolta a tutto
volume un magnifico
successo di Bollywood.
Nel
subcontinente
indiano, il cinema non
è arte elitaria, ma
cultura popolare di
massa.
Sono diretto a Santa
Cruz, quartiere del
centro di Mumbai. Al
settimo piano di un
edificio
piuttosto
spoglio
ho
appuntamento
con
Ritesh
Sidhawani,
nuovo beniamino di
Bollywood. Ha appena
prodotto il film Rock
On!!(insistesuldoppio
punto
esclamativo),
una sorta di commedia
musicale rivolta ai
giovani e molto simile
aglispettacolidirivista
di Broadway tipo Rent
oMovin’Out.
“In India, i giovani
stanno
cambiando.
Devono
cambiare
anche i classici film di
Bollywood
fatti
di
songs
&
dance,
musiche e danze. I
giovani sono sempre
più istruiti, hanno
accesso a internet,
hannotelefonicellulari,
guardano Mtv. Anche
noidobbiamocambiare
insieme a loro.” Ritesh
Sidhawani ha solo
trentacinque anni, è di
origini pakistane ed è
un
importante
produttore della scena
cinematografica locale
che aspira al successo
mondiale. È proprio
l’incarnazione
della
“nuovaBollywood”,più
sperimentale, più rock,
disposta ad assumersi
più rischi e più attenta
a un pubblico più
“civilizzato”. Il budget
di Rock On!! ammonta
a 6,5 milioni di dollari,
cifra enorme rispetto
alla media dei film di
Bollywood.
Unsimileincremento
di budget è possibile
grazie allo sviluppo dei
multisala in tutte le
grandi città, con il
conseguente notevole
aumento dei prezzi dei
biglietti di ingresso
(vedere un film in un
multisala costa 200
rupie, circa 3 euro,
mentre in un normale
cinema costa tra le 10
e le 40 rupie, cioè
meno di 50 centesimi
di
euro).
I
film
proiettati nelle città
portano
dunque
maggiori incassi; la
nuova Bollywood cerca
di rivolgersi a questi
nuovi giovani con più
disponibilità
economiche attraverso
film d’azione e storie
più moderne. Dopo
oltre quindici anni di
televisionisatellitari,la
liberalizzazione
dell’economia,
lo
sviluppo
dell’immigrazione
verso l’Occidente e il
forte
aumento
di
ragazzi indiani che
studiano
nelle
università americane e
ladiffusionediinternet
in
India,
sono
soprattutto i giovani
delle città e istruiti a
essere cambiati – e
anche Bollywood deve
cambiare.
“Non mi piace tanto
il termine Bollywood.
Preferisco
dire
semplicemente
‘industriadelcinemadi
Mumbai’. Del resto,
questo è un vero e
proprio
settore
produttivo.
Peraltro,
qui in India, non
abbiamo più nessun
problema
di
finanziamento, è molto
facile trovare denaro,”
constata
Ritesh
Sidhawani.
Il
cambiamento
economico in corso a
Bollywood è inaudito:
ieri, questo settore era
isolato,
poco
valorizzato,
lasciato
alla mafia e si basava
su
un
capitalismo
familiare fatto “con i
soldi
di
papà”
all’internodiunregime
di stampo socialista; i
contratti si facevano a
voce, gli script erano
continuamente
improvvisati
e
il
marketing
era
confinato alle sale
cinematografiche.
Oggi, mi conferma
Sidhawani,Bollywoodè
diventata un’industria
di stampo americano. I
produttori e i direttori
del marketing hanno
studiatoaLosAngeles,
l’intero
settore
è
gestito
in
modo
professionale, i budget
per il marketing sono
decuplicati,
gli
investitori esterni sono
diventati indispensabili
e le agenzie di talenti,
gliavvocatieidirettori
finanziari hanno messo
ordine nei conti. Come
negli Stati Uniti, anche
a
Bollywood
cominciano a circolare
ampiamente
espressioni
come
accountability,
pilot,
green light, pitch e
balancesheet.
Rock On!! vuole
conquistare il mercato
mondiale,
anzitutto
quello indiano, poi
inglese,
australiano,
sudafricano, dei paesi
del Golfo, del Pakistan
e ovviamente degli
Stati Uniti. “All’estero,
il nostro pubblico è
formato soprattutto da
indiani emigrati. Per
loro il cinema è
immaginazione, ricerca
disogni,èunmodoper
restare legati al loro
paese.”
Le
argomentazioni
di
Ritesh Sidhawani sono
un po’ confuse, quasi
come il piccolo ufficio
disordinato dove mi
riceve, in cui vedo una
pila di giornali, tra le
quali diverse edizione
indiane
di
“RollingStone” (con la
copertina proprio su
RockOn!!).
Gli chiedo se è
convinto
di
poter
sfondare sul mercato
Usa. Questa è la sua
risposta: “Sì, noi non
abbiamo bisogno degli
americani
per
raggiungere gli indiani
che vivono negli Stati
Uniti.Facciamodasoli.
Loro, invece, hanno
bisogno di noi per
raggiungeregliindiani,
poiché i loro film non
funzionano tanto bene
da queste parti. Sanno
che il cinema indiano
sta diventando globale
e vogliono anche loro
una fetta della torta,
maperilmomentonon
ci
riescono.
Né
attraverso
la
distribuzione,
né
facendo coproduzioni a
livellolocale”.
Cosa
vuol
dire
quell’espressione “una
fetta
della
torta”?
Ancheseprivodiquote
diriserva,dicensurae
di
misure
protezionistiche,
in
effetti
il
cinema
indiano, sul fronte
interno, scoppia di
salute.Raggiungeoltre
il 90-95 per cento del
botteghino, mentre gli
americani si devono
accontentare di una
“fetta
della
torta”
molto piccola, attorno
al 5 per cento (alcuni
miei interlocutori tra i
dirigenti di Hollywood
mi dicono invece il 10
percento,maèdifficile
poter
disporre
di
statisticheattendibiliin
India). In ogni caso,
questa capacità del
cinema indiano (di
Bollywood
in
particolare)diresistere
di fronte a quello
americano è davvero
sorprendente.Idatidel
pubblico
sono
addirittura sbalorditivi:
3,6 miliardi di biglietti
venduti in tutto il
mondo per i film
indiani contro i 2,6
miliardi dei film di
Hollywood. Tuttavia, il
confronto si ferma qui,
poichéiltotaledelboxofficeindianoindollari
è di appena 2 miliardi,
undatodavveroesiguo
rispetto ai circa 38
miliardi raggranellati
dal cinema americano
(datidel2008).Soloun
film come Pirati dei
Caraibi, nel 2006, ha
fattoregistrarelametà
del box-office mondiale
di tutti i film di
Bollywood.
Perinvertirelarotta,
gli americani cercano
dunquediadottareuna
nuova strategia basata
sullaproduzionedifilm
indiani in India. È
quanto stanno facendo
Warner, Disney, 20th
Century
Fox
e
Columbia. Per capire
gli obiettivi di queste
major sono andato a
intervistare i dirigenti
chelavoranoinIndia.
“Il mio job è fare sei
filmindianiall’anno.La
strategia degli studios
americani è ormai
mondiale. Per noi non
si tratta più soltanto di
distribuire i nostri film
in
India,
ma
di
produrretuttiifilmdel
mondo,” spiega Uday
Singh, vicepresidente
di Sony Pictures in
India, che dirige la
divisione Produzione di
film di Columbia. Mi
trovo all’estremo Nord
diMumbai,inunazona
urbanaincuigliedifici
moderni
hanno
sostituito le vecchie
paludi.
L’ambiente
naturale
è
completamentesparito,
nella hall dell’azienda
c’è una foresta di
bambùinplastica.
Negli uffici lavorano
circa 400 persone, tra
cui molti giovani, tutti
nei loro cubicles, con
computer
Sony
di
ultima generazione e
un telefono Blackberry
– tutte cose in aperto
contrasto
con
l’immensa
povertà
delle bidonville che si
attraversano
per
arrivare in questa
sperduta zona degli
uffici e del commercio.
“L’unica
cosa
che
funziona qui sono i
contenuti
locali,”
insisteUdaySingh.“La
distribuzione di film
americani in India è
fallita;
dobbiamo
produrre film locali, se
possibile
con
un
potenziale di livello
mondiale. Questo è
l’unico nostro valore
aggiunto: gli indiani
non sanno fare film
globali. Noi, invece,
abbiamo il marketing e
la rete di distribuzione
internazionale capaci
di trasformare un film
di successo nazionale
in
un
successo
mondiale.”
Per raggiungere un
mercato
unico
al
mondo,incuiunfilmdi
successo
indiano
raggiunge i 33 milioni
di dollari di incasso
settimanale, Sony, mi
spiega Uday Singh, le
ha tentate tutte con i
suoi film di successo
americani.Hadoppiato
i film in venti lingue
per
cercare
di
raggiungere
più
pubblico
possibile
all’interno di un paese
con ventidue lingue
ufficiali e centinaia di
lingue
regionali
e
dialetti (anche Warner
ha doppiato Batman. Il
cavaliere oscuro in
quattordici
lingue).
Sono state aggiunte
canzonihindiinCasino
Royale,sonostatigirati
video
con
cinque
gruppi
locali
per
lanciare Spider-Man e
sono state condotte
cinque
diverse
campagnemarketingin
cinque lingue, tra cui
hindi, tamil e telugu.
Matuttociòèservitoa
poco. Infatti, SpiderMan ha ottenuto un
successo significativo
(17 milioni di dollari di
incassi, un risultato
storico per Hollywood
al botteghino indiano),
ma siamo ben lontani
dai risultati raggiunti
nel resto del mondo. “I
film di Bollywood sono
molto diversi dai film
americani, nella loro
ideazione e nella loro
struttura. Il pubblico
indiano si aspetta che
nei film ci siano songs
&dance,uninsiemedi
tradizione e modernità
difficile da capire per
gli
occidentali,”
concludeUdaySingh.
Nello
stesso
quartiere, a qualche
edificio di distanza,
incontro
Kunal
Dasgupta, che dirige
Sony
Entertainment
Network, il settore
audiovisivo del gruppo
in India. “La cosa
affascinante
degli
indianiècheassorbono
ogni tipo di cultura
diversa dalla loro, ma
alla fine restano se
stessi. Apprezzano le
serie americane, ma
quando si tratta di
sposarsi accettano i
matrimoni combinati
dallafamiglia.”Sonyha
dunque l’obiettivo di
aumentare
la
produzione
locale,
benché la serie Indian
Idol sia semplicemente
un riadattamento di
AmericanIdol.“Inostri
contenuti
saranno
sempre più improntati
alla realtà locale e
sempre
meno
americani,” conferma
Kunal Dasgupta, che
lavora da quindici anni
perSony.
L’investimento
di
Sony in India persegue
anche altre finalità.
Cinema e televisione
sono, infatti, un altro
modo per promuovere
ilmarchioe,attraverso
un’immagine glamour,
è possibile vendere
schermi
piatti,
computer,
telefoni,
telecamere digitali. “In
India, la gente crede
chesiamoun’emittente
televisiva che produce
strumentazioni
elettroniche!”
dice
divertita
Kunal
Dasgupta che dipende
da Sony a Los Angeles
e non dalla sede
centrale di Sony in
Giappone.Ilproduttore
Aditya Bhattacharya fa
dell’ironiasullavolontà
americana
di
conquistare il mercato
indiano: “Agli occhi di
molti
di
loro,
rappresentiamo il più
grosso mercato al
mondo”,
dice
puntandosi due dita
davantiagliocchi.“Per
questo gli americani
sono tutti eccitati,
soprattutto da quando
hanno fallito in Cina.
Tuttavia, non saranno
in grado di penetrare
nel mercato indiano,
perché non hanno
saputo farlo con quello
cinese.”
Di questo stesso
avviso è Navin Shah,
giovane
amministratore
delegato del gruppo
multimedia
Percept,
che incontro a Lower
Parel,nell’estremoSud
di
Mumbai.
Per
raggiungere
quegli
uffici sono rimasto due
ore imbottigliato nel
traffico: Mumbai è una
città immensa con uno
sviluppo urbano poco
pianificato.
Spostandomi da una
parte all’altra ho visto
un caos indescrivibile,
numerose bidonville,
montagne di rifiuti
abbandonati,
marciapiedi
che
sostituiscono le strade
quando queste sono
sature di veicoli, una
situazione sanitaria e
alimentare
difficile,
acqua
stagnante,
peraltro non potabile.
Nell’ambito
della
concorrenzatraIndiae
Cina, la prima è ben
più
povera
della
secondaedèmoltopiù
caotica.
Tuttavia,
l’Indiahaunvantaggio:
è un paese giovane, è
una
democrazia
e
desidera
il
cambiamento.
“Vogliamo costruire
la nuova Bollywood,”
mi dice Navin Shah
che,asolitrentacinque
anni, ha già prodotto
quarantacinque
film
per Bollywood. Mi
trovo dunque di fronte
a
un
giovane
amministratore
delegato
di
una
giovane
azienda,
all’interno di un paese
giovane – e ciò è in
apertocontrastoconla
“vecchiaEuropa”incui
l’amministratore
di
un’azienda di questo
calibro (Percept ha
duemila
dipendenti)
avrebbe
oltre
cinquant’anni. In Cina,
invece, sarebbe un
vecchio esponente del
Partitocomunista.
“La nuova Bollywood
ha bisogno di nuove
storie,
di
script
migliori, di veri storytelling e di attori più
giovani. Non dobbiamo
abbandonareilsongs&
dances
che
ci
contraddistingue, ma
bisogna ringiovanire i
film perché il pubblico
sta cambiando. I film
devono essere un po’
meno prevedibili, però
l’happy
end
deve
necessariamente
restare.” Navin Shah
crede soprattutto alle
nuove
tecnologie,
settoreincuil’Indiaha
sopravanzato gli altri
paesi emergenti e
attraversocuiilcinema
indiano
intende
svilupparsi
ulteriormente. “L’India
è un paese talmente
fiero
dei
propri
progressi tecnologici
chequisipensacheIt,
anziché
Industrial
Technology, significhi
IndianTecnologies,”mi
diceconironia.
Navin
Shah
mi
mostra un documento
che riporta l’attuale
box-office in India: “In
generale, ormai, il
denaro
viene
dai
multisalaedalmercato
internazionale, e non
dai cinema one screen
che esistono nei nostri
seicentomila villaggi.
Questi cinema sono
moltopiùnumerosi,ma
non fruttano più nulla.
L’unico
tipo
di
consumatore a cui
aspiriamo è l’indiano
cheviveincittàevain
un multisala”. Navin
Shah si esprime in un
inglese perfetto e mi
complimento con lui
per il suo accento. Ne
va fiero. In India, la
lingua ufficiale negli
ambienti del cinema è
l’inglese e anche tra
loro gli indiani parlano
in
inglese
–
quantomeno una sorta
di
“hinglish”,
una
lingua a metà tra
l’inglese e l’hindi. Gli
faccio notare che in
GiapponeeCina,anche
nel
settore
dell’intrattenimento,
sono pochi i dirigenti
che parlano inglese. Il
suo orgoglio ne è
ulteriormente
ravvivato. Poi Navin
Shah mi dice una frase
un po’ enigmatica:
“Bollywood è ormai
un’industria diretta da
persone che tra loro
parlanoinglese,mache
fanno film in hindi.
Questa è la nuova
Bollywood – ed è
questoilproblema”.
Presso Star India, a
New
Delhi,
le
argomentazioni sono
leggermente diverse. E
non è un caso. Star
India
appartiene,
infatti,
al
gruppo
panasiatico Star, la cui
sede è a Hong Kong,
ma la casa madre è
negli Stati Uniti, si
trattadiNewsCorp,di
Rupert Murdoch. Nella
sede di Star India, a
New Delhi, incontro
Parul Sharma. “Di
fatto, gli americani
sono
sempre
più
presenti in India e
riescono a fare sempre
meglio poiché hanno
una buona strategia.”
Di quale strategia si
tratta?
“Localized
contents,”
risponde
prontamente
Parul
Sharma.
“I
nostri
contenuti
devono
essere calibrati sulla
realtàlocaleal100per
cento, oppure si tratta
di formati americani
che
vengono
‘indianizzati’,
altrimenti
creiamo
programmi
interamente costruiti
per l’India.” Le chiedo
allora in cosa consista
questa
“indianizzazione”.
“Dobbiamo sostenere
valoriindianipertuttii
contenuti: obblighi nei
confronti della propria
famiglia, matrimonio
come
questione
sensibile
e
potenzialmente
combinato,
specifica
condizionedelladonna,
mai parlare di sesso,
mai dire parolacce
davanti
a
propri
genitori,nonsipossono
mostrare persone che
si baciano né fare
allusioni
sessuali,
mantenere
precisi
codici
dell’abbigliamento non
occidentali in famiglia,
rispetto degli animali
sacri, non ci si ciba di
carne bovina.” Tutto
qui
è
fortemente
family-oriented.
In
India, molti dei miei
interlocutori mi hanno
parlato
di
lento
processo
di
trasformazione
di
questivalori,michiedo
come
ciò
possa
avvenire all’interno dei
contenuti.
Parul
Sharma mi risponde:
“Certo,
l’India
sta
cambiando, ma non
come vorrebbero gli
occidentali. Sono i
giovani
indiani
a
portare
avanti
il
cambiamento.
Nelle
serietelevisive,oggi,si
possono
vedere
matrimoni d’amore e
non solo matrimoni
combinati, ci sono
divorzi, persone con
vite parallele, ci si
veste all’occidentale,
capita di vedere anche
persone omosessuali.
Maperilcambiamento
civuoletempo”.
Senza giri di parole
chiedo a Parul Sharma
se l’interesse di Star
per
l’India
abbia
qualche legame con i
fallimenti delle major
americane, e Star in
particolare,inCina.Ma
Parul Sharma non
rispondealladomanda,
mi dice semplicemente
che non posso fare il
suo nome e che non
vuole dire nulla su
questo tema on the
record. Avrei voglia di
chiederle, come alla
fine del film The
Millionnaire: “È la sua
rispostadefinitiva?”.
Poco dopo, peraltro,
mi fornisce l’esempio
del gioco televisivo Chi
vuole
essere
milionario?. Il format
del quiz appartiene a
Sony ed è stato
riadattato in India da
Star Tv con il titolo
Kaun
Banega
Crorepati, presentato
dal celeberrimo attore
cinematografico
Amitabh
Bachchan
(nell’ultima stagione è
stato sostituito da
un’altra star, Shah
Rukh Khan). Grazie a
questa
trasmissione,
Star è diventata uno
dei canali più visti del
subcontinenteindiano.
Attorno alla versione
indiana di Chi vuole
essere milionario? è
costruito
il
film
vincitore di otto Oscar
The Millionnaire, di
Danny Boyle. Peraltro,
il suo grande successo
èdirettamentelegatoa
questa ambientazione
televisiva. Il giovane
JamalMalik(DevPatel,
un
inglese
di
diciannove anni di
origini
indiane)
proveniente da una
bidonville di Juhu a
Mumbai
diventa
milionario grazie al
gioco,maèaccusatodi
averimbrogliato.Ilfilm
ètrattodaunromanzo
indiano
di
Vikas
Swarup ed è stato
girato in India, a
Mumbai. Non si tratta,
tuttavia, di un film
indiano. Il regista è
inglese e il film è stato
prodotto da diversi
studi
americani
e
inglesi, in particolare
Pathé Uk (la divisione
britannica del gruppo
francese Pathé), Fox
Searchlight
Pictures
(del
gruppo
di
Murdoch) e Warner
Bros.
È
stato
distribuito da Pathé in
tutto il mondo e da
Warner Independent
Pictures nell’America
del Nord (in India è
statodistribuitodaFox
Star
Studios,
di
Murdoch). Come era
già accaduto con Kung
Fu Panda prodotto da
americani e non da
cinesi e con Bombay
Dreams,
commedia
musicale di Broadway
prodotta da inglesi,
anche il caso di The
Millionnaire dimostra
chegliindianinonsono
logicamente
nella
miglior posizione per
distribuire su scala
mondiale una cultura
fondata
sulle
loro
specifiche
storie.
Accade, ancora una
volta, come in The
Millionnaire, quando,
prima di capire che il
boss che ha di fronte
vuole renderlo cieco
per
mandarlo
a
elemosinare,
un
bambino
dice:
“Si
prende cura di noi,
dev’essere una brava
persona”.
Qualchegiornodopo,
nel Sud di Mumbai,
vicino
alla
Porta
dell’India, incontro il
patron di Warner Bros
India,
Blaise
Fernandez.
Contrariamente
alla
maggior parte dei miei
interlocutori in questo
paese ha fiducia sulle
capacità
di
penetrazione
del
cinema americano nel
subcontinente indiano.
Prevede addirittura un
aumento del box-office
per i film Usa del 50
per cento del mercato
nel giro di qualche
anno
“come
nella
maggior parte degli
altripaesi”(oggièal5
per cento). L’unica
condizione
per
raggiungere
questo
risultato
è,
però,
produrre film in linea
con “lo spirito di
Bollywood”.
Blaise
Fernandez
lavora per Warner da
vent’anni, ma la major
ha
cominciato
a
produrre
film
per
l’India solo dal 2005,
aumentando i propri
interessi da queste
parti mentre riduceva
gliinvestimentiinCina.
“Il nostro obiettivo è
conquistare
un
pubblico mainstream.
Però, a Bollywood non
ci
sono
formule
magiche. So solo che
dobbiamo
produrre
filmdiimprontalocale.
Ilmercatoègigantesco
ed è molto aperto. Gli
indianivoglionorestare
indiani:
vogliono
vedereilorofilmhindi,
con songs & dances,
con
melodrammi
flashy, stravaganze e
risse
eccessive.
Vogliono film lunghi,
anche di tre ore, pieni
didialoghi,anchedopo
scene di suspense.
Vogliono che il bene
vinca sempre sul male
echeilcattivocontinui
a restare tale. Povertà,
bidonville,
analfabetismo:
gli
indianivoglionofuggire
dalla realtà e lasciare
spazio alla fantasia.
Tuttavia, all’interno di
un film tutto deve
essere prevedibile, non
c’è spazio per la
sorpresa.Ècosì.Enon
cambierà. Tocca a noi
adattarci. Una major
come la nostra, anche
se americana, qui deve
produrre film indiani,
nonamericani.Edèciò
chefaremo.”
InIndia,Cina,Egitto,
Turchia, Brasile, le
persone che mi hanno
spiegato meglio la
globalizzazione
all’interno di questi
paesi
sono,
paradossalmente,
i
rappresentanti
degli
studios e delle major
americani. Tutti i miei
interlocutori
hanno
contestato l’idea di
uniformazione
della
cultura. Non tanto in
difesa
dei
propri
interessi,
ma
per
pragmatismo, perché
hanno fallito quando
hanno privilegiato i
contenuti americani. I
patrondiWarnerIndia,
Disney India, Condé
Nast in India, Cnn
Türk, Mtv Francia,
Warner China, Fox in
Egitto, Universal in
Brasile
sanno
per
esperienza che devono
assestarsi sul “local”
perstareall’internodei
mercati
emergenti.
“Localize or die (stai
sul locale o muori) è
una formula famosa in
India,” mi dirà uno di
questi
patron.
“Facciamo
del
‘bollyvogue’
e
ci
assestiamo sempre di
più sulla realtà locale
per i nostri contenuti,”
conferma
Bandana
Tewari, caporedattore
di “Vogue India”. “Qui
si parla delle star di
Bollywood e non di
quelle di Hollywood.
C’è una vera e propria
‘bollywoodizzazione’ di
tuttalaculturaindiana,
e
noi
dobbiamo
renderne conto. Qui, a
‘Vogue
India’,
ci
interessiamo dunque
poco di quanto accade
nel resto dell’Asia,
poiché l’India è un
continente
vero
e
proprio.” Del resto, i
magazine della stampa
occidentale sono tutti
assestati su questa
linea:
“Gq”,
“RollingStone”,
“People”,
“Marie
Claire”,
“Cosmopolitan”, “Elle”
e numerosissime altre
testate americane ed
europee pubblicate in
India parlano solo di
questo paese. Sono
magazine che non si
trovano
solo
ai
chioschi,
ma
sono
venduti
anche
da
giovani indiani poveri
di dodici o tredici anni
che
ripetono
disperatamente
“‘Vogue’,
madam?,
‘Gq’, sir?” ai finestrini
delle auto ferme al
semaforo rosso. Sono
ragazzini sfruttati da
intermediari
che
prendono
tutto
l’incasso lasciando loro
meno di un dollaro al
giorno.
Per il momento, i
risultati delle major
americane in India non
sono particolarmente
positivi. Sul fronte
della produzione locale
si può già parlare di
fallimento. Il primo
tentativo di Columbia
nel 2007, con il film
Saawariya (Beloved), è
stato battuto nelle sale
dall’uscita
contemporanea di Om
Shanti Om di Farah
Kahan,
interpretato
dalla star Shah Rukh
Khan.
Anche
la
coproduzionediDisney
conglistudiosYashRaj
perilfilmd’animazione
Roadside Romeo nel
2009 non ha ottenuto
risultati migliori, così
come è stata un
fallimento l’esperienza
di Warner con Chandai
Chowk to China. Gli
investimenti
di
DreamWorks
per
creare
uno
studio
d’animazione
a
Bangalore,
in
partenariato con lo
studio
indiano
Paprikass Perspective,
non hanno ancora
portato frutti. Eppure
gli americani hanno
idee e non demordono:
Warner
ha
in
programma dodici film
inIndia,Disneyquattro
film di animazione,
Sony-Columbia ha in
progetto
sei
film
l’anno, mentre 20th
Century Fox, lo studio
diMurdoch,haquattro
progetti di produzione,
di cui due già sotto
contratto. Gli indiani
osservano
questo
grande spiegamento di
forze
senza
inquietudine
e
imparano.
Bollywood,tuttavia,è
solo una parte del
cinemaindiano.Ilresto
èprodottoaldifuoridi
Mumbai, in oltre venti
lingue e in diverse
regioni. “I film non
bollywoodiani
raramente
hanno
spettatori su scala
nazionale
e
difficilmente hanno un
successo di pubblico,”
spiegaNinaGupta,che
dirige a Mumbai la
National
Film
&
Development
Corporation, l’istituto
pubblicodipromozione
e sviluppo del cinema.
Lealtrecinematografie
indiane,comeilcinema
tamilaChennai(nuovo
nome di Madras), il
cinema di “Tollywood”
a Kolkata (nuovo nome
di Calcutta) e le
cinematografie di New
Delhi, Bangalore (in
lingua
kannada),
Andhra Pradesh (in
telugo) hanno una
“incidenza sui critici,
nei cineclub e nei
festival di tutto il
mondo,mahannopoco
pubblico, anche in
India”, prosegue Nina
Gupta.
Così come Bollywood
rappresenta una parte
fondamentale del boxofficeinIndia,lostesso
accade anche per le
esportazioni in tutto il
mondo. Molti dei miei
interlocutori
hanno
indicato un dato di
penetrazione
sul
mercato internazionale
del 2,5 per cento, un
risultato migliore dei
film
europei,
ma
decisamente
debole
rispetto agli americani
che controllano il 50
per cento del mercato
mondiale. La geografia
della diffusione del
cinema di Bollywood è
comunquesignificativa,
i risultati sono in
crescita,
soprattutto
grazie agli indiani che
vivono all’estero, i
“Non Resident Indian”
(Nri). Anzitutto ci sono
imercatitradizionalidi
Bollywood:
Bangladesh, Pakistan,
Nepal,
Sri
Lanka,
Afghanistan, parte del
Sud-est
asiatico
(soprattutto Indonesia,
Malesia e Singapore),
ma mai Cina, Corea e
Giappone,
dove
il
cinema
indiano
semplicemente
non
esiste. Ci sono poi altri
mercati
importanti,
come Cuba, Russia, le
repubbliche dell’Asia
centrale
come
Turkmenistan
e
Kazakistan (ai tempi
dell’Ursssiprivilegiava
infatti il cinema di
Bollywood rispetto a
quello di Hollywood,
vietato per ragioni
politiche). Il vettore
principale
delle
esportazioni
di
Bollywood rispetto ai
film hollywoodiani è il
prezzo. Si spiega così,
in parte, la loro
influenza in Maghreb,
soprattuttoinMarocco,
e in diversi paesi
dell’Africa anglofona
dove il cinema indiano
è popolare (Nigeria,
Kenya, Sudafrica). Ho
sentito
parlare
di
Bollywood
anche
nell’Africa francofona:
“I camerunesi vogliono
film indiani perché
sono stati allevati a
film di Bollywood,
inoltre, metterli in
programmazione costa
molto meno dei film
americani”, mi spiega
Sally Messio, direttrice
dei
programmi
e
presentatrice di punta
della
Televisione
nazionale del Camerun
(Crtv), quando visito a
Yaoundé i locali di
questa emittente di
stato.“Inoltreilcinema
di Bollywood è vicino
alla cultura africana
basata sul rispetto
degli anziani e dei
valori della famiglia; è
un cinema con meno
sensualità e meno
violento rispetto alle
serie
o
ai
film
americani, qui siamo
più attestati su cose
come sogni, favole,
principi azzurri, buoni
e cattivi. Gli africani
vogliono
questo,”
aggiungeSallyMessio.
In ogni caso questi
mercati
sono
in
evoluzione.
L’India
stessa,
ormai
consapevole del peso
della nuova Bollywood
nell’economia
emergente,
ha
aumentato i costi dei
diritti di diffusione e
intende farli pagare
anche ai russi e agli
africani, mentre in
precedenza chiudeva
un
occhio
sulle
trasmissioni
non
autorizzate
e
sul
mercato dei video
pirata.
Inoltre,
Bollywood è vittima
della concorrenza di
Hollywood: quando il
cinema americano era
proibito, per esempio
inUrss,ilconfrontotra
le due cinematografie
nazionali
era
impossibile,
mentre
oggi avviene a scapito
degli indiani. I giovani
russi e marocchini
preferiscono spesso i
film
d’azione
hollywoodiani di meno
didueoreallemelense
pellicole
bollywoodiane,
prevedibilieditreore.
Il declino di Bollywood
nei paesi emergenti, in
Africa e nei paesi del
Sud del mondo, è
annunciato.
Loscenarioèdiverso
neipaesidelGolfoein
Medio Oriente, un
mercato nel contempo
vecchio ed emergente.
Gli indiani chiamano
stranamente
questa
regione“WestAsia”eil
cinema di Bollywood vi
sta
conoscendo
importanti sviluppi sia
perché
ci
sono
numerosi
lavoratori
indiani
immigrati
(superano il 20 per
centodellapopolazione
in Qatar e hanno
percentuali
elevate
anche a Dubai e nello
Yemen), sia perché i
valori indiani sulla
famiglia, le donne e il
sesso sono compatibili
con l’islam sunnita o
sciita. “Qui il cinema
indiano
rappresenta
oggiil10percentodel
box-office,
ma
rappresentavail30per
cento
negli
anni
cinquanta,”mispiegaa
Damasco Mohammed
alAhmad,direttoredel
dipartimentodiCinema
all’interno del governo
siriano. “I settori medi
della
popolazione
apprezzano questi film
con musiche e danze.
Piace
il
fascino
‘orientale’. E poi sul
fronte della famiglia e
dei valori, il cinema
indiano condivide gli
stessi
ideali
della
popolazione araba. Le
classialteeglistudenti
preferiscono invece il
cinema
occidentale,
soprattutto
quello
americano.”
Sul
fronte
dei
mercati
occidentali,
negli Stati Uniti, in
Canada, in Inghilterra
e in Germania agli
emigrati indiani piace
vedere i film di
Bollywood poiché li
riportaacasa.Sistima
che questi emigrati
sianoalmeno20milioni
suddivisi in 120 paesi
del mondo intero e di
cui solo 3 milioni negli
Stati Uniti. Peraltro, il
governo indiano di
recente ha creato un
Ministry of Overseas
Indian
Affairs
per
occuparsi meglio di
questapopolazione.
In definitiva, il punto
di forza del cinema
indiano all’interno dei
confini nazionali – il
carattere identitario,
songs & dances, colori
caldi, emozioni vive –
può rappresentare un
puntodebolesulfronte
internazionale. “Sono
in corso dibattiti su
diversi
temi:
fra
tradizioneemodernità,
tra sensualità e sesso,
tra attrici overkitsch
che
riproducono
i
pregiudizi sulle loro
caste e liberazione
della donna, tra film
bollywoodiani
che
raccontano sei volte la
stessa storia e film
d’azione che tengono
alta la tensione del
pubblico con ritmo e
velocità,” afferma il
produttore
Pinaki
Chatterjee a Mumbai.
“Se Bollywood vuole
diventare globale, non
potrà continuare a
raccontarelestorieche
racconta
oggi,”
sostiene
il
critico
cinematografico Saibal
Chatterjee intervistata
aNewDelhi.
Ci sono voci ancora
più
critiche,
per
esempio quella del
produttore e regista
Aditya Bhattacharya:
“Il
problema
di
Bollywood oggi è che
gli
emigrati
sono
diventati ancora più
conservatori
degli
abitanti
del
subcontinente indiano.
Vogliono ritrovare al
cinema il paese che
hanno lasciato. Non si
sono evoluti con il
tempo, contrariamente
alle nuove generazioni
di indiani. Sul fronte
dei
valori,
della
famiglia, delle caste
sonomoltoreazionarie
molto arcaici. Vogliono
vedere ragazze sullo
schermo per capire
come sono oggi in
India, vogliono vedere
matrimoni
indiani
combinati,
vogliono
vedere vestiti molto
colorati. Siccome sono
loro a costituire una
parte importante del
box-office, non tanto in
termininumerici,main
termini
di
dollari,
questo
pubblico
contribuisce
alla
stagnazione
di
Bollywood”.
Se si osservano da
vicinoirecentisuccessi
diBollywoodnegliStati
Uniti, si scopre che
granpartedegliincassi
al
botteghino
si
concentra
su
un
numero ridotto di sale
cinematografiche, una
sessantina di schermi.
Tutti questi cinema si
trovano nei quartieri
chiamati “Little India”
nelle città e negli stati
in cui vivono molti
indiani: New York,
Chicago,
Atlanta,
Washington,California,
Texas e New Jersey.
Peraltro,
nel
film
bollywoodiano Kal Ho
Na Ho si dice che a
New York una persona
suquattroèindiana(in
realtà è una su
trentadue,
che
è
comunque un dato
considerevole).
Per
l’uscita di un grande
film di Bollywood, le
sale di queste “Little
India”arrivanoanchea
riempirsi, ma si tratta
esclusivamente di Non
Resident
Indians.
Sessantasale,anchese
piene, è poca cosa
rispetto all’uscita negli
StatiUnitidiunfilmdi
successo come Batman
proiettato su 4366
schermi.
Bollywood è a metà
fra
tradizione
e
modernità. Il successo,
nel1995,eduratooltre
tredici
anni
sugli
schermiindianidelfilm
The Brave Heart Will
Take the Bride (con le
starShahRukhKhane
Kajol Devgan), che
racconta
la
storia
d’amoretradueindiani
disecondagenerazione
che
vivono
in
Inghilterra, ma attesi
in
India
da
un
matrimonio combinato
–illietofineèafavore
del
matrimonio
d’amore – ha mostrato
la posta in gioco di
questa
modernizzazione
in
stile
indiano.
In
definitiva, il futuro si
gioca sulle attese del
pubblico, soprattutto
quello degli emigrati
che non costituiscono
affatto un fronte unico.
“La prima generazione
di Nri vuole ritrovare
nei film di Bollywood il
sound of home (il
sapore di casa),” mi
dice il critico Jerry
Pinto, al Bbc, uno dei
bardell’HotelMarriott.
“Ma per la seconda
generazione,Bollywood
è il sound of their
parents, la cultura dei
genitori,nonlaloro.La
terza generazione se
ne
frega
completamente.
Per
loro è sound of
nothing.” Se questa
ipotesi fosse vera,
l’industria del cinema
indiano
dovrà
attendereancoramolto
per
realizzare
prospettive di sviluppo
neimercatioccidentali.
Riuscirà a imporsi
l’India nel mondo,
attraverso
il
suo
cinemaelesuecanzoni
bollywoodiani, riuscirà
a creare contenuti
globali? La maggior
parte dei produttori
incontrati al Marriott
della spiaggia di Juhu,
tutti i patron degli
studios visti al Film
City di Mumbai, tutti i
dirigenti intervistati a
New Delhi ne sono
convinti. Ma ciascuno
ha le proprie strategie
per realizzare film
mainstream,
tra
cinema più identitario
ed etnocentrico (storytelling indiano per
conquistareilmondo)e
un
cinema
più
globalizzato la cui
indianità sarebbe un
po’ cancellata (per
conquistare il pianeta,
Bollywood
deve
imparare a fare film
come gli americani) –
ma
queste
due
concezioni
sono
probabilmente
incompatibili tra loro.
Dal canto loro, gli
americaniriuscirannoa
imporsi in India con i
loro film di successo o
grazie alla produzione
di contenuti locali?
Tutti i patron degli
studios
americani
intervistati in India o a
LosAngelescicredono,
tanto più ciecamente
dato che hanno di
fronte a loro un
mercato né saturo né
maturo, di 1,2 miliardi
di abitanti. Si tratta di
un mercato talmente
grande e di un paese
talmente
decentralizzato che si
dovrebbe parlare di
“StatiUnitidell’India”.
Chiharagione?Peril
momento
i
primi,
poiché
l’India
ha
saputo proteggere il
proprio
settore
cinematografico e ha
continuato
a
mantenere il 95 per
cento del botteghino
all’interno del paese
con i propri film. Ma i
secondi sanno che
l’americanizzazione
dell’India è ineluttabile
e
si
chiama
“indianizzazione”.
Adattando, all’indiana,
le serie e i film
americani, gli indiani
hanno siglato alcuni
dei loro più grandi
successi. Ma questi
sono
contenuti
americani
che
penetrano lentamente
nel
subcontinente
indiano. Ormai, con la
fine
della
loro
economia di stampo
socialista, gli indiani
partono alla conquista
di
Hollywood
e
acquisiscono case di
produzione negli Stati
Uniti, in cui producono
i loro film di cassetta.
Emergono.
Senza
garanzie di successo.
Per
il
momento
Bollywood continua a
guardare
Hollywood
con invidia e amarezza
poiché non ha ancora
saputolanciareunsolo
blockbuster mondiale,
né global hit, come
dicono gli americani. I
duepaesisiscrutanoe
questofacciaafacciaè
sintetizzato dal nome
“Bollywood”.
Raramente c’è stata
un’espressione
così
imprecisa,
ma
raramente un termine
èstatocosìefficace.
11.
LostinTranslation
La mia inchiesta sui
flussimusicaliinAsiaè
cominciata con una
serata
al
cinquantaduesimo
piano del Park Hyatt
Hotel nel quartiere di
Shinjuju a Tokyo ad
aspettare
un
produttore di “J-Pop”
che non è mai arrivato
all’appuntamento. Per
fortunaeroinunluogo
spettacolare
con
un’eccellente
vista
sulla città. Sembra, in
realtà, che la persona
che dovevo incontrare
mi aspettasse a sua
volta a un bar del
trentottesimo
piano.
L’altra
consolazione
della faccenda è che,
su quella torre, ero
seduto al New York
Bar, quello in cui si
incontrano Bill Murray
e Scarlett Johansson
nel film Lost in
Translation.
La
musica
giapponese di oggi si
chiama“J-Pop”(chesta
per Japan pop). In
questa
regione
dell’Asia
esistono
anche
la
“K-Pop”
coreana, il “canto-pop”
che è il pop cinese in
lingua
cantonese
prodotto a Hong Kong
e il “mandarin pop” (o
pop continentale), che
è il pop cantato in
lingua mandarina e
prodotto soprattutto a
Taiwan. Questi flussi
culturali pop asiatici
sono
complessi
e
disegnano una nuova
geografia
delle
industrie creative i cui
principali centri sono
Tokyo,
Pechino,
Shanghai,
Seul,
Bangkok e Giacarta.
Per cercare di capire
meglio questo mondo
mi sono occupato di JPop,K-Popecanto-pop
facendo inchieste in
unadecinadipaesiper
capire se, su questo
fronte,
esiste
una
cultura
asiatica
comune. Anzitutto, la
musica non funziona
come il cinema e,
anche nel medesimo
continente,
esistono
scambi culturali molto
diversi. “Per il J-Pop
esistono due tipi di
mercato
internazionale,”
mi
spiega
Ichiro
Asatsuma, presidente
della Music Publisher
Association of Japan,
che incontro a Tokyo
nella sede di questa
importante lobby della
musica.
“C’è
un
mercato asiatico in cui
ilJ-Popsiesportacome
generemusicaleveroe
proprio e c’è un
mercato europeo e
americano in cui il JPop è trattato come
‘colonna sonora’ di
cartoni animati, film
d’animazione,
videogiochi e serie
televisive. Sono due
mercatidistinti.”
In Asia, il J-Pop è
forte in Corea del Sud
e nei paesi raccolti
sotto la sigla Sea
(South-East Asia, Sudest asiatico), ma è
completamente
inesistente in India –
paese ermeticamente
chiuso agli scambi di
contenuti culturali con
l’Asia orientale. In
Cina, invece, “il J-Pop
esiste,maseguestrane
vie traverse”, spiega
Masuro
Komai,
presidente
di
Fuji
Pacific
Music
intervistatoaTokyo.
“Strane vie traverse”
è
un’espressione
enigmatica poco chiara
che ho cercato di
capire nel corso delle
mie ricerche. Significa
anzitutto
illegalità,
poiché la pirateria è
molto diffusa in Asia, e
in
Cina
sembra
raggiunga il 95 per
centoperlamusicaeil
cinema
(un
dato
impossibile
da
verificare,
ma
indicatomi
dalla
maggior parte dei miei
interlocutori
in
Giappone, Corea, nel
Sud-est asiatico e nella
Cina
stessa).
Ma
significa
anche
adeguamento
attraverso il sistema
delle“cover”che,come
vedremo, è davvero
centrale in questo
settore. Il J-Pop è più
interessante di quanto
possa
sembrare.
Peraltro, come spesso
accade nel settore
dell’intrattenimento, le
strategie, il marketing
e la diffusione dei
prodotti culturali sono
semprepiùinteressanti
deicontenutistessi.
CoolJapan
“La cosa importante
è che il Giappone, da
una
decina
d’anni
circa, sia tornato cool
inAsiaeciòèaccaduto
soprattutto grazie al JPop,” mi dice Tatsumi
Yoda, amministratore
delegato
di
DreamMusic a Tokyo
(le
stesse
argomentazioni sono
state usate dai coreani
parlando
dei
loro
“drama”). “A lungo,”
prosegue
Tatsumi
Yoda, “il Giappone è
sembrato
occuparsi
solo
del
proprio
mercato interno senza
ambizioni su scala
regionale o a livello
globale. Avevamo un
atteggiamento
indeciso,
come
se
avessimo paura di
apparire imperialisti.
Oggiquestitimorisono
scomparsi e vogliamo
diffondere i nostri
contenuti culturali sia
sul fronte regionale sia
su
quello
internazionale,
con
tuttiimezzipossibili.”
Il Giappone ha la
doppia caratteristica di
essere
un
paese
sviluppato e di non
appartenere
“all’Occidente”. È un
paese
“non
occidentale” che è
stato a lungo un
modello. Nello stesso
tempo, il Giappone è
un paese che, dopo la
Seconda
guerra
mondiale,hafrenatole
proprie
velleità
culturali al punto da
restare completamente
introverso,
dando
l’impressione di essere
chiuso all’interno della
propria cultura. Fiero
della
propria
omogeneità e poco
favorevole
all’immigrazione,
è
passato da un “grande
imperialismo” a una
sorta
di
“piccolo
nazionalismo”.
Il
Giappone è uno dei
paesi più ermetici alle
altre culture ed è
anche uno dei paesi
che meglio resiste alla
cultura
americana,
anche senza quote di
riserva
e
senza
censura. Come accade
anche in India, quando
nel
paese
viene
introdotto un prodotto
culturale
americano
questo viene subito
“giapponesizzato”.
A fronte di tutto ciò,
il Giappone è un paese
che ha poco esportato
la propria cultura. Ha
venduto
walkman,
telefoni
cellulari,
computer, televisori a
schermo
piatto,
Playstation 1, 2, 3 di
propriaproduzione,ma
fino agli anni novanta
ha poco esportato le
proprie
produzioni
cinematografiche,
letterarie e musicali.
Le statistiche fornite
dall’Organizzazione
mondiale
del
commercio (Wto) e
dalla Banca mondiale
lo collocano ancora al
dodicesimo posto fra i
paesi esportatori di
film,
programmi
televisivi, musica, dopo
la Corea, la Russia e
anche dopo la Cina. Si
vendono
bene
i
prodotti
industriali
dell’elettronica,
indifferenziati e senza
una specifica identità
culturale, ma non i
contenuti giapponesi
che invece hanno una
propria e specifica
identità. Si riesce a
vendere
l’hardware,
ma non il software.
Naturalmente ci sono
state alcune importanti
eccezioni: i cartoni
animati negli anni
settanta (Goldrake e
CandyCandy),imanga
negli anni ottanta,
qualche
film
d’animazione
(Akira,
che è tratto da un
manga) e i videogiochi
(Nintendo,Sega,Sony).
In
questi
settori
fortemente legati alle
immagini, il Giappone
ha da tempo più
esportazioni
che
importazioni. Tuttavia,
atortooaragione,per
lungo
tempo
i
giapponesi
hanno
provato un senso di
inferiorità e si sono
sentiti culturalmente
dominati
dall’Occidente. Ciò non
significa, ovviamente,
che
la
cultura
giapponese
fosse
debole o fragile –
tutt’altro. Sul fronte
interno, e pur con
poche esportazioni, la
cultura giapponese è
fiorente, grazie a una
grande
richiesta
interna e grazie a
industrie
creative
autonome (con una
moneta forte come lo
yen, il mercato interno
giapponese
è
il
secondo
mercato
televisivo al mondo e il
secondo
mercato
discografico dopo gli
StatiUniti).
La
globalizzazione
culturale
ha
trasformato
questa
situazione. Il Giappone
è riuscito infatti ad
aprirsi
alla
globalizzazione poiché
lo sviluppo tecnologico
e l’accelerazione della
velocitàdegliscambidi
flussi culturali hanno
permesso
che
si
riducesse il divario tra
mercato interno e
mercato esterno. In
pochi anni è riuscito a
recuperare il proprio
ritardo, anche se le
esportazioni
dei
contenuti
culturali
continuano a essere
ampiamente al di sotto
delle importazioni, nel
cinema, nell’editoria e
nella musica – a
eccezione
dei
videogiochi
e
dei
manga.
Dagli anni novanta,
con la globalizzazione,
è cambiata anche la
geografia degli scambi
culturali:
i
paesi
emergenti (Cina e
Indonesia), quelli non
ancora o già capitalisti
(Corea del Sud, Hong
Kong,
Singapore,
Taiwan) hanno aperto
ampie prospettive di
mercato al Giappone.
LaCina,chesecondole
stime
dovrebbe
scalzare il Giappone al
secondo posto nella
classifica delle potenze
economichemondiali,è
diventata
il
primo
partner economico del
Giapponealpostodegli
StatiUniti.Ovunque,la
diffusione del settore
audiovisivo
ha
decuplicato la richiesta
di contenuti. Così i
giapponesi
hanno
capito
che
non
dovevanorestarechiusi
e isolati (e alla stessa
conclusione
sono
arrivati gli abitanti
della Corea del Sud
che, tenuto conto della
frontiera ermetica che
li separa dalla Corea
del
Nord,
vivono
ugualmente
la
sensazione di essere
relegatisuun’isola).
C’è
stata
una
tentazionediripiegosu
se stessi, è una
strategia che avrebbe
potuto
essere
intrapresa. Tuttavia, il
Giappone era ormai
consapevole
della
saturazionedelproprio
mercato interno, della
necessità di innovare
per
svilupparsi:
l’economia stagnava, il
debito
pubblico
aumentava
e
la
popolazione
invecchiava (il 21 per
centodellapopolazione
giapponese ha oltre
sessantacinque anni,
per questo è il paese
con più anziani al
mondo). All’inizio degli
anni novanta è stata
invece tentata un’altra
strada, una nuova
strategia
battezzata
“Ritorno in Asia” e
fondatasull’obiettivodi
riaffermare la propria
identitàasiatica.
Anzitutto sul fronte
politico.
Il
Meti,
ministero
dell’Economia,
del
commercio
e
dell’industria
giapponese
ha
riconosciuto per la
prima
volta
l’importanza
delle
industrie creative per
l’economia del paese,
soprattutto dopo il
successo
del
videogioco Pokémon di
Nintendo e dei film
Principessa Mononoke
eLacittàincantatadel
geniale
Hayao
Miyazaki. Da questo
momento sono state
fatte sovvenzioni a
questi
settori.
“Il
nostro primo obiettivo
è l’Asia,” mi spiega
KeisukeMurakami,uno
dei direttori del Meti a
Tokyo, “e il nostro
obiettivo finale è la
Cina. Queste sono le
nostre priorità.” Un
messaggio privo di
ambiguità e davvero
significativo,
considerato
che
provienedaunufficiale
di alto rango del
governogiapponese.
Grazie agli sbocchi
commerciali
favoriti
dalla globalizzazione, il
Giappone
ha
cominciato
ad
avvicinarsiaipaesiche
avevano
un
atteggiamento critico
rispetto
all’imperialismo
americano, adottando
argomentazioni
già
sostenute
in
precedenza dai capi di
governo Lee Kuan-Yew
aSingaporeeMahathir
Mohamad in Malesia.
Insieme a questi paesi
e
alla
Cina,
in
quest’ultimo caso non
solo
per
ragioni
economiche,
il
Giappone
intendeva
difendere i “valori
asiatici”
contro
la
decadente
morale
occidentale.
Progressivamente ha
avuto consapevolezza,
o
quantomeno
ha
assunto, la propria
“asiaticità”,
come
attesta uno dei più
celebri
slogan
dell’inizio degli anni
novanta: “Datsuönyua”
(“Fuggire
dall’Occidente, entrare
inAsia”).
In questo modo, i
giapponesi si sono resi
conto di uno scenario
che non sospettavano,
cioè che i paesi vicini
erano moderni. Seul,
Taiwan,
Singapore,
Shanghai
avevano
economie
sviluppate
quanto
quella
giapponese, un ceto
medio
istruito
e
tecnologie
all’avanguardia.
Il
Giappone ha dunque
dovuto fare dietrofront
sulla
“missione
civilizzatrice” dell’Asia
perchénonerapoicosì
avanticomecredeva.
Il“ritornoinAsia”ha
caratterizzato anche la
diplomazia nipponica
sul fronte degli scambi
culturali con gli altri
paesi asiatici, ormai
considerati dei partner
(secondo la cosiddetta
“dottrina
Fukuda”).
Questa
strategia
diplomatica,
accompagnata da una
dissimulata
politica
commerciale, è stata
avviata prima con la
Corea del Sud, poi con
i paesi del Sud-est
asiatico e infine con
quellidelSuddell’Asia.
Naturalmente anche la
Cina è rientrata in
queste strategie e con
questo
paese
il
Giapponehaavviatoun
processo di reciproco
riconoscimento della
rispettiva
potenza
economica.
Anche
l’Australia si colloca
all’interno di questa
strategianipponica.
Inoltre, il Giappone
ha capito che avrebbe
ulteriormente
rafforzato la propria
potenza puntando sui
contenuti culturali e
sui media e non solo
sull’elettronica.
Era
dunque necessario, nel
contempo, ispirarsi al
modello americano e
fargli
concorrenza.
Infatti,
proprio
in
questafaseattornoagli
anni novanta, Sony e
Matsushita
hanno
acquisito gli studios
americani Columbia e
Universal,
confermando così la
strategia
dell’epoca,
quella chiamata delle
“sinergie”
tra
hardware e software
nel settore audiovisivo,
ovvero tra dispositivi
tecnologiciecontenuti.
Igiapponesisirendono
dunque conto che il
potereèfattodiharde
disoftelodetienechi,
nel contempo, è in
grado di creare e
distribuire
prodotti
culturali,chicostruisce
immaginiesogni.Parte
da qui la concorrenza
al
monopolio
americano
delle
industriedeicontenuti,
sullorostessoterreno.
Questa
nuova
strategiaeladifesadel
soft power in stile
asiatico – senza più
guerre e senza più far
paura, ma diffondendo
immagini e diventando
cool–hannopuntatosu
un
settore
particolarmente
florido,
quello
dei
manga,dacuièpartita
la
riconquista
giapponese dell’Asia e
poi del resto del
mondo.
Imanga,mediaglobali
Mi
trovo
nel
quartiere Iidabashi di
Tokyo, nella sede del
gruppo Kadokawa, uno
dei principali editori di
manga in Giappone.
Shin’ichiro
Inouye,
presidente
di
Kadokawa, comincia il
nostro
incontro
entrando nel vivo della
questione:
“Deve
tenere presente che la
cultura giapponese è
aperta al mondo, che
cerca di svilupparsi sui
mercati internazionali
e
che
comunque
resterà profondamente
giapponese.
Ciò
significa
che
diffonderemo i nostri
prodotticosìcomesono
in
campo
internazionale.
Non
cercheremodiadattarli
ai gusti del pubblico di
tutto il mondo, come
fanno
invece
gli
americani. Questo è il
nostropuntodiforza:il
Giappone
è
cool
rimanendo se stesso,
ovvero
fortemente
giapponese”.
Il gruppo Kadokawa,
dall’alto
della
sua
“nipponicità”,
ha
avviato
un’offensiva
internazionale
che
riutilizza i manga su
tutti
i
formati
all’internodellapropria
strategia di diffusione
dei contenuti. Nella
sede del gruppo, a
Tokyo,
constato
peraltro che Keroro,
uno dei personaggi
manga di punta del
gruppo, e di colore
interamente verde, è
presente ovunque, in
ascensore, nella hall
dell’edificio,
nei
videogiochi
e,
ovviamente, in formato
peluche “kawai” sulle
scrivanie dei trecento
disegnatori e autori
che
lavorano
per
l’azienda.“Unmangaè
sempre il risultato di
due lavori: disegno e
scrittura,”
conferma
Shin’ichiroInouye.
Ilmercatodeimanga
è
di
certo
internazionale, ma si
confronta con uno
scenario complesso: il
Regno Unito è un
mercato poco ricettivo
nei
confronti
dei
manga, mentre su
quello francese sono
già ben consolidati;
Germania e Stati Uniti
sono in ritardo, ma in
crescita,
mentre
l’America latina, dopo
una lunga fase di
reticenza per questi
prodotti, ha cominciato
da qualche anno ad
aprirsi.
Il successo della
strategia di questo
grupposispiegaconla
diffusione dei manga
ad ampio raggio su
tutti i tipi di supporto,
ulteriormente possibile
con il digitale, la
telefonia mobile e le
serie
televisive.
Shin’ichiro
Inouye
definisce
questa
procedura “media mix”
(che in Occidente si
chiama “versioning” o
“mediaglobal”).
La convergenza di
contenuti e tecnologie,
così efficace nel caso
dei manga, è una delle
chiavi del successo del
Giappone.
Shubebey
Yosida, amministratore
delegato
di
Sony
Computer
Entertainment
Worldwide
Studios,
intervistatoinunadelle
torri in cui ha sede
Sony
a
Tokyo,
conferma il valore di
questastrategia:“Coni
cartoni animati, i film
d’animazione,
o
videogiochi, i manga, i
comic-book e spesso
con le serie televisive,
abbiamo costruito un
nuovo
sistema
economico giapponese
in cui si uniscono
diversi
settori.
Playstation è un buon
esempio di questa
strategia,
poiché
adattiamo
i
nostri
contenuti a numerosi
giochi”
(tuttavia,
Yoshida non mi dice
che i contenuti di
Playstation 3 sono
spesso sviluppati da
case
europee
o
americane
e
sono
prodottiinCina).
Le esportazioni non
sempre sono facili e la
concorrenza è spesso
agguerrita.Acausadei
brutti ricordi lasciati
dall’“Impero del Sol
levante”
nell’anteguerra,
la
cultura
“made
in
Japan” è stata a lungo
vietata a Taipei e Seul
(fino al 1993 i prodotti
televisivi a Taiwan e
fino al 1998 i prodotti
culturali in Corea).
Inoltre,ilgovernodella
Corea del Sud ha la
tendenza a preferire la
cultura americana a
quella
giapponese,
considerata
più
imperialista
e
più
pericolosaperilpopolo
coreano.
Il “ritorno in Asia”
del
Giappone
ha
seguito una strategia
precisa. La guerra dei
contenuti
è
stata
lanciata
con
lo
stratagemmadiavviare
nuovamente
una
cultura
panasiatica,
sottinteso con forti
tinte giapponesi. Oggi
si gioca nel settore dei
format televisivi, e
degli “idol”, le star
della
musica,
in
concorrenza
tra
GiapponeeCorea.
LaguerratraJ-PopeKPop
Yoyo è la manager
del grande rocker
cinese Cui Jian. La
incontroperuntèinun
albergodiPechino.Jian
ha venduto 50 milioni
di dischi in tutto il
mondo
(è
sotto
contratto con l’inglese
Emi). Yoyo mi spiega
come Cui Jian sia
riuscito a diventare
così celebre in Cina
nonostante la censura.
“Primadilui,icantanti
cinesi facevano musica
di propaganda. Il loro
canoneerailfolkloree
cantavano in playback.
Cui Jian invece fa
musica rock, affronta i
problemi della società
cinese e canta dal
vivo.” Per qualche
tempo Cui Jian è stato
censurato, per aver
tenuto un concerto in
piazza Tienanmen “su
richiesta
degli
studenti” (ci tiene a
precisare), ma poi è
stato
nuovamente
approvato. Le autorità
lo tollerano perché
restasempreneilimiti:
è peraltro protetto da
un immenso successo
popolare,mentreisuoi
attacchi
contro
il
sistema
musicale
cinese (soprattutto la
sua battaglia contro il
playback)
sono
piuttosto contenuti. I
testi delle sue canzoni,
sottoposti come per
tutti gli artisti cinesi al
vaglio della censura,
non pongono più alcun
problema. Peraltro non
gli verrebbe mai in
mente
di
fare
operazioni contro la
Cina,comehannofatto
il
gruppo
inglese
Radiohead, che a un
concertohatiratofuori
labandieradelTibet,e
la cantante islandese
Bjork che alla fine di
unconcertoaShanghai
hacominciatoagridare
“Tibet, Tibet”. Cui Jian
èaccorto,eperquesto
ha potuto aprire il
concerto dei Rolling
Stones in Cina, mentre
leesibizionidiRem,U2
e Oasis sono state
vietate nel paese a
causa
delle
loro
dichiarazioni a favore
del
Dalai
Lama.
“Diversamente
dal
cinema,lamusicaperil
governo cinese non è
un settore strategico,
dunque è molto meno
controllata,”
spiega
Yoyo. “Se è vero che
talvolta il rock, specie
quello alternativo, è
soggetto a censura, il
pop
in
lingua
mandarina è poco
controllato tanto è
edulcorato
e
inoffensivo. Si lasciano
vivere le boy band di
adolescenti innocenti e
un po’ sbigottiti poiché
questopopmainstream
non rappresenta un
pericolo per il governo
e ciò ne spiega la
diffusione
e
il
successo.”
La
musica
pop
ascoltata
in
Cina,
anche se cantata in
cantonese
o
mandarino,
non
necessariamente
è
cinese.
Spesso
è
importata, anche se i
cinesinonlosanno.Per
rendersi
conto
dell’influenza del pop
transasiatico in Cina è
sufficiente fare un giro
nellemigliaiadinegozi
di cd e dvd diffusissimi
a Pechino, Shanghai e
Hong Kong. Gli album
sono venduti in milioni
di copie, e il dato è
certamente più elevato
tenuto conto della
diffusione
della
pirateria che rende
impossibile distinguere
un album originale da
uno
contraffatto.
Spesso i cinesi non
sanno
che
questi
dischi, anche quelli
pirata,
sono
stati
prodotti in fabbriche
del Sud della Cina a
partire da canzoni
registrate al di fuori
delpaese.
Lamusicapiùdiffusa
traigiovanicinesisono
il cantopop di Hong
Kong(incantonese)eil
pop in mandarino. In
entrambiicasisitratta
dimusicapopdiorigini
straniere
e
poi
formattata
per
il
pubblicocineseaHong
Kong e Taiwan, veri e
propri trampolini di
lancio per la diffusione
della musica popolare
cinese.Daquesteparti,
gli artisti sono più
liberi,
la
diversità
etnica è maggiore, le
casediscografichesono
più affidabili (spesso
sono sostenute da
bancheinternazionalie
da agenzie di talenti
americane)
e
il
copyright è un po’
meno protetto. “La
musica asiatica entra
in Cina attraverso
HongKongeTaiwan.Il
pop giapponese ha un
grande
mercato
e
prima
di
essere
distribuito nella Cina
continentale
è
‘rielaborato’,
cioè
tradottoinmandarinoe
presentato con un
packaging
più
conforme al mercato.
Sono delle cover,” mi
spiegaYoyo.
Il J-Pop e il K-Pop si
diffondono dunque in
Cina
e
in
Asia
attraverso il sistema
delle cover. Uno degli
esempi migliori è Jolin,
che riprende i grandi
successi americani, li
rielabora e li ricanta
con
un
accento
“continental”
mandarino nelle sale
degli studi di Taiwan
perilpubblicocinese.
Ilsistemadellecover
è alla base anche del
successo della grande
star coreana BoA, che
canta in coreano per il
pubblico coreano, in
giapponese
per
i
giovani di Tokyo (è
bilingue),iningleseper
igiovanidiSingaporee
Hong Kong e ha
imparato a cantare
anche in mandarino
per piacere al pubblico
cinese. A partire da
Taiwan i suoi dischi
sono diffusi in Cina,
doveèunastarnotada
Shanghai a Shenzhen.
BoA è una sorta di
JanetJacksonasiaticae
dal 2008 ha grande
successo anche negli
Stati Uniti, soprattutto
all’interno
delle
comunitàasiatiche(che
compongono
una
popolazione
complessiva
di
13
milionidipersone).Per
conquistarli
ha
trasformato la propria
immagine di giovane,
sexyekavaï(carina)in
personaggio
più
maturo
e
più
femminista. Per la
versione internazionale
dei suoi album, BoA
registra in inglese e
mandarino (come il
successo Girls on Top
nelsuoquintoalbumin
coreano). BoA è oggi
una delle più grandi
cantanti di tutto il
continente asiatico e
non
sembra
sorprendere nessuno
che una coreana che
parlaanchegiapponese
canti in mandarino. Al
contrario,pericinesiè
cool.
Fa ancora meglio il
gruppo Super Junior,
composto da tredici
ragazzi
coreani
selezionati dalla casa
discografica
per
conquistare tutti i
mercati asiatici. Questi
ragazzi, giovani e belli,
con capelli lunghi alla
coreana, cantano in
diverse
lingue.
Il
gruppoèdunquediviso
in “unità” più piccole
per adattarsi al paese
in cui viene prodotto:
in Cina, l’unità cinese
“SuperJuniorM”canta
in
mandarino,
in
Giappone“SuperJunior
J” fa concerti in
giapponese, mentre in
Corea è di scena
“Super
Junior
K”.
Attraverso
diverse
combinazioni, questo
gruppo può esibirsi
ovunque
in
Asia
cantando una lingua
nazionale conosciuta
dalpubblico.
Esistono poi altri
casi:laboybandSmap
(composta da cinque
ragazzi
giapponesi
diventati celebri su
Channel V, emittente
che trasmette in tutta
l’Asia),
U2K
(due
giapponesi
e
un
sudcoreano),
Tvxq!
(cinqueragazzicoreani
che
cantano
in
mandarino e diventati
dellestarinGiappone),
Dreams Come True
(trio
di
Taiwan
prodotto da Sony) e
Hot (gruppo coreano
che
canta
in
giapponese e cinese).
Esistono anche band
composte da ragazze:
Girls’
Generation
(Corea),
Ses
(trio
coreano composto da
una
coreana,
una
giapponese
e
un’americana). Anche
alcuni solisti sono
prodotti con questi
formati variabili: Rain,
un giovane coreano, è
diventato una sorta di
Michael
Jackson
asiatico con i suoi
album fatti soprattutto
per i giapponesi; Dick
Lee è una star di
Singaporechecantada
tempo in inglese e
mandarino;
Stefanie
Sun è una cantante di
Singapore che canta in
mandarino e in diversi
dialetti cinesi, così ha
potuto
aprirsi
al
mercato cinese, di
Taiwan e della Cina
continentale; infine c’è
Jay Chou, il celebre
taiwanese scritturato
dalla
Sony,
anche
attore in La città
proibita
di
Zhang
Yimou, che canta in
mandarinoesivesteda
cowboy per piacere in
tuttal’Asia.
Spesso,
questi
cantantirifannocelebri
canzoni di successo
anglosassoni,
come
Ymca
dei
Village
People
cantata
in
mandarino
o
cantonese, e ottengono
un immenso successo
locale.
Il
pubblico
cinese si entusiasma
per queste hit che,
cantate in mandarino,
sembrano
canzoni
nazionali; nessuno sa
realmente che sono
prodottedagiapponesi,
coreani e taiwanesi
(talvolta da giapponesi
a Taiwan con il
marchio Sony Music
Taiwan).
Attraverso
questi giochi linguistici
emerge
come
la
globalizzazione
culturale sia fatta di
riadattamenti vari: la
musica americana è
ripresadagiapponesie
coreaniepoiregistrata
da una boy band o una
idolinmandarino.
BoA, Super Junior,
Hot, Ses, Tvxq! sono
prodotti in Corea da
Sm
Entertainment.
Negli uffici di Seul
incontro Lee SooMan,
amministratore
delegato di Sm: “La
strategia del nostro
gruppo è costruita
attorno alla lingua.
Costruiamo boy band a
partire da casting fatti
a ragazzi che parlano
diverse lingue come i
membri
di
Super
Junior,chesonotuttidi
diverse nazionalità. In
alcuni casi facciamo
fareaicantanticorsidi
lingua,
come
è
accadutoperBoAcheè
sotto contratto con noi
da quando ha undici
anni e a cui abbiamo
fatto
imparare
il
giapponese, l’inglese e
il
mandarino.
Generalmente,
le
nostre
boy
band
possono cantare in
quattro
lingue:
coreano,
inglese,
giapponese
e
mandarino – talvolta
anche più di quattro
lingue.
Poi
organizziamo
grandi
campagnedimarketing
completamente
attestate sulla realtà
locale
a
cui
ci
rivolgiamo:
promozione, prodotti,
trasmissioni televisive.
Infine, i nostri artisti
sono
‘multi-purpose
stars’, ovvero sanno
cantare,
ballare,
recitare nelle serie
televisive,
fare
i
fotomodelli.Sonomolto
polivalentieconquesto
sistemaabbiamocreato
lamodadelleboyband
coreane”.
Come spesso accade
nel K-Pop e nel J-Pop,
la maggior parte delle
star
di
Sm
Entertainment
sono
degli
idol
(in
giapponese
aidoru):
sono scritturati molto
giovani,tragliundicie
i quindici anni, per il
loro fisico e per la loro
voce. “La bellezza è
uno dei canoni che
riesce meglio a essere
esportato da un media
all’altro e da un paese
all’altrointuttal’Asia,”
conferma seriamente
Lee-SooMan.
Anche altre aziende
seguono simili logiche
di “cross-media” in cui
i diversi ambiti della
comunicazione
sono
messi in connessione
tra loro, per esempio
Sony dal suo quartier
generale per l’Asia a
Hong Kong (sede che
controlla
tutto
il
mercato asiatico e che
dipende direttamente
da Sony negli Stati
Uniti, escludendo il
Giappone
seguito
direttamente
da
Tokyo). Così, in Asia,
continente della fusion
in
campo
gastronomico, scopro
anche la fusion dei
media e delle lingue.
Per
conquistare
il
pubblico asiatico, la
complicata
strategia
delle
case
discografiche
giapponesi si basa su
due
elementi:
“localization” e “media
fusion”. Ho poi capito
che anche le serie
televisive seguono la
stessastrategia.
“Glocalization”
è
dagli anni novanta
un’espressione
alla
moda (che sta per
“globallocalization”).A
dirla
tutta,
sono
sempre stato un po’
diffidente verso questo
concetto di stampo
vagamente
commerciale e i cui
simboli
sono
McFalafels
di
McDonald’s in Egitto,
McLuks al salmone in
Finlandia e McHuevos,
con un uovo, in
Uruguay.Maadesso,in
Asia, con BoA e Super
Junior
comincio
a
conoscere
la
dimensione locale e
regionale della musica
pop. Diversamente dal
cinema, in cui gli
scambi internazionali
anche nello stesso
continente sono rari,
nella
musica
sono
piuttostosviluppati.
Giapponesi e coreani
hanno
pragmaticamente
capito
che
per
esportare
la
loro
musica e le serie
televisive in Cina e
ovunque in Asia non
bisogna
imporre
prodotti standard né
difendere la propria
lingua. Una strategia
ancora più fine di
quella
usata
dagli
americani. Hanno così
inventato la “cultura
sushi”, più “glocale”
della
cultura
di
McDonald: un prodotto
complesso, variegato e
mai identico, ma che
ovunque
evoca
il
Giappone,
indipendentemente
dalla lingua che si
parla.Questatecnicadi
“relocalizzazione”
avviene
attraverso
l’efficace tecnica delle
cover, un fenomeno
molto più diffuso di
quantoimmaginassi.La
stessa soluzione con il
successo
della
differenziazione
si
ritrova a Channel V
(l’emittente del gruppo
Star Tv con sede a
Hong Kong) rispetto
all’emittente
americanizzata
Mtv
Asia (con sede a
Singapore).Glistudidi
Channel V sono a
Taiwan,
l’emittente
trasmettemoltaJ-Pope
K-Pop e la musica
mandarina formattata,
i conduttori parlano
mandarino
e
i
contenuti
sono
panasiatici, locali e
menoamericani.Grazie
a questa “asiaticità”,
l’emittente di Murdoch
ha sopravanzato la
concorrenza
del
gruppo Viacom. Mtv
Asia ha poi corretto il
tiro, soprattutto con la
trasmissione in prima
serata Jk Hits, che
mandainondalehitdi
J-Pop e K-Pop. Anche
Axn,
l’emittente
musicale di Sony con
sede a Singapore,
segue
queste
dinamiche.
All’interno di questa
concorrenza, i coreani
hanno
promosso
i
propri artisti K-Pop in
giapponese
in
Giappone e hanno
preso vantaggio sui
nipponici
che,
inizialmente,
non
volevano cedere sulla
questionelinguistica.A
farnelespeseèstatala
J-Pop. Ma i giapponesi
hanno
poi
saputo
rispondere con armi
proprie: concorsi di
idol, serie televisive,
telefonia
mobile,
videogiochi e, ancora
unavolta,imanga.
AsiaBagus! (L’Asia è
formidabile), questa è
stata la prima reazione
giapponese:
un
concorso
di
idol
pensato
dalla
televisione giapponese
Fuji Tv, registrato a
Singapore (per dargli
un tocco transasiatico)
e
trasmesso
in
contemporanea
in
CoreadelSudeinuna
decinadialtripaesidel
Sud-est asiatico per
conquistare
altri
mercati. Sony Music
Japanharealizzatouna
trasmissione simile, La
voce
d’Asia,
per
identificare la nuova
popstar asiatica e che
gli ha permesso per
esempio di lanciare la
cantante
filippina
Maribeth diventata poi
una star in Indonesia,
grazie al marketing
giapponese. Anche le
agenzie
di
talenti
giapponesi Amuse e
HoriPro Entertainment
Group
hanno
moltiplicato i concorsi
inCinaperindividuare,
traledecinedimigliaia
di candidati, la futura
star in mandarino. A
modoloro,igiapponesi
funzionano in Asia
come gli americani nel
restodelmondo.Ancor
meglio, hanno una
sorta di filtro che
traduce la cultura
“occidentale”
per
l’Asia. Il loro maggior
successo rispetto agli
Stati Uniti, soprattutto
in Cina, viene dal fatto
che si sono concentrati
sul
settore
dei
videogiochi e della
musica, molto meno
sensibilidaunpuntodi
vistapoliticorispettoal
cinema.
In
questo
modo,
la
cultura
giapponese
perde
molta
della
sua
nipponicità.
Un’altra
strategia
della J-Pop è la
diffusione dei “drama”.
La musica giapponese
è stata associata ai
contenuti
di
serie
televisive di successo:
come accade in India
con le songs & dances
dei film di Bollywood,
l’onnipresenza
delle
boy band nei drama
giapponesi
ha
permesso di rendere le
canzoni celebri nei
paesi
asiatici
in
relazione
alla
diffusione delle serie
televisive. Infine, i
giapponesi hanno fatto
ancora meglio con le
tecnologie. La J-Pop ha
invaso la telefonia
cellulare
soprattutto
grazie alle Ring Back
Tones, suonerie che
scattano mentre si
attende la risposta
dell’interlocutore (e da
non confondere con le
suonerie
che
sostituiscono il trillo).
C’è poi il Color Call
Tone,unbranodiJ-Pop
che fa da sottofondo
alle conversazioni. Le
copertine degli album
sono
ovviamente
trasformate in sfondi
per i cellulari. Queste
invenzioni giapponesi,
eanchecoreane,fanno
furore in Corea, in
Indonesia, a Taiwan e
ovunque in un’Asia
tornata
“giapponesizzante”.
In ogni caso, è
sorprendente
constatare
che
la
musica ascoltata in
Asia è quella nazionale
oppure quella “per
tuttal’Asia”esiascolta
poco quella americana:
in Giappone si stima
che
la
musica
giapponese faccia l’80
per cento delle vendite
contro il 20 per cento
della
musica
anglosassone; anche in
Corea,laK-Popsembra
occuparel’80percento
del mercato nazionale;
a Hong Kong la cantopopraggiungeil70per
centodellevenditeela
musica
asiatica
è
dominante anche in
Indonesia. Forse la
musica
“ascoltata”,
rispetto
a
quella
“comprata”,
è
più
favorevole
agli
americani per via della
pirateria,
dello
scaricare musica da
internet
e
della
televisione,
ma
in
proporzioni
molto
diverse.
Infatti,
la
pirateria
coinvolge
anche J-Pop e K-Pop e
non solo i prodotti
americani. In Cina e in
Indonesia, e nei paesi
poveri del Sud-est
asiatico
come
il
Vietnam, i cd e i dvd
piratati offrono alle
serie coreane, alla J-
Popeaifilmamericani
ampiadiffusioneesono
tollerati dal mercato
ufficiale.
C’è
tuttavia
un’eccezione:
Singapore. All’interno
dellacittàstatodomina
lamusicaanglosassone
conl’80percentodelle
vendite.
Eppure,
quandosiintervistanoi
dirigentidelleindustrie
creative
locali,
si
constatacheildibattito
sulla
minaccia
all’identità
culturale
non esiste, mentre
sembra fondamentale
in Cina, Giappone e
Corea del Sud. A
Singapore,
paese
multiculturale
e
comunitarista,
si
importano
senza
problemi
tutti
i
contenuti
che
provengono
dall’esterno e non si
cerca
neanche
di
adattarli. Non c’è filtro
come in Giappone, né
censura
antioccidentalecomein
Cina,néfusioncomein
Thailandia:
a
Singapore, gli abitanti
parlano spesso tra loro
in mandarino e in
inglese, accolgono i
prodotti
culturali
americani, talvolta a
scapito dei prodotti
asiatici (alla gente del
Sud-est asiatico piace
andare a Singapore a
fare turismo per avere
l’impressione di stare
“in Occidente”). È un
paese
molto
diversificato, è un’Asia
in miniatura al punto
che,
arrivando
a
Singapore, mi sono
detto che in qualche
modo è “l’Asia per
principianti”. Eppure,
la città stato è la
quintessenza di una
formadimodernitàche
non
è
né
l’occidentalizzazionené
l’americanizzazione,
ma una sorta di
singaporizzazione
in
cui la cultura di ogni
minoranza
è
valorizzata. Dopo aver
inventato, come dicono
da quelle parti, “il
capitalismo in stile
asiatico”
e
oggi
convinti che i valori
dell’Asia
siano
superiori
a
quelli
occidentali, gli abitanti
di Singapore stanno
pensando una nuova
cultura transasiatica.
Se questa ipotesi fosse
valida, è probabile che
coinvolgerà non tanto i
prodotti e i contenuti
ma i servizi e, come a
Hong Kong e Taiwan,
cercherà
tutti
gli
avvicinamenti possibili
conlaCina.Gliabitanti
di Singapore sono
infattianchecinesi.
Nel cinema, come
nella
musica,
agli
americaninonriescono
tutti i colpi in Asia. È
ormai lontano il tempo
–gliannicinquanta–in
cui erano acclamati
dagli asiatici per aver
inventato la macchina
elettrica che cuoce il
riso,
simbolo
dell’“american way of
life” che arrivava in
Asia.
I
dirigenti
americani,chevogliono
diffondere in tutto il
mondo
contenuti
mainstream identici, in
inglese, non hanno la
stessa finezza dei loro
colleghi della Corea, di
Taiwan, di Singapore e
Hong Kong che per
rendere i loro prodotti
culturali mainstream
accettano di cancellare
le singolarità nazionali
e la lingua. E in questi
flussiinterasiatici,sela
cavano
anche
se
perdono – lost in
translation – la loro
identità.
Restano i drama, le
serie
televisive
asiatiche.
Comincia
un’altra
battaglia
culturale,
ulteriormente diversa
da cinema e musica. Il
mainstream ha regole
che
cambiano
a
seconda dei continenti
e dei settori. E questa
voltalaguerranonèsu
scala
regionale,
è
planetaria.
12.
Geopoliticadeidrama,
delletelenoveledel
Ramadanedialtre
telenovele
In tutta l’Asia sono
chiamati “F4”. Sono i
quattro
protagonisti
della serie televisiva
Boys Over Flowers, la
“F”significa“fiori”,ma
anche
“belli”
nel
linguaggio usato dagli
adolescenti.
Una
ragazzaprovenienteda
una famiglia povera, i
cui genitori gestiscono
una
lavanderia
automatica, riesce a
entrare in un liceo
d’élite in Corea in cui
deve
subire
la
prepotenza di quattro
giovani ricchi, belli e
arroganti
che
intimoriscono
gli
studenti più fragili. La
ragazza comincia a
proteggere le vittime
delle ingiuste angherie
degli “F4”, ma si
innamora di uno di
loro. La serie, una
sorta di Sex and the
City
in
versione
maschile, è composta
daventiquattroepisodi,
contiene
vicende
intrecciate
e
ramificate,
la
sceneggiatura è rapida
e piena di colpi di
scena, ma dietro una
trama apparentemente
semplicistaemergeuno
spaccato sociale ben
più
profondo.
All’interno della serie
la
musica
è
onnipresente
ed
efficace: ha contribuito
sia a pubblicizzare e
rendere
noto
il
programma, sia alla
venditarecord,intutta
l’Asia, della colonna
sonora.
La storia è tratta da
un celeberrimo manga
degli anni novanta, di
quelli che si chiamano
“shojo manga” poiché
rivoltoaunpubblicodi
ragazze tra i dieci e i
diciotto
anni.
Inizialmente, nel 2001,
Boys Over Flowers era
una serie televisiva di
Taiwan, poi nel 2005 è
stata
realizzata
la
versione
per
il
Giappone, nel 2008
quella per la Corea e
sono
già
stati
annunciati i remake
perleFilippine,mentre
per la Cina si parla
anche di un film e di
una
commedia
musicale. Tutti questi
adattamenti a partire
da un format creato a
Taiwan
hanno
contribuito al successo
in tutto il continente
asiatico, anche nei
paesi dove aveva già
trionfato la versione
originale.Ifan–milioni
di
adolescenti,
soprattutto ragazze –
commentano le diverse
versioni,confrontanole
duefamiglieingioco(è
una sorta di West Side
Story all’asiatica) e
discutono
all’infinito
della
bellezza
di
ciascuno dei quattro
ragazzi(ilmiopreferito
è Kim HyunJoong, ma
leragazzepreferiscono
ingenereLeeMinHoo
Kim Sang Bum). La
versionecoreana,cheè
il terzo remake, ha
ottenuto un grande
successo in prima
serata su Kbs, la
televisione
pubblica
coreana, e poi in
Giappone, Indonesia,
Vietnam, Thailandia, a
Taiwan, e grazie al
mercato nero di dvd in
Cina – così è diventata
ilfenomenoasiaticodel
2009.
In
Corea,
peraltro,
data
l’importanza di questi
programmi, non si
parla
di
serie
televisive,
ma
semplicemente
di
“drama”.
Labattagliadeiformat
“Boys Over Flowers
in Asia è un vero e
proprio
fenomeno
sociale,” spiega BJ
Song, personaggio di
culto in Corea del Sud,
celebre
produttore
musicale e presidente
di Group8, importante
società nel settore
audiovisivo
che
produce musica K-Pop,
commedie musicali e
soprattutto
celebri
drama coreani – tra
cui, ovviamente, Boys
Over Flowers. Dal suo
ufficio si accede a un
immenso terrazzo con
vista sul quartiere hip
di Itaewon, a Seul. Ha
grossi occhiali, un
pizzetto bianco e parla
bene inglese. “Nella
versione coreana di
Boys Over Flowers
abbiamo
voluto
mantenere la velocità
originale del manga, i
cliffhangers che sono
l’elemento che crea
suspense.
Inoltre,
l’esperienza del liceo è
stata
rielaborata
affinché
anche
le
persone anziane, nel
ripensare alla loro
adolescenza, potessero
identificarsi con gli
F4.” Gli chiedo poi di
indicarmi
le
caratteristiche
delle
soap opera coreane. BJ
Song quasi sobbalza:
“Non sono delle soap!
Sono dei drama! Sono
veri
e
propri
teleromanzi con storie
e una vera e propria
sceneggiatura.
Alle
soap
manca
la
struttura, servono solo
a far passare il tempo.
Noi invece abbiamo
creato la “Hal-lyu”. In
Europa,
Hal-lyu
(letteralmente
“nouvelle
vague
coreana”)siriferisceai
film d’autore coreani,
mentre
localmente
l’espressione
è
utilizzata soprattutto
per
richiamare
il
successodeidrama.La
“nouvelle
vague
coreana” non è stata
un
fenomeno
per
festival e cineforum,
ma un fenomeno di
intrattenimento
del
pubblico di massa. È
statomainstream.
BJ Song tamburella
su uno dei suoi
computer
Samsung
(siamo in Corea). Il
nome così simile a
quello di un dj ben si
addice al personaggio,
un musicista che ha
composto la colonna
sonora di decine di
serietelevisiveedifilm
celebri in tutta l’Asia.
Non oso chiedergli se
sia il suo vero nome
oppure,
dato
il
contesto, se è un
“cover name”. Dopo
una lunga pausa, BJ
Song
prosegue
il
discorso: “Le nostre
serie devono essere
conformi
ai
valori
asiatici. In Corea il
confucianesimoèmolto
forte, non tanto come
religione, ma come
cultura. Ciò significa
chebisognarispettarei
propri antenati, che la
famigliaèilfulcrodella
società e che i legami
di sangue prevalgono
sulle altre leggi; in
Corea le figure del
fratello e della sorella
sonofondamentaliedè
impensabile
poter
discutere un ordine
imposto dal padre o da
un fratello maggiore.
Poi c’è tutto ciò che
riguardailmatrimonio:
l’amore
è
una
responsabilità
che
impegna, quindi non si
può sposare qualcuno
se
rifiutato
dalla
famiglia e si deve
sottostare al codice
coreano del seon, una
sorta di matrimonio
combinato dai genitori,
soprattutto se non si è
ancora
sposati
a
trent’anni. I nostri
dramadevonoriflettere
questa mentalità, un
codice etico molto
rigido. Nel contempo,
una volta rispettato
questo codice come
sfondo, sullo schermo
abbiamo la libertà di
mostrare molte cose.
Per esempio, si può
ridere. Un drama deve
essere fun, divertente.
Poi bisogna parlare
della realtà, poiché un
drama coreano è molto
reale,
gli
attori
recitano normalmente,
senza
quelle
interpretazioni
eccessivechesivedono
nelle serie giapponesi,
ed è qui che la cosa
diventa interessante.
Nelle nostre serie non
c’è sessualità, ma si
vedono persone che si
baciano: qui non siamo
a Bollywood! E poi
nellavitaquotidiana,ci
sono
tradimenti,
prostituzione
e
omosessualità. Certo,
possiamoparlarne.Elo
facciamo”.
Una
cosa
che
sorprende nei drama
coreani è la presenza
costante
di
attori
giovani e belli. “La
bellezza fisica è il
principio fondamentale
di un drama coreano,
in particolare quella
maschile, poiché il
pubblico delle serie
televisive è composto
soprattutto
da
casalinghe e ragazze.
Per
esempio,
per
ognuno dei quattro
personaggi di Boys
Over Flowers, abbiamo
fatto
provini
a
quattrocento
attori.
Inoltre, dal momento
chelenostreseriesono
destinate
all’esportazione e sono
dunque doppiate, gli
attori sono importanti
soprattutto per il loro
lookenonperlavocee
la dizione. Spesso in
Asia si pensa che i
giovanicoreanisianola
quintessenza
della
bellezzaasiatica,iltopmodel tipo. Esportiamo
anchequesto.”
L’esportazione
dei
drama coreani è un
settoreeconomicovero
e
proprio.
Alla
direzione del network
Mbc a Seul, JungSook
Huh
conferma
l’importanza di questo
mercato. “Siamo il
primo produttore di
drama
coreani.
Li
vendiamo in tutto il
continente asiatico, ma
vendiamo anche il
format,
mercato
altrettanto importante.
Il format, che è sotto
copyright, è qualcosa
di più di un’idea e
qualcosa meno di un
drama: acquistando i
diritti, un produttore
può rifare la serie,
riproporne la trama e i
personaggi, ma ha la
libertà, regolamentata
dal
contratto,
di
adattarla alla realtà
locale affinché sia
compatibile
con
specifici valori locali.
Inoltre è interpretata
da attori di quel paese
che parlano la lingua
notaatutti.”
Laguerradelsettore
audiovisivo in Asia
orientale, tra Giappone
e Corea, tra Corea e
Taiwan, tra Taiwan e
Cina è in realtà una
guerra sui format più
che sui programmi. Si
parla
peraltro
di
“format
trade”,
mercatodeiformat.
Dopo i giapponesi, i
coreani sono diventati
potenti esportatori di
formatdidrama.Èuna
questione importante
poiché la loro lingua è
poco parlata in Asia e
dunque
hanno
maggiore interesse a
mettere sul mercato
contenuti
più
che
prodotti finiti. Di fatto,
la Corea vende il
doppio
di
format
rispetto a serie fatte e
finite.
L’aspetto
affascinante
è
la
globalizzazione
di
questi format e il loro
mercato.
Lavenditadelleserie
e dei format coreani è
in forte crescita in
Asia: anzitutto verso il
Giappone
che
per
ragioni
finanziarie
costituisce il primo
mercato. Poi ci sono
Taiwan, Hong Kong,
Singapore, ovvero i
mercati “cinesi”, con
tutti i relativi problemi
dell’aspirazione e delle
difficoltà di introdursi
nellaCinacontinentale.
“La Cina è un mercato
che
fatichiamo
a
raggiungere
direttamente.
Ci
arriviamo soprattutto
con la vendita dei
format,
oppure
ci
arriviamo
con
coproduzioni realizzate
con Shanghai Media
Group e altre aziende
pubbliche cinesi che
fanno da intermediari.
Quando queste strade
non
funzionano,
dirottiamosullavendita
dei format a Taiwan o
Singapore, poi sono
loro a introdurli in
Cina,” commenta JungSook Huh. In altri
termini,
i
coreani
hanno gli occhi puntati
sulla
Cina
e,
constatando
la
diminuzione
della
produzione di serie
televisive continentali
dapartediHongKong,
hanno
deciso
di
infilarsi nella breccia.
La censura cinese
tollera queste serie
inoffensive
per
adolescenti poiché non
minacciano la sua
sovranità. Se però il
loro successo dovesse
ulteriormente
aumentare, è possibile
un intervento della
censura per ragioni di
protezionismo
economico.
La strategia della
Corea del Sud consiste
inoltre nel cercare
mercati di “serie B”,
quelli che interessano
meno americani e
giapponesi.
La
Thailandia,
per
esempio, è un mercato
fondamentale per la
Corea,
come
l’Indonesia per via dei
suoi quasi 250 milioni
di abitanti. A questo
mercato appartengono
anche
il
Sud-est
asiatico,leFilippine,la
Malesia e il Vietnam,
nonostante il basso
potere d’acquisto. La
strategia dei coreani è
invadere questi spazi
economici con serie
televisive
a
buon
mercato,ancheacosto
di perdere denaro,
come
accade
in
Vietnam,
ma
per
abituare gli spettatori
alla cultura coreana e
poter
trarre
poi
benefìci
politici
e
finanziari. I drama e la
K-Pop sono per la
Corea uno strumento
per esercitare soft
power.
Unaltromercatoche
suscita
particolare
attenzione è quello dei
coreanichevivonoaldi
fuori
del
paese,
soprattutto negli Stati
Uniti, dove risiedono
1,3 milioni di coreani.
“I
coreani-americani
sono la chiave del
nostro successo in
Nord
America,
soprattutto grazie ai
network specializzati
via cavo,” spiega JungSook Huh. C’è tuttavia
un
altro
mercato
ugualmente sensibile,
quello dei nordcoreani.
Nella Corea del Sud ci
si
pensa
continuamente,manon
se ne parla. Non è
tanto una questione di
denaro,
poiché
l’obiettivo è politico. In
Corea del Sud tutti
hanno
lasciato
intendere
che
la
diffusione dei drama
oltre
il
confine
militarizzato
rappresenta una nuova
frontiera da abbattere,
è una priorità non
dichiarata.Seilconfine
politico è insuperabile,
i sudcoreani hanno
pensatoaunastrategia
di aggiramento tramite
la diffusione delle loro
serie
televisive
attraverso il mercato
nero
e
la
Cina
continentale.
Nelle
cittàalconfinetraCina
e Corea del Nord, i
drama coreani e la
musica K-Pop sono più
facilmente accessibili
poiché queste province
sono
popolate
da
numerosi cinesi di
origine coreana e le
relazioni commerciali
tra Cina e Corea del
Nord sono attualmente
in forte espansione. I
cinesi rivendono ai
nordcoreani i vecchi
modelli di lettori di cd
e
videoregistratori
ormai obsoleti con un
traffico
commerciale
molto
intenso,
inarrestabileancheper
la polizia nordcoreana,
particolarmente
ossessionata
dal
controllo dei prodotti
culturali americani o
sudcoreani. Sotto la
dittatura comunista di
KimJong-ilsinasconde
in realtà un mercato
nero molto diffuso, che
èinrealtàunaformadi
capitalismo esasperato
e
sotterraneo
(l’economiasudcoreana
è circa cinquanta volte
più ricca di quella del
Nord,
con
una
popolazione che è
solamente il doppio).
“Fino a qualche anno
fa,sesivenivasorpresi
con
un
disco
sudcoreano si finiva
direttamente in galera.
Oggi tutt’al più accade
che venga sequestrato
dai
poliziotti
nordcoreani che lo
tengono per sé,” mi
spiega a Seul un
importante
professionista
del
commercio con la Cina
(che rifiuta di essere
menzionato per non
mettere in pericolo la
suaazienda).
Sul
fronte
delle
esportazioni dei drama
coreani c’è poi il
mondo
musulmano.
“Vendiamomoltidrama
in
Medio
Oriente
poiché
le
donne
musulmane
si
identificano totalmente
con
i
personaggi
femminili
coreani,”
conferma,
alla
direzione
dell’emittente Mbc a
Seul, Jung-Sook Huh.
“Le nostre idee sulla
famiglia,sulruolodella
donna sono piuttosto
compatibili.
Per
esempio, la nostra
serie Jewel in the
Palace,
in
cinquantaquattro
episodi, ha avuto un
successo immenso in
Iran e in Afghanistan.
Anche i paesi del Golfo
costituiscono
un
mercato
in
forte
crescita.Nelcontempo,
dobbiamorisolvereuna
questione
molto
difficile tra aspettative
differenti:daunaparte
ci sono quelle molto
conservatrici,
per
esempio, dei paesi
musulmani; dall’altra
c’è la censura cinese
che
vuole
storie
romantiche,difantasia,
con personaggi ben
identificabili
come
buoni e cattivi, poi ci
sono quelle più postmoderne, se mi si
passa il termine, del
pubblico giapponese e
dei coreani-americani,
che vogliono storie più
attuali,
più
imprevedibili e meno
rispettose dei codici.
Dobbiamo
dunque
giostrarci tra questi
mercatiesispiegacosì
perché
produciamo
diversi format. Per
esempio, in Jewel in
the Palace con la star
mondiale Lee YoungAe, che interpreta una
ragazza povera che
diventa una grande
cuoca e va a fare lo
‘chef’ alla corte di un
re, la storia si svolge
cinquecento anni fa;
oppure, Coffee Prince,
una miniserie in stile
‘gay-friendly’ in cui il
protagonista non vuole
stare
ai
dettami
familiari, apre un bar
in un quartiere alla
moda di Seul dove
assumecomecamerieri
solo ragazzi sexy e alla
fine si innamora di un
travestito
che
si
rivelerà poi essere una
donna…”Ineffetti,una
cosapost-moderna.
In una periferia di
lusso di Seul, incontro
ilgiornodopoKimJong
Sik,
amministratore
delegato
di
Pan
Entertainment,
una
importante casa di
produzionedidrama.È
accompagnato da una
produttrice televisiva e
siccome nessuno dei
due parla inglese, e io
quel giorno sono senza
interprete, fa venire
immediatamente uno
dei giovani attori più
promettenti della casa,
Yoo Dong-hyuk, che è
bilingue. “I drama
coreani sono molto
atipici.Èunaquestione
di desiderio, passione,
amorepuroegrande.È
questo che ha fatto il
successo in tutta l’Asia
della
nostra
serie
Winter Sonate.” Kim
Jong
Sik
insiste
sull’importanza della
musica nei drama,
anche
perché
contribuisce
a
far
conoscere in Asia i
cantanti di K-Pop.
Come accade anche a
Bollywood,iduesettori
si
sostengono
a
vicenda.
A un certo punto
dell’intervista,
Kim
Jong Sik smette di
parlare.Iononriescoa
capire cosa voglia dire
e neanche Yoo Donghyuk riesce a tradurre.
Con l’aiuto di un
traduttore automatico
Samsung,KimJongSik
riesce a comunicarmi
la parola che voleva
dire, “confucianesimo”.
È la seconda volta che
usa questo termine
durante
il
nostro
incontro. Poi riprende
il discorso: “La Cina
comunista ha rigettato
il confucianesimo, il
Giapponenonlohamai
accolto, solo i drama
hanno mantenuto lo
spiritodiConfucioeciò
spiegailsuccessodelle
nostre serie in Asia. È
uno spirito a cui i
cinesi
aspirano
consapevolmente,
mentre i giapponesi lo
cercano
inconsciamente.
I
coreani, invece, pur
essendo
in
maggioranza cristiani,
hanno
lo
spirito
plasmato
sul
confucianesimo”.
Personalmente, questa
analisi pseudoreligiosa
nonmiconvincemolto,
l’ho riportata come mi
èstatadetta.
Poco dopo, al caffè
Starbucks dell’angolo,
proseguoildialogocon
Yoo Dong-hyuk, che è
stato il mio traduttore
improvvisato. È un
fotomodello di ventisei
anni,
indossa
una
camicia bianca e una
lunga giacca nera,
jeans di marca e ha i
capelli spettinati come
gli attori di Boys Over
Flowers. Gli chiedo
come si chiama questo
taglio di capelli così
diffuso tra i giovani
idol:“Allacoreana”,mi
risponde
semplicemente
Yoo
Dong-hyuk.
E
poi
aggiunge: “Spesso è
questo taglio di capelli
arendercisweet–edè
quello che adorano le
ragazze”. Il patron del
gruppo
Pan
Entertainment, che ha
sotto
contratto
il
ragazzo, di lui mi ha
dettocheharecitatoin
sei drama e che negli
Stati Uniti, per i
coreani-americani,
è
una star. Gli chiedo
come mai parli così
bene l’inglese. “Ho
lavoratocomeattorein
America,” mi risponde.
“Sono affascinato dalla
cultura
televisiva
americana,dalmododi
recitare degli attori di
Friendsenaturalmente
daWentworthMillerin
Prison Break.” Poi
aggiunge:
“Mi
piacerebbe essere una
specie di Yunjin Kim in
versione
maschile
(l’attricediSeulcheha
recitato nel celebre
film coreano Shiri
prima
di
essere
scritturata per la serie
televisiva
americana
Lost)”. Alla domanda
su come si diventa una
star in Corea risponde:
“È una questione di
fortuna, di cogliere
l’attimo
facendosi
trovare
pronti
al
momento giusto e
bisogna essere belli, è
questo ciò che conta”.
Gli chiedo poi in che
forma sia legato alla
suacasadiproduzione,
se è dipendente o a
contratto. “Non posso
rispondere,
deve
chiederlo
al
mio
agente,
è
lui
a
occuparsi di queste
cose.”
In Corea e Giappone
resto sorpreso dalla
giovane
età
degli
attori. A Bollywood e
HongKonglestarsono
attori maturi diventati
celebri nel corso del
tempo – Ambitabh
Bachchan, Shah Rukk
Khan, Jackie Chan,
Andy Lau. In Corea la
maggior parte degli
attori è giovanissima,
attorno ai vent’anni.
Esiste una cultura
esasperata del “teenpop”: i desideri degli
adolescenti
determinano i consumi
dell’insieme
della
popolazione. Si tratta,
a mio avviso, di un
fenomeno contrario a
quanto è avvenuto per
secoli nella cultura
europea ma anche
asiaticaconRamayana,
Mahabharata,
Akira
Kurosawa, Kenzaburo
Oe e Yukio Mishima.
Oggi, al loro posto,
sono le boy band
giapponesi, i giovani
attori di drama con i
capelli alla coreana, le
star del rap thai e le
giovani cantanti di
Taiwan a modulare la
cultura
asiatica
globalizzata.
In Corea c’è una
grossa polemica sulle
pressioni
esercitate
dagli americani per
liberalizzare il settore
audiovisivo e il cinema
affinché il mercato dei
contenuti si apra agli
studios di Hollywood.
Attraverso un accordo
bilaterale di libero
scambio firmato il 30
giugno
2007
a
Washington, i coreani
hanno accettato di
ridurre le loro quote di
riserva.
Le
organizzazioni ufficiali
a sostegno del cinema
coreanoegliattivistidi
Coalition for Cultural
Diversity in Moving
Images a Seul mi
hanno
lasciato
intendere che gli Stati
Uniti
avrebbero
minacciatodiritirarele
lorotruppedallaCorea
se fossero rimaste le
quotediriservasuifilm
americani. Di sicuro
una
simile
interpretazione
è
esagerata
e
probabilmente
gli
americani non sono
mai arrivati a questo
punto: non potrebbero
mai abbandonare un
hard power in cambio
di un soft power.
Sembra
tuttavia
evidente che abbiano
fatto pressione per
ottenereunasituazione
aloropiùfavorevole.
All’ambasciata degli
Stati Uniti di Seul,
superprotetta
dai
marines, sono ricevuto
dal
ministroconsigliere,
un
diplomatico navigato
che
opera
come
consulente
commerciale (non ho il
permesso di farne il
nome).
Nega
fermamente qualsiasi
pressione. “La Corea,
insieme al Giappone, è
un mercato chiave per
le
industrie
dei
contenuti
per
gli
americani.Questoèun
fatto. Tuttavia, ad
abbassare le quote di
riserva sono stati i
coreani stessi poiché
avevano altri interessi
economici da mettere
sulla bilancia, per loro
più importanti. Non è
mai
stato
un
prerequisito,
come
invece è stato detto. È
una cosa che posso
assicurare perché sono
stato io a condurre le
trattative per questo
accordo
e
posso
garantire che i nostri
eventuali prerequisiti
non
avrebbero
riguardato il cinema.
Anche
i
coreani
avevano
molte
esigenze, soprattutto
nel settore agricolo, e
così è stata condotta
una trattativa. Una
trattativa
difficile,
come quelle fatte con
moltipaesiperarrivare
adaccordicommerciali
bilaterali. I coreani
avevano il massino
interesse nel firmare
questo
accordo
fondamentale per la
loro elettronica e la
loro agricoltura, per
questohannoaccettato
disacrificareilcinema.
Hanno scelto Samsung
alpostodeifilm.Èuna
sceltacoreana.”
Il sistema coreano
dellequotediriservaè
originale. Per un certo
numero
di
giorni
all’anno, il cinema
nazionale deve essere
l’unico proiettato, ogni
cinema è libero di
scegliereigiorniincui
i film stranieri sono
vietati. Fino al 2007,
146 giorni all’anno
erano
riservati
al
cinemacoreano,ovvero
il 40 per cento; questa
percentuale è stata poi
abbassata a 73 giorni
dopo l’accordo del
2007, ovvero al 20 per
cento. I risultati non si
sono fatti attendere.
Prima
di
questo
accordo, il cinema
americano
rappresentavail40per
cento del botteghino
coreano (e al 60 per
cento per il cinema
coreano),poièsalitoal
50 per cento (e il
cinema
coreano
è
crollato al 49 per
cento).
“L’abbassamento delle
quote di riserva non è
l’unica cosa che spiega
il crollo del cinema
coreano,ancheseviha
contribuito,”diceMark
Siegmund della Seul
Film Commission. “Il
problema
è
che
produciamo meno film
e sempre meno per un
pubblicomainstream.Il
nostrocinemacontinua
ad andare bene nei
festival
dei
film
d’autore in Europa, ma
non attira i giovani
coreani. Questo è il
nostroproblema,nonè
solo una questione di
quote di riserva.” Al
Korean Film Council, il
settoregovernativoche
proteggel’industriadel
cinema, si difende
fermamente il sistema
delle quote di riserva,
mentre la maggior
parte
dei
miei
interlocutori
dell’industria
del
cinema incontrati a
Seul, soprattutto tra i
gestori dei cinema, è
più scettica. Alcuni lo
consideravano
controproduttivo e ne
volevano l’abolizione:
“Le quote di riserva
hannoindebolitolesale
cinematografiche
poiché
non
rispondevano
alle
esigenze di moltissimi
giovani coreani che
vogliono vedere i film
americani. Sono stati
allontanati dai cinema
e spinti ad acquistare
questi film in dvd o a
scaricarli da internet.
Inoltre è un sistema
indifferenziato
che
colpisce
il
cinema
giapponese, taiwanese,
francese tanto quanto
quelloamericano.Epoi
bisogna sapere che già
da molto tempo il
sistema delle quote di
riserva
non
era
rispettato dai gestori
stessidellesale.Invece
di
questo
sistema
arcaico
avremmo
bisogno
di
una
produzione nazionale
forte, di qualità e
destinataaunpubblico
di massa. È l’unica
soluzione”, spiega il
responsabile di una
catena di multisala
(chenonvuolesiafatto
il suo nome per timore
di
reazioni
degli
operatori del settore).
“In realtà bisogna dire
che, come è accaduto
anche in Messico, la
Mpa ha ferocemente
combattuto il sistema
delle quote di riserva
coreane concentrando
la sua attività di
pressione sui gestori
dellesale.Convintiche
i film di successo
hollywoodiani fossero
desideratidalpubblico,
soprattutto dai giovani
coreani, sono stati
soprattutto i gestori i
migliori alleati degli
americani
nella
richiesta di abolire le
quote
di
riserva,
sperandocosìdivedere
aumentare
i
loro
introiti,”
commenta
Alejandro
Ramirez
Magaña, il celebre
patron della catena di
cinema
messicani
Cinepolis,
che
ha
fortemente investito in
Asia (e che io ho
intervistato
in
Messico). Per i gestori,
tuttavia, il risultato
sembralimitato.
In ogni caso, con o
senza quote di riserva,
a partire dalla Guerra
di Corea la Corea del
Sud
è
quasi
il
cinquantunesimo stato
degli Usa poiché, in
ragione della presenza
della Corea del Nord,
questa isola somiglia a
una vera e propria
portaerei americana.
Nelle vie di Itaewon,
non lontano da una
base americana, si
vedono le pattuglie di
militari americani e, di
sera,
i
bar
più
malfamatisonopienidi
soldati. Gli Stati Uniti
sono il paese in cui
vivonopiùcoreanialdi
fuoridellaCorea.Tutto
ciò comporta numerosi
scambi culturali tra i
duepaesi.
In questo specifico
rapporto con gli Stati
Uniti per i coreani si
gioca
anche
un
problema
più
complicato, relativo al
bisogno
di
riconoscimento e alla
ricerca di una propria
identità.
Contrariamente
al
Giappone, che cerca di
preservare la propria
specificità,
e
a
Singapore, che non ha
questa ambizione, la
Corea cerca invece di
recuperareunapropria
specifica identità. Si
tratta di un’identità
complessapersaconla
Guerra di Corea e con
la separazione dal
Nord, paese per cui si
prova odio ma dal
quale si è anche
gelosamenteaffascinati
per la sua purezza
nazionalista “coreana”,
mentre la Corea del
Sud è un paese
globalizzato. C’è un
rapporto
complesso
con gli americani che
hanno accettato di
morire per una Corea
libera, ma invadenti e
onnipresenti da un
puntodivista,militare.
Infine,siprovaunforte
sentimento
di
inferioritàneiconfronti
del
Giappone,
dominatore
nel
passato, e della Cina,
ormai
minaccia
economica e forse
militare. Oggi, non è
facile
essere
sudcoreani.
I
teleromanzi
del
Ramadan
A un’ora di strada a
ovest del Cairo ci sono
gli
studi
cinematografici
e
televisivi
della
televisione
egiziana,
unaveraepropriacittà
nota come Media City.
In realtà questa nuova
città
interamente
costruita nel deserto si
chiama6thOctoberCity
(in riferimento alla
Guerra
dello
Yom
Kippurtralacoalizione
Egitto-Siria e Israele,
che
gli
egiziani
sostengono di aver
vinto).
Qui si producono i
musalsalat:
i
teleromanzi
del
Ramadan. Queste soap
opera
sono
state
inventatedagliegiziani
esonopopolariintutto
il mondo arabo. Ogni
puntata dura in media
cinquanta
minuti
(un’ora
con
la
pubblicità) e ogni serie
è composta da trenta
episodi, trasmessi ogni
giorno
durante
il
Ramadan
e
poi
ritrasmessi
continuamente
per
tutto l’anno. A Media
City si fanno le riprese
di una ventina di serie
completeall’anno.
“Il
successo
dei
musalsalat
è
strettamente legato al
Ramadan,”
spiega
Youssef
Cherif
Rizkallah, che dirige la
divisione
internazionalediMedia
City.
“Le
famiglie
restano rinchiuse in
casa per tutto il giorno
per un mese intero e
quindi
guardano
continuamente
la
televisione. Anche i
giovani non possono
andare al cinema,
tranne la sera.” Il
formato
del
programmaèsemplice:
è un divertimento per
un pubblico di massa,
leggero
e
comprensibilepertutti.
Si
affrontano
le
questioni della vita
quotidiana, i problemi
coniugaliesociali,sono
anzitutto teleromanzi a
scopo morale. “È una
forma di divertimento
con dei valori e dei
principi,”
sottolinea
Youssef
Osman,
direttore
della
produzione
dei
teleromanzi a Media
City. Poi aggiunge
lucidamente: “Questi
valori, completamente
conformi alla religione
musulmana, fanno il
successo
dei
teleromanzi
del
Ramadan nel mondo
arabo,
ma
sono
fallimentarialtrove”.
Anche nelle case
produttrici
questa
forma
di
intrattenimento
popolare egiziana è
criticata. “I giovani
vogliano più azione e
meno
melodrammi,”
prosegue
Youssef
Osman.
“Allora
abbiamo cominciato a
fare serie da quindici
episodi anziché trenta
per
accelerare
la
trama. Poi, i giovani
vogliono
vedere
ragazze più belle, non
velate
e
un
po’
scoperte.”
Vogliono
dunque più sesso?
“Nondireichevogliono
vedere
sesso,
ma
almeno che un ragazzo
possa
baciare
la
ragazza.
E
così
facciamo scene in cui i
ragazzi baciano le
ragazze.”
Questi
prodotti oggi hanno
buoni ascolti in Egitto,
Marocco,
Tunisia,
Libano,
Siria
e
Palestina, ma tutte le
scene
di
baci
o
“leggermente
osé”
sono tagliate nei paesi
del Golfo e in Arabia
saudita. “Credo che il
successo del cinema
egiziano in tutto il
mondo arabo, e in
particolare
dei
musalsalat, venga dal
fatto che siamo più
liberi e più emancipati
rispetto agli altri paesi
musulmani,”
precisa
Youssef Osman. “I
nostrifilmapronospazi
di libertà, costruiscono
un immaginario per
giovani
arabi
che
adorano la bellezza
delle nostre donne e
l’attrattiva dei nostri
uomini.” Gli chiedo poi
se l’islamismo che sta
tornando con forza
possa
modificare
questo
scenario.
YoussefOsmansiritrae
sullasuapoltronasotto
il
ritratto
del
presidente
Hosni
Mubarak: “Vedremo.
La televisione e il
cinema egiziani sono
sempre più controllati
dal denaro dei paesi
del Golfo. Questo avrà
delle ripercussioni. Per
esempio,cisonoattrici
senza
velo
che
decidono di indossarlo
per
rispondere
al
mercato e conquistare
maggior
pubblico,
soprattutto nei paesi
del Golfo. Di sicuro
oggi ci sono molte più
donne velate rispetto a
vent’anni fa. Sono in
aumento
evidenti
formediislamizzazione
anche
nel
settore
audiovisivo in Egitto.
Anche questo avrà
delle
ripercussioni.
Globalizzazione contro
islamizzazione: sono i
terminideldibattitoda
questeparti”.
Media City è una
sorta di Cinecittà del
Medio Oriente, è una
specie di Hollywood
orientale ed è uno dei
complessi
cinematografici
più
moderni della zona
araba. Gli studi sono
costruiti nel deserto e
non hanno concorrenti,
a parte forse Media
City di Dubai. È una
sorta di “zona franca”
poiché offre condizioni
vantaggiose per le
riprese ed è stata
creata dal ministero
dell’Informazione
egiziano nel 1998 con
metà fondi pubblici e
metà capitali privati. È
stata inaugurata nel
2002,
offre
infrastrutture, équipe
di tecnici e personale
particolarmente
competenti,
rilascia
autorizzazioni per fare
riprese nel deserto o
davanti alle Piramidi.
“Se un produttore ha
bisogno
di
mille
comparse,
posso
trovargliene nel giro di
qualche ora,” dice
Youssef
Cherif
Rizkallah. “Ci sono 2
immense sale di posa,
75
scenografie
differenti, 50 studi
televisivie15zoneper
le riprese esterne con
scenografie naturali.”
Visito a lungo questo
luogo
molto
affascinante, ci sono
scenografiepertuttele
esigenze:
piramidi
(una, in cemento, solo
la
facciata),
una
stazione
ferroviaria,
una vecchia strada del
Cairo,
un
accampamento
beduino, un fiume, una
foresta tropicale e
anche
un
campo
minato con manichini
disoldatiisraeliani.
Media City è dunque
un luogo per venire a
fareripresepertuttala
zona araba: i paesi del
Golfo,ilLibano,laSiria
e anche l’Iraq, vi si
girano infatti anche
musalsalat iracheni. I
dirigenti di Media City
sperano
anche
di
attirare
le
troupe
occidentali, ma nel
farmi la promozione
delle
attrezzature
presentinonsirendono
conto che la questione
del velo e del divieto
assoluto
di
alcol
possono rappresentare
un
freno
per
i
produttori occidentali.
Ancora una volta, i
punti
di
forza
dell’Egitto verso il
mondo arabo sono
punti deboli rispetto al
restodelmondo.
Alla fine della visita
ho
una
strana
impressione che mi
evoca
manie
di
grandezza
d’altri
tempi: non l’Egitto dei
faraoni,malaRomania
di Ceausescu – in
versione
Hosni
Mubarak.Vedofontane
immense dalle quali
non zampilla un goccio
d’acqua,stradedeserte
che non portano da
nessuna
parte,
montagne
artificiali
costruite con macerie,
scialbe
copie
di
sculture egiziane e
arrivo poi alla Master
Control Room, dove ci
sono
persone
appisolate. L’edificio
centrale – chiamato
“complesso Mubarak
A” – ha la forma di H.
Chiedo il perché. “H
sta per Hosni, il nome
del presidente,” mi
risponde
Youssef
CherifRizkallah.
“I teleromanzi del
Ramadanprodottidagli
egiziani oggi non sono
più
all’avanguardia.
Sono ormai musalsalat
datati,giratiinstudioe
con
sceneggiature
vecchie
di
quarant’anni.
Il
pubblico arabo non li
apprezzerà ancora a
lungoeigiovanihanno
già
smesso
di
guardarli.” Si esprime
in questi termini a
Damasco,
qualche
mese
dopo,
Firas
Dehni, celebre regista
di teleromanzi ed ex
direttore
del
dipartimento
di
Produzione
della
televisione nazionale
siriana.
In Siria, le serie
televisive hanno il
vento in poppa: la
cinematografia
nazionale è in rovina,
maiteleromanzihanno
successo. “Incarnano
l’infitah,
l’attuale
apertura del paese,”
spiega Firas Dehni che
ho incontrato in un
ristorante della città
vecchia in una pausa
delle riprese. “Qui
facciamo
riprese
all’esterno, in strada,
affrontiamo tutti i temi
tabù come corruzione,
sessualità,
aborto,
droga,
relazioni
sessuali
fuori
dal
matrimonio e anche la
transessualità.
Naturalmente c’è una
linea che non si può
oltrepassare”
(Firas
Dehni, dal momento
che lavora per la
televisione ufficiale di
stato, non dice quale
sia questa linea, ma so
che qualsiasi critica
politica o religiosa,
qualsiasideviazionedai
princìpi
musulmani,
qualsiasi difesa dei
dirittidell’uomoodella
libertà d’associazione,
apologia di Israele,
critica al presidente
BacharalAsadportano
in prigione, come mi è
stato confermato dal
responsabile di una
Ong intervistato a
Damasco,
che
ha
appena trascorso due
anni in carcere per
aver difeso i diritti
dell’uomo).
I teleromanzi siriani
sono
costruiti
sul
modello delle serie
americane:
ogni
episodio contiene una
storia completa che si
chiude, dunque non è
necessario vedere ogni
episodio per capire la
trama. Questo è il
vantaggio rispetto ai
musalsalat egiziani, in
cui le puntate si
susseguono per una
stagione intera, in
particolare durante il
Ramadan.
Sedutoauntavolodi
un albergo del centro
storico di Damasco,
Makram Hannoush, un
libanese che produce
numerose
serie
televisive, si interroga
sull’attuale
successo
del settore audiovisivo
siriano: “Bisogna però
minimizzare le cose. È
vero che usiamo la
lingua parlata, che
facciamo
riprese
all’esterno, che siamo
un po’ più liberi. Se le
nostre
serie
sono
innovative,
quando
arriva il Ramadan
torniamo però un po’
meno liberi. Per quella
stagione
dobbiamo
tornare a format molto
rigidi, come quelli
egiziani: 30 episodi da
45 minuti ciascuno, 22
ore e 50 minuti in
tutto.Nonunminutodi
più! Questo è il
Ramadan”.
Il celebre attore
siriano Jihad Saad, che
recita in numerosi
teleromanzi
del
Ramadan,
difende
invece il sistema e
mostra
qualche
perplessità
sulle
mutazioni in corso:
“L’apertura
della
Siria...
ma
cosa
significa? Vuol dire
aprirsi agli americani,
farecomeloro?”.
Rispetto
all’Egitto,
che
produce
annualmente
una
cinquantina di serie
televisive, la Siria è un
paese emergente del
mondo arabo nella
produzione del settore
audiovisivo. Cerca di
essere audace, poiché,
nonostanteledrastiche
regole della dittatura,
sa che può affermarsi
solo con soggetti di
attualità,
riprese
esterne e assumendo
dei rischi. Il regime
lascia fare. Il successo
economico
per
le
esportazioni di questa
industriacreativanonè
probabilmente
estraneo
a
questa
libertà ben integrata,
ma non fa presagire
nulla per il futuro. Per
ilmomento,nonostante
la
mancanza
di
democrazia politica e
di libertà dei media, la
modernizzazione della
Siria passa per le serie
televisive.
Fino
a
quando?
Le
telenovele
alla
conquista
dell’intero
continenteamericano
Mi trovo in un
ristorante indiano con
dolci finti, un’attrice
avvolta in un sari, una
cameriera che deve
ripetere più volte la
sua parte su richiesta
di un regista un po’
spazientito. La scena è
decisiva: l’attrice si è
innamorata
di
un
intoccabile mentre la
sua famiglia ha già
organizzato
un
matrimonio combinato.
All’esterno è stata
allestita una via di
Jaipur,
città
del
Rajasthan,
con
i
lavatoi, un tempio
indiano e un cinema in
cui si proietta, stando
alla locandina, Jodhaa
Akbar, un recente film
di Bollywood con la
star
Aiswarya
Rai
Bachchan.
Per
le
necessità della serie
televisiva Camhino das
Indias, il regista ha
chiesto che venisse
ricreato
anche
un
pezzodelfiumeGange:
allora centinaia di
operai
si
sono
adoperati
per
accontentarlo ed ecco
pronto il fiume nelle
scenografie.Comesea
Jaipur scorresse il
Gange.
Sul set si parla
portoghese
poiché,
come si sarà capito,
non mi trovo in India,
ma negli studi di Tv
Globo. Camhino das
Indiasèunatelenovela
seguita con passione
tutte le sere della
settimana da milioni di
brasiliani. Davanti ai
miei occhi si sta
realizzando un nuovo
episodio, poiché la
telenovela
è
in
continua lavorazione,
tra
scrittura
e
realizzazione
delle
riprese.
Gli studi di Projac (il
nome
ufficiale
è
Central
Globo
de
Produção)
sono
a
un’ora di strada a sudovest di Rio, sono stati
inaugurati nel 1995,
hanno un’estensione di
130 ettari e hanno
dieci studi per le
riprese, di cui quattro
interamente destinati
alle
telenovele
brasiliane. Ogni anno
inquestistudivengono
girate 2500 ore di
riprese per programmi
televisivi; essi sono di
proprietà di Tv Globo,
uno
dei
quattro
network più potenti al
mondo. Questo è il
cuore
dell’industria
dell’intrattenimento
brasiliana.
“Se vuole sapere
cos’erano gli studios
americani
nell’epoca
d’oro di Hollywood
deve
vedere
cosa
facciamo da queste
parti,” mi dice un po’
ironicamente
Guel
Arraes,
regista
di
telenovele,
sceneggiatore
di
successo,
e
attualmente direttore
della divisione Fiction
deglistudidiTvGlobo.
Come la maggior parte
degli attori e dei
tecnici, anche lui è un
lavoratore dipendente.
Per Globo si lavora
tutto l’anno, come
accadeva a Hollywood
negli anni trenta, non
con singoli contratti
per
una
specifica
telenovela.
Per una giornata
intera attraverso gli
studi di Tv Globo a
bordo di un “carro
elettrico” (la golf-kart
in brasiliano), guidato
da Edson Pimentel,
direttore esecutivo di
Projac.Neiluoghidelle
riprese vedo una finta
favela, una pista per
elicotteri, una chiesa i
cui lati sono ciascuno
di uno stile diverso
(gotico,
barocco,
romanico),
una
caserma dei pompieri
(vera), una scenografia
di Fez, un’altra di
Miami e naturalmente
la via di Jaipur sulle
rive del Gange. La
maggior parte delle
scenografie è montata
su ruote per poter
essere
facilmente
spostata, riposizionata
e sistemata. Sono in
una vera e propria
fabbrica dei sogni
montatasuruote.Poco
dopo visito l’atelier di
cucitura in cui ci sono
65.000
costumi,
ciascunoconuncodice
a barre, disposti per
chilometri.
Tv Globo trasmette
sei
episodi
alla
settimana per ogni
telenovela e fino a
cinque telenovele al
giorno, di cui tre
inedite trasmesse alle
ore 18, 19 e 21 e
alcune
miniserie
trasmesse alle ore 22.
Ogni giorno, verso le
ore
14,
sono
ritrasmesse telenovele
della
stagione
precedente. “Dunque
dobbiamoprodurreuna
ventina di episodi alla
settimana.
È
matematico,” mi dice
Edson Pimentel, che
poi
prosegue:
“Le
trasmettiamo
una
settimana dopo averle
girate. Le telenovele
sono
un
prodotto
fresco”.
A questi ritmi, si
tratta sicuramente di
un prodotto fresco, ma
sonoancheunprodotto
continuamente
riadattato
poiché
appartieneaungenere
ampiamenteconsumato
e con necessità di
cambiamento.
Guel
Arreas
traccia
lo
scenario:
“La
telenovela in Brasile è
un’istituzione.
Nelle
campagne
e
nelle
favelas, tutti guardano
latelenoveladellasera,
lapiùpopolareèquella
delle ore 21, dopo il
Jornal Nacional delle
20, che è ancora
seguito
dalla
maggioranza
dei
brasiliani. Per farla
breveèlastoriadiuna
coppia
che
vuole
baciarsieabbracciarsi,
ma
che
lo
sceneggiatore,
per
duecento episodi, ha
deciso di non volerli
lasciar fare. Da qui
l’impazienza
della
coppia
e
dei
telespettatori.
Nel
frattempo
ci
sono
infiniti
intrecci
secondari
che
generano suspense –
elementodecisivodella
telenovela”. Il modello
era questo, ma oggi è
in
piena
trasformazione. Guel
Arreas
riprende
il
discorso:
“I
tempi
cambiano e per le
esportazioni facciamo
50-60episoditagliando
le vicende secondarie,
manteniamo solo la
main story line” (si
esprime in inglese per
dire
la
storia
principale).
Osservo
che 60 episodi per
riuscireadabbracciarsi
e baciarsi è ancora
tanto.
A seconda dei vari
paesi, le telenovele
cambiano molto stile e
filosofia.“Latelenovela
brasiliana
è
meno
melodrammatica
di
quella di altri paesi
dell’America
latina,”
prosegue Guel Arreas.
“L’intento
è
più
realistico, gli attori
recitano in modo meno
eccessivo,
meno
marcato.
Non
necessariamente
compare all’improvviso
una donna forte con le
braccia
alzate
sull’ampia
scala
d’ingresso della casa,
segno di opulenza e
della differenza di
classe sociale, che
grida:‘Díosmio!’.”
Il Brasile è stato il
primo
paese
a
trasmettere telenovele
inprimaserata,mentre
negli altri paesi erano
relegate al pomeriggio
per un pubblico di
casalinghe. Il risultato
è stato eclatante e ha
fattoregistrareancheil
seguito di un ampio
pubblico maschile. “In
Messico le telenovele
sono più tradizionali,
piùmelodrammatichee
dunque conservatrici:
la protagonista è pura,
bianca,èsemprebuona
esoffre,èunasanta.In
Venezuela,
le
telenovele sono puro
intrattenimento
e,
paradossalmente
trattandosidelpaesedi
Chávez,
sono
più
liberali. In Colombia ci
sibasasufattirealiper
fare
telenovele
poliziescheofiabesche.
Anche in Argentina la
protagonista soffre, ma
può rivelarsi perfida,
condurre un doppio
gioco e alla fine
risultare cattiva. Si
osano
affrontare
soggetti scomodi. Si
rompono
i
soliti
schemi,”
sintetizza
Victor Tevah, direttore
aggiunto
di
una
importante società di
produzione
di
telenovele argentine,
Pol-Ka, con sede nel
quartiere Palermo di
BuenosAires.
In Brasile si gira
molto
in
esterna,
almeno il 40 per cento
della serie, spesso
all’estero, mentre per
esempio in Messico le
telenovele sono girate
soprattutto in studio. I
costi sono più elevati,
ma si offrono immagini
più colorate e più
credibili.“Laspecificità
delle nostre telenovele
è che sono girate in
corso d’opera, così
possiamo modificare la
trama in base alle
reazioni del pubblico e
agli
ascolti.
Soprattutto, è una
storia che continua,
non è come le serie
televisive americane in
cui
ogni
episodio
racconta una storia a
sé: in Brasile bisogna
vedere180puntateper
conoscere tutta la
storia,ilpubblicoèpiù
fedele e più leale,”
spiegaEdsonPimentel.
Dunque le telenovele
brasiliane sono lunghe,
generalmente quelle di
Tv Globo durano 170180 episodi, mentre
quelle di Record Tv
250; se il successo
continua
possono
essere prolungate per
un tempo indefinito
(fino a oggi il massimo
è 596 episodi). Sono di
generi
diversi
(commedie,
drammi,
melodrammi)
e
affrontano vari temi,
spesso
legati
a
problemi personali e
sociali:
questioni
familiari,
crisi
di
coppia, rivelazione di
figli
illegittimi.
Affrontano anche la
vita nelle favelas, la
droga, l’alcolismo, la
corruzione. Il mercato
pubblicitario
è
concentrato nelle città
di San Paolo e Rio, e
ciò
influisce
sui
contenuti: “Dato che il
pubblico delle grandi
città è più aperto sulle
questioni sociali, sulla
sessualità
e
l’omosessualità,
è
chiarocheletelenovele
brasiliane siano più
edgy”, conferma Luigi
Baricelli, una star che
sono
riuscito
a
intervistare
al
ristorante
dell’emittente
e
impegnata ogni giorno
a presentare in diretta
la trasmissione Video
ShowsuTvGlobo.
Per
quanto
sia
predominante
sul
mercato, il network
privato Tv Globo non è
l’unico a trasmettere
telenovele in Brasile.
C’è anche Record Tv,
vicinaaglievangelistie
finanziata da Televisa,
grande
gruppo
messicano. Di questa
emittente
incontro
TiagoSantiago,celebre
sceneggiatore
che
dirigeletelenoveleper
questo canale: “Come
tutti vengo da Tv
Globo. Tra le due
emittenti c’è una sana
concorrenza.
A
settembre
trasmetteremo
tre
telenovele al giorno”.
Tiago Santiago dirige
una squadra di otto
autori
per
le
sceneggiature:
“Scriviamo
insieme
secondo un planning
quotidiano molto ben
rodato: al mattino
presto, scrivo la sintesi
della
scena
che
dobbiamo stendere nel
corsodellagiornata,mi
ispiro soprattutto ai
fatti letti sui giornali;
poilamandoviamailai
miei collaboratori che
ci lavorano da casa. Ci
dividiamo la scrittura,
ciascuno fa la sua
parte. A metà della
giornata,tuttigliautori
mi inviano ciò che
hanno
scritto.
Poi
rendiamo coerente la
trama,
correggiamo,
alla fine della giornata
abbiamo
una
cinquantina di pagine
pronte, piene di grandi
emozioni e di ragazze
inminigonna.Lascena
che scriviamo questa
settimanasaràgiratala
settimana prossima e
trasmessa la settimana
dopo.
Questo
ci
permette
di
assecondare le attese
del pubblico e di
restare
legati
all’attualità”.
Tiago
Santiago mi spiega
peraltro che i suoi
guadagni
dipendono
dal
seguito
della
telenovela, lo stipendio
di base aumenta se la
serie ha ascolti. “Alla
fine della giornata il
successo si misura
molto semplicemente:
siete stati capaci di
creare storie che la
gente ha voglia di
guardare?”
All’ingresso c’è un
immenso mappamondo
con all’interno una
televisione, è il logo di
Tv Globo. Sono nella
sede
storica
del
gruppo, molto lontano
dagli studi, vicino al
giardino botanico di
Rio.
Luiz
Claudio
Latgé,unodeidirettori
di Tv Globo e oggi alla
testa del canale di
informazioni non stop,
è
entusiasta:
“Le
telenovele di Tv Globo
contribuiscono a unire
il paese sul piano
linguistico e sociale.
Tutta la famiglia, tutte
le classi sociali si
ritrovano attorno alla
telenoveladellasera.Il
Brasile
ha
quasi
duecento milioni di
abitanti, è immenso,
l’unico in America
insiemeagliStatiUniti.
Il nostro segnale è
diffuso da centoventi
stazioni in tutto il
paese e le nostre
telenovele
sono
venduteinuncentinaio
dipaesi.Èunsuccesso
eclatante se si pensa
che
parliamo
portoghese, una lingua
poco
diffusa
nel
mondo”.
In realtà, il Brasile è
un soggetto nuovo nel
mercato degli scambi
culturali internazionali.
È ancora un paese
emergente
per
il
settore audiovisivo: se
è vero infatti che le
telenovele brasiliane si
vendono da tempo,
sonodavveroredditizie
solo da qualche anno.
“Siamo ancora un
mercato
giovane
nell’intrattenimento,”
conferma Luiz Claudio
Latgé. Il pubblico con
un potere d’acquisto
rilevante, quello a cui
si
rivolgono
i
pubblicitari, in Brasile
è nell’ordine dei sei
milioni di persone.
Quindi, non si tratta di
unmercatomaturo.Ma
se si prende l’esempio
dei telefoni cellulari –
ne possiedono ormai
novanta milioni di
brasiliani, ovvero la
metà della popolazione
– le prospettive di
crescita sono chiare.
“Le persone con un
buon potere d’acquisto
dovrebbero
passare
prossimamentedaseia
cento
milioni.
Diventeremo
una
formidabile
potenza
economica e le risorse
dell’intrattenimento e
dei
media
aumenteranno
ampiamente. Il Brasile
presto non sarà più un
paese
emergente,
saremo
emersi,”
conclude
con
un
sorriso Luiz Claudio
Latgé.
I
mercati
delle
telenovele
brasiliane
sono numerosi. C’è
anzitutto quello dei
paesi
di
lingua
spagnola e le serie
sono
girate
fin
dall’inizio
in
due
versioni:
portoghese
per il Brasile, spagnolo
per l’esportazione in
America latina (poco
versolaSpagnadovele
telenovele brasiliane in
sostanza
non
si
vendono). Il mercato
ispanico principale, in
questazona,continuaa
essere il Messico, date
le
sue
dimensioni
geografiche.
L’Argentina costituisce
un
mercato
più
limitato, ma è un buon
promotore
e
rappresentauntestper
gli altri paesi. Il
mercato lusitano si
limita al Portogallo,
cliente
fedele
e
simbolicamente
importante per Tv
Globo,
ma
economicamente poco
rilevante.Oltreaipaesi
dell’Americalatina,che
sono
consumatori
discontinui
delle
telenovele brasiliane in
funzione delle loro
specifiche produzioni,
c’è il mercato latino
negli Stati Uniti. Su
questo scenario c’è la
concorrenza
del
Messico, ma Tv Globo
ha siglato accordi con
l’emittente americana
Telemundo
per
diffondere
le
sue
produzioni doppiate in
spagnolo.
Poi ci sono i paesi
dell’Europa centrale e
orientale,
grandi
consumatori
di
telenovele.InRomania,
per esempio, esiste un
network, Acasa Tv,
ampiamente destinato
alle
telenovele
sudamericane.
A
Bucarest
vanno
particolarmente bene i
prodotti
brasiliani,
colombiani
e
venezuelani.
“In
Romania le telenovele
sono spuntate subito
dopo il 1989, sono
state una sorta di
liberazione da quel
primo ‘reality show’
rappresentato
dalla
rivoluzione,” spiega il
critico cinematografico
AlexLéo
Serban.
“Queste
telenovele
hanno un pubblico
soprattutto femminile,
non molto istruito.
Alcune
di
queste
mamme ‘telenovelofile’
hanno chiamato i loro
figlicomeiprotagonisti
delle serie.” Di sicuro,
il fatto che la Romania
siaunpaeselatino,con
una
lingua
simile
all’italiano,
facilita
forme
di
identificazione.
Le
telenovele
brasiliane funzionano
anche
in
Russia,
Polonia, Serbia, in
Repubblica Ceca, a
confermadell’ampiezza
del fenomeno. “I Paesi
dell’Est e la Russia
rappresentano ormai il
70 per cento delle
nostre
vendite,”
conferma a Buenos
Aires
Michelle
Wasserman, che vende
le telenovele argentine
della rete Telefe. “I
russi preferiscono le
nostre telenovele per
scelta
ideologica,
perché
non
sono
americane, e perché i
nostri attori sono più
‘bianchi’ e hanno uno
spirito più europeo
rispetto a quelli delle
serie
messicane
e
brasiliane,perirussiè
più facile identificarsi
conloro.Peraltro,èciò
che
costituisce
la
nostra forza in Europa,
e talvolta anche in
America latina, poiché
gli ispanici adorano le
attrici bionde con gli
occhiazzurri.”
Il successo delle
telenovele brasiliane è
diffuso anche in Medio
OrienteenelMaghreb,
come accade per i
drama coreani. Alcune
telenovele sono state
girate in Marocco, e
questo certamente è
stato
utile
come
richiamo
per
il
pubblico arabo. In
questiultimianni,nelle
telenovele
brasiliane
sono stati introdotti
molti
ingredienti
stranieri, soprattutto
arabi, e questo ne ha
facilitato la diffusione.
Ma la chiave del
successo commerciale
delle telenovele sul
fronte
delle
esportazioni è il costo.
Tv Globo diffonde le
telenovelealribasso:in
termini
di
costi,
rispetto
alle
serie
americane si tratta di
prodotti da discount.
“Preferiamo acquistare
telenovele
brasiliane
invece
delle
serie
americane per via dei
prezzi,”mispiegaSally
Messio, direttrice dei
programmi
e
presentatrice di punta
della
televisione
nazionale del Camerun
(Crtv), quando visito i
locali
di
questa
emittente di stato.
“Noncompriamoquesti
programmi
direttamente
dal
Brasile, ma attraverso
casedidistribuzionedi
Abijan
e
Dakar,”
aggiunge. Il Discop di
Dakar è una fiera del
settore audiovisivo in
cui i paesi africani
acquistano le serie
televisive,comeaccade
con il Discop di
Budapest per l’Europa
centrale e orientale,
oppure il Bcww in
Corea del Sud, l’Atf a
Singapore
e
naturalmente il Mip-Tv
a Cannes per i mercati
europei classici. “Ci
sono numerosi luoghi
esotici,spessofiereper
addetti ai lavori in cui
si
svolge
questo
mercato delle serie
televisive.Èdavveroun
mercatointernazionale.
Ma gran parte degli
acquisti viene fatta
ogni anno negli Stati
Uniti,alLAScreenings
di Los Angeles e al
Natpe di Las Vegas,”
spiega
Michelle
Wasserman, direttrice
delle
vendite
internazionali di Telefe
a
Buenos
Aires.
Secondo Tv Globo,
sono centoquattro i
paesicheacquistanole
telenovele prodotte da
loro. È il primo
prodotto
culturale
esportatodalBrasile.
Lasciando Rio, resto
sorpresonelconstatare
che il conducente del
taxi, mentre guida,
guarda uno schermo
digitale posto a destra
delquadrodibordodel
veicolo. Non è di certo
un procedimento molto
sicuro, ma gli autisti
brasiliani non hanno
paura di nulla. L’uomo
si gira verso di me per
parlare, intanto guida,
e mi dice che gli piace
moltolatelenovelache
stanno trasmettendo,
CamhinodasIndias.
Qualche mese dopo
mi trovo a Città del
Messico, nella sede di
Televisa.Perentrarein
questo
impero
dell’intrattenimento,
bisogna passare per
una piccola porta non
lontanadall’autostrada.
All’esterno,
sull’edificio, c’è il logo
riconoscibile
di
Televisa, un immenso
sole giallo. All’interno
c’è un’attività così
frenetica che sembra
quasi di essere in una
fabbrica.
Tutto
è
talmente immenso e
rapido che, mi dice
Rodrigo Artega, il
direttore aggiunto di
Televisa,“gliattorinon
hanno il tempo di
imparare il copione né
di
studiare
il
personaggio,
usano
degli
auricolari
attraverso
cui
gli
vengono suggerite le
battute”. Assisto alle
ripresedellatelenovela
Atrévete
a
soñar:
l’attore principale è
una star messicana
adoratadallefolle,èin
pigiama nel suo letto.
Mi viene fornito un
auricolare e ascolto il
suggeritore. “Ma è
dopo questa scena che
morirò?” chiede a un
certo punto l’attore al
regista. Infatti, non si
ricorda più la trama
della telenovela in cui
sta recitando, poiché
gira scene di diverse
telenovele
senza
seguire
un
ordine
cronologico. Poco dopo
vado a visitare il
Centro di Educación
Artistica de Televisa: è
la scuola per diventare
attori all’interno degli
studi e assisto al corso
per gli allievi. Per tre
anni, nove ore al
giorno, imparano a
danzare,
cantare,
recitare. Si tratta di
una scuola in cui
l’esercizio fisico è una
delle principali attività
e c’è una severa
selezione: su settemila
candidati,
se
ne
diplomano
solo
venticinque.
Sono
affascinato dal fatto
che Televisa riservi
tanta
cura
alla
formazione dei suoi
attori.
La
sera,
guardando un episodio
della telenovela di cui
ho visto le riprese,
constato
che
è
continuamente
interrotto
da
spot
pubblicitari. Mi rendo
contocheTelevisaèun
network mainstream di
pubblicità intervallata
dateleromanzi.
Il
mercato
internazionale
delle
telenovele rappresenta
oggi
una
guerra
culturale
tra
la
maggiorpartedeipaesi
dell’Americalatinaedè
condotta da potenti
gruppi di media. La
concorrenza è ancora
più agguerrita poiché i
paesi
dell’America
latina non hanno un
network comune, come
Star Tv in Asia o Al
Jazeera nel mondo
arabo.
Il
colosso
brasiliano Tv Globo
affronta
il
colosso
messicano
dell’intrattenimento
Televisa, ma anche
Telefe in Argentina,
Rcn in Colombia e
Venevisión
in
Venezuela
(che
produce le proprie
telenovele a Miami in
collaborazione
con
Univision). Tutti questi
gruppi
sono
in
concorrenza tra loro
anche sul mercato più
redditizio: quello dei
latinoschevivononegli
Stati Uniti, già tenuto
d’occhiodalleemittenti
americane in spagnolo
con sede a Miami,
TelemundoeUnivision.
Con 45 milioni di
ispanici
sul
suolo
americano, più un
numero tra i 10 e i 15
milioni di immigrati
illegali,
soprattutto
messicani, gli Stati
Uniti sono oggi il
secondo
paese
di
lingua
ispanica
al
mondo,
dopo
il
Messico, ma prima
della Spagna. Questo
mercato “latino” degli
Stati
Uniti
è
fondamentalepertuttii
produttori
di
telenovele.
È
una
potenziale
audience
molto
superiore
a
quella della maggior
parte degli altri paesi
dell’America
latina,
esclusi il Messico e il
Brasile. È soprattutto
un bersaglio ideale per
la
pubblicità,
un
pubblico con un forte
potered’acquisto.Tutti
i soggetti di questa
industria
hanno
dunque
gli
occhi
puntati su Miami e Los
Angeles,
capitali
esterne
dell’America
latina.
Per il momento, il
leaderdelmercatoèdi
sicuro Univision, la cui
sede sociale è a New
York, ma gli studi sono
a Miami. Il network
raccoglie il 90 per
cento
dell’audience
latino-americana,
soprattutto sulla costa
ovest e nel Sud degli
Stati Uniti, grazie alle
telenovele acquistate
da
Televisa,
suo
partnerprivilegiatoper
gli Stati Uniti. Tre
quarti
della
programmazione
di
Univision
sono
telenovele
rivolte
soprattutto
ai
messicaniamericani,
valutati in oltre 29
milioni
sul
suolo
americano (illegali non
inclusi,
stimati
in
almeno 11 milioni,
ovvero 40 milioni di
potenziale pubblico). Il
network
cerca
di
rivolgersi soprattutto
agli immigrati più
recenti, quelli che
conservano la cultura
del
loro
paese
d’origine,eailorofigli,
laprimagenerazionedi
messicani-americani,
ovvero la comunità più
rilevante
numericamente. Negli
studi di Univision di
Miami
vengono
registrati
ogni
settimanaicelebritalkshow della cubanoamericana
Cristina
Saralegui–unasortadi
Oprah Winfrey latina –
e
la
trasmissione
Sabado
gigante,
programmi
poi
ritrasmessi
da
numerose
reti
televisive latine negli
StatiUnitieinAmerica
latina in regime di
syndication.
La
concorrenza,
tuttavia, è agguerrita:
Telemundo,
che
appartiene a NbcUniversaldal2002,che
ha solo il 10 per cento
dell’audience, è in
crescitasullacostaest.
Contrariamente
alla
concorrenza,
Telemundo ha come
obiettivo il pubblico
ispanico
nella
sua
diversità,inparticolare
i
giovani
latinos
bilingue di seconda e
terza generazione. Nel
tentativo di sottrarre
fette di mercato al
leader
Univision,
Telemundo ha tentato
in questi ultimi dieci
anni diverse soluzioni:
anzitutto ha prodotto
remake di celebri serie
americane
come
Starsky e Hutch e
Charlie’s Angels in
lingua
spagnola
a
partire dall’idea che il
pubblico di latinos
fosse sufficientemente
americanizzato
da
voler vedere serie
americane
e
sufficientemente
ispanico da volerle
vedere in spagnolo.
Sbagliato. I latinos
volevano Friends in
inglese e telenovele in
spagnolo e dunque
l’audience è crollata. Il
secondo tentativo di
Telemundo è stato
acquistare telenovele
originali da network
brasiliani come Tv
Globo, argentini come
Telefe, o colombiani
come
Rcn
e
naturalmenteanchedal
concorrente
di
Televisa-Univision
in
Messico, Tv Azteca.
Questa
volta
si
riescono a fare ascolti
importanti tra cubani,
portoricani
e
colombiani, ma non tra
i messicani-americani
(l’unico mercato che
conta) che continuano
a preferire soprattutto
l’altro
network.
Secondo fallimento. Di
recente, Telemundo ha
adottato una nuova
strategia ampiamente
finanziata da Nbc:
produrre
telenovele
originali nei propri
studi di Miami con
l’obiettivo
di
privilegiare
le
tematiche preferite dai
messicano-americani,
ma aggiungendo la
specifica dimensione
della loro vita negli
Stati Uniti (cosa che le
telenovelemessicanedi
Televisa trasmesse da
Univision non riescono
a fare). Le musiche
sono state affidate a
gruppi
messicanoamericani,
l’accento
latino degli attori è
stato reso più neutro e
nella trama sono stati
introdotti
temi
specifici,
come
il
razzismo anti-ispanico
e
l’immigrazione
illegale. Il successo di
questo nuovo format è
relativo, ma l’audience
è
in
crescita
in
proporzioni
incoraggianti.
Più
recentemente ancora,
Telemundoelapotente
Nbc, che la controlla,
hanno assestato un
colpo
spettacolare
degno di una vera
telenovela, sono infatti
riusciti a rompere in
parte
l’accordo
di
esclusiva tra Univision
e
Televisa,
così
Telemundo
potrà
acquistare le serie
messicane da Televisa
per il pubblico latino
negli Stati Uniti, ma
anche vendere sul
mercato
messicano
telenovele girate a
Miami. Sicuramente,
per i due network
americani,
le
prospettive
sono
buone, dato che la
popolazione
latinoamericana
continua ad aumentare
negli Stati Uniti e dato
cheilmercatoispanico
si
consoliderà
giocoforza.
Questa potenzialità
non è sfuggita a
nessuno
e
la
concorrenza non si
limita a questi due
soggetti, in guerra
ormai da dieci anni. Di
fronteaquestinetwork
americani, anche TV
Globo e Telefe sono
sbarcati negli Stati
Unitipervendereiloro
format. Anche major
come Disney, Cbs, Fox
e Time Warner di
recente
hanno
cominciato a produrre
telenovele a Miami per
il
pubblico
latinoamericano.
“A
grandilinee,ilmercato
della televisione in
America
latina
è
composto in questo
modo:
audience
messicana e brasiliana,
format ideati a Rio e
Buenos Aires, denaro
messicano, patron di
Miami e con mercato
che porta negli Stati
Uniti,”
sintetizza
Mariano Kon, direttore
generale della casa di
produzione
Cuatro
CabezasinArgentina.
Sempre a Buenos
Aires, la casa di
produzione Pol-Ka si
occupa della versione
latinoamericana
di
Desperate Housewives,
la serie americana di
successo di Disney e
Abc. “Non ne facciamo
un solo adattamento,
ma cinque versioni
diverse: una per il
Brasile in portoghese,
tre per la Colombia,
l’Argentina e l’Ecuador
e
una
versione
telemundo
per
il
network
omonimo
rivolto a messicani e
ispanici che vivono
negli
Stati
Uniti,”
spiega Victor Tevah,
direttore aggiunto di
Pol-Ka a Buenos Aires.
Sonosorpresodalfatto
che
non
venga
realizzata
alcuna
versioneperlaSpagna.
“È normale, prendiamo
direttamente la serie
americanaefacciamoil
doppiaggio nei nostri
studi per il network
Cuatro
e
non
utilizzando
una
versione
sudamericana,” spiega
Pablo Romero Sulla,
direttore dei contenuti
di Sogecable, divisione
del settore audiovisivo
del
gruppo
Prisa,
intervistato a Madrid.
“Tra una serie e l’altra
non ci sono differenze
sostanziali, ciò che
cambia è la forma,”
aggiunge Tevah. “Per
ogni
versione
latinoamericanarestail
medesimo contesto, lo
stesso scenario, girato
in una periferia a nord
di Buenos Aires; a
cambiare
sono
gli
interni delle case.
Modifichiamo piccoli
dettagli,
l’abbigliamento
dei
personaggi, le pietanze
che
consumano
a
tavola. Cambiamo le
professioni di alcune
figure, per esempio
nella serie argentina,
l’idraulico diventa il
titolare di un’impresa
di idraulica, poiché,
contrariamente
agli
Stati Uniti, qui è
impensabile che un
idraulico viva in una
periferiadilusso.Nella
serie per Telemundo,
l’immigrato messicano
diventa
invece
un
immigrato
venezuelano.”Infindei
conti, anche inserendo
molte donne sull’orlo
della crisi di nervi
come
nella
serie
originale, le case di
produzione
trasformano a modo
loro
la
versione
americana in una vera
epropriatelenovela.La
versione spagnola ha
un titolo in stile
Almódovar,
Esposas
Desperadas.
In America latina, la
questione
dell’adattamento locale
e
dell’accento
è
importante.
Contrariamente
a
quanto
si
possa
immaginare,
non
sempre
tutti
i
latinoamericani
di
lingua spagnola si
capiscono facilmente
tra
loro.
“Generalmente
si
pensa che l’accento
messicano sia il più
tipico,”spiegaMariano
César, direttore dei
programmidelnetwork
argentino
Isat,
intervistato a Buenos
Aires. “Anche l’accento
colombiano è tipico.
Tuttavia la parlata
cubana,
argentina,
uruguaiana
e
venezuelana
sono
molto diverse. Per
diventare un network
comune a tutti gli
ispanici, cerchiamo di
utilizzare lo spagnolo
‘neutro’, uno spagnolo
indifferenziato
e
leggermente
semplificato, oppure di
sottotitolare le nostre
telenovele e i nostri
contenuti
il
più
possibile.
Però
la
sottotitolatura
deve
essere fatta in diverse
lingue, per esempio in
Spagna e in Argentina
non si scrive nello
stesso modo. Il rischio,
altrimenti, è che non
tutti possano seguire i
nostriprogrammi.”
Mariano Kon, della
casa di produzione
Cuatro Cabezas di
Buenos Aires, non è
per nulla convinto: “In
un
certo
periodo
abbiamopensatochelo
spagnolo ‘neutro’ fosse
la soluzione: è lo
spagnolo inventato per
il doppiaggio, uno
spagnolo
da
televisione.Maèmolto
artificiale.
È
lo
spagnolo
che
sognavano gli studios
di Hollywood. Era
un’illusione”.Dalcanto
suo,
Michelle
Wasserman, direttrice
delle vendite di Telefe,
il
primo
network
argentino, conferma a
Buenos
Aires:
“Il
mercato
delle
telenovele ci impone il
doppiaggio.
Anche
quando vendiamo le
nostre telenovele a
paesi
ispanici,
dobbiamo
doppiarle.
Così come per lei
sarebbe assurda una
serie francese con un
accento del Québec, lo
stesso
accade
per
l’Americalatina”.
Alla sede di un altro
grande
network
argentino, Canal 9 a
Buenos
Aires,
l’amministratore
delegato
Carlos
Gaustein, in aperta
concorrenza
con
Telefe, fa un’analisi
simile. Tuttavia pone
l’accento sullo stretto
legame che esiste tra
paesi produttori di
telenovele e la loro
economia,
compresa
l’ascesa
dei
paesi
emergenti anche nel
settoreaudiovisivo.“La
produzione
di
telenovele e la loro
diffusione sui mercati
esteri
sono
strettamente legate al
potere economico dei
singoli paesi. Ormai il
Messicoèincrescita,il
Brasile esplode, noi
siamo in fase di
stagnazione
e
il
Venezuela in crollo. Il
successodipendemolto
dal mercato interno: i
paesi emergenti prima
vannomegliodeglialtri
nella produzione e poi
arrivano
anche
le
esportazioni.
Il
Venezuela,
per
esempio,eraungrosso
esportatore
di
telenovele,
ma
il
presidente
Hugo
Chávez ha indebolito il
sistema di produzione
privato e i contenuti
sono crollati. Oggi il
network venezuelano
Venevisión è costretto
a produrre le sue
telenoveleaMiamicon
il network americano
Univision.”Leindustrie
creative sono settori
industriali
veri
e
propri.
A Caracas, Marcel
Granier,
amministratore
delegato di Rctv, un
network
tradizionale
proibito da Chávez, ma
che
continua
a
trasmettere
i
suoi
programmi via cavo e
via satellite, conferma:
“L’economia è rovinata
e la censura dei media
è totale. Prima di
Chávez, il Venezuela
era
il
secondo
produttore
di
telenovele
dopo
il
Messico. Oggi è già un
ottimo risultato se
siamo i quinti e
dobbiamo comprare le
serie dai messicani di
Televisa
e
dai
colombiani di Rcn”. Il
concorrente principale,
Venevisión, ieri antiChávez e oggi più
moderatopertimoredi
perdere
le
autorizzazioni
a
trasmettere,
ha
realizzato una seconda
linea di produzione di
telenovele a Miami
“per avere più libertà,
raccogliere le forze e
preparare il futuro in
caso di difficoltà a
Caracas” (afferma uno
dei responsabili che
preferisce
restare
anonimo).Sulleragioni
di
questo
crollo,
German Pérez Nahim,
direttore generale di
Televen, un importante
network
privato
venezuelano,
mostra
prudenza poiché non
può
permettersi,
afferma egli stesso, di
avere un rapporto
polemicoconilgoverno
di Chávez: “Le regole
giuridiche
cambiano
spesso. Il mercato
pubblicitarioècrollato.
La
recente
realizzazione di un
doppio tasso di cambio
è
arbitraria.
L’inflazione
è
galoppante, c’è una
continua svalutazione,
aumenta
la
disoccupazione.
Le
tecnologie sono in
ritardo. L’insicurezza
economicaèesplosa.È
il crollo dell’economia
auccidereilmercatodi
telenovele. Inoltre, non
bisogna
dimenticare
cheoggiilVenezuelaè
il paese con il tasso di
criminalità più elevato
dell’America latina e
questoindeboliscetutti
i progetti”. La sua
famigliaviveaMiamie
lui stesso gira con la
scorta.
Il presidente di Rctv,
Inés Bacalao de la
Peña, incontrata a
Caracas, aggiunge un
altro elemento, quello
della cultura e della
lingua: “Le telenovele
venezuelane
non
riescono a imporsi
perché stanno a metà
tra
due
grandi
tendenze di questo
genere.
Le
nostre
storie non sono né
classiche e tradizionali
come
accade
in
Messico – dove la
ragazza povera trova
amore e denaro e
recita in costume –, né
contemporanee
e
direttamente
legate
alla vita delle persone,
comeaccadeinBrasile,
in cui le serie parlano
di favelas, droga, gay.
Siamo meno liberi del
Brasileneicostumi,ma
piùdelMessico.C’èpoi
il
problema
dell’accentolinguistico:
quello spagnolo di
messicani e colombiani
è ben accettato in
America latina, quello
degli argentini e il
nostro è meno ben
accolto. Se vogliamo
trasmettere le nostre
telenovele in America
latina
dobbiamo
doppiarle”.
Nella
geopolitica
delleserietelevisive,la
cosa più affascinante è
forse
quella
del
doppiaggioinrelazione
all’uso dei sottotitoli. È
un
aspetto
fondamentale
che
mette in luce il ruolo
della cultura locale
all’interno
della
globalizzazione.
Su
questo
fronte
è
possibile dividere i
paesi in tre categorie.
Anzitutto ci sono i
paesi, generalmente di
dimensioni geografiche
ridotte, in cui le
telenovele
straniere
sono trasmesse in
lingua originale e sono
sottotitolate
per
renderle comprensibili
alpubblicolocale.Trai
paesi che sottotitolano
senzadoppiarecisono:
Olanda,
Danimarca,
Finlandia,
Belgio
fiammingo, Portogallo,
Israele,
Islanda,
Romania, Malesia e i
paesiarabi.Poicisono
i paesi che, per
nazionalismo,
per
ragioni sindacali, o
perché la popolazione
ha ancora sacche di
analfabetismo,
doppianoleseriesenza
sottotitoli: Ungheria,
Repubblica
Ceca,
Vietnam,
Canada
(soprattuttoilQuébec),
Francia,
Belgio
francofono, Italia (dove
isindacatiimpediscono
di sottotitolare per
difendere i posti di
lavorodeidoppiatori)e
anche la Spagna che
doppia con l’accento
castigliano
le
telenovele ispaniche.
Infine, c’è un sistema
misto e piuttosto raro,
usato in Russia e
Polonia,
chiamato
“voice-over” in cui uno
o due attori descrivono
lascenaincuigliattori
recitano
in
lingua
originale, una forma di
narrazione
ereditata
dallacensurasovietica.
Negli Stati Uniti,
invece,
non
vige
nessuno
di
questi
sistemi. Come diceva
Jean
Baudrillard:
“L’America
è
la
versioneoriginaledella
modernità e l’Europa è
la versione doppiata o
sottotitolata”. Dunque
negli Stati Uniti si
prediligono le serie e i
filminlinguaoriginale,
in
inglese,
e
si
importanopocoleserie
straniere.
“È
più
riposante,” spiega con
ironia Chris Clark,
direttore del Saint
Louis Film Festival
intervistato
nel
Missouri.
“Con
i
sottotitoli
è
meno
entertaining.
Si
abbandona la cultura
mainstream
per
rientrare in una di
nicchia.”
La guerra mondiale
delleserieedeiformat
televisivi è appena
cominciata.
Come
all’interno
di
una
telenovela ben fatta,
questo
mercato
provoca
bramosie,
resistenze, cambi di
alleanze e, spesso,
gelosie. La Corea del
Nord veglia perché i
drama sudcoreani non
oltrepassino i confini; i
cinesi diffidano del
successo dei drama
taiwanesi, i giapponesi
intensificano gli sforzi
per
battere
i
sudcoreani,
che
aumentano gli sforzi
per
battere
i
giapponesi; i siriani e i
libanesi
vogliono
recuperaremercatosul
fronte dei teleromanzi
del
Ramadan,
controllato dall’Egitto,
tallonati dai paesi del
Golfo;
il
colosso
brasilianoTvGloboèin
concorrenza con quello
messicano Televisa, a
costodiallearsicongli
imperialisti americani
di Telemundo; e Hugo
Chávez vorrebbe che
Venevisión, il network
venezuelano,
producesse telenovele
a livello locale (è
esasperato dal fatto
chevenganoprodottea
Miami). È una vera e
propria
guerra
culturale che si dipana
sotto i nostri occhi, sui
nostrischermi.
Eppure,
contrariamente
al
cinema, alla musica, ai
cartoni animati e ai
videogiochi, le serie
televisive
“viaggiano
poco” – e spesso su
cortedistanze,suscala
continentale,
raramente a livello
globale. Il mercato
televisivo è soprattutto
un mercato locale,
anche se i format
possono
diventare
mondiali.
Solo
gli
americani hanno un
grande
successo,
aumentano
i
programmi per un
pubblico di massa e
talvolta
riescono
meglio degli altri a
conquistare tutti. Per
comprendereleragioni
di questo successo, è
necessarioandarenella
capitale
del
mainstream
dell’America
latina,
Miami.
13.
Miami,capitalepop
dell’Americalatina
Lincoln
Road,
a
Miami Beach, è una
piccola arteria che
attraversa da ovest a
est questa lingua di
terra che somiglia a
un’isola. All’estremità,
sulla costa atlantica,
c’è
una
celebre
spiaggia su cui svetta
l’Hotel Ritz-Carlton, la
quintessenzadiciòche
rappresenta
nell’immaginario
americano
South
Beach, il Sud di Miami
Beach. Qui si trovano:
sole
tutto
l’anno,
architettura art déco,
Shakira,
sigari
La
Gloria
Cubana,
lo
spagnolo come lingua
ufficiosa, la seconda
residenza di Madonna,
MiamiVice,ladiversità
etnica e soprattutto la
musica“latina”.
“In America latina
non ci sono i latinos. I
latinos sono qui,” dice
intonodiprovocazione
José
Tillan,
vicepresidente di Mtv
Latin America, che
incontro al civico 111
di Lincoln Road a
Miami Beach. Tutte le
majordelladiscografia,
le agenzie di talenti, i
network
televisivi
musicali e i loro show
specializzati, le radio
latine, le società di
diritti
d’autore,
le
riviste musicali come
“Billboard” o quelle
dell’intrattenimento
come “Variety” hanno
un ufficio su Lincoln
Road o nelle vie
adiacenti. Al punto che
questo complesso di
uffici
è
chiamato
“Silicon
Beach”
o
“Hollywood
Latin
America”.
José Tillan è cubano,
come
molti
professionisti
dell’industria
discografica incontrata
a Miami, ma i suoi
colleghi di Mtv Latin
America
(chiamata
talvolta Mtv Latin o
semplicemente
Mtv
Latino) sono spagnoli,
argentini, venezuelani,
colombiani
e
soprattutto messicani.
“Questo è il quartier
generale per tutta
l’America
latina.
Abbiamo dipendenti di
tutte
le
origini
ispaniche.
Storicamente, Miami
era una città con molti
cubani, poi è diventata
una
città
più
eterogenea con l’arrivo
dimoltiispanicidiogni
nazionalità e di ogni
etnia.Èancheunacittà
molto mista in cui le
minoranzevivonomeno
ghettizzate rispetto ad
altre città degli Stati
Uniti.Èunconcentrato
dell’America latina, ma
il
nostro
mercato
principale ormai è il
Messico,”
sintetizza
Tillan. Gli uffici di Mtv
a
Miami
sono
specializzati
nella
musica latina, così
come a Nashville ci si
concentra la musica
country. “Ci si occupa
anche del mercato
‘latino’ per gli Stati
Uniti,
in
forte
espansione,”
precisa
Tillan.
Dalla fine degli anni
novanta, Mtv si è
diversificata:ilnetwork
si adatta a ogni paese,
adottandonelalinguae
producendoprogrammi
a
livello
locale.
“Seguiamo il nostro
slogan: ‘I want my
Mtv’. In America latina
abbiamo
emittenti
diverse:uncanaleperi
latinoschevivononegli
Stati Uniti, uno per il
Messico,
uno
per
l’Argentina e Mtv in
portoghese.” Mentre
ascolto parlare José
Tillan mi viene in
mente
che
nella
metropolitanadiMiami
i cartelli e gli annunci
sono in tre lingue:
inglese, spagnolo
portoghese.
e
Il giorno dopo ho
appuntamento
con
Gabriela
Martinez,
vicepresidente
di
Warner Music Latin
America,nellasededel
gruppo su Washington
Street,
una
via
perpendicolare
a
Lincoln Road, a Miami
Beach. Come Mtv,
anche Warner ha il
proprio
quartier
generale “latino” a
Miami. Da questa sede
viene
diretta
una
decina di altri uffici
negli Stati Uniti e in
America latina. Quasi
duecentocinquanta
dipendentidiWarnersi
occupano di “musica
latina”,
un’ulteriore
controprovachequesto
genere è un aspetto
fondamentale per la
major di New York.
Gabriela Martinez è
messicana e come tutti
a Miami si sposta
continuamente
tra
Miami, il Messico e
l’America latina. “Fino
al 2001 i nostri uffici
erano a New York, poi
abbiamo trasferito il
nostro
quartier
generale ‘latino’ qui a
Miami,
capitale
dell’America
latina
negli
Stati
Uniti,”
precisa Martinez. “La
Florida non è il
mercato
più
importante, ma Miami
è il simbolo di questo
mercato, è anche la
città più eterogenea e
quella
che,
geograficamente,
permetteconmaggiore
agio
di
spostarsi
ovunque,”
aggiunge.
Da
Miami,
tutta
l’America
latina
è
facilmente
raggiungibileinaereo.
Jorge Fonseca è il
direttore artistico di
Sony Norte, l’etichetta
“latin” di Sony a
Miami: “Sono sempre
sulcampo.VadoaCittà
del
Messico
per
ascoltare i gruppi in
studio, a Portorico per
ascoltare i concerti, a
Miami per partecipare
alle serate open mic
(microfoni
a
disposizione di chi
vuole salire sul palco)
dell’Università
di
Miami. Scopro nel
contempo autori e
cantanti, compositori e
musicisti. Qui a Miami
è possibile avere la
migliore
visione
d’insieme di questo
settoredimercato”.
“Viva L’Avana, viva
Cuba, viva gli Stati
Uniti, viva Miami, viva
New
York,
viva
Washington.” Così ha
chiuso il suo concerto,
tenutosi sulla piazza
della
Repubblica
dell’Avana
nel
settembre
2009
il
cantante
Juanes,
venuto da Miami, e
davanti a un milione di
persone – un pubblico
enorme.
Miami è anche la
capitale straniera di
Cuba.
La
musica
cubana venduta in
tuttoilmondoèspesso
prodotta e diffusa da
cubani di Miami, come
mi dice Rafael Artero,
vicepresidente di Bmg
Music Publishing a
Miami (Bmg è la
divisione
musicale
“publishing”
del
colosso
tedesco
Bertelsmann,
ormai
autonomo da Sony).
“Gli europei, ghiotti di
musica cubana, non lo
sanno, ma la musica
cubana che ascoltano
spessoèprodottanegli
Stati Uniti. È una
musica fatta da cubani
di Miami. La vera
musica cubana fatica a
essereesportata,nonè
abbastanzaconformeai
nostri stili per poter
avere
successo
commerciale in tutto il
mondo. E non è
mainstream. Ma nello
stesso tempo è più
pura.” Altri manager
incontrati a Miami
spiegano invece di
lavorare per Cuba,
“sotto il mantello”,
secondo l’espressione
di
Ivan
Alvarez,
vicepresidente
di
Universal
Music
PublishingaMiami.Poi
prosegue:
“Abbiamo
relazioni con Cuba, fa
parte
della
nostra
professione. Nel nostro
catalogo c’è molta
musica cubana, anche
se è vero che si tratta
di un genere musicale
ancora in evoluzione,
datato e un po’ al di
fuori delle tendenze
attuali.
Ma
anche
questo côté vintage fa
partedelsuosuccesso.
Inoltre, e soprattutto,
ci stiamo preparando
per
quando
Cuba
diventerà libera”. Nel
frattempo,IvanAlvarez
guarda
più
verso
Portorico che verso
Cuba, perché da lì
proviene
il
nuovo
genere di cui tutti
parlano a Miami, il
reggaeton.
“Il reggaeton mette
insieme le masse di
latinos”
“Il reggaeton è l’hiphop
dei
latinos,”
sintetizza con una sola
frase Rafael Artero. “È
una musica urbana, un
altro nome del rap
latino,” prosegue. Su
Latino 96.3 a Los
Angeles, Mega 97.9 a
New York, Klol a
Houston e su diverse
stazioni
radio
di
Univision
e
Clear
Channel a Miami, il
reggaeton è diventato
la musica dominante
nel
2005-2006.
In
origine, questo genere
musicale – un rap in
spagnolo con ritmi
sincopati derivati dalla
musica caraibica –
nasce a Portorico,
territorio
non
incorporato sotto la
sovranità degli Stati
Uniti. A importare e
diffondere negli Usa
questo genere è stata
la
comunità
portoricana di New
York e Orlando, in
Florida, seguita poi dai
giamaicani.Ilgeneresi
è poi diffuso da una
regione all’altra grazie
aimilionidilatinosche
vivono negli Stati Uniti
e ha modificato la
geografia tradizionale
dellamusicalatinafino
ad allora frammentata
in “nicchie”: musiche
ispirateaiCaraibisulla
costa est (tropicalismo,
salsa,
merengue,
bachata);
musiche
influenzate o derivate
dai generi messicani in
California e negli stati
del Sud (in particolare
laregionalemessicana,
una sorta di country
messicano, soprattutto
banda,
ranchera,
mariachi, norteña); e
una
musica
molto
cubana in Florida. Il
reggaeton,
inizialmente,
era
cantato in spagnolo,
poi è diventato un
miscuglio linguistico di
espressioni
“spanglish”,
metà
spagnolo,metàinglese,
e in questo modo è
diventato
più
mainstream.
Il
successo
del
reggaetonsispiegacon
il fatto che questo
genere è stato capace
ditesserelegamitrala
seconda e la terza
generazione di ispanici
che vivono negli Stati
Uniti e le loro origini,
quelledeilorogenitori:
lo
stile
urbano
dell’hiphop
rappresenta il paese in
cui vivono, mentre il
ritmo
caraibico
rappresenta le loro
radici. Il giovane latino
non ha più bisogno di
scegliere tra la sua
famiglia e la cultura
popolare
americana,
fra tradizione e cool.
Daddy Yankee, un
portoricano di ventotto
annidiventatounastar
di
questo
genere
musicale,
ha
sintetizzato
efficacemente
il
concetto
dicendo:
“Questa
musica
permette alla seconda
generazione di sentirsi
latina. Il reggaeton
unifica le masse di
latinos”.
A
partire
dal
momento in cui il
reggaetondecollanegli
StatiUniti,lemajordel
disco,chefinoadallora
avevano
ignorato
questo genere poiché
lo consideravano “hiphop con venticinque
anni
di
ritardo”
(secondolaformuladel
patron di una major
citato
dal
“New
Yorker”),
se
ne
impadroniscono.
È
necessario sapere che,
all’inizio del nuovo
millennio, la comunità
ispanica diventa la
prima
minoranza
americana, davanti ai
neri.
L’incremento
degli ispanici è tre
voltesuperioreaquello
degli altri americani
(oggi sono 45 milioni,
ovvero il 15 per cento
della popolazione degli
StatiUniti,metàdiloro
ha meno di ventinove
anni), così le case
discografiche
si
concentrano su questo
mercato
latino
potenzialmenteinfinito.
Ai patron delle major
sembra di aver trovato
l’oro “brown”: eccoli
dunque attentissimi ai
dati di Nielsen del
mercoledìmattina(agli
abbonatisonofornitele
vendite
dettagliate
della
settimana
precedente divise per
genere e città negli
Stati
Uniti
e
in
Canada), appassionarsi
alla hurban music, un
insieme di hispanic e
urban e attenti all’hiphop
latino
e
al
reggaeton. Il primo
disco d’oro arriva con
Daddy Yankee che
vende un milione di
copie con Barrio Fino
del 2004 (uscito per
Universal), grazie alla
sua hit Gasolina. Il
videoclip mostra una
ragazza a cui piace
andare a caccia di
ragazzi in auto e
dunque ha bisogno di
“gasolina”, che è stata
interpretata,divoltain
volta, come alcol di
contrabbando, sperma
e benzina. “Titts & ass
(tette e culi) sono la
chiave del successo,”
mi dice in tono serio il
veterano della musica
latina Henry Stone,
ottantanove
anni,
intervistato nella sua
residenza di Coconut
Grove nel Sud di
Miami. Il reggaeton è
un genere con forti
riferimenti
sessuali,
soprattutto quando si
balla corpo a corpo
nelle discoteche, è un
gangsta rap latino
dichiarato – secondo i
suoi sostenitori, la
lingua
spagnola
permette negli Stati
Uniti
più
audacia
dell’inglese.
Il contesto specifico
di Miami spiega in
larga parte il fatto che
Miami
Beach
sia
diventata la capitale
del reggaeton e più in
generale della musica
latina. A Downtown
Miami, sull’altro lato
della baia, a cinque
chilometri da Miami
Beach, ci sono le
banche più ricche di
tutta l’America latina.
Qui star del Messico,
fuoriusciti
cubani,
venezuelani
antiChávez,
mafiosi
brasiliani e uruguaiani
depositano il denaro,
con una discreta dose
disicurezza.
A Miami ci sono
inoltre
studi
di
registrazione di alta
qualità,
ereditati
dall’epoca del Miami
Sound, il soul e il rock
degliannisettanta,che
attirano musicisti ben
oltre il genere della
musica
“latina”.
Numerosi
gruppi
americani di R&B e
rap, spesso inglesi che
vogliono registrare in
un ambiente calmo
lontano da Londra, si
danno appuntamento
neglistudidiMiami.Ci
sono anche settori
delle
major
specializzati
nella
distribuzione di cd e
dvd, oggi in grande
difficoltà, ma sempre
strutturatiaMiami.
“Inoltre, a Miami c’è
un’attività legale che
segue
le
regole
americane, mentre è
poco
affidabile
in
Americalatina,”spiega
Rafael Artero. “Per
esempio, le trattative
sui diritti, la gestione
del
copyright,
la
scrittura di contratti
internazionali
estremamente
complessi. Questa è la
forza degli Stati Uniti
ed è ciò che spiega
l’importanza di Miami
per tutta l’America
latina.” Anche se è
meno noto, a Miami
esistono
forme
di
sostegno pubblico per
le
industrie
dell’intrattenimento,
soprattutto attraverso
crediti sulle imposte e
un sistema di zoning
che
facilita
l’insediamentoaMiami
Beach
di
aziende
americane e straniere.
Alla
Universal
di
Miami, Ivan Alvarez
conferma
questa
ipotesi: “In Venezuela
non
c’è
stabilità
politica o economica e
c’è
una
forte
criminalità;
in
Colombia non si può
essere sicuri delle
banche; in Messico il
copyright
non
è
protetto e i cd inviati
con
Amazon
non
arrivano
mai
a
destinazione;
in
Argentina i tassi di
cambio sono artificiosi;
in Brasile c’è tensione
sociale
e
molta
corruzione;
ovunque
mancano
reti
televisive, agenzie di
talenti,
stampa
specializzata
nel
settore musicale e siti
internet
capaci
di
generare
un
passaparola
internazionale.C’èsolo
Miami
che
può
rispondere a tutti i
bisognidelmondodella
musica.
Miami
è
l’America latina senza
criminalità e senza
corruzione”. (Forse, mi
viene però in mente
l’assassinio
dello
stilista Gianni Versace,
che viveva su Ocean
Drive a Miami, per
mano di un gigolò
serial killer che lo
uccisesullaspiaggiadi
SouthBeach.Nonsono
certo che Miami abbia
tuttelemiglioriqualità
mentre
i
paesi
dell’America
latina
siano pieni di difetti.
Mi pare un’immagine
frutto di pregiudizi e
figlia
del
passato
dell’America latina e
molto
meno
del
presente – Venezuela
escluso –, per esempio,
il Messico e il Brasile
sono paesi emergenti
potentielaColombiaè
perfettamente in grado
difarfunzionarelesue
banche).
Jorge
Fonseca,
rappresentantediSony
a Miami, aggiunge
all’analisi un elemento
a
suo
avviso
determinante:
la
diversità
etnica.
“Miami è l’America
latina in miniatura.
Solo a Miami c’è un
simile mélange etnico.
In
nessun’altra
capitale, Buenos Aires,
Città del Messico, Rio,
San Paolo, c’è questa
diversità. Anche i neri
qui sono molto ben
integrati.EpoiMiamiè
deliberatamente
una
capitaledelmondogay,
è
aperta,
fattore
fondamentale affinché
gli artisti si trovino
bene.
Miami
è
diventata la capitale
dell’America latina per
la musica, poiché è la
città della diversità
latinaglobalizzata.”
In questo contesto ci
sono inoltre aziende
legate alla pubblicità e
al marketing – tutte le
grandi agenzie hanno
unufficioaMiami–,un
numeroimpressionante
di club, discoteche e
soprattutto
piccole
locationincuiqualsiasi
gruppo può fare uno
show-casenelretrosala
di un ristorante su
Washington Avenue a
SouthBeach.Èdunque
evidentel’interesseper
un artista a venire a
Miami. Poi ci sono le
radio. “Sono state le
radio ad aver fatto di
Miami
un
luogo
imprescindibile per la
musica
latina,
comprese le numerose
radio illegali a bassa
frequenza,” spiega Bo
Crane, presidente di
Pandisc,
etichetta
indipendente di musica
latina. Miami ha la
massa critica di un
intero
continente
concentratainunasola
città.
L.A.,LatinAmerica
Vista
dall’America
latina, la posizione
dominante di Miami
suscita
incredulità,
amarezza e gelosie.
Molti
dirigenti
dell’industria musicale
intervistati a Buenos
Aires,
Città
del
Messico,
Caracas,
Porto Alegre e Rio
criticano la pretesa dei
gringos di Miami di
considerarsi la capitale
estera
dell’America
latina.
Tutti
riconoscono,tuttavia,il
potere di Lincoln Road
e, attraverso questa
famosastradadiMiami
Beach, degli “EE.UU.”,
ovvero “los Estados
Unidos”, come sono
chiamati gli Stati Uniti
inAmericalatina.
InArgentina,ipatron
dell’industria musicale
pongono
l’accento,
giustamente,
sulla
buona tenuta nelle
vendite dei generi
locali, come salsa e
tango
(in
Brasile
parlano di samba e
bossanova, una musica
più nera). Tutti sono
costretti a riconoscere,
nonostante tutto, che
quando si tratta di pop
trans
nazionale,
comuneaidiversipaesi
dell’America
latina,
vengono alla mente
solo i nomi di artisti
latinoamericani
“miamizzati”.
Per molti giovani
sudamericani,
la
musica pop latina ha il
nome
di
Juanes,
Shakira
e
Gloria
Estefan e talvolta di
Jennifer Lopez e Ricky
Martin. Queste sono le
stardell’Americalatina
globalizzataetuttioggi
sono
americani
o
americanizzati.
Juanes è colombiano
econtinuaacantarein
spagnolo(talvoltaporta
anche negli Stati Uniti,
per militanza, una
celebre maglietta con
scritto
“se
habla
español”) ed è sotto
contrattoconUniversal
a Miami dove ha una
casa. È fiero delle sue
origini colombiane e
dissimula
la
sua
americanizzazione.
Shakira, star libanocolombiana, è l’esatto
contrario: cantava in
spagnolo
e
ha
deliberatamentescelto,
imparando
l’inglese
con determinazione, di
cantare in americano;
era
già
nota
in
Colombia, ma è stato
l’inglese
a
farla
diventare famosa a
livello internazionale
ed è prodotta a Miami
(edèdiventatabionda).
Oggi fa uscire i suoi
album in versione “Us”
e in versione “latina”.
Juanes e Shakira sono
autori, compositori e
interpreti e questo ha
permesso loro una
lungacarriera.
Gloria Estefan è la
piùgrandestarcubana
dell’intrattenimento
latino contemporaneo,
ha conseguito sette
Grammy Awards e
venduto
novanta
milioni di album in
tutto il mondo, di cui
un quarto negli Stati
Uniti.Lasuafamigliaè
fuggita
a
Miami
durante la Rivoluzione
cubana poiché il padre
era una delle guardie
del corpo di Batista. A
venticinque anni ha
cominciato la carriera
musicaleall’internodel
gruppo Miami Sound
Machine. Al contrario
di Shakira, e guidata
dal
marito,
il
produttore
cubanoamericano di origini
libanesi Emilio Estefan
(che dirige la carriera
dell’una e dell’altra),
ha
cominciato
a
cantare in inglese
prima di ritrovare le
sue radici e di incidere
in spagnolo. Vive a
MiamiBeach.
La
carriera
di
Jennifer Lopez e di
Ricky
Martin
–
entrambi
sotto
contratto con Sony
Music Entertainment –
è
più
americana
ancora.Laprimaèuna
“nuyorican”
(neologismo che indica
i newyorkesi di origine
portoricana):ènatanel
Bronx all’interno della
comunità portoricana,
anche
se
le
si
rimprovera di non
riuscire
a
parlare
correttamente
in
spagnolo (e ha dunque
cercato di cimentarsi,
senza
troppo
convincere, con Una
noche más, versione
latina
del
celebre
Waiting for Tonight). Il
secondo è nato a
Portorico.
Entrambi
hanno
inserito
il
reaggaeton nelle loro
canzoni per avere uno
stilepiù“latino”.Mase
JenniferLopezcantain
inglese, Ricky Martin
ha seguito lo stesso
percorsodiShakira:ha
cominciato la carriera
in una boy band latina,
poi ha intrapreso la
carriera
solista
cantando in spagnolo e
poi
è
passato
all’inglese (la celebre
Livin’laVidaLoca,con
titolo inglese e parole
in inglese e spagnolo
segnano il passaggio).
La strategia di Ricky
Martin è stata: uscire
dalla “nicchia” della
musica latina, entrare
nelle
diverse
hit
parade,
conquistare
pubblico negli Stati
Uniti
e
diventare
mainstream. Sia per
Ricky Martin sia per
Jennifer
Lopez
l’operazione
ha
funzionato
e,
accentuando la loro
americanizzazione,
i
due
artisti
sono
diventati star globali.
Di contro, in America
latina
sono
stati
criticati
per
aver
abbandonato le loro
radici, ma anche in
quella
parte
del
continente americano
continuano a vendere
molti dischi. Le hit di
tutti questi cantanti,
eccetto
quelle
di
Juanes,sonoall’interno
delle chart pop e non
più
latin,
poiché
cantano in inglese.
Forse sono diventati
mainstream, ma hanno
abbandonato la musica
ispanica.
A trenta minuti di
strada da Rio de
Janeiro, all’interno di
un parco tropicale di
alberi centenari vicino
al Lago Tijuaca, tra
colline e oceano, c’è la
sede
di
Universal
Music Brasile. José
Antonio
Eboli,
amministratore
delegatodiUniversal,è
una persona affabile e
sorridente,miricevein
jeans e maglietta al
secondo piano di un
immenso edificio in
stile neolecorbusier in
questo
contesto
paradisiaco. Sul suo
coffeetable c’è una
collezione
di
“Billboard”chesembra
conoscere a memoria.
Ai muri sono appesi
poster
di
Mariah
Carey,
Eminem
e
Caetano Veloso – il
grande
artista
di
Universal Brasile. “Qui
dirigiamoleattivitàper
tutto
il
Brasile,
dipendiamo
dall’amministratore
delegato di Universal
Latin America che ha
sede a Miami,” spiega
subito José Eboli. La
strategia di marketing
per la creazione di una
star
latina
alla
Universal è evidente.
Eboli
la
descrive
chiaramente:
“Per
iniziare è necessario
breakyourownmarket
first, avere successo a
livello locale. Avere
questa base locale è la
chiave fondamentale:
inColombiaperJuanes
e Shakira, Portorico
per Daddy Yankee e
Ricky
Martin.
È
necessario aver avuto
successo nella propria
comunità e avere una
popolarità
da
trasmettere, una storia
di
successo
da
raccontare. Poi, you
have to get Us latino
market. José Eboli
insiste
su
questa
espressione
inglese.
Ma come si fa a
conquistare il mercato
dei latinos negli Stati
Uniti?“Sipuòfaresolo
a Los Angeles o
Miami,”
prosegue
Eboli. “È lì che si
diventa ‘latinos’. La
colombiana Shakira è
diventata una cantante
conosciuta in tutto il
mondo,
anche
in
Giappone, a Miami; la
stessa cosa è accaduta
a
Juanes.
Non
sarebbero mai arrivati
in Giappone senza
passare per Miami. A
partire da Miami, con
un po’ di fortuna, si
conquista prima il
mercato latino degli
Stati Uniti, un mercato
complesso e suddiviso
in molti settori di
nicchia. I latinos, da
quelle
parti,
si
considerano ispanici,
maancheamericani;la
loro ascesa sociale
passa in larga parte
attraversolanegazione
della
loro
cultura
d’origine, soprattutto a
partire dalla seconda
generazione. È dunque
un pubblico complicato
che spesso preferisce
Madonna
a
Ivete
Sangalo.Poisiaffronta
ilmercatomessicano,il
più
importante
in
terminiquantitativi,eil
più
difficile
da
conquistare;seilpiano
funziona si riesce a
conquistare anche il
resto
dell’America
latina.
Le
cose
avvengono più o meno
sempre
in
questa
sequenza.
Solo
a
partire da Miami un
artista è in grado di
superare i confini,
diventare
hot
in
Americalatinaepoinel
restodelmondo.Miami
èilpassaggioobbligato
diquestastrategia.”
Sul
mercato
brasiliano José Eboli
esita
prima
di
rispondere: “Spesso il
Brasile è un mercato a
parte, come se non
fossimo in America
latina. A causa del
portoghese,ilBrasileè
un’isola e i successi
spagnoli penetrano più
difficilmente da queste
parti.
Juanes,
per
esempio, che è un
artista Universal ed è
una grande star per
tutti i latinos, non è
mai stato famoso in
Brasile. Cerchiamo di
promuoverlo facendolo
suonare con musicisti
brasiliani.
Abbiamo
anche pensato di farlo
cantare in portoghese,
ma i brasiliani non
amano le star che
cantano in portoghese
in modo artificiale,
preferiscono chi canta
in inglese. Qui il modo
migliore per diventare
big è recitare in una
telenovela
di
Tv
Globo”.Personalmente,
apprezzo gli album di
Juanes e, fra tutti
questi
artisti,
mi
sembrailpiùautentico,
è
rimasto
spiccatamente
colombiano.Chiedopoi
come questi artisti
riescano ad arrivare in
Europa. José Eboli: “Il
passaggio obbligato è
Madrid,eIbizal’estate.
Lisbona ha la stessa
funzioneperilmercato
dellamusicabrasiliana,
ma è più marginale. In
tutti
i
casi,
la
circolazione
della
musica è generalmente
a senso unico, va
dall’America
latina
verso l’Europa e non
piùilcontrario.Alungo
le capitali dell’America
latina
sono
state
Madrid e Lisbona, ma
Miami oggi le ha
soppiantate
tutte.
L’influenza
del
Portogallo in Brasile e
della Spagna nei paesi
ispanici ormai è del
tutto marginale: ciò si
spiega
con
le
dimensioni geografiche
di questi paesi, con le
differenze economiche
e soprattutto con la
quantità
della
popolazione”.
Il
Brasile, per esempio,
oggi è venti volte più
popolato
del
Portogallo; è membro
del G20 e ha un Pil
quasi cinque volte
superiore a quello del
Portogallo.“IlBrasileè
diventatoungigante,il
Portogallo un nano,”
concludeJoséEboli.
Chiedo allora come
possa
diventare
“global” un artista
brasiliano. Né José
Eboli né il produttore
brasiliano
Leninha
Brandao
che
ho
incontrato
hanno
cercatodinascondermi
ilfattocheesseresotto
contratto
con
una
grande major a livello
locale non porta quasi
mai a un successo
mondiale. L’ufficio di
Universal a Rio, per
esempio,nonpotràmai
permettereaunartista
brasiliano di diventare
“global”. È solo un
mercato nazionale con
scarsa influenza sugli
altri paesi e sul
mercatointernazionale.
Peraltro,neiraricasiin
cui alcuni artisti locali
diventano
sufficientemente
mainstream per essere
esportati,
generalmente passano
sotto
l’ala
della
direzione della major a
MiamioLosAngeles.
In tutta l’America
latina ho sentito una
giustificata amarezza
di fronte all’hold up
musicale fatto dagli
Stati Uniti producendo
musicalatina.Tuttavia,
i più lucidi dei miei
interlocutori
hanno
capito che il problema
è più complesso: non
esistono
generi
musicali
nazionali
ricchi e potenti, e
generi
tipicamente
americani
che
attraversano i confini
senza avere bisogno di
Miami–dallasalsaalla
bossanova, passando
per il tango o la
cumbia, tra decine di
altri –, non esiste più
una
cultura
pop
comune
ai
paesi
dell’America
latina,
tranne
la
cultura
mainstream
nordamericana.
“Gli Stati Uniti si
impongono
culturalmente
in
America latina a causa
della divisione dei
paesi latinoamericani,”
spiega José Zimerman,
uno dei direttori di Tv
Brasil, la televisione
pubblica brasiliana. E
ciò che vale per la
musica vale anche per
il
cinema
come
conferma,
soggettivamente, Steve
Solot, un americano
intervistato a Rio che
lavoraperglistudiosdi
Hollywood: “L’America
latina è un insieme di
paesi
molto
nazionalisti, ciascuno
dei quali rifiuta il
proprio
vicino.
Detenendo il potere
economico di tutta
l’America
latina,
i
brasiliani
guardano
verso l’Asia e verso
l’Africa in una logica
tra paesi del Sud,
piuttosto che verso
l’America latina; gli
argentini si rivolgono
all’Europaeguardanoi
brasiliani dall’alto, il
Messico, la Colombia e
il Cile guardano più
versogliStatiUnitiche
verso gli altri paesi
latinoamericani;
il
Venezuela si isola e
critica tutti. È questa
guerra fratricida a
spiegare il fatto che
non esiste una cultura
comune, né esiste una
cinematografia ‘latina’:
i film brasiliani non
funzionano in Messico,
i
film
argentini
falliscono in Brasile.
L’unico posto in cui
sonoapprezzati,edove
sono proiettate quasi
tutte le cinematografie
latino-americane, sono
paradossalmente
gli
Stati Uniti. Così in
America latina, noi
americani abbiamo un
terreno davvero molto
favorevole
per
esportare
film
di
successo.
I
film
statunitensi
sono
l’unico cinema comune
a
tutti
i
latinoamericani”. Steve
Solot
dimentica
pellicole come I diari
della motocicletta (su
Che
Guevara)
del
brasiliano
Walter
Salles,
con
attori
messicani
e
una
sceneggiatura scritta
con un argentino, o il
film messicano Y tu
mamá también, ma è
vero che sono delle
eccezioni
(e
quest’ultimo film è
stato lanciato negli
Stati Uniti, in tre sale
di cinema d’autore di
New
York
e
in
cinquantasalelatinosa
LosAngeles,attraverso
un abile marketing che
mette insieme l’élite
artistica e il pubblico
latino,
prima
di
arrivare
in
Sud
America).
Gli americani sanno
riconquistare
e
sfruttare la sensibilità
“latina”
quando
è
possibile:“Èlaforzadi
Juanes, Shakira, Ricky
Martin
e
Jennifer
Lopez, ovvero artisti
americani con uno
spanish flavor”, spiega
il critico Diego Lerer,
del grande quotidiano
“Clarín” a Buenos
Aires. “Questo pop
latinizzato
e
americanizzato
ha
ridotto
lo
spazio
‘latino,’dicedesolatoil
produttore
Daniel
Grinbank, quando lo
incontro nella sede
della
società
nel
quartiere Palermo di
BuenosAires.Grinbank
è
oggi
uno
dei
principalipromoterper
l’America latina, ha
organizzato il concerto
gratuito dei Rolling
StonesaCopacabanaa
Rioeleundicidatedel
tour di Madonna in
America
latina.
Prosegue: “Gli artisti
sono
colombiani,
cubaniomessicani,ma
vivononegliStatiUniti.
Il segnale ‘latino’ è
irradiato da Miami e il
pubblico lo riceve in
Messico o in Brasile.
Questa è la musica
latina di oggi ed è
americana”.
La nostalgia per
un’epoca in cui i paesi
latinoamericani
dialogavano tra loro è
ancora più forte per
André
Modani,
settantotto
anni,
veterano
della
bossanova
che
mi
riceve
con
spirito
vivace nella sua casa
tutta di legno e vetro,
gioiello di architettura,
sulle colline di Rio de
Janeiro. “Ogni paese
dell’America
latina
conduce la propria
guerra di indipendenza
culturale e musicale.
Ciascuno
si
batte
contro tutti gli altri,
come
piccoli
re
feudali,”
sospira
Modani.
“Così,
la
musica
latina
non
funzionapiùtraipaesi
dell’America latina e il
Mercosur (Modani si
riferisce al fallimento
del
Mercosur,
il
mercato
interno
fondato nel 1991 tra
Brasile,
Argentina,
Paraguay e Uruguay).”
Ilcelebreproduttoredi
bossanova
poi
prosegue: “Gli unici a
comunicareatuttisono
gli
americani,
in
particolare
cantanti
come Ricky Martin e
Jennifer Lopez, perché
accettano
le
loro
origini”.
Mi
fa
osservare che ci sono
toreri e ballerine di
flamenco,
in
stile
Carmen, nei videoclip
in inglese di Jennifer
Lopez (per esempio
nella sua hit Ain’t
Funny).“Forsesitratta
diclichélatinos,maciò
produce un mercato di
cinquanta milioni di
persone negli Stati
Uniti,” prosegue André
Modani. “Per il Brasile
il problema è ancora
maggiore, poiché non
esiste una vera e
propria
comunità
brasiliana negli Stati
Uniti.
Così
gli
americani
non
ci
conoscono perché non
ci vedono. Inoltre, la
nostra musica non si
vendenegliUsa,senon
in settori di nicchia.
Perché un cubano di
Miami,unmessicanodi
Albuquerque,
un
portoricano di New
York
dovrebbero
ascoltareunartistache
non parla neanche
spagnolo? Miami forse
è la capitale esterna di
CubaedelMessico,ma
non del Brasile” (negli
Stati
Uniti
vivono
346.000
brasiliani,
ovverolo0,1percento
della
popolazione
americana, un dato
basso rispetto ai 29
milioni
di
messicaniamericani,
anche se esiste una
comunità
brasiliana
attivaaMiami).
Qualche mese prima,
dopo un concerto a
Juan-les-Pins(Suddella
Francia) in cui si è
esibito a sessantasette
annipienodienergiae
di
spirito,
ho
intervistato
Gilberto
Gil, celebre cantante
della bossanova, poi
del tropicalismo e in
quel momento ministro
dellaCulturainBrasile
duranteilgovernoLula
(ha ricoperto questa
carica dal 2003 al
2008). “La politica del
presidente Lula tenta
distringerelegamicon
la maggior parte dei
paesi
dell’America
latina, un po’ come ha
fatto il Giappone con il
suo‘ritornoinAsia”,mi
dice con calma seduto
nel suo camerino e in
francese Gilberto Gil.
Poi
prosegue:
“La
nostra
priorità
è
costruire industrie di
contenuti forti. Credo
nella cultura come
arte, ma anche come
settore economico. Per
i giovani delle nostre
favelas, credo allo
sviluppo
economico
attraverso la cultura.
Ci ho creduto tutta la
vita”.Nelcamerino,Gil
prende tempo. Mi
racconta come nel
1967,
quando
ha
cominciato a usare
chitarre elettriche in
un festival di San
Paolo, è stato insultato
eaccusatodiessereun
agente
dell’imperialismo
americano che cercava
di imporre influenze
occidentali
nella
musicabrasilianapura.
“Ci piaceva solo il rock
anglosassone
e
la
cultura pop,” esclama
Gilberto Gil. Finisce in
prigioneepoiriparain
esilioaLondra.
Gilberto Gil fa un
paragone tra l’epica
battaglia a favore del
rock e quella di oggi
legata a internet. Nei
panni del musicista
difende
i
diritti
d’autore, ma come
ministro della Cultura
ha
cercato
di
promuovere la libera
diffusione della musica
– mi dice di essere lui
stesso un “hacker” –,
soprattutto attraverso
le licenze “creative
commons”.
Memore
dell’esperienza
personale di giovane
nero, cresciuto nel
Brasilepovero,sentedi
doverfarequalcosaper
i giovani delle favelas
che vuole aiutare a
comunicare grazie al
digitale. La sera del
nostro
incontro,
Gilberto Gil ha cantato
Pela internet le cui
parole
recitano:
“Voglio essere sul web
/
Promuovere
un
dibattito / Radunare
attraversointernet/Un
gruppo di fan del
Connecticut / Voglio
essere sul web per
raggruppare / Le case
del Nepal e i bar del
Gabon”.
Nel corso delle mie
inchieste, mi è stata
piùvoltecitatalafrase
di George W. Bush,
allora presidente degli
Stati Uniti, che arriva
in America latina e si
scusa di fronte al
pubblico di un meeting
dicendo:“Sorry,Idon’t
speak latin” (scusate
non parlo latino). Che
siaveraomeno,lagag
è
divertente
e
soprattutto solleva una
questione importante:
neanche
i
latinos
parlano più “latin”.
Questoèilproblema.
Contrariamente
a
quanto credevo, non
esiste
affatto
una
culturacomuneatuttii
paesi
ispanici
e
lusofoni. Il sogno di
Simón
Bolívar
di
un’Americalatinaunita
è un miraggio sul
fronte
culturale,
soprattutto per quanto
riguarda
l’entertainment.
Di
sicuro
esiste
un
mercato da 350 a 450
milioni di persone con
unagrandeomogeneità
linguistica
–
lo
spagnolo – ma solo le
major statunitensi del
cinema e della musica
riescono ad accedervi.
Si tratta, in effetti, di
una
“diversità
standardizzata”
profondamente
sconcertante. Solo una
cultura
globalizzata,
ampiamenteformattata
negli
Stati
Uniti,
raduna oggi i popoli
dell’America latina, in
particolare attraverso
grandi
star
della
musica,unpop“latino”
ibrido, film di successo
al cinema, format di
talk-show televisivi e
bestseller letterari – a
cominciare da Paulo
Coelho, autore del
successo
mondiale
L’alchimista,
inizialmente pubblicato
da una piccola casa
editrice brasiliana e
oggi distribuito negli
Stati
Uniti
da
HarperCollins,
l’imprint
che
appartiene a News
Corp
di
Rupert
Murdoch, e in tutto il
mondo
attraverso
un’agenzia con sede in
Spagna. È lontano il
tempo in cui scrittori
come
Jorge
Luis
Borges, Julio Cortázar,
Gabriel
García
Márquez,MarioVargas
Llosaeranoconsiderati
ambasciatori culturali
dei loro paesi e
dell’America
latina.
Oggi il soft power si
misura
più
sull’intrattenimento
che
sulla
cultura
d’élite.
Solo
le
telenovele
sembrano
sfuggire
a
questa
uniformazione,
ma
anche queste sono
l’esito
di
una
commercializzazione a
oltranza e di una
concorrenza selvaggia
traipaesidell’America
latina e le televisioni
nordamericane.
Oggi, la separazione
traAmericadelNorde
America del Sud è più
sottile e si confonde
con la globalizzazione.
In una certa misura, a
eccezione
delle
telenovele, è spesso la
cultura pop americana,
o americanizzata, a
comporre la cultura
comune dell’America
latina
per
quanto
riguarda
l’intrattenimento
mainstream.
Dopo aver realizzato
lamiainchiesta,lacrisi
economica
ha
modificato lo scenario
di Miami. Mtv Latin
America ha mantenuto
lapostazioneprincipale
a Miami, ma ha
“regionalizzato”
ulteriormente gli uffici
di Città del Messico e
Buenos
Aires
per
esserepiùvicinaalsuo
gruppo, beneficiare di
tassi di scambio tra
dollari e pesos e fare
concorrenza, a Buenos
Aires, a Much Music
Tv.Incampotelevisivo,
invece,
Disney
ha
puntato
soprattutto
sugli uffici di Buenos
Aires e chiuso quelli di
Miami. Cnn Español
mantiene la sede ad
Atlanta. Hbo ha invece
consolidato Hbo Latin
AmericaaMiami.Peril
cinema e il settore
audiovisivo,
Miami
accusa il colpo della
concorrenza di Los
Angeles, Buenos Aires,
RioeCittàdelMessico;
invece,
sul
fronte
musicale,
Miami
continua
a
essere
dominante.
“Ogni volta che c’è
una crisi economica
negli
Stati
Uniti,
l’industria discografica
abbandona Miami; ma
ogni volta che c’è una
importante
crisi
politica in America
latina,tuttiriportanole
truppe
a
Miami.
Aspettiamolaprossima
crisi per fare armi e
bagagli.
Forse
si
verificherà
con
l’apertura di Cuba e
allora Miami diventerà
indispensabile,”
sintetizza
Rafael
Artero.
Resta la questione
demografica – come
sempreunadellechiavi
del successo o del
fallimento
delle
industrie creative in
tutto
il
mondo.
Anzitutto negli Stati
Uniti,
cuore
del
mercato:“Laprincipale
minaccia che incombe
sul mercato latino in
America del Nord, sul
lungo
termine,
è
l’assimilazione.
Oggi
mum e dad guardano
telenovele
in
una
stanza e ascoltano
musica latina, mentre
incameracisonoifigli
che guardano alla tv
una serie televisiva
americana e ascoltano
hip-hop”, spiega il
dirigente
di
una
televisione
a
Los
Angeles.Dalcantosuo,
Mariano Kon, della
casa di produzione
Cuatro
Cabezas
a
Buenos Aires, è più
critico ancora: “Per un
certo periodo abbiamo
creduto che il tipo
‘latino’ esistesse, ma
che fosse un elefante
bianco. È l’illusione
secondocuigliispanici
sembranotuttiidentici.
È una visione da
americani. Gli studios
hollywoodiani sognano
un‘mercatolatino’,ma
è
un’entità
molto
artificiale”.
Luiz
Claudio Latgé, uno dei
direttoridelgruppoTV
Globo, è ancora più
esplicito: “Anche gli
americanisannodinon
poter
governare
l’America latina da
Miami”.
Altri
sono
più
ottimistiepensanoche
l’America latina possa
svegliarsi: “Il Brasile
ormai è una grande
potenzaeconomica,ma
in Europa è ancora
considerato come il
paese delle favelas,
della miseria e della
violenza.Gliamericani,
invece, non sanno
nemmeno
che
esistiamo
e
che
parliamo portoghese.
Ci confondono con il
Venezuela! Quando si
rendono
conto
dell’errore, diventiamo
una potenza su cui
contare,
anche
nell’intrattenimento”,
spiega José Zimerman,
uno dei direttori di Tv
Brasil,
televisione
pubblicabrasiliana.
José
Tillan,
vicepresidente di Mtv
Latin
America,
sottolinea anche che le
previsioni
sull’americanizzazione
degli ispano-americani
sono sbagliate: “Non
siamo
come
gli
ungheresi o gli italiani,
la cui acculturazione è
diventata totale in
proporzioneconlaloro
americanizzazione.
I
latinos
resteranno
latinosnegliStatiUniti
perché sono numerosi,
grazie ai mezzi di
comunicazione
moderni, per via della
vicinanza
geografica
con i loro paesi e
soprattutto
perché
modificheremo
in
profondità gli Stati
Uniti”.
Poi
Tillan
conclude:
“Stiamo
realizzando
la
‘latinoamericanizzazione
della cultura de los
EstadosUnidos”.
14.
ComeAlJazeeraè
diventataun’emittente
mainstreamdelmondo
arabo
Un sabato verso le
ore 16, nel bel mezzo
di un pomeriggio caldo
e umido del luglio
1997,
le
famiglie
saudite
stanno
guardando
alla
televisione
un
programma educativo
destinato ai ragazzi e
trasmesso da Canal
France International –
una
banca
di
programmi
televisivi
francesi, filiale del
gruppo
France
Televisions.
L’emissione
è
assicurata dal satellite
ArabSat, piattaforma
inaugurata nel 1985 e
realizzata da ventuno
paesi arabi, il segnale
principale è trasmesso
da Riyadh in Arabia
saudita.
Improvvisamente,
si
verifica un errore nella
trasmissione
del
segnale e al posto di
Canal
France
International
è
mandato in onda Canal
+. Si sarebbe trattato
di un banale errore
tecnico
senza
particolari
conseguenzese,inquel
momento, Canal + non
stesse
trasmettendo
ClubprivéauPortugal,
unfilmpornografico.
Seduto su un largo
divano, nel suo ufficio
di place des Ailes a
Boulogne-Billancourt
(periferia
ovest
di
Parigi e luogo in cui
hanno
sede
molte
emittenti
televisive
francesi),
Philippe
Baudillon è tranquillo.
All’epoca dell’incidente
del cambio di canale
dirigeva Canal France
International (oggi è
amministratore
delegato
di
Clear
Channel France, filiale
del colosso americano
delle affissioni urbane,
neicuiufficimiriceve):
“Posso solo dire che
quella è stata la cosa
peggioredituttalamia
carriera.
Attraverso
Canal
France
International,
l’audience
dei
programmifrancesiera
in forte aumento nei
paesi del Golfo. Questo
errore ha mandato a
monte tutta la nostra
strategia di sviluppo.
La trasmissione del
film pornografico di
Canal + è durata circa
trenta minuti prima
che i tecnici parigini
rimediassero
alla
cantonata” (il film era
destinatoauncanalea
pagamento
del
Pacifico). Secondo i
dati dell’epoca, il film
porno
è
stato
trasmesso
in
una
ventina di paesi arabi
e,
potenzialmente,
avrebbe potuto essere
visto da un pubblico di
33 milioni di persone.
“È stato terribile, ha
mandato all’aria la
presenza francese nei
paesidelGolfoesiamo
stati radiati dall’offerta
dei programmi,” dice
dispiaciuto
Philippe
Baudillon.
Su questa vicenda,
Ahmed H.M. Al Kilani,
intervistato a Riyadh,
capitale
dell’Arabia
saudita, è ancora più
critico: “All’epoca ero
rappresentante
di
Canal
France
International in Arabia
saudita. Mi ricordo
benissimo. È stato
terribile.
Abbiamo
cercato di bloccare
subito il programma,
ma alla sede centrale
dell’emittente
non
rispondeva
nessuno.
Peraltro,c’eragiàstato
qualche
problema
quando
avevano
trasmesso
un
programma ‘un po’
leggeroeosé’dalLido.
In
quell’emittente
franceseeranodavvero
incompetenti,
non
capivano nulla della
culturaaraba”.
Secondo la versione
ufficiale sostenuta a
Parigi, ma con scarse
prove che possano
avvalorarla,
questo
incidente,
effettivamente
avvenuto, è stato un
pretesto per cacciare i
francesidaArabSat.“È
una
spiegazione
plausibile,”
sostiene
Saud
al
Arifi,
amministratore
delegato
dell’importante gruppo
saudita
di
media
satellitari Salam Media
Cast, incaricato di
gestire l’integrazione
dei
contenuti
su
ArabSat e da me
intervistato a Riyadh.
Poi
prosegue:
“In
Arabia saudita, i film
pornografici esistono a
pagamento,
ed
esistevano
anche
all’epoca.Sonocriptati,
anchesemoltiriescono
ad accedervi in modo
illegale. La collera dei
sauditi
in
quella
circostanza è stata
dunque proporzionale
alla loro voglia di
liberarsi dei francesi”.
Per scrupolo, Al Arifi
telefona
in
mia
presenza
a
un
rappresentante
di
ArabSat in Giordania
per
chiedergli
se
l’incidente sia stato un
pretesto
per
sbarazzarsi
dei
francesi.
Dall’altro
capo sento rispondere
in arabo. Dopo aver
riattaccato, Al Arifi mi
traduce la risposta in
inglese. “Ad ArabSat
dicono che non è stato
unpretesto,quelfilmli
ha
davvero
fatti
infuriare.”
Nonsappiamoancora
se quel film porno sia
stato una messa in
scena o un pretesto,
ma in ogni caso ha
avuto come effetto di
radiare Canal France
International
da
ArabSat
poiché
i
sauditi si sono sentiti
oltraggiati da questo
errore “tecnico” e a
nulla sono valse le
pressioni
della
diplomazia francese. Il
canale
liberatosi
nell’offerta di ArabSat
è assegnato a una
giovane emittente che
da tempo cercava di
aumentare il proprio
pubblico e ambiva a
diventare mainstream:
AlJazeera.
Alla sede di Al Jazeera
nelQatar
Alle ore 21.30 in
punto, su tutti gli
schermi della “control
room”,
compare
l’immagine
di
Mohamed
Krichen.
Attorno a me, otto
uomini sono intenti a
lavorare davanti a
trentasei
schermi
televisivi
e
venti
computer di ultima
generazione.Quattrodi
loro
indossano
il
dishdasha, il lungo e
magnifico abito bianco
in uso nei paesi del
Golfo, e portano in
testa
una
kefiah
bianca. Mi trovo a
Doha, capitale del
Qatar, all’interno della
sede di Al Jazeera. È
appena cominciata la
diretta di uno dei più
celebri
talk-show
dell’emittente,
Ma
war’aalkhabar (Tra le
righe).
Il quartier generale
di Al Jazeera (che in
arabo vuol dire “La
Penisola”) è un bunker
estremamente protetto
situatoaunaventinadi
minuti dal centro di
Doha, in mezzo al
deserto. All’esterno ci
sono uomini armati e
torrette di controllo,
mentre all’interno ci
sono prati verdi (mi si
diceimportati,apezzi).
Per
entrare
devo
sottopormi
a
due
controlli di polizia, ma
una volta dentro posso
circolare
piuttosto
liberamente.
Sono
subito meravigliato nel
vedere una situazione
particolare
data
dall’eterogeneità delle
persone presenti: ci
sonomoltedonneconil
veloemoltealtresenza
velo,
uomini
in
dishdasha e altri in
jeans.
Nelbarinternoincui
ho appuntamento con
MohamedKrichensono
sorpreso nel vedere
gente di una pluralità
di nazionalità e di
religioni. Mi vengono
presentati
drusi,
libanesi
sciiti,
palestinesi
sunniti,
sauditi laici, inglesi
islamisti
–
nessun
abitante del Qatar, già
non molto numerosi in
generale e ancor meno
traigiornalisti.
“Nel mondo arabo la
corrente islamista è
forte.
È
dunque
comprensibile
che
esista anche all’interno
di Al Jazeera. Si può
tuttaviaessereislamisti
e validi giornalisti,”
precisa
subito
in
francese
il
mio
interlocutore.
Mohamed Krichen è il
presentatore di punta
di Al Jazeera, ha
cominciato alla Bbc ed
è tra i fondatori
dell’emittente araba,
manonèislamista.Nel
comitato di redazione
dell’emittente
passa
per
essere
un
“nazionalista
panarabo”,esidicesia
incontrapposizionecon
l’attuale direttore di Al
Jazeera.
Krichen,
tuttavia, non intende
affrontare la questione
e svicola: “Io difendo i
valori e l’integrità del
giornalismo, questa è
l’unica cosa che mi
muove, è l’unica guida
dei
miei
comportamenti”. Allora
gli chiedo in modo
esplicito un suo parere
su Wadah Khanfar,
attuale direttore di Al
Jazeera, molto criticato
per la sua vicinanza
con gli islamisti (e di
cui Krichen è uno dei
principali
oppositori
all’interno
dell’emittente):“Lasua
nomina è stata una
decisione
politica
dell’emiro del Qatar,
non
posso
pronunciarmisuquesta
scelta.
Tuttavia,
essendoci di mezzo Al
Jazeera, non bisogna
emettere
giudizi
frettolosi.
Certo,
abbiamo fatto degli
errori,
un’emittente
comelanostranonpuò
essere sempre perfetta
e irreprensibile. Posso
però affermare che il
pluralismo è visibile
all’interno
del
palinsesto:
su
Al
Jazeera
sono
rappresentate tutte le
tendenze del mondo
arabo”.
All’iniziodellaguerra
inAfghanistan,Krichen
era inviato sul campo.
Poi ha intervistato il
presidente israeliano
Shimon Peres durante
la Guerra di Gaza –
un’impresa folle per
un’emittente araba. Ha
intervistato anche il
presidente della Siria
Bachar al Asad, il
presidentedell’Autorità
nazionale palestinese
Mahmud Abbas e il
presidente
del
Venezuela
Hugo
Chávez.Ovunque,nella
rete di Al Jazeera,
Krichen è riconosciuto
per
la
sua
professionalità e la sua
serietà. Presenta i
telegiornalidellaserae
tre volte alla settimana
conduce Tra le righe,
una delle trasmissioni
politiche più popolari
del mondo arabo. “È lo
show
numero
uno
sull’emittente
araba
numero uno,” dice con
vanto Nazar Daw,
produttore
del
programma,
intervistato alla fine
della diretta. Krichen è
meno spavaldo e fa il
modesto: “Il nostro
successo è dovuto al
fatto che privilegiamo
leinformazionirispetto
ai
commenti,
cerchiamo
di
descrivere l’attualità
più che dare le nostre
opinioni”. Inoltre, il
programma è un newsshow, ovvero collegato
alle
notizie
della
giornata. I temi sono
scelti il pomeriggio
stesso della diretta e il
produttore
mi
conferma che fino a
trenta minuti dalla
messa in onda possono
subire variazioni. “Di
sicuro, è il programma
più mainstream di Al
Jazeera,”precisaNazar
Daw,perchéèinprima
serata ed è legato alla
stretta attualità. “Si
tratta, in realtà, di una
sorta
di
editoriale
dell’emittente.”
Da
quest’angolo
del
deserto del Qatar ho
l’impressione
che
figure come quelle di
Krichen e l’esempio di
libertà all’interno dei
media
arabi
rappresentato da Al
Jazeera
possano
portarelontano.
AlJazeeranasceil1°
novembre 1996 per
volontà di un solo
uomo,
l’emiro
del
Qatar. Il Qatar è un
minuscolo stato di
ottocentomila abitanti,
in grande maggioranza
immigrati del Pakistan,
dell’India e dell’Iran. È
stato a lungo uno dei
paesi più poveri del
Medio Oriente e in
meno di vent’anni,
grazie ai giacimenti di
petrolio e alla scoperta
di giacimenti di gas (i
più grandi al mondo
dopo quelli di Russia e
Iran), è diventato uno
dei più ricchi. È
avvenuto il “boom
petrolifero”. Se in
passato
era
uno
sconosciuto,
oggi
l’emiro siede alla corte
deigrandidellaTerrae
dialoga con tutti i
paesi.
Inizialmente
aveva
posizioni
filoarabe, ma dal 2001
ha
cominciato
a
dialogare
con
gli
islamisti (alcuni dicono
che
sia
passato
dall’orbita della Lega
araba
a
quella
dell’Organizzazione
della
conferenza
islamista, ma è un
punto
molto
controverso). In ogni
caso, il Qatar è un
paese
fondamentale
all’interno
della
costruzione
di
un
nuovo asse forte del
mondoaraboinsiemea
SiriaeIranpiùchecon
EgittoeArabiasaudita.
Le
relazioni
diplomatiche
con
questi
paesi
sono
peraltrocomplesseedi
difficile
interpretazione.
Il
Qatar ha una politica
estera non allineata
rispetto
al
mondo
arabo,fattadivisibilità
internazionale e di
indipendenza su scala
regionale: dialoga con
culturediverse,sipone
come mediatore tra
Oriente e Occidente,
nutre diffidenze verso
l’Arabia
saudita,
sostiene
la
pacificazione
del
Libano
attraverso
accordi con Hezbollah
e,
ovunque,
porta
avanti una diplomazia
“da
libretto
degli
assegni”. Ma il Qatar
tiene anche i piedi in
più scarpe: è vicino
all’Iran, ma continua a
tenere
sul
suo
territorio
la
base
americana di Al Udied
(a partire dalla quale è
stata avviata la guerra
in Iraq del 2003); si
mette in condizione di
sudditanza,
nel
contempo, con gli Stati
Uniti di George W.
Bush e la Siria di
Bachar
al
Asad;
autorizza gli israeliani
ad aprire un ufficio
“commerciale” a Doha,
con status diplomatico,
situato non lontano
dalla
residenza
di
Khaled Meshal, leader
di Hamas, in esilio
protettonelQatar.
Questa
sottile
politica
diplomatica
compare,
inevitabilmente, nella
linea editoriale di Al
Jazeera che, spesso, si
allinea alle variazioni
della
politica
diplomatica del Qatar.
“AlJazeeraèlapolitica
estera del Qatar, è un
prodotto
d’esportazione,
un’ambasciata
del
Qatar,” dice Ahmed
Kamel, ex direttore
dell’emittente. “Non è
un’ambasciata,”
sottolinea
Atef
Dalgamouni, uno dei
fondatori e tra i
principali dirigenti di
AlJazeeraaDoha,“èil
ministero degli Esteri
delQatar.”
Al Jazeera decolla
realmente alla fine del
dicembre 1998 grazie
al potente segnale
lasciatoliberodaCanal
France International: è
l’unica emittente a
poter trasmettere le
immagini
dell’operazione Desert
Storm, l’attacco aereo
americano in Iraq.
Queste
immagini
esclusive
rappresentano l’inizio
di un riconoscimento
sulla
scena
internazionale. Da qui
comincia anche lo
sviluppo della sua
audience che aumenta
enormementenelcorso
degli anni facendola
diventare un’emittente
imprescindibileintutto
il mondo. Trasmette le
immaginidellaseconda
Intifada palestinese a
partire dal 2000, i
video di Osama bin
Laden e la guerra in
Afghanistan nel 2001,
la guerra in Iraq nel
2003, la Guerra di
Gazanel2008.
Al
Jazeera
è
un’emittentearaba,ma
le relazioni con questo
mondosonocomplesse,
infatti è vietata in
Tunisia,
Marocco,
Algeria e Iraq; fino al
2007,alcunistatiarabi
come l’Arabia saudita
hanno minacciato di
proibirla,
più
recentementel’hafatto
l’Autorità palestinese.
Anche l’India si era
espressa in questo
senso.Inognicaso,che
sia proibita o meno, è
sufficiente
una
parabola di meno di
cento euro per captare
il segnale ovunque nel
VicinoeMedioOriente.
Paradossalmente,
l’emittente non è stata
criticata
solo
dai
talebani e dagli sciiti
radicali, ma è stata
violentemente
attaccata e minacciata
dall’amministrazione
Bush negli Stati Uniti
(una discussione tra
George Bush e Tony
Blair, riportata in una
nota
britannica
segreta, lascia pensare
che
George
Bush
avrebbe
avuto
l’intenzione
di
bombardare la sede
dell’emittente a Doha,
ma la veridicità del
documento è tutta da
provare). Al Jazeera,
peraltro, ha accusato
l’amministrazione Bush
di aver fatto pressione
sui
cablo-operatori
affinché non facessero
arrivare il segnale
all’interno
delle
abitazioni negli Stati
Uniti. Anche in questo
caso
l’affermazione
deve essere provata,
ma è vero che Al
Jazeera, per ragioni
politiche
o
commerciali, è poco
presente sulle reti
americane.
Anche
questo è un paradosso:
in termini di censura e
di limitazione della
libertàdiinformazione,
gli Stati Uniti si sono
comportati
con
Al
Jazeera
come
le
dittaturearabe,mentre
isuoisostenitoridicono
che l’emittente ha
semplicemente fornito
una
copertura
giornalistica sul campo
che Cnn non ha voluto
opotutogarantire.
I grandi anni di Al
Jazeerasonostatitrail
1996 e il 2001. In
questo
periodo,
l’emittente ha infranto
tutti i tabù del mondo
arabo,soprattuttosulle
donneesullasessualità
e ha aperto un ufficio
in Israele e dato la
parola per la prima
volta all’interno di un
media
arabo
ai
rappresentanti
dello
stato ebraico (spesso
senza
tagliare
né
travisarne
le
argomentazioni). Molti
telespettatori
arabi
hanno
così
potuto
vedere per la prima
volta un israeliano
sostenere il proprio
punto di vista su
un’emittentearaba.Dal
2001, tuttavia, sembra
che l’emittente abbia
cambiatolinea.
Hossein Abdel Ghani
dirige gli uffici di Al
Jazeera al Cairo. Per
incontrarlo
è
necessario avere tanta
tenaciaquantounbuon
senso
dell’orientamento,
poiché gli uffici si
trovano in un desueto
edificio sulle rive del
Nilo, senza alcuna
visibilesegnalazionené
indicazione.
L’ascensore
non
funziona e le scale non
vengono pulite da
diversi
mesi,
c’è
polvere ovunque. Al
quintopianononc’èné
il campanello, né un
cartello,
né
un
centralino. Non c’è
neanche
una
particolare sicurezza.
AlJazeerahapostouno
dei
suoi
centri
nevralgici mondiali al
Cairo in un luogo
inaccessibile
e
sconosciuto a (quasi)
tutti. All’interno degli
ufficicisonogiornalisti
e
cameraman
che
lavorano, donne senza
velo con magliette
attillate colorate in
stileAmericanAppareil
intente a lavorare,
tranquillamente, come
gli uomini. Decine di
telecamere
digitali
sono appoggiate sui
tavoli, anche macchine
fotografiche Sony. Un
cameriere mi porta un
caffè. Ovunque, sui
muri, è ben visibile il
logo di Al Jazeera – il
nome scritto in corsivo
con caratteri arabi
dorati sembra una
fiamma – sotto c’è
scritto, in arabo e in
inglese, il motto “Il
punto di vista e il suo
contrario”.
Hossein Abdel Ghani
mi riceve in jeans e
scarpe da ginnastica –
all’americana. In virtù
delle rigide regole di
comunicazione
dell’emittente,èl’unico
ad avere il diritto di
parlareconl’esterno,e
lo fa senza troppi giri
di parole. “In Egitto
siamoinunasituazione
controversa. Paghiamo
il prezzo della nostra
libertà e della nostra
indipendenza,”
afferma, confermando
il
fatto
pubblicato
anchesuigiornali,cioè
che
ha
appena
trascorso due giorni in
prigione. Dirige un
gruppo di venticinque
persone, un ufficio
sensibile all’interno di
unpaesesensibile.
Hossein Abdel Ghani
parla
inglese
con
accentoperfetto.Come
molti dei centoventi
giornalistidiAlJazeera
hacominciatoaLondra
nell’ufficio Arabic Bbc
News, un’emittente in
joint-venture tra Bbc
World Service e la
società saudita Orbit.
La
chiusura
dell’emittente
nel
1996, a causa di
disaccordi tra inglesi e
sauditi, ha contribuito
al lancio di Al Jazeera.
Hossein Abdel Ghani è
stato incaricato, nel
1997, di aprire l’ufficio
egiziano di Al Jazeera,
un anno dopo l’avvio
dell’emittente a Doha.
Insieme agli uffici di
Ramallah e Baghdad,
anche quelli del Cairo
sono
tra
i
più
importanti.Induestudi
sommariamente
attrezzati, ma ben
situati, i giornalisti
realizzanoiloroservizi
di
fronte
a
un
panorama
naturale
impressionante: il Nilo
e l’immensa città del
Cairo.
“Facciamo
giornalismo secondo le
regoleinternazionalied
è questo che ci viene
rimproverato dai paesi
arabi e anche dagli
Stati Uniti,” afferma
Hossein Abdel Ghani,
che mi fa osservare
sulle pareti del suo
ufficio un gran numero
di diplomi e medaglie
ricevuti in tutto il
mondo
come
riconoscimento
di
indipendenza
della
stampa. Al Cairo c’è
anche un’équipe che
segue lo sport per Al
Jazeera e ci sono
giornalisti
che
realizzano documentari
culturali e talk-show.
“Il nostro successo è il
frutto di una sottile
miscela
tra
informazione
e
intrattenimento.
Questa formula piace
molto ai milioni di
personecheciseguono
fedelmente in tutto il
mondo. Ci occupiamo
dituttociòchetoccala
gente, le masse, non
l’élite. Per questo sono
importanti sia i nostri
telegiornali sia i nostri
talk-show: i fatwa talkshow,
condotti
da
satellite sheiks, hanno
per esempio un gran
successo.”
Hamid Taoufik, che
incontro qualche mese
piùtardiinSiria,nonsi
esprimerebbe
mai
usando
espressioni
come“fatwatalk-show”
o
“sceicchi
via
satellite”,
anzi
malsopporta lo spirito
del collega egiziano.
Abdul Hamid Taoufik è
a capo dell’ufficio di Al
JazeeraaDamascoedè
stato direttore politico
della
televisione
ufficiale siriana. Ha
baffi sottili, piccoli
occhiali,
i
capelli
brizzolati, parla veloce
e a lungo e lascia poco
spazio alle domande;
non parla inglese e a
intervistarloconmec’è
un traduttore. L’ufficio
in Siria di Al Jazeera è
posto
sopra
un
Columbus Café, a East
Mezh, una periferia
ricca a ovest di
Damasco. Dalla strada,
il logo dell’emittente è
piccolomabenvisibile.
Al primo piano, in
quattro o cinque uffici,
c’è una quindicina di
persone.
Ci
sono
telecamere appoggiate
per terra. “In Siria,
siamo
un’emittente
popolare,” dice con
soddisfazione
Abdul
Hamid Taoufik. “Le
persone
più
politicizzate guardano
AlJazeeraol’emittente
diHezbollah,AlManar,
che
è
considerata
l’emittente
della
resistenza. Altrimenti,
per svagarsi, molti
siriani guardano Lbc,
emittente
libanese,
oppure i canali sauditi
di Mbc.” Chiedo come
sia possibile conoscere
i dati dell’audience.
“Non
si
possono
sapere. Non esistono
statistiche sul settore
audiovisivo in Siria e
non esiste l’auditel nei
paesi arabi,” sospira
Abdul Hamid Taoufik.
“Né il governo, né i
privati conoscono le
cifre. Si possono fare
solo
delle
ipotesi”
(secondo diverse fonti,
ilpubblicodiAlJazeera
supererebbe
i
50
milioni di famiglie al
giorno). Un cameriere
ci porta un tè turco,
parliamo a lungo, ma
non apprendo granché
sulla questione che mi
interessa, ovvero come
AlJazeerasiadiventata
un’emittente
mainstream. La stanza
è circondata da tende
rosse che danno un
senso di soffocamento
e fanno provare una
sensazione
di
claustrofobia.
Al
momento dei saluti
finali, Abdul Hamid
Taoufik mi fa vedere
unamagnificacopiadel
Corano,
dipinta
a
mano, messa in vista
all’ingresso del suo
ufficio. Mentre sto
uscendo, chiedo un
parere sulle voci che
girano secondo cui Al
Jazeera,
in
Siria,
sarebbe
vicina
al
potere
e
lascio
intendere che, per
aprire
l’ufficio
di
Damasco, forse si è
dovuta fare qualche
concessione.
Il
direttore di Al Jazeera
a Damasco mi guarda
con calma. In quel
momento
gli
altoparlanti moderni e
rumorosi trasmettono
l’invitodelmuezzinalla
preghiera. “Non siamo
sottomessi al potere,
lavoriamo rispettando
la legge siriana e la
deontologia
del
giornalismo
di
Al
Jazeera,” si giustifica
abilmenteAbdulHamid
Taoufik.
Qualchegiornoprima
avevo parlato a Londra
con uno dei fondatori
di Al Jazeera che era
statoanchedirettoredi
alcune
reti
appartenenti
all’emittente prima di
dare le dimissioni.
“L’ufficio di Al Jazeera
a Damasco è molto
legatoallostatosiriano
e diffonde informazioni
ufficiali,” mi aveva
avvertito (questo ex
dirigente vuole restare
anonimo per rispetto
dei suoi colleghi e per
potermi parlare più
liberamente).
È necessario sapere,
tuttavia,
che
per
diversi anni, anche la
Siria, come diversi
paesiarabi,haproibito
Al Jazeera sul suo
territorio e rifiutava
ogni richiesta di visto
ai suoi giornalisti;
aprire un ufficio a
Damasco era dunque
altamente improbabile.
Sipuòfarel’ipotesiche
lasuarecenteapertura
sia stata negoziata ad
alto livello, grazie a un
riavvicinamento
diplomaticotrailQatar
elaSiriaapartiredalla
Seconda guerra del
Libano nel 2006 e ai
negoziati del conflitto
condotti dall’emiro del
Qatar(chenel2008ha
fatto
un
regalo
personalealpresidente
siriano Bachar al Asad,
unAirbus).
In ogni caso, il mio
interlocutore critica il
giornalismo
di
Al
Jazeera in Siria e, più
in generale, le sue
trasformazioni. A suo
avviso c’è stata una
“evidente
reislamizzazione di Al
Jazeera a partire dal
2001”, e gli effetti si
vedono
in
modo
particolareinSiriaein
Libano.
Il
mio
interlocutore comincia
poi una lunga analisi e
fa
una
disamina
personale
sui
cambiamenti
fatti
dall’emittente. “Prima
del
2001
era
soprattutto
una
televisione
nazionalista, possiamo
dire laica, all’interno
della tradizione del
nazionalismoarabo,del
panarabismo e del
socialismo
arabo,
rappresentato
dalla
Legaaraba–edicuiil
Qatar è membro. La
filosofia
di
fondo
dell’emittentesibasava
sulla modernizzazione
dei paesi arabi e sullo
spirito di apertura
arabo, quello che si
chiama
infitah.
A
partire
dall’11
settembre 2001, si è
invece orientata verso
una
crescente
islamizzazione.
Progressivamente, per
piccoli passi, si è
cominciato a preferire
la Siria all’Egitto, i
Fratelli musulmani alla
Lega araba, Hamas a
Fatah.
Sono
stati
trasmessi i video di
Osama bin Laden, non
tanto
per
fare
informazioneoperfare
audience,
ma
per
motivi di propaganda.
Anche le parole usate
sonoindicative:siparla
del
‘presidente’
Saddam Hussein e non
del ‘dittatore’ come
fannoglioccidentali;di
‘resistenti’
iracheni
invece di ‘ribelli’; di
‘forze
dell’invasione’
americane anziché di
‘forze
della
coalizione’.” Nel 2003,
Wadah Khanfar, un
palestinese che ha
studiatoinGiordania,è
diventato
a
trentaquattro
anni
direttore di Al Jazeera.
In precedenza era a
capo
l’ufficio
di
Baghdad nel momento
incuièstatorovesciato
Saddam Hussein, e ciò
gli ha permesso di
acquisire una certa
fama benché, secondo
il mio interlocutore,
“avesse un’esperienza
giornalistica limitata”.
Poi l’ex fondatore di Al
Jazeeracheintervistoa
Londra riprende il
discorso: “Da quando
Wadah Khanfar è stato
nominato presidente,
Al Jazeera è diventata
favorevole
alla
resistenzairachena.Da
quel momento è stata
sostenuta
una
posizione contro gli
sciiti in Iraq, ma a
favore degli sciiti in
Iran, Libano e Siria. Si
è
poi
scelto
di
sostenere Al Qaeda in
Afghanistan, di tener
viva la memoria di
Saddam Hussein, di
mostrarsi favorevoli a
Hezbollah
e
Ahmadinejad. Si è
scelto
anche
di
sostenere
l’antiamericano Chávez
in
Venezuela
e
l’islamista Erdogan in
Turchia!
È
un
cambiamento
totale
rispetto all’obiettività
diAlJazeeradegliinizi
e rispetto al suo
desiderio di neutralità.
In quel momento ho
datoledimissioni”.
Ho lasciato parlare il
mio
interlocutore,
conosce
la
storia
dall’interno,
è
autorevole e affidabile,
ma ha la propria
interpretazionedeifatti
che, ovviamente, non è
condivisa
da
altre
persone
che
considerano Al Jazeera
“un’emittente
come
un’altra”.
Alcuni
rimarcano
che
all’interno del network
ci sono molte libertà e
molte
differenze.
Dopotutto, mi si dice a
Doha, il fatto che
l’emittente difenda i
valori
arabi
non
impedisce
di
fare
giornalismo, e non è in
realtà molto diversa
dallaCnn,chesostiene
il punto di vista degli
Stati Uniti e i valori
americani. Mi si fa
notare anche che, se
alcuni uffici di Al
Jazeera
sono
effettivamente
“all’ascolto”
di
Hezbollah o di Hamas
in
relazione
alle
situazioni
locali,
l’ufficio di Ramallah
resta, per esempio,
piuttosto
laico
e
“all’ascolto” di Fatah.
“Sarei la prima a
lasciare Al Jazeera se
diventasse filoiraniana
e islamista,” afferma
Dima
Khatib,
una
palestinese intervistata
a Caracas e direttrice
dell’ufficio
di
Al
Jazeera in Venezuela.
Al
contrario,
il
direttore di un ufficio
di Al Jazeera, appena
licenziato,
conferma
che,
durante
le
manifestazioni
dell’opposizione
iraniana nel 2008, è
emersa la vera natura
di Al Jazeera: “Durante
quegli
avvenimenti,
l’emittente
era
completamente
a
favore di Ahmadinejad.
Ancora oggi difende le
popolazionidiciviliela
democrazia, ma in Iran
è stata difesa e
sostenuta
una
dittatura”.
Anche
questo
dirigente
dell’emittente precisa
che i legami con
Hamas sono diventati
piùstrettidopol’arrivo
di Wadah Khanfar alla
testa di Al Jazeera.
L’informazione mi è
stataconfermatadapiù
interlocutori.
Altri sostengono che,
grazieadAlJazeera,in
molti paesi arabi come
la Siria, i media del
settore
audiovisivo
sono stati privatizzati;
secondoloro,inoltre,la
presenzadell’emittente
avrà sul lungo periodo
effetti
decisivi
in
termini
di
modernizzazione
del
mondo
arabo.
Soprattutto, Mohamed
Krichen spiega che
“l’opposizione
tra
sunnitiesciitinonèun
criterio pertinente per
valutare le modalità
attraverso
cui
Al
Jazeera
fa
informazione”. Ahmed
Kamel, ex direttore
dell’ufficio
di
Al
Jazeera a Bruxelles,
sostiene
che
le
trasformazioni
dell’emittente sono nel
contempo di natura
ideologica
e
commerciali. A partire
dal successo ottenuto,
Al Jazeera ha voluto
adeguarsi
alle
aspettativedella“gente
araba della strada” e
dunque, per forza di
cose, è diventata più
islamista
per
contrapporsi
al
crescente antiarabismo
degli Stati Uniti di
George W. Bush. “Al
Jazeera è un’emittente
privata
che
punta
all’audience
e
al
profitto,” spiega Labib
Fahmy, suo collega e
nuovo capo dell’ufficio
di
Al
Jazeera
a
Bruxelles. “Ciò che fa
muovere l’emittente è,
in effetti, la pressione
dellastrada,”conferma
Mohammed Krichen.
“Siamosempresottola
costante
pressione
dell’opinione pubblica
araba.Mamichiedose
siamo il riflesso di
questa
opinione
pubblica araba oppure
selasubiamo.”
Afiancodiuncelebre
ristorante gay, non
lontano dall’emittente
concorrente Future, si
trova la discreta sede
di Al Jazeera, in via
Hamra, nel settore
Kantari di Beirut in
Libano.
Telecamere
circondano
l’edificio
giallo-rosa. Le scarne
indicazioni all’esterno,
e soprattutto le dodici
parabole sul tetto,
fanno semplicemente
intendere che qui, a El
Mina, al primo piano
c’è
un’emittente
televisiva. All’interno
c’è
un’immensa
redazione in open
space. Su un muro c’è
la grande fiamma del
logo di Al Jazeera e
anche la fotografia di
Tarek
Ayoub,
corrispondente ucciso
nell’aprile 2003 da un
missile americano che
ha colpito la sede
dell’emittente
a
Baghdad.
Il capo dell’ufficio di
Al Jazeera a Beirut si
chiama Ghassan Ben
Jeddou e da questa
sede presenta ogni
settimana il talk-show
Dibattito
aperto.
GhassanBenJeddou,di
padre tunisino sunnita,
madre
cristiana,
sposato con una sciita,
suscita controversie e
fascino. Nel mondo
arabo
è
noto
soprattutto per aver
intervistato nel luglio
2006, nel pieno del
conflitto
israelolibanese,
Hassan
Nasrallah, segretario
generale di Hezbollah.
Con la telecamera,
GhassanBenJeddouha
filmato anche i tunnel
segreti che collegano
Gaza all’Egitto. (Non
sono
riuscito
a
intervistarlo, il motivo
ufficiale è che la
settimana in cui ero a
Beirut lui era nel Sud
del Libano a registrare
lasuatrasmissione.)
Anche
sulla
concezione
di
giornalismo
rappresentata
da
Ghassan Ben Jeddou i
pareri sono discordi.
“Al Jazeera è contro la
democraziainLibanoe
l’ufficio locale, anche il
suo capo, è a favore di
Hezbollah, vicino agli
iraniani e all’emiro del
Qatar,”sostieneAhmad
Kamel,exgiornalistadi
Al Jazeera e oggi a
capo dell’ufficio di Bbc
a
Damasco.
Altri
pensano invece che la
sua intervista al leader
di Hezbollah, Hassan
Nasrallah, sia stato un
colpo giornalistico che
non sarebbe riuscito
neancheallaCnn:“Èla
conferma
del
suo
talento
giornalistico,
non di collusioni con
Hezbollah”,sostieneun
responsabile di Al
Jazeera a Doha. (Si
ricorda
che
per
realizzare
questa
intervista,GhassanBen
Jeddouèstatocondotto
dalsuointerlocutorein
un luogo segreto con
gli occhi bendati e
all’interno di un “blind
bus”, un veicolo con i
vetri oscurati. Hassan
Nasrallah è infatti uno
degli
uomini
più
ricercatidaIsraeleche
lo considera “uno dei
principali terroristi del
mondo”. Quando Ben
Jeddou
ha
chiesto
durante l’intervista a
Nasrallah
dove
si
trovassero,
anche
questi non ha saputo
rispondere poiché vi
era stato condotto a
suavoltabendato.)
Un format News &
Entertainment
Il
mio
obiettivo
continua
a
essere
quello di capire come
AlJazeerasiadiventata
un’emittente
mainstream.
E
le
ragioni
di
questa
trasformazione
non
vanno ricercate nelle
questioni politiche, ma
nel tipo di giornalismo
e nei format televisivi
adottati dall’emittente.
“Il successo di Al
Jazeera è frutto dei
suoi talk-show,” spiega
Labib Fahmy, direttore
dell’ufficio
di
Al
Jazeera
in
Belgio,
incontratoinunbardel
centro di Bruxelles. Il
mio interlocutore non
vuole
parlare
di
questionipolitiche(non
è
autorizzato
a
esprimersi su questi
temi), ma accetta di
parlare di come Al
Jazeera sia diventata
mainstream.
Il segreto di Al
Jazeera è il palinsesto.
Ha
una
programmazione
diversificata e offre a
ciascuna sensibilità del
mondo arabo un suo
specificotalk-show.Per
i
liberali
c’è
la
trasmissione Più di
un’opinione, girata a
Londra
con
il
presentatore di punta
Sami Haddad. Poi c’è
Solo per le donne, un
programma
sulle
questioni
femminili
presentato con pugno
durodallasirianaLuna
Shebel che, tra le
persone arabe da me
intervistate, suscita o
profonda avversione o
adorazione
(il
programma è stato
sospeso di recente).
Per i nazionalisti c’è la
trasmissione di punta
L’opinione contraria,
sulmodellodiCrossfire
di Cnn, condotta da
Doha da un drusosiriano,
Fayzal
al
Qazem, che affronta
anche questioni tabù e
“smitizza i miti”, dice
egli stesso, critica
inoltre i governi dei
vari
paesi.
La
trasmissione
politica
Tra le righe, di
Mohammed Krichen,
accontenta il pubblico
che
sostiene
il
nazionalismo
panarabista
e
gli
islamisti.
Per
gli
islamisti sunniti c’è
invece Senza frontiere
del flemmatico Ahmed
Mansour,
trasmessa
dal Cairo (si dice che
questo egiziano sia
vicino
ai
Fratelli
musulmani).
Soprattuttoperloroc’è
La sharia e la vita
trasmesso da Doha
ogni domenica alle ore
21.05 (ora de La
Mecca). In questa
trasmissione interviene
regolarmente,
come
invitato, una grande
star,losceiccoYoussef
al
Qaradauoi,
un
telepredicatore
islamista (fuoriuscito
egiziano e noto per
esserevicinoaiFratelli
musulmani).
In
questo
programma, il satellite
sheik (così chiamato
perché fa prediche via
satellite) risponde a
domande
concrete
formulate
da
musulmani su come
vivere nella modernità
restando
buoni
credenti. Milioni di
persone
sono
influenzate dalle sue
opinioni e dalle sue
fatwa. È un grande
sostenitore
dei
palestinesi
sulla
questione
degli
attentati kamikaze, è
nemicodegliStatiUniti
per l’invasione in Iraq,
ma è critico verso Al
Qaeda
poiché
considera
“controproduttivi” gli
attentati
dell’11
settembre. Secondo i
suoi
sostenitori,
YoussefalQaradauoi,è
in realtà l’interprete di
un islam progressista,
soprattutto
nei
confronti delle donne.
Altriinveceloaccusano
di aver invocato la
jihad contro la Francia
quando ha proibito il
foulard islamico nelle
scuole
pubbliche.
Risponde in modo
affermativo
a
un
telespettatore che gli
chiede se il Corano
consente di potersi
filmare
mentre
fa
all’amore
con
sua
moglie. Inoltre, la sua
posizione sulla fellatio
come compatibile con i
valori
dell’islam
continua a essere uno
degli interventi più
dibattuti di tutta la
storia della televisione
araba.
“È
stata
una
trasmissione
come
L’opinione contraria a
permettere
ad
Al
Jazeera di diventare
mainstream.
Probabilmente è lo
show oggi più celebre
del mondo arabo e
Fayzal al Qazem è una
star internazionale. Il
successo viene dalla
libertà che si respira
nel programma, le
persone discutono in
modo brillante e con
veemenza. Il mondo
arabo è molto diviso al
suo interno e questo
tipo di trasmissioni
ricostruisce un certo
equilibrio e l’audience
aumenta. Non sono
tanto le news, ma i
news-show
e
l’intrattenimento
ad
averci permesso di
arrivare dove siamo
oggi,” conferma Labib
Fahmy,
direttore
dell’ufficiodiBruxelles.
In origine, il format
di Al Jazeera avrebbe
dovutoesserequellodi
“news
&
entertainment” – il
cosiddetto
“infotainment” –, ma
dopo aver visionato i
pilots,l’emirodelQatar
ha
privilegiato
esclusivamente
l’informazione.
Tuttavia,
l’intrattenimento
è
rimasto
presente
all’interno
del
palinsesto e si è
accentuato
con
l’aumento dei format
dei talk-show (che,
tecnicamente,
sono
spesso dei news-show,
ma con una forte
componente
di
intrattenimento).
“All’inizio i talk-show
duravano un’ora e
mezza, poi li abbiamo
portati a cinquanta
minuti,”
spiega
Mohammed Krichen.
“Sono stati i nostri
talkshow a contribuire
alla modernizzazione
del
mondo
arabo.
All’inizio
risultavano
scioccanti e incredibili
per molti spettatori.
Poi li abbiamo abituati
alla nostra audacia e il
pubblicocihaseguito.”
Anche la dimensione
interattiva
è
importante:
molte
trasmissioni
valorizzano il pubblico
rispondendo
alle
domande telefoniche
fatte
durante
le
trasmissioni,
si
fa
intervenire il pubblico
in studio o utilizzando
ilwebperfarsentirele
domande, le reazioni e
le voci della strada. Al
Jazeera dà la parola al
popolo, nessun altro
media lo aveva fatto
prima. “Inoltre, ci si
chiede sempre più
spesso
di
‘personificare’
il
dibattito, di raccontare
dellestorie,dimandare
in
onda
‘storie
concrete’,
testimoni,
storie
vissute,”
conferma Labib Fahmy
aBruxelles.
Nelnovembre2006è
stata
avviata
la
versione in inglese di
Al Jazeera, emittente
che risponde a una
precisa
strategia
dell’emiro del Qatar.
Anzitutto, fare di Al
Jazeera un gruppo
media
globale:
in
questa fase sono stati
introdotti
canali
sportivi a pagamento e
importanti siti web (è
stato avviato anche un
canale per bambini, Al
Jazeera
Children,
lanciato dalla moglie
dell’emiro, ma senza
legamistrutturaliconil
gruppoAlJazeera).Per
aumentare
la
sua
influenza si è inoltre
ritenutonecessarioche
Al Jazeera cominciasse
a
comunicare
con
l’Occidente.
“Per
invertire la direzione
dei
flussi
di
informazione
che,
normalmente,
si
spostano da ovest
verso est e da nord a
sud, mentre vogliamo
fare
reportage
a
partire dai paesi arabi
e
trasmetterli
in
Occidente.
Con
le
nostre
immagini
possiamo capovolgere
la direzione dei flussi
audiovisivi.
Siamo
diventati mainstream
con le nostre immagini
vere sulla guerra in
Iraq,inAfghanistanea
Gaza.
Tutti
hanno
cominciato a guardare
le nostre immagini,
anche quelli che non
capivano l’arabo. Era
dunque necessario che
cominciassimo
a
trasmettereininglese,”
mi
dice
Atef
Dalgamouni,
un
giordano di nazionalità
americana e tra i
fondatori di Al Jazeera
English
intervistato
nella
sede
dell’emittente a Doha.
Al Jazeera dunque
recluta
giornalisti,
hosts e anchors, e ben
pagati (sul modello
americano,nonsiparla
di
speaker
al
femminile,
ma
di
anchor),diCnn,Abce,
come dalle origini, di
Bbc.
Tuttavia
l’emittente
non
è
ovviamente riuscita ad
avere star come quelle
di Cnn – tipo Larry
King,
Anderson
Cooper, Wolf Blitzer,
Lou Dobbs, Christiane
Amanpour e Fareed
Zakaria – ma questi
restano il modello e
sonoimitatiaDoha.
Al Jazeera araba e la
consorella inglese sono
due entità separate e i
giornalistichelavorano
per
la
prima
collaboranodiradocon
la
seconda.
“L’emittente
internazionale prende
più precauzioni, vuole
fornire
un’immagine
positiva del mondo
arabo,”
lascia
intendere un direttore
dell’ufficio
di
Al
Jazeera.
Il canale in inglese
cerca di raggiungere
anche i musulmani che
non parlano arabo, in
Indonesia,
India,
Pakistan,
nell’Africa
anglofona,maanchele
giovani generazioni di
arabi in Europa. A
Giacarta,
capitale
dell’Indonesia,incontro
Stephanie
Vaessen,
corrispondente di Al
Jazeera English. È
bionda, olandese e non
corrisponde per nulla
al
profilo
della
giornalista
di
Al
Jazeera
che
mi
aspettavo di incontrare
nel
primo
paese
musulmano al mondo.
“L’ufficio di Al Jazeera
a Giacarta dipende
dall’ufficio regionale di
Kuala
Lumpur
in
Malesia,
quartier
generale del gruppo
rivolto
all’Asia
musulmana,” mi dice. I
corrispondenti di Al
Jazeera in Cina, India,
Thailandia
e
alle
Filippine dipendono da
quella sede. Secondo
diverse fonti locali, Al
Jazeera non ha un
grande impatto in
Indonesia.
Per
Al
Jazeera, l’Asia è un
mercato emergente e
comunque l’emittente
ci investe molto, per
esempio producendo
una
speciale
trasmissione asiatica
One on One East (che
riprende il format di
Asian Uncut di Star
World a Hong Kong,
che a sua volta
riprende il format del
talk-show
Jimmy
Kimmel Live! di Abc
negliStatiUniti).
Oggi il gruppo di Al
Jazeera si sviluppa in
tutte le direzioni. La
dimensione
del
divertimento
mainstream sembra la
nuova priorità, insieme
all’informazione. Per
questo, nel novembre
2009,
sono
state
acquisite
per
650
milioni
di
dollari
diverse
emittenti
sportive satellitari del
grupposauditaArt,con
irelatividirittisportivi.
Grazie a questa mossa,
Al
Jazeera
Sport
Channels (Jsc) può
trasmettere le partite
di
calcio
del
campionato algerino,
marocchino,
siriano,
giordano, egiziano e
numerosi altri eventi
sportivi
come
le
Olimpiadi e soprattutto
i Mondiali di calcio del
2010 e del 2014. Al
Jazeera detiene ormai
quasi un monopolio
dello sport nel mondo
arabo, anche se la
concorrenza,
Abu
Dhabi Television, ha
ottenuto i diritti per il
campionato di calcio
inglese per 330 milioni
di
dollari.
Progressivamente, con
lo sport all’interno
della sua offerta nel
settore
dell’intrattenimento, Al
Jazeera diventa un
gruppo media globale,
uno dei più importanti
del
mondo
arabo.
Unisce inoltre, in un
sottile dosaggio, canali
gratuiti e canali a
pagamento: i canali di
informazione gratuita
conducono il pubblico
verso i canali a
pagamento.
Attualmente dispone di
due
canali
d’informazione
continua in arabo e in
inglese, di una dozzina
dicanalisportivi,dicui
sette gratuiti e cinque
a pagamento, di un
canale gratuito che
trasmettedocumentari,
di un programma in
persiano, di un canale
per
i
bambini
(indipendente) e ha
numerosi altri progetti
in corso di sviluppo.
“Dopo l’informazione,
lo sport è l’elemento
centrale di Al Jazeera,”
conferma
Madjid
Botamine,presentatore
di punta della rubrica
sportiva di Al Jazeera,
intervistato
nella
newsroom
dell’emittente a Doha.
Ilgruppoentradunque
con
forza
nell’intrattenimento
per un pubblico di
massa.
“Il
nostro
obiettivoèraggiungere
tuttigliarabi,poituttii
musulmani, poi tutto il
mondo,” mi spiega a
Doha uno degli uomini
chiave di Al Jazeera, il
giordano-americano
Atef Dalgamouni. Ma
come
è
possibile
riuscire
conquistare
pubblico a est e a
ovest? “Qui ad Al
Jazeeranonparliamodi
est e ovest, ma di nord
e sud. E riusciremo a
raggiungere
tutti
attraverso
informazione
e
intrattenimento.
Vogliamo essere un
gruppo mainstream. Al
Jazeera guarda da sud
verso nord,” conclude
Dalgamouni.
Oggi, nel mondo
arabo, esistono oltre
cinquecento
canali
televisivi
e
ciò
indebolisce
sia
l’audience
sia
il
mercato pubblicitario
sucuipuntaAlJazeera.
Tuttavia,
questa
situazione
non
ha
modificatolaspecificità
dell’emittente e il fatto
che
continui
a
rappresentare
un
modello per il mondo
araboenonsolo.Trale
emittenti più influenti
ci sono Nile News Tv,
emittente
di
informazione egiziana
vicina al presidente
Hosni Mubarak, Abu
Dhabi dal Golfo, Arab
News
Network,
emittente con sede a
Londra e di proprietà
del
nipote
del
presidente Bachar al
Asad e naturalmente
vicino agli interessi
siriani; Al Aqsa Tva,
l’emittente palestinese
di Hamas; Al Manar,
l’emittente
di
Hezbollah; Al Arabiya,
l’emittente araba di
informazione con sede
a Dubai Media City,
controllata
da
un
gruppo saudita. Ho
visitato la maggior
parte
di
queste
emittenti a Dubai,
Riyadh,
Damasco,
Beirut,Londra,alCairo
per cercare di capire
perché nessuna di
queste–tranneforseAl
Arabiya – sia riuscita a
diventare un’emittente
globalizzata,
mainstream
tanto
quantoAlJazeera.
La
guerra
immagini
delle
“È
davvero
il
benvenuto nell’ufficio
stampa di Hezbollah.”
Rana, una giovane
donna con il velo, capo
dell’ufficio stampa del
Partito sciita libanese,
mi
accoglie
calorosamente
parlando un francese
perfetto. Mi alzo, le
tendo la mano, ma lei
ritrae la sua e mi
guarda un po’ stupita,
poi con un sorriso mi
dice:“Qui,traglisciiti,
gli uomini non possono
toccare la mano di una
donna”. Porgo le mie
scuse.
“Non
deve
scusarsi,
non
c’è
problema,
gli
occidentali non sono
abituati.Laperdono.”
Haret Hreik è il
feudo di Hezbollah a
Beirutsud.Mitrovonel
distretto di Dahieh, il
quartiere
sciita
di
Beirut, chiamato più
semplicemente
“periferia sud”. Siamo
a soli venti minuti dal
quartiere cristiano di
Ashrafieh,
dove
alloggio, ma l’autista
del taxi che mi ci ha
portato
era
inizialmente titubante;
anche tutti gli altri
interlocutori libanesi
mi hanno sconsigliato
di andarci, per ragioni
di sicurezza, per gli
occidentali e i cristiani
è una zona pericolosa.
L’esercito
israeliano
nel
2006
ha
bombardato
queste
strade.
Numerosi
edifici,
distrutti
o
sventrati, ne portano
ancora i segni, anche
se
alcune
rovine
risalgono alla Guerra
del Libano del 1982 e
devono ancora essere
rasealsuolo.
L’ufficio stampa di
Hezbollahsitrovanella
principale arteria di
Haret
Hreik
e,
apparentemente, non
sembra sottoposto ad
alcun
regime
di
sorveglianza
particolare.
All’ingresso
dell’edificio
c’è
il
cartello
“Media
Relation of Hezbollah”,
a testimoniare che la
formazione libanese si
considera
un’organizzazione
rispettabile. Il partito
sciita
vuole
“libanesizzarsi”
per
vincere le elezioni (ha
avuto due ministri nel
governo
di
unità
nazionaledelnovembre
2009). Al primo piano
sono accolto in un
piccoloufficioincuimi
si chiede di attendere.
Appesa alla parete c’è
una
bandiera
di
Hezbollah, verde su
sfondo giallo, al centro
c’è un fucile d’assalto
tipoAk47consopraun
brano
del
Corano
scritto in rosso e sotto
c’è
un’altra
frase:
“Resistenza islamica in
Libano”.Difronteame
c’è una televisione
accesa, sul canale Al
Manar. Devo fornire il
mio
passaporto,
il
tesserinodigiornalista,
immediatamente
fotocopiati su una
macchina
polverosa
che
funziona
lentamente. Ricevo poi
un accredito stampa di
Hezbollah
che
mi
autorizza a visitarne
l’emittente televisiva,
Al Manar, la radio, Al
Nour, ma che non mi
dà diritto di fare
fotografie, descrivere i
luoghi degli studi e
intervistare
il
personale
senza
autorizzazione
(peraltro la cosa non
mistupisce,sochenon
visiterò
gli
studi
ufficiali e che in ogni
caso ci sono più studi,
dal momento che Al
Manar è sotto la
minaccia
di
bombardamenti
israeliani. So anche,
per esperienza, che
nessuno accetterà di
parlarmi
senza
l’autorizzazione
dell’ufficio in cui mi
trovo).
La
cosa
più
impressionante
di
questa
calorosa
accoglienza è il fatto
che l’ufficio stampa di
Hezbollahèingradodi
accogliere giornalisti
stranieri in diciassette
lingue, benché non
siano molti a venire
fino qui. Il capo
dell’ufficio stampa, la
signora
Rana,
mi
precisa che il Libano è
un paese libero, che
posso andare dove
voglio e che sono il
benvenuto a Haret
Hreik.
L’emittentetelevisiva
Al Manar (Il Faro) è
stata creata nel 1991.
È
una
classica
emittenteinondehertz
per il Sud del Libano e
un canale satellitare
per il Vicino Oriente e
il resto del mondo.
Secondo quanto mi si
dice,
“azionista
principale”diAlManar
è
Hezbollah,
che
ottiene una serie di
fondi
direttamente
dall’Iran e, secondo
un’importante
inchiesta del “New
Yorker”, anche da un
poco chiaro sistema di
cellule autonome di
fundraising insediate
nei paesi del Golfo,
nell’Asia musulmana,
in America latina e
anche negli Stati Uniti.
Secondo alcune stime,
sembra che Al Manar
sia vista da circa dieci
milioniditelespettatori
in Libano e in tutta la
regione (ma senza
strumenti efficaci di
misurazione
del
pubblico il dato non
puòessereverificato).
A Haret Hreik, a
Beirut sud e, più
lontano, a sud del
Libano,
Al
Manar
avrebbe,
secondo
diversi
miei
interlocutori,
diversi
ufficiestudi,alcunidei
quali localizzati nei
sotterranei
e
in
condizioni di massima
sicurezza, soprattutto
quando
Hassan
Nasrallah, capo di
Hezbollah,trasmette.È
impossibile verificare
queste
informazioni.
UnedificiodiAlManar
è
comunque
accessibile.
I portavoce di Al
Manar difendono la
loro
etica
professionale.Rifiutano
la neutralità di Al
Jazeera che dà la
parola agli israeliani e
“trasmette tanto la
voce
delle
vittime
quanto
degli
aggressori”.
Al
contrario di Al Jazeera,
Al Manar dichiara di
essere di parte, a
favore
degli
sciiti
libanesi
e
dei
palestinesi
vittime
dell’occupazione
israeliana.
Nell’inchiestadel“New
Yorker”, viene citato il
direttore di Al Manar
Hassan Fadlallah (che
non ho incontrato)
quando ha detto nel
2002:“Nonèneinostri
obiettivi
intervistare
Ariel Sharon. Vogliamo
avvicinarlo non per
fargli un’intervista, ma
perammazzarlo”.
Mi chiedo allora
come sia possibile il
successo di questa
emittente a Beirut sud
e nel Sud del Libano e
tra
i
palestinesi,
mentre in molti paesi
del
mondo
(per
esempio in Francia) è
vietata poiché sostiene
posizioni negazioniste
sulla Shoah. Secondo
glisciitilibanesidame
intervistati,AlManarè
il
simbolo
della
resistenza. “Guardiamo
Al Manar, ascoltiamo
Al Nour (radio di
Hezbollah)
e
ci
sentiamofieri,”midice
Salim, uno studente
incontrato
nel
quartiere di Haret
Hreik. Gli piacciono in
particolare “i missili
Qassam che Hezbollah
tira ogni tanto su
Israele”.
Più
significativa
è
la
posizione
dei
palestinesi in Libano,
della Cisgiordania e
Gaza che sono fieri di
Hezbollah e della sua
emittente ufficiale Al
Manar, benché sciita
(loro sono sunniti), per
la sua “vittoria” nel
Sud del Libano quando
Hezbollah ha “cacciato
l’esercitoisraeliano”.
Per i suoi detrattori
cristiani
o
sunniti
moderati
che
ho
incontratoinLibano,Al
Manar
ha
come
obiettivo principale di
spingere i palestinesi a
compiere
attentati
kamikaze, e il suo
successo si spiega con
questa
dimensione
propagandistica. Altri
sospettano
che
Al
Manar sia un canale di
trasmissione
delle
informazioni
di
Hezbollah dal Libano
verso i responsabili di
Hamas. Anche per i
critici più moderati, Al
Manar
e
i
suoi
sostenitori
iraniani
sono un importante
vettore
per
la
diffusionenellaregione
dell’islamismo e di
posizioni a favore degli
sciiti.
Il
successo
dell’emittente e il fatto
chesiapiùmainstream
per palestinesi, sciiti
libanesi
e
sunniti
siriani
sembrano
dunque dovuti alla
propaganda,allafedee
allaresistenza.
Nel
pomeriggio,
sempre munito del
lasciapassare fornitomi
daHezbollah,vadoalla
ricerca di negozi di cd
e dvd piratati a Haret
Hreik.
Karam,
un
giovane
sciita
incontrato
in
un
cybercafé
del
quartiere, accetta di
accompagnarmi. Agli
incroci delle strade ci
sono fotografie giganti
che
ritraggono
i
“martiri”, i militanti di
Hezbollah
uccisi
durante
l’offensiva
israeliana del 2006.
Talvolta vedo il ritratto
dell’ayatollah
Khomeini, la guida
spirituale sciita della
Rivoluzione iraniana.
Incontro alcune donne
con il velo, alcune
indossano il burqa, ma
altre sono senza velo e
sembranoaloroagioin
jeans e scarpe da
ginnastica, come se
fossero
nelle
vie
cristiane di Beirut.
Entro insieme a Karam
in diversi negozi della
Hassan
Nasrallah
Street, soprattutto in
una specie di gift shop
di Hezbollah, in cui si
vendonobandiereverdi
e gialle, cd musicali
delle forze militari
sciite. Un po’ più
lontano, Karam mi
porta in un mediastore
in cui vedo migliaia di
cd e dvd illegali,
soprattuttoamericanie
arabi. I film arabi sono
soprattuttoegiziani,c’è
qualche
film
di
Bollywood e di kung fu
diHongKong.Maipiù
visibili sono i prodotti
americani. Ci sono
numerosifilmdiDisney
e tutti i film recenti di
successo di Hollywood,
gli ultimi album di 50
Cent, Lil Wayne e
KanyeWestemoltifilm
d’azione.
“I
film
violenti americani sono
per noi tutti un
esempio da seguire,”
mi dice Karam, con
tono serio (mi dice di
adorare in particolare
le torce Mag-Lite della
Lapd, la polizia di Los
Angeles,
e
che
vorrebbe averne una).
Al di sopra della cassa
c’è un ritratto gigante,
quello
di
Hassan
Nasrallah, uno degli
uominipiùpopolaridel
mondo
arabomusulmano.
“Tutti questi film
sono illegali,” mi dice
Karam.
“Qui
sono
prodotti i cd e i dvd
masterizzati
da
computer, poi si fanno
fotocopie a colori delle
custodie
dei
dvd
affinché il prodotto sia
più
bello.”
La
responsabile
del
negozio, una bella
ragazza senza velo in
jeans e maglietta, che
Karam
conosce,
annuisce. Poi mi dirà
chelefa“unpo’ilfilo”,
ma è una ragazza
“difficile”; le ragazze
più facili si trovano a
Beirut, e il fine
settimana
va
nel
quartierecristiano“per
andare a rimorchiare
ragazze”. Chiedo a
Karam,
che
ha
venticinque anni, per
chi ha votato alle
ultime elezioni libanesi
e perché. Lui mi
risponde: “Ho votato
per Hezbollah perché
difende
il
nostro
paese”.
“Contrariamente
a
quanto pensate spesso
voi in Europa, gli sciiti
non votano Hezbollah
perchéèunmovimento
violento, ma perché è
un movimento dolce e
protettivo,” mi dice
qualche giorno più
tardi, sempre a Beirut
sud,
l’intellettuale
LoqmanSlimchedirige
un importante centro
culturale indipendente
tra gli sciiti. Nelle sue
argomentazioni insiste
sui servizi in ambito
sociale e scolastico
realizzati da Hezbollah
nella periferia sud di
Beirut
(“grazie
soprattutto a denaro
iraniano”).
Poi
prosegue dicendo che
“Hezbollahhainvestito
molto
sull’intrattenimento e
sui media. In passato
ha saputo fare della
violenza
una
coreografia, conosce il
valore dell’estetica in
campo politico e oggi
punta sulla ‘resistance
pop
culture’.
Ciò
significa che Hezbollah
favorisce sia la cultura
pop sia le armi e
sostiene una cultura
della battaglia, del
combattimento e della
resistenza attraverso
immagini,
libri
e
dischi”.
Nelle vie di Haret
Hreikhovistodecinedi
bar, cybercafé, ma
nessun
cinema.
“Hezbollah non vuole
cinema
e,
teoricamente, è ostile
alla
musica
come
accade in Iran. Ma
siamo a Beirut, sa di
dover
fare
delle
concessioni.Autorizzai
barsesonofrequentati
solo da uomini. Su
molti altri temi, gli
ufficiali sciiti sono
addirittura più aperti:
non vogliono figurare
come
censori,
né
esseretroppoortodossi
suidirittidelledonneo
essere in conflitto con
le
aspirazioni
al
divertimento
dei
giovani sciiti libanesi.
Hezbollah non intende
allinearsi alle posizioni
moralistiche di Iran e
Siria, sa che per
ottenere consensi deve
‘libanesizzarsi’.
Per
questo
chiude
un
occhio sul mercato
nero di cd e dvd,”
spiega Loqman Slim.
Poi aggiunge: “Gli
arabi inseguono un
altro sogno, quello
della modernità. Ma
vogliono
diventare
moderni da soli, senza
gli occidentali, senza
gliamericani”.
Il giorno dopo vado
nei campi dei profughi
palestinesi di Sabra e
Chatila, nella periferia
ovest di Beirut. Sono
dunque nella zona
sunnita, all’interno di
un quartiere povero in
cui il Libano non ha
mai voluto integrare i
palestinesi che vivono
lì dal 1948. Anche se
nati in Libano, talvolta
da tre generazioni, i
palestinesi continuano
a non avere diritto di
voto, né passaporto,
non possono esercitare
numerose professioni
liberali, inoltre non
possono
comprare
appartamenti, dunque
sono obbligati a vivere
neicampi.
In una via pedonale
di Sabra, trasformata
in mercato, Hassan, un
palestinese che vende
su un banco di fortuna
cd di musica araba –
riconosco quelli di
Elissa,
Amr
Diab,
Majid, Latifa –, accetta
di accompagnarmi in
negozi di dvd. Lascia
momentaneamente
l’attivitàalfratelloemi
porta in un negozio in
una
vietta
perpendicolare sui cui
muri si vedono ancora,
come mi mostra, le
tracce dei proiettili del
massacro di Sabra e
Chatila del 1982. Ci
sono dvd di film arabi
classici
(soprattutto
egizianiesiriani).Dopo
un breve colloquio in
arabo con il venditore,
Hassan mi prende per
mano e mi fa passare
per una porticina con
un grosso catenaccio e
mi
conduce
nel
sottosuolo. Con grande
stupore mi trovo di
fronte a quattro sale la
cui modernità stride
conlapovertàdellavia
di Sabra, piene di
migliaiadicdedvd.In
questo
enorme
scantinato ci sono
numerosi clienti. Vi si
trova
tutta
la
produzione americana,
anche i film usciti da
una settimana. “C’è
anche un reparto di
vecchi film,” mi dice
Hassan – guardo per
capire quale tipo di
classici vi si trova e
vedoSpider-Man.
Tutti i film sono
minuziosamente
ordinatipergenere,poi
inordinealfabeticoper
attore (Tom Cruise,
Matt Damon, Leonardo
DiCaprio,
Harrison
Ford, Brad Pitt, Arnold
Schwarzenegger, Will
Smith ecc.). Ci sono
anche numerose serie
televisive americane.
Come all’interno del
quartiere
sciita,
il
venditore mi spiega in
inglese che i dvd sono
fabbricati in Cina, ma
sonomasterizzatiqui,a
Sabra
e
Chatila,
scaricati da internet
(non vuole dirmi dove
si trova il laboratorio
clandestino in cui si
approvvigiona). C’è un
settore di programmi
piratati per il sistema
Windows, un settore di
videogiochi, ma si
trovano
anche
i
discorsi di Hassan
Nasrallah in cd e il
settore islamista. Tra i
diversi dvd vedo anche
Valzer con Bashir.
Sapendo che questo
notevole
film
d’animazioneisraeliano
sulmassacrodiSabrae
Chatila
è
stato
censurato in Libano,
come tutti i film
israeliani, e che la sua
diffusione è totalmente
illegale e perseguibile,
chiedo al venditore
perché lo vende. “Non
è un film ebreo, è un
filmarabo,locompri,è
davvero bello,” mi dice
ilvenditorechenonha
ancora sedici anni (mi
sidiràlastessacosain
seguito, nel quartiere
Bahsa a Damasco, in
cui migliaia di dvd
piratati americani sono
venduti per strada e in
cui si può acquistare
altrettanto facilmente
ValzerconBashir).
Sempre
nello
scantinato di questo
negozio
palestinese,
Hassan mi porta in
un’altra
sala
che,
secondo lui, dovrebbe
interessarmi.
Sono
immediatamente
sbalordito per ciò che
vedo: c’è un settore,
molto
frequentato,
pieno
di
film
pornografici.
Film
americani, asiatici e
anche arabi. Sulla
custodia dei dvd ci
sono donne con il velo
eincuiilvelosiferma
all’altezza della vita e
poi nude sotto, oppure
donne con il velo e
sottovesti
luccicanti.
Non oso chiedere se ci
siano film pornografici
gay.
In seguito, ho visto
tre negozi di questo
tipo a Sabra e Chatila,
non
particolarmente
frequentati
ma
estremamente facili da
identificare, e se le
autorità lo volessero,
da chiudere. Sembra
certo che tutti – gli
imam del campo, i
responsabili
politici
sunniti, gli ufficiali
palestinesi, le autorità
libanesi – lascino fare
deliberatamente
pur
conoscendo
questa
grande
diffusione
dell’intrattenimento di
Hollywood, di soap
opera americane e di
film pornografici. “Si
possono
trovare
altrettanti film porno
dagli sciiti di Haret
Hreik,” mi dice il
venditore palestinese
sunnitadiunodiquesti
negozi vicino alla via
Sabra. Capisco dalle
sue parole che si sente
rassicurato da questa
dichiarazione
improvvisa.
Al Arabiya, quando i
sauditientranoingioco
A una decina di
chilometri da Dubai,
sulla
strada
in
direzionediAbuDhabi,
la Dubai Media City è
come un miraggio nel
deserto. Fino a cinque
anni fa, la città dei
media
dell’emirato
arabo non esisteva.
Oggi un cartello indica
con
fierezza
“The
largest
media
production zone in the
world” (la zona di
produzione di media
più grande al mondo).
Ci arrivano autostrade
giganti che si fermano
nel deserto come se
fossero insabbiate e
non
andassero
da
nessuna
parte;
in
questa
zona
sono
cresciute come funghi
1300
aziende
del
settore
audiovisivo,
della stampa e di
internet; ci sono un
centinaio di grattacieli,
affiancati da enormi
gru, la cui costruzione
si è interrotta con la
crisi immobiliare del
2008
e
il
quasi
fallimento dell’autunno
2009; da lontano si
vedono
due
torri
gemelle che sono la
copiadell’EmpireState
Building. A Dubai,
emirato
di
un’irriverente
sovrabbondanza
di
ricchezza,lospettacolo
preferito degli emiri
sono le corse dei
cammelli con un robot
al posto del fantino (i
bambini sono stati
vietatipernonrovinare
loro
la
colonna
vertebrale).
Mazen
Hayek
tiene
a
sottolineare che non si
tratta di cammelli, ma
di dromedari: “Qui non
cisonocammelli”.
Nella
sede
del
gruppo Mbc nel cuore
dellaDubaiMediaCity,
dove l’emittente Al
Arabiya ha il quartier
generale, mi riceve
Mazen Hayek. È il
portavocedelgruppo,è
un caloroso libanese
chehogiàincontratoa
Parigi, mi parla in
francese. “Siamo un
gruppo saudita con
sede negli Emirati,”
precisa subito per
evitare
ogni
confusione. Come Al
Jazeera, emittente del
vicino Qatar e odiato
concorrente, Mbc ha
cominciato
a
trasmettere a Londra
nel
1991,
per
comunicare con gli
arabi emigrati. Dal
2002 il gruppo si è
insediato a Dubai.
“Contrariamente ad Al
Jazeera, noi seguiamo
una
logica
commerciale. Tra i
gruppi di media arabi
siamo l’unica azienda
in attivo. Vogliamo
difenderelamodernità,
favoriamo
l’edutainment e siamo
molto legati ai valori
arabi,”
sintetizza
Hayek.
Nelle
mie
inchieste
all’interno
dell’industria
della
televisione araba ho
sentito
spesso
il
termine“edutainment”,
che mette insieme
educazione
e
intrattenimento.
È
un’espressione che si
può tradurre come
educare attraverso il
divertimento.
“È
divertimento
intelligente,”
spiega
Mazen Hayek. Per lui
come per gli altri miei
interlocutori arabi, è
unterminecheassume
un comodo significato
politico,
poiché
l’edutainment arabo si
distingue
dall’entertainment
americano, considerato
abbrutente e poco
conforme ai valori
dell’islam. Si tratta di
una
precauzione
linguistica giustificata
da questioni religiose.
Del resto, Mazen è
consapevoledelquadro
della
situazione:
“Siamo odiati dagli
islamisti radicali, dai
talebani, da Al Qaeda,
dai
religiosi,
da
Hezbollah.
Rifiutano
tutti l’intrattenimento
poiché
nell’islam
radicale non c’è posto
per il divertimento. I
nemici
dell’intrattenimento
sono gli islamisti”.
Diverse serie televisive
arabe
realizzate
secondo
format
occidentali (Loft Story
nel
Bahrein,
Star
Academy in Kuwait,
Libano
e
Arabia
saudita, Super Star in
Libano e Siria) hanno
dato luogo a fatwa
emesse da religiosi e
hanno
suscitato
manifestazioni
di
ostilità e di condanna
della“SatanAcademy”.
“Per quanto riguarda
il pubblico, cerchiamo
di raggiungere i 350
milioni di arabi nel
mondo e l’1,5 miliardi
di musulmani. Ma se
sappiamo comunicare
agli arabi, comunicare
ai musulmani è molto
più
difficile:
gli
iraniani,
gli
indonesiani, gli indiani
sono forse musulmani
come noi, ma hanno
valori spesso molto
lontani dai nostri e
naturalmente
non
parlanoarabo.”
Mofeed Alnowaisir è
il responsabile dei
nuovimediadiMbc.Gli
faccio visita nel suo
ufficio alla sede del
gruppo a Riyadh e
resto sorpreso dalla
sua giovane età e dal
suodinamismo.
È vestito con una
lunga thobe bianca,
l’abito
tradizionale
saudita,
ma
sullo
schienale della sua
sediac’èunabitoFcuk.
Mi
chiedo,
senza
formulargli
la
domanda, se per caso
usi l’abito tradizionale
allavoroepoisicambi
per andare nei centri
commerciali con gli
amici a Riyadh. Il
giovane principe mi
spiega la strategia del
suogrupposuinternet.
“La nostra strategia è
raggiungere tutti nella
zona
araba,
a
differenzadiAlJazeera
che si orienta su una
nicchiaediRotanache
si interessa solo al
mercatodeigiovani.La
nostra filosofia e il
nostro business plan
sono
diversi.
Raggiungeremoinostri
obiettivi
grazie
al
digitale.” Con quel
linguaggio,
mi
fa
pensare a un giovane
imprenditore di startup della Silicon Valley.
Anche lui parla di
musulmani, soprattutto
di
iraniani
e
indonesiani.
Lascia
intendere
che
attraverso
internet
sarà
possibile
raggiungere molte più
persone. A registratore
spento,
un
altro
responsabile di Mbc in
Arabia saudita mi dice
che uno degli obiettivi
delgruppoèdiffondere
programmi in Iran, ma
siccome
è
vietato
trasmettere da Riyadh
e Dubai in persiano,
Mbc aggira la regola
diffondendo i suoi
programmi verso l’Iran
in arabo, ma con
sottotitoliinpersiano.
La ragione di queste
trasmissioni da Dubai
verso
l’Iran
sta
anzitutto
nei
forti
legamicheesistonotra
iduepaesiperviadella
presenza a Dubai di
decine di migliaia di
iraniani
–
forse
centomila
–
e
soprattutto
di
lavoratori
immigrati
che fanno avanti e
indietro con il loro
paese e di cittadini
fuggiti dal regime
islamista iraniano dopo
il 1979, spesso artisti,
intellettuali o mercanti
del suk di Teheran. In
secondo luogo, per
ragioni demografiche:
la popolazione iraniana
è
particolarmente
giovane e il mercato
dell’intrattenimento è
di certo in aumento. In
questa zona, in cui la
richiesta è forte e
l’offerta censurata, ci
sono
dunque
prospettive
commerciali illimitate.
Infine, per ragioni
politiche, i paesi del
Golfo, e in modo
particolare
l’Arabia
saudita,conduconouna
guerra fredda con
l’Iran e cercano di
“arginare” il regime
utilizzando i media
attraverso la battaglia
delle idee e delle
immagini.
Tutto
concorre
a
far
diventare Dubai la
piattaforma
commerciale strategica
attraverso
cui
trasmettere
flussi
d’informazione e di
contenuti tra Iran e
resto del mondo. Voice
of America e Bbc in
persiano, le emittenti
musicali iraniane come
Persian Music Channel
vi si sono insediate e
garantiscono i legami
tra Iran e Occidente.
Queste reti all’interno
dei paesi del Golfo si
basano
spesso
sull’importante
comunità
iraniana
presente
a
Los
Angeles,cheassicurail
legame con gli Stati
Uniti. Dubai è quindi
oggi
una
capitale
dell’industria
dei
contenuti, una sorta di
HongKong,diMiamio
di Singapore per il
mondo arabo nel suo
complesso e per il
mondo
persianoiranianoinparticolare.
VisitandoilocalidiAl
Arabiya
a
Dubai,
facendo un giro negli
studi televisivi in cui si
registrano
i
programmi, assistendo
alle trasmissioni, sono
sorpreso dalla libertà
delle donne, quasi
sempre senza velo, e
dalfattochetrauomini
e donne ci siano
relazioni distese. Il
gruppo
Mbc
ha
insediato
la
sua
emittente Al Arabiya
all’interno della Dubai
Media City, gran parte
della
produzione
televisivaèconcentrata
qui perché questa è
una “free zone”, libera
in tutti i sensi. È
sicuramente una zona
franca
sul
piano
economico poiché le
aziende non pagano né
tasse,
né
diritti
doganali. Inoltre, come
in Svizzera, esiste un
segreto bancario che
facilita i trasferimenti
monetari dall’Iran, i
movimenti di capitali
tra paesi nemici e
soprattutto
il
riciclaggio di denaro
sporco. Ma la cosa più
importanteècheDubai
è
un
mercato
pubblicitario in cui le
agenzie
di
comunicazione
acquistano spazi per
tutto il mondo arabo.
Se
all’interno
del
settore
della
televisione araba c’è
una forte concorrenza,
con oltre cinquecento
emittenti, quello della
pubblicitàèfortemente
concentrato: “Il 50 per
cento della pubblicità
per
le
televisioni
satellitari gratuite è
nelle mani di una
decina di emittenti”,
riconosceDaniaIsmail,
direttrice
della
strategia
di
Mbc.
Chiedo se, con la crisi
del 2009, Dubai è in
pericolo. Dania Ismail
mi risponde: “Sa, si ha
l’abitudine di dire che
ilmercatopubblicitario
oscilla tra Beirut e il
Golfo. Ogni volta che
c’è una crisi a Dubai,
gliinserzionistivannoa
Beirut. Ma ogni volta
che c’è la guerra a
Beirut o che Hezbollah
va al governo in
Libano,
tornano
a
Dubai. Se vanno via,
aspettiamo
che
ritornino”.
Infine, Dubai è una
zonaliberaperimedia,
internet e i costumi.
“Qui non c’è alcuna
censura, non c’è alcun
controllo,”
dice
compiaciuto
Mazen
Hayek, portavoce di
Mbc. Poi aggiunge:
“Nei nostri talk-show
siamo molto liberi,
parliamo di tutto, di
donne che rifiutano di
portare il velo, di gay.
Ma nel contempo non
siamo
qui
per
disjoncter la società
araba (usa il termine
francese
per
dire
‘mandare in tilt’). Tutti
i nostri talk-show sono
registrati,
e
se
necessario
editati.
Abbiamo regole molto
precise, per esempio
non si possono dire
parolacce.
Non
si
improvvisa mai nulla.
Non
si
verificano
incidenti. Se mai ce ne
fossero, tagliamo”. La
star Lojain Ahmed
Omran, un’affascinante
saudita, che presenta
la fascia mattutina di
Mbc 1 e parla tutti i
giorni a milioni di
arabi,
conferma:
“Siamo sempre un po’
in bilico. In televisione
non porto il velo, cosa
rara per una donna
saudita, ma metto un
foulard
per
non
provocare. Facciamo
soprattutto
edutainment. Parlo di
tutto,manelcontempo
devo essere didattica e
diplomatica.
Se
spingessi le donne a
essere
lesbiche
chiuderebbero
l’emittente!”.
In
termini di libertà, un
altro mio interlocutore
all’interno di Mbc, che
preferisce
restare
anonimo per ragioni
evidenti,
mi
dice
comunque
che
“a
Dubai la libertà è
relativa: non si può
bere, non si può
spergiurare,nonsipuò
mostrare una donna
svestita o in costume
da bagno e anche i
segni d’affetto tra
uominiedonnedevono
essere molto limitati.
Non è l’Arabia saudita,
ma è comunque un
‘islam del deserto’,
quello dei beduini, in
fondopiùtollerantema
anche più arcaico”. Le
riprese di una versione
araba di Sex and the
City
che
avrebbe
dovuto
essere
realizzataaDubaisono
state
rifiutate
dall’emirato
che,
nonostantetutto,opera
secondo
la
legge
coranica.Così,glistudi
sono utilizzati quasi
esclusivamente
dai
paesi arabi e talvolta
da Bollywood. Mai
dagli occidentali. Di
fatto, i programmi più
“liberi” di Mbc non
sonoregistratiaDubai,
ma a Beirut, al Cairo e
forse ben presto ad
AbuDhabi.
Negli Emirati arabi
uniti è stata a lungo
vigente una tacita
ripartizione del settore
audiovisivo: Abu Dhabi
finanziava e Dubai
produceva. La prima
aveva le banche, la
seconda gli studi. Di
recente, Abu Dhabi ha
creatolapropriaMedia
City e, di fronte agli
errori
finanziari
e
speculativi
della
capitale del vicino
emirato,
intende
approfittare
della
ricchezzaperattirarea
sé un po’ del buzz
dell’intrattenimento
arabo. Alle manie di
grandezza di Dubai
fanno eco quelle dei
banchieridiAbuDhabi,
ben
decisi
a
soppiantare l’emirato
caduto in disgrazia e
recuperare un po’ del
suo glamour. Resta il
fatto che i canoni
morali di Abu Dhabi
sembrano ancora più
rigididiquellidiDubai.
Soprattutto,
i
due
emirati
possiedono
entrambi infrastrutture
e mezzi economici
importanti ma pochi
contenuti: sono poco
popolati e privi di una
classe
di
creatori,
devono
sempre
ricorrere ad artisti,
registi,
tecnici
specializzati
e
sceneggiatori
di
Libano,EgittoeSiria,e
ciò frena il loro
sviluppo. Il futuro dirà
se queste città sorelle
saranno
capaci
di
restare a lungo le
capitali
dell’intrattenimento
arabo,
oppure
se
saranno state solo un
miraggioneldeserto.
QuandosiparladiAl
Arabiya e della sua
concorrenza
diretta
con Al Jazeera, c’è un
ultimo tema che deve
essere
affrontato,
quello del ruolo degli
americani nella sua
nascita. Molti miei
interlocutori
in
Palestina, Siria, nel
Qatar, a Dubai hanno
insinuato
che
Al
Arabiya sarebbe nelle
manidegliamericani.È
un’ipotesi
plausibile,
ma poco provata. Sul
tema intervisto Abdul
Rahman al Rashed,
amministratore
delegato di Al Arabiya,
che,
naturalmente,
nega qualsiasi legame.
Sostiene che i sauditi
di Mbc non hanno in
ogni caso bisogno del
denaro americano, “i
mezzi finanziari non
sono per nulla un
problema
per
Al
Arabiya”. Rahman al
Rashed mi fornisce
comunque
due
informazioni
fondamentali
e
teoricamente riservate,
cioècheilbudgetdiAl
Arabiya
sarebbe
“attorno ai 120 milioni
all’anno, ovvero il 50
per cento di quello di
Al Jazeera in arabo”
(ovviamente
è
impossibile verificare
questi
due
dati
fondamentali).
Lo
specialista di media
sauditi, Saoud al Arifi,
intervistato a Riyadh è
più moderato: “Se
ricevono
denaro
americano per vie
traverse? Dalla Cia?
Forse sì. Forse no.
Dubito”.
Ho
intervistato
altri
esperti
e
tutti
confermanoilfattoche
non esistono legami
strutturali, o scambi
finanziari, tra gli Stati
Uniti e l’emittente
saudita,
ma
sottolineano
la
possibilità
di
“convergenze
di
interessi”. Uno di loro
precisa,acondizionedi
restare anonimo: “Gli
americani,
come
i
sauditi,
sono
interessati al fatto che
esista
una
vera
concorrenza ad Al
Jazeera, questo è ciò
che li unisce”. Un
diplomaticooccidentale
in carica a Riyadh
afferma invece che “Al
Arabiya,vuoleesserela
voce del mondo arabo,
primadiesserelavoce
del mondo musulmano
– in fondo il contrario
di Al Jazeera. Mbc, al
quale
appartiene
l’emittente,
è
un
gruppo schermo che
riflette la posizione del
regime saudita, come
Al
Jazeera
riflette
quella del Qatar. Su
alcuni temi come Iran,
Hezbollah,
Siria,
l’emittente
può
risultare vicina agli
interessiamericani,ma
il legame con gli Stati
Uniti
è
molto
improbabile.
Il
re
Abdallah
dell’Arabia
saudita, che è entrato
in una logica di guerra
fredda con gli sciiti,
conduce
una
diplomazia dei media,
la sua”. Tuttavia, le
relazioni commerciali
con gli americani sono
numerose: Mbc per
esempio
ha
recentemente siglato
unaccordoesclusivodi
treanniconParamount
per trasmettere i film
di Hollywood sui suoi
canali
di
cinema.
Diversi interlocutori a
Los Angeles mi hanno
confermato
che
esistono accordi simili
conDisneyeWarner.
Lascio Dubai un po’
sconvolto. In questo
piccolo
emirato
praticamente non ho
visto autoctoni, gli
emiri,
oziosi
privilegiati. Ho visto
soprattutto libanesi e
immigrati del Pakistan,
dal
Bangladesh
e
dall’India (Mumbai è a
solo due ore e mezza
da Dubai). Portandomi
all’aeroporto, l’autista
del taxi, un po’ perso
fra tutte le strade con
ostacoli nella Dubai
Media City, chiede più
volte indicazioni a
lavoratori indiani e
hindi. Poi passiamo
davanti a un immenso
centro commerciale e
midice,ininglese:“Èil
Dubai Mall. Il più
grande shopping mall
al mondo, con il più
grande
hotel
internazionale e il più
grande multisala del
pianeta”.
È
visibilmente
meravigliato. Poi fa un
cenno: “Guardi, è la
BurjDubai,latorrepiù
alta del mondo. Non ci
crederà,èaltaquasiun
chilometro”.
Ilfiumedellaverità
Hala Hashish in
Egitto è una star.
Contrariamente
alle
sue assistenti non
porta il velo, ma
occhiali neri: “È il mio
modo di portare il
velo,”
mi
dice
sorridendo. “Non sto
scherzando,
questa
mattinanonhoavutoil
tempo di truccarmi.”
Incontro Hala Hashish
più volte al Cairo, nel
grande
edificio
circolare della radiotelevisionenazionalein
cui
lavorano
oltre
quarantamila egiziani.
Come
a
Parigi,
Yaoundé,
Shanghai
anche qui l’edificio
della radio-televisione
pubblica
è
tondo,
circolare e, al Cairo,
c’è anche un personale
pletorico che gira in
tondo.
Hala Hashish dirige
una sorta di Cnn
egiziana,
emittente
televisiva nazionale di
informazione continua,
Nile News Tv (Egypt
NewsChannel).Èstata
presentatrice dell’hit
parade
di
musica
egiziana
At
your
Request e di Arabic
Chart, trasmissione di
musica famosa da
Beirut a Tunisi, al
quale
il
pubblico
partecipava
per
telefono o con sms a
pagamento
(che
finanziavanoloshow)e
conosce
bene
le
tecniche
mediatiche
popolari. Dal momento
che aveva lavorato
anche per conto del
governo
egiziano,
all’interno dell’agenzia
ufficiale
di
informazione, conosce
ancheilpolitichese.
Lo slogan della sua
emittente è “The River
ofTruth”(Ilfiumedella
verità).Sullaparetedel
suo ufficio, un grande
ritratto
di
Hosni
Mubarak ci osserva:
“Sono
una
donna
forte”, dice chiedendo
con fermezza a un
cameriere di avere un
caffè e la sua borsa.
Peraltro,
mentre
discutiamo, un fiume
continuo di camerieri,
consulenti, giornalisti
(anche uno dell’odiata
concorrenza
di
Al
Jazeera) sfila nel suo
ufficio, e questa donna
mi pare effettivamente
forte. Mi è stato
raccontato che aveva
fatto
mettere
la
fotocopiatrice di Nile
NewsTvnelsuoufficio
per controllare chi la
utilizzava. E non è solo
una voce, nell’ufficio
vedolafotocopiatricee
tutti quelli che se ne
servono
passano
davantialei.
L’emittente, il cui
obiettivo
non
dichiarato
è
la
concorrenza ad Al
Jazeera,
trasmette
ventiquattr’ore
su
ventiquattro in arabo.
Ilcanalerappresentail
governoegizianoedice
di essere un media
“moderato”, così come
l’Egittosidefinisceuno
“stato
moderato”,
spiega Hala Hashish.
Poi
aggiunge:
“Al
Jazeera è un’emittente
più
negativa,
più
critica,
noi
siamo
invece positivi. La
nostra formula è fatta,
nel
contempo,
di
informazione
e
divertimento. Abbiamo
inventato il format
news
&
entertainment”,
dice
Hala Hashish, senza
rendersi conto che è la
formuladiAlJazeerae,
da oltre vent’anni, di
numerose
emittenti
americane. Allora le
dico: “Ha ragione, è
una formula di Al
Jazeera: un insieme di
newsedentertainment,
è questo che ne ha
fatto
il
successo”.
Dunque, come tutti,
anche
l’emittente
pubblica
egiziana
trasmette sempre più
talkshow “live” per
unire cultura, varietà e
sport all’informazione.
Tuttelesere,lacelebre
trasmissione Live from
Cairofausoeabusodi
questo
format.
“L’informazione
fa
parte
dell’intrattenimento,”
concludeHalaHashish.
LatelevisionedelSud
Qualche mese dopo
mi trovo a Caracas, in
Venezuela, nell’ufficio
di
Andrés
Izarra,
presidente onnipotente
di Telesur. Giovane,
muscoloso,abbronzato,
in jeans e scarpe da
ginnastica,Izarramidà
l’impressione di un
omosessuale di West
Hollywood
appena
uscito da una palestra.
Gli comunico le mie
impressioni. “Cerco di
fare sport tutti i giorni
e la mia palestra è
vicinoall’ufficio.Masa,
da quando sono l’uomo
di Hugo Chávez nei
media, ho una vita
sociale molto limitata.
Non posso uscire che
subito vengo additato.
Allora
trascorro
il
tempo qui a lavorare,
sto con mia moglie e i
miei due figli.” Poi
prende il telefono che
aveva appena fatto un
bip.Rispondedigitando
alcune parole. Mi dice:
“Era
un
sms
di
Chávez”.
Non so se fosse vero
o meno, comunque
Izarra,
trentacinque
anni, è gia stato due
volte ministro della
Comunicazione
di
Chávez,
presidente
venezuelano
autoproclamatosi
leader del “socialismo
del
Ventunesimo
secolo”.Midicediaver
lavorato prima come
corrispondente di Cnn,
Nbceperlatelevisione
venezuelana.
Parla
correntemente inglese,
tedesco e francese. È
stato anche consigliere
dell’ambasciata
del
Venezuela negli Stati
Uniti. Da due anni è
stato
chiamato
da
Chávez a presiedere
una delle emittenti più
importantidell’America
latina, Telesur. È una
televisione
che
trasmette ventiquattro
ore su ventiquattro ed
è stata chiamata dai
numerosi
oppositori
“TeleChávez”.
Telesur (Tele Sud, in
spagnolo)
è
stata
avviata nel 2005 dal
Venezuela
con
il
sostegno finanziario e
logistico di sei paesi
“fratelli”:
Cuba,
Bolivia,
Ecuador,
Nicaragua, Uruguay,
Argentina
(ma
al
progetto non hanno
contribuito
né
il
Brasile, con cui il
Venezueladialoga,néil
Messico, il Perù e il
Cile, nemici giurati, né
soprattuttolaColombia
considerata, a causa
della sua vicinanza con
gliamericani,“l’Israele
dell’America latina”).
“Non
siamo
un’emittente
di
propaganda. Abbiamo
un punto di vista, il
punto di vista della
sinistra. E difendiamo
l’America
latina.
Durante il colpo di
statoinHonduras,Cnn
Español parlava solo
della morte di Michael
Jackson. Noi parliamo
di questa regione. Ci
occupiamo di America
latina. Cnn Español se
ne frega. Noi amiamo
sinceramentel’America
latina. Vogliamo dare
una voce al Sud,”
precisaIzarracontatto
e
professionalità.
Dietro di lui c’è un
quadro immenso che
rappresenta
Fidel
Castro;
sulla
sua
scrivania
c’è
una
fotografiadiCastrocon
un berretto di Telesur;
più in là, su una
scrivania strapiena di
libri,c’èunafotodilui,
consuofiglioeChávez.
Osservo tra me e me
che mancano solo
Simón Bolívar e Che
Guevara.
È stato il colpo di
stato in Honduras a
portare alla ribalta
Telesur, un po’ come,
con
le
debite
proporzioni, l’attacco
aereo americano ha
fatto conoscere Al
Jazeera a tutto il
mondo. Mentre Cnn
Español, che trasmette
da
Atlanta,
generalmente
tace
sulle
guerriglie
di
estrema sinistra o
tratta a margine nelle
sue informazioni le
vicende di Bolivia ed
Ecuador,Telesurrende
conto
di
qualsiasi
evento, sempre in
diretta. L’emittente ha
un’importante équipe
anche a Cuba, le
immagini sono fornite
gratuitamente
dall’ufficio di Telesur a
L’Avana, finanziato da
RaulCastro.
Chiedo a Izarra di
quale budget disponga
per la sua televisione
neoguevarista. “Ho 50
milioni
di
dollari
l’anno,” risponde con
aria
sincera.
Dal
momento
che
l’emittente ha 400
dipendenti, 12 uffici
all’estero, altre sedi
che
apriranno
a
Portorico, Madrid e
Londra nel 2010, e
considerati i grandi
investimenti fatti nel
digitale
e
nel
satellitare, mi rendo
subitocontochequesta
cifraèfalsa.Cosìcome
sono sicuro che mente
quando mi dice che
Chávez non interviene
mai
nella
linea
editoriale di Telesur. Il
presidente-militare è
celebre
per
la
trasmissione
Aló
Presidente,
sulla
televisione del regime:
èunadiscussioneconil
“popolo” di quattro o
cinque ore tutte le
domeniche
ed
è
ritrasmessa su tutti i
canali del paese su
semplice sua richiesta.
“Chávez vuole essere
sempresuTelesur,non
rispetta l’indipendenza
deimedia,anchequella
dell’emittente
meno
indipendente
del
Venezuela,” dice con
ironia il patron di
un’emittente
concorrente.
La maggior parte dei
miei interlocutori in
Brasile,
Messico,
Argentina
ha
sottolineato
il
fallimento del progetto
di Telesur e i suoi
ascolti ridicoli. Faccio
una domanda a Izarra
su
questo
punto.
“Siamo
molto
soddisfatti della nostra
audience. In Venezuela
siamo
leader
nell’informazione.
Altrove
siamo
in
crescita. Telesur è
un’emittente giovane,
trasmettiamo da soli
quattro
anni.
La
battaglia si gioca sul
fronte dei media e in
America latina sono
tutti di destra. Ma la
rivoluzionediBolívarin
Venezuela ha aperto il
futuro e ha creato una
via per la democrazia.
C’è un nuovo soggetto
di fronte all’élite, i
poveri. La democrazia
cresce. I successi della
rivoluzione di Chávez
sono oggettivamente
importanti. Quelli che
sono stati esclusi dai
ricchi, dai monopoli,
dai conservatori hanno
presoilpotere.Telesur
è la loro emittente.”
Andrés Izarra parla
velocemente, più come
un guerrigliero che
come un manager
americano. È agitato,
rapido, molto efficace,
muove le mani, prende
uno dei suoi tre
cellulari, tra cui un
iPhone
e
un
Blackberry,
dà
un’occhiata al suo
iMac.
Riprende:
“Certo,
c’è
una
rivoluzione in corso
all’internodeimediain
questo
paese,
la
democratizzazione
dell’informazione
è
necessaria.
È
una
guerra. Ciascuno deve
scegliere il proprio
campo. L’opposizione
continuerà a logorarci
e noi continueremo a
proteggere
la
rivoluzione.
Li
oscureremo
se
necessario perché una
televisione di merda
come
Globovision
merita
di
essere
bandita, neanche in
Francia sarebbe mai
autorizzata. Rctv era
un’emittente
in
posizione
monopolistica. Noticias
24 è la voce degli
americani in Colombia.
Abbiamo interrotto il
monopolio
di
Cnn
Español.
Abbiamo
restituito una voce al
Sud. Il nostro slogan è
‘Nuestro Norte es el
Sur’(IlnostroNordèil
Sud).
Siamo
l’equivalente di Al
Jazeera per l’America
latina”. Izarra si alza
improvvisamente
e
soffermailsuosguardo
con tenerezza verso le
colline del quartiere
Boleita
Norte
di
Caracas, dove si trova
il barrio Petare – una
dellepiùgrandifavelas
dell’America latina (in
Venezuela le favelas si
chiamano“barrios”).
Il magico nome di Al
Jazeera
è
stato
pronunciato.
Andrés
Izarra
non
vuole
parlarne troppo, ma so
che
esiste
un
importante accordo di
collaborazione
tra
Telesur e Al Jazeera.
“Ci
scambiamo
immagini,” mi dice
semplicemente. Poco
dopo, nella newsroom
di
Telesur
vedo
giornalisti
tradurre
alcuni programmi di Al
Jazeera,
facilmente
riconoscibili
dalla
fiamma color oro. Nel
congedarmi,
Andrés
Izarra mi fa un regalo:
una biografia di Simón
Bolívar in spagnolo,
pubblicata
dalle
edizioni
della
presidenza
della
“Repubblica socialista
bolivariana
del
Venezuela”. Mentre lo
ringrazio,
vedo
in
corridoiounafotografia
appesa al muro, il
celebre ritratto di Che
Guevara del fotografo
Korda.
Bolívar,
Guevara, Chávez e
Castro,èlaquadratura
del
cerchio
del
pensiero socialista in
vogaaCaracas.
“Con
Telesur,
vogliamo costruire un
ponte tra America
latina e mondo arabo,”
mispiegalaserastessa
all’internodiunpiccolo
bardiunquartierechic
di
Caracas,
Dima
Khatib. Dima dirige
l’ufficiodiAlJazeerain
Venezuelae,misidice,
è vicino ad Andrés
Izarra
e
Chávez.
“Chávez voleva creare
una sorta di Al Jazeera
in America latina e io
ho lavorato con Andrés
perprogettareTelesur.
Chávez vuole fare di
Telesur il primo media
dell’America latina e si
ispira molto ad Al
Jazeeracheèriuscitoa
diventare il primo
media
del
mondo
arabo.”
Dima
Khatib
è
palestineseedènatain
un campo in Siria, ha
una formazione da
interprete
e
parla
correntemente arabo,
spagnolo, inglese e
francese e lavora per
l’emittente araba fin
dagliinizi.Èunafigura
nota di Al Jazeera e ha
scelto di trasferirsi in
Venezuelaperaprirein
America latina l’ufficio
regionale
dell’emittente.
“Da
Caracas abbiamo la
copertura
di
tutta
l’America
latina,
abbiamo un piccolo
ufficio in inglese a
Buenos Aires e un
corrispondente
in
Brasile, ma gran parte
del lavoro viene fatto
dal Venezuela. Sono
l’unica corrispondente
straniera a viaggiare
con
Chávez.
Ci
conosciamo bene. Noi
vogliamo svegliare il
mondo arabo e Chávez
vuole
cambiare
l’America latina. Ci
capiamo.
Abbiamo
costruito un’asse sudsud,”precisaKhatib.
Con
l’accordo
segreto stretto con Al
Jazeera (e che mi è
stato descritto nel
dettaglio
da
due
interlocutori a Doha e
Beirut), Telesur può
ottenere gratuitamente
le immagini a sua
scelta dei programmi
dell’emittente araba.
Secondo
alcune
indiscrezioni, nel corso
del
2010,
Telesur
apriràinoltreunufficio
a Doha e uno a
Damasco,sempreconil
sostegno di Al Jazeera.
In
cambio,
i
corrispondenti di Al
Jazeera a Caracas
possono usare a loro
piacimento gli studi di
Telesur
e
le
strumentazioni
tecniche. Di sicuro, il
sodalizio va oltre ed è
fatto anche di scambi
di
informazioni.
Secondo alcuni miei
interlocutori,
probabilmente esistono
anche accordi per
facilitare
le
comunicazioni
satellitari,
ma
escludono relazioni di
denaro (il Qatar e il
Venezuela sono paesi
ricchi).
Tuttavia,
secondo
il
rappresentante
del
Congresso americano
Connie Mack IV, un
repubblicano eletto in
Florida, “questa nuova
alleanza tra Telesur e
Al Jazeera ha come
obiettivo la creazione
di
un
network
televisivo mondiale per
i terroristi e i nemici
dellalibertà”.
Network di terroristi
mi
pare
davvero
eccessivo, ma di certo
è in corso una guerra
sul fronte dei media e
delle immagini. La
conferma
viene
semplicemente
ascoltando
gli
oppositori di Chávez in
Venezuela.
Marcel
Granier è tra questi, è
l’amministratore
delegato
di
Rctv,
un’importante
emittente
che
trasmette in frequenze
hertz, specializzata in
informazione,
intrattenimento
e
telenovele, che si è
vista
ritirare
l’autorizzazione
a
trasmettere da parte
del ministero della
Comunicazione
di
Chávez. “Il futuro di
Rctvdipendedalfuturo
del
Venezuela,”
commenta rassegnato
Granier,inunlussuoso
salone all’interno della
superprotetta sede di
Rctv,
nell’edificio
storico che ospitava in
precedenza
Radio
Caracas. “Lei crede
che qui viviamo in una
democrazia?”
mi
chiede
gentilmente
Granier per testarmi.
Evito di esprimermi,
ma
decidiamo
di
proseguire l’intervista
inmodofranco.Conun
francese si sente in
territorioamicoeparla
sapendo
che
ne
riporterò
le
dichiarazioni: “Qui c’è
una dittatura militare.
C’èunacensuratotale,
completamente
arbitraria. C’è una
censura politica, ma
anche
commerciale.
Per esempio, saturano
completamente
il
mercato pubblicitario
per costringere le
emittenti private a
chiudere senza doverlo
fare loro con la forza.
Ci
attaccano
personalmente, è in
gioco
la
nostra
integrità fisica. Io ho
paura per la mia
famiglia e sento la mia
vita in pericolo”. Gli
chiedo se ha mai
pensato di espatriare.
“Sono
venezuelano,
questo è il mio paese.
La mia famiglia sta a
Miami. Ma i miei
dipendenti sono qui,
sono
minacciato,
denunciato. Ma amo il
mio paese. Devo stare
qui.” Gli chiedo poi la
suaopinionesuTelesur
e il suo direttore
Andrés Izarra. “Dice di
aver lavorato per Cnn,
ma nessuno se lo
ricorda.
La
mia
televisione è stata
proibita
dal
suo
ministero.Nonl’homai
incontrato. Telesur è
un’emittentescellerata,
molto più pericolosa di
Al
Jazeera
poiché
lavora in modi non
conformi alle pratiche
del giornalismo. Qui in
Venezuela,Telesurnon
può fare più disastri di
quelli fatti da Chávez
che
ha
rovinato
l’economia, distrutto la
democrazia e messo il
bavaglio allo stato di
diritto.
Anche
in
Brasile e Argentina,
l’emittente è piuttosto
inoffensiva,
sono
grandipaesichenonsi
lasciano
influenzare.
Invece Telesur è molto
pericolosaneipaesipiù
piccoli come Uruguay,
Bolivia, Honduras e
Guatemala,
poiché
conduce una guerriglia
politica di estrema
sinistra.
Non
è
importante l’audience,
è
uno
strumento
strategico.
È
un’emittente che ha
molto più peso di
quanto
possa
sembrare.
Fa
letteralmente
la
guerra.”
“Visit
Israel,
Before
IsraelVisitsYou”
Per
andare
da
Gerusalemme
a
Ramallah prendo lo
sherut (taxi collettivo)
numero 18. È la
seconda volta in vita
mia che vengo nella
capitale della Palestina
e sono spaesato poiché
nulla
è
cambiato.
Prendo contatto con
alcuni palestinesi di
mia conoscenza, trovo
unalbergodifortunae
attendo la giornalista
Amira Hass all’interno
delbarStar&Bucksdi
Ramallah. Il posto è
una copia dei bar della
celebre
catena
americana,manonèin
franchising,
il
“caffellatte”costadieci
shekel israeliani (quasi
due
euro).
Alcuni
ragazzi fumano la pipa
adacqua,unodiquesti
indossa una maglietta
con la scritta “Nypd”
(New
York
Police
Department). Su uno
schermo piatto gigante
sintonizzato
sull’emittente saudita
Rotana
passano
videoclip con ragazze
moltosvestite.Sulviale
di questo bar si
vendono cd piratati di
RotanaeritrattidiChe
Guevara.
Improvvisamente, un
camioncino con uomini
di Fatah armati passa
nellestrade,sparanoin
aria.
Mi
sento
comunquealsicuro.
Poco dopo mando
alcune
e-mail
dal
cybercafé.
Sono
sorpresodallapresenza
di decine di cybercafé
che non c’erano nel
mioviaggioprecedente
nelcentrodiRamallah.
La
velocità
di
connessione è rapida e
nel computer vicino al
mio un ragazzo discute
via Skype con i fratelli
che vivono negli Stati
Uniti.
Altri
clienti
consultano
siti
israeliani o cercano di
rimorchiare ragazze su
siti di incontro arabi.
Unodeigiovaniuomini
concuiparlomichiede
di prestargli il mio
iPod, mette le cuffie e
capita su un brano di
Re
Leone
(forse
sorprende che ci sia
questa musica sul mio
iPod):
“È
Simba”.
Conosce il film a
memoria, anche il suo
amico.Nonhannovisto
il film né al cinema, né
in televisione, ma “sul
computer”. La falsa
leggenda
africana
americanizzata (simba
significa
leone
in
swahili)funzionaanche
inPalestina.
Poco dopo, Amira
Hassarrivadasola.Ha
i capelli neri e una
mèche davanti, porta
un foulard verde e blu
fluorescente attorno al
collo. Sorride, parla
con calma, ha una
dolcezza evidente che
dissimula uno spirito
rivoltoso. Il parabrezza
della sua auto, sulla
sinistra, ha fori di
proiettile: “Non ero in
macchina quando c’è
stato questo scontro
armato tra Hamas e
Fatah”, precisa. Allo
specchietto retrovisore
ha
attaccato
un
pendaglio con sopra
Che Guevara. Nello
scenario
politico
israeliano, Amira Hass
è
considerata
di
estrema sinistra. Il
programma
della
giornata prevede un
giro in Palestina, tra i
check-point, i media e
laculturalocali.
Poco dopo la nostra
partenza, all’uscita di
Ramallah c’è il primo
check-point.
Ingenuamente, penso
che stiamo rientrando
in Israele. “Sbagliato,”
midiceAmiraHass.“È
quanto
l’esercito
israeliano vuol far
credere. Di fatto, in
Palestina
ci
sono
check-point
dappertutto. L’esercito
israeliano dice che è
per
questioni
di
sicurezza, ma in realtà
èpercrearequelloche
chiamo
‘designated
territoiries’, marcare il
territorioisraeliano.”
Amira Hass è una
delle
più
celebri
giornaliste del Vicino
Oriente(eunadellepiù
premiate sul fronte
internazionale).
È
israeliana
ed
è
corrispondente
fissa
dalla Cisgiordania del
quotidiano di Tel Aviv
“Haaretz”. È l’unica
giornalista
ebrea
israelianacheabitanei
territori
palestinesi
(primaaGazaapartire
dal 1993 e poi a
Ramallah dal 1997). È
figlia
di
genitori
sopravvissuti
allo
sterminio nazista degli
ebrei ed è nata a
Gerusalemmenel1956.
I suoi reportage sono
generalmente
favorevoliaipalestinesi
e
la
sua
specializzazione è la
minuziosaanalisi,quasi
scientifica,
della
colonizzazione
israeliana in corso nei
territori. I lettori di
“Haaretz” chiedono il
suo licenziamento con
centinaia di lettere.
Peraltro, ha avuto
numerosi
contrasti
anche
con
Yasser
Arafat e Fatah, di cui
ha spesso denunciato
l’incuria, lo sperpero,
la corruzione. “Sono
moltocriticaanchecon
ipalestinesi,nonsipuò
direchesiatuttacolpa
degli israeliani,” dice
AmiraHass.
Mentre viaggio con
lei la osservo lavorare.
A ogni checkpoint, in
ogni
punto
di
approvvigionamento di
acqua, ogni volta che
una via è decretata
“sterile”
(termine
ufficiale israeliano per
indicare che è vietata
la circolazione dei
palestinesi, benché ci
troviamo in Palestina),
ognivoltachevedeuna
terra
confiscata,
quando vediamo il
“Muro” (a un certo
punto vedo la scritta
“StoptheWall”),Amira
Hass scrive. Guarda la
cartina, confronta i
tracciati delle strade,
constatalacomparsadi
chiusure elettrificate
(“che
mettono
i
palestinesi in gabbia,”
dice),
segue
minuziosamente
gli
spostamenti
della
“frontiera” – il suo
tema principale – e
prende appunti a tutta
velocità
sul
suo
computer Dell. “Sono
molto
fact-checking,
non sono emotiva. I go
by the numbers,” dice
per insistere sulle sue
descrizioni meticolose
incuiriportadati,fatti,
cartine, strade, tunnel,
ponti, deviazioni. A Tel
Aviv, il caporedattore
la considera un po’
ossessiva.
Nei
quartieri
palestinesi
scopro
spesso in vendita, sui
marciapiedi
come
ovunque,migliaiadicd
edvdcontraffatti,molti
sono americani. “I
palestinesi odiano gli
americani, ma si tratta
diunantiamericanismo
sentimentale,
romantico,
non
ideologico. Ascoltano
musica americana e
guardano i film di
Hollywood come tutti,”
spiega Amira Hass.
Sonoineffettisorpreso
di trovare la maggior
parte degli ultimi film
di
successo
hollywoodiani nelle vie
di Ramallah e in altre
cittàdellaPalestina.“Il
paradosso è che i
giovani
palestinesi
dellaCisgiordaniasono
molto
più
americanizzati
in
generale dei giovani
degli altri paesi arabi:
questo si spiega con la
loro vicinanza con
Israele,”
conferma
AmiraHass.
Il culto per i film
americanièunpuntoin
comune tra giovani
israeliani e giovani
palestinesi. Tuttavia,
Benny
Ziffer,
caporedattore
del
quotidiano israeliano
“Haaretz” (il giorno in
cui l’ho intervistato
indossavaironicamente
una maglietta con la
scritta “Visitate Israele
prima
che
Israele
venga a farvi visita”)
relativizza
questa
vicinanza: “Quello dei
palestinesi
è
un
americanismo
superficiale,
quello
delle marche e della
moda, della musica
pop, dei film di
successo e di internet.
Manelmomentoincui
si entra nella cultura
reale,quellachesivive
in casa propria resta
una
cultura
molto
islamica. Per esempio,
la cultura televisiva è
molto
musulmana,
soprattuttoconleserie
siriane, egiziane e in
questo periodo con
quelle turche che sono
molto
seguite
in
Palestina.Ilsuccessodi
queste serie turche è
rilevante, poiché sono
nel
contempo
musulmane
e
più
moderne rispetto al
mondo arabo; in fondo
è in questo modo che
avviene
un’americanizzazione
indiretta, attraverso il
filtro turco. Ma per il
momento è ancora una
cultura
molto
islamica”. Gael Pinto,
critico cinematografico
perlostessogiornalee
intervistato alla sede,
constata che in Israele
non esiste un dibattito
sull’America:
“Contrariamente alla
Palestina, qui non c’è
dibattito
sull’imperialismo
americano
o
sulla
dominazionedegliStati
Uniti,èunfatto.Siamo
talmente
americanizzati che non
c’è neanche bisogno di
parlarne”. Un collega
di Pinto, il celebre
storico Tom Segev, ha
scritto
un
libro
sull’americanizzazione
culturale di Israele e
racconta
come
progressivamente
lo
stato ebraico abbia
abbandonatoilmodello
sionista, quello dei
kibbutz o di un
socialismo alla Ben
Gurion, per dirigersi
verso i valori del
pragmatismo
e
dell’individualismo. La
prova, mi dice, è che
Israele oggi è una
“start-upnation”,ilsuo
dinamismo economico
si spiega attraverso il
più elevato numero di
start-up rispetto a
Giappone,
India,
Inghilterra. Il titolo del
librodiTomSegev,che
ricevo in dono, è
sintomatico, Elvis in
Jerusalem.
Qualchetempoprima
avevo fatto le mie
inchieste a Gaza, in
particolare nel campo
di Jabaliya, e avevo
potutoosservarecheAl
Jazeera era guardata
nella
maggioranza
delle case palestinesi,
negli uffici in cui
andavoedallefamiglie
che mi accoglievano.
Anzituttoeroincredulo,
per via della grande
povertàdiquesticampi
palestinesi. Poi ho
capito che quanto
vedevo a Gaza, come a
Ramallah, Betlemme,
Damasco,
Attaba
Square (il mercato nel
cuoredelCairodovesi
trova quella che gli
egizianichiamano“Cell
Phone
Street”,
la
strada dei telefoni
cellulari)
era
una
regola internazionale:
ovunque si trovano
facilmente decine di
migliaia di antenne
paraboliche e decoder
satellitari, venduti tutti
al mercato nero. Con
l’equivalente
di
venticinqueeurosipuò
comprare un decoder,
con dodici una piccola
parabola.
Secondo
alcune stime, solo il 2
per
cento
dei
palestinesi
ha
un
abbonamento
satellitare
legale,
tenuto conto dei costi,
mal’80percentodella
popolazione delle città
ha accesso a questi
servizi
in
modo
collettivo e illegale.
Alla
direzione
dei
grandi gruppi di media
arabi,Mbc,Art,Rotana
aRiyadheDubai,tuttii
miei interlocutori mi
hanno confermato che,
secondo loro studi, la
quasi totalità della
popolazione
araba,
anche nelle zone più
povere, ha accesso a
una parabola e il tasso
di penetrazione della
televisione via satellite
era pressoché totale.
Abbiamotuttiimpresse
nella
mente
le
immaginidibeduininel
deserto,
con
il
dromedario
e
la
parabola.
“Qui
la
ricchezzadellefamiglie
si misura con le
dimensioni
della
parabola,” mi dice
scherzando
Ayman,
uno studente di Gaza
nel campo di Jabaliya.
“Spesso
dopo
le
ventidue non c’è più
acqua né luce nelle
strade,
ma
le
televisioni
restano
accese. E più la
parabola è grande più
canali si prendono.” A
casa sua sono accolto
come un amico, mi si
offre da mangiare e
vengotrattatocomeun
grande ospite. Su una
cartina mi mostra il
“suo villaggio”, Hulda,
in terra israeliana.
“Vengodalì”(ineffetti
è suo nonno a esserne
originario,madal1948
lasuafamiglianonciè
più tornata). Appesa
alla parete c’è una
fotografia:“ÈSaid,mio
fratello maggiore, è
stato ucciso a Tsahal”.
Su una televisione in
soggiorno continua ad
andareAlJazeera.
Alla
sede
di
“Haaretz”,aTelAviv,il
giornalistaBennyZiffer
conferma:“Nonappena
il membro di una
famigliaodiunclanha
una parabola, tutto il
quartiere riceve le
televisioni
satellitari
gratuitamente.
I
palestinesi sono al
corrente di tutto, nei
villaggi più lontani e
nei campi palestinesi
più
poveri.
La
Palestina,
geograficamente,
è
un’enclave, ma sul
fronte dei media è
molto
aperta
e
ampiamente
‘connessa’. Le persone
vivono in una specie di
prigione
in
cui
l’informazione
è
incontrollata
e
illimitata.
È
un
paradosso:
la
separazione e il muro
con Israele e dall’altra
partel’accessototaleai
media. E più nessuno
può fermare questa
liberazione
delle
immagini nel mondo
arabo, ormai senza
alcunmuro”.
Secondo
un
sondaggio
del
Palestinian
Central
Bureau of Statistics, il
75 per cento dei
palestinesi di Gaza e
della
Cisgiordania
utilizzerebbeAlJazeera
come prima fonte di
informazione.
La
seconda
emittente
sarebbe Al Manar,
quella di Hezbollah,
che
mostra
di
frequente
i
bombardamenti e le
vittime
palestinesi.
Abbandonando
la
striscia di Gaza, ho
l’impressione assurda
di una guerra mai
terminata
in
cui
l’esercito
israeliano
continuaadistruggere,
con bombe finanziate
dagli
americani,
insediamenti
palestinesi
finanziati
daglieuropei.
A Ramallah il capo
dell’ufficio
di
Al
Jazeera
si
chiama
Walid al Omary. È una
vera star nel network
di Al Jazeera ed è
anche una star in
Palestina. Grazie a una
rete
di
giornalisti
corrispondenti ufficiali
(una trentina) e di
innumerevoli
corrispondentiufficiosi,
ha informazioni molto
precise
su
quanto
accade in tutti i
territori
palestinesi.
Facendo uno dei lavori
più
pericolosi
al
mondo, questo araboisraeliano, nato in
Israele
vicino
a
Nazareth,
che
ha
studiato all’Università
di Tel Aviv, non
abbandona mai i suoi
tre cellulari (uno per i
contatti nei territori
occupati, un numero
israeliano e uno per le
chiamate
internazionali). Deve la
popolarità
alla
copertura che ha dato
della seconda Intifada
in Palestina a partire
dal settembre 2000
(visita di Ariel Sharon
sulla spianata delle
moschee)
e
più
recentemente
alla
Guerra
di
Gaza
(20082009)
in
cui
aveva sei reporter sul
campo, mentre Cnn,
Abc, Cbs e Bbc non ne
avevanoalcuno,pervia
delle restrizioni sui
media
imposte
dall’esercito israeliano.
Così, Al Jazeera è
rimasta
live
per
ventidue giorni per
descriverelasituazione
di Gaza. Non sono
riuscito a incontrare
WalidalOmaryquando
eroinPalestina,mame
ne hanno parlato in
molti. Grazie ai suoi
reportagefaesisterela
resistenza palestinese
nella
quotidianità,
attraverso le immagini,
rendendola
globalizzata
e
mainstream,pertuttoil
mondoarabo.
Nel contempo, Walid
al Omary ha spesso
denunciato,
come
Amira Hass, le derive
dell’Autorità
palestinese, e ciò gli è
costatoalcuneminacce
dal potere in carica a
Ramallah. Essendo un
arabo-israeliano
(dunque è accreditato
da Israele con un
tesserino della stampa
che gli permette di
superare i check-point
nei territori occupati),
ha la possibilità di
verificaretuttiifattidi
cui è a conoscenza con
le autorità israeliane e
con
i
colleghi
giornalisti
ebrei,
secondoilprincipiodel
“fact-checking”
americano, che gli
permette di essere
rispettato, per la sua
deontologia, anche in
Israele. “Walid è un
grande
giornalista,
molto
equilibrato,
molto serio, è un
modello,” spiega il
presentatore di punta
di
Al
Jazeera,
Mohammed Krichen,
intervistato a Doha.
Dima
Khatib,
la
palestinese che dirige
l’ufficiodiAlJazeerain
Venezuela, è ancora
più esplicita: “Walid è
un gigante, è un
fenomeno.Èilsimbolo,
luidasolo,dellanostra
scuola di giornalismo.
Ha problemi con tutti,
ma tutti parlano con
lui.Rappresentalevoci
liberate di Al Jazeera e
della Palestina messe
insieme: ci ha fatto
vedere la Palestina
come
non
la
conoscevamo e l’ha
fattavederealmondo”.
Nel
corso
della
giornata trascorsa con
Amira
Hass
in
Cisgiordania,
siamo
entrati
in
diverse
colonie ebree – gli
accampamenti
dei
coloni israeliani, come
all’epoca dei primi
kibbutz, in cui olivi,
eucalipti,
pomodori
crescono nel deserto.
Una
bandiera
israeliana sventola sul
settlement (si dice
anche outpost). Una
gru Caterpillar. Un
colono
ebreo
con
grosse
mani
da
lavoratoreciriceve.Ha
diversi ventilatori che
fanno
un
rumore
continuonelsuoufficio
di caposquadra di una
stazione radio legata
all’esercito israeliano.
Ascoltandoilcolonoho
l’impressione
di
trovarmiinColoradoin
mezzo agli evangelisti
americani, ma qui si
aggiunge la specifica
mentalitàdell’assediato
assediante.
Contrariamente
a
quanto
potessi
immaginare,
Amira
Hass
ha
buone
relazioni con i coloni e
quello che incontriamo
è anche uno dei suoi
informatori.Anonimo.
Rientrando
a
Gerusalemme,
vedo
giovani
palestinesi
saltare il “Muro”. Se
l’esercito israeliano li
vedesse,
verrebbero
uccisi. “Saltano perché
altrimenti dovrebbero
fare diversi chilometri
per passare da un
check-point. Il muro
separa due quartieri
dello stesso villaggio,
talvolta passa anche
tra le case della stessa
famiglia,”
mi
dice
AmiraHass.
La sera, nelle strade
della vecchia città di
Gerusalemme,sentoun
brano di musica araba
che mi aveva colpito in
Cisgiordania, ma di cui
ignoro il titolo. Nelle
bancarelle
di
alimentari, i venditori
di
vestiti,
tutti
sembrano
ascoltare
questa musica molto
coinvolgente trasmessa
afortevolumedacasse
appese alle vetrine dei
negozi.
Il
suono
riecheggia sulle vie
lastricate di pavé di
Gerusalemme,
così
come
risuonava
a
Ramallah, Betlemme,
HebroneGaza.
Chiedo a uno dei
venditori, Hazem, un
palestinese di Gerico,
di trovarmi la canzone.
Per qualche shekel, mi
vende il cd che ho
sentito dappertutto e
che ho cominciato ad
apprezzare
involontariamente. La
custodiaèinarabo.Poi
ho saputo che era
l’ultimo album di Amr
Diab, distribuito dalla
casa
discografica
Rotana. La rivoluzione
che Al Jazeera è
riuscita a fare per
l’informazione
nel
mondo arabo, la sta
facendo anche Rotana
perl’intrattenimento.
15.
Ilprincipedeimedia
neldeserto
Alle 14 in punto, un
sabato – primo giorno
della settimana in
Arabiasaudita–,arriva
il principe Al Waleed.
La sua leggendaria
puntualità
è
sorprendente.
L’evidente scompiglio
di qualche minuto
prima da parte del
personale
lasciava
presagire il suo arrivo.
Nell’ascensore, le armi
delleguardiedelcorpo
erano visibili sotto le
tuniche bianche. Le
ragazze
della
reception,
di
una
bellezza
da
fotomodelle,senzavelo
né burqa, ma in
pantaloni attillati e
tacchi a spillo, si
agitavano. L’arrivo del
principe
era
annunciato.“Quinonlo
chiamiamoil‘Principe’,
ma il ‘chairman’,”
correggeShadiSanbar,
il suo più stretto
collaboratore.
In
mezzo
alla
gigantesca hall c’è un
immenso
logo
di
Rotana:
un
mappamondo verde, il
colore
dell’islam,
attraversato da una
lettera araba stilizzata.
Il messaggio è chiaro.
MitrovonelregnodiAl
Waleed,
al
cinquantottesimo piano
della Kingdom Tower,
uno dei simboli di
Riyadh,
capitale
dell’Arabia saudita. La
torre di vetro di
novantanove piani di
proprietà del principe
somiglia a un banale
apribottiglie ed è la
sede della Kingdom
Holding Company, la
multinazionale
finanziaria
del
principe. In realtà, il
principe si chiama Al
Waleed bin Talal bin
Abdul Aziz al Saud, è
principe di sangue,
membro della famiglia
reale
dell’Arabia
saudita, è nato nel
1955 ed è uno dei
trentasette nipoti del
fondatore del paese, re
Abdul Aziz al Saud, di
cui porta il nome come
vuole la tradizione. È
dunque
nipote
dell’attualereAbdallah
e,dapartedimadre,è
nipote del primo capo
del governo del Libano
moderno, paese di cui
halacittadinanza.Èun
imprenditore e uomo
d’affari che ha fatto
fortuna con la finanza
internazionale e gli
investimenti
immobiliari, ed è così
diventato uno degli
uomini più ricchi del
mondo. Ha investito
capitali in una serie di
società,diventandouno
degli azionisti di peso
di
News
Corp,
Citybank, Aol, Apple,
Walt Disney, eBay,
PepsicoedEuroDisney.
Al Waleed controlla
inoltre diversi giornali
influenti della regione,
in
particolare
“Al
Hayat”.
È
anche
filantropoesostienegli
studi islamici, per
esempio all’Università
di Harvard, e le arti
islamiche, come al
Museo del Louvre.
Esattamente un mese
dopo l’11 settembre è
andato a New York a
rendere omaggio alle
vittimedelWorldTrade
Center, portando un
assegnodidiecimilioni
didollariperilfondodi
sostegno alle vittime
degli attentati. Le
televisioni di tutto il
mondo
lo
hanno
mostrato
mentre
camminava
tra
le
macerie accanto al
sindaco di New York
(ma un comunicato
stampa in cui Al
Waleed criticava la
politica
americana
verso i palestinesi non
è piaciuto al sindaco
chehadunquerifiutato
l’assegno).
“Al Waleed è un
uomo
straordinariamente
atipico,
anticonformista.
Fa
partedell’élite,manon
è solo un ereditiere,
suo padre era troppo
liberale
e
non
abbastanza ricco, era
chiamato il ‘Principe
rosso’.
La
sua
discendenza gli ha
permesso di avere una
rete di relazioni e
un’ottima
posizione
sociale, ma la sua
fortuna, Al Waleed, se
l’è costruita quasi da
solo. Ha studiato negli
Stati Uniti e gestisce il
suo
business
‘all’americana’. Al di
sopra di tutto mette la
cultura dei beduini. In
affari è un nomade,
nonèuncapitalistache
accumula.
Succede,
peraltro, ancora che
vada a dormire nella
sua tenda nel deserto
insieme ai beduini, per
trovare la calma. Per
meditare prima di
prendere
decisioni
importanti. Il deserto
non mente, il deserto
non
lo
tradisce,”
precisa, con una certa
passione,ilsuobraccio
destroShadiSanbar.
Al
Waleed
è
l’immagine
progressista
del
regime. Il re Abdallah
lo protegge, ma non lo
ha mai nominato suo
erede. In ogni caso
sembra
aver
autorizzato nel 2008 la
banca reale a coprirne
idebitiperproteggerlo
dalla crisi finanziaria
mondiale in cui Al
Waleed avrebbe perso
miliardididollari(circa
21 miliardi di perdite
nel
2008
secondo
diversianalisti,ecosìè
precipitato dal quinto
al ventiduesimo posto
nella classifica degli
uomini più ricchi al
mondo).
Circondato da un
nugolo di consiglieri e
guardie del corpo, Al
Waleed arriva. Indossa
il thobe, la tunica
bianca tradizionale in
Arabia saudita, e porta
lo shmaikh, una sorta
di kefiah a quadretti
rossi. Ha baffi e grossi
occhiali,
fatica
a
nascondere i suoi tic,
ma ha un’aura che il
cerimoniale che lo
accompagna accresce
ulteriormente. Tutti i
sabati,quandononèin
viaggio, arriva verso
mezzogiorno
nella
torre di sua proprietà,
fa
la
preghiera,
presiede le riunioni,
lavora con banchieri,
avvocati,
consulenti
finanziari, fin verso le
duedinotte,poidorme
tutta la mattinata –
come spesso i principi
di sangue sauditi. Al
sessantaseiesimo piano
c’è la sede della
multinazionale,
la
società
madre;
al
cinquantottesimo
quella
di
Rotana.
Infatti, il sabato alle
14, il principe viene a
presiedere il consiglio
di amministrazione del
suo gruppo media,
Rotana. Arriva e si
siede a capotavola, più
che
presiedere,
troneggia
fra
i
direttori.
Cala
il
silenzio. Comincia la
riunione. L’espressione
“factum principis” non
mi è mai parsa tanto
azzeccata come in
questomomento.
Rotanaèstatacreata
nel 1987. È il gruppo
media
e
intrattenimento di Al
Waleed. “Il principe
detiene il 95 per cento
della
casa
madre,
Kingdom
Holding
Company, una società
parzialmente quotata
in Borsa, ma Rotana è
interamente di sua
proprietà,èsuodenaro
personale. Il principe è
sempre
stato
affascinato dai media,”
mi
spiega
al
sessantaseiesimo piano
della
torre
Shadi
Sanbar,
direttore
finanziario e numero
due
della
multinazionale.
Al Waleed è il
capitanod’industriadei
media
arabi.
Il
magnate
australoamericano Murdoch ha
investito
da
poco
diverse
decine
di
milioni di dollari in
Rotana e detiene ora il
20 per cento del
capitale del gruppo
saudita. “Il principe ha
investito in News Corp
attraverso
la
sua
Holding Company e
adesso
Murdoch
investesuRotana:sono
partecipazioni
incrociate
e
intelligenti. Per noi si
tratta
di
un
investimento
puramente finanziario,
mentre per Murdoch
ha una valenza più
strategica
e
geopolitica. In questo
modo
potrà
raggiungere
un
mercato di 350 milioni
di arabi,” commenta
Sanbar.
Anche
gli
americani di Sony
CorporationofAmerica
hanno firmato, nel
giugno
2008,
un
contratto esclusivo con
Rotana
per
la
distribuzionedeifilmdi
Sony, Columbia, Metro
Goldwyn Mayer e dei
dischiSonyMusic,Cbs,
Artista ed Epic per
tuttoilmondoarabo.
Rotana è strutturata
attorno a sei divisioni.
Ladirezionegeneralee
finanziaria del gruppo
è a Riyadh, ma le
attività sono suddivise
in diversi quartier
generali: il settore
cinema è al Cairo, la
musica
e
il
management
degli
artisti a Beirut, le
televisioni e le radio
trasmettono dal Golfo,
mentre la divisione
internet è ripartita
nellamaggiorpartedei
paesi
arabi
dal
Marocco alla Siria. Il
gruppo è frazionato in
tutto il mondo arabo e,
con
questo
vasto
impero, Al Waleed
punta alla riconquista
delmondomusulmano.
Rotana
possiede
studicinematograficial
Cairoeinquestomodo
controlla il 50 per
cento del catalogo
cinematografico arabo.
Nella
musica
la
supremazia è ancora
maggiore: quasi il 90
per cento della musica
mainstream
commercializzata nel
mondo
arabo,
dal
Marocco alla Siria,
sarebbe nelle mani di
Rotana. “È vero, siamo
in
posizione
monopolistica
nella
musica,”
conferma
ShadiSanbar.Rotanaè
nelcontempopromoter
eagenziaditalentiesi
è specializzata in due
settori
che
contribuiscono
a
questo
monopolio.
Anzitutto internet: il
gruppo ha investito
milioni di dollari in siti
ultramoderni
e
nell’Iptv, la televisione
via internet. “Secondo
noi, cultura, musica,
film, televisione, libri
devono
diventare
interamente
digitali.
Tutto
cambierà
completamente. È ciò
che
chiamo
‘telecotainement’, un
insieme
di
telecomunicazioni
e
intrattenimento.Nonci
saranno più dischi, né
libri, né giornali, né
televisione, ma solo
schermi collegati a
internet.Pernoiilweb
non costituisce una
minaccia,
è
un’opportunità.
Coglieremo
tutte
queste opportunità, ne
abbiamo
i
mezzi.
Deteniamo i diritti su
tutti i contenuti di
intrattenimento
e
media, su tutte le
piattaforme, per tutti i
paesi.
Dunque
prepariamo il futuro.
Qui sono l’uomo della
cultura
araba
del
futuro,” dice Youssef
Mughrabil,
direttore
incaricato dei “nuovi
media” a Rotana (ho
saputo poi che questo
saudita, che porta la
cravattaenonlathobe,
ha studiato ingegneria
all’Università
del
Coloradoelavoratoper
trent’anniperilcolosso
americano
di
telecomunicazioni
At&TnegliStatiUniti).
Infine
c’è
la
televisione.
Rotana
possiede oltre venti
emittenti
che
trasmettono
soprattutto
via
satellite. Ufficialmente
sono vietate in molti
paesi, tra cui l’Arabia
saudita (dove sono
ufficialmente
autorizzati solo i due
canali
pubblici
in
frequenze hertz Saudi
1 e Saudi 2) e sono
accessibili
a
tutti
tramite
parabole
acquistate
a
buon
mercato in tutti i paesi
arabi e in Iran. Sono
soprattuttoemittentidi
cinema arabo e di
musica in cui gli artisti
prodotti da Rotana
passano
continuamente.
La
priorità di Rotana è il
divertimento
mainstream: Al Waleed
sa che le principali
trasmissioni
di
intrattenimento e i
format dei programmi
di successo nei paesi
arabi sono importati
dagli Stati Uniti. Per
esempio, la versione
araba di Chi vuole
essere
milionario?
presentata da una sex
symbol libanese ha un
pubblico enorme in
tutto il mondo arabo e
tutti
conoscono
la
celebre frase “Jawaab
nihaa’i?” (è la tua
risposta definitiva?). Al
Waleed
vuole
interrompere
questo
monopolio americano.
In Egitto ha creato in
poco
tempo
un’emittente di cinema
insieme
a
Rupert
Murdoch,pertestareil
mercatoeammansireil
miliardario: Fox Movie
trasmette,
essenzialmente,
ventiquattro ore su
ventiquattro
in
versione
originale
sottotitolata, i film
prodotti dalla major
hollywoodiana di sua
proprietà,
20th
Century
Fox.
Per
ammissione
stessa
degli
egiziani
che
dirigono per Rotana
l’emittente dal Cairo,
dove li ho intervistati,
per loro si tratta
soprattutto di “inserire
pubblicità tra i film
inviati da Murdoch”.
Ma questo è stato
l’inizio di una strategia
rivoltaatuttoilmondo
arabo e su tutti i
supporti
mediatici
eccezionalmente
ambiziosaecomplessa.
Da quel momento, il
principe ha aggiunto
diversi gioielli al suo
impero: oltre a Rotana
possiede, infatti, a
titolo
personale,
l’emittente satellitare
libanese
Lnb,
specializzata in talkshow popolari, sul
modello americano, e
un’emittente
inglese
poco nota, Al Reselah,
destinata ai musulmani
di tutto il mondo.
“Stiamo
lavorando
anche
per
creare
un’emittente
di
informazione non stop,
ma è probabile che il
principe la finanzierà
con denaro proprio, al
di fuori di Rotana,”
confessa
finalmente,
dopo che gli ho fatto
più volte la domanda
senza avere risposta,
Fahad Mohammed Ali,
direttore generale di
Rotana (l’unico uomo
che indossa la thobe
incontrato nello stretto
entourage del principe
aRiyadh).
“La
mission
di
Rotana
è
l’intrattenimento,”
precisa Shadi Sanbar.
“Ormai Rotana è un
gruppo
interamente
assestatosuldigitale,è
in pieno sviluppo e sta
diventando sempre di
più
internazionale.
Prima si va alla
conquista del mondo
arabo poi… the sky is
the limit (il limite è il
cielo).” Rotana è un
gruppo
globale,
planetario. Il nuovo
mondo non ha confini.
“Me lo lasci dire
ancora
una
volta,
affinché sia chiaro,”
prosegue, “Rotana si
svilupperà in tutto il
mondo.” Mostro il mio
stupore per obiettivi
che vanno ben oltre il
mondo arabo. “La
nostra
filosofia
è
difendereivaloriarabi.
Il nostro obiettivo è di
tipo panarabista. Il
principe crede nelle
potenzialità
della
demografia, la chiave
nel
settore
dell’intrattenimento. I
giovani con meno di
venticinqueannisonoil
60 per cento della
popolazione in Arabia
saudita,quelladimeno
diquindicianniquasiil
40 per cento. La
maggiorpartedeipaesi
arabi ha statistiche
simili. Questi giovani
consumano
–
e
consumeranno
–
anzitutto
intrattenimento,
più
delle news. Questo è il
settore di Rotana.
Abbiamo
il
futuro
davanti a noi, nel
mondo
arabo,
ma
anche oltre,” precisa
Sanbar, che non mi
dicepiùnient’altro.
C’è però qualcosa
che stona, da quando
sono in Arabia saudita.
Mi trovo di fronte a un
paradosso: i sauditi
sono onnipresenti nei
media, ma i media in
Arabia saudita sono
assenti.
I
più
importanti gruppi del
settore audiovisivo del
mondo arabo – Rotana,
Orbit,Art,Mbc–hanno
la loro sede sociale a
Riyadh, ma nessuna
emittente
trasmette
dall’Arabia saudita. È
una situazione che mi
ricorda quelle delle
radio
“periferiche”
francesi (Rmc, Europe
1,
Rtl)
che
trasmettevano
da
Montecarlo,
dalla
Germania
o
dal
Lussemburgogiacchéil
monopolio di stato
impediva loro di farlo
dal territorio francese.
Qui il ruolo dello stato
è
ulteriormente
appesantito
dalle
questioni
politiche,
religiose, dei costumi.
Èungrandeparadosso:
pressoRotanaaRiyadh
sono nella sede di uno
dei principali gruppi
media
arabi,
specializzatoincinema,
musica, televisione, ma
in Arabia saudita non
esiste una sala per
concerti, poiché film e
musica non religiosi
sono vietati. “È un
territorio nel contempo
medievale
e
postmoderno,” afferma
il
regista
Ahmed
Dakhilallah,
che
intervisto sotto la sua
tenda a Riyadh, io
stesso
stupito
di
trovarmi seduto su un
tappeto a piedi nudi a
mangiare datteri, di
fronte a un cineasta in
un paese in cui il
cinema non esiste.
“L’Arabia saudita ha
l’accortezzadirifiutare
al proprio interno ciò
che diffonde altrove,”
mi dice il giorno dopo
con
un’espressione
enigmatica
la
realizzatrice di punta
della
televisione
saudita, Hiyam Kilani
(una donna senza velo
né sposata, che mi
riceve in jeans in casa
sua, alla presenza del
fratello). Suo fratello è
giustamente
più
circospetto, è stato
rappresentante
di
televisionioccidentalia
Riyadh, e in un
francese
perfetto
formula
un’altra
ipotesi: “Qui il rischio
nonètantoquellodiun
ritorno al passato,
verso
emittenti
retrograde, ma quello
di
un’evoluzione
all’americana:
telepredicatori
che
vogliono modernizzare
le televisioni arabe in
nomediAllahapartire
dall’Arabia
saudita”.
Bisognainterpretarein
questo senso le voci
secondo cui i sauditi
vorrebbero riportare i
gruppi di media in
Arabia
saudita
piuttosto che lasciarli
trasmetteredaDubaie
Abu Dhabi? Sembra
che l’intento sia quello
di portare le sedi di
Rotana, Mbc, Art e i
loro studi alla King
Abdallah
Economic
City, una nuova città a
norddiDjedda,sulMar
Rosso, dove ha appena
aperto un’importante
Media City. I sauditi
hanno
lasciato
intendere – non ne
esistono prove – che la
città sarebbe come
Dubai,unazonafranca,
in termini fiscali e di
“lifestyle”.
Peraltro,
quest’ultimo termine è
equivoco ed è oggetto
didibattiti.
L’Arabia è un paese
rigoroso in cui la
religione
è
una
questione di stato: è il
paese
del
pellegrinaggio a La
Mecca, unica forma di
turismoconsentita,ein
cui negozi e uffici
chiudono cinque volte
al giorno per la
preghiera. È il paese
della moutawa, polizia
religiosa,odeicostumi
(il vero nome è
“Comando
per
la
repressione del vizio e
la promozione della
virtù”) con novemila
agenti,sostanzialmente
chierici barbuti. Non
sono armati e agiscono
in tutto il paese con
azioni di forza, molto
visibili, con megafoni
alla mano, che mi
ricordano stranamente
i metodi usati negli
Stati
Uniti
dall’associazione gay
che lotta contro l’Aids,
Act Up. A Riyadh ho
incontrato gli agenti
della moutawa mentre
controllavanoledonne,
la lunghezza del loro
velo, impedivano loro
di
guidare
e
verificavano
che
fossero proprio con il
marito
quando
uscivano di casa (cosa
che fanno raramente).
La delazione, mi si
dice, è la principale
fonte di intervento di
questa
polizia
dei
costumi. “Tuttavia, la
moutawa non entra
negli uffici di Rotana.
Qui il principe è
bendisposto, questa è
un’oasi rara. Le donne
sono
tutte
delle
bombe,”
mi
dice,
visibilmente
infiammato, il mio
accompagnatore
e
traduttore
che,
al
sessantaseiesimo
piano,mimostraanche
la moschea personale
delprincipe.
Mentre
lascio
il
regno di Al Waleed,
passo all’ufficio di
Shadi Sanbar, posto
proprio di fronte alla
moschea. Questi mi
ringrazia della visita e
mi regala un bel sacco
inpelleverde,ilcolore
dell’islam,
con
il
marchiodiRotana.
A pianoterra della
torre del principe Al
Waleed, in un bar
Starbucks,
apro
il
sacco di cuoio e vi
trovounatazzaRotana,
una penna stilografica
Rotana,
un
report
annuale del gruppo, la
biografiainarabodiAl
Waleed del giornalista
Riz Khan e soprattutto
decine di copie di
riviste americane come
“Time”, “Newsweek”,
“Vanity
Fair”,
“Forbes”,
con
copertine contraffatte.
Inquestefotografiec’è
Al Waleed in vestito o
maniche di camicia,
noninthobe.Suqueste
primepaginerealizzate
con Photoshop, si vede
il principe a bordo di
uno yacht privato di
ottantasei metri, al
volantediunadellesue
trecento auto, a bordo
di un Boeing 747
trasformato in aereo
privato (nel 2010 ha
ricevuto l’Airbus A380
che ha ordinato). La
megalomania
del
principe è evidente.
Poi, all’interno del
sacco verde scopro un
portadocumenti
più
piccolo,
anch’esso
verde, una sorta di
pochette
di
lusso.
All’interno del bar
Starbucks
apro
la
pochette
che
si
dispiega e scopro, con
grande stupore, che si
tratta di un magnifico
tappeto portatile da
preghiera.
Musica
in
Libano,
televisione a Dubai,
cinemaalCairo
Il Rotana Café di
Damasco
si
trova
all’interno del Four
Seasons,
uno
dei
complessi alberghieri
piùlussuosidellaSiria.
Peraltro, non è un
semplice albergo, ma
un resort, un luogo di
villeggiatura di lusso,
di
turismo
internazionale d’élite
che, su diciotto piani,
propone decine di
ristoranti alla moda,
ristoranti
up-scale,
piscineeterme,oltrea
ostentate
gallerie
commerciali e molti
negozidimoda.L’hotel
appartiene al principe
AlWaleed(èl’azionista
di riferimento degli
alberghi Four Seasons
ed è proprietario del
George V a Parigi) e,
naturalmente, al suo
interno ha aperto un
RotanaCafé.
Il Rotana Café di
Damascoèsutrepiani,
poiché
comprende
anche un negozio di
dischi in stile Virgin
Megastore per ricchi a
pianoterra e, al primo
piano,
un
caffèristorantecondecinedi
schermi che proiettano
in
continuazione
videoclip di Rotana Tv,
infine c’è un immenso
lounge
bar
con
terrazza con vista sulle
moschee, il parco e il
centro
storico
di
Damasco. Vi si fuma il
narghilè,
ma
le
bevande alcoliche sono
vietate,cisonococktail
di frutta, chiamati
Mocktails, tra cui il
famoso
Nojito
(un
imbevibile
“Nonalcoholic Mojito”,
incuiilrumèsostituito
dalla Schweppes). Qui
si possono incontrare
tutte le star di Rotana,
dalvivoovirtualmente.
Infatti,ilprincipeinvita
regolarmente le sue
star a soggiornare nei
suoi alberghi e a
partecipare a serate
nei Rotana Café per
incontrare i fan. Si
possono
anche
comprareicdevedere
i video dell’egiziano
superstar Amr Diab, di
Angham o Sherin, due
cantanti sexy egiziane,
dell’irachenoMajid,del
siriano
George
Wassouf, dei sauditi
Abu Baker Salim e
MohammedAbdo(sulle
copertine degli album
che acquisto entrambi
portano una kefiah
sulla testa), o la
tunisina
Latifa,
la
siriana Assalah e la
libanese Elissa. Tutti
questi artisti sono
grandi star nel mondo
arabo e i loro album
sono stati registrati in
Libano.
A Beirut, il Rotana
Café si trova sulla
piazza de l’Etoile, nel
quartiere cristiano, al
pianoterra
di
un
edificio
moderno.
Quattro piani sopra ci
sono gli uffici di
Rotana. “Rotana ha
stabilito
il
settore
musicale qui a Beirut,”
conferma
Tony
Semaan,direttoreA&R
di Rotana Music, che
mi riceve nel suo
ufficio
un
sabato
mattina. Semaan ha
trentadue anni e, mi si
dice, è uno dei più
grandi scopritori di
talenti del mercato
della musica araba.
Mentreuncameriereci
porta un tè in un
coffee-mug
firmato
Rotana
e
Semaan
termina
una
conversazione
telefonica
con
un
manager in Egitto,
osservo il suo ufficio
che fa angolo. Su una
mensola, ben in vista,
c’è la biografia in
versione americana di
Al
Waleed,
Businessman
BillionairePrince.
“Rotana è un gruppo
mainstream. Il nostro
obiettivo
è
la
popolarità.ConRotana,
AlWaleedvuolecreare
un
colosso
dell’intrattenimento
per tutto il mondo
arabo e per tutto il
mondo. E vuole farlo a
qualsiasi costo. Si
tratta di un progetto
economico, ma anche
politico,” commenta in
francese Tony Semaan.
Perraggiungerequesto
obiettivo, il gruppo
saudita ha collocato il
quartier generale della
musica a Beirut, quello
delcinemaalCairoele
emittenti televisive a
Dubai. “Beirut è la
capitale della musica
araba, tutti i media
arabi hanno qui uffici
per
la
produzione
musicale,
studi
di
registrazione e per
girare videoclip, siamo
i leader in questa
zona,”
commenta
Semaan. La strategia,
indicata
dal
mio
interlocutore,
è
semplice: in tutto il
mondo si pensa alla
musica
araba
con
donne con il velo e
uomini con la kefiah,
Rotana invece produce
video con ragazze sexy
e poco coperte, come
su Mtv. Naturalmente,
non avendo il diritto di
filmare le ragazze a
Riyadh,perladivisione
musicale del gruppo è
statasceltaBeirut.
Rotana
ha
sotto
contratto
circa
centotrenta star della
musica araba; per ogni
album,
gli
artisti
ricevono un flat fee,
una cifra forfettaria,
raramente hanno una
percentuale
sulle
vendite. Poi la major
adatta la musica a
versioni e piattaforme
diverse:
cd,
dvd,
videoclip, programmi
televisivi,
prodotti
derivati,
contratti
pubblicitari e persino
le tazze per il caffè.
Rotanasioccupaanche
del management e
ovviamente
dei
concerti
di
questi
artisti, secondo una
strategia
detta
a
“trecentosessanta
gradi” (Tony Semaan
lascia intendere che
questa
modalità
è
tipicadiRotana,invece
è la strategia in voga
nella maggior parte
delle
case
discografichedituttoil
mondo, dopo essere
stata quella di tutte le
agenziedipubblicità).
Icantantivengonoda
tutto il mondo arabo,
dal Maghreb all’Iraq,
ma mai oltre. Per
essere scritturato, un
artista deve avere un
“forte potenziale nel
mondo arabo”, ovvero
deve
poter
avere
pubblico in diversi
paesi.Rotanapersegue
questa
strategia
crossover
facendo
cantare le star in
egiziano, che è il
dialetto che permette
diesserecapitiintutto
il mondo arabo. “È un
accento
facile
da
imparare e facciamo in
modo che i cantanti
libanesi, siriani e dei
paesi del Golfo cantino
in dialetto egiziano per
raggiungere
tutti,”
spiegaTonySemaan.
Per
il
momento
Rotana non ha ancora
la dimensione globale
che ha in progetto di
raggiungere. Le star
del
gruppo
non
vendono quasi niente
in Asia, nulla in
America
latina
né
nell’Africa
subsahariana,
poco
negli
Stati
Uniti.
Tuttavia,ilgruppodiAl
Waleed è andato ben
oltre
le
proprie
aspettative nella zona
al centro del suo
obiettivo,
la
zona
chiamata da Rotana
“MenaRegion”(Middle
East North Africa). Qui
i
risultati
sono
eccezionali. Secondo i
dati forniti dal gruppo,
e
impossibili
da
verificare,
le
centotrenta star di
Rotana
coprirebbero
l’85 per cento della
musicavendutaintutto
il mondo arabo. I
risultati
sono
in
crescita nel Maghreb,
grazie a star come la
tunisina
Latifa,
la
marocchina
Laila
Ghofran,
l’algerina
Amel Bouchoucha e
Thekra, una tunisina
trasferitasiinLibia,poi
in
Egitto,
e
recentemente uccisa in
circostanze sospette.
“Adesso,
il
nostro
obiettivo è il mercato
maghrebino in Europa,
soprattutto in Italia,
Spagna e Francia. In
campo
musicale,
costruiamo
concretamente
l’Unione
per
il
Mediterraneo cara al
presidente Sarkozy,”
mi dice sorridendo
TonySemaan.
Gli
obiettivi
del
gruppo, tuttavia, non
finiscono
qui.
Gli
album, nell’epoca della
pirateria di massa,
nella
strategia
di
Rotana non sono più
una priorità, ma uno
strumento
di
promozione, la priorità
è la televisione. In
questo settore, con
diverse
emittenti
televisive
musicali,
Rotana è leader nei
paesi
arabi.
Sul
modello di Mtv, il
gruppo ha inventato il
videoclip arabo di tre
minutietrenta.“Prima,
le televisioni egiziane
trasmettevano canzoni
egiziane che potevano
durare anche trenta o
quarantaminuti.Erano
lunghi poemi senza
fine,” spiega Semaan.
“PoisulmodellodiMtv
e dei videoclip, Rotana
si è assestata sul
formato di tre minuti e
trenta.” Tuttavia, il
successo del gruppo
non è dovuto solo a
questo nuovo format,
ma anche alle belle
ragazze che figurano
nei videoclip, al loro
scarno vestire rispetto
agli usi del mondo
musulmano,
alla
sensualità del loro
linguaggio. Per molti
questa è la rivoluzione
che Rotana ha fatto
compiere
all’intrattenimento
arabo.Ilrisultatoèche
quattro delle emittenti
di Rotana sono tra i
dieci
canali
più
guardati nella regione
araba. Di fronte a
questo colosso saudita,
sul fronte musicale,
l’americana
Mtv
scompare.
Sul Monte Libano,
nel
quartiere
Naccache, periferia a
nord di Beirut, la sede
di Mtv è faraonica. Ci
sono una decina di
edificinuovifiammanti,
sedici studi televisivi,
bar e un servizio di
sicurezza senza pari.
Alla reception, cinque
ragazze in stile top
model rispondono al
telefono
e
accompagnano
gli
invitati in studio. Il
logo di Mtv – blu e
rosso – non lascia
comunque
alcun
dubbio.
Il
nome
dell’emittente non ha
proprio alcun legame
con
l’omonimo
americano:
Murr
Television (più nota
come Mtv in Libano) è
una delle principali
emittenti generaliste
dei cristiani libanesi.
“Non ha alcun legame
con il gruppo Viacom
che possiede Music
Television (Mtv) negli
Stati Uniti,” conferma
Michel
Murr,
amministratore
delegatodelgruppo.
Michel
Murr
è
visibilmente contento
di poter incontrare un
francese e mi riceve,
disteso e accogliente,
nella sede del gruppo
insieme alla moglie,
Pussy,
un
sabato
pomeriggio. Nel corso
della nostra lunga
intervista
risolve
alcune questioni per
telefono
con
un
ministro
(la
sua
famigliaèalcentrodel
potere
cristiano
libanese, suo zio, che
ha il suo stesso nome,
Michel Murr, era il
ministro dell’Interno e
uno degli uomini di
fiducia dell’ex primo
ministro Rafik Hariri,
assassinato). Il mio
interlocutorenonvuole
parlare
troppo
di
politica. Mi ripete più
volte che la sua
emittente è “neutra”,
ma so che fa parte dei
“cristiani
sunniti”:
secondo la battuta
frequente a Beirut, la
minoranza cristiana si
è frazionata nel 2009
tra “cristiani sunniti”,
antisiriani, e “cristiani
sciiti”, filo-Hezbollah.
In
Libano,
ogni
emittente televisiva è
legata a un partito
politico e questo ne
riduce
molto
l’imparzialità.
“Quiabbiamounodei
più
importanti
complessi
di
produzione del settore
audiovisivo del Vicino
Oriente,”
mi
dice
MichelMurr.“IlLibano
costituisce la frontiera
del mondo arabo, per
questo
vengono
registrati i programmi
televisivi più moderni
dellaregione.Ledonne
sono
libere,
la
strumentazione tecnica
è
molto
avanzata
rispetto agli altri paesi
arabi.
L’intrattenimento è la
nostraprofessione.”
Pussy Murr mi fa
visitare gli studi del
gruppo,
chiamati
“Studiovision”, il mio
intento è seguire le
registrazioni di Rotana
Café, la trasmissione
culturale di punta di
Rotana Moussica, una
delle
emittenti
di
Rotana. La scenografia
del talkshow è celebre
intuttoilmondoarabo:
unbanconedabar,una
finta libreria piena di
volumi
e
lattine
Rotana, imitazioni di
Coca-Cola.
Il
programmaèindiretta
ed è condotto da un
gruppo
di
giovani
intrattenitori
che
discutono liberamente
tra loro della scena
musicale,
di
televisione,
di
intrattenimento e di
tutto ciò che fa il buzz
delmomento.
Spesso gli argomenti
dei
giovani
intrattenitori suscitano
polemicheneipaesidel
Golfo, in Egitto e in
Arabia saudita. Nel
2009iltalk-showLinea
rossa
sull’emittente
libanese Lbc, di cui
ormai il principe Al
Waleed è azionista di
maggioranza,
ha
scatenato una forte
polemica: un giovane
saudita, Mazen Abdel
Jawad,
descriveva
comeusavailbluetooth
per rimorchiare le
ragazze saudite velate
negli
shopping-mall
non potendo parlare
direttamente con loro
(è stato condannato a
cinqueannidiprigione,
mille
frustate
per
“condotta immorale” e
l’emittente Lbc è stata
minacciata
di
oscuramento in Arabia
saudita).
“È nei talk-show
registratiaBeirutdalle
emittenti televisive di
Rotana, Mtv, Lbc o
Mbcchec’èlamaggior
libertà. Nel mondo
arabo,ciòcheigiovani
sidicono,ecidicono,è
completamente
incredibile.
Con
il
pretesto di parlare tra
loro, di evocare i
rumors e i pettegolezzi
della televisione, di
descrivere la loro vita
quotidiana, affrontano
le
questioni
della
droga,
della
prostituzione, dei gay,
della vendita delle
donne irachene, di
lesbiche e transessuali.
Per un uomo della mia
generazione
è
completamente
inverosimile intendere
tutto ciò. Sono loro,
questi animatori di
talk-show che non
hanno
neanche
venticinque anni, che
contribuiranno
all’apertura dei paesi
arabi,”
afferma
il
produttore di serie
televisive
Makram
Hannoush, un libanese
intervistatoaDamasco.
Questi
talkshow
mandati in onda in
Libano, Qatar e più
raramente
negli
Emirati vanno oltre il
semplice divertimento:
stanno intaccando le
fondamenta stesse del
mondo arabo. Sono
fonte di inquietudine
per l’establishment di
paesi come l’Arabia
saudita,l’IranelaLibia
e sono causa di
sconvolgimento sociale
per
le
famiglie
patriarcali.
Infatti,
mettono in discussione
l’ordine familiare, la
separazione tra generi,
scompaginano
la
divisione del lavoro e
mettono in discussione
il
codice
d’onore.
Portandosulloschermo
non solo donne senza
velo,
ma
semplicemente
delle
donne,questitalk-show
di Al Jazeera e Lbc, i
programmi di Mbc, i
videoclip di Rotana
chiudono
con
la
tradizione che confina
la donna nello spazio
privato
e
riserva
all’uomo lo spazio
pubblico.
Questa
rivoluzione in corso è
unfattoimportante.
“The Arab Warren
Buffett”
è
il
soprannome dato dal
“Time” al principe Al
Waleed. “Il principe Al
Waleed
vorrebbe
piuttosto diventare il
Murdoch del Medio
Oriente,”
corregge
Frederic Sichler. “Più
che Warren Buffett, il
suo
modello
è
Murdoch, peraltro è il
secondo azionista più
importante di News
Corp,
il
gruppo
multimedia
di
Murdoch.” L’ufficio di
Frédéric Sichler si
trova nell’Hotel Four
Seasons del quartiere
Garden City del Cairo,
un magnifico palazzo
sulle rive del Nilo.
Sichler
è
stato
direttore di Studio
Canal,ladivisionedella
produzione di cinema
dell’emittente francese
Canal +, ed è stato
chiamato dal principe
saudita a presiedere la
divisione cinema di
Rotana. “Rotana è un
gruppo nato per fare
musica araba, datosi
poi alla televisione e
attualmente indirizzato
verso il cinema,” dice
Sichler.
NeipaesidelGolfo,il
problema non è il
denaro, ma il talento.
In Egitto è il contrario.
I primi hanno banche,
capitali, reti satellitari,
ma sono privi di
creatività.
Le
innumerevoli emittenti
e la loro miriade di
programmi, insediate a
Dubai, Abu Dhabi, nel
Qatar, hanno bisogno
di contenuti. I principi
dei paesi del Golfo e i
loro uomini di fiducia,
per
i
film,
si
approvvigionano
al
Cairo. In effetti, in
Egitto,esistonotuttele
tecnicheelepossibilità
perprodurreedisporre
dicontenutidelsettore
audiovisivo:
coproduzioni,
prelazionidifilmperle
televisioni del Golfo,
joint-venture,
produzioniproprie.
“Rotana
è
una
societàrivoltaatuttoil
mondo
arabo.
Ci
interessiamodituttele
cinematografie arabe,
poiché se la musica
attraversa
tutti
i
confini di questa zona,
la cinematografia è
invece molto legata ai
diversi
contesti
nazionali,”
prosegue
Frédéric Sichler. “Nel
cinema,
infatti,
contrariamente
alla
musica, i profitti si
fannopersingolipaesi,
e in ciascuno dei paesi
arabi
ci
sono
regolamentazioni
precisechenecessitano
dipermessiassegnatia
livello locale.” Come
tutti gli altri gruppi di
media
nel
Medio
Oriente, Rotana cerca
di agire sul mercato
arabo
globale
sul
fronte
della
produzione,
mentre
lavora sui mercati
nazionali
per
la
distribuzione. “L’Egitto
continua a essere il
fulcro della produzione
cinematografica,”
prosegue Sichler. “È
l’unico paese arabo in
cui esista un’industria
cinematografica, ben
oltre gli altri tre
produttori del mondo
arabo: Siria, Libano e i
paesi del Golfo.” Poi
aggiunge: “In Egitto
esiste
una
diffusa
cultura
cinematografica, ogni
anno si vendono tra i
venti e i trenta milioni
di biglietti, mentre in
Marocco meno di due
milioni. Gli egiziani
fanno commedie e
intrattenimento
da
sempre, è un cinema
che funziona in tutto il
mondo arabo, mentre
nonhanessunapresail
cinema
d’autore
marocchino.Perquesto
Rotana ha insediato il
suo quartier generale
dicinemaquialCairo”.
Ci sono altre ragioni
che fanno del Cairo il
fulcro del cinema del
mondo arabo. In Egitto
c’è una ricca creatività
grazie a una lunga
tradizione nel settore
audiovisivo,
esistono
un grande vivaio di
sceneggiatori, attori e
registi e una cultura
artistica, letteraria e
del divertimento di
vecchia data. “Il Cairo
è la Hollywood del
mondo arabo per il
cinema
e
la
televisione,” conferma
Mohammed Mouneer,
direttoremarketingdel
gruppo
Rotana
al
Cairo. L’Egitto è anche
l’unico grande paese
arabo:
con
una
popolazione
di
75
milioni di abitanti è il
primo mercato arabo
del pianeta (di cui 17
milioni al Cairo, che è
al contempo la più
grande città araba al
mondo e la città
africana più popolata).
Il paese ha un’enorme
diversitàetnicaemolta
immigrazione
proveniente da tutti i
paesi arabi. “L’Egitto è
una società eterogenea
e multietnica come gli
Stati Uniti,” afferma
Hala
Hashish,
direttricediEgyptNew
Channel,intervistataal
Cairo. “È l’unico paese
arabo in cui si possono
incrociare tanti siriani
quanti
marocchini,
libanesi o libici. È una
società
cosmopolita,
più
aperta
e
diversificata,
anche
perché è uno stato
pacifico. Poi qui si può
girare un film o un
teleromanzocondonne
senzavelo,cosainvece
impossibile a Riyadh o
Teheran.” Inoltre, al
Cairo sono presenti
tutti
i
network
televisivi
mondiali,
personale
tecnico
efficiente,
c’è
la
coperturadeisindacati,
esiste una censura
limitata sui costumi
(rispetto al resto del
mondoarabo)esiparla
una lingua usata in
diversi paesi arabi e
compresainquasitutti.
“Due
arabi
di
nazionalitàdiverse,per
potersi capire, devono
utilizzare il dialetto
egiziano,”
spiega
Youssef Osman, che
dirige la produzione di
Media City vicino al
Cairo. “È un circolo
virtuoso,”
conferma
Hala Hashish, “i film
sono girati in egiziano,
i cantanti prendono
l’accento egiziano, i
nostri media sono i più
potenti nel mondo
arabo, e ciò rafforza la
musica e il cinema
egiziani.”
Infine, per capire il
ruolodecisivodelCairo
rispetto a Dubai, Abu
Dhabi, Beirut nelle
industrie creative, è
necessario aggiungere
lapresenzadibanchee
una
valuta
relativamente sicure.
Infine,
l’Egitto
ha
relazioni diplomatiche
con la maggior parte
dei paesi arabi, con gli
Stati Uniti, l’Europa e
Israele
e,
commerciando
con
Israele,
l’Egitto
si
garantisceladiffusione
dei
contenuti
in
PalestinaeGiordania.
La
strategia
multimedia, rivolta a
tutto il mondo arabo,
del gruppo Rotana con
le sue filiali di Riyadh,
Dubai, Beirut e Il
Cairo, sembra mietere
successi e non avere
punti deboli. Tuttavia,
diversi
miei
interlocutori
non
condividono
questo
ottimismo. Tra questi
c’èilproduttorediStar
Academy in versione
araba,
Nagi
Baz,
intervistato a Beirut,
che mette in dubbio la
vitalità
dell’azienda:
“Rotana
non
è
un’azienda come le
altre, è l’ancella di Al
Waleed. Il business
model non conta nulla:
esiste solo un obiettivo
politico e identitario
arabo”.
Altri
sottolineano
la
megalomania
del
principe:“OgniannoAl
Waleedinvitagliartisti
Rotana in un Hotel
Four Season, tutto
pagato, e li fa cantare
per la sua gloria.
Recentemente
ha
regalato alla maggior
parte di loro una Bmw
franco di porto, tutti lo
hanno ringraziato e si
sonorivendutil’autodi
lusso per intascare i
soldi”. Pascal Gaillot,
amministratore
delegato di Emi-Medio
Oriente, concorrente
diretto
di
Rotana,
intervistato a Dubai
sottolinea: “Rotana ha
ammazzato il mercato
musicale
arabo
abbassando i prezzi. È
concorrenza
sleale.
L’obiettivo del principe
non è economico, ma
quello di far conoscere
lamusicaaraba.Perlui
Rotana
è
un
divertimento,
noi
invece
facciamo
business”. Altri sono
ancora
più
critici:
sembra che Rotana
imponga alle proprie
radio e televisioni di
trasmettere i cantanti
del gruppo e sembra
che
abbia
diffuso
clausole irregolari con
gli
artisti
che
sarebbero “legati mani
e piedi contro le
tradizionali
pratiche
internazionali
sul
copyright”,
secondo
Maxim
Dupa,
che
coordina l’ufficio di
esportazione
della
musica al ministero
della
Cultura
del
Libano. Le critiche
sono
ancora
più
velenose sulla qualità
della musica promossa
da Rotana: “un pop
americanizzato
in
lingua
araba”;
“standardizzazione
araba”;
“Mtv
in
peggio”; “nella musica
c’è sempre lo stesso
ritmo, nei videoclip è
sempre la stessa storia
di un uomo e una
donna
che
si
incontrano,
si
allontanano e poi si
ritrovano”;
“Rotana
non fa progredire la
musica
araba,
la
ammazza”. Infine, si
rimprovera Al Waleed
di aver scelto Beirut
per produrre musica e
IlCairoperilcinema,e
ciò sarebbe la prova
della sua ipocrisia: “Il
saudita Al Waleed sa
benissimo che non
potrebbe fare i suoi
film o registrare i suoi
album a Riyadh. Può
mostrare donne senza
veloaBeirutoalCairo,
ma non in Arabia
saudita o nei paesi del
Golfo. È la chiara
dimostrazione
dell’ipocrisiadeiregimi
sunniti puritani che
interpretano in modo
radicale il Corano e
proibiscono all’interno
dei loro confini ciò che
promuovono altrove”.
Un altro dirigente del
settore
audiovisivo
intervistato a Media
CitydiDubaiaggiunge:
“L’Arabia saudita è il
paese dell’ipocrisia più
totale: si proibisce
l’alcol, le donne sono
velate, ma di nascosto
è il paese in cui ci si
può
procurare
facilmente
qualsiasi
cosa: alcol, droga,
prostitute, transessuali
e tutto il resto. L’élite
saudita
è
molto
stravagante.
E
Al
Waleed,cheappartiene
a questa élite, ha
divorziatotrevolteedè
il
simbolo
delle
contraddizioni
di
questo paese”. Con
ironia, un dirigente di
Rotana mi dice: “È
vero, alcuni dei nostri
cantantisonopoptutto
l’anno, ma appena
arriva il Ramadan, si
trasformanoincantanti
islamici. Fa parte dei
paradossi del mondo
arabo”.
A discolpa di Rotana
e di Al Waleed si
potrebbe
formulare
anche un’altra ipotesi,
secondocuilastrategia
del
gruppo
intenderebbe
contribuire
alla
modernizzazione
del
mondo arabo nel suo
complesso, e più nello
specifico
dell’Arabia
saudita. Il fatto che il
principe
difenda
i
diritti delle donne e
avanzi critiche ripetute
contro
l’ala
più
retrograda del regno
va in questo senso. È
un pesce-pilota di un
regime che intende
“modernizzarsi”?
Forse. È l’interprete
della corrente liberale?
Questa è l’opinione di
alcuni esperti da me
interpellati.
È
filoamericano?
Sicuramente, ma è
anche
un
grande
sostenitore della causa
palestinese.
È
filolibanese,
e
in
particolare dei sunniti
libanesi? Di sicuro, se
non altro per le sue
origini familiari. È
invece difficile dire se
sia in conflitto aperto
con l’ala dura del
regime.Peraccreditare
la tesi “modernista”, è
necessario
ricordare
che Al Waleed è stato
oggetto di una fatwa
preventiva emessa nel
settembre 2008 dallo
sceicco
saudita
radicale
Saleh
al
Lihedan che rendeva
legittima
la
sua
uccisionesecontinuava
a
contribuire
alla
diffusione
di
programmi
televisivi
“corrotti” ed “empi”.
Ma lo sceicco è stato
dimesso
dalle
sue
funzionidalre.
Igruppirivoltiatutto
il mondo arabo come
Rotana,maancheAmc,
Mbc possono riuscire
nella loro strategia
commerciale culturale
e mediatica nell’epoca
della globalizzazione?
È una domanda di
difficilerisposta.Nonsi
può tuttavia dubitare
chequestigruppisiano
dominanti sul fronte
dell’intrattenimento e
dei
media
arabi.
Possono spingersi oltre
e fare concorrenza ad
americani ed europei
su mercati non arabi?
Quisiponeilproblema
dei valori e della
censura del mondo
arabo, che sono il
puntodiforzadiquesti
gruppi
nella
loro
regione, ma il punto
debole sui mercati
internazionali.
In
Egitto,
un
paese
relativamente “aperto”
rispetto al resto del
mondo musulmano, ho
capito meglio i limiti
della strategia araba
che vuole diventare
mainstream in tutto il
mondo.
Hollywoodneldeserto
MamdouhalLaithysi
rifà
gli
occhi
guardando il piccolo
schermodiunavecchia
televisione. Mi riceve
nel suo gigantesco
ufficio
e
ascolta
distrattamente le mie
domande aspettando la
traduzione (non parla
néfrancesenéinglese)
e in questo modo può
continuare a guardare
le donne con un
vertiginosodécolletédi
unfilminbiancoenero
degli anni cinquanta
conOmarSharif.
Mamdouh al Laithy
ricopre
diverse
funzioni:
dirige
il
settore
della
produzione
cinematografica della
Media City del Cairo,
presiede il sindacato
dei registi dell’Istituto
del
film
e
della
televisione nazionale
egiziana,
dirige
l’Associazione
dei
critici cinematografici
e
prosegue,
a
settantatré anni, la
lunga
carriera
di
sceneggiatore e, mi si
dice, di successo. È
circondato da donne
conilvelocuicontinua
a dare ordini, da una
moltitudine
di
segretari, valletti e
autisti ai suoi ordini, è
il
padrone
dell’industria
cinematografica
egiziana.
È
stato
ufficialedipolizianegli
anni sessanta, poi è
stato promosso ed è
passato dal ministero
dell’Interno al settore
audiovisivo
per
sorvegliare la libertà
degliartisti.Neglianni
settanta è incaricato
della censura delle
sceneggiature di film e
teleromanzi. Nel 1978
diventa
“censore
generale” per i film
mandati in televisione,
unpostopiùadattoper
unexpoliziottocheper
unosceneggiatore.
Sopra di lui c’è una
fotografia di Hosni
Mubarak,
autocrate
politico tanto quanto
lui è un autocrate
culturale. Sul tema del
protezionismo
in
Egitto, Mamdouh al
Laithy spiega come il
paese
difenda
la
propria cinematografia
attraverso una rigida
limitazione del numero
di
copie
di
film
stranieri
e
la
scritturazione di attori
egiziani
grazie
al
monopoliodeisindacati
degli attori. Il mio
interlocutore,
ex
censore
in
capo
egiziano, non capisce
invece la mia domanda
sulla censura. Pone
fine all’intervista e mi
accompagna fuori con
fermezza. Lo lascio nel
suo grande ufficio,
autocrate isolato, a
finire di guardare le
donne leggere e libere
di film egiziani di
un’epoca in cui non
erano censurati – da
lui.
Per comprendere le
regolamentazioni del
cinema in Egitto, e per
cercare di capire se il
cinema arabo possa
diventare mainstream
al di fuori dei paesi
arabi, ho cominciato
bussando alla porta
sbagliata. Poi mi sono
recato al ministero
della Cultura egiziana.
Mi
riceve
Anwar
Ibrahim,direttoredelle
relazioniinternazionali.
A parte un caffè turco,
frasi di circostanza
sulla
“diversità
culturale”
e
sull’amicizia
francoegiziana,
l’intervista
non fa minimamente
avanzare
la
mia
inchiesta. Non so se il
mio interlocutore non
sappia
nulla
del
sistema protezionista
egiziano,oppuresenon
voglia dire niente. Non
so se abbia qualche
timore,
se
sia
incompetente o se sia
una forma di controllo
politico. Anche il mio
secondo tentativo si
rivela dunque un buco
nell’acqua.Tentoallora
con
Arab
Media
Corporation.
L’ufficio di Hadil
Saleh si trova al
decimo piano di un
discreto edificio sulla
strada panoramica El
Nile, nel quartiere di
Maadi, nel Sud del
Cairo. Le porte dorate
e in legno pregiato, il
marmoelevetrateche
danno
sul
fiume
stonano
con
la
decadenza dell’edificio
e le guardie che
dormono nella hall.
Hadil è figlio del
miliardario
saudita
Sheik Saleh Abdullah
Kamel, proprietario di
Arab Radio Tv (Art),
una
multinazionale
dell’intrattenimento.
Come Rotana, questa
major ha la sede
sociale
in
Arabia
saudita,
gli
studi
cinematografici e la
direzione
dei
“contenuti” sono al
Cairo, le reti di
diffusioneinGiordania.
Controlla una ventina
di
televisioni
a
pagamentoosatellitari,
il cui fiore all’occhiello
è Cinema Channel
(un’emittente tipo la
francese Canal + per
tutto il mondo arabo),
con
un
catalogo
impressionante di film
storici e infrastrutture
di distribuzione molto
potenti. “Non c’è alcun
posto per fare cinema
in Arabia saudita, per
questo il principe ha
collocato gli studi qui,
al Cairo,” spiega Wael
M. Essawy, direttore
generaledelladivisione
egiziana della major. Il
gruppo ha un progetto
commerciale,culturale,
ma anche una mission
morale:
grazie
al
denaro dei paesi del
Golfo,
intende
influenzare i contenuti
del cinema egiziano
per adeguarsi alle
aspettative e ai valori
delpubblicoarabo.
KhaledAbdalGaleel,
consiglierespecialedel
gruppo,
al
Cairo,
conferma senza giri di
parole: “Abbiamo una
strategiarivoltaatutto
il
mondo
arabo.
Vogliamo creare un
settore
produttivo
completo
utile
a
valorizzare la cultura
araba e a sostenere
l’orientamentoarabo.Il
nostro
scopo
è
difendere la nostra
cultura,
le
nostre
tradizioni, i nostri
valori,
la
nostra
religione. Il nostro
obiettivo
non
è
guadagnare denaro: il
principe
è
già
miliardario,
non
avrebbe alcun senso.
La cosa importante
sono i nostri valori. La
nostra
visione
del
mondo. Vogliamo fare
film per trasmettere
dei valori, non per
guadagnare
denaro
come
fanno
gli
americani.
È
una
strategia morale e
credo che abbiamo
sostanzialmente
il
diritto
di
farlo.
Soprattutto,
oggi,
abbiamo
potere,
capacità e soldi per
difendere il punto di
vista
arabo.
E
condurremo
questa
battaglia”.
I produttori arabi e i
patron delle industrie
creative a Riyadh,
Beirut,
Damasco,
Dubai, Doha e Il Cairo
sono dunque pronti a
lanciarsinellabattaglia
mondialedeicontenuti.
Ritengono che cinema,
musica e programmi
televisiviarabipossano
diventaremainstreame
conquistare il resto del
mondo. Hanno già
avviato
le
loro
strategie.
Ora
è
necessario conoscere il
punto di vista della
concorrenza,
soprattutto
dei
distributoriamericani.
L’ufficio della 20th
Century Fox si trova
nella parte vecchia del
Cairo,inviaAlAzbeka.
“È dalla parte del bar
americano,” è l’unica
indicazione che mi è
stata
comunicata.
L’autista del taxi è
analfabeta e non se ne
fa
nulla
delle
indicazioni scritte che
ho con me, deve
chiedere ai passanti
cosa ci sia scritto sul
mio
foglietto
per
condurmi in quella via.
L’edificio è vecchio e
nel
contempo
classicheggiante,
in
cattivecondizioni,hail
fasto di una volta,
appassito. Si potrebbe
pensare di trovarsi di
fronte
a
Palazzo
Yacoubian. Anche qui
c’è
un
guardiano
addormentato
nella
hall e nessuno sa a
quale piano si trovi
l’ufficio della Fox.
Prendo un ascensore
scassatoesenzalucee
arrivo al terzo piano.
Penso che in un’epoca
diversa da film di
successo come Titanic
e Avatar, da questo
edificio sono uscite
pellicole che hanno
conquistato il mondo
arabo.Strano.
Se
l’edificio
ha
un’aria
da
caos
egiziano, all’interno gli
uffici sono moderni e
“all’americana”.
Sui
muri, bianco gesso, ci
sono
locandine
gigantesche di Guerre
stellari,
X-Men
e
Simpsons. Nell’ufficio
principale
c’è
un
pendolo della 20th
Century Fox che tutte
le ore fa risuonare la
famosa Fox Fanfare.
Antoine Zeind è il
presidente di United
Motion Pictures, una
societàchedistribuisce
in esclusiva i film degli
studios americani nei
paesiarabi,soprattutto
FoxeWarner.
“Oggi in Egitto, non
si tagliano più le scene
in cui ci sono baci, ma
quelle in cui ci sono
donne nude o poco
vestite sì!” sospira
Antoine
Zeind.
È
cristiano (maronita) e
parla
correntemente
inglese e francese.
Sono
venuto
a
incontrarlo per capire
il
sistema
di
regolamentazione del
cinema
in
Egitto.
Questa
volta
ho
bussato alla porta
giusta.
Antoine Zeind: “La
censura
riguarda
soprattutto i tre ‘soliti
sospetti’,
religione,
sesso e politica. Ma si
tratta di una censura
sempre più ipocrita,
con diversi livelli e
criteri di applicazione,
e bisogna conoscerne i
codici”. Per renderla
operativa, il governo
egiziano ha fissato un
sistema
di
autorizzazione
preventiva dei film
prima della loro uscita
nei cinema. “L’ufficio
della
censura
può
proibire
qualsiasi
lungometraggiooppure
chiedere dei tagli per
‘mancanza
di
moderazione’,” mi dice
Zeind, “rispetto al
corpo femminile, per
opinioni
ostili
nei
confronti
dell’Egitto,
del
presidente
Mubarak, del Profeta o
dell’islam,
e
naturalmente per ogni
riferimento esplicito a
sessualità,
omosessualità,
ma
stranamente né la
violenza né l’alcol
costituiscono
un
problema.” Anche in
questo caso si tratta di
una censura molto
imprevedibile: il film
Yacoubian
Building
tratto dal romanzo del
celebre
scrittore
egiziano‘AlaalAswani,
che affronta l’ascesa
dell’islamismo
in
Egitto,l’omossessualità
e
lo
sfruttamento
sessuale di giovani
donne, non è stato
censurato (solo vietato
ai minori di diciotto
anni). Ha riscosso
anche
un
certo
successo in Egitto.
Censurediquestotipo,
ancor
più
rigide,
esistono
anche
in
Arabia saudita, nei
paesidelGolfo,inSiria
einIran.
Inoltre, il governo
egiziano
limita
la
diffusione dei film
stranieriacinquecopie
per ogni città al
massimo. “Siccome, in
realtà,cisonosolodue
grandicittàinEgitto,Il
Cairo e Alessandria, in
generale
abbiamo
dirittoadiecicopieper
tutto il paese,” dice
amareggiato Zeind. “È
un mercato chiuso,
oppuresemichiuso.Esi
capisce bene come il
cinema egiziano possa
occuparel’80percento
delbotteghinoeperché
il cinema americano è
cancellato. Cancellato
nel senso che abbiamo
il restante 20 per
cento, ma il mercato
egiziano è di difficile
penetrazione per la
cultura americana. Si
rende conto: dieci
copie per un paese di
settantacinque milioni
diabitanti!Anchesemi
dirà che c’è di peggio,
per esempio in Libia,
dove distribuisco film
della Fox, abbiamo
diritto a una sola
pellicola!”
La
“cancellazione”
del cinema americano
deve essere attenuata.
Se la quota di cinema
egiziano
resta
complessivamente
dominante in Egitto, la
concorrenza americana
è diventata rilevante
nelle zone urbane. La
loro quota di mercato
può raggiungere il 4550 per cento nei
multisala delle grandi
città,
dove
sono
concentrati i film di
successo
hollywoodiani. Inoltre
c’èilmercatonero,che
permette di accedere
facilmente al Cairo,
come altrove, a tutti i
filmamericaniindvda
prezzistracciati.
A
questa
regolamentazione
attraverso il numero di
copie si aggiunge un
sistema di tassazione
sfavorevole al cinema
straniero: 5 per cento
su tutti gli introiti del
box-office per i film
egiziani, 20 per cento
sui
film
stranieri.
Tuttavia,AntoineZeind
suggerisce
che
il
problema
principale
della diffusione del
cinema americano in
Egitto, oltre questo
doppio protezionismo
dellalegge,èculturale.
La questione è quella
dei sottotitoli, poiché
come in tutti i paesi
arabi, quasi tutti i film
stranieri non sono
doppiati. In un paese
con un analfabetismo
vicino al 30 per cento
ciò
contribuisce
a
frenare la diffusione
dei
film
stranieri.
“Anche
se
avessi
centocinquanta copie
di un film non saprei
dove proiettarle: la
richiesta di cinema
americano è scarsa,
anche se in aumento,”
ammetteZeind.
Infine, esiste una
regolamentazione
indiretta attraverso il
mercato. In Egitto
esistono
fondamentalmente due
distributori che hanno
sale proprie e sono
fortemente
integrati
verticalmente (ovvero
distribuiscono i film
che producono). Di
conseguenza, questo
duopolio
funziona
secondo il principio
dell’esclusività: i film
americani
sono
marginalizzati,
soprattutto durante i
periodi più favorevoli
del box-office, come in
estate, la fine del
Ramadan o la festa del
Sacrificio.
In definitiva, il dato
reale di penetrazione
del cinema americano
in Egitto è difficile da
valutare.
Secondo
diversi
distributori,
sarebbe attorno al 2025 per cento del boxoffice,mentreilrestoè
rappresentato da film
egiziani, mentre la
cinematografia araba,
europea o straniera è
praticamente
inesistente (gli ufficiali
egiziani
confermano
queste statistiche). “In
Egitto
ci
sono
pochissimi film siriani,
quasi
nessun
film
libanese e nessun film
del Maghreb,” spiega
Zeind.
Un
film
americano
fa
al
massino
150.000
ingressi: “Con Titanic,
che
è
stato
un’eccezione
con
400.000 ingressi in
ventisei
settimane,
sono riuscito a fare sei
spettacoli al giorno e
con sole cinque copie!
Abbiamo aggiunto una
proiezionedetta‘supermidnight’ alle due del
mattino e nei centri
urbani
anche
una
proiezione ‘after-thesuper-midnight’,
alle
quattro del mattino,
chiamata ‘El Shabah’
(il fantasma)”! Solo il
cinema
americano
riesce a sfondare in
Egitto,ancheseancora
moderatamente.“Mala
richiesta
di
film
americani crescerà,”
prevede Zeind. “C’è
sempre più appetito
per i film d’azione
americani. Gli egiziani
non sanno più fare
intrattenimento
mainstream e anche i
giovani tendono a non
vedere più i loro film.
Se la richiesta è
limitata
in
modo
autoritario nei cinema,
il pubblico troverà su
internet e sui canali
satellitari
l’offerta
culturale
che
desidera.”
Hala
Hashish,
direttricediEgyptNew
Channel,
respinge
completamente queste
argomentazioni.
“Gli
arabi sono capacissimi
di
produrre
intrattenimento
mainstream
e
di
dimenticare l’islam. In
Egitto
facciamo
intrattenimento dalla
notte dei tempi.” Di
fronte a lei ci sono tre
schermi
che
trasmettono
in
continuo Al Jazeera, Al
Arabiya e Egypt New
Channel. “Tutti e tre
questi canali sono
molto
mainstream,”
aggiunge indicando gli
schermi. “E peraltro
parlano tutti egiziano.
Ascolti,
giornalisti,
cantanti,
attori
di
cinema, le persone
dell’intrattenimento
sono
tutte
egizianizzate.”
“Egizianizzazione”, è
la prima volta che
sento
questa
espressione che ricalca
quella
di
“americanizzazione”.
Forse è a partire dal
mondo
arabo
che
bisogna cominciare a
misurare il dominio
americanonellacultura
di massa. Il successo
planetario
dell’intrattenimento
americano è simile al
successo
dell’intrattenimento
egiziano sul mondo
arabo; è solo una
questione di scale
differenti.
Anch’esso
suscita critiche ed è
accusato
di
imperialismo.
Come gli Stati Uniti,
anche l’Egitto difende
da tempo la cultura di
massa
e
il
divertimento. Questa
tradizione
di
intrattenimento
popolare
è
onnipresente e non è
accompagnatadaalcun
giudizio critico ed
estetico
volti
a
costruire
gerarchie
culturali. In Egitto
esiste
un
cinema
d’autore,dicuiYoussef
Chahine
è
stato
l’archetipo, ma non
esiste invece, come in
Francia o in Marocco,
un discorso pubblico
ufficiale che valorizza
l’arte
invece
del
divertimento
e
si
propone di finanziare
questo
per
controbattere l’altro.
SecondoAntoineZeind,
questa
sarebbe
la
spiegazione
del
dominio egiziano nei
paesi
arabi:
“In
Marocco, Tunisia, ma
anche Vietnam, Siria e
Corea,
Belgio
francofono, Argentina
in cui il modello
francese è sempre
stato forte in ambito
culturale, si privilegia
la cultura di stato e si
sovvenziona il cinema
d’autore; in Egitto,
India, Brasile, tra i
fiamminghi, a Hong
Kong e oggi a Pechino,
come da sempre negli
StatiUniti,siprivilegia
il divertimento. Per
questo i secondi hanno
successo e i primi
invece no. Per questo
la cultura marocchina
nonhaalcunainfluenza
oggi nel mondo arabo
mentre
domina
la
cultura
egiziana”.
Questopungentepunto
di vista è condiviso dal
critico cinematografico
Youssef
Cherif
Rizkallah, intervistato
al Cairo: “Il Marocco
ha una produzione
artistica,
spesso
sostenuta dallo stato.
Si possono vedere
questi film in sale che
proiettano
cinema
d’autore in Europa, ma
non sono proiettati
neanche in Algeria e
Tunisia. Mentre invece
i nostri film dominano
il
cinema
del
Maghreb”.
È
dunque
lecito
chiedersiseipaesiche
riescono ad affermarsi
all’internodegliscambi
culturali internazionali
edeiflussidicontenuti
sono
quelli
che
sostengono
l’intrattenimento
rispettoall’arte.Questa
argomentazione
è
condivisa
nell’Africa
francofona da Charles
Mensah,direttoredella
cinematografia
del
Gabon, intervistato in
Camerun.
“Le
cinematografie
che
puntano
sul
film
d’autore,sulmodellodi
quella francese, come
quelle di Marocco,
Gabon e Camerun, non
riescono a diffondere
ampiamente i loro film
all’estero,
mentre
quelli che promuovono
un
divertimento
all’americana,
come
Egitto,
Nigeria
e
soprattutto
l’India
riesconomeglio.”
Come Stati Uniti e
India,anchel’Egittoha
una
relazione
particolare con le star.
Oggisonopochiipaesi
che hanno star molto
popolari all’interno dei
loro confini – quelle
vere, capaci di creare
parapigliaeaffascinare
le folle –, sono più rari
ancora
quelli
che
hanno saputo produrre
star
globalizzate
conosciute in tutto il
mondo. Appartengono
aquestaschieraArnold
Schwarzenegger, Tom
Cruise, Leonardo Di
Caprio, Harrison Ford,
Will Smith, ma sulla
scena mondiale gli
europei sono ormai
assenti, mentre alcune
star
indiane
ed
egiziane cominciano a
fare concorrenza a
questiattoriamericani.
A Mumbai sono stato
sorpresodallareazione
isterica delle folle alla
comparsa di star di
Bollywood,
Amitabh
Bachchan o Shah Rukh
Khan, e ho visto le
stesse scene nelle vie
del Cairo quando una
sera,
mentre
lo
intervistavo nella sua
auto dai vetri oscurati,
il
giovane
attore
cinematografico
e
presentatorediuntalkshowtelevisivo,Khaled
Abol Naga, è stato
riconosciuto
a
un
semaforo rosso da
decine
di
giovani
egiziani che ci hanno
seguito per le vie,
costringendo la polizia
a
intervenire
per
liberare il passaggio e
facilitare la fuga della
star. E si trattava solo
di un giovane attore
debuttante.
Quasi alla fine di
questa lunga inchiesta
è dunque opportuno
chiedersi
se,
per
diventaremainstreame
comunicare a tutti,
bisogna
privilegiare
l’intrattenimento
e
valorizzarlo
con
sincerità.
Bisogna
puntare
sullo
star
system piuttosto che
sugli attori? Bisogna
abbandonare i propri
valori, la propria arte,
lapropriaidentità?Per
diventare
universali
bisogna cessare di
avere
un’identità
nazionale? È dunque
necessario un viaggio
in Europa, per capire
comeinquestovecchio
continente, patria della
cultura occidentale e
dei suoi valori, si sia
smesso di voler essere
mainstream.
16.
Laculturaantimainstream
dell’Europa
Jonathan Karp, detto
Jon, ha quarantun anni
ed
è
la
star
dell’editoriaamericana.
Mi
concede
un’intervistaall’interno
diunagrandissimasala
riunioni
che
può
ospitare oltre cento
persone, benché siamo
solo noi due. È editor
in chief, una sorta di
direttore letterario, di
Random House, il più
importante
gruppo
editoriale
americano
(Karpmidice:“Ilprimo
editore al mondo”).
Sono al civico 1745 di
Broadway a New York,
all’angolo
della
Cinquantaseiesima
Strada,treisolatiasud
di
Central
Park.
Nell’immensahalldella
Random House Tower,
sede del gruppo, ci
sono migliaia di libri
messi in cubi di vetro
impilati l’uno sull’altro
fino ad arrivare al
soffitto,
spettacolare
esempio
della
produzione della casa
editrice. Il più noto di
questi libri è Il Codice
DaVinci di Dan Brown
–
con
sessantasei
milioni
di
copie
vendute e tradotto in
quarantaquattro
lingue.
“Ogni
anno
pubblichiamo fra i
tremila e i cinquemila
libri,” afferma Karp.
“Siamo un editore
mainstreameciòcheci
interessa
sono
i
bestseller.” Jonathan
Karp punta soprattutto
sugli instant o runway
bestsellers (quelli che
vendono molto subito)
e sui coast-to-coast
bestsellers (quelli che
piacciono a tutti, da
unacostaall’altradegli
Stati Uniti). Pubblica
ancheautorimenonoti,
ma
con
grandi
potenzialità,
cioè
quando crede che un
libro
possa
raggiungere il tip-ping
point
(espressione
famosa
nell’editoria
americana
e
nell’ambito
del
marketing per indicare
il punto a partire dal
quale un prodotto è
desiderato
da
un
pubblico di massa e
contagioso). Inoltre è
attento a libri che
possonoessereadattati
dal
cinema
hollywoodiano e per
questospessoopzionati
da una major ancor
prima
di
essere
pubblicati. Non gli
interessa per nulla
pubblicare
libri
o
monografie senza una
storia vera, ai novels,
romanzi
noiosi,
preferisce le fictions;
lascia pubblicare alle
“UniversityPress”testi
accademici, con un
preciso punto di vista,
argomentazione
e
analisi,
preferisce
quelli
che
chiama
elegantemente
pop
books.
L’istinto
metà
editoriale
e
metà
commerciale
di
Jonathan Karp e la sua
capacità di individuare
i libri più mainstream
difictionodinarrative
non-fiction (un testo o
un
saggio
che
raccontano una storia
che i lettori possono
seguire dall’inizio alla
fine), gli sono valsi
l’encomio da parte
degli addetti ai lavori.
“Non mi occupo dei
libripubblicatidatutto
il
gruppo,”
spiega
comunque
Jonathan
Karp,“masolodiquelli
pubblicati da Random
House con il suo
marchio.”
Infatti,
lavora per la casa che
negli
ambienti
si
chiama
“Little
Random”,
l’imprint
Random
House
all’interno del gruppo
RandomHouse.
Negli Stati Uniti,
come nella maggior
parte
dei
paesi
occidentali, l’industria
del libro è organizzata
secondo il sistema
degli
imprint:
all’interno
di
uno
stesso gruppo ci sono
diverse case editrici,
apparentemente
indipendenti,
che
pubblicano con il loro
marchio.
Random
House, per esempio,
comprende
un
centinaio di imprint
come Alfred Knopf,
Ballantine, Bantam e
Pantheon
Books,
ciascunadiquestecase
editrici pubblica un
centinaio
di
libri
all’anno. “In termini
generali,
l’imprint
mantiene una forte
identitàeditoriale:fale
scelte degli autori,
gestisce il marketing,
la pubblicità e le
relazioniconlastampa.
Gli uomini chiave degli
imprint sono gli editor.
Tutto ciò che è backoffice è invece gestito
da Random House, la
casamadre.”Perback-
office, Jonathan Karp
intende
produzione,
stampa, distribuzione,
magazzino, contabilità,
questionilegaliediritti
derivati
(vendita
all’estero, piattaforme
digitali, vendita su eBooks
e
Kindle,
adattamentinelsettore
audiovisivo).
“Sul
fronte
della
casa
madre,
gli
uomini
chiave sono i numbers
people, le persone che
sioccupanodinumeri,”
prosegue Karp. Negli
Stati Uniti si dice che
questo
sistema
dovrebbe servire a
favorire
la
diversificazione
dei
titoli nel settore degli
imprint,
mentre
all’interno del gruppo
favorirebbe
le
economie
di
scala
combinate
e
la
distribuzione di massa.
Ècomesedaunaparte
ci fosse la grande
autonomiadiunastartup e dall’altra la forza
d’urto
di
una
multinazionale. Questo
modello
di
funzionamento
è
vigente in tutte le
industrie creative e si
ritrova anche nelle
major della discografia
attraverso
le
“etichette” (Columbia
Records, Artista e Rca
sono
per
esempio
etichettediSony)econ
le “unità specializzate”
degli
studios
hollywoodiani (Focus
FeaturesperUniversal,
New Line Cinema per
Warner).
Anche
i
gruppi
editoriali
americanihannopropri
imprint come Simon &
Schuster e The Free
Press all’interno di
Viacom, HarperCollins
all’interno di News
Corp.
Dopo la nostra prima
intervista,
la
star
dell’editoriaamericana,
Jonathan Karp, che era
rimasto alla Random
House per sedici anni,
ha dato le dimissioni
per andare a lavorare
per la concorrenza,
Warner
Books,
controllata dal colosso
Time Warner. La sede
del gruppo è nella
partesuddiNewYork,
al civico 1271 di
Avenue
of
the
Americas, nella stessa
torre del “Time”. Karp
è presidente di un
nuovo imprint creato
da lui stesso, Warner
Twelwe. “Pubblichiamo
ormaitroppilibrienon
abbiamo il tempo di
occuparcene. Questo
imprint si chiama così
perché abbiamo deciso
di pubblicare solo
dodici libri all’anno,”
spiegaJonKarp.
Cosìfunzionadunque
l’editoria
americana.
Eppure nessuno dei
due fiori all’occhiello
dell’editoria
statunitense, Random
HouseeWarnerBooks,
è americano. Random
House, infatti, primo
gruppo editoriale degli
Stati
Uniti,
è
controllata dal colosso
tedesco Bertelsmann,
mentreWarnerBooksè
stata acquisita nel
2006 dal francese
Hachette Book Group
(Lagardère).
Ormai
l’imprint di Jonathan
Karp si chiama solo
Twelwe.
Le
due
princiali case editrici
americane, di fatto,
sonoeuropee.
“Abbiamounagrande
decentralizzazione. Si
cercano sinergie, ma
l’editoria continua a
essereunsettoremolto
artigianale.
La
concorrenza interna è
sana,” spiega Arnaud
Nourry,
amministratore
delegato di Hachette
Livre.
Axel
Gantz,
editore di successo e
rappresentante
di
Bertelsmann France,
che intervisto a lungo
su un treno Tgv,
conferma:
“Bertelsmann
segue
una
filosofia
della
decentralizzazione
totale,tutteledecisioni
sonopresedachihala
responsabilità su un
dato
settore”.
In
Germania, alla sede di
Bertelsmann, dove la
direzione si è rifiutata
di ricevermi e dove le
poche persone che
intervisto
vogliono
restare anonime, mi si
dice che “Bertelsmann
è una multinazionale
molto
delocalizzata,
ogni unità ha libertà
totale nella conduzione
e nella gestione del
proprio business; le
unichecosepredefinite
sono le strategie e le
politiche
di
investimento”. La casa
madre
Bertelsmann,
gestita
da
una
fondazione familiare e
non quotata in Borsa,
non
intende
né
controllare
né
organizzare la politica
editoriale di Random
House, così come non
interviene
sulle
trasmissioni
delle
emittenti
radiotelevisive Rtl, Channel
5, M6 e Fun Radio. “Il
vero
patron
di
Bertelsmann per quasi
sessant’anni, Reinhard
Mohn, recentemente
scomparso,
rappresentava
un
residuo del capitalismo
renano familiare e
regionalizzato.
Ogni
settore
è
molto
autonomo
e
ogni
dipendente
è
responsabilizzato
attraverso una cultura
dellacollaborazionetra
direzione e lavoratori,”
mi spiega uno dei
membridelconsigliodi
sorveglianza
di
Bertelsmann. Non ho
conferme dirette di
questo
“idilliaco
modello” dei rapporti
di lavoro tra dirigenza
e dipendenti, ma nei
settori del gruppo
visitati a Praga, Parigi
e
New
York
ho
sicuramente notato la
forte
decentralizzazione.
“Non
dobbiamo
chiedere alcuna ‘luce
verde’ a Bertelsmann.
Non controlla né la
linea editoriale, né le
nostre
scelte
commerciali, solo i
nostri risultati e le
vendite,” conferma a
Praga
Jan
Knopp,
responsabile
del
marketing dell’editore
Euromedia,
di
proprietà
di
Bertelsmann.
Tuttavia, i libri e i
giornali editati da
Bertelsmann,lamusica
vendutadallasuafiliale
Bmg
Publishing,
i
programmi televisivi e
radiofonici del gruppo
non sono tedeschi – e
spesso
non
sono
neanche europei. La
multinazionale tedesca
controlla
Random
House, che continua a
essere
un
gruppo
editoriale
completamente
americano.
L’Unione
europea,
composta da ventisette
paesi, è un continente
talmente
vasto
e
diversificato che in
temadimediaecultura
del
divertimento
meriterebbe un libro a
sé. Si pongono infatti
temi come il ruolo
cruciale di Bbc nel
mondo, l’impero di
Berlusconinelcontesto
italiano, il potere di
multinazionali francesi
come
Vivendi
e
Lagardère,
inglesi
come Emi e Pearson,
spagnole come Prisa,
portoghesi come Sic,
rumene come Cem e
tanti altri. Su questi
diversi gruppi ho fatto
alcune inchieste, ma
piuttosto
che
riportarne i risultati ho
preferito privilegiare,
in
questo
capitolo
finale sull’Europa, un
approccio trasversale
più approfondito su
cinquespecificiaspetti:
i
paradossi
del
successo
dei
videogiochi francesi, il
ritorno in Europa dei
cechi,
le
tensioni
culturali in Belgio, il
ruolo di Londra e
Parigi come capitali
dellamusicaafricanae,
infine, ai confini del
continente,
le
aspettative
europee
della
Turchia,
tra
americanizzazione
e
islamizzazione.
Ogni singolo paese,
preso a sé, ha scarso
peso all’interno dei
flussi dei contenuti
internazionali, benché
la
presenza
di
Inghilterra,Germaniae
Francia abbia una
certa
incidenza.
Tuttavia,
l’Unione
europeaèfortee,sulle
esportazioni
dei
contenuti, è seconda
dopo gli Stati Uniti.
Soprattutto, tra i paesi
europeic’èunrilevante
scambiodiprodottiedi
informazioni e ciò
fornisce
reale
consistenza al mercato
interno e alla natura
dell’intrattenimento
europeo. Il successo,
tuttavia, finisce qui. Le
importazioni
di
contenuti, soprattutto
dagli
Stati
Uniti,
superano
le
esportazioni
e
ciò
rende la bilancia dei
pagamenti
europea
molto deficitaria in
termini di cultura e di
informazione(mentreè
ampiamente in attivo
per gli Stati Uniti). Le
statistichemostranoun
declino
importante
delle esportazioni di
musica, dei programmi
televisivi e dei film
europei (il libro resiste
meglio) da una decina
di anni con un ritmo di
–8 per cento all’anno.
In estrema sintesi:
l’Europa cala nella
produzione
ed
è
diventata
il
primo
importatore
di
contenuti al mondo,
mentre gli Stati Uniti,
la
cui
produzione
esplode, sono ormai
ampiamente il primo
esportatore di suoni e
immagini – e queste
esportazioni
sono
dirette anzitutto verso
l’Europa. Come siamo
arrivati
a
questa
situazione?
Le
prossime
pagine
cercanodirisponderea
questadomanda.
Il successo in trompe
l’œil dei videogiochi
europei
Quando ho voluto
saperedovesonocreati
i giochi La tigre e il
dragone e Brothers in
arms
della
casa
francese Ubisoft, mi è
stato fatto il nome
Zhabei. Mi è subito
sembrato un nome
strano, Zhabei, e non
riuscivo a immaginare
dovepotessetrovarsi,a
Parigi o in qualche
altro
angolo
della
Francia.
Ubisoft è uno dei
colossi del videogioco
ed
è
una
casa
produttrice
e
distribuitrice europea.
Le sue entrate sono in
forte crescita, come
quelle
della
concorrenza, American
Electronic
Art,
Blizzard,
Activision
(queste ultime due
sono state acquisite da
Vivendi). Il successo
economico
dei
videogiochi si spiega
soprattutto
con
l’ascesa dei giochi su
internet,
degli
abbonamenti per i
prodotti multigiocatore
e della connessione
totale delle consolle di
nuova generazione con
internet. La Xbox 360
(dell’americana
Microsoft), Playstation
3 (della giapponese
Sony) e Wii (della
giapponese Nintendo)
sono veri e propri
prodotti multimediali.
Di fronte al successo
dei giochi prodotti da
Ubisoft
e
Vivendi
Games, ho cercato di
capire il segreto del
french
touch
nel
settoredeivideogiochi,
dove
le
aziende
francesi sono ormai
leader mondiale. Così
hoscopertoZhabei.
Zhabei
periferia
è
nella
nord
di
Shanghai, una zona
industriale high tech
nota con il nome di
Shanghai Multimedia
Valley. Viene subito da
chiedersi se sia una
sorta di Silicon Valley
in miniatura al servizio
diunpaesegigantesco,
ma in realtà è solo la
concreta
esemplificazione della
delocalizzazione delle
industrie
creative
europeeinCina.
Mi trovo così di
fronte Zhang Ian Xiao,
che nel suo ufficio ha
Marsupilami, il canescimmiainpelucheeil
cane giallo di Martin
Matin. Zhang Ian Xiao
è il presidente di
Fantasia
Animation,
una società privata di
produzione di film
d’animazione,
di
cartoni animati e di
videogiochi.Mitrovoin
questi locali quasi per
errore, prima di fare
visita a Ubisoft. Ian
Xiao è stato direttore
della
ampiamente
ufficiale
Shanghai
Television e da sempre
le sue passioni sono i
cartoni animati e lo
“sport
elettronico”
(cioè i videogiochi). “Il
nome della mia società
è un composto di
‘fantasia’ e ‘Asia’,”
spiega Zhang Ian Xiao,
nel suo ufficio di
Shanghai.
Fantasia
Animation
realizza
cartonianimatiegiochi
per conto di numerosi
produttori ed editori
europei.
A un centinaio di
metri
da
Fantasia
Animation si trovano
Magic Motion Digital
Entertainment, uno dei
più
grandi
studi
d’animazione 3D della
Cina; Game Center,
una delle principali
società di videogiochi
della regione e, un po’
oltre, finalmente, la
società“offshore”della
casa francese Ubisoft.
Qui sono sviluppati
videogiochi come La
tigre e il dragone e
Brothersinarms.
“I dipendenti qui
sono
ben
pagati,
meglio che altrove a
Shanghai,” sostiene il
responsabile
dello
studio. “Guadagnano
tra i 1500 e i 10.000
yuan Rmb al mese
(150-950
euro),
il
doppio di un salario
normale per questo
tipo di lavoro a
Shanghai. Anche se in
euroèmenodelsalario
minimo in Francia o
negli Stati Uniti e
senza
previdenza
sociale.” (Intervistati
non in presenza del
datore di lavoro, i
dipendenti mi dicono
che il loro stipendio è
inferiore a 4000 yuan
Rmb, ovvero 400 euro
al mese.) Il successo
commerciale
di
Fantasia
Animation,
Magic Motion, Game
Center e della società
offshore di Ubisoft si
spiega con la presenza
di questo tipo di
manodopera:
nel
contempo
altamente
qualificata
e
incredibilmente a buon
mercato. Il massimo,
per gli europei. Anche
nell’epoca del digitale,
per produrre un film
d’animazione o un
videogioco
è
necessario,
infatti,
molto “tempo uomo”,
dunque le case di
produzione occidentali
mantengono
il
controllo
della
sceneggiatura e del
marketing
e
subappaltano tutte le
fasi intermedie per la
produzione di film e
videogiochi a società
cinesi come quella di
Zhabei.
Girando per gli uffici
di Ubisoft e Fantasia,
vedocentinaiadicinesi
ammassati in vecchi
depositi che sembrano
scalcinati
se
si
considera
la
loro
struttura,
ma
ultramoderni se si
guardano la quantità e
la
qualità
dei
computer. In ogni sala,
a ogni piano, ci sono
ingegneri,
tecnici,
sceneggiatori,
animatori, compositori
d’immagini
che
disegnano,
colorano,
creano. Hanno l’aria di
essere appassionati ed
entusiasti della loro
attività. Vestono in
jeans
e
indossano
scarpe Nike e hanno
meno di trent’anni.
Ciascuno sta nel suo
cubicle, insieme agli
altri all’interno di un
openspace,enellasua
campana
di
vetro
ascolta rap americano
opopinmandarinosul
proprio iPod e beve
Coca Zero appoggiata
sui minuscoli tavoli
luminosi.
All’interno
di
Fantasia Animation mi
viene fatto visitare un
ufficio
chiamato
“zone”,
dove
i
capiprogetto sono in
contatto
con
i
committenti europei a
cuifannoapprovare,in
inglese,leproduzionia
mano a mano che
avanzano: i contatti
telefonici avvengono la
mattinaprestoolasera
tardi per adattarsi alle
differenze
di
fuso
orario. Anche presso
Ubisoft
si
pratica
questo
dialogo
internazionale,
ma
invece di collegare
Cina ed Europa, i
capiprogetto ricevono
ordini da oltre il
Pacifico e arrivano
regolarmente
pacchi
spediti
con
Fedex
Worldwide,
cioè
provenienti dagli Stati
Uniti. Tutti lavorano
“all’americana”.Scopro
dunque
che
i
committenti di una
società francese come
Ubisoft non si trovano
aParigi,mainAmerica
delNord(aVancouver,
a Montréal, oppure in
Texas e in Carolina del
Nord).
Peraltro,
i
recenti successi di
Ubisoft
sono
smaccatamente
americani: Assassin’s
Creed 2, Avatar e la
versione in videogioco
dei romanzi di Tom
Clancy. È inoltre in
preparazione
il
videogioco ispirato ai
racconti di Le mille e
una notte, la cui storia
verrà portata sugli
schermi da Disney nel
2010conLesabbiedel
tempo.
All’interno di questi
videogiochi, il french
touch è davvero molto
relativo. Come accade
a Bertelsmann con
l’editore
Random
House, oppure a Sony
conlamajorColumbia,
i francesi controllano
quella che è forse la
più importante casa di
produzione
di
videogiochi, ma non
producono
giochi
francesi.
Vivendi
Games nel 2007 ha
acquisito il colosso
americano Activision e
lo studio californiano
Blizzard (editore del
celebre
gioco
“fortemente
multigiocatore” World
ofWarcraft).Daallora,
Vivendi
è
leader
mondiale
dei
videogiochi. Ma allora,
i
contenuti
sono
francesi,oquantomeno
europei? “Tutti i nostri
giochi sono pensati,
sviluppati
e
commercializzati negli
Stati Uniti,” conferma
undirigentediBlizzard
intervistato a Irvine,
vicino Los Angeles. “Il
fatto di appartenere a
una
multinazionale
francesenonincideper
nulla sui prodotti che
creiamo. Tutt’al più,
questi giochi hanno un
tocco asiatico, poiché
molti
giochi
sono
prodotti in Asia, ma in
nessun caso hanno un
sapore europeo. Del
resto, non saprei cosa
vuol dire avere un
sapore
europeo.”
Blizzard,
prima
di
essere acquisita da
Vivendi, aveva uno
studio in Francia, dopo
l’acquisizione è stato
chiuso.
All’interno di Zhabei,
qualcheoradopo,sono
invitato a pranzare con
le équipe di Fantasia,
Magic
Motrion
e
Ubisoft.Cercodicapire
lo status giuridico di
questesocietàoffshore,
chedavveromisfugge.
All’inizio del pranzo mi
si spiega che sono
società “private”: in
generale “l’economia
socialistadimercatoӏ
un capitalismo. A poco
a poco capisco che
queste società sono
legate
“anche”
a
ShanghaiMediaGroup,
un
immenso
conglomerato pubblico
che comprende decine
di televisioni e di radio
di
stato
e
studi
cinematografici
che
appartengono alla città
di
Shanghai.
“L’economia socialista
di mercato” cinese è
caratterizzataancheda
un
autoritario
centralismo socialista.
Continuo a non capire
se sono società private
o pubbliche e cerco di
capire i legami che
uniscono
queste
società
e
come
avvengano
le
transazioni finanziarie,
che
immagino
importanti, con Europa
e Stati Uniti. In Cina
bisogna
saper
attendere
e
porre
regolarmente la stessa
domanda, a ogni tappa
dell’intervista,
senza
insistere,masenzamai
allentare la presa, fino
aquandononsiottiene
risposta alla domanda
formulata. Alla fine del
pranzo,
i
miei
interlocutori
mi
spieganoche,ineffetti,
ciascuna di queste
aziende funziona con
società “che fanno da
passerella”, con sede a
Hong
Kong,
che
effettuano
le
transazioni finanziarie.
“Per far rientrare il
denaro, la società e le
banche di Shanghai
funzionano bene, ma
quando si tratta di
farne
uscire,
per
investire,
comprare
materiale,
fare
coproduzioni passiamo
per la società di Hong
Kong.” Non riesco a
ottenere altre notizie
sui legami tra società
pubbliche cinesi e
società schermo di
HongKong,macapisco
cheperrenderesicurii
fondi, evitare limiti sui
movimenti di capitali
all’estero fissati da
Pechino
e
per
effettuare importanti
versamenti
internazionali,
Hong
Kongèindispensabile.
LasciandoZhabeiela
Shanghai Multimedia
Valley incontro un
gruppo
di
donne
anziane che sembrano
molto
agitate
e
manifestano
pacificamente. Chiedo
al mio traduttore di
dirmi cosa c’è scritto
sui loro cartelli e cosa
rivendicano.
Ogni
giorno queste donne
vengono a manifestare
davanti
ai
locali
moderni delle società
che
lavorano
con
l’Occidente
perché
queste aziende sono
state costruite sui loro
villaggi, sulle loro
terre.
Sono
state
cacciate. Chiedono un
compenso,
un
risarcimento
economico. Da mesi
questedonneanzianee
poveremanifestanonel
silenzio generale e in
un freddo glaciale
secco. Sono le vittime
collaterali
delle
delocalizzazioni
europee.
Siamo di fronte a un
nuovo panslavismo nei
paesi
dell’Europa
centrale?
Sia che producano
videogiochiconUbisoft
e Activision, sia che
pubblichino libri con
Random
House
o
Hachette Book Group,
sia che distribuiscano
musica Emi (major
della
discografia
controllata da diversi
fondi di investimento
inglesi) o Universal
Music (che appartiene
alla francese Vivendi),
gli europei producono
raramente
cultura
mainstream “europea”.
Nel migliore dei casi,
queste multinazionali
tedesche, francesi o
inglesi
producono,
spesso con successo,
prodotti e servizi per il
loro mercato interno,
ma poco esportati,
anche nel continente
europeo. Per il resto,
producono
per
il
mercato internazionale
semplicemente
un
intrattenimento
mainstream
americanizzato.
E
quando si viaggia in
America latina, Medio
Oriente e Asia e si
incontrano i dirigenti
locali
delle
major
europee della musica,
Emi e Universal, si
resta
sorpresi
nel
sentirlidirechetuttala
parte
artistica
è
trattata dagli uffici di
NewYork,MiamieLos
Angeles – e quasi mai
da quelli di Parigi e
Londra. Pascal Gaillot,
che dirige Emi in
Medio Oriente e Nord
Africa, intervistato a
Dubai
conferma:
“Dipendo da Londra
per
le
questioni
finanziarie ma da un
americano, Billy Mann,
direttore A&R di Emi,
che sta a New York,
per tutte le questioni
artistiche”.
Inoltre
Gaillotspiegache,aldi
fuori della musica
strettamente inglese,
tutte
le
decisioni
artistiche di Emi sono
prese a New York, per
l’America latina, l’Asia,
il
Medio
Oriente,
l’Africa e l’Europa.
Anche a Parigi, il
potenteamministratore
delegato di Universal
Music
France
riconosce che la sede
delgruppoèNewYork.
“Laragioneèsemplice:
gli Stati Uniti sono il
mercatopiùgrandeper
la
musica.
Però,
Universal è una major
francese
poiché
l’azionista
di
riferimento
è
francese,”
spiega
Nègre. José Eboli,
amministratore
delegato di Universal
Music a Rio, conferma
che
le
decisioni
artistiche per il Brasile
sono prese a Miami,
poi a New York. Anche
se alcune major della
discografia
sono
europee, le decisioni
artistiche sono prese
negliStatiUniti.
Per capire questa
situazione e la fragilità
della cultura “comune”
degli europei, ho fatto
inchieste a Praga,
Londra, Roma, Madrid,
Bruxelles,Copenaghen.
Ovunque ho trovato
una situazione simile:
una feconda cultura su
scala nazionale, spesso
di qualità, e talvolta
anche di successo, ma
non esportata, e una
cultura
americana
onnipresente,
che
rappresenta il “resto”
della cultura. Non
intendo
l’arte,
la
cultura storica o i
valori
veicolati
attraverso la cultura,
ma parlo di prodotti
culturali, di cultura di
massa, di cultura dei
giovani. Questa cultura
europea comune non
esiste più. L’unica
cultura
mainstream
comune
ai
popoli
europei è diventata la
culturaamericana.
“Prima
della
rivoluzione e della
caduta del comunismo
nel 1989, qui era
vietato vedere film
americani. Oggi è il
contrario:èvietatonon
vedere
un
film
americano,” dice con
autoironia
Martin
Malík, che dirige gli
uffici di Warner Bros
nellaRepubblicaCeca.
Mi trovo al numero
13dellaviaSoukenická
di Praga. Alla sede
locale di Warner tutti
sono di nazionalità
ceca, ma lavorano per
gli americani. Martin
Malík
afferma:
“Il
botteghino ceco è,
come
ovunque
in
Europa, fatto dalla
produzione nazionale e
da quella americana.
Trannequalchesingolo
film, spesso tedesco,
comeGoodbyeLenino
Le vite degli altri, il
cinema europeo in
sostanzanonesistepiù
nella Repubblica Ceca.
Di fronte ai film di
successo
hollywoodiani,
la
cinematografia
nazionale
tiene
piuttosto
bene.
In
questi ultimi anni, la
produzione ceca è
addirittura aumentata
e
i
nostri
film
raggiungono un terzo
della quota di mercato
del botteghino” (in
Europa, è la seconda
cinematografia
ad
avere risultati così
importanti sul proprio
territorio,
dopo
la
Francia).
Tecnicamente, più la
produzione nazionale
aumenta, più la quota
di cinema americano
decresce, anche se
arriva sempre al 50 e
spesso60percentodel
box-office. Come si
spiega questo successo
del cinema ceco? “Il
nostro
cinema
ha
successo grazie alle
commedie
e
soprattutto a quelle
che si chiamano teen
comedies, che hanno
unseguitoimmensotra
igiovani,anchesesono
spesso adattamenti di
formatamericani,come
American Pie o Rent,”
spiega
il
critico
cinematografico Irena
Zemanova.
“Esiste
anche
un
cinema
nazionale popolare con
commedie
in
stile
familiare, comico e
leggero, spesso con
temimoltoprovincialie
talvolta rurali. Da noi
tutto ciò ha successo,
piace
al
nostro
presidente
nazionalista, ma è
molto
ruspante
e
soprattutto non viene
esportato,” commenta
Steffen Silvis, critico
cinematografico
al
“PraguePost”.
Il
“ritorno
in
Europa”, slogan della
rivoluzione del 1989,
non ha avuto alcuna
concreta applicazione
sul piano culturale. A
eccezione
degli
slovacchi, i cechi non
hanno
particolari
legami con le nazioni
confinanti: pochi con i
tedeschi, per nulla con
i polacchi e raramente
con ungheresi, sloveni,
croati, rumeni. Gli
attuali dirigenti della
Repubblica Ceca, a
cominciare
dal
presidente
Vaclav
Klaus, si rifiutano di
pensare che l’identità
nazionale
possa
dissolversi all’interno
dell’Europa.
Alla
cultura europea tutti
hanno
tendenza
a
preferire la cultura
nazionale
o,
alla
peggio,
la
cultura
americana.
“Pur
essendo
molto
nazionalista,
il
presidente Klaus è
piuttosto
soddisfatto
della penetrazione del
cinema
americano:
Hollywood difende il
sogno americano fatto
diindividualismoenon
di giustizia sociale, di
valorifamiliarienondi
fraternità.
È
esattamente questa la
politica nazionalista di
Klaus,” mi spiega a
Praga
il
critico
cinematograficoMichal
Prochazka. Il redattore
capodel“PraguePost”,
Frank
Kuznik,
conferma
pur
relativizzando questa
evoluzione: “Nel 1989,
i cechi hanno voluto
raggiungere ‘l’Ovest’.
Vent’anni dopo si sono
resi conto che neanche
questo
‘Ovest’
concorda con la loro
identità così come non
concordava
con
il
comunismo.
Il
presidente Klaus è
euroscettico
e
protezionista,
vuole
ristabilire la cultura
cecacomesuccedecon
la musica e il cinema:
non
vuole
né
un’americanizzazione,
né
un’occidentalizzazione,
né un ritorno al
panslavismo,
ma
semplicemente
un
ritorno alla cultura
ceca.Sitratta,tuttavia,
di una sensibilità che
hanno le persone che
erano adulte prima del
1989,quellechehanno
votato per Klaus, ma
pernullapresentenelle
giovanigenerazioniche
sono
letteralmente
affascinate dal cinema
americano”. Il critico
cinematografico Irena
Zemanovaèancorapiù
chiara:“Èevidenteche
la cultura mainstream
in Repubblica Ceca è
americana e quella dei
giovani
è
quasi
totalmente
americanizzata”.
InEuropacentrale,è
addirittura probabile
che l’influenza degli
americani sia ancora
più forte di quanto si
possa immaginare. Gli
studios,
infatti,
investono spesso nei
film
nazionali
attraverso un abile
sistema
di
coproduzioni, inoltre,
dal 1989, Praga è un
laboratorio
per
Hollywood: “Molti film
cechi sono prodotti
grazie a investimenti
americani,eciòsivede
nelle sceneggiature”,
commenta
Martin
Malík alla sede di
Warner Bros a Praga.
Inoltre, gli studi cechi
hanno
un
buon
rapportoqualità-prezzo
e gli americani ci
vengono anche per
girarci i loro film.
Infine, il cinema ceco
per
quanto
forte
all’interno dei propri
confini non si esporta.
Come ovunque, c’è un
cinema nazionale, ma
the
other
cinema
(l’altro cinema) resta
americano. “I cechi
sanno fare film per i
cechi, ma solo gli
americani sanno fare
film per tutto il mondo
e per tutti,” conclude
MartinMalík.
Qualche giorno dopo
mi reco presso il
principale distributore
di film in Repubblica
Ceca, il colosso locale
Bonton
Film
Entertainment.
Mi
trovo
sulla
via
Nadrazini,allasededel
gruppo, al di sopra di
un
grande
centro
commerciale
della
periferia sud-ovest di
Praga. Bonton Film è
stata privatizzata nel
1989 e da allora è
diventata un passaggio
obbligato
per
la
distribuzione di film
nazionali e americani.
“Sui grandi mercati
come
Germania
e
Inghilterra, le major
americane sono in
concorrenza tra loro e
hannoufficipropri.Ma
nei paesi più piccoli,
nei cosiddetti mercati
secondari,
come
Portogallo, Romania o
da noi, le major
collaborano tra loro e
si sostengono: hanno
creato
delle
jointventure per distribuire
i loro film e si
appoggiano a società
locali come la nostra
peraffrontaremeglioil
mercato,” mi spiega
Ales Danielis, direttore
della
distribuzione
cinema di Bonton Film
Entertainment.
Danielis distribuisce in
esclusiva i film di
Universal,Paramounte
Fox,
mentre
la
concorrenza,
Falcon
Films,
distribuisce
Disney e Columbia.
Danielis non dice però
che per avere questa
licenza
esclusiva
rinnovata ogni anno, è
obbligato a prendere
tutti i film prodotti
dagli
studios
hollywoodiani per un
anno, naturalmente i
film di successo, ma
anche
film
più
scadenti, secondo il
principio del blockbooking,
sistema
anticoncorrenzavietato
negli Stati Uniti dal
1948, ma ancora oggi
imposto
dagli
americani in Europa
centraleeorientale.
Con questa duplice
operazione di forti
investimenti
nelle
coproduzionilocaliedi
saturazione
del
mercato
attraverso
accordi
anticoncorrenziali, gli
americani
vogliono
continuare a dominare
il botteghino di quella
che stranamente si
chiama “zone Emea”.
All’internodiun’analisi
sul
“Global
Entertainment” fatta
dallasocietàamericana
PricewatherhouseCoope
mostratami a Praga
scopro
che
questi
piccoli
paesi
sono
indistintamente
considerati dagli Stati
Uniti
all’interno
dell’Emea,
“Europa,
Middle-East & Africa”,
anche la Mpaa utilizza
questacategoria.
La potenza degli
Stati Uniti nel cinema
si ritrova nel resto
della
cultura
mainstream
in
Repubblica
Ceca.
Nell’editoria, il 60 per
cento di traduzioni è
dall’americano
(il
resto: dal tedesco il 29
per cento, dal francese
il 6 per cento e dal
russo il 2 per cento).
“Traduciamo
soprattutto dall’inglese
americano e quasi
niente più dal russo.
Con il 1989 siamo
improvvisamente
passati
dal
russo
all’inglese,” conferma
Denisa
Novotna,
responsabile della casa
editrice
ceca
Euromedia,
che
appartiene al colosso
Bertelsmann.
Sulla
piazza Venceslao visito
una delle principali
librerie della città,
sono
sorpreso
nel
vedere da lontano
scaffali di libri in
tedesco, inglese e
anche
francese,
apparentemente
simboli della diversità
culturale, ma quando
mi avvicino ai testi,
constato
che
la
maggiorpartediquesti
titoli sono identici,
spesso
bestseller
americani tradotti in
diverselingue.
Nella
musica,
i
gruppi
anglosassoni
sono allo stesso livello
del
rock
locale
particolarmente vitale
e dinamico, anche
perché prima del 1989
era proibito, i capelli
lunghi spaventavano i
comunisti. Ma le sale
da
concerto
programmano poco i
gruppi
europei:
i
grandi artisti sono
soprattutto cechi o
anglosassoni (tra loro
c’è qualche inglese). I
programmi
televisivi
sono
ancora
più
americanizzati, spesso
sono rifacimenti in
ceco di serie di
successo,
oppure
vengono acquistati i
format: “Negli anni del
comunismo
la
televisione trasmetteva
molti film di Bollywood
e serie televisive di
Hong Kong, prodotti
poco
costosi
e
politicamente
inoffensivi.
Adesso,
questi prodotti ‘esotici’
sono
destinati
ai
festival e si guardano
soprattutto programmi
americanizzati”,
commenta il critico
cinematografico
MichailProchazka.
Laculturaamericana
guadagna terreno a
spese della cultura
europeaedelle“altre”,
manonindebolisceper
nulla la cultura ceca.
“Prima
del
1989
sognavamodifarparte
della cultura europea.
Ma dopo la rivoluzione
abbiamo scoperto che
era un’illusione: non
esiste oggi una cultura
comune in Europa
centrale e orientale.
Siamo tutti egoisti:
vogliamo
costruire
relazionispecifichecon
Germania, Inghilterra,
Stati Uniti e non con i
paesiconfinanti.Icechi
sono quasi totalmente
atei, e guardano i
polacchi, che sono in
gran parte religiosi,
con
preoccupazione;
detestanoglislovacchi;
non considerano gli
ungheresi.
Chi
vorrebbevederequiun
film
ungherese?
Nessuno! È difficile
costruire una cultura
comune con i paesi
confinanti se non ci
sono
relazioni.
A
beneficiare di questo
egoismo europeo sono
gli
americani,”
conferma il critico
cinematografico
di
“Prague Post”, Steffen
Silvis.
Il vero sconfitto dal
1989 all’interno degli
scambi culturali in
Europa centrale è la
Russia. “Con la caduta
del
comunismo
è
scomparsa la cultura
‘panslava’,”
spiega
Tomas
Hoffman,
direttore della casa di
produzione
Infinity.
“Non c’è più alcun
legame con i russi: su
questo aspetto siamo
tutti d’accordo, cechi,
slovacchi, ungheresi e
rumeni. Non vogliamo
più sentire parlare di
russi. Non ci fanno più
paura,
sono
semplicemente
inesistenti.
Ce
ne
freghiamo
completamente di loro.
La
Russia
non
rappresenta più un
riferimento culturale
per i cechi. Il vuoto
lasciato
dai
cori
dell’Armata rossa è
stato colmato da Mtv
Europa.”
Le
divisioni
particolarismi
culturaeuropea
e
i
della
Recentemente
ho
trascorso alcuni giorni
in
Belgio
e
alla
Commissione europea
e ho potuto avere
ulterioriconfermedella
fragilità della cultura
europea. Peraltro, in
tema
di
cultura
dell’intrattenimento, a
Bruxelles ho trovato
una situazione simile a
quella verificatasi a
Beirut.
Nella capitale del
Belgio,
valloni
e
fiamminghi sono in
aperto contrasto tra
loro: i primi hanno
paura dell’“oppressore
olandese” (così si è
espresso
un
mio
interlocutore
francofono
a
Bruxelles), i secondi
rifiutano un Belgio che
nega la loro cultura e
la loro lingua. Le
rivalitàeledifficoltàdi
una cultura condivisa
sono ben illustrate dal
fatto che non esiste un
ministero della Cultura
belga (federale). Ci
sono
invece
tre
ministeri: uno per i
francofoni, uno per i
fiamminghi e uno per
la piccola comunità di
lingua tedesca. Poi ci
sono le deleghe di
questi ministeri per la
regione di Bruxelles
(uno per francofoni,
uno per i fiamminghi e
uno per i progetti
bilingue). Dunque, in
totale, ci sono sei
ministri!
L’incontro con Alain
Gerlache,expresidente
di
Rtbf,
radiotelevisione
pubblica
francofona,econPeter
Claes, uno dei direttori
della Vrt, televisione
belga
di
lingua
olandese,
mi
ha
permesso di capire
concretamente
il
significato di questa
guerrainterna.
Le due emittenti
hannosedenellostesso
edificio, ma ciascuna
haunproprioingresso,
un proprio servizio di
sicurezza
e
studi
propri.
Il
lungo
corridoio che le separa
sembra il Muro di
Berlino. Ho invitato
Peter
Claes
ad
accompagnarmi nella
“zona francofona” –
dove non era mai
andato – e varcata la
soglia, questo giovane
uomointelligentemiha
chiesto di fare insieme
a lui il confronto tra i
divani, i distributori di
bibite e gli studi.
Secondo
questo
confronto, per gli studi
Vrt è all’avanguardia, i
divani migliori sono
quelli di Rtbf, mentre
non
eravamo
d’accordo, ovviamente,
sulcibo.Naturalmente,
Peter Claes scherzava.
Ma
quando
siamo
tornati dalla parte di
Vrtmihafattopensare
ai cristiani di Beirut
chesisentonoalsicuro
quando rientrano ad
Ashrafieh, la zona
cristiana, dopo essere
stati – fatto raro – a
Haret
Hreik,
il
quartierediHezbollah.
“Del cantante Arno
mi piacciono le parole:
il Belgio è un paese
piccolo,
non
è
presuntuoso come i
francesi, egocentrico
come
gli
inglesi,
bisogna accontentarsi
di ciò che si ha. È
fiammingo,macantain
francese e olandese,”
raccontaPeterClaesdi
Vrt in un francese
perfetto.“Daunaparte
ci sono i fiamminghi
che
accusano
i
francofonidiavereuna
cultura presuntuosa e
arrogante, come quella
dei
registi
fratelli
Dardenne; dall’altra ci
sono i francofoni che
rifiutano il cinema
fiammingo
americanizzato e quel
pop
nordico
da
vichinghi,”
sospira
Alain Garleche, ex
presidente di Rtbf, un
francofono che parla
fiammingo. Garleche è
stato lo sceneggiatore
diunbeldocumentario
intitolato Bye
Bye
Belgique: sul modello
deLaguerradeimondi
di Orson Welles, i
programmidiRtbfsono
stati improvvisamente
interrotti
per
annunciare
che
i
fiamminghi
avevano
fatto la secessione; è
stato
mandato
in
diretta alla televisione
con veri uomini politici
efintireportage.Ilfilm
ha impressionato il
pubblico, forse non era
poi così tanto una
finzione.
“Tra fiamminghi e
francofoni non c’è
guerra,
è
ancora
peggio,”dicePetervan
der Meersch, redattore
capo di “Standaard”,
principale quotidiano
belga
in
lingua
olandese. “Il nostro
problema
ormai
è
l’indifferenza.
Gli
abitanti
di
lingua
olandese non sono
neanchepiùinteressati
aquantofannoquellidi
lingua
francese
e
viceversa. Ci sono due
culture
e
due
televisioni
nazionali,
ma ciò che è più grave
è che anche l’opinione
pubblica è divisa in
due. Le persone non si
parlanopiù.”
Jan
Gossens,
fiammingo e patron di
Kvs, importante luogo
culturale di lingua
olandese a Bruxelles,
condivide questo punto
di vista: “I fiamminghi
sono
ossessionati
dall’idea di fare la loro
nazione e affermano
che il Belgio è una
nazione artificiale. Io
preferisco
pensare
invece che siamo tutti
ilprodottodimolteplici
identità
non
cristallizzate.
Per
esempio, l’inglese – e
non il francese né
l’olandese
–
sta
prendendo
il
sopravvento
e
sta
diventando la lingua
deibelgi”.
Laculturaamericana
conquista terreno sulle
divisioni degli europei.
A poco a poco, l’unica
cultura comune dei
belgi tende a essere
quella americana –
ovviamente
con
l’eccezione di Tintin, il
fumetto letto dalle due
parti
della
Linea
Maginot. Anche se è
Steven Spielberg ad
avere in progetto di
farne un adattamento
cinematografico. Così
l’America si appropria
di un simbolo del
Belgio, come aveva
fattoconilkungfueil
panda dei cinesi. Nel
frattempo, nel 2008
qualcuno ha avuto
l’idea di mettere in
vendita il Belgio su
eBay.
La
cultura
mainstream
europea
oggi si sta indirizzando
verso il modello belga.
Battaglie linguistiche,
di identità culturali,
crescente
inconsapevolezza della
cinematografia e della
musica
degli
altri
paesi, poche letture
comuni, frazionamento
comunitario. Con tutte
queste divisioni, la
cultura
americana
avanza
inesorabilmente.
All’interno di questo
fragile
scenario
europeo
mi
sono
chiesto quali fossero i
punti di forza e le
possibilità del Vecchio
continente.Hogiratola
domanda
a
molti
interlocutori
e
le
risposte
fornitemi
compongono
un
complesso mosaico. A
Bruxelles mi è stato
detto:“Rifarelacultura
europea
è
come
cercare di ricomporre
pesci integri a partire
dalla zuppa di pesce”.
AParigiilproduttoree
distributore di cinema
Marin Karmitz è più
ottimista: “Il nostro
punto di forza è che
siamo degli artisti e
dobbiamo valorizzare
questoaspetto,bisogna
valorizzare l’arte”. Il
produttore
italiano
Sandro
Silvestri,
intervistato durante le
riprese di un film a
Cinecittà, dice invece
che “a caratterizzare il
cinema
europeo
è
l’indipendenzaequesta
indipendenza è vitale,
soprattuttorispettoalla
televisione
che,
ovunque,èinposizione
di
dipendenza,
specialmente in Italia
grazie a Berlusconi”.
Rappresentanti della
cultura
francese
intervistati in diversi
paesi pensano anche
loro che “dobbiamo
restare degli artigiani
di fronte all’industria
americana: dobbiamo
ripartire da ciò che
siamo,elanostraforza
sono gli indipendenti,
non le major, il cinema
e la cultura d’autore,
nonildivertimento”.In
Europa, molti puntano
sulle
nicchie
di
mercato,
sulla
specializzazione
e
rifiutano la cultura
mainstream.
Tutti
hanno sostenuto la
“diversità
culturale”
come una sorta di
arma, una comoda
espressione per ogni
occasione che sembra
ormai
l’unico
contrappeso
all’imperialismo
culturale
americano.
Molti mi hanno parlato
dell’Africa.InAfricagli
americani non ci si
avventurano, “perché
non
è
redditizia”,
“perché
non
è
abbastanza ricca per
loro”, “perché non ci
capiscono nulla”, mi è
stato detto. Sembra
dunquecheinAfricaci
siano solo gli europei.
Allora sono andato a
verificare.
Londra
e
Parigi,
capitali della world
musicafricana
In Africa, il potere di
attrazionedellacultura
europea continua a
essere forte e città
come Londra e Parigi
sono ancora crocevia
dei flussi musicali
provenienti da questo
continente.
Mi trovo nell’auto di
Etienne Sonkeng, il
sindaco di Dschang,
cittàdelNord-ovestdel
Camerun.
Improvvisamente
il
sindaco
chiede
all’autista di fermarsi
poiché ha visto un
abitante della città
costruire una casa
senza permesso: il
sindaco
scende
dall’auto di funzione e
minaccia la persona di
far demolire l’edificio
abusivo.
Tornando
sull’auto mi dice poi:
“Guardi là, spaghetti”.
Di questi “spaghetti”
ne ho visti spesso al
Cairo,
Shanghai,
Mumbai, Damasco e
neicampipalestinesidi
GazaeBetlemme:sono
innumerevoli fili che
collegano le case tra
loro. “Non sono fili
elettrici, né per il
telefono,”
precisa
Etienne Sonkeng, ma
per
le
televisioni
satellitari,
“anche
questi sono illegali e
riforniscono tutto un
quartiere a partire da
una sola parabola. In
Africa, questo tipo di
illegalità
è
particolarmente diffuso
e si potrebbe dire che
si tratta di ‘home
cinema’ grandi quanto
intere città.” Questi
“spaghetti” sono ben
visibili e penzolanti,
collegano una casa
all’altra, così con un
solo
abbonamento
pagato possono vedere
la televisione mille
famiglie: gli africani
hanno inventato il
“cavo aereo” invece di
quello
sotterraneo.
“Qui
in
Camerun,
esistono
quasi
duecento
lingue
nazionali,
dunque
franceseeinglesesono
una lingua comune. La
gente magari vive in
case di fortuna, ma
tutti possono vedere
cinquanta
canali
francesi,
inglesi
e
americani
senza
pagare,” dice estasiato
il sindaco che non ha
mai
pensato
di
reprimere il fenomeno.
A Dschang non si
possono costruire case
abusive, ma si possono
ricevere illegalmente
tutte le televisioni del
mondo.
Il giorno dopo mi
trovo
a
Yaoundé,
capitale del Camerun.
Sui mercati e lungo i
viali di questa grande
città
dell’Africa
centrale si trovano
numerosi cd e libri
venduti al mercato
nero. Ci sono film
Disney in dvd in
versione francese, con
la custodia fotocopiata
a
colori;
molte
commedie
musicali
americane, il rap di
TupacShakureancora
molte audiocassette. I
prodotti culturali non
sono venduti in negozi
di dischi o librerie, ma
sono
venduti
dai
sauveteurs
(abusivi),
così vengono chiamati
in Camerun i venditori
ambulanti abusivi. Qui
il mercato nero è la
norma,
e
non
l’eccezione,
e
l’abbondante
polizia
non è minimamente
interessata
alla
questione.
In Africa, la cultura
della
strada
è
fondamentale,
e
attorno a essa si
sviluppa il commercio.
Anche i libri sono
venduti al mercato
nero, fotocopiati per
abbattereicosti,infatti
un libro nuovo costa
quindicimila
franchi
Cfa, mentre un libro
fotocopiato si compra
con
quattromilacinquecento
franchi
Cfa.
Data
questa diffusione del
mercato illegale, è
difficile
avere
statistiche
affidabili
sullevenditedimusica,
filmelibri.
A Youandé, Mal (è il
suo vero nome e
ometto il cognome per
evidenti ragioni) mi
spiegacomefunzionail
mercato
nero
dei
dischi. “La pirateria di
prodotti culturali è un
settoreeconomicovero
e proprio. Impiega
centinaia di persone
nella produzione, nella
distribuzione e nella
vendita.”
Questo
sistema
interessa
milioni di album, si
tratta di un esempio in
scala
ridotta
dell’industria culturale
legale.Icdeidvdsono
fabbricati in Cina e
masterizzati
in
laboratori illegali a
Cotonou
(Benin),
Douala
(Camerun),
Abijan (Costa d’Avorio)
e Lomé (Togo) – tutte
queste città sono dei
porti.
Mal
fa
rifornimento a Douala,
il grande porto del
Camerun, e vende i cd
nelle vie di Yaoundé
ogni
giorno
della
settimana, domeniche
incluse. “Il 99 per
cento dei cd venduti in
Camerun è piratato,”
afferma Mal, che non
ha nessuna prova del
dato che fornisce, ma
tutto concorre a far
pensare
che
sia
plausibile.
Marilyn Douala Bell,
la figlia di uno dei
principali
capi
dell’etnia bamileke di
Douala, la più grande
città del Camerun, mi
spiega a lungo che
tuttalavitaculturalein
Africa è organizzata
attraverso
circuiti
paralleli.Peresempio,i
“cine-club”
sono
organizzati a casa di
privati che hanno un
videoregistratore
e
invitanogliabitantidel
quartiere,
a
pagamento, a vedere i
film.
Questa
rete
parallela compensa lo
scarso numero di sale
cinematografiche nelle
città
dell’Africa
subsahariana.
Anche se i prodotti
culturali
piratati
venduti nelle strade
africane sono spesso
americani,
l’Europa
continua a essere un
passaggio
obbligato
periflussidicontenuti
all’interno
del
continente
africano.
Nella più classica delle
tradizioni
coloniali,
Londra e Parigi in
modo
particolare
hanno
un
ruolo
fondamentale per gli
scambi con l’Africa
anglofonaeconl’Africa
francofona. Accade un
po’ come a Miami per
l’America latina, Hong
Kong e Taiwan per la
Cina, Beirut e Il Cairo
per il Medio Oriente:
LondraeParigisonole
capitali
esterne
dell’Africa.
In Camerun, in un
ristorante di Yaoundé,
incontroEricdeRosny,
un gesuita diventato
scrittore:
“Qui,
in
ambito musicale, ci
sono quelli che si
ispirano alla tradizione
e quelli che imitano
l’Occidente,
ovvero
Parigi. La linea di
divisione nella cultura
popolare si colloca qui,
fra
tradizione
ed
Europa.
Inoltre,
sempre più spesso i
cantanti camerunensi
aggiungono
termini
inglesi nelle canzoni
francesi, fa più hip. È
un
grande
cambiamento”.
Da tempo, Londra e
Parigipermettonoaun
artista africano di
affermarsiediottenere
“l’appeal
internazionale”
necessario
al
suo
riconoscimento.
“Quando un artista
diventa famoso nel suo
paese, deve passare
perParigiperacquisire
credibilità
e
conquistare poi tutto il
continente
africano.
Salif Keita del Mali,
Mori
Kanté
della
Guinea,
Youssou
N’Dour del Senegal,
Manu Dibango del
Camerun, Ray Lema
del Congo, il gruppo
senegalese
Touré
Kunda: tutti questi
artisti sono diventati
celebri in Francia,”
dice Christian Mousset
che dirige il festival
francese
Musiques
Métisses, intervistato
qualche mese dopo al
WomexdiCopenaghen,
la grande fiera di
musica“world”.
Come
si
spiega
questo
ruolo
importante
assunto
dall’Europa in Africa, è
un fenomeno che sarà
duraturo? “A Parigi e
Londra ci sono studi di
registrazione di qualità
che mancano in Africa,
anche se ce ne sono di
buoni a Bamako nel
Mali, Abijan in Costa
d’Avorio, Kinshasa in
Congo e Dakar in
Senegal.Cisonoanche
numerose
etichette,
molto rare in Africa. A
Londra ci sono festival
come il Womad, i Bbc
Awards per la World
Music, ci sono agenti,
produttoriepromoter,”
spiegaSambaSene,un
senegalese di Dakar,
cheviveaEdimburgoe
che ho incontrato a
Copenaghen.
La
situazione politica e le
tensioni diplomatiche
tra paesi non facilitano
gli scambi: spesso è
impossibileorganizzare
una tournée in Africa,
gli
artisti
non
ottengono il visto, per
esempio per andare
semplicemente
da
Yaoundé a Dakar. Le
dogane
impediscono
spesso il trasporto di
strumenti musicali e
materiale. E le guerre
civiliinCostad’Avorio,
nella
Repubblica
democratica del Congo
e in Ruanda non
facilitano di certo le
cose.
“Da
Parigi,
riusciamo
a
raggiungere
tutta
l’Africa,mentrequando
si sta in Africa non si
riesce
neanche
a
dialogare tra paesi
confinanti,”
dice
avvilito
Luc
Mayitoukou,
responsabile di Zhu
Culture
a
Dakar
(intervistato
a
Copenaghen).
In
Europa ci sono anche i
media.
“Da
Parigi
raggiungiamo tutte le
minoranze africane in
Francia grazie a Rfi o
alla playlist di France
Inter e Radio Nova, gli
inglesi fanno la stessa
cosa con la Bbc,”
conferma Claudy Siar,
presentatore di punta
della musica africana
su Rfi e direttore di
Tropiques
Fm,
intervistato a Parigi. E
poi c’è la diversità
africana: a Londra e
Parigi ci sono tutte le
minoranze
africane,
un’eterogeneità
che
non esiste in nessuna
parte del continente
africano.
Infine,
ovviamente,
c’è
il
denaro.
“Un
solo
concerto pagato in
euro o sterline in
Europa porta più di
tuttiiconcertifattiper
un anno in Africa
pagatiinCfa,”constata
tristemente
Samba
Sene.
InAfrica,lamusicaè
stata
a
lungo
a
immagine
dell’aviazione.
La
compagnia aerea Air
Africa che faceva voli
interni al continente è
fallita.Così,perandare
daunacapitaleall’altra
dell’Africa,
bisogna
transitare per Parigi o
Londra. Per molto
tempo è accaduta la
stessa cosa con la
musica.
La
ripartizione
geografica
ereditata
dall’epoca coloniale è
piuttosto immutabile:
Senegal,
Camerun,
Costa d’Avorio, CongoKinshasa, Mali e Africa
dell’Ovest hanno come
punto di riferimento
Parigi (o Bruxelles per
la
Repubblica
democratica
del
Congo),
mentre
Nigeria, Etisia, Ghana,
Uganda, Africa dell’Est
e Africa del Sud e
ovviamenteilSudafrica
hanno come punto di
riferimento Londra. Un
ristretto numero di
paesi
di
lingua
portoghese,
come
Mozambico,
Angola,
Capo Verde, Guinea
Bissau, avevano come
punto di riferimento
soprattuttoLisbona.La
circolazione
dei
prodotti culturali in
Africaseguivalelingue
elastoriacoloniale.
Queste dinamiche di
vecchia data tuttavia
stanno cambiando. Ciò
che è avvenuto alla
Spagna con l’America
latina, ovvero il lento
cambiamento
della
cartografiadeimediae
delle industrie creative
con l’ascesa di potenti
gruppi
come
il
messicano Televisa e il
brasilianoGloboTv,sta
accadendo a Francia e
Inghilterra in Africa. I
cambiamenti
della
musica
grazie
al
digitale, che facilita la
produzione
e
la
diffusione locale, il
successo
del
rap
africano su tutto il
continente,
dovuto
anche alla diminuzione
dei visti concessi per
andare in Europa,
hanno
portato
gli
africani a cominciare a
organizzarsiinproprio,
senza più dovere – o
potere – passare per
Londra o Parigi. Agli
scambi
nord-sud
subentrano quelli sudsud.
Internet
fa
cominciare tutto da
zero. In Africa, ormai
ogni musicista ha la
propria
pagina
su
MySpaceeigruppinon
hanno più bisogno
degli
europei
per
diffondere il loro rap.
“Glibastaassistereagli
Hip-Hop Awards di
Dakar, al festival Rap
Assalamalekoum
in
Mauritania, al Waga
Hip Hop in Burkina
Faso,” spiega Philippe
Contrath, direttore del
festival
Africolor,
intervistato a Parigi.
Internet modifica in
profondità la mappa
degli
scambi
di
contenuti in Africa,
offre nuove possibilità
di distribuzione, a
vantaggio soprattutto
delrap,musicadel“do
it
yourself”
per
eccellenza. Questo è
anche un esito della
globalizzazione
delle
persone frenata dalle
ambasciate europee: “I
francesi hanno una
politicadeipermessidi
soggiorno
inadatta
all’epoca
della
globalizzazione,fattadi
disprezzo
e
di
mancanza
di
condiscendenza,
che
sanzionaduramentegli
artisti africani e li
spinge a viaggiare non
più verso Parigi, ma
verso Dakar e Lagos,
versogliStatiUnitieil
Sudafrica”,
dice
dispiaciuto
Claudy
Siar.
In questi ultimi anni,
due paesi in modo
particolare
hanno
assunto
un
ruolo
fondamentale
nello
scenario africano, a
vantaggio soprattutto
dell’ascesa della lingua
inglese in tutto il
continente: Nigeria e
Sudafrica. “Le nuove
capitali
culturali
dell’Africa
sono
anglofone, questo è il
problema per Parigi,”
commenta Mayitoukou,
responsabile di Zhu
CultureinSenegal.
LaNigeria,anzitutto,
èuncolossodell’Africa
subsahariana:
è
il
paese più popolato del
continenteafricanocon
centocinquanta milioni
diabitantiedèunodei
paesi più ricchi, con
un’economia dinamica
grazie ai giacimenti di
petrolio nel Delta del
Niger. Anche se metà
della popolazione vive
al di sotto della soglia
di povertà, nonostante
la grande corruzione e
la
mancanza
di
sicurezza per la vita
delle
persone,
la
Nigeria
possiede
influenti
industrie
creative. La celebre
Nollywood,contrazione
diNigeriaeHollywood,
produce dagli anni
novantaoltremillefilm
all’anno.
Sarebbe
dunque
il
terzo
produttore di film al
mondodopoStatiUniti
e India. Il confronto,
tuttavia, si ferma qui
poiché
la
grande
maggioranza di questa
produzione,
opportunamente
chiamata
“home
video”, è fatta senza
cinema
e
senza
pellicole. Si tratta
quasi interamente di
video
con
piccoli
budget,
trame
rudimentali,
attori
improvvisati
e
clamorosierroriditipo
tecnico. Questi home
video sono girati in
qualche giorno con
budgetdimenodimille
euroesonoriservatial
consumoadomiciliosu
videoregistratore
poichégiraredinotteè
pericoloso e perché
manca un circuito di
sale cinematografiche.
Il prezzo a buon
mercato sollecita la
produzione e frena la
pirateria. Così, con
attrici
procaci,
sceneggiature piene di
pratiche magiche e
sesso, di ricchi africani
imborghesitiedicattivi
ancora più crudeli che
nella realtà (cosa non
da poco in questo
paese), i film di
Nollywood hanno un
successo mainstream
inNigeriaeovunquein
Africa occidentale. “I
film nigeriani sono un
vero
e
proprio
fenomeno in Africa
nera. Se i produttori
decidessero
di
sottotitolarli
in
francese, avrebbero un
gran successo anche
nell’Africa francofona,”
sostiene Remi Sagna,
direttore
dell’Organizzazione
internazionale
della
francofonia intervistato
in
Camerun.
Per
aumentare
le
esportazioni
e
l’acquisto di diritti
televisivi,
Nollywood
privilegia
per
il
momento le produzioni
in inglese e punta sui
mercati
dell’Africa
anglofona, soprattutto
l’Africa dell’Est e,
naturalmente,
il
Sudafrica.
Il
Sudafrica
è
diventato infatti il
modello da seguire e il
punto di riferimento
per tutti i paesi
africani, convinti di un
nuovo scenario sudsud. “Ormai, un artista
africano dispone di
tutto ciò di cui ha
bisogno a Johannes
burg: trova studi di
registrazione,
etichette, denaro, una
legislazione
che
protegge il copyright.
Stiamo diventando la
capitale della cultura,
dell’intrattenimento e
dei media in Africa,”
spiega Damon Forbes,
direttore dell’etichetta
Sheer
Sound,
che
appartiene al gruppo
Sheer, un’importante
major
musicale
sudafricana
(Forbes,
intervistato
a
Copenaghen,
è
originario
dello
Zimbawe e vive da
tempoinSudafrica).
Il Sudafrica, con
quarantanovemilionidi
abitantieunPilinforte
crescita, che da solo
ammonta a un quarto
di quello di tutto il
continente, è oggi un
paese
emergente,
l’unico
a
potersi
chiamarecosìinAfrica.
È ricco di materie
prime,
soprattutto
minerali,
e
ciò
contribuisce a questo
eccezionaledinamismo.
Coinvoltodallacrisidel
2008,ilpaesehaatteso
i Mondiali di calcio del
2010 per rilanciare
l’economia.
In
campo
cinematografico,
il
Sudafrica del post-
apartheid, ha ormai
unacrescenteinfluenza
con il recente successo
di film come District9,
Disgrace e Tsotsi.
Questa cinematografia
nazionale in pieno
sviluppo è ampiamente
sostenuta in termini
artistici,
tecnici
e
finanziari dagli studios
hollywoodiani
che
hanno identificato il
Sudafrica come paese
determinante per il
futuro
delle
loro
produzioni locali e per
il
loro
box-office
mondiale.Nellamusica
ilsuccessoèancorapiù
evidente. Per esempio,
il Moshito, il salone
dell’industria musicale
del
Sudafrica,
è
diventato
un
importante crocevia e
un mercato decisivo
per la musica africana.
Anche
gli
europei
cominciano a prendere
in
considerazione
questa nuova realtà, di
cui rischiano di essere
le prime vittime, e nel
gennaio
2010
il
Sudafrica
è
stato
l’invitato d’onore del
Midem,
la
Manifestazione
internazionale
dell’industria musicale
aCannes.
Infine, uno degli
ambiti in cui è più
sorprendente
il
cambiamento è quello
della battaglia sui
diritti sportivi. Se si
prende per esempio la
premiere
league
inglese di calcio, i cui
interessi sono i più
costosiepiùimportanti
per lo sviluppo di
un’offerta televisiva a
pagamento, l’Africa è
ormai suddivisa in tre
zone: il mercato arabo,
Maghreb incluso, dove
Abu Dhabi Tv ha
acquisito i diritti per
330 milioni di dollari
sottraendoli
ad
Al
Jazeera;laNigeriaèun
mercato a sé stante e i
diritti sono ormai nelle
mani
del
colosso
nigeriano Hi-Tv; infine
il Sudafrica e il resto
dell’Africa
subsahariana, in cui i
diritti
sono
di
Multichoice del gruppo
sudafricano Naspers.
Una
suddivisione
significativa.
“Ilnostroproblemaè
che però ci manca la
massa
critica.
Il
mercato interno è
insufficiente, tanto più
che è frammentato in
un paese con tredici
lingue
ufficiali.
Dobbiamo
dunque
avviarciconforzaverso
l’esportazione.
Non
tanto verso l’Africa,
poiché le vendite sono
scarse a causa della
pirateria e poiché la
nostra influenza è
limitata
nell’Africa
francofona e di lingua
portoghese.
Per
diventare la capitale
culturale
del
continente,ilSudafrica
deve fare ancora molta
strada. Ci restano il
mercato europeo e
soprattutto
nordamericano.Inostri
vantaggi
sono
numerosi e i nostri
artisti sono accolti
bene negli Stati Uniti.
E poi, c’è il Sud.
Stiamoentrandoinuna
nuova fase, quella del
dialogo
sud-sud,”
commenta
Damon
Forbes,
direttore
dell’etichetta
Sheer
SoundaJohannesburg.
Per gli europei, non
c’è dunque solo la
concorrenza
di
Sudafrica, Nigeria e
Stati Uniti, ma sta
emergendoconsempre
più forza la nuova
concorrenza dell’asse
sud-sud,
anche
proveniente
dall’esterno
del
continente
africano.
Stainfatticrescendoin
Africa la presenza del
Brasile. La cosa si
spiega con i legami
storici con i paesi
africani
di
lingua
portoghese, ma anche
conlarecentestrategia
del Brasile, dove la
popolazione è in parte
nera, di diventare una
capitale esogena del
continente. Una città
brasiliana e nera come
SalvadordeBahiaoggi
intende
affermarsi
come capitale della
musicaafricana.
I cinesi non sono da
meno.
Hanno
fortemente investito in
quella che si chiama
ormai “Cinafrica”. La
loro presenza è ancora
principalmente di tipo
industriale, legata alle
infrastrutture,
alle
materie prime e ai
trasporti:
nel
continente africano ci
sarebbero già mille
imprese
cinesi
e
cinquecentomila
lavoratori cinesi. Con
l’aumento degli scambi
commerciali, la Cina
provvede
anche
a
rifornire l’Africa di reti
senza fili e di fibre
ottiche, che utilizzano
in particolare i cavi
aerei, un’alternativa ai
cavi sotterranei, più
costosi. A Brazzaville,
una società cinese sta
costruendo la nuova
sede della televisione
nazionale congolese; la
stessa cosa avviene in
Guinea. E siamo solo
agli inizi. Dopo il
settorehardsaràpoila
volta di quello soft. È
inoltre possibile anche
l’esportazione
di
contenuti, quelli che
provengono
dallo
sviluppo
della
produzione
cinematografica cinese
edelpopinmandarino.
L’Africa sarà allora
invasa da prodotti
culturali cinesi a buon
mercato, accessibili e,
mi hanno detto alcuni
ufficiali
cinesi,
“desiderati, perché i
valori asiatici sono più
compatibili con i valori
africani rispetto a
quelli occidentali”. Ci
saràspazioancheperil
mercato
dell’informazione.
I
cinesi hanno lanciato
nel 2009 “Africa”,
un’importanterivistadi
informazione. Le loro
emittenti internazionali
in inglese sono diffuse
sulcontinenteneroesi
dice si stia avviando
un’emittente cinese di
informazione. Questo
piano mi è stato
descritto
con
precisione
da
Fu
Wenxia,undirigentedi
Smeg (Shanghai Media
and
Entertainment
Group),
uno
dei
principaligruppimedia
pubblici cinesi. Stando
a quanto dice questo
ufficiale intervistato a
Shanghai,
i
cinesi
prevedono
di
aumentarefortementei
loro investimenti in
Africa nei settori delle
tecnologie,
dell’audiovisivo
e
dell’informazione nei
prossimidiecianni.
“Si corre il rischio
che nel settore della
cultura
africana,
Francia e Inghilterra
vengano sostituite dal
Brasile e dalla Cina
all’interno del nuovo
dialogo sud-sud. Per
l’Europa sarebbe un
problema, ma per gli
africani ciò aprirebbe
nuove prospettive e
nuovi mercati,” spiega
Marc
Benaiche,
animatore
di
Mondomix,
una
piattaformafrancesedi
musiche del mondo.
Dopo la musica sarà
dunque la volta di
cinema, televisione e
informazione? Per il
momento in Africa non
circolano
contenuti
cinesi, e la questione
linguistica,
probabilmente,
continuerà
a
rappresentare
un
problema. Ma fino a
quando?
Unultimoesempiodi
questaverarivoluzione
geopolitica
dei
contenuti è il caso di
Naspers. Naspers è un
colossosudafricanonei
media, inizialmente si
occupava di stampa e
televisione, poi dagli
anni
ottanta
ha
diversificato
la
produzione puntando
sulla televisione e dal
2000 su internet, con i
social network e le
messaggerieistantanee
per telefoni cellulari
(alternativa agli sms
nei paesi con un basso
tenoredivita).Primadi
puntare su internet, i
dirigenti di Naspers
hanno
deciso
di
puntare
sulla
televisione satellitare e
sulla telefonia mobile
per diffondere i loro
contenuti, consapevoli
del fatto che, nel
contesto africano, non
esisteva ancora un
diffuso uso privato di
internet: come nella
maggiorpartedeipaesi
in via di sviluppo,
l’accesso a internet
avviene
in
luoghi
collettivi, i cybercafé e
gli
uffici.
Nel
contempo, Naspers ha
investito in campo
internazionale e dagli
anni
novanta
ha
aumentato
le
partecipazioni
nei
media
dell’Africa
subsahariana,
del
Sudest
asiatico
e
dall’inizio del nuovo
millennio si è orientato
sui paesi emergenti,
anzitutto
Russia,
Brasile
e
Cina.
Costruendo legami con
l’Asia e l’America di
lingua portoghese, il
gruppo
sudafricano
spera di diventare uno
dei
grandi
gruppi
media
dei
paesi
emergentiefavoriregli
scambi dei contenuti
secondo una logica
sud-sud.
Gli europei, anzitutto
i francesi e gli inglesi,
incontrano dunque una
certa concorrenza sul
continente
africano,
dove, con un certo
spirito
paternalista
ancora
tinto
di
colonialismo,
si
credevano punti di
riferimento assoluti. Il
fatto che l’economia
del continente nero si
orienti
verso
il
Sudafrica
e
verso
Brasile e Cina non è di
buon auspicio per
l’Europa.
Questo
fenomeno
dimostra
tuttavia
che
sta
avvenendo
un
cambiamento
inevitabile
degli
equilibri
culturali
internazionali e degli
scambi dei flussi di
contenuti
nell’epoca
dellaglobalizzazione.
Ai confini dell’Europa,
dell’Asia e del mondo
arabo:
la
Turchia
americanizzata
Per
misurare
le
fragilità dell’Europa, e
per concludere questa
inchiesta ho deciso di
andare in Turchia, ai
confini del continente,
alla sua frontiera, tra
Asia
e
mondo
musulmano,traEuropa
eAmerica.
Ays‚e Böhürler è
un’intellettuale
musulmana, porta il
velo e si definisce
islamista. È regista,
realizza documentari
ed è produttrice di
Canal 7, un’emittente
turca vicina al potere
islamico,
all’interno
dellaqualesioccupadi
programmi
per
le
donne e i bambini. La
incontro nel suo ufficio
di Istanbul, dove mi
accoglie con contenuta
benevolenza
e
approfitta del tempo
della traduzione per
consultare
freneticamente la sua
casella
di
posta
elettronica su Gmail su
un computer Apple.
“Noi turchi siamo gli
unici a fare sintesi
dellecultureeuropeee
siamogliuniciafornire
al continente una reale
diversità.
Siamo
l’estremo
Oriente
dell’Europael’estremo
Occidente dell’Oriente.
Di
fronte
al
bombardamento della
cultura
americana
riusciamoaproteggere
la nostra cultura. Il
marxismo
ieri,
l’islamismo oggi, il
femminismo
delle
donne musulmane, per
esempio, sono tutti
modi attraverso cui
mantenere
questa
identità. Abbiamo il
nostro modo di restare
turchi
di
fronte
all’Occidente.”
Ays‚e
Böhürler si definisce
“semi-femminista”
e
sostiene che il velo sia
“unsegnodimodernità
e di reazione al
bombardamento della
cultura
americana”
(ripete
l’espressione
più volte). Critica la
cultura
dell’intrattenimento
che
“sminuisce
la
donna e la riduce a un
oggetto, a un corpo,
alla sua bellezza”, ma
considerandosi
moderata,rifiutaanche
i
dettami
sull’abbigliamento
degli islamisti radicali.
“In Turchia, siamo il
simbolo di un islam
moderato. C’è una
controcultura, con una
musica
islamica,
televisioni e cinema: è
il nostro ‘christian
rock’.”
Ays‚e
Böhürler
prosegue: “Il problema
della cultura turca è
cheèmoltoparticolare
e specifica del nostro
paese. Produciamo una
cultura ‘space-specific’
che, per definizione,
non
può
essere
esportata facilmente,
tranne
nei
paesi
musulmani”.
Fa
riferimento alle celebri
serie televisive turche,
che mettono in scena
personaggi provenienti
dal ceto medio delle
città, con un accento,
valori morali e senso
dell’ironia
specifici,
nelle quali non è raro
trovare delitti d’onore
e vendette. Queste
serie hanno un grande
successo in Turchia e
vengono ampiamente
esportate con forza nel
mondo
arabomusulmano–manonin
Europa. “La nostra
cultura alla turca è
geniale, ma gli europei
non
lo
sanno!”
conclude.
Il giorno dopo mi
reco alla sede di Cnn
Türk, la cui presenza è
di per sé indicativa
delle
tensioni
tra
Oriente e Occidente,
soprattutto perché si
trova
in
Europa,
all’interno di un paese
storicamente
filoamericano,
ma
membro
dell’Organizzazione
della
conferenza
islamica. “Siamo una
televisione turca, in
lingua turca, che si
rivolge
ai
turchi,”
precisa subito Ferhat
Boratav, presidente di
Cnn Türk. Per lui, la
televisione
è
una
questione relativa al
suopaese.
Il suo ufficio si trova
inunalontanaperiferia
di Istanbul, all’interno
di
un
enorme
complesso, sede del
gruppo
privato
di
media chiamato Dogan
Tv Center. Il gruppo
Dogan,lacuiricchezza
viene dal petrolio, ha
una forte presenza
nellastampa,l’editoria,
la
musica,
la
televisione,
dove
possiede
numerose
emittentisoprattuttoin
partenariato con gli
americani di Time
Warner.
Gli
fa
concorrenza un altro
colosso di media, il
gruppo
di
telecomunicazioni
Çukurova che possiede
il
network
Show.
Questi due gruppi, in
concorrenza tra loro,
cercano di svilupparsi
all’esterno nella “zona
turca”
e
vogliono
diventare
grandi
gruppi media su scala
regionale.
“Non siamo un clone
di Cnn, siamo un clone
mutante!” spiega con
ironia Ferhat Boratav,
alla
Cnn
Türk.
L’emittente che dirige
è una joint-venture tra
CnneilgruppoDogan,
dunque nel contempo
americana e locale, ma
ancora
una
volta
Boratav insiste sulla
dimensione
turca
dell’emittente.
“Il nome Cnn è più
forte
di
quello
dell’America.
Qui
l’emittente
non
è
identificata con gli
Stati Uniti: si può
amare Cnn Türk e
odiare gli americani.
Siamo considerati una
televisione turca.” Cnn
Türk ripropone alcuni
programmi di Cnn, in
particolaretrasmissioni
esclusive
di
informazione
e
documentari,
ma
produce la maggior
parte dei programmi
localmentepoichéil90
per cento sarebbe in
turco. “Siamo tipici
dell’infotainment:
informazione
e
intrattenimento,”
confermasenzagrande
originalità Boratav. I
talk-show
sono
al
centro
della
programmazione
dell’emittente,
soprattutto
How
come?, L’Arene e +1,
che hanno grande
seguito di pubblico.
Anche i programmi
musicali
sono
fondamentali
come
Frequency,cheuniscei
successi
turchi,
soprattutto
l’hip-hop
turco, con le hit
americane. “Vogliamo
essere
compatibili.”
Boratavripetepiùvolte
questa espressione e
glichiedodiesserepiù
esplicito: “Vuol dire
essere nel contempo
moderni,
americani,
legati allo spirito del
tempo e dei giovani,
restandoturchi”.
Per capire meglio
cosa significa questa
“compatibilità”
nel
mondo
dell’intrattenimento
incontro al piano di
sotto Barcu Senbakar,
che produce il celebre
programma
settimanale
How
Come?,emidice:“Cnn
Türk è un’emittente
troppo seria e il nostro
compito è spezzare
questa
serietà.
Facciamounoshowpiù
divertente,
tra
informazione
e
intrattenimento.
Per
esempio
invitiamo
persone famose ma
anche gente ordinaria,
un autista di taxi, una
cameriera.Siorganizza
ildibattitoesitrattano
temi seri in modo
divertente. Il pubblico,
in studio, reagisce e
applaude in diretta. È
davvero
molto
divertente”.
Il
presentatore del talkshow quotidiano +1 su
Cnn
Türk,
Mithat
Bereket,ciraggiungee
interviene:
“Vuole
sapere perché qui
facciamo
intrattenimento?
Semplice, perché non
vogliamo
fare
informazione
noiosa.
La stampa deve essere
critica, problematica,
impegnata. Questo non
è
il
ruolo
della
televisione:
deve
permettere di fuggire
dai
doveri,
dai
problemi.
La
televisione è un media
mainstreamedevefare
intrattenimento”.
L’arrivo
del
divertimento di massa
alla televisione turca si
è realizzato con la
deregolamentazione
del settore audiovisivo,
la fine della televisione
pubblica unica e la
privatizzazione,
il
gruppo Dogˇan è il
modello
di
queste
evoluzioni. Lo scrittore
Volkan
Aytar,
dell’importante
fondazioneturcaTesef,
spiega in termini più
concettuali quanto è
accaduto:
“Paradossalmente,
questi grandi gruppi
media
si
sono
sviluppati nello stesso
periodo in cui si stava
indebolendo la cultura
kemalista, quella della
Turchia
dell’anteguerra, laica
ma anche autoritaria
edelitaria.Questaélite
legittimava la cultura
ufficiale,
turca,
nazionalista e rifiutava
la cultura popolare e
quelladelleminoranze,
quella delle donne e
dei kurdi. A poco a
poco,
la
musica
classica
è
stata
sostituita dalla musica
delle classi popolari,
quella che si chiama
‘arabesk’, una musica
pop con strumenti
occidentali, ma su
motivi
orientali
tradizionali. Al posto
dei concerti d’élite
aumentanoirock-bar,i
folk-ballade-bars, l’hiphop alla turca e anche
la musica americana si
infila nella breccia con
la fine di un certo
nazionalismo
turco.
Oggilanostramusicaè
‘americano-arabesk’!
L’intrattenimento
si
sviluppa con la fine
della cultura d’élite,
molto condiscendente,
molto
paternalista.
L’intrattenimento si fa
strada alla fine della
cultura borghese in
Turchia”.
LaTurchiaèfieradel
propriointrattenimento
e della sua nuova
cultura mainstream, e
ora conta di esportarli.
Si afferma come un
potere culturale su
scala regionale, che
diffonde
i
propri
contenuti in una zona
ibrida che va dal Sud
dei Balcani (Bulgaria,
Romania,
Albania,
Macedonia)
alle
repubbliche asiatiche o
di lingua turca dell’ex
Urss
(Azerbaijan,
Uzbekistan,
Kazakistan,
Turkmenistan), senza
dimenticare Armenia,
Georgia,
Ucraina,
Moldaviaealcunipaesi
del Medio Oriente
(Siria,Iraq,Iranfinoin
Israele). Opera dunque
all’interno
di
un
mercato insolito. Il
gruppo Dogˇan investe
ampiamente
nei
Balcani, la concorrente
Show Tv si radica con
forza in Ucraina e tutti
puntano chiaramente
con le loro serie
televisive cool e il loro
“hip-hop islamico” al
mondo
persiano
e
arabo. Il successo di
questa cultura turca
mainstreamaumentain
tutta la regione, ormai
sotto il fascino neoottomano dell’Iran e
l’Egitto, passando per
Siria e Palestina. I
musulmani apprezzano
i codici misti di questo
intrattenimento turco,
nel contempo orientale
e moderno, e anche
musulmano – piacciono
anche le ragazze senza
velo.
Un buon esempio di
questi
“paradossi
geograficiӏilcasodel
cantante Tarkan, le cui
canzoni Kiss Kiss e
Kuzu Kuzu, o più
recentemente l’album
Metamorfoz,
hanno
avuto grande successo.
In
Turchia
è
soprannominato
“il
principe del pop” e la
suainfluenzanelpaese
è
paragonata
dal
“Washington Post” a
quella di Elvis Presley
negli
Stati
Uniti.
Tarkan riscuote un
grande successo in
tutta
la
zona
d’influenza
dell’intrattenimento
turco, in Asia centrale,
Russia, Europa dell’Est
e
Medio
Oriente.
Eppure canta in turco,
non in inglese, utilizza
anche
idiomi
tradizionali e ciò gli è
valso le felicitazioni
dell’associazione
nazionale
di
preservazione
della
lingua turca. Tuttavia,
ha
aumentato
le
provocazioni
di
caratteresessuale,fino
a baciare sulla bocca
ragazzi con i baffi,
suscitando un dibattito
ricorrente sulla sua
omosessualità – che ha
fermamente negato – e
ha
aumentato
la
passione che suscitava
tra
i
giovani,
i
travestiti, come tra gli
islamisti turchi. In
questo
modo
è
diventato lo sponsor
ufficiale di Pepsi-Cola.
“Sembra strano, sa,
perchéall’iniziononho
mai
pensato
che
avrebbe funzionato,”
ha spiegato Tarkan in
un’intervista a Cnn.
“Canto solo in turco e
nessuno al mondo può
capire una parola di
quanto dico. Ma credo
che sia anzitutto il mio
ritmo
(groove)
a
spiegare
il
mio
successo. E poi i baci
sonouniversali.”
In Turchia, ai confini
dell’Europa,
le
possibilità e gli aspetti
di fragilità del paese
sono, in miniatura,
quelli
dell’intero
continente
europeo.
Tra laicità e religione,
tra americanizzazione
ed etnocentrismo, tra
cultura
e
intrattenimento,
il
paese vacilla, come
spesso fa l’Europa.
“Siamo molto ambigui,
molto incerti, molto
schizofrenici,”
conferma lo scrittore
Volkan Aytar, alla sede
della fondazione Tesef.
“L’americanizzazione
dellaTurchiaèdavvero
paradossale, anche la
sua
difesa
dell’intrattenimento.
Consideriamo
gli
americani più forti e
più moderni di noi, per
le
loro
evoluzioni
tecnologiche
e
culturali.QuiaIstanbul
si vedono ovunque
marche
americane,
Starbucks,
Levi’s,
McDonald’s:
consumiamo prodotti
americani
perché
vogliamo vivere una
vita migliore, e questi
prodotti ne sono il
simbolo. Nel contempo
vogliamo
restare
turchi.”VolkanAytarsi
toglielagiaccapesante
(quel giorno a Istanbul
c’era un freddo secco)
eriprende:“Comesifa
a restare turchi nel
mondo di oggi? Non è
così
semplice.
Vogliamo essere nel
contempo moderni e
orientali,forseeuropei,
ma certamente non
americani, né arabi.
Allora nei nostri film
mostriamoinostridolci
tipici, i lokum, giriamo
all’interno dei bagni
turchi,ripresentiamola
storia turca e le sue
mitologie facendo un
cinema
molto
autoreferenziale – e
nessun altro, se non
noi,vuolvederequesto
cinema
d’autore
nazionale! Ci rendiamo
improvvisamente conto
che i nostri giovani
preferiscono i film
americani. I giovani
turchi si rivolgono
versol’America,amano
l’azione, la velocità, la
libertà,lamodernità,le
ragazze di questi film
hollywoodiani
così
universali,
contrariamente
ai
nostri. Vogliono più
intrattenimento,
più
cultura mainstream. Li
osserviamo diventare
americani. Anche le
minoranze,ikurdiegli
armeni, vogliono più
film americani, per
sfuggire
all’oppressione
dell’élite turca. Così
non
capiamo
più
niente.
Allora
gli
europeiincercad’arte,
o
gli
islamisti
ossessionati
dalla
religione, ci chiedono
perché non ci sono
cammelli nei nostri
film, poiché secondo
loro questo elemento li
renderebbe
più
autentici e forse più
mainstream. La cosa
però è del tutto
ridicola, noi non siamo
arabi. Qui non ci sono
né
cammelli,
né
dromedari. Si trovano
soloneglizoo.”
Conclusioni
Unanuovageopolitica
dellaculturae
dell’informazione
nell’epocadeldigitale
La guerra mondiale
dei
contenuti
è
dichiarata.
È
una
battaglia che si svolge
attraverso i media per
il
controllo
dell’informazione; nel
settore televisivo per il
dominio dei format
audiovisivi, delle serie
televisive e dei talkshow; nella cultura per
la conquista di nuovi
mercati attraverso il
cinema, la musica e il
libro; infine è una
battagliainternazionale
attorno agli scambi di
contenuti su internet.
In questa guerra per il
soft power sono in
campo forze molto
diseguali
tra
loro.
Anzitutto è una guerra
di posizione tra pochi
paesi dominanti, in cui
siconcentralamaggior
parte degli scambi
commerciali; poi è una
guerra di conquista tra
paesidominantiepaesi
emergenti
per
assicurarsi il controllo
delle immagini e dei
sogni dei numerosi
abitanti
dei
paesi
dominati,
che
producono poco, o per
nulla, beni e servizi
culturali. Infine, si
tratta di battaglie su
scala regionale per
acquisire
nuova
influenza
attraverso
culturaeinformazione.
All’interno dei flussi
di
contenuti
internazionali, misurati
in termini quantitativi
in modo impreciso da
Fmi, Wto, Unesco e
Bancamondiale,c’èun
colosso come gli Stati
Uniti
che
esporta
ampiamente e ovunque
i propri contenuti con
circa il 50 per cento
delle
esportazioni
mondiali. Insieme a
Canada e Messico,
l’America del Nord
domina gli scambi
senza
avere
concorrenza(circail60
per
cento
delle
esportazioni mondiali).
Segue un potenziale
concorrente,
ma
probabilmente
in
declino, come l’Unione
europea composta da
ventisettepaesi,conun
terzo
delle
esportazioni. Insegue
poi,abuonadistanza,e
senza
avere
un
grandissimo peso negli
scambi mondiali dei
contenuti, una decina
di paesi: Giappone,
leader degli outsider,
Cina e soprattutto
Hong Kong, Corea del
Sud, Russia, Australia.
Per
il
momento,
Brasile, India, Egitto,
Sudafrica e paesi del
Golfo non figurano
significativamente
come paesi esportatori
di contenuti, anche se
stanno
aumentando
fortemente le loro
esportazioni
e
sviluppando
solide
industrie creative al
lorointerno.
In termini generali, i
paesi che esportano
beni e servizi culturali
e informazione sono
circa gli stessi che
importano contenuti.
C’è solo un’importante
differenza, gli Stati
Uniti
hanno
una
bilancia commerciale
ampiamente
positiva
(sono
il
primo
esportatore e solo il
quinto importatore). Al
contrario,
l’Unione
europea è il primo
importatore e solo il
secondoesportatore.In
larga
misura,
a
eccezione ancora degli
Stati
Uniti,
la
maggioranza
degli
scambi avviene su
scala regionale. Per
esempio,
all’interno
dell’Unione europea, le
esportazioni
e
le
importazioni
sono
superiori a quelle che
avvengono al di fuori
dell’Europa.
La
globalizzazione
non
solo ha accelerato
l’americanizzazione
della
cultura
e
l’emergere di nuovi
paesi, ma ha favorito
anche
i
flussi
d’informazione e di
cultura
su
scala
regionale, forse non
globali,maugualmente
internazionali.
Questi dati sui flussi
di
contenuti
internazionali
sottostimano, tuttavia,
alcune evoluzioni in
corso. Sono molto
imprecisi e gli stessi
economisti sostengono
che sono dati che
emergono
da
operazioni di “alta
acrobazia”. Al di là dei
problemi di metodo
posti dalla raccolta e
dal confronto dei dati,
è evidente che queste
statistiche,
spesso
formulate in dollari,
riflettono una realtà
moltofalsatadalpotere
dellerispettivevalutee
dai tassi di cambio.
Comunicano dati, ma
non dicono nulla della
reale influenza. In
effetti, misurare flussi
culturali in valuta,
piuttosto
che
attraverso il numero di
libri o di biglietti di
cinema venduti, mette
automaticamente
ai
margini
tutte
le
economie emergenti.
Per
esempio,
3,6
miliardi di biglietti
sonovendutiognianno
in tutto il mondo dai
film di Bollywood,
contro i 2,6 miliardi di
Hollywood, ma se si
confrontano gli incassi,
il botteghino indiano
fatica a superare i due
miliardi
di
dollari
l’anno,
mentre
Hollywood guadagna
quasi 40 miliardi di
dollari (dati del 2008).
Infine, se le statistiche
internazionali
sono
poco affidabili per
quanto riguarda gli
scambi di prodotti
materiali, sono ancora
meno opportune per
misurare
l’informazione,
i
servizi, i format dei
programmi televisivi e
internet.
Per
non
parlare della pirateria.
Per
tutte
queste
ragioni,
la
globalizzazione
dei
contenuti
è
un
fenomeno analizzato in
modo insufficiente. Per
valutarne l’incidenza si
dovrebbero utilizzare
altre unità di misura:
numero di citazioni,
diffusione di format e
di codici narrativi,
impatto sui valori e le
rappresentazioni.
È
chiaro che né la
superpotenzanéipaesi
dominati
hanno
interesseapromuovere
analisidiquestotipo.
La nuova mappa
degli scambi fa venire
alla
luce
anche
problematiche
molto
più
complesse
di
quanto
possano
pensare i teorici delle
“industrie culturali” o
di
quanto
vadano
affermando oggi gli
altermondialisti e gli
antiamericani,
che
hanno la tendenza a
confondere la Cia con
l’Afl-Cio,
la
confederazione
sindacale statunitense.
La
teoria
dell’imperialismo
culturale
americano
presuppone che la
globalizzazione
culturale
sia
un’americanizzazione
unilaterale
e
unidirezionale da parte
di una “iperpotenza”
diretta verso i paesi
“dominati”. La realtà è
più sfumata e più
complessa.
La
situazione attuale è
caratterizzata,
nello
stesso
tempo,
da
omogeneità
ed
eterogeneità. Stiamo
assistendoallosviluppo
di un intrattenimento
mainstream
globale
ampiamente americano
e alla costituzione di
blocchi
su
scala
regionale. Inoltre, le
culture nazionali si
rafforzano
ovunque,
anche
se
“l’altro”
referente,
“l’altra”
cultura, corrispondono
sempredipiùagliStati
Uniti. Infine, tutto si
accelera
ed
è
interconnesso:
l’intrattenimento
americano è spesso
prodotto
da
multinazionalieuropee,
giapponesi e indiane,
mentreleculturelocali
sonosemprepiùspesso
coprodotte
da
Hollywood. I paesi
emergenti
vogliono
affermarsiall’internodi
questi scambi e fare
concorrenzaall’impero.
Questa
guerra
culturalemettedunque
in gioco numerosi
soggetti.
La
globalizzazione
e
internet riorganizzano
gli
scambi
e
trasformano le forze in
gioco.
Di
fatto,
scompaginano tutte le
carte.
L’intrattenimento
americano
Nel
settore
dell’intrattenimento e
dei media, gli Stati
Uniti sono dunque
senzaegualiesonoper
il momento il leader
incontrastato, in grado
di
adeguarsi
continuamente
alla
nuova realtà e in
continuo
progresso
(l’esportazione
di
prodotti
e
servizi
culturalièinrialzocon
un ritmo del 10 per
cento
all’anno
attualmente). Come e
perché?
Il sistema americano
di
produzione
dei
contenuti è un modello
complesso,
è
il
prodotto di una storia,
di
un
territorio
immenso
e
di
un’immigrazione
proveniente da tutti i
paesi, con la presenza
di tutte le lingue e di
tutte le culture. Le
ragioni
di
questa
situazione
e
le
spiegazioni di questo
dominio culturale sono
molteplicielericordoa
grandi linee. Anzitutto,
all’interno
delle
università
vengono
incentivate ricerca e
sperimentazione,
esistono finanziamenti
pubblici
decentralizzati,
la
controcultura
è
valorizzatainnumerosi
luoghi alternativi, c’è
molta
vitalità
che
proviene dalla mobilità
e dall’idea di ascesa
sociale
fortemente
radicata nella società,
si crede nei singoli
artisti e c’è una
vivacità
eccezionale
delle comunità etniche
grazie
al
modello
originale
di
integrazioneedidifesa
di
una
“diversità
culturale”
all’americana.
Formazione,
innovazione,
assunzione di rischi,
creatività e audacia
sono incentivate nelle
università,
nelle
comunità e nel settore
noprofit,aldifuoridel
mercato e in modo
fortemente
decentralizzato.
Infine, c’è il dominio
di industrie creative
dotate
di
ingenti
capitali. Le più visibili
sono naturalmente gli
studios e le major. La
composizione
societaria
e
l’azionariato
dei
principali conglomerati
media americani è
interessante:
cinque
dei
sei
principali
studios cinematografici
sono americani, anche
se
Columbia
è
giapponese, ma gli
investimenti stranieri,
provenienti soprattutto
da paesi del Golfo,
India e Hong Kong
(ovvero la Cina), oggi
sono
considerevoli.
Nella musica, solo una
delle quattro major
internazionali
è
americana (Warner), le
altre
sono
inglesi
(Emi),
francesi
(Universal)
e
giapponesi
(Sony).
Nell’editoria
la
situazioneèancorapiù
articolata: il colosso
Random
House
appartiene al tedesco
Bertelsmann
e
il
gruppo Time Warner
Books è stato acquisito
dal
francese
Lagardère.
Si
sbaglierebbe dunque
prospettiva
nel
considerare
queste
industriecreativecome
soloamericane.
In realtà, in termini
dicontenuti,questidati
sul capitale e sulla
nazionalità di queste
multinazionali hanno
un’influenza limitata. I
film prodotti da Sony e
Columbia
sono
smaccatamente
americani, la musica
distribuitadaUniversal
e Emi è in gran parte
anglofona, i bestseller
più
tipicamente
americani sono spesso
pubblicati
da
Bertelsmann.
Paradossalmente, con
l’acquisizione
degli
studiosColumbia,delle
case discografiche Cbs
Music, Arista e Rca, i
giapponesidiSonynon
hanno indebolito la
culturaamericana,anzi
fornendo
i
mezzi
finanziari di cui questa
aveva bisogno, l’hanno
ulteriormente
rafforzata. Al di là del
loro azionariato e dei
luoghi in cui si trovano
le sedi sociali, questi
studios e queste major
restano
molto
americani.
Questa
realtà indebolisce le
interpretazioni
neomarxiste secondo
cui, per analizzare le
industrie creative, la
cosa importante è
sapere chi detiene il
loro capitale, chi è
proprietario dei mezzi
di produzione, con il
presupposto che chi le
possiedelecontrolla.
È dunque necessario
utilizzare nuove chiavi
di
lettura
per
analizzare, nell’epoca
della finanziarizzazione
dell’economia, ciò che
definisco “capitalismo
hip”:
un
nuovo
capitalismo“avanzato”,
globale, caratterizzato,
nel contempo, da una
forte
concentrazione
ma
anche
grande
decentralizzazione
e
dall’essere
forza
creativaedistruttiva.È
pertuttequesteragioni
e perché la cultura, i
media e internet sono
ormai mescolati, che
nonbisognapiùparlare
di “industrie culturali”,
cheèunveroeproprio
ossimoro,
ma
di
industrie dei contenuti
odiindustriecreative.
Con i conglomerati
media
di
nuova
generazione,
il
capitalismo hip non è
monolitico:sitrasforma
costantemente,
si
adatta continuamente,
poiché le industrie
creative non seguono
più la logica del
modello di fabbrica
come avveniva con gli
studiosdell’epocad’oro
di Hollywood, oggi
sono composte da reti
diproduzionecostituite
dacentinaiadimigliaia
di piccole e medie
imprese e di start-up.
Non sono più major,
ma sono composte da
migliaia di etichette e
di imprint e di unità
specializzate,
sono
indipendenti
che
diventano
progressivamente
major e queste major
sono
dirette
da
indipendenti diventati
mainstream. Non si
tratta più di “oligopoli
con
frangia
concorrenziale” (major
che
producono
mainstream,circondate
da indipendenti che si
rivolgono a mercati di
nicchia),comecontinua
a ripetere la vulgata
economica, ma di un
sistema
realmente
decentralizzato in cui
major e indipendenti
sonoconnessitraloroe
non in concorrenza,
sono indispensabili le
une agli altri. Si tratta
di
un
modello
dinamico, non statico,
che in realtà cerca
spessodiprivilegiarela
creatività
invece
dell’omogeneità,l’hipe
il cool invece di una
riproduzione sempre
uguale,ilcambiamento
costante invece della
standardizzazione,
l’originalità
invece
della copia (benché ci
siaancheunatendenza
inversa,
meno
rischiosa, per esempio
con il media franchise
nel
cinema).
La
globalizzazione
e
internet,
caratteristiche
del
capitalismo
hip,
rafforzanoeaccelerano
queste logiche e il
dominio
americano,
come abbiamo avuto
modo di vedere. In
questo
senso,
le
industrie dei contenuti
sembrano
anticipare
profonde
dinamiche
che
finiranno
ben
presto per coinvolgere
tuttal’economia.
Questo sistema ha
raggiunto negli Stati
Uniti un grado di
tecnicità, complessità,
lavoro
di
collaborazione davvero
sorprendente
e
insospettabile se visto
dall’esterno.
Contrariamente
a
quantosicredespesso,
è
molto
difficile
produrre
intrattenimento
mainstream. Al centro
di questo meccanismo
ci sono le agenzie di
talenti, vero e proprio
ago della bilancia del
mercato dei contenuti
globali. Le agenzie
gestiscono il “capitale
umano” in modi molto
diversi
da
quanto
avveniva con il vecchio
sistema degli studios e
dello star system; si
occupano infatti di
tutti, piccoli e grandi,
creano
così
un’inflazione generale
dei
costi,
ma
contribuiscono anche a
regolare
l’intero
sistema,
attraverso
avvocati,
manager,
sindacati. Gli studios,
le
major
e
i
conglomerati media, i
veri
detentori
del
potere e banche del
sistema, acquisiscono
invece il capitale più
prezioso prodotto dalle
industrie creative: l’Ip,
la famosa Intellectual
Property o proprietà
intellettuale.
All’interno di questo
quadro, il sistema del
copyright americano e
soprattutto la clausola
speciale del diritto del
lavoro – il cosiddetto
dispositivo del “work
for
hire”
–
contribuiscono
alla
circolazione mondiale
dei contenuti e al loro
adattamento su tutti i
supporti. Il copyright e
il work for hire si
rivelano
particolarmente adatti
alla globalizzazione e
all’epocadeldigitalein
quantonondefiniscono
piùl’artistacomeunico
detentore dei diritti
sull’opera, eliminano il
final cut, e non
prevedono il rilascio di
autorizzazioni
preventive,
come
accade con il “diritto
d’autore” in versione
europea. In questo
modo è più facile
adattare un contenuto
a tutti i supporti e si
facilitano il versioning
e il Global Media. Si
riduce
tuttavia
la
dimensione
artistica
delle opere e i creatori
hanno sempre meno
tutele rispetto alle
major.
Il modello americano
di
produzione
dei
contenuti è dunque un
sistemaspecificoincui
tutti i soggetti in gioco
sono nel contempo
indipendentiecollegati
tra loro, mentre le
norme
pubbliche
anticoncorrenza,
quando esistono, e le
normative
collettive,
quando
funzionano,
cercano regolarmente
di correggerne gli
eccessi.Infindeiconti,
il modello è costituito
da migliaia di soggetti
autonomi
che,
perseguendo obiettivi
“privati”
e
in
concorrenza tra loro,
finiscono nondimeno, e
nonostante una grande
imprevedibilità,
per
dare all’insieme del
sistema
una
sua
coerenza e una certa
stabilità.
Contrariamente
a
quanto ripetono gli
osservatorisuperficiali,
la
cultura,
l’informazione e anche
l’intrattenimento, negli
Stati Uniti, non sono
merci come le altre,
appartengono a un
ambito specifico e
costituiscono
una
“eccezione culturale”
sul
territorio
americano.
La forza di questo
sistema
era
già
evidente nella prima
metà del Ventesimo
secolo quando il jazz e
il cinema americano
hanno
dilagato
in
Europa. Ma nell’epoca
della globalizzazione e
dei
cambiamenti
tecnologici
questo
sistema si rivela più
efficace che mai. La
privatizzazione
delle
emittenti televisive in
Europa, Asia, America
latina e Medio Oriente
ha incrementato la
richiesta di contenuti
americani.
La
diversificazione
dei
supporti multimediali,
ilviacavo,ilsatellite,il
digitale terrestre e
internet hanno favorito
la loro circolazione.
Inoltre, la mancanza di
prodotti di successo in
numerosi paesi ha
velocementeportatogli
americani ad adattarsi
aicontestilocali:illoro
approccio
alla
globalizzazioneèattivo
e
mette
insieme
diffusione di contenuti
di
massa,
indifferenziati
e
mainstream,
e
diffusione
specializzata, assestata
su specifici settori di
nicchia
dei
paesi
importatori. Sul fronte
televisivo
vendono
format all’interno di
mercati soprattutto di
scala nazionale. Nella
musica e nell’editoria,
mercati misti con una
forte dose di prodotti
nazionalivendonohite
bestseller mondiali e
produconodischielibri
di autori locali. Sul
fronte del cinema, i
film di successo, i
blockbuster,
hanno
grande seguito quasi
ovunque
poiché
producono non film
semplicemente
americani, ma prodotti
universali e globali. I
francesi fanno film per
i francesi, gli indiani
pergliindiani,gliarabi
per gli arabi: solo gli
americani fanno film
per tutti. Oggi, ancor
prima di puntare al
mercato interno, sono
gli unici a pensare di
realizzarefilmdestinati
all’esportazione.
La priorità degli
studios e delle major
non è solo imporre il
loro cinema, la loro
musica e difendere un
imperialismo culturale,
ma è accrescere e
ampliareiloromercati.
Sitrattadiunobiettivo
economico
completamente diverso
da quello ideologicoculturale perseguito se
possibile con prodotti
“americani”, ma anche
con
prodotti
“universali”, creati per
piacere a tutti e in
tutto il mondo, non
costituisce, infatti, un
problema
limitare,
attraverso
i
focus
group,
lo
spirito
americano delle loro
produzioni.
Inoltre,
finanziano e realizzano
prodottisuscalalocale
o regionale, tradotti in
realtà a Hong Kong,
Mumbai, Rio o Parigi e
per un preciso tipo di
pubblico (gli studios
hollywoodiani
realizzano ogni anno
circa duecento film
locali
in
lingua
straniera
raramente
diffusinegli
Stati
Uniti).
L’America
produce
dunque, nel contempo,
cultura mainstream e
contenuti di nicchia
differenziati. In questo
senso, gli studios e le
major
sono
meno
ideologici e più apolidi
di quanto si possa
immaginare.
Come
BankofAmerica,Hsbc,
vogliono conquistare il
mercato
indiano,
cinese e brasiliano – in
dollari o in valuta
locale.Percertiaspetti
sono
anche
avvantaggiati, poiché
attraverso la presenza
negli Stati Uniti di
numerose minoranze,
che sono elemento
centrale del sistema
americano, le industrie
creative
statunitensi
possono
testare
all’interno del loro
territorio
i
diversi
prodottieprevederese
saranno
capaci
di
conquistare il mondo.
Mi sembra dunque più
opportuno affermare
che gli americani siano
fautori di uno specifico
e originale modello
economico più che di
una
strategia
per
imporre
al
mondo
alcuni
valori
e
un’egemoniaculturale.
In questo senso,
l’America produce una
“diversità
standardizzata”,
profondamente
impressionante,
ma
straordinariamente
efficace in termini di
diffusione.
È
un
modello di cultura
simile al “tex-mex”,
ovvero
né
propriamente texano
némessicano,poichéla
cultura tex-mex è una
cultura
locale
americanizzata
dagli
stessi
messicaniamericaninelterritorio
degliStatiUniti.DaRe
Leone ad Aida, da
Kung Fu Panda a The
Departed, da Tintin di
SpielbergaShakira,gli
Stati Uniti esportano
questo tipo di cultura,
né
completamente
originalenétotalmente
americana.
Ma c’è di più. Gli
Stati Uniti non solo
esportano
i
loro
prodotti culturali, ma
esportano anche un
modello. A Damasco,
Pechino,Tokyo,Riyadh
e Caracas sono stato
colpito dal fascino che
su
tutti
i
miei
interlocutori esercita il
modello americano di
intrattenimento.
Le
parole sono in hindi o
mandarino,
ma
la
sintassi è americana.
Questa è la forza degli
Stati Uniti e nessun
altro soggetto, per il
momento, è dotato di
questa
forza,
né
l’Unioneeuropea,néla
Cinacon1,3miliardidi
abitanti.
Viene da chiedersi,
ma
è
difficile
rispondere, se gli Stati
Uniti possano perdere
la leadership mondiale
sui contenuti culturali,
cosìcomenonsonopiù
il
paese
con
i
grattacieli più alti, che
oggisitrovanoaTaipei
e Dubai. Se però non
bisogna considerare la
potenza
americana
come definitiva, poiché
nulla è definitivo, non
bisogna
neanche
sottostimarla.
Lo
scenario è sicuramente
articolato e più volte si
è insistito in queste
pagine sull’ascesa dei
paesi emergenti, non
solo
in
campo
economico, cosa che è
stata già ampiamente
analizzata, ma anche
nell’industria
dei
contenuti–cosainvece
più
raramente
riconosciuta.
Viene
dunque da chiedersi se
sul
fronte
delle
industrie creative si
prospetta davanti a noi
un
mondo
“postamericano”.
Questo
scenario mi pare da
escludere, ma credo
che la nuova geografia
dei
media
e
dell’intrattenimento
sarà
probabilmente
caratterizzata da una
pluralità di centri e di
polarità.Èevidenteche
siamo di fronte a paesi
emergentichevogliono
produrre e sostenere i
loro contenuti. A mio
avviso,lacrescitadegli
“altri” non avverrà a
scapito degli Stati
Uniti, ma a loro
vantaggio poiché si
apriranno
nuovi
mercati e condizioni
perproduzionisuscala
locale. In ogni caso
siamoinunasituazione
in cui non si vede il
declino americano e
stanno
comparendo
nuovi
concorrenti.
Siamo di fronte al “the
rise of the rest”, la
crescita degli altri
paesi,
secondo
la
formula del giornalista
indiano-americano
FareedZakaria.
Assistiamo dunque a
una
trasformazione
radicale
della
geopolitica
degli
scambi dei contenuti
culturaliemediatici.La
paura
dell’egemonia
americana
–
un’ossessione tanto a
ParigiquantoaRoma–
sembra
invece
un
concettoormaidesueto
a Mumbai e Tokyo. In
Iran,India,Cinamilioni
di persone non sanno
chi
siano
Mickael
Jackson o Madonna. A
Seul, Taiwan e Hong
Kong si teme di più
l’egemonia giapponese
o cinese di quella
americana;
in
Argentina si ha più
paura del Brasile o del
Messico;inGiapponee
in India si diffida della
Cina
più
che
dell’America. Gli Stati
Uniti continuano a
essere un partner o un
concorrente, ma non
sono gli unici a
maneggiare il soft
power, a produrre
contenutiedesportarli.
In
questo
rimescolamento delle
carte, ci sono vincitori
(gliStatiUnitieipaesi
emergenti) e vinti (i
paesi dominati). Ci
sono anche i paesi che
vedono diminuire le
loro quote di mercato.
Sono i paesi che non
hanno
costruito
industrie
creative
potenti,
e
stanno
dunque
perdendo
velocità; sono quelli
che non hanno accolto
la globalizzazione, i
suoi potenziali mercati
ecedonoilpasso;sono
quelli
che
hanno
pensato a internet
come a una minaccia e
non
come
a
un’opportunità e che
rischiano di non aver
alcun
potere
nel
mercato dei contenuti.
Questa è la situazione
dell’Europa nel suo
complesso e di paesi
come Portogallo, Italia
eSpagna,maanche,in
minor
misura,
di
Francia e Germania
che stanno perdendo
terrenosulfrontedegli
scambiculturali.
Sta prendendo forma
una nuova geografia
della circolazione dei
contenuti, quella del
Ventunesimo secolo. I
grandi assi di questo
scenario sono: scambi
nord-sud sempre più
asimmetrici e scambi
sud-sud sempre più
diseguali tra paesi
emergenti e paesi più
poveri. C’è un paese
dominante sempre più
potente, ma che con
l’arrivo delle nuove
potenze non sarà più
l’unico a dominare. Ci
sono paesi emergenti
chesisviluppanoanche
attraverso
i
loro
contenuti. Infine ci
sono
vecchi
paesi
dominanti,
a
cominciare
dall’Europa,
che
rischiano di essere
sommersi. Il radicale
cambiamento
della
cultura
e
dell’informazione
nell’economia
immaterialeeglobaleè
un
grande
evento
dell’inizio
del
Ventunesimosecolo.
L’ascesa culturale dei
paesiemergenti
Fra tutti i paesi
emergenti, il Brasile è
tra i più interessanti.
Grazie a un’ampia
popolazione e a una
florida economia, è
l’unico
paese
dell’America latina non
più emergente, ma
ampiamente emerso.
Nello stesso tempo è
un paese isolato, per
via della sua storia e
soprattutto della sua
lingua,ilportoghese.Il
Brasile è alla ricerca
della propria identità e
insieme
all’India
sostiene la battaglia in
favore della diversità
culturale in nome dei
paesi del Sud. Vuole
difendere
i
propri
interessi di fronte agli
Stati Uniti, ma intende
anche lottare (cosa di
cui gli europei non si
sono resi conto) contro
l’arroganza culturale
della vecchia Europa,
in
particolare
di
Portogallo e Spagna. Il
Brasileèinoltrepronto
a ricostruire legami
economici e culturali
con paesi confinanti,
anche con il Venezuela
di Chávez, ma altresì
con Cina e India, così
comeconStatiUnitied
Europa.
Sul
fronte
dei
contenuti
e
della
produzione
mainstream, l’America
latina
nel
suo
complesso vive una
situazione meno felice,
complessa
ed
eterogenea. Escluse le
telenovele e alcuni
generi musicali con un
grossoimpattosuscala
regionale,
oggi
in
Sudamerica circolano
pochi contenuti latinos
di
massa.
L’intrattenimento
latinooggisiproducea
Miami e Los Angeles,
capitali
esterne
dell’America
latina
mainstream. Il Brasile
e il Messico possono
difendere
le
loro
industrieecompensare
la
loro
bilancia
commerciale culturale
in squilibrio con gli
StatiUnitiattraversole
dimensioni
e
il
dinamismo del loro
mercato interno, ma
Argentina, Colombia e
Venezuela non sono in
questa
situazione.
Peraltro, tutti questi
paesi
perseguono
logiche
fatte
di
particolarismiinvecedi
favorire gli scambi con
i
paesi
confinanti.
All’interno di questo
scenario, nel cinema,
nei
videogiochi
e
sempre di più nella
musica pop e nei
bestseller, gli Stati
Uniti
hanno
gioco
facile. Attraverso la
globalizzazione e il
ruolo del Messico che
fa da filtro, la linea di
separazione
tra
America del Nord e
America del Sud tende
ascomparire.
I
contenuti
Ramadan
I
problemi
del
della
frammentazione
dell’America
latina
sono
ancora
più
evidenti nel mondo
arabo che è oggi,
insieme a Cina e
Venezuela,ilprincipale
concorrente culturale
dell’Occidente.
Peraltro, europei e
americani sono posti
sullo stesso livello
all’interno dei discorsi
critici attorno ai valori
formulati a Riyadh,
Damasco e Teheran.
Oggi, nei paesi del
Golfo sono comparsi
potenti
gruppi
multimedia (Mbc, Art,
Rotana, Al Jazeera). Il
loro
obiettivo
è
costruirefortiindustrie
creative
per
comunicare a tutto il
mondo
arabo,
difendere
i
valori
dell’islameconquistare
nuovi
mercati.
In
questomodointendono
lottare
contro
il
dominio culturale e
ideologico
dell’Occidente.
Visto
dai
paesi
arabi,
l’Occidente
è
semplicemente
un’immagine, talvolta
un miraggio, più che
una realtà geografica.
Èuninsiemedivalorie
di
atteggiamenti,
George Bush e Disney,
hard e soft power,
diritti dell’uomo e
cristianesimo,
liberazione delle donne
e
diritti
degli
omosessuali,
cultura
dominanteall’esternoe
presenza di nemici
interni.
Quando
vengono intervistati, i
sostenitori musulmani
dell’industria
dei
contenuti e dei media
contrappongono
all’Occidente i valori
della
famiglia,
la
tolleranza religiosa, il
rifiuto della violenza e
della sessualità – non
sono poi così lontani
daivalorimainstreame
familiari di Disney e
della
Mpaa.
Le
contraddizioni
di
questa battaglia contro
l’Occidente
sono
immediatamente
chiare.
In ogni caso, questa
strategia
antioccidentale che si
esprimeneicontenutiè
elaborata a Riyadh,
Doha,
Damasco
e
Teheran e realizzata a
Dubai, Beirut e Il
Cairo.
Il
primo
obiettivo è riunificare
la cultura del mondo
arabo, dal Marocco
all’Iraq. In seguito si
progetta di allargarsi
verso
la
cultura
musulmana
guadagnando pubblico
in Iran e Indonesia,
passando
per
Afghanistan, Pakistan
ma anche Turchia e
India.Infine–esaràla
cosa più difficile –, di
conquistare il resto del
mondo. Si punta sui
musulmani dell’Asia e
sugli immigrati del
Maghreb
per
indirizzarsi verso gli
“housing
estates”
dell’Inghilterra,
le
“banlieues” francesi e
le
“barriadas”
spagnole.Questopiano
mi
è
stato
accuratamente
presentatodaidirigenti
dei gruppi Mbc, Art,
Rotana e Al Jazeera,
ma
continua
a
confrontarsi con le
tensioni interne al
mondo
arabomusulmano. Ci sono
anzitutto le opposizioni
interne tra sciiti e
sunniti, probabilmente
menofortiinterminidi
contenuti di quanto
non si possa credere.
C’è poi l’opposizione
fra la tradizione del
nazionalismopanarabo,
piuttosto
laico,
di
ispirazione socialista,
rappresentato
dalla
Legaarabaesostenuto
da Egitto, Giordania e
Tunisia,eilmovimento
islamistarappresentato
dai Fratelli musulmani,
dall’Organizzazione
della
conferenza
islamica e dall’asse
Siria-Iran-Qatar. Oggi i
conservatori
dell’Arabia
saudita
sono
ostili
alle
evoluzioni moderne dei
gruppi
dell’intrattenimentodel
mondoarabofinanziate
dai loro figli, ma sono
ancora
più
ostili
all’Iran.Eilmiliardario
saudita Al Waleed,
proprietariodelgruppo
Rotana,cheharicevuto
una fatwa da parte dei
religiosi radicali, è per
molti aspetti più vicino
agli americani che ai
mullah, gli eruditi
musulmani. Questo è
uno dei paradossi di
una cultura che cerca
di abbracciare tutto il
mondo arabo, che è
tuttaviaattraversatoda
livelli
diversi
di
modernizzazione e di
infitah, lo spirito di
apertura. Il problema
dei paesi arabi non è
solo di natura morale,
maancheproduttivoed
economico. I paesi del
Golfo
svolgono
la
funzione di banche in
grado di finanziare
potenti
industrie
creative,manonhanno
al loro interno i
creatori necessari, né
storie da raccontare,
devono comprarle a
caro prezzo in Egitto e
Libano. Altrove, nel
Maghreb o in Siria,
mancano capitali e
strumentididiffusione.
Infine,
le
canzoni
prodotte da Rotana a
Beirut, i teleromanzi
del Ramadan realizzati
al Cairo e Damasco, i
programmi
televisivi
diffusi
da
Dubai
tendono a riprodurre
una
forma
di
sottocultura
mainstream
americanizzata, ormai
solo con un vago
accento egiziano. A
Damasco e Tunisi ci si
può forse illudere di
essere mainstream, ma
laforteesportazionedi
contenuti
arabi
a
destinazione
dei
mercati internazionali
deve ancora avvenire.
Inoltre
l’intrattenimento
dei
paesi
arabi
deve
ancora dimostrare di
essere
capace
di
conquistare
i
musulmani di Asia,
IndonesiaeIndia.
Da
Hollywood
Bollywood,eritorno
a
L’India è il colosso
asiatico che suscita
oggi
maggior
attenzione. L’emergere
del
subcontinente
indianoèilsimbolodel
risveglio di tutta l’Asia
del Sud. Gli americani
depongono
molte
speranze
nell’India,
tanto più che le
delusioni in Cina sono
state importanti. In
questo
paese
non
esistono
quote
di
riserva
contro
le
importazionidiprodotti
culturali, né censura e
invecediunmercatodi
1,3 miliardi di cinesi,
gli americani sono
prontiadaccontentarsi
di un mercato di 1,2
miliardi di indiani.
L’India, tuttavia, non
interessa
solo
in
terminiquantitativi,ma
anche sul fronte dei
capitali
e
delle
competenze
nell’ambito
del
mainstream. L’ingresso
in grande stile del
colosso
indiano
Reliance a Hollywood,
attraverso
un
importante
investimento
in
DreamWorks, dimostra
la nuova ambizione
degli
indiani,
che
cercano dunque di
costruire
potenti
industrie creative al
proprio interno, per
affrontaregliamericani
sul loro stesso terreno
dell’intrattenimento
mainstream
e
per
opporsi
alla
Cina.
Come
è
noto,
quest’ultimoobiettivoè
ormaiperseguitoanche
dagli americani ed è
possibile
formulare
l’ipotesi di un roseo
futuro delle relazioni
economiche e culturali
tra Stati Uniti e India:
gli
indiani
hanno
bisogno
degli
americani per fare da
contrappesoallaCinae
gli Stati Uniti hanno
bisogno dell’India per
sfondare in Asia dopo
averfallitoinCina.
In ogni caso, il
progetto degli indiani
di costruire potenti
industrie dei contenuti
destinati al mondo
interositrovadifronte
a
questioni
problematiche.Sipone,
da una parte, la scelta
di
continuare
a
sviluppare i loro punti
di forza in ambito
cinematografico
e
musicale – le songs &
dances di Bollywood
per esempio – con il
rischio che questa
cultura risulti troppo
specificaedifficilmente
esportabile, e dall’altra
parte si pone la scelta
di
cominciare
a
produrre
cinema
anglosassone a tinte
indiane, con il rischio
di farsi schiacciare
dalla
concorrenza
americana.
Per
il
momento, il botteghino
indiano decolla negli
StatiUnitieinEuropa,
ma
resta
ancora
fortemente dipendente
dal consumo delle
minoranze indiane che
vivono all’estero – i
famosi Non Resident
Indian o Nri. È un
successo in termini di
dollari, un po’ meno in
termini di biglietti di
ingresso
e
un
fallimento quando si
tratta di convincere un
giovane
bi