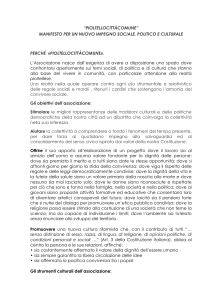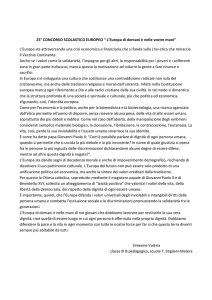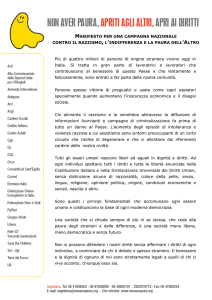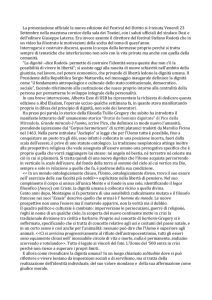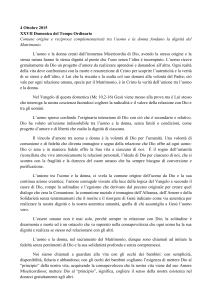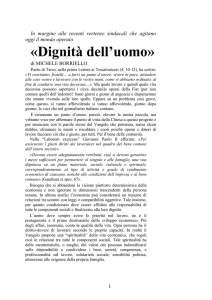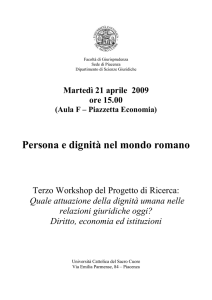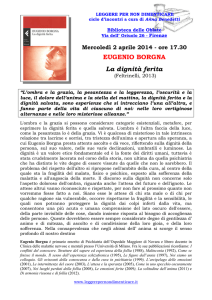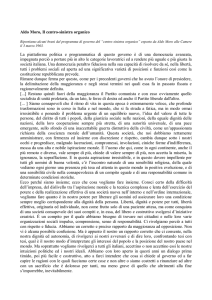pensare la
dignità umana
QUADERNI DELL’ALMO COLLEGIO BORROMEO | PAVIA
A.A. 2011-2012
pensare la
dignità umana
QUADERNI DELL’ALMO COLLEGIO BORROMEO | PAVIA
qb
c
ne
ia
quaderni dell'almo collegio borromeo
Università degli Studi
di Pavia
Dip. di Diritto Romano
Storia e Filosofia del Diritto
Progetto editoriale e realizzazione Almo Collegio Borromeo, Pavia
a cura di
don Paolo Pelosi | Giampaolo Azzoni | Davide Griffini
immagine di copertina
http://www.flickr.com/photos/petertandlund/7006420637/ Dagens foto - 170: Walk With Me di petertandlund (CC BY-NC-ND 2.0)
© 2013, Almo Collegio Borromeo - Pavia | www.collegioborromeo.it
pubblicazione degli interventi svolti nel ciclo di incontri promosso dal Collegio Borromeo in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di
Diritto Romano, Storia e Filosofia del Diritto, nell’ambito del progetto P.A.V.I.A realizzato nell’ambito dei Servizi agli studenti nei Comuni sedi di Università,
promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
ii
introduzione
Consegniamo alla ‘rete’ questo primo e.book di una collana di
Quaderni dell’Almo Collegio Borromeo che ci auguriamo possa essere
lunga.
Ci fa piacere inaugurare la serie con la raccolta degli atti di un
ben riuscito ciclo di conferenze sulla dignità umana, tenute in Collegio
durante l’anno accademico 2011-12, con il coordinamento del professor
Giampaolo Azzoni.
Come proprio Azzoni ha scritto in un suo saggio, quello di
dignità umana è il concetto normativo che meglio interseca le due
grandi tradizioni dell’Occidente moderno, il cristianesimo e
l’illuminismo, rappresentando quindi l’esito più alto di una
convergenza tra differenti prospettive valoriali.
Il pensiero corre alla Lettera ai Galati di S. Paolo (3, 28) o ai
documenti del Concilio Vaticano II, ma anche a Immanuel Kant e,
infine, alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea dove la
dignità della persona umana non viene posta solo come un diritto
fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti
fondamentali.
In questo contesto, il tema del rispetto e della valorizzazione
della dignità di ogni uomo, promossi dalla nostra civiltà sotto la spinta
dell’istanza cristiana, merita di essere costantemente approfondito con
una riflessione sempre più adeguata ai tempi e alle circostanze. Ecco il
senso di una lettura multidisciplinare come quella offerta in questa
pubblicazione.
La convinzione profonda è che ogni discorso e impegno per la
crescita della nostra società non possa che partire dalla centralità della
persona e della sua dignità.
don Paolo Pelosi
Rettore del Collegio Borromeo
iii
pensare la
dignità umana
P AOLO B ECCHI U NIVERSITÀ DEGLI S TUDI DI G ENOVA
La dignità umana
e l’ordinamento giuridico
italiano
INDICE
1. Usi della dignità nella Costituzione e nella
legislazione ordinaria
2. Usi della dignità nella giurisprudenza
costituzionale e in quella ordinaria
3. Conclusioni
Note
1. Usi della dignità nella Costituzione e nella
legislazione ordinaria
La prima cosa che non può non sorprendere quando ci si appresta ad analizzare l’ordinamento costituzionale italiano è
l’uso del termine dignità. La Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 – e dunque anteriore alle
stessa Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo – contiene tre riferimenti espliciti alla dignità: l’art. 3, 1˚comma, si riferisce alla “pari dignità sociale”, di tutti i cittadini, l’art. 36,
1˚comma, sostiene che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione tale da “assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza
libera e dignitosa”; l’art. 41, 2˚comma, afferma che l’attività
economica privata non può svolgersi “in modo da recar danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Abituati a considerare la dignità in modo astratto, come una
qualità inerente l’essere umano, intrinseca alla condizione
umana, dobbiamo subito registrare che nulla di tutto ciò si ritrova negli articoli citati. La Repubblica italiana non è fondata
sul riconoscimento di un principio assoluto e incondizionato
come la dignità umana, ma “sul lavoro” come recita l’art. 1 e
di conseguenza il soggetto con cui viene posta esplicitamente
in relazione la dignità non è mai l’uomo in quanto tale, ma il
cittadino, il lavoratore, l’imprenditore. Persino laddove si trova la locuzione “dignità umana” (art. 41) essa riguarda in particolare le mansioni lavorative che non devono rivelarsi degra5
danti o umilianti per coloro che sono chiamati ad eseguirle.
Vale la pena sottolineare però l’espressione “pari dignità sociale” che, se male non mi appongo, non si ritrova in nessun’altra
Costituzione.
Come è stato osservato in uno dei pochi contributi dedicati
specificamente a questa formulazione “si tratta evidentemente
di un parametro non assoluto, ma relazionale”(1), non è cioè
un principio incondizionato, pre-positivo, paragonabile, per
fare un esempio significativo a quello che emerge dall’articolo
1 del pressoché coevo Grundgesetz (2), bensì una qualificazione di diritto positivo, che in modo esplicito viene attribuita alla totalità dei cittadini.
C’è uno stretto collegamento tra i tre articoli della Costituzione in cui compare il riferimento alla dignità. Il filo che li collega è la nozione di lavoro, a cui a ben vedere si riferisce anche
l'articolo 3, se interpretata in una accezione ampia, vale a dire
non limitata come nei due precedenti articoli all’attività di lavoro subordinato. È il lavoro che consente di realizzare la “pari dignità sociale”. Aboliti tutti i titoli nobiliari contribuire con
il proprio lavoro (qui inteso nella sua accezione più ampia di
esplicazione di una attività produttiva) al progresso della società è l’unico titolo di dignità ammesso dalla costituzione italiana, e diventa il suo valore fondante.
Ciascun cittadino è portatore di un valore pari a quello di ciascun altro cittadino e questo già implica la deduzione contenuta nel secondo comma dell’art. 3, vale a dire la piena partecipazione di tutti i cittadini – soprattutto di coloro che a causa del-
le loro condizioni ne sono di fatto impediti – alla vita della collettività: “dignità” non è un dato naturale da difendere, ma
qualcosa da promuovere e costruire rimuovendo tutti quegli
ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, 2˚comma). Vi è tuttavia anche un altro aspetto da considerare. Se
l’art. 3 ha questa funzione propositiva, negli altri due contesti
essa compare come limite: sia come limite all’attività imprenditoriale, che come abbiamo visto non può svolgersi in modo
da danneggiare la dignità umana (art. 41), sia come limite all’attività lavorativa. L’art. 36, infatti, mentre garantisce al lavoratore “un’esistenza libera e dignitosa” e il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, sottolinea che a questo
diritto “non può rinunciarvi” (art. 36, 3° comma).
Mentre la dignità è tradizionalmente associata all’aggettivo
“umana”, la Costituzione italiana però, introducendo i due aggettivi “pari” e “sociale”, preconizza uno scenario diverso, quello appunto descritto dall’art. 3, al 2˚comma. La dignità è connessa tanto al ruolo che ciascun consociato è chiamato attivamente a svolgere all’interno della società, quanto al fatto che
lo Stato deve assicurargli la possibilità di svolgere e di svolgerne dignitosamente uno. Come il lavoro oltre ad essere un diritto è altresì un dovere, così la dignità oltre ad essere un onore,
del tutto sui generis poiché connesso ai meriti acquisiti con le
proprie prestazioni sociali e un onere, dal momento che ciascun consociato è chiamato a contribuire con la sua attività al
progresso economico e sociale del proprio paese.
6
Ben inteso, anche la Costituzione italiana riconosce i “diritti
inviolabili dell’uomo” in quanto tale (art. 2) e dunque non solo
nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la propria personalità, ma anche come “singolo”, e tuttavia è significativo che neppure l’art. 32, 2˚comma, un articolo, come vedremo al centro
di molte attuali discussioni, in cui si afferma che “nessuno può
essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (e che persino quest’ultima “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), ritorni esplicitamente il riferimento alla dignità umana.
Implicito resta il rinvio alla dignità anche in un altro punto
esemplare: quello che riguarda il trattamento del detenuto.
L’art. 27, 3˚comma, afferma, in negativo, che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e
subito dopo continua, in positivo, che esse “devono tendere alla rieducazione (sociale) del condannato” (3). Così pur riconoscendo attraverso l’umanitarismo penale il principio che nessun condannato deve essere trattato in modo degradante e
umiliante è, ancora una volta, sulla dimensione sociale che si
insiste, sottolineando che lo scopo della pena deve mirare al
recupero sociale del detenuto.
L’analisi della Costituzione potrebbe continuare entrando nel
dettaglio delle singole disposizioni analizzate, ma non è questa l’occasione per farlo, qui preme piuttosto sottolineare che
l’uso esplicito del vocabolo “dignità” è in essa circoscritto alla
dimensione sociale – la dignità paritaria che implica l’eguaglianza sostanziale dei cittadini –, mentre l’altro uso, quello
che la considera un principio supremo, pre-positivo, è solo im-
plicito. La formulazione del tutto peculiare usata dal Costituente – “pari dignità sociale” – non ha avuto particolare fortuna
in dottrina (4), salvo le rare eccezioni che abbiamo segnalato.
Basta sfogliare i manuali di diritto costituzionale più accreditati (5) e le enciclopedie giuridiche più diffuse per rendersene
subito conto. Solo l’Enciclopedia giuridica Treccani ha inserito una voce concernente la dignità, ma significativamente essa
riguarda esclusivamente la dignità del lavoratore (6). L’interesse tuttavia sta senza dubbio crescendo, come mostra l’introduzione della voce “dignità” nel Trattato di Biodiritto (7) e nel recentissimo quarto volume dell’Enciclopedia di bioetica e
scienza giuridica (8). Come è evidente è la connessione tra
bioetica e dignità ad essere ora al centro di molte discussioni
sia con riferimento all’inizio della vita (tecniche di riproduzione assistita) sia alla fine (rifiuto di cure, eutanasia). Ma di tutto ciò ci occuperemo in seguito.
Prima di analizzare alcune interessanti pronunce giurisprudenziali è opportuno fare una carrellata della legislazione ordinaria. Anche se la nozione di dignità non compare nè nel codice civile, nè in quello penale, molteplici sono i riferimenti alla
dignità nelle leggi ordinarie. Tenuto conto dell’importanza che
assume la figura del lavoratore nella Costituzione è proprio da
qui che prende le mosse il legislatore, approvando con la legge
n. 300 del 20 maggio 1970 lo Statuto dei lavoratori, in cui è
centrale il richiamo alla dignità. Tutelando la categoria dei lavoratori da modalità di controllo messe in atto dai datori di lavoro sull’attività lavorativa e sul lavoratore medesimo la legge
portava a concreta realizzazione il dettato costituzionale (9).
7
In anni più recenti quella tutela si è di molto estesa, comprendendo anche un’ampia gamma di comportamenti riconducibili al cosiddetto mobbing (si veda il d. leg. 11 aprile 2006, cd.
Codice delle pari opportunità) e ad un fenomeno che spesso a
questo è connesso, quello delle molestie e in specie di quelle
sessuali, considerate alla stregua di discriminazione (10).
Partendo dal soggetto-lavoratore nel corso degli anni la tutela
della dignità si è andata ad estendere a diversi altri soggetti,
tutelati proprio per via della loro specifica condizione: il detenuto, la donna, il malato, la persona disabile, lo straniero, il
consumatore, il defunto, e così via con differenziazioni ulteriori e sempre più specifiche (ad es.: il tossicodipendente, il malato terminale ecc.). Non pare invece aver assunto un ruolo di
rilievo il richiamo alla dignità con riferimento all’embrione.
Nella pur controversa legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione
assistita non ricorre mai il riferimento alla dignità dell’embrione, quantunque il primo articolo assicuri “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. Di seguito una rassegna delle leggi più importanti.
Con riferimento alla condizione di detenuto già la legge n. 354
del 26 luglio 1975, sull’ordinamento penitenziario, portando a
concreta realizzazione quanto previsto dalla Costituzione, afferma che “il trattamento penitenziario deve essere conforme
ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. Con riferimento alla donna si pensi anzitutto alla legge
n. 194 del 22 maggio 1978 sull’interruzione volontaria della
gravidanza, in cui si sottolinea che gli accertamenti necessari
in vista di tale richiesta dovranno avvenire “nel rispetto della
dignità e della riservatezza della donna” (art. 5). Con riferimento alla condizione di malato già l’importante legge n. 833
del 23 dicembre 1978, con la quale si istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, richiamando l’art. 32 della Costituzione, fa
esplicito riferimento al fatto che anche i trattamenti sanitari
obbligatori disposti dall’autorità giudiziaria devono avvenire
“nel rispetto della dignità della persona umana” (art. 33). In
particolare al tossicodipendente si riferisce il testo unico della
legge in materia (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; le recenti modifiche, l. n. 49 del 2006, non riguardano il tema qui trattato), il
quale prevede che il programma terapeutico socio-riabilitativo
sia “formulato nel rispetto della dignità della persona“ (art.
122, 2˚comma). Della dignità del malato terminale si occupa il
controverso progetto di legge su “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento”, ma si tratta di un riferimento meramente formale (il disegno di legge all’art. 1, lettera b, “riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via preliminare
rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”), contraddetto da concrete disposizioni che di fatto per più versi la violano (non è richiesto il consenso del paziente quando ci si trovi in una situazione d’urgenza, anche se l’interessato è ancora capace di intendere e di volere e quindi gli si impone un trattamento non voluto [art. 2,
c. 9], si esclude dalla dichiarazione eventuale anticipata di trattamento la possibilità di esprimersi sull’alimentazione e l’idratazione artificiali [art. 3, c. 4]). Qualcosa di analogo si può dire
con riferimento a tutt’altra condizione, quella di straniero: la
legge n. 40 del 6 maggio 1998 all’art. 12 afferma che qualora
8
non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione del
clandestino “lo straniero è trattenuto nel centro (di permanenza temporanea) con modalità tali da assicurare la necessaria
assistenza e il pieno rispetto della sua dignità”. (La legge più
recente del 24 luglio 2008, n. 125 non modifica questo punto
se non per il fatto che ora i centri sono chiamati “di identificazione e di espulsione). In un successivo d.p.r. del 30 marzo
2001 si sottolinea però la necessità di monitorare “il livello di
diffusione nel nostro paese di atti discriminatori (…) profondamente lesivi della dignità degli stranieri”. Con riferimento alle
persone disabili particolare importanza riveste la legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale, i diritti delle persone disabili (legge n. 104 del 5 febbraio 1992) la quale “garantisce il
pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società” (art. 1). Una più recente legge (la n. 7 del 9 gennaio
2006) tutela inoltre specificamente le persone disabili da discriminazioni, specificando che tra di esse vanno fatte rientrare anche le “molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero
creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità
nei suoi confronti” (art. 2, 4˚comma). Con riferimento alla
condizione di consumatore, anche se la disciplina specifica
(legge n. 281 del 30 maggio 1998) non conteneva un esplicito
richiamo alla tutela della dignità, esso era tuttavia presente
nella legge n. 39 del 1˚marzo 2002 in cui, integrando precedenti disposizioni, si vietava “la televendita, che vilipenda la
dignità umana” (art. 52). Sorprende l’uso del vocabolo “vilipenda”: tale fattispecie di reato infatti si riferisce nell’ordinamento italiano all’offesa fatta verso istituzioni, cose e simboli
tutelati per legge; il vilipendio di persone riguarda soltanto chi
professa la propria fede religiosa o l’amministra, e nell’ambito
dei delitti contro la pietà dei defunti. È evidente che il legislatore, qui, ha fatto un uso diverso del vocabolo. Riguardo al consumatore si deve però ora tenere presente il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (con il quale è stato emanato il Codice del
Consumo). In particolare nell’art. 27 bis compare la salvaguardia della dignità umana nei codici di condotta specifici che
possono essere adottati da organizzazioni imprenditoriali e
nell’art. 30, 1˚comma, in cui è vietata “la televendita che offenda la dignità umana”. Con riferimento al defunto il riferimento alla dignità compare in alcune leggi regionali in materia di
servizi funebri e cimiteriali, laddove si afferma la necessità di
tutelare la “dignità del defunto” (ad es. art. 1 della legge regionale umbra del 21 luglio 2004, n.12).
Tra le condizioni, sempre più specifiche, che prevedono una
tutela della dignità va annoverata quella di membro di una associazione che abbia come sua finalità la promozione sociale.
Nell’art. 2 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 si parla infatti di “dignità degli associati”. E, per sottolineare questo aspetto della dignità connessa al ruolo che la persona riveste sulle
formazioni sociali, si possono ricordare i codici deontologici di
molte professioni in cui il vocabolo “dignità” viene utilizzato
per indicare la propria categoria: la dignità riferita allo status
di lavoratore si estende così alle libere professioni, come quel9
la del giornalista, dell’avvocato, del consulente del lavoro, del
medico e del farmacista.
Sinora la nostra attenzione si è principalmente focalizzata, anche se non in modo esclusivo, su quella dimensione sociale della dignità che riguarda concrete categorie di persone, le quali
nelle diverse formazioni sociali in cui temporaneamente o stabilmente sviluppano la loro personalità possono, attraverso discriminazioni di ogni genere, trovare un impedimento alla loro realizzazione. Oggi tuttavia i pericoli per la dignità umana
possono venire anche dalla società stessa, nel momento in cui
essa tende a privare i singoli individui del nucleo più profondo
di intimità, che dovrebbe invece essere sottratto agli occhi indiscreti del pubblico. Ogni uomo non solo ha diritto ad essere
rispettato, in positivo, per quello che è nella società, ma anche
in negativo, per quello che di sé non vuole far conoscere agli
altri, e su cui desidera che sia mantenuto l’assoluto riserbo. La
dignità in questo caso non riguarda il lavoratore, la donna, la
persona disabile e così via, ma ciascun individuo che ha diritto
a non essere disturbato nella sua sfera privata. La nozione di
riservatezza, di privacy, è così l’altra faccia della dignità sociale. Tanto quest’ultima incide sull’esistenza sociale, quanto la
prima sull’esistenza individuale. L’apposito codice in materia
di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003) nasce proprio da questa esigenza. Ed è significativo che tale codice non
si limiti ad enunciare fattispecie astratte e generali sotto le
quali il giudice dovrà sussumere i casi concreti; ma preveda
l’istituzione di un Garante che dovrà valutare se singole situazioni possano costituire violazione della privacy.
Due provvedimenti al riguardo sono di particolare interesse:
nel primo (9 novembre 2005, il relatore è Pizzetti), riguardante il trattamento dei dati personali in ambito sanitario viene
ribadito che esso deve avvenire “nel pieno rispetto della dignità dell’interessato” e che la “tutela della dignità personale deve
essere garantita nei confronti di tutti i soggetti cui viene erogata una prestazione sanitaria, con particolare riguardo a fasce
deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori, gli anziani e i
soggetti che versano in condizioni di disagio o di bisogno”.
(Garante per la protezione dei dati personali, Strutture sanitarie: rispetto della dignità umana). Anche se la “dignità personale” riguarda tutti, una particolare attenzione viene riservata
alle fasce deboli.
Il secondo provvedimento riguarda un argomento dal punto
legislativo ancora aperto: vale a dire quello delle intercettazioni telefoniche. A seguito della reiterata pubblicazione da parte
di varie testate giornalistiche di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche il Garante (relatori: Chiaravalloti e Paissan) ha emanato il 21 giugno 2006 un provvedimento (Garante per la protezione dei dati personali, Pubblicazione di intercettazioni telefoniche e dignità della persona) in cui si ribadisce che il diritto dei cittadini all’informazione, con la connessa
libertà di stampa deve comunque avvenire senza ledere “il pieno rispetto della dignità della persona”.
In conclusione: la legislazione ordinaria lascia emergere una
tutela della dignità molto differenziata, che dalla dimensione
eminentemente sociale e lo stretto legame con l’idea di eguaglianza sostanziale, come esplicitamente previsto dalla Costitu10
zione, è passata via via a coprire nuovi scenari. Tutto ciò si riflette, come tra poco vedremo, tanto nella giurisprudenza costituzionale quanto in quella ordinaria.
Ma prima va pur ricordato un elemento importante. La dignità umana come tale è pur entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico con la ratifica del Trattato di Lisbona, avvenuta con legge n. 130 del 2.8.2008, il quale all’art. 1bis colloca la
dignità al primo posto tra i valori fondanti gli Stati membri
dell’Unione (seguono in successione la libertà, la democrazia,
l’uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani), mentre i primi cinque articoli della sua Carta dei diritti fondamentali sono
raccolti sotto il Capo I, dedicato alla dignità, e qui la dignità,
nell’ordine di successione, precede il diritto alla vita, il diritto
all’integrità della persona, il divieto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, la proibizione della schiavitù e
del lavoro forzato.
2. Usi della dignità nella giurisprudenza costituzionale
e in quella ordinaria
È qui impossibile un’analisi dettagliata del profilo giurisprudenziale (11). Ci limiteremo, pertanto, a registrare le tendenze
di fondo. Cominciamo anzitutto dalle pronunce della Corte Costituzionale. La Corte ha fatto un uso tutto sommato piuttosto
prudente del principio di dignità – a partire dalla sentenza n.
3 del 1957 in cui si tenta persino di definire la “pari dignità sociale” osservando che l’espressione “sta a significare, che deve-
si riconoscere ad ogni cittadino uguale dignità pur nella varietà delle occupazioni o professioni anche se collegate a differenti condizioni sociali”- circoscrivendolo a quanto specificamente previsto dall’art. 3 della Costituzione per ribadire l’illegittimità di qualsiasi forma di discriminazione, oppure utilizzandolo come elemento rafforzativo, di sostegno, quando entrano in
gioco i diritti inviolabili dell’uomo tutelati all’art. 2. In alcune
sentenze, più recenti, essa non si sottrae neppure all’attività di
bilanciamento (si veda esemplarmente la n. 196 del 2004).
Restano invece piuttosto isolate le pronunce in cui la Corte riconosce alla dignità un rilievo autonomo. Ciò avviene, se non
sbaglio, solo in due casi: quando attraverso di essa si vuol configurare un nuovo diritto costituzionalmente protetto, come
esemplarmente la sentenza n. 37 del 1985, nella quale si fa discendere dalla dignità “un diritto costituzionale agli alimenti”,
o quando la dignità – sottratta ad ogni bilanciamento – viene
intesa come un limite, rispetto al quale altri diritti costituzionalmente tutelati devono soccombere. È questo il caso più interessante ed una sentenza al riguardo merita una considerazione più ravvicinata.
Nella sentenza n. 293 dell’11 luglio 2000, riguardante il fondamento giustificativo della punibilità di coloro che diffondono a
mezzo stampa con particolari impressionanti raccapriccianti
immagini di avvenimenti realmente verificati, la Corte Costituzionale ha riconosciuto nella dignità un limite invalicabile, oltre il quale neppure la libertà di manifestazione del pensiero
può spingersi, dal momento che “quello della dignità della persona è, infatti, valore costituzionale che permea di sè il diritto
11
positivo”. Per la Consulta, insomma, c’è un “contenuto minimo” del rispetto della persona umana che oltrepassa la pur legittima pluralità delle concezioni etiche presenti nella nostra
società e questo contenuto lo si ritrova nel principio della dignità che diventa, in tal modo, una sorta di norma di chiusura
dell’intero ordinamento.
Di “nucleo irriducibile” o “irrinunciabile”, “limite invalicabile”, rappresentato dalla dignità si parla anche in alcune sentenze attinenti i trattamenti sanitari (ad es.: sentenza n. 509 del
13 novembre 2000, richiamata anche nella sentenza n.11 del
2005; sentenza n. 282 del 19 giugno 2002 o, più recentemente
la sentenza n. 10 del 2010). Tra queste da ricordare ancora,
più recentemente la n.151 dell’8 maggio 2009 che ha dichiarato, limitatamente ad alcune parole, l’illegittimità della legge
sulla procreazione medicalmente assistita, richiamando gli
art. 3 e 32 della Costituzione (peraltro senza utilizzare espressamente la parola “dignità”).
Ci siamo soffermati su alcune pronunce della Corte Costituzionale in cui la dignità viene tutelata in quanto tale, ma si tratta
– occorre ribadirlo – di casi piuttosto isolati. Molto più spesso
essa non si riferisce all’uomo in quanto tale, ma ad una qualità
concreta inerente la condizione esistenziale o professionale
della persona. Viene così protetta, per fare qualche esempio,
la dignità del militare in generale (sentenza 189/1976) e del
militare subordinato in particolare (sentenza 45/1992), della
casalinga in quanto lavoratrice (sentenza 85/1985), della persona sottoposta a perizia medico-legale (sentenza 54/1986),
del minore dato in adozione (sentenza 303/1996) del detenu-
to in generale (sentenza 526/2000) e del detenuto in particolare (sentenza 158/2001) del bambino handicappato (sentenza
465/2002), del giudice (sentenza 204/2004), dei siciliani (sentenza 283/2002) degli omosessuali (ordinanza 129/2005) degli ebrei (sentenza 268/1998) e soprattutto (e di gran lunga
prevalente) del lavoratore. Proprio questa attenzione riservata
dalla Corte non all’uomo in astratto, ma ad individui concreti
ed in particolare a quei “soggetti deboli” che possono facilmente diventar oggetto di discriminazione è un’ulteriore conferma
del timbro particolare che ha la dignità nell’ordinamento costituzionale italiano.
Questa specificità è confermata dell’analisi della giurisprudenza ordinaria. Dopo quanto sin qui si è detto non dovrebbe sorprendere che proprio la dignità del lavoratore rappresenti
l’esempio che ricorre con maggiore frequenza nelle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali (12). Merita qui di essere
riportato il passo di una importante pronuncia della Corte di
Cassazione (la n. 5977 del 29 novembre 1985): “La dignità del
lavoratore è l’estrinsecazione della persona umana nella caratteristica che le è propria di ordinare le sue azioni al più alto
grado di compimento, in vista di uno scopo comune, quale sviluppo del consorzio di vita economica, sociale e spirituale in
cui vive, affinamento della propria coscienza e capacità di esteriorizzare anche solo con il comportamento, il principio di elevazione morale, insito in ogni uomo. La prestazione di lavoro
è impossibile in una condizione di disprezzo di essa, di disprezzo della persona che la rende, di disprezzo degli uomini che vi
12
attendono, e, quindi, in una condizione di costrizione ad eseguirla senza dignità…”
Il modo in cui qui la Suprema Corte pone in risalto l’importanza del lavoro e della dignità di chi lavora è in precisa sintonia
con il dettato costituzionale e conferma la centralità che il lavoro (ed il lavoratore) ha nell’organizzazione sociale ed economica del nostro Paese.
Più recentemente il rispetto della dignità del lavoro ha assunto specifiche connotazioni come quelle definite dal fenomeno
del mobbing o delle molestie, in particolare sessuali. E anche
nella giurisprudenza ordinaria si manifesta quella stessa tendenza, che abbiamo già documentato in quella costituzionale,
vale a dire la tutela della dignità di specifiche categorie di persone: i minori, i portatori di handicap, i tossicodipendenti, i
detenuti, gli extra-comunitari, i militari con ruoli subordinati
e le persone decedute.
Un’analisi dettagliata ci porterebbe troppo lontano. Ma almeno un caso merita di essere richiamato, perché bene mostra
l’evoluzione compiuta anche dalla Suprema Corte. La sentenza riguarda la condanna (confermata in appello) di un comandante di fregata per il reato di ingiuria ad inferiore. Il ricorso
si basava sul fatto che nel procedimento era stato omesso di
valutare la dichiarazione della persona offesa, la quale aveva
escluso ogni intento offensivo in una espressione volgare che
il suo superiore gli aveva rivolto, considerandola alla stregua
di un atteggiamento scherzoso. La Corte Suprema ha tuttavia
rigettato il ricorso osservando che è irrilevante “che il soggetto
passivo abbia percepito l’espressione offensiva senza ritenersi
offeso, in quanto l’oggetto della tutela penalistica va individuato in termini assai più ampi, e precisamente nel valore della
dignità umana in quanto tale (Cass. pen. 1˚aprile 2004,
n.15503). È evidente che qui la dignità assurge a valore oggettivo, del tutto indipendentemente dalle valutazioni soggettive
delle parti coinvolte. Dalla tutela della dignità sociale del lavoratore siamo passati alla tutela di un’idea di dignità come valore indisponibile ed irrinunciabile anche da parte del suo titolare.
È tuttavia (a partire dal 1990 con una sentenza della Corte
Ass. di Firenze del 18 ottobre che ha fatto storia) soprattutto
con riferimento ai trattamenti sanitari che in molte pronunce
troviamo un rinvio al principio della dignità. Fuoriesce dai limiti di questo contribuito un’analisi dettagliata al riguardo,
qualcosa va però in conclusione detto, riguardo a due casi tormentati che hanno suscitato in Italia un ampio dibattito. Mi
riferisco come è evidente alle tristi vicende di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro (13).
Nel caso di Welby, affetto da distrofia muscolare progressiva,
l’accento sulla dignità viene posto dai suoi legali nella loro richiesta di sospensione della respirazione artificiale, poiché
questa avrebbe consentito la prosecuzione sì della vita, ma in
condizioni ritenute dal loro assistito degradanti e lesive della
sua dignità. Il rispetto di quest’ultima viene qui strettamente
connesso al diritto di autodeterminazione, nella fattispecie al
diritto di rifiutare un trattamento non più voluto. Un diritto
ampiamente tutelato – come abbiamo visto – dalla Costituzio13
ne italiana e tuttavia farlo effettivamente valere è stato molto
più difficile di quanto si potesse in linea di principio immaginare. Al dottore che ha materialmente staccato il respiratore,
dopo aver accertato anche nell’imminenza del distacco la volontà dell’interessato, è stato infatti imputato il reato di omicidio del consenziente, quantunque alla fine il giudice dell’udienza preliminare abbia prosciolto il medico, in ragione dell’esimente dell’adempimento di un dovere. Nella sua motivazione,
tra l’altro, il giudice descrive Welby come un paziente “ormai
profondamente consapevole di aver esaurito ogni aspettativa
di vita, di una vita che ancora possa essere chiamata tale e che
abbia conservato la dignità coessenziale alla qualità di uomo”
(Tribunale Roma, sentenza 23 luglio/17 ottobre 2007, n.
2049). Anche se questo richiamo alla dignità è del tutto marginale e non ha influito sulla decisione presa dal giudice è significativo che egli riconosca, sia pure implicitamente, incompatibile con il senso di dignità della paziente la prosecuzione della
vita in quelle condizioni.
oggettivo, confuso ad onor del vero, con il diritto alla vita. D’altro canto la Corte di Cassazione, con sentenza del 16 ottobre
2007, n. 21748, fa propria la visione soggettiva della dignità,
ritenendo indegno protrarre per anni la mera sopravvivenza
del corpo di una persona, che se cosciente, non avrebbe sicuramente accettato. Va peraltro riconosciuto che l’ultima sentenza tenta in realtà una sintesi tra la versione oggettiva e quella
soggettiva della dignità nel momento in cui vuol tener ferma
l’idea della tutela della dignità umana nella sua generalità e
astrattezza, salvo d’altro canto concretamente riconoscere il
diritto “di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo
canoni di dignità umana propri dell’interessato”. Insomma,
proprio il tema del finis vitae lascia intravedere un aspetto sul
quale la riflessione è ancora soltanto agli inizi, e cioè che la dignità è un principio superiore della vita stessa.
Proprio su questo punto è interessante l’altra vicenda, quella
di Eluana Englaro, che fa bene emergere questa versione della
dignità, riconducibile all’autodeterminazione del paziente, che
alla fine si è imposta. Del lungo iter processuale ricordiamo
qui solo la fase iniziale e quella finale. Il primo decreto del Tribunale di Lecco (1° maggio 1999) dichiara inammissibile la richiesta di autorizzazione alla sospensione dell’idratazione e
nutrizione artificiali poiché “la dignità attinge dal valore assoluto della persona e prescinde dalle condizioni anche disperate in cui si esplica la sua esistenza”. La dignità è qui un valore
Dopo quanto abbiamo detto resta aperto un interrogativo di
fondo: c’è qualcosa che accomuna gli usi legislativi e giurisprudenziali, così disparati, che abbiamo incontrato, o la dignità si
rivela un’idea tanto suggestiva ed evocativa, quanto vaga e indeterminata? Cosa lega, per fare qualche esempio, la tutela della dignità dei detenuti alla tutela della dignità dei lavoratori?
O la dignità di questi ultimi a quella dei malati terminali? È
evidente che in tutte le situazioni indicate la “dignità” assume
un significato diverso. Un detenuto ha diritto ad una cella pulita, a non essere maltrattato o torturato, ad un minimo di riser-
3. Conclusioni
14
vatezza; un lavoratore, anzitutto, ad un’attività lavorativa e ad
un ambiente di lavoro non degradanti. Anche qualora si volesse definire il lavoro salariato come una forma di sfruttamento,
neppure il marxista più ortodosso lo paragonerebbe ad una
forma di tortura. E le difficoltà non fanno che aumentare non
appena si passa da situazioni comunque connesse ad una dimensione sociale a situazioni in cui la dimensione è individuale: che cosa ha a che fare la dignità del lavoratore, il diritto al
pieno sviluppo della sua personalità e alla partecipazione effettiva alla vita della collettività, con la dignità del malato terminale che proprio in nome della dignità rifiuta di procrastinare
la morte nel tempo?
Persino la stessa espressione “vita dignitosa” acquista due significati diversi a seconda che si riferisca al diritto che ha il lavoratore ad una retribuzione che consenta a lui e alla sua famiglia di condurre una vita dignitosa, o al diritto che ha il malato
terminale di non prolungare ulteriormente una vita da lui ritenuta, appunto, non più dignitosa. Peraltro, proprio con riferimento a quest’ultimo caso l’argomento della dignità viene utilizzato tanto da coloro che in nome della sacralità della vita sono contrari all’eutanasia, quanto da coloro che richiamandosi
all’autodeterminazione del paziente sono invece favorevoli.
Si sarebbe, a prima vista, tentati di concludere che la nozione
di dignità sia di per sé poco utile a risolvere i problemi che concretamente si presentano: se ad essa si fa ricorso è paradossalmente perché la sua sostanziale indeterminatezza fa sì che essa sia utilizzabile per scopi molto diversi: la sua duttilità la ren-
de applicabile ad una pluralità indefinita di situazioni. Da qui,
in fondo, la sua scarsa utilità pratica.
Questa conclusione è però, a ben vedere, tutt’altro che convincente. Che della dignità si parli al plurale non deve sorprendere. Il linguaggio ha una struttura aperta e non si vede perché
questo non dovrebbe valere anche per la parola “dignità”, come tutte le altre parole anche questa è ambigua e soprattutto
vaga. Questo è proprio quanto emerge dalla registrazione dei
diversi usi, nei diversi contesti, che abbiamo fatto. Si potrà certo discutere se usi “marginali” della dignità siano coerenti o
meno, con il significato di solito attributo a quella parola, ma
il vero problema è un altro: qual è il nucleo centrale di certezza, ammesso che ve ne sia uno che consente di definire questo
vocabolo?
Non si può rispondere astrattamente a questa domanda; alla
luce degli usi che abbiamo sin qui registrato si può però dire
che nei primi decenni successivi alla promulgazione della Costituzione l’accento batte sulla “dignità sociale” e sullo stretto
legame che questa ha con l’eguaglianza sostanziale (art. 3), nell’ultimo decennio pur senza venir meno questo motivo ad esso
se ne è aggiunto un altro, imperniato sull’art. 32, il quale insiste sul fatto che “in nessun caso” nell’ambito dei trattamenti
sanitari può essere violato “il rispetto della persona umana”,
indicando così un limite che neppure la legge può varcare. Per
quanto paradossale possa sembrare il carattere assoluto, incondizionato, della dignità compare nella Carta costituzionale
solo nel punto in cui espressamente la parola non c’è, anche se
15
buona parte della dottrina e della giurisprudenza oggi interpreta quell’articolo alla luce del principio dignità.
Così, incisivamente, si esprime Stefano Rodotà, dopo aver citato l’art. 32 della Costituzione: “È, questa, una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione, poiché pone al legislatore un limite invalicabile, più incisivo ancora di quello previsto
dall’articolo 13 per la libertà personale, che ammette limitazioni nella base della legge e con provvedimento motivato dal giudice. Nell’art. 32 si va oltre. Quando si giunge al nucleo duro
dell’esistenza, alla necessità di rispettare la persona umana in
quanto tale, siamo di fronte all’indecidibile” (14). Peraltro anche qui il principio compare in stretta connessione con un diritto fondamentale, quello della salute. Insomma, ciò che in
generale sembra caratterizzare il dibattito giuridico italiano
sulla dignità è che questo principio non compare quasi mai come valore assoluto, incondizionato, quale fondamento dei diritti umani, ma semmai concorre con essi.
Con riferimento al dibattito italiano bene si attaglia quanto Eugenio Ripepe (uno dei pochi filosofi del diritto – assieme a chi
scrive – ad essersi occupato dell’argomento) ha invece preteso
di generalizzare, vale a dire che la dignità lungi dal fondare alcunché è soltanto la “risultante di un insieme di valori” (15)
sempre variabile e legata all’evoluzione della sensibilità prevalente. Similmente il noto civilista Paolo Zatti ha di recente sostenuto la tesi che per spiegare la dignità può essere utile far
ricorso al termine (di derivazione junghiana) di “costellazione”. La dignità si costella, interagisce con la vita e l’integrità e
quindi con la libertà, senza che per questo vada perduta quella
dimensione sociale che sin dall’inizio in Italia la contraddistingue. Ma gli pare rischioso “rinunciare al fondamento della dignità” (16). Quel fondamento però non può che alludere ad un
nucleo duro, sicuramente meno duttile ma anche più stabile
ad una, per così dire, clausola generale, che senza negare tutte
quelle settoriali che il multiforme uso della dignità ha messo
in evidenza, le supera; e quel nucleo non può essere trovato
nell’aggettivo “sociale”, ma nell’aggettivo “umano”, che non è
un mero di più, ma qualcosa a tal punto costitutivo della dignità che nella lingua tedesca forma con essa un’unica parola:
Menschenwürde.
Il nucleo intangibile della dignità è dunque l’uomo stesso. Ad
essere indisponibile, inscalfibile, è l’idea atemporale, ontologica, della natura umana, ma ciò ha a che fare soprattutto con
gli attuali angosciosi problemi connessi alla manipolazione genetica. E su questo il dibattito è aperto.
Note
1 Cfr. G. Ferrara, La pari dignità sociale. (Appunti per una ricostruzione), in Studi
in onore di Giuseppe Chiarelli, vol.II, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 1089-1105; la stessa linea interpretativa, ma attualizzata al nuovo contesto sociale della crisi del Welfare si ritrova nell’articolo di M.R. Marella, Il fondamento sociale della dignità
umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo di contratti, in “Rivista
critica del diritto privato”, XXV, 1, 2007, pp. 67-103. Cfr. anche P. Grossi, La dignità nella Costituzione italiana, in La tutela della dignità dell’uomo, a cura di E. Ceccherini, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 113-136 (il saggio è apparso anche,
con lo stesso titolo, in “Diritto e società”, 2008/1, n. 1, pp. 31-63). Tra gli scritti più
recenti si veda F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Torino, Giappichelli, 2011.
16
2 Il comma 1 dell’art. 1 del Grundgesetz recita: «La dignità umana è intangibile.
Rispettarla e difenderla è dovere di ogni potere dello Stato». Per un confronto tra
la Costituzione italiana e quella tedesca con specifico riguardo al tema della dignità
non posso qui che rinviare al mio contributo: Die italienische verfassungsrechtliche Variante im Vergleich zur deutschen, in: Menschenwürde. Begründung, Konturen, Geschichte, a cura di G. Brudermüller e K. Seelmann, Würzburg, Kӧnigshausen und Neumann, 2008, pp. 107-116 e ora, in una versione integralmente rielaborata, a P. Becchi, La dignità umana nel Grundgesetz e nella Costituzione italiana,
in «Ragion pratica», Nr. 38, 2012, pp. 25-43. La parte monografica del fascicolo,
che ho curato insieme a F. Belvisi e V. Pacillo, è dedicata alla dignità umana.
3 Si veda, al riguardo, in particolare M. Ruotolo, Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana, in “Diritto e società”,
2005/1, n. 3, pp. 51-74 e, del medesimo autore, la monografia Diritti dei detenuti e
Costituzione, Torino, Giappichelli, 2002.
4 Prima del contributo di Ferrara, citato alla nota 1, la formulazione era stata ampiamente sottovalutata dai costiruzionalisi e compare solo del tutto incidentalmente nelle due monografie che affrontano in modo specifico il tema della dignità sotto
il profilo costituzionale. Cfr. F. Bartolomei, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Torino Giappichelli 1987, pp. 20-21 e A. Pirozzoli, Il valore costituzionale della dignità. Un’introduzione, Roma, Aracne, 2007, pp. 125-126. Una
trattazione più ampia nel recente volume di M. Di Ciommo, Dignità Umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, Firenze, Passigli, 2010, p. 147-156.
5 I più importanti sono riportati nell’esile sottoparagrafo dedicato alla “pari dignità
sociale” nel recente Commentario alla Costituzione, Art. 1-54, Torino, UTET,
2006, pp. 671-72 (A. Celotto).
6 Cfr. A. Cataudella, Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della), in Enciclopedia Giuridica Treccani, XI, Roma, 1989 (1a ed.), pp. 1-11 (dell’estratto).
7 Cfr. G. Resta, La dignità, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti,
vol. I: Ambito e fonti del biodiritto, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 259-296 (si tratta
del miglior lavoro di sintesi attualmente esistente per quel che attiene il biodiritto).
8 Dignità umana, in Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, diretta da E.
Sgreccia e A. Tarantino, vol.IV, Napoli-Roma, ESI, 2012, pp. 283-320.
9 Oggi, una controriforma del mercato del lavoro imposta all’Italia dall’Unione Europea sta smantellando le conquiste dei lavoratori ottenute con le lotte operaie alla
fine degli anni Sessanta. L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori prevedeva infatti una
norma di tutela come è quella del reintegro per chi fosse stato licenziato senza una
giusta causa o in modo discriminatorio. Senza il “principio lavorista” (art. 1), si perdono i fini e le forze che reggono l’affermazione dell’uguaglianza e la “pari dignità
sociale” dei cittadini (art. 3): gli stessi diritti inviolabili (art. 2) perdono il loro fondamento ultimo.
10 Cfr., in generale, M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Milano,
Giuffrè, 2003 e, specificamente, M. Barbera, Molestie sessuali: la tutela della dignità, in “Diritto e pratica del lavoro”, 1992, pp. 1401-1406.
11 Per un esame più approfondito cfr. anzitutto A. Ruggeri – A. Spadaro, Dignità
dell’uomo e giurisprudenza costituzionale, in “Politica del diritto”, 3, 1991, pp.
343-337 e, più recentemente F. Gambini, Il principio di dignità, in I diritti della
persona. Tutela civile, penale, amministrativa, a cura di P. Cendon, vol.I, Torino,
UTET, 2005, pp. 236-241 e soprattutto A. Pirozzoli, Il valore costituzionale della
dignità. Un’introduzione, Roma, Aracne, 2007, pp. 103-137 (alle pagine indicate si
trova la più ampia rassegna, oggi esistente, della giurisprudenza costituzionale).
12 Per un’analisi più approfondita non si può qui che rinviare a A. Cataudella, Dignità e riservatezza del lavoratore in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma,
1989, pp. 1-11 dell’estratto; e G. Alpa, Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali, in “Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, II, 1997, pp. 415-426.
13 Per una ricostruzione complessiva delle due vicende processuali non posso qui
che rinviare al mio articolo Am Ende des Lebens. Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Tod in der heutigen Medizin, in Auf der Scholle und in lichten
Hӧhen. Festschrift für Paul Richli zum 65. Geburtstag, a cura di M. Caroni, S. Heselhaus, K. Mathis, R. Norer, Zürich-St. Gallen-Baden-Baden, 2011, pp. 23-54. Una
ricostruzione più analitica la si può trovare nei miei seguenti contributi: La vicenda Welby: un caso ai limiti della denegata giustizia, in “Ragion pratica”, 28, 2007,
pp. 299-312; Piergiorgio Welby e il diritto di lasciar(si) morire, in “Ragion pratica”, 30, 2008, pp. 245-265; L’imperialismo giudiziario. Note controcorrente sul
caso Englaro, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto” LXXXVI, 3, 2009,
pp. 379-403. Cfr. P. Becchi, La giustizia fra la vita e la morte, Torino, Giappichelli,
2012.
17
14 Così si esprime Stefano Rodotà nell’editoriale con cui si apre la parte monografica intitolata Sulla giuridificazione della dignità umana, della “Rivista critica del
diritto privato”, XXV, n.1, 2007, 3-5 (4).
15 Cfr. E. Ripepe, La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto, in
La tutela della dignità dell’uomo, a cura di E. Ceccherini, Napoli, E.S.I., 2008, pp.
11-38.
16 Cfr. P. Zatti, Note sulla “semantica della dignità”, in Bioetica e dignità umana.
Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo, a cura di E.
Furlan, Milano, F. Angeli, 2009, pp. 95-109 (107), anche P. Zatti, Maschere del diritto volti della vita, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 24-49 (46).
18
G IOVANNI G ASPARINI U NIVERSITÀ C ATTOLICA DEL S ACRO C UORE
Bellezza
e dignità umana
Tra dignità e bellezza
1. A proposito di valori
Il grande, ineludibile tema dei valori porta lo scienziato e il ricercatore sociale a percorrere lo stretto crinale che separa la
sociologia dalla filosofia e ne coglie al tempo stesso feconde
possibilità di scambio e di reciproco arricchimento.
Il sociale, vale a dire gli aspetti e i destini delle società così come il loro tessuto interno costituito di relazioni tra gruppi e attori sociali, è sempre stato oggetto di analisi filosofica, sin da
Platone e Aristotele. A tali analisi si accostano poi le riflessioni
e prescrizioni teologico-religiose – basti citare la visione di società e di legge che prende forma nel mondo ebraico come
esplicita conseguenza di quanto scritto nella Bibbia –, oltre
ad analisi e valutazioni politiche interessate a favorire un certo disegno e assetto del sociale: esemplare in questo senso
l’analisi di Machiavelli, che dopo parecchi secoli viene tuttora
universalmente utilizzata in chiave di scienza politica.
INDICE
1. A proposito di valori
2. La dignità e la bellezza nella vita sociale
3. La bellezza e l’Italia
Riferimenti bibliografici
Vale la pena di richiamare qui per sommi capi che la sociologia nasce tra fine Ottocento e inizio Novecento per offrire una
diversa visuale sul e del sociale: una prospettiva che, come afferma autorevolmente Max Weber, è “libera dai valori”
(wertfrei), e non corrisponde cioè a valutazioni di come la società e i rapporti sociali “dovrebbero essere” ma di come essi
si manifestano realmente, oggettivamente in un certo senso,
in un contesto dato e attraverso un approccio descrittivo-interpretativo che si suppone indipendente dai desideri e dagli au19
spici dell’osservatore sociale, del politico, del reggitore di uno
stato.
Viene quindi in evidenza il tema dei valori, i grandi principi
che regolano non solo la vita personale di ogni individuo ma
anche la struttura dei diversi sistemi sociali, degli stati e persino – tendenzialmente e tentativamente - di una realtà mondiale come è quella oggi rappresentata dalle Nazioni Unite, al cui
fondamento si trova la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948
Dal punto di vista della sociologia, i valori possono essere definiti nel modo più semplice come i giudizi su ciò che è considerato bene o male, positivo o negativo nel sociale, vale a dire in
un determinato sistema sociale, in una collettività che si dà
delle norme e delle leggi, le quali possono variare grandemente nel tempo e rispetto a quelle di altri gruppi sociali e di altri
stati. Un esempio drammatico al riguardo è rappresentato dal
valore della vita in caso di gravi violazioni delle leggi compiute
da singoli membri di un sistema: alla maggioranza di stati che
non applicano la pena di morte fanno tuttora da contrappunto, come è noto, altri stati che prevedono per le forme di devianza-delinquenza più gravi l’applicazione di tale forma estrema di pena.
Tra il “dover essere” degli approcci filosofici e teologici e l’approccio orientato all’“essere” delle scienze sociali (sociologia,
antropologia culturale, psicologia sociale ecc.), i sociologi si sono districati non senza fatica. Charles Wright Mills, indimenticato sociologo americano morto prematuramente negli anni
Sessanta del Novecento, affermava in epigrafe alle sue opere
di aver cercato di essere obiettivo, non neutrale. E del resto,
se andiamo a osservare la vita e gli orientamenti socio-politici
dei padri della sociologia, come Max Weber e Emile
Durkheim, possiamo cogliere un loro impegno quanto meno
di principio in favore di certi orientamenti ideali o ideologici
nel sociale.
L’approccio che si vorrebbe qui proporre è in consonanza con
la sfida di Mills di conciliare l’obiettività dell’osservazione dei
dati di realtà sociale con l’impegno “non neutrale” nei confronti dei grandi valori:
si tratta in altri termini di immaginare e praticare una Sociologia umanistica, che pur mantenendo il carattere cosiddetto
della Wertfreiheit sia tuttavia sensibile e attenta ai valori. Oggi, nel contesto della società post-industriale (o post-moderna) che si sta strutturando a livello mondiale nel XXI secolo,
con i gravi problemi posti dalla globalizzazione e dalla crisi
economica, ritengo che per lo scienziato sociale sia sempre più
opportuno, e persino doveroso in termini deontologici, dichiararsi non neutrale ma al contrario simpatetico e sensibile rispetto ai grandi valori. Sono, questi macro-valori, quelli che
in fondo permettono anche alle scienze sociali e umane di continuare ad operare e a svolgere una funzione conoscitiva e critica nei sistemi contemporanei: si tratta della convivenza e del
dialogo tra gruppi sociali e paesi portatori di culture diverse,
della pace, della democrazia e del rispetto dei diritti delle minoranze. E sono, naturalmente, i grandi valori nati dalla rivoluzione francese – libertà, eguaglianza e solidarietà (moderna
20
traduzione della fraternità) – ai quali si può aggiungere esplicitamente il valore-quadro della dignità della persona: dignità
di ogni individuo indipendentemente dalla sua condizione di
nascita, dai suoi comportamenti, dalle sue specifiche opzioni
politiche e religiose. Il perseguimento della giustizia, poi, rappresenta in un certo senso il punto di riferimento sintetico e il
suggello dei valori condivisi in una società come quella di oggi, che si afferma espressione di uno stato di diritto.
Il disegno di una sociologia umanistica, che si apparenta più
all’anima filosofica e letteraria delle radici del pensiero sociale
piuttosto che a quella scientifica in senso stretto che ha accompagnato la disciplina sin dalle sue origini (cfr. Lepenies 1987),
è particolarmente interessato non solo ai valori ma anche agli
aspetti concreti del vivere insieme (la qualità della vita realizzata e/o consentita nei nostri sistemi): è qui che il tema della
bellezza e della sua costruzione sociale a vari livelli assume un
valore non secondario in termini di indagine, di opzioni e di
fattibilità.
2. La dignità e la bellezza nella vita sociale
Il quadro sinteticamente delineato sollecita una messa a fuoco
comparata o integrata tra la dignità e la bellezza: quest’ultima
va considerata anch’essa nelle sue valenze e ricadute sociali, e
come un valore che può essere esplicitamente dichiarato e perseguito da un dato sistema (cfr. Gasparini 2012).
Prima di illustrare in alcune dimensioni la tematica della bellezza è opportuno arricchire i riferimenti alla dignità sopra
enunciati. Ora, il valore-principio fondamentale della dignità
di ciascun essere umano è richiamato sin dal Preambolo e dal
primo articolo della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo del 1948 allorchè si afferma:
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, … [Preambolo]
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. [art.1]
Lo stesso documento ribadisce all’art.22 che ad ogni individuo
è riconosciuta la possibilità di realizzare i diritti economici, sociali e culturali “indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”.
La Costituzione italiana, da parte sua, proclama espressamente, all’art.3, la pari dignità di tutti i cittadini in relazione al valore della libertà:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, approvata nel 2000, nel suo Preambolo unisce esplicitamente il valore della dignità umana ai tre grandi valori adottati dagli stati
moderni, ponendolo quindi a oggetto del primo articolo:
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà. (…) [Preambolo]
21
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. [art.1]
Le fa eco l’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea (Carta di Lisbona approvata nel 2009), che recita solennemente:
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
Ora, alla prefigurazione e creazione di una società orientata a
tali grandi valori di base non è estraneo il tema della bellezza.
L’irrinunciabilità dell’obiettivo della bellezza per l’uomo – che
noi consideriamo nello stesso tempo, in un’ottica sociologica
umanistica, una persona irripetibile nella sua unicità e un attore sociale che condivide con molti altri una realtà di vita e una
serie di condizionamenti e di possibilità inerenti a un dato
contesto e struttura sociale – è affermato anzitutto da scrittori
e filosofi umanisti. Tra gli altri François Cheng, autorevole mediatore contemporaneo tra la cultura cinese e quella occidentale, rileva il fatto stupefacente che l’universo non sarebbe obbligato ad essere bello ma tuttavia lo è:
L’universo potrebbe essere semplicemente dotato del carattere della verità,
ma in tal caso esso sarebbe formato da elementi funzionali, uniformi, indifferenziati e intercambiabili. La vita invece ci parla dell’unicità e insostituibilità
di ciascun essere nello spazio e nel tempo, ed è questo ciò che provoca incessantemente stupore, ponendosi all’origine della bellezza. L’unicità trasforma
ogni essere in una presenza che, come un fiore o un albero, continua a tendere nel tempo verso la pienezza del suo sviluppo [éclat], che è la definizione
stessa di bellezza” (Cheng 2006, p.26).
Nota ancora Cheng, con una osservazione traducibile anche in
termini sociali, che esiste tra ciascuna presenza uno scambio
che assicura la permanenza della bellezza in una sorta di rete
collettiva universale:
La bellezza attraverso il suo potere di attrazione contribuisce alla costituzione dell’insieme delle presenze in un’immensa rete di vita organica in cui tutto si collega e si tiene insieme, dove ogni unicità trova senso di fronte alle altre unicità e in tal modo prende parte al tutto. (Cheng 2011, p.23)
Gli fa eco in qualche modo uno studioso cognitivista come Howard Gardner, quando osserva che le esperienze di bellezza
rappresentano “una delle ragioni principali per essere vivi, per
desiderare di restare vivi, per condividere la gioia di vivere
con altri” (Gardner 2011, p.191).
In termini certo diversi ma non troppo lontani nel fondo si
esprimeva nell’immediato dopoguerra un umanista ed economista come Louis Joseph Lebret, fondatore del movimento
Economie et Humanisme negli anni Quaranta e successivamente consigliere al Concilio Vaticano II, allorché poneva la
bellezza subito dopo la verità tra i valori dell’uomo nella società industrializzata:
L’uomo moderno ha un immenso bisogno di bellezza. L’uomo non ha solo
bisogno di verità. Egli è anche avido di bellezza. Senza bellezza gli manca
qualcosa, è infelice. (…)
Mentre la verità penetra nella mente lentamente, e sovente attraverso il ragionamento, per induzione o deduzione, la bellezza s’impone a tutto l’essere.
(…)
Chi percepisce la bellezza penetra immediatamente nel più intimo delle cose. (…)
22
L’uomo moderno raramente incontra la bellezza: egli ne è allontanato dagli
ambienti delle fabbriche, delle strade e delle periferie urbane; vive in case
mal costruite; utilizza strade senza armonia … (Lebret 1946, I, p.80)
Senza nulla perdere della propria forza e capacità di attrazione, il tema della bellezza viene riportato qui esplicitamente alla dimensione sociale, vale a dire alla possibilità concreta di
vivere esperienze di bellezza dal punto di vista del lavoratore,
dell’uomo comune e dell’attore sociale che partecipa ad una
società urbano-industriale di massa come quella di metà Novecento. E’ evidente che non si può trattare esclusivamente di un
fatto volontaristico, lasciato alla sensibilità o alle opzioni individuali: esso risente infatti delle dimensioni strutturali e delle
opzioni culturali e politiche della società in questione, o per
usare una locuzione sintetica del suo impegno nei confronti
della costruzione sociale della bellezza.
Appare significativo, in questa prospettiva, quanto è stato
scritto in particolare a proposito del rapporto tra arte e società
in occasione di una mostra dedicata nel 2011-2012 a Cézanne, vale a dire che
L’arte è elemento essenziale per la costruzione di una convivenza civile che
abbia per obiettivo la felicità di tutti e di ciascuno. L’inesausta ricerca di
Cézanne è in questo senso un esempio e una sfida (Pisapia 2011)
Si
può immaginare allora una società giusta e dignitosa che sia
anche una società bella, nella quale – per fare alcuni esempi –
vengano tutelati e curati adeguatamente la natura e il paesaggio, o in cui si combatta l’inquinamento ambientale compreso
quello acustico, o dove le condizioni della realtà urbana siano
improntate a criteri che coniughino armoniosamente la dimen-
sione estetica con la vivibilità e con il rispetto delle regole da
parte di tutti. E, ancora, si può cercare di costruire una società
le cui strutture educative sin dalla scuola dell’obbligo contemplino una esplicita educazione alla bellezza (nelle espressioni
naturali e paesaggistiche, nell’arte, nella stessa vita quotidiana) dei giovani scolari e studenti.
Attualizzando un invito di Albert Camus, Salvatore Veca ha
recentemente posto in epigrafe alla sua “teoria della giustizia
senza frontiere” l’impegno dello scrittore francese di mantenere una duplice fedeltà, tanto alla bellezza quanto agli oppressi,
realtà entrambe presenti nel mondo. Nella prospettiva di Veca
l’essere fedeli alla bellezza, che rifugge sia dal riduzionismo di
chi afferma non esservi spazio per la bellezza stessa sia dall’utopia di una società perfetta e indifferente ai duri vincoli della vita reale, si traduce nell’impegno nei confronti di una filosofia politica “che ci orienti nell’esplorazione dello spazio delle
possibilità, entro il più ampio spazio che il mondo ci concede”
(Veca 2010, p.7). Restano molto aperti qui i contenuti da dare
al perseguimento del valore della bellezza nel sociale: una società bella in ogni caso non può non porsi il tema di un confronto e di un’integrazione con una società giusta, così come –
secondo alcuni, specialmente nel mondo cattolico - di una società e di una “vita buona” (cfr. Scola 2009).
Cade opportuno a questo punto il richiamo di un nuovo valore
generale che è venuto acquistando progressivamente una certa diffusione e consenso negli ultimi decenni ed è rappresentato dalla qualità della vita, solitamente considerata in opposizione alle aspirazioni ad un benessere di tipo economico mera23
mente materiale: queste ultime peraltro – non sorprendentemente – continuano a raccogliere una adesione individuale e
collettiva molto elevata.
La qualità della vita ha a che vedere con la costruzione sociale
della bellezza che si esprime in un sistema attraverso una serie
di situazioni, comportamenti ed esperienze che si riflettono
nella vita quotidiana. Indico in modo sintetico e a titolo di
esempio la bellezza percepita (e anche attivamente tutelata)
della natura e del paesaggio, l’armoniosità e vivibilità di un
contesto urbano da fruire in modi concentrati anziché concitati – dando spazio ad esempio a pratiche di lentezza negli spostamenti e nella fruizione urbana, o preservando fasce e aree
di silenzio a contrasto dell’inquinamento da rumore dominante -, la bellezza in sé di certe città che godono complessivamente di un particolare genius loci (come in Italia Venezia,
Roma e Firenze, per citare tre casi di rinomanza universale),
la bellezza di elementi e fenomeni culturali, dalle feste civili e
religiose tradizionali fino alla gastronomia locale (come lo
slow food in opposizione al fast food metropolitano). Ma altri
elementi fondamentali si possono aggiungere, come la stessa
bellezza del corpo umano, elemento di godimento estetico e di
attrazione così come oggetto di cure e attenzioni che oggi trovano riflessi rilevanti nel perseguimento di condizioni di forma e di fitness adeguate. E, naturalmente, la qualità della vita
ha a che vedere con quella bellezza di cui è espressione tipica e
privilegiata l’arte nelle sue variegate espressioni, così come
l’artigianato e il design, in cui il nostro paese mantiene espressioni e tradizioni molteplici e di grande prestigio.
Costruire una società orientata in vario modo alla bellezza presuppone l’adozione di certi modelli e strutture formative, come si è già accennato sopra di passaggio. Si vorrebbe qui ribadire che una educazione consapevole ed esplicita alla bellezza
nella società contemporanea, a partire dall’infanzia ma protratta in forme diversificate e molteplici a tutte le età della vita, potrebbe avere il compito di affiancare ai modelli efficientistici, economicistici e competitivi dominanti – legati alle caratteristiche tecnologico-organizzative della network society attuale - altri elementi e prospettive non meno cruciali per i destini individuali e collettivi: la capacità di concentrazione e di
silenzio, la valorizzazione della qualità in sé accanto o in contrapposizione alla quantità, la lentezza da alternare opportunamente alla velocità, la convivialità con cui temperare l’individualismo, la sobrietà, la riscoperta della gratuità e delle dimensioni spirituali della vita. E naturalmente una rinnovata e
creativa attenzione all’educazione alla bellezza – premessa per
una costruzione sociale e persino di una “politica” della e per
la bellezza – avrebbe come strumento privilegiato di espressione ed esercitazione le forme artistiche e quelle dell’artigianato.
3. La bellezza e l’Italia
Dalle pagine che precedono si può trarre un primo elemento e
orientamento sintetico: quello che dignità e bellezza possono
convivere nei sistemi contemporanei, per quanto non sempre
sia facile cogliere i livelli e i modi di tale compatibilità. Al riguardo, il tema della dignità, a cui si connette strettamente co24
me si è visto quello della giustizia, si pone in modo particolarmente acuto nei paesi e nei contesti in cui non sono adeguatamente soddisfatti i bisogni elementari e primari della popolazione o di parte considerevole di essa: è evidente che una società i cui membri vivono in maggioranza ad un livello di sussistenza, come è il caso oggi in particolare di parecchi paesi del
continente africano, non si ponga come obiettivo primario
quello della costruzione della bellezza nel paesaggio naturale o
urbano.
Ma la bellezza, al fondo, non è un problema di lusso, come indicano anche una serie di testimonianze quali quelle sopra indicate: anche in situazioni di deprivazione materiale o di povertà, i membri delle società moderne sembrano non accontentarsi di un semplice benessere materiale, sono avidi di bellezza per riprendere le parole dell’economista Lebret.
L’Italia di oggi, alla luce della sua storia negli ultimi duemila
anni almeno, esprime una realtà e una istanza di bellezza del
tutto peculiare. Senza volersi addentrare in paragoni indebiti
né tanto meno accampare pretese di superiorità nei confronti
di altri paesi, è indubbio che il nostro paese rappresenti in termini universalmente riconosciuti un polo essenziale di attrazione in termini di bellezza: una bellezza persistente da secoli
e articolata in forme assai diverse.
La bellezza – in termini di una sua visibilità e fruibilità sociale
– potrebbe addirittura rappresentare il perno di un rilancio
dell’identità italiana nel mondo, a conclusione dei primi 150
anni di unità di un paese che proprio in questi anni si è interro-
gato sui fondamenti dei propri caratteri, così come sono percepiti sia all’interno che all’esterno.
L’Italia è un paese non solo indivisibile, come recita la Costituzione, ma molto particolare: un paese unico per la sua storia,
per l’apporto dato al mondo intero in termini anzitutto culturali e spirituali. Credo che, nel travaglio che scuote oggi la società italiana, si potrebbero proporre tre aspetti sintetici per riaffermare la sua identità. Si tratta di elementi di indubbia attualità che nello stesso tempo hanno alle spalle una storia lunghissima. Essi hanno a che vedere in modo esplicito con la bellezza: mi riferisco all’arte, alla natura-paesaggio, alla lingua.
Sull’arte, anche in termini di riflessi sul sociale (educazione e
cultura, economia, turismo, oltre che qualità della vita) il discorso appare indiscutibile e quasi scontato. Non si tratta di
stabilire graduatorie o record tra i capolavori artistici che hanno visto la luce in Italia – molti dei quali sono peraltro ospitati
in musei stranieri, a partire dal dipinto più visitato nel mondo
che è la Gioconda di Leonardo esposta al Louvre -, ma di riconoscere l’innegabile, straordinario e costante apporto artistico
al mondo che il nostro paese ha dato nei secoli e che ancora
oggi gli viene riconosciuto. Lo testimonia tra l’altro il fatto che
l’Unesco considera l’Italia il detentore nel mondo della massima parte delle opere d’arte conosciute. Questo tratto caratteristico dell’identità italiana rappresenta un patrimonio da valorizzare e da offrire adeguatamente non solo agli italiani ma all’Europa di cui facciamo parte e naturalmente al mondo intero.
25
Nell’area artistica, come specificazione ulteriore e completamento volto all’attualità, non va trascurato anche il patrimonio che la creatività italiana nei secoli ha saputo perpetuare e
rinnovare fino ad oggi nelle forme più varie di artigianato presente in tutte le regioni del paese, così come la componente di
bellezza che si esprime nel design, nella produzione di oggetti
industriali di uso quotidiano e nella moda che nel secondo dopoguerra si è imposta nel mondo all’insegna del made in
Italy.
Di passaggio, è significativo che nel 2012 sia stato lanciato dal
quotidiano Il Sole – 24 Ore un “Manifesto per la cultura” che
ha ricevuto molte adesioni e tra l’altro ha suscitato una esplicita presa di posizione del governo in carico, attraverso i tre ministri dei Beni culturali, dello Sviluppo economico e dell’Istruzione, Università e Ricerca, i quali hanno auspicato
[…] un investimento che deve interessare lo straordinario patrimonio culturale italiano, inteso non solo come risorsa da tutelare e preservare, ma da animare e valorizzare sempre di più, perché elemento costitutivo dell’identità
del Paese, della sua storia, della sua civiltà, del suo “saper fare”, della sua
stessa competitività. (Ornaghi, Passera, Profumo 2012)
Il paesaggio, secondo elemento indicato di una riaffermazione identitaria dell’Italia, integra un ambiente naturale di varietà stupefacente, se si tiene conto delle dimensioni relativamente limitate del paese: non a caso in Italia si registra il numero più elevato di specie vegetali tra quelle presenti sul territorio di qualunque altro paese europeo. L’Italia, il bel paese
sin dai tempi di Dante e di Petrarca fino all’omonima opera ottocentesca dell’abate Stoppani che ebbe grande risonanza,
esprime un singolare assortimento di paesaggi: essi risentono
tanto della diversità di condizioni naturali e climatiche (dai
ghiacciai alpini fino ai vulcani attivi in Sicilia e nelle isole circostanti) quanto dell’invenzione storicamente determinatasi di
soluzioni culturali specifiche a ciascuna area. Dai paesaggi alpini a quelli appenninici, dagli ambienti marini liguri e tirrenici a quelli assai diversi delle coste adriatiche e delle isole maggiori, dalla pianura padana ai laghi prealpini, dalle colline toscane a quelle umbre e marchigiane, tralasciando parecchie
altre aree, si assiste ad una varietà che si nutre nello stesso
tempo di natura e di cultura: quest’ultima coinvolge anche il
tipo di insediamenti urbani e rurali tipici di ogni paesaggio. E’
bene ricordare qui che dal Settecento, se non prima, il Grand
Tour in Italia offriva ai giovani aristocratici e intellettuali di
tutta Europa una serie di bellezze che erano rappresentate insieme da arte e da natura-paesaggio.
La lingua è il terzo elemento di bellezza e di valorizzazione
identitaria dell’italianità che si vorrebbe proporre. Al riguardo, pur evitando eventuali confronti con altre lingue, è opportuno prendere atto che la lingua italiana, troppo poco valorizzata oggi nel mondo a vantaggio di altre più funzionali all’informatica e più forti per ragioni economico-politiche, non soltanto è dotata di grande musicalità, versatilità e attitudine ad
esprimere le sfumature più minute dei sentimenti, ma si trova
affiancata e corroborata da una letteratura che è considerata
unica al mondo, a partire dalla presenza di Dante, “il poeta assoluto” come lo chiamava a ragione Cristina Campo, i cui versi
26
ogni italiano è tuttora in grado di ascoltare e – sia pure con
qualche sforzo – di comprendere.
L.J.Lebret (1946), Guide du militant, Economie et Humanisme, L’Arbresle (Rhône), 2 voll.
Uno dei più autorevoli critici contemporanei ha scritto recentemente che la lingua italiana è “una lingua ricca, leggera, complessa, nobile, musicale” (Citati 2011), al punto tale che negli
ultimi anni essa è stata adottata da un certo numero di scrittori maghrebini e africani che l’hanno preferita al francese, la loro lingua ex-coloniale.
W.Lepenies (1987), Le tre culture, Il Mulino, Bologna.
Così, senza alcuna velleità nazionalistica, l’Italia può riscoprire oggi con umile orgoglio la propria straordinaria vocazione
alla bellezza nell’arte, nella natura e nel paesaggio, nella lingua, per offrirla al mondo in un dono condiviso.
A.Scola (2009), La vita buona, Messaggero di S.Antonio, Padova.
L.Ornaghi, C.Passera, F.Profumo (2012), “Cultura. Necessario
tornare a investire”, Il Sole – 24 Ore, 24 febbraio.
G.Pisapia (2011), Esposizione Cézanne – Les Ateliers du Midi,
Palazzo Reale, Milano, ottobre 2011 – febbraio 2012.
S.Veca (2010), La bellezza e gli oppressi, ed.ampliata, Feltrinelli, Milano.
Riferimenti bibliografici
F.Cheng (2006), Cinq meditations sur la beauté, Albin Michel, Paris.
Id. (2011), Oeil ouvert et coeur battant, Desclée de Brouwer –
Collège des Bernardins, Paris.
P.Citati (2011), « I narratori che scelgono l’italiano », Corriere
della sera, 6 novembre.
H.Gardner (2011), Verità, bellezza, bontà, Feltrinelli, Milano.
G.Gasparini (2012), “La costruzione sociale della bellezza”, Aggiornamenti sociali, 63, 4, aprile, pp.297-306.
27
M ARKUS K RIENKE F ACOLTÀ TEOLOGICA DI L UGANO
Dignità umana e
bene comune
I NDICE
1. Considerazioni introduttive
2. Il comune contesto “ideale”
3. Dignità Umana in contrapposizione al bene
comune?
4. Ritrovare la sintesi
Note
1. Considerazioni introduttive
Anche se pochi studi se ne sono accorti, la “storia delle idee”
della dignità umana è intimamente connessa con il concetto
del bene comune, anzi si può dire che trova le sue radici in quest’ultimo. Compito di queste riflessioni è argomentare questo
nesso, che a prima vista può sembrare senz’altro molto sorprendente: di solito si identifica il fondamento della dignità
umana nel pensiero kantiano (1), mentre il bene comune fa capo al filone aristotelico-tommasiano del pensiero occidentale.
Oggi vediamo infatti nella discussione attuale questi due concetti spesso ideologicamente contrapposti, innanzitutto nel dibattito tra “libertarismo” e “communitarismo”. È stato innanzitutto Alasdair MacIntyre a schierare il filone aristotelico-tommasiano, basato sull’etica della virtù e sul concetto di bene comune, contro l’individualismo moderno che nella storia delle
idee fa capo a Locke e Kant (2). Ma proprio se abbiamo presente questa discussione accesa, possiamo evincere che la riconsiderazione della loro comune appartenenza ideale è in grado di
aprirci nuove prospettive per oltrepassare battaglie di trincea
che oggi piuttosto impediscono il progresso culturale anziché
promuoverlo.
Come distinzione iniziale dei due concetti, possiamo delineare
la seguente considerazione: mentre il termine dignità umana
fa prevalere l’individuo alla società ed appartiene in quanto
concetto giuridico al discorso della “modernità”, il bene comune è riferito al livello politico della comunità e ci deriva piutto28
sto dal contesto “premoderno”. Mentre quest’ultimo concetto
segue la logica argomentativa “eteronoma” (“premoderna”), il
primo viene declinato sulla falsariga di quella “autonoma”
(“moderna”). Ma contrariamente a questo quadro generale,
ciò che in realtà rende complicato il rapporto tra dignità umana e bene comune non è affatto la presunta “opposizione” tra i
due termini, ma piuttosto la loro vicinanza. E con questa osservazione si oltrepassa già la loro contrapposizione ideologica.
Infatti, abbiamo a che fare in entrambi i casi (1) con un concetto morale (quindi di etica della politica e del diritto) che spiega la “ragione dell’obbligazione” nella sfera pubblica, che svolge quindi la (2) funzione di legittimazione per la realtà politico-giuridica e che ha (3) l’importante compito di critica del potere politico. In questa prospettiva, si delinea quindi un compito importante chiarire innanzitutto il loro comune contesto
“ideale”.
2. Il comune contesto “ideale”
Troviamo dei riferimenti più espliciti per questo comune contesto in un terzo autore rispetto ad Aristotele e Kant, ossia
Tommaso d’Aquino. In effetti, egli non soltanto riscopre nel
medioevo occidentale Aristotele, ma anticipa anche – cosa un
po’ meno nota – tanti concetti importanti di Kant. E non a caso dobbiamo a lui la prima definizione filosofica del termine
“bene comune”, che come mero termine appare per la prima
volta già negli Stoici romani. In che cosa consiste questo primo significato autentico del bene comune, che si lascia eviden-
ziare proprio come contesto storico-ideale dello sviluppo del
concetto di dignità umana?
Per rispondere a questa domanda, conviene analizzare la dimensione del bene comune in Aristotele: per lui, τὸ κοινῇ
συµφέρον significa il bene del corpo politico (polis) che è quel
“contesto” e “ordine” della realizzazione del “vivere bene”, della “felicità” che è la «piena realizzazione dell’umanità di ciascuno dei suoi membri» (3). Infatti, è tale società politica, non
l’individuo né la famiglia, che viene chiamata dallo Stagirita
“autosufficiente” o “autarchica”. In questo senso, la polis diventa l’ultimo punto di riferimento per definire quel «ciò cui
tutto tende» che è la definizione di “bene” in Aristotele, e costituisce così la «comunità […] perfetta», «per rendere possibile
la vita, in realtà per rendere possibile una vita felice» (4). Come afferma Aristotele nell’Etica Nicomachea, «identico è il bene per il singolo individuo e per la città; tuttavia è chiaramente cosa più grande e più perfetta conseguire e salvaguardare
quello della città. Il bene infatti è amabile anche nella dimensione dell’individuo singolo, ma è più bello e più divino quando concerne un popolo o delle città» (5).
Mentre alla famiglia sono associati i rapporti diseguali e gerarchici tra le persone (padre, madre, schiavi), la società assolveva la funzione etica dei rapporti egalitari e quindi di “giustizia”. Allo stesso momento, però, questa uguaglianza si articola
come un’uguaglianza elitaria, in quanto valeva solo per gli uomini liberi, il che significava concretamente per non più di un
quarto della società. Innanzitutto nel rapporto tra liberi e
schiavi, tra Greci e Barbari, tra uomini e donne, tra giovani e
29
adulti ecc. si esprimeva una disuguaglianza fondamentale, che
era considerata di “diritto naturale”. Per questo certi gruppi di
persone erano di per sé esclusi dallo svolgimento della “vita
politica” e quindi dalla partecipazione nel senso pieno della parola alla “buona vita” della “polis”. Considerando che Aristotele definisce l’essere umano uno “zoon politikon”, allora queste
persone sono esclusi dalla realizzazione della vita nel suo significato pieno, e costituiscono una seconda parte della società,
in quanto anche loro non possono certo vivere al di fuori della
società. Lì, infatti, per i Greci vivono solo le bestie e gli dèi: i
primi perché non sono capaci di rapporti sociali, i secondi perché sono gli unici individui “autarchici”. La società politica è
pensata come un organismo, in cui ogni parte (organo) ha il
suo posto e svolge il suo ruolo naturalmente assegnato da essa. Evidentemente, senza la vita dell’organismo la singola parte non potrebbe né realizzarsi né vivere, ma in ogni caso si deve realizzare nella maniera assegnatagli dalla costituzione naturale dell’organismo.
Tale contesto “politico” del “bene comune”, connesso alla realtà della polis, assegna a quest’ultima una responsabilità elevata nella realizzazione – Rawls parlava addirittura della «massimizzazione» – del bene (comune ed individuale), attraverso
un compito educativo (e perciò tendenzialmente interventista)
per lo sviluppo e la formazione di una vita virtuosa. La “misura” dell’uomo, quindi, era metafisicamente determinata nel
contesto politico della polis. A conoscerla e concretizzarla erano destinati i filosofi, in quanto si potevano basare su un “vantaggio conoscitivo” nel contesto politico.
L’apporto decisivo di San Tommaso per la filosofia politica
non sta tanto nella misura in cui riprende l’accezione di questo “bene politico” di Aristotele, ma in quanto la modifica: il
bene comune è identificato non con il telos della felicità che
l’individuo acquisisce nel contesto sociale della polis, ma con
il fine della beatitudine che è Dio come il bonum commune extrinsecum et intrinsecum di ogni essere umano (6). E anche
se egli condivide con Aristotele il riferimento fondamentale alla dimensione sociale per il conseguimento del “fine” della persona, questa non è più identificata con la polis ma con la “società dei santi”. L’uso di un vocabolario molto simile non deve
ingannare: mentre il contesto sociale di riferimento per Aristotele era la polis, per San Tommaso lo è la dimensione sociale
della natura umana perfezionata per grazia, ossia la communio sanctorum (7). Il “telos” non si identifica più con un “ideale” di società concreta, ma quest’ultima è finalizzata, a sua volta, alla civitas Dei. Ciò non toglie niente al fatto che San Tommaso possa fedelmente riportare la posizione di Aristotele per
quanto alla società politica: «Ciascuna causa tanto è anteriore
e preferibile, quanto è maggiore il numero di cose a cui si
estende», per cui «sembra molto più importante e perfetto
procurare e salvare ciò che è bene per l’intera città piuttosto
che ciò che è bene per un solo uomo». Ma questa dimensione
ora è inserita nel bene soprannaturale: «si è detto che ciò è
più divino, per il fatto che assomiglia maggiormente a Dio, il
quale è la causa ultima di tutti i beni». Questo bene soprannaturale, Dio, non è un bene “politico” ma riferito al compimento della persona in quanto tale: e per questo il compimento
dell’individuo (la felicità) non è più finalizzato alla dimensio30
ne della polis, ma vice versa la comunità politica risulta indirizzata alla tensione tra dimensione naturale e soprannaturale
della natura umana. Come primo risultato, tale finalizzazione
trascendente del bene comune porta ad un’universalizzazione
personalistica di questo concetto, che supera l’aristotelico elitarismo morale.
In questa maniera, la polis come fine risulta sostituita dalla
“natura umana” in quanto creata da Dio e quindi in quanto essa porta in sé la “legge naturale” come riflesso della “legge eterna” del Creatore. E la “natura umana”, rispetto alla natura
non-umana, ha lo specifico di avere la capacità (intelligenza)
della conoscenza di Dio e del bene comune. Certamente questa duplice conoscenza delinea un ordine lessicale: la persona
è finalizzata innanzitutto alla beatitudine e all’interno di questa destinazione soprannaturale si trova anche costitutivamente membro della società politica. Mentre la prima finalizzazione impegna tutta la persona, l’ultima la concerne soltanto in
quanto cittadino: «l’uomo non è ordinato alla comunità politica secondo tutto se stesso e secondo tutte le cose sue […], ma
tutto ciò che l’uomo è, e ciò che può, e ha, deve essere ordinato a Dio» (8). In questa dimensione trascendente della natura
umana, quest’ultima acquisisce la sua dignità (come immagine di Dio e coronamento della creazione) che quindi, in conseguenza dei ragionamenti appena svolti, diventa il criterio per
il bene comune (9).
In che cosa consiste precisamente questa dignità per San Tommaso? Essa si basa sulla considerazione che «le sostanze intellettuali sono governate per se stesse, le altre cose invece per
esse» e perciò «la creatura razionale è governata per se stessa». Incontriamo qui una nuova definizione del significato di
dignità: “dignus” non è più soltanto colui che nella gerarchia
sociale occupa un posto più in alto, ma soprattutto e fondamentalmente chi raggiunge un livello morale più alto di autogoverno e autocontrollo. Questa dimensione è stata considerata già da Cicerone, il quale distinse due significati di questo termine: da un lato, in quanto segnala, all’interno del pensiero
stoico sulla dignità dell’uomo che partecipa al Logos universale, questa posizione speciale dell’uomo nel cosmo, e, dall’altro
lato, la dimensione politico-sociale del termine che designa
persone più egregie all’interno della gerarchia sociale. Come
per lo stesso Cicerone, però, anche nella storia successiva, diventò incisiva soprattutto la seconda dimensione del termine,
cioè quella che definisce la dignità in riferimento alla collocazione sociale di una persona. È il merito di Tommaso d’Aquino di aver messo al centro della riflessione filosofica il primo
significato: ossia quello che assegna all’uomo ontologicamente
un posto elevato nella creazione, per cui il criterio delle virtù e
quindi del perfezionamento della persona non sta più nella polis politica, ma è diventato personalistico e quindi, si potrebbe
dire, de-politicizzato, appunto perché il telos della natura umana non è più indirizzato alla dimensione politica ma alla trascendenza. Attraverso questa riflessione, già iniziata dagli Stoici e poi teorizzata da Tommaso d’Aquino, nella dignità umana
si poteva scoprire il criterio del bene comune. L’importanza
storico-ideale di tale passaggio è stata descritta egregiamente
da Rosmini nella Filosofia del diritto: «Ora chi mai può disconoscere il fatto, che il Cristianesimo, introducendo la carità
31
nel mondo, vi pose un principio d’incessante azione, e ch’egli
ha così immensamente aumentata e perpetuata l’attività negli
uomini? […] Un principio di libertà sì manifesto, che mentre
all’umanità gentile parea non potersi muovere oppressa sotto
il peso d’inesorabile fato, l’uomo cristiano all’opposto sente la
propria individualità, e svolge in sè stesso una sempre nuova
libera sua potenza? Se altro dunque non è una società umana
che un complesso, un avvincolamento di diritti e di doveri, chi
non intende da questo solo, come l’istituzione della società cristiana, dee aver influito su tutte le altre società, sulla domestica e sulla civile specialmente, facendo comparire in esse nuovi
diritti, quasi dal nulla traendoli con potenza creatrice, ed accertando gli incerti, pur con solo ammigliorarne la radice, coll’ammigliorar cioè e quasi creare nell’uomo il soggetto de’ diritti?» (10). Con quest’analisi Rosmini ha elaborato precisamente la dimensione che il cristianesimo, con l’aiuto della riflessione stoica, ha inserito nella tradizione aristotelica del bene comune. Tale aspetto nuovo si evince dal momento che per
l’Aquinate «nessuno deve danneggiare ingiustamente un altro
per promuovere il bene comune», ossia, in altre parole, il bene
comune non è più l’ultimo orizzonte della valutazione morale
del perfezionamento dell’uomo. Grazie al riferimento della persona umana alla trascendenza tramite la conoscenza di Dio, il
bene comune trova come limite e misura lo stesso soggetto. In
questo modo è nato il «soggetto de’ diritti».
Per la politica del bene comune nasce così una nuova criteriologia: anche se San Tommaso ripete ancora l’importanza educativa del governo individuata in Aristotele, riguardo al “perfe-
zionamento” delle virtù esso non ha più nessuna competenza,
in quanto essa avviene nel contesto non politico ma soprannaturale. Riguardo a quest’ultima dimensione, il governo può soltanto garantire le condizioni e le istituzioni più favorevoli,
quindi creare le condizioni di possibilità, ma non più l’esito.
Sarebbe infatti compito del Re, secondo Tommaso, di «provvedere alla vita buona della moltitudine secondo questo criterio,
cioè secondo quanto conviene al conseguimento della beatitudine celeste, ossia fornire le cose che conducono alla beatitudine celeste e proibire, nella misura in cui ciò sia possibile, quelle ad esse contrarie» (11).
Il bene comune è quindi tutto declinato sul concetto della natura umana nella sua tensione tra natura e compimento soprannaturale, e non più all’interno del riferimento della polis. Segno evidente per questa nuova determinazione del concetto è
[1] l’importanza della contemplazione spirituale, e [2] la rivalutazione conseguente del “lavoro”. Si tratta di due dimensioni
che non troviamo nella visione dell’uomo di Aristotele. In primo luogo, la contemplazione non è più considerato l’elemento
che distingue la “vita felice” di alcuni filosofi dalle altre vite,
ma è diventato elemento della vita del cristiano in quanto tale:
la natura umana in quanto tale si deve perfezionare attraverso
la contemplazione, perché ora non è più una particolare prestazione intellettuale dei sapienti, ma un esercizio di tutti. In
secondo luogo, l’uomo, nella versione cristiana, si realizza positivamente nel lavoro, per cui il lavoro non è più un elemento
che distingue una vita “inferiore” da quella che realizza la “felicità”, come in Aristotele separa quella degli schiavi dai liberi.
32
Infatti, nel mondo greco il lavoro non era considerato un elemento del perfezionamento della natura umana in quanto tale, ma proprietà caratteristica della vita inferiore delle persone
non libere. La realizzazione della vita umana avvenne al di là
del lavoro in una vita da filosofo o da politico. Ora, nel cristianesimo, i monasteri benedettini sono evidenti indicazioni per
una considerazione della realtà umana radicalmente nuova,
che segnano l’inizio di una nuova epoca (Medioevo): perché
con la regola ora et labora non intesero affatto definire una
“vita particolare” dei monaci, alla quale sono chiamati solo pochi, ma stabilirono un nuovo ideale di vita per la città, una
nuova antropologia. Qui si evince chiaramente che il riferimento alla trascendenza dà luogo ad una nuova interpretazione
delle relazioni sociali, e quindi del bene comune, come esse
vengono esemplarmente realizzate nei monasteri come modello sociale alternativo. Non a caso, infatti, accanto alla scienza
politica di Aristotele, Tommaso stabilisce quella monastica e
l’economia: contemplazione e lavoro sono declinate come due
elementi della dignità specifica della persona individuale. La
persona non viene più definita a partire dal contesto politico e
secondo i suoi parametri: ossia nella distinzione tra liberi e
schiavi, tra greci e barbari ecc., ma la dimensione politica è soltanto una tra altre in cui l’essere umano si realizza.
Nella misura in cui il bene comune ha acquistato in San Tommaso la dimensione della dignità umana, esso diventa anche
“legittimazione” o “criterio” del potere politico: infatti i suoi
compiti – assicurazione dell’«unità della pace», del «bene materiale dei sudditi» e «stimolare la vita virtuosa dei sudditi» –
si giustificano come “sussidiari” alla realizzazione della vita
morale della persona che consiste (1) nell’autodeterminazione
alla moralità in libertà e (2) nella vita religiosa, e tramite queste due dimensioni è finalizzata alla felicità e alla beatitudine.
In queste dimensioni, in Tommaso d’Aquino sin trova prefigurata l’idea moderna della libertà di coscienza e di opinione, del
concetto di dignità umana e dell’importanza della libera autodeterminazione del soggetto da qualsiasi costruzione o paternalismo politico.
Questa concezione di bene comune tommasiana si costituisce
quindi con elementi che non derivano né dall’ambito politico
né da quello pubblico aristotelico, ma dalla realtà metafisica
di un corpo sociale consistente da relazioni interpersonali. Da
questa prospettiva si evince, che è quindi la dimensione metafisica della persona ad assegnare la vera e propria dimensione
morale al bene comune. Senza la persona, il bene comune non
è pensabile: San Tommaso ne presenta una vera e propria definizione basata sulla dignità della persona: «Questo intero, che
è la moltitudine civile, oppure la famiglia domestica, ha la sola
unità di ordine, secondo la quale qualcosa non è uno in assoluto. Perciò la parte di quell’intero può avere un’operazione che
non è operazione dell’intero, come un soldato dell’esercito
può avere un’operazione che non è dell’intero esercito. Nondimeno anche lo stesso intero ha qualche operazione che non è
propria di una qualche parte, ma dell’intero, per esempio il
combattimento dell’intero esercito. E il trainare una nave è
operazione della moltitudine i coloro che trainano la nave. Esiste invece qualche intero, che ha unità non solo per ordine,
33
ma per composizione, o per connessione, o anche per continuità, secondo la quale unità è uno in assoluto, perciò non vi è alcuna operazione della parte che non sia dell’intero. Nelle realtà continue infatti è identico il moto del tutto e della parte; e
similmente nelle realtà composte, o connesse, l’operazione della parte è principalmente del tutto».
Questa definizione del bene comune tramite elementi che formeranno nella modernità l’idea di dignità umana viene svolta
da San Tommaso come una riflessione morale, e non politica.
Una tale depoliticizzazione rispetto ad Aristotele non significa
però che questo concetto non abbia nessuna conseguenza o importanza politica, come abbiamo appena visto. Le sue ricadute
sulla politica sono però morali e la dignità umana ancora non
è un concetto giuridico. Persino l’uccisione del tiranna – argomento in cui si evince l’importanza della dimensione morale
della natura umana, e la sua dignità, in precedenza al contesto
politico – non è argomentata in maniera giuridica, ossia come
un diritto individual-liberale, ma si riflette sulla sua giustificazione morale. Come si vede, le riflessioni in Tommaso avvengono all’interno di una considerazione del contesto sociale della natura umana: non un ragionamento individualistico, ma il
motivo del bene comune diventa la giustificazione morale dell’uccisione del tiranna.
Ciò comporta delle conseguenze precise per l’articolazione del
bene comune che ancora non ha acquisito la sua intera accezione personalistica e mantiene la sua configurazione come quadro morale-sociale della persona contro la quale quest’ultima
non ha un vero e proprio diritto di individualità: infatti, per la
dimensione morale e soprannaturale della persona, il bene comune mantiene la sua funzione etica costitutiva. In altre parole, la dignità della persona e anche la sua “prospettiva” di beatitudine non si lasciano definire senza la considerazione etica
del bene comune. Il diritto viene determinato a partire dalla
moralità (diritto naturale) e non ha ancora acquisito la sua definizione più specifica a partire dalla dignità e la libertà morale della persona. Tale contesto morale in cui è articolata la soggettività dei diritti, si esprime in alcuni luoghi di Tommaso
d’Aquino in cui ragioni del bene comune prevalgono ancora
sui diritti individuali: «Peccando, l’uomo lascia l’ordinamento
della ragione e digrada dalla dignità dell’uomo, in quanto l’uomo è libero per natura e vive per sé, cade nella dipendenza delle bestie […]. Siccome è un male di uccidere un uomo per
quanto rimane nella sua dignità, potrebbe essere un bene di
uccidere un uomo come se fosse un animale, se vive nei peccati, perché l’uomo cattivo è peggio di una bestia e causa danni
maggiori». L’uomo quindi ha ontologicamente una dignità per
creazione, ma la deve costantemente adempiere e rinnovare.
La misura di questo “adempimento” si desume dal bene comune: la dignità non è affermata completamente come principio
ontologico (soggettività), in quanto come principio morale è
inserito all’interno della “regola” del “bene comune”. Questo
fa sì che in San Tommaso abbiamo a che fare, in fin dei conti,
con una concezione ancora “eteronoma” della dignità umana
che assegna al bene comune la prerogativa criteriologica alla
dignità umana. Ci troviamo, come ora si evince immediatamente, alla soglia dello sviluppo dell’idea individuale di dignità umana, ma che ancora non viene sviluppata perché il crite34
rio determinante della riflessione è il bene comune che inserisce la persona costitutivamente in un contesto sociale di riflessione.
3. Dignità Umana in contrapposizione al bene
comune?
Con Hobbes il pensiero politico moderno afferma un cambiamento paradigmatico nella determinazione del rapporto tra
dignità umana e bene comune, in quanto il Leviatano può assicurare la dignità (la vita) degli individui soltanto attraverso il
bene comune dell’ordinamento statale. La dignità umana continua così a dipendere dalla determinazione del bene comune
che ora però risulta – insieme alla trascendenza divina – radicalmente immanentizzato: come il Leviatano rappresenta il
“Dio mortale” in politicis, così la vita umana risulta completamente reintegrato nel contesto politico: infatti al di fuori del
Leviatano per l’uomo non c’è prospettiva di sopravvivenza: un
uomo diventa il lupo dell’altro e qualsiasi esistenza umana diventa impossibile nella guerra di tutti contro tutti (12). Ora, la
politicizzazione dell’individuo attraverso il bene comune identificato con lo Stato e con la sua volontà realizza una situazione di rischio per l’individuo ancora più radicale rispetto al contesto antico, perché ora, nella modernità, non è più una moralità razionale ad esigere l’ossequio individuale, ma la pura ragione di Stato. Tale dimensione si radicalizza poi soprattutto
in Rousseau. In altre parole, non è il contesto sociale della polis, ma lo Stato moderno che si identifica con il “bene comu-
ne”. Questa radicale politicizzazione del bene comune ora provoca l’astrazione degli elementi individuali della dignità umana dal loro contesto stoico e tommasiano, per farli diventare
l’affermazione della libertà ed individualità della persona radicalmente antecedente a qualsiasi inserimento sociale o politico. Già con John Locke infatti si compie il passo di assegnare
la dignità umana alla situazione giuridica e prestatale dell’individuo, mentre il bene comune rimane collegato al contesto
politico e quindi appare solo come un risultato del contratto
sociale (13). Con questo ribaltamento della determinazione di
rapporto tra diritto individuale prepolitico e bene comune statalizzato rispetto ad Hobbes, Locke diventa il padre del liberalismo moderno. Infatti, in questo modo è data per la prima volta la possibilità che il bene comune non è più la condizione di
possibilità per la realizzazione della dignità umana, ma può
entrare in conflitto con essa e metterla a rischio.
È uno dei caratteri contraddistintivi del pensiero politico di
Kant ad aver riconosciuto in Rousseau l’apporto decisivo per il
pensiero politico moderno ossia la congiunzione di tutte le volontà di una comunità politica in una sola, e quindi lo Stato come possibilità della libertà e dignità della persona. Ma a differenza dal pensatore francese, egli riuscì a pensare tale realtà
radicalmente a partire dalla dignità dell’individuo: da ciò risulta una forte e inscindibile connessione dell’individuo al contesto politico, in quanto soltanto all’interno di questo esso acquisisce la dimensione della dignità umana come soggettività del
diritto: «L’idea di una costituzione politica in generale, che è
nel contempo per ogni popolo un imperativo assoluto della ra35
gione pratica giudicante secondo i concetti del diritto, è santa
e irresistibile; e anche se l’organizzazione dello Stato fosse in
se stessa difettosa, nessun potere subalterno in questi Stati potrebbe opporre una resistenza attiva al sovrano legislatore»
(14). In questo modo avviene all’interno della sfera politica un
capovolgimento della concezione rousseauiana e il bene comune diventa un risultato della dignità umana nella cui definizione esso si trova ormai incluso. Solo con Kant abbiamo quindi,
in fin dei conti, il ribaltamento dalla concezione morale eteronoma di Aristotele ad una concezione definibile come autonoma, e la dimensione del bene comune come elemento esplicativo di ciò che è la dignità umana come principio di ordinamento politico. Il concetto di bene comune, infatti, non è per niente superato nell’accezione della dignità umana in Kant, in
quanto la persona può affermare e trovare riconosciuta la sua
dignità soltanto all’interno del contesto politico. E soltanto
con Kant, la dimensione politica è veramente pensata a partire dalla dignità della persona e si porta a compimento la novità di Tommaso d’Aquino rispetto ad Aristotele. In questo
modo, abbiamo a che fare per la prima volta con la formulazione radicale della “dignità umana” come unico principio originario della legittimazione dell’etica politica e giuridica. Infatti
la dignità dell’uomo sta nell’autodeterminazione della ragion
pratica, che in questa maniera diventa radicalmente “inizio” e
“principio” del concetto di “bene”: «E’ impossibile pensare nel
mondo, e, in genere, anche fuori di esso, una cosa che possa
considerarsi come buona senza limitazioni, salvo, unicamente,
la volontà buona» (15). Qualsiasi dimensione di bene comune
dipende quindi dalla volontà individuale che è l’autodetermi-
nazione della ragione pratica in libertà: questa esclude la teleologia alla base del bene comune come valore finale della felicità. Anzi, per Kant la dignità della ragione sta proprio nel fatto
di non avere un fine al di fuori di sé e di determinarlo in libera
autodeterminazione morale (autonomia), ma di diventare, attraverso l’autodeterminazione secondo l’imperativo categorico, degna di essere felice. Mentre questo concetto rimanda però alla trascendenza che non può essere oggetto della filosofia
trascendentale, Kant trae per il contesto morale e politico la
conseguenza della dignità assoluta della persona, ontologicamente radicata nella sua libertà: «Nel regno dei fini, tutto ha
un prezzo o una dignità. Ha un prezzo ciò, al cui posto può esser messo anche qualcos’altro, di equivalente; per contro, ciò
che si innalza al di sopra di ogni prezzo, e perciò non comporta equivalenti, ha una dignità».
Il “bene comune”, come conseguenza da questa definizione della “dignità umana”, è l’esistenza dell’uomo nello Stato, perché
solo all’interno dello Stato, quindi in uno “stato” di costituzione giuridica, può vivere la sua dignità, contrariamente allo
“stato di natura”, dal quale quindi è obbligato ad uscire. Per
questo, qualsiasi possibilità di insurrezione contro il sovrano o
di rivoluzione viene radicalmente negata da Kant. Non esiste
un appello ad un bene comune sostanziale superiore allo Stato
per legittimare una resistenza contro la sovranità. Il bene comune risulta quindi desostanzializzato e meramente formale:
si identifica con le condizioni di possibilità politico-giuridiche
sancite dallo Stato e che sono dovute alla dignità degli individui perché la felicità è interpretata come telos della vita indivi36
duale: «la salute pubblica, che deve per prima essere presa in
considerazione, è proprio quella costituzione legale che assicura ad ognuno la sua libertà per mezzo di leggi; dove rimane impregiudicato per ciascuno cercare la felicità per la via che gli
sembra migliore» (16). Il bene comune quindi non ha perso
soltanto la sua origine politica, ma anche la sua dimensione
metafisico-sostanziale: siccome il bene comune classico è stato definito in riferimento al conseguimento del perfezionamento virtuosa di essa, la definizione kantiana della dignità umana conosce come punto di partenza soltanto la ragion pratica
(la «volontà buona») ed ha reso irrilevante, di conseguenza, la
concretezza della natura umana come condizione per questo
compito. E siccome questa dignità della persona non viene né
riconosciuta né garantita nello “stato di natura” ma attraverso
l’ordinamento formale costituzionale dello Stato liberale, il bene comune si identifica – come dimensione di realizzazione
della dignità della persona – con quest’ultimo, e l’imperativo
morale nell’ambito politico diventa quello di lasciare lo stato
di natura, intesa come affermazione che la persona come essere morale non può vivere al di fuori di un contesto politico-giuridico di diritto. Lo “stato” della persona che è la stessa dignità si identifica perciò con lo “Stato” nel suo ordinamento costituzionale e quindi con il bene comune. Questo è solo possibile,
però, se l’idea del bene comune è pensata in maniera formale,
ossia come ordinamento e garanzia dei diritti fondamentali.
In ogni caso, Kant esclude una determinazione metafisico-sostanziale del bene comune, perché non corrisponderebbe alla
dignità umana. Il bene comune trova quindi il suo criterio necessario nella dignità umana. Per la stessa ragione, Kant rifiu-
ta completamente il compito educativo dello Stato, tipico di
una concezione sostanziale o etica del bene comune, che può
risultare soltanto «il dispotismo più grande immaginabile».
Kant ha determinato, quindi, per la prima volta, il bene comune radicalmente come espressione della dignità umana.
Sarà Georg Wilhelm Friedrich Hegel a criticare questa concezione kantiana per il suo formalismo astratto: senz’altro anche
per lui, nei Lineamenti di filosofia del diritto, la dignità umana, con il corrispondente imperativo etico-giuridico, funge come “principio” dell’ordinamento moderno – confermando
quindi il superamento kantiano dell’aristotelismo – ma che
non potrebbe essere allo stesso modo anche il suo “fine” perché è privo di qualsiasi contenuto etico materiale. Solo identificandosi con il bene comune – che per Hegel è l’eticità della famiglia, della società civile e dello Stato – la dignità umana potrebbe acquisire la sua dignità etica. La libertà dell’individuo,
per Hegel, si compie eticamente quindi soltanto in strutture di
bene comune: famiglia, società civile e Stato. In questo modo,
Hegel reintegra la dignità umana nella dimensione finalistica
del bene comune, e dimostra questa integrazione come antropologicamente necessaria in quanto la libertà soggettiva costituirebbe sempre e solo un principio insufficiente per poter assicurare quel “bene” all’uomo di cui avrebbe maggiormente bisogno. Perciò, Hegel sviluppa un’idea di ordinamento come
espressione dello Spirito oggettivo, e quindi come concezione
sostanzialistica – recuperando in questa maniera, appunto, la
classica dimensione metafisica del bene comune, ma all’interno dell’ordinamento costituzionale dello Stato moderno, intro37
ducendo le forme dell’eticità e definendo lo Stato come massima istituzione e vero telos dello sviluppo della libertà (dignità). Hegel afferma in questo modo che l’uomo non si realizza
in senso vero e proprio attraverso una dignità astratta e nei
rapporti formal-apriori di libertà con gli altri, ma in fin dei
contri soltanto in relazioni sostanziali, nelle quali la libertà individuale si concretizza, mentre altrimenti rimarrebbe formale ed astratta e in questa negatività non si affermerebbe quale
libertà umana ed espressione della dignità della persona (17).
L’ordinamento istituzionale nella sua realizzazione nell’eticità,
e quindi in quanto bene comune, completa e realizza la dignità umana la quale, al di fuori di esso, rimarrebbe sempre priva di eticità e in quanto tale si annullerebbe difatti nella propria “non verità”. Significativamente, per Hegel è, in fin dei
conti, nella famiglia, nelle corporazioni e nello Stato che l’uomo trova la sua realizzazione: «Il diritto degli individui alla
loro destinazione soggettiva alla Libertà, ha il suo compimento nel fatto che gli individui appartengono alla realtà etica. Infatti, la certezza della loro Libertà ha la propria verità in tale
oggettività, e, nell’Etico, gli individui possiedono realmente la
loro propria Essenza, la loro universalità interna» (18). In
questo senso, l’eticità è «l’Idea della Libertà nel senso del Bene vivente» (19), riassumendo in sé le due dimensioni del diritto e del dovere, dell’individualità e della collettività. Si tratta,
in altre parole, di condizioni sociali che consentono all’uomo
di “diventare uomo”, di “realizzare” quella dignità che altrimenti non c’è – una dimensione tipica della concezione classica del bene comune. Questo passaggio avviene come un sottomettersi coscientemente e volontariamente alla vita universa-
le che si realizza concretamente nelle tre forme dell’eticità, e
in maniera massima nello Stato di diritto: «Lo stato inteso come la realtà della volontà sostanziale, realtà ch’esso ha nell’autocoscienza particolare innalzata alla sua universalità, è il razionale in sé e per sé. Questa unità sostanziale è assoluto immobile fine in se stesso, nel quale la libertà perviene al suo supremo diritto, così come questo scopo finale ha il supremo diritto di fronte agli individui, il cui supremo dovere è d’esser
membri dello stato» (20).
Come si evince, Hegel in questa maniera raddoppia il concetto
di “dignità umana”, concependola sia come “principio” che come “fine”, intendendone però due realtà morali molto diverse:
infatti, solo nell’ultima accezione, essa è identificata con il “bene comune” che entra in conflitto con la definizione della “dignità umana” come principio dell’autodeterminazione morale
del soggetto: ciò che “comincia” come principio individuale finisce “deindividualizzato” (in realtà: «aufgehoben») nello Stato (21). Per questo, come il dovere fondamentale era quello di
«esser membri dello stato», tutti i doveri che per Hegel sono
sempre doveri all’interno dello Stato che così avanza come il
luogo etico del bene comune: «Una dottrina immanente e coerente dei doveri, invece, non può essere altro che lo sviluppo
dei rapporti che nello Stato sono necessari per via dell’Idea della Libertà, e che, pertanto, sono reali nella loro intera estensione» (22). L’uomo nella sua dignità personale, così, non è più
fine dell’eticità; trasferendo la teleologia dell’eticità nello Stato
di diritto, essa si avvera soltanto nella persona come cittadino
dello Stato. In questo modo, Hegel risolve il conflitto tra “di38
gnità umana” e “bene comune” nella Aufhebung della prima
nel secondo. Mentre in Aristotele la dimensione individuale
era determinata a partire da quella comune, in Hegel il bene
comune (l’eticità) è determinata a partire dalla Aufhebung della dignità umana, che quindi a sua volta si comprende solo
nel suo fine che è lo stesso bene comune. In questo consiste la
differenza del bene comune come polis in Aristotele e come
Stato di diritto in Hegel.
4. Ritrovare la sintesi
Dall’insoddisfazione con il riferimento del bene comune allo
Stato moderno – in maniera negativa (Kant) o positiva (Hegel) – nasce la proposta di Antonio Rosmini, che si contraddistingue per una reinterpretazione originale di San Tommaso
nella modernità e per averlo collocato all’interno della sfida
kantiana ed hegeliana. Mettendosi sul terreno del pensiero moderno Rosmini considera la “persona” come radicalmente
una, e soprattutto per le sue dimensioni di bene e di libertà
non può essere separata in aspetti diversi. Egli distingue all’interno della persona il supremo principio personale – la volontà libera – che è espressione pratica di quel “principio divino”
nell’uomo che è l’intuizione dell’idea dell’essere e quindi la costituzione dell’intelletto. Sta in questo principio la dignità dell’uomo, perché questa partecipazione all’essere la rende fine e
grazie alla sua libera volontà l’uomo può indirizzare tutti gli
altri principi concreti della natura umana a secondo questo supremo principio. Così «si può dir fine la persona umana, come
quella che partecipa dell’infinita dignità dell’ente, a cui trovasi
essenzialmente congiunta […] Sotto questo punto di vista si
può dire fine la stessa persona umana, cioè può dirsi fine il bene infinito, di cui è essenzialmente partecipe questa persona
ordinata a parteciparne vie più» (23). La libertà è quindi originalmente “libertà concreta”, per la stessa costituzione ontologica della persona: e in quanto pone in sintesi “idea” (legge morale) e “realtà” dell’uomo (la sua tendenza al bene eudaimonologico) costituisce la moralità della stessa. Abbiamo in questa
sistematica la esatta ripresa della sistematica del bene comune
in San Tommaso, ma ora incentrata sulla dinamica conoscitiva e morale del soggetto che in questo modo diventa, come Rosmini afferma, il «soggetto de’ diritti» il quale è costituito in
una triplice «cagione della dignità»: percezione all’essere nell’intuizione intellettiva dell’essere, ordinamento dell’essere
umano al bene assoluto e il godimento e la beatitudine che da
questa congiunzione risultano. È questa per Rosmini la costituzione della dignità umana nel triplice radicamento nell’essere.
La realizzazione di questa libertà morale che è la realtà concreta di questa costituzione della dignità, si ha nella relazione ad
altre libertà che essa necessariamente incontra realizzando la
propria dinamica che è quella del “perfezionamento”: essendo
la libertà morale, tende incessantemente verso il suo perfezionamento. Proprio questa struttura di perfezionamento, però,
non è completamente sottoposta alla “scelta” liberale – mero
arbitrio – ma ha delle dimensioni “non negoziabili”, o meglio:
“naturali”. Rosmini individua ora una duplice dimensione di
39
perfezionamento: nel rapporto all’assoluto aperto dalla stessa
costituzione della dignità umana, e nella famiglia – “società
domestica”. Il “bene” della persona appare quindi come il “perfezionamento” della libertà del soggetto, che si realizza in relazione ad altri. Rosmini recupera in questa maniera non solo il
senso religioso-etico del bene comune in San Tommaso, ma lo
declina anche in maniera personalistica e quindi lo rende fruibile anche dal pensiero moderno. Il bene comune è la realtà
personale vissuta in compartecipazione relazionale: relazione
all’altro con cui è naturalmente connessa in relazioni familiare, e al totalmente altro della trascendenza divina. In altre parole: la “dignità umana” si realizza sempre in strutture di “bene comune” che però non sono strutture predeterminate o da
un realismo metafisico aristotelico, o dallo Stato moderno (Hegel) – entrambi concetti politici del bene comune –, ma sono
le stesse strutture metafisiche della libertà morale in quanto
relazione, e quindi sono dimensioni del perfezionamento della
natura umana. E solo dopo aver declinato il bene comune come dimensione religiosa e familiare della persona, se ne aggiunge ancora una terza dimensione ossia quella della società
civile che si rapporta alle prime due in maniera completamente sussidiaria. Ciononostante realizza anch’essa una dimensione di bene comune – questo sarebbe il bene comune politico
che significativamente, per il suo rapporto sussidiario alle altre due società, risulta il più debole nella gerarchia del bene comune.
Questa gerarchia sussidiaria del bene comune riconosce quindi come primo e più importante livello la dimensione religiosa
della persona che può viverla soltanto insieme ad altri, come
ad esempio nella Chiesa (24). Il secondo livello è costituito dal
bene della famiglia, che di nuovo esprime una dimensione della libertà umana che deve essere condivisa con altri (25). Solo
al terzo e ultimo posto segue anche la necessità della comunità
politica la quale significa che anche nel contesto politico esiste
un bene condiviso della natura umana. Rosmini formula questa struttura sussidiarietà all’interno del bene comune nella
modernità per parare la sua identificazione con la volontà o la
ragion di Stato, e sottolinea che quindi soltanto nella e attraverso la definizione della dignità della persona e dei suoi diritti individuali si può anche affermare un bene comune politico
(26).
In questa fondazione antropologica e nella triplice articolazione del bene comune Rosmini recepisce quindi la vera originalità di San Tommaso. A questo punto diventa chiaro, come Rosmini è riuscito a conciliare bene comune e dignità umana
che tra Kant ed Hegel si accordavano soltanto in maniera problematica e riduttiva, in quanto Kant riportava il primo al secondo, e Hegel interpretava la dignità umana in maniera compiuta solo all’interno del bene comune. Rispetto a San Tommaso, Rosmini rovescia la determinazione di rapporto integrando le strutture del bene comune come dimensioni relazionali-istituzionali nella libertà (dignità) stessa (27).
Innanzitutto, in riferimento alla prima e più importante dimensione di bene comune, ossia la società teocratica (la Chiesa) oppure «famiglia soprannaturale» come la chiama anche,
è interessante che lo stesso Rosmini ne propone anche una let40
tura “laica” come «società del genere umano» (28). Tale dimensione universale non nasce soltanto dall’universalismo cristiano che si esprime anche nella Chiesa mandata a tutti gli uomini, ma soprattutto dalla considerazione che la dimensione
di compimento soprannaturale della natura umana per la quale essa è sacramento, indica questa dinamica di perfezionamento soprannaturale della natura umana. Per questo, in Rosmini la Chiesa è anche segno visibile di un bene comune che
remotamente è il bene comune di tutta la umanità, come esso
viene espresso soprattutto attraverso l’etica dei diritti umani.
La dimensione del bene comune nel suo perfezionamento soprannaturale non fonda quindi un esclusivismo cristiano, ma
crea bene comune dell’umanità che vede tutti gli uomini non
in quanto individui singolari ed astratti, ma attraverso un legame che significa non soltanto libertà individuale ma anche rapporti di responsabilità reciproca e di doveri umani specifici
(29). Sono quindi questi legami antropologici di libertà che
creano solidarietà e responsabilità e che si articolano nel linguaggio della tradizione tomistica come strutture “familiari”:
la famiglia naturale che instaura i legami e i doveri tra i coniugi e tra loro ed i figli, la famiglia soprannaturale che unisce le
persone nella loro tendenza al perfezionamento ma che forgia
anche lo sguardo per il fatto che tutti gli uomini sono già uniti
in una famiglia umana e che devono vivere rapporti di fraternità attraverso l’etica dei diritti e doveri umani (30). Non è quindi il contesto della nazione o dello Stato che potesse determinare ciò che deve essere il bene comune per tutti: la persona
sta in un contesto di diritti e di doveri con gli altri già per la
struttura antropologica del suo essere, e quindi in maniera
molto più originale del contesto politico-statale (31).
Il bene comune designa innanzitutto il contesto prestatale e in
questa maniera, come si può evincere dalla riflessione rosminiana, costituisce il vero e proprio fondamento etico dei diritti
umani. Contrariamente, i diritti umani indicano a loro volta il
limite necessario per non identificare il bene comune con lo
Stato e la sfera politica, in quanto definiscono l’ambito dell’umano escludendo la competenza e la prerogativa dello Stato
in questo compito. Bene Comune e diritti umani sono quindi
correlati come principi che si reggono, delimitano e giustificano a vicenda. Sarebbe una riduzione unilaterale cercare di voler ridurre l’uno all’altro o definire l’uno semplicemente come
“sostituzione” o “articolazione moderna” dell’altro. Conviene,
nella riflessione etica e politica, soprattutto nell’ambito internazionale, riscoprire questo nesso reciproco.
Possiamo desumere quindi dalle pagine analizzate della Filosofia del diritto di Rosmini tali conclusioni: bene comune significa che non c’è diritto senza realizzazione di libertà morale in
contesti relazionali concreti, e quindi senza relazione e società. La dimensione etica del bene comune sta nel fatto che esso
è universale e si estende all’uomo in quanto tale nella sua dignità. Il “perfezionamento” della persona avviene in queste
strutture della libertà morale, non in società politiche: per il
Roveretano, infatti, il bene comune non può essere in nessun
modo politicizzato (e quindi assolutizzato), ma costituisce il
contesto etico della dignità umana e quindi del fondamento
dei diritti umani.
41
Note
1. Evidentemente il concetto di dignità umana risale fino al pensiero romano e alla
distinzione importante di Cicerone tra una dimensione che la riflette a partire dall’ordine naturale e che perciò assegna all’uomo una posizione di spicco nel contesto
ontologico in quanto partecipa alla razionalità della natura, e una dimensione che
considera la persona nel contesto sociale-politico per cui essa assume una dimensione “relativa” alla posizione e al riconoscimento di cui gode pubblicamente.
2. Cfr. A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, tr. it. P. Caprioli, Milano 1998, 302-303.
3. E. Berti, Nuovi studi aristotelici, vol. 3. Filosofia pratica, Brescia 2008.
4. Aristotele, Politica, I, 1252b 28-31.
5. Aristotele, Etica Nicomachea, I, 2 (1094b 7-11).
6. Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I 60, 5 ad 3, ad 5; I/II 109, 3; II/II
25, 1 ad 2; I/II 26, 2-4.
7. Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I/II 21, 4 ad 3; cfr. anche
J. Maritain, La persona e il bene comune, Brescia 2009.
8. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I/II 21, 4 ad 3. In questo senso, il bene
comune politico diventa il criterio etico per le leggi positive; cfr. ibid. I/II 90, 4. Per
questo motivo, la giustizia del singolo nei confronti del contesto politico, che si realizza nell’adempimento delle leggi (giuste) (iustitia legalis), è il contesto in cui si
collocano le due modalità specifiche di giustizia, ossia del rapporto del “tutto” alla
“parte” (iustitia distributiva) e tra i cittadini (iustitia commutativa).
9. Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II/II 68, 3; I/II 21, 4 ad 3; I/II 113,
9 2 ad 2.
12. Cfr. T. Hobbes, De cive, VI, 1-15; cfr. inoltre E.-W. Böckenförde, Gemeinwohlvorstellungen bei Klassikern der Rechts- und Staatsphilosophie, in: H. Münkler /
K. Fischer (edd.), Gemeinwohl und Gemeinsinn im Recht. Konkretisierung und
Realisierung öffentlicher Interessen, Berlin 2012, 43-65, qui 56-60. Böckenförde
sottolinea che la concezione hobbesiana non significa in nessun modo uno sganciamento del sovrano dai presupposti morali vincolanti della retta ragione e soprattutto della sua responsabilità dinanzi a Dio. Ma si tratta di vincoli morali che giuridicamente non sono rivendicabili in quanto ciò metterebbe a repentaglio la sovranità
assoluta. Ciò che avviene quindi innanzitutto è la dissoluzione della legge positiva
dalla legge naturale e il confinamento di quest’ultima alla mera dimensione morale. Ciò significa che la realizzazione politica del bene comune consiste nella creazione di condizioni di pace e tranquillità per la vita civile in cui i cittadini sono messi
in grado di godere dei beni nel migliore modo. Il bene comune, quindi, risulta separato da una concezione morale di “vita buona”. In Locke, questo concetto viene giuridicamente portato, in maniera critica rispetto ad Hobbes, ad un concetto di garanzia di libertà e proprietà degli individui.
13. Cfr. J. Locke, Two Treatises of Government, § 4-6, 123, 135.
14. I. Kant, La metafisica dei costumi.
15. I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi.
16. I. Kant, Sul detto comune: «questo può essere giusto in teoria, ma non vale per
la pratica».
17. Cfr. L. Siep, Was heißt: “Aufhebung der Moralität in Sittlichkeit” in Hegels Rechtsphilosophie?, in: Hegel-Studien 17 (1982) 75-96.
18. G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del Diritto, § 153.
19. G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del Diritto, § 142.
20. G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del Diritto, § 258.
10. A. Rosmini, Filosofia del diritto, 6 voll., a c. di P. Orecchia (Ediz. naz., 35-40),
Padova 1967-1969, II, n. 496 (IV, p. 854). Cfr. la vicinanza di questa posizione con
il giudizio analogo di Hegel, in: Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a c. di C. Cesa, Roma-Bari 2009, § 482 aggiunta.
21 G. Luf, Menschenwürde in der Philosophie des Deutschen Idealismus, in:
K. Seelmann (ed.), Menschenwürde als Rechtsbegriff (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 101), Wiesbaden 2004, 82-92.
11. Tommaso d’Aquino, De regimine principum, 14s.
22. G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del Diritto, § 148.
42
23. Rosmini, Filosofia del diritto, I, n. 52, nota 2 (I, p. 192, nota 2).
24. Rosmini, Filosofia del diritto, II, nn. 632-735 (IV, pp. 888-917).
25. Rosmini, Filosofia del diritto, II, nn. 969-1039 (IV, pp. 989-1011)
26. Cfr. Rosmini, Filosofia del diritto, II, nn. 1644-1645, 1660 (V, pp. 1223, 1227);
C. Liermann, Rosminis politische Philosophie der zivilen Gesellschaft, Paderborn
et al. 2004.
27. Cfr. M. Krienke, What is the connection between common good and human dignity? The contribution of the Thomistic tradition to a reflection on common good,
in: Philosophical News, n. 6, Milano 2013, 54-60.
28. Cfr. Rosmini, Filosofia del diritto, II, nn. 635-670 (IV, pp. 888-898).
29. Cfr. M. Krienke, Menschenwürde als notwendig anerkannte Freiheit in Hegel
und Rosmini. Wie kann „intersubjektive Allgemeinheit“ gedacht werden?, di prossima pubblicazione.
30. Cfr. Rosmini, Filosofia del diritto, II, nn. 966-968 (IV, pp. 985-987).
31. Cfr. Rosmini, Filosofia del diritto, I, p. 164; II, n. 987 (IV, p. 993).
43
M ARIA Z ANICHELLI U NIVERSITÀ DEGLI S TUDI DI P ARMA
Dignità umana
e disabilità
I NDICE
1. La tutela delle persone disabili nelle società
attuali
2.
La dignità umana dall’autodeterminazione
alla vulnerabilità
3. Integrare la vulnerabilità umana nel discorso
morale
4. Disabilità e dignità umana
a. Dignità del disabile in quanto individuo: oltre la categoria
b. Dignità del disabile in quanto persona: oltre
le capacità
c. Dignità del disabile in quanto essere
umano: oltre l’indipendenza
Bibliografia citata
Una riflessione sulla condizione disabile richiede cautela e
umiltà: nascere con un handicap o diventare disabile nel corso
della vita è un’esperienza esistenziale irriproducibile, la cui
portata eccede ogni tentativo di studio e discorso critico; è
dunque anzitutto l’esperienza diretta, ben più di qualunque
istanza teorica esterna, che può legittimare a parlarne. Un
aspetto che tuttavia merita di essere approfondito, anche sul
piano teorico, è la possibilità di scorgere nel disagio e nella sofferenza legati alla disabilità luoghi di manifestazione della dignità umana: situazioni in cui l’umanità, pure provata dal limite, non cessa per questo di essere riconoscibile nei suoi tratti distintivi inalienabili, ed è anzi tanto più meritevole di rispetto e tutela.
Se è innegabile che le persone disabili siano partecipi a pieno
titolo di quella dotazione universale che da secoli definiamo
“dignità umana”, ciò significa che il nucleo di tale dotazione
non va ricercato in quelle abilità e competenze che normalmente fioriscono in alcune stagioni o circostanze della vita
umana, ma va identificato altrove: in ciò che caratterizza più
essenzialmente ogni persona in quanto tale, in ciò che ne costituisce il valore permanente, e la rende degna di cura e protezione, anche e soprattutto quando è colpita da una disabilità
congenita, o quando la sua autosufficienza viene meno per infortuni o malattie o per l’avanzare dell’età.
A fronte di modelli culturali, giuridici, etici oggi sempre più incentrati sull’individuo quale artefice autonomo e vincente della propria vita, appagato dall’esercizio della sua autodeterminazione e dalla fruizione dei suoi diritti, uno sguardo consape44
vole sulla disabilità come concreta modalità del vivere umano,
esito sempre possibile della nostra condizione di esseri fragili
e imperfetti, può contribuire a una ridefinizione della dignità
umana, capace di ricomprendere anche quelle situazioni in
cui la persona appare più bisognosa di sostegno, impossibilitata a scegliere, dipendente dagli altri.
1. La tutela delle persone disabili nelle società attuali
Un importante fattore di promozione della dignità umana nelle sue espressioni più fragili e vulnerabili è oggi il diritto, anche attraverso le varie forme di tutela che assicura alle persone disabili. Non a caso ad esse è dedicata la prima carta dei diritti del terzo millennio: approvata dalle Nazioni Unite nel
2006 ed entrata in vigore nel 2008, la Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità insiste ripetutamente sul concetto
di dignità (artt. 1, 3, 16, 25). Tra i suoi fini principali vi è promuovere il rispetto per la “inerente dignità” delle persone disabili (art. 1). E il “rispetto per la dignità intrinseca” è il primo
dei principi generali ricordati all’art.3.
I disabili sono intesi dalla Convenzione come coloro che “hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su
una base di eguaglianza con gli altri” (art. 1.2). Questa definizione reca traccia di un’evoluzione semantica: se tradizionalmente la disabilità era conseguenza diretta di un deficit individuale, oggi è intesa invece come risultato dell’interazione tra
soggetto e ambiente, in senso fisico, istituzionale e culturale.
La stessa evoluzione è ravvisabile nell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, 2001), adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che non identifica più la disabilità con le disfunzioni psico-fisiche (come avveniva nell’Internationl Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, ICIDH, 1980), ma valuta in ogni essere
umano diversi livelli di “funzionamento” e di “disabilità”, anche alla luce di fattori contestuali.
Lo spostamento di attenzione dalla menomazione come dato
ineliminabile alle varie possibilità di intervento nel rapporto
soggetto-ambiente è alla base dell’ampia normativa giuridica
che si è sviluppata in favore delle persone disabili. Si possono
ricordare negli Stati Uniti il Rehabilitation Act (1973) e l’Americans with Disabilities Act (1990); in Gran Bretagna il Disability Discrimination Act (1995); in Francia la Loi pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées (2005); in Italia la legge 104/1992
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, la legge 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili, la legge 67/2006 per la tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazioni. Anche l’Unione europea è impegnata nella lotta contro le discriminazioni derivanti
dalla disabilità (direttiva 2000/78; Carta dei diritti fondamentali, artt. 21, 26; TFUE Parte I, art 10 del Titolo II e Parte II,
art. 19).
La tutela giuridica riservata ai disabili rappresenta un indubbio progresso istituzionale, ed è il segno di una speciale sensi45
bilità del diritto odierno nei confronti dei soggetti svantaggiati. Ma non basta di per sé ad assicurare l’attuazione della loro
dignità nel senso più ampio, né impedisce che permangano varie criticità in alcuni atteggiamenti culturali oggi dominanti.
Se è vero, infatti, che risultano ormai acquisite importanti garanzie in termini di diritti, pari opportunità e strumenti di inclusione, non possono invece dirsi altrettanto consolidate nel
sentire comune la consapevolezza della dignità intrinseca che
accomuna i disabili a tutte le altre persone, e la disponibilità
ad accettare il decadimento psico-fisico e la mancanza di autosufficienza come dimensioni ineludibili dell’esistenza umana,
degne di cura e attenzione.
Assistiamo, cioè, a uno squilibrio tra il livello spesso molto
avanzato delle soluzioni giuridiche e dell’integrazione sociale
in favore dei soggetti più vulnerabili e una mentalità diffusa
che tende invece a coltivare ideali utopici di efficienza, produttività, autonomia, rimuovendo di fatto la disabilità dal proprio
orizzonte consueto, quasi fosse un’eventualità eccezionale in
cui incorrono pochi sfortunati.
Si tratta di una difficoltà più generale a riconoscere la debolezza, la dipendenza dall’aiuto altrui, in definitiva l’imperfezione,
quali requisiti “normali” dell’umanità, e a integrarli effettivamente nella dignità propria dell’essere umano. Un pregiudizio
culturale che si traduce a sua volta in una visione antropologica limitata e fuorviante: l’illusione che la condizione umana
sia connotata essenzialmente da forza, libertà, autonomia, capacità di scelta è un ostacolo all’accettazione di quelle situazio-
ni in cui tali requisiti risultano attenuati o assenti: la disabilità
è un caso paradigmatico.
Se tendiamo a rimuovere l’handicap è perché esso ci parla della nostra vulnerabilità: in esso ci si svela con particolare intensità quella fragilità che non vorremmo vedere e che pure in
una certa misura ci riguarda tutti, almeno potenzialmente o in
certe fasi della vita, oppure indirettamente, per il fatto che
l’esistenza di persone disabili interpella la responsabilità di
ognuno. Cogliere anche in tale vulnerabilità i connotati incancellabili della dignità umana può apparire quasi una sfida rispetto ai modi di pensare più diffusi cui si accennava; eppure
è il presupposto indispensabile per accostarsi all’handicap senza pregiudizi e anche, più in generale, per mantenere uno
sguardo realistico e non riduzionistico sulla condizione umana.
2. La dignità umana dall’autodeterminazione alla
vulnerabilità
Dal punto di vista teorico, al fine di ricostruire il nesso tra dignità umana e condizione disabile, occorre ripensare in primo luogo il concetto stesso di dignità. Nozione in origine religiosa e metafisica, essa ha poi acquisito un proprio statuto anche nel linguaggio morale e giuridico. È con l’umanesimo moderno che si afferma una visione antropocentrica e razionalistica della dignità: grazie al dono della ragione l’uomo è libero,
capace di autodeterminarsi, e dunque superiore alle altre crea46
ture, prigioniere di meccanismi di comportamento prefissati.
Emblematica l’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola, in cui Dio dice all’uomo: “La natura determinata per
gli altri è chiusa entro leggi da me prescritte. Tu, invece, te la
fisserai senza essere impedito da nessun limite, secondo il tuo
arbitrio al quale ti ho consegnato” [Pico della Mirandola
1486].
Ma la teorizzazione più compiuta di un legame necessario tra
la dignità dell’uomo e la sua autonomia razionale si deve a
Kant. Nella Fondazione della metafisica dei costumi egli ha
tematizzato la dignità quale prerogativa tipica ed esclusiva dell’uomo in quanto essere ragionevole capace di darsi una legge
morale. Proprio in forza di tale prerogativa, affrancato dalle
leggi naturali, egli può essere “fine in sé” e “legislatore del regno dei fini”. Pertanto “soltanto la moralità, e l’umanità in
quanto capace di moralità, possono avere dignità”, e “il principio della dignità della natura umana e di ogni natura ragionevole” è l’autonomia [Kant 1785, pp. 94-5]. Kant riconduce inoltre la dignità all’idea dell’umanità come valore intrinseco non
negoziabile, superiore ad ogni prezzo. Nella Metafisica dei costumi essa è consacrata come principio deontologico universale nell’imperativo categorico:
“l’umanità è in se stessa una dignità, poiché l’uomo non può
essere trattato da nessuno (cioè né da un altro, e neppure da
lui stesso) come un semplice mezzo, ma deve sempre essere
trattato nello stesso tempo come un fine; e precisamente in
ciò consiste la sua dignità (la sua personalità), per cui egli non
solo si eleva al disopra di tutti gli altri esseri della natura che
non sono uomini, destinati appunto per questo a servirgli da
strumento, ma anche, di conseguenza, si innalza al di sopra di
tutte le cose.” [Kant 1797, p. 334].
La dignità dell’uomo, dunque, è esaltata nella modernità in
quanto connessa alla razionalità e all’autonomia che lo contraddistinguono, segno del suo primato sugli altri esseri viventi e della sua centralità nell’universo. Ma questo è un resoconto solo parziale. Individualismo e autonomia soggettiva sono
stati messi radicalmente in questione da varie filosofie novecentesche. Basti pensare ai moniti della Scuola di Francoforte
circa gli effetti distruttivi e autodistruttivi della “ragione strumentale”, e circa la condizione di schiavitù, reificazione e vulnerabilità in cui l’individuo è stato ridotto proprio dalla sua
smisurata indipendenza e dal suo potere illimitato sulle cose
[Horkheimer, Adorno 1947; Horkheimer 1947]. I rischi che la
hybris razionalistica comporta per il destino dell’umanità sono stati denunciati analogamente da Hans Jonas: “L’esclusiva
fissazione sull’uomo in quanto diverso dal resto della natura
può significare solo immiserimento, anzi disumanizzazione
dell’uomo stesso, […] il che dunque contraddice il suo fine dichiarato, sanzionato proprio dalla dignità del suo essere”. Di
qui l’invito alla responsabilità, alla cura per l’essere umano minacciato nella sua vulnerabilità [Jonas 1984, p. 175].
È evidente come queste istanze filosofiche contribuiscano a ridisegnare il paradigma della dignità dell’uomo ridimensionandone la presunta onnipotenza, e dando pienamente ragione di
quei tratti di debolezza, non autosufficienza e bisogno di protezione che fanno parte naturalmente della condizione umana, e
47
che un modello come quello kantiano invece espungeva del tutto.
Ma non è solo il pensiero filosofico a registrare questa evoluzione. Uno sguardo ad alcune fonti giuridiche conferma l’emergere nel Novecento di un nuovo tipo di attenzione al valore dell’umanità, che passa non dall’esaltazione delle sue competenze ma semmai dalla consapevolezza delle sue ferite. Il concetto di dignità umana, dal trionfalismo prometeico della sua genesi moderna, approda a uno statuto più ampio e articolato,
contrassegnato dal senso del limite e della vulnerabilità: un
bene fragile, di cui è in gioco la sopravvivenza, i cui presupposti sono messi costantemente a repentaglio da guerre, ingiustizie, discriminazioni, ma anche dal progresso tecnologico, dalla
scienza, dalle stesse conquiste dell’ingegno umano.
L’attenzione del diritto per la dignità umana, non a caso, è
una ‘novità’ del Novecento: la nozione, del tutto assente nelle
carte dei diritti di stampo illuminista, comincia a comparire
solo con le convenzioni internazionali e con le costituzioni liberal-democratiche del secondo Dopoguerra. In particolare, il
nesso normativo dignità-diritti è istituito dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948, fin dal Preambolo: “il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo”. Il documento è frutto di un percorso storico-politico
tormentato dopo i totalitarismi, l’olocausto, i genocidi: il richiamo alla dignità diviene un monito a preservare l’umanità
dalle sue stesse aggressioni. Una visione non certo legata, dun-
que, alla razionalità e all’autonomia morale dell’uomo, ma al
contrario alla consapevolezza di quanto egli possa essere di
volta in volta prevaricatore violento o vittima inerme della sopraffazione dei suoi simili. Come ha osservato Michael Ignatieff, la Dichiarazione
“è scritta nella piena consapevolezza di Auschwitz e nella consapevolezza nascente di Kolyma. La consapevolezza della barbarie europea è radicata nelle parole del preambolo […]. La Dichiarazione […] fu scritta quando la fede nell’Illuminismo stava affrontando la sua più profonda crisi. In questo senso, i diritti umani non sono tanto la dichiarazione della superiorità
della civiltà europea quanto un monito degli europei perché il
resto del mondo eviti di riprodurre i suoi stessi errori [Ignatieff 2001, p. 67]”.
Considerazioni analoghe si potrebbero fare sulla Legge fondamentale tedesca del 1949, che si apre affermando: “La dignità
della persona è intangibile. Al suo rispetto e alla sua protezione è vincolato l’esercizio di ogni potere statale. Il popolo tedesco riconosce pertanto i diritti umani inviolabili e inalienabili
come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della
giustizia nel mondo” (art. 1). Da simbolo di orgoglio e superiorità qual era stata in età moderna, la dignità umana diventa
nel Novecento un bene fragile, e proprio per questo meritevole di tutela giuridica. “Dopo Auschwitz”, si potrebbe dire, una
fondazione puramente illuministica e razionalistica della dignità è divenuta per sempre impossibile.
48
A questo proposito non si può non accennare alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000), che ha fatto
della dignità umana la propria pietra angolare. Dopo la proclamazione iniziale (“La dignità umana è inviolabile. Essa deve
essere rispettata e tutelata”, art. 1), gli articoli successivi tipizzano come oggetto di diritti alcuni beni che danno corpo alla
dignità stessa (vita, integrità fisica e psichica, consenso libero
e informato della persona interessata), e come oggetto di divieti alcuni comportamenti che la violano (pena di morte, pratiche eugenetiche, atti di disposizione del corpo a scopo di lucro, clonazione riproduttiva degli esseri umani, tortura, pene
o trattamenti inumani o degradanti, schiavitù, servitù, lavoro
forzato, tratta degli esseri umani).
Queste ultime previsioni confermano la vocazione contemporanea della dignità a operare come principio a tutela della fragilità umana e insieme come monito contro lo strapotere dell’uomo sull’uomo, anche in ambito bioetico. Un ruolo che
emerge con nettezza in un altro importante documento giuridico, la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della
biologia e della medicina, elaborata dal Consiglio d’Europa e
firmata a Oviedo nel 1997. Essa, dopo aver sottolineato nel
Preambolo che “un uso non adeguato della biologia e della medicina può condurre ad atti che minacciano la dignità umana”, afferma la volontà di tutelare “l’essere umano nella sua
dignità e nella sua identità” (art. 1), e riconosce la che “l’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sull’interesse della società o della scienza” (art. 2).
Sulla scorta di tali declinazioni giuridiche, si può dunque ricostruire una fisionomia della dignità idonea a rappresentare la
condizione umana anche nelle sue espressioni più fragili e indifese. È questa versione della dignità che può consentire, ben
più di quella kantiana, di includere anche la disabilità tra gli
aspetti dell’umanità meritevoli di riguardo e protezione. A tal
fine occorre però chiarire ulteriormente il concetto di dignità
che ci si propone qui di adottare, trattandosi di una nozione
semanticamente indeterminata, adattabile agli obiettivi delle
filosofie e ideologie più svariate. Per dignità si intende qui anzitutto ciò che connota essenzialmente l’essere umano (concetto descrittivo che designa la specie biologica) in quanto persona (concetto normativo, nomen dignitatis). Dignità, in questa
prospettiva, è una dotazione intrinseca della persona più che
un risultato da conseguire: nessuno la attribuisce o la sottrae,
a sé o ad altri; si può solo, con il proprio agire, riconoscerla o,
di fatto, violarla. Oltre che un bene in sé, la dignità è anche un
criterio normativo, che opera come limite dell’agire (per esempio, l’art. 41 della Costituzione italiana afferma che l’iniziativa
economica privata non può svolgersi in modo da recare danno
alla dignità umana) e come fine dell’agire (per esempio, l’art.
36 della stessa Costituzione prescrive che la retribuzione del
lavoratore sia tale da garantire a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa). Proprio in forza di questa attitudine
normativa la dignità umana è il fondamento dei diritti: “tutti i
diritti umani derivano dalla dignità e dal valore inerente della
persona umana” (Conferenza Mondiale di Vienna sui diritti
umani, 1993).
49
La dignità, infine, è un universale concreto: esprime il nucleo
indefettibile comune a tutta l’umanità ma si incarna nell’irriducibile singolarità delle persone. Tale dimensione individuale non comporta come esito scontato la relativizzazione soggettivistica: l’individuo portatore di dignità è una persona in relazione con altre persone, la sua identità si nutre di questa interdipendenza, e la sua dignità non è frutto di una costruzione volontaria completamente affidata al suo arbitrio, ma al contrario è una dotazione oggettiva che, sebbene si esprima e si attui
in modo personale, lo accomuna ai suoi simili e lo ricongiunge
ad essi. Come ricorda l’art. 1 della Dichiarazione universale,
“tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
3.
Integrare la vulnerabilità umana nel discorso morale
La vulnerabilità che, come si è visto, va riconosciuta come propria dell’essere umano e parte essenziale della sua dignità, da
rispettare e tutelare, ha una manifestazione paradigmatica nella disabilità. Il dato oggettivo che molte persone siano prive di
quelle prerogative di razionalità, autonomia, integrità psico-fisica che nel paradigma moderno costituivano il valore dell’essere umano, in realtà non sminuisce per nulla la loro dignità,
e rende pertanto desueto quel paradigma. Non a caso nei modelli filosofici contemporanei che hanno ripreso l’idea kantiana dell’uomo come essere razionale, libero e indipendente non
vi è spazio per i disabili (1). Si può citare, a questo riguardo, la
teoria di John Rawls, che esclude dalle questioni primarie di
giustizia lo svantaggio dovuto all’handicap: “dato che partiamo dall’idea della società come equo sistema di cooperazione,
noi assumiamo che le persone, in quanto cittadini, abbiano tutte le capacità che permettono loro di essere membri cooperativi della società stessa” [Rawls 1993]. La prospettiva razionalistica fondata sull’autonomia individuale, condotta all’estremo,
può addirittura comportare l’esclusione dei disabili dalla comunità morale: per H. Tristram Engelhardt, ad esempio, i “ritardati mentali gravi” non hanno lo status morale di persone,
riservato solo ai soggetti autocoscienti, capaci di scegliere e
stringere accordi [Engelhardt 1986].
Le omissioni del pensiero liberale riguardo all’handicap sono
state denunciate da varie filosofie che hanno riportato l’attenzione sul tema. In primo luogo i disability studies, campo di
ricerca accademica connesso ai movimenti di rivendicazione
sorti nel mondo anglosassone dagli anni ’60, hanno assunto la
disabilità come categoria critica e hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e la comunità scientifica, combinando analisi teorica e attivismo politico. Dopo una fase iniziale
di lotta per la parità, tale orientamento ha privilegiato dagli anni ‘70 un’autocomprensione comunitaria, mirante a rivendicare la differenza e a promuovere la propria identità culturale
[Davis 2006].
Al modello rawlsiano si contrappone poi esplicitamente il capability approach. Amartya Sen, in particolare, vede nella disabilità un problema primario di giustizia su scala globale, data la scarsa possibilità per le persone disabili di accedere alle
50
capacità e alle opportunità disponibili a tutti gli altri [Sen
2009]. Anche Martha Nussbaum ha ricondotto la disabilità al
modello delle capacità ma ne ha accentuato il profilo antropologico. Le ingiustizie subite dai disabili sarebbero dovute anzitutto all’incapacità di riconoscere la dipendenza e il bisogno di
cura quali caratteristiche diffuse dell’umanità [Nussbaum
2006]. Queste ultime considerazioni rinviano direttamente alla ethics of care, un paradigma teorico che ha criticato l’illusorietà dell’uguaglianza liberale, cieca rispetto alle sperequazioni che caratterizzano il dependency work, l’accudimento delle
persone non autosufficienti, gravante quasi esclusivamente
sulle donne senza alcun tipo di riconoscimento [Kittay 1999,
p. 95].
Gradualmente si va dunque affermando anche nel pensiero filosofico l’attenzione a quei tratti di dipendenza e debolezza
che segnano l’umanità, e la necessità di integrarli effettivamente nelle teorie etico-politiche accanto ai requisiti tradizionali
di forza e autonomia. Se l’autonomia è aspirazione costitutiva
di ogni persona, la vulnerabilità è caratteristica altrettanto ineliminabile. Una polarità presente in tutti gli esseri umani:
“l’autonomia è quella di un essere fragile, vulnerabile. E la fragilità sarebbe soltanto una patologia, se non fosse la fragilità
di un essere chiamato a diventare autonomo” [Ricœur 1995].
4. Disabilità e dignità umana
ovvio: esistono persone disabili, la grande maggioranza delle
altre persone è immune dalle limitazioni che le colpiscono, e
non sperimenterà mai su di sé la loro sofferenza. La specificità
di tale condizione è di per sé fin troppo scontata. E tuttavia
non è su questo che si fonda l’interrogativo morale suscitato
dalla disabilità, ma al contrario sui fattori di continuità che
sussistono tra disabili e non disabili: fattori reali, tanto più significativi e degni di attenzione quanto più la menomazione o
la patologia tenderebbe a oscurarli, a farli dimenticare.
La dignità del disabile dev’essere dunque ripensata guardando
a lui in quanto individuo, persona, essere umano, prima che
disabile. Ciò permette anche di evidenziare alcune criticità delle concezioni appena ricordate in tema di handicap: rispettivamente, (a) l’attenzione all’individuo corregge l’idea della disabilità come identità collettiva accreditata dai disability studies; (b) l’attenzione alla persona ridimensiona l’enfasi posta
dal capability approach sulle capacità e sui funzionamenti;
(c) l’attenzione all’essere umano evita gli opposti riduzionismi
del liberalismo e della ethics of care, che in modo speculare
assolutizzano, rispettivamente, l’indipendenza e la dipendenza quali cardini della condizione umana.
Spostare l’attenzione da ciò che separa disabili e non disabili
a ciò che invece li accomuna può essere un primo contributo
al fine di preservare e valorizzare la dignità di ogni essere umano.
La consapevolezza della vulnerabilità come caratteristica diffusa dell’umanità non può certo indurre a misconoscere un dato
51
a. Dignità del disabile in quanto individuo: oltre la categoria
Tutelare giuridicamente le persone con disabilità non significa
proteggere un’identità collettiva o una categoria in quanto tale; significa proteggere in primo luogo individui affetti da specifici problemi che richiedono risposte adeguate. Destinatari
della tutela restano comunque i singoli individui: i diritti “dei
disabili” sono diritti individuali, non diritti di una comunità.
Si proteggono diritti dei disabili non per promuovere gli interessi di un gruppo, bensì per permettere una vita migliore a
individui svantaggiati, secondo la stessa logica e per le stesse
ragioni che giustificano la previsione di diritti umani universali. Fondamento di tale tutela è l’esigenza di preservare non tanto un’identità nella sua specificità, bensì la dignità comune a
tutti gli esseri umani.
Promuovere l’autocomprensione comunitaria della disabilità
come minoranza oppressa, come hanno fatto i disability studies a partire dagli anni ’70, comporta il rischio di creare
un’identità collettiva separata e autoreferenziale, e ciò rischia
di tradursi in un ostacolo all’effettiva tutela dei diritti individuali dei disabili [Shakespeare 2006]. Del resto, la capacità di
guardare alla persona disabile nella sua unicità corrisponde,
ben prima che a una concezione teorica, a un’esigenza intuitiva, tanto più “vitale” quanto più stretto è il legame con la persona stessa. Dalle testimonianze di chi ha un familiare disabile emerge spesso la necessità irrinunciabile di vedere in lui un
essere assolutamente unico, un individuo a sé, e non certo
l’esemplare rappresentativo di una categoria. Eva Kittay, a proposito di sua figlia, affetta dalla nascita da una grave disabilità
psichica, ha parlato del “bisogno di considerare Sesha come
un’eccezione, non come membro di un gruppo stigmatizzato”
[Kittay 1999, p. 289]. Analogamente, Michael Bérubé scrive a
proposito di suo figlio, affetto da sindrome di Down: “Jamie è
completamente sui generis, e quando sono con lui non riesco
a pensare a lui se non come Jamie” [Bérubé 1996, p. X].
Sottolineare il primato dell’individualità della persona disabile rispetto alla sua appartenenza alla “categoria” dei disabili
significa restituire alla persona la sua dignità e unicità, che precede la sua qualificazione come disabile e la sua assimilabilità
ad altri soggetti che condividono lo stesso limite. È stato detto
giustamente che i “diritti dei disabili” non dovrebbero essere
un’aggiunta specifica alla lista dei diritti civili, bensì il loro pieno compimento [Bérubé 2009].
b. Dignità del disabile in quanto persona: oltre le capacità
Su un piano di riflessione etico-antropologica, le nozioni di capacità e funzionamento accreditate dal capability approach
presentano un limite: enfatizzano ciò che una persona può o
dev’essere in grado di essere e di fare, anziché il fatto prioritario che quella persona “semplicemente” c’è, esiste, e ha comunque per ciò stesso un valore intrinseco incommensurabile.
Una persona infatti non è la somma delle sue abilità, non è riducibile a ciò di cui è capace, né può essere definita in base ai
suoi deficit. Come ha scritto Robert Spaemann, “[v]i sono qualità che ci spingono a definire gli uomini «persone». Tuttavia,
52
ciò che chiamiamo persone non sono queste qualità, ma coloro che le portano”. Che il valore di una persona e il significato
della sua vita trascendano le sue capacità e i suoi funzionamenti vale a maggior ragione per i disabili: “il fatto che nella comunità di riconoscimento dell’umanità si tratti realmente del riconoscimento dell’essere se stessi e non, in realtà, soltanto della
valutazione di qualità utili o gradevoli, diventa completamente chiaro nella relazione con coloro che non hanno tali qualità” [Spaemann 1996].
La priorità ontologica e assiologica della persona rispetto alla
sua condizione accidentale di abile o disabile è alla base dell’approccio fenomenologico alla disabilità come esperienza
umana. Ne sono un esempio significativo gli studi della filosofa statunitense S. Kay Toombs, colpita più di trent’anni fa da
una forma di sclerosi multipla che l’ha condotta progressivamente a perdere del tutto ogni autonomia fisica:
“Per offrire rispetto alle persone con disabilità si deve guardare oltre lo stereotipo, alla persona. Le persone che vivono con
disabilità sono persone, semplicemente questo, in primo luogo e principalmente persone. Se ti concentri solo sulla mia disabilità, essenzialmente rendi me invisibile. Prestando attenzione alla persona e non alla disabilità, gli altri attestano che
la limitazione fisica o mentale non sminuisce il valore personale”. [Toombs 2009, p. 344]
La necessità di considerare i disabili come destinatari di cure
professionali e di forme specifiche di assistenza non deve oscurare il fatto che essi sono anzitutto persone. La loro esistenza
dovrebbe indurre a riflettere su ciò che vi è di comune tra loro
e tutti gli altri, su “ciò che ci definisce nella nostra essenzialità,
al di là delle nostre competenze, del nostro sapere, dei nostri
doni, delle nostre debolezze”. Come scrive Jean Vanier, fondatore dell’Arche, comunità di accoglienza per disabili mentali
con sedi in tutto il mondo,
“Un handicap è fonte di una sofferenza che rischia di mettere
in ombra tutto il resto della persona. Spesso, quando si guarda
un portatore di handicap, non si vede che questo; lo si guarda
con tristezza, a volte con pietà. Eppure i portatori di handicap
sono, prima di tutto, delle persone che vivono pienamente”.
[Vanier 1998, p. 25]
c. Dignità del disabile in quanto essere umano: oltre
l’indipendenza
È interessante notare che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità promuove l’indipendenza non come fine in
sé ma come condizione per partecipare alla vita comunitaria,
“al fine di impedire la segregazione e l’isolamento” (art. 19).
La nozione di “vita indipendente” è associata alla “inclusione
nella società”, e implica principi quali partecipazione, accesso
ai servizi e all’assistenza (art. 19); anche in tema di accessibilità l’indipendenza è connessa alla partecipazione (art. 5). Anche la legge italiana 104/1992 associa ripetutamente l’autonomia alla partecipazione, all’integrazione sociale, alla comunicazione (artt. 1 [a], [b]; 5; 13.3; 16.3).
53
L’indipendenza non dovrebbe dunque diventare un ideale assoluto. È certo auspicabile che essa sia promossa con adeguati interventi politico-legislativi; ma senza eludere un dato antropologico fondamentale: nessuno è del tutto indipendente,
nemmeno i non disabili; tutti gli esseri umani vivono di relazioni, comprese le relazioni di aiuto. Sono “animali razionali
dipendenti” [MacIntyre 1999]. La cultura oggi dominante censura invece l’idea stessa di “dipendenza”. Basti pensare all’ideale utopico di salute e benessere come assenza di limitazioni e completa integrità fisica e mentale: esso ostacola non solo
l’accettazione della malattia e dell’invecchiamento quali dimensioni naturali della vita, ma anche la possibilità di scorgere una dignità nella condizione disabile. L’illusione dell’autosufficienza porta a misconoscere la dimensione relazionale della vita umana e la dipendenza come componente costitutiva di
tale relazionalità:
“Viviamo in un mondo in cui la piena indipendenza dall’aiuto
e dalla benevolenza altrui può essere un obiettivo molto difficile da raggiungere, e a volte può non essere nemmeno l’obiettivo più importante”. [Sen 2009, p. 315]
In conclusione, ripensare l’umanità senza ridurla all’indipendenza e alle capacità, e dissipare l’ideologia di una presunta
“identità disabile” è forse il principale contributo che la teoria
può dare alla dignità dei disabili. Si tratta “semplicemente” di
riavvicinarli a tutte le altre persone, prendendo coscienza della comune umanità. In fondo, ciò che in essi interpella e provoca è proprio la consapevolezza che nella loro condizione avrebbe potuto (o potrà) trovarsi chiunque (si pensi a infortuni o
malattie che in breve tempo rendono disabili persone fino ad
allora perfettamente sane). Per tutelare pienamente la dignità
delle persone disabili occorre “una filosofia in grado di integrare la vulnerabilità endogena degli esseri viventi in generale e
dell’essere umano in particolare” [Kristeva 2011, p. 9].
Note
1. Sono qui ripresi e sviluppati alcuni temi affrontati in forma diversa in M. Zanichelli , Persone prima che disabili. Una riflessione sull’handicap tra giustizia
ed etica, Brescia, Queriniana, 2012.
Bibliografia citata
M. BÉRUBÉ, Life As We Know It. A Father, A Family and An
Exceptional Child, New York, Pantheon Books, 1996;
M. BÉRUBÉ, Citizenship and Disability, in R.M. BAIRD, S.E. ROSENBAUM, S.K. TOOMBS (eds.), Disability. The Social, Political
and Ethical Debate, Prometeus Books, Amherst, New York,
2009;
L.J. DAVIS (ed.), The Disability Studies Reader, London - New
York, Routledge, 2006, II ed..
H.T. ENGELHARDT JR., Manuale di bioetica [1986], a cura di
S. Rini, Milano, Il Saggiatore, 1999;
M. HORKHEIMER, TH.W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo
[1947], trad. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1980;
54
M. HORKHEIMER, Eclisse della ragione. Critica della ragione
strumentale [1947], trad. di E. Vaccari Spagnol, Torino, Einaudi, 1982;
M.C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità,
nazionalità, appartenenza di specie [2006], a cura di C. Faralli, Bologna, Il Mulino, 2007;
M. IGNATIEFF, Una ragionevole apologia dei diritti umani,
[2001], trad. di S. D’Alessandro, Milano, Feltrinelli, 2003
G. PICO DELLA MIRANDOLA, Oratio de hominis dignitate
[1486], trad. di E. Garin, Firenze, Vallecchi, 1942;
H. JONAS, Il principio responsabilità, [1984], Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, trad. di P.P.
Portinaro, Torino, Einaudi, 1993;
J. RAWLS, Liberalismo politico [1993], a cura di S. Veca, Torino, Edizioni di Comunità, 1999;
I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi [1785], in
Id., in Scritti morali, trad. di P. Chiodi, Torino, Utet, 1970;
I. KANT, La metafisica dei costumi [1797], trad. di G. Vidari,
Roma-Bari, Laterza, 2001;
E.F. KITTAY, La cura dell’amore. Donne, uguaglianza, dipendenza [1999], trad. di S. Belluzzi, Milano, Vita & Pensiero,
2010;
J. KRISTEVA, J. VANIER, Il loro sguardo buca le nostre ombre.
Dialogo tra una non credente e un credente sull’handicap e la
paura del diverso [2011], trad. di A. Piovanello, Roma, Donzelli, 2011
A.MACINTYRE, Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù [1999], a cura di M. D’Avenia, Milano, Vita & Pensiero, 2001;
P. RICŒUR, Autonomia e vulnerabilità [1995], in ID., Il Giusto,
vol. 2, a cura di D. Iannotta, Cantalupa, Effatà Editrice, 2007;
A.C. SEN, L’idea di giustizia [2009], trad. di L. Vanni, Milano,
Mondadori, 2010;
T. SHAKESPEARE, Disability Rights and Wrongs, London New York, Routledge, 2006;
R. SPAEMANN, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno” [1996], a cura di L. Allodi, Roma-Bari, Laterza, 2005;
S.K. TOOMBS, Living and Dying With Dignity. An Alternative
Perspective, in R.M. BAIRD, S.E. ROSENBAUM, S.K. TOOMBS
(eds.), Disability. The Social, Political and Ethical Debate,
Prometeus Books, Amherst, New York, 2009;
J. VANIER, Abbracciamo la nostra umanità [1998], trad. di C.
Gaini Rebora, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2000.
55
J EAN -L UC E GGER G IURILINGUISTA E SAGGISTA - B ERNA
Dignità umana e silenzio e silenzio
I NDICE
1. Tre premesse
2. Una metafisica del silenzio
3. Il rispetto delle cose
4. Critica della fisiognomica
5. Conclusione: il silenzio e l'intero
Note
1. Tre premesse
Sono cosciente che il titolo della mia conferenza può dar adito
a malintesi e per questo mi pare importante fare tre premesse
per fugare subito alcuni legittimi dubbi.
In primo luogo ci si può domandare se non ci troviamo dinanzi a una contraddizione: se c'è qualcosa che contraddistingue
l'essere umano, qualcosa di specificamente umano, questo è
senza dubbio la parola. Sin dagli antichi greci l'uomo è lo zoon
logon ekon, l'animale razionale secondo la tradizione occidentale ma, eccepisce Heidegger, «animale razionale» è una traduzione limitativa, perché logos significa anche parola e ciò che
caratterizza l'uomo per il filosofo tedesco non è tanto la ragione quanto invece il linguaggio, il logos in quanto verbo, la capacità di parlare e di creare parole (1), al punto che il linguaggio potrebbe costituire l'elemento per eccellenza per fondare
la dignità umana, o per lo meno per ripristinare l'umanità: mi
pare interessante segnalare a questo proposito le esperienze di
rieducazione di giovani criminali condotte in Svizzera con il
metodo della verbalizzazione e della scrittura: ci si rende conto, anche sulla scorta di studi americani corroborati però dalla
pratica, che esiste un significativo parallelismo tra il disordine
verbale di una persona e il disordine della sua vita: «quando
manca la capacità di nominare le cose e le emozioni, manca
un meccanismo fondamentale di controllo sulla realtà e su noi
stessi» (2), e dunque la parola, il fatto di verbalizzare e articolare secondo un ordine le esperienze di violenza subite o com56
piute, consente di oggettivare tale vissuto e distanziarsene, collocarlo in una prospettiva umana; da qui un potere quasi taumaturgico della parola, un suo stretto legame con quanto ci
identifica più umanamente e quindi, indirettamente, con la dignità). Del resto i greci consideravano barbaro, cioè non umano o comunque di un livello umanamente inferiore, chi secondo loro non era dotato della capacità di parlare la lingua greca,
chi difettava del linguaggio per antonomasia. Dunque, la parola è un fattore fondamentale di dignità umana. E il silenzio in
tutto questo? Se la parola contraddistingue l'umano, il silenzio
non ci porta ad un livello subumano, non degno dell'umanità?
Il silenzio di cui vorrei discorrere stasera non è opposto alla
parola, anzi, come vedremo, sta alla base della parola e la legittima; quindi il primo dubbio è fugato poiché la parola ha una
grande parte nella definizione della dignità umana.
In secondo luogo vorrei precisare anche subito che il silenzio
di cui tratterò non rientra nella generale retorica della purificazione che in diverse forme va qua e là diffondendosi nelle nostre società. Viviamo in un mondo dominato dalla logica dell'incremento, della crescita, con evidenti effetti collaterali: inquinamento, aumento dei ritmi lavorativi e della redditività,
consumo di materie prime non rinnovabili, deforestazione,
congestione delle vie di comunicazione, pervasività dell'informazione, onnipresenza di rumore e via dicendo. In un simile
contesto si levano sempre più insistentemente voci critiche e
vengono investite anche molte energie per contenere le ripercussioni di tale modello di crescita. Si moltiplicano gli sforzi e
le proteste per ridurre l'impatto ambientale dei nostri modelli
di vita, ridurre lo stress da lavoro, ridurre il consumo di energia, ridurre la produzione di rifiuti, ridurre il traffico ecc. Si inizia a promuovere l'idea che occorre sostituire la logica dell'incremento con una logica della riduzione, entrare nell'èra del
«meno», The Age of Less (3). In questa sorta di fuga dagli eccessi e da quello che è stato definito l'horror pleni, il silenzio
può rappresentare ‒ e di fatto rappresenta ‒ una mèta ambìta
o per lo meno la direzione da seguire per ritrovare una dimensione umana autentica; del resto, anche in Italia la letteratura
sul silenzio inteso in questo senso non manca; ricordo ad
esempio il libro di uno studioso inglese pubblicato da Feltrinelli nel 2008 in cui la nostalgia del silenzio assurge addirittura a
rivendicazione politica e assume la forma del manifesto. Nel
suo Manifesto per il silenzio Stuart Sim, volendosi fare interprete di una generale preoccupazione per il rischio di estinzione di questo fenomeno, propone un vero e proprio programma a sostegno della tutela del silenzio in ambito sociale, politico e globalmente umano (4). Ecco, il silenzio di cui vorrei parlare stasera comprende evidentemente anche questo aspetto,
ma non pertiene precipuamente a questa logica della fuga da
una realtà assordante, non si oppone quindi in primo luogo al
rumore.
E la mia terza e ultima premessa per ben instradare la nostra
riflessione concerne evidentemente la via mistica. Il silenzio è
un vettore privilegiato di esperienze spirituali o comunque alogiche; nella nostra tradizione occidentale costituisce una forma di sigillo e quasi una prova dell'elevatezza, dell'eccellenza
dei contenuti vissuti. Il cammino della speculazione filosofica
57
è costellato di pensatori che, pur nella diversità innegabile delle loro dottrine, condividono una diffidenza più o meno accentuata nei riguardi dell’approccio dialettico della realtà, considerandolo insufficiente e poco idoneo per raggiungere un’intelligenza soddisfacente ed autentica dell’essere e che, di conseguenza, subordinano le capacità descrittive del discorso predicativo alle illimitate potenzialità euristiche del silenzio. Un
esempio tratto dalla fine del 400, il secolo che con Pico della
Mirandola ha riscoperto e celebrato l'umano e la nozione stessa di dignità umana: Nicola Cusano sottolinea che «la nostra
ricerca della sapienza ineffabile [...] è possibile più nel silenzio
e nella visione, che nel parlare e nell’ascoltare» (5). Ora, non è
mia intenzione questa sera invitarvi a fare qualsivoglia esperienza mistica parlandovi del silenzio o dell'ineffabile.
Riassumendo, dunque, il silenzio di cui vorrei trattare stasera:
- non si oppone alla parola;
- non si oppone al rumore;
- non si oppone alla ragione.
Mi pareva importante fare queste premesse per preparare il
«terreno» ma anche per evidenziare quanto la nozione di silenzio sia densa di significati, connotata socialmente e filosoficamente e direi connotata in un modo che la rende quasi scomoda per riflettere su un concetto come la dignità umana, la rende una nozione poco pertinente, impertinente anzi, forse inutile. Max Picard, il filosofo svizzero che ci accompagnerà stasera, ha scritto:
«Il silenzio è oggi l'unico fenomeno "senza utilità" [ohne
Nutzen]. Del resto non s'addice all'odierno mondo dell'utile, si
limita ad esistere e sembra non avere alcun altro scopo, né si
presta a qualsivoglia sfruttamento» (6).
Il silenzio è privo di utilità: ecco, stasera vorrei mostrare che
proprio per il fatto che è estraneo alla logica dell'utile, il silenzio può aiutarci a pensare la dignità umana in una prospettiva diversa. In che senso però il silenzio può avere un rapporto
con la dignità umana? Per rispondere occorre dapprima esaminare rapidamente i capisaldi della dottrina picardiana del
silenzio.
2. Una metafisica del silenzio
La prospettiva in cui si muove il pensiero di Picard è la presenza o presenzialità (Gegenwärtigkeit); siamo cioè di fronte a
un pensiero attento alle cose, alle persone e ai fenomeni nel
loro apparire assoluto, assoluto in quanto liberato dalle innumerevoli connessioni (oggi, è bene ricordare, tutto sembra dover essere per forza interconnesso) che secondo il nostro occultano l’essenza originaria delle cose; scrive per l’appunto Picard:
«ho sempre tentato nei miei libri di liberare i singoli oggetti e
fenomeni dalle migliaia di relazioni, di rendere l’oggetto chiaramente visibile in se stesso, in modo che l’uomo potesse di
nuovo avere un incontro con il mondo come esso veramente
è: ossia un oggetto nettamente separato dall’altro» (7).
58
In questa sorta di archeologia (o archeofanìa) del presente,
in questa lettura poetica del reale (come la definì Lévinas), che
non intende superare le cose in un sistema concettuale ma
semmai metterne in evidenza lo spessore e l'inesauribilità prima ancora di qualsivoglia cattura concettuale (prima di ogni
Be-griff) da parte della ragione, il silenzio riveste un ruolo centrale. Ma, e qui la precisazione è fondamentale, il silenzio non
interviene quale facilitatore o vettore di un certo tipo di incontro con le cose, bensì assume importanza proprio quale ingrediente irrinunciabile dell’essere, coefficiente di sostanzialità e,
in definitiva, vera e propria dimensione metafisica della realtà.
Per Picard, a tutela dell’oggettività del reale esiste un mondo
del silenzio, da intendere come una dimensione dell’essere nella quale si attua, si dispiega, una delle componenti ontologicamente più pregnanti del reale. A proposito di questa valenza
oggettiva del silenzio è opportuno leggere direttamente quanto scrive Picard:
«Una volta il silenzio ricopriva tutte le cose. Prima di potersi
avvicinare a un oggetto, l’uomo doveva innanzi tutto infrangere l’involucro del silenzio, e il silenzio si ergeva anche dinanzi
ai pensieri che l’uomo voleva pensare. L’uomo non poteva gettarsi direttamente sui pensieri e sulle cose, poiché questi erano protetti dal silenzio che li circondava; ed egli era a sua volta trattenuto dal volgersi troppo precipitosamente verso di loro. Il silenzio stava dinanzi ai pensieri e alle cose, in una presenza oggettiva, e si ergeva davanti ai pensieri e alle cose come
un oggetto. L’uomo si muoveva lentamente e con timidezza
verso i pensieri e verso le cose; il silenzio si frapponeva sempre nel moto tra un pensiero e l’altro, tra una cosa e l’altra e il
ritmo di questi movimenti era scandito dal silenzio. Ogni movimento era un atto particolare. Prima di poter avanzare si doveva rimuovere il silenzio, la roccia primordiale del silenzio; ma
poi, una volta pervenuto ad un pensiero, l’uomo era veramente in esso e anzi solo in quel momento il pensiero o la cosa erano veramente presenti: veniva generata una presenza, talmente l’uomo era dentro il pensiero o la cosa». [MS, 191]
Ecco, il silenzio non è uno stato in cui possiamo collocarci a
seconda delle circostanze (il minuto di silenzio in onore di
qualcuno o di qualcosa, ad esempio), il silenzio è una dimensione dell'essere, ha rilevanza ontologica in quanto sigillo,
guaina metafisica che avvolge gli enti e certifica la loro separazione. Il silenzio, dice ancora Picard, rafforza la sostanzialità
delle cose, restituisce le cose a se stesse, ne ripristina l'integrità. Per capire il messaggio di Picard occorre allora capovolgere
la nostra prospettiva abituale: siamo abituati a concepire il silenzio come qualcosa che si ottiene per attenuazione di stimoli
acustici; per Picard esso esiste indipendentemente da ogni volontà e al cessare del rumore diviene semmai percepibile (8).
Ora, se analizziamo più da vicino il rapporto tra essere e silenzio ci accorgiamo che quello che Picard definisce il «grande
mondo dell'oggettività del silenzio» delinea una dimensione
59
nella quale si esercita un atto di sostanzialità caratterizzato da
quattro momenti:
1. momento di stasi, di arresto, nel quale il divenire cede il posto all’essere («Nel silenzio la sostanzialità delle cose è rafforzata») e l'ente può pertanto esercitare pienamente la propria
virtù entitativa;
2. in secondo luogo un momento di coesione formale, di integrità e interezza e pertanto di separazione degli enti; il silenzio
è indice inequivocabile di quell'autonomia grazie alla quale
ogni cosa è più in rapporto con se stessa, è più per sé che non
per altro (9);
3. in terzo luogo, un momento di verticalità, di rapporto diretto con la profondità, con quello che l'autore chiama il «fondo»
delle cose (10), con quell'area di intimità in cui ci si può muovere solo in silenzio. Questa capacità che ha il silenzio di instaurare una relazione verticale è importante soprattutto sotto
il profilo antropologico, perché il silenzio è il centro dell'uomo, è la sede in cui si origina ogni atto veramente umano, ad
esempio la parola (11);
4. e infine un momento di eccedenza, di vera dignità della forma intesa come perfezione dell’ente, chiaro oltrepassamento
di quanto è meramente necessario in un eccesso («das
Mehr»), in un sovrappiù rispetto a ogni sua strumentalizzazione e subordinazione utilitaristica (il silenzio è «sacra inutilità») (12).
Stasi, separazione, fondo, eccesso. L’origine delle cose, la venuta all’essere è per Picard innanzi tutto un atto di separazione, un atto di santità nel senso etimologico del termine (13).
Le cose esistono perché separate, giacché l’atto separa (Aristotele) (14) e, come ha sottolineato anche Jeanne Hersch, la separazione è la cifra della creazione (15). Il silenzio è suggello di
chiusura e di separazione e ciò che si separa emerge dallo sfondo dell’indistinto e dell’amorfo, accede all’essere.
3. Il rispetto delle cose
Silenzio, essere, separazione, forma. L'opera di Picard mira a
riscoprire il silenzio quale dimensione essenziale della realtà,
descrive, come aveva visto Bachelard, la sottile coefficienza
del silenzio nella fenomenicità del mondo (16) ma, mi pare di
poter dire, nel suo intento di rendere manifesto il silenzio (17)
vuole innanzi tutto ripristinare le cose nella loro autonomia
entitativa, nella loro integrità (Unversehrtheit) e, direi, nella
loro dignità. Come bisogna intendere infatti questa dottrina
del silenzio, questa metafisica del silenzio? Credo che questa
rivalutazione sia da riallacciare al concetto di fenomeno originario (Urphänomen), mutuato da Goethe, al concetto cioè di
una realtà irriducibile. La prova inequivocabile dell'oggettività
del reale risiede per Picard nell'anteriorità, nella datità a priori (das Vorgegebene), di fenomeni fondamentali e irriducibili
che costituiscono l'orizzonte dell'agire umano e la misura dell'essere nel mondo. I fenomeni originari sono irriducibili non
nel senso che vi sia un limite alla loro analisi, ma piuttosto per60
ché segnano il limite di pertinenza oggettiva per l'essere umano, sono dei paradigmi reali di interezza. Il silenzio è fra i fenomeni originari quello che racchiude più oggettività, quello che
permea di se stesso tutti gli altri e, forse proprio per questo, il
primo. Scrive Picard:
«Il silenzio è un fenomeno originario, ossia è una datità primaria non riconducibile a nulla d'altro. Non può essere sostituita da nient'altro né con altro scambiata e dietro di essa non
vi è nulla a cui riallacciarla, tranne il Creatore medesimo.
Il silenzio esiste originariamente e naturalmente come gli altri fenomeni originari, come l'amore, come la fedeltà, come la
morte e come la vita stessa. Il silenzio però esisteva prima ancora di tutti gli altri fenomeni originari ed è presente in ognuno di essi. Fra i fenomeni originari è quello primigenio; ingloba gli altri, l'amore, la fedeltà, la morte, sicché in essi vi è più
silenzio che manifestazione, nell'amore, nella fedeltà, nella
morte vi è più silenzio di quanto si mostri amore, fedeltà e
morte nel mondo» (18).
Siamo allora in grado di capire meglio cosa intende Picard
quando afferma che il silenzio «conferisce alle cose che lo abitano parte della sua sostanzialità», oppure quando aggiunge
che «Nel silenzio la sostanzialità delle cose è rafforzata» (19).
Si tratta di sottolineare l'irriducibilità di ogni ente, la sua dignità, dovuta all'incidenza del silenzio che, in quanto fenomeno
originario, non rimanda a nulla di altro, è un assoluto, non è
scomponibile in parti più elementari. Ogni cosa, ogni ente, merita rispetto, ha una propria dignità, perché ogni ente prima
ancora di essere il risultato di un processo o prima ancora di
essere la somma delle sue parti è un'unità totale dotata di una
propria intelligibilità e di un propria originalità ontologica.
Tutti voi, credo, conoscete la metafora della ghianda e della
quercia di Hegel: la verità della quercia, dice Hegel, non sta
nel suo seme o nella ghianda o nella quercia stessa, ma in tutto il processo (dialettico) che dal seme porta alla ghianda e poi
alla pianta matura. «Das Wahre ist das Ganze» (20), la verità
è il tutto, sottinteso tutto il divenire dell'essenza. Ebbene, per
Picard la stasi, la presenza, cancella il divenire, crea un nuovo
ordine a sé stante:
«Oggi nelle scuole si è soliti mostrare ai bambini un filmato
che descrive lo sviluppo di un fiore partendo dal suo seme. La
metamorfosi si dipana lentamente sotto gli occhi dei bambini.
Ma il prodigio non consiste nella crescita del fiore davanti a
noi, bensì nella sua presenza, nel fatto che il fiore è talmente
presente come se non fosse mai divenuto, poiché in realtà il
suo sviluppo è risolto nella sua esistenza presente. Questo è il
miracolo, il fatto che il fiore sia qui come se mai fosse divenuto». (21)
La presenza, la stasi, annulla il divenire, instaura una nuova
intelligibilità, genera un irriducibile (ma anche un inesauribile
direbbe Pareyson) e il silenzio che avvolge le cose è come il sigillo di questa separazione, la prova visibile (vedremo perché
«visibile») che siamo in presenza di una alterità. Del resto, la
risposta a Hegel è proprio questa: «Solo dinanzi al silenzio si
dispiega l'unità totale di una cosa (Nur vor der Breite des
Schweigens breitet sich das Ganze eines Dinges aus)» (22).
61
Se ripensiamo a quanto abbiamo detto all'inizio, cioè che l'intenzione di Picard è di «liberare i singoli oggetti e fenomeni
dalle migliaia di relazioni, di rendere l’oggetto chiaramente visibile in se stesso», scopriamo che questa impostazione di fondo non ha mire speculative ma è animata proprio da un intento etico, dalla preoccupazione di ripristinare gli enti nel loro
statuto appropriato di unità totali affinché possa avvenire un
incontro al giusto livello ontologico fra l'uomo e l'essere («in
modo che l’uomo potesse di nuovo avere un incontro con il
mondo come esso veramente è»). La nozione di incontro è qui
particolarmente importante: oggi per dimostrare la realtà dell'essere contro il pensiero postmoderno si afferma che occorre
incontrare le cose in quanto esse hanno d'inatteso, di eccedente la rappresentazione, di «inemendabile» (23). È giusto, ma
direi che non basta incontrare le cose, occorre incontrarle al
giusto livello, a un livello che corrisponda alla loro integrità,
alla loro dignità. Ma qual è questo livello adeguato, quando è
dato incontrare le cose nella loro integrità (Unversehrtheit)?
Ebbene, l'ente ripristinato nella sua verità, nel suo essere separato, nella sua interezza, è definito immagine (das Bild) e l'immagine non solo richiede un approccio integrale ed etico, che
preservi l'integrità della stessa (24), ma si costituisce essa stessa attraverso il rispetto, il respicere, il fatto di guardare indietro al suo archetipo, al punto che il rispetto è l'atto costitutivo
dell'immagine, la vocazione intima di ogni cosa:
meno, perché ora sono a casa. La lontananza, da cui provengono, è risolta in splendore: si volgono indietro brillando». (25)
«Le parti di una cosa convergono tendenzialmente verso la loro origine; nell'immagine sono; l'anelito verso l'origine viene
La fisiognomica si è tradizionalmente affermata come la scienza della lettura dell’indole umana attraverso l'aspetto esteriore
del corpo, segnatamente i tratti del viso, quasi una sorta di de-
L'apparire delle cose in quanto immagini è splendore del rispetto. Vedete che in Picard, come in Lévinas, l'etica si fa estetica, ma si fa estetica perché il rispetto è iscritto nelle cose stesse. Ho visto che una delle lezioni di questo ciclo s'intitolava
«Dignità Umana e bellezza», credo che nell'estetica di Picard
vi sia una componente etica anche molto forte.
Per esemplificare questa valenza etica dell'immagine mi sembra interessante analizzare brevemente come il silenzio agisce
in quell'immagine per eccellenza che è il volto umano. In fondo, la critica di Picard alla fisiognomica classica mira appunto
a salvaguardare la dignità umana in una scienza che apparentemente pare contraddire l'irriducibilità dell'umano a prospettive altre, subordinate.
4. Critica della fisiognomica
Picard ha scritto tre opere sulla fisiognomica, ma l’attenzione
alle fattezze dell’uomo, e anzi alle fattezze di tutta la realtà, attraversa l’intera sua opera, talché alcuni non hanno esitato a
definire l'impostazione generale del suo metodo come una sorta di fisiognomica dell’essere.
62
cifrazione dell’apparenza per scoprire ciò che questa esprime
(26). In questa prospettiva il volto assume uno statuto particolare poiché concentra nei suoi lineamenti l’espressione di tutta l’anima («Imago animis vultus est», sentenziava Cicerone)
e perché è l’area privilegiata del corpo per accedere al mondo.
In virtù della sua esposizione e patenza (la sua nudità direbbe
Lévinas) (27) il viso è la parte del corpo che più manifesta la
dimensione profonda dell’uomo e, nel contempo, per la sua
apertura sul mondo, si dichiara anche quale vettore di esplorazione dell’esteriorità, come la parte del corpo più protratta in
avanti (28). È un'esperienza che facciamo quotidianamente: il
volto è la parte del corpo nella quale più facilmente ci identifichiamo e, viceversa, è la parte del corpo nella quale generalmente ci facciamo riconoscere. Ma questa centralità del volto
non è dovuta per Picard alla sua trasparenza (un assunto regolarmente rimproverato alla fisiognomica) (29), bensì alla traccia di una decisione, all'espressione di una distanza. La logica
della decifrazione immediata presupposta normalmente dalla
fisiognomica sminuisce anzi per Picard i due termini in relazione, perché ne occulta sia la specificità sia la dignità. Infatti, se
vi fosse corrispondenza assoluta tra l’interiorità umana e la
forma del viso, l’interiorità sarebbe riducibile alla sua espressione plastica, sarebbe limitata ai tipi o alle forme caratteriali
che traspaiono nei tratti somatici perdendo qualsivoglia mistero, libertà e complessità. D’altro canto, se non fosse che segno
esteriore di caratteristiche soggettive, se la sua forma si esaurisse nell’espressione di elementi della personalità, il viso diventerebbe semplice strumento subordinato a una funzione di
significazione e perderebbe la sua natura di fenomeno origina-
rio, ossia il fatto di essere una datità primaria che trova il proprio senso nella sua stessa immediata presenza:
«Proprio qui sta la dignità del volto umano, nel fatto che nel
volto l’uomo decide se accettare ciò che l’immagine del viso
esprime in silenzio. In questa decisione l’uomo è sottratto dal
mero corso naturale delle cose e si ricrea una nuova natura
grazie allo spirito» (30).
Il volto dunque, lungi dall’essere mera espressione dell’anima,
è il luogo di una decisione, è segno concreto e visibile di una
netta separazione tra due grandezze a sé stanti, il viso e l’interiorità. La fisiognomica di Picard pone certo i due ordini in relazione, ma il loro reciproco rapporto non è necessariamente
univoco, di diretta corrispondenza (31). L’uomo può essere
perfettamente identico al suo aspetto, ma non lo deve necessariamente, ha la libertà di essere diverso dal suo viso (32), proprio perché il rapporto tra questi due ordini non è l’equivalenza diretta, bensì lo scambio dinamico tra dimensioni a sé stanti, contemperazione e bilanciamento di istanze eterogenee:
«Come abbiamo detto, non importa che l’esteriorità, il viso,
appaia secondo la natura dell’interiorità, importa invece che il
viso aiuti l’interiorità ad essere una vera interiorità. Non conta
che il viso sembri cattivo nonostante che l’interiorità sia buona. Conta però che il viso assuma su di sé la cattiveria affinché
l’interiorità possa essere buona, – questa è la vera corrispondenza» (33).
A livello fenomenologico tale complessa relazione dinamica ha
il suo corrispettivo nella traccia iscritta nel volto stesso di una
63
doppia separazione: separazione del volto dal resto del corpo
e, più profondamente, separazione del volto dalla propria forma. La decisione è iscritta dapprima nella collocazione del viso rispetto al resto del corpo, nel distacco netto dall’oscurità
amorfa (Ungegliedert) della nuca e del cranio, un distacco che
rievoca l’atto deciso, la sorpresa, della sua venuta all’esistenza.
(34) Vi è dunque una separazione tra il corpo e il viso che situa quest’ultimo a un altro livello e che è all’origine della sorpresa e della novità che accompagna ogni epifania del viso
(35). Il volto non è la continuazione di altre parti del corpo,
ma è una forma a sé stante, separata e ben delimitata.
Ma il viso è poi separato anche rispetto alla sua stessa forma.
La decisione si manifesta come presenza di un eccesso di sostanzialità nel viso umano, eccesso che rende questa parte del
corpo leggera e fluttuante (schwebend) sul suo sostrato fisico
e ne fa un’entità che sfugge ad ogni com-prensione (36), un'entità che come dice Lévinas è presente nel suo rifiuto di essere
contenuta (37). Il viso è uno spiraglio aperto direttamente sull’eterno, è scolpito nell’eternità (38), sicché nella sua apparizione pare riferirsi più ad un archetipo, all’idea, che non all’uomo. Nel viso, più che in ogni altro apparire, si manifesta quella discreta (silenziosa) dialettica che lega l’immagine al suo
prototipo (Urbild) e che fa di ogni apparizione una risposta
inadeguata e quindi sempre nuova ad un assoluto inesprimibile (39). È proprio in questa iconicità (Bildhaftigkeit), in questo rapporto di apertura sull’infinito, in questo débordement
della forma (Levinas) per eccesso di sostanzialità (das Mehr)
che Picard situa fenomenologicamente la possibilità di scelta e
di decisione dell’uomo, lo scarto che connota il libero arbitrio:
«Il viso è apparenza, immagine, si libra sopra la forma umana, ne è svincolato, pronto ad essere accolto. E l’immagine, leggera e fluttuante, non grava sull’interiorità, l’interiorità e l’esteriorità restano distanti l’una dall’altra: l’iconicità è il fondamento formale della libertà dell’interiorità rispetto all’esteriorità» (40).
La traccia dell’infinità nel viso, l’inesauribilità del suo darsi
nell’apparenza, l’eccesso di sostanzialità e la refrattarietà ad
ogni categorizzazione, tutte caratteristiche che fonderanno peraltro la filosofia levinassiana del volto, hanno per Picard il loro fondamento nell’iconicità del viso, nel suo essere immagine, il che, secondo la logica fenomenologico-fisiognomica picardiana, è dovuto a sua volta alla presenza attiva del silenzio,
al fatto cioè che il viso è intriso di silenzio. Il silenzio è anzi un
organo del viso:
«Il silenzio è come un organo nel viso umano. Nel viso non ci
sono soltanto gli occhi e la bocca o la fronte, ma vi è anche il
silenzio. Esso è ovunque nel viso, è il sostrato di ogni sua parte» (41).
Il silenzio è il centro invisibile verso cui convergono tutte le
parti che compongono il viso e da cui queste sono ordinate.
Nella loro diversità, l’occhio, il naso, la bocca e ogni altra parte
del viso costituiscono un’unità coerente grazie proprio alla forza unificante del silenzio. Anche nella fisiognomica agisce la
concezione ontica del silenzio che informa tutto il pensiero di
64
Picard. Nel silenzio, come abbiamo visto, le cose sono più connesse con se stesse che con quanto le circonda (42). Per questo il viso sembra fluttuare sopra la sua forma. In questa leggerezza alberga la risposta all’atto creatore, la vocazione prima
del viso che è innanzi tutto di essere risposta all’esistenza e a
chi dell’esistenza è all’origine:
«Il viso umano è più rivolto verso Dio che non verso l’uomo, è
innanzi tutto risposta a Dio; risponde al Creatore. Questa risposta avviene nel silenzio. Tutto nel volto è retto in funzione
di questa risposta. Il viso si esprime e diviene chiaro per gli uomini soltanto nella misura in cui la risposta a Dio, il silenzio
rivolto a Dio, lo permette. La chiarezza ed espressività verso
gli uomini è subordinata a questo silenzio» (43).
Io credo che sottolineare che ogni chiarezza ed espressività
del viso è subordinata al silenzio significa porre nel cuore dell’esposizione fenomenica della persona, cioè nel viso, la presenza attiva di uno scarto, di una distanza rispetto alla logica
dell’esibizione, e quindi farne une segno visibile della primazia della dignità umana su ogni tentativo di lettura totalizzante (44). Il silenzio, la subordinazione dell’apertura del viso al
silenzio, consente all’uomo di decidere se assumere o meno
nel proprio viso la propria interiorità, è dunque il fondamento
della distanza dalla propria natura, è il fondamento dell’eccentricità con cui l’uomo relativizza la propria esistenza, con cui
«esce» da se stesso e invece di essere semplice tramite della
natura agisce liberamente, si fa persona (Robert Spaemann)
(45).
5. Conclusione: il silenzio e l'intero
Siamo partiti dalla mancanza di utilità del silenzio. Abbiamo
visto che questa refrattarietà del silenzio ad ogni strumentalizzazione è da associare alla sua pura sostanzialità e alla sua capacità di rendere le cose assolute. Abbiamo poi descritto come
si manifesta e come si esercita (in quattro momenti) la valenza
oggettiva del silenzio e in seguito scoperto che proprio grazie
all'efficienza del silenzio le cose si fanno immagine e in quanto
immagini sono un monito di rispetto per l'essere, permeano la
realtà di rispetto. Analizzando l'immagine per eccellenza, il volto umano, siamo infine giunti a capire che nel volto si manifesta fisiognomicamente la decisione umana circa l'espressione
della propria indole e pertanto che nel volto si mostra tutta la
distanza dell'essere umano nei confronti della sua natura e
quindi, indirettamente, la sua libertà e dignità. Lungo tutto
questo itinerario, in ogni sua tappa, il silenzio ci è apparso come un fattore di assolutizzazione e di separazione: il silenzio
restituisce le cose a se stesse, le separa, ne fa degli assoluti irriducibili e il silenzio separa anche l'essere umano dalla sua natura facendone un essere responsabile, capace di decisione.
Si può evidentemente condividere o meno le posizioni di Picard, si può anche affermare categoricamente che un mondo
del silenzio non esiste e che pertanto la realtà si costruisce diversamente. Io credo tuttavia che il contesto contemporaneo
abbia bisogno di riscoprire il silenzio come dimensione dell'essere, ma anche il silenzio quale fondamento della parola.
65
La parola: oggi comunichiamo generalmente mediante strumenti elettronici, mass media e piattaforme virtuali, viviamo
in un mondo di informazioni costruito su parole che nascono
da altre parole e che sembrano generarsi spontaneamente per
contiguità immediata, nel tempo reale. Ma queste sono parole
che nascono per far scorrere questa realtà fluida ed istantanea
(liquida), sono parole che non domandano una risposta, nascono senza interpellare veramente l'essere umano (del resto non
ce ne sarebbe il tempo). Come rilevava il sociologo Jean
Baudrillard, in Internet non esiste il silenzio perché i contenuti mediatici (parole o immagini) non tacciono mai, devono succedersi senza interruzione (46). Questa realtà liquida si costruisce non grazie alle parole ma intorno al brusio verbale
(Wortgeräusch) che per Picard designa proprio l'opposto del
silenzio, un vuoto involucro sonoro privo di limiti precisi e privo di sostanzialità che riempie i canali della comunicazione
odierna (47). Forse il silenzio potrebbe aiutarci a ritrovare la
vera parola, la parola che nasce dal centro dell'uomo ‒ che appunto è silenzio ‒ e che interpella un altro silenzio (48).
Ma poi abbiamo bisogno del silenzio di Picard anche in un altro senso più fondamentale, proprio quale garante della separazione. Per diversi aspetti le scienze contemporanee ci pongono di fronte all'esigenza di distinguere ciò che è umano da ciò
che non lo è, cioè ci impongono di definire, separare l'uomo e
quanto gli pertiene specificamente da quanto lo costituisce chimicamente o biochimicamente e da quanto potrebbe aggiungersi all'umano. Sempre più spesso la scienza ci chiede di decidere dove inizia l'umano e dove esso finisce. Grazie alla conver-
genza di nanotecnologie, biotecnologie, intelligenza artificiale
e scienze cognitive si riesce oggi a mappare il genoma umano,
si ipotizza la creazione di organismi viventi mediante manipolazioni genetiche, la clonazione di organi e facoltà umane,
l'ibridazione tra l'organismo umano e le macchine, la manipolazione di embrioni e via dicendo. Ci sono scienziati che non
esitano a definire il momento attuale come un momento di
«svolta antropologica» perché le nuove possibilità che si aprono alla scienza e all'ingegneria genetica e cognitiva stanno plasmando una nuova identità dell'uomo o comunque dislocando
i limiti tradizionali della nostra concezione dell'umanità. Un
esempio significativo di tale temperie è un'indagine svolta dal
filosofo francese Roger-Pol Droit sulle diverse rivoluzioni
scientifiche che stanno modificando l'immagine classica dell'uomo; volevo leggervi solo un passaggio dell'introduzione di
questo recente libro che situa, mi pare eloquentemente, i termini della problematica:
«Impiantare nel nostro cervello estensioni di memoria, banche dati, strumenti di calcolo o di aiuto alle decisioni, riprogrammare le nostre cellule per evitare la malattia, la disfunzione o l'usura degli organi, collegare direttamente il nostro organismo ai sistemi informatici, regolare permanentemente il suo
funzionamento, ibridare corpo e macchine, allontanare i limiti
dell'esistenza, trasformare la successione delle generazioni, le
identità sessuali: tutto questo è diventato prospettabile. E la
lista delle metamorfosi che potrebbero far scomparire l'immagine classica dell'umano si allunga» (49).
66
Di fronte a questi sviluppi mi pare che sia estremamente importante salvaguardare la coscienza condivisa di quelli che sono i contorni dell'umano, la certezza di un nucleo intangibile
dell'umano, di un limite o di quello che Habermas definiva un
«involucro deontologico di salvaguardia dei confini umani»
(50) che serva a tutelare l'inviolabilità della persona, una zona
di silenzio appunto, di irriducibilità, che separi l'umano da
ogni prevaricazione riduttiva o strumentalizzante.
«Sembra proprio un miracolo che l'essere umano sia ancora
circoscritto da contorni e che non sia dilaniato dalle sue stesse
possibilità» (52).
Abbiamo bisogno di ricollocare l'essere umano e le cose in
una prospettiva che ne preservi l'integrità, ossia che le consideri come delle unità totali, degli interi, che eccedono le loro
componenti e questo in due sensi:
Note
- sia nel senso che sono più delle loro parti (il tutto è più della
somma delle sue parti);
- sia nel senso che appartengono ad un altro ordine d'intelligibilità rispetto a quello delle loro componenti, dunque che sono esseri con esigenze specifiche, particolari.
Il silenzio apre questa prospettiva integrale, senza peraltro
pre-orientarla o indirizzarla ideologicamente. Prescindere da
questo silenzio significa essere defraudati delle cose prima ancora di averle realmente incontrate (51), ma significa anche
ignorare le prerogative dell'intero e quindi, per quanto concerne l'uomo e la sua dignità, rischiare di sacrificare la propria natura a profitto delle sue stesse possibilità di autoplasmarsi: in
questo senso mi pare interessante ricordare ‒ mettendolo in
relazione con la citazione precedente ‒ quanto Picard scriveva
già nel 1934:
Ecco, se questo miracolo perdura ancora oggi (fino a quando?), forse è anche grazie all'involucro di silenzio che ancora
ci avvolge.
1 Sein und Zeit, §34: «Die spätere Auslegung dieser Definition des Menschen als
animal rationale, "vernünftiges Lebewesen", ist zwar nicht "falsch", aber sie verdeckt den phänomenalen Boden, dem diese Definition des Daseins entnommen ist.
Der Mensch zeigt sich als Seiendes, das redet».
2 Cfr. il resoconto sulle esperienze dell'associazione Rendez-vous en bibliothèque
in La Liberté del 7 gennaio 2012, p. 9. Citazione da CAROFIGLIO 2010, 19; ma cfr.
anche op. cit. p. 18: «Il rapporto fra ricchezza delle parole e ricchezza di possibilità
(e dunque di democrazia) è dimostrato anche dalla ricerca scientifica, medica e criminologica: i ragazzi più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci, sul piano del lessico, della grammatica e della sintassi. [...] La povertà della comunicazione, insomma, si traduce in povertà dell'intelligenza, in doloroso soffocamento delle emozioni. [...] Chi non ha i nomi per la sofferenza la agisce, la esprime
volgendola in violenza, con conseguenze spesso tragiche».
3 Cfr. ad es. DAVID BOSSHART, The Age of Less, Amburgo 2011.
4 STUART SIM, Manifesto per il silenzio, Feltrinelli, Milano 2008 (trad. it. di ADELE OLIVERI del testo originale: Manifesto for Silence: confronting the politics and
culture of noise, Edimburgh University Press Ltd., 2007).
5 «Nostra inquisitio ineffabilis sapientiae, [...] potius in silentio et visu, quam in
loquacitate et auditu reperitur» De Venatione Sapientiae, XXXIII.
6 MAX PICARD, Il mondo del silenzio, a c. di J.-L. EGGER, Servitium, Sotto il
Monte (BG), 2007, p. 20 [qui di seguito citato come MdS].
67
7 MICHAEL PICARD, Auswahl von wichtigsten „Stellungen“ von Max Picard, Neggio 1980 [excerpta dall’epistolario di Max Picard, dattiloscritto inedito], testo del
18.8.46.
faudrait un grand livre. Ce livre est écrit. Il faut lire de Max Picard: Le monde du
silence» GASTON BACHELARD, La poétique de l'espace, PUF, Paris 20049, p.
167.
8 «Certo, dove finisce la parola inizia il silenzio. Ma non inizia perché cessa la parola; inizia in quanto solo allora diventa manifesto», MAX PICARD, Il mondo del silenzio, cit. p. 17.
17 «... sei die Welt des Schweigens, die heute verdeckt ist, wieder deutlich gemacht»
18 MdS, 23.
9 MdS, 75: «In un mondo nel quale opera il silenzio una cosa è più legata al silenzio che a un'altra cosa. Esiste più per se stessa, appartiene più a se stessa che non
una cosa in un mondo privo di silenzio, dove una cosa è soltanto in rapporto con
altre cose».
10 MdS, 74: «Ogni oggetto hai sé un fondo molto più remoto della parola che lo
nomina. Questo fondo l'uomo può incontrarlo soltanto col silenzio».
11 MdS, 61: «L'uomo nella cui essenza abiota ancora il silenzio si volge al mondo
muovendo dal silenzio; il silenzio è il centro dell'uomo. Il moto allora non avviene
direttamente da un essere umano all'altro, bensì dal silenzio dell'uno al silenzio dell'altro».
12 «Che cos'è l'eccesso? Questo: in ogni creatura vi è più di quanto sia necessario
affinché sia com'è. Oltre a tutto il necessario vi è qualcosa in più nelle cose della
creazione, il mondo non è impostato secondo un calcolo esatto e misurato, secondo
l'appena sufficiente, bensì secondo la pienezza. L'eccesso è il fondamento del mondo, non il razionato», MAX PICARD, Das letzte Antlitz. Totenmasken von Shakespeare bis Nietzsche, Knorr & Hirt, Ahrbeck, 1959, p. 8.
13 Santo, participio passato di sancire, che vale «rendre intangibile» e, pertanto,
«separare».
14 Metafisica 1029a 28.
15 «La creazione comincia dunque con la separazione, prima della quale non c’è
altro che il creatore. Essa solo permette il raggruppamento, la ripartizione, l’ordine, la forma», JEANNE HERSCH, Essere e forma, Mondadori, Milano 2006, p.
88.
16 «Mais il faudrait une enquête d'un autre style pour dégager la métaphysique de
tous les au-delà de notre vie sensible. En particulier, pour dire comment le silence
travaille à la fois le temps de l'homme, la parole de l'homme, l'être de l'homme, il
19 MdS, 21.
20 Phänomenologie des Geistes, Vorrede, Ullstein, Frakfurt/M-Berlin-Wien,
1983, p. 22: «Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine
Entwicklung sich vollendende Wesen».
21 MAX PICARD, Die Atomisierung der Person, Im Furche Verlag, Hamburg
1958, p. 12.
22 MdS, 75.
23 Ci riferiamo al recente volume di MAURIZIO FERRARIS, Manifesto del nuovo
realismo, Laterza, Roma-Bari, 2012, in particolare p. 51.
24 Max Picard, «Bild und Pseudobild» in Erziehung zur Menschlichkeit, die Bildung im Umbruch der Zeit, Festschrift für Eduard Spranger zum 75. Geburtstag,
27 Juli 1957, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 108.
25 Max Picard, Fragmente aus dem Nachlass 1920-1965, hrsg. und eingeleitet von
Michael Picard, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1978, p. 32.
26 «Fisiognomica è la scienza per imparare a conoscere il carattere (e non i destini
contingenti) dell’uomo, ricavandolo dalla più minuziosa comprensione del suo
aspetto esteriore, quindi dalla sua fisionomia», Lavater, Johann Caspar, Della fisiognomica, trad. a c. di Laura Novati, TEA, Milano 1993, p. 33 [ed. orig. Von der Physiognomik, Weidmann, Lipsia 1772].
27 Nudità in quanto assenza di forma («nudité dégagée de toute forme») e principio assoluto di significazione: «Le visage s’est tourné vers moi – et c’est cela sa nudité même. Il est par lui-même et non point par référence à un système», Emmanuel Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité, Martinus Nijhoff, La Haye,
1961 [trad. it. a c. di A. Dell'Asta, Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca
68
Book, Milano 1990]. Sul rapporto tra il pensiero del volto in Picard e Lévinas si
leggerà con profitto il saggio di Silvano Zucal, «La filosofia del volto in Max Picard
e Emmanuel Levinas», in Rassegna di teologia, vol. 47, n. 4, 2006, pp. 561-584.
28 «Nessun’altra parte del corpo è riposta così nel profondo, così vicina all’abisso
come il viso, ma nessun’altra parte è anche così protratta in avanti, così decisamente nel mondo, – e proprio in questa tensione vive il viso: indietro in bilico sull’abisso e in avanti proteso verso il mondo, questa è la vita del viso», MAX PICARD, Die
Grenzen der Physiognomik, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1937, p. 139.
29 Celebri ad esempio, anche per la loro pungente ironia, le critiche di Hegel nella
Fenomenologia dello spirito, cfr. Patrizia Magli, Il volto e l’anima. Fisiognomica e
passioni, Bompiani, Milano 1996, pp. 359-362.
30 «Das macht die Würde des Menschengesichtes aus, dass der Mensch an ihm
sich entscheidet, ob er das annimmt, was das Bild des Gesichtes schweigend
ausdrückt» MAX PICARD, Die Welt des Schweigens, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1948, p. 99 [ital. cit. p. 93].
31 «Das eben charakterisiert das Menschengesicht: es ist nicht nur nach dem Gesetz der Entsprechung geformt, sondern das Überraschende baut auch an ihm»,
MAX PICARD, Das Menschengesicht, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich
1947, pp. 69-70.
32 «Der Mensch kann so sein, wie er aussieht, er braucht es aber nicht, er hat die
Freiheit, anders zu sein als sein Gesicht», MAX PICARD, Die Grenzen der Physiognomik, cit., p. 173.
33 «Nicht darauf kommt es an, haben wir gesagt, dass das Äussere, das Gesicht, so
erscheint, wie das Innere ist, sondern darauf, dass das Gesicht dem Innern hilft,
ein rechtes Inneres zu sein. Es ist nicht wichtig, dass das Gesicht bös aussieht,
obwohl das Innere gut ist. Aber es ist wichtig, dass das Gesicht das Böse auf sich
nimmt, damit das Innere gut sein kann, – das ist die wahre Entsprechung », MAX
PICARD, op. cit., pp. 47-48 [ital. in Max Picard, Il rilievo delle cose. Pensieri e aforismi, a cura di Jean-Luc Egger, Servitium, Sotto il Monte 2004, p. 83].
34 «Nur durch einen besonderen Akt, der plötzlich geschah und einheitlich und in
einem Augenblick – es war der Augenblick der Ewigkeit – konnte das Menschengesicht entstehen; das Unerwartete, das in jedem Menschengesicht ist, das Überraschende, mit dem jedes Menschengesicht vor einem erscheint, stammt von diesem
Akt her», MAX PICARD, Die Grenzen der Physiognomik, cit., p. 27
35 «Sorprendente e nello stesso tempo necessario, così appare ogni vero viso. Sorprendente e ogni volta nuovo: perché il viso brilla chiaramente e direttamente davanti a noi come se fuoriuscendo dall’eternità l’anima lo avesse accompagnato nel
presente proprio in questo preciso istante e unicamente per noi; e poi necessario
perché la sorpresa è tale da indurci a credere che la divinità non avrebbe potuto
crearlo diversamente», Max Picard, Il rilievo delle cose, cit., p. 81 [ted. Das Menschengesicht, cit., p. 148].
36 «Gestalt des Gesichts, Gestalt überhaupt, ist mehr, als durch allen Zweck und
alle Anpassung erklärt werden kann. Die Gestalt besteht jenseits allen Zweckes»,
Max Picard, Das Menschengesicht, cit., p. 200.
37 Emmanuel Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité, Martinus Nijhoff,
La Haye, 1980, p. 168: «Le visage est présent dans son refus d'être contenu».
38 «Das Gesicht ist ein Relief auf dem Hintergrund des Ewigen und darum
deutlich und in allen Einzelheiten sichtbar», MAX PICARD, Das Menschengesicht,
cit., p. 137.
39 «Darum hören die Bilder nie auf, einem neu zu sein, weil das Bild nie aufhört,
das Urbild zu fragen, und die immer gleiche Antwort des Urbildes ist unausdeutbar», MAX PICARD, «Bild und Pseudobild», cit., p. 104
40 «Das Gesicht ist Erscheinung, Bild, es schwebt über die Gestalt des Menschen,
es ist losgelöst, bereit, dass es abgeholt werde. Und das Bild, das leicht ist und
schwebt, drückt nicht auf das Innere, Innen und Aussen bleiben distanziert voneinander: die Bildhaftigkeit ist die formale Basis für die Freiheit des Innern vom Äusseren», MAX PICARD, Die Grenzen der Physiognomik, cit., p. 45.
41 «Das Schweigen ist wie ein Organ im Menschengesicht. Nicht nur die Augen
und der Mund und die Stirne sind im Gesicht, sondern auch das Schweigen. Es ist
überall im Gesicht, es ist die Unterlage jedes Teiles», MAX PICARD, Die Welt des
Schweigens, cit., p. 97 [ital. cit. p. 91]
42 «In ener Welt, in der das Schweigen wirkt, ist in Ding mehr mit dem Schweigen
verbunden als mit einem anderen Ding. Es ist mehr für sich da, es gehört mehr
sich selbst, als ein Ding in der Welt ohne Schweigen, wo Ding nur mit Ding zusammenhängt», MAX PICARD, op. cit., p. 77.
43 «Das Menschengesicht ist viel mehr Gott hingehalten als den Menschen, es ist
zuallererst Antwort an Gott, es antwortet dem Schöpfer. Diese Antwort geschieht
69
im Schweigen. Alles im Gesicht richtet sich darnach. Das Gesicht ist nur in dem
Masse laut und deutlich zu den Menschen hin, als die Antwort an Gott, das Schweigen zu Gott hin, es erlaubt. Die Deutlichkeit und Lautheit zu den Menschen hin ist
diesem Schweigen untergeordnet», MAX PICARD, Die Grenzen der Physiognomik,
cit., p. 13
50 In tedesco la «grenzerhaltende deontologische Schutzhülle», JÜRGEN HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, a c. di Leonardo Ceppa, Einaudi, Torino 2002, p. 83.
44 Anche per questo si è potuto presentare Picard come un innovatore della fisiognomica, cfr. Schmölders, Claudia, Das Vorurteil im Leibe. Eine Einführung in die
Physiognomik, Akademie Verlag, Berlino 1995, p. 33.
52 «Wie ein Wunder erscheint es, dass der Mensch noch von Konturen begrenzt
ist und dass er von seinen eigenen Möglichkeiten nicht zersprengt wird», MAX PICARD, Die Flucht vor Gott, Eugen Rensch Verlag, Zürich 1934, p. 22 [trad. nostra].
51 «Wir sind der Dinge ledig, ehe sie unser sind».
45 «Essi [gli uomini] non sono semplicemente la loro natura, la loro natura è qualcosa che essi possiedono. E questo possedere è il loro essere […] Non accade qualcosa attraverso di esse [le persone], come nelle altre cose, ma esse agiscono in rapporto a se stesse. Il che significa: esse sono libere», SPAEMAN, ROBERT, Persone. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno", a c. di L. Allodi, Laterza, Bari-Roma
2005, pp. 32-33 [ed. orig. Personen. Versuche über den Unterschied zwischen "etwas" und "jemand", Stuttgart 1996].
46 «Le silence est banni des écrans, banni de la communication. Les images médiatiques (et les textes médiatiques sont comme les images) ne se taisent jamais: images et messages doivent se succéder sans discontinuité», JEAN BAUDRILLARD,
La transparence du mal. Essai sur les phénomènes extrêmes, Galilée, Paris 1990,
p. 20.
47 In questo senso, benché mirato ad altre finalità, va anche l'invito rivolto da UMBERTO ECO nel suo discorso al convegno 2009 dell'Associazione Italiana di Semiotica intitolato «Veline e silenzio», ora in IDEM, Costruire il nemico e altri scritti
occasionali, Bompiani, Milano 2011, pp. 207-215.
48 MAX PICARD, Il mondo del silenzio, cit., p. 154: «La parola che invece nasce
dal silenzio muove dal silenzio verso la parola per poi ritornare nel silenzio e da
questo verso una nuova parola e ancora di nuovo al silenzio e così via, di modo che
la parola proviene sempre dal centro del silenzio: il flusso della frase è sempre interrotto dal silenzio e sempre la verticalità del silenzio urta contro l'orizzontalità del
flusso della frase e l'interrompe».
49 MONIQUE ATLAN, ROGER-POL DROIT, Humain. Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, Flammarion, Paris 2012, p. 16 [trad.
nostra].
70
Relatori del ciclo di incontri e autori dei testi
Almo Collegio Borromeo, Pavia
PENSARE LA DIGNITA’ UMANA
martedì 27 marzo 2012, ore 21
PAOLO BECCHI, Università degli Studi di Genova
La dignità umana e l’ordinamento giuridico italiano
martedì 3 aprile 2012, ore 21
GIOVANNI GASPARINI, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dignità umana e bellezza
martedì 17 aprile 2012, ore 21
MARKUS KRIENKE, Facoltà teologica di Lugano
Dignità umana e bene comune
martedì 8 maggio 2012, ore 21
MARIA ZANICHELLI, Università degli Studi di Parma
Dignità umana e disabilità
martedì 15 maggio 2012, ore 21
JEAN-LUC EGGER, Giurilinguista e saggista - Berna
Dignità umana e silenzio
lxxi