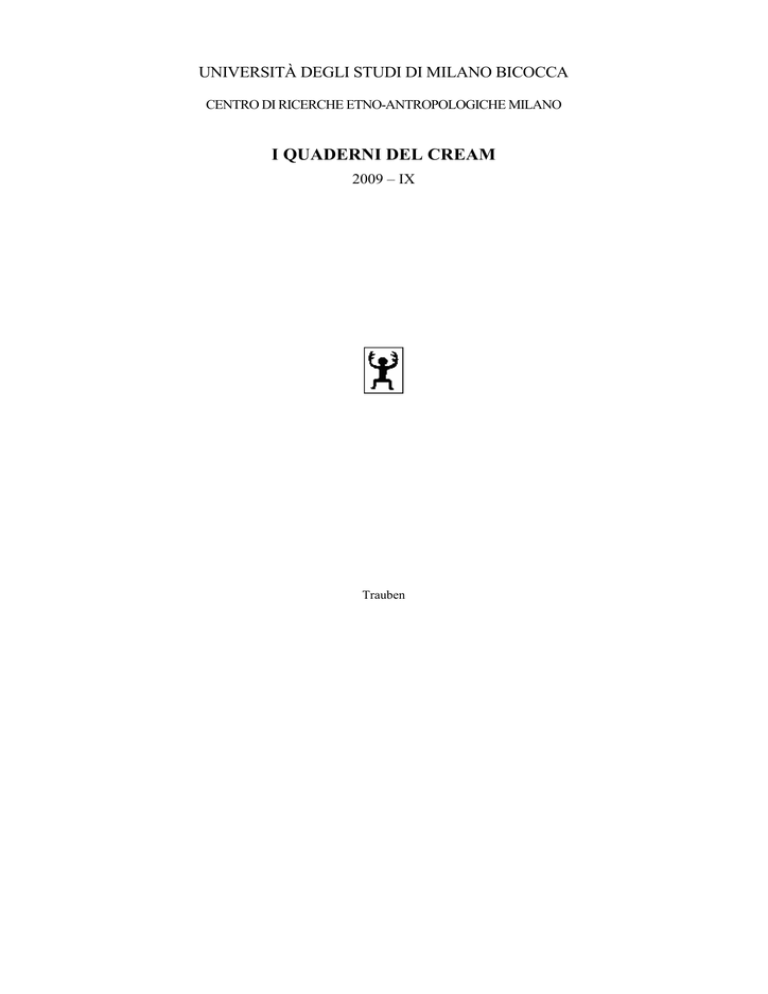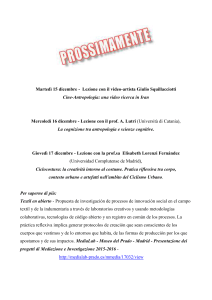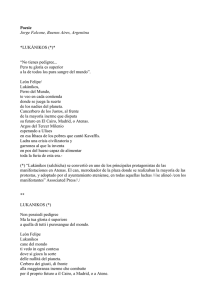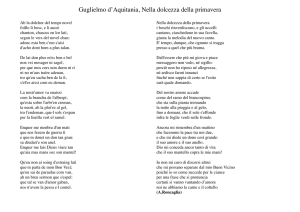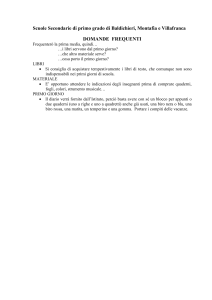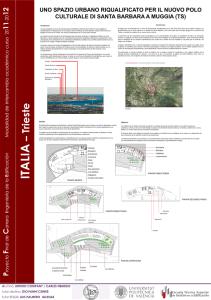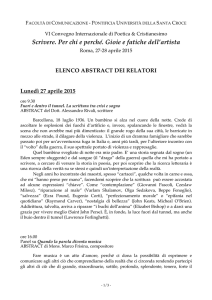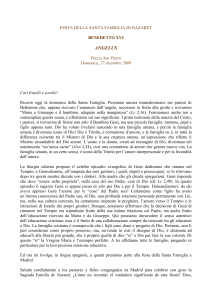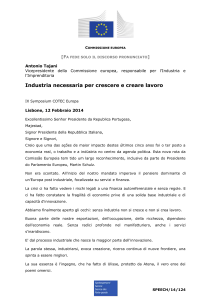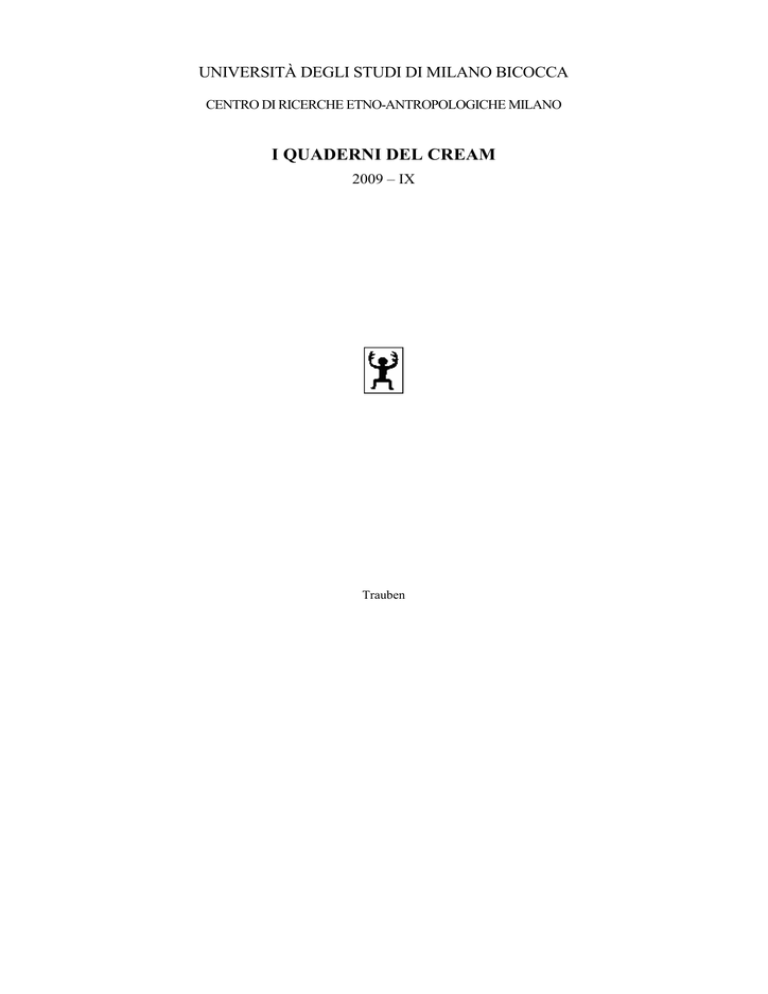
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
CENTRO DI RICERCHE ETNO-ANTROPOLOGICHE MILANO
I QUADERNI DEL CREAM
2009 – IX
Trauben
I quaderni del CREAM sono una pubblicazione a cura del Centro di Ricerche Etno-Antropologiche dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Raccolgono articoli, note, recensioni e testi di conferenze e seminari tenuti nell’ambito delle attività del Centro e delle iniziative ad esso
collegate: Corso di Laurea Specialistica in Scienze Atropologiche ed Etnologiche, Dottorato in Antropologia della Contemporaneità (DAC),
Corso di Perfezionamento in Antropologia Culturale (COPAC), Laboratorio di Antropologia Visiva (LAV), Seminario di Antropologia del
Medio Oriente e del Mondo Musulmano (SAMOMU), Seminario di Atropologia Teorica (SAT).
Unidea-UniCredit Foundation, nell'ambito del proprio impegno nel
campo della ricerca, sostiene le attività del CREAM.
Direttore Roberto Malighetti
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 'Riccardo Massa'
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1
20126 Milano
© 2009 Trauben editrice s.a.s
via Plana 1 – 10123 Torino
fax 011.837193
www.trauben.it
ISSN 1970-867X
I quaderni del CREAM , 2009, IX
Indice
5
Ugo Fabietti, Diversità delle culture e disagio della contemporaneità
21
Antonino Colajanni, Lo sviluppo visto dalle periferie del mondo.
Analisi antropologiche delle nozioni locali dello sviluppo
31
Sebastião Moreira Duarte, Odorico Mendes e l’identità europea del
Brasile
45
Roberto Malighetti, Regimi multiculturali e pratiche di cittadinanza
67
Silvia Barberani, L'incontro turistico tra equivoci e malintesi
89
María Elizabeth Alejandrina Domínguez Ángel, Tradición y
globalización. ¿Consumismo en el carnaval de Chiautempan, Tlaxcala?
109
Manuela Tassan, Categorie a confronto: ‘natura’ e ‘ambiente’ nel dibattito antropologico
135
Matteo Canevari, Figure dell’ibridazione e figure del nulla. Georges
Bataille tra etnografia e nichilismo
I quaderni del CREAM , 2009, IX
UGO FABIETTI
DIVERSITÀ DELLE CULTURE
E DISAGIO DELLA CONTEMPORANEITÀ
1
Signor Ministro, Magnifico Rettore, gentili ospiti, colleghe e colleghi,
componenti tutte di questa Università, cari studenti. Che un docente di
antropologia sia stato chiamato a tenere la prolusione di apertura dell’Anno Accademico in occasione del decennale della nostra fondazione è, oltre che ovvio motivo di soddisfazione per coloro che a tale disciplina si dedicano, e per la Facoltà di Scienze della Formazione
presso cui lavorano, anche segno che la comunità degli studiosi di
questo Ateneo si è mostrata disposta a riconoscere all’antropologia
culturale una dignità pari a quella di altri saperi, dal profilo forse più
netto e dal prestigio sicuramente più antico. Perciò ringrazio quanti, e
tra questi in primo luogo il Magnifico Rettore, hanno voluto rivolgere
quest’invito a un antropologo, un onore tutt’altro che frequente nella
tradizione accademica del nostro Paese.
È dal punto di vista dell’antropologia culturale che intendo dunque
affrontare, nel tempo concessomi, una questione che non sempre sembra poter essere ricondotta entro i termini della ragionevolezza.
Si tratta della diversità culturale nel suo intreccio con le molteplici
facce della contemporaneità, un tema che in una istituzione preposta
alla produzione e alla trasmissione del sapere dovrebbe far parte del
“brusìo etico di fondo” per quanti, pur da angolature disciplinari molto
1
Prolusione del 26 novembre 2007 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca
per l’apertura dell’anno accademico 2007-2008 nell’occasione del decennale della
fondazione dell’Ateneo.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
5
differenti, hanno il compito di “orientare” le giovani generazioni nel
mondo presente e, possibilmente, a venire.
Questo mondo – si dice oggi un po’ ovunque – si presenta non solo
come frammentario, mutevole, incerto e globale (indipendentemente
da ciò che si possa pensare di tutte queste cose), ma anche popolato
sempre più di “sensibilità diverse in inevitabile contatto” capaci di generare ombre, idoli e spettri che, come avete tutti potuto verificare in
maniera sempre più frequente e drammatica in questi ultimi anni, si
sono rivelati difficilmente esorcizzabili con una fede cieca nella miracolosità delle leggi del mercato, così come con l’adozione di ricette
politiche fondate su ideologie male assortite. Lasciando da parte le
ombre e gli idoli, mi concentrerò sugli spettri.
Uno di questi spettri si aggira oggi non solo per l’Europa, ma nel
mondo intero, ed è lo spettro della diversità culturale. Lo spettro naturalmente non è la diversità culturale in quanto tale, una cosa tanto reale quanto la pioggia o un quadro di Leonardo, bensì ciò che gli esseri
umani immaginano che essa sia. Come tutti gli spettri degni di questo
nome, anche il nostro fa le sue apparizioni in maniera sporadica ma
improvvisa e spesso devastante, portando con sé sconcerto, ansia, rifiuto, paura, rabbia e violenza. Non si tratta di un fatto esclusivamente
occidentale, ma planetario. Lo spettro sembra infatti essere sempre più
ubiquo.
Due paradossi paiono tuttavia legarsi alla questione della diversità
culturale percepita come fonte di inquietudine.
Il primo paradosso, tutto sommato banale, è che se la diversità culturale è un problema, dovrebbe esserlo sempre, dal momento che ciascuno di noi la sperimenta nel punto stesso in cui finisce la propria
pelle. Bisognerebbe essere infatti capaci di dire dove finisce una cultura e dove ne comincia un’altra.
Il secondo paradosso, più carico di implicazioni, si fonda tanto su
un postulato antropologico ragionevole quanto su una constatazione di
fatto. Il postulato è che se è vero, come sosteneva Wittgenstein, che
noi abitiamo un mondo costruito attraverso il nostro linguaggio, allora
noi agiamo, pensiamo, immaginiamo secondo l’uso specifico di quel
linguaggio particolare.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
6
La constatazione di fatto, invece, è che il numero di questi linguaggi si è ridotto e va riducendosi a una velocità impressionante. C’è
ragione di credere che le circa seimila lingue parlate oggi sulla Terra
siano la metà di quelle parlate fino a due secoli fa. E sembra anche che
le seimila lingue di oggi siano destinate a ridursi a tremila entro la fine
di questo secolo. Se a ciò si aggiunge che la popolazione mondiale ha
superato i sei miliardi di individui nel 2000 e salirà a otto tra circa
vent’anni, la riduzione della diversità linguistica e culturale acquista
dimensioni ancor più macroscopiche. Di questa tendenza la maggior
parte di noi ha un’impressione sfocata quando guarda immagini di paesaggi urbani e di umanità apparentemente sempre più uniformi, e
quando rileva l’uso sempre più planetario di una lingua veicolare come l’inglese globale (il cosiddetto globenglish).
Di fronte a questi paradossi le domande che ci dovremmo porre
sono allora: qual è la soglia, se non è la nostra pelle, oltre la quale la
diversità culturale comincia a “costituire un problema”? E perché la
diversità culturale pare costituire un problema proprio quando sembra
che vada riducendosi rapidamente ?
Un tentativo di risposta a queste domande può venire dalla considerazione sia della natura della contemporaneità, sia della forma specifica che la diversità culturale assume in relazione alla contemporaneità medesima.
“Contemporaneo” è, per definizione, tutto quanto riguarda l’oggi e
si situa in una specie di contiguità esistenziale con il nostro Io.
Non c’è dubbio che questa percezione possa variare da un individuo all’altro, da un gruppo all’altro, ma le parole “contemporaneo” e
“contemporaneità” appartengono al linguaggio con cui noi cerchiamo
di dire, di trasmettere la nostra sensazione di attualità.
L’idea di contemporaneità tuttavia, se ricondotta esclusivamente a
ciò che comunemente si intende – cioè l’oggi, l’orizzonte attuale del
nostro mondo – non esaurisce il significato del concetto a cui tale idea
vorrebbe rimandare. Siamo spesso sorpresi dal carattere rapido e continuo delle mutazioni del mondo attuale: tuttavia queste mutazioni non
ci sembrerebbero tanto rapide se non le registrassimo altrettanto rapidamente.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
7
Queste mutazioni, unitamente alla rapidità con cui le apprendiamo,
fanno somigliare il mondo attuale più a un caleidoscopio in continua
rotazione che non a un cannocchiale ben piantato attraverso cui guardare verso obiettivi futuri. È infatti proprio grazie a questa velocità
con cui apprendiamo un mondo che muta velocemente che noi costruiamo la percezione della realtà circostante.
Apprendiamo questa contemporaneità sulla base di due fattori principali. Uno è la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa; l’altro sono le migrazioni di massa. Se grazie ai mezzi di comunicazione
sperimentiamo quanto sia “veloce” questo nostro mondo nel “venire
verso di noi” in tempo, come si dice, reale, per effetto delle migrazioni
di massa sperimentiamo direttamente la diversità culturale.
Nei medesimi spazi urbani e in un numero crescente degli spazi
sociali che frequentiamo, incrociamo sempre più corpi che portano su
di sé il segno della differenza, che portano con sé storie e memorie
cresciute nella reciproca lontananza, e tuttavia oggi sempre più “costrette” ad incontrarsi. Portano l’eco di mondi fino a un’epoca recente
remoti, dove il corpo può essere una cosa da nascondere o da esibire,
ma dove esso significa sempre e comunque qualcosa, perché il corpo
porta con sé la marca dell’identità. Come scrisse Merleau-Ponty giusto
mezzo secolo fa, “dire che ho un corpo è una maniera per dire che
posso essere visto come un oggetto, ma anche che cerco di essere visto
come un soggetto”.
Percepire la diversità culturale anche solo attraverso un contatto visivo è sempre qualcosa che lascia largo spazio all’immaginazione. Ma
l’elaborazione di questa immaginazione non è lasciata interamente al
soggetto che percepisce. Anziché venire elaborata attraverso uno sviluppo di relazioni concrete, tale rappresentazione è “filtrata” dai media, i quali provvedono a costruire la diversità in base a procedure visive e linguistiche che non sono né “neutre” né “neutrali” e che, proprio per questa ragione, producono esiti particolari. Senza evocare
l’immagine di popoli esotici, ma rimanendo sul terreno del nostro
quotidiano, basterà riflettere soltanto su come queste rappresentazioni
mediatiche della diversità si fondino per lo più su una stereotipizzazione che prende le mosse dal fenomeno della devianza. L’eco suscitato
recentemente da alcuni tragici fatti di cronaca di cui sono stati prota-
I quaderni del CREAM , 2009, IX
8
gonisti cittadini di altre nazionalità e di altre “culture”, ha costituito la
base per spontanee generalizzazioni suscettibili di farci vedere nell’altro – il diverso da noi – un soggetto ostile. Mentre non sempre ci
rendiamo conto che, sul versante opposto, certe idee e certi comportamenti considerati come “occidentali” da altri osservatori possono
provvedere, come di fatto provvedono, il materiale adeguato per la
plasmazione di rappresentazioni di “noi” che sono altrettanto stereotipate in senso negativo.
Entrano così a far parte del nostro mondo attuale non solo fatti e
eventi, ma anche forme di sensibilità estetica, morale, religiosa spesso
tanto diverse tra loro quanto ciascuna di esse differisce dalle nostre.
Ma vi entrano secondo modalità che sono specifiche della nostra contemporaneità, modalità che tendono a trasformare tutte quelle realtà in
elementi potenzialmente costitutivi del disagio del nostro tempo.
L’idea di contemporaneità acquista allora un significato aggiuntivo
che completa quelli di “odierno” e di “attuale”: il significato di una realtà in cui tutto incide potenzialmente sul qui e sull’altrove. L’idea di
contemporaneità esprime, in questo senso, la forma comunicativa dominante nella “condizione post-moderna” – se quest’ultima espressione ha un significato preciso – poiché è proprio oggi che, attraverso
il fattore della simultaneità noi stiamo vivendo, come ha fatto notare
Marc Augé, l’esperienza del restringimento dello spazio e della perdita del senso della profondità storica.
Le scienze umane e sociali hanno avuto la tendenza, negli ultimi
decenni, a invocare tre elementi fondamentali in cui leggere le ragioni
della post-modernità. Si tratta della cosiddetta fine delle “grandi narrazioni”; del supposto tramonto delle ideologie; e, infine, della progressiva rinuncia delle istituzioni ad assumersi la responsabilità di regolare
i processi che si riconoscono alla base dell’integrazione sociale, con la
conseguente delega di tale responsabilità a ciò che si è soliti definire
come “il privato”.
Fine delle grandi narrazioni, tramonto delle ideologie, delega di responsabilità. Credo che questi tre punti siano altrettanti elementi da
considerare se si vuole comprendere in maniera non superficiale il
senso di disagio suscitato spesso, soprattutto in certi ambienti, dall’incontro con la diversità culturale.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
9
Si dice che le grandi narrazioni che hanno ispirato per circa due secoli tanto le elite politiche quanto le masse occidentali, e non solo, sono tramontate: l’inarrestabile avanzata della civiltà, la fiducia nel progresso, l’immortalità della nazione, il trionfo della scienza, lo sviluppo, la marcia verso una società di uguali. Ma non sempre si riconosce
che altre narrazioni hanno preso il posto di quelle di un tempo. Se la
storia appariva una volta come una traiettoria destinata a realizzare il
destino positivo dell’Uomo (la metafora del cannocchiale), è arrivata
“la fine della storia” di Francis Fukuyama; se l’immaginazione filosofico-politica aveva potuto prospettare l’avvento di una fratellanza planetaria, lo “scontro di civiltà” prospettato da Samuel Huntington sembra, per alcuni, averla non solo smentita, ma addirtitura rimpiazzata. E
mentre una volta, nonostante tutto, si era forse più attenti di oggi
all’agire umano nelle situazioni concrete e al complesso delle condizioni storiche che tale agire determinano, oggi alcuni importanti commentatori mediatici di politica internazionale ci parlano dell’“Anarchia
prossima ventura” (Robert Kaplan) o degli Stati Uniti nelle vesti di
Marte guerriero e dell’Europa nelle vesti di Venere amorevole, la cui
remissività rischia di compromettere la sacrosanta missione ordinatrice
del suo nerboruto olimpico collega (David Kagan).
Metafore, semplici metafore, potrebbe dire qualcuno. Certo, ma a
parte il fatto che le metafore sono, come ha spiegato George Lakoff,
“ciò che ci fa vivere”, perché è attraverso di esse che leggiamo il mondo (più di quanto comunemente non siamo disposti a credere), queste
particolari metafore sono usate da figure oggi estremamente influenti
sul piano mediatico, e anche da coloro che, nel mondo, le rilanciano
sui giornali, alla radio e soprattutto nei talk show televisivi. E poiché
noi percepiamo, che lo vogliamo o no, il mondo contemporaneo soprattutto attraverso i media, queste metafore hanno un potere enorme
nel determinare il modo in cui noi guardiamo alla diversità culturale.
Che cosa sono, queste metafore, se non le parole chiave di nuove
narrazioni? L’anarchia che verrà ci viene presentata come la conseguenza inevitabile del tribalismo atavico dei popoli africani e asiatici;
lo scontro di civiltà sarebbe l’esito fatale dell’incontro tra culture fondate su principi religiosi differenti, mentre Marte e Venere impersonerebbero la risolutezza e l’esitazione rispettivamente con cui ameri-
I quaderni del CREAM , 2009, IX
10
cani ed europei sono “culturalmente orientati” nei confronti del “disordine” del mondo attuale.
Non è certo possibile discutere qui in dettaglio i limiti delle teorie
di questi opinionisti mediatici, in alcuni casi consiglieri politici molto
ascoltati, la cui autorevolezza si fonda però più che sulla conoscenza
dettagliata degli oggetti delle loro argomentazioni, sulla loro capacità
di nascondere la propria mancanza di conoscenze.
Questi “politologi in mongolfiera”, come li avrebbe chiamati volentieri Clifford Geertz, presentano poche e schematiche idee che si
fanno beffa delle sterminate conoscenze accumulate sulle culture e
sulle società del pianeta; conoscenze che, se prese in considerazione,
renderebbero assai più problematiche le affermazioni circa l’inevitabilità dello scontro di popoli con lingue, culture e religioni differenti, o
quelle sull’immutabilità delle culture, per non dire le argomentazioni
di chi prova a convincere i politici e lettori dei giornali che se i paesi
sottosviluppati sono tali è per via della loro “cultura”. Questi commentatori ed esperti, spesso nelle vesti di consiglieri governativi collocati
al centro del potere planetario, non prendono ovviamente in considerazione gli esempi storici di lunga convivenza tra comunità culturalmente
eterogenee; non riconoscono che le culture chiamate “tribali”, anziché
essere dei monoliti, sono composite, cambiano, e rivelano pluralità di
vedute, dibattiti e disaccordi anche al proprio interno; e sembrano voler
farci dimenticare che se i paesi sottosviluppati sono tali è perché le loro
risorse continuano ad essere prelevate (quasi sempre con la complicità
di una parte delle elite locali) a vantaggio dei paesi ricchi.
Questi commentatori sono i “moderni creatori di miti”, ossia individui che forniscono spiegazioni confortanti del perché le cose sono
come sono. Dal momento che si fondano quasi sempre su visioni stereotipate degli altri popoli, questi miti offuscano la nostra capacità di
pensare criticamente o di entrare in un rapporto di empatia con altri
esseri umani, con il risultato di legittimare lo status quo presso il
grande pubblico.
Ora, che cos’è un mito se non è una narrazione? Che cosa sono lo
scontro di civiltà, l’immobilità delle culture, il tribalismo “ancestrale”,
la povertà “culturalmente congenita” dei popoli poveri, se non le nuove narrazioni mediatiche della contemporaneità? Per la verità c’è
I quaderni del CREAM , 2009, IX
11
qualcosa che le distingue dalle narrazioni del passato. E questo qualcosa è che esse non hanno nulla di veramente “grande”.
Ed eccoci così arrivati al supposto tramonto delle ideologie, a cui
le narrazioni, grandi o piccole che siano, sono indissolubilmente legate.
Consideriamo un’idea centrale della nostra tradizione culturale, quella
che, secondo alcuni, ci fa “più occidentali” di tante altre: l’idea di democrazia. Inventata dagli antichi greci liberi esclusivamente a proprio
uso e consumo, ricevette sostanza e forma universale dall’illuminismo,
non diversamente da quelle di libertà, diritti dell’uomo, rappresentanza
politica, uguaglianza, ecc. Essa nacque da un travaglio storico-politicosociale che, nell’arco di svariati secoli, diede vita a pratiche individuali
e istituzioni collettive molto specifiche. Inoltre essa plasmò, proprio
come si direbbe nel caso di una fede religiosa o di una filosofia di vita
intensamente praticate, una nuova forma di coscienza.
Il colonialismo prima, e la globalizzazione poi hanno fatto sì che
questa idea di democrazia, e quelle ad essa correlate, viaggiassero per
il mondo. Che fine hanno fatto però queste idee, e quella di democrazia in particolare, una volta trasferite in contesti storico-culturali
diversi da quello da cui trassero origine?
Nonostante sembri che la diversità culturale si stia rapidamente riducendo, assistiamo oggi in realtà alla comparsa di una straordinaria
varietà di forme di comportamento e di stili espressivi che potrebbero
definirsi “ibridi”, se non fosse che questa parola rischia di rinviare ad
un’idea di purezza che, in materia di comportamenti e di modi di pensare, cioè di cultura, può essere esistita solo in un ideale mondo preadamitico. Riguardo alla idea di democrazia, questa, trasportata altrove,
è stata spesso declinata diversamente che in Occidente, dove per altro,
come ben sappiamo, non c’è sempre stato – e credo che non ci sia
nemmeno oggi – un accordo perfetto sulle modalità e le forme della
sua piena realizzazione. I movimenti sociali che si sono sviluppati un
po’ ovunque nel mondo in questi ultimi venti anni hanno per esempio
dato vita a forme di resistenza e di mobilitazione che si autodefiniscono democratiche, dove però il significato che tali movimenti attribuiscono a questo termine non è proprio identico a quello assegnatogli di
solito alle riunioni della Banca Mondiale o del Fondo Monetario Internazionale. Il significato che la parola democrazia può assumere tra
I quaderni del CREAM , 2009, IX
12
gli abitanti delle megalopoli asiatiche o sudamericane che tentano di
accedere a una risorsa vitale come l’acqua (spesso controllata da società di gestione private), o tra quanti rivendicano in Africa e altrove il
diritto di accedere a farmaci anti-AIDS a costi non esorbitanti, non è
quello che in alcuni discorsi politico-mediatici viene spesso associato
a una generica libertà individuale consistente nell’agire in vista dei
propri interessi.
È stato pertanto un errore storico difficilmente rimediabile quello
di chi “vedendo emigrare le nostre parole ha pensato di assistere alla
vittoria dei nostri miti” ma che, smentito dai fatti, ha ritenuto legittimo
imporre la “verità” dei propri miti con la forza, indignandosi poi di
fronte al fatto che avessero potuto verificarsi delle “reazioni”. Bastava
aver letto Balzac, il quale fa dire al suo “medico di campagna”, il dottor Benassis: “In fatto di civiltà – monsieur – nulla è assoluto […..]
bisogna consultare lo spirito di un paese, la sua situazione, le sue risorse, studiare il terreno, gli uomini e le cose, e non voler piantare le
vigne in Normandia”.
Queste osservazioni sull’intramontabilità delle narrazioni e delle
ideologie che sempre le accompagnano, ci portano a considerare infine il fenomeno della progressiva tendenza che le istituzioni mostrano,
in materia di responsabilità sociale, a delegare sempre più al settore
privato.
Come ha ben mostrato Zygmunt Bauman, questa tendenza non è,
checché ne dicano i suoi più accesi sostenitori, per nulla foriera di una
maggiore libertà individuale, ma piuttosto di un sempre più diffuso
timore generalizzato. In questa società, che Bauman definisce molto
appropriatamente “la società dell’incertezza”, gli individui scoprono
ogni giorno di più che i mezzi per sottrarsi all’imponderabilità del vivere sono affidati a soggetti mossi dalla logica del guadagno.
La tendenziale ritrazione da parte dello stato si è coniugata inoltre,
in questi ultimi anni, con una retorica della flessibilità e della professionalizzazione che, per le modalità in cui è stata attuata, sembra aver
generato gli effetti contrari a quelli che si proponeva: immobilismo
(per non dire arretramento) sociale, e perdita secca delle competenze,
tecniche e culturali.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
13
Tralascio qui gli effetti di questi nuovi scenari sul modo in cui la
soggettività individuale trova le forme della sua realizzazione, anche
se è facile immaginare quanta differenza possa passare tra un’identità
individuale costruita all’insegna di un “progetto di vita” plausibile, e
un’identità che deve invece ricostituirsi in base a continue dislocazioni
alla ricerca di “un centro di gravità permanente”. Emblematica, da
questo punto di vista, la realtà giovanile che, in un Paese come il nostro, vede appunto i giovani alle prese da un lato con disoccupazione,
sottoccupazione, precariato persistente e, dall’altro, con curricola di
studi i quali, non sempre e non ovunque sembrano accorciare i tempi
di una auspicabile autonomia.
Ma altri motivi contribuiscono a far sì che la contemporaneità venga avvertita come priva di centratura.
In questa società pervasa dal senso della frammentazione e dell’insicurezza da un lato, e dalla regolamentazione visibile o nascosta, esplicita o implicita, da parte di sistemi anonimi (pubblici e privati),
dall’altro, la presenza sempre più massiccia di individui “portatori” di
una qualche forma di “diversità culturale” viene a turbare sia il già
fragile mondo di chi è escluso dall’àgape consumistica, sia il quieto
vivere di chi, pur potendo godere della ricchezza prodotta da sé o da
altri, si sente assediato nella propria sicurezza e libertà d’azione. Specialmente quando la presenza di questa diversità si presenta sotto forma di devianza stereotipizzata.
Lo stesso Bauman, d’altronde, ha ritenuto di poter cogliere un elemento caratteristico della nostra epoca proprio nel differente atteggiamento che le società ricche tengono, rispetto al passato, nei confronti dello straniero. Il progetto della modernità, egli sostiene, è stato
quello di eliminare lo straniero o di ignorarlo. Il non-progetto della
post-modernità, invece, è quello di aver promosso l’assuefazione alla
sua presenza. Tale assuefazione non è certo il risultato di una apertura
disinteressata e solidale nei confronti della diversità culturale. È piuttosto un “riflesso strutturale” del quadro socio-economico complessivo
caratterizzato dalla flessibilità e dalla accentuata intercambiabilità dei
ruoli produttivi e, all’interno di questa dinamica, dalla necessità di reperire forza-lavoro in settori occupazionali lasciati vacanti dalla popolazione occidentale.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
14
Se la contemporaneità risulta “incerta” in quanto priva delle caratteristiche di una “attendibilità progettuale” che le epoche precedenti
sembravano, almeno idealmente, promettere, ora essa appare anche
costellata di diversità culturali che contribuiscono a incrementare la
sensazione di smarrimento e di “perdita del centro”.
La presenza dello straniero non è infatti solo un elemento strutturale della riproduzione sociale, e nemmeno un fenomeno limitato ai
paesi ricchi dell’Occidente. Masse di migranti e di rifugiati si riversano oggi quasi ovunque nel mondo, creando e ricreando continuamente
spazi di marginalità che si sommano a quelle già esistenti nei paesi di
arrivo. Le ragioni di questi spostamenti sono note: guerre, povertà, persecuzioni etniche, politiche e religiose, carestie ma anche, e forse soprattutto, il desiderio universalmente umano di cercare un luogo dove la
vita possa essere migliore, secondo il detto latino, ubi bene, ibi patria.
Ora, è proprio dal contributo che la politica e la cultura possono
dare alla realizzazione di questa antica massima che dipende, forse, la
possibilità di diradare, in futuro, le comparse del nostro spettro.
Se pensare la diversità culturale non è affidarsi passivamente alla
stereotipizzazione mediatica della devianza, né credere ciecamente alle narrazioni dei guru dell’immaginazione geopolitica contemporanea,
qual è allora l’atteggiamento con cui dobbiamo provare a disporci nei
suoi confronti?
Comprendere la diversità culturale non significa ricondurre quest’ultima ai rassicuranti schemi del nostro sistema categoriale, al nostro
“punto di vista”. L’applicazione di tali schemi ad altre forme di vita
culturale è problematica e, se pervicacemente e acriticamente perseguita (come purtroppo sembra essere in molti ambienti), destinata a
produrre “un deserto di fragorosi e conflittuali soliloqui”, dove ciascuno resta prigioniero del proprio monologo sentendosi autorizzato, come spesso infatti vediamo, a proclamare unilaterali, spavalde e intransigenti assunzioni di verità.
È stato fatto osservare che il mondo sociale non si articola più in
“trasparenti noi” da una parte, con cui possiamo facilmente dialogare
(per quante siano le differenze tra noi stessi), ed “insondabili loro”
dall’altra, con cui non potremmo condividere idee, valori e aspettative.
Infatti la differenza comincia, a ben guardare, proprio tra noi, e non si
I quaderni del CREAM , 2009, IX
15
esaurisce nella diversità fisica o delle nostre inclinazioni personali, ma
riguarda differenze di istruzione – quindi di linguaggio – di genere, di
classe, e quant’altro.
Se lo vogliamo, possiamo non essere sempre prigionieri delle nostre vedute, della nostra “cultura”; così come gli “altri”, se lo vogliono, possono non esserlo sempre della loro. È vero che la nostra immaginazione, come quella di tutti, è circoscritta da un linguaggio e che
questo linguaggio è, come abbiamo visto, costruito spesso da altri; ma
abbiamo pur sempre la possibilità di immaginare “oltre”, di espandere
questo linguaggio, come diceva Walter Benjamin, e grazie a ciò “allargare” il nostro orizzonte mentale, cercare di capire come gli altri ci
percepiscono e, così facendo, percepire meglio noi stessi in mezzo agli
altri. Cos’è, in fondo, la capacità di giudizio se non la possibilità, universalmente umana, di prendere le distanze da ciò che può apparire
scontato?
Quanti oggi temono il cosiddetto relativismo, ritengono che esso si
traduca nella perdita di qualunque possibilità di discernere tra cose
importanti e cose che non lo sono, tra vero e falso, tra bene e male, dal
momento che tutti i giudizi sarebbero sempre giudizi relativi a questo
o a quel criterio di valutazione derivante, a sua volta, dalla cultura
specifica di riferimento. Ma questo timore è, come ha scritto Clifford
Geertz parafrasando Shakespeare, “l’occhio dell’infanzia che teme un
diavolo dipinto”. La paura del relativismo ha infatti in larga misura
preparato l’ansia stessa di cui questa paura vive. Almeno per quanto
riguarda la vocazione della disciplina che qui rappresento, cercare di
comprendere la diversità culturale non significa giustificare pratiche e
atti che sono all’origine di sofferenze umane, ma non significa nemmeno ritenere che se qualcuno non crede nel mio Dio è sicuramente
perché crede nel mio diavolo.
Nessuno si sogna di rimanere indifferente, credo, alle mutilazioni
genitali femminili o allo sterminio dei nativi americani ritenendo che
tutto sommato siano cose riconducibili allo “spirito culturale” (per non
dire religioso) di coloro che compiono o hanno compiuto questi atti
rispettivamente. Così come si può rimanere sorpresi alla vista di una
donna musulmana che, di fonte alla condanna a trent’anni di reclusione del proprio marito colpevole di aver ucciso la propria figlia perché
I quaderni del CREAM , 2009, IX
16
protesa alla propria integrazione nella società in cui è cresciuta (ubi
bene, ibi patria), reagisce assumendo comportamenti autolesionistici.
Ma sarebbe davvero superficiale identificare una simile reazione come
un rifiuto culturale (per non dire religioso) del verdetto medesimo, e
non considerare invece quanta disperazione, certo culturalmente costruita, cioè elaborata, interiorizzata, ed esibita, possa esserci in chi
vede a una tragedia aggiungersene un’altra, personale, familiare e anche sociale.
Comprendere la diversità culturale significa individuarla come tale
e coglierla nella logica che le è propria; ma significa anche sapere che
questa diversità vuole sempre, in un modo o nell’altro, sentirsi riconosciuta. Se tentare di comprendere la diversità significa considerarla
senza ricondurla a una versione imperfetta o deviata del noi, resta il
problema di decidere se con questa diversità vogliamo dialogare oppure no. L’alternativa è chiara, come credo sia anche la risposta. Se non
vogliamo sprofondare nel deserto dei fragorosi e conflittuali soliloqui
dobbiamo “ragionare”, e quando si tratta di questioni morali “ragionare”, come ha osservato il filosofo Charles Taylor, significa sempre ragionare con qualcuno. E quando ragioniamo con qualcuno che non
appartiene al nostro orizzonte culturale – come gli antropologi sanno
per esperienza diretta – non ragioniamo nel vuoto, come “se stessimo
parlando con qualcuno che non riconosce alcun imperativo morale”.
Quando abbiamo un interlocutore dobbiamo compiere quindi uno sforzo in direzione di una ricerca di parametri non necessariamente identici,
ma dal cui confronto possa scaturire un’auspicabile compatibilità.
È proprio su questa auspicabile e non impossibile compatibilità che
va giocata una politica dell’integrazione equilibrata sostenuta da misure di tipo giuridico e istituzionale che, da un lato, consentano una convivenza rispettosa ma non autorinunciataria da parte di alcuno della
propria identità e della propria tradizione e, dall’altro, precludano derive marginalizzanti, gerarchizzanti o addirittura xenofobe.
Non si riesce mai completamente nell’impresa di comprendere la
diversità culturale – e gli antropologi lo sanno per primi – ma sono le
ragioni del mondo che ci dovrebbero persuadere dell’opportunità di
questo sforzo. Quello che poteva sembrare una volta una curiosa vocazione di pochi – gli antropologi – consistente nell’andare laggiù per
I quaderni del CREAM , 2009, IX
17
capire il punto di vista degli altri, e del loro modo di vedere il loro
proprio mondo mettendosi all’interno del loro stesso mondo, oggi si
impone, seppure in termini diversi, ormai a noi tutti anche qui da noi.
A livello personale e privato, perché il sociale contemporaneo lo rende
necessario, circondati come siamo dalla diversità culturale nel nostro
quotidiano; ma anche a livello pubblico e sociale perché una politica
che non percorresse questa strada rischierebbe non solo di divenire
sempre più autoreferenziale, ma anche di lasciare questi temi di capitale importanza comune alla mercé di rozze contrapposizioni. L’orizzonte politico del nostro tempo non può più permettersi di interpretare
la natura culturalmente diversa e complessa della contemporaneità attraverso letture datate, né tantomeno occultarla o, che è peggio, aggredirla mediaticamente con furoreggianti proclami populistici.
Al tempo stesso, l’impegno culturale del nostro tempo non può più
trincerarsi dietro olimpici sguardi “da lontano”. Cultura e politica devono sentirsi chiamate a uno sforzo di ripensamento della contemporaneità eticamente plausibile per le diverse componenti dello scenario
planetario. Quella che qui abbiamo definito contemporaneità ha e avrà
sempre più il potere di farci percepire le differenze dove prima non
avvertivamo che delle somiglianze, e di farci avvertire delle somiglianze dove percepivamo soltanto delle differenze. Mentre sono le distanze tra i termini “noi” e “loro”, “qui” e “laggiù” e anche “somiglianza” e “differenza” – che ora, in questa contemporaneità delle percezioni
e dei vissuti culturali, stanno assumendo nuove forme e nuovi significati. Mondi come quello cinese o giapponese, ad esempio, che parevano immersi in una lontananza avviluppata nelle suggestioni dell’orientalismo, si vanno avvicinando a noi a motivo di altre suggestioni
(quelle del mercato) che tuttavia non potranno, da sole, prendere il posto delle prime, ormai demolite dalla critica post-coloniale. Né ci pare
allettante l’idea di restare in possesso, come solo modo di conoscere la
diversità culturale, delle immagini di improbabili mondi esotici forniteci dall’industria del turismo globale.
Se nel mondo di oggi l’antropologia ha un qualche ruolo, questo è
lo stesso che ha avuto ai suoi esordi: cercare di comprendere la diversità culturale per quello che è, e non per quello che spesso ci si immagina che essa sia. Per questo l’antropologia merita di essere ascoltata,
I quaderni del CREAM , 2009, IX
18
come spero sia avvenuto oggi in questa occasione. Questo non significa che domani accadranno miracoli, ma dobbiamo fare tutto il
possibile per sottrarre i discorsi sulla diversità culturale alle facili dicotomie, alle rozze stereotipizzazioni e alle scellerate contrapposizioni
spesso strumentali, le quali non contribuiscono certamente a farci
comprendere la diversità e il mondo attuale, quanto piuttosto a presentarceli entrambi come tenebrosi, proprio come quel “cuore di tenebra”
del romanzo conradiano, che era al tempo stesso oscuro, cioè ignoto e,
proprio perché ignoto, maledetto.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
19
ANTONINO COLAJANNI
LO SVILUPPO
VISTO DALLE PERIFERIE DEL MONDO.
ANALISI ANTROPOLOGICHE
DELLE NOZIONI LOCALI DELLO SVILUPPO
Quello dello sviluppo è un processo planetario iniziato in Occidente
più di un secolo fa e che oggi invade i discorsi quotidiani di politici,
riformatori, uomini comuni. E nelle periferie del mondo costituisce
un’aspirazione quotidiana, un sogno ricorrente, che si accompagna all’ammirazione per le società ricche dell’Occidente, che si vorrebbero
imitare acquisendo le tecnologie avanzate, l’abbondanza di risorse finanziarie da investire, l’organizzazione del lavoro, la capacità di costruire sistemi industriali. Un sogno ricorrente che si presenta spesso
come il desiderio di vedere realizzato il “Regno dell’Abbondanza”.
Ma, come si sa, la povertà e la distanza tra sistemi economici ricchi
e sistemi poveri o a limitata produttività, è un fatto, che continuiamo a
osservare impotenti, nonostante le periodiche ed enfatiche dichiarazioni di politici e tecnici sulla prossima “fine della povertà”. L’ottimismo dei primi anni del dopoguerra (quando fu inventata, creata e resa
operativa, la irriducibile differenza tra “popoli sviluppati” e “popoli
sottosviluppati”) ha cominciato a diminuire negli ultimi decenni e la
sicurezza di una volta si attenua sempre di più. Sull’inefficacia dell’aiuto allo sviluppo o sulle posizioni critiche e autocritiche c’è ormai
una letteratura sterminata. Pare insomma che lo sviluppo (un curioso e
complesso processo, una “scelta storica” verificatasi in Occidente dopo lunghi decenni di prove e sperimentazioni) non sia facilmente “esportabile” al di fuori dei confini delle società ricche e tecnologicamente avanzate.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
21
Sequela tardiva e circospetta delle imprese coloniali che hanno caratterizzato il mondo a partire dalla metà dell’Ottocento, l’era dello
sviluppo ne è in buona misura la continuazione, anche se il vecchio
controllo militare e politico dei paesi marginali da parte delle potenze
europee e americane è stato lentamente sostituito con il controllo economico. Nella prima fase di entusiastica espansione delle idee e delle
pratiche dello sviluppo, attraverso investimenti partiti dai paesi ricchi,
che avrebbero dovuto produrre risparmi e re-investimenti, accompagnati da trasferimenti di tecnologie e di know-how, di fatto le imprese
dello sviluppo hanno favorito la creazione di élite politico-economiche
locali, rafforzato forme diverse di dipendenza, diffuso modelli di vita
occidentali, e soprattutto generato un immenso deposito di consumatori. Ma presto è venuta l’epoca delle critiche e dei dubbi. La lenta diffusione dei dubbi e dei correttivi critici ha seminato incertezze, che
per primo il Rapporto Pearson (1969) aveva in parte identificate. Poi
venne il Rapporto Brandt (1973) e il Rapporto del Club di Roma,
quindi tutte le attenuazioni del concetto prima sicuro e autonomo e
presuntuoso dello Sviluppo con aggettivi che ne frenavano in buona
misura l’ambizione e la sicurezza (“Sviluppo Sostenibile”, “Sviluppo
Umano”, “Sviluppo Sociale” “Sviluppo Partecipativo”, “Auto-sviluppo”), e infine la proposta di concetti che limitavano fortemente le sue
capacità creative e positive, come “Esclusione Sociale” (vista come necessaria conseguenza diretta dello sviluppo), e così via. È apparso
chiaro ormai da tempo, insomma, che quello dello sviluppo è tutto
meno che un concetto-processo universalistico, una “necessità storica”
di tutte le società, un passo obbligato della storia dell’umanità, nel
quale l’Occidente è solo il capofila, l’avanguardia. Lo sviluppo appare
a molti ormai come una proiezione planetaria, necessitata, degli interessi vitali, delle logiche, delle grammatiche e delle retoriche, delle
società ricche dell’Occidente. Un modello di vita e di necessità storiche che serve soprattutto a chi l’ha inventato.
Certo, non si può negare che ancora oggi la gigantesca industria internazionale dello sviluppo sia al lavoro incessantemente, coinvolgendo investimenti multimiliardari e un impressionante apparato istituzionale (FAO, Banca Mondiale, PNUD, IFAD, UNICEF, UNESCO,
OMS, e così via), nonché un numero enorme di tecnici specializzati
I quaderni del CREAM , 2009, IX
22
(più di 300.000) che vanno in giro per il mondo a predicare (oggi con
sempre minore sicurezza) il vangelo della crescita economica, della
sempre maggiore produzione, delle grandi infrastrutture (oggi si torna
a parlare della necessità di potenziare l’agricoltura, la formazione e la
salute delle società meno fortunate, ma decenni or sono si parlava dello sviluppo come consistente soprattutto nella costruzione di grandi
infrastrutture come ponti, dighe, strade, strade ferrate, sistemi industriali chiavi in mano, e così via). Il cambiamento nel linguaggio dello
sviluppo non si può negarlo, qualcosa si muove con sempre maggiore
energia. Innanzitutto, la diffusione delle posizioni “anti-sviluppiste” e
critiche (primo fra tutti il nostro Wolfgang Sachs e l’Istituto Wupperthal, ma non solo lui) che vengono da intellettuali di punta dell’Occidente; poi, l’intervento critico corrosivo di gruppi e organizzazioni del
mondo rurale e indigeno di alcuni paesi di quello che una volta si definiva “Terzo Mondo”, che hanno identificato gli interessi, le retoriche
e le ipocrisie che spesso si accompagnano alle iniziative di sviluppo;
infine, un progressivo spostamento dei fondi internazionali dalle iniziative di promozione economica e sociale delle popolazioni povere
alle situazioni di “emergenza”, conflict-resolution e peace-keeping,
determinate da guerre locali, disastri, spostamenti di popolazione, carestie. E in generale, si può dire che, lentamente, anche nei centri di
elaborazione e di decisione delle politiche dello sviluppo, l’impostazione strettamente tecnico-economica (“cambia l’economia e il resto
seguirà!”) sta per essere sostituita da una visione più ampia, che concede sempre più spazio a fattori imponderabili, agli aspetti socioculturali; una visione “olistica”, che considera i processi di cambiamento come processi complessi, a più dimensioni, nei quali l’economia e la tecnica non sono che due delle dimensioni di fondo, ma che
non esauriscono il quadro. Basterebbe esaminare con cura alcune recenti pubblicazioni della Banca Mondiale dedicate al tema “Cultura e
Sviluppo”, i lavori della Commissione sulla Cultura e lo Sviluppo
dell’UNESCO, le pubblicazioni della Interamerican Development
Bank sugli aspetti sociali e culturali della povertà in America Latina, i
documenti del progetto internazionale “Research on Agriculture” della
FAO, infine i progetti dell’IFAD tra le popolazioni indigene dell’America Latina, per farsene un’idea.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
23
* * *
Proviamo però a capovolgere il punto di vista sullo sviluppo. Non
più soffermandoci sulle idee specifiche, sulle pratiche e le strategie
d’azione, sui movimenti economici e sulle giustificazioni teoricoideologiche di chi l’ha inventato, nel centro del mondo, ma partendo
dalle idee, dalle percezioni e valutazioni, dalle scelte esplicite ed implicite, dal modo di riceverlo e di reagire alle sue proposte, che si sono
manifestati nelle società marginali del mondo contemporaneo. Insomma, proviamo a “vedere lo sviluppo dall’altra parte”, dalla parte di
chi lo riceve, lo subisce, deve fare i conti con esso.
Innanzitutto, vale la pena di cominciare identificando – già all’interno della macchina teorico-pratica che gestisce l’intero fenomeno –
una serie di gradini, una serie di derive, che vanno dai centri di pensiero dell’economia mondiale (le grandi università con i grandi libri di
economia, i grandi documenti politici delle assise internazionali, le
strategie delle grandi istituzioni), giù giù fino alle agenzie di esecuzione dei progetti e dei programmi (Uffici della cooperazione internazionale dei governi nazionali e locali, società di esecuzione, ONG). Non
è difficile identificare un processo di attenuazione, di deformazione, di
distorsione, di adattamento, delle grandi teorie alle necessità contingenti della burocrazia, dei paesi e delle regioni. Insomma, il sociale (il
tessuto politico ed economico locale, i gruppi locali di interesse, i costumi e i modi di vita) tende a “risucchiare” l’apparato concettuale,
metodologico e operativo dello sviluppo all’interno delle sue logiche,
dei suoi interessi, delle sue capacità, ed a trasformarlo. In ogni regione
del mondo dove interviene un progetto o un programma, che è stato
disegnato secondo regole, aspettative, interessi teorici e pratici, modellistiche e logiche generali di origine lontana, appaiono subito – già
dopo l’inizio delle trattative che porteranno all’intervento, prima che
esso prenda corpo – una serie di “gruppi d’interesse” (soggetti, imprese, gruppi sociali e politici) che iniziano a reagire al nuovo intervento,
prima che esso venga messo in essere, rivelando accettazione o rifiuto
di alcuni aspetti, correzioni, travisamenti, re-interpretazioni, riorganizzazioni. Sicché, si può dire di quasi tutti i progetti di sviluppo che le
logiche sociali ed economico-politiche locali finiscono per addomesti-
I quaderni del CREAM , 2009, IX
24
care le grandi teorie e metodologie che vengono dal centro del mondo.
Anche perché raramente i progetti e i programmi vengono ideati e disegnati a partire da una vera, attenta e accurata analisi delle forze in
campo esistenti in una certa regione, delle aspettative e degli interessi
reali della popolazione, dei bisogni primari, delle logiche culturali e
dei sistemi di valori locali. Esse si rivelano lentamente, dopo che l’intervento è già stato deciso e durante la sua esecuzione. Si può infatti
dichiarare, senza tema di smentita, che uno dei maggiori difetti dell’attuale pianificazione degli interventi dello sviluppo risiede nella mancanza, o scarsa importanza, delle indagini preliminari sull’economia
sociale locale, sulla rete delle relazioni sociali e politiche del territorio,
sui sistemi di idee e valori, sulle credenze e le pratiche ivi esistenti.
Un’indagine preliminare affidata ad un esperto ricercatore sociale può
soffermarsi con attenzione sui principi e le pratiche del sistema economico locale, che può essere caratterizzato dai principi della redistribuzione, e magari non ossessionato dalle logiche della sempre maggiore produzione per soddisfare bisogni crescenti (in certi sistemi sociali i bisogni possono essere socialmente controllati), le tecnologie
locali possono essere adeguate ai suoli, alle piante esistenti, al clima,
l’organizzazione del lavoro può essere incastrata in una rete di rapporti sociali, e il sistema di idee, la cosmologia e i rituali, possono essere
strettamente connessi con l’organizzazione della produzione, della distribuzione e dei consumi. Tocca al ricercatore di disegnare il complesso quadro locale, prima che si pensi a proclamare bisogni, carenze, necessità, che il più delle volte vengono dai quadri di riferimento,
dalle aspettative e dalle esperienze lontane dei donatori dell’Occidente; vengono semplicemente e automaticamente proiettati acriticamente sulla situazione locale.
La prima ricerca moderna su queste “visioni locali dello sviluppo”,
sulle percezioni, categorizzazioni, reazioni delle popolazioni marginali
alle imprese dello sviluppo, fu quella di Sandra Wallman, che pubblicò nel 1977 una raccolta di brevi saggi di diversi autori sulle percezioni, giudizi, valutazioni delle attività e dei progetti di sviluppo da
parte di popolazioni rurali, indigene, di molti paesi del mondo. Il libro
era dedicato a sondare il gap di comprensione e di comunicazione tra i
poveri del mondo e le logiche del cambiamento economico-sociale
I quaderni del CREAM , 2009, IX
25
pianificato. I ricercatori interrogavano i testimoni marginali sui “vantaggi” e “svantaggi”, sui “profitti” e le “perdite”, sulle forme di resistenza e
di incomprensione, su ciò che essi percepivano, comprendevano, dei
messaggi e delle proposte-azioni che ricevevano. Appariva insomma
evidente, da questa raccolta di ricerche, che lo sviluppo, celebrato come invenzione economico-sociale che attraverso la tecnica, la scienza,
l’organizzazione del lavoro ed il know-how, la rinuncia a benefici attuali per maggiori benefici futuri, avrebbe migliorato sensibilmente il
livello di vita delle popolazioni locali, e trasmesso a tutti le logiche, le
capacità e i successi del capitalismo di origine euro-americana, di fatto
invece penetrava con difficoltà nelle periferie del mondo. La comunicazione e la formazione risultavano quindi le vere variabili assenti dai
processi di induzione del cambiamento. E del resto, “comprendere” la
logica dello sviluppo non era cosa agevole, né facile o rapida. Ogni
sistema locale aveva la sua logica, la sua grammatica e la sua retorica,
che non sempre si accordava con facilità con la logica del progetto. In
un libro del 1992, dedicato espressamente alle nozioni locali di sviluppo, e curato da alcuni studiosi del Dipartimento di Antropologia
dell’Università di Stoccolma, fu pubblicato un saggio su una situazione sociale per così dire, “estrema”. In un villaggio indigeno della Nuova Guinea, la popolazione locale legava senza esitazione lo “sviluppo”
alle cose che venivano da fuori, ai beni dell’Occidente, che tendevano
a generare una rottura con la tradizione, ma utilizzava, per comprendere e rendere cognitivamente e simbolicamente accettabile la trasformazione economico-sociale indotta dai nuovi beni, un modello sociorituale particolare, quello dei “Culti del Cargo”, che nei decenni passati avevano invaso quasi tutta l’Oceania. Si trattava di un sistema simbolico-rituale secondo il quale gli indigeni ritenevano di poter influenzare le decisioni degli antenati, che avrebbero acconsentito di procurare quantità straordinarie di beni di origine e carattere occidentale (delle mitiche “navi” cariche di ogni ben di Dio), solo che i discendenti
fossero stati in grado di eseguire correttamente dei rituali magicoreligiosi, i quali davano ai beni dello “sviluppo”, e a tutto il processo,
un carattere di automatismo magico-rituale, nel quale non si percepiva
alcuna connessione dell’avvento dei nuovi beni con il lavoro, la tecnica, l’organizzazione, gli investimenti e la razionalità economica. In
I quaderni del CREAM , 2009, IX
26
altri casi, per esempio nel mondo rurale della Colombia, quello dello
sviluppo veniva interpretato come un chiaro esempio (negativo) del
disinteresse e della incapacità del governo. Infatti, quello che si definiva “sviluppo” veniva inteso come un necessario e buon effetto di
adeguate politiche di aiuto del governo, dovute come obblighi del potere centrale, non come effetto di dinamiche economico-tecniche di investimenti e rendimenti; e quindi un “dovere” del governo. Le economie locali dovevano dunque “ricevere” aiuti, e poiché aiuti non avevano
ricevuto in abbondanza negli anni 90 del secolo passato, la percezione
locale dello sviluppo corrispondeva a un imputazione di “colpa” nei
confronti del governo. Ma i funzionari locali della burocrazia regionale
mostravano una diversa concezione dello sviluppo, come di una forma
di necessaria “civilizzazione” delle riottose e tradizionaliste costumanze della gente rurale. Era cioè qualcosa che doveva essere appreso,
imparato, nel quale bisognava essere “formati”. I burocrati locali, dunque, percepivano il loro compito, nel campo delle azioni di sviluppo,
come quello di formatori, trasmettitori di idee di modernità a gente arretrata. Ma non nel senso direttamente e specificamente economicotecnico, bensì in quello più generale di “maestri, portatori delle idee
della modernità”, intesa come urbanità, abbandono di credenze arcaiche, pulizia, religiosità urbana.
Non lontano dalle pianure coltivate a banane della costa nord della
Colombia, nella Sierra Nevada de Santa Marta, gli indigeni Kogi, molto tradizionali e legati a una impostazione mistico-religiosa e contemplativa della vita, rifiutavano la parola stessa dello “sviluppo”, e stimolati dai ricercatori, alla fine non trovavano di meglio che tradurre la
parola “sviluppo” con un termine equivalente a “divinazione”. A loro
modo di vedere sia le concezioni occidentali dello sviluppo, del miglioramento e della crescita economica, sia la loro divinazione, riguardavano visioni del futuro positive, arricchenti, desiderate e alla fine
sanzionate e decretate dagli operatori del rituale come “inevitabili” e
“sicure”. Il fatto che la divinazione declinasse semplicemente un futuro già scritto, definito e inevitabile, non opera dell’uomo, e che invece
lo sviluppo venuto dall’Occidente si riferisse al lavoro, allo sforzo, alla responsabilità e capacità degli attori sociali, a nuove strumentalità e
a un “saper fare” che dipendeva dalle decisioni, dalle capacità impreve-
I quaderni del CREAM , 2009, IX
27
dibili di esseri umani, non li impressionava affatto. Privilegiavano le
analogie (previsione-statuizione di un futuro migliore) e trascuravano le
differenze (anche perché non credevano affatto nelle capacità dei progetti di sviluppo promossi dai Bianchi, di migliorare effettivamente le
condizioni di vita; raccontavano di infiniti progetti falliti, abbandonati,
inefficaci, dopo qualche anno di illusioni). Ma gli Aruaco, un popolo
vicino ai Kogi anche se molto più “modernizzato”, sembravano comprendere e accettare i caratteri propri dello sviluppo dell’Occidente.
Dopo anni di interventi del governo o di organizzazioni internazionali,
proclamavano di essere già in parte “sviluppati”, perché accettavano il
principio di “avere sempre più cose”, oggetti, beni, denaro. Tuttavia,
mostravano difficoltà a comprendere il principio del “lavoro-rinunzia
ai consumi-investimento-utilità differita”. Per loro “svilupparsi” voleva dire essenzialmente “diventare come i Bianchi”, essere in grado di
procurarsi i loro beni, non di produrli.
E i vicini Wayú, pescatori e piccoli allevatori della penisola della
Guajira, consideravano con una certa sufficienza i “progetti” portati
dai Bianchi (pieni di oggetti e di cose poco comprensibili, spesso inefficaci), e li definivano “regali sciocchi”, non collegati con il sistema
locale della reciprocità, privi di senso e di legami con le relazioni sociali locali, e tuttavia consistenti in “cose” che potevano avere una
qualche utilità. Se invece dovevano definire una iniziativa propria per
migliorare le condizioni di vita, pensata e disegnata all’interno del sistema sociale locale, nei tempi e nei modi dettati dalla tradizione, usavano un diverso termine, che ritradotto in italiano significava “tessere
al telaio”. Operazione quest’ultima di lunga durata, di complessità notevole, e comportante un intreccio di diverse operazioni con differenti
fili, colori, movimenti delle mani. La differenza, anzi l’opposizione,
tra i due tipi di espressioni metaforiche (“regalo sciocco” e “tessere al
telaio”), rivela molto delle concezioni e delle pratiche di questa popolazione colombiana, nonché del loro severo giudizio sulle iniziative
provenienti dai Bianchi.
Questi pochi e sommari esempi dovrebbero mostrare quanto possa
essere interessante indagare sulle concezioni, percezioni e categorizzazioni locali dello sviluppo; e quanto possa essere opportuno registrare
e commentare le traduzioni locali, in lingue vernacole, dei termini
I quaderni del CREAM , 2009, IX
28
fondamentali del vocabolario dello sviluppo. Oltre al concetto basico,
si può indagare, ed è stato fatto, termini come “progetto”, “sostenibilità”, “valutazione”, “finalità generali e specifiche”, “monitoraggio”, e
così via. La successiva “retro-traduzione” (back-translation) dai termini indigeni a una lingua dell’Occidente, può consentirci di chiarire
il modo in cui una società locale pensa, categorizza e classifica ciò che
noi definiamo “sviluppo”.
Insomma, i processi di sviluppo visti nelle concrete operazioni sociali, nelle collegate rappresentazioni mentali e nelle espressioni linguistiche, così come esse si presentano a livello locale, rivelano una
diversa configurazione dei fenomeni di cambiamento economico-sociale pianificato. La gente comune vede il mondo dello sviluppo in
modo molto diverso dai funzionari internazionali, dagli economisti teorici, dai politici dei grandi paesi, e dai tecnici che girano il mondo
con la valigetta delle quarantotto ore. E le loro interpretazioni, le loro
azioni di nascosta resistenza, di travisamento e re-interpretazione dei
messaggi e delle strategie di azione pensate a migliaia di chilometri di
distanza, sono parte importante, anzi fondamentale dell’intero processo. Esse possono anche spiegare i frequenti insuccessi, la inefficacia
degli interventi, la straordinaria variabilità delle risposte locali a progetti pensati e gestiti in modo analogo, o spesso identico, in situazioni
assai differenti.
Il paradosso che queste indagini sulle nozioni locali dello sviluppo
suscitano consiste nel fatto che l’arricchimento di informazione critica
sui processi-mondo, e la messa in discussione dei modelli monistici ed
etnocentrici provenienti dal centro del pianeta, che ci fanno coscienti
di quanto poco abbiamo tenuto conto degli interessi e dei punti di vista
degli altri, nonché dei possibili modelli alternativi elaborati da altre
culture e altre società, prende consistenza in un’epoca nella quale
l’espansione dell’economia e delle tecniche occidentali, e dei modelli
di vita ad esse connessi, sta lentamente ma inesorabilmente eliminando le possibili alternative. Ci rimane dunque il sospetto che la coscienza critica dei limiti dello sviluppo occidentale arrivi in un certo senso
troppo tardi, quando lo spazio per vere alternative di origine esterna si
sta riducendo sempre di più.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
29
Bibliografia
Abram S., Waldren J. 1998 (a cura di), Anthropological perspectives on local
development. Knowledge and sentiments in conflict, Routledge, LondonNew York.
Apffel-Marglin F., PRATEC 1998, The spirit of regeneration. Andean culture confronting Western notions of development, Zed Books, LondonNew York.
Colajanni A. 2004, L’analisi sociale nelle iniziative di promozione dello sviluppo, V. Ianni (a cura di), Verso una nuova visione dell’aiuto. Le autonomie locali nella cooperazione internazionale allo sviluppo. Manuale di
formazione per amministratori locali, ANCI/MAE, Roma, pp. 245-254.
Colajanni A., Mancuso A. 2008, Un futuro incerto. Processi di sviluppo e
popoli indigeni in America Latina, Ed. CISU, Roma.
Dahl G., Rabo A. 1992 (a cura di), Kam-Ap or Take-Off. Local notions of development, Stokholm Studies in Social Anthropology, Stokholm.
Easterly W. 2006, Lo sviluppo inafferrabile. L’avventurosa ricerca della crescita economica nel Sud del mondo, Bruno Mondatori, Milano.
Groves L., Hinton R. 2004 (a cura di), Inclusive aid. Changing power and
relationships in international development, Earthscan, London.
R. Malighetti 2005 (a cura di), Oltre lo sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, Meltemi, Roma.
Mosse D. 2005, Cultivating development. An ethnography of aid policy and
practice, Pluto Press, London-Ann Arbor.
Sachs W., Loske R., Linz M. 1997 (a cura di), Futuro sostenibile. Riconversione ecologica. Nord-Sud. Nuovi stili di vita, Wuppertal Institut, E.M.I,
Bologna.
Tommasoli M. 2001, Lo sviluppo partecipativo. Analisi sociale e logiche di
pianificazione, Carocci, Roma
Wallman S. 1977 (a cura di), Perceptions of development, Cambridge University Press, Cambridge.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
30
SEBASTIÃO MOREIRA DUARTE
1
ODORICO MENDES
2
E L’IDENTITÀ EUROPEA DEL BRASILE
“La storia si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo”... e anche contro lo spazio, direbbe oggigiorno l’autore de I Promessi sposi, alla vista della distanza fattasi miracolosamente corta tra
“quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno” e i due rami
d’acqua a mezzogiorno del pianeta – i fiumi Anil e Bacanga – che circondano la città di São Luís do Maranhão, in Brasile, prima di unirsi a
formare l’Oceano Atlantico. Tuttavia, nonostante il miracolo della distanza accorciata, qualcuno dei miei uditori potrebbe non stare lungi
dall’incarnare l’attitudine di don Abbondio, “seduto sul suo seggiolone
(...) con un libricciolo aperto davanti (...), convalescente della febbre
dello spavento”, e con tutto il diritto chiedere a se stesso: “Carneade!
Chi era costui?” Voglio dire: “Brasile! Ma che diavolo è questo paese?”
La domanda è del tutto pertinente, considerando il tema che è oggetto del nostro incontro. Noi stessi, come brasiliani, ci siamo spesso
chiesti nel corso degli eventi della nostra vita nazionale, nei dibattiti
1
Sebastião Moreira Duarte, laureato in Filosofia e Pedagogia, laurea magistrale in
Administração Universitária e Dottorato di Ricerca in Letteratura comparata presso la
University of Illinois, USA. Professore presso la Universidade Federal do Maranhão,
editore e critico letterario, membro della Academia Maranhense de Letras, ha pubblicato
su riviste brasiliane e straniere. Fra i suoi saggi: O périplo e o porto (1990), Estudos sobre o mosaico (1992), Épica americana: O Guesa de Sousândrade, e o Canto general
de Pablo Neruda (1992), A épica e a época de Sousândrade (2002). Fra le sue poesie:
Novena de Natal (1977), Canto essencial (1979), Calendário lúdico (1998).
2
Testo della conferenza dal titolo L’identità europea del Brasile nell’opera di Odorico
Mendes tenuta presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, lunedì 19 maggio 2009.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
31
politici e accademici, nei titoli dei giornali, nelle chiacchiere di salotto: “Che paese è il Brasile?” E, per la soddisfazione del nostro appetito
carnevalesco, le risposte che abbiamo generato, tra le più varie e abbondanti, non divergono molto dalla pittoresca definizione data da due
dei vostri eminenti scrittori: “Brasile: grande, immenso, ricco paese
dell’America che manda in Europa caffé, noccioline e imperatori spodestati e al quale noi mandiamo carne da lavoro – poveri cafoni che
diventano milionari, quando non muoiono di febbre gialla”3. (Al giorno d’oggi, la versione giornalistica aggiungerebbe che le esportazioni
dal Brasile per l’Italia includono prostitute di gran lusso e giocatori di
calcio di grande fama, mentre l’Italia ci manda mafiosi come Tommaso Buscetta e latte Parmalat, fatto di candeggina e acido solforico).
Come sappiamo, la ricerca dell’identità è uno dei compiti più impervi di cui si fanno carico i paesi colonizzati, data la peculiarità della
loro formazione sociale. Nel caso del Brasile, essendo noi esotici in
maniera conveniente e non mancando di mania di grandezza – che ora
ci salva, ora ci condanna, a secondo dell’argomento e dell’argomentatore – ci aggrada la peculiarità di reclamare uno dei primi posti in peculiarità, nel cospetto delle nazioni. La nostra storia accumula indici
incredibili di peculiarità, sin dai primi capitoli. Fino ad oggi rimane
incerto se i portoghesi ci scoprirono per caso o di proposito. Quest’anno, per esempio, commemoriamo il bicentenario di un fatto singolarissimo: quello della fuga in Brasile di D. João VI, del Portogallo,
l’unico re a fare fesso Napoleone Bonaparte e anche l’unico a mettere
piede in territorio americano. Lo accompagnava una moltitudine di
sedicimila nobili e cortigiani, che fece crescere di un terzo la popolazione di Rio de Janeiro, in meno di sessanta giorni. E allora, si invertirono ruoli e posizioni: la Colonia passò a governare la Metropoli. Tredici anni più tardi, quando ritorna in Portogallo, il re lascia tra noi suo
figlio come successore. Egli ci darà l’indipendenza con un solo grido
(e anche la responsabilità del debito portoghese verso l’Inghilterra).
Nell’anno seguente, il 1822, questo giovane principe, D. Pedro, fonda
un impero, l’unico in America, facendosi signore di un enorme territo-
3
Giuliotti e Papini 1923, vol. I, p. 465.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
32
rio indiviso, in contrasto con la frammentazione delle numerose repubbliche ispanoamericane.
Le peculiarità si succedono: non sono passati ancora sette anni, che
l’imperatore portoghese del Brasile indipendente abdica al trono, attraversa il mare, va a combattere il fratello che gli usurpava la corona
portoghese, lo sconfigge sui campi di battaglia, insedia la figlia brasiliana come regina del Portogallo. In Brasile Pedro I lascia il figlio erede di appena sei anni, affidato ai brasiliani e donato al Brasile. Si improvvisa una Reggenza, che, per un decennio, cerca di gestire innumerevoli crisi, quasi tutte di carattere separatista. Finalmente, nel 1841, si
anticipa la maggiore età di D. Pedro II. Ha inizio il Secondo Impero,
uno dei più lunghi, più solidi e più rispettabili periodi di governo in
tutte le Americhe.
Ma, se avevamo un paese, mancava costruirlo. Nel piano delle realizzazioni materiali e simboliche, mancavano infatti al paese i marchi
distintivi che gli garantissero un inserimento di livello nel catalogo dei
popoli civilizzati. Meglio dire che al Brasile mancava il giusto profilo
e l’immagine adeguata per avere le sue realizzazioni e il suo destino
equiparabili alle grandi nazioni del mondo. Per sorte e per facilitare
l’opera, è proprio dall’Europa che viene il soffio ispiratore e l’incitamento a procedere in questo senso. Nel vecchio continente, la bufera
romantica che si propone di realizzare l’obiettivo voltairiano di “impiccare l’ultimo re con le budella dell’ultimo frate” spinge i poeti sui
campi di battaglia nella lotta per l’indipendenza delle nazioni.
In Brasile, dove tutto deve cominciare da capo, questo ideale libertario impone un intrepido programma di costruzione nazionale. Nel
dominio delle lettere e delle arti, l’Indipendenza sarà avvenimento civico trasformato in obbligo morale. È ciò che esprime il portabandiera del
nostro romanticismo, Domingos José Gonçalves de Magalhães, appena
arrivato dall’Europa. Nel manifesto inaugurale del 1836, dopo aver affermato che la letteratura annuncia “alle generazioni future quali furono
il carattere e l’importanza di un popolo del quale essa è l’unica rappresentante nella posterità”, egli enfatizza: “Una sola idea assorbe tutti i
pensieri, un’idea fino allora quasi sconosciuta: è l’idea di patria; essa
domina tutto e tutto si fa per lei o nel suo nome. Indipendenza, libertà,
istituzioni sociali, riforme politiche, creazioni necessarie in una nuova
I quaderni del CREAM , 2009, IX
33
nazione, questi sono gli oggetti che occupano le intelligenze, che attirano l’attenzione di tutti, e gli unici che interessano al popolo”.
È chiaro, l’idea di fondare la patria fondando la sua letteratura dovrà avere inizio con un poema epico, la concezione più eccelsa, secondo la scala dei valori consacrata dal neoclassicismo che ebbe lunga vita
ancora nell’ambiente romantico brasiliano. I poeti della giovane nazione
non lascerebbero di gareggiare con i vati della vecchia metropoli, la cui
opera massima era Os lusíadas, l’epopea delle scoperte portoghesi. In
questa maniera la ricerca o l’attesa del nostro Camões – o, perché no?
del nostro super-Camões – avverrebbe in simultanea con l’implementazione di un doppio programma realizzato dalla nostra élite intellettuale:
prima, intraprendendo l’archeologia dei nostri miti fondatori, che dessero materia al poema glorioso da produrre e allo stesso tempo che formassero l’immagine di un Brasile colto, erede delle virtù più nobili e
delle tradizioni più colte; e, concomitantemente, trovando il mecenate
che patrocinasse l’impresa letteraria.
Questo programma-comandamento rappresenterà un ingente sforzo di
razionalizzazione della storia patria. Risultava indispensabile “correggere
il passato”, riscriverlo, ridisegnare il profilo, e la posizione dei suoi protagonisti. L’impresa ha inizio nel 1838, con la fondazione dell’Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, non a caso, sotto l’auspicio del bambino
di tredici anni che sarà l’imperatore Pedro II. Per capire la portata di questa missione, è sufficiente ricordare che è di questo tempo il cambio dei
cognomi effettuato da alcune famiglie di stirpe lusitana, optando per un
“lignaggio” indigeno, così come molte altre passarono a utilizzare cognomi francesi. Oltre a ciò, è significativo che quasi la metà – 430 su 900
– dei titoli nobiliari conferiti dai due imperatori portoghesi si formulavano
con una toponimia indigena “di bizzarra sonorità per l’udito europeo”,
come segnala uno dei nostri migliori studiosi.4
Per non perdere il filo della nostra riflessione, sottolineiamo appena che questa “tendenza genealogica mira a realizzare un’opera americana, secondo però i modelli e i valori culturali dell’Europa, dal momento che “essa consiste nello scegliere nel passato locale gli elementi
adeguati ad una visione che di un certo modo è nativista ma cerca di
4
Candido 1987, p. 173.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
34
avvicinarsi il più possibile agli ideali e alle norme europei” o “nel rendere compatibile con gli standard europei la realtà di una società pioniera, sincretica sotto l’aspetto culturale, meticcia sotto l’aspetto razziale”. Non si trattava quindi di americanizzare l’europeo ma bensì di
europeizzare l’americano. Soprattutto, affinché risalti in piena luce il
senso finale di questo lavoro di adozione, adattamento e trassigurazione dei fatti e delle figure della nostra storia, effettuato dall’istituto
imperiale, segnaliamo che già da allora vengono disseminati i miti invocati come appannaggio della brasilianità:
il mito della grandezza territoriale del Brasile, quello della maestà e opulenza della natura brasiliana, quello dell’eguaglianza di tutti i brasiliani, quello della benevolenza, ospitalità e grandezza di carattere del popolo brasiliano,
quello delle grandi virtù dei nostri costumi patriarcali, quello delle non volgari qualità affettive e morali della donna brasiliana, quello dell’alto standard di
civilizzazione brasiliana e della pace privilegiata in cui viveva il paese, in un
mondo dominato dalle lotte politiche e sociali5.
Quanto al patrono dell’epopea brasiliana, costui non tarda a configurarsi nella stessa persona del magnanimo imperatore, umanista e
cultore dei classici, amico di scrittori come Alessandro Manzoni in
Italia o Victor Hugo, in Francia. Il Brasile ha la dimensione dell’Impero Romano. Una nuova Roma nasce sotto il sole dei tropici. Mecenate si trasfonde nello stesso Augusto, e Augusto chiama il suo Virgilio: nel caso, il protetto Domingos José Gonçalves de Magalhães, il
cui fiasco nella realizzazione della “epopéia oficial do Segundo Reinado”6 – il suo poema A confederação dos tamoios, del 1856-1857 ma
già commissionato nel 1837 – suscita un’accesa polemica, con la partecipazione di notabili belletristi dei due continenti, tuttavia, invece di
implodere la spropositata proposta, causa una sorta di epidemia di poemi epici che dura circa quattro decadi, dal primo all’ultimo dei nostri
romantici (questo, il maranhense Sousândrade, l’unico che ebbe esito
nell’impresa, ma per altro cammino). È in questo panorama di idee che
entrano in scena il volto e l’opera di Manuel Odorico Mendes, che qui si
5
6
Amora in Martins 1915-1933, vol. III, p. 321.
L’espressione è di Wilson Martins 1915-1933, vol. III, p. 268.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
35
presentano con il marchio, tra i più visibili, dell’identità europea, perseguita con tenacia dall’ideologia letteraria del secolo XIX brasiliano.
Odorico Mendes nacque a São Luís do Maranhão nel 1799, e morì
a Londra, nel 1864, quando, dopo un lungo soggiorno a Parigi, si preparava a ritornare alla terra natale. Studente della Università di Coimbra dove, come dice uno dei suoi contemporanei, “tutti i talenti andavano a cercare la loro consacrazione, e senza le cui pergamene a nessuno era dato aspirare agli onori e grandezze cui poteva arrivare allora
un figlio del Brasile”7, Mendes fece parte del famoso Grupo Maranhense, che diede alla sua terra l’antonomasia di Atene brasiliana e consacrò
nella letteratura nazionale nomi come Sotero dos Reis, João Lisboa,
Gomes de Sousa, Gonçalves Dias, ecc. Nella provincia e nella capitale
dell’impero, prese posizioni di prima linea nel consolidamento dell’indipendenza del Brasile. Personaggio di spicco nel movimento che portò
all’abdicazione di D. Pedro I al trono imperiale, il 7 aprile 1831, l’avrebero fatto reggente se non fosse stato suo fermo proposito restare fuori
dal nuovo regime per la sincera ragione di essere egli stato tra i suoi
primi fautori. Giornalista influente, fu anche membro dell’istituto dove
si effettuava il filtraggio ideologico del passato nazionale, allo scopo di
incorporare le tradizioni native del giovane Brasile nelle radici ancestrali della cultura europea. Scrittore, si identifica come il neoclassico al
quale si deve, fino ad oggi, l’unica traduzione completa di Virgilio fatta
da un solo autore in portoghese. A quest’opera, che rappresenta la sua
realizzazione intellettuale per eccellenza e che gli costò dieci anni di lavoro, si aggiunge la sua traduzione delle due epopee omeriche. Patriarca
dell’Umanismo Brasiliano, la Academia Brasileira de Letras lo proclamò patrono dei nostri traduttori.8
Convivono così in Odorico Mendes, il politico liberale e l’uomo di
lettere conservatore, il che è appena un apparente paradosso: rivoluzionario quanto alle basi razionali della propria origine, il suo liberalismo
7
Lisboa 1995, p. xx.
Essendosi stabilito a Parigi per molti anni, Odorico Mendes lasciò una discendenza
in Francia. È figlio di suoi pronipoti lo scrittore Maurice Druon, che fu Ministro della
Cultura e Segretario dell’Accademia Francese. Curioso è il fatto che al traduttore neoclassico brasiliano non mancò, in Francia, il contatto con il gruppo dei “poètes maudits” del simbolismo francese, fra i quali suo genero Antoine Cros.
8
I quaderni del CREAM , 2009, IX
36
significava la fiducia nel dominio universale della ragione, alla quale
toccava, anzitutto, governare le parole, perchè avesse efficacia il governo emancipatore degli individui. Sotto una luce più ristretta, il politico
Odorico Mendes è lo stesso letterato che è presente e prende parte nella
scena in cui si svolgono, di pari passo, l’emancipazione politica brasiliana e il progetto della nostra letteratura autoctona. Egli si posiziona
come attore udito e ubbidito da entrambi i lati di questo teatro di azioni.
Nell’arena politica, la sua convinzione è che, se l’indipendenza ha
dato ai brasiliani una patria distinta da quella dei portoghesi – e per
tanto si adoprò Odorico (il suo profilo liberale come politico) – ciò
non autorizza a dimenticare che portoghesi e brasiliani continuano, e
devono continuare, uniti dalla stessa lingua (il suo profilo conservatore come uomo di lettere). Portogallo e Brasile sono popoli fraterni,
ed è importante tenere a mente che è per questa strada che la nazione
brasiliana giunge, con pieno diritto di eredità, al ricchissimo fiume
della latinità. Osserviamo di passaggio come, facendo l’apologia del
legato lusitano, Odorico sintetizzi l’inventario dei miti nazionali inculcati a partire dall’Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
Malgrado le ingiustizie che pativamo dai cattivi governi, malgrado le meschine gelosie della Metropoli, i nostri padri ci trasmisero: 1° la religione più
civilizzatrice; 2° franchezza e ospitalità a nostro carico, non a parole e cortesia; 3° una legislazione civile migliore di quella delle nazioni più presuntuose; 4° una lingua sonora la più ricca, se non per le cose dell’industria modernissima, per la Storia, per la Navigazione, per la Poesia, con tutte le sfumature, varietà e grazia.9
Nel campo delle lettere, non gli manca la sensibilità per capire che
un novus ordo saeclorum va nell’aria e che le prime contaminazioni
dell’estetica romantica raggiungono le spiagge del Brasile. Urge far
sorgere le “creazioni necessarie in una nazione ”, come rivendica il
suo amico Domingos Magalhães. E se, ritardatario nell’arte poetica,
Odorico Mendes si sente poco a suo agio a discutere con la nuova generazione, non per questo però si sente di offrire un minor contributo
al progetto della grande epopea dell’Impero Brasiliano. Al contrario,
9
Mendes 1858, p. 507.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
37
la sua solida formazione, saldamente umanista, costituisce un autorevole patrimonio che gli permette di rispondere alle sollecitazioni alla
maniera di un religioso che offre la Bibbia a un neofita. Odorico va alle
origini dell’epopea occidentale. Da laggiù egli porta la sua traduzione di
Virgilio che, sin dal Rinascimento, era modello canonizzato della perfetta epopea, somma della civiltà comune all’immensa nazione latina, in
ambo i lati degli oceani, poema costitutivo della prima Roma, e pertanto
paradigma del poema inaugurale della Roma americana.
A questo punto, per una debita lettura dell’intenzione della sua opera politico-letteraria, conviene fare una verifica di date: Odorico
Mendes elabora la sua traduzione del poeta latino in data anteriore al
1847, anno in cui si trasferì in Francia. In questo tempo Magalhães assume l’incarico del suo disastrato poema. Altri poeti si lanciano nella
stessa impresa. Non si prenda perciò come coincidenza gratuita che egli
abbia iniziato dall’Eneida nel 185410 – Eneida brasileira, facciamo attenzione all’aggettivo aggiunto al titolo latino (e che è parallelo all’Eneida portuguesa, opera classica di João Franco Barreto11 che Odorico apprezzava molto) – e che, concluso il lavoro di redigere in vernacolo tutta l’opera virgiliana, dopo “dieci anni, con poche interruzioni,
di uno studio e di accurata applicazione”12, egli pubblichi il Virgílio
brasileiro, nel 1858. Non deve anche essere un dettaglio senza importanza che, costretto, anche per comandamento scolastico, al dovere
della precisione e del vocabolo esatto, egli rappresenti nel Virgilio
brasileiro una Eneida che è più una seconda traduzione che una seconda edizione, come dichiarò, tante sono le alterazioni da un testo
all’altro. La pubblicazione di parte dell’opera sarebbe una consegna
anticipata al fine di orientare l’impresa epica dei brasiliani. Questo, se
guardiamo alle frontiere nazionali. Fuori di esse, altra motivazione
vendicativa di certo lo chiamava, quale patriota della devozione alla
lingua patria: la famosa edizione poliglotta di Virgilio,13 pubblicata nel
suo tempo e da lui utilizzata, conteneva, delle lingue sorelle, la versio10
Mendes 1854, p. 392.
Barreto 1664 e 1670.
12
Lettera di Odorico Mendes a Paulo Barbosa da Silva, gentiluomo della Casa Imperiale, datata 21 settembre 1858. In Lacombe 1989, p. 52.
13
Moufalcon 1838.
11
I quaderni del CREAM , 2009, IX
38
ne italiana, francese e spagnola del poema latino, ma non includeva
quella portoghese, che, d’altronde neppure esisteva per intero. La sua
opera denunciava e riempiva questa lacuna.
Quanto a offrirsi come guida per la nostra rivoluzione romântica, si
veda come Odorico si dirige al pubblico lettore della sua Eneida:
“Sumite materiam vestris, qui scribitis aequam / Viribus”. È di Orazio
questo precetto di misurare, il poeta, la proporzione tra le proprie risorse e la materia che pretende porre in versi. Prendendo per sé la raccomandazione, il traduttore sta dicendo, senza aver bisogno di dirlo,
che essa si applica, con tutta e maggior ragione, a coloro che lo prendano per maestro.14 Più avanti si giustifica:
Non possedendo l’ingegno indispensabile per intraprendere un’opera originale almeno di second’ordine, persuaso tuttavia, che lo studio della lingua e la frequente lezione della poesia mi abilitavano a volgere in portoghese l’epopea più di
mio gusto, sono anni che mi occupo dell’Eneida. Mi do per contento se ottengo
un posto ai piedi di Aníbal Caro, Pope, Monti, Francisco Manuel, e di altri buoni
traduttori poeti; e, nel caso ciò mi sia vietato, mi consolo con il piacere attinto
nelle storie di Virgilio. (...) Questo piacere, in verità, è stato quello che mi ha sostenuto in tanto arduo compito, ancor più che il desiderio di lodi; che tuttavia aggradano il nostro amor próprio, e farei a meno di meritarle.15
Qui sta, già abbiamo avuto occasione di dirlo, meno una scusa di
modestia e più un’affermazione di autorità. Felice di gareggiare alla
pari con i più illustri traduttori di Virgilio nelle varie lingue moderne,
Odorico Mendes capisce che è per questa via che gli tocca dare dignità
alla lingua portoghese e, tramite essa, al Brasile. Ai Virgilio brasiliani,
il compito di realizzare la nostra epica definitiva. Qui si inserisce per
forza una pausa valutativa: poema di elevazione della lingua nazionale, forse sì. Epica definitiva, forse no. Voltiamo la nostra analisi alla
14
Odorico fu riverito come maestro. Della sua autorità si avvale Domingos José Gonçalves de Magalhães, per fare l’apologia de A confederação dos tamoios, sotto il
fuoco dei critici: “E como bem notou o Sr. Odorico Mendes: os selvagens, rudes e de
costumes quase homéricos, podem prestar belos quadros à epopéia. O parecer de tão
abalizado crítico, que nos deu Virgílio em português e luta para interpretar Homero, é
de tanto peso, que decide só por si qualquer dúvida. Feliz me julgo em pensar como
ele que sabe o que é uma epopéia” (cit. in Wolf 1955, p. 249).
15
Mendes 1854 p. 5; 1858, p. 203.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
39
torsione trasfiguratrice della storia, intrapresa con la valorizzazione
europeista della realtà brasiliana. Nell’elenco selettivo di miti atraverso i quali si fabbricherebbe l’epopea dell’Impero, l’elemento nativo
sarebbe trasformato in eroe omerico. Questa visione, del resto, già traspira nell’estetica hegeliana, ma riempiendo una preconcettuosa equivalenza: il genere epico si collocava nei tempi della remota antichità, e
ad essi equivaleva. L’epopea era morta e sepolta a partire dall’età moderna. A sussistere in qualche angolo del mondo sarebbe possibile rincontrarla tra i primitivi abitanti delle selve americane. Nel 1826, il
francese Ferdinand Denis, buon conoscitore del Brasile, afferra il suggerimento e lo trasforma in invito e propaganda:
L’America deve essere libera tanto nella sua poesia quanto nel suo governo. Se questa natura dell’America è più splendida di quella dell’Europa, che
avranno di inferiore agli eroi dei tempi favolosi dell’Europa questi uomini
[gli indigeni]? (...) I loro combattimenti, i loro sacrifici, le nostre conquiste,
tutto presenta un aspetto splendido. (...) D’altro canto tutto l’eroismo dell’Età
Media, tutto lo spirito ardente e avventuroso dei tempi della cavalleria, non si
insinuano con un colorito particolare in questi viaggi dei primi esploratori, penetrando coraggiosamente al centro delle foreste vergini, affrontando audacemente animali sconosciuti, visitando nazioni che potevano distruggerli? (...) Se
i poeti di queste regioni poterono ammirare la natura, penetrare nella grandezza che essa offre, dentro di pochi anni, essi saranno i nostri maestri.16
La sagacità immaginativa di questo nativismo naturo-indianista
serve al proposito contradittorio di sostenere nuovi ideali politici con
vecchie idee estetiche e, così, aiuta nella migliore lettura di quella età,
che addita il futuro per mantenerlo uguale al passato. All’interno del discorso letterario, si riproduce la conciliazione eclettica tra il cambiamento proclamato dalla società imperiale brasiliana e le continue manovre per la manutenzione dei privilegi dei suoi baroni. Per questo, la metamorfosi dei silvicoli brasiliani in guerrieri dell’Iliade o dell’Odissea,
che in nulla li migliora: al contrario, per fare di essi quello che non sono, li annulla, li spegne dinnanzi alla storia. Avverte Antonio Cândido:
16
Denis 1968, p. 36-37.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
40
Questo indio eponimico, questo antenato simbolico giustificatore tanto
del meticciato, quanto del nativismo, poteva avere libertà nel piano dell’ideologia poiché la sua evocazione non toccava il sistema sociale che si basava
sullo sfruttamento dello schiavo negro e questi riceveva un abbozzo di trattamento letterario idealizzatore nella seconda metà del secolo XIX, quando
ebbe inizio la crisi del regime servile.17
Mentre era possibile celebrare una delle matrici della formazione
brasiliana, anche se in forma razionale, l’altra non era neppure riconosciuta come tale. Il negro, per nostra vergogna, contava appena come animale
da carico, pezzo di macchina produttiva della colonia fino agli ultimi anni
dell’impero. Rimaneva la matrice bianca, colta, aristocratica, europea, che
si faceva ricca con la terra dell’indio e con il sudore africano.
Manuel Odorico Mendes, che aveva temprato il carattere alla forgia del liberalismo e fu abolizionista sin dalla gioventù, di certo si opponeva all’ingiustizia intrinseca di questo sistema. Ma sarebbe troppo
aspettarsi che avesse coscienza delle sue contraddizioni. Egli ci chiede
la parola per congedarsi, e torna in compagnia di Virgilio per mostrare
ancora un tratto forte del suo umanesimo. Penetrando nelle note con
cui Odorico arricchisce la sua traduzione, diremo che è quasi impossibile discernere che cosa è più grande: se il suo apprezzamento totale
per l’opera o la venerazione estrema che egli dimostra per le virtù umane di Virgilio. Dal momento che non stiamo tenendo un corso di letteratura, sia il sufficiente menzionare che il traduttore tutto loda, tutto perdona, tutto giustifica – in un poema che il proprio autore lasciò inconcluso e chiese che fosse bruciato – mentre, visibile e invariabilmente
disturbato, non lascia passare una sola critica, senza pietà, per qualsiasi
critico del poeta latino, per minimo che sia. Egli spiega questo atteggiamento: “È meno costoso riconoscere qualche imperfezione che la morte
prematura non permise di correggere che a forza di studio accurato trascinare le bellezze alla larga sparse in tutte le sue composizioni ”18.
17
Cândido 1987, p. 173
Più avanti, riferendosi alla disposizione testamentária di Virgilio di bruciare l’Eneide, Odorico continua: “Eu suspeito que nem todos eles [os versos] eram para ser completados; que não poucos teriam de desaparecer, incluindo-se a matéria ou nos antecedentes ou nos conseqüentes: parece-me que muitas das emendas teriam consistido em
cortes de algumas excrescências, em alterações dos lugares em que o Poeta repete os
18
I quaderni del CREAM , 2009, IX
41
Odorico, tanto o più di Dante, considera Virgilio un pedagogo della
civilizzazione, in ciò che la vita del poeta rivela d’amore e attaccamento
“alla terra della sua residenza”, delicatezza d’animo, castità dei costumi,
“costante desiderio di vivere in pace e in seno alle Muse”, bucolismo,
pacifismo. Lasciamo che il brasiliano fissi il profilo del Mantovano:
Dirò in breve della sua indole e carattere, della sua morale e virtù. Parco,
sobrio, semplice, compassionevole, senza orgoglio, senza invidia, viveva della libertà di opulenti amici, (…) in mezzo al conforto che gli procurò la superiorità del suo talento, non si dimenticò della sua Mantova e del suo paese, del
suo umile padre e fratello, dei poveri contadini che erano stati suoi compagni
nell’infanzia. I contemporanei di merito, i poeti suoi emuli, sempre gli furono
cari. (...) Perdonò di buon grado i suoi detrattori (...); fece giustizia ai poeti dei
quali si valse. Lo strappo però che più manifesta la delicatezza del suo animo è
la ricusa formale dei beni confiscati a un proscritto che Augusto gli offriva in
dono, pur obbligato come era al Signore di Roma che lo riempì di mille favori.
Preferì i dettami della propria coscienza, col rischio di incorrere nel disprezzo
di chi era capace di renderlo miserabile, dato che la ricusa, contenendo una
censura, doveva accendere la bile infiammabile del proscrittore.19
Nei suoi ultimi anni il maranhense Manuel Odorico Mendes visse a
Pisa e viaggiò per l’Italia, dove incontrò clima migliore per la salute e
materiale per concludere la traduzione di Omero che aveva iniziato dopo
l’estremo sforzo di portare Virgilio alla lingua di Camões. Questo soggiorno, dice uno dei suoi biografi, fu:
sogno dorato di ogni immaginazione di artista e poeta che alla fine il Cielo gli concesse di realizzare dopo tanti anni di attesa. Si direbbe che la favola,
di mani date con la storia antica e moderna, si compiaccia di fare gli onori di
ospitalità a coloro che visitano questa terra portentosa con lo spirito preparato
a comprendere e ammirare le meraviglie che popolano le sue città e le sue
rovine. Tra queste ali splendide e fantastiche di quadri, statue e monumenti di
ogni genere, alcuni orgogliosamente in piedi, altri prostrati dal tempo e umiliati nella polvere, e nel mezzo dell’alba della resurrezione di un grande poseus próprios versos; talvez em realçar as ações de certas personagens subalternas,
mas não tanto crêem vários críticos de paladar enfastiado, que nem com o admirável
plano da Eneida se mostram contentes” (Mendes 1995, p. 9)
19
Mendes 1995, p. 3.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
42
polo, l’attraversò Odorico Mendes, quale vero pellegrino della religione delle
muse, arrivò al Posillipo, per compiere un voto antico, deponendo un mazzo
di fiori sulla tomba del poeta amato.20
Il sogno lungamente accarezzato viene così descritto dallo stesso
Odorico:
Giunto al Posillipo, nei dintorni di quella città molto amena, i napoletani
mostrano oggi con orgoglio la tomba del poeta che tanto li onorò, all’ombra di
un alloro, che i visitatori, al passare di là, strappandone i rami lo fecero morire.
Desiderio ho anche io di contemplare tanto nostalgico monumento! Se i contrattempi della vita non permetteranno, se muoio prima di soddisfare questo
desiderio, chiedo da qui a uno dei miei figli che là vada e non si dimentichi di
deporre su di esso un mazzo di fiori, ricordandosi che suo padre solo durerà
nelle memoria dei nostri concittadini ancora qualche anno dopo la sepoltura,
rifugiato sotto le ali di tanto sublime scrittore.21
Oggi, ancora una volta accompagnato da Virgilio, Odorico Mendes
ritorna in Italia. Ed io, molto onorato, sono grato di aver avuto l’occasione di riportare Odorico in Italia e deporre in suo omaggio questa
corona di fiori.
Bibliografia
Barreto J. F. 1981, Eneida portuguesa, I.N.-C.M.
Cândido A. 1987, Literatura de Dois Gumes, A educação pela noite e outros ensaios, Ática, São Paulo.
Denis F. 1968, Resumo da história literária do Brasil, G. César (a cura di), Historiadores e críticos do Romantismo. A contribuição européia: Crítica e história literária, Livros Técnicos e Científicos, Edusp, São Paulo, Rio de Janeiro.
Giuliotti D., Papini G. 1923, Dizionario dell’omo salvatico, Vallechi, Firenze.
Jacobina Lacombe A. 1989 (a cura di), Carta de Odorico Mendes a Paulo Barbosa
da Silva, Gentil-homem da Casa Imperial, datada de 21 de setembro de 1858,
20
21
Lisboa 1995, p. xi.
Lisboa 1995, p. xi.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
43
Cartas de Manuel Odorico Mendes, Academia Brasileira de Letras Rio de Janeiro.
Lisboa J.F. 1995 (2ed.), Biografia de Manuel Odorico Mendes, Virgílio brasileiro ou tradução do poeta latino, Edufma, São Luís.
Martins W. 1915-1933, História da inteligência brasileira, T. A. Queiroz Editor,
São Paulo.
Mendes O. 1854, Eneida brasileira ou tradução poética da epopéia de P.
Virgílio Maro, Tip. de Rigoux, Paris.
Mendes O. 1858, Virgílio brasileiro, ou tradução do Poeta latino, Tip. de W.
Remquet & Cia, Paris (2ed. 1995, atualizada com introdução e notas de Sebastião Moreira Duarte, Edufma, São Luís).
Moufalcon J. B. 1838 (a cura di), Oeuvres de Virgile traduites en vers Français
par Tissot et Delille; en Espagnols par Gusmán, Velasco et Louis de Leon; en
Italians par Arici et A. Caro; en Anglais par Warton et Dryden; en Allemands
par Voss. Texte en régard d’après Heyne, et précédée de la vie de Virgile, de
notices bibliographiques, etc., Édition poliglote, Paris et Lyon.
Wolf F. 1955, O Brasil literário, Companhia Editora Nacional, São Paulo (ed. or.
1863, Le Brésil littéraire, Ascher, Berlin).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
44
ROBERTO MALIGHETTI
REGIMI MULTICULTURALI
E PRATICHE DI CITTADINANZA
Le politiche identitarie articolate nelle ideologie e nelle pratiche multiculturali stanno sempre più manifestando le loro collusioni con le antiche strategie di dominio inaugurate dal senato romano per dividere et
imperare. Promuovono, attraverso il rilascio selettivo di privilegi, l’adesione ai poteri egemonici, prevenendo, nel contempo, la coalizione e
le sfide degli elementi contrastivi. In quanto strumenti delle logiche
dell’integrazione nazionale, usano l’identità come tecnologia di potere
e consegnano le contraddizioni ai meccanismi del dominio centralizzato dello Stato, riproducendo i dispositivi del razzismo illustrati da
Foucault (Foucault 1976): le frammentazioni multiculturali, come le
gerarchie razziali, sono un mezzo del biopotere per esercitare una sovranità eugenetica contro le minacce provenienti da fattori esogeni ed
endogeni. Risolvono il multiculturalismo nella sua negazione, rivelandone l’oscuro lato monoculturale.
Ontical human social units
Il multiculturalismo realizza la forma più compiuta in cui lo stato
nazionale contemporaneo descrive e pensa se stesso, una manifestazione della reazione alla sua delegittimazione e alle minacce di erosione
dell'egemonia dei poteri dominanti (Malighetti 2002). Coniuga l'omogeneizzazione con l’organizzazione verticale della società, in analogia ai
principi dei modelli segmentari (Evans-Pritchard 1940, Sahlins 1961):
l’alterità assume la specifica funzione di “opposizione complementare”
I quaderni del CREAM , 2009, IX
45
(Dumont 1966), identificata, contingentemente, all’interno della comunità o esternamente, secondo gli interessi e le necessità.
Fagocitando le lotte per il riconoscimento dei diritti, i programmi
multiculturali agiscono selettivamente sui meccanismi autogeni e allogeni in modo da mistificare le contraddizioni politiche ed economiche
strutturali. Pensano le società come mosaici di monoculture dominanti, omogenee e dai confini ben precisi, in rapporto a monoculture minoritarie altrettanto chiuse. Essenzializzano la distinzione reciproca e
la coesione interna costruita, alternativamente, attorno a variabili culturali, genealogiche, territoriali, religiose, linguistiche o razziali.
L’ideologia identitaria forza le culture, costruite come entità fisse,
astoriche e impermeabili, all’interno degli spazi discorsivi della razza
contro i quali furono originariamente concepite. Le sue discipline, rischiano forti complicità con ciò che Taguieff (1988) ha denominato
“razzismo differenzialista”, reificando le differenze culturali e identificando organicamente le identità in termini irriducibili e incommensurabili. Interpretano i conflitti fra gruppi come prodotti apolitici di una
naturale xenofobia che impone la difesa di ogni cultura dal meticciamento di un’originale autenticità e purezza bio-culturale.
Il modello multiculturalista riproduce la logica del sistema sudafricano di segregazione razziale, dove studiosi della tradizione volkekunde
fornirono le basi ideologiche per il regime dell' apartheid. Utilizzando
gli strumenti dell'antropologia, così come furono elaborati in epoca coloniale, i "government anthropologists" e gli ideologi del National Party
– riuniti nel Ministero di Cooperazione e Sviluppo – scorsero nella divisione del paese in comunità etniche, concepite come "ontical, human
social units" (Coertze 1978), il rispetto delle singole tradizioni culturali locali, conservate nella loro naturalezza e lontane da possibilità di
contaminazione (Grillo, Rew 1985; Malighetti 2001).
L’articolazione dei gruppi sulla base dei sentimenti primordiali di
appartenenza è strutturalmente coerente con la costruzione del dominio,
la necessità di controllo e con la formazione di lealtà da parte dello Stato-Nazione moderno contro gli elementi critici che lo attraversano
(Stolcke 1995; Appadurai 1996). Espelle la dimensione del cambiamento, considerato come effetto dell’intervento di enti patogeni esterni come l'immigrazione ma non la globalizzazione, considerata, naturalmente, come fenomeno evolutivo e quindi "interno". Esclude la possibilità
I quaderni del CREAM , 2009, IX
46
di articolare le differenze secondo prospettive complesse (classe, genere, status, ruolo, età ecc.), riconoscendo le diversità solamente nei
termini univoci che sono istituzionalizzati dalle nicchie create dal multiculturalismo: l’adesione e l’appartenenza ad un’identità culturale uniforme è il prerequisito fondamentale per il riconoscimento sociale e
politico e per l’eventuale accesso alla cittadinanza.
In epoca coloniale le diverse amministrazioni hanno prodotto gruppi sociali attraverso l’identificazione dell’appartenenza etnica, religiosa, territoriale o razziale. Usando le politiche dell’indirect rule e della
cooptazione della leadership indigena basate sul modello dello stato
nazionale europeo, il sistema coloniale britannico ha inventato le tribù
in Africa (Southall 1970), ponendole l’una contro l’altra e governando
attraverso il conflitto e l’assegnazione selettiva di privilegi e potere:
paradigmatici, a tale riguardo, sono l’invenzione e l’uso del conflitto
fra Hutu e Tutsi in Rwuanda-Burundi, la separazione fra cingalesi e
tamil nell’allora Cylon a partire dalle leggi speciali britanniche a favore della creazione di un’élite anglofona, la funzione dei censimenti nel
promuovere una stratificazione delle “auto-identificazioni” coerenti
con l’esercizio del dominio.
I linguaggi dei protagonisti dei movimenti di liberazione e dei
leader della post-indipendenza hanno rinnovato – come ammoniva
Franz Fanon a proposito dei pericoli insiti nel feticismo delle identità
pietrificate – nuove forme di conflittualità e di oppressione, esercitate
direttamente dalle elites coloniali e dai nuovi gruppi dominanti. Quella
che Appiah (1991) definisce come intellighentsia compradora in quanto
mediatrice del commercio culturale con l’Europa, ha coniugato i fallimentari progetti di modernizzazione con il sostegno alle rivendicazioni
di identità primordiali, imperniate su una mimicry (Bhabha 1994) che
riproduce le rigide strutture frammentate del governo coloniale.
Le metafisiche dell’identità fanno parte dei discorsi che percorrono i linguaggi politici non solo dei conservatori occidentali o degli
stati ex-coloniali, ma anche delle forze progressiste e delle rivendicazioni identitarie di vari movimenti contemporanei. Non si manifestano solamente nelle forme di "populismo autoritario" (Hall 1985), che
saldano multiculturalismo, patriottismo, xenofobia e militarismo con
le retoriche dell’autenticità e della purezza di tradizioni culturali attribuite a gruppi omogenei, come ultimo ricorso per sostenere l’idenI quaderni del CREAM , 2009, IX
47
tificazione con i regimi e per costruire lealtà incondizionate contro le
contaminazioni dei gruppi subalterni, degli immigranti e dei devianti.
Sono altresì presenti nella riproduzione dell'idea verticale di "identità
nazionale" da parte dei governi progressisti, articolata in un’infausta rete di leggi speciali sulle minoranze, fondate sul presupposto che le politiche per tali gruppi siano specifiche, separate dai problemi dei cittadini
dello Stato, e, quindi, estranee ai concetti di nazione e comunità1.
Da queste prospettive le varie conformazioni di ciò che Spivak
(1999) chiama essenzialismo strategico, invece di costituire un cavallo
di Troia progressista in grado di aprire spazi di partecipazione politica
e civile, colludono con le logiche reazionarie. Inserite in un quadro fenomenologico come “errore necessario” per raggiungere il riconoscimento di diritti civili e politici, le differenti “azioni affermative” e
“positive”, o, come vengono forse meglio chiamate le “discriminazioni positive”, rischiano di alimentare forme di razzismo differenzialista
(Taguieff 1988), di assolutismo etnico (Gilroy 1993) o di identità tribale (Clifford 1997) congruenti con le politiche dominanti. Difendendo la seduzione nativista nei confronti di una presunta purezza etnica naturale e originaria, operano una sorta di “congelamento metonimico” (Appadurai 1996) che circoscrive e omologa le identità individuali e collettive nelle riserve a cui vengono fatte appartenere da poteri allogeni. Legittimano l’uso di categorie politiche e disciplinari –
come la razza e le ideologie razziali – negate dalla storia prima ancora
che dalla scienza. Soprattutto non riescono a conseguire gli obiettivi
prefissati di rafforzare i soggetti più deboli, per cui sono disposte a correre rischi molto gravi e restituire le scienze sociali a un antico e funesto
passato2. Al contrario, sostengono forme di subordinazione e di esclusione, organizzate e contenute all’interno di dispositivi verticali che
neutralizzano, frammentandole, le possibilità di lotte e solidarietà o1
Ricordano il sistema giuridico coloniale olandese che aveva pensato la società del
Suriname come plural society fondata su una legislazione oligarchica che identificava
in termini etnico-razziali rigidi e fissi i cittadini, sottomettendoli a un codice civile e
penale che variava in funzione della categorizzazione prodotta dal governo (Dew
1994, Suparlan, 1995).
2
Di particolare interesse, a riguardo, sono i lavori sul supporto delle scienze umane ai
programmi nazisti e dei regimi totalitari (Dow Lixfeld 1994; Conte, Essner 1995;
Shaff 2002).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
48
rizzontali fra differenti categorie di esclusi. In India le quote riservate
nel settore pubblico e nelle università hanno beneficiato le caste identificate dal governo come “inferiori”, a discapito di altri cittadini marginalizzati. In Sud Africa, la discriminazione positiva e le generiche
strategie Bee (Broad-Based Black Economic Empowerment Act), non
hanno avuto alcun impatto sulla redistribuzione delle ricchezze. Negli
Stati Uniti la discriminazione positiva che privilegia le appartenenze
razziali a discapito della povertà in generale, non solo si è contrapposta al sogno di Martin Luther King per un futuro «indifferente al colore della pelle», ma non intacca la promozione di una maggior giustizia
sociale. In Brasile le astratte politiche delle quote riservate alla popolazione nera e indigena nelle università, hanno inaugurato imbarazzanti politiche dell’identificazione razziale ed etnica, oltre a mistificare le
cause socio-economiche dell’esclusione accademica. In Francia e in
Italia, il tentativo dello stato di organizzare servizi diseguali mobilita
l'interesse contro gli effetti superficiali, rendendosi funzionale a impedire una seria riconsiderazione dell'ordine sociale razzista.
Il tragico ossimoro
Le politiche multiculturali configurano le logiche identitarie secondo strategie che assumono le figure contrastive della chiusura e della
minaccia (Remotti 1995; Appadurai 2005). Implicano differenti modalità di katharsis che purifichino dallo sporco interno e dalla contaminazione esterna ed esercitino violenza contro le connessioni, il flusso temporale e il cambiamento (Douglas 1966). L’affermazione di un
nucleo sostanziale sottrae i diritti, i privilegi, le prerogative, le conquiste, il territorio dell’idem, al dibattito, alla negoziazione e quindi
all’alterazione. La costruzione dell’alter come minaccia a una supposta indiscutibilità e inalterabilità, rende intollerabile qualsiasi alterazione dell’integrità: le minoranze, gli esseri umani insufficienti (disabili, anziani, malati), i devianti sono considerati sovversivi rispetto al
rapporto che pone in reciproca definizione la purezza, la totalità e il
confine sociale inviolato e divengono i primi obiettivi dell’emarginazione e delle epurazioni (Douglas 1966; Remotti 1995; Appadurai
I quaderni del CREAM , 2009, IX
49
2005)3. La fragilità strutturale dell’identità realizza le contraddizioni
del multiculturalismo e porta le politiche multiculturali a passare dalla
difesa di un neutrale e oggettivo pluralismo, a forme di aggressione
contro le sozzure (Clifford 1988): la “soluzione finale” dell’altro risolve il multiculturalismo nel suo opposto.
La pulizia etnica ha attraversato la storia dell’umanità, costituendo,
in quanto processo di uniformazione, l’atto fondativo delle realtà statali (Baumann 1989; Gourevitch 1998). La “violenza strutturale” (Farmer 2003) é un tecnica per “immaginare una comunità” (Anderson,
1983) che permette di identificare concretamente le astratte categorie
etniche, attribuite a un improbabile “medesimo” da proteggere, e, nel
contempo, ad un “altro” da “pseudo-specificare” (Erikson 1966) e da
mutilare: dell’umanità, dei diritti, della cittadinanza, della vita o anche
di parti del corpo, segno tangibile della negazione della sua presenza
(Feldman 1991; Malkki 1995; Hayden 1996; Herzfeld 1997; Appadurai
2005).
Diverse prospettive antropologiche (Daniel 1996; Desjarlais, Kleinman 1994; Hayden 1996; Malkki 1995; Nordstrom 1997; Tambiah 1996)
considerano la violenza come un ingrediente dell’identità che si esprime nei tentativi di imporre i modelli ideali dell’uniformità su realtà sociali e strutturali in costante alterazione. La violenza estrema e
spettacolare è considerata un modo per produrre quello che Appadurai
(1998) ha definito “adesione totale” e che Gourevitch ha descritto, a
proposito del genocidio in Ruanda come “pratica di costituzione della
comunità” (1998, p. 95). Si è costituita a partire da una forma di modernità fondata su idee di maggioranza e minoranza derivate dai censimenti e sostenute dalle rappresentazioni mediatiche del sé e dell’altro. Come suggerisce Appadurai (2005), entrambe recano in sé il seme
del genocidio fondato su politiche identitarie e su mappe necrografi3
Forme di violenza intransitiva che operano concettualmente prima di manifestarsi
nell’azione, sono presente in ogni istituzione chiusa, promotrice di confini e di identità (Bowman 2001). Si materializzano in modalità diffuse di esclusione sociale, disumanizzazione, spersonalizzazione, che normalizzano il comportamento brutale e la
violenza verso gli altri. Sono presenti anche nelle politiche repressive delle istituzioni
totali attraverso modalità definite da Basaglia come “crimini di pace” che cancellano
la dignità di individui stigmatizzati come non persone (Basaglia, Ongaro Basaglia
1975; Scheper-Hughes 1997).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
50
che: alimentate da retoriche pseudo-demografiche, reagiscono alle minacce cercando di eliminare lo sporco che le separa dalla purezza
(Appadurai 2005)
La deriva etnonazionalista e spesso etnocida dipende dalla profonda
reciprocità che sussiste nel pensiero liberale fra le categorie di maggioranza e minoranza, intimamente connesse alle concezioni di nazione,
popolazione, rappresentatività, tecniche di conteggio e di classificazione
(Appadurai 2005). La violenza intrastatale nasce da qualche concezione
del’ethnos come univoco e orientato alla completezza e dall’idea – alimentata dalla duttilità dei censimenti – che maggioranza e minoranza
possano invertirsi di ruolo. I separatisi etnici muovono dall’identità
etnica, razziale o religiosa per rivendicare a sé il potere dello Stato
(Kaldor 1999). La forza di tale processo si manifesta nella capacità di
smantellare le comunità esistenti e sostituirle con nuove. Il caso Iugoslavo esprime il ruolo cruciale del “nazionalismo dall’alto” (Zimmermann 1995), fondato sulla possibilità di aggregazione statale su base
etnica. Le politiche nazionaliste nella Iugoslavia di fine anni Ottanta e
dei primi anni Novanta trasformarono quelli che prima erano territori
abitati da concentrazioni di vari gruppi che coesistevano strettamente
intrecciati, in uno Stato governato da membri di una nazione maggioritaria: alla vigilia dell’esplosione della violenza i livelli di eterogeneità nazionale erano in costante aumento per numero crescente di matrimoni misti, di nascite da genitori misti, e di identificazioni come iugoslavi e non come appartenenti a minoranze o categorie etno-nazionali (Hayden 1996). Il conflitto, determinato da specifiche scelte politiche, utilizzò elementi culturali e mediatici come supporto ideologico
alla creazione di forme di opposizione complementare intorno a precisi interessi economici o politici, riuscendo a mettere in campo un efficace apparato in grado di convincere che i croati fossero nazisti ustasha, i serbi assassini cetnici e i mussulmani bosniaci l’avanguardia
della minaccia islamica (Hayden 1996).
Extra ordinem
L’apparato delle leggi speciali nei confronti di gruppi selezionati,
identificando parti della società al di fuori del diritto, introduce preocI quaderni del CREAM , 2009, IX
51
cupanti elementi di scarsa consistenza democratica. Produce una sovranità definibile con Carl Schmidt come il potere di proclamare lo
stato di eccezione, di sospendere “legalmente” la validità della legge e
i fondamenti giuridici dello Stato, esercitando un dominio arbitrario
senza alcuna mediazione
La storia e la cronaca mostrano come in nome della sicurezza,
dell’accoglienza, del soccorso o dei diritti umani, lo stato di eccezione
autorizzi poteri enormi agli esecutivi, promuovendo una rivoluzione
autoritaria, spesso gestita attraverso i media (Ackerman 2004). La ricorrente ricorsa a mezzi straordinari e la deroga temporale e contestuale alle norme finisce con lo standardizzarsi e diventare una modalità consuetudinaria e mobile del contratto sociale. L’inversione del
rapporto tra regola e emergenza produce un effetto perverso di continuità e ubiquità dell’emergenza, congruente con le strategie dei poteri
che possono trarre profitto dall’universalizzazione di tale stato (Benjamin 1955; Agamben 2003).
I dispositivi dell’emergenza determinano una situazione paradossale, extra ordinem, una forma di esclusione che si materializza nelle legislazioni sempre più repressive e negli spazi riservati: nei campi dei
rifugiati, degli immigrati, dei clandestini, delle vittime, dei prigionieri
di guerra, degli uomini e delle donne trafficati, traumatizzati, mutilati.
Questi luoghi sono popolati da esseri umani trasformati in entità astratte destinate a essere identificate, censite, contate e quantificate,
catalogate, ed etnicizzate. Mentre la legge classica pensa in termini di
individui e di società, cittadini e stato, il dispositivo dell’emergenza
ragiona in termini di corpi indistinti e de-localizzati, da nutrire, sfamare, vestire, curare, secondo le strategie e le categorie diagnostiche dell’amministrazione, esportabili in tutti i contesti. La dimensione biopolitica evidenzia le nuove condizioni giuridico-politiche dei rapporti
fra Stato e individui, svelando i rischi e i paradossi esistenti negli stessi sistemi giuridici delle democrazie moderne: in nome della sicurezza, dell’accoglienza, del soccorso o dei diritti umani, i cittadini sono
trasformati in semplici corpi o nuda vita (Agamben 1995).
Sotto la pressione dell’urgenza, l’intensa attività si fissa come non
negoziabile. Trasfigura i problemi sociali in questioni tecniche ed emergenziali, inaugurando modelli organizzativi che fondano la loro
legittimità sulla performatività e sull’efficacia in maniera totalizzante
I quaderni del CREAM , 2009, IX
52
a discapito di modalità alternative di intervento. La riflessione critica
sulle contraddizioni o sulle cause della marginalità e dell’esclusione è
eliminata. I fattori disgreganti sono al massimo considerati in termini
apolitici, meccanici e naturali, come semplici risultati di esplosioni
sporadiche legate a stati endemici di warfare tribalistica o ad una storia significativamente ritenuta locale e mai globale. L’interazione evidente fra attività umane e catastrofi naturali, come anche fra catastrofi
naturali e fattori politici, è rimossa insieme agli effetti determinati dai
cosiddetti “equilibri internazionali” e alle competizioni su risorse in
continua diminuzione. In quanto “macchine anti-politica”, le configurazioni emergenziali sospendono la “politica” alimentando il fatalismo, il clientelarismio, l’assitenzialismo e la dipendenza (Fergusson
1990). Imprigionano i progetti alternativi e neutralizzano le potenzialità di innovazione locali, considerando i problemi fondiari, delle risorse, dell'occupazione o dei salari come problemi esclusivamente
"tecnici". Molto spesso si servono dell’apporto della logistica e di
meccanismi garanti l’ordine, la stabilità e la sicurezza, estendendo quella che Giorgio Agamben (1995) definisce la “zona grigia” di operazioni
militari giustificate come operazioni umanitarie in cui gli attori civili
hanno sempre meno margini di autonomia e libertà. La fine dell’emergenza produce la sospensione dell’attenzione dei media, l’immediata
interruzione dell’intervento, il trasferimento della macchina organizzativa in nuovi scenari emergenti dello scacchiere geo-politico.
In nome dell’emergenza vari dispositivi e tecniche di soggettivazione (associazioni, centri di prima accoglienza, tribunali, servizi sociosanitari, scuole, ONG) agiscono sul territorio come ciò che Appadurai (1996), chiama “sovranità mobili”, realtà che si spostano imponendo regole e imperativi, legittimati sotto la bandiera di valori indiscutibili. “Esperti di soggettività” (Rouse 1995) o “modernizzatori intermedi” (Rabinow 2003), esercitano potere e sovranità adattando e
ridefinendo le pratiche di governamentalità (Foucault 1994). Una pletora di managers, burocrati, scienziati, tecnici, volontari, cercano di
tradurre attraverso il filtro delle loro ambizioni, interessi e capacità, le
politiche globali in quelle locali. Disaggregano le reti di influenza,
modificano i sistemi di potere pre-esistenti, concepiscono nuove alleanze e confondono le strategie d’autorità dei poteri locali: designano
competenze, distribuiscono ruoli e integrano gruppi locali nel circuito
I quaderni del CREAM , 2009, IX
53
nazionale e internazionale come negoziatori di nuove forme di governance. Spesso, in una riedizione delle politiche dell’indirect rule, favoriscono la cooptazione delle ledearship, alimentando, nel contempo,
le forme di esclusione già esistenti.
Comunità di esperti e di poteri coercitivi si mobilizzano costringendo alla partecipazione (o, meglio, a essere partecipati) solamente
in termini di identità artificialmente prodotte dai linguaggi e dalle categorie dei progetti. Ignorano la varietà delle relazioni di potere che
determinano l’utilizzo e il controllo delle risorse, nonché la molteplicità dei modi in cui tali relazioni di potere si articolano con le varie forme di stratificazione sociale. Costruiscono – selezionando e quindi escludendo – gli interlocutori e i gruppi sociali secondo modelli integrati e visioni stereotipate che enfatizzano l’omogeneità, la solidarietà
interna e le capacità d’azione collettiva, producendo forme di comunità locali tribalizzate all’interno di confini territorialmente, linguisticamente, razzialmente, etnicamente autentici e puri, analoghe a quelle
create dall’antropologia al servizio dei progetti di sviluppo delle varie
amministrazioni coloniali.
Le mutazioni del capitalismo determinate dalla crisi del welfare
state keynesiano, dall’apertura dei mercati al neo-liberismo, dal crollo
del sistema westfaliano delle relazioni internazionali fondato sulla sovranità degli Stati e dall’affossamento dell’ONU dopo l’11 settembre,
hanno promosso una gestione “privata” dell’umanitario. Associazioni
e organizzazioni non governative sono entrare a far parte di un sistema
di relazioni con le istituzioni politiche, economiche e gli attori privati,
assumendo un ruolo crescente di rappresentanza e partecipando a importanti processi decisionali, grazie allo statuto consultivo conferito
loro dalle istituzioni nazionali e internazionali. Dovendo affrontare la
competizione per la raccolta dei fondi si trovano costrette a mettere in
campo un imponente apparato in grado di rincorrere le emergenze. Attraverso la retorica della compassione e la semiotica dell’immagine,
producono eventi comunicativi a colpi di dichiarazioni e di immagini
dal forte carattere emotivo per evocare l’indignazione, la compassione
e la necessità morale dell’azione. L’ostentata e insieme fortemente
censurata visibilità, accecante nella sua vacuità, segue registri molto
più sensibili alla drammatizzazione dell’evento umanitario e molto
meno alla miseria ordinaria. Uno degli esiti dell'aiuto umanitario è un
I quaderni del CREAM , 2009, IX
54
rilevante deficit democratico a sostegno del potere economico e politico di vere e proprie caste locali di tecnocrati e oligarchi mafiosi, come
è avvenuto nell'ex Unione Sovietica. Libere dalle reti del controllo elettivo, accedono, attraverso le loro ONG, ai finanziamenti, controllano gli organismi internazionali che erogano fondi ed esercitano le
loro pressioni e la loro egemonia sui media e sulle istituzioni politiche.
Senza identità
In un panorama che la cultura egemonica non riesce ad imporre in
termini omologanti e totalizzanti, diverse forme di soggettività riescono
a sfuggire alle tecniche di governamentalità statale e alle pratiche di
“normazione”. Queste agencies aprono spazi antropopoietici che smantellano i sistemi di classificazione, svuotano e superano le identità,
configurandosi in termini contingenti e precari, come reti che coinvolgono una molteplicità di posizionamenti. Rifiutano la propria fondazione in termini assolutistici e contraddicono i poteri dominanti e i
tentativi di promuovere un’ideologia felice e “rappacificata” del multiculturalismo e della globalizzazione come qualcosa di inevitabile e di
già compiuto, che risolve i conflitti e l’articolazione interna. Ne mostrano, invece, la complessità nelle pratiche e nei microprocessi della
vita quotidiana, sottratte a una singola logica ed articolate in arene in
continua effervescenza in cui differenti visioni del mondo, interessi e
poteri si collegano, si contrappongono e colludono (Hannerz 1992;
Appadurai 1996; Clifford 1997; Amselle 2001).
Varie esperienze “dal basso” mettono in discussione il rapporto esoticizzante fra distanza e differenza e l’immediata coincidenza di
luogo, cultura e identità (Canclini 1998; Gupta, Fergusson 1997; Malighetti 2007). Sottraggono il globale all’universalità astratta con cui
viene imposto dalle ideologie dominanti, collocandolo nella sue articolazioni reali, necessariamente locali e particolari. Offrono la possibilità di trascendere la reificazione delle differenze e considerano, da
un lato, le "culture tradizionali" nel loro coinvolgimento trasformativo
con la modernità: inseriscono le idee e le pratiche della modernità nelle pratiche locali, frammentando e disperdendo la modernità nelle rielaborazioni “micro-moderne” in costante proliferazione. Dall'altro perI quaderni del CREAM , 2009, IX
55
mettono di pensare le realtà contemporanee non in termini omologanti, ma secondo concetti complessi, come ibridazione e meticciamento
che costituiscono, come sottolinea Appadurai, un valido antidoto alle
pulsioni etnocide (Appadurai 2005, p. 132)
Le “articolazioni” (Clifford 1988) gli ethnoscapes (Appadurai 1996)
sostituiscono all'idea di processi che dovrebbero rimpiazzare il moderno al tradizionale, l'idea di una modernità multipla (Comaroff,
Comaroff 1993), intesa come un insieme di realtà negoziali prodotte
essenzialmente dalla coappartenenza (Gadamer 1965) della modernità
e della tradizione, del globale e del locale (Malighetti 2005). Le “sozzure” (Clifford 1993) sarebbero, cioè, fertilizzanti per nuove sintesi ed
“emersioni” culturali e sociali: generano potenti controtendenze rispetto alle strategie globalizzanti, mostrando un dinamismo fondato sulla
fusione, sulla mescolanza e sull’opposizione.
Le soggettività locali segnate da tradizioni molteplici, hanno importanti contributi da apportare alle configurazioni culturali e agli
sforzi intellettuali e politici, rompendo il tempo lineare del discorso
occidentale (Benjamin 1955). La loro condizione “ibrida” abdica all'ambizione di riscoprire la purezza culturale o l’assolutismo etnico. Si
appropria, invece, dello spazio catacretico (Spivak 1999) focalizzato
su quella dimensione dell’arena sociale in cui i soggetti recuperano i
significati, traducendoli e imponendo su di essi i propri segni.
La considerazione delle rielaborazioni locali della modernità riconosce l'intensità, la rapidità e le proprietà auto-organizzanti di parte
del cambiamento sociale contemporaneo e rivela come i differenti
messaggi vengano tradotti, miscelati e rielaborati da attori localmente
situati ed organizzati. Invita a giudicare le possibilità aperte alle pratiche “di base” per produrre creazioni originali ed escogitare i mezzi per
liberare le società dall’immaginario della modernizzazione e per diminuirne la dipendenza dall’episteme della modernità.
Laboratori di forme di umanità e di produzione culturale portano
avanti pratiche di cambiamento sociale, culturale, economico e politico, che si sottraggono ai meccanismi della dipendenza e del dominio
(Appadurai 2005; Escobar, Lins Ribeiro 2005; Malighetti 2005). Si
fondano sulla diversità culturale, intesa come forza in costante mutamento e quindi, innovativa, e sulla valorizzazione dei bisogni e delle
opportunità economiche in termini diversi da quelli del profitto e dello
I quaderni del CREAM , 2009, IX
56
sviluppo modernizzante. Tentano di superare i fallimentari approcci
assistenzialistici, i frammentari interventi emergenziali e le compassionevoli e contraddittorie azioni umanitarie, a favore di iniziative integrate
e multisettoriali fondate sul protagonismo e le potenzialità alternative
delle risorse umane locali. Cercano modi di crescita collettiva che non
privilegino un benessere materiale devastante per i legami sociali e per
l'ambiente, rompendo con quell'impresa di distruzione che si perpetua in
nome della globalizzazione e dello sviluppo (Escobar 1995).
I nuovi attivismi transnazionali superano gli obiettivi dei grandi
movimenti dei secoli XIX e XX, fondati sui principi di solidarietà, identità e interessi universali, in opposizione ad avversari concepiti in
forme altrettanto generiche. Costruiscono nuove dimensioni globali non
attraverso concezioni universalistiche dei problemi, dei diritti o delle
norme, ma tramite strategie contingenti che considerano un problema,
un’alleanza, una vittoria alla volta (Appadurai 2005, p. 131). Producono
solidarietà a partire da convergenze di interessi più ristrette e in modi
più specifici, induttivi e contestuali, ponendo l’interconnessione globale
al servizio di forme locali di potere (Appadurai 2005, p. 132).
La scommessa politica dei gruppi “marginali” consiste nella capacità di contrapporsi agli assiomi del nazionalismo e della modernità
nella loro forma egemonica. Come “contromodernità” mostrano che
ogni cultura è sempre stata meticcia o multiculturale, prodotto di una
lunga storia di appropriazioni, resistenze, compromessi in continuo
mutamento, di antagonismi, incoerenze, contraddizioni. Le culture non
sono "impazzite" (Clifford 1988) solamente nella contemporaneità a
causa della globalizzazione che non è un fenomeno recente, avendo
costituito, attraversandola, la storia dell’umanità, da quando i primi
afro-discendenti lasciarono l’Africa Orientale circa settantamila anni
fa. Prima della creazione della forma dello stato-nazione europeo e
della sua esportazione planetaria, il mondo pullulava di società senza
nome e senza confini, o che disponevano di termini molto generici per
definire il sé collettivo indicanti condizioni, status, posizioni economiche o politiche.
Delocalizzate e deterritorializzate le culture e le identità emergono
come vere e proprie finzioni, forme di rappresentazione del sé relazionali in continua trasformazione nell'ambito dei rapporti che un
gruppo umano intrattiene con altri e con il contesto che li contiene. InI quaderni del CREAM , 2009, IX
57
vitano a considerare “chi crea e chi definisce” o “chi manipola nella
contingenza e a quale scopo” i significati culturali, attraverso quali dinamiche e investendo quali “tratti” e in accordo a quali prospettive egemoniche nelle differenti contingenze (Malighetti 2008). In una sorta di “politica economica della conoscenza” (Keesing 1974), spingono a riflettere
sull’intreccio fra sistemi simbolici e sistemi di potere e sulla produzione e
riproduzione di forme culturali, non prescindendo dal riferimento al rapporto fra processi socioeconomici e geopolitici globali e locali.
Cittadinanze negoziali
I fenomeni di meticciato, di sincretismo, di creolizzazione, di trasnculturazione (Ortiz 1940) caratteristici delle situazioni coloniali
(Balandier 1955), possono essere recuperati come modelli paradigmatici delle soggettività contemporanee. La condizione diasporica dei
gruppi ai margini della storia, dei popoli colonizzati, degli schiavi, degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati, degli esuli, degli espatriati
diviene il precedente storico del soggetto decentrato e delocalizzato
dall’accelerazione di quelli che Giddens ha definito “meccanismi disgregatori” e “dislocanti” della globalizzazione (Giddens 1990).
Il concetto di diaspora permette di decostruire le identità culturali
superando la logica binaria del pensiero colonialista connotata in termini biologico-naturali e razzisti. Rimanda al riconoscimento dell'eterogeneità e della diversità e ad una concezione delle soggettività che
vivono attraverso, non malgrado, la varietà e il cambiamento. Percorse da diversi mondi culturali, con diverse storie, lingue e tradizioni,
queste soggettività articolano forme di appartenenze multisituate
(Marcus 1998, pp. 79-104), riproducendosi continuamente mediante
la "trasformazione" e la "differenza"4. L’Atlantico Nero è la metafora
dei riconoscimenti culturali, politici ed estetici irriducibili a qualsiasi
4
Gilroy (1987) studia i neri inglesi in alternativa all'ideologia dell'assolutismo etnico dei
discorsi del “nuovo razzismo britannico” ma anche alle concezioni del nazionalismo
culturale nero. Come ricorda Mellino (2005, p.141) l’identità giamaicana è considerata da Hall nei suoi aspetti ibridi: dal mix di colori che caratterizza la popolazione
alla miscela di gusti e sapori diversi della cucina, all'estetica del crossover e del cut and
mix che è alla base della musica (Hall 1990).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
58
tradizione nazionale e base etnica, alle strutture statali, alle limitazioni dell’identità, dell’etnia e della razza. Le travelling cultures (Gilroy
1993) possono essere concepite come "controculture della modernità", forme di creatività culturale, prodotte da confronti, incontri fusioni e resistenze che sfidano le concezioni della nazionalità, dell'etnicità, dell'autenticità o dell’integrità culturale.
Il transnazionalismo inteso non solo come dimensione di vita attraverso i confini, ma soprattutto come rifiuto dell’assimilazione e, contemporaneamente, come strategia volta a lottare contro l’esclusione,
può essere visto come uno spazio dove i soggetti articolano forme di
potere alternative a quelle basate sulla sempre più improbabile omogeneità, universalità e territorialità della nazione come presupposto e
base fondamentale dello Stato. Impone la riconsiderazione dei fondamenti della cittadinanza e delle relazioni – non più immediate – fra
Stato e Nazione (Habermas 1996), come anche dei legami fra individui, Stato e forme alternative di potere che intervengono nella regolamentazione delle vite delle persone. Presenza assente (Sayad 1991), il
soggetto transnazionale definisce le proprie appartenenze multiple e
gli adattamenti a partire dalle articolazioni fra varie comunità politiche
e economiche, dalla flessibilità della sua posizione geografica e sociale, dalle residenze temporanee e dalle rimesse di denaro.
I limiti del concetto di cittadinanza sono messi alla prova dallo
scarto fra cittadinanza formale e sostanziale e dalla permanenza di
meccanismi di esclusione al di là della cittadinanza che definiscono
negativamente i corpi sociali. Invece che una struttura monolitica esterna rispetto alle preoccupazioni e alla vita quotidiana delle persone,
la cittadinanza può essere pensata come uno spazio vissuto (Holson,
Appadurai 1996) e un processo dialogico (Grillo, Pratt 2006). In quanto tale può essere misurata attraverso l’analisi delle micro-dinamiche
di inclusione ed esclusione, inscritte nelle vite dei soggetti e luoghi in
cui i diritti vengono negoziati, realizzati o negati.
La crescente complessità delle categorie sanziona diversi statuti
socio-politici e giuridici: dal pieno cittadino senza diritti regolari, al
residente senza cittadinanza; dal lavoratore stagionale al rifugiato; dal
richiedente asilo ai cittadini con più passaporti, fino ai clandestini che
attraversano i confini senza permesso o che non riescono a rinnovare il
visto. Da un lato i nuovi regimi di cittadinanza hanno esteso la cittadiI quaderni del CREAM , 2009, IX
59
nanza ai membri non residenti della maggioranza etno-nazionale, attraverso procedure di naturalizzazione, applicate soprattutto al caso delle
elites: significativamente le forme più forti del nazionalismo sikh sono
australiane; i più oltranzisti nazionalisti croati sono nati in Canada;
gran parte dei più ferventi nazionalisti algerini sono francesi; molti dei
più radicali nazionalisti cinesi sono americani (Anderson 1983, pp.5557). Contemporaneamente la cittadinanza è negata a molti residenti
che non appartengono al gruppo dominante, trasformando – attraverso
un processo di de-naturalizzazione – coloro che hanno sempre vissuto
in un determinato territorio, da cittadini a stranieri. I casi di cittadini
che attraversano le categorie della sistema giuridico, mostrandone le
contraddizioni sono numerosi, spaziando dai cittadini iugoslavi, a
quelli del Commonwealth residenti in Great Britain, dagli indigeni agli indigenti, dai meninos de rua ai favelados, dai disoccupati ai portatori di handicap. Queste categorie esistono solamente come problemi
sociali e come minacce all’ordine costituito. I loro statuti negativi
(senza terra, senza lavoro, senza diritti, sans papiers) mobilizzano le
forse armate dello Stato e, in molti casi, dei poteri paralleli del narcotraffico, delle mafie, o degli interessi socio-economici nell’obiettivo
comune di eliminarli.
Differenti forme di soggettività sono portatrici di domande che non
si fondano semplicemente “sul diritto di essere diversi” rispetto alle
norme della comunità nazionale dominante, come nelle concezioni
delle politiche del “riconoscimento” di Charles Taylor (1994) o della
cittadinanza culturale di Renato Rosaldo (1993). Inaugurano, piuttosto, pratiche di ciò che Ong (1999) chiama “cittadinanze flessibili”,
articolazioni delle affiliazioni contingenti e complesse con le appartenenze e le negoziazioni multiple. Si propongono come alternative etiche e politiche nella lotta contro i diversi tipi di particolarismi culturali
e razziali promossi sia dalle destre conservatrici e liberiste, sia dalle
sinistre, altrettanto conservatrici e, naturalmente, liberiste. Non celebrano un astratto universalismo egalitario o un vuoto “sradicamento"
o un’indifferenza alle tradizioni o alle appartenenze (Robins 1993). Al
contrario raccolgono localmente le sfide dei cosmopolitismi discrepanti (Clifford 1997), vernacolari (Bhabha et. Al. 2002), multisituati
(Robinson 1992), o critici (Rabinow 2003). Sviluppano forme di glocalismo politico che superano il concetto di identità e rilanciano le difI quaderni del CREAM , 2009, IX
60
ferenze culturali nell'ethos dell'interdipendenza. Si configurano in
termini di negoziazione fra i diversi gruppi che lottano per i propri
diritti (Balibar 1995) attraverso il dialogo e la cooperazione.
Prospettive che non coinvolgano l’identità inaugurano possibilità di
elaborare politiche aperte e disponibili alle negoziazioni e all’unione.
Sottraendosi alle inquietanti naturalizzazioni e alle pericolose logiche
multiculturali, permettono di sostenere l’identificazione contingente e
artificiale, e quindi pienamente politica, di obiettivi e valori comuni.
Bibliografia
Amselle J.L. 2001, Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures,
Paris, Flammarion; trad. it. 2001, Connessioni. Antropologia dell'universalità
delle culture, Bollati Borignhieri, Torino.
Ackerman B. 2004, The Emergency Constitution, Yale Journal of Law, vol. 113,
pp. 1029-1091; trad. it. 2006, La costituzione di emergenza. Come salvaguardare la libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo, Meltemi Editore, Roma.
Agamben G. 1995, Homo Sacer I. Il potere sovrano e la vita nuda, Einaudi, Torino.
Agamben G. 2003, Stato di eccezione, Homo Sacer II, Bollati Boringhieri, Torino.
Anderson B. 1983, Imagined Communities. Reflections on the Origins and
Spread of Nationalism, Verso, London; trad. it. 1996, Comunità immaginate,
Il Manifesto libri, Roma.
Appadurai A. 1996, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization,
University of Minnesota Press, Minneapolis-London; trad. it. 2001, Modernità in polvere, Meltemi, Roma.
Appadurai A. 1998, Dead Certainty. Ethnic Violence in the Era of Globalization,
Pubblic Culture, vol. 10, n. 2, pp. 225-247.
Appadurai A. 2005, Sicuri da morire. La violenza nell’epoca della globalizzazione, Meltemi, Roma.
Appiah K.A. 1991, Is The Post in Post-Modernism the Post in Post-Colonialism?,
Critical Enquiry, vol. 17, pp. 336-357.
Balandier G. 1995, Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, Presses Universitaires
de France, Paris.
Balibar E. 1988, Race, nation, classe, les identités ambiguës, La Découverte, Paris.
Basaglia F., Ongaro Basaglia F. 1975, Crimini di Pace, Einaudi, Torino.
Baumann G. 1996, Contesting Culture, Cambridge University Press, Cambridge.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
61
Benjamin W. 1955, Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main; trad. it.
1976, Angelus Novus, Einaudi, Torino.
Bhabha H.K. 1994, The Location of Culture, Routledge, London,; trad. it. 2001, I
luoghi della cultura, Meltemi, Roma.
Bhabha H.K. et al. 2002, Cosmopolitanism, Public Culture, vol.12, n. 3, pp. 1-13.
Bowman G. 2001, The Power of Violence in Identity, B. E. Schmidt, I. W. Schroder
(a cura di), Anthropology of Violence and Conflict, Routledge, London.
Butler J. 1995, For a careful reading, L. Nicholson, Femninist Contentions,
Routledge, London.
Canclini G.N. 1990, Culturas Hìbridas, Estrategias para Entrar y salir de la
Modernidad, Banco de la Republica, Bogotà; trad. it. 1998, Culture ibride.
Strategie per entrare e uscire dalla modernità, Guerini e Associati, Milano.
Clifford J. 1988, The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography,
Literature, Art, University of California Press, Berkeley; trad. it. 1993, I frutti
puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Bollati Boringhieri, Torino.
Clifford J. 1997, Routes, Harvard University Press, Harvard; trad. it. 2001,
Strade, Bollati Boringhieri, Torino.
Coertze C. 1978, Volkekunde, South African Journal of Ethnology, n. 1, pp. 2-34.
Comaroff J., Comaroff J. 1993, Modernity and its Malcontents, Ritual and Power
in post-Colonial Africa, University of Chicago Press, Chicago.
Conte E., Essner C. 1995, La quête de la race. Une antropologie du nazisme, Hachette, Paris.
Daniel V.E. 1996, Charred Lullabies: Chapters in an Anthropology of Violence,
University of Chicago Press, Chicago.
Desjarlais R., Kleinman A. 1994, Violence and Demoralization in the New
World Disorder, Anthropology Today, vol. 10, n. 5, pp.9-12.
Dew E.M. 1994, The difficult flowering of Surinam: ethnicity and politics in a
plural society, Martinus Nijhoff, The Hague.
Dow J., Lixfeld H. 1994, The Nazification of an Academic Discipline. Folklore in
the Third Reich, University of Indiana Press, Bloomington.
Dumont L. 1966, Homo hierarchicus, University of Chicago Press, Chicago;
trad. it. 1991, Homo hierarchicus, Adelphi, Milano.
Erikson E.H. 1966, Ontogeny of ritualization in man, Philos. Trans Roy. Soc., n.
251.
Escobar A. 1995, Imagining a post-development era, J. Crush (a cura di), Power of
development, Routledge, London, pp.211-227; trad. it. 2005, Malighetti R. Oltre lo sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, Meltemi, Roma, pp. 187-218.
Escobar A., Lins Ribeiro G. 2005. World Anthropologies: Disciplinary Transformations in Contexts of Power, Berg, Oxford.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
62
Evans-Pritchard E.E. 1940, The Nuer, a description of the Modes of Livelihood
and Political Institutions of a Nilotic People, Oxford University Press, London; trad. it. 1975, I Nuer, un'anarchia ordinata, F. Angeli, Milano.
Farmer P. 2003, Pathologies of Power. Health, Human Rights and the New War
on the Poor, University of California Press, Berkeley.
Fergusson J. 1990, The Anti-Politics Machine: "Development", Depolitization
and Bureaucratic Power in Lesotho, University of Minnesota Press, Minneapolis; trad. it. parziale in R. Malighetti 2001 (a cura di), Antropologia Applicata, Unicopli, Milano, pp. 265-274.
Foucault M. 1976, La Volonté de savoir, Editions Gallimard, Parìs.
Foucault M. 1994, Il faut défendre la societé. Cours au Collège de France 19751976, Gallimard Seuil, Parìs.
Foucault M. 1964, L'usage des plaisirs. Histoire de la sexualité II, Gallimard, Paris.
Gadamer H.G. 1965, Wahreit un Methode, J.C.B. Mohr, Tubingen,; trad.it. 1987,
Verità e metodo, Bompiani, Milano.
Giddens A. 1992, Central Problems in Social Theory, Actions, Structure and
Contradictions in Social Analysis, University of California Press, Berkeley.
Gilroy P. 1987, There Ain’t no Black in the Union Jack, Routledge, London.
Gilroy P. 1993, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciuosness, Verso,
London; trad. it. 2003, The Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e
doppia coscienza, Meltemi, Roma.
Grillo R. Pratt J. 2002, The Politics of Recognizing Difference: Multiculturtalism
Italian-Style, Ashgate Publishing, Farnham; trad. it. 2006, Le politiche del riconoscimento delle differenze: multiculturalismo all'italiana, Guaraldi, Rimini.
Grillo R., Rew A. 1985, Social Anthropology and Development Policy, Tavistock, London.
Gupta A. Fergusson J. 1997, Anthropological locations. Boundaries and grounds
for a field science, University of California Press, Berkeley.
Habermas J. 1996, Kampf um Anerkennung im demokratischen Rechtsstaat, J.
Habermas, C. Taylor, Einbeziehung des Anderen, Suhrkamp, Frankfurt am
Main.
Hall S. 1985, Authoritarian Populism, a Reply to Jessop et al., New Left Review,
vol. 151, p.115-124.
Hall S. 1990, Cultural Identity and diaspora , J. Rutherford (a cura di), Identity,
Lawrence and Wishart, London.
Hannerz U. 1992, Cultural Complexity, Columbia University Press, New York;
trad. it. 1998, La complessità culturale, Il Mulino, Bologna.
Hayden R.M. 1996, Imagined communities and real victims, Self-determination
and ethnic cleansing in Yugoslávia, American Anthropologist, vol. 23, n. 4,
pp. 783-801.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
63
Hertzfeld M. 1997, Cultural Intimacy. Social Politics in the Social Organization of
Meaning, Columbia University Press, New York; trad. it 1998, La complessità
culturale. L'organizzazione sociale del significato, Il MUlino, Bologna.
Holson J., Appadurai A. 1996, Cities and Citizenship, Public Cultures, vol. 8, pp.
187-204.
Huntington S. 1994, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York; trad. it. 2001, Lo scontro delle civiltà e il
nuovo ordine mondiale, Milano, Garzanti.
Kaldor M. 1999, New and Old Wars. Organizaed Violence in a Global Era, Polity Press, Cambridge.
Keesing R. 1974, Theories of culture, Annual Review of Anthropology, vol. 3,
pp.73-97.
Latouche S. 1989, L'occidentalisation du monde, La Découverte Paris; trad. It.
1992, L'occidentalizzazione del mondo, Bollati Boringhieri, Torino.
Malkki L.H. 1995, Purity and Exile: Violence, memory and National Cosmology
among Hutu refugees in Tanzania, University of ChicagoPress, Chicago.
Malighetti R. 2001, Antropologia Applicata. Dal nativo che cambia al mondo
ibrido, Edizioni Unicopli, Milano.
Malighetti R. 2002, Il tragico ossimoro. Note sulla deriva monoculturale del multiculturalismo, Passaggi. Rivista Italiana di Scienze Transculturali, n. 4,
pp.38-52.
Malighetti R. 2004 Il Quilombo di Frechal. Identità e lavoro sul campo in una
comunità di discendenti di schiavi, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Malighetti R. 2005, Oltre lo sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, Meltemi,
Roma.
Malighetti R. 2007 (a cura di), Politiche dell’identità, Meltemi, Roma.
Malighetti R. 2008, Clifford Geertz. Il lavoro dell’antropologo, Utet, Torino.
Marcus G. 1998, Ethnography through the Thick and the Thin, Princeton University Press, Princeton.
Mellino M. 2005, La critica postcoloniale, Meltemi, Roma.
Nordstrom C. 1997, A different Kind of World Story, University of Pennsylvania
Press, Philadelphia.
Ong A. 1999, Flexible Citizenship. The Cultural Logic of Transnationality, Duke
University Press, Durham and London; trad. it. 2003, Cittadinanaza Flessibile, Raffaello Cortina, Milano.
Ortiz F. 1940, Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, J. Montero, Habana; trad. it. 2007, Il contrappunto cubano del tabacco e dello zucchero, Città
Aperta, Enna.
Rabinow P. 2003, Anthropos Today. Reflections on Modern Equipment, Princeton University Press, Princeton.
Remotti F. 1995, Contro l’identità, Laterza, Roma-Bari.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
64
Robertson R. 1992, Globalization, Social Theory and Culture, Sage, London.
Robins B. 1993, Secular Vocations. Intellectuals, Professionalism, Culture,
Verso, London.
Rosaldo R. 1993, Culture and Truth, BEACON Press, Boston; trad. it. 2003, Cultura e verità, Meltemi, Roma.
Rouse R. 1995, Questions of identity, personhood and collectivity in transnational migration to the United States, Critique of Anthropology, vol. 15, n. 4,
pp. 351-380.
Said E. 1993, Culture and Imperialism, Vintage, London; trad. it. 1998, Cultura e
imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente,
Gamberetti Editrice, Roma.
Sayad A. 1991, L'immigration ou les paradoxes de l'alterité, Eds. Universitaires,
Paris; trad. it. 2008, L' immigrazione o i paradossi dell'alterità, Roma, Ombre
Corte.
Sahlins M.D. 1961, The Segmentary Lineage, an Organization of Predatory Expansion , American Anthropologist, vol. 63, n. 2, pp. 332-345, ; trad. it. Il lignaggio segmentario: una organizzazione per l’espansione predatoria, U.
Fabietti (a cura di), Dalle tribù allo Stato. Saggi di antropologia politica, Unicopli, Milano.
Scheper-Hughes N. 1997, Peace-Time Crimes, Social Identities, vol. 3, pp.
471-497.
Shaff G.E. 2002, Scientific Racism in Service of the Reich. German Anthropology
in the Nazi Era, A. L. Hinton, Annihilating Difference, University of California Press, Berkeley.
Southall A. 1970, The Illusion of Tribe, Journal of Asian and African Studies,
vol. 5, pp. 28-50.
Stolcke V. 1995, Talking Culture. New Boundaries of Exclusion in Europe, Current Anthropology, vol. 36, n.1, pp.1-24.
Spivak G. 1999, A Critique opf Post-Colonuial Reason. Towards a History of
the Vanishing Present, Harvard University Press, Harvard; trad. it. 2004,
Critica della ragione postcoloniale, Meltemi, Roma.
Suparlan P. 1995, The Javanese in Suriname: Ethnicity in an Ethnically Plural
Society, Arizona State University Program for Southeast Asian Studies,
Tempe.
Taguieff P.A. 1988, La force du préjugé. Essai sur le racisme et des doubles,
Editions La Découverte, Paris; trad. it. 1994, La forza del pregiudizio, Il Mulino, Bologna.
Tambiah S. J. 1996, Leveling Crowds: Ethnonationalist Conflicts and Collective
Violence in South Asia, University of California Press, Berkley.
Taylor C. 1994, Multiculturalism, Princeton University Press, Princeton.
Tomlinson J. 1999, Globalization and Culture, Polity Press, Cambridge.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
65
Zimmermann W. 1995, A breakdown of the civil order. The Balkan Bloodbath,
International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 9, n. 3, pp. 401-422.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
66
SILVIA BARBERANI
1
L'INCONTRO TURISTICO
TRA EQUIVOCI E MALINTESI
Hosts e guests
La peculiarità dell'approccio antropologico al fenomeno turistico
consiste nell'assunzione del binomio hosts-guests2 – visitati e visitatori, membri delle comunità locali e turisti – come luogo di osservazione privilegiato delle dinamiche in atto nel reciproco incontro: l'interazione, intesa in termini di mutuo scambio, non riducibile a semplice
transazione economica né pensabile in termini di opposizione tra entità omogenee – la cultura ospitante e la cultura turistica –, consiste
piuttosto nell’incontro di aspettative, immagini, rappresentazioni identitarie talvolta contrastanti ma indissolubilmente interrelate.
Il binomio hosts-guests può essere storicamente scisso nei due orientamenti teorici che hanno assunto rispettivamente come oggetto di
studio uno dei due poli: l'antropologia del turismo che analizza il polo
degli hosts e l'antropologia dei turisti che si occupa invece del polo dei
guests.
L'antropologia del turismo si istituzionalizzò come disciplina solo a
partire dalla fine degli anni Settanta3 del secolo scorso, sulla scia delle
1
Ricercatrice, Università degli Studi di Milano Bicocca.
Termine elaborato dall’approccio antropologico al turismo, nel contesto del passaggio dal turismo a motivazione edonistica o turismo ricreativo (delle 4 “s”: sun, sex,
sea, sand), diffusosi a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso e legato alla
semplice liberazione dalla routine lavorativa, al turismo culturale.
3
L’atto di fondazione della disciplina consiste nella pubblicazione contemporanea di
due opere collettanee: Smith V. 1978 (a cura di), Hosts and Guests: The Anthropology
2
I quaderni del CREAM , 2009, IX
67
suggestioni esercitate dai Cultural Studies della scuola di Chicago e
dai Post Colonial Studies, da cui riprese l'idea che i popoli invasi, dai
coloni prima e dai turisti poi, fossero portatori di forme di resistenza e
di un'originale creatività culturale. Tale presupposto, applicato all'analisi del fenomeno turistico, consentì di dar voce ad attori sociali considerati fino ad allora passivi – gli hosts – in grado di gestire attivamente, attraverso il ricorso a strategie di difesa e processi di rappresentazione dell'autenticità, la presenza dei turisti.
Agli studi pionieristici degli anni Settanta, improntati alla difesa
delle comunità locali e alla denuncia delle conseguenze negative prodotte su di esse dall'impatto sociale, economico e culturale del turismo, analizzate in un'ottica acculturativa e dipendentista che individuava nelle comunità locali l'oggetto dello sfruttamento dei visitatori, fece seguito un mutamento di prospettiva che focalizzò l'attenzione sulla
rappresentazione che le comunità locali andavano elaborando del turismo internazionale e sulle conseguenti strategie di resistenza e ridefinizioni identitarie promosse dall'interesse turistico4. Il turismo, da elemento esterno che crea un impatto sulle comunità di ricezione, passivamente subito dai suoi membri, cominciò ad essere interpretato
come lo strumento mediante il quale gli hosts, considerati attori sociali
of Tourism e De Kadt E. 1978 (a cura di), Tourism. Passport to Development? Perspectives on the Social and Cultural Effects of Tourism in Developing Countries.
4
Gli studi sul turismo hanno ripreso la dicotomia teorizzata dagli economisti tra una
definizione di turismo come elemento catalizzatore delle differenze sociali e culturali
tra visitatori e visitati, da un lato e come “passaporto per lo sviluppo” (De Kadt 1978)
e motore di modernizzazione, dall’altro. Questa contrapposizione di matrice economica, riformulata nel contesto degli studi sociali, ha indotto gli antropologi del
turismo a distinguersi tra quanti considerano il turismo come forma di neocolonialismo (Nash 1981), strumento di commercializzazione e degrado delle culture ospitanti (Greenwood 1978) e, in anni più recenti, “forma compiuta della guerra” (Augé
1999, p.8) e “in molti spazi tropicali, l’ultima freccia all’arco coloniale con il suo
corredo di esotismo e di dominio dei mercati e delle menti” (Michel 2001, p. 38) e
quanti attribuiscono invece al turismo una funzione di mantenimento dei confini
culturali (Buck 1978), di rafforzamento delle tradizioni e incremento delle produzioni
artistiche (Mc Kean 1978, Picard 1995), di messa in atto di processi di rappresentazione dell’autenticità (Mac Cannell 1976), di resistenza (Boissevain 1996) e di costruzione identitaria (Bruner 2004).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
68
dotati di agency5, mettono in atto processi di resistenza e di costruzione identitaria nel contesto dell'incontro con l'alterità incarnata dai
guests.
Fu solamente all'inizio degli anni Novanta, come conseguenza del
ripensamento della metodologia etnografica fondata sul concetto di
campo, non più inteso secondo il modello della co-residenza di antropologo e nativi che l'ingombrante presenza dei turisti andava ad intaccare6, ma piuttosto in termini di viaggio (Clifford 1997), che gli antropologi cominciarono ad interessarsi anche al contesto di provenienza
dei turisti, superando in parte l'immagine negativa ascritta ad essi7 e
5
Concetto elaborato dagli esponenti della teoria della pratica che differisce dai più
generici “azione”, “capacità di agire” o “libero arbitrio”, evidenziando i vincoli sociali, culturali e linguistici entro i quali ha luogo l’azione e i modi in cui le persone hanno la possibilità di modificare le strutture sociali e politiche essendone a loro volta
influenzate; l’accento è posto sull'intenzionalità e la negoziazione interazionale.
6
La presenza dei turisti sui campi di ricerca degli antropologi è una realtà con cui da
sempre i ricercatori hanno dovuto confrontarsi, come attestano i commenti e le
reazioni a quelli che vengono comunemente considerati elementi esogeni contaminanti, annotati sui taccuini di autorevoli antropologi: M. Griaule, C. Lévi-Strauss, C.
Geertz, solo per fare qualche esempio. Tuttavia, nel corso degli anni, la diffusione planetaria delle pratiche di viaggio ha contribuito a rendere il contatto con le diversità
culturali un’esperienza che oggi permea il quotidiano di molti individui che finiscono
inevitabilmente con l’entrare in competizione con gli antropologi, non solo attraverso
l’invasione dei loro campi di ricerca, ma anche attraverso la produzione di discorsi,
fondati sulla testimonianza diretta e diffusi attraverso i racconti di viaggio effettuati al
rientro, che sembrano minacciare la stessa autorità etnografica tradizionale. L’evidenza di un’analogia di esperienza condivisa da antropologi e turisti, seppure caratterizzata da una peculiarità di sguardo e da finalità differenti, è stata oggetto di un vero e
proprio dibattito tra quanti, come M. Crick (1995), interpretano questo rapporto in
termini di parentela alla lontana -antropologi e turisti sono “distant relatives”- o, come
J. Boissevain (1996, p. 8), di “somiglianza di famiglia” -poiché accomunati dal desiderio di accedere alle “back regions”, per cogliere le dimensioni nascoste e intime
della cultura studiata, nel caso dell’antropologo, per potere esperire l’autentico, nel
caso del turista - e quanti, come M. De Certeau (1980), in termini di filiazione spuria,
rispettivamente fondate su una retorica della somiglianza che evoca la parziale
sovrapposizione di identità, e della differenza che implica invece una definizione del
turista come il “doppio capovolto” dell’io antropologico, parafrasando J. D. Urbain
(1991). Entrambe le prospettive tuttavia evocano l’immagine del turista come figura
con cui l’antropologo si deve confrontare per ridefinire la propria identità.
7
Neppure C. Geertz è estraneo a questa ascrizione, nonostante i propositi iniziali, espressi nel saggio, Cultural Tourism: Tradition, Identity and Heritage Construction
I quaderni del CREAM , 2009, IX
69
perdonando loro l'atavica colpa di non essere nativi né residenti nella
comunità studiata. Nel contesto della neonata ”antropologia dei turisti”, alcuni ricercatori scelsero come oggetto di studio i discorsi prodotti dai turisti, attraverso l'analisi di racconti di viaggio, narrazioni di carattere eterogeneo e interviste semistrutturate8, mentre altri assunsero
espressamente il ruolo di guide turistiche9, coniugando la doppia condizione di ricercatore e membro della stessa comunità a cui appartengono i turisti e il duplice statuto di soggetto osservante ed oggetto dell'osservazione. A prescindere dalla metodologia di ricerca utilizzata
dai singoli studiosi, l'antropologia dei turisti analizza essenzialmente
le componenti motivazionali ed immaginative dei guests, evidenziandone le ricadute sulle modalità di interazione con gli hosts, i tentativi
di questi ultimi di assecondare le richieste dei primi e gli inevitabili
equivoci che accompagnano l'incontro.
La difesa dell’intimità culturale e gli equivoci dell'autenticità
Con il passaggio storico dal turismo di massa al turismo culturale10
e la massiccia adesione degli studiosi al paradigma esperienziale teorizzato da autori quali D. Mac Cannell (1976), D. Nash (1981) e N.
Graburn (1983) che istituisce un'analogia tra turismo e pellegrinaggio
e individua nella ricerca dell'autenticità il movente dell'agire turistico,
si delinea un contesto di osservazione privilegiato di quelle dinamiche
in atto nell'interazione tra hosts e guests delineate sopra: la proiezione
delle aspettative dei turisti sui luoghi visitati, le risposte creative dei
membri delle comunità locali, ma anche le visioni reciprocamente stereotipate che generano equivoci e malintesi.
(1997), in cui ripercorre gli oltre quaranta anni della sua pratica etnografica in Indonesia,
intrecciando componente biografica e trasformazioni del fenomeno turistico.
8
Rappresentativi di questo orientamento sono R. Bendix (2002) e J. Harrison (2003).
9
Rappresentativi di questo orientamento sono E. M. Bruner (1995; 2005), C. Palmer
(2001), P. Favero (2000) e M. Aime (2005).
10
Modalità di fruizione turistica caratterizzata da un incremento dell’attenzione dei
guests nei confronti della componente umana delle località turistiche e dall’estensione
dell’incontro ad una più elevata porzione della popolazione locale.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
70
Nell’ambito del turismo culturale la domanda turistica si configura
come ricerca di autenticità che sottopone gli insiders11 al dilemma della scelta tra desiderio di assecondare le richieste dei guests e l'esigenza
di salvaguardare la propria cultura e quotidianità. Questo processo fu
inizialmente interpretato, nell'ambito dell'antropologia del turismo
(Mac Cannell 1976, Boissevain 1996), attraverso il ricorso alla metafora teatrale con cui E. Goffman (1956) analizzò la rappresentazione
della vita quotidiana12, individuando nelle front regions il luogo della
rappresentazione dell'autenticità e nelle back regions il luogo della difesa dell'“intimità culturale”13. Il passaggio da una modalità di fruizione turistica ludica e ricreativa ad una culturale, incentrata sull’ideologia del contatto con l’ambiente naturale e la popolazione locale, ha
in molti casi contribuito all’acutizzarsi delle tensioni in atto nell’incontro tra guests e hosts, relazione intrinsecamente ambigua e potenzialmente conflittuale, per la natura transitoria del turismo e per la disuguaglianza economica che spesso intercorre tra i protagonisti:
l’incontro si configura dunque in termini di opposizione tra desiderio
dei visitatori di penetrare nell’intimità delle back regions, inaccessibili
11
Termine coniato dall’antropologo J. Boissevain per definire il nuovo statuto degli
hosts in quanto “persone che soddisfano i bisogni dei turisti e sono al tempo stesso
l’oggetto della loro attenzione” (1996, p.1). Questa definizione riassume la condizione
degli individui direttamente coinvolti nell’attività turistica e della maggior parte dei
membri di una comunità locale di ristrette dimensioni che si trasformi in destinazione
di turismo culturale: essere costretti ad assecondare le esigenze dei turisti, poiché è dal
loro grado di soddisfacimento che deriva la prosperità dell’industria locale e rappresentare, al tempo stesso, l’oggetto della curiosità dei visitatori, sempre più interessati,
come evidenzia J. Urry (1990), alla ricerca di cultura, natura e vita rurale “tradizionale”, piuttosto che di sole, sabbia e mare.
12
Secondo Goffman, la vita quotidiana degli individui è connotata dalla presenza di
due piani paralleli: quello pubblico, definito “front-stage” (ribalta), in cui l’attore
mette in scena il suo io sociale, e il “backstage” (retroscena), in cui l’individuo torna
ad essere se stesso, così sintetizzati: “quando si svolge un’attività in presenza di altre
persone, l’espressione di alcuni aspetti viene accentuata, mentre altri aspetti che
potrebbero screditare l’impressione voluta vengono soppressi. È chiaro che i fatti
accentuati appaiono in quella che ho chiamato ribalta e dovrebbe essere altrettanto
chiaro che ci può essere un altro territorio - chiamiamolo retroscena - dove fanno la
loro comparsa i fatti che sono stati soppressi” (Goffmann 1956, p. 132).
13
M. Herzfeld definisce in questi termini il concetto di intimità culturale: “condivisione
di tratti conosciuti e riconoscibili che non solo definiscono l’interiorità, ma sono anche
percepiti come oggetto di disapprovazione da parte di potenti estranei” (1998, p. 71).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
71
agli estranei e giudicate perciò più reali ed “autentiche” e per questo
più appetibili, e desiderio dei locali di tutelare la loro sfera privata,
tentando di circoscrivere lo sguardo dei turisti sulla superficie delle
front regions, siano esse il prodotto di una spontanea esibizione o di
una messa in scena. Il conflitto tra queste esigenze contrastanti sembra
essere endemico ad ogni interazione turistica, come attestano, da un
lato, le ricorrenti lamentele degli abitanti locali nei confronti di comportamenti intrusivi dei turisti, annotate nei taccuini degli antropologi,
e, dall’altro, gli espedienti, sempre più creativi, a cui ricorrono i locali
nel tentativo di tutelare la loro privacy14.
La dicotomia tra front regions e back regions non costituisce solamente un meccanismo di difesa dell’intimità, ma può rappresentare
una reazione al processo di mercificazione della cultura, in certa misura implicito nello sviluppo stesso del turismo culturale: la trasformazione di alcuni aspetti della cultura in attrazioni turistiche, promossa
da agenti esterni o dalle autorità, può infatti essere avvertita dagli
hosts come un’invasione di spazi ritenuti propri o come una violazione
di rituali, che innescano meccanismi di diserzione o di istituzione di
spazi e rituali paralleli ad uso esclusivamente locale15.
La contrapposizione tra front regions e back regions può inoltre
rappresentare una strategia di resistenza agita in modo consapevole ed
intenzionale dagli stessi hosts che possono decidere di prendere parte
attivamente al processo di invenzione, trasformazione e rivitalizzazione culturale per adeguarsi alle esigenze dei turisti, promuovendo pro14
J. Boissevain (1996) individua sei differenti strategie a cui i membri delle comunità
locali ricorrono per gestire la presenza ingombrante dei turisti: difese segrete, occultamento di alcuni tratti della cultura locale, recinzione reale o simbolica di spazi ed
eventi, incremento dei rituali pubblici, proteste organizzate ed aggressioni
15
A titolo d’esempio, M. Crain (1996) descrive come nel villaggio andaluso di Almonte, dinnanzi a quello che viene percepito come un inarrestabile processo di mercificazione del pellegrinaggio pentecostale (romería), trasformato in evento mediatico
per turisti, i locali mettano in atto una strategia di difesa che consiste nella creazione
di un insieme di controrituali che hanno luogo in spazi alternativi in cui lo sguardo
turistico è circoscritto: attività devozionali e pellegrinaggi spontanei al santuario per
l’adempimento di un voto, eventi che, evocando l’immagine del sacro come aspetto
della vita quotidiana piuttosto che come evento che deve essere celebrato un volta
all’anno, sembrano riuscire a ripristinare l’antica funzione coesiva della romería pentecostale, istituendo “comunità ristrette” tra i partecipanti, da cui i turisti sono esclusi,
ma anche forme alternative di pellegrinaggi istituzionalizzati, come il traslado.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
72
cessi di mercificazione della cultura e di autenticità rappresentata che,
focalizzando l’attenzione dei turisti sulle front regions commercializzate, fungono da elementi di protezione dell’intimità culturale.
Il postulato dell’esistenza di un’autenticità “vera”, collocata nel retroscena, e di un’autenticità rappresentata, collocata sulla ribalta è stato declinato attraverso il ricorso a tre casi etnografici divenuti esempi
paradigmatici dell’antropologia del turismo: il modello Amish, Bali e
Alarde. Questi tre paradigmi veicolano due differenti modalità di fruizione della rappresentazione dell’autenticità a cui sono attribuite, rispettivamente, una funzione di consolidamento (modelli Amish e Bali) e una
funzione distruttiva (modello Alarde) della cultura della comunità.
Il caso della comunità degli Amish della Pennsylvania analizzato
da R. Buck (1978), nella metà degli anni Settanta, è divenuto un modello paradigmatico di come il turismo funga da elemento di mantenimento dei confini culturali stabilendo una cesura netta tra uno spazio
esibito, su cui fare arrestare lo sguardo dei turisti (front region) e uno
spazio intimo, delegato alla difesa della quotidianità e della cultura
degli hosts (back region). Lo studio rivela infatti come questa comunità riesca a conservare il suo modo di vita, nonostante l’avvento dei turisti, mediante la presentazione ai visitatori di una rappresentazione
fittizia della sua esistenza che funge da difesa e confine con il mondo
esterno: l'immagine proposta, in accordo con quella promossa dall’industria turistica che opera nell’area circostante e, in anni recenti, autogestita, è quella di una comunità chiusa e legata ad antiche tradizioni,
quali l’utilizzo di un vecchio dialetto tedesco, il rifiuto dei profitti terreni e il ricorso a mezzi di trasporto arcaici. In questo caso, come in
molti altri, si assiste ad un adeguamento dell'offerta alla domanda turistica: la rappresentazione si costruisce su quegli elementi che gli hosts
attribuiscono alle aspettative dei guests, appiattendosi su immagini
stereotipate e riduttive che consentono la salvaguardia di quelle componenti della cultura locale ritenute fondanti l'identità comunitaria. L'incontro tra hosts e guests assume qui le sembianze di un equivoco in cui
la “finzione” dell'autenticità rappresentata consente rispettivamente ai
guests di vedere soddisfatte le loro aspettative e confermato il loro immaginario e agli hosts di circoscrivere l'incontro in un setting istituzionalizzato, mettendo in atto la difesa della propria intimità culturale.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
73
Il secondo modello deriva dalla ricerca condotta a Bali, all’inizio
degli anni Settanta, da P. Mc Kean (1978), che evidenzia come qui l’industria turistica sia promossa e gestita da corporazioni locali, fondate
su legami familiari e di vicinato, che vigilano sulla qualità dei prodotti
e sul rispetto delle tradizioni che, attraverso la mediazione turistica,
hanno subito un processo di preservazione e riscoperta. Il denaro ricavato dall’industria turistica viene infatti investito dai locali nella promozione delle tradizioni che contribuiscono a rafforzare l’identità culturale dell’isola, innescando un processo di “involuzione culturale”, in
cui la conservazione delle tradizioni, e quindi il ritorno al passato,
rappresenta l’elemento catalizzatore dell’interesse dei turisti, veicolo
della modernizzazione. Bali fu oggetto di un restudy nel corso degli
anni Ottanta, ad opera di M. Picard (1992), da cui emerge come il turismo internazionale abbia indotto una vera e propria “cultura turistica”,
forma di produzione e presentazione di pratiche culturali per i turisti
che non intaccano la struttura della società. Questo processo di esposizione della cultura locale allo sguardo dei turisti non produce rappresentazioni inautentiche, ma diviene la risorsa che consente il rinnovamento delle tradizioni autoctone, attraverso la conservazione o la produzione di performances artistiche e culturali riservate ai soli locali.
Ripercorrendo lo sviluppo turistico di Bali, esso può essere sintetizzato nella creazione di un backstage che a sua volta genera un frontstage
su cui fare arrestare lo sguardo dei turisti, difendendo così la propria
intimità culturale. Questa rilettura ha il merito di evidenziare come i
confini tra front e back regions, che il turismo tenta costantemente di
oltrepassare, non siano entità rigide e fisse ma subiscano continui
riaggiustamenti da parte dei locali stessi, attraverso la creazione di sfere sacre inviolabili e come il turismo, anziché agire come elemento disgregativo, tenda invece a ricompattare le vecchie identità.
Il terzo modello è il prodotto della ricerca condotta da D. Greenwood (1978), alla fine degli anni Sessanta, relativa alle conseguenze
dell’impatto turistico sulla città basca di Fuenterrabia. Lo studio è incentrato sull’analisi dell’Alarde, celebrazione annuale che commemora la vittoria riportata dagli spagnoli sull’esercito francese nel 1638.
Nella descrizione di Greenwood le cause della trasformazione dell’Alarde da rituale pubblico a performance turistica sarebbero da imputare all’avvento del turismo di massa che, con la crescente richiesta
I quaderni del CREAM , 2009, IX
74
di partecipazione dei turisti alla celebrazione, avrebbe eroso la funzione coesiva della celebrazione e l’intensa partecipazione emotiva
della popolazione locale. All’epoca della sua pubblicazione, lo studio
di Greenwood fu elevato a modello paradigmatico della potenzialità
distruttiva del turismo di massa nei confronti della cultura locale. Tuttavia, ad una lettura posteriore, le cause della trasformazione del significato della performance sono da attribuirsi a ragioni più strettamente
politiche, segnatamente i rapporti tra autorità centrale e popolazione
locale nella gestione dell’Alarde: come evidenzia lo stesso Greenwood
nelle riedizioni del 1977 e del 1989, da rituale pubblico l’Alarde si è
trasformata nel principale evento politico del conflitto tra baschi e governo centrale16.
La prospettiva incentrata sulla contrapposizione tra front e back
regions, pur avendo il merito di evidenziare l'agency degli hosts, attori
sociali in grado di condurre la rappresentazione turistica, gestendo
attivamente la presenza dei guests e difendendo la loro intimità quotidiana e culturale, è stata fatta oggetto, in anni recenti, di critiche e
riformulazioni. Questa teorizzazione infatti si basa sul presupposto,
dato per scontato, dell’esistenza di una realtà vera ed autentica situata
nel retroscena, mentre la letteratura etnografica fornisce numerosi
esempi che rinviano all'esistenza di una realtà più sfumata, in cui è
difficile stabilire una cesura netta tra ciò che è autentico e ciò che è
solo rappresentato come tale.
In primo luogo, infatti, i processi di autenticità rappresentata si
fondano spesso su pratiche culturali preesistenti di cui mantengono
16
Studi più recenti attestano un processo di reviviscenza dell’Alarde a livello
popolare, imputando al clima politico degli anni in cui fece ricerca Greenwood, le
conclusioni catastrofiste che aveva preannunciato. Il rifiuto compatto della popolazione, alla richiesta delle autorità locali, nel 1969, di ripetere la cerimonia introducendo
biglietti a pagamento per i visitatori, doveva essere interpretato non come opposizione
unanime della comunità alla turistificazione del rituale ma come un atto politico
contro il governo antidemocratico, corrotto e antibasco di allora, così come la rinascita
della cerimonia nel 1988 doveva essere interpretata come rivendicazione di un’identità etnica, quella basca, in lotta contro il governo centrale vissuto come oppressivo,
conseguenza della reinterpretazione della festa messa in atto dai locali, nel contesto
del clima politico postfranchista.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
75
inalterata la forma, mutandone invece il movente17. Un esempio tipico
in questo senso è costituito dalle danze “tradizionali” rappresentate per
i turisti che subiscono inevitabilmente un processo di semplificazione
e contrazione temporale, nonché un radicale cambiamento di significato, mantenendo però inalterato l'uso di costumi, maschere, gestualità,
trasformandosi spesso in un efficace strumento di trasmissione dei
simboli culturali che definiscono l'identità e l'appartenenza comunitaria alle nuove generazioni18. O ancora il caso di oggetti venduti ai turisti come souvenir che fanno parte del corredo materiale di una comunità seppure con significati e finalità differenti19.
In secondo luogo, spesse volte, nelle back regions si situano comportamenti, pratiche, beni materiali di provenienza esterna alla società
ospitante che si pongono in netto contrasto con le immagini che la
letteratura di viaggio, la pubblicità turistica e i mass media hanno depositato nell'immaginario dei turisti. Lo scollamento tra la rappresentazione turistica e la realtà esperita diviene particolarmente stridente nel
caso di quelle popolazioni a cui è stata delegata l'incarnazione dell'alterità pura e intorno alle quali è stato costruito un immaginario turistico
improntato all'esotismo: in questo caso, l'adozione di comportamenti,
beni materiali o simboli di provenienza occidentale – per esempio la
trasformazione dell'incontro turistico in transazione di tipo economico
17
Ad esempio, K. Adams (1993) evidenzia come i complessi rituali funebri per cui
sono diventati famosi i Tana Toraja di Sulawesi facessero parte della loro cultura anche prima della loro trasformazione in meta di “turismo mortuario”.
18
Ad esempio M. Aime (2000) evidenzia come i dogon del Mali, pur consapevoli della
differenza di significato delle performances turistiche e delle danze ad uso e consumo
locale, rivendichino il ruolo di vettore della trasmissione alle nuove generazioni di conoscenze e di pratiche tradizionali implicito nelle danze rappresentate per i turisti.
19
Per esempio le molas, pannelli tessili creati dalle donne kuna delle isole San Blas
(Panama) mediante una tecnica di sovrapposizione e intarsio di tessuti colorati, tradizionalmente parte del loro abbigliamento e, in anni recenti, acquistate dai turisti come
souvenir. Le donne hanno mantenuto inalterata la tecnica dell’intaglio ma hanno
modificato i soggetti raffigurati, accogliendo i simboli derivati dal contatto con l’alterità:
agli iniziali segni astratti e naturalistici, fecero seguito i simboli presi a prestito dall’iconografia religiosa, seguiti dagli emblemi che evocavano eventi storici come la
conquista delle Americhe o la loro lotta per l'indipendenza e, in anni recenti, da oggetti
appartenenti alla modernità, come aerei, navi, macchine da cucire, automobili, protagonisti di Walt Disney. Per una dettagliata analisi delle molas dei kuna cfr. M. B. Swain
(1978). Per ulteriori informazioni: http://www.interkultura.it/kunamolas.htm.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
76
da parte degli hosts20, l'utilizzo di capi d'abbigliamento21 o di simboli
occidentali come la coca cola nelle aspersioni rituali22 – da parte degli
hosts si scontra con il desiderio dei guests di oltrepassare la ribalta per
liberarsi della rappresentazione di facciata e ritrovare nel retroscena la
verità di un popolo intatto, indissolubilmente legato alla tradizione. La
letteratura etnografica rimanda dunque l'immagine di una realtà eterogenea, che impone ai turisti di decidere se interpretare la discrepanza
tra aspettative e realtà attraverso il ridimensionamento del loro immaginario o la rimozione della realtà e induce gli studiosi del turismo ad
un ripensamento dei concetti stessi di autenticità e tradizione.
Il postulato dell'esistenza di una realtà autentica collocata nelle
back regions è stato rimesso in discussione ad esempio dall'antropologo americano E. Bruner che, alla distinzione tra front regions e back
regions, contrappone una visione dell’autenticità come semplice pretesto, la cui analisi è soggetta all’uso che turisti, locali e produttori fanno
del termine, superando le opposizione restrittive tra autentico-inautentico, vero-falso, realtà-rappresentazione, fronte-retro. Ciò che emerge
dall’interazione tra hosts e guests, secondo Bruner, è una cultura nuo20
La richiesta di denaro per essere fotografati, da parte degli hosts, tralasciando le
questioni etiche che essa solleva, provoca lo sdegno di molti turisti perché vedono in
essa la trasformazione, messa in atto dai locali, dell’interazione host-guest, che nel
loro immaginario si rappresenta in termini di reciproco incontro, scevro da interessi e
fini materiali, in una transazione puramente economica. Ecco che allora i locali, ai
quali i turisti, attraverso la mediazione dell’immaginario, hanno delegato la conservazione della purezza delle tradizioni, sopraffatte nelle moderne società occidentali
dalla tecnologia e dai comfort, finiscono per contraddirne le aspettative, riconducendo
l’interazione nel contesto di una logica di mercato che rivela lo scollamento tra la
rappresentazione dei turisti e la realtà: la delusione che ne deriva si traduce nel
paradosso dei turisti di rimproverare ai locali quello che è il prodotto della loro stessa
società di provenienza.
21
M. Aime (2005), attingendo dalla sua esperienza di viaggio in Africa Occidentale,
racconta come gli hosts indossino nella loro quotidianità jeans, infradito di gomma,
scarpe da ginnastica e orologi e come questi oggetti scompaiano nel corso delle performances turistiche, in quanto sgraditi allo sguardo del turista, per ricomparire nell’ambito di rituali ad uso e consumo locale, dando vita ad uno dei tanti paradossi del
turismo poiché le danze «autentiche» sembrano non tradizionali, mentre quelle per
turisti sembrano «autentiche».
22
Ad esempio, J. L. Amselle (2001, p. 22) parla dell’uso della coca-cola nei matrimoni
dei luo del Kenya; Aime (2005, p. 134) dell’utilizzo di Fizzy come bevanda
sacrificale in Benin.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
77
va costruita appositamente per i turisti, ma non per questo etichettabile
come inautentica, poiché non esiste un simulacro o un originale di cui
essa sarebbe la riproduzione. Sebbene le performances turistiche derivino da una matrice culturale locale, esse sono “nuove in quanto il
contesto, il pubblico e i tempi cambiano continuamente. Detto in altri
termini, la performance è costitutiva” (2005, p. 5).
Alla luce di queste riflessioni, l'autenticità, più che un equivoco
può essere invece considerata una sorta di malinteso che apre uno
spazio a nuove modalità di comunicazione tra hosts e guests e veicola
forme di identità e di appartenenza inedite, se per malinteso, in accordo con W. Jankélévitch, intendiamo quel “non so che” su cui si
fonda la finzione della mancata comprensione e quell' “imbroglio” che
consente la comunicazione tra due parti. Il malinteso infatti, a differenza
dell'equivoco, presuppone le dimensioni dell'intenzionalità e della soggettività che rinviano al concetto di agency: “perché ci sia malinteso
non bisogna solo avere capito male, bisogna non accorgersene subito, o
almeno (se si ha qualche interesse a perpetuare l'equivoco) fare finta di
non accorgersene subito” (Jankélévitch 1957, p. 253).
Cerchiamo ora di capire in che misura l'autenticità possa essere
interpretata mediante il ricorso alla categoria di malinteso.
Le molteplici declinazioni dell’identità.
Il termine “autenticità”, a livello di senso comune, rinvia a una qualità posseduta da un oggetto o alla realtà evenemenziale di un fatto;
evoca l’idea di genuinità, sincerità e schiettezza; richiama la validità di
un documento o l’originalità di un prodotto23. In ambito antropologico, sono passati ormai vari decenni da quando il concetto di autenticità è stato fatto oggetto di un processo di decostruzione. La disciplina si è infatti trovata, fin dai suoi esordi, a doversi confrontare con
il concetto di autenticità, nella duplice accezione di principio orientativo della ricerca, sotto forma di ricostruzione e di comprensione
delle società indigene nella loro integrità, da un lato, e di propensione
etica, caratteristica dell’approccio evoluzionista e del concetto di pro23
Dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
78
gresso da esso veicolato, alla conservazione e alla sottrazione delle
culture altre al rischio dell’estinzione causata dalla società occidentale.
Oggi, tuttavia, questo concetto è stato privato di ogni validità euristica,
mettendone in evidenza la natura di pregiudizio etnocentrico prodotto
dalla modernità, come conseguenza della presa di coscienza che le
culture, non sono entità omogenee e chiuse, caratterizzate da un’essenza immutabile, ma piuttosto, “frutti puri che impazziscono” (Clifford
1988), in quanto sottoposte ad un costante processo di contaminazione, ibridazione e meticciamento. Contrariamente a quanto avvenuto
nel contesto degli studi antropologici, il concetto di autenticità, sembra
conservare invece un forte potere suggestivo nell’ambito del turismo,
in termini di ricerca di culture locali “autentiche” come motivazione al
viaggio e un’intensa forza simulativa, sotto forma dell’illusione dell’autenticità promossa dall’industria turistica.
Nel contesto dell’interazione turistica, il termine “autenticità” rappresenta un concetto ambiguo, il cui uso originario è collegato all’ambito museale, in cui il termine è sinonimo di originale e da qui esteso
al turismo, i cui prodotti, materiali e immateriali, sono spesso definiti
“autentici” qualora siano realizzati o compiuti dai locali, seguendo i
dettami del costume e della tradizione. In questo caso, il concetto di
autenticità è direttamente connesso a quelli di cultura tradizionale e di
origine, evocando un senso di genuinità, realtà ed unicità, non esente
da contraddizioni e paradossi. Tra i turisti vi è infatti la tendenza ad
applicare l’etichetta di autenticità, la cui area semantica confina con
quella di verità, a ciò che segue la tradizione, evocando l’immagine di
qualcosa che si è mantenuto inalterato nel tempo.
Il concetto di autenticità può essere utilizzato per indicare una caratteristica dell'oggetto visitato24 o una qualità percettiva dello sguardo
del visitatore. Nella storia degli studi antropologici sul turismo si è
operato un progressivo slittamento da una concezione essenzialista
dell’autenticità – autenticità = attributo – ad una concezione di autenticità come processo di costruzione negoziabile – autenticità = proiezione dell'attributo – che induce un ripensamento del concetto stesso di
24
Toured object (Wang 1999): termine che designa gli oggetti, di diversa natura, che
rappresentano lo scopo della visita turistica.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
79
tradizione. Ripercorriamo le principali tappe di questo processo di decostruzione e riformulazione del concetto di autenticità.
L’approccio oggettivista, rifacendosi alla concezione museale dell’autenticità degli originali, che in questo caso rappresentano gli oggetti visitati percepiti dai turisti, considera l’autenticità una qualità intrinseca agli oggetti e presuppone un criterio assoluto ed oggettivo di
misurazione: la ricerca dei turisti di esperienze autentiche non è che
un’esperienza epistemologica che deriva dal riconoscimento degli oggetti visitati come autentici. Il limite imputato alla prospettiva oggettivista consiste nell’incapacità di restituire il carattere che potremmo
definire “fuzzy” del concetto di autenticità, reso visibile dal divario tra
una prospettiva etica ed una emica: ciò che da esperti o studiosi è etichettato come “autenticità inautentica” o “rappresentata” può infatti
essere percepito come autentico e reale dai soggetti che lo esperiscono, come ad esempio avviene nel caso dei turisti di massa.
Un secondo tentativo di esplicazione di questo concetto complesso
proviene dall’approccio costruttivista, secondo cui l’autenticità non è
una qualità oggettivamente misurabile di ciò che viene visitato, ma il
risultato di una costruzione sociale che si esprime attraverso punti di
vista, credenze e prospettive condivise o rapporti di potere. L’autenticità è dunque una nozione relativa, “negoziabile” (Cohen 1988),
contestualmente determinata ed ideologica. N. Wang (1999) parla a
questo proposito di autenticità simbolica poiché, non presupponendo
una corrispondenza con la realtà, può essere la proiezione di un sogno,
di immagini stereotipate e di aspettative sugli oggetti visitati che, di
conseguenza, sono esperiti come autentici non perché originali o reali
ma perché sono percepiti come segni o simboli dell’autenticità. L’approccio costruttivista è estremamente eterogeneo ma è possibile rintracciare alcuni elementi costanti: il rifiuto del postulato dell’esistenza
di un originale assoluto e statico o di un’origine da cui dipende l’autenticità assoluta degli originali; la condivisione della natura costruita
delle tradizioni formulata da Hobsbawm e Ranger (1983); l’adesione
ad una visione pluralista e relativa dell’autenticità, come risultato
dell’interpretazione e della prospettiva di ogni singolo soggetto; la teorizzazione dell’autenticità come proiezione di credenze, aspettative e
immagini stereotipate dei turisti sugli oggetti visitati; la comune attenzione ai processi di “autenticità emergente” (Cohen 1988) che sanciI quaderni del CREAM , 2009, IX
80
scono il passaggio di un oggetto, nel corso del tempo, dalla sfera
dell’inautentico e dell’artificiale a quella dell’autenticità, come nel caso della produzione di manufatti indigeni per il mercato turistico che
finiscono con il diventare essi stessi “autentici”.
Un ulteriore passo in direzione dell’istituzionalizzazione dell’autenticità come modalità di sguardo dei visitatori è compiuto dall’approccio postmodernista, caratterizzato da un processo di decostruzione
dell’autenticità, il cui esempio paradigmatico è rappresentato dal concetto di “iper-realtà” di U. Eco (1986), incarnato da Disneyland, prodotto della fantasia e dell’immaginazione, a cui non sono applicabili
gli attributi di verità o falsità data l’assenza di un originale che possa
essere usato come metro di riferimento. In questo caso, il processo di
decostruzione del concetto di autenticità passa attraverso la destrutturazione dei legami tra copia e originale, o tra segno e realtà. A Disneyland infatti non c’è un confine assoluto tra reale e falso poiché “le
cose non sono semplicemente vere o false ma vere-vere, false-vere,
vere-false e false-false”25 e il reale può trasformarsi in finzione e viceversa. Implicito nell’approccio postmodernista è la giustificazione
dell’artefatto, della copia, dell’inautentico: qui il grado di realtà della
rappresentazione è direttamente proporzionale al grado di convincimento della stessa, il cui potere simulativo è enfatizzato dallo sviluppo
della tecnologia.
L’ultima mossa di questo processo di decostruzione consiste nella
teoria dell’autenticità esistenziale (Wang 1999), secondo la quale i turisti postmoderni non sono interessati all’autenticità degli oggetti visitati ma sono alla ricerca dell’autenticità di loro stessi con l’aiuto delle
attività liminali compiute in vacanza e degli oggetti visitati: il carattere
soggettivo o intersoggettivo di questa percezione non intacca, dal punto di vista del turista, il suo grado di realtà. L’approccio di Wang indica un cambiamento di prospettiva: se infatti oggettivisti, costruttivisti
e postmodernisti discutono se e in che misura gli oggetti visitati siano
esperiti come reali, Wang sostiene l’irrilevanza dell’autenticità degli
oggetti visitati, individuando nella ricerca di un’autenticità alternativa,
quella esistenziale, il movente dell’agire. Ciò che induce i turisti a par-
25
Fjellman 1992, p. 255.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
81
tire è la ricerca di un sé autentico e di un’autenticità intersoggettiva26.
La questione degli oggetti visitati passa in secondo piano.
L'autenticità: un felice malinteso.
Un esempio di autenticità simbolica che veicola una nuova concezione di tradizione è dato dalle storyboards (Colombo 2003), tavolette
di legno incise e dipinte, raffiguranti leggende mitologiche e scene di
vita quotidiana, inventate negli anni ’70 da alcuni artisti del villaggio
di Kambot, della regione del Sepik, in Papua Nuova Guinea, modificando un oggetto tradizionale, per soddisfare le esigenze di turisti e
mercanti d’arte primitiva. Le storyboards rappresentano uno straordinario esempio di “autenticità emergente” poiché, a differenza dell’arte
tradizionale, che riflette ed incarna valori e identità del passato, incorporano forme artistiche ed artigianali precedenti, non riprodotte fedelmente ma costantemente rinnovate e modificate nel contesto dei
cambiamenti socio-culturali che hanno avuto luogo negli anni e del
contatto culturale che, nel corso di tre generazioni, ha assunto le sembianze di missionari di diverse confessioni religiose, amministratori
tedeschi ed australiani e infine turisti, divenendo veicoli di nuovi valori, identità e rapporti con il mondo esterno. Sebbene il loro uso princi26
Wang individua nell’autenticità esistenziale indotta dal turismo due dimensioni: una
intra-personale e l’altra inter-personale. La prima allude alla centralità attribuita nelle
pratiche turistiche alle sensazioni corporee e al corpo, in contrapposizione al controllo
esercitato su di essi nella moderna quotidianità alienata e al processo di costruzione
del sé come motivazione turistica, particolarmente evidente nel turismo d’avventura in
cui attraverso il superamento di sfide estreme il vecchio sé è sostituito da uno nuovo. La
seconda allude alla ricerca dell’autenticità sociale, fortemente ridotta nella modernità dal
controllo esercitato dalle istituzioni, in cui le pratiche turistiche e gli oggetti visitati
fungono da strumento di incontro che consente di stabilire interrelazioni autentiche. La
ricerca di autenticità sociale può essere finalizzata al rafforzamento dei legami familiari
o alla creazione di opportunità di incontro, socializzazione ed interazioni emotive
fondate sulla condivisione e sulla co-partecipazione dei turisti alle esperienze vissute,
generando communitas nell’accezione turneriana, in cui, nello spazio turistico liminale, i
legami sociali sono percepiti in termini di relazioni interpersonali non-mediate e pure, in
analogia con quanto avviene per i pellegrini che nel loro viaggio dalla periferia al centro,
dotato dei valori più sacri e investito delle emozioni più elevate, si rapportano gli uni
agli altri come uguali sociali.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
82
pale rimanga legato all’interazione tra hosts e guests, questi ultimi
principali destinatari della produzione delle storyboards, acquistate
come souvenir, in anni recenti si assiste ad un processo di risignificazione di questi oggetti, come supporto visivo per la trasmissione dei
miti alle nuove generazioni e di trasformazione in un vero e proprio
simbolo identitario della comunità di Kambot. Il valore performativo
di questo processo viene esplicitato dalla decisione degli incisori delle
storyboards di continuare a rappresentare un insieme di simboli, opportunamente selezionati come rappresentativi della loro cultura – la
canoa, il fiume, le palafitte, la casa cerimoniale e i miti – a dispetto
dell'incapacità dei turisti di leggere la simbologia rappresentata come
manifestazione dell’identità di Kambot piuttosto che di un altro villaggio del Sepik, rivelando l'esistenza di un duplice destinatario alternativo della rappresentazione: gli stessi abitanti di Kambot che individuano nei simboli rappresentati un elemento di coesione e identificazione comunitaria e gli abitanti dei villaggi limitrofi a cui viene delegato il processi di riconoscimento della differenziazione.
Il caso etnografico riportato evoca una realtà che si colloca al margine delle contrapposizioni tra back e front regions, autentico ed inautentico, vero e falso, tradizione e mutamento. Le storyboards infatti,
per il fatto stesso di rappresentare la risposta creativa ed originale da
parte degli hosts alle richieste dei fruitori del turismo culturale o etnico che ha per meta il villaggio di Kambot, si collocano nello spazio
dell'incontro turistico designato alla messa in scena dell'autenticità,
ovvero la front region, in cui le modalità di interazione tra hosts e
guests risultano fortemente istituzionalizzate e determinate. Tuttavia,
il significato identitario da esse veicolato, sebbene estraneo ai turisti,
induce una loro ricollocazione nella front region, in quanto risultato
del processo di selezione di alcuni tratti ritenuti costitutivi dell'intimità
culturale di Kambot.
Diviene dunque problematico qualunque tentativo, non solo di stabilire una cesura netta tra spazi di interazione contigui, ma anche di
assegnazione degli attributi di autentico e inautentico. Abbiamo visto
infatti come un oggetto che per definizione nasce senza alcuna pretesa
di autenticità, destinato all'uso e consumo dei turisti, finisca con il diventare più autentico del suo originale, se per autenticità si intende
una categoria che incorpora nella sua definizione anche l’interazione
I quaderni del CREAM , 2009, IX
83
tra tradizione locale ed influssi esterni, accolti e rielaborati in modo
attivo dai nativi, in chiave di rivendicazione e difesa della propria intimità culturale.
Le storyboard e il processo di rappresentazione dell'autenticità da
esse veicolato rappresentano dunque l' “imbroglio” su cui si fonda la
possibilità di comunicazione tra le due parti, ciascuna delle quali è intenzionata a perpetrare l'equivoco: i turisti pensano di avere acquistato
un oggetto autentico, esteticamente gradevole, espressione della cultura materiale del villaggio di Kambot, in grado di attivare il ricordo dell'esperienza vissuta27; gli abitanti di Kambot, da parte loro, soddisfano
le esigenze dei turisti e li trasformano in inconsapevoli mediatori tra i
produttori e i reali destinatari della rappresentazione.
Nel malinteso, l'incontro prende forma e trasforma il confine in una
zona neutra che apre uno spazio alla comunicazione, tra hosts e guests
o, come direbbe F. La Cecla: “tra due o più culture, tra alcune apparentemente subordinate ma in realtà abili nel giocare sul proprio travestimento da offrire ai curiosi e altre apparentemente dominanti ma assetate di esotismo e alterità”28.
Bibliografia
Nel testo, l’anno che accompagna i rinvii bibliografici secondo il sistema autoredata è sempre quello dell’edizione in lingua originale, mentre i rimandi ai numeri di pagina si riferiscono sempre alla traduzione italiana, qualora negli estremi
bibliografici qui sotto riportati vi si faccia esplicito riferimento.
Adams K. 1993, Club Dead, Not Club Med: Staging Death in Contemporary Tana
Toraja (Indonesia), Southeast Asian Journal of Social Science, n. 21, pp. 62-72.
27
Ad esse sembra dunque possibile applicare la prospettiva suggerita da D. Canestrini
(2001) per l’interpretazione dei souvenir, suscettibili di un duplice sguardo: quello di
chi li produce e quello di chi li compra, rispettivamente riconducibili alla definizione
di souvenir come “piccolo totem dell’identità” (p. 33) espressione della cultura materiale e veicolo del profilo storico e culturale degli autoctoni e di souvenir come “spoletta della memoria” (p. 12), testimonianza del desiderio dei turisti di familiarizzare
con una realtà attraverso il possesso di un suo condensato e al tempo stesso certificazione dell’esperienza di viaggio vissuta.
28
F. La Cecla, 2001, p. IX.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
84
Aime M., 2000, Diario dogon, Bollati Boringhieri, Torino.
Aime M. 2005, L’incontro mancato. Turisti, nativi, immagini, Bollati Boringhieri, Torino.
Amselle J.L. 2001, Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures,
Flammarion, Parigi; tr. it. 2001, Connessioni. Antropologia dell’universalità
delle culture, Bollati Boringhieri, Torino,
Augé M. 1997, L’impossible voyage. Le tourisme et ses images, Parigi, Payot &
Rivages; tr. it. 1999, Disneyland e altri non-luoghi, Bollati Boringhieri, Torino.
Bendix R. 2002, Capitalizing on memories past, present and future. Observations
on the interviewing of tourism and narration, Anthropological Theory, vol.4,
n. 2, pp. 469-487.
Boissevain J.1996 (a cura di), Coping with tourists: European reactions to mass
tourism, Berghahn Books, Oxford.
Bruner E.M. 1989, Of cannibals, tourists and ethnographers, Cultural Anthropology, vol. 4, n.4, pp. 439-446.
Bruner E.M. 1994, Abraham Lincoln as Authentic Reproduction: a Critique of
Postmodernism, American Anthropologist, n. 96, pp. 397-415.
Bruner E.M. 1995, Ethnographer/Tourist in Indonesia, J.B. Allcock, E.M. Bruner,
M.F. Lanfant (a cura di) International Tourism. Identity and Change, Sage,
Londra, pp. 224-241.
Bruner E.M. 2005, Culture on Tour. Ethnographies of Travel, University of
Chicago Press, Chicago.
Buck R.C. 1978, Boundary Maintenance Revisited: Tourist Experience in an Old
Order Amish Community, Rural Sociology, vol. 2, n. 45, pp. 221-234.
Canestrini D. 2001, Trofei di viaggio. Per un’antropologia del souvenir, Bollati
Boringhieri, Torino.
Clifford J. 1988, The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography,
Literature, and Art, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), tr. it. 1993,
I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati
Boringhieri, Torino.
Clifford J. 1997, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century,
Harvard University Press, Cambridge (Mass.), tr. it. 1999, Strade. Viaggio e
traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino.
Colombo D. R. 2003, Arte e identità: le storyboards di Kambot (Papua Nuova
Guinea), S. Manoukian (a cura), Etno-grafie. Testi, oggetti, immagini, Meltemi, Roma, pp. 77-100.
Cohen E., 1988, Authenticity and Commodization in Tourism, Annals of Tourism
Research, vol.2, n. 15, pp. 371-386.
Crain M.M. 1996, Contested Territories: The Politics of Touristic Development
at the Shrine of El Rocìo in Southwestern Andalusia, J. Boissevain (a cura),
Coping with Tourists, Berghahn Books., Oxford, pp. 27-55.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
85
Crick M. 1995, The Anthropologist as Tourist: An Identity in Question, J.B. Allcock, E.M. Bruner, M. F. Lanfant (a cura), International Tourism. Identity
and Change, Sage, Londra, pp. 205-223.
De Certeau M., 1980, L’Invention du Quotidien, Union générale d’éditions,
Parigi; tr.it., 2001, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma.
De Kadt E. 1978 (a cura di), Tourism. Passport to Development? Perspectives on
the Social and Cultural Effects of Tourism in Developing Countries, Oxford
University Press, New York.
Eco U. 1986, Travels in Hyperreality, Londra, Picador.
Favero P. 2000, O’ sole mio: Italian Charter Tourists’ Experiences of the Midnight
Sun in North Cape, Norway, Anthropological Quarterly, vol.1, n. 73, pp. 1-19.
Fjellman S.M., 1992, Vinyl Leaves: Walt Disney World and America, Westview
Press, Boulder.
Geertz C. 1997, Cultural Tourism: Tradition, Identity and Heritage Construction,
W. Nuryanti (a cura di), Tourism and Heritage Management, Gadjah Mada
University, Yogyakarta, pp. 14-24.
Goffman E. 1956, The Presentation of Self in Everyday Life, University of Edinburgh, Edinburgo, tr. it., 1969, La vita quotidiana come rappresentazione, Il
Mulino, Bologna.
Graburn N.H., 1983, The Anthropology of Tourism, Annals of Tourism Research, n. 10, 1, pp. 9-33.
Harrison J. 2003, Being a Tourist: finding meaning in pleasure travel, University
of British Columbia Press, Trent.
Greenwood D. 1978, Culture by the Pound. An Anthropological Perspective on
Tourism as Cultural Commodization, V. Smith (a cura di) Hosts and Guests.
The Anthropology of Tourism, Blackwell, Oxford, pp. 129-138.
Herzfeld M. 1997, Cultural Intimacy, Social Poetics in the Nation State, Routledge, New York; tr. it., 2003, Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo, l’Ancora del Mediterraneo, Napoli.
Herzfeld, M., 1998, Intimità culturale, marginalità e definizione della diversità: la
politica dell’esistenzialismo, L. Passerini (a cura di), Identità culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni, La Nuova Italia, Firenze, pp. 67-83.
Hobsbawm E., Ranger T. 1983 (a cura di), The Invention of Tradition, Cambridge, University Press, Cambridge; tr. it., 1987, L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino.
La Cecla F. 1998, Il malinteso, Laterza, Roma.
La Cecla F. 2001, Turismo: supponendo che sia una cosa divertente, prefazione a
O. Lofgren, Storia delle vacanze, Bruno Mondadori, Milano, pp. VII-XVI.
Jankélévitch, W., 1957, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, P.U.F., Parigi; tr.
it. 1987, Il non-so-che e il quasi-niente, Marietti, Genova,
I quaderni del CREAM , 2009, IX
86
Mac Cannell D. 1984, Reconstructed Ethnicity: Tourism and Cultural Identity in
Third World Communities, Annals of Tourism Research, n. 2, pp. 375-391.
Mac Cannell D. 1992, Empty Meeting Grounds. The Tourist Papers, Routledge,
Londra.
Mac Cannell D. 1976, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Schocken
Books, New York; tr. it., 2005, Il turista. Una nuova teoria della classe
agiata, Utet, Torino.
McKean P.F. 1978, Towards a Theoretical Analysis of Tourism. Economic Dualism and Cultural Involution in Bali, V. Smith (a cura di) Hosts and Guests.
The Anthropology of Tourism, Blackwell, Oxford, pp. 93-107.
Nash D. 1981, Tourism as an Anthropological Subject, Current Anthropology,
vol.5, n. 22, pp. 461-481.
Palmer C. 2001, Ethnography: A Research Method in Practice, International
Journal of Tourism Research, n. 3, pp. 301-312.
Picard M., 1995, Bali. Tourisme culturel et culture touristique, L’Harmatthan,
Parigi.
Smith V. 1978 (a cura di), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism,
Blackwell, Oxford,
Swain M. B., 1978, Cuna women and Ethnic Tourism. A way to persist and an
Avenue to Change, V. Smith (a cura di) Hosts and Guests. The Anthropology
of Tourism, Blackwell, Oxford, pp. 71-81.
Urbain J. D.1991, L’idiot du voyage. Histoires de touristes, Parigi, Plon; tr. it.,
2003, L'idiota in viaggio. Storia e difesa del turista, Aporie, Roma.
Urry J. 1990, The Tourist Gaze, Sage, Londra, tr. it., 1995, Lo sguardo del turista. Il tempo libero e il viaggio nelle società contemporanee, Seam, Formello.
Wang, N., 1999, Rethinking Authenticity in Tourism Experience, Annals of
Tourism Research, vol. 2, n. 26, pp. 349-370.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
87
1
MARÍA ELIZABETH ALEJANDRINA DOMÍNGUEZ ÁNGEL
TRADICIÓN Y GLOBALIZACIÓN.
¿CONSUMISMO EN EL CARNAVAL
DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA?
Los integrantes del cuerpo académico Cultura y trabajo: expresión
regional de la globalización señalamos al inicio de este libro que la
globalización presenta problemas de definición debido a la multiplicidad de enfoques, y por ello optamos por la exposición de algunas de
sus expresiones generales y regionales para obtener una definición
operacional, que nos ayude a interpretar los fenómenos que cada
miembro investiga. Observamos que se globalizan las formas de ser,
conforme al molde occidental moderno presentado por Europa y
Estados Unidos. Se expande y profundiza el sistema capitalista de
libre comercio, de división internacional del trabajo y de integración
regional. Con ello, la implantación de un nuevo orden internacional en
el que se establecen nuevas hegemonías que pugnan por el control
único.
El CA considera en el ámbito regional formas de subempleo
características de la entidad, como un híbrido en el que se observa
empleo, actividades de servicios, autoempleo, migración, etc. Asimismo, la adopción de tecnologías de control, como videocámaras en
las calles y una creciente influencia de los medios de comunicación.
En consecuencia, se presenta una problemática social y cultural nueva
en Tlaxcala: creciente individualismo, aumenta la depresión, escisión
familiar, migración externa e interna, alteración de la identidad de la
personalidad, formas de esclavitud, exclusión laboral disfrazada, flexibilidad laboral, incertidumbre generalizada, crisis de eficacia de los
1
Universid autonóma de Tlaxcala (México).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
89
medios de control social tradicional, que se expresan como un vacío,
aprovechado por el mercado. El empleo funciona como medio de control, debido a que se obtiene y se permanece en él por medios
corporativos. Se observa también creciente consumismo en diversos
sectores sociales que buscan ser modernos, alterando con ello importantes tradiciones de la región, como la del carnaval.
La ideología cultural del consumismo
A partir de lo expresado, una respuesta a la cuestión del sistema de
valores apropiado para una transición hacia la modernización capitalista
es la ideología cultural del consumismo. Wells (1972) ha sugerido que
es necesario dividir analíticamente el concepto de “modernización” y
reemplazarlo por el concepto de “consumismo”, definido como el aumento en el consumo de cultura material de los países desarrollados.
La importante investigación de Wells (1972) sobre los efectos de la
televisión en Latinoamérica documenta que Estados Unidos tiene una
fuerte influencia para el consumo y una muy débil influencia para la
producción en la televisión latinoamericana. Esto lo explica con la
afirmación de que la tarea específica del sistema capitalista global en
el Tercer Mundo es promover el consumo entre la gente, sin importar
su capacidad para producir por sí misma, y sin prestar mayor atención
a su capacidad para pagar lo que consume. En este sentido, el consumo no tiene nada que ver con la satisfacción de las necesidades
biológicas, ya que la gente intentará satisfacer esas necesidades sin
incitación de nadie, pero sí tiene que ver con crear lo que puede ser
llamado necesidades inducidas. Esto implica que a la gente en el
Tercer Mundo hay que enseñarle a consumir, en el sentido especial de
crear y satisfacer necesidades inducidas (Belk 1988). La publicidad, el
principal, pero no el único, canal a través del cual se transmite la
ideología cultural del consumismo, se ha proyectado a sí misma como
una práctica educativa o, al menos, informativa (Sklair 1988).
El estudio de los medios de comunicación en el Tercer Mundo y su
relación con la publicidad es el lugar obvio para empezar a investigar
el modo como funciona la ideología cultural del consumismo. No es
accidental que la mayor parte de la investigación sobre este tema se
I quaderni del CREAM , 2009, IX
90
haya realizado en el marco de teorías sobre el imperialismo cultural y
de los medios.
El imperialismo cultural, imperialismo de los medios
La tesis del imperialismo cultural sostiene que los valores y
creencias de los países poderosos se imponen a los países débiles bajo
la forma de la explotación. El imperialismo de los medios se deduce
lógicamente del imperialismo cultural. Si se admite el control de la
cultura occidental o estadounidense, entonces este se logra claramente
a través del control de los medios de comunicación, que crean las
condiciones para la conformidad con la hegemonía cultural y limita
las posibilidades de resistencia eficaz. Estas teorías se sostienen y se
cuestionan de forma muy fuerte. Hay cuatro tipos principales de teorías críticas al imperialismo cultural y de los medios. Primero, lo que
se identifica a menudo como “imperialismo cultural y de los medios
estadounidenses” es en verdad una práctica profesional avanzada. En
segundo lugar, funcionan procesos completamente diferentes en diferentes países y las variaciones nacionales pueden ser más importantes
que los modelos globales. Tercero, todos los países desarrollan fuerzas
mediáticas y culturales internas que contrarrestan las influencias externas de los productos culturales estadounidenses. En cuarto lugar, el
caudal de medios estadounidenses puede trabajar a favor o en contra
de la autonomía nacional (Sklair 2003).
Según Zayed, la adopción de la cultura de los consumidores funciona en tres niveles contradictorios. En primer lugar, la elección de bienes
importados baratos puede ser racional económicamente para los consumidores pobres; en segundo lugar, el consumismo es “usado por la
gente a quien se subordina como un velo para tapar las condiciones
materiales difíciles en las que viven” y funciona como “un símbolo de
existencia en contraste con el proceso de degradación que es también un
resultado de la naturaleza subordinante del consumismo”. Su argumento
implica que una vez que se adopta la ideología cultural del consumismo,
la gente pobre no puede arreglárselas económicamente, y se debe
desarrollar una forma de resistencia (Zayed 1987).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
91
La investigación de Zayed hace un avance importante al entender
la ideología cultural del consumismo como una práctica transnacional.
Demuestra que las personas no son “drogados culturales” que obedecen sin pensar las instrucciones de un orden social explotador, aun
cuando esas instrucciones sean eficaces en un nivel subliminal. La
gente, especialmente la gente pobre del Tercer Mundo, adopta la
ideología cultural del consumismo por razones fácilmente comprensibles. En algunas circunstancias, es la única opción razonable para
ellos desde el punto de vista económico. A menudo, quizá siempre, es
una trampa, pero no penetra a causa de la estupidez ni siquiera de la
ignorancia, sino por la falta de alternativas viables. Es una trampa
similar a la de los campesinos que alimentan sus hijos hambrientos
con el maíz para sembrar. No tienen alternativa. El punto es que la
ideología cultural del consumismo neutraliza y reinterpreta las tradiciones culturales de forma que sofoca la oposición cultural. Esta es
una de las formas más eficaces en las que funciona el capitalismo
global en ambientes evidentemente hostiles. A través del consumismo,
la sociedad tradicional se convierte en occidentalizada y “modernizada”. La incursión del sistema capitalista en la periferia supone dos
procesos: la intensificación creciente de las relaciones de mercado,
acompañada de la intensificación del consumo y la difusión de la
cultura de masas; la concentración y la diferenciación de la producción (Zayed 1987).
Con la globalización también se observa la eliminación y discriminación de las culturas como una tendencia, por ello, el proceso
acelerado de interconexiones crecientes entre las culturas, que presentan un contraste claro y contradictorio entre los países del centro y
los periféricos. Tras estas manifestaciones, la globalización se ha
convertido en fuente de preocupación e incertidumbre, porque implica
la exclusión social, el desempleo y la marginación. En los países más
pobres se vive una doble angustia: miedo a ser eliminados y, por lo
tanto, a ser excluidos del desarrollo de la historia. Es claro que la
globalización simpatiza con los idearios del liberalismo y del neoliberalismo, es decir, con la economía y la libertad. Libertad económica como condición de libertad política. Aquí, la globalización
encuentra su base en los siguientes elementos: control de mercados
financieros mundiales, acceso a los recursos naturales del planeta, los
I quaderni del CREAM , 2009, IX
92
medios de comunicación, las armas de destrucción masiva y el desarrollo tecnológico. A estos últimos nos referiremos ahora, para conocer
el papel que Estados Unidos ha tenido al impulsar el consumo armamentista.
Carnaval, globalización y guerra en Chiautempan
Las últimas dos guerras sostenidas entre Estados Unidos contra
Afganistán e Irak se han venido expresando en el carnaval de Chiautempan desde hace cinco años. Los habitantes de este municipio han
expuesto como símbolos de resistencia al dominio estadounidense, a
Bin Laden y Saddamm Hussein. Si tenemos presentes las historiografías de estas guerras podremos notar algunos indicadores que nos
revelen las pretensiones de fondo de este país. No es casual que en los
últimos decenios Estados Unidos estuviera reiniciando la espiral
armamentista. De acuerdo con la fuente proporcionada por Glinkin
(1987), fue el primer país en crear y usar el arma nuclear; fue el
primero en construir bombarderos estratégicos, pesados portadores de
armas nucleares y submarinos atómicos con cohetes a bordo. Con la
prueba de la bomba atómica y los bombardeos norteamericanos de
Hiroshima y Nagasaki, la carrera armamentista fue en crecimiento. De
acuerdo con la opinión de Glinkin, la actual carrera de las armas
surgió y adquirió un carácter tan peligroso porque están interesados en
ella y la alientan, círculos políticos y económicos sumamente influyentes, especialmente los de Estados Unidos, para quienes la fuerza
militar sigue siendo el medio de alcanzar objetivos en política exterior,
y la carrera de los armamentos es la principal fuente de ganancias.
Podemos leer en el artículo de Jaime Martínez (2001), cómo The
New York Times, daba a conocer el 28 de Septiembre de 1998 una lista
de “ventas de materiales necesarios para guerra bacteriológica y otras
armas de destrucción masiva” (Martínez 2001). Uno de los casos aludido por el diario identificaba ventas norteamericanas en los ochenta
con aprobación gubernamental, que incluían patógenos mortíferos
elaborados en un centro de investigación en Fort Detrick, Maryland.
Por su parte, el gobierno inglés, hasta antes de 1997 continuó otorgando licencias a firmas británicas para exportar a gobiernos como el
I quaderni del CREAM , 2009, IX
93
de Irak, insumos utilizados en la fabricación de armas biológicas. En el
mismo artículo Jaime Martínez ofrece detalles de lo que el gobierno de
Estados Unidos fabrica y vende. En el primer semestre de 1997, el
Boston Globe y The Washington Post informaron del ataque norteamericano biológico contra Cuba en 1971. Los hechos fueron confirmados por fuentes dentro y alrededor de los círculos de la inteligencia
de EU. Así, con el conocimiento de oficiales de la CIA, comandos
ligados a grupos terroristas anticastristas introdujeron y dispersaron en
la isla un virus africano de fiebre porcina. Seis semanas después, al
estallar la epidemia, medio millón de cerdos debieron ser sacrificados
para evitar un desastre completo (Martínez 2001).
Este evento fue considerado por la FAO (Organismo dependiente
de las Naciones Unidas relacionado con la alimentación) como el
evento más alarmante de 1971, pues había sido la primera vez en que
la enfermedad golpeaba el hemisferio occidental. Toda la producción
porcina de la isla se detuvo por meses. “Una fuente ligada a la CIA
declaró que el germen fue suministrado en un contenedor sellado sin
identificación, en Fort Gulik, la base militar norteamericana en el
Canal de Panamá” (Martínez 2001). La misma fuente informó sobre
operativos estadounidenses en 1969 y 1970, con la finalidad de
dispersar nubes y dañar cultivos azucareros en Cuba. En ese mismo
contexto, la revista Covert Actino, del verano de 1982, aventuró la
posibilidad de que un brote de dengue estallado en la isla pudiese
haber sido ocasionado por la CIA. De mayo a octubre de 1981 se
presentaron 300 mil casos de epidemia, que debió ser erradicada luego
de una masiva campaña contra el Aedes aegypti, el mosquito transmisor. La hipótesis surgió de la acumulación de circunstancias, como
fue el incremento, tal vez inducido, en la precipitación que favorece la
diseminación del transmisor. Según Covert Actino, el ejército norteamericano y colaboradores académicos ya experimentaban con el
dengue desde 1959, en Fort Detrick, Maryland, y el Instituto militar de
Investigación Walter Reed en Washington.
Vayamos ahora a otro de los países que ha sufrido los ataques del
gobierno de Estados Unidos. Con la información que Pascal Beltrán del
Río (2001) nos proporciona, sabemos que Afganistán cuenta con un
sector minero en nacimiento e hidrocarburos. El principal yacimiento de
gas se encuentra en la región de Shebergan, y concentra el 40% de las
I quaderni del CREAM , 2009, IX
94
reservas del país. La casi totalidad de su producción se exporta a
Uzbekistán. El subsuelo de Afganistán alberga 4% de las reservas
mundiales de carbón, pero no son explotadas. La invasión soviética
acabó con todo el potencial industrial del país, que hasta hoy sigue
siendo aniquilado.
Un país devastado por 20 años de guerra, sin recursos, Afganistán
tiene la desdicha de encontrarse justo en el cruce entre dos mundos:
primero entre el imperio ruso y el británico; luego entre la URSS y el
bloque Occidental, y ahora en una zona de influencia que se disputan
la Federación de Rusia y Estados Unidos (Mergier 2001).
Tras observar la extrema complejidad de la situación en la que
Afganistán se encuentra (en pleno corazón de Asia Central), y la
estrategia de las compañías petroleras en esa región, el escritor francés
Franςois Lafargue expone lo que a su parecer constituye la causa del
problema bélico entre Estados Unidos y Afganistán. Relata como
antecedente del problema el año de 1991 con la desaparición de la
URSS, la independencia de las cinco repúblicas soviéticas de Asia
Central – Kazakstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmekistán – y el deseo de la mayoría de ellas de distanciarse de Moscú. El
presidente de Turkmekistán, Saparmurad Niasov era uno de los más
decididos en buscar la manera de exportar sus inmensas riquezas de
gas y petróleo sin pasar por Rusia. La construcción de gaseoductos y
oleoductos en Irán fue vetada por Washington. Surgió entonces la idea
de atravesar Afganistán. A finales de 1994, los talibanes irrumpieron
en el escenario político afgano, que acabaron por dominar casi por
completo en 1998. En el ensayo de Lafargue puede leerse que a finales
de 1994 e inicios de 1995, la empresa argentina Bridas empezó a
aparecer en el panorama. Contactó al presidente Niasov y negoció con
él un jugoso contrato para la futura explotación y exportación del gas
de Turkmekistán. Eso provocó que la empresa estadounidense Unolocal entrara a la batalla durante el segundo semestre de 1995 y
detuviera los proyectos de los argentinos.
Para una mejor comprensión de los intereses del gobierno de Bush,
necesitamos tener presente el antecedente creado por su padre en este
sentido. Durante su gobierno, George Bush padre, comenzó su política
petrolera expansionista. Antes de llegar a la presidencia fue empresario petrolero, y logró entre otras cosas, abrir la industria petrolera
I quaderni del CREAM , 2009, IX
95
soviética, colocar a Estados Unidos en el Medio Oriente y apoderarse
de los campos petroleros del Mar Caspio. Aprovechó para ello tres
sucesos que marcaron el cambio en la correlación de fuerzas políticas
en la región: la derrota de la Unión Soviética en 1989, el arribo de los
ayatolas chiítas al poder en Irán en 1982 y la desintegración de la Unión
Soviética en 1991. Embajador en China, funcionario de la Agencia
Central de Inteligencia y después presidente de Estados Unidos, Bush
padre conocía a fondo la situación que imperaba a mediados de la
década de los ochenta en el mercado petrolero internacional y sabía
cómo abrir las puertas a las transnacionales en el ámbito mundial.
Miguel García Reyes, investigador del Centro de Estudios de Asia
y África de El Colegio de México, expone que fue en este contexto en
el que Bush convenció en julio de 1991, durante su visita a la Unión
Soviética, a Mijail Gorbachov, para que ambas naciones colaboraran
en el ramo petrolero por medio de empresas privadas y no de gobiernos ni de organizaciones financieras internacionales. Con esto,
Chevron, por ejemplo, ganó contratos de explotación en Kazakstán,
Amoco lo hizo en Azerbaiyán, Mobil concluyó jugosos contratos en la
región de Sajalin, mientras que Exxon hizo lo mismo en la región
septentrional de Rusia, Pechora. El investigador señala que Bush
padre enfrentó de manera muy rápida la invasión de Irak a los campos
petroleros de Kuwait. Y es que, explica, Washington sabía que la verdadera finalidad de Irak eran los pozos petroleros de Arabia Saudita,
donde se encuentran 259 mil millones de barriles de petróleo; esto es,
20% de las reservas petroleras mundiales.
En El nuevo orden petrolero global, Miguel García Reyes y Djalma Ojeda Fierro mostraban ya las intenciones de expansión de
Estados Unidos en la zona de Asia Central. El libro destaca que la
región que rodea a Afganistán tiene un gran valor petrolero: reservas
de más de 200 mil millones de barriles, además de que también es rica
en gas natural. García Reyes destaca que el deseo de Estados Unidos
es controlar el puente euro-asiático en la comercialización petrolera de
la zona. Expone además que la idea de Bush es cercar a Rusia
mediante el control de Afganistán que tiene frontera con Tayikistán,
nación que impulsaba a la llamada Alianza del Norte. Sin embargo,
nos dice, “Rusia está tratando de recuperar la periferia que perdió
cuando se acercó al capitalismo. Ahora busca acuerdos con India y
I quaderni del CREAM , 2009, IX
96
China, que deben concretarse pronto. De lo contrario, Estados Unidos
tomará posesión también de Asia Central, como lo hizo del Golfo
Pérsico después de la guerra.” Con estos antecedentes, el investigador
asegura que el presidente de los Estados Unidos buscaba consensos
para, con el pretexto de atrapar a Osama Bin Laden, posesionarse y
controlar Afganistán, Turkmekistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, naciones de Asia Central, que tienen cerca de 200 mil millones
de barriles de reservas de petróleo, lo que los convierte en la segunda
zona proveedora del mundo, después del Golfo Pérsico, que posee 660
mil millones de barriles. Además, Estados Unidos podrá controlar,
mediante inversiones de transnacionales petroleras, los ductos que
surten de gas y petróleo a Europa, con lo que “abrirá o cerrará la llave
del suministro cuando quiera.”
Observamos en todo lo anterior que la globalización se expresa
como un proceso que pretende la expansión de capitales a escala
mundial, que al chocar con las realidades regionales adquiere características singulares. Se trata de un proceso inconcluso de capitales, que
promueve la crisis, el incremento de la competencia y la aceleración
del cambio tecnológico. Además, promueve una modernización que se
puede traducir en secularización, individualización, urbanización, industrialización, mercantilización y racionalización. Así, la globalización se expresa como una organización en la que los hombres son
transformados en engranajes de una máquina, dominada por la técnica
y la economía, promoviendo la división del trabajo en distintas escalas
y la difusión de los factores productivos, acordes con los principios
del mercado.
El impulso al consumismo a través de redes mediáticas transnacionales, nos conduce inevitablemente a la tensión entre lo global y
lo local. Por ello, ahora revisaremos el impacto de esta ideología
cultural en una sociedad tradicional que ha visto modificadas las
expresiones simbólicas de su carnaval, Chiautempan, municipio del
estado de Tlaxcala, que se ha caracterizado por representar las guerras
antes descritas durante la celebración de la fiesta.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
97
Efectos del consumismo en el Carnaval de Chiautempan, Tlaxcala
El Carnaval es una tradición muy importante en el estado de
Tlaxcala, y debido al interés por conocer si hay efectos del consumismo en la celebración de Chiautempan, decidimos emprender la
búsqueda, recurriendo a la etnografía para recuperar las percepciones
que danzantes, espectadores, autoridades y población en general tiene
de esta tradición. Chiautempan se ha distinguido por ser un espacio
donde permanece vigente el performance del Ahorcado en Carnaval,
entendiendo por tal los actos vitales de transferencia, que trasmiten
saber social, memoria, y sentido de identidad a través de acciones
reiteradas. Encontramos así que en Chiautempan sus habitantes llevan
a cabo año con año una sátira social, donde las acciones de autoridades del ámbito económico, social, político y religioso quedan al
descubierto cuando son expuestas públicamente en el performance del
Ahorcado. Herederos de una tradición milenaria, los habitantes de este
pueblo recuerdan a través del carnaval eventos de la historia de la que
han sido parte. Las percepciones y reflexiones sobre el tiempo presente que compartieron con nosotros, nos permitieron distinguir los
efectos que el consumismo está provocando en la interpretación de
esta tradición. Revisemos sus características.
En el carnaval de Chiautempan se realizan dos desfiles a los que la
población asiste con gran entusiasmo, el de inauguración y el de cierre, donde participan escuelas de la localidad y algunas otras invitadas.
Distintos barrios participan de manera autónoma: algunos hombres se
disfrazan de mujeres, otros imitan a personajes políticos, como burla
al manejo de sus cargos en el gobierno, y se presenta la nueva reina de
carnaval. También asisten invitados de algunos estados como Veracruz, Estado de México, Puebla, etc.
El ahorcado es una satirización de las diferentes personalidades
políticas más conocidas, que se actualiza durante el carnaval. Se trata
de una crítica de los ciudadanos en la que manifiestan cómo quisieran
que fuera su gobierno. Aquí se alude a los políticos, servidores públicos y personajes conocidos. El ahorcado se representa el día del remate, día en que concluye la fiesta, donde también hay desfile, bailes y
otros eventos realizados en las calles y el zócalo del municipio. El
ahorcado se lleva a cabo en el centro de la localidad y se reparten
I quaderni del CREAM , 2009, IX
98
carteles en todos los barrios. Estos carteles contienen la sátira de la
que son objeto el ayuntamiento, los empresarios, la iglesia, los servidores públicos y el cuerpo administrativo.
Chiautempan es uno de los municipios con un porcentaje significativo de empresarios. Los encontramos como dueños de colegios
particulares, de comercios y de industrias textiles. Vale tener esto en
cuenta si notamos que son estas figuras las que se ridiculizan durante
el carnaval. En los espacios rurales las figuras que se ridiculizan y
cuestionan son las del hacendado, viuda, y sacerdote. En contraparte,
en el espacio urbano, las de comerciantes, empresarios, las esposas de
ambos, y las de sacerdotes. Sea el espacio rural o urbano, estas figuras
están al frente de instituciones que generan riqueza. Con la representación del ahorcado queda al descubierto que las medidas empleadas
durante la Reforma no fueron suficientes para expulsar a la clase
dominante de ese tiempo y aún la vemos en las instituciones más
importantes de Chiautempan. ¿Cuál es el sentido de la denuncia que
los chiautempenses externan durante el carnaval con la actuación del
ahorcado? Creemos que hay una demanda implícita por un orden
distinto, en el que no sea el extranjero quien siga enriqueciéndose con
el trabajo del pueblo, y en consecuencia, lo mantenga empobrecido.
Chiautempan demanda, a través de la actuación del Ahorcado, la
eliminación de esa figura de poder.
Ahora bien, por lo que respecta a los desfiles, observamos que en
Chiautempan prosigue la costumbre de que la reina de carnaval y sus
seguidores alegren la fiesta distribuyendo al público observador gran
cantidad de dulces, y despierten con ello la algarabía de la población.
Esta costumbre de arrojar dulces durante las procesiones de culto a
deidades antiguas se encontraba ya en el siglo XVI tanto en España
como en Italia y Francia. Los especialistas en el tema como Bajtin
(1999), Ciapelli (2001), Caro Baroja (1979), Le Roy Ladurie (1994),
Heers (1988) y Burkckhardt (1984), han encontrado reminiscencias de
esta costumbre en las marchas de carnaval en toda Europa. Hoy las
podemos apreciar en los desfiles del carnaval de Chiutempan, donde la
reina de la fiesta simboliza a una deidad femenina de tiempos antiguos. Además de la reina de carnaval, participan en el desfile los
contingentes representativos de los barrios de Chiautempan, donde el
barrio también genera identidad. En las repuestas que nuestros inforI quaderni del CREAM , 2009, IX
99
mantes nos proporcionaron pudimos notar que su conformación
responde a la historia de los grupos sociales que lo integran. Algunos
aluden a la antigüedad de la familia, otros, al prestigio social y unos
más, a la actividad desempeñada. Sea una u otra la referencia, el barrio
los representa frente a la comunidad. Esta es la razón por la que
durante el desfile marchan distintas camadas de los barrios que integran a Chiautempan.
Además de las camadas, desfilan durante el carnaval los personajes
que participan en el performance del ahorcado. Así encontramos a las
“lloronas”, hombres disfrazados de mujeres, haciendo denuncias en
grandes cartulinas, en las que exhiben al tesorero del ayuntamiento por
su inadecuado proceder en el manejo de los recursos. Asimismo, las
encontramos haciendo alusión al enriquecimiento de los empresarios
de la localidad. También encontramos en el desfile a personajes
disfrazados de Osama Bin Laden y Saddamm Hussein con mantas en
las que cuestionan la intervención de Bush en Afganistán e Irak. Aquí,
el ahorcado guarda una simbología muy compleja. Por una parte, el
ahorcado representa a la institución, a la formalidad, al orden, etc., y
periféricas a él se encuentran las lloronas, que representan al pueblo
que cuestiona, que ríe, que ridiculiza lo formal, que sobaja lo que está
en un nivel superior y lo elimina. De esta manera, las lloronas, que
simbolizan al pueblo que se mofa, crean otra realidad, desapareciendo
los símbolos del poder, representados en Chiautempan por los funcionarios públicos, políticos, iglesia, empresarios y comerciantes, y crean
otra, a la que imprimen las características de un nuevo orden. Para
ello, los actores utilizan máscaras que les permiten exteriorizar sin
problema alguno el sentimiento contenido. Así, bajo la máscara emerge la verdad declarada por el pueblo, emerge la demanda de otra
realidad, surge la realidad verdadera y se borra la de la apariencia.
En Chiautempan, el performance del Ahorcado promueve en las
conciencias de los ciudadanos la crítica dirigida hacia los símbolos de
poder, representados por el presidente municipal, presidente de la
república, políticos locales y extranjeros, iglesia, comerciantes y
empresarios. La particularidad de Chiautempan es que distribuye antes
de la ejecución del performance, los guiones que contienen el desarrollo de su actuación. También encontramos en los desfiles de
Chiautempan a contingentes representativos de los estados de Puebla y
I quaderni del CREAM , 2009, IX
100
Veracruz. Asimismo, a grupos de Cuba y Brasil, que nos permiten ver
algunos rasgos de su carnaval. Es posible que aquí esté la respuesta al
problema que hoy nos ocupa, observar los efectos del consumismo en
el carnaval de Chiautempan. El carnaval de este municipio ha ido
incorporando a su celebración a diversas instituciones. Escuelas del
municipio, y otras invitadas, así como contingentes de otros estados
participan en el desfile de carnaval. Con esto, la presidencia municipal
se ha convertido poco a poco en el eje rector que orienta la estructura
de la fiesta, lo que ha traído consigo que el carnaval esté modificando
sustancialmente el sentido de la representación. Si observamos con
cuidado, veremos que el desfile se ha convertido en un ingrediente
importante para los comercios locales y enormes trasnacionales, que
aprovechan la ocasión para vender sus mercancías.
Es necesario resaltar esta situación porque si las autoridades y la
población del municipio continúan en esta dinámica, la celebración
del carnaval podría salir de su control y pasar a manos de grandes
empresas como ha sucedido en el Puerto de Veracruz, donde el interés
gira alrededor de las ganancias monetarias que la fiesta genera. Al
respecto, debemos aclarar, que tras un recorrido por el estado costeño
pudimos percatarnos de la dificultad que la población tiene para
disfrutar de su desfile de carnaval, debido a que el ayuntamiento vende a las empresas trasnacionales los lugares por donde transita el
desfile, y éstas a su vez los venden a la población a precios muy
elevados. Si Chiautempan prosigue en la dinámica de promover durante
sus desfiles a empresas como Coca Cola, Pepsi Cola, Corona, Superior,
etc., lo que veremos más adelante será un municipio atrapado en las
redes del consumismo, característico de la globalización. Y el riesgo se
extenderá de manera lógica al resto de las comunidades pues una
característica que el carnaval ha seguido es la de imitar lo que el resto
de los municipios implementa para hacer novedosa la fiesta.
Las compañías comerciales están haciendo suya la idea de que el
carnaval es un tiempo ideal para fomentar la embriaguez y aprovechan
la ocasión para infiltrarse en la población, obligándola a pagar por
observar sus anuncios mercantiles. Esta es la estrategia que siguen las
transnacionales para transformar una tradición local en un desfile comercial, de carácter global, que les garantiza el consumo de los productos producidos. Este fenómeno nos permite ver claramente cómo
I quaderni del CREAM , 2009, IX
101
aplica el estudio de los medios de comunicación en el Tercer Mundo.
Aquí, la publicidad es el lugar obvio para empezar a investigar el
modo como funciona la ideología cultural del consumismo.
La participación dentro del carnaval le otorga al chiautempense
prestigio social frente a la comunidad. Por ello, el día en que concluye
la fiesta se hace pública la colaboración de las dos comisiones y se
subrayan los nombres de las personas que otorgan los apoyos gestionados. Asimismo, se dan a conocer los nombres de las dos comisiones
que trabajarán en la celebración del carnaval del siguiente año. Con
esto, el compromiso social que los participantes adquieren para
colaborar es difícil de romper pues la comunidad se convierte en
testigo y juez de su asentimiento para hacerlo. De esta manera, el
prestigio y el compromiso social quedan estrechamente ligados. El
participante se compromete socialmente a cumplir con lo establecido,
y el cumplimiento de este compromiso le da frente a la comunidad
reconocimiento y prestigio social.
Si consideramos la historia del ahorcado, vemos la recurrencia de
las figuras que son objeto de burla en Chiautempan: tenderos, carniceros, panaderos, etc., todos comerciantes de comida y bebida, a
quienes los chiautempenses rebajan a un cuerpo material, a un cuerpo
que se degrada, a un cuerpo que desaparece y que es el que caracteriza
al carnaval. Resulta interesante que actividades ligadas al sector
primario tales como la producción del pan, la venta de la carne y otros
productos básicos tenga una fuerte presencia en el desarrollo de la
historia del Ahorcado en Chiautempan. Y es que estas actividades
están ligadas directamente con la acción de ingerir. De acuerdo con
Bajtin, vemos que
... la comida y la bebida eran el centro de atracción de los banquetes
conmemorativos. La alegría y la risa festiva se manifestaban con motivo del
banquete y se asociaban con la imagen de la muerte y el nacimiento (renovación de la vida) en la unidad compleja de lo "inferior" material corporal
ambivalente (a la vez devorador y procreador) (Bajtin 1999).
Siguiendo a Rabelais (2002), la tendencia a la abundancia y a la
universalidad está presente en cada una de las imágenes del comer y
del beber, pues son una de las manifestaciones más importantes de la
vida del cuerpo grotesco. Los rasgos particulares de este cuerpo son el
I quaderni del CREAM , 2009, IX
102
ser abierto, estar inacabado y en interacción con el mundo. En el
comer estas particularidades se manifiestan del modo más tangible y
concreto: el cuerpo se evade de sus límites; traga, engulle, desgarra el
mundo, lo hace entrar en sí, se enriquece y crece a sus expensas. El
hombre degusta el mundo, lo introduce en su cuerpo, lo hace una parte
de sí mismo. Es conveniente señalar para el caso de Chiautempan, que
el comer colectivo, coronación de un trabajo colectivo, no es un acto
biológico o animal, sino más bien un acontecimiento social. Por ello,
en el proceso organizativo del carnaval, los organizadores colocan al
banquete en un lugar especial. En esta comunidad el banquete celebra
siempre la victoria. Las mayordomías o comisiones actúan con eficacia para asegurar la comida y bebida de los participantes. Por ello, el
triunfo del banquete es universal, es el triunfo de la vida sobre la
muerte.
Otra de las características del carnaval en Chiautempan es el
carácter prohibitivo de su celebración. Gobernadores, presidentes municipales y sacerdotes aparecen en escena para aprobar o desaprobar la
fiesta, según sus conveniencias. En Chiautempan permanece vivo el
carácter burlesco del carnaval dirigido contra las autoridades eclesiásticas del lugar. De acuerdo con Heers, el carnaval era una fiesta
que la iglesia católica promovía, y de la cual se desprendió por ser el
blanco preferido de los ataques de sus mismas órdenes religiosas. Sin
embargo, a pesar de separarse de ella, la iglesia sigue siendo cuestionada no sólo por sus feligreses sino ahora también por los civiles. Una
de las críticas más severas tiene que ver con la opulencia en la que
vive el clero. Otra, con el actuar poco ético de los sacerdotes en un
buen número de comunidades, y una más, con relación al estado de
embriaguez en el que llegan a oficiar misa. Resulta interesante que la
crítica dirigida a la iglesia católica provenga de sus propios intelectuales. El tiempo transcurre, hay cambios sustanciales en los contenidos
de los guiones, hay transformaciones en las figuras de poder, y sin
embargo, hay rasgos de la celebración que permanecen latentes. Diremos, a manera de recordatorio, que la obra de Heers nos permitió
encontrar un hilo conductor a la siguiente interrogante: ¿por qué tras
ser la promotora de estas fiestas, la iglesia católica prohibió su
celebración, no sólo en los períodos históricos antes referidos, sino
también en la actualidad? Heers señala que la fiesta cómica, burlesca,
I quaderni del CREAM , 2009, IX
103
y por tanto muy poco satírica es, por su origen y por su esencia,
paralitúrgica: una diversión de iniciados para sorprender a los demás,
incluso para chocarles, y después atraerles.
El orden de las actividades carnavalescas es el siguiente: después
del desfile de disfraces, prosigue la satirización a través de diálogos,
criticando a quienes se hayan distinguido por alguna acción trascendente, positiva o negativa, realizada en el transcurso del año, dentro
y/o fuera de la comunidad. Después, se procede a colgar un muñeco,
mismo que simboliza al “reo” (el ahorcado), elaborado con alambre y
forrado con papel de colores. Se le rellena de cuetes y luces, y se le
prende fuego. Este acto representa la quema del “mal humor” y se
concluye así la escenificación del Carnaval y del Ahorcado.
La vestimenta de los huehues hombres de Chiautempan se compone de los siguientes elementos: se cubren el rostro con una máscara
de facciones españolas, y la cabeza con una pañoleta de color, sobre la
cual colocan un sombrero de palma, adornado con largas y vistosas
plumas de colores y pequeños espejos, de los cuales penden pañoletas
de colores. Utilizan pantalón y camisa blanca con grecas bordadas;
llevan una capa, también bordada, y castañuelas. Las mujeres llevan
un vestido blanco bordado con flores y guías, usan zapatos rojos. Cabe
señalar en este aspecto que, como resultado de la influencia de la
televisión, de la publicidad y del proceso migratorio de nuestros trabajadores a Estados Unidos, los danzantes han bordado a sus capas
representaciones de caricaturas como la del “Correcaminos”, “El
Demonio de Tazmania”, “Piolín”, etc. Los chiautempenses han asimilado elementos comerciales de diversas transnacionales, convirtiéndose en presas fáciles del consumismo e imprimiendo a la tradición
del carnaval un cambio significativo. Otro rasgo en el que se percibe
la ideología cultural del consumismo es el cambio en el uso del
calzado. En lugar de los típicos botines o huaraches, hoy nuestros
huehues danzan con tenis de moda.
Ahora nos referiremos a los significados que los chiautempenses le
dan al carnaval. Apegándonos a las respuestas ofrecidas, encontramos
que los ciudadanos de este municipio encuentran el origen de las
danzas en los bailes colectivos celebrados en el señorío de Tizatlán.
Respecto del vestuario usado, refirieron que el blanco significa la
pureza, y el rojo, la sangre derramada por los indígenas en la conI quaderni del CREAM , 2009, IX
104
quista de ese señorío. Además, cada una de las flores del vestuario
alude a las generaciones que han continuado con la tradición. La guía
de los trajes marca la diferencia con respecto a las demás camadas.
Otros señalaron que la indumentaria usada por los hombres es una
imitación del catrín español. En esta idea, el carnaval presenta aquí otro
significado: es el tiempo en el que los trabajadores indígenas tenían
oportunidad de burlarse de sus patrones y manifestar su inconformidad
por el maltrato recibido. Para esto, utilizaban máscaras con rasgos
semejantes a los del colonizador e imitaban sus comportamientos.
Un significado más está ligado a la religión católica. Así tenemos
que el carnaval también es una fiesta para despedir a la carne.
Entonces, es un tiempo de permisibilidad, en el que los excesos con
relación al vino y a la comida están justificados. Encontramos así tres
significados, el primero, ligado a formas de culto prehispánicas, el
segundo, vinculado a la Semana Santa, y el tercero, como el tiempo
permitido para destruir simbólicamente a la autoridad. A estas
significaciones profundas agregaríamos dos más, una ligada a los
cuerpos grotescos de hombres disfrazados de mujeres viejas en estado
de gravidez, y otra, vinculada al ejercicio de la guerra. Respecto de la
primera significación, coincidimos con Bajtin en ver en esos cuerpos
la circularidad del tiempo, donde un cuerpo viejo muere para alumbrar
uno nuevo. Aquí, el cuerpo grotesco es un cuerpo en movimiento, es
un cuerpo fecundante-fecundado, que da a luz al mundo.
Ahora bien, con respecto a la segunda significación, Chiautempan
refiere de manera recurrente el maltrato sufrido, después de la Conquista, por los colonizadores españoles. Con la guerra de Independencia, el chiautempense puede desahogar durante el carnaval todo el
rencor que el colonizador le despierta, expresando libremente sus
ideas y haciendo burla del español. La guerra expresa la resistencia de
estos pueblos a seguir bajo el yugo español. Chiautempan alude a la
guerra de Independencia, a la guerra sufrida contra Francia, a la
Revolución Mexicana y a la guerra chiapaneca. Asimismo, a las
guerras sostenidas por Bush contra Afganistán e Irak, en las que se
expresan claramente las tendencias de control social por parte de
Estados Unidos, al emplear la carrera armamentista para activar su
economía.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
105
Conclusiones
La respuesta a la pregunta inicial de este capítulo es, sí. Sí hay
consumismo en el carnaval de Chiautempan. Los tentáculos de las
grandes transnacionales se han extendido al espacio local y están
transformando esta tradición. Los habitantes van asumiendo poco a
poco los nuevos elementos y hoy los perciben como parte de ella. Los
carros alegóricos de las empresas transnacionales Coca Cola, Pepsi
Cola, Sabritas, etc., están presentes en los desfiles de carnaval no sólo
en Chiautempan, Tlax., sino en los del Puerto de Veracruz y Mazatlán,
en Brasil y en otras partes del mundo donde se festeja el carnaval.
Hoy, las grandes transnacionales se benefician con la celebración de
esta tradición, pues se han apropiado de la ideología cultural de
muchos pueblos que festejan el carnaval. La televisión, el cine, la
publicidad y otros medios de comunicación alientan a los habitantes
de todas las regiones a consumir los productos que producen. Y esto
no queda ahí, pues a partir del consumismo, los reproductores de la
tradición han asumido los símbolos de estas empresas y los han hecho
suyos, imprimiéndolos al traje que usan. Además, el uso de nuevo
calzado; de tenis, en lugar de huaraches o botines; de gorras, en lugar
del sombrero típico; de máscaras de luchador, en lugar de las máscaras
con facciones españolas o francesas, es una respuesta a la cuestión del
sistema de valores apropiado. Es decir, para una transición exitosa hacia
la modernización capitalista, las empresas transnacionales emplean la
ideología cultural del consumismo. ¿Una invitación al olvido?
Las empresas transnacionales le están enseñando a la población de
Chiautempan y de otros lugares del Tercer Mundo a consumir, en el
sentido especial de crear y satisfacer necesidades inducidas. En las
respuestas ofrecidas por los informantes más ancianos de la región se
percibe su preocupación por mantener viva la historia de la tradición.
Es decir, no olvidar el significado de cada uno de los elementos que
conforman el traje de los danzantes. Cada color, cada pluma, etc., es
parte de la historia del pueblo de Chiautempan. La insistencia en no
olvidar el maltrato sufrido por los indígenas tlaxcaltecas, la burla dirigida al español al imitar sus danzas, trajes, características del rostro,
tiene una intención: guardar memoria de los eventos históricos para no
repetir los mismos errores. Con la incursión de nuevos elementos que
I quaderni del CREAM , 2009, IX
106
nada tienen que ver con la historia revolucionaria de este pueblo, a lo
que se está empujando a sus habitantes es a olvidar. Veíamos al inicio
del capítulo que la ideología cultural del consumismo neutraliza y
reinterpreta las tradiciones culturales de forma que sofoca la oposición
cultural. Esta es una de las formas más eficaces en las que funciona el
capitalismo global, y de la que Chiautempan está siendo objeto.
Bibliographia
Bajtin M. 1999, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El
contexto de Francois Rabelais, Alianza Editorial, Madrid.
Beltrán del Río P. 2001, El hambre, Proceso, n. 1300, México.
Belk R. 1988, Third World consumer culture, Research in Marketing, Supplement 4, pp. 103-127.
Burkckhardt J. 1884, La cultura del Renacimiento en Italia, Porrúa, México.
Caro Baroja J. 1979, El Carnaval (análisis histórico-cultural), Taurus, Madrid.
Ciapelli G. 2001, Un festín para los sentidos, La aventura de la historia, n. 28,
Año 3, Febrero.
Glinkin A., Isakova N., Yakovlev P. 1987, América Latina contra el peligro de
Guerra, Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, Moscú.
Heers J. 1988, Carnavales y fiestas de locos, Península, Barcelona.
Le Roy Ladurie E. 1994, El Carnaval de Romans, De la Candelaria al Miércoles
de Ceniza 1579-1580, Instituto Mora, México.
Martínez Veloz J. 2001, ¿Apoyo incondicional?, Proceso, n° 1300, México.
Mergier A. M. 2001, Afganistán, El petróleo, Proceso, n° 1300, México.
Rabelais F. 2002, Gargantúa y Pantagruel, Grupo Editorial Tomo, S. A. de C.
V., México.
Sklair L. 1988, Transcending the Impasse: Metatheory, Theory and Empirical.
Research in the Sociology of Development and underdevelopment, World
Development, Vol. 16, pp.697-709.
Sklair L. 2003, Sociología del sistema global. El impacto socioeconómico y
político de las corporaciones transnacionales, Gedisa, Barcelona.
Wells A. 1972, Picture-Tube Imperialism? The impact of U. S. television on
Latin America. Maryknoll, Orbis, NY.
Zayed A. 1987, Popular culture and consumerism in underdevelopment urban
areas: a study of the Cairene quarter of Al-Sharrabiyya, G. Stauth, S. Zubaida
(a cura di), Mass Culture, Popular Culture and Social Life in Middle East,
Campus Verlag, Frankfurt, Boulder, Colorado.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
107
MANUELA TASSAN1
CATEGORIE A CONFRONTO:
‘NATURA’ E ‘AMBIENTE’
NEL DIBATTITO ANTROPOLOGICO
L’articolo intende proporre una revisione critica delle categorie “natura” e “ambiente” all’interno del dibattito antropologico. In primo luogo,
verrà problematizzato il loro ruolo nell’ambito della rigida distinzione
tra prospettive materialiste e simboliste degli anni ’60, espressione a
livello disciplinare della dicotomia teoretica natura-cultura. Ho scelto di
focalizzare l’attenzione sull’antropologia ecologica proposta da Rappaport e sullo strutturalismo di matrice cognitivista di Lévi-Strauss, poiché ritengo possano essere considerati degli esempi quasi idealtipici di
tale dualismo epistemologico. L’obiettivo è dimostrare come, pur nella radicale diversità dei loro approcci, sia possibile riconoscere nei loro lavori una medesima concezione oggettivante della ‘natura’, ben
espressa dalla sua “traduzione” nei termini di ambiente, fondamentale
parola-chiave dell’ecologia scientifica.
In secondo luogo, propongo una riflessione sulla svolta epistemologica monista avvenuta, o quanto meno auspicata, in campo antropologico. In particolare, intendo accennare al contributo offerto nel dibattito da un particolare approccio teorico, noto come ecologia politica post-strutturalista (Peet, Watts 1996a; Escobar 1999; Biersack,
Greenberg 2006). Affermatasi nel contesto americano, ha tentato di
applicare le potenzialità euristiche offerte dalla critica postmoderna
allo studio antropologico natura, senza cadere in quelle forme radicali
di costruttivismo guardate con sospetto da importanti studiosi del settore (Descola, Pálsson 1996; Ingold 2000; Milton 1996). Questo approccio teorico si è inoltre distinto anche per il suo tentativo di elabo-
1
Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano Bicocca.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
109
rare una peculiare concettualizzazione di natura, distinta rispetto alle
categorie analitiche delle “scienze dure”.
La dicotomia natura-cultura
Com’è noto, l’opposizione tra natura-cultura affonda le sue radici
nella scissione tra spirito e materia consolidatasi nella storia del pensiero filosofico occidentale. La metafisica dualistica di Cartesio ha posto le basi della scienza proprio nella distinzione tra sostanza estesa
(res extensa) e sostanza pensante (res cogitans), separando nettamente
una concezione meccanicistica del mondo corporeo da una concezione
spiritualistica dell’uomo. L’antitesi uomo-natura si è quindi riconfigurata nei termini di un’irriducibile spaccatura ontologica tra Soggetto conoscente e Oggetto che si offre al pensiero. Secondo Merleau-Ponty,
“l'idea della natura come esteriorità implica immediatamente l'idea
della natura come sistema di leggi” (1996, p. 12, corsivo aggiunto) che
preesistono all'uomo e che, quindi, si presterebbero ad un'opera di “disvelamento”. La storia del concetto di natura sarebbe stata, dunque,
segnata dalla progressiva divaricazione tra significato scientifico e significato morale: “la natura reificata, ridotta a mera res extensa, esaurita dalla sola dimensione quantitativa, resta priva di legami di origine
e significato con la soggettività, la res cogitans” (Tallacchini 1998, p.
11, corsivo aggiunto).
L'antropologia, per lungo tempo, non ha mai rimesso in discussione la validità della dicotomia e, soprattutto negli anni '50-'60, come
vedremo nei prossimi paragrafi, si è, anzi, sviluppata attorno a questo
fondamentale nucleo teorico, oscillando tra posizioni marcatamente
materialiste e interessi di tipo cognitivo per la cultura. Le prime tentavano di spiegare l'organizzazione sociale e la cultura di un gruppo
come risposte adattive ad un ambiente specifico, pensato come sistema chiuso in equilibrio omeostatico (Escobar, Hvalkof 1998; Orlove
1980). Le seconde rappresentavano la natura come il sostrato materiale su cui poggiano le attribuzioni di senso della cultura. La ricostruzione di queste prospettive attraverso il contributo di due autori agli
antipodi tra loro non si propone in alcun modo di essere esaustiva, ma
intende solo mostrare il ruolo e il significato assunto dalle categorie
‘natura’ e ‘ambiente’ nel modello epistemologico dualista.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
110
Prospettive materialiste: l’antropologia ecologica
Prima di analizzare nello specifico l’ecoantropologia2 di Rappaport, ritengo fondamentale offrire due precisazioni. In primo luogo,
l’antropologia ecologica non rappresenta l’unica prospettiva qualificabile come “materialista”. Come osservano Descola e Pálsson (1996, p.
2), anche la sociobiologia o alcune branche dell’antropologia marxista
possono rientrare, per esempio, in questa schematizzazione, seppur
con sfumature di significato diverse.
In secondo luogo, è bene puntualizzare che l’antropologia ecologica stessa non costituisce un indirizzo teorico univoco e coerente. Sotto
questa “etichetta” confluiscono, infatti, prospettive diverse, seppur accomunate, almeno in origine, da un approccio sostanzialmente nomotetico, dove le concezioni locali della natura appaiono come rappresentazioni distorcenti di una realtà esterna colta invece dall’antropologo nella sua scientifica oggettività. Secondo Ingold (1992, p. 39), il
principale tratto distintivo dell’antropologia ecologica, pur nella varietà dei suoi sviluppi, risiede nella peculiare concezione della cultura
che presuppone, considerata come un fondamentale meccanismo di
adattamento all’ambiente.
Come efficacemente evidenziato da Orlove (1980), è nel panorama
culturale americano che si sviluppa uno specifico interesse antropologico per la tematica ambientale. In particolare, Julian Steward è stato
considerato il precursore dell’antropologia ecologica. Egli, significativamente, non usa mai il termine “natura”, ma preferisce un lessico differente, che lo collochi nel campo semantico delle scienze naturali, in
particolare dell’ecologia scientifica:
(...) il significato principale di ecologia è “adattamento all’ambiente”. Fin
dai tempi di Darwin l’ambiente è stato concepito come il tessuto complessivo
della vita all'interno del quale tutte le specie animali e vegetali interagiscono
reciprocamente e con i caratteri fisici sopra una data unità territoriale. (Steward 1977 [1955], p. 43, corsivo aggiunto)
Fondatore dell’ecologia culturale, Steward propone una visione
dell’ambiente come “fattore extraculturale” che, proprio perché “ester2
Termine mutuato da Lanternari (2003).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
111
no alla cultura”, può spiegare le origini stesse del mutamento culturale, risolvendo in questo modo quello che considera lo “sterile assunto
secondo cui la cultura deriva dalla cultura” (ibid., p. 51).
Con Steward, l’ambiente acquista una potenzialità esplicativa in
campo antropologico solo attraverso l’inquadramento teorico offerto
dall’ecologia, di cui assume l’approccio e il linguaggio. La natura, qui
intesa come sinonimo di materia organica e di ineluttabili leggi biologiche, si impone nel polo “materiale” della dicotomia attraverso un
concetto di ambiente mutuato dalle “scienze dure”.
L’approccio ecosistemico di Roy Rappaport
La dimensione empirica e il legame con l’ecologia verranno portati
alle estreme conseguenze nell’antropologia ecologica di Andrew Vayda
e del suo allievo Roy Rappaport, basata su una prospettiva ecosistemica e su un approccio funzionale (functional). L’attenzione si sposta dal
modo in cui l’ambiente stimola, o impedisce, l’affermazione di alcune
particolari forme sociali e culturali alla problematizzazione dei modi
in cui tali forme funzionano per mantenere le relazioni esistenti con il
proprio ambiente (Ortner 1984, p. 133). Se Steward aveva tentato di
portare la cultura, intesa soprattutto in un’accezione tecnico-materiale,
al centro dell’analisi ecologica, Rappaport, in particolare, si focalizza
sul concetto di ecosistema, con cui intende un “sistema di scambi trofici localizzati” (Rappaport 2000[1968], p. 225), dove i gruppi umani
sono intesi come unità demografiche, comparabili a qualsiasi altra popolazione biologica.
Lo statuto epistemologico dell’ecologia si struttura, infatti, attorno
a due grandi oggetti d’interesse: da una parte, le popolazioni – animali, vegetali o microbiche –, dall’altra gli ecosistemi. Una popolazione è
costituita da un insieme di individui di una stessa specie che coesistono in una data porzione di spazio, in cui possono dar luogo, attraverso
dei processi biodemografici, a delle ricombinazioni genetiche (Barbault 2000, pp. 150-151). L’idea di ecosistema presuppone, invece,
l’esistenza di flussi di materia e di energia che strutturano i sistemi
ecologici, di cui si studiano le dinamiche e l’organizzazione spaziale,
poiché “l’être vivant (…) c’est avant tout une machine, qui consomme
de l’énergie” (ibid., p. 164).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
112
In Pigs for the Ancestors, l’opera più famosa di Rappaport, uscita
nel 1968, si abbandona qualsiasi velleità esplicativa per mostrare semplicemente “how things work”, adottando un punto di vista descrittivo,
di cui si presume l’inequivocabile oggettività (Vayda 2000 [1968], p.
VIII). L’obiettivo dell’antropologia ecologica non è, dunque, una riflessione sull’uomo nella sua specificità, ma, al contrario, negli aspetti
che lo accomunano con le altre specie viventi, poiché “the study of
man like culture-bearer cannot be separated from the study of man as
a species among species” (Rappaport 2000, pp. 241-242). Per rendere
il concetto di cultura applicabile anche al di fuori dell’ambito strettamente umano, viene interpretato in termini comportamentali e non in
chiave simbolica e significante. Una prospettiva contro cui Marshall
Sahlins si scagliò fortemente nel suo Culture and Practical Reason,
ritenendo che vi si esprimesse una forma di feticismo dell’ecologia, in
cui “niente della cultura è ciò che sembra” e tutto si traveste da fatto
naturale assumendo l’apparente capacità di essere fondamentale ed esatto, pur essendo, invece, sostanzialmente astratto e frutto di un’attività simbolica che rappresenta la facoltà specifica dell’uomo (Sahlins
1982[1976], p. 32, p. 102).
Rispetto all’ecologia culturale di Steward, l’attenzione tende a spostarsi dall’adattamento, che si riferisce all’insieme dei processi attraverso cui la struttura dei sistemi cambia in risposta a delle pressioni
ambientali, alla regolazione, termine usato per indicare i meccanismi
che permettono ai sistemi di mantenere la propria struttura (Rappaport
2000, p. 241). È in questa prospettiva che va collocato lo studio del rituale condotto da Rappaport presso gli Tsembanga della Nuova Guinea:
Ritual will be regarded here as a mechanism, or set of mechanisms, that
regulates some of the relationship of the Tsembanga with components of their
environment. The term regulate and regulation imply a system; a system is
any set of specified variables in which a change in the value of one of the
variables will result in a change in the value of at least one other variable. (ibid., p. 4, corsivo nell’originale)
Il rituale viene quindi posto al centro dell’analisi per i suoi effetti
regolativi sull’ambiente, in grado di autoregolarsi (self-regulated) sulla base di meccanismi di feed-back pensati sul modello della ciberne-
I quaderni del CREAM , 2009, IX
113
tica3. In questo contesto, il concetto di funzione assume un significato
specifico, diverso dal suo omologo strutturalista britannico. I classici
studi funzionalisti sulla religione, secondo Rappaport, analizzano il
ruolo giocato dal rituale nelle relazioni riscontrabili entro un gruppo di
individui, da lui definito congregation, che vedono dipendere il proprio benessere collettivo dall’attuazione di una serie di performances. Il
suo interesse si focalizza, invece, su “how ritual affects relationships between a congregation and entities external to it” (ibid., p. 1, corsivo
nell’originale), partendo dal presupposto che l’ambiente sia sostanzialmente il prodotto di un’insieme di variabili misurabili empiricamente.
In questo tipo di ricerca, non si vuole negare la componente simbolica
presente nella relazione tra una congregazione e il suo ambiente di riferimento (ibid., p. 2-3). Il rituale assume però rilevanza non per il senso
attribuito dagli attori alle loro performances, ma perché questo “fare sociale” produce un cambiamento nel mondo extra-sociale.
Rappaport applica all’ambiente la scissione, dominante in antropologia, tra punto di vista etico ed emico e costruisce due possibili modellizzazioni dell’ambiente, al tempo stesso antitetiche e complementari. Ritengo interessante porre a confronto le due definizioni che vengono proposte in Pigs for the Ancestors:
The operational model is that which the anthropologist constructs trough
observation and measurement of empirical entities, events, and material relationship. He takes this model to represent, for analytic purposes, the physical
world of the group he is studying (ibid., p. 237, corsivo aggiunto).
The cognized model is the model of the environment conceived by the
people who act in it. The two models are overlapping, but not identical. (...)
[T]he cognized model may include elements that cannot be shown by empirical means to exist, such as spirits and other supernatural beings. (…) [W]hile
it must be understood by those who entertain it to be a representation of the
material and non material world, has a function for the actors: it guides their
action (ibid., p. 238, corsivo aggiunto).
(….) [T]he important question concerning the cognized model, since it
serve as guide to action, is not the extent to which it conform to “reality”(…),
3
Teoria che corrisponde all’organizzazione, di natura comunicazionale, propria delle
macchine artificiali (Morin 1977, p. 236)
I quaderni del CREAM , 2009, IX
114
but the extent to which it elicits behaviour that is appropriate to the material
situation of the actors (…) (ibid., p. 239, enfasi nell’originale).
Il primo modello dovrebbe restituire la presunta oggettività del
mondo reale, attraverso resoconti che l’antropologo costruisce utilizzando i concetti mutuati dall’ecologia biologica. A partire da questo
punto di riferimento scientifico valuta il ruolo dell’“epistemologia nativa” nell’indurre comportamenti in grado di ripristinare inconsapevolmente una condizione di equilibrio ecologico. Il cognized model,
infatti, si comporterebbe come la memoria di un computer, che, in risposta a dei segnali provenienti da un stato delle variabili, attiva dei
programmi per tornare ad un range di valori di riferimento che considera idoneo per il sistema. Tale modello rappresenta, dunque, uno dei
mezzi a disposizione di una popolazione per trovare un progressivo
aggiustamento rispetto al proprio ambiente e di cui l’antropologo può
valutare l’efficacia (ibid., p. 239-241).
Rappaport riconosce non solo di non essere stato in grado di occuparsi di come cambiano i modelli nativi, ma di non aver adeguatamente affrontato nemmeno i rapporti che intercorrono tra questi e il
modello “scoperto” dall’antropologo. A suo parere nemmeno l’etnoscienza, pur centrata su un punto di vista emico, sembra in grado di
rendere conto delle nozioni folk dei processi funzionali, non andando
oltre la registrazione delle distinzioni tassonomiche. Ritiene piuttosto
che le teorizzazioni di Lévi-Strauss potrebbero forse avvicinarsi più
concretamente al raggiungimento dello scopo (ibid., p. 238, nota 4).
La prospettiva ecosistemica sarà molto criticata, soprattutto per il
suo funzionalismo riduzionista che ha portato Rappaport a “lasciar
fuori la cultura”4 dall’analisi (Milton 1996, p. 55). In seguito, sarà lui
stesso a rivedere in parte la sua prospettiva (Rappaport, 1979). Questi
sviluppi successivi, di cui Biersack offre un’utile sintesi (1999), esulano dallo scopo di questo excursus sulla sua opera il cui obiettivo è
stato piuttosto quello di mostrare come abbia contribuito a legittimare
una particolare lettura aculturale della natura in ambito antropologico.
Nonostante le differenze con l’approccio di Steward, che invece
poneva la cultura al centro delle sue riflessioni seppur in un’accezione
tecnico-materiale, entrambi concettualizzano la natura come “ambien4
“Leaving culture out”
I quaderni del CREAM , 2009, IX
115
te”, facendo propria la terminologia dell’ecologia. Come osserva Tallacchini, “ambiente” nasce proprio come “nozione avalutativa, vocabolo
tecnico che deve indicare un sapere rigoroso e neutrale sulle tematiche
ecologiche (...)” (Tallacchini 1998, p. 14). Lo spostamento semantico
dalla natura all’ambiente simbolizza pienamente l’adesione ai canoni positivisti delle scienze naturali ed esclude la possibilità di integrare prospettive teoriche più sensibili ad una dimensione interpretativa. L’estrema
specializzazione, l’approccio descrittivo, l’uso di categorie analitiche
vicine o speculari a quelle degli scienziati naturali sono stati gli elementi che hanno contribuito ad isolare l’antropologia ecologica rispetto agli
sviluppi teorici dell’antropologia sociale e culturale.
Prospettive cognitiviste: l’etnoscienza e lo strutturalismo di Lévi-Strauss
L’etnoscienza, cioé lo studio delle tassonomie native, condivide
con l’antropologia ecologica la stessa concezione di fondo del mondo
naturale. Come mostrato da Cardona, per gli etnoscienziati le diversità
presenti in natura si sono, infatti, originate “(…) fuori dalla coscienza
percettiva dell’uomo, e in qualche modo indipendenti dalla forza della
sua percezione, anche se poi di questa hanno bisogno per venire definitivamente in essere (…)” (Cardona 1985, p. 9). La differenza, pur
oggettivamente esistente nella realtà a prescindere dall’uomo, non ha,
dunque, senso finché non la si percepisca come tale. L’asse della riflessione è, dunque, centrato sugli aspetti cognitivi, ma senza rimettere
in discussione un certo modo di concettualizzare la natura che rimane
il dato di partenza oggettivo.
La scienza è il punto di riferimento imprescindibile dell’analisi tanto per l’etnoscienza quanto per l’antropologia ecologica, ma da un
punto di vista differente. L’obiettivo non è un uso diretto delle sue categorie conoscitive, ma il loro utilizzo come termini di paragone per
organizzare lo studio dei “saperi pratici” posseduti da una data comunità in modo da valutarne l’intrinseca “scientificità”. Tale bagaglio di
conoscenze deve essere verificabile attraverso l’esperienza e organizzato entro un sistema coerente, in cui le diverse specie devono essere
identificate in modo condiviso e non equivoco. Secondo l’etnoscienza,
le classificazioni del mondo naturale dei “nativi” poggiano su delle
basi oggettive e si articolano sulla base di principi costruttivi e regolaI quaderni del CREAM , 2009, IX
116
rità empiriche che giustificano l’attribuzione del termine “scienza” a
sistemi di pensiero “localizzati”, a cui viene apposto il prefisso ‘etno’
per evidenziare la contrapposizione col carattere universale del sapere
scientifico (Cardona 1985, p. 11).
La prospettiva adottata da Lévi-Strauss, in un certo senso, porta alle estreme conseguenze i presupposti teorici dell’etnoscienza, alla ricerca delle strutture profonde del pensiero che costituiscono il presupposto all’elaborazione delle “tassonomie native”. Non a caso, il riferimento agli studi di Conklin (1954), considerato tra i fondatori
dell’etnoscienza, è esplicito fin dalle prime pagine della sua famosa
opera La Pensée Sauvage (1996[1962]), in cui si loda il suo tentativo
di “dare un’idea del contatto intimo tra uomo e ambiente che l’indigeno impone costantemente all’etnologo” (ibid., p. 19). Lévi-Strauss
ne utilizzerà il ricco e accurato materiale etnografico come “materia
prima” a sostegno delle sue argomentazioni.
Secondo la sua prospettiva strutturalista, alla base di qualsiasi forma di pensiero, sia esso scientifico o “primitivo”, vi è un’essenziale
esigenza di ordine espressa nei confronti del mondo naturale che non
può essere considerata solo in funzione dell’attività pratica, poiché esprime una più profonda e vitale esigenza intellettuale (ibid., pp. 2122). Qualsiasi processo conoscitivo si fonda su questo presupposto
comune e la differenza tra lo scienziato e il “selvaggio” è individuabile solo nel grado di accuratezza che caratterizza i rispettivi percorsi
intellettuali. In un caso come nell’altro, “i rapporti dell’uomo con
l’ambiente naturale fungono da oggetti di pensiero” e in questa dimensione essenziale risiederebbe l’autentico “primato delle infrastrutture” (ibid., p. 109, corsivo aggiunto). Tale termine, di ascendenza marxista, acquista rilevanza non come precondizione materiale dell’azione
e del cambiamento sociale, ma come presupposto imprescindibile della
facoltà cognitiva dell’uomo con cui l’etnologo deve sapersi confrontare.
Solo una solida esperienza etnografica può permettere di comprendere
induttivamente, a posteriori, i principi alla base di una qualsiasi classificazione, in nessun caso postulabili a priori (ibid., p. 71).
È interessante rilevare che dagli scritti di Lévi-Strauss emerge una
significativa differenza semantica tra ‘natura’ e ‘ambiente’. Quest’ultimo termine tende ad essere utilizzato in senso “ecologico” per riferirsi a quel contesto materiale, retto da leggi biologiche, che esiste a
prescindere dall’azione umana, ma di cui l’uomo si appropria innanziI quaderni del CREAM , 2009, IX
117
tutto simbolicamente, attraverso le sue strutture concettuali. Nelle sue
argomentazioni rappresenta, dunque, il mondo fisico dell’esperienza
quotidiana dei soggetti. L’uso della categoria ‘natura’ esprime, invece,
una dimensione più astratta e al tempo stesso più essenziale. Una duplicità che emerge con chiarezza ne Le strutture elementari della parentela (1969[1949]), dove indica sia il riferimento al filosofico “stato
di natura” di chiara ascendenza rousseauiana, sia la sfera della necessità biologica che, come tale, presenta il carattere dell’universalità, contrapposta al relativismo delle norme sociali. Se il processo naturale si
distingue dal processo culturale per l’assoluta mancanza di regole e il
conseguente dominio universale dell’eredità biologica (ibid., p. 46),
l’obiettivo è allora cercare di individuare proprio l’ipotetico momento
di passaggio che ha segnato l’attraversamento del confine dalla natura
alla cultura. Lévi-Strauss lo individua nella proibizione dell’incesto,
unica regola sociale che segna l’ingresso nella cultura proprio in virtù
della sua normatività, ma il cui carattere universale testimonia la sua
appartenenza anche alla sfera della natura.
L’istituzione di vincoli di parentela, intesa come forma di regolamentazione della vita sessuale, diventa dunque sinonimo di un delicato momento transitorio in cui si qualifica l’umano nella sua specificità
emancipandolo dal puro dominio biologico, nonostante la sessualità
già di per sé rappresenti “un embrione di vita sociale all’interno della
natura” (Lévi-Strauss ibid., p. 51). Non è un caso che un ampio filone
di studi antropologici, che dichiara di occuparsi del tema della natura,
si focalizzi proprio sullo studio delle nuove forme di definizione della
parentela alla luce delle prospettive aperte dalla genetica e dalla scienza in generale, di cui si può citare, solo a titolo esemplificativo, il contributo di Strathern (1992). Questo campo d’indagine utilizza il termine ‘natura’ in un’accezione che si colloca idealmente a metà strada tra
il suo significato realistico e quello metafisico, per usare il linguaggio
di Soper (1995).
Nella prospettiva di questa influente filosofa inglese, la ‘natura’ si
presenta innanzitutto come un concetto metafisico (metaphysical concept), oggetto di speculazione filosofica. Una categoria in rapporto alla quale l’umanità pensa la sua differenza e la sua specificità, ma i cui
confini sono oggetto di continua ridefinizione, alla luce di una percezione sempre mutevole di cosa può essere specificamente attribuibile
all’uomo. In secondo luogo, è un concetto realista (realist concept)
I quaderni del CREAM , 2009, IX
118
poiché si riferisce alle strutture e ai processi causali concepiti come
leggi necessarie costantemente in azione nel mondo fisico che costituiscono l’oggetto di studio delle scienze naturali e rappresentano il
presupposto dell’intervento umano in campo biologico. Infine, ‘natura’ è anche un concetto profano o superficiale (lay or surface concept), usato nel discorso quotidiano, al di fuori di una cerchia ristretta
di specialisti, per riferirsi a delle caratteristiche del mondo ordinariamente osservabili e direttamente tangibili (Soper 1995, pp. 155-156).
È la natura oggetto di valutazione estetica o il referente di discorsi valutativi. Al tempo stesso indica la ‘materia prima’ dei processi produttivi, inquinata e sfruttata (ibid., pp. 180-181). È proprio la componente
“superficiale” della natura che viene lasciata in ombra dagli studi antropologici che si occupano di parentela.
Nel 1972, Lévi-Strauss viene chiamato a partecipare negli Stati Uniti ad una conferenza per delucidare i rapporti possibili tra strutturalismo ed ecologia (Lévi-Strauss 1984), occasione di cui approfitta per
rispondere anche alle accuse di “idealismo” e “mentalismo” spesso
mossegli dai colleghi anglosassoni. È lecito supporre che questo invito
sia stato direttamente influenzato dal particolare momento storico. In
questo stesso anno, infatti, si tiene a Stoccolma la Conferenza delle
Nazioni Unite sull’Ambiente Umano che segna la comparsa dell’ambiente nell’agenda politica internazionale in seguito all’imporsi delle
prime crisi ecologiche. La prospettiva cognitivista di Lévi-Strauss appariva forse difficilmente conciliabile con la nuova attenzione verso
certe problematiche.
Nel corso del suo intervento, infatti, si può cogliere tra le righe la
volontà di evidenziare l’importanza che l’ambiente, inteso in senso
ecologico, ha nella sua riflessione, rappresentando un preludio essenziale alla comprensione delle strutture inconsce che ordinano il reale.
Ribadisce fermamente che l’accesso alla struttura non può che avvenire attraverso l’analisi empirica di quegli elementi del mondo naturale
che in un dato contesto sociale sono stati eletti a “tratti distintivi”, oggetto di una particolare concettualizzazione. L’applicazione di un metodo induttivo allo specifico caso etnografico permette infatti di valutare la forma peculiare localmente assunta dall’insieme significativo di
due tipologie di determinismi che vincolano la vita sociale a livello
intrinseco ed estrinseco. Il primo è rappresentato dalle leggi che governano le operazioni mentali attraverso cui si esprime il pensiero, il
I quaderni del CREAM , 2009, IX
119
secondo dalle costrizioni prodotte dagli orientamenti storici e dalle
proprietà dell’ambiente (Lévi-Strauss 1984, pp. 131-132, p. 139).
Data l’importanza attribuita al mondo fisico, anche se nel suo caso
risulta strumentale ad un altro livello di riflessione, ritiene importante
puntualizzare alcuni aspetti problematici legati al tema della percezione. Secondo Lévi-Strauss, i dati immediati prodotti dall’esperienza
consistono fin dall’inizio in proprietà distintive astratte dal reale ed è
quindi solo a livello emico che le operazioni sensibili e le funzioni intellettuali della mente si fondono per esprimere un comune adeguamento al mondo materiale. Il problema non è solo costruire una teoria
adeguata della percezione, ma anche riconoscere l’intrinseca strutturalità della materia e di vedere in questa caratteristica il punto di connessione tra uomo e ambiente. Il corpo stesso rappresenta un ambiente
organico, presupposto necessario per la percezione dell’ambiente fisico entro cui si trova inserito:
(…) Occorre dunque che tra i dati sensibili e la loro codificazione cerebrale, che sono i tramiti di questa percezione, e il mondo fisico stesso, esista
una certa affinità.
(….) Lungi dal vedere nella struttura un puro prodotto dell’attività mentale, si riconoscerà che gli organi di senso posseggono un’attività strutturale e
tutto quanto esiste fuori di noi, gli atomi, le molecole, le cellule, gli stessi organismi mostra caratteri analoghi. Poiché queste strutture, esterne le une, le
altre interne, non si lasciano attingere al livello étique, ne risulta che l’ordine
delle cose è di ordine émique e non étique; dovremo quindi aggredirlo sotto il
primo aspetto. (Lévi-Strauss 1984, pp. 139-142, corsivo aggiunto)
La realtà étique, dunque, non esiste in nessun luogo e vano è il tentativo di scindere due ordini di realtà che non possono essere pensati
in forma disgiunta, come hanno tentato di fare i sostenitori di un “materialismo volgare” e di un “empirismo sensualista”, come lui stesso li
definisce (ibid., p. 143).
Nell’antropologia di Lévi-Strauss, “l’ambiente” rappresenta la materia prima del pensiero simbolico, così come “la natura” definisce
l’antitesi filosofica dell’umano. In entrambe le accezioni, la tensione è
verso il polo della cultura e l’importanza della natura così come
dell’ambiente si giustifica solo come punto di partenza attraverso il
quale trascendere ad un altro livello dell’analisi o come elemento di
contrappunto nella ricerca di ciò che è essenzialmente umano. SeconI quaderni del CREAM , 2009, IX
120
do Descola (1996, p. 84), Lévi-Strauss, nel contributo del ’72, ha cercato di ricomporre il dualismo natura-cultura, ma lo ha fatto utilizzando una concezione naturalistica del lavoro della mente, interpretata
come “filtro” atto alla decodifica di set di contrasti già presenti in natura e a lei strutturalmente simili. Una prospettiva esplicitamente ravvisabile nella parte conclusiva della sua argomentazione:
Solo una stretta collaborazione tra le scienze umane e le scienze naturali
permetterà di ricusare un dualismo metafisico ormai obsoleto. Invece di opporre l’ideale al reale, l’astratto al concreto, l’émique all’étique, si riconoscerà che i dati immediati della coscienza, irriducibili ad uno qualsiasi di questi
termini, si situano a mezza strada, già codificati dagli organi dei sensi e dal
cervello, a somiglianza di un testo, che, come ogni testo, dev’essere decodificato perché lo si possa tradurre nel linguaggio di altri testi (Lévi-Strauss
1984, p. 143, corsivo aggiunto)
La res extensa trova così un punto di contatto con la res cogitans
nelle proprietà strutturali che li accomunano. La natura rivela, infatti,
quello stesso ordine binario che organizza l’attività sensoriale e mentale dell’uomo. La “segreta armonia” tra “l’esplorazione dei sensi” e
“il mondo in cui essa è comparsa”, messa in luce dallo studio antropologico di sistemi conoscitivi non scientifici, può tradursi, conclude
Lévi-Strauss, in una forma più consapevole di rispetto verso la natura,
che, con i suoi vegetali e animali, rappresenta per l’umanità “la fonte
delle emozioni estetiche più intense e (...) delle sue prime e già profonde speculazioni” (ibid., pp. 144-145). Il suo tentativo di risolvere la
dicotomia non modifica, però, in maniera sostanziale la concezione
dei termini che la compongono. Tende piuttosto a spostare la questione sul piano della percezione, ponendo le basi per un avvicinamento
alle neuroscienze.
È interessante rilevare la differenza semantica tra l’uso del termine
natura rilevabile ne Le Strutture Elementari della Parentela e quello
che emerge nell’argomentazione presentata in Strutturalismo ed Ecologia. Nel primo caso, la ‘natura’ si configura come puro regno della
necessità biologica opposta alla normatività sociale propria della cultura umana, in un’accezione che rimanda al concetto “realista” proposto da Soper, ma con valenze “metafisiche”. Nel secondo, invece, la
natura, rievocata nella sua componente “superficiale o profana”, come
oggetto delle attività speculative e dell’apprezzamento estetico, coinI quaderni del CREAM , 2009, IX
121
cide col concetto di “ambiente” di pertinenza dell’ecologia e dunque
dell’antropologia ecologica. Lévi-Strauss riconosce implicitamente
l’esistenza di una realtà esterna e oggettiva che, però, esula dagli scopi
della sua riflessione.
La scissione tra strutturalismo ed ecoantropologia riproduce in ambito antropologico la macrodivisione tra scienze umane e naturali,
senza rimettere in discussione il paradigma positivistico che le presuppone. La natura, in quanto “materia pura”, può solo essere oggetto
dell’antropologia ecologica, mentre rimane il sostrato fondamentale, ma
non problematizzato, delle classificazioni e delle simbolizzazioni prodotte dalla cultura. Il polo materialista della dicotomia natura-cultura
sottolinea la centralità del comportamento umano come strumento di
una sorta di inconsapevole razionalità ecologica che mira al mantenimento dell’equilibrio ecosistemico, nonostante gli attori, attraverso il
rituale, siano semplicemente convinti di rinsaldare i rapporti con gli
spiriti dei propri antenati, come nel caso riportato da Rappaport. Il polo idealista focalizza, invece, la sua attenzione sul linguaggio, unica
chiave di accesso al pensiero, nel tentativo di esplicitare le categorizzazioni native del mondo naturale.
Antropologia ecologica e antropologia strutturalista, pur essendosi
ritagliate uno spazio d’analisi specifico alle due estremità della dicotomia, hanno però congiuntamente contribuito ad offrire un’immagine
reificata del mondo naturale, priva di consistenza storica e scevra di
implicazioni politiche. Una “dimenticanza” ancora più macroscopica,
se pensata in rapporto alla nascita della “questione ecologica”, ai primi
clamorosi disastri ambientali e alle conseguenti rivendicazioni dei movimenti ambientalisti (Pellizzoni 2001). L’antropologia, tra le varie
scienze sociali, è stata quella che si è dimostrata più restia ad aprirsi
agli stimoli provenienti da questo mutato panorama storico, lasciando
certe problematiche appannaggio dei dibatti dei filosofi, dei politologi
o dei sociologi (Milton 1993).
I due approcci, inoltre, pur nella loro distanza, hanno condiviso anche un altro importante aspetto che ha caratterizzato per lungo tempo
l’antropologia, fino alla presa di posizione critica delle correnti postmoderne e decostruzioniste. Il ruolo dell’attore, la sua soggettività,
la capacità d’azione (agency) sono componenti necessariamente irrilevanti in un tipo di analisi che pensa l’uomo in relazione all’assoluta
preminenza delle costrizioni biologiche o che si pone alla ricerca una
I quaderni del CREAM , 2009, IX
122
di “grammatica universale della cultura”. In entrambi i casi, infatti,
l’obiettivo analitico è proprio trascendere le singole individualità per
costruire modelli teorici generalizzanti.
La svolta epistemologica monista
Nel corso degli anni '80, l’antropologia ecologica ha conosciuto un
inesorabile declino, oscurata dalle possibilità aperte dalla critica postmoderna (Descola, Pálsson 1996, p. 1). La riflessione sulla pratica
etnografica, il decostruttivismo, la centralità del discorso e del potere
come categorie analitiche, nonché la visione “testualista” della cultura
e, non ultima, una prospettiva decisamente actor-oriented nella spiegazione delle dinamiche sociali avevano decisamente spostato l’asse
del discorso antropologico sulla dimensione linguistica e interpretativa
della cultura, da cui la natura realista - nell’accezione di Soper (1995)
- caratteristica dell’antropologia ecologica non poteva che rimanere
inevitabilmente esclusa. L’attenzione si stava focalizzando sulla natura come prodotto socio-culturale storicamente determinato, dando così un impulso essenziale alla decostruzione della dicotomica impostazione cartesiana.
Come osservato da Soper (1995), la teoria culturale postmodernista
ha invitato a diffidare di qualsiasi posizione intellettuale che cerchi di
dare consistenza universale a ciò che in realtà è meramente convenzionale, come ad esempio l’idea stessa di ‘natura’. Emblematico, a riguardo, il contributo di Marilyn Strathern che, in una famosa pubblicazione del 1980, discute l’ambiguità di fondo espressa dalla categoria
“natura”, tanto sinonimo di “ambiente” per gli studi ecologici quanto
di “natura umana” per la letteratura femminista, centrata sulla relazione tra i sessi come espressione di una lotta per il potere (1980, pp.
179-180). In questo secondo caso, in particolare, l’associazione tra artefatti culturali e creatività maschile rappresenterebbe il processo attraverso il quale si è cercato di relegare la donna ad espressione di una
presunta “naturalità” ed istintività, deprivandola della sua identità sociale. Le difficoltà, però, non si esauriscono nell’eterogeneità delle interpretazioni del concetto di “natura”, ma, secondo Strathern, riguardano la dicotomia natura-cultura nel suo complesso ed emergono con
I quaderni del CREAM , 2009, IX
123
chiarezza una volta che si tenti di applicarla a contesti diversi da quello occidentale:
The point to extract is simple: there is not such thing as nature or culture.
Each is highly relativized concept whose ultimate signification must be derived from its place within a specific metaphysics. No single meaning can in
fact be given to nature or culture in western thought; there is no consistent
dichotomy, only a matrix of contrasts (…). The question then becomes how
large part of the total assemblage of meanings must we be able to identify in
other cultures to speak with confidence of their having such notions (Strathern 1980, p. 177, enfasi nell’originale).
In questa prospettiva, ‘Natura’ e ‘Cultura’ non esprimono dunque
nessuna realtà essenziale, ma rappresentano dei concetti comprensibili
solo entro lo specifico ambito di utilizzo.
La riflessione postmoderna, radicalizzando una visione decostruzionista della realtà sociale, è stata duramente criticata per gli esiti
problematici a cui avrebbe condotto una piena applicazione delle sue
teorie nel campo degli studi antropologici sul mondo naturale. Secondo Milton, l’adesione ad un’idea di “ambiente” esclusivamente come
costruzione dei processi cognitivi e del linguaggio sarebbe inconciliabile con il programma disciplinare dell’antropologia ecologica, che
presuppone un concetto “realista” di natura (Milton 1996, p. 22). Precluderebbe, inoltre, anche la possibilità di ritagliare un ruolo per l’antropologo nel quadro dell’attivismo ambientalista (ibid., p. 53).
Una posizione condivisa da Descola e Pálsson, secondo cui il rischio insito in un approccio radicalmente interpretativo e simbolico
consisterebbe nel veicolare un’immagine statica e passiva dell’ambiente naturale, mettendone in discussione la sua stessa esistenza, poiché “[f]or modern textualists, however, the environment is not only
simply a script in a metaphoric sense: beyond cultural interpretation
there is only triviality, if not empty space” (1996, p. 11).
Da un punto di vista filosofico, Latour (1995, 2000) ha sottolineato
quanto sia stata artificiosa la completa negazione di una componente
extra-discorsiva della natura. L’eccessiva concentrazione sul linguaggio
avrebbe portato ad un’autonomizzazione del discorso (ibid., p. 79) tale
da emanciparlo da qualsiasi contatto critico con la dimensione sensibile:
I quaderni del CREAM , 2009, IX
124
Che le si chiamino «semiotica», «semiologia» o «svolta linguistica», tutte queste filosofie hanno l’obiettivo di rendere il discorso non un intermediario trasparente che metterebbe il soggetto in contatto col mondo naturale, ma
un mediatore indipendente tanto della natura quanto della società. (…) La
grande debolezza di queste filosofie è stata quella di rendere più difficili i
collegamenti tra un discorso reso autonomo e la natura o il soggetto/società
ch’esse lasciavano intatti (…) (ibid., pp. 78-80).
Secondo Latour, è necessario problematizzare, su un piano prettamente filosofico, quella rigida opposizione tra multiculturalismo e mononaturalismo su cui si è fondato il sapere antropologico. Concentrandosi sullo studio della molteplicità e della differenza culturale, l’antropologia avrebbe sostanzialmente accettato l’idea di una natura – pensata
come universale e oggettiva – conoscibile solo attraverso le “scienze
dure” (Latour 2000, p. 29). “Natura e società”, invece, suggerisce Latour, non dovrebbero più essere considerati come “i termini esplicativi,
ma ciò che richiede una spiegazione congiunta” (1995, p. 100, corsivo
aggiunto). L’antropologia, nella sua specificità disciplinare, dovrebbe
inoltre ricordare che “(...) il concetto stesso di cultura è un prodotto artificiale, creato da noi mettendo la natura tra parentesi. Ora, non ci sono culture (diverse e universali) più di quanto non ci sia una natura universale. Ci sono solo nature-culture e sono loro che offrono l’unica base
di confronto possibile” (ibid., p. 127, enfasi nell’originale).
Ritengo che la prospettiva delle “nature-culture” proposta da Latour non rappresenti semplicemente un evocativo gioco linguistico, ma
possa essere considerata la premessa epistemologica essenziale per ripensare il significato della natura in ambito antropologico. Non più
dunque una materia inerte e scissa dalla cultura, né un puro concetto
facente parte di un mondo delle idee di platonica ascendenza, ma la
sintesi sempre mutevole di entrambe le dimensioni che si produce in
contesti diversi a partire dal quotidiano “lavoro” pragmatico e speculativo dei soggetti.
Nel prossimo paragrafo vedremo come la specificità dell’ecologia
politica post-strutturalista risieda proprio nel tentativo di integrare
una simile epistemologia monista entro una rete storicizzata di relazioni di potere.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
125
Natura, potere, discorso: l’ecologia politica post-strutturalista
Il termine “ecologia politica” appare per la prima volta nel titolo di
un libro del 1967, anno in cui Bruce Russett pubblica International
Regions and the International Systems: A Study in Political Ecology.
L’uso della parola “ecologia” rappresenta, però in questo caso, più una
metafora dell’interconnessione delle relazioni politiche che un vero e
proprio interesse sui cambiamenti o la conservazione dell’ambiente
biofisico (Forsyth 2003, p. 3). Secondo una tradizione ormai consolidata e condivisa, è stato invece Eric Wolf ad usare per primo, nel
1972, questa nuova categoria nella particolare accezione che intendo
porre in evidenza in questo contesto (Biersack 2006; Scoones 1999;
Garland, Márquez 2000; Peet, Watts 1996a).
È bene precisare, infatti, che ‘ecologia politica’ è stata un’“etichetta” utilizzata in maniera piuttosto eterogenea soprattutto in relazione al
significato attribuito al termine ‘ecologia’. Secondo la ricostruzione offerta dallo stesso Forsyth (2003), si varia dall’‘ecologia’ come scienza
all’‘ecologia’ come generico riferimento alla componente ambientale
in un tipo di analisi più interessata alla dimensione più strettamente
politico-sociale. ‘Ecologia politica’ è stata anche un’espressione utilizzata per indicare l’attivismo politico di matrice ambientalista e le
relative correnti di pensiero che ne hanno guidato l’azione (Giddens,
Touraine, Offe 1987; Moscovici 2005), generando spesso una certa
confusione terminologica.
L’ecologia politica a cui faccio riferimento, invece, si configura
come un indirizzo di studi nato con l’obiettivo di criticare la prospettiva ecosistemica dell’antropologia ecologica. Sin dai suoi esordi, alla
fine degli anni ‘70, si è distinta più che per una teoria coerente, per la
definizione di aree di inchiesta simili, come lo studio del cambiamento
ambientale e la questione dell’accesso alle risorse (Peet, Watts 1996a,
pp. 4-6; Greenberg, Park 1994). Considerata inizialmente come una
‘teoria neo-marxista del sistema mondo’ focalizzata sulle problematiche ecologiche, si è poi progressivamente trasformata in un insieme di
orientamenti teorici riconducibili a ‘frameworks post-marxisti’ (Biersack 2006, p. 4):
While early political ecologists sought to demonstrate impacts of marginalization, land tenure, or production pressure on environmental changes such
I quaderni del CREAM , 2009, IX
126
as soil erosion and deforestation, they often failed to explore how the environment is negotiated and affected in arenas such as the household, the
workplace, the community, the state. Current research continues to seek better methods to learn about and from participants in these arenas and also to
investigate the workings of knowledge, discourse, and practice in social
movements, urban landscapes, institutions like the World Bank, national and
global governance, and other spaces. (...) A second significant challenge is to
design studies that allow us to see – and analyze – relations of difference and
power within and among these myriad locales. (...) (Paulson, Gezon, Watts
2003, p. 210, corsivo aggiunto).
La “svolta post-strutturalista” dell’ecologia politica ha portato ad
assimilare l’idea di conoscenza non come rappresentazione, ma come
contenuto che si costruisce attraverso la conversazione e la pratica sociale. La realtà non viene considerata come un fatto oggettivo, che esiste indipendentemente dagli esseri umani, ma l’effetto del linguaggio
inteso come discorso. Se il processo di significazione costruisce la realtà piuttosto che rifletterla, il risultato non sarà neutrale, ma il prodotto degli imprescindibili rapporti di potere che la caratterizzano (Biersack 2006, p. 13). Di conseguenza, si assume l’idea che il potere abbia
una duplice connotazione. Da una parte, rappresenta una relazione sociale costruita sulla distribuzione asimmetrica di rischi e risorse che
invita a focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui circola tra gruppi sociali e spazi diversi (Paulson, Gezon, Watts 2003, p. 209). Dall’altra, viene considerato non solo come una forma di pressione sistemica esercitata dall’esterno e a cui il soggetto si oppone ma anche, in
un senso ancor più spiccatamente foucaultiano, come la condizione
stessa dell’esistenza, costitutivamente presente in qualsiasi relazione
intersoggettiva (ibid., p. 209).
Il riferimento alla “politica” che caratterizza questo indirizzo disciplinare rimanda, quindi, all’insieme delle pratiche e dei processi attraverso cui il potere, inteso nelle sue svariate forme di possibile espressione, è gestito e negoziato (Paulson, Gezon, Watts 2003, p. 209).
Secondo Tsing, il punto fondamentale è chiedersi “[w]hat counts as
“the environment” in any given political negotiation, corporate strategy, research initiative, livelihood trajectory, or policy program? How
are new “environments” created within these projects?” (Tsing 2001,
p. 4). Si possono, infatti, riscontrare definizioni conflittuali di “ambiente” a diversi ordini di analisi attraverso una ricerca etnografica
I quaderni del CREAM , 2009, IX
127
multiscala (Paulson, Gezon, Watts 2003, p. 211). Focalizzando l’attenzione sulla dimensione “domestica”, emergono le dinamiche sottese alla definizione dei diritti di proprietà e alle modalità di organizzazione del lavoro che contribuiscono a delineare micropolitiche di accesso e controllo delle risorse. Questo tipo di esperienza localizzata,
ma non per questo omogenea e statica, può essere proficuamente messa in rapporto con l’azione di altre tipologie di agenti che si muovono
nel medesimo contesto ma su un altro livello politico (Peet, Watt
1996a, p. 10):
Secondo Tsing, l’interrelazione dialettica tra diversi ordini d’indagine permette di comprendere “(...) how nature becomes an actor in
social history” (Tsing 2001, p. 4, corsivo aggiunto). In altre parole, si
potrebbe dire che il processo di interazione tra differenti appropriazioni semantiche della natura “agisce” nella vita sociale, contribuendo
a favorire certi “mondi di vita” a discapito di altri. Tsing, in realtà,
sembra usare l’idea di natura come “attore” non tanto in questa accezione, quanto in quella decisamente più “materialista” proposta dagli studiosi di storia ambientale. Questi ultimi hanno cominciato ad attribuire
il concetto di agency alla natura, nonostante presupponga l’idea di un
agire consapevole, proprio per sottolineare la reciproca azione trasformativa dell’uomo sugli elementi naturali e viceversa, la cui portata si
modifica costantemente a seconda dell’epoca storica. La storia dei progetti di irrigazione, per esempio, mostrerebbe come l’acqua si sia costituita come un vero e proprio “agente storico” nella definizione di peculiari dinamiche sociali (ibid., p. 5). Secondo quanto precisato da Tsing,
“[t]he nature of nature’s agency shifts depending on the historically
specific form of human and non-human interaction that makes up what I
am calling an environmental project” (ibid., p. 5, corsivo aggiunto).
Il concetto di progetto ambientale non è privo di interesse. Innanzitutto, il termine “progetto” rimanda a un insieme di idee e pratiche che
assumono una stabilità per lo meno relativa e si concretizzano attraverso l’azione sociale, che si esprime in forme mutevoli, che vanno
dal consolidarsi di particolari convenzioni culturali all’implementazione di specifici interventi governativi. Tsing lo intende come “an institutionalized discourse with social and material effects”. Fa dunque
riferimento anche ad una progettualità intesa in senso lato, come
costruzione collettiva che si esplica nell’agire quotidiano: “[e]ach environmental project propel us into a transformed natural and social
I quaderni del CREAM , 2009, IX
128
world through the way it combines environmentally significant ideas,
policies, and practices” (ibid., p. 4). Se l’attore governativo, quindi,
agisce sulla base di un progetto ambientale per molti aspetti esplicito,
questo si confronta necessariamente con la progettualità localizzata e
spesso implicita che caratterizza i suoi interlocutori locali.
L’ecologia politica marxista propendeva nettamente per la “polarità materiale” della dicotomia. L’ecologia politica di seconda generazione (Biersack 2006), invece, ha posto in risalto il ruolo analitico attributo alla dimensione discorsiva, pur senza cancellare l’importanza
tradizionalmente attribuita all’aspetto strutturale. Ha tentato, piuttosto,
di inglobarlo in una materialist-discursive analysis in cui si articolino
congiuntamente le componenti simboliche e concrete (Peet, Watts
1996b, p. 262).
Secondo Biersack, termini come “seconda natura”, “natura sociale”, “natura umanizzata” permettono di identificare un oggetto d’indagine distinto rispetto alla natura studiata dalle “scienze dure”. Tali espressioni possono, infatti, essere reinterpretate nei termini di una
forma di significazione della natura come prodotto dell’inscindibile
commistione di attività e discorso. Se la “seconda natura” di Marx ed
Engels, come poi la “natura umanizzata” di Godelier (1985), erano
concetti che sottolineavano la sola azione trasformativa dell’uomo
sull’ambiente, nella definizione di Biersack emerge invece un’interpretazione che lei stessa definisce “più ampia”:
Here I use the term second nature to mean something broader than Marx
and Engels meant: a nature that is humanly produced (through conceptualization as well as activity) and that therefore partakes, but without being entirely, of the human (Biersack 2006, p. 14, enfasi nell’originale).
Although second nature is “after nature”, it does not supersede nature,
but, rather, constitutes the interface between (first) nature, on the one hand,
and culture, power, and history, on the other (ibid., enfasi nell’originale).
La “prima natura” sarebbe dunque la natura di pertinenza delle
scienze “dure”, in un’accezione sostanzialmente identica al concetto
“realista” proposto da Soper (1995). Il concetto di “seconda natura”
permetterebbe, invece, di inglobare nell’analisi componenti, come il potere, il discorso e la storia, trascurate dall’antropologia ecologica. La distanza epistemologica che intercorre tra la “prima” e la “seconda natura”
I quaderni del CREAM , 2009, IX
129
segna il passaggio da un’idea gerarchica del rapporto tra natura e cultura
- sia nel caso in cui si sostenga che la natura dia forma alla cultura, sia, al
contrario, che la cultura imponga un significato sulla natura (Descola,
Pálsson 1996, p. 3) - , ad una prospettiva pienamente ibrida sulla natura,
considerata come il prodotto sempre mutevole dell’intersezione tra dimensione materiale, pratiche ed interpretazione (Escobar 1999).
Conclusioni
Nella prima parte dell’articolo, si è sottolineato come l’antropologia ecologica di Rappaport e lo strutturalismo di Lévi-Strauss abbiano condiviso una medesima concezione della natura, considerata
come un oggetto neutro e non problematico. Rappaport ha posto la
natura/ambiente al centro delle sue teorizzazioni, ma a partire dall’imprescindibile riconoscimento dell’indiscussa priorità gerarchica delle
“scienze dure”, i cui saperi confluivano nei “modelli operazionali”
dell’antropologo. Lévi-Strauss ha visto nella natura/ambiente “solo” la
materia prima infrastrutturale oggetto delle elaborazioni proprie delle
strutture inconsce che aveva postulato, vero fulcro dei suoi interessi.
Antropologia ecologica e antropologia cognitiva, pur essendosi ritagliate uno spazio d’analisi specifico alle due estremità della dicotomia
cartesiana, hanno congiuntamente contribuito ad offrire un’immagine
reificata del mondo naturale, priva di consistenza storica e scevra di
implicazioni politiche.
Nella seconda parte, invece, si è tentato di mostrare come l’ecologia politica post-strutturalista offra attualmente il frame teorico più
originale, oltre che più aperto e flessibile, entro cui tentare di articolare percorsi sperimentali di ricerca etnografica sul mondo naturale su
basi moniste. Superando la visione strettamente marxista dell’ecologia
politica di prima generazione (Biersack, Greenberg 2006), ha promosso una sintesi proficua tra la concezione foucaultiana della politica e
del potere e l’attenzione rivolta congiuntamente alla dimensione simbolica e materiale. Sottolineando l’intrinseca politicità della natura,
negoziata e contesa in contesti segnati da differenti asimmetrie di potere, ha così valorizzato un approccio multidimensionale in grado di
dialogare con l’ecologia scientifica senza assimilarne in toto il modello teorico.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
130
Bibliografia
Barbault R. 2000, Écologie, environnement et société, M. Abélès, L. Charles, H.P. Jeudey, B. Kalaora (a cura di), L’environnement en perspective. Contextes
et représentation de l’environnement, l’Harmattan, Paris, pp. 149-173.
Biersack A. 1999, Introduction: From the "New Ecology" to the New Ecologies,
American Anthropology, vol. 101, n. 1, pp.15-18.
Biersack A. 2006, Reimagining Political Ecology: Culture/ Power/ History/ Nature, A. Biersack, J. B. Greenberg (a cura di), Reimagining Political Ecology,
Duke University Press, Durham & London, pp. 3-40.
Biersack A., Greenberg J. B. (a cura di), 2006, Reimagining Political Ecology,
Duke University Press, Durham & London.
Cardona G. R. 1985, La foresta di piume. Manuale di etnoscienza, Biblioteca Universale Laterza, Roma, Bari.
Conklin H. C. 1954, The relation of Hanunóo culture to the plant world, PH Dissertation, Yale University.
Descola P. 1996, Constructing natures. Symbolic ecology and social practice, P.
Descola, G. Pálsson (a cura di), Nature and Society, Anthropological perspectives, Routledge, London, New York, pp. 82-102.
Descola P., Pálsson G. 1996, Introduction, P. Descola, G. Pálsson (a cura di), Nature and Society, Anthropological perspectives, Routledge, London, New
York, pp. 1-21.
Escobar A. 1999, After Nature. Steps to an Antiessentialist Political Ecology,
Current Anthropology, vol. 40, n. 1: 1-30.
Escobar A., Hvalkof S. 1998, Nature, Political Ecology, and Social Practice:
Toward an Academic and Political Agenda, A. Goodman, T. L. Leatherman
(a cura di), Building a New Biocultural Synthesis. Political-Economic Perspectives on Human Biology, University of Michigan Press, Ann Arbor, pp.
425-450.
Forsyth T. 2003, Critical Political Ecology. The Politics of Environmental Science, Routledge, London, New York.
Garland E. B., Márquez S. M. 2000, De la economía política a la ecología
política: Balance global del ecomarxismo y la crítica al desarrollo, A. Viola (a
cura di), Antropología del desarrollo. Teoría y Estudios Etnográficos en
América Latina, Paidós, Barcelona - Buenos Aires – México, pp. 125-167.
Giddens A., Touraine A., Offe C. 1987 (a cura di), Ecologia Politica , Feltrinelli,
Milano.
Godelier M., 1985, L’ideale e il materiale. Pensiero, economie, società, Editori
Riuniti, Roma; ed. or. 1984, L’idéal et le Matériel. Pensée, économies, sociétés, Libraire Arthèm Fayard, Paris.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
131
Greenberg J. B., Park T. 1994, Political Ecology, Journal of Political Ecology,
vol. 1, pp. 1-12.
Ingold T. 1992, Culture and the perception of the environment, E. Croll, D.
Parkin (a cura di), Bush Base, Forest Farm: Cultures, Environment and Development, Routledge, London, New York, pp. 39-56,
Ingold T. 2000, The perception of the environment, Routledge, London, New
York.
Lanternari V. 2003, Ecoantropologia. Dall’ingerenza ecologica alla svolta eticoculturale, Edizioni Dedalo, Bari.
Latour B. 1995, Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica, Eleuthera, Milano; ed. or. 1991, Nous n’avons jamais été modernes, Édition La Découvert, Paris.
Latour B. 2000, Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze, Raffaello Cortina Editore, Milano; ed. or. 1999, Politiques de la nature, Édition La
Découvert & Syron, Paris.
Lévi-Strauss C. 1969, Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano;
ed. or. 1949, Les structures élémentaires de parenté, PUF, Paris.
Lévi-Strauss C. 1984, Strutturalismo ed Ecologia, Lo sguardo da lontano, Einaudi, Torino; ed. or. 1983, Le regard éloigné, Plon, Paris.
Lévi-Strauss C. 1996, Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano; ed. or. 1962,
La Pensée Sauvage, Plon, Paris.
Merleau-Ponty M. 1996, La natura: lezioni al College de France 1956-1960,
Raffaello Cortina Editore, Milano; ed. or. 1995, La nature. Notes de cours du
Collège de France, textes établis et annotés par Dominique Séglard, Éditions
du Seuil, Paris, collection «Traces écrites».
Milton K. 1993, Environmentalism and Anthropology, K. Milton (a cura di), Environmentalism. The View from Anthropology, Routledge, London New
York, pp. 1-17.
Milton K. 1996, Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the Role of
Anthropology in Environmental Discourse, Routledge, London, New York.
Morin E. 1977, La Méthode. I. La Nature de la Nature, Le Seuil, Paris; trad. it.,
2001, Il metodo. La natura della natura, Raffaello Cortina, Milano.
Moscovici S. 2005, Sulla natura. Pensare l’ecologia, il Saggiatore, Milano; ed.
or. 2002, De la nature. Pour penser l’écologie, Métailié, Paris.
Orlove B. 1980, Ecological Anthropology, Annual Review of Anthropology, vol.
9, pp. 235-273.
Ortner S. 1984, Theory in Anthropology since the Sixties, Comparative Studies
in Societies and History, vol. 26, n. 1, pp. 126-166.
Paulson S., Gezon L. L., Watts M. 2003, Locating the Political in Political Ecology: An Introduction, Human Organization, vol. 62, n. 3, pp. 205-217.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
132
Pellizzoni L. 2001, Il rischio ambientale nella società contemporanea, B. De
Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro (a cura di), Il rischio ambientale, Il Mulino,
Bologna, pp. 11-36.
Peet R., Watts M., 1996a, Liberation Ecology. Development, sustainability, and
environment in the age of market triumphalism, R. Peet, M. Watts (a cura di),
Liberation Ecologies. Environment, Development, Social Movements, Routledge, London, New York, pp. 1-45.
Peet R., Watts M., 1996b, Conclusion. Towards a theory of liberation ecology, R.
Peet, M. Watts (a cura di), Liberation Ecologies. Environment, Development,
Social Movements, Routledge, London, New York, pp. 260-269.
Rappaport R. 1979, Ecology, Meaning and Religion, North Atlantic Books,
Richmond, CA.
Rappaport R. 2000[1968], Pigs for the ancestors : ritual in the ecology of a New
Guinea people, 2nd ed., Long Grove, Illinois: Waveland Pr. Inc; trad. it. 1979,
Maiali per gli antenati. Il rituale nell'ecologia di un popolo della Nuova Guinea, Franco Angeli, Milano
Russett B. 1967, International Regions and the International Systems: A Study in
Political Ecology, Rand McNally, Chicago, IL.
Sahlins M. 1982, Cultura e Utilità, Bompiani, Milano; ed. or. 1976, Culture and
practical reason, University of Chicago Press, Chicago.
Scoones I. 1999, New Ecology and the Social Sciences: What Prospects for a
Fruitful Engagement?, Annual Review of Anthropology, vol. 28, pp. 479-507.
Soper K. 1995, What is nature? Culture, Politics and the Non-Human, Blackwell, Oxford & Cambridge.
Steward J. 1977, Teoria del mutamento culturale: la Metodologia dell'Evoluzione
Multilineare, Bollati Boringhieri, Torino; ed. or. 1955, Theory of Culture
Change: the Methodology, University of Illinois press, Urbana [etc.].
Strathern M. 1980, No Nature, No Culture: the Hagen Case, C. Mac Cormack,
M. Strathern (a cura di), Nature, Culture and Gender, Cambridge University
Press, Cambridge, pp. 174-222.
Strathern M., 1992, After nature: English kinship in the late twentieth century,
Cambridge University Press, Cambridge.
Tallacchini M. 1998, Introduzione. Una scienza per la natura, una filosofia per
la terra, M. Tallacchini (a cura di), Etiche della terra. Antologia di filosofia
dell’ambiente, Vita e Pensiero, Milano, pp. 1-57.
Tsing A. L. 2001, Nature in the Making, C. L. Crumley (a cura di), New Directions in Anthropology and Environment, Altamira Press, Walnut Creek, CA;
Lanham, Maryland; Oxford England, A Division of Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., pp. 3-23.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
133
Vayda A. P., 2000 [1968], Foreword, Rappaport, 2000, Pigs for the ancestors : ritual in the ecology of a New Guinea people, 2nd ed., Waveland Pr.
Inc., Long Grove, Illinois.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
134
MATTEO CANEVARI1
FIGURE DELL’IBRIDAZIONE E FIGURE DEL NULLA.
GEORGES BATAILLE TRA ETNOGRAFIA E NICHILISMO
I Versi satanici cantano l’ibrido,
l’impuro, l’eterogeneità,
le trasformazioni nate da combinazioni
nuove e inattese tra gli esseri umani,
le culture, le idee, la politica, i film, le canzoni.
Questo libro celebra la commistione
e teme l’assolutismo della purezza.
L’ibrido, il guazzabuglio,
un po’ di questo, un po’ di quello,
ecco come il nuovo viene al mondo.
Questa è la grande occasione
offerta al mondo dalla migrazione di massa
e io mi sono sforzato di coglierla.
Salman Rushdie
Brividi ibridi
“Non ci si addentra impunemente nell’alterità: il viaggio e la sosta
nei vari angoli del mondo esplorati dall’antropologia provocano uno
spaesamento, uno sradicamento i cui effetti si manifestano nel proporsi l’antropologia non solo come uno sguardo della modernità sull’alterità, ma anche come uno sguardo che, formandosi attraverso
l’alterità, coinvolge da ultimo la stessa cultura della modernità”2: Il
contatto culturale produce, da una parte e dall’altra, la formazione di
1
Matteo Canevari si è laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Pavia; ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università di Ginevra.
Docente di Filosofia e Storia presso i licei, è autore di una monografia su Georges
Bataille dal titolo La religiosità feroce – Studio sulla filosofia eterologica di Georges
Bataille e di una introduzione a Nietzsche dal titolo Leggere la Genealogia della
morale di Nietzsche.
2
Remotti 1998, p. 69.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
135
figure di confine, nate sullo sradicamento, che sono la realizzazione
dell’incontro, del conflitto e della compenetrazione, e possono costituire il ponte per la comprensione del rapporto tra le differenze perché
hanno messo in questione la loro appartenenza culturale. Si tratta degli
ibridi. Figure del vacillamento dell’identità, essi aprono il discorso a
una logica differente rispetto all’opposizione io-tu che rischia sempre
di risolversi negli estremi di un astratto universalismo umanitario di
carattere egualitario e totalizzante, in quanto disinteressato alle differenze perché troppo concentrato nella ricerca delle somiglianze a discapito delle specificità storiche, sociali, culturali o in esplicito etnocentrismo troppo ossessionato dal desiderio paranoico di porre confini
e differenze all’interno dell’universalità del genere umano.
Ciò che vogliamo proporre in questo studio, sulla scorta della suggestione problematica offerta dal saggio di Francesco Remotti, ma integrata con le riflessioni sul fenomeno contemporaneo dell’ibridazione
proposte da James Clifford in cui la crisi si afferma come chiave di
lettura della modernità non solo nella sua accezione negativa di rottura
di una continuità ma anche in quella propositiva di apertura, di possibilità, di novità, è il tentativo operato negli anni Trenta da Georges
Bataille, eterogeneo, letterario, provocatorio, di porre la questione
dell’identità ibrida che andava formandosi dal contato tra la cultura
occidentale e l’alterità culturale portata all’evidenza dalla scienza etnografica. La mia tesi è che, attraverso la riflessione di Bataille possiamo vedere che la crisi che attraversa il Novecento, di cui Bataille è
un rappresentante e un pensatore originale, la zona grigia di confusione del contatto tra culture sortisce risultati che vanno al di là delle attese, nel senso certo di uno sradicamento culturale, di una perdita di
identità, che non riconosce più le vecchie identità e i suoi valori, ma
anche nella direzione della pura apertura, ancora indeterminata e indeterminabile, della possibilità di “inventarne” di nuovi secondo una
modalità che può costituire un esempio per pensare la dinamica di
formazione delle identità ibride in generale.
Rischi ibridi
L’ibrido rischia sempre o di smarrirsi nel vuoto della dispersione
su cui si tiene precariamente, o di rifluire verso una concezione rigida,
I quaderni del CREAM , 2009, IX
136
esclusiva e rassicurante dell’identificazione, che nasce dal rifiuto di
uno dei due termini in tensione, che gli permetterebbe di ricostituirsi
un “io”, non importa se ritagliato sull’io originario, sull’identità dell’altro fatta propria acriticamente o su un elemento immaginato nuovo
e invece tanto più vecchio quanto più immaginario. Ma può anche costituirsi consapevolmente come una figura terza tra l’io e il tu il cui
statuto è difficilmente definibile; figura estrema della non-appartenenza che gode della libertà nuova dell’esteriorità a tutti i sistemi di significati, ma anche soffre della vertigine e del pericolo dell’oscillazione
in questa doppia esteriorità. La vicenda rocambolesca di Cabeza de
Vaca, riportata da Tzvetan Todorov nel saggio sulla conquista dell’America, un avventuriero spagnolo che vive in Sud America una vicenda romanzesca che lo porta, per un lungo periodo, a condividere la
vita e i costumi degli indios, è un esempio di questa oscillazione dei
significati che caratterizza i fenomeni di ibridazione. Al termine della
sua vicenda, Cabeza de Vaca si scopre nell’impossibilità di definire se
stesso rispetto alle sue due appartenenze, india e spagnola.3 La storia
offre lo spunto per la riflessione su quel soggetto terzo, questo “noi”
che nasce dalla doppia estraneità di cui parla Todorov, da cui è possibile partire per pensare il rapporto con l’altro e con il proprio.
In questo senso, le forme dell’ibridazione, come domanda sulla
nuova identità possibile, che nasce nel contatto culturale, danno ragione dell’approccio di parte della cultura novecentesca all’antropologia,
all’etnografia e all’esotismo in genere. L’“altro” vi è inizialmente appropriato in funzione critica del “proprio” nella misura in cui si differenzia radicalmente dalla cultura occidentale e quindi dà ragione di
una presa di distanza possibile. Certamente non si tratta di un fatto
nuovo.4 Ma la mia tesi è che la saldatura di questo tipo di straniamento
con il nichilismo novecentesco produce un esito che va al di là della
semplice funzione critica e apre nuove possibilità di riflessione sull’identità e la differenza. Il rapporto con l’alterità portata all’attenzione dall’etnografia conduce alcune figure di intellettuali a spingersi ol3
Cfr.: “L’universo mentale di Cabeza de Vaca sembra vacillare (...) non vi sono più
due partiti, noi (i cristiani) e loro (gli indiani), ma tre: i cristiani, gli indiani e «noi».
Ma chi sono questi «noi», esterni all’uno come all’altro mondo, per essere stati tutti e
due vissuti dall’interno?” (Todorov 1992, p. 242).
4
Si pensi al rilievo della figura del buon selvaggio che tra Sei e Settecento diviene
metafora critica della società dell’epoca.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
137
tre la sola dimensione negativa della critica. In questo sforzo di superamento nella direzione di una nuova ricomposizione identitaria,
l’altro diviene una figura del nulla, una figura del nichilismo, capace
al tempo stesso di disappropriarmi e di consegnarmi ad una nuova, diversa, complessa e mutevole identità, aperta a nuovi interrogativi e a
nuove possibili combinazioni, nata dalla riflessione sul significato
dell’“essere terzo” e decentrato del “noi”. In altri termini, la mia proposta è di pensare il fenomeno dell’ibridazione all’interno della riflessione sul nichilismo come posizione di pensiero che permette di concepire l’ibrido al tempo stesso come figura della negazione dell’identità e apertura di identità molteplici, inaugurando in questo modo una
modalità di pensiero nuova, una epistemologia rinnovata. È la posizione di Bataille.
“ETHNOLOGIE – je dis: non! à la terne geôle où je gis”5
Per comprendere la rilevanza della riflessione etnografica in Bataille, Anne Roche (1998), in un saggio sul rapporto con l’antropologia in
Bataille e Simone Weil, suggerisce di interrogare la linea editoriale di
quella strana rivista che fu Documents che il nostro ideò e diresse e che,
insieme a Michel Leiris, animò in modo originale. La rivista porta come
sottotitolo Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, Ethnographie. Nel progetto culturale di Documents l’etnografia gioca un ruolo importante. Il
gruppo dei redattori della rivista vi riconosce una conoscenza necessaria per tutti coloro desiderano prendere le distanze dalla presunta superiorità dell’identità occidentale. Attenta alla varietà della condizione
umana, la rivista vuole tenere una linea di rottura rispetto alla cultura
tradizionale dominante. Vuole essere scioccante e disvelante delle ipocrisie dell’idealismo morale. Si assesta su di una linea critica dei
presupposti culturali della società europea occidentale e, con Bataille,
aperta verso le esperienze e le conoscenze più stranianti, ripugnanti,
insopportabili in funzione negativa e dissacratoria, ovvero nichilista.
A questo scopo, Bataille si appropria dello “strano etnografico” perché
l’“approccio etnografico” – e l’effetto di straniamento che ne deriva –
gli permette di seguire la sua linea di ricerca senza i limiti delle nozio5
Leiris 1985, p. 26.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
138
ni morali da cui, ritiene, che l’etnografia prescinda totalmente in quanto scienza del diverso.6
Il gruppo di Documents e, in seguito quello del Collège, comprende rapidamente che l’etnografia, riportando l’attenzione sul fenomeno
elementare, di base, della varietà umana, capace di produrre forme diversissime di convivenza sociale e di strutture valoriali di riferimento
e di concepire le più singolari visioni del mondo e immagini dell’uomo, genera un effetto di decentramento rispetto ai valori culturali
di riferimento che la mette naturalmente in accordo con la crisi che attraversa la vecchia Europa al passaggio del secolo. Non solo frutto
dell’epoca, l’etnologia ha spinto questa crisi al di là dei suoi presupposti divenendo di fatto una delle cause del sovvertimento etico ed epistemologico nonché il luogo privilegiato per l’elaborazione di un pensiero del decentramento.7 Nei primi decenni del secolo, l’etnografia ha
prodotto un vero choc che ebbe un effetto generalizzato di liberazione
della riflessione morale e politica, dell’ideazione poetica e artistica e
della riflessione epistemologica. A quella nuova forma di conoscenza
si deve un effetto di ribaltamento sulla società occidentale degli interrogativi che l’osservazione etnografica sollevava sui fondamenti delle
società altre, sulle forme di pensiero, sulle convinzioni morali e sullo
statuto stesso del sapere. Si tratta di un effetto generalizzato a cui Bataille, tra i primi, dà un significato preciso.8 Per questo approccio a6
Cfr.: “Cette science qui a ceci de magnifique que, plaçant toutes les civilisations sur le
même pied et ne considérant aucune d’elle comme plus valable qu’une autre a priori en
dépit de la complexité plus ou moins grande des superstructures ou du raffinement plus
ou moins accentué des notions dites “morales”, elle est la plus généralement humaine,
parce que, non limité (...) aux hommes blancs, à leur mentalité, à leur intérêts, à leurs
techniques, elle s’étend à la totalité des hommes” (Leiris 1930, p. 406).
7
È posizione di Isabelle Rieusset quando scrive: “Non seulement il y a une concomitance objective entre la naissance de l’ethnologie et le décentrement des valeurs de la
métaphysique. Mais on peut dire que l’ethnologie a apporté des éléments nouveaux qui
ont permis de pousser plus avant cette critique. Autrement dit, l’ethnologie n’a pas été
seulement marquée par les effets d’une crise des valeurs. Elle en a accru l’incidence,
devenant de ce faut l’une de causes de ce bouleversement à la fois éthique et épistémologique… On doit donc admettre que l’ethnologie a été un des lieux de recherche privilégié pour l’élaboration d’une pensée du décentrement” (Rieusset 1987, p. 136).
8
Cfr.: “Le matériaux ethnologique firent choc et, comme chez bien d’autres, le choc
entraîna chez Georges Bataille une série de décentrements par rapport aux évidences
de sa culture reçues… L’ethnographie crée donc le choc qui libère le travaille poéticophilosophique qui permet d’entendre ce qu’il est interdit d’entendre dans notre culture
I quaderni del CREAM , 2009, IX
139
narchico, caustico, sovversivo della cultura francese degli anni Venti e
Trenta all’etnologia nascente, Clifford ha proposto la definizione, davvero interessante, di surrealismo etnografico.9 Ad alcuni intellettuali
della generazione disillusa uscita dal disastro morale e materiale della
prima guerra mondiale, la nuova scienza appare un chance di ripensamento che giustifica, legittima e anzi sprona all’accentuazione della
disgregazione e del caos in un senso gioiosamente sovversivo. In Bataille l’elemento sovversivo e negativo la fa da padrone, ma in un senso da valutare con attenzione.
Le lune morte10
L’effetto più immediato del decentramento culturale prodotto dall’etnografia è la nascita di soggetti ibridi. La nascita di un soggetto
dall’identità ibrida è tanto più facile quando il rapporto con la cultura
di appartenenza è debole per vari motivi: perché distante spazialmente, perché attraversata da una crisi, perché rifiutata scientemente. A
seguito di Clifford, possiamo dire che queste sono le condizioni nelle
quali si apre l’età contemporanea dal momento che “nel corso degli
anni venti è diventato concepibile uno spazio realmente globale di
connessioni e dissoluzioni culturali”11. Ciò che la caratterizza è l’apertura in Occidente di una zona di confine in cui la presa di distanza dalla mentalità comune e il fascino dell’alterità si fondono per dare vita a
nuove figure ibride di intellettuali. Condensando in sé la negazione
dalle certezze identitarie del passato e la proiezione verso l’incertezza
del futuro, queste identità nuove, fluide e incoerenti rappresentano
et d’en contourner ainsi les limites à l’aide d’autres temps et d’autres sociétés” (Godelier 1987, p. 1).
9
Cfr.: “Negli anni venti e trenta (...) etnografia e surrealismo si svilupparono in stretta
vicinanza. Uso il termine surrealismo in un senso ovviamente ampio per circoscrivere
una estetica che valorizza il frammento, le collezioni bizzarre, le giustapposizioni
sorprendenti, che cerca di provocare la manifestazione di realtà straordinarie tratte dai
domini dell’erotico, dell’esotico, dell’inconscio. Questo insieme di atteggiamenti non
può, naturalmente, essere limitato al gruppo di Breton” (Clifford 1993, p. 144).
10
Secondo la definizione di Marcel Mauss, il compito principale dell’etnologia è
scoprire le tante lunes mortes nel firmamento della ragione (cit. in Clifford, 1993,
p.155).
11
Clifford 1993, p. 15.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
140
nuove possibilità di significazione. Al tempo steso negatori e costruttori, caratteristica propria di questi ibridi è di intrattenere un rapporto
ambivalente di prossimità e distanza con i sistemi di classificazione
consueti e consolidati che vengono da essi deliberatamente confusi,
mischiati ad altri eterogenei, sovvertiti nel loro senso proprio e dotati
di nuovi significati. Con essi, nell’apertura dell’area vuota lasciata dal
disincanto contemporaneo, lo spirito epocale del nichilismo e l’esotismo etnografico si incontrano per dare luogo a identità singolari e
molteplici, ciascuna diversa dall’altra, fatta di un “noi” costituito da
una doppia alterità rispetto al “proprio” e all’“altro” ma che non può
prescindere né dall’uno né dall’altro; un “noi” che vive delle incertezze in cui già incorse l’avventuriero Cabeza de Vaca, in cui “‘qualcosa’
ancora ‘viene fuori’, anche se solo a ‘frammenti isolati’”12. L’impeto
negativo della cultura sovversiva degli anni Venti non deve farci perdere di vista il “qualcosa” di positivo che stava “venendo fuori”, anche
se non è facile definirlo e anche solo individuarlo; al contrario correremmo il rischio di classificare troppo sbrigativamente come distruttrici le ambigue figure ibride che incontriamo in questi anni e così facendo ne esauriremmo troppo semplicemente il messaggio sovversivo,
depotenziandolo. Clifford tratteggia chiaramente nella sua ambivalenza la condizione esistenziale dell’ibrido definendola
come frutto impuro: questa mescolanza di retaggi è o un’anima perduta
sradicata oppure un nuovo ibrido (...) È una diffusa condizione di perdita della centralità in un mondo di distinti sistemi di significato, uno stato consistente nell’essere dentro la cultura mentre si guarda ad essa dall’esterno, una forma di automodellamento personale e collettivo.13
La novità novecentesca rispetto all’esperienza di Cabeza de Vaca,
in cui l’etnografia ha la sua parte, risiede nel fatto che lo straniante
non può più essere tenuto a distanza, non deve essere cercato lontano.
Esso incombe ed entra nella nostra vita quotidiana. L’effetto di straniamento è ciò che risulta dopo la riduzione a maceria del nostro universo di riferimento semantico; un effetto che da alcuni, in quegli anni
decisivi di inizio secolo, è scientemente ricercato attraverso lo stravol12
13
Idem, p. 16.
Idem, p. 18 e 22.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
141
gimento del conosciuto poiché in esso vedono una via di fuga da una
società sentita come decadente e asfittica. Per essi, lo straniamento è il
perno su cui incentrare la loro critica corrosiva e fondare un nuovo
punto di vista originale su di sé e sul proprio tempo, al tempo stesso
strano e straniante. In quegli anni, si affaccia l’idea che “l’abisso della
‘modernità’, cioè della privazione o della frantumazione di cultura e di
storia, e questo “stato di emergenza” in cui viviamo è la regola, non
l’eccezione”14, ovvero è la condizione quotidiana nella quale si trova a
vivere l’uomo nell’epoca contemporanea, e su cui, quindi, occorre ripensare la sua identità per rifondarla e aprirla all’altro. È quell’aspetto
di frantumazione proprio dell’epoca che Bataille avverte più chiaramente nel suo rapporto con l’esotico e lo strano etnografico e che sviluppa con maggior originalità. Diviene sempre più chiaro a Bataille
che lo straniante “etnologico” è ovunque, non solo nell’esotismo del
dato etnografico. Nella riflessione di Bataille, l’universo di senso di
appartenenza dell’uomo occidentale non è più dato per scontato. Esso
vacilla al pari di quanto accade nel contatto con gli altri sistemi di riferimento di cui dà testimonianza l’etnografia. In questo senso, grazie a
questa apertura, a questa breccia epocale nelle certezze consolidate,
per Bataille il rapporto con l’etnologia come scienza specifica che ha
come oggetto l’altro, lo strano, l’insolito si fa più facile e più fruttuoso
per lo scambio di conoscenze, di metodi, di riflessioni. Quella scienza
rappresenta, per Bataille, una forma esemplare del tipo di sapere adeguato all’epoca in cui più nulla è dato per acquisito, ma tutto è messo
in questione, tutto è da ri-conoscere. Tutto il mondo è divenuto “esteriore”, alterità espulsa dal consesso del significato, escremento e cadavere per usare il lessico batailliano. Quindi, in questo mondo decentrato l’altro, lo straniero in senso proprio ma anche lo strano – ciò che
rappresenta l’alterità in quello che ci è prossimo – emerge come figura
del nulla di sapere e di identità, impossibile, impensabile e inassimmilabile che perciò è “ciò che è da pensare e ciò che dà da pensare”.
Quando si parla di etnografia, dice Clifford “l’‘esotico’ (...) è nei
paraggi”15, ma questa categoria ampia deve essere collocata con precisione all’interno della ricerca batailliana. L’accezione cadaverica, mostruosa ed escrementizia dall’alterità come metafora di ciò che mi de14
15
Benjamin 1962, p. 75.
Clifford 1993, p. 22.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
142
compone, mi destruttura, mi destabilizza esprime più specificamente
l’approccio di Bataille al tema etnografico. La tecnica dello straniamento e dell’accostamento arbitrario si incontra in Bataille con questa
sensibilità di fondo da cui trae la preferenza per l’accezione mostruosa
e oscena dell’etnografia. Leiris spiega la voga dell’esotismo degli anni
Venti e Trenta attraverso il disgusto che ispirano l’Europa e la civilizzazione, ma Bataille si spinge oltre nell’approfondimento dell’indagine
della categoria esperienziale dello straniante, oltre l’esaltazione della
negritudine come alternativa culturale.16 L’esotico diviene via via, in
Bataille, una categoria interpretativa sempre più interiorizzata che dà
ragione di una diversa scelta esistenziale e della sua indagine essenziale sull’identità umana. Diviene una categoria etica, di un’etica della
ricerca che mette capo a un approccio aperto e antidogmatico ai metodi e agli oggetti del sapere in generale, primo tra tutti l’uomo e io stesso in quanto questo uomo storicamente, socialmente, culturalmente
determinato.
Con la rivista Documents e poi con il Collège de Sociologie vediamo approfondirsi in Bataille il tema dell’esotico fino ad allontanarsi dal dato prettamente etnografico, che, per così dire, viene da distante geograficamente, per addentrarsi nel prossimo, lo strano che sta vicino, a cui appartengo, e su cui si fonda la mia appartenenza, in quell’intreccio tra dato sociologico ed esperienza psicologica che per la
sua ricerca e la sua esistenza stessa divengono fondamentali fino a radicalizzarsi nella questione esistenziale ed essenziale di fondo, quella
della negatività esperienziale che troverà compimento nell’Esperienza
interiore.17 In altri termini, diviene chiaro per Bataille che le lunes
mortes di cui parla Marcel Mauss non sono solo le altre razionalità
possibili che l’etnologia offre alla riflessione, ma sono quelle “toppe
di inesistenza, calce o cenere/pronte a farsi movimento e luce”18 che
16
Cfr.: “En cette Europe chaque jour plus sordide dans laquelle nous vivons, l’exotisme exerce un attrait de plus en plus violent sur un certain nombre d’esprits, ceux
dont la respiration se fait mal dans cette chambre surchauffée et surpeuplée” (Leiris 1930, p. 375-376).
17
A proposito dell’intenzione del Collège de Sociologie, cfr.: “Rendere estraneo ciò
che appare familiare (...) con la cura meticolosa di un etnografo ‘esotico’ (...) divenire
osservatori che osservano quegli altri che siamo noi e, al limite, quell’altro che è il
nostro stesso io” (Jamin 1980, p. 16).
18
L’espressione è di Vittorio Sereni nella poesia La spiaggia (Sereni 1975, p. 86).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
143
via via ritrova vicine a sé nei fenomeni di possessione collettiva e
nell’angoscia dell’estasi interiore nel mezzo della sua stessa esperienza di vita e della sua riflessione sociale. Lune morte della razionalità
individuale e dell’organizzazione collettiva, aspetti in ombra e ignoti –
dove l’accento cade sull’aggettivo morte a sottolinearne il lato oscuro,
impresentabile, osceno, in una parola socialmente interdetto nell’insieme ordinato e ordinario della razionalità omogenea di cui costituiscono il mancamento e la trasgressione – che costituiscono le chance per
una riflessione originale e per esperienze eccezionali. Dimensioni nascoste dell’individualità e del legame comunitario che non sono caratterizzabili in positivo, ma ciò non di meno esse sono il punto di partenza per riflettere su come approcciarsi alla differenza a partire da
una epistemologia rinnovata che Bataille chiama anche non-sapere. Il
rapporto con l’esotismo etnografico porta Bataille a ribaltare le questioni che l’etnologia si pone a proposito delle culture altre sulla propria cultura, producendo una riflessione originale. Ciò che emerge in
Bataille, è che anche noi siamo messi in questione dalla messa in questione generale prodotta dal rapporto tra culture nella misura in cui la
differenza ci nega come identità finite e autoevidenti. L’esempio della
riflessione di Bataille, ci permette di dire che l’apporto più originale
dell’etnologia alla cultura di inizio secolo è l’invito a prendere coscienza del fatto che anche noi “siamo morti”, dobbiamo essere ripensati, dobbiamo riformulare le nostre categorie di identificazione perché esse non sono così evidenti e note come si poteva ritenere; e
l’etnologia, mettendoci di fronte alla nostra negazione che è l’altro ce
ne offre l’occasione e anche gli strumenti di riflessione. “Il baratro che
l’idea di morte rappresenta per ciascuno non è nient’altro che il sostituto più addomesticabile di un avversario molto più terribile: la presenza dell’altro”19.
La logica che guida il pensiero di Bataille è riconoscibile nel filo
conduttore della scoperta delle potenzialità distruttrici ma anche creatrici del negativo che va dai primi articoli di Documents a La pratique
19
Grassi 1998, p. 43-44, che continua: “Confrontarsi con la morte non significa incontrare la propria morte, ma imbattersi in quella di un altro. Il baratro che l’idea di
morte rappresenta per ciascuno non è nient’altro che il sostituto più addomesticabile
di un avversario molto più terribile: la presenza dell’altro (...) La presenza dell’altro
suscita l’infinito terrore di non poter mai riuscire ad avvicinarglisi del tutto e, al
contempo, di essere sempre in procinto di confondersi con lui”.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
144
de la joie devant la mort, ultima relazione di Bataille al Collège de
Sociologie alla vigilia dello scoppio della guerra. Nel contesto del ripensamento epistemologico che la ricerca etnografica avvia in tutte le
scienze e i saperi dell’uomo, Bataille si concentra in modo originale
sull’esperienza pensante della zona di confine dell’elemento negativo
insito nel fenomeno dell’ibridazione del sapere, della sua apertura
all’alterità che passa per la sua alterazione. È il potere del negativo il
centro della sua epistemologia della differenza, il sempre impensato
negativo che non cessa di incombere alla “fine dalla Storia”, radice di
tutte le perdite d’identità, da cui occorre partire per riflettere sulla differenza. L’interesse per le esperienze-limite a cui l’etnografia ha dato
nuovo alimento, che Bataille riconosce nell’erotismo, nel sacrificio,
nell’estasi, ne è un esempio. Parafrasando Marie-Christine Lala, possiamo dire che queste esperienze rappresentano per la riflessione batailliana dei luoghi in cui i significati oscillano e le identità si dissolvono aprendo uno spazio dove l’alternativa tra senso e non senso lascia il posto all’alternanza tra perdita e significato della perdita.20 Esattamente lo spazio incerto di questa alternanza è il punto da cui partire per comprendere la specificità dell’identità ibrida.
Questo pensiero originale della negazione che superando l’alternativa tutta metafisica tra senso e non-senso permane nella negazione
fino a farne l’affermazione paradossale di una nuova forma ibrida che
si dà solo come il “non” di un’identità, di un’omogeneità, di un sapere,
come la sua trasgressione, o la sua morte è, forse, l’apporto più interessante di Bataille al dibattito epistemologico acceso anche dalle riflessioni dell’etnografia ed è un punto che deve restare chiaro parlando del surrealismo etnografico di Bataille. Vi risiede, infatti, il discrimine che lo distingue da altri approcci che privilegiano il lato positivo e quindi la forma espressiva del collage, della giustapposizione di
elementi eterogenei che permette la strutturazione di un sovra-senso;
basti pensare all’evoluzione del surrealismo di Andre Breton che Bataille presto abbandona dopo che il movimento ebbe preso le distanze
20
Cfr.: “Est le marque vive d’un espace où l’alternative, toute métaphysique, entre
sens et non-sens, le cède à l’alternance réglée du jeu entre disparition et sens de la
disparition” e idem, p. 193: “à l’instant de la dissolution, le signifié est perçu en tant
que non-sens, à la fois moteur et dérobé, mais toujours réitéré sous la forme du rien”
(Lala 1987, p. 194).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
145
dell’esplosività del dadaismo. Clifford sottolinea che la rivista Documents faceva largo impiego della tecnica della giustapposizione per
colpire il lettore associando, secondo una logica fuori dai canoni comuni, gli articoli più disparati e le immagini più strane. Ma se andiamo a prendere in esame il contributo specifico di Bataille, ci rendiamo
conto che non gli sfugge la possibilità di significazione in positivo
propria dell’assemblaggio ma non gli interessa, anzi la rifiuta come
possibilità privilegiata perché liquida troppo rapidamente il problema
centrale dell’epoca, quello nichilistico del nulla. Il patchwork di detriti
in funzione significante a Bataille non interessa; gli interressa piuttosto pensare il detrito stesso senza senso, la forma staccata senza significato, il particolare senza sistema, la negatività senza impiego. Roland Barthes (1974) descrive la pratica batailliana di Documents come
una pratica dello smembramento del sapere che attraverso la miniaturizzazione lo rende futile, burlesco, eteroclito fino a denaturizzarlo.
Ma Bataille, nel pensamento del detrito, desidera farsi un concetto anche dell’uomo e anche, soprattutto, di se stesso come detrito e relitto
della (post-) modernità, forma staccata senza sistema, e quindi al tempo stesso comico, patetico e parodistico, intrinsecamente sovversivo.
Persino nell’opera più etnologica di tutte e di tutte la più compiuta e
ordinata, La Part maudite, al di là del dato etnografico del potlach, la
festa di distruzione, al centro dell’interesse è l’elemento della distruzione stessa che apre la riflessione al concetto di economia allargata,
che illumina il rapporto tra eccesso ed eccedenza, che travalica i limiti
ristretti della sola scienza economica, non configurandosi semplicemente come critica all’economia di produzione capitalista o socialista,
ma come problema esistenziale, cosmico e ontologico.
Ma prima della Part maudite e anche dell’articolo La notion de dépense che prepara il testo del dopoguerra, l’esotico nell’accezione del
mostruoso, eccessivo ed eccedente che oscilla tra senso e non senso,
della rivista Documents assolve già a questa funzione di inclassificabilità radicale, che si preciserà nelle opere successive, di ciò che fa parte
essenzialmente dell’esistenza umana ma ne costituisce l’oscurità, e
quindi si dà come apertura per una pensabilità tanto più impossibile
quanto più urgente, in quanto l’assenza di classe del mostruoso è una
“categoria paradossale”, perché in realtà è una anti-categoria, ma centrale della contemporaneità nichilistica che, se non pensata e sentita
I quaderni del CREAM , 2009, IX
146
interiormente, riemerge sotto forme ancora più mostruose, come i sentori di guerra imminente facevano presagire.
Il potlach della modernità, alla vigilia della guerra, ma anche successivamente con il rinnovarsi continuo delle possibili minacce totali,
come il conflitto atomico degli anni Cinquanta e Sessanta e oggi la catastrofe ecologica, rischia di essere la realizzazione mostruosa di un
incubo immane di distruzione che supera ogni possibilità di drammatizzazione rituale sbilanciando i pesi sensibilmente, forse irrimediabilmente, nel senso della distruzione.21 Su questo rischio totale Bataille, a partire proprio dal disorientamento degli anni Trenta, richiama
l’urgenza di pensare la distruzione, di pensare la consumazione, di
pensare la ritualizzazione dell’osceno e del morto, di ripensare il dominio del sacro e, attraverso questa riflessione ampia ed empia, non
cessa di porre la priorità di ripensare un’antropologia capace di sostenere un’etica all’altezza dei tempi.22 In questo senso, Bataille coglie il
senso del richiamo di Nietzsche sulla “necessità della guerra”, non in
senso bellicista ma nella direzione della comprensione di una dimensione essenziale dell’esperienza umana. Lo scontro tra le forze è parte
della condizione umana, fingere che esso non vi sia rischia di avere
21
Lo aveva ben compreso Callois, amico e collaboratore di Bataille, nel famoso L’uomo e il sacro del 1950 sottolineando che “La prospettiva di una festa totale, che
rischia di travolgere nei suoi orrendi vortici quasi l’intera popolazione del globo, e di
annientare la maggioranza dei suoi partecipanti, annuncia stavolta l’avvento di una
fatalità effettiva, spaventosa, paralizzante e perciò tanto più affascinante. La realtà
eguaglia la favola: arriva ad averne le dimensioni cosmiche, si rivela capace di attuarne gli esiti fatali. Oggi un mito di annientamento universale come quello del Crepuscolo degli Dei non appartiene più al solo dominio dell’immaginazione. La festa,
tuttavia, era la messa in scena di una fantasia. Era simulacro, danza e gioco. Mimava
la rovina dell’universo per assicurarne la rinascita periodica (...) Non sarebbe più così
il giorno in cui l’energia liberata in un parossismo sinistro, di una vastità e di una
potenza sproporzionate alla fragilità della vita, dovesse rompere definitivamente
l’equilibrio a favore della distruzione” (Callois 2001, p.174).
22
Cfr.: “Non serve a niente chiudersi gli occhi; manca la comprensione del sacro, manca
quella della guerra. Per farla breve, manca proprio la conoscenza dell’uomo d’oggi (...)
Ma insistiamo: lo studio del sacro dà il senso di una difficoltà insolubile e di una
maledizione dell’uomo. Senza il sacro, la totalità della pienezza dell’essere sfugge
all’uomo, che sarebbe così solo un uomo incompleto: ma se il sacro prende la forma
della guerra, l’uomo è minacciato di annientamento totale” (Bataille 2001, p. 190-191).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
147
effetti molto più devastanti che non riconoscere il carattere creativo
della sua negatività.23
Il mio vicino di casa è un licantropo
Che l’esotico, nell’accezione ampia che abbiamo visto, non possa
essere tenuto a distanza non significa solo che fa parte integrante
dell’esperienza delle modernità, ma soprattutto che esso abolisce la
distinzione tra un dentro e un fuori. L’esotico è dentro nella misura in
cui è esterno al solito e al corrente, estraneo, strano, altro e quindi mi
appartiene e gli appartengo nella misura in cui lo percepisco parte di
me, ma come fosse uno scivolamento della mia identità e quindi parte
del mio straniamento, e fuori di me, fuori da ciò che mi identifica, da
ciò che posso nominare “io”. È a partire da questa interpretazione dell’esotico che, in Bataille, si apre il ripensamento del rapporto tra identità e differenza nella riflessione sull’uomo in quanto soggetto di sapere e d’esperienza. Giustamente Bataille riconosce ciò che è da pensare
dell’esotico non solo nella differenza culturale, ma nella differenza
tout court che è data dall’erotismo, dall’inconscio, dalla morte, dal sacrifico e dal sacro che sono esperienze limite che implicano e intaccano il soggetto “in proprio”. Ciò che emerge dal suo pensiero è che essi
sono “oggetti” dell’esotico e io sono il “soggetto” che li esperisce ma
l’unica cosa che c’è è lo straniamento stesso.24 Il concetto stesso di
23
Contrapponendo le società totalitarie a quelle democratiche e libere, Grassi (1998,
p. 141-142) scrive: “Le società eterogenee, che per poter persistere devono essere in
grado di lasciar coesistere al loro interno molteplici punti di vista, hanno bisogno di
rapporti di forza in cui l’intesa, la concordia, l’alleanza, la connessione riescano ad
accettare la presenza della diversità, dell’indipendenza, del conflitto, della divisione.
In questi termini, in vista della comprensione dell’epoca attuale, caratterizzata dalla
comunicazione senza frontiere e dalle emigrazioni di massa, non è opzionale ma necessario prendere in considerazione la prospettiva del non-sapere (...) È proprio il
punto di vista del non-sapere che, consentendo di comprendere e accettare il ‘polemos’, in conflitto che ‘si svolge nei limiti di una naturale inimicizia’ ha maggiori
chance d’impedire il ricorso alla violenza di Polifemo, alla guerra di tutti contro tutti”.
24
Il richiamo di Bataille alla nozione di differenza in quanto tale può ricordare il
progetto di Essai sur l’esotisme che Victor Segalen pensava di realizzare grazie agli
appunti di viaggio, alle suggestioni e alle riflessioni raccolte tra il 1908 e il 1918 e di
cui restano solo frammenti sparsi, un indice degli argomenti e alcuni abbozzi dei
capitoli iniziali. Tra le intuizioni più interessanti di Segalen vi è di allargare il
I quaderni del CREAM , 2009, IX
148
differenza è il fulcro della ricerca batailliana e in questo senso qualunque cosa può essere investita di volta in volta di questa aura strana.
Ciò che conta non è l’oggetto strano in sé ma invece il “fatto” che una
differenza insolita si dia nel quotidiano, nel solito, nel conosciuto, nel
mezzo dell’identità. Qualsiasi cosa può essere esotica. Tenendosi lontano dall’idolatria del feticcio, Bataille comprende che, come per il
perturbante in Sigmund Freud (1919), ciò che deve essere compreso
non è l’oggetto in sé, l’oggetto etnografico, per esempio, ma ciò che
accade nel perturbamento, la dinamica emotiva che costituisce il nucleo dell’“esotico”, dello strano. Per questo, sottolinea nell’esotico
l’elemento dell’interdetto e del rimosso guardando alla più grande varietà delle manifestazioni e non solo ai dati dell’etnografia.
Leggendo il fenomeno dello straniamento in relazione al concetto
di interdetto, acutamente Bataille rileva che di fronte all’interdetto,
l’atteggiamento è ambivalente. Pur restando nell’ordine interiore dello
straniamento, rispetto ad esso le emozioni possono essere contrastanti;
come sottolinea Clifford, per Bataille, la repulsione e il conseguente
rispetto dell’interdetto si fonda su un’emozione negativa della novità
radicale; viceversa, l’accettazione dello straniamento e la conseguente
violazione dell’interdetto si aprono su un’ “emozione positiva”. “Demistificare e valorizzare ‘l’emozione positiva’ della trasgressione in
tutte le sue varianti fu, per Bataille, il progetto di un’intera vita”25.
Ma l’originalità dell’approccio batailliano alla potenzialità implicitamenente trasgressiva dell’etnografia è nel fatto che se è vero che
concetto di esotismo al di là dei confini dell’etnografia e della curiosità pregiudiziale e
strumentale del colonialismo fino a comprendere l’idea di sentimento della differenza
in quanto tale. L’esotismo diviene così un concetto generale che indica ciò che è
diverso e la diversità in genere. Nell’ultima nota dei suoi appunti, leggiamo: “Je
conviens de nommer ‘Divers’ tout ce qui jusqu’aujourd’hui fut appelé étranger, insolite, inattendu, surprenant, mystérieux, amoureux, surhumain, héroïque et divin même,
tout ce qui est Autre” (Segalen 1995, p. 778).
Tuttavia, a distinguere Bataille e Segalen vi è, a mio giudizio, l’insistenza del primo
non tanto sulla differenza che distingue le cose le une dalle altre ma sulla differenza
come alterazione di ciò che è noto da parte di ciò che è ignoto, di ciò che è classificabile da ciò che è inclassificabile. In Bataille vi è una attenzione per l’alterazione e lo
scivolamento dei significati delle cose che in Segalen non c’è, a fronte, invece, nel
secondo di una attenzione verso ciò che distingue le cose le une dalle altre rafforzandole nella loro identità.
25
Clifford 1993, p. 153.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
149
l’etnografia insegna a valorizzare l’esotico, l’insolito, il paradossale e
invita a una radicale riposizionamento delle categorie familiari, in Bataille questo approccio non resta al livello di uno studio distaccato ma
chiama ad una adesione esistenziale senza riserve.26 Se Leiris e Bataille cercano nell’esotico ciò che smentisce la loro società e la loro cultura di appartenenza accentuandone la crisi, Bataille solo cerca in esso
un appoggio al suo desiderio d’essere selvatico divenendo egli stesso
selvaggio. Ancora più chiaramente Roger Callois, collaboratore del
progetto per una sociologia sacra del Collège, spiega che la differenza
fondamentale tra il suo approccio di studioso e quello di Bataille, che
segnò l’allontanamento tra i due e determinò in parte la fine del progetto atipico del Collège, risiede nel fatto che là dove il primo intendeva applicarsi ad uno studio metodico e analitico dei fenomeni, Bataille invece si spingeva sempre all’interiorizzazione dei fenomeni
stessi nell’intenzione primaria di annullare la distanza rispetto ad essi
per riattivarne l’esperienza in prima persona. Significativo, in questo
senso, è l’effetto di una conferenza sullo sciamanismo tenuta da Anatole Lewitsky al Collège nel 1939. Lewitsky, tra le altre considerazioni, vi sottolinea lo statuto sociale eccezionale e ambiguo dello sciamano che si potrebbe definire di natura antisociale, al tempo stesso dentro e fuori la sua società di appartenenza. Bataille resta colpito, fulminato da questa figura negatrice al punto di volerla incarnare lui stesso
per condurre un’esistenza “da sciamano”, ritagliata sullo stesso modello di socializzazione e d’esperienza, poiché a partire da essa, dall’esperienza riattualizzata della sua eccezionalità, vede la possibilità di
interrogare in profondità l’enigma sociale e il problema stesso dell’uomo fuori dalle concezioni comuni sulla natura umana. L’interesse
e l’approccio partecipativo di Bataille con la negatività spiegano allora
26
A proposito dell’approccio di Battaile, cfr. Grassi (1998, pp. 35-36): “Indica il
tentativo di farsi carico di un ascolto pànico: un ascolto disincantato dell’altro che
permetta di elaborarne l’aterità non attraverso un sistema astratto di riferimenti, ma
affrontandone la presenza inquietante nei casi concreti della vita quotidiana (...)
Osservando le cose in questo modo, si manifesta come le relazioni intersoggettive
costruiscano un piano inclinato e slittante, in cui il paradigma dell’osservatore e
quello dell’attore si mettono in questione costantemente e reciprocamente e danno
forma a un modello di autorità che si disconosce passo dopo passo, che si misura
indefinitamente con la propria autoverifica e che non consente a nessuno di paralare e
giudicare in suo nome” (Grassi 1998, pp. 35-36).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
150
l’entusiasmo delle sue curiosità etnografiche per il diverso, l’altro, lo
strano. In Bataille la congiuntura epocale tra crisi, critica dei valori e
scienza etnografica ha una sfumatura particolare nella misura in cui il
suo rapporto senza riserve con la questione del negativo, inteso nel
senso sopra indicato, permette e apre allo scambio fecondo con l’altro
etnografico. In Bataille il rapporto senza mediazioni con il totalmente
altro che è la negatività permette il confronto con l’altro etnografico
perché quelle riserve su di sé che costituiscono le difese per l’autoconservazione, che ne avrebbero impedito la comprensione, sono già
state abbattute a partire dalla deliberata presa di distanza dalla sua cultura d’appartenenza da cui parte originariamente la sua ricerca. Se è
vero in generale che l’altro è necessariamente ciò che mi intacca in ciò
che mi è proprio, quest’idea è ancora più vera per Bataille. Centrale,
per il suo approccio, è la messa in discussione non solo dei fondamenti ma del concetto stesso di fondamento, di originario, di essenziale e quindi dell’identità propria, che apre alla concezione della differenza e del molteplice.
Ecco, allora, che l’oggetto esotico etnografico assume una connotazione più ampia in Bataille. Esso risulta una figura che rappresenta
emblematicamente l’esotico nella sua accezione più ampia e generale,
quella di una potenza destabilizzante che si ritrova sempre accanto al
“proprio” come suo lato in ombra. In questo senso, nella riflessione di
Bataille, l’esotico è riconducibile all’accezione che sviluppa Rocco
Ronchi, come ciò che è in grado di “restituire il cosmos ordinato alla
potenza di una mostruosa ‘illeité’”27. Come scrive Émanuel Lévinas in
un senso critico, distante dall’intenzione di Bataille ma simile nella
comprensione del fenomeno, si tratta di una potenza che è straniera “à
toute distinction entre un ‘dehors’ et un ‘dedans’”28. In Bataille, la figura dell’ibrido, da cui siamo partiti, è questa confusione di dentro e
27
Cfr.: “Restituire il cosmos ordinato alla potenza di una mostruosa ‘illeité’, quella
stessa che risuona impersonale nella proposizione il y a, sottrarre il mondo al dominio
di un soggetto-autore (...). Agendo come un potente corrosivo, disincarna questo
mondo restituendolo in effigie a quella potenza elementare e neutra del c’è sulla
quale, imponendo silenzio al ‘mormorio dell’incessante e dell’interminabile’, questo
cosmos si era edificato (...). Eterno ritorno del Medesimo, che l’‘io’ per realizzarsi
come solida identità e come ‘essere nel mondo’ aveva dovuto, già da sempre,
rimuovere” (Ronchi 1985, p. 95 e pp. 93-94).
28
Lévinas 1947, p. 87.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
151
fuori che si sottrae al cosmo dei significati ponendosi fuori dall’io in
quanto centro di sapere, aprendo il “proprio” all’“improprio”.
Il “noi”, ambiguo e indefinibile, che nasce da quella apertura consapevole al diverso destabilizzante (e non importa più a questo punto
che sia il diverso etnografico, il sogno, il diverso sociale, la rivoluzione, l’estasi perché ciò che importa è cosa accade nell’incontro stesso)
è allora già sulla via nietszchiana del superamento del nichilismo perché è al tempo stesso figura della morte che sostiene in sé il negativo,
la fine dell’idealità del valore, dell’appartenenza alla verità, della permanenza del soggetto, dell’identità, e una nuova, indefinibile possibilità che si forma, una potenzialità che nasce, una identità che si affaccia definibile come un “noi-altri”, altri perché diversi e sempre alterati, presi nella tensione irriducibile tra identità e differenza. È questo il
frutto dell’incontro tra etnografia e nichilismo, e la loro mutua implicazione, che porta Bataille a ricomprendere l’esotico etnografico nel
discorso più ampio della sua amicizia nietzschiana. Come scrive Francois Warin, non c’è riconoscimento dell’universalità dell’uomo senza
affermazione della sua pluralità e della sua differenza.29 Per chiarire
questo passaggio possiamo prendere a prestito le parole di Maurice
Blanchot che chiama questa differenza specifica che costituisce il movimento di pensiero di Bataille, e che abbiamo voluto indicare come
significativo per la comprensione dei fenomeni di ibridazione, “parola
plurale”30 e la definisce come “la ricerca di una affermazione che, pur
sfuggendo ad ogni negazione, non unifichi e non si lasci unificare, ma
ogni volta rimandi ad una differenza sempre più tentata di differire. È
una parola essenzialmente non-dialettica, che dice l’assolutamente diverso che non può mai essere ridotto allo stesso né collocarsi in un tutto”31. E continua Blanchot, “dunque la parola plurale è forse questa
parola unica in cui ciò che è detto una volta da «me», è ripetuto una
seconda volta da ‘Un Altro’, e così è reso alla sua Differenza essenzia-
29
Cfr.: “Il n’y a pas de reconnaissance de l’universalité de l’homme sans affirmation
de sa pluralité et de sa différence (...) Entre le ‘nous tous’ de l’universalisme abstrait
et le ‘moi, je’ de l’individualisme misérable, il y a le ‘nous autres’ de Nietzsche, une
pensée du cas singulier qui déjoue l’opposition du particulier et de l’universel” (Warin
1994, p. 256).
30
Blanchot 1977, p. 290.
31
Ibidem
I quaderni del CREAM , 2009, IX
152
le”32. Il pensiero e il soggetto sono come “abitati” da un altro che si dà
diversamente da essi ma non senza di essi in un rapporto di trasgressione e superamento reciproco e ininterrotto.
Valorizzare il negativo significa valorizzare l’esperienza del sentimento positivo dell’esotico in quanto negazione, figura della negatività. Significa contrastare la pulsione di fuggire (fisicamente o idealmente verso un metafisica di riferimento, se restiamo nella dinamica
nietszchiana) e valorizzare ciò che si dà in quel momento, quel sentimento stesso che in quel momento è il solo esistente, che ha annullato
tutto e quindi è un nulla quello che si dà ma un nulla pieno di domande. L’interrogazione sul sentimento dell’esotico passa, in Bataille, nella domanda fondamentale dell’Expérience Intérieure sotto la forma
dell’impossibile del pensiero, ciò che non può essere perché è “senza
di me”, mi scarta dalla mia presenza, mi disappropria, eppure “è qua”
al mio posto e avanza pretese. Non classificare l’esotico etnografico
nelle proprie categorie di appartenenza ma tenerlo nella sua alterità
radicale è un primo passo in questa direzione che si approfondirà sempre più nel senso dell’indagine sull’esperienza stessa dello straniamento. In questo senso l’accettazione piena e senza riserve del nichilismo
apre a questa possibilità di contatto con l’etnologia.
Une anthropologie déchirée
“Mais la différence était que Georges Bataille voulait réellement
devenir chaman” dice Callois nel 1970,33 rievocando in modo ancora
sensibilmente toccato dopo molti anni un episodio chiave di quell’antico progetto d’amicizia che era stato il Collège de Sociologie.
Questo episodio apparentemente così strano, persino per Bataille, dice
invece molto dell’intenzione con cui Bataille si accosta alla scienza etnologica del suo tempo, e non solo a quella. Al di là della semplice acquisizione di concetti della scienza etnologica con cui interpreta le forme comunitarie in generale e, quindi, anche della società del suo tempo,
il suo rapporto con l’alterità rappresentata dall’etnografia è sostenuto da
un’intenzione che va al di là del puro interesse conoscitivo.
32
33
Ibidem
Caillois 1970, p. 7.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
153
Bataille non si farà scrupoli di fedeltà alla scientificità di quei concetti rielaborandoli in forme eterogenee ed impiegandoli in senso largo. Nella sua scoperta dell’etnografia è soprattutto mosso da un intento etico capace di avviare un ripensamento epistemolgico; cerca in essa lo spunto che, attraverso il decentramento rispetto alle categorie di
pensiero correnti, gli permetta di dare vita a una critica radicale della
società che sfoci nel ripensamento dell’idea stessa dell’uomo passando
per il rinnovamento epistemologico delle modalità di pensarlo. Questo
percorso si struttura secondo una serie di rinunce, di sacrifici, di dislocazioni di sé rispetto alla propria identità culturale, valoriale e di sapere
che Bataille farà sempre in prima persona ritenendo l’esperienza l’elemento prioritario e imprescindibile del nuovo stile di pensiero e di vita
di cui vuol essere innanzi tutto il testimone (la vittima, verrebbe da dire)
e non solo l’ideatore. E sente il suo percorso di dislocazioni tanto più
urgente quanto più, per tutti gli anni Trenta, avverte pressante la necessità di pensare delle forme originali di comunità che fossero da una parte adeguate ai tempi e quindi capaci di far propria la specificità critica
del venire meno dei fondamenti dell’era contemporanea, dall’altra si costituissero come un’alternativa alla logica omologante dell’utile e del
sapere che, nel mezzo della crisi e in risposta ad essa, stava prendendo
una deriva aberrante nell’edificazione dei sistemi totalitari.
Bataille riconosce il decentramento necessario rispetto a un intero
sistema politico, morale e culturale nel concetto etnografico di dépense di cui, negli anni, sviluppa tutte le implicazioni etiche, esistenziali
ed ontologiche proiettandolo al di là dei limiti economico-sociali cui
appartiene.34 Per comprendere l’originalità della complessa evoluzione
del suo straniamento, l’approccio senza riserve di Bataille con lo sciamanismo è quanto mai significativo. Lo spiega in modo molto chiaro
Isabelle Rieusset riportandolo all’intenzione batailliana di pensare lo
straniamento attraverso l’edificazione di “un mythe nouveau” che permettesse di ripensare la figura dell’uomo decentrato dell’epoca con-
34
Cfr.: “Il s’agit pour lui de tirer de ces informations ethnographiques les éléments nécessaires pour penser un système d’échanges politiques et économiques fondé sur la dépense,
permettant une alternative à la logique de l’utile e du savoir qui sous-tend les systèmes
contemporains jusque dans leurs exacerbation totalitaires” (Rieusset 1987, p. 125).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
154
temporanea.35 Come sostiene Rieusset, in questi anni, Bataille vuole
trovare il fondamento etico di una azione negatrice che il contesto politico, con l’ascesa del nazismo, chiama sempre più pressantemente a
cercare. È l’etnologia, allora, a fornirgli il punto d’osservazione privilegiato, perché decentrato, per vedere gli elementi fantasmatici chiave
su cui si fonda la struttura sociale e, attraverso la riflessione etnologica, riconosce nel mito il fondamento dell’azione collettiva. L’insieme
delle energie affettive che il mito può risvegliare diviene, allora, il
contesto in cui pensare un’etica per una nuova concezione dell’uomo.
Il mito, quindi, non gli interessa come fenomeno sociologico da studiare ma piuttosto come un crogiuolo di forze da cui attingere per porre su basi diverse la domanda sui modi della vita associata in cui agisce una originale figura d’uomo. Infatti, secondo Rieusset, attraverso
il problema del mito, il pensiero di Bataille passa dall’orizzonte etnologico a quello antropologico, cioè passa a porre in primo piano la
domanda sull’idea dell’uomo.
È vero che Bataille ritrova nella potenza del mito quei legami forti
capaci di fondare una comunità “religiosa”, non nel senso trascendente
del termine ma invece in quello usato da Mauss a proposito delle pratiche rituali delle società primitive, “immanent au mouvement communiel qui anime les membres (...) étranger à tout principe transcendant”36, ma non lo fa senza sconfessare il mito stesso edificando un
contro-mito che fa scivolare la sua analisi verso una riflessione antropologica originale.37 Sulla sua analisi del mito interviene una preoccupazione etica. In altri termini, non è indifferente per Bataille su quale
mito dovrebbe costituirsi la futura comunità. Il mito adeguato all’era
contemporanea è, per Bataille, un anti-mito, sintesi, smentita e alterazione di tutti i miti e di tutte le possibilità del mitologico in quanto
fondamento per l’identificazone. Perché esso possa fare da fondamento per un’etica antagonista deve, in qualche modo, incarnare visibilmente il rifiuto di ogni sistema chiuso e mantenere la negatività del
35
Ibidem: “Ce ne sont pas les sociétés chamaniques elles-mêmes qui intéressent
Georges Bataille, c’est le fait qu’elles actualisent certaines des valeurs éthiques sur
lesquelles il entend fonder un mythe nouveau”.
36
Mauss cit. in Rieusset 1987, p. 123.
37
Cfr. Rieusset (1987, p. 127): “C’est cette exigence qui a fondé son intérêt pour le
mythe, et conséquemment pour l’ethnologie. Elle est d’ordre non seulement méthodologique mais éthique” (Rieusset 1987, p. 127).
I quaderni del CREAM , 2009, IX
155
concetto di dépense. Se esso deve procedere dalla comprensione della
crisi della contemporaneità, senza negarla, né fuggirla, ma al contrario
assumendola in sé come punto di partenza, deve contenere in sé l’idea
dell’assenza e della messa in questione dell’uomo, deve rappresentare
la frammentazione e la dispersione del moderno. Esso deve rappresentare la rinuncia violenta ad ogni sapere costituito e ad ogni volontà di
dominio e costituirne anzi l’alterazione. Ad esso appartiene un’idea
d’uomo scabro, irregolare, polimorfo, caratterizzato solo in senso negativo come il “non” di una pienezza, segnato soprattutto dalla perdita
d’identità a cui è esposto. In questo senso si costituisce come un antimito nel senso che, pur godendo della potenza del mito, esso è la negazione di tutti i miti precedenti in ciò che essi hanno di positivo poiché esso è il mito della negatività pura, della perdita dell’identità,
dell’accesso ad una umanità altra della quale si conosce solo il non.
Come è noto questo anti-mito è il mito di Acéphale, il dio acefalo degli anni del Collège. Scrive Rieusset che “Georges Bataille définit
l’absence comme le seul vrai mythe, il dira: ‘il n’est pas loisible à quiconque de ne pas appartenir à mon absence de communauté. De même
l’absence de mythe est le seul mythe inévitable’”38. Su questa figura
del mito del dio acefalo si produce lo scivolamento di Bataille dall’etnologia all’antropologia poiché quello che essa mette in campo non
è più solo la questione della potenza del mito ma è la questione
dell’identità dell’uomo.
L’Acefalo è il punto di domanda posto sulla figura umana di cui
questo essere mitologico vorrebbe essere lo specchio. Se inizialmente
quell’immagine dell’uomo-dio acefalo rappresenta la possessione collettiva, ben presto, nella riflessione di Bataille, assume una funzione
totalizzante di tutta l’esperienza umana che passa sotto l’ottica tragica
della dépense. Infatti, la seconda nozione chiave dell’etnologia di cui
Bataille si appropria liberamente è il sacrificio. L’uomo del mito rovesciato del contemporaneo è definito dallo logica dello scambio propria
del sacrificio, nel senso che esso è sacrificatore e sacrificato, carnefice
e vittima poiché il sacrificio a cui è chiamato dalla crisi della contemporaneità è quello della perdita di se stesso perché nella contemporaneità non sono solo gli altri ad essere divenuti degli ibridi, ma, per effetto del ribaltamento, lo sono anch’io, perché il mondo intero è sotto
38
Rieusset 1987, p. 123.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
156
effetto di ibridazione. Entrare nel gioco delle ibridazioni significa perdere se stessi e la certezza del proprio sapere. Ma volerlo perdere consapevolmente, significa aprire la strada per un’epistemologia rinnovata, che si basa non sulla certezza ma sulla differenza. L’ibrido batailliano, che si assesta sulla zona di confine in cui la perdita del proprio
coincide ancora con l’acquisizione in negativo dell’altro, è da intendere come il risultato del sacrificio più grande, quello dell’identità della
figura umana. Bataille cerca nel dato etnografico e nell’esotico, nello
strano in senso largo, tutti i motivi grotteschi, scioccanti, violenti, comici, mostruosi, curiosi o semplicemente culturalmente altri che possano snaturare l’idea di una natura umana univoca e universalmente
identica per aprirla ad una messa in questione radicale e, quindi, porla
sotto il dominio negativo del dio acefalo. In questo senso indichiamo
nell’ibrido un altro modo per intendere il senza patria e senza padre
nietzschiano che Bataille reinterpreta nel mito dell’acefalo.39 Carlo
Pasi sottolinea che Acéphale rappresenta il mito dell’espulsione del
padre, la liberazione dal padre dopo che era stato incorporato come
principio dell’identificazione.40 E in questo senso vi sarebbe continuità
tra l’essere senza padre e l’essere senza patria, l’essere apolide e il ricercare un’identità ibrida che caratterizza buona parte della cultura
della crisi. La liberazione dall’uno coincide con l’estraneità all’altra.
Tuttavia, l’ibrido dice qualcosa di più. Esso è una figura più rappresentativa della crisi poiché frutto del sacrificio di sé, è il luogo di una
negatività, di una distanza dal proprio, in cui si dà quella compenetrazione tra dimensioni diverse, tra elementi eterogenei, che caratterizza
l’epoca della crisi. E l’impatto della scienza etnografica sulla cultura
occidentale mette in evidenza che la compenetrazione stessa, che altera e confonde il proprio, determina la messa in crisi continua dell’identità. Nell’ibrido non si dà solo una presa di distanza rispetto ad
un luogo di appartenenza, un semplice decentramento, ma invece una
doppia non-appartenenza, e quindi una doppia distanza, nella quale si
danno delle identità alterate in cui l’idea stessa di centro non ha più
senso. In questo senso esso è l’esperienza vissuta della crisi del moderno poiché è una forma d’esistenza che ospita in sé tutte le negativi-
39
40
Mi riferisco all’aforisma 377 della Gaia scianza intitolato Noi senza patria.
Pasi 1987, pp. 104 e 107.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
157
tà che la alterano, la decentrano rispetto a sé, la ricompongono in modo eccentrico e, al tempo stesso, la disfano.41
Di scivolamento in scivolamento, allora, con l’ibrido come figura
della differenza, nuova e critica, nata dalla compenetrazione di elementi eterogenei, arriviamo a definire i principi dell’eterologia batailliana come “mélanges inassimilables”42. Con quest’idea dell’ibrido
come miscuglio di elementi inassimilabili che dà l’esperienza dell’eterogeneo, allora, possiamo comprendere il desiderio di Bataille di
“divenire sciamano” e proporla alla riflessione come modalità possibile per la comprensione dell’identità ibrida. Divenire sciamano studiando lo sciamanismo significa abbandonare il terreno del sapere per
conoscere più da vicino, senza mediazione, l’esperienza dell’identità
ibrida. Significa scegliere a favore dell’alterazione di sé, cioè voler fare l’esperienza di un’alterità nella quale si coglie una particolare importanza per la definizione della propria identità, e per la propria esistenza.43 L’ibrido, per Bataille, non è il modello dell’etnografo che
mantiene la distanza rispetto a ciò che studia ma è un soggetto che nasce proprio nello sforzo dell’annullamento della distanza dall’altro,
assumendolo su di sé, lasciando che l’altro lo invada, facendone il
41
È utile per comprendere la contiguità dell’esistenza dell’ibrido con la crisi
dell’occidente il pensiero di Warin (1994, pp. 313 e 314): “L’européen est aujourd’hui
celui qui a renoncé au pathos de l’autenticité, qui a renoncé a avoir un style propre (...)
L’homme moderne, ou comme on dit aujourd’hui ‘post-moderne’ est un homme ‘sans
qualité’, il n’est rien par lui même et, pour cette raison (...) il est (...) apte à jouer tous
les rôles”. E Bataille si inserisce su questa congiuntura epocale in modo originale: “ il
ne restait donc à Bataille qu’à répéter celui qui mit fin au mythe de l’exemplarité et fit
de l’irresponsabilité une conquête et une victoire”.
42
Come scrive Francis Marmande conosciamo “leur dynamique propre qui ne repose
pas sur le goût contrariant de l’envers du goût commun, mais sur les mélanges
inassimilables” (Marmande 1987, p.23).
43
Cfr.: “Le chaman incarne à ses yeux la volonté de puissance, celle de la magie qui
est une attitude d’insoumission de la communauté à l’égard des dieux. (...) [Mais] le
chaman n’occupe pas autant une position hiérarchique. Marginal, le chaman détermine une structure sociale qui règle son équilibre à partir de cette dépense qu’il
incarne, au lieu de se polariser autour d’un centre, d’un chef” (Rieusset 1987, p. 125).
Bataille propende per lo sciamano perché nella sua idea la società sciamanica rappresenta quella che più s’avvicina alla sua idea di una società acefala. Bataille vuole
incarnare la sua concezione dello sciamano, lo vuole rendere attuale nella sua stessa
esistenza, poiché il mito acefalo a cui essa appartiene e su cui conta di fondare un’etica
nuova, per lui esiste pienamente e autenticamente solo nella sua attualizzazione
I quaderni del CREAM , 2009, IX
158
proprio vissuto, nell’intenzione innanzitutto di estraniare sé da se stesso
per fare posto ad altri sé possibili, in uno sforzo autoriflessivo continuo,
non astrattamente speculativo, ma a partire dall’esperienza che mette
capo ad una interminabile messa in discussione che deve fare da paradossale fondamento per una vera epistemologia dell’alterità.
In questo senso, l’originalità della riflessione batailliana sull’esotico risiede nel fatto che quello che Bataille mette in atto negli anni tra
Documents a Acéphale è uno studio antropologico da condursi attraverso gli strumenti dell’etnologia di sé secondo la bella espressione di
Michel Blais. L’esotismo, per Bataille, è sempre più vicino di quanto
non si pensi.44 Il suo essere dis-appropriato ai territori dell’esotico,
nella sua riflessione antropologica è il segno dell’intenzione etica che
lo porta a rivolgere innanzitutto su di sé lo sguardo dell’etnografo per
dislocarsi rispetto alle sue certezze e porsi innanzi tutto come domanda aperta, enigma senza soluzione. L’ibrido è il prodotto del ritorno
sul soggetto della forma del fascinoso enigma dell’esotico.45
È una scienza particolare, allora, quella che Bataille sta cercando di
edificare attraverso la sua frequentazione dell’etnologia denominandola non-sapere, al tempo stesso una forma di sapere paragonabile ad
altre e “sapere di un non” che contiene in sé la sua negazione. È una
“eterologia” che, se nasce come scienza dell’eterogeneo in generale,
connotandosi cioè per i suoi contenuti, si precisa sempre più come una
forma eterologica di sapere, connotandosi quindi per i suoi metodi e la
44
Se è vero, come dice Lecoq (1987, p. 111), che la posizione di Bataille “consiste en
pratique à énoncer la présence de l’irrationnel au sein du rationnel. (...) Et cela se
vérifie particulièrement dans l’usage qu’il fait des informations ou théories ethnologiques”, il primo oggetto di interesse della sua riflessione a cui applicare le
informazioni e le teorie etnologiche, è sempre lui stesso.
45
Spiega questa dinamica Blais (1987, pp. 142-143): “L’inspectant et l’inspecté sont
l’un et l’autre l’homme sauvage, vierge, premier, innocent, nu d’avant la découverte
tragique du dénuement (...) Relation d’aller loin de soi et de retour sur soi. Georges
Bataille sera donc son propre ethnologue, dans une relation de parade et de mascarade
(...) Cette étude intransitive-intransigeante, au-dehors et au-dedans de cet homme-Janus
(...) Où se situe alors l’identité? Où gît cachée la connaissance? (...) Dans cette absence
de références qui rassurent, de sens qui oriente, cet innommable (parce qu’inconnu) en
appelle aussitôt au pro-nominal: c’est dire combien l’ardent désir de cet autre si étrange
intime l’ordre de retourner l’arme (ethnologique) contre soi (...) Mais enfin, qu’est-ce
que l’ethnologie? (...) C’est l’art de se mettre en perspective par rapport à l’exotisme (...)
En ce sens, Georges Bataille ne peut qu’avoir un désir ethnologique”.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
159
particolare forma di sapere cui mette capo, che investe soprattutto ciò
che l’uomo sa di sé e le modalità secondo cui conosce. Il contatto con
l’alterità dei contenuti, dà l’avvio alla ricerca di una alterità delle forma del sapere.
Se, come dice Rieusset, Bataille, attraverso lo studio del mito, si
sposta dall’etnologia all’antropologia, l’approdo a cui perviene con il
suo attraversamento eterogeneo dell’etnografia, è una “anthropologie
déchirée”46, antropologia della crisi del moderno che sa dare conto
della differenza e della morte con la quale, come sostiene Lala, la
scienza è introdotta immediatamente nel dominio non metafisico dell’umano, dove s’apre alla conoscenza un “domaine nouveau” nel quale vi è una “mise en valeur des possibles de l’homme”, a partire dagli
“effets du non-savoir”47.
Che cos’è allora lo sciamano per Bataille, cosa rappresenta per la
sua riflessione? E cosa significa il suo desiderio di “divenire sciamano”? Lo sciamano è una figura ibrida, “esotica” in senso ampio, è
una delle “figure del nulla”, del mio nulla, del non-sapere, della mia
crisi del sapere, che rappresenta una logica altra e un’altra forma di
esistenza. Per conoscere in profondità tutto il suo senso bisogna innanzi tutto annullare la distanza tra lui e me accettando e accentuando
come chance, continua apertura, quanto di precarietà del sapere si viene così a produrre. Ma è questo il senso profondo della scienza eterologica che Bataille andava costruendo in quegli anni cruciali.
46
Lala 1987, p. 196.
Cfr. Lala 1987, p. 196: “La pensée de Georges Bataille procède de sa capacité à
faire surgir du problème de la mort (...) les contenus qui en coulent. Il n’y a ni
fascination, ni répétition vaine d’un point de vide, mais au contraire mise en valeur
des possibles de l’homme. Un domaine nouveau s’ouvre à la connaissance à partir des
effets du non-savoir. A la place des idéologies et des religions, la science est introduite dans le domaine de l’humain”.
47
I quaderni del CREAM , 2009, IX
160
Bibliografia
Barthes R. 1974, Les sorties du texte, AA.VV., Bataille, Union Générale
d’Editions, Paris.
Bataille G. 1977, La guerra e la filosofia del sacro, R. Callois, L’uomo e il sacro,
Bollati Boringhieri, Torino.
Benjanin W. 1962, Angelus Novus, Einaudi, Torino.
Blanchot M. 1959, L’entretient infini, Gallimard, Paris; trad. it. 1977, L’infinito
intrattenimento. Scritti sull’insensato gioco di scrivere, Einaudi, Torino.
Callois R. 1950, L’Homme et le sacré, Gallimard, Paris; trad. it. 2001, L’uomo e il
sacro, Bollati Boringhieri, Torino.
Clifford J. 1988, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography,
Letterature and Art, Harvard University Press, Cambridge (Mass.); trad. it.
1993, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX,
Bollati Boringhieri, Torino.
Freud S. 1919, Das Unheimliche, Gesammelte Werke, Fischer, Frankfurt a.M.
Godelier M. 1987, L’endroit d’où il nous parle, D. Lecoq, J.-L. Lory (a cura di),
Ecrits d’ailleurs. Georges Bataille et les ethnologues, Éditions de la Maison
de Sciences de l’Homme, Paris.
Grassi C. 1998, Il non-sapere. Georges Bataille sociologo della conoscenza, Costa & Nolan, Milano.
Jamin J. 1980, Un sacré collège ou les apprentis sorciers de la sociologie, Cahier
internationaux de sociologie, n. 68.
Lala M.-C. 1987, Incidences de l’impossible sur la pensée de Georges Bataille
face à l’oeuvre de la mort, D. Lecoq, J.-L. Lory (a cura di), Ecrits d’ailleurs.
Georges Bataille et les ethnologues, Éditions de la Maison de Sciences de
l’Homme, Paris.
Lecoq D. 1987, L’œil de l’ethnologie sous le dent de l’écrivan, D. Lecoq, J.-L.
Lory (a cura di), Ecrits d’ailleurs. Georges Bataille et les ethnologues, Éditions de la Maison de Sciences de l’Homme, Paris.
Leiris M. 1930, L’œil de l’etnhographe, Documents, vol. II, n. 7.
Leiris M. 1985, Langage tangage, Gallimard, Paris.
Lévinas E. 1947, De l’existence à l’existant, Éditions de la Revue Fontaine, Paris.
Marmande F. 1987, Georges Bataille: le motif atzèque, D. Lecoq, J.-L. Lory (a
cura di), Ecrits d’ailleurs. Georges Bataille et les ethnologues, Éditions de la
Maison de Sciences de l’Homme, Paris.
Pasi C. 1987, L’hétérologie e Acéphale. Dal fantasma al mito, J. Risset (a cura
di), Il politico e il sacro, Liguori, Napoli.
Remotti F. 1998, Per un’antropologia della storia. Apporti di Walter Benjamin, S.
Borutti, U. Fabietti (a cura di), Fra antropologia e storia, Mursia, Milano.
Rieusset I. 1987, Le Collège de Sociologie: Georges Bataille et la question du
mythe, de l’ethnologie à l’anthropologie: un décentrement épistémologique,
I quaderni del CREAM , 2009, IX
161
D. Lecoq, J.-L. Lory (a cura di), Ecrits d’ailleurs. Georges Bataille et les ethnologues, Éditions de la Maison de Sciences de l’Homme, Paris.
Roche A. 1998, Simone Weil et l’anthropologie des années trente: une «rencontre
manquée», C. Jacquier (a cura di), Simone Weil, l’expérience de la vie et le
travail de la pensée, Sulliver, Arles, pp. 175-194.
Ronchi R. 1985, La realtà e la sua ombra, Nuova Corrente, vol. XXXII, n. 95.
Segalen V. 1995, Essai sur l’esotisme, Œuvres Complètes, Éditions Laffont, Paris.
Sereni V. 1975, Gli strumenti umani, Einaudi, Torino.
Todorov T. 1982, La conquête de l’Amérique – La question de l’autre, Éditions
du Seuil, Paris; trad. it. 1992, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Einaudi, Torino.
Warin F. 1994, Nietzsche et Bataille – La parodie à l’infini, Presses Universitaires de France, Paris.
I quaderni del CREAM , 2009, IX
162
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
CENTRO DI RICERCHE ETNO-ANTROPOLOGICHE MILANO
I QUADERNI DEL CREAM
2004 – I
Jack Goody, The Taliban, the Bamiyan and Us. The Islamic Other.
Emanuela Guano, A passeggio per la Boca. Geografia simbolica ed esperienza dello spazio in un
quartiere di Buenos Aires.
Sergio F. Ferretti e Mundicarmo M. R. Ferretti, La trance nelle religioni afro-brasiliane del Maranhão.
Mauro Van Aken, Dances out of Place: Palestinian Dabkeh in the Jordan Valley (Jordan).
Maria Grazia Riva, Aspetti “formativi” della cooperazione allo sviluppo.
Marco Sanlorenzo, La malattia e i suoi attori tra la popolazione Bara.
2004 – II
Tullio Seppilli, La funzione critica dell’antropologia medica:temi, problemi, prospettive.
Romano Mastromattei, Il governo ombra del Nepal.
Ildàsio Tavares, La liturgia della sopravvivenza negra.
Roberto Malighetti, Emergenza come fine dello sviluppo. Le alternative dei favelados di Rio de Janeiro.
Manuela Tassan, La cultura dell’ambiente nelle politiche di sviluppo della FAO.
2005 –III
Marc Augé, Culture et religion.
Ugo Fabietti, Foucault, l’antropologia, l’Islam.
Denis Gay, The Policy of the Religious Centre in Bombay. Toward a Gujarati Community of Madagascar.
Cecilia Guidetti, Maternità e migrazione.
Alessandra Gribaldo, Natura e tecnologia: la riproduzione nell’era delle biotecnologie.
Lorenzo Bonoli, La conoscenza dell’alterità tra urto e sorpresa.
2005 – IV
Alberto Sobrero, Descrivere il mondo per dettagli. Letteratura e scienza sociali in Balzac.
Silvia Barberani, Morti e riti di memoria in una comunità della Grecia.
Livia Napoleoni, Le guerre dimenticate: la guerriglia maoista in Nepal e la questione femminile.
Fabrizio Floris, Non-luoghi, città e ville nue.
Federica Riva, Donne, ambiente e politiche dello sviluppo nel Garhwal.
Roberto Malighetti, Merleau-Ponty's concept of the body.
2006 – V
Vincent Crapanzano, Lo scenario: oscurando il reale.
Ugo Fabietti, Sulle idee di 'esotico' e di 'esotismo': lo sguardo di un antropologo.
Mariella Pandolfi and Philippe Rousseau, Looking for Anthropos. With a little help from Pirandello’s
infinity absurdity.
Roberto Malighetti, Identities in the Quilombo of Frechal. Fieldworking in a Brazilian rural black
community.
Hashem Sedqamiz, Il tempo delle cose, il tempo degli uomini: percezione della temporalità e forme di
vita a Shiraz.
Setrag Manoukian, Cose di casa: modalità di esposizione e costruzione dei sessi a Shiraz.
2007 – VI
Editoriale di Roberto Malighetti
Renato Rosaldo, Clifford Geertz: interpretazione, voce, etiche.
Ugo Fabietti, La scomparsa di Clifford Geertz (1926-2006).
Alberto Gasanti, Pluralismo giuridico e pluralismo culturale. I diritti di cittadinanza.
Patrizio Warren, Agricoltura e ruralità nelle culture nazionali postcoloniali. Un'analisi comparativa.
Lucia Rodeghiero, Riesumazioni e definizione del suolo nazionale nella ex-Jugoslavia.
Lorenzo D'Angelo, Corpo, legge, verità. Le verità della tortura e le torture della verità.
Elisa Galli, Dai discorsi alle rappresentazioni dello sviluppo. Due progetti nel Somaliland.
2007 – VII
Luisa Faldini, Words and writing. The metabolisation of tradition in Brazilian condomblé.
Claudia Mattalucci, L'âme des peoples à évangéliser. L'usage missionnaire de quelques outils ethnologiques.
Patrizio Warren, Pax italica. Il punto di vista degli attori locali su PRODERE a Chalatenango e nell'Ixil.
Marie-Christine Lammers, Anatomia della sofferenza. Una visione contemporanea dell'ambiguità della passione a Douala.
Daniela Cherubini, La rielaborazione identitaria del movimento associativo di donne gitane in Andalusia. La prospettiva "intersezionale" nell'analisi dei processi di produzione, riproduzione e ridefinizione
dell'identità etnica.
Rossana Borretti, Violenza, emozioni e incorporazione. Etnografia di un'esperienza di malattia.
Alessandra Micoli, La stanza della memoria. La città narrata in un ecomuseo
2008 – VIII
Ibrahima Sow, Génétropisme et sanctions de l'imaginaire.
Pablo Rodríguez Ruiz, Tiempos, espacios y contextos del debate racial actual en Cuba.
Mundicarmo Rocha Ferretti, Cura e pajelança em terreiros do Maranhão (Brazil).
Manuela Tassan, Le identità della natura. Alcune questioni teorico-metodologiche nello studio antropologico della natura
Matteo Alcano, Farmaci allo specchio di Venere. Alcune considerazioni sulle terapie antiretrovirali e
sulla riappropriazione del corpo femminile.
Bruno Barba, The Magic of World. Problems of Methodology in Anthropology.
LE PUBBLICAZIONI DEL CREAM
(CENTRO DI RICERCHE ETNO-ANTROPOLOGICHE - MILANO)
1. Silvia Barberani, Sulla frontiera del Mediterraneo. Turismo e memoria a
Kastellorizo (Egeo orientale)
2004, ISBN 888839866X, pp. 248 (esaurito)
2. Beyond Borders. Anthropological and Historical Approaches to Ethnic Relations in Postsoialist Europe, ed. by D. Torsello and L. Rodeghiero. Contributors: Davide Torsello, László Öllös, Károly Tóth, Lucia Rodeghiero, Roberto Valle.
2006, ISBN 8888398724, pp. 75 - € 10,00
3. Sara Zambotti, La scuola sintonizzata. Pratiche di ascolto e immaginario tecnologico nei programmi dell’Ente Radio Rurale (1933-1940)
2007, ISBN 978888990923, pp. 114 - € 14,00
4. Modelli per le scienze umane: antropologia, scienze cognitive, sistemi
complessi, a cura di Silvana Brutti.
Maurice Bloch, Truth and Sight; Claude Calame, Modèle du code et modèle herméneutique: une “anthropopoiésis” génétique? Francesco Remotti, Perché gli antropologi non possono fare a meno della complessità? Silvana Borutti, Che cosa
l’antropologia può aspettarsi dal concetto di complessità? Ugo Fabietti, On the
meaning and role of “discovery”in anthropological research. Roberto Malighetti,
Temporalità etnografiche: autorità, autorizzazione, autore. Eleonora Montuschi,
Transdisciplinarietà e oggetti sociali.. Luca Vanzago, Transdisciplinarietà e oggetti sociali. Risposte a Eleonora Montuschi. Flavio Cassinari, Il tempo nelle scienze
umane. Tre prospettive. Irene Maffi, Per una difesa dell’incontro etnografico come
fonte della comprensione tra culture.
2007, ISBN 978-88-89909 256, pp. 172 - € 18,00
5. Simona Vittorini, Rituals, Symbols and Politics of Indian Nationalism
2009, ISBN 9788889909461, pp. 260 - € 18,00
Stampato presso Maja - Torino