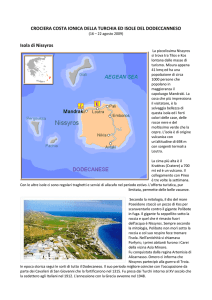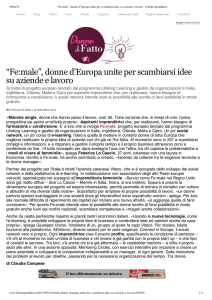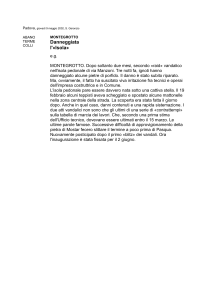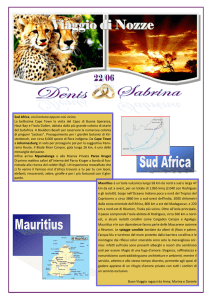40
L’OPINIONE
Nestore, il matelico
e altri tipi siciliani
uanti siciliani esistono
e si contendono il
campo nella terra dell’isola? Quanti tipi umani? Quante maschere
della vita e del dolore?
Domande. Queste, che in qualche
modo riecheggiano le intense pagine che con
impareggiabile acutezza Gesualdo Bufalino
e Leonardo Sciascia vollero dedicare a
meglio comprendere l’isola dei loro natali, a
scavarne il cuore denso di bellezza e di storia, ma sempre come intriso dal sapore di
una imminente fine, di una non revocabile
condanna.
C’è dunque il catanese, nutrito di spirito composito, insieme greco, fenicio, normanno, e perciò dotato di una “vis” personalissima, che lo conduce alla battuta mordace, all’ironia anche volgare ma sempre
tagliente come una affilatissima lama, votato alla cerca di relazioni umane autentiche
al crocevia delle quali guazzare come un
pesce nell’acqua, pure allo scopo di capire
l’altrui buona fede, l’altrui credulità e che ha
trovato nella maschera di Angelo Musco la
sua più vera e indimenticabile espressione.
C’è il palermitano che, per il catanese,
non può che darsi come “matelico”, intraducibile epiteto destinato a designare l’animo
di artistico decaduto a quella certa indolente e di se compiaciuta mollezza che gli è
spesso inconsapevole compagna, figlia palese d’un che d’arabeggiante.
C’è il siracusano, capace di battezzare
il proprio figlio – in virtù di una sopita
ascendenza – con il nome di Nestore o di
Aiace; e di farlo con estrema naturalezza,
come si trattasse di nomi di abituale e serena sobrietà, ai quali tutti possono e debbono
essere avvezzi.
C’è il girgentino, disincantato dal
mondo e dall’orizzonte che rimane sempre
troppo lontano, inavvicinabile; ed ancora,
c’è il messinese, da generazioni in attesa di
una giuntura col continente che facesse della
Q
sua città – così gli hanno giurato – un’attrazione mondiale; e il gelose, il randazzese,
l’ennese… e non si finirebbe mai, non si
potrebbe mai completare questa ricchissima
ed infinita galleria di tipi umani, segnati dal
tempo e dalla storia.
Tutti diversi, connotati in modi di
inconfondibile specificità l’uno rispetto all’altro; eppure tutti assolutamente simili, come
impastati dal senso di un’attesa e di una irrimediabile stanchezza per aver troppo atteso.
Ed è questo, a ben guardare, il tratto
umano più caratteristico della nostra genìa,
unica davvero, anche perché d’origine remota, perduta nella lontananza dei secoli, dei
millenni.
Siamo tutti diversi: a distanza di pochi
chilometri, perfino l’accento, la parlata, la
flessione dei verbi assume quasi la patente
della incomprensibilità.
Il catanese stenta a capire in pieno la
parlata del brontese e questi a malapena
intende lo stretto dialetto nisseno.
Tuttavia, l’insularità si lascia cogliere
come una dimensione che tutti ci accomuna
indissolubilmente e che tutti ci assegna al
medesimo destino di trepidante abbandono.
I tempi lontani, per le scorrerie del conquistatore di turno; oggi, in forza di una
ragione politica e sociale che non riesce a dispiegarsi come dovrebbe nel tessuto umano e
relazionale dell’isola.
Lo stesso disincanto, la stessa smaliziata rassegnazione albergano negli occhi del
contadino “strambo” – come gli ennesi appellano con una evidente punta di senso di
superiorità gli abitanti Calascibetta (da ex
“extra.urbem”) – ed in quelli dell’uomo d’affari palermitano e del professionista catanese.
E, forse, è questa la vera democrazia:
l’unica possibile. Quella di una superiore e
disincantata antropologia.
Vincenzo Vitale