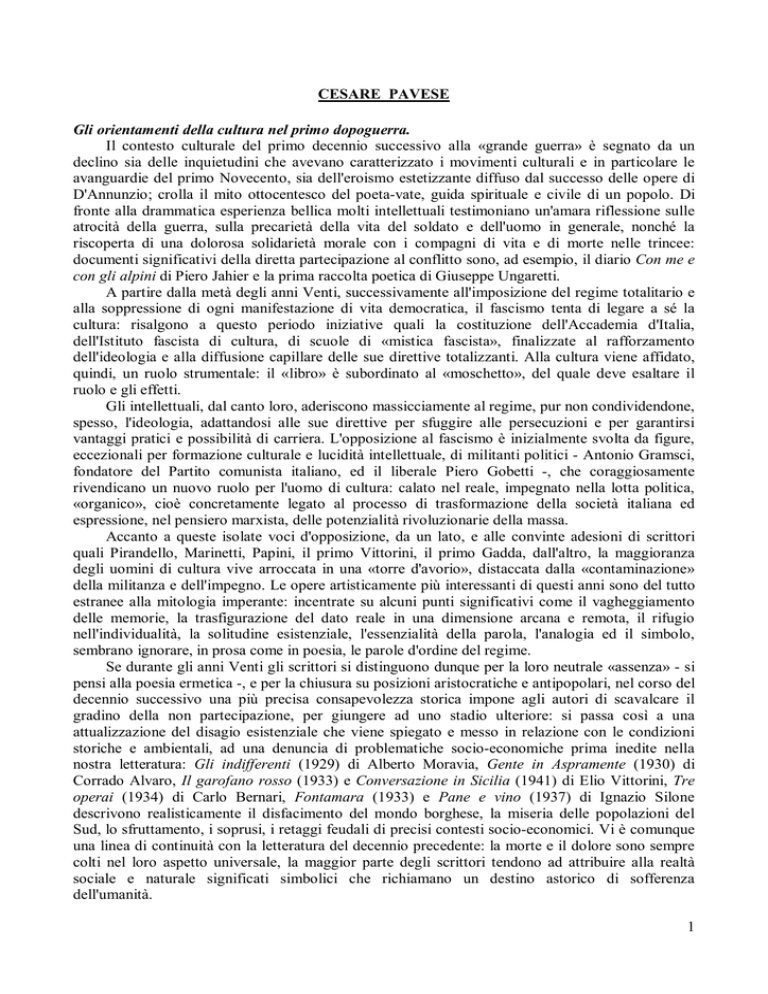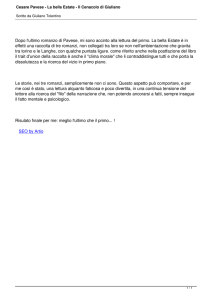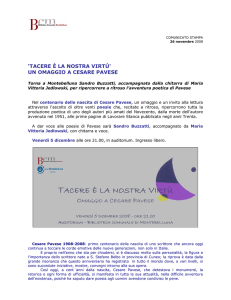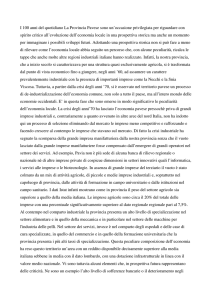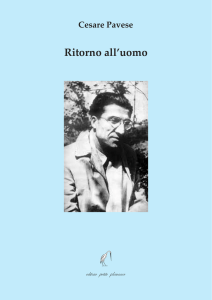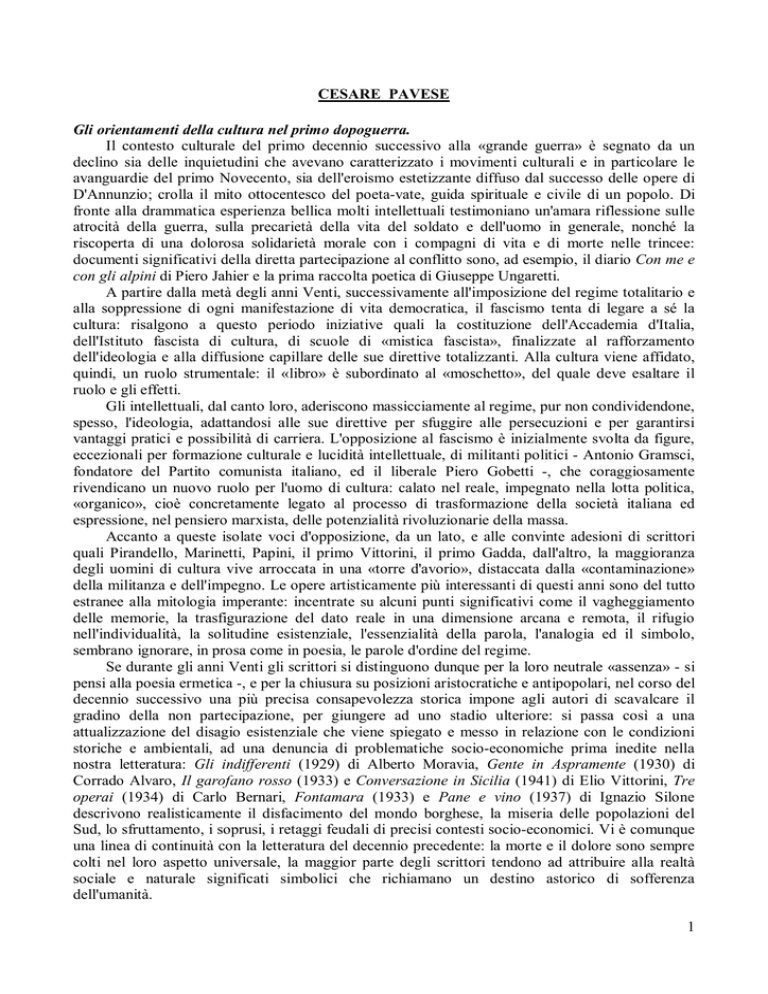
CESARE PAVESE
Gli orientamenti della cultura nel primo dopoguerra.
Il contesto culturale del primo decennio successivo alla «grande guerra» è segnato da un
declino sia delle inquietudini che avevano caratterizzato i movimenti culturali e in particolare le
avanguardie del primo Novecento, sia dell'eroismo estetizzante diffuso dal successo delle opere di
D'Annunzio; crolla il mito ottocentesco del poeta-vate, guida spirituale e civile di un popolo. Di
fronte alla drammatica esperienza bellica molti intellettuali testimoniano un'amara riflessione sulle
atrocità della guerra, sulla precarietà della vita del soldato e dell'uomo in generale, nonché la
riscoperta di una dolorosa solidarietà morale con i compagni di vita e di morte nelle trincee:
documenti significativi della diretta partecipazione al conflitto sono, ad esempio, il diario Con me e
con gli alpini di Piero Jahier e la prima raccolta poetica di Giuseppe Ungaretti.
A partire dalla metà degli anni Venti, successivamente all'imposizione del regime totalitario e
alla soppressione di ogni manifestazione di vita democratica, il fascismo tenta di legare a sé la
cultura: risalgono a questo periodo iniziative quali la costituzione dell'Accademia d'Italia,
dell'Istituto fascista di cultura, di scuole di «mistica fascista», finalizzate al rafforzamento
dell'ideologia e alla diffusione capillare delle sue direttive totalizzanti. Alla cultura viene affidato,
quindi, un ruolo strumentale: il «libro» è subordinato al «moschetto», del quale deve esaltare il
ruolo e gli effetti.
Gli intellettuali, dal canto loro, aderiscono massicciamente al regime, pur non condividendone,
spesso, l'ideologia, adattandosi alle sue direttive per sfuggire alle persecuzioni e per garantirsi
vantaggi pratici e possibilità di carriera. L'opposizione al fascismo è inizialmente svolta da figure,
eccezionali per formazione culturale e lucidità intellettuale, di militanti politici - Antonio Gramsci,
fondatore del Partito comunista italiano, ed il liberale Piero Gobetti -, che coraggiosamente
rivendicano un nuovo ruolo per l'uomo di cultura: calato nel reale, impegnato nella lotta politica,
«organico», cioè concretamente legato al processo di trasformazione della società italiana ed
espressione, nel pensiero marxista, delle potenzialità rivoluzionarie della massa.
Accanto a queste isolate voci d'opposizione, da un lato, e alle convinte adesioni di scrittori
quali Pirandello, Marinetti, Papini, il primo Vittorini, il primo Gadda, dall'altro, la maggioranza
degli uomini di cultura vive arroccata in una «torre d'avorio», distaccata dalla «contaminazione»
della militanza e dell'impegno. Le opere artisticamente più interessanti di questi anni sono del tutto
estranee alla mitologia imperante: incentrate su alcuni punti significativi come il vagheggiamento
delle memorie, la trasfigurazione del dato reale in una dimensione arcana e remota, il rifugio
nell'individualità, la solitudine esistenziale, l'essenzialità della parola, l'analogia ed il simbolo,
sembrano ignorare, in prosa come in poesia, le parole d'ordine del regime.
Se durante gli anni Venti gli scrittori si distinguono dunque per la loro neutrale «assenza» - si
pensi alla poesia ermetica -, e per la chiusura su posizioni aristocratiche e antipopolari, nel corso del
decennio successivo una più precisa consapevolezza storica impone agli autori di scavalcare il
gradino della non partecipazione, per giungere ad uno stadio ulteriore: si passa così a una
attualizzazione del disagio esistenziale che viene spiegato e messo in relazione con le condizioni
storiche e ambientali, ad una denuncia di problematiche socio-economiche prima inedite nella
nostra letteratura: Gli indifferenti (1929) di Alberto Moravia, Gente in Aspramente (1930) di
Corrado Alvaro, Il garofano rosso (1933) e Conversazione in Sicilia (1941) di Elio Vittorini, Tre
operai (1934) di Carlo Bernari, Fontamara (1933) e Pane e vino (1937) di Ignazio Silone
descrivono realisticamente il disfacimento del mondo borghese, la miseria delle popolazioni del
Sud, lo sfruttamento, i soprusi, i retaggi feudali di precisi contesti socio-economici. Vi è comunque
una linea di continuità con la letteratura del decennio precedente: la morte e il dolore sono sempre
colti nel loro aspetto universale, la maggior parte degli scrittori tendono ad attribuire alla realtà
sociale e naturale significati simbolici che richiamano un destino astorico di sofferenza
dell'umanità.
1
La ripresa del gusto narrativo
La nuova concezione della letteratura presente nel terzo decennio del secolo si attua anche
grazie ad una ripresa del gusto narrativo che vede come motore propulsore «Solaria», rivista
fiorentina sorta nel 1926, avente come progetto la sprovincializzazione della letteratura nazionale,
attraverso la conoscenza delle opere di autori ignorati dalla cultura ufficiale come Franz Kafka,
Marcel Proust, James Joyce, Italo Svevo e Federigo Tozzi; programma caratterizzato dalla tendenza
ad una narrativa lirica, nella quale la memoria e l'indagine psicologica sono però finalizzate a far
emergere una realtà dinamica, frammentata, problematica. La narrativa si allontana dalla
trascrizione oggettiva del mondo, caratteristica del realismo ottocentesco, per rivolgersi ad una
descrizione critica della realtà: la scrittura tende a rappresentare non gli oggetti ma il vissuto che
conferisce agli oggetti un valore soggettivo, psicologico. L'intento dell'autore non è più quello di
descrivere personaggi e costruire trame, bensì quello di far emergere atmosfere, stati d'animo,
ambienti, conflitti. Ne derivano la predilezione per figure adolescenziali, simboli del tormentato
rapporto io-realtà interiore, individuo-società, e la volontà di descrivere le trasformazioni in atto
presenti nella società, rivolgendo lo sguardo anche alle realtà periferiche, tentando però
costantemente di rapportarsi ad un orizzonte più ampio, nazionale ed internazionale. Tale attenzione
critica alla realtà costituisce il fondamento della contemporanea letteratura europea ed americana;
quest'ultima proprio dalla seconda metà degli anni Trenta viene introdotta in Italia grazie alle
traduzioni e alle riflessioni di Pavese e Vittorini.
L'influenza della letteratura americana
L' ideologia fascista, nel nome della tradizione e della romanità, promuove una letteratura
vincolata ad una rigida chiusura nei confronti delle altre culture, rifiutando la diffusione e la
suggestione delle produzioni straniere: l'Italia vive di una cultura asfittica e provinciale. Le
innovative esperienze di autori stranieri quali Proust, Joyce, Kafka, Freud, gli espressionisti
tedeschi sono quasi del tutto ignorate in Italia, nonostante riviste importanti, come appunto
«Solaria», tentino una sprovincializzazione della nostra letteratura, per un'apertura verso una
dimensione europea.
Alla fine degli anni Venti, quando ormai si sono tristemente dissolte tutte le incertezze
sull'atteggiamento repressivo e coercitivo del regime, alcuni giovani intellettuali cercano di
restituire una funzione attiva alla cultura, conferendole un significato morale e civile.
La lenta diffusione delle contemporanee letterature straniere svela il totale isolamento della cultura
italiana, fossilizzata ed ancorata alla tradizione classica, rispetto alla vitalità e ai fermenti innovativi
di altri Stati. Di fondamentale importanza è l'ingresso nel nostro paese della produzione americana,
di cui si tenta in questi anni una prima divulgazione: le opere di Ernest Hemingway, Sherwood
Anderson, John Dos Passos, William Faulkner, Sinclair Lewis propongono nuove tematiche, nuove
tecniche narrative, nuove modalità espressive, nuove possibilità di approccio critico alla realtà,
trasmettendo l'immagine di una società e di una cultura vitali, primitive, sanguigne, libere, selvagge,
di una letteratura «pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve di tutto il passato
del mondo e insieme giovane e innocente» - come afferma Pavese. Le operazioni editoriali di
Pavese e Vittorini che proponevano il mito dell'America degli «anni ruggenti», degli eroi ribelli ed
anticonformisti, furono bloccate dal regime fascista, consapevole delle potenzialità eversive di
queste proposte. Ma la diffusione della cultura statunitense, esempio di arte realistica, dinamica,
democratica, sortisce effetti ben più durevoli e profondi, indirizzando gli autori italiani verso una
letteratura meno arida e conformistica, additando la strada dell'impegno (engagement, lo
chiameranno i francesi), verso una concreta riflessione morale e sociale sulla dignità umana, sul
valore della libertà, che non di rado assume i toni di un'aperta denuncia.
La tendenza al reale e l'estetica dell'impegno
Il dramma della seconda guerra mondiale, la partecipazione delle masse alla Resistenza, le
condizioni di vita per molti miserevoli alla fine del conflitto e, nonostante questo, il clima di
2
speranza per un nuovo corso della situazione sociale e politica, orientano gli intellettuali sempre più
verso un'estetica dell'impegno; discussioni e polemiche si sviluppano sulle riviste e sulle
pubblicazioni, l'attività editoriale diviene ben presto frenetica, quasi attraversata dall'urgenza di
riguadagnare il tempo perduto nel ventennio fascista (fondamentale l'opera della casa editrice
Einaudi e di Pavese che ne è uno dei massimi responsabili). Vengono messe sotto accusa la
letteratura e la cultura decadenti, la posizione dell'artista disinteressato, distante dalla realtà, dalla
vita del popolo; il giudizio di condanna nei confronti della cultura precedente è soprattutto motivato
dal fatto che essa era apparsa incapace di opporsi al fascismo, incentrata com'era sulle
problematiche esistenziali del singolo: non aveva colto l'importanza, per la stessa vita del singolo,
di rapportarsi ai problemi della collettività.
La tendenza realistica si accompagna ad una fiducia illimitata nella possibilità di istituire un
rapporto di solidarietà autentico tra gli uomini: sembra che la vita possa, come scriverà Calvino,
«ricominciare da zero», aperta a un dialogo appassionato tra uomo e uomo.
In Francia il filosofo e scrittore francese Jean Paul Sartre superava la «nausea» e l'assurdità
dell'esistenza quotidiana, proponendo dalle pagine di una sua rivista, «Tempi moderni», la
necessità, per l'intellettuale, dell'azione, della scelta della responsabilità politica, in una parola la
necessità di una cultura militante in grado di «concorrere a produrre certi mutamenti nella società».
«Il Politecnico»
In Italia tale concezione è resa esplicita dalla nascita, a Milano, della rivista «II Politecnico»,
diretta dal 1945 al 1947 da Elio Vittorini, che si propone il compito di dare voce proprio agli
intellettuali «impegnati». Non a caso, accanto a tematiche meramente letterarie (si ricordino la
pubblicazione a puntate del romanzo Per chi suona la campana di Emest Hemingway, la
divulgazione di testi di poeti, come Thomas Eliot, e filosofi, come Jean Paul Sartre, stranieri), la
rivista affronta anche problematiche politiche come le inchieste sulla Fiat, sulla Montecatini,
l'intervista al segretario della Cgil, i servizi sulla scuola. Vittorini, e con lui gli scrittori
«progressisti», erano convinti assertori del ruolo di una nuova cultura che rigettasse la «torre
d'avorio», la concezione dell'artista neutrale, e che fosse invece impegnata nella trasformazione del
reale, nel tentativo di farsi interprete delle masse lavoratrici e guida della ricostruzione democratica
del paese.
Tale azione, se coincideva con quella svolta dalle forze di sinistra, in realtà rovesciava
radicalmente il rapporto politica/attività culturale quale era concepito dalla linea ideologica del
Partito comunista ed in particolare da quella del suo segretario nazionale, Palmiro Togliatti. Per
Vittorini è la cultura a fare la storia, non la politica; la politica viene confinata entro i limiti della
cronaca; per Togliatti è impossibile separare l'azione culturale dalla politica, poiché entrambe si
muovono nella storia.
Lo scontro su questo fondamentale punto si fece aspro: ai redattori del «Politecnico»,
soprattutto dopo la trasformazione del foglio in mensile ed il suo avvicinarsi a temi esclusivamente
culturali (psicoanalisi, esistenzialismo, ecc.), i dirigenti comunisti rimproveravano anche la volontà
di affermare una cultura enciclopedica, la tendenza a ricercare il diverso, il sorprendente, in
sostanza la «generica ricerca del nuovo», che dal punto di vista del Pci non corrispondeva
all'impegno che la politica chiedeva agli intellettuali e non poteva essere in grado di rompere
definitivamente con una tradizione falsamente rivoluzionaria, quale era stata quella dei movimenti
culturali del primo Novecento.
Alla fine, dopo la Lettera a Togliatti (nella quale Vittorini ribadiva l'idea che solo una cultura
autonoma può essere in grado di arricchire la politica e non certo una cultura subordinata alle
direttive del partito, tale da portare l'intellettuale a non essere altro che il «piffero della
rivoluzione», «II Politecnico», che dipendeva fin dall'inizio dal Partito comunista per la diffusione e
la distribuzione, cessava le sue pubblicazioni.
Rimaneva comunque forte sia la resistenza di molti intellettuali progressisti ad allinearsi a
prospettive rigorosamente classiste, sia soprattutto l'esigenza di una nuova cultura realistica e
popolare che fosse in grado, come aveva affermato Giaime Pintor, «di contribuire alla liberazione di
3
tutti».
Il Neorealismo
Il Neorealismo fu soprattutto questo (anche se non è facile, data la molteplicità di esperienze e
di atteggiamenti, indicarne l'estensione e i confini): esigenza di dare il massimo rilievo alla realtà
sociale e politica, ai fenomeni collettivi, da sempre esclusi dalla cultura. La letteratura (ma ciò
accadde anche alle arti figurative e soprattutto al cinema) dal 1945 alla fine degli anni Cinquanta fu
caratterizzata da una vera e propria «fame di realtà», da una nuova presa di contatto con il «reale»:
nuova perché il reale non era più, come nella letteratura degli anni Trenta e Quaranta, contemplato,
bensì veniva raccontato a partire da fatti vissuti direttamente dall'autore (la guerra, la Resistenza,
l'ingiustizia, la morte, la fame, la questione meridionale) nel tentativo di ricavarne stimoli atti a
costruire una società rinnovata.
Raccontare questa realtà significò per molti pensare di aver superato l'orto chiuso della
letteratura, la «torre d'avorio» di una cultura in qualche modo responsabile di non aver saputo
impedire il fascismo e la guerra; significò anche dare corpo al sogno utopistico di un'umanità
nuova, più libera e più felice. Artisti, scrittori e registi cercheranno le «nuove parole», come le
chiamava Pavese, in grado di dare voce a quest'umanità, al proletariato urbano e contadino, agli
uomini e alle donne di un'Italia umile e minore. Dalle pagine dei romanzi (di Elio Vittorini, Cesare
Pavese, Beppe Fenoglio, Giuseppe Berto, Renata Viganò, Italo Calvino, Vasco Pratolini, Carlo e
Primo Levi), dalle scene dei film (ad esempio Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, o Roma città
aperta, e Sciuscià di Roberto Rossellini) emergerà la voce di un popolo che sembra raccontare se
stesso.
In letteratura tale risultato è reso possibile dallo sforzo di identificazione compiuto dall'autore
nei confronti del personaggio e di liberazione dalla lingua astratta, cifrata, utilizzando sia il modello
verghiano, sia quello della narrativa americana (peraltro filtrato da Pavese e Vittorini), al fine di
pervenire ad un linguaggio immediato, parlato, in grado di amalgamare il dialetto, la lingua
letteraria, l'italiano regionale.
Pavese e il romanzo italiano del Novecento
Pavese continua ad essere uno degli autori più amati della nostra letteratura e lo è oggi per un
motivo opposto a quello che fece la sua fortuna durante gli anni Quaranta. Pavese, infatti, era stato
ammirato dai suoi contemporanei sia perché sembrava aver anticipato con Paesi tuoi (1939) il
linguaggio, lo stile, i contenuti della letteratura neorealistica, sia per il suo ruolo di intellettuale
«impegnato», che aveva contribuito prima a svecchiare la letteratura italiana attraverso la scoperta
degli scrittori americani e poi ad immettere argomenti e problematiche nuovi per la nostra cultura
(etnologia, antropologia) attraverso il ruolo di responsabile di diverse collane per la casa editrice
Einaudi.
Oggi invece il fascino che Pavese esercita anche, e forse soprattutto, sui giovani deriva da
quello che le sue opere realmente descrivono: la figura dell'uomo diviso dalla contraddizione tra
esistenza individuale e collettività, tra l'attrazione esercitata dalla solitudine, dal passato mitico, e la
volontà di comunicare con gli altri, di agire nel presente per modificarlo.
In effetti, lo scrittore era lontanissimo sia dai presupposti ideologici del Neorealismo, dalla sua
volontà di documentare e trasformare la realtà sociale e politica, dalla sua enfatizzazione dei valori
affermati dalla Resistenza, sia dalla figura di intellettuale attento alle potenzialità rivoluzionane del
popolo.
Questo non significa che Pavese non sia un realista. Anzi, Pavese era stato attratto dalla
letteratura americana proprio per quel linguaggio diretto e antiletterario che la animava, per la
schiettezza, la «franchezza», dirà, con la quale essa aderiva alle cose, alle situazioni definite in uno
spazio e in un tempo circoscritto. Ma una narrativa di questo genere era ammirata da Pavese perché
in essa, come ebbe modo di dire, «veniva recitato il dramma di tutti». E’ questo riferimento
all'universale condizione dell'uomo che lo rende distante dalle posizioni neorealistiche «ufficiali».
Per Pavese, ma anche per il realismo italiano degli anni Trenta e Quaranta e per molti scrittori
4
definiti «neorealisti», la rappresentazione di una realtà locale (le colline delle Langhe, le piazze e le
strade di Torino) funge da simbolo di una verità più vasta che riguarda tutti gli uomini, simbolo,
appunto, del «dramma di tutti».
Come si vede, è un realismo che si esplicita nell'unione di concretezza e di universalità, un
realismo profondamente connesso al simbolismo. La descrizione di una realtà concreta e di un
tempo circoscritto al presente serve allo scrittore per estrarre da quei particolari concreti e da quel
presente una verità perenne, fuori del tempo e dello spazio.
Questa impostazione rimane una costante della narrazione pavesiana; non è un caso che quando
Pavese tenta di uscire da una rappresentazione simbolica, da una rappresentazione cioè che
costantemente richiama l'universale, non riesce a costruire una scrittura viva (per esempio nella
stesura de Il compagno, pubblicato nel 1947), così come accade del resto anche a Vittorini (ad
esempio nel romanzo resistenziale Uomini e no).
In Pavese, come per i più grandi scrittori realisti della prima metà del Novecento (Vittorini e
Fenoglio) il Neorealismo costituisce solo uno sfondo, un ambito di riferimento denso di
problematiche e discussioni. In questo senso si spiega la contraddizione insanabile tra l'intellettuale
Pavese impegnato politicamente (dopo il '45, quando si iscriverà al Pci) e lo scrittore Pavese che
non dà voce a questo stesso impegno (così come si spiega la rottura tra Vittorini e Togliatti e
l'isolamento volontario di Fenoglio): si tratta di una contraddizione che non permette di collocare la
sua opera in un movimento, di etichettarla, e che è presente nell'uomo Pavese prima che nell'opera,
in un uomo che chiuderà la sua vita con il suicidio.
Quella contraddizione irrisolta, che determinò la sconfitta pavesiana, ha contribuito a
formulare nei confronti della sua opera l'accusa, da parte della critica marxista, di «decadentismo»,
con la quale si indicava una narrativa più attenta ai conflitti intimi della coscienza e del sentimento
che ai conflitti reali della società e della storia;un'accusa che non ha permesso per decenni di
cogliere adeguatamente il realismo pavesiano.
Perché, a ben vedere, tale contraddizione irrisolta, oltre che esistenziale, deriva dalla stessa
formazione letteraria pavesiana. Di fatto il realismo pavesiano nasce e si sviluppa in un contesto
(quello degli anni Trenta) nel quale risulta impossibile delineare una linea discriminante tra
romanzo decadente e romanzo realistico-oggettivo, tra evocazione memoriale, mitica, e
rappresentazione di tematiche sociali.
Nella narrazione pavesiana quella contraddizione trova spesso un felice equilibrio grazie allo
stile, che alterna il dialogo al monologo inferiore e all'evocazione memoriale (attraverso la tecnica
del flashback) e grazie anche alla psicologia dei personaggi, che viene risolta in una
rappresentazione che rende i personaggi «tipi», simboli dell'umanità.
Pavese è consapevole che la realtà è caos, violenza, mistero e che la letteratura crea immagini
basandosi sì su quella realtà definita dal momento storico a cui appartiene, ma tentando
costantemente di muoversi al di là di essa, affinché quelle immagini diventino simboli in grado di
esprimere la natura perenne dell'uomo: il realismo pavesiano, mentre si impegna nella
rappresentazione del reale, mette sempre in luce le potenzialità simboliche della realtà.
Per Pavese la parola non è un mezzo di registrazione del reale, così come l'opera d'arte non
può essere semplice denuncia o testimonianza di una situazione sociale: egli è consapevole
dell'azione fondamentale svolta dallo scrittore nella riproduzione del reale. Questo assunto gli
permette di sfuggire al pericolo, in cui cadranno molti scrittori del Neorealismo, di una trascrizione
quasi cronachistica della realtà. Pavese, come lui stesso afferma, ricerca «una realtà non
naturalistica ma simbolica», in cui i gesti, gli eventi, accadono «non perché così vuole la realtà, ma
perché così decide l'intelligenza»: in questo modo i gesti, gli eventi, assumono un valore universale
«che li solleva fuori dal tempo».
Pavese oggi
“Insieme a Vittorini, Pavese ha svolto un ruolo essenziale nel passaggio tra la cultura degli anni
Trenta e la nuova cultura democratica del dopoguerra: ha rivolto un’attenzione alla realtà popolare e
contadina che ha avuto essenziale risonanza negli anni del Neorealismo; è stato un grande operatore
5
culturale, che ha mediato aspetti ed esperienze della cultura europea ed americana, estranei
all’idealismo da noi dominante; ha vissuto in pieno la stagione dell’impegno nel partito comunista.
A lui e alla sua opera si è guardato a lungo, da parte della cultura di sinistra, soprattutto in rapporto
alla sua figura di ‘intellettuale’. Ma, come mostra la stessa tragica conclusione della sua esistenza,
Pavese è molto lontano dal vitalismo di Vittorini, dalla sua volontà sempre costruttiva e positiva: la
sua partecipazione al presente si lega sempre a un senso lacerante della contraddizione tra
letteratura e impegno politico, tra esistenza individuale e storia collettiva, tra continuità di un
passato mitico e possibilità di trasformazione del mondo. Nel suo rapporto con la letteratura e con il
mondo, vissuto in pochi anni turbinosi, egli si sente continuamente trascinato entro una realtà che
sente estranea, con cui il suo io non riesce mai a conciliarsi; e nello stesso tempo cerca di affermare
il senso più profondo di sé nella scrittura, nella conquista di uno ‘stile’ e di una ‘maturità’ che
resistano al tempo. Pavese vive questa ricerca e queste contraddizioni con un’ostinata e tragica
serietà, mirando, fino in fondo, ad ‘essere tragicamente’ ”. (Giulio Ferroni)
Romualdo Marandino
6