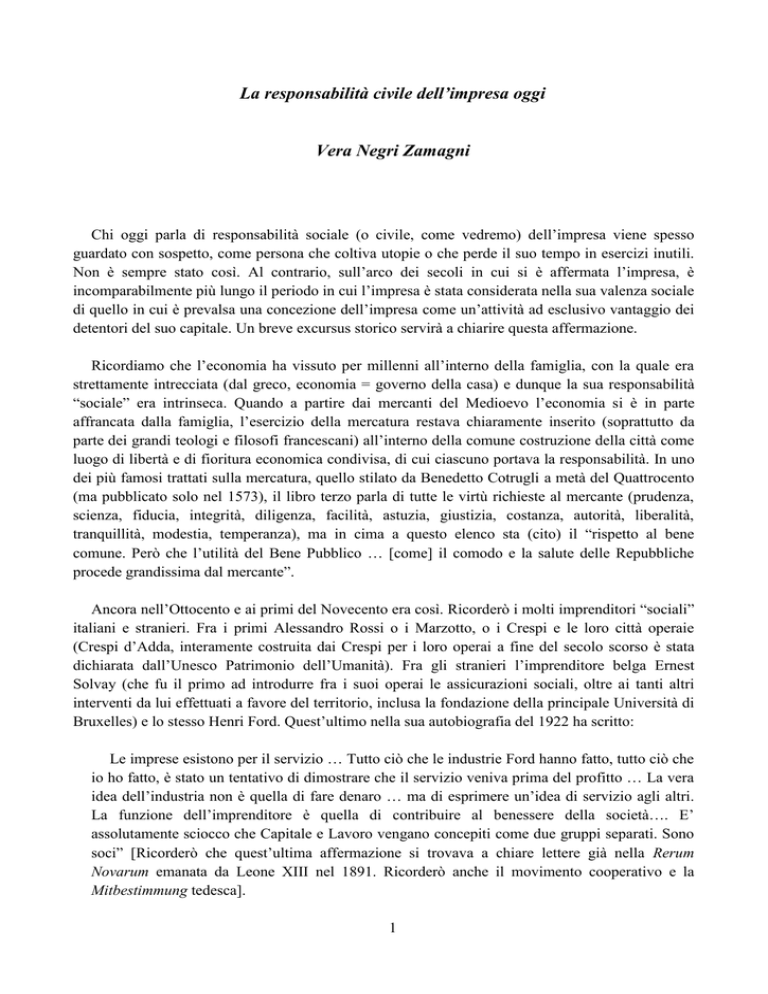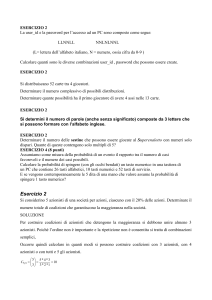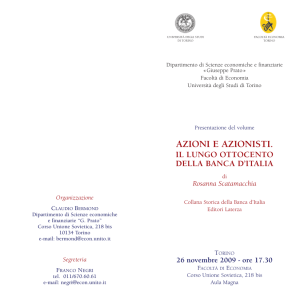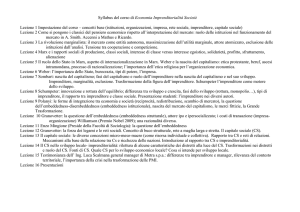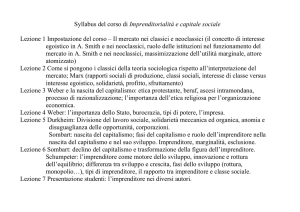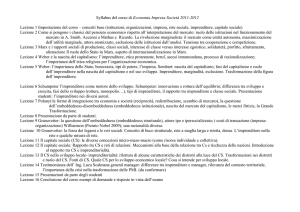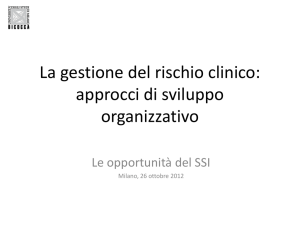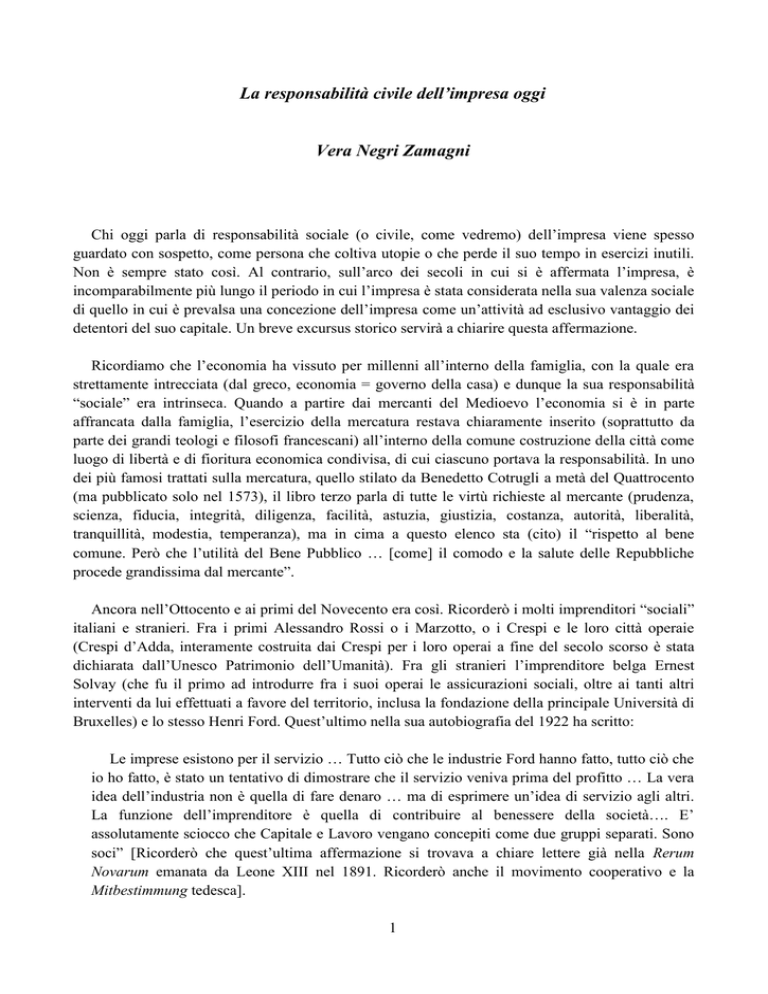
La responsabilità civile dell’impresa oggi
Vera Negri Zamagni
Chi oggi parla di responsabilità sociale (o civile, come vedremo) dell’impresa viene spesso
guardato con sospetto, come persona che coltiva utopie o che perde il suo tempo in esercizi inutili.
Non è sempre stato così. Al contrario, sull’arco dei secoli in cui si è affermata l’impresa, è
incomparabilmente più lungo il periodo in cui l’impresa è stata considerata nella sua valenza sociale
di quello in cui è prevalsa una concezione dell’impresa come un’attività ad esclusivo vantaggio dei
detentori del suo capitale. Un breve excursus storico servirà a chiarire questa affermazione.
Ricordiamo che l’economia ha vissuto per millenni all’interno della famiglia, con la quale era
strettamente intrecciata (dal greco, economia = governo della casa) e dunque la sua responsabilità
“sociale” era intrinseca. Quando a partire dai mercanti del Medioevo l’economia si è in parte
affrancata dalla famiglia, l’esercizio della mercatura restava chiaramente inserito (soprattutto da
parte dei grandi teologi e filosofi francescani) all’interno della comune costruzione della città come
luogo di libertà e di fioritura economica condivisa, di cui ciascuno portava la responsabilità. In uno
dei più famosi trattati sulla mercatura, quello stilato da Benedetto Cotrugli a metà del Quattrocento
(ma pubblicato solo nel 1573), il libro terzo parla di tutte le virtù richieste al mercante (prudenza,
scienza, fiducia, integrità, diligenza, facilità, astuzia, giustizia, costanza, autorità, liberalità,
tranquillità, modestia, temperanza), ma in cima a questo elenco sta (cito) il “rispetto al bene
comune. Però che l’utilità del Bene Pubblico … [come] il comodo e la salute delle Repubbliche
procede grandissima dal mercante”.
Ancora nell’Ottocento e ai primi del Novecento era così. Ricorderò i molti imprenditori “sociali”
italiani e stranieri. Fra i primi Alessandro Rossi o i Marzotto, o i Crespi e le loro città operaie
(Crespi d’Adda, interamente costruita dai Crespi per i loro operai a fine del secolo scorso è stata
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità). Fra gli stranieri l’imprenditore belga Ernest
Solvay (che fu il primo ad introdurre fra i suoi operai le assicurazioni sociali, oltre ai tanti altri
interventi da lui effettuati a favore del territorio, inclusa la fondazione della principale Università di
Bruxelles) e lo stesso Henri Ford. Quest’ultimo nella sua autobiografia del 1922 ha scritto:
Le imprese esistono per il servizio … Tutto ciò che le industrie Ford hanno fatto, tutto ciò che
io ho fatto, è stato un tentativo di dimostrare che il servizio veniva prima del profitto … La vera
idea dell’industria non è quella di fare denaro … ma di esprimere un’idea di servizio agli altri.
La funzione dell’imprenditore è quella di contribuire al benessere della società…. E’
assolutamente sciocco che Capitale e Lavoro vengano concepiti come due gruppi separati. Sono
soci” [Ricorderò che quest’ultima affermazione si trovava a chiare lettere già nella Rerum
Novarum emanata da Leone XIII nel 1891. Ricorderò anche il movimento cooperativo e la
Mitbestimmung tedesca].
1
Quando l’impresa ha iniziato ad essere considerata come luogo di esclusiva massimizzazione dei
profitti per gli azionisti? Con il capitalismo manageriale azionario tra anni 1930 e 1970. Le imprese
diventate Public Companies avevano annullato il ruolo dell’imprenditore (la proprietà diffusa non
era in grado di esprimere una sua propria visione) e i managers si erano di gran lunga “semplificati”
la vita assumendo come unico obiettivo dei loro sforzi appunto la massimizzazione dei profitti degli
azionisti, i quali in questo modo non avrebbero avuto di che lamentarsi e quindi non avrebbero
avuto ragione di cambiare i managers né di opporsi alle loro laute remunerazioni. I motivi di questa
deriva sono più complicati di così e hanno a che vedere più in generale con lo scivolamento
dell’intera economia verso un paradigma individual-utilitaristico di marca anglosassone, che
rappresenta uno dei paradigmi economici sviluppati nel corso del tempo, certamente non l’unico.
Un tema che ci porterebbe lontano.
Ricorderò tuttavia le molte imprese per lo più familiari che hanno continuato a richiamarsi alla
responsabilità sociale, oltre alle imprese cooperative e a quelle not-for-profit. Ancora, nella nostra
costituzione ci sono forti richiami alla valenza sociale delle imprese, per esempio nell’art. 41, dove
si afferma che l’iniziativa economica privata è libera, ma che “non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. O anche
nell’art. 45, che riguarda le imprese cooperative, considerate degne di particolare promozione da
parte dello Stato proprio per la loro valenza sociale.
Il recente scoppio di incredibili speculazioni, il diffondersi a macchia d’olio di gravi e crescenti
disparità sociali, la crisi economica generalizzata, la mancanza di lavoro stanno ora ridando voce a
quella sparuta schiera di pensatori che, in mezzo ad un mare di economisti mainstream che si erano
accodati allo “shareholder value” (il valore per gli azionisti), a partire dagli anni 1970 aveva
iniziato a riproporre il tema della responsabilità sociale dell’impresa. Questi recenti gravi danni del
capitalismo finanziario hanno moltiplicato le già pesanti esternalità negative prodotte da imprese
irresponsabili verso tutto e tutti, ad eccezione degli azionisti, imprese che avevano praticato un
eccessivo sfruttamento delle risorse, un diffuso inquinamento, uno sfruttamento intensivo del
lavoro. La misura colma sta spingendo verso alcune posizioni forti di contrasto nei confronti di
questo scivolamento del ruolo dell’impresa, come quella presa dal Consiglio d’Europa nel febbraio
2011, che richiama le imprese ad una “Shared Social Responsibility”.
Agganciarsi a questa ripresa di interesse nei confronti della RSI è stato spontaneo e anche
doveroso da parte di Banca Carim, una società per azioni erede, non possiamo dimenticarlo, di
un’impresa bancaria che era stata per 150 anni not-for-profit. Con il suo primo bilancio intero postcommissariamento, Banca Carim ha voluto dunque fin da subito manifestare con il bilancio sociale
che qui presentiamo la sua sensibilità sociale, anzi la sua sensibilità civile. Se, infatti, la RSI fa leva
sugli stakeholder (portatori d’interesse) direttamente legati all’impresa (azionisti, dipendenti,
fornitori, clienti), la RCI si allarga anche al territorio, con speciale riferimento al sostegno e alla
promozione del Terzo Settore, e alle amministrazioni pubbliche, secondo un approccio di
“sussidiarietà circolare” (Stato, Imprese, Società Civile) che si è ormai affermato.
Questa sensibilità civile è ben presente nei nuovi amministratori della Banca e nei suoi dirigenti,
ma si è rafforzata con l’incorporazione di Eticredito, che ha portato ad una modifica di Statuto in tal
senso. Prima di dare parola al direttore che illustrerà i principali aspetti concreti del nostro bilancio
sociale, desidero terminare con una citazione da un recente lavoro (2011) di uno dei guru americani
della teoria aziendale, Michael Porter, anche lui convertitosi dallo “shareholder value” allo “shared
value”:
2
Il concetto di valore condiviso ( shared value) riconosce che sono i bisogni della società e non
solo i bisogni economici convenzionali a definire il mercato: Esso riconosce che i disastri sociali
… creano [anche] …costi interni per le aziende …E’ venuto il momento di assumere una visione
più ampia della creazione di valore… Abbiamo bisogno di una forma più sofisticata di
capitalismo, impregnata di finalità più sociali (M. Porter e M.R. Kramer, “Creating Shared
Value”, in Harvard Business Review, 2011, p. 85, trad. mia)
3