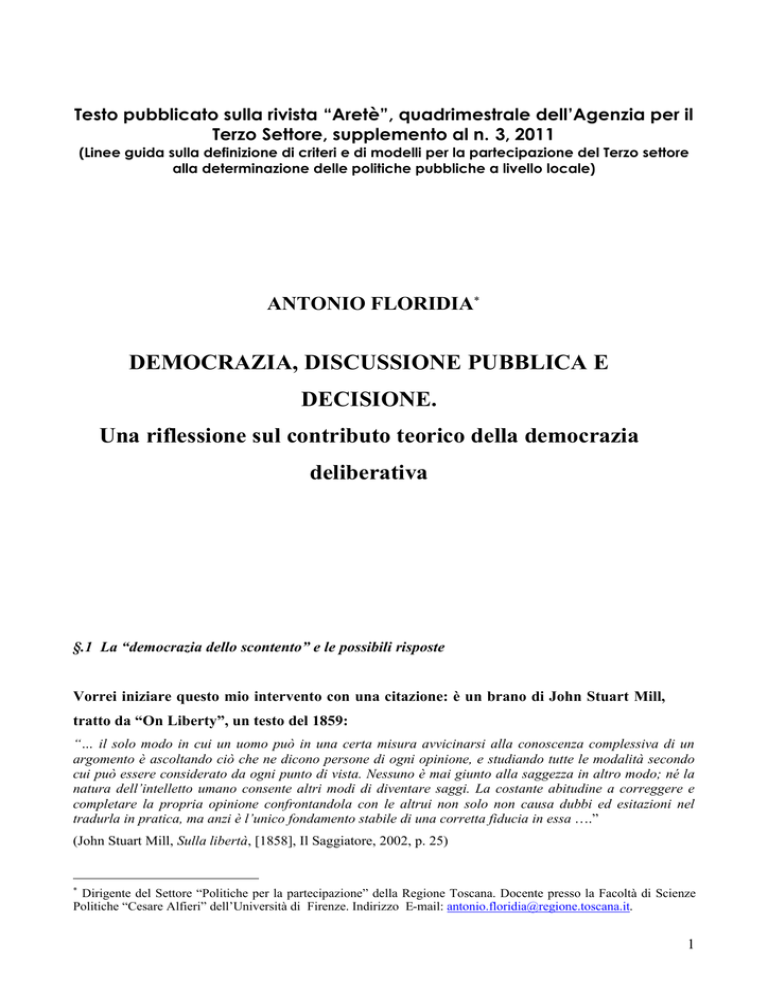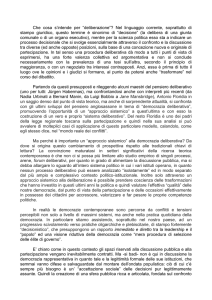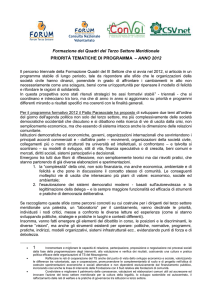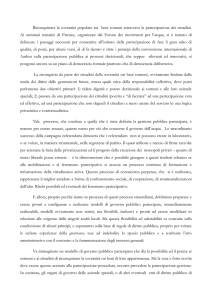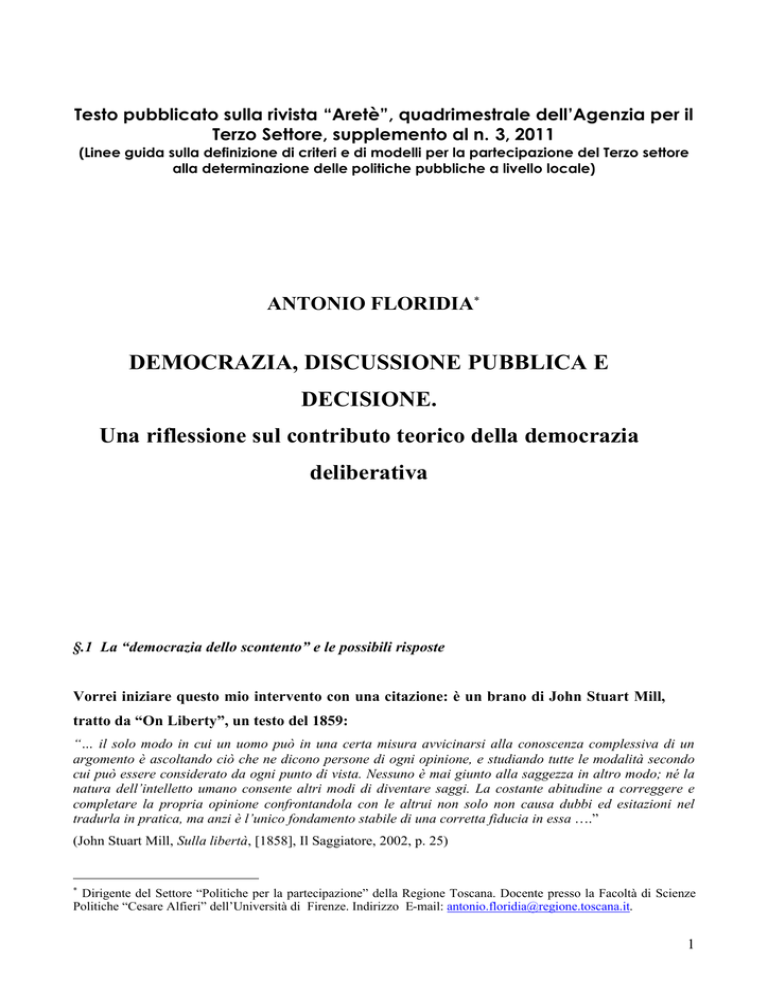
Testo pubblicato sulla rivista “Aretè”, quadrimestrale dell’Agenzia per il
Terzo Settore, supplemento al n. 3, 2011
(Linee guida sulla definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del Terzo settore
alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale)
ANTONIO FLORIDIA∗
DEMOCRAZIA, DISCUSSIONE PUBBLICA E
DECISIONE.
Una riflessione sul contributo teorico della democrazia
deliberativa
§.1 La “democrazia dello scontento” e le possibili risposte
Vorrei iniziare questo mio intervento con una citazione: è un brano di John Stuart Mill,
tratto da “On Liberty”, un testo del 1859:
“… il solo modo in cui un uomo può in una certa misura avvicinarsi alla conoscenza complessiva di un
argomento è ascoltando ciò che ne dicono persone di ogni opinione, e studiando tutte le modalità secondo
cui può essere considerato da ogni punto di vista. Nessuno è mai giunto alla saggezza in altro modo; né la
natura dell’intelletto umano consente altri modi di diventare saggi. La costante abitudine a correggere e
completare la propria opinione confrontandola con le altrui non solo non causa dubbi ed esitazioni nel
tradurla in pratica, ma anzi è l’unico fondamento stabile di una corretta fiducia in essa ….”
(John Stuart Mill, Sulla libertà, [1858], Il Saggiatore, 2002, p. 25)
∗
Dirigente del Settore “Politiche per la partecipazione” della Regione Toscana. Docente presso la Facoltà di Scienze
Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. Indirizzo E-mail: [email protected].
1
Questo brano può essere accostato ad un altro celebre passo, tratto dall’orazione funebre di
Pericle per gli eroi della guerra del Pelopponeso, così come Tucidide ce l’ha tramandato, e che
è considerato il “manifesto” della democrazia ateniese:
“Per noi,[ateniesi], la cura degli interessi privati procede di pari passo con l’attività politica, ed anche
se ognuno è preso da occupazioni diverse, riusciamo tuttavia ad avere una buona conoscenza degli
affari pubblici. Il fatto è che noi siamo i soli a considerare coloro che non se ne curano non persone
tranquille, ma dei buoni a nulla. E siamo gli stessi a partecipare alle decisioni comuni, ovvero a
riflettere a fondo sugli affari di Stato, poiché non pensiamo che il dibattito arrechi danno all’azione; il
pericolo risiede piuttosto nel non chiarirsi le idee discutendone, prima di affrontare le azioni che si
impongono”.
[La guerra del Pelopponeso, II, 40]
Sono brani celebri, specie il secondo, che vorrei qui riproporre solo per sottolineare un
elemento che li accomuna e che oggi ci tocca da vicino, nonostante i molti secoli che li
separano tra loro, e la distanza che separa il mondo in cui viviamo noi oggi dalle epoche
in cui queste idee furono concepite.
Possiamo definire questo elemento come il nesso tra discussione pubblica e decisione: il
nesso tra i processi e le modalità attraverso cui si formano le opinioni e i giudizi di un
individuo e le azioni che questo individuo intraprende.
Riprenderemo questo punto, ma prima occorre soffermarsi su una premessa alla nostra
analisi. Viviamo in un’epoca in cui un dato sembra caratterizzare i regimi democratici
contemporanei, non solo quelli più consolidati ma anche quelli frutto delle più recenti
ondate di democratizzazione: un diffuso “malcontento”, una diffusa disaffezione, verso la
politica, in generale, e poi verso le istituzioni democratiche, verso il loro “rendimento”,
verso la loro capacità di corrispondere a quei due fondamentali requisiti della
democrazia che vanno sotto il nome di accountability e responsiveness. Vi è oramai una
mole impressionante di studi e di ricerche che assumono questo dato, a volte persino in
modo acritico e ripetitivo, senza la necessaria problematicità: ad esempio, quando si
assume la caduta della partecipazione elettorale come un segno univoco di questo clima di
sfiducia generalizzata, e non si studiano anche i fenomeni di segno diverso, quale quello
che è stato definito come “astensionismo intermittente”, ovvero una reazione “selettiva”
degli elettori che possono anche tornare alle urne, quando la posta in gioco è sentita come
rilevante, o l’offerta politica presenta segni e tratti di novità. I recenti referendum
costituiscono un chiaro esempio di come non sia né scontata né univoca questa tendenza
ad una riduzione dei livelli di partecipazione politica.1
1
Per un approccio critico al tema della “democrazia dello scontento”, si veda il recente lavoro di Mastropaolo (2011, in
particolare p. 221 e sgg.)
2
Tuttavia, non c’è dubbio, il dato prevalente è quello di una crisi di fiducia, di un
sentimento diffuso di insoddisfazione nei confronti delle modalità ordinarie di
funzionamento delle nostre democrazie. Il punto su cui riflettere, allora, è questo: quali
strategie, quali risposte, si stanno delineando di fronte a questa pericolosa crisi di
legittimazione della democrazia? E come rispondere ad un apparente paradosso: in una
fase storica in cui il valore della democrazia sembra affermarsi universalmente, e un
moto poderoso investe anche popoli fino ad oggi soggetti a regimi autocratici e autoritari,
la qualità della nostra democrazia sembra essere rimessa radicalmente in discussione.
Ebbene, di fronte a questo scenario, una risposta è sembrata prevalente, almeno finora, in
una parte consistente delle èlites politiche, anche nel nostro paese: è una risposta che, a
fronte della crescente complessità e difficoltà dell’azione di governo delle nostre società,
sembra cercare – in varia misura e diverse forme, secondo i contesti e le tradizioni
nazionali - la via di fuga della semplificazione delle procedure democratiche,
dell’accentramento dei poteri, del decisionismo. Una via di fuga che, in taluni casi, assume
anche i caratteri di una risposta populista e i tratti di una esasperata personalizzazione
della leadership.
E’ una visione che assume e radicalizza la concezione della democrazia proposta da
Joseph Schumpeter: la democrazia come una mera procedura elettorale che seleziona un
team di politici, in concorrenza tra loro sul mercato politico per acquistare il consenso e la
legittimità ad assumere decisioni in nome di tutti.
Potremmo dire, un po’
scherzosamente, che oggi molti politici e amministratori sono degli “schumpeteriani
inconsapevoli”, o degli schumpeteriani malgrè soi….
Beninteso, in alcuni casi, questa risposta nasce anche da una sincera preoccupazione
democratica: a fronte della vera e propria crisi di legittimazione che minaccia le
istituzioni, e a fronte dell’assenza o della crescente rarefazione dei canali di mediazione
tra le istituzioni stesse e la società (primi fra tutti, i partiti), molti politici, specie quelli
chiamati direttamente a rivestire una carica istituzionale, sono come afferrati da una
sorta di “angoscia del fare”. Ai loro occhi, l’unica possibile risposta sembra possa essere
quella di dimostrare “con i fatti” l’efficacia del loro operare, la “bontà” delle loro
decisioni. E da qui, anche, molto spesso, l’insofferenza che traspare nei confronti di tutto
ciò che appare come un intralcio, si tratti delle procedure burocratiche (e fin qui lo si può
comprendere), ma anche, molto spesso, dello stesso variegato esprimersi, nella società e
nelle istituzioni, di opinioni e giudizi differenziati, di numerosi “poteri di veto”, di
resistenze, proteste, gruppi di interesse, ecc.
3
Insomma, una visione della politica come nobile arte della mediazione sembra
decisamente impopolare, nei nostri tempi: la ricerca paziente di possibili soluzioni
condivise sembra proprio una via poco praticabile. La ricerca del consenso attraverso la
costruzione di una rete di relazioni tra la politica e gli interessi e i valori presenti nella
società, sembra una via ostica e impervia: il consenso oggi sembra che possa formarsi
solo attraverso la comunicazione e i nuovi canali che le tecnologie dell’informazione
mettono a disposizione. Molto più semplice, e “comodo”, un post su Facebook, che non i
tradizionali e faticosi “tavoli” della concertazione.
Ora, se questa concezione, che potremmo definire, direttistica o immediatistica della
democrazia, alla fin fine, si rivelasse efficace e ben funzionante, resterebbe solo da
prenderne atto. Ma così non è: la realtà che abbiamo di fronte è quella di una vera e
propria illusione decisionistica. Vi è uno scarto tra la legittimità delle decisioni di policy
che un’autorità politica potrebbe assumere e la legittimazione con cui tali decisioni
vengono percepite da coloro che pure sono i destinatari di quelle policies, il grado di
riconoscimento e accettazione con cui la società vive queste decisioni. E vi è uno scarto tra
ciò che si annuncia di voler fare e ciò che poi si fa effettivamente; e non per ignavia,
incapacità o altri limiti soggettivi, ma perché, nei fatti, le decisioni si rivelano spesso
molto più complicate e difficili di quanto si immaginasse, e intervengono variabili
impreviste e imprevedibili che costringono a “rallentare”, a ripensarci, a considerare
altre soluzioni.
Questa ineffettualità di una logica decisionista porta con sé anche un’altra illusione:
quella tecnocratica, ovvero siamo ben lontani da un tempo in cui si poteva pensare che
potesse rivelarsi sufficiente ed efficace l’appello alla tecnica e alla scienza, o alla
“competenza burocratica”, come fondamento di legittimazione di una decisione.
Una nuova consapevolezza sta maturando, sia pure a fatica, di fronte alle illusioni e ai
fallimenti di una risposta fondata su una logica di accentramento del comando e su una
concezione elitistico-competitiva della democrazia. Nemmeno il più illuminato e
lungimirante statista, ma neanche un bravo sindaco, può pensare o presumere di poter
racchiudere nella propria capacità di visione strategica tutte le infinite variabili che oggi
concorrono a definire una decisione pubblica, dalla più complessa a quella
apparentemente più semplice. Non esiste una razionalità sinottica e onnicomprensiva del
policy maker, in grado di padroneggiare tutte le conoscenze e le esperienze necessarie a
prendere una buona decisione: viviamo in un mondo in cui domina una radicale
incertezza strategica. Nessun decisore politico, da solo, o magari circondato da un suo staff
4
di consulenti o di abili spin doctors, può “calcolare” gli effetti e le conseguenze di una
decisione, e nemmeno può pensare che il grado di consenso che essa riscuote sia
misurabile attraverso i sondaggi o i focus groups. E poi, in tanti campi, è la stessa
produzione di politiche pubbliche, la loro stessa efficacia, che presuppone e implica la
compartecipazione attiva dei possibili destinatari di quelle politiche, sia nella fase della
loro elaborazione, sia nella fase della loro implementazione.
Di fronte a questo scenario, tuttavia, rischia di assumere un sapore nostalgico, e alla fine
irrealistico, un mero richiamo a concezioni e pratiche della democrazia che abbiamo
vissuto in passato. Anche su questo punto, bisogna essere netti. Si impone comunque la
ricerca di nuove vie, l’elaborazione di un nuovo pensiero democratico, la sperimentazione
di nuovi modelli di partecipazione, l’individuazione di nuovi equilibri tra rappresentanza
e partecipazione.
§. 2. Forme e “aggettivi” della democrazia
Nel discorsi che oggi capita spesso di ascoltare sulla democrazia e le sue prospettive,
appare notevole la confusione tra piani diversi: in pratica, molto spesso, non si riesce ad
usare il termine stesso “democrazia” senza affiancare ad esso un qualche aggettivo, che
cerca di specificarne i caratteri e i presupposti: rappresentativa, partecipativa, deliberativa,
diretta, associativa, ma poi anche plebiscitaria e populista, elitistica, ed altri se ne
potrebbero aggiungere.
Di fronte a questo proliferare di possibili “aggettivi della democrazia”, ritengo che si
possa trovare un criterio ordinatore che forse ci può aiutare a fare un po’ di chiarezza: è
possibile cioè individuare un continuum tra due dimensioni estreme, ovvero il carattere
più o meno mediato o immediato della democrazia. Da una parte, quindi, una visione
semplificata che tende ad accreditare una connessione diretta tra la “fonte” della
sovranità (il “popolo”) e una leadership tendenzialmente personalizzata e “carismatica”;
e dall’altra parte, una visione della democrazia come un processo mediato attraverso cui
la sovranità popolare costruisce, in modo indiretto ma non per questo meno democratico, la
propria rappresentanza politica ed esercita, in vario modo, il suo diritto a partecipare
alla determinazione delle scelte politiche. Visioni contrapposte, per le quali ben diverso è
il ruolo che riveste anche la cornice costituzionale che definisce la separazione dei poteri, i
5
loro equilibri e i loro reciproci controlli, nonché i limiti entro cui si esercita il potere di
governo, per quanto legittimato dalle procedure elettorali: per la prima concezione, che
diremmo immediatistica, della democrazia, tale cornice costituzionale diviene molto
spesso, un fastidioso intralcio che depotenzia o distorce l’efficacia delle decisioni e
l’espressione della presunta “volontà popolare”; per la seconda concezione, il quadro dei
vincoli costituzionali è un essenziale presupposto della democrazia, all’interno del quale
soltanto anche la partecipazione politica dei cittadini può esprimersi in forma
continuativa ed efficace, proprio perché può far leva su un equilibrio pluralistico di
poteri e su un articolato sistema di garanzie e di diritti.
E ancora: una visione immediata della democrazia presuppone una concezione atomizzata
e individualistica della partecipazione, -- fondandosi su un rapporto tra i singoli individui
e i detentori del potere da essi direttamente legittimati; una visione mediata della
democrazia presuppone invece e incoraggia il ruolo e la costruzione di una dimensione
associativa diffusa, la creazione di corpi intermedi che spezzino l’isolamento degli
individui, in modo da aggregare e strutturare la loro domanda nei confronti del sistema
politico.
Che la democrazia sia, innanzitutto, caratterizzata da elezioni regolari, periodiche e
competitive, naturalmente, è un punto fermo; ma tutto ciò rappresenta una condizione
necessaria ma non sufficiente a garantire una buona qualità della democrazia. Il potere
dei cittadini non può essere ridotto alla loro facoltà di cacciar via i cattivi governanti,
quando se ne presenta l’occasione. Una buona qualità della democrazia presuppone una
società civile attiva, consapevole, partecipe; presuppone una circolarità permanente tra
rappresentanza e partecipazione, un’attivazione costante dei circuiti dell’accountability
che veda il protagonismo dei cittadini.2
Si comprende perciò il senso delle citazioni iniziali: bisogna riattivare una dimensione
essenziale della democrazia, quale è stata concepita, nel corso dei secoli, dai massimi
pensatori che a questo ideale hanno dedicato la loro riflessione, e quale è stata riproposta,
in anni più recenti, in particolare, dal modello teorico della Deliberative Democracy e
dalla concezione della partecipazione che esso suggerisce e implica. Questa dimensione
può essere definita come la sfera della discussione pubblica: la democrazia vive se si riesce
a creare, allargare, strutturare spazi e luoghi in cui il confronto pubblico e argomentato
sulle decisioni collettive possa avvenire in modo sistematico e possa produrre, appunto,
quello che si dice un empowerment della società civile.
2
Su questi temi, da prospettive diverse, Urbinati (2010) e Manin, (2010).
6
Ma, attenzione, empowerment non significa “cessione di sovranità”, ovvero pensare che le
forme di partecipazione della società civile possano sostituirsi alle legittime istituzioni
della democrazia rappresentativa. La partecipazione deve essere concepita come una fase
del processo decisionale, non come il luogo, e tanto meno come il luogo esclusivo, della
decisione. Empowerment significa altro, ossia capacità di influenza politica: immettere nel
circuito dei processi decisionali il sapere diffuso, le competenze, le esperienze, le visioni, che
emergono dalla società civile e che possono contribuire al farsi delle decisioni pubbliche,
arricchendone la qualità, la condivisione, la legittimità e, quindi, perciò stesso, l’efficacia.
Sono esigenze sentite e diffuse, affermazioni che molti sottoscriverebbero. Ma come è
possibile realizzare concretamente l’obiettivo di un arricchimento dei processi
decisionali? Attraverso quali strategie è possibile che le istituzioni attingano veramente ai
saperi e alle esperienze della società civile?
Una possibile risposta, che talora assume il carattere di una scorciatoia di sapore
populista, dice, pressappoco: “occorre ascoltare i cittadini”, oppure “il politico deve stare
tra la gente”. Bene, ma si può definire “partecipazione”, questa? Non proprio: questa
risposta riconduce ad un’altra dimensione, in sé tutt’altro che deprecabile, ma diversa,
ossia la capacità della politica di costruire relazioni stabili con le domande dei cittadini.
Altra cosa ancora sono le risposte che le istituzioni, in vario modo e con vario successo,
ma in modo sempre più frequente, tentano di sperimentare: ossia, strumenti, più o meno
sistematici, per ascoltare o consultare i cittadini, o raccogliere le loro opinioni: ora,
ascolto e consultazione, in varie situazioni, sono pratiche meritorie e positive, ma sono
anch’esse cosa diversa dalla partecipazione.
Partecipazione implica l’”esser parte” di una decisione, poterne influenzare i contenuti,
contribuire a definirli. Ma come può accadere questo, e come possiamo proporci che
accada, se il quadro delle opinioni e delle credenze dei cittadini appare molto spesso poco
informato, poco consapevole, segnato da incertezze o da pregiudizi? Insomma, i cittadini
hanno la competenza politica necessaria affinché il loro contributo, la loro partecipazione,
concorra davvero a produrre decisioni giuste ed efficaci, in materie che sono spesso molto
complesse?
Spesso, - riprendendo la celebre massima di La Rochefoucauld, secondo cui “l’ipocrisia è
l’omaggio che il vizio rende alla virtù” – in realtà ciò che prevale è un’altra convinzione,
anche nei politici e negli amministratori mossi dalle migliori intenzioni: si rende omaggio,
appunto, alla “virtù” della partecipazione dei cittadini, ma si ritiene che essa, in fondo,
7
sia solo una perdita di tempo; o che “stare a sentire quello che dicono i cittadini”, allo
stesso modo, sia sostanzialmente inutile, anche perché le opinioni che essi esprimono sono
le più disparate e contraddittorie, e quindi, alla fine, il decisore politico si trova
comunque nella necessità di dover decidere e di assumersi le proprie responsabilità, nella
solitudine del suo potere.
Si badi, queste obiezioni non sono senza fondamento: le opinioni dei cittadini “comuni”
sono, in effetti, molto spesso, volatili e incostanti, mutevoli, condizionate da interessi
particolari o viziate da pregiudizi. E la complessità di molte decisioni, la densità delle
loro implicazioni tecniche e scientifiche, sono anch’esse un dato obiettivo. La stessa
molteplicità degli interessi in gioco sembra rendere, obiettivamente, in molti casi, più
credibile e risolutivo, meno faticoso, il ricorso ad un qualche “taglio” dei tanti “nodi
gordiani” che costellano il cammino di una politica pubblica (in omaggio, del resto, alla
stessa radice etimologica del “decidere”: il latino “de-caedere”… tagliare, appunto).
E dunque, come rispondere a queste obiezioni e posizioni, a questi orientamenti che, nelle
nostre società, possono contare su una potente forza di inerzia, che spinge alla passività,
all’apatia, alla chiusura nella dimensione privata, tra i cittadini, per un verso, e alla
“chiusura” autoreferenziale dei decisori politici, per altro verso?
§ 3. “Dal metodo consultivo a quello deliberativo”
Prima di affrontare il versante più direttamente teorico dell’approccio deliberativo, e di
vederne anche le implicazioni metodologiche e operative, si impone una specifica
riflessione sulle forme di rappresentanza e partecipazione del Terzo Settore.
A partire dal lavoro di Robert Putnam sulle “tradizioni civiche” nelle regioni italiane
(1993), e a partire dalla sua ispirazione schiettamente tocquevilliana, è oramai
largamente diffusa la convinzione, e non mancano anche le ricerche empiriche in materia,
che la robustezza del tessuto associativo che innerva una società costituisca un essenziale
ingrediente di ciò che possiamo definire la qualità di una democrazia. Se per “capitale
sociale”, riprendendo le parole di Putnam,
“intendiamo la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo
civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo
iniziative prese di comune accordo…il capitale sociale facilita la cooperazione spontanea”
(Putnam, 1993, p. 196),
non c’è dubbio che la ricca trama dell’associazionismo del Terzo Settore costituisca oggi
in Italia una fondamentale dotazione di “capitale sociale”: non a caso, Roberto Cartocci
8
(2007), nella sua ricerca volta a disegnare un “atlante del capitale sociale” nel nostro
paese, ha assunto il numero dei donatori di sangue come uno degli indicatori che ci
permette di individuare i confini di questa mappa, e la diversa densità dello stock che
caratterizza le regioni e le province italiane, con una perdurante frattura che divide
l’Italia, come nota Cartocci, lungo l’asse dei fiumi Tronto e Fiora.
Tuttavia, sempre Putnam, in un successivo lavoro (2000), ci ha messo in guardia da una
visione acritica e indifferenziata del “capitale sociale”. La fondamentale distinzione cui
fare riferimento è quella tra un capitale bonding e un capitale bridging, tra un capitale
sociale che costruisce reti fiduciarie escludenti e “a corto raggio”, volte ad innalzare
barriere e tracciare confini e a definire identità “chiuse, e un capitale sociale “che invece
costruisce “ponti”, che allarga le reti della solidarietà e dell’identità collettiva, aperto e
inclusivo, volto a rinsaldare la fiducia orizzontale (verso gli sconosciuti e i diversi) e quella
verticale, ovvero il rapporto tra società e istituzioni.
L’altra fondamentale avvertenza che la ricerca teorica sul concetto di “capitale sociale” è
quella che ci mette in guardia da una visione deterministica, che affidi tutto ai sentieri
della dipendenza storica: il capitale sociale non vive di inerzia, ha bisogno di essere
costantemente alimentato e riprodotto: e quindi decisivo è il ruolo degli attori, la loro
capacità strategica, e decisivo il comportamento stesso delle istituzioni, la buona o cattiva
“pedagogia civile” che da essa proviene .
Ritengo che questa traccia possa essere utile ad avviare una riflessione sul nostro tema.
L’ipotesi che ci sembra di poter avanzare, è che questa enorme dotazione di “capitale
sociale” costituito dal Terzo Settore abbia bisogno oggi di essere valorizzato in forme
nuove. Chi scrive si può considerare un osservatore “esterno”, con tutti i limiti che questo
può comportare; ma uno sguardo dall’esterno, oggi, forse può cogliere, in modo
certamente sommario, alcuni nodi problematici. A partire da un interrogativo: l’insieme
delle organizzazioni che vengono racchiuse sotto la definizione di “Terzo settore” possono
essere considerate solo come entità associative, strutture di auto-organizzazione della
società civile, o non sono oramai, a pieno titolo, attori che operano all’interno di
specifiche arene politiche, arene in cui si costruiscono policies e in cui si confrontano
diversi portatori di interesse in competizione tra loro?
Si può benissimo sostenere che sono l’una cosa e l’altra; ma questo, indubbiamente,
produce una tensione, può creare squilibri in un senso o nell’altro, può aprire dinamiche
virtuose, ma anche di altro segno.
9
Come emerge anche dal recente Libro Bianco, e in particolare dal capitolo secondo, su
“identità e rappresentanza nel Terzo Settore”, emergono problemi di rappresentanza e di
rappresentatività. Vi sono due possibili versanti e snodi critici, particolarmente complessi,
su cui oggi occorre misurarsi: da un lato, un versante esterno, ossia quelle che possiamo
definire le forme di intersezione tra le istituzioni e il Terzo settore all’interno dei processi
decisionali di costruzione delle politiche pubbliche; e, dall’altro lato, il versante interno, le
forme stesse con cui, all’interno di ciascuna associazione, si producono idee, decisioni,
orientamenti e posizioni che poi interagiscono con i processi di decision-making “esterni”.
In uno dei saggi più noti in cui è stato proposto il modello teorico della Democrazia
Deliberativa, Jon Elster (2005) ha tematizzato proprio le tre modalità ideal-tipiche della
decisione: arguing, voting e bargaining. Argomentare, votare e negoziare: queste tre
modalità, naturalmente, si possono applicare, insieme o separatamente, in contesti
decisionali molto diversi. Ebbene, questo schema ci può offrire una chiave per affrontare
il nostro tema: il Terzo Settore è indubbiamente un soggetto e un protagonista dei
processi di negoziazione che contribuiscono a definire una sfera delle politiche pubbliche;
ma quali sono le risorse negoziali di cui dispone? Come si formano opinioni e
orientamenti che poi vengono fatti valere sui tavoli della “concertazione”? quali sono gli
interessi e i valori di cui si fanno portatori i loro rappresentanti? Esiste una qualche
forma di accountability tra la base associativa e i rappresentanti legittimati a “trattare”
con le istituzioni?
In un capitolo del Libro Bianco si parla esplicitamente di un passaggio che occorre
compiere: “dal modello consultivo a quello deliberativo”. E si propone una formulazione
generale per indicare lo strumento con cui questo passaggio può avvenire: la creazione di
forum deliberativi. Ci sembra il nodo cruciale: proprio per questo, una riflessione sul
modello teorico della Democrazia Deliberativa crediamo possa offrire, a chi vive più
direttamente questa realtà, spunti ed elementi di riflessione utili ad arricchire questa
prospettiva. Il modo con cui affronterò questa parte del mio intervento è di natura
spiccatamente teorico: ma credo che risulteranno molto chiare, successivamente, le
implicazioni metodologiche e operative che ne derivano.
§. 4 Il modello teorico della Democrazia Deliberativa.
Al centro del modello teorico della Democrazia Deliberativa vi è un assunto
fondamentale: come ha scritto Jon Elster, (1998, pp. 1-8), vi è “l’idea che la democrazia si
10
fonda sulla trasformazione più che sulla mera aggregazione delle preferenze”. E il luogo in
cui le preferenze si trasformano è la discussione pubblica: ovvero, scrive ancora Elster, un
processo di “collective decision-making” che è “democratico” in quanto prevede “la
partecipazione di tutti coloro saranno coinvolti in una decisione o dei loro
rappresentanti”; e che è “deliberativo” in quanto si svolge “attraverso argomenti offerti
da, e a, partecipanti che siano orientati [committed] da valori di razionalità e
imparzialità”.
Le preferenze (in un’accezione più ampia, possiamo dire: i valori, i giudizi, le opinioni)
degli individui coinvolti in un processo decisionale non possono e non debbono solo essere
“contate” o “aggregate”, attraverso procedure di voto, o meramente registrate in qualche
modo, ma possono e debbono formarsi e trasformarsi nel corso di una discussione pubblica
che si svolga su basi di imparzialità, parità e eguaglianza. Troviamo qui l’idea che una
decisione collettiva possa essere assunta sulla base di argomentazioni razionali, e sulla
base di informazioni e conoscenze condivise (e non, necessariamente, sulla base di un
negoziato tra interessi contrapposti e/o di un voto che veda una tesi prevalere sull’altra);
ma poi vi è anche l’idea che una decisione collettiva debba essere assunta sulla base della
partecipazione di “tutti” coloro che sono, in varia misura, coinvolti nella decisione stessa,
ovvero sulla base di un principio di “massima inclusività”. Ciò che conta è che tutti coloro
che abbiano “qualcosa da dire” su una decisione che, in varia misura, li tocca
direttamente, abbiano la possibilità di farlo; e che possano riconoscere il fatto che,
comunque, della loro opinione si sia discusso e che, in una qualche misura, essa sia stata
presa in considerazione e abbia contribuito al definirsi di una soluzione quanto più
possibile condivisa o di una base comune di consenso.
Sulla base di questi assunti, naturalmente, si sono sviluppate diverse versioni o
interpretazioni, sul senso e le finalità che può assumere una concezione deliberativa della
democrazia. In particolare, sulla base di questo modello normativo, si sono sviluppate
concezioni più o meno “esigenti” o “restrittive” delle condizioni che permettono di
definire come democratico un processo di costruzione di una decisione collettiva.
Non possiamo qui addentrarci su questo terreno. A noi preme qui sottolineare soprattutto
come questo approccio offra una possibile via di soluzione al dilemma sopra prospettato:
come è possibile una vera “partecipazione” dei cittadini ai processi decisionali, quando
questi ultimi sono sempre più complessi, esigono competenze tecniche e scientifiche
sempre più raffinate, e richiedono una capacità di controllo su un gran numero di
11
variabili? E come è possibile “partecipare” quando la maggior parte dei cittadini appare
poco informata, a volte apatica, a volte indifferente?
La via di una possibile soluzione (che non certo non raggiungerà mai quanto prospettato
da un modello ideale, ma che a tale modello potrà comunque provare ad approssimarsi),
è quella di costruire percorsi e processi partecipativi al cui interno i cittadini possano non
solo e non tanto esprimere la loro opinione, quanto e soprattutto formarsela e
trasformarla nel vivo di uno scambio argomentativo con altri cittadini e con esperti di
diverso orientamento.
Al centro del modello teorico della Democrazia Deliberativa si pone dunque la profonda
differenza tra logiche aggregative e logiche trasformative.
Logiche aggregative sono quelle che, nella costruzione di una decisione, assumono come
date (o esogene, cioè definite prima e al di fuori del processo decisionale) le “preferenze”
(le opinioni, giudizi, credenze) degli attori e che si limitano a sottoporle ad una procedura
di voto: a “contarle”, secondo regole di tipo elettorale, generalmente fondate su un
principio di maggioranza.
Logiche trasformative sono quelle che assumono invece una visione complessa (e più
realistica) delle “preferenze” iniziali degli attori: come opinioni e giudizi (o pre-giudizi)
fondati su una base informativa parziale, o anche distorta, e su schemi cognitivi parziali e
non sempre dotati di una propria coerenza interna; e come “preferenze” spesso volatili o
contraddittorie, caratterizzate da un grado mutevole di consapevolezza riflessiva.
Gli individui, molto spesso, non entrano e non concorrono ad un processo decisionale
collettivo sulla base di giudizi pre-definiti, coerenti, chiari e consapevoli; o di
“preferenze” che si siano formate sulla base di una compiuta valutazione di tutte le
alternative possibili e di tutte le loro implicazioni e conseguenze3. Un processo decisionale
di tipo deliberativo assume perciò anche un’essenziale dimensione formativa, diviene un
luogo in cui si sviluppano forme di apprendimento collettivo: riprendendo qui uno dei
“padri nobili” di questa concezione della democrazia, John Dewey, possiamo anche dire
che la ricerca della soluzione ad un problema collettivo assume la forma di una “public
inquiry”, di un’indagine pubblica, di un esercizio collettivo dell’intelligenza sociale. E’ solo
grazie al confronto tra punti di vista diversi e conflittuali che un individuo può
comprendere “ciò che vuole veramente”. E’ vero, come sostiene la dottrina liberale, che
ciascun individuo “è il miglior giudice dei propri interessi”; ma davvero ciascuno è in
grado, da solo, e immediatamente, di valutare cosa è “giusto” fare, per sé e per gli altri?
3
Su questo, si veda Luigi Bobbio (2007)
12
Se non è così, e respingiamo peraltro ogni logica paternalistica, per cui un’autorità
superiore si arroga il diritto di decidere per conto degli altri, resta una sola via: quella
che suggeriva Mill, il confronto argomentato tra le opinioni, il progressivo e reciproco
chiarimento tra i diversi punti di vista, senza la pretesa di giungere ad una qualche
“verità assoluta”. Non vi sono volontà predeterminate da contare (per verificare quale sia
quella maggioritaria), ma giudizi e valutazioni da formare nel vivo di uno scambio
argomentativo. Come ha scritto Bernard Manin, in uno dei testi fondativi della nuova
riflessione teorica sulla deliberazione, “di una conclusione cui si giunga attraverso
argomenti, non si dice che sia vera o falsa, ma semplicemente che essa produce un maggiore
o minore sostegno a seconda che l’argomento sia stato più o meno convincente...più forte o
più debole” (1987, p. 353).
Proprio perché assumono che le condizioni iniziali di un processo decisionale siano
caratterizzate dall’incompletezza e dalla frammentarietà delle informazioni di cui
dispone un individuo, e dall’assenza di un insieme predefinito (e simultaneamente
controllabile) di variabili e di alternative tra cui scegliere, le logiche “trasformative” –
proprie di una concezione deliberativa del processo decisionale – affidano un grande
ruolo alla costruzione di spazi dialogici, e di procedure regolate e strutturate di discussione
pubblica. Decisiva, quindi, è l’adozione di metodologie partecipative che consentano la
crescita di una consapevolezza critica e condivisa di un problema collettivo e delle sue
possibili soluzioni. Le tecniche partecipative possono essere le più varie, ed infatti – in
questi anni – se ne sono sviluppate e sperimentate molte e di diverse; ma esse devono
corrispondere ai paradigmi di razionalità argomentativa e di inclusività sopra delineati.
In questa visione della democrazia deliberativa, non vi è una generica propensione
“partecipazionista”, o un’illusoria riproposizione della “democrazia diretta”; anzi, ne
siamo agli antipodi. Un’assemblea confusa e vociante, in cui pochi parlano e molti si
limitano ad ascoltare, non è una buona pratica democratica. Qui, l’accento cade sulle
procedure attraverso cui si costruisce uno spazio deliberativo, sulle regole condivise (tempi
e modi della discussione) attraverso cui si costruisce un processo decisionale. Il come si
discute, la definizione di un setting deliberativo, incide sulla qualità democratica della
deliberazione. Ed è solo attraverso una corretta determinazione delle procedure, che la
discussione pubblica può produrre i suoi potenziali benefici effetti: una maggiore
legittimazione della decisione finale, un arricchimento delle capacità critiche degli
individui, la produzione di maggiori legami sociali e di fiducia reciproca.
13
Il quadro fin qui delineato del modello teorico della democrazia deliberativa,
naturalmente, si è scontrato e si scontra con numerose obiezioni, che investono
soprattutto il grado di “realismo” o di “praticabilità” delle sue assunzioni, le dinamiche
effettive che si possono produrre in un’arena deliberativa, l’esistenza effettiva di tutti
quei requisiti (innanzi tutto, le basi informative paritarie e le dotazioni cognitive degli
individui) che possono garantire il carattere democratico della deliberazione e i principi
di eguaglianza e razionalità su cui esso deve fondarsi (la “situazione discorsiva ideale”, di
cui ha parlato Habermas). Ma un modello normativo è tale, appunto, se propone dei
paradigmi attraverso cui valutare i processi reali o a cui ispirarsi nella costruzione di
strategie innovative. E il modello teorico della Democrazia Deliberativa sta producendo e
suggerendo soluzioni pratiche al problema di una nuova e diversa concezione della
partecipazione. Certamente, le sperimentazioni si potranno solo approssimare ai requisiti
normativi che la teoria prospetta; ma, con ciò stesso, forse qualche passo avanti si potrà
produrre
§ 5. Luoghi, obiettivi e soggetti della Deliberazione pubblica.
Nel testo del citato capitolo del Libro Bianco, riprendendo un intervento di Stefano
Zamagni, si prospetta, come abbiamo già ricordato, la costituzione di “forum deliberativi
su base territoriale”, come uno degli strumenti attraverso cui si può meglio esprimere la
natura e la mission del Terzo Settore.
L’espressione “Forum deliberativi”, come ben si comprende, è termine molto ampio, che
richiede una specificazione delle specifiche metodologie con cui progettare, organizzare,
gestire e concludere una discussione pubblica, che risponda ai paradigmi normativi sopra
richiamati. Su questo punto, si potrebbe aprire una riflessione specifica sulle più
opportune soluzioni, avvertendo di un rischio sempre incombente: che rimanga incerto il
confine tra consultazione e partecipazione, e che si creino organismi consultivi, e non
propriamente deliberativi, con una debole interazione tra discussione e decisione.
Credo che una via per meglio individuare in che modo una pratica deliberativa può
intervenire nel campo del Terzo Settore, sia innanzi tutto quella di distinguere i diversi
luoghi e momenti in cui tale pratica può svilupparsi.
Un tema molto discusso nella letteratura teorica sulla Democrazia Deliberativa è appunto
quello dei luoghi in cui si può esercitare una buona pratica deliberativa. Una pratica
deliberativa, innanzi tutto, è possibile ed auspicabile all’interno degli organismi della
14
democrazia rappresentativa: e non a caso, abbiamo o dovremmo avere, dei “Parlamenti”,
luoghi istituzionali in cui si confrontano, si discutono pubblicamente, si esprimono e si
rappresentano le posizioni ideali e politiche presenti in una società: era questo, del resto,
il modello a cui si ispirava il liberalismo democratico classico, in particolare nella visione
aperta e dinamica di John Stuart Mill (su cui, Urbinati, 2006). Ma un modello
deliberativo di decisione può essere applicato all’interno di un qualsiasi organo collegiale
o di un qualsiasi gruppo di individui: così, ad esempio, si è potuto parlare della logica
deliberativa che guida alcune associazioni o movimenti sociali (Della Porta, 2005).
Nel nostro caso, si tratta di individuare se esistano e come eventualmente strutturare
degli organismi, rappresentativi di una pluralità di organizzazioni, in grado di operare
secondo una dimensione propriamente deliberativa. E si tratta di capire se si tratta di
organismi in cui siano presenti anche i rappresentanti delle istituzioni, quali siano le
finalità affidate alle deliberazioni di questi organismi, e di quali poteri decisionali essi
siano investiti. E’ un tema che esula dal compito che mi sono prefisso.
Credo tuttavia che le migliori potenzialità di un approccio deliberativo si possano cogliere
altrove, su altre due dimensioni, quella interna alle singole associazioni, e quella che
potremmo definire come la costruzione di specifici processi partecipativi finalizzati alla
soluzione di specifici problemi di policy.
Sul primo punto, sfugge alla nostra competenza e alle nostre conoscenze, una valutazione di
quali siano oggi le procedure con cui le diverse organizzazioni regolano il rapporto tra la
base associativa e i loro gruppi dirigenti. Se, come emerge dalla lettura del Libro Bianco, si
segnala un problema di rappresentatività, si può presumere che, anche per queste
organizzazioni, come per altre (ad esempio, i sindacati e le rappresentanze di categorie), sia
presente, o sia sempre incombente, il rischio di un basso livello di coinvolgimento della base
associativa e di un conseguente distacco tra le posizioni e le scelte strategiche dei gruppi
dirigenti e gli effettivi orientamenti dei rappresentati. Con un conseguente, pericoloso,
sospetto sulla effettiva natura delle tesi che i rappresentanti di un’associazione difendono e
sostengono all’interno dei processi di concertazione.
Su questo versante, un approccio deliberativo può rivelarsi benefico, e aiutare nella ricerca
di un corretto equilibrio tra rappresentanza e partecipazione. Non si tratta di evocare
retoricamente “il rapporto con la base”, ma di costruire le occasioni specifiche attraverso
cui un’intera associazione discute le proprie scelte. Lo specifico apporto di una concezione
deliberativa consiste qui nel sottolineare come non bastino (o anzi, spesso, si rivelino
inefficaci e frustranti) le tradizionali occasioni assembleari, e di come sia possibile invece
15
strutturare percorsi interni di discussione e di verifica in grado di valorizzare l’apporto di
esperienze e competenze, in questo caso, non solo del “cittadino ordinario” (come
suggerisce la teoria deliberativa), ma del “socio ordinario”.
Quello che va sottolineato è come il recupero di una maggiore rappresentatività e,
soprattutto, legittimazione dei gruppi dirigenti, attraverso meccanismi deliberativi ben
congegnati, costituisca una grande risorsa negoziale nel momento in cui si apre un
confronto “esterno” con le istituzioni o altre associazioni. Non è solo la “forza dei numeri”,
a pesare sui tavoli di un negoziato, ma anche la qualità della partecipazione “interna” che
ha concorso a definire una posizione e un orientamento.
Questo approccio ci permette anche di tentare una risposta ad uno degli snodi problematici
segnalati nel Libro Bianco, ossia quello della quantità della partecipazione: far sì che il
numero più ampio possibile di soci sia coinvolto nella dinamica associativa, è certo obiettivo
da perseguire; ma è anche vero che sarebbe illusorio pensare o immaginare livelli di
intensità partecipativa sempre e comunque molto elevati o generalizzati. In molti casi, conta
maggiormente la rappresentatività, la ricchezza e la varietà dei “punti di vista” che si
esprimono nel corso di un processo deliberativo, che non il mero dato quantitativo sul
numero dei partecipanti, ad esempio, ad un’assemblea o ad un incontro. E le metodologie
deliberative che ricorrono anche all’estrazione casuale, in alcuni casi, e con i dovuti
accorgimenti, possono rivelarsi utili, in quanto integrano la presenza dei segmenti
abitualmente più attivi di un’associazione con il coinvolgimento di altri segmenti,
solitamente meno sollecitati.
Il secondo punto, ovvero la costruzione di specifici processi partecipativi finalizzati alla
soluzione di specifici problemi di policy, ci offre la possibilità di cercare una risposta anche
ad un altro nodo problematico segnalato dal Libro Bianco, ovvero l’effettiva incidenza delle
pratiche partecipative sulla decisione pubblica.
Credo che sia su questo terreno che una concezione deliberativa della partecipazione ci
possa offrire gli spunti più promettenti.
In sintesi: ritengo che la via più feconda sia quello di attivare processi deliberativi
strutturati su specifiche oggetti o su singole policies che presentino particolare rilevanza
politica o che presentino aspetti potenzialmente conflittuali. I soggetti che promuovono
questi processi possono essere diversi: ad esempio, la stessa istituzione cui compete la
titolarità di una decisione, o anche gli organismi rappresentativi in cui siano presenti sia le
istituzioni che le diverse associazioni.
16
Concretamente: se in un dato ambito territoriale, sorge una specifica questione (ad
esempio, una scelta obbligata tra allocazioni alternative di risorse destinate alle politiche
sociali), si può seguire la via tradizionale di una negoziazione, o anche di una mera
consultazione, che lascia la decisione finale nelle mani di chi è deputato a decidere; ma si
può anche scegliere la via di un percorso deliberativo, in cui le diverse opzioni sono
sottoposte ad una discussione pubblica, ad un confronto argomentato sulle possibili
priorità e sulle possibili ragioni che consigliano l’una scelta o l’altra. L’esito di una
soluzione condivisa, o tanto meno unanime, non è garantito a priori, ma certamente un
percorso pubblico e trasparente di discussione renderà comunque più legittima la decisione
finale, che spetta comunque alle istituzioni che sono titolari di un potere legittimo sulla
materia.
Insisto sul carattere strutturato e condiviso di questi processi deliberativi: ad esempio, un
organismo rappresentativo in cui siano presenti molte associazioni e le istituzioni potrebbe
farsi promotore di un processo che abbia le seguenti tappe e caratteristiche:
a) un comitato di garanzia in cui siano presenti tutti i soggetti rilevanti e che si assuma
l’incarico di presentare un dossier aperto, in cui le diverse opzioni sono illustrate e
motivate e tutte le informazioni rilevanti condivise (ad esempio, i vincoli di
bilancio);
b) una fase articolata di incontri, discussioni e luoghi (anche “virtuali”) in cui tutte le
posizioni e i punti di vista abbiano “piena cittadinanza”, pari dignità e pari
visibilità;
c) momenti specifici di confronto con i portatori di esperienze significative e di “buone
pratiche”, nonché con i portatori di competenze tecnico-scientifiche, in modo da
accrescere le informazioni condivise e il livello di consapevolezza diffusa sui termini
del problema;
d) attivare metodologie specifiche, per far sì che la deliberazione non avvenga solo tra i
rappresentanti delle associazioni, ma cerchi anche di coinvolgere, oltre che la base
associativa, gli stessi cittadini destinatari delle politiche in discussione;
e) un “rapporto finale”, in cui le varie tesi espresse non vengono “contate”, ma
illustrate e presentate, sia quelle prevalenti che quelle minoritarie, e sottoposte al
titolare della decisione finale.
Naturalmente, anche per un percorso così strutturato si pone il problema del grado
effettivo di incidenza sulle decisioni; ma qui bisogna essere molto netti: non è possibile
17
alcuna codificazione giuridica, che garantisca a priori tale incidenza. Un processo
deliberativo, nel momento in cui si rivela efficace, pone, e può porre solamente, vincoli
politici al decisore. Tanto più un processo partecipativo risulterà ricco, creativo, originale,
tanto più esso sarà politicamente influente e segnerà un effettivo processo di empowering
della società civile, e tanto più poi le istituzioni non potranno non tenerne conto nelle loro
decisioni finali, che spetta comunque a loro assumere. E’ una dialettica aperta, tutta e
integralmente politica, che nasce dall’interazione tra la forza della società civile e
l’apertura, direi la lungimiranza politica, la “razionalità” intrinseca, delle istituzioni e degli
attori politici.
Infine, un’ultima osservazione. Abbiamo ricordato all’inizio come una buona qualità
della democrazia presupponga anche una ricca dimensione associativa, un tessuto di corpi
intermedi che producano quella fondamentale risorsa che va sotto il nome di fiducia, la
fiducia reciproca tra i cittadini e la fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Ebbene, la
concezione della partecipazione e della democrazia che qui abbiamo perorato non si
rivolge a individui isolati, a cittadini “virtuosi”, sì, ma racchiusi in una dimensione
individualistica: il tessuto associativo, le forme di auto-organizzazione della società civile,
possono e devono concorrere a costruire questa sfera pubblica di dialogo, possono aiutare
in modo decisivo la formazione di cittadini aperti e consapevoli, capaci di offrire un
contributo alla soluzione di problemi collettivi. E possono, soprattutto, concorrere alla
costruzione e alla gestione di un’ampia gamma di politiche pubbliche (in particolare,
quelle per il Welfare) per le quali l’apporto della società civile è fondamentale. Non basta
avere e coltivare un ricco capitale sociale o costruire reti di solidarietà “a corto raggio” :
occorre che questo capitale e queste reti interagiscano positivamente con la politica e le
istituzioni. E’ questo il contributo fondamentale che il Terzo Settore può dare alla qualità
della nostra democrazia.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Bobbio L.,
- 2007, Tipi di preferenze, tipi di deliberazione, in “Rivista italiana di scienza politica”, n. 3, pp. 359383.
Cartocci R.,,
2007, Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Bologna, Il Mulino.
18
Della Porta D.
2005, Deliberation in Movement: Why and How to Study Deliberative Democracy and Social
Movements, in “Acta Politica”, n. 40, (pp. 336–350).
Elster J.,
- 1998, (a cura di), Deliberative Democracy, Cambridge, Cambridge University Press.
Floridia A.,
2008, Democrazia deliberativa e processi decisionali: la legge della Regione Toscana sulla
partecipazione, in “Stato e mercato”, n. 1.
Gastil J., Levine P.,
2005, (a cura di), The Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Civic Engagement in
the 21th Century, San Francisco, Jossey-Bass.
Manin B.,
- 1987, Legitimacy and Political Deliberation, in “Political Theory”, vol. 15, n° 3, pp. 338-368
- 2010, Principi del governo rappresentativo, Bologna, Il Mulino.
Mastropaolo A.,
2011, La democrazia è una causa persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta, Torino, Bollati
Boringhieri.
Putnam R.,
- 1993, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press
(trad. it, Le tradizioni civiche nelle regioni italiane, Milano, Mondadori)
- 2000, Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community (trad. it., Capitale sociale e
individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in America, Bologna, Il Mulino, 2004).
Urbinati N.,
2006, L’ethos della democrazia. Mill e la libertà degli antichi e dei moderni, Bari, Laterza.
2010, Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri, Roma, Donzelli.
19