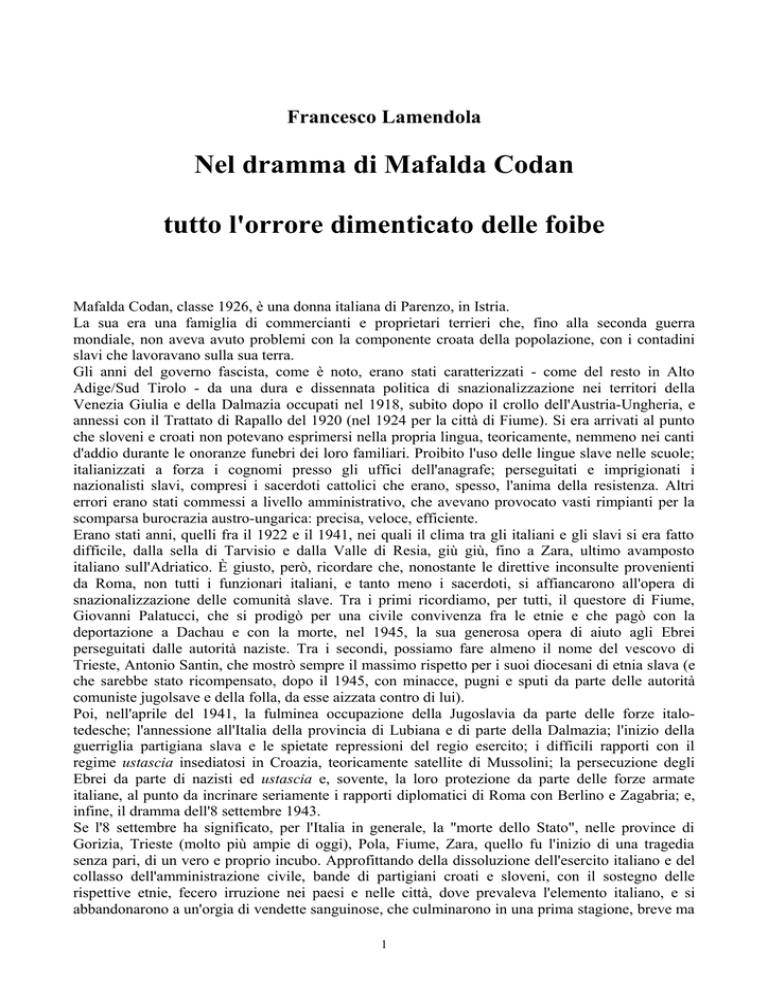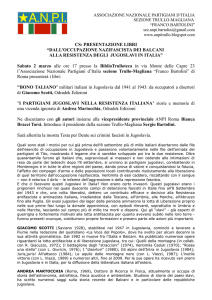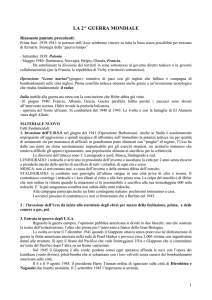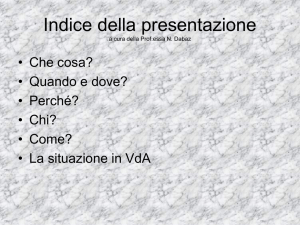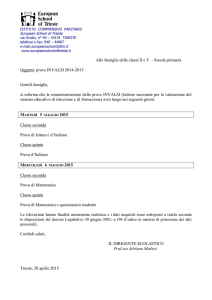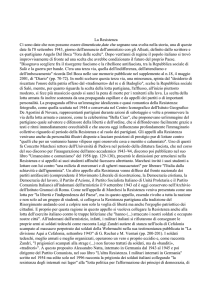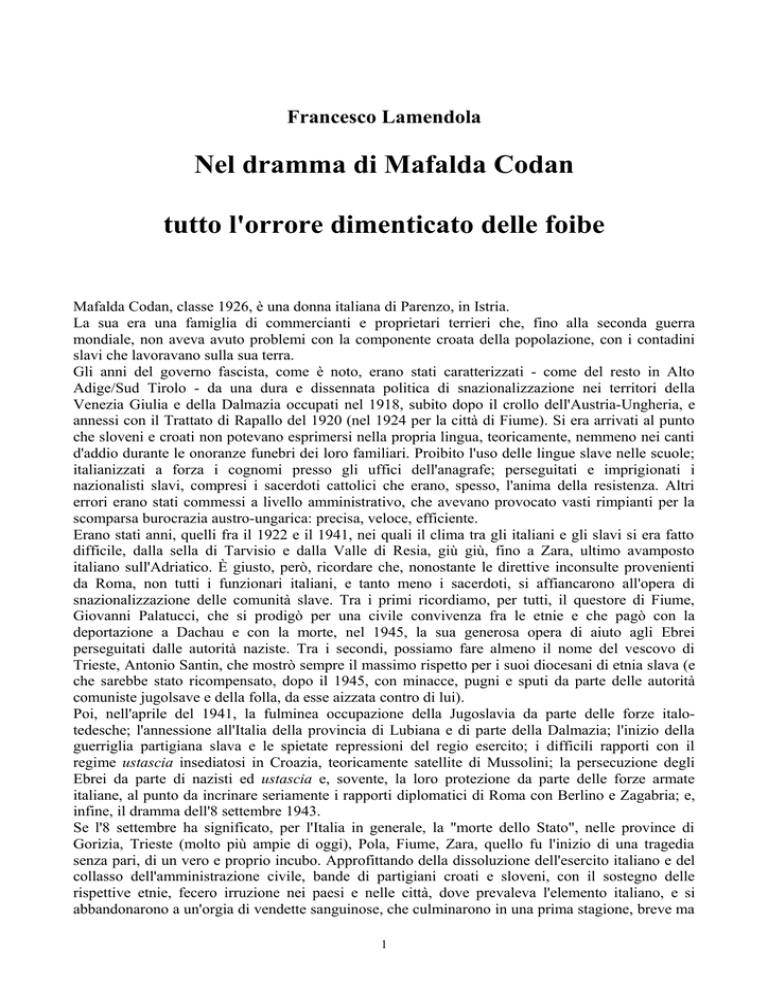
Francesco Lamendola
Nel dramma di Mafalda Codan
tutto l'orrore dimenticato delle foibe
Mafalda Codan, classe 1926, è una donna italiana di Parenzo, in Istria.
La sua era una famiglia di commercianti e proprietari terrieri che, fino alla seconda guerra
mondiale, non aveva avuto problemi con la componente croata della popolazione, con i contadini
slavi che lavoravano sulla sua terra.
Gli anni del governo fascista, come è noto, erano stati caratterizzati - come del resto in Alto
Adige/Sud Tirolo - da una dura e dissennata politica di snazionalizzazione nei territori della
Venezia Giulia e della Dalmazia occupati nel 1918, subito dopo il crollo dell'Austria-Ungheria, e
annessi con il Trattato di Rapallo del 1920 (nel 1924 per la città di Fiume). Si era arrivati al punto
che sloveni e croati non potevano esprimersi nella propria lingua, teoricamente, nemmeno nei canti
d'addio durante le onoranze funebri dei loro familiari. Proibito l'uso delle lingue slave nelle scuole;
italianizzati a forza i cognomi presso gli uffici dell'anagrafe; perseguitati e imprigionati i
nazionalisti slavi, compresi i sacerdoti cattolici che erano, spesso, l'anima della resistenza. Altri
errori erano stati commessi a livello amministrativo, che avevano provocato vasti rimpianti per la
scomparsa burocrazia austro-ungarica: precisa, veloce, efficiente.
Erano stati anni, quelli fra il 1922 e il 1941, nei quali il clima tra gli italiani e gli slavi si era fatto
difficile, dalla sella di Tarvisio e dalla Valle di Resia, giù giù, fino a Zara, ultimo avamposto
italiano sull'Adriatico. È giusto, però, ricordare che, nonostante le direttive inconsulte provenienti
da Roma, non tutti i funzionari italiani, e tanto meno i sacerdoti, si affiancarono all'opera di
snazionalizzazione delle comunità slave. Tra i primi ricordiamo, per tutti, il questore di Fiume,
Giovanni Palatucci, che si prodigò per una civile convivenza fra le etnie e che pagò con la
deportazione a Dachau e con la morte, nel 1945, la sua generosa opera di aiuto agli Ebrei
perseguitati dalle autorità naziste. Tra i secondi, possiamo fare almeno il nome del vescovo di
Trieste, Antonio Santin, che mostrò sempre il massimo rispetto per i suoi diocesani di etnia slava (e
che sarebbe stato ricompensato, dopo il 1945, con minacce, pugni e sputi da parte delle autorità
comuniste jugolsave e della folla, da esse aizzata contro di lui).
Poi, nell'aprile del 1941, la fulminea occupazione della Jugoslavia da parte delle forze italotedesche; l'annessione all'Italia della provincia di Lubiana e di parte della Dalmazia; l'inizio della
guerriglia partigiana slava e le spietate repressioni del regio esercito; i difficili rapporti con il
regime ustascia insediatosi in Croazia, teoricamente satellite di Mussolini; la persecuzione degli
Ebrei da parte di nazisti ed ustascia e, sovente, la loro protezione da parte delle forze armate
italiane, al punto da incrinare seriamente i rapporti diplomatici di Roma con Berlino e Zagabria; e,
infine, il dramma dell'8 settembre 1943.
Se l'8 settembre ha significato, per l'Italia in generale, la "morte dello Stato", nelle province di
Gorizia, Trieste (molto più ampie di oggi), Pola, Fiume, Zara, quello fu l'inizio di una tragedia
senza pari, di un vero e proprio incubo. Approfittando della dissoluzione dell'esercito italiano e del
collasso dell'amministrazione civile, bande di partigiani croati e sloveni, con il sostegno delle
rispettive etnie, fecero irruzione nei paesi e nelle città, dove prevaleva l'elemento italiano, e si
abbandonarono a un'orgia di vendette sanguinose, che culminarono in una prima stagione, breve ma
1
tremenda, di infoibamenti. Non si sarebbe creduto che gli slavi delle province orientali italiane
avessero maturato un rancore così profondo, un desiderio di rivalsa così sanguinario: ma fu
precisamente quello che accadde in quei giorni.
Le violenze incontrollate su una popolazione inerme, per fortuna, non durarono a lungo, perché nel
giro di qualche giorno arrivarono in forze i tedeschi, che rilevarono l'amministrazione civile italiana
e il disciolto esercito regio. Quella fu, probabilmente, l'unica parte d'Italia in cui l'arrivo delle forze
armate germaniche fu salutato come quello dei provvidenziali liberatori. Sta di fatto che i tedeschi
ripresero velocemente il controllo della situazione, ripristinarono un minimo di ordine e salvarono,
è il caso di dirlo, migliaia di italiani da una fine atroce.
La guerriglia partigiana, però, egemonizzata dai comunisti del maresciallo Tito, non fece altro che
ripiegare temporaneamente nelle zone più inaccessibili, nei boschi e sulle montagne, donde si
organizzava (anche col materiale da guerra catturato all'esercito italiano dopo l'8 settembre) e
incominciava a sferrare decisi, micidiali attacchi contro le forze d'occupazione, oltre che contro le
truppe ustascia di Ante Pavelic e contro i cetnici, monarchici e anticomunisti, di Draga Mihailovic.
Insomma una guerra feroce di tutti contro tutti, che all'inimicizia lungamente sopita fra slavi e
italiani, vedeva intrecciarsi e sovrapporsi quella fra le diverse etnie e i diversi orientamenti politici
dei gruppi partigiani della ex Jugoslavia.
Sulle Prealpi Giulie si formarono anche delle bande partigiane italiane, che poi, nell'estate del 1944
riuscirono a creare la più vasta "repubblica partigiana" di tutta la guerra civile 1943-45 (insieme a
quella della Carnia), tra il Friuli orientale, la valle dell'Isonzo e la Selva di Ternova. Ma in
settembre essa venne distrutta e la rappresaglie tedesche si abbatterono inesorabili sulle stremate
popolazioni; fra l'altro, vennero incendiati i tre paesi di Nimis, Attimis e Faedis, posti sulle pendici
prealpine tra Gemona e Cividale.
In quelle regioni orientali d'Italia i gruppi partigiani erano in prevalenza formati da comunisti,
inquadrati nelle divisioni Garibaldi, la cui politica verso i partigiani jugoslavi era di piena
collaborazione, mentre non sempre altrettanto buoni erano i rapporti fra essi e le formazioni
partigiane di ispirazione moderata, specialmente cattolica, inquadrate nei reparti della Osoppo. A un
certo punto, anzi, le relazioni fra garibaldini dal fazzoletto rosso e osovani dal fazzoletto verde si
logorarono al punto da degenerare nell'atroce massacro di Porzus, di cui si è finalmente tornato a
parlare dopo tanti anni di occultamenti e di colpevoli silenzi.
La collaborazione fra garibaldini e comunisti del IX Korpus sloveno, viceversa, si spinse fino al
passaggio dei primi sotto il comando strategico dei secondi, che ne ordinarono il trasferimento al di
là dell'Isonzo; ciò che lasciava campo libero agli jugoslavi nel far valere ambiziose rivendicazioni
territoriali nei confronti non solo dell'intera Venezia Giulia (Trieste compresa), ma anche di una
larga porzione del Friuli, possibilmente fino al Tagliamento. E tutto questo, con il sostanziale
assenso di Togliatti che, rientrato in Italia nel 1943, dopo anni di esilio nell'Unione Sovietica, aveva
lanciato la "svolta di Salerno" all'insegna dell'unità antifascista, comprese (per il momento) le forze
monarchiche del Regno del Sud e le formazioni partigiane d'ispirazione moderata.
Tutta la regione della Venezia Giulia e la stessa provincia di Udine, frattanto, con il nome di
Adriatische Kunstenland (Litorale Adriatico), erano state poste sotto il comando diretto di un
Gauleiter del Terzo Reich, l'austriaco Friederich Rainer, mentre la "sicurezza" (ossia le operazioni
contro la guerriglia partigiana) era affidata a un personaggio che ha lasciato di sé una fama alquanto
sinistra: Odilo Globocnik. Nella regione alpina della Carnia, poi, i tedechi avevano autorizzato
perfino il trasferimento di una intera popolazione cosacca che, proveniente dal Kuban, avrebbe
dovuto crearsi una nuova patria intorno a Tolmezzo: si trattava di russi collaborazionisti, sotto il
comando del generale P. N. Krasnov (già noto in Europa, fra le due guerre, come autore di fortunati
romanzi storici).
Ma il "Reich millenario" aveva ormai i giorni contati e, tra la fine di aprile e i primi di maggio del
1945, le difese tedesche crollarono sotto la duplice spinta dei partigiani jugoslavi di Tito e delle
armate anglo-americane che, dopo il forzamento della linea del Po, avanzavano lungo l'alto
Adriatico, in direzione di Trieste.
2
La gara di velocità per entrare primi nel capolugo giuliano fu vinta, sia pure di poco, dai titini, nel
quadro di un disegno annessionistico lungamente premeditato; tanto è vero che sia Lubiana che
Zagabria furono occupate da essi solo in un secondo momento, ben sapendo che, in quel caso, non
avrebbero dovuto sostenere alcuna discussione internazionale per il loro possesso. Per quaranta
giorni (1° maggio-12 giugno 1945), le forze partigiane jugoslave occuparono la città, sequestrando
materiale, arrestando indiscriminatamente persone sospette, imponendo un clima di terrore, con
l'appoggio della minoranza slovena residente nei quartieri operai della periferia; e quando, alla fine,
sotto la pressione anglo-americana, si decisero ad evacuare Trieste, un numero imprecisato di
cittadini italiani risultarono mancanti all'appello: parte erano stati uccisi, parte deportati verso ignota
destinazione e con imputazioni tanto vaghe quanto speciose.
Nelle campagne e nelle cittadine del goriziano, dell'Istria, di Fiume e di Zara (quest'ultima
completamente distrutta, nel 1943, da criminali bombardamenti delle "fortezze volanti" alleate), tra
la fine di aprile e il maggio del 1945 si scatenò una seconda, e ancor più sanguinosa, ondata di
violenze d'ogni genere e di uccisioni a danno della popolazione italiana. A migliaia vennero gettati
nelle foibe: fascisti e antifascisti, uomini e donne, giovani e vecchi, proprietari e operai. La verità è
che, con il pretesto dell'epurazione antifascista, i comunisti jugoslavi condussero una vera e propria
operazione di "pulizia etnica", allo scopo di spargere il terrore fra la popolazione italiana e indurla a
fuggire in massa, facilitando così l'annessione di quei territori da parte di Belgrado. Operazione che
venne coronata da un successo pressoché totale, dato che fra il 1945 e il 1947, quando apparve
evidente che il trattato di pace avrebbe sancito l'ingiusta cessione di quasi tutta la Venezia Giulia e
di tutta la Dalmazia alla Jugoslavia, comprese città italianissime come Pola e Zara, si verificò un
esodo di italiani che coinvolse più di 350.000 persone.
Se ne andarono senza nulla poter portare con sé, dopo aver vissuto per oltre due anni nell'angoscia
e, in molti casi, dopo aver assistito a violenze d'ogni genere o averle personalmente subite: minacce,
stupri, pestaggi, uccisioni. I circa 30.000 italiani di Pola, partendo a bordo delle navi per non tornare
mai più, lasciarono aperte le porte delle loro case, come ad invitare gli Jugoslavi a prendersi ogni
cosa. Facilitando loro il furto legalizzato dei sacrifici di una intera vita, vollero con quel gesto
sottolineare la violenza di cui erano vittime.
Non è necessario indugiare, in questa sede, su cose ormai note, anche se lungamente rimosse dalla
memoria, perché quegli italiani che fuggivano dal terrore delle foibe erano maledettamente
"scomodi" e la loro accoglienza, nell'Italia dell'immediato dopoguerra, fu tutt'altro che generosa.
Rinchiusi nei campi di raccolta, frastornati, senza nulla tranne gli abiti che indossavano e
pochissimo altro, venivano spesso additati - specie dal Partito Comunista Italiano, nel clima
arroventato che precedette le elezioni politiche del 1948 - come fascisti, traditori, poco meno che
delinquenti. Sono oggi disponibili buone ricerche storiche su questi tragici fatti, da quando - con la
fine della "guerra fredda" - anche l'Italia ha cominciato a voltare pagina e si è sforzata di ritrovare le
ragioni di un clima politico normale; anche se il pericolo delle strumentalizzazioni è sempre
presente, come se i morti e i profughi fossero appannaggio di una sola parte ideologica. Ma questo è
un vecchio vizio tipicamente italiano: il rifiuto di una memoria condivisa, in nome di uno spirito di
fazione che offusca i valori universali.
Ricordiamo soltanto alcuni titoli, fra le numerose opere oggi disponibili: Lo sterminio mancato. La
dominazione nazista nel Veneto orientale, 1943-45, di Pier Arrigo Carnier (Milano, Mursia editore,
1982); Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio, di Raoul Pupo (Milano, Rizzoli,
2005); Senza pace. L'incerto confine orientale italiano in trent'anni di storia (1915-1945), di
Franco Stefani (Udine, Cooperativa Editoriale Il Campo, senza data); e, ancora, L'esodo. La
tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia,di Arrigo Petacco (Milano,
Arnoldo Mondadori editore, 1999). In queste opere, il lettore desideroso di approfondimenti potrà
trovare molti dati interessanti e ancora poco noti al grande pubblico; perché, per le ragioni
anzidette, una pesante cortina di silenzio è pesata sulle vicende della Venezia Giulia fra il 1943 e il
1947.
3
Ma spesso, più che i lavori - pur importanti - degli studiosi di professione, per comprendere il clima
di certi momenti storici sono utili le memorie dirette delle persone comuni che ebbero in sorte di
trovarsi nell'occhio del ciclone, videro ogni cosa e riuscirono a sopravvivere, per raccontare le loro
drammatiche esperienze ai contemporanei che non c'erano - o, se questi non vogliono ascoltare, alle
generazioni successive.
Uno di questi testimoni straordinari è appunto, come abbiamo detto più sopra, Mafalda Codan. Nel
1943, quando si scatenò la prima ondata di violenze anti-italiane, aveva appena diciassette anni; nel
1945, quando si rifugiò a Trieste, dopo la strage della sua famiglia, ma fu di nuovo arrestata e
deportata dagli jugoslavi, ne aveva diciannove. Oggi è una signora di ottantadue anni, insegnante in
pensione, e vive a Bibione.
Ha scritto un diario della sua esperienza di guerra, che costituisce un eccezionale documento
storico. Basti dire che sette persone della sua famiglia vennero trucidate dai partigiani slavi e che lei
stessa venne deportata in Jusoslavia a guerra finita, e rilasciata solo nel 1949, in seguito a uno
scambio di prigionieri organizzato dalla Croce Rossa. Suo padre, arrestato a Parenzo subito dopo i
fatti dell'8 settembre 1943, era stato gettato nella foiba di Vines, insieme a tre zii e a un cugino
della madre. Lei stessa, allora, con la madre e un fratello, si era rifugiata a Trieste, dove però cadde
nuovamente nelle mani dei comunisti jugoslavi, nel maggio del 1945, insieme al fratello. Riportata
a Parenzo, subì un "processo popolare" da parte degli ex coloni di suo padre, fu insultata,
sputacchiata, e infine condannata a morte.
Durante un trasferimento via mare come prigioniera, fece naufragio, allorché la nave su cui
viaggiava urtò contro una mina; salvatasi miracolosamente e sbarcata, fu accolta dai bastoni e dalle
grida ostili della folla, che la ricondusse dai suoi aguzzini. Trasferita a Pisino, le fu ucciso il
fratello, il cui corpo venne gettato nella foiba. Successivamente venne rinchiusa nel carcere di
Fiume; poi, fino al maggio del 1946, in quello di Maribor. Internata, da ultimo, nel campo di
"rieducazione" di Begunje, venne liberata, come si è detto, nel 1949, a Gorizia, in seguito a uno
scambio di prigionieri.
Il diario di Mafalda Codan è stato pubblicato dall'istituto Regionale per la Cultura Istriana, in
collaborazione con l'Unione degli Istriani, col titolo: Sopravvissuti alle deportazioni in Jugoslavia
(Trieste, Bruno Facchin Editore), e ad esso rimandiamo per una lettura completa. Qui ci limitiamo a
riportarne pochi passi particolarmente significativi, già pubblicati del musicista e saggista
Alessandro Tortato sul numero del 9 febbraio 2008 del Corriere della Sera, a pag. 18 dell'inserto
del Corriere del Veneto.
Non vi aggiungiamo alcun commento, perché sarebbe inutile e poco rispettoso. I fatti riportati sono
tali, che richiedono solo silenzio e una profonda capacità di ascolto.
"Il 7 maggio 1945 prendo un libro e vado in giardino. Appena uscita mi trovo davanti tre
partigiani comandati da Nino Stoinich con il mitra spianato. Prima di tutto si rallegrano
dell'orribile morte dei miei cari e poi mi intimano di seguirli. (…)
"Prima sosta, Visinada. Mi portano sulla piazza gremita di gente, partigiani, donne scalmanate,
urlano, gesticolano, imprecano. S. mi presenta come italiana, nemica del popolo slavo, figlia di
uno sfruttatore dei poveri, tutti cominciano a insultarmi, a sputacchiarmi, a picchiarmi con lunghi
bastoni e a gridare: a morte, a morte. Vedo i miei coloni e molte persone aiutate e mantenute gratis
da mio padre. Non posso credere ai miei occhi, sono gli stessi che prima 'veneravano' la mia
famiglia e si consideravano amici, ora sono qui per condannarmi e per gridare. 'a morte'. A Santa
Domenica mi portano davanti alla casa di Norma Cossetto, infoibata nel settembre del 1943,
chiamano sua madre, vogliono farla assistere alle mie torture per ricordarle il martorio della sua
Norma. (…)
"Nell'ex dopolavoro mi attendono tre donne. Mi legano a una colonna in mezzo alla sala, a sinistra
e a destra mi mettono due bandiere slave con la stella rossa e sopra la testa il ritratto di Tito. E un
druze grande e grosso che dà il via al pestaggio. Con tutta la sua forza comincia a percuotermi con
una cinghia. Mi colpisce così forte sugli occhi che non riesco più a riaprirli. Mi spiace perché ho
4
sempre avuto il coraggio di fissare negli occhi chi mi picchiava. Le sevizie continuano, le donne mi
colpiscono con grossi bastoni, con delle tenaglie cercano di levarmi le unghie perché sono troppo
corte. Una scalmanata con un cucchiaio di gratta le palpebre gonfie, ferite e chiuse: «Apri gli
occhi che te li levo» mi grida. Più tardi mi fanno fare il giro del paese legata a una catena come
ujn orso, mi segue un codazzo di bambini divertiti. Arriva un caro, mi fanno salire, fanno correre il
cavallo e io devo stare in piedi. Le continue scosse mi fanno cadere e, ogni volta, un colpo di mitra
mi rialza. (…)
[Poi Mafalda è trasferita nel carcere di Pisino e rinchiusa in una cella proprio accanto a quella
dove è stato messo suo fratello].
"Le urla di dolore di mio fratello Arnaldo e degli altri suoi compagni di pena mi risuonano
dolorosamente nella testa giorno e notte. (…)
"Al mattino gli aguzzini entrano felici di aver ucciso tanti nemici del popolo. Li hanno massacrati
tutti. Uno entra e mi chiede: Quanti anni aveva tuo fratello? Non voleva morire sai, anche dopo
morto il suo corpo ha continuato a saltare.(…)
E che cosa pensa, oggi, Mafalda Codan di tutti quegli orrori?
"Non ho odio, ma continuo a provare un grande dolore ancora oggi non solo per avere perso sette
parenti stretti e per aver subito le torture, ma per il silenzio vergognoso di tutti questi anni."
Un silenzio durato, veramente, troppo a lungo.
5