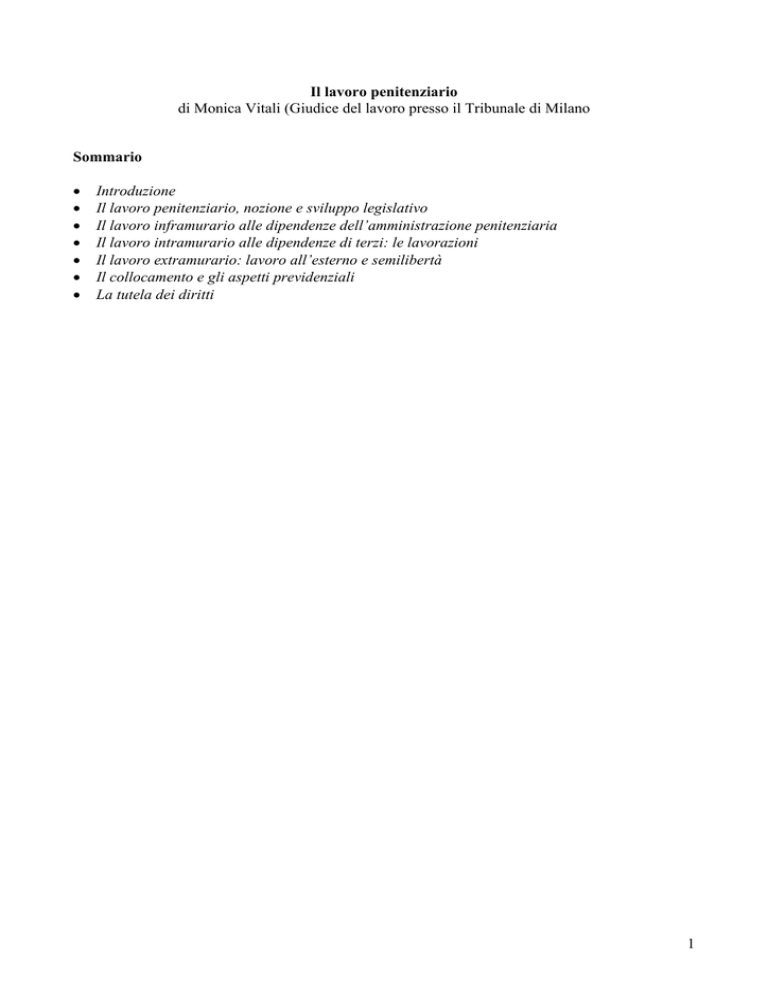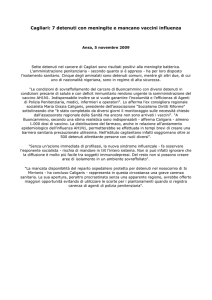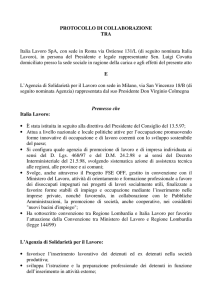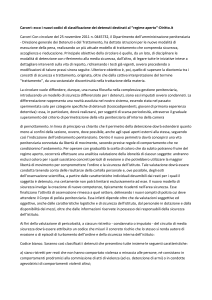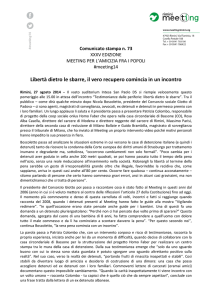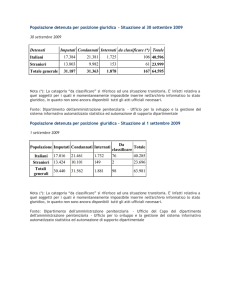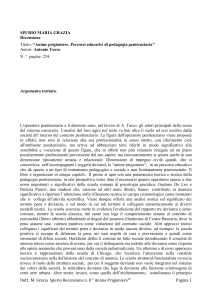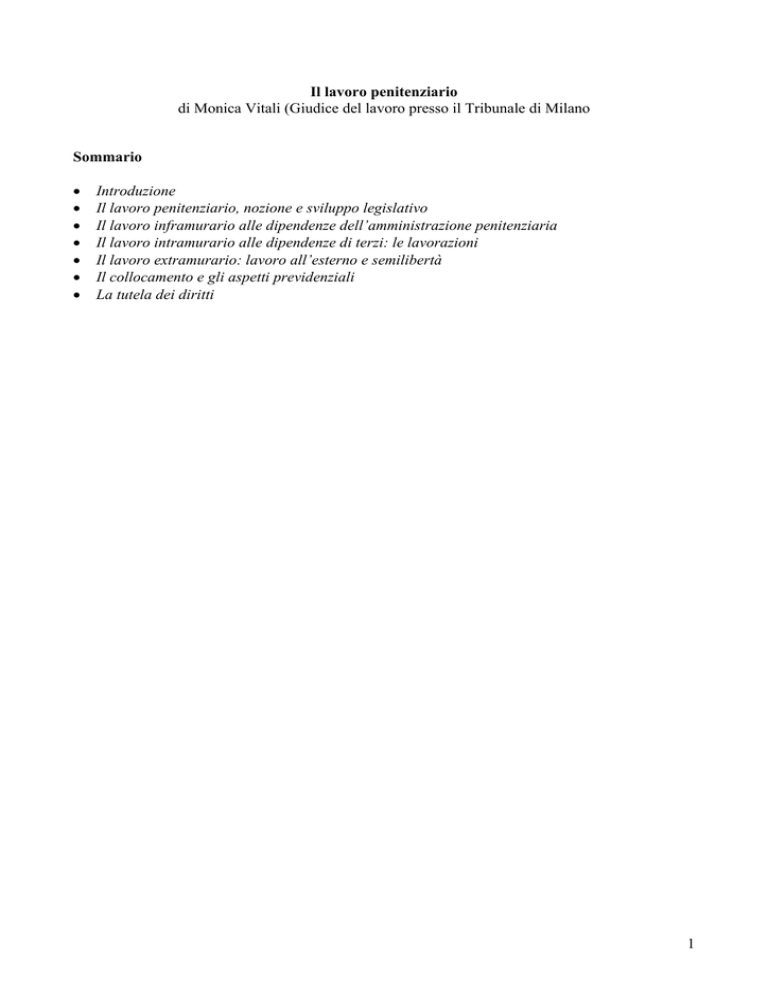
Il lavoro penitenziario
di Monica Vitali (Giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano
Sommario
•
•
•
•
•
•
•
Introduzione
Il lavoro penitenziario, nozione e sviluppo legislativo
Il lavoro inframurario alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria
Il lavoro intramurario alle dipendenze di terzi: le lavorazioni
Il lavoro extramurario: lavoro all’esterno e semilibertà
Il collocamento e gli aspetti previdenziali
La tutela dei diritti
1
Prefazione (Virginio Colmegna, direttore della Caritas Ambrosiana)
Siamo di fronte ad un lavoro di qualità scientifica ma che assume anche una importante valenza
sociale: questa opera nasce in un contesto, per così dire, partecipato. È il contesto di un patto tra i
sindacati, le associazioni imprenditoriali, il volontariato. la Provincia e il Comune di Milano che si
sono riuniti in un’Associazione per favorire il lavoro dei detenuti, degli ex detenuti e delle persone
soggette a trattamento penale esterno.
Perché inserire al lavoro persone sottoposte a esecuzione pena o che l’hanno appena espiata?
Anzitutto per il profondo valore che questo può avere per la società nel suo complesso.
La società si propone per sanare uno strappo causato dall’autore di reato, offrendogli uno spazio al
proprio interno. Uno spazio che sia fortemente connotato di doveri/diritti, uno spazio nel quale sia
possibile stare e i cui confini siano molto chiari. Per tali ragioni, il lavoro è sempre stato considerato
uno degli strumenti migliori per identificare questo spazio.
Inoltre, essere in un contesto produttivo significa anche, per il detenuto, entrare concretamente in
quel sistema sociale che ha come compito la tutela della cittadinanza promovendo la legalità, sia
comminando le pene, sia sviluppando capacità di prevenzione e recupero.
Il tema lavoro riporta in modo forte alla questione delle pene alternative al carcere: cioè di tutti quei
modi diversi dalla privazione della libertà per ritornare in un rapporto positivo con la società.
Il lavoro è anche il primo passo perché una persona possa non scegliere i sistemi criminali, ma
quelli legali. Bisogna chiedere ai sottoposti a pena di assumersi una grande responsabilità verso la
società, proprio come strumento di risarcimento. Bisogna chiedere loro di puntare sulla concretezza:
dimostrare operativamente la volontà ad essere parte di una società, nei modi in cui questa società
sa regolare la convivenza legale.
Bisogna chiedere loro di non aspettarsi nulla di pronto, ma di mettersi all’opera per ricevere la
formazione adeguata e cercare lavoro. Questo si può fare solo offrendo opportunità reali. A questo
scopo l’Associazione Agenzia di Solidarietà per il Lavoro ha messo a punto degli Sportelli per i
detenuti delle carceri della provincia di Milano e per gli esterni. Sportelli nei quali si possono
affrontare, a tutti i livelli, gli aspetti dell’inserimento lavorativo. L’Agenzia può rendere questi
Sportelli pienamente operativi solo a patto che il tessuto produttivo e sociale sia pronto.
Agli imprenditori si chiede di rendersi disponibili alle domande legate all’inserimento di personale
in condizione di detenzione. Bisogna che si preparino: i problemi maggiori vengono dalla
burocrazia, non certo da lavoratori che sono molto più motivati degli altri.
L’Agenzia offre gratuitamente un servizio completo a tutti coloro che, imprenditori, desiderino
assumere persone in una situazione di svantaggio sociale. Vi è poi un servizio informatizzato di
banca dati, in stretta connessione con il sistema degli uffici provinciali, che consente di avere una
chiara fotografia sulle competenze dei detenuti e degli altri soggetti ristretti nella libertà. Rilevante è
l’importanza attribuita all’attività di carattere culturale e scientifico.
L’Agenzia si è da subito caratterizzata per il suo eminentissimo Comitato Scientifico (composto da:
Pietro Ichino, Francesco Maisto, Laura Mengoni, Franco Scarpelli, Carlo Stelluti, Monica Vitali),
nella consapevolezza che gli strumenti operativi e i momenti di discussione ed approfondimento,
ben suffragati da ricerca, sono la vera strada per creare il cambiamento.
In questo contesto, nasce questo volume, il cui grande valore è da attribuirsi in toto a chi lo ha
scritto, ma che la nostra Agenzia (grazie anche alla Provincia di Milano) ha commissionato, per
dare fondamento scientifico all’impegno che faticosamente svolgiamo ogni giorno e per offrire
competenze e conoscenze adeguate a chi opera dentro e fuori il carcere, alle imprese che si offrono
ad assumere persone che arrivano dal carcere e a chi, come l’Agenzia, ha il compito di sollecitare la
partecipazione.
2
Introduzione
Il problema peculiare del lavoro penitenziario, inteso come lavoro caratterizzato soggettivamente
dalla condizione di detenuto del prestatore di lavoro, è quello del continuo intersecarsi tra situazioni
giuridiche nascenti dal rapporto di lavoro e istanza punitiva dello Stato. Il tema del riconoscimento
dei diritti di coloro che prestano una attività lavorativa durante la detenzione, infatti, può essere
sintetizzato nella dicotomia tra "detenuti lavoratori" e "lavoratori detenuti" ed è stato affrontato,
essenzialmente, in un’ottica penale e penitenziaria, così da privilegiare, rispetto ai diritti civili dei
lavoratori detenuti, la pretesa punitiva dello Stato, subordinando permanentemente i primi alla
seconda.
Come è stato autorevolmente affermato, la secolare ossessione dell’istituzione penitenziaria è stata
ed è quella di vedersi distruggere dall’affermazione dei diritti. Tale ossessione ha condizionato e
condiziona, ancor oggi, il modo con cui i penitenzialisti affrontano l’argomento, atte standosi su una
linea difensiva tutta tesa alla salvaguardia del rapporto punitivo e poco attenta al tema del
riconoscimento dei diritti, riconoscimento che, al contrario, appare l’elemento centrale nel pensiero
dei (pochi) giuslavoristi che, in tempi ormai lontani, si sono avvicinati al tema.
Tale approccio difensivo non è stato abbandonato neppure dopo l’entrata in vigore della prima
legge sull’ordinamento penitenziario del 1975 e della successiva novella del 1986, la c.d. Legge
Gozzini: i riflessi di tale approccio saranno posti in luce nel prosieguo del discorso, ma, in questa
sede introduttiva, vale la pena di evidenziare la profonda limitazione culturale che questa ossessione
ha comportato, sotto il profilo della tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori detenuti, sempre e
comunque considerati come detenuti lavoratori.
Sotto altro profilo, le novità introdotte con la L. n. 663 1986 (c.d. Legge Gozzini) hanno addirittura
raddoppiato l’ossessione lavoristica dei penitenzialisti: la Legge Gozzini si poneva non solo
l’obiettivo di migliorare il governo del carcere, bensì anche quello di decarcerizzare, prevedendo un
catalogo più ampio di alternative alla detenzione.
La tendenza giurisprudenziale che si è venuta formando ha però finito, in generale, con l’attribuire
all’attività lavorativa il carattere di presupposto necessario per il riesame della pretesa punitiva dello
Stato, anche laddove non era normativamente richiesto, per esempio in materia di affidamento in
prova al servizio sociale, e, in particolare, con il connotare il lavoro come presupposto essenziale
per l’ammissione alle misure alternative nell’unica direzione del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, valutando come inaffidabili ipotesi diverse da questo paradigma.
Il circolo virtuoso immaginato dal legislatore, di allargamento delle occasioni di lavoro, come
conseguenza dell’ampliamento delle misure alternative non si è, quindi, realizzato, ed è quanto mai
improbabile che si verifichi ora, nell’attuale assetto del mercato del lavoro: persino un legislatore
poco innovativo come quello italiano, ha preso atto della mutata situazione occupazionale,
riconoscendo maggiori spazi alle ipotesi di lavoro autonomo, interinale e a tempo determinato, così
che la pretesa della Magistratura di Sorveglianza di moderare il lavoro extramurario nei termini
tradizionali del rapporto subordinato a tempo indeterminato risulta ancorata a schemi superati dalla
situazione di fatto e restringe, ancora una volta, l’ambito di operatività della decarcerizzazione.
L’evoluzione legislativa emergenziale ha condiviso e favorito queste linee di tendenza
giurisprudenziale: la modifica strutturale del lavoro penitenziario, attuata normativamente, si è
mossa appunto nell’ottica di un allargamento delle ipotesi di lavoro inframurario, sul presupposto di
ormai acquisite restrizioni all’ammissione al lavoro extramurario, attraverso la riduzione degli spazi
delle misure alternative.
Il presupposto, rimasto invariato e sottostante ad ogni riflessione in materia, è comunque quello
della peculiarità del lavoro penitenziario, in quanto giuridicamente collegato alla valenza
rieducativa: la funzione terapeutica del lavoro ha così finito per incidere sulla causa del rapporto
che, ancor oggi, non è visto in termini di neutra sinallagmaticità, bensì di assoggettamento a un
3
regime riabilitativo, con conseguenti discriminazioni, rispetto ai lavoratori e tra gli stessi lavoratori
detenuti.
In realtà, il lavoro non può più ritenersi seriamente uno strumento terapeutico, per la gran parte dei
detenuti attualmente ristretti nelle carceri italiane: in primo luogo, perché essi sono in grande misura
stranieri, privi di prospettive giuridiche di inserimento nella realtà sociale ed economica italiana; in
secondo luogo, su un piano più generale, perché la strada del lavoro terapeutico non può
prescindere dalla possibilità di offrire occasioni di lavoro professionalmente gratificanti e spendi
bili nel mondo esterno (e qui il discorso riguarda anche i detenuti italiani).
L ‘abbandono della prospettiva terapeutica, prima ancora che dar luogo a modificazioni legislative,
si deve tradurre in un diverso criterio interpretativo d’individuazione dei diritti del lavoratore
detenuto, sottolineando che sono gli stessi che ineriscono al rapporto di lavoro di ogni soggetto di
diritti, con le necessarie limitazioni derivanti dalle esigenze di un regime detentivo. In altri termini,
si tratta di ridefinire il rapporto di lavoro dei detenuti, non come un tipo legale a se stante,
caratterizzato dalla finalità rieducativa (finalità che si è ormai ridotta a una fiera foglia di fico sotto
la quale occultare il fallimento della prospettiva correzionale), bensì come un normale rapporto di
lavoro, salvi alcuni indispensabili adattamenti legati alla condizione soggettiva di una delle parti del
rapporto stesso. È questa la prospettiva in cui si muove la presente trattazione.
4
Il lavoro penitenziario: nozione e sviluppo legislativo
Evoluzione storica del lavoro penitenziario
Il tema del lavoro penitenziario aveva suscitato nei primi anni Settanta l’interesse di alcuni
giuslavoristi, che ravvisarono nella disciplina, allora vigente, i segni persistenti di rapporti giuridici
desueti e di modelli appartenenti ad un’epoca ormai remota. Il materiale normativo con cui tali
autori si dovevano confrontare era ancora costituito dal R.D. 18 giugno 1931 n. 787, che
considerava il condannato come privo di qualsiasi capacità di agire, attribuendo, in modo
paternalistico, allo Stato una superiore funzione educativa e di tutela, con la conseguenza che il
lavoro veniva concepito come parte integrante della pena e come strumento di ordine e disciplina.
In quanto sottratto, in ogni suo aspetto, alla disponibilità del detenuto, il lavoro era un obbligo, ma,
almeno nell’opinione prevalente, non un diritto, non faceva sorgere, di massima, interessi tutelabili
giuridicamente, mancando ogni rapporto di corrispettività tra lavoro prestato e mercede ricevuta.
Per ogni aspetto, il rapporto di lavoro del detenuto era appiattito sulla incombente e prevalente
funzione punitiva assegnata all’istituzione carceraria.
La dottrina e la giurisprudenza, dal canto loro, non avevano sottoposto ad alcuna valutazione critica
il lavoro carcerario, pur in presenza dei principi costituzionali - cardine del diritto del lavoro,
ricostruendolo, in termini teorici, come una prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo
schema del rapporto di lavoro subordinato in quanto nascente da un obbligo legale.
La novità della Legge sull’ordinamento penitenziario L. 26 luglio 1975 n. 354
La grande novità portata dalla L. 26 luglio 1975 n. 354 e dal successivo regolamento di esecuzione,
D.P.R. 29 aprile 1976 n. 43l, sotto il profilo che qui interessa, è costituita proprio dal fatto che, pur
essendo ribadita l’obbligatorietà del lavoro dei detenuti, il lavoro stesso tende a perdere il carattere
afflittivo, per diventare un elemento cardine del trattamento penitenziario, diretto a rieducare il
detenuto e a reinserirlo nella collettività, attraverso l’adozione di comportamenti conformi ai
parametri correnti di normalità sociale.
Su di un piano più generale, viene a modificarsi la posizione del detenuto nei suoi rapporti con
l’Amministrazione penitenziaria, nel senso che l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario
devono riflettere quelli del lavoro nella società libera (art. 20 L. n. 354/1975) e la determinazione
delle remunerazioni dovute, a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato, viene agganciata
agli indici di adeguatezza fissati dalla contrattazione collettiva (art. 22 O.P.). Ciò non significa,
peraltro, che sia accolto, in ambito di lavoro carcerario, il principio di corrispettività tra lavoro e
retribuzione, conformemente ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza, di cui all’art.
36, 1 comma, Cost., dal momento che si parla di mercede, e non di retribuzione, e viene comunque
mantenuta la trattenuta dei tre decimi finalizzata all’assistenza alle vittime del delitto.
Una valutazione complessiva della riforma non può, tuttavia, nascondere il fatto che alcune
affermazioni, come quella concernente la necessità di far acquisire ai detenuti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, per agevolarne il reinserimento sociale,
sono di carattere puramente pro grammatico e resteranno disattese già in sede di regolamento di
attuazione.
In linea generale, poi, la modificazione tipologica del lavoro carcerario viene ridimensionata dallo
stesso legislatore, in quanto la realizzazione delle finalità del trattamento viene condizionata al
mantenimento della disciplina in carcere.
La legge di modifica dell’ordinamento penitenziario 10 ottobre 1986 n. 663, c.d. Legge Gozzini,
prosegue sulla stessa linea di tendenza, rimuovendo alcune limitazioni, poste in precedenza,
all’ammissione al lavoro all’esterno, introducendo una fase di controllo giurisdizionale nel
procedimento che ne regola l’ammissione del detenuto e, soprattutto, abolendo la trattenuta dei tre
5
decimi sulle mercedi. In quegli stessi anni, altre norme vengono a incidere sul tema del lavoro
carcerario:
si tratta di disposizioni sparse in vari strumenti legislativi, quali la L. 28 febbraio 1987 n. 56 e il
D.P.R. 18 maggio 1989 n. 248, che aumentano la sensazione dell’interprete di trovarsi di fronte ad
un complesso normativo scoordinato e lacunoso, nel quale risulta difficile orientarsi per la
frammentarietà e l’imprecisione dei testi normativi.
L’art. 19 L. 56/1987 attiva nuove competenze degli organi pubblici di collocamento per quanto
riguarda la domanda di lavoro extramurario, ma non raggiunge grandi risultati per una serie di
difficoltà che saranno evidenziate a suo tempo: in ogni caso, ciò che emerge è l’eccessiva prudenza
del legislatore, auto limitatosi ad un intervento sulle sole procedure, senza dare spazio a sistemi di
incentivazione alle aziende ed a miglioramenti sul piano della formazione professionale della
popolazione detenuta.
Il D.P.R. 248/1989, poi, ha modificato il regolamento penitenziario in alcune sue parti relative al
lavoro carcerario: anche in questo caso, tuttavia, l’intervento del legislatore pecca di scarsa
incisività, restando confinato agli aspetti della disciplina e della sicurezza. Solo due norme (artt. 47
e 45) si ricollegano direttamente all’attuazione dell’art. 19 L. 56/1987, prevedendo i criteri e le
modalità per l’assegnazione del lavoro ai detenuti.
La legislazione emergenziale
Le più recenti modificazioni legislative appartengono già alla fase cosiddetta emergenziale: la L. 12
agosto 1993 n. 296 ha, infatti, modificato gli artt. 20 e 21 e ha introdotto l’art. 20 bis L. 354/1975.
Sotto un primo profilo, il legislatore ha posto, almeno programmaticamente, sullo stesso piano la
destinazione dei condannati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale,
consentendo, da un lato, l’organizzazione di lavorazioni gestite direttamente da imprese pubbliche o
private, con modalità specificatamente previste, e, dall’altro, l’istituzione di corsi di formazione
professionale svolti da aziende pubbliche o private convenzionate.
Sotto un secondo profilo, è stato introdotto un meccanismo di assegnazione del lavoro intramurario,
cioè un vero e proprio collocamento interno, che opera attraverso la formazione di graduatorie dei
detenuti e di tabelle dei posti, mentre per il lavoro all’esterno vengono richiamate le norme sul
collocamento ordinario e l’art. 19 L. n. 56/1987.
Questo quadro legislativo configura un’ulteriore fase storica del lavoro carcerario: una volta preso
atto che, nella fase precedente, l’aumento delle misure alternative alla detenzione, realizzato dalla
legge Gozzini, non aveva prodotto l’effetto sperato di ampliare le occasioni di lavoro extramurario
per i detenuti e che l’opzione legislativa si è orientata verso un restringimento della possibilità di
accesso ai benefici, necessariamente, il lavoro penitenziario deve modificarsi, nel senso di un
allargamento delle ipotesi di lavoro intramurario in relazione alle ridotte possibilità di svolgimento
di attività lavorative all’esterno, sia per le note limitazioni introdotte con l’art. 4 bis L. 354/75, sia
per la nuova situazione del mercato del lavoro delineatasi sin dalla prima metà degli anni novanta.
La realtà attuale del lavoro nel mondo carcerario è, tuttavia, molto lontana dall’offrire una
possibilità di occupazione intramuraria a tutti i detenuti: infatti, riesce a lavorare in carcere solo una
esigua minoranza sul totale dei ristretti e la gran parte di questi, secondo i dati forniti dal Ministero
della Giustizia, è impegnata nei lavori c.d. domestici, mentre coloro che svolgono lavorazioni per la
committenza pubblica e privata sono un numero quasi insignificante su base nazionale, anche se
molto interessante sotto il profilo qualitativo di alcune esperienze.
Gli ultimi sviluppi legislativi
A distanza di sette anni dalle ultime modifiche alla L. 354, nel giugno 2000 sono stati adottati due
importanti strumenti legislativi: il primo è costituito dal D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230,
"Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
6
della libertà, approvato, dopo un lungo e faticoso iter, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del
16 giugno 2000.
Si tratta di una completa revisione delle norme di esecuzione della L. 26 luglio 1975 n. 354, resa
necessaria dall’evoluzione delle strutture e delle disponibilità dell’amministrazione e dalle mutate
esigenze trattamentali, nell’ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento. Le singole
disposizioni saranno esaminate in relazione ai vari tipi di lavoro penitenziario individuati: in linea
generale, può rilevarsi come, in materia di organizzazione del lavoro, il nuovo regolamento
recepisca l’impostazione contenuta nella novella del 1993, specificando le regole per
l’organizzazione di lavorazioni penitenziarie, sia all’interno che all’esterno dell’istituto, gestite
direttamente anche da imprenditori, pubblici o privati, o da cooperative sociali.
Il secondo è costituito dalla L. 22 giugno 2000 n. 193, c.d. Legge Smuraglia: recependo le
indicazioni di larghi settori del privato sociale, il legislatore è finalmente intervenuto, modificando
la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con
l’aggiunta, alle categorie già contemplate dall’art. 4 L. 8 novembre 1991 n. 381, delle "persone
detenute o internate negli istituti penitenziari".
Ha, poi, esteso il sistema di sgravi contributivi e fiscali, già previsto in favore delle cooperative
sociali, alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all’interno
degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, facendo, per la prima volta, un
apprezzabile sforzo per rendere appetibile alle imprese esterne l’utilizzo della manodopera detenuta.
Il lavoro nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
Un significativo contributo all’individuazione della nozione di lavoro penitenziario è stato offerto
dalla pluriennale giurisprudenza della Corte Costituzionale. Fondamentale è in proposito la sentenza
30 novembre 1988 n. 1087 che, pur non essendo la prima in argomento, costituisce il punto di
partenza per qualunque elaborazione sul tema. La Corte, nel dichiarare infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 L. 261uglio 1975 n. 354, ha sancito la distinzione tra lavoro
dei detenuti e dei non detenuti, riconoscendo espressamente la peculiare funzione del lavoro dei
primi, quale elemento fondamentale del trattamento rieducativo e del reinserimento sociale, senza
che tale particolarità possa, tuttavia, concretarsi in minori garanzie per i lavoratori detenuti,
certamente in contrasto con i principi costituzionali.
Il successivo passo dei giudici della Consulta è stato quello di individuare le diverse situazioni
soggettive dei detenuti lavoratori corrispondenti a quattro diverse tipologie di rapporto di lavoro
carcerario:
1. il lavoro svolto all’interno dell’istituto, alle dipendenze della stessa Amministrazione
Penitenziaria come addetti ai c.d. lavori domestici interni;
2. il lavoro svolto all’interno dell’istituto, come addetti alle c.d. lavorazioni;
3. il lavoro extramurario svolto in regime di semilibertà;
4. il lavoro all’esterno di cui all’art. 21 L. 354/1975 alle dipendenze di un soggetto privato, ma
sotto il diretto controllo della direzione carceraria.
L’argomentazione della Corte non sembra originale, laddove si adegua in forma acritica alla tesi
penitenzialistica, secondo cui il lavoro carcerario, in quanto strumento per il recupero dei detenuti
ed il loro riadattamento alla vita sociale, è una semplice modalità trattamentale, da valorizzare per i
suoi scopi special-preventivi, che, tuttavia, non deve essere assoggettata alla disciplina del lavoro
libero.
Risulta, al contrario, originale, nel momento in cui limita questa valutazione al solo lavoro
inframurario alle dipendenze dell’Amministrazione, chiarendo che, per il lavoro extramurario, il
rapporto che viene ad instaurarsi è disciplinato, nei suoi elementi essenziali, dal diritto comune. Le
diverse situazioni di lavoro carcerario verranno esaminate una ad una, suddividendole, a fini
espositivi, in tre categorie:
1. il lavoro inframurario alle dipendenze della Amministrazione carceraria;
7
2. il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi;
3. il lavoro extramurario, svolto in regime di lavoro all’esterno o di semilibertà.
Si affronteranno gli argomenti dell’evoluzione e dello svolgimento del rapporto, della sua
costituzione e cessazione, sulla base del paradigma della riconducibilità di ciascuno al tipo legale di
cui all’art. 2094 c.c., tentando di tenere distinti, sul piano degli effetti giuridici, il rapporto di lavoro,
da un lato, e il rapporto punitivo, dall’altro. La riflessione riguarda anche la tipologia di lavoro per
la quale tale distinzione appare più complessa, cioè il lavoro inframurario alle dipendenze della
Amministrazione carceraria.
Le attività artigianali, intellettuali e artistiche
Nella figura generale del lavoro carcerario sono anche comprese altre realtà lavorative che meritano
alcuni brevi cenni. In primo luogo, le attività artigianali, intellettuali e artistiche di cui all’art. 20 L.
n. 354/1975 e all’art. 51 Regolamento; in secondo luogo, il lavoro a domicilio di cui all’art. 19 VI e
VII comma L. 56/1987 e all’art. 52 Regolamento ed, infine, il lavoro autonomo di cui all’art. 48 XII
comma Regolamento.
Per quanto riguarda le prime, l’art. 20 XV comma L. 354/1975 espressamente prevede che "I
detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possano essere
esonerati dal lavoro ordinario all’interno del carcere ed essere ammessi ad esercitare, per proprio
conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche".
Tali attività autonome, in base alle disposizioni dell’art. 51 del nuovo regolamento, che ricalca,
sotto questo aspetto, il precedente testo, si svolgono, fuori dalle ore destinate al lavoro ordinario, in
locali appositi, ovvero, se non vi sia necessità di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechino
molestia, anche nelle celle. Il regolamento specifica che tali attività possono essere svolte da
condannati e internati anche nelle ore dedicate al lavoro, con una autorizzazione specifica del
direttore, sentito il gruppo di osservazione e trattamento: funzionano, in tal modo, come pienamente
sostitutive del lavoro inframurario, con la ovvia prescrizione che siano allora svolte con impegno
professionale.
Infine, queste attività sono assoggettate all’identico regime di prelievo per le spese processuali ed il
risarcimento del danno cui sono sottoposte le altre remunerazioni dei condannati. L’ottica del
legislatore è quella di permettere anche uno sbocco all’esterno dei prodotti realizzati dal detenuto,
attraverso l’invio agli eventuali destinatari, così da rendere del tutto simili tali attività a quelle poste
in essere come lavorazioni alle dipendenze di terzi, salvo il carattere autonomo, nel senso di auto diretto, delle stesse.
Il lavoro a domicilio
Per quanto riguarda il lavoro a domicilio, si tratta di una tipologia introdotta come novità assoluta
con la L. 56/1987. All’art. 19 VI e VII comma L. 56 cit., il legislatore non ha fornito alcuna
definizione di tale tipo di lavoro inframurario, limitandosi a richiamare l’applicabilità delle norme
sull’ordinamento penitenziario, in materia di lavoro artigianale, intellettuale e artistico, e
preoccupandosi di ribadire, all’art. 52 Regolamento, le stesse modalità e condizioni di svolgimento,
già previste dal regolamento di esecuzione all’art. 51. Infatti, anche nel caso di lavoro a domicilio, il
datore di lavoro deve versare alla Direzione carceraria le somme dovute al lavoratore, al netto delle
ritenute di legge, dimostrando altresì l’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.
Nulla viene detto per quanto riguarda i modi di determinazione della retribuzione, ma, in proposito,
si deve osservare come la dottrina avesse ammesso l’applicabilità della normativa ordinaria e,
quindi, anche dell’art. 8 L. 18 dicembre 1973 n. 877, anche prima dell’esplicito riferimento al
rispetto della normativa vigente, contenuto nel testo del nuovo art. 52 del Regolamento.
In linea generale, si è osservato come, nel caso del lavoro a domicilio carcerario, il nesso di
compatibilità con la legge regolatrice della materia debba essere duplice, in quanto i limiti di
8
attuazione della disciplina ordinaria derivano non solo dai connotati particolari della prestazione di
lavoro, bensì anche dalla particolare condizione soggettiva del lavoratore detenuto. Ciò perché, se la
specialità del lavoro a domicilio si radica, soprattutto, nella natura del luogo della prestazione,
sottratto all’immediato controllo del datore di lavoro, nel lavoro a domicilio carcerario si verifica
l’ulteriore particolarità che il lavoro non viene svolto nel domicilio abituale del lavoratore né,
comunque, in locali di cui abbia la disponibilità.
Perciò, il rinvio alla disciplina del lavoro autonomo carcerario non assume alcuna valenza
qualificatoria, nel senso di far rivivere il lavoro a domicilio autonomo, bensì va riferita alla
regolamentazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, sotto il profilo
dell’individuazione dei locali
in cui svolgere il lavoro, l’uso degli strumenti necessari, il rimborso delle spese sostenute
dall’amministrazione, l’invio all’esterno dei beni prodotti: aspetti, questi ultimi, che vanno regolati
tenendo in considerazione le peculiarità del luogo dove la prestazione si svolge e la condizione di
privazione della libertà personale in cui versa il lavoratore a domicilio.
Il rinvio alle disposizioni del regolamento per il lavoro autonomo in materia di lavoro a domicilio
diventa allora comprensibile e non smentisce la natura subordinata del lavoro a domicilio
carcerario, restando limitato alla fissazione di una serie di regole, per il lavoro inframurario non
gestito direttamente dall’Amministrazione penitenziaria, e ricollegate all’esistenza del rapporto
punitivo in capo al prestatore di lavoro, essendo del tutto indifferente il carattere auto o etero diretto della prestazione.
Il lavoro autonomo
Quanto, infine, al lavoro autonomo, non collegato allo svolgimento di attività artigianali,
intellettuali o artistiche, già in precedenza, si era giunti, in via interpretativa, ad ammettere la
possibilità dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo all’esterno, in assenza di preclusioni
legislative espresse in proposito.
Il D.P.R. n. 248/1989 aveva, poi, modificato l’art. 46 XII comma del Regolamento, stabilendo che
può essere disposta l’ammissione al lavoro esterno autonomo, alle stesse condizioni previste, in
linea generale, dall’art. 21 I comma, L. 354/1975 per l’assegnazione al lavoro extramurario, sempre
che il detenuto dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare a questa attività con
impegno professionale.
L’art. 48 XII comma del nuovo Regolamento contiene una norma identica a quella del previgente
testo: anche in questo caso, tuttavia, il condannato è tenuto a versare alla Direzione dell’istituto
l’utile finanziario che gli deriva dall’attività di lavoro autonomo svolto, sul quale vengono effettuati
i prelievi per le spese processuali ed il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 24 L. 354/1975.
Analogamente, l’art. 54 III comma del Regolamento permette di ritenere possibile lo svolgimento di
lavoro autonomo in regime di semilibertà.
Le borse lavoro
Un ultimo cenno deve essere dedicato all’argomento delle c.d. borse lavoro, che pure rientrano
nell’argomento del lavoro penitenziario, in senso lato. La borsa lavoro consiste nell’inserimento, a
titolo gratuito, di lavoratori appartenenti alle aree del disagio sociale, quali tossicodipendenti,
detenuti o ex detenuti, in imprese private, con la previsione della erogazione di una indennità a
carico dell’ente pubblico di assistenza o che, in generale, ha in carico il soggetto a rischio.
La borsa lavoro viene solitamente assegnata, nell’ambito di convenzioni tra soggetti pubblici ed
imprenditori privati, ovvero cooperative, allo scopo di facilitare l’ingresso di tali soggetti
svantaggiati nel mondo del lavoro. Anche i detenuti possono usufruire di questa possibilità che
assume, nei loro confronti, il carattere di presupposto per l’ammissione a forme di lavoro
9
extramurario, garantite, solitamente, da enti locali territoriali che favoriscono, terminato il periodo
di formazione professionale, l’inserimento lavorativo permanente del soggetto stesso.
Si tratta di un fenomeno molto diffuso, rispetto al quale esistono, peraltro, una serie di problemi di
inquadramento giuridico. In particolare, sotto il profilo della riconducibilità di tali forme al
paradigma del lavoro subordinato, con tutte le ovvie conseguenze, sul piano della disciplina del
rapporto. Il contratto di borsa lavoro, è stato ricondotto allo schema di un contratto atipico,
qualificato dalla sola causa dell’addestramento professionale e del recupero sociale, e non
assimilabile in quanto tale, ad un rapporto di scambio, come quello di lavoro subordinato, con
l’ovvia conseguenza di non poter usufruire del sistema di tutela apprestata dall’ordinamento per il
lavoratore dipendente.
La tutela dei diritti
Il continuo intersecarsi tra situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di lavoro e istanza punitiva
dello Stato si riflette anche sul tema della tutela dei diritti.
L’argomento sarà trattato al termine dell’esame delle singole tipologie di lavoro penitenziario,
quando saranno state identificate le varie posizioni giuridiche, vantate nelle diverse situazioni di
lavoro extra e inframurario, ma, in questa sede di definizione della nozione di lavoro carcerario, è
opportuna qualche premessa di carattere generale, sul tema delle procedure attraverso cui azionare
giurisdizionalmente la tutela dei diritti riconosciuti a coloro che prestano una attività lavorativa
durante la detenzione.
La norma fondamentale in ambito penitenziario è l’art. 69 VI comma L. 354/1975: tale disposizione
stabilisce che il Magistrato di Sorveglianza decide con ordinanza, impugnabile soltanto per
cassazione, secondo la procedura di cui all’art. 14 ter della stessa legge, sui reclami dei detenuti e
degli internati concernenti l’osservanza delle norme riguardanti:
a. l’attribuzione della qualifica lavorativa;
b. la mercede;
c. la remunerazione;
d. lo svolgimento delle attività di tirocinio;
e. lo svolgimento delle attività di lavoro;
f. le assicurazioni sociali.
L’art. 14 ter citato, richiamato dalla norma in esame, pone, a sua volta, le regole procedimentali del
reclamo, relativamente alla sua proposizione, alla trattazione dello stesso, in un’udienza in camera
di consiglio, al rispetto del principio del contraddittorio, realizzato attraverso la partecipazione
personale del difensore del reclamante e del pubblico ministero, nonché attraverso la possibilità per
l’interessato e l’Amministrazione penitenziaria di inviare memorie, e, infine, alla decisione del
giudice in forma di ordinanza.
In materia di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’Amministrazione penitenziaria,
l’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale si è mossa nel senso di giungere
progressivamente all’accoglimento della distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità,
nell’ambito dei provvedimenti di competenza della Magistratura di Sorveglianza, tra provvedimenti
relativi alle modalità di esecuzione della pena, attratti nell’area dell’amministrazione, e
provvedimenti riguardanti la misura e la qualità della pena, attratti nell’area giurisdizionale alla
stregua della riserva di legge.
Per quanto riguarda, poi, il tema specifico della tutela dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei
detenuti ed internati, sin dall’inizio, la Corte ha chiarito come il procedimento instaurato dal
reclamo del detenuto in materia di lavoro non possa sostituire la tutela giurisdizionale, riservata al
giudice dei diritti, secondo le regole della competenza ordinaria. "non essendovi motivo di
distinzione, a tale proposito, tra il normale lavoro subordinato e il lavoro dei detenuti".
Ciò significa che, laddove vi sia il riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo, connesso
alla sussistenza in capo al detenuto della titolarità di un rapporto di lavoro, la relativa azione
10
giurisdizionale dovrà essere fatta valere avanti il Giudice unico in funzione di Giudice del lavoro,
secondo le norme processuali tipiche del processo del lavoro.
Tale affermazione, peraltro, deve essere coordinata con quella della differenziazione tra lavoro
inframurario e lavoro extramurario, di cui alla citata sentenza n. 1087 della Corte Costituzionale,
che, distinguendo queste due forme di lavoro, sotto il profilo della nozione e della disciplina, riduce
la prima a modalità trattamentale penitenziaria e valorizza la seconda, come modalità alternativa di
esecuzione della pena.
Questo necessario coordinamento e l’evoluzione normativa della disciplina delle c.d. lavorazioni,
creano, tuttavia, una serie di problemi interpretativi in ordine al riparto delle competenze tra
Magistratura di Sorveglianza e Giudice del Lavoro che dovranno essere esaminati nel capitolo
dedicato al problema della tutela dei diritti.
11
Il lavoro inframurario alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria
La distinzione tra lavori domestici e lavorazioni
La definizione di lavoro inframurario è intuitiva, dal momento che il termine serve ad indicare ogni
tipo di attività lavorativa svolta da detenuti all’interno dell’istituzione carceraria: la particolarità del
luogo in cui si svolge è l’elemento qualificante.
All’interno di questa categoria, la distinzione fondamentale, che è già stata introdotta nel precedente
capitolo, esaminando la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, è quella tra lavoro alle
dipendenze della stessa Amministrazione penitenziaria e lavoro alle dipendenze di terzi. La
contrapposizione strutturale tra questi due tipi di attività è icasticamente indicata dalla terminologia
utilizzata comunemente per indicare queste due forme di lavoro carcerario.
Nel caso del lavoro alle dipendenze dell’ Amministrazione, si parla di c.d. lavori domestici per
identificare, con assoluta certezza, tutta quella serie di compiti, vari e non solo domestici, che
servono a far funzionare la macchina carceraria, come lo spesino, lo scrivano, lo scopino, l’addetto
alla manutenzione, il cuoco, e cosi via. Nel caso del lavoro alle dipendenze di terzi si parla di
lavorazioni, ponendo l’accento sul carattere produttivo di tali attività, contrapposto al carattere
domestico e, per definizione, improduttivo del primo.
La distinzione va, comunque, sottolineata, dal momento che, nel secondo caso, è più agevole,
soprattutto a seguito delle riforme legislative del 1993, cercare di applicare il nuovo e diverso
criterio interpretativo nell’individuazione dei diritti del lavoratore detenuto, già delineato, e
giungere alla conclusione che tali diritti sono gli stessi che ineriscono al rapporto di lavoro di ogni
soggetto, salvo le necessarie limitazioni derivanti dalle esigenze di un regime detentivo e, quindi,
gli indispensabili adattamenti legati alla condizione soggettiva di una delle parti del rapporto stesso.
Al contrario, nel caso dei lavori domestici alle dipendenze dirette dell’Amministrazione
penitenziaria, tale conclusione non è affatto scontata, alla luce del carattere di specialità e della
genesi non contrattuale che li contraddistingue.
Il lavoro per l’amministrazione: obbligo o diritto?
La prima caratteristica del lavoro inframurario alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria
è l’assenza di quella trilateralità tipica di ogni altro tipo di lavoro carcerario. Infatti, manca, in
questa ipotesi, un datore di lavoro distinto dall’amministrazione, così che la fondamentale
distinzione tra rapporto punitivo e rapporto di lavoro appare molto più difficile da individuare nei
suoi esatti contorni; allo stesso modo, risulta difficile, in concreto, identificare il momento di
esercizio del potere derivante dall’uno e dall’altro rapporto da parte del medesimo soggetto che è
titolare di entrambi.
L ‘altra caratteristica, strettamente connessa a questa, anche se relativa non più al piano strutturale
del rapporto, bensì a quello genetico non contrattuale, è rappresentata dalla configurabilità del
lavoro carcerario come diritto o obbligo: in altri termini, se pure ha perduto il carattere afflittivo che
lo contraddistingueva prima dell’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario, il lavoro viene,
ancor oggi, configurato come un obbligo per il detenuto, in quanto elemento cardine di un
trattamento rieducativo globale, diretto a rieducarlo, appunto, e a rendere possibile il suo
reinserimento nella collettività, attraverso l’imposizione di modelli di comportamento conformi ai
parametri sociali.
Una delle precedenti stesure del testo della legge sull’ordinamento penitenziario recitava: "ai fini
della rieducazione al condannato e all’internato è assicurato il lavoro", formula che aveva indotto
gli interpreti a ritenere esistente un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto al lavoro, mentre la
formulazione definitiva dell’art. 20, 3° comma, L. 354 - "Il lavoro è obbligatorio per i condannati e
per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro" - non autorizza
più questa conclusione.
12
L’art. 50 Regolamento ribadisce questa impostazione, stabilendo che i condannati egli internati
(cioè i sottoposti alle misure di sicurezza detentive della casa di lavoro e della colonia agricola), non
ammessi al lavoro all’esterno, alla semilibertà o autorizzati allo svolgimento di attività artigianali,
intellettuali o artistiche, ovvero al lavoro a domicilio, "per i quali non sia disponibile un lavoro
rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell’art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere
un’altra attività tra quelle organizzate dall’istituto", cosi che l’obbligo del lavoro viene, ancora una
volta, confermato come un elemento del trattamento rieducativo.
Del resto, l’art. 15 2° comma, L. 354/1975, dopo aver indicato nella triade tradizionale, istruzione,
lavoro e religione, cui aggiunge le attività culturali, ricreative e sportive, il contenuto del
trattamento, specifica, nuovamente, che: "Ai fini del trattamento, salvo casi d’impossibilità, al
condannato e all’internato è assicurato il lavoro".
Ciò significa che è rimasto immutato il carattere di specialità del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione penitenziaria, dove la particolare natura del datore di lavoro, lo Stato stesso, e
dell’attività esercitata, non finalizzata alla produzione, determinano un duplice limite
all’applicabilità della normativa standard, con il risultato di rendere meno ampio l’ambito della
tutela giuridica riconoscibile ai detenuti.
Assegnazione del lavoro e costituzione del rapporto
Se si passa a esaminare, allora, il primo aspetto del rapporto di lavoro, la sua costituzione, il punto
più rilevante, è quello delle modalità di assegnazione al condannato di una posizione lavorativa
all’interno dell’istituto; questione tanto più rilevante in una situazione come quella attuale, di
cronica carenza di attività lavorativa inframuraria.
Solo con la modifica del sesto comma dell’art. 20 Legge n° 354, introdotta dalla Legge 12 agosto
1993 n° 296, sono state abbandonate quelle prerogative discrezionali riconosciute alla direzione
carceraria nell’assegnazione al lavoro, che consentivano, in precedenza, di utilizzare l’assegnazione
al lavoro in un’ottica, nel migliore dei casi, premiale.
La formulazione originaria della norma si limitava a prevedere che, ai fini delle assegnazioni dei
detenuti al lavoro, la direzione dovesse tener conto dei loro desideri ed attitudini e delle condizioni
economiche della famiglia.
Ora, invece, l’art. 20 VI comma Legge n° 354/1975 indica, in primo luogo, i criteri di priorità per
l’assegnazione al lavoro, e, in secondo luogo, fissa una serie di procedure, così da tipizzare un vero
e proprio sistema di collocamento dei detenuti, per lo svolgimento del solo lavoro inframurario. Per
quanto riguarda il lavoro svolto all’esterno, è lo stesso art. 20 ai commi XI e XII a richiamare la
disciplina generale del collocamento, ordinario e agricolo, e l’art. 19 Legge n° 56/1987, così che, in
campo extramurario, si debbono ritenere applicabili le norme ordinarie, con i problemi di
coordinamento che saranno esaminati nel capitolo relativo a quest’argomento.
Per il lavoro inframurario è stabilito che i criteri di priorità nell’assegnazione siano esclusivamente
quelli dell’anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, dei carichi familiari, della
professionalità, delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui potrà il detenuto
dedicarsi dopo la scarcerazione.
L’art. 49 del nuovo Regolamento, con una significativa innovazione rispetto al testo del
corrispondente art. 47 D.P.R. n° 431 1976, contiene un secondo comma, nel quale si stabilisce che
il direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro, avvalendosi
anche del gruppo di osservazione e trattamento, così che viene sancita l’applicazione dei principi
legali, cardine della buona amministrazione, anche in ambito penitenziario.
Quanto alle procedure, il collocamento avviene sulla base di graduatorie fissate in due apposite
liste, una generica e l’altra per qualifica o mestiere; i posti di lavoro disponibili devono essere
indicati in una tabella preparata dalla Direzione dell’istituto, suddivisi ai sensi dell’art. 47 X comma
del nuovo Regolamento, identico al previgente art. 45 VIII comma D.P.R. n° 431 1976, in servizi
d’istituto, lavorazioni interne e lavorazioni esterne. La tabella è modificata secondo il variare della
13
situazione e contiene anche l’indicazione dei posti di lavoro disponibili all’interno per il lavoro a
domicilio, nonché quelli disponibili all’esterno. Per la formazione delle graduatorie all’interno delle
liste e per il nullaosta per le richieste di avviamento, in base all’art. 20 VIII comma Legge n° 354,
presso ogni istituto è costituita una commissione cui partecipano:
il direttore dell’istituto;
a) un rappresentante del Corpo di polizia penitenziaria (appartenente al ruolo degli ispettori o dei
sovrintendenti);
b) un rappresentante del personale educativo, eletti, questi ultimi due, all’interno della rispettiva
categoria di appartenenza;
c) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul
piano nazionale;
d) un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l’impiego territorialmente
competente;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali;
f) infine, un rappresentante dei detenuti, privo di potere deliberativo, che viene sorteggiato
secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di ciascun istituto.
Svolgimento del rapporto
Una volta assegnato il lavoro ed instauratosi il rapporto tra l’Amministrazione penitenziaria e il
condannato, si tratta di verificare quali diritti, nascenti in capo al lavoratore libero, possano essere
riconosciuti al detenuto dipendente dell’amministrazione, alla luce del carattere di specialità di tale
tipologia di lavoro inframurario. Come detto, la particolare natura del datore di lavoro, coincidente
con lo stesso soggetto esercente il potere punitivo dello Stato, e dell’attività esercitata, non
finalizzata alla produzione, determina un duplice limite all’applicabilità della normativa standard.
Ora, l’art. 20 XVII comma Legge n° 354, in ordine allo svolgimento del rapporto, stabilisce
significativamente che la durata della prestazione lavorativa non possa superare i limiti stabiliti
dalle leggi vigenti e che, alla stregua di tali leggi, è garantito il riposo festivo. Di conseguenza, la
durata della giornata lavorativa non può superare il limite giornaliero delle otto ore e deve essere
garantito un giorno di riposo settimanale.
Come è stato osservato, inspiegabile, al contrario, appare il silenzio del legislatore in materia di
ferie, non solo perché il diritto alle ferie è sancito come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni
lavoratore, in quanto diretto a consentirgli il recupero delle energie fisiche e morali, ben si anche
perché l’ordinamento penitenziario prevede uno strumento premiale specifico, come i permessi
premio (di durata non superiore a quindici giorni ogni volta e per complessivi giorni quarantacinque
per ogni anno di espiazione di pena), per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di
lavoro, che ben possono essere coordinati con la fruizione delle ferie.
Recentemente, con ordinanza 5 maggio 1999, il Magistrato di Sorveglianza di Agrigento ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 XVI comma Legge n° 354/1975
(attualmente XVII comma, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge n° 193/2000), nella
parte in cui non riconosce, oltre al diritto al riposo festivo e alla tutela assicurativa e previdenziale,
il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva nei confronti del detenuto lavoratore, con
riferimento agli artt. 27 e 36 Cost..
Secondo il giudice remittente, il diritto a fruire delle ferie annuali, in aggiunta al riposo settimanale,
non può non essere riconosciuto anche al detenuto-lavoratore, per garantire il suo diritto al recupero
delle energie consumate durante l’attività lavorativa ed al soddisfacimento delle proprie esigenze
personali. Inoltre, rileva il Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, tale mancato riconoscimento
rende il lavoro penitenziario “sicuramente più afflittivo”, pregiudicandone la funzione rieducativa.
Al di là del silenzio della legge ordinaria ed in attesa della decisione della Corte Costituzionale,
l’esistenza di un principio costituzionale in materia fa si che il diritto alle ferie debba, comunque,
riconoscersi ai detenuti dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria, in coincidenza con la
14
concessione dei permessi premio, mentre, nei casi in cui ciò non sia possibile, per l’inapplicabilità
nel caso concreto della disciplina di cui all’art. 30 ter Legge n° 354/1975, al detenuto lavoratore
dovrà, comunque, essere riconosciuto un periodo retribuito, equivalente alla durata di non
effettuazione dell’attività lavorativa, dedicato al riposo o alle attività sportive e ricreative esistenti (e
usufruibili) all’interno dell’istituto.
Allo stesso modo, nel caso in cui il detenuto lavoratore opti per la rinuncia all’utilizzazione delle
ferie, ritenuta legittima in questa ipotesi dalla dottrina, dovrà essergli riconosciuto il diritto alla
relativa indennità sostitutiva.
Passando poi a diritti non ricavabili direttamente da norme di rango costituzionale, nessuna
disposizione è rinvenibile con riferimento al diritto alle mansioni e alla qualifica contrattuale: la
situazione per i detenuti addetti a lavori domestici è certamente semplificata alla luce del tipo di
attività inframurarie che solitamente svolgono, nel senso che l’applicabilità della regola di cui
all’art. 2103 c.c. sul divieto di assegnazione di mansioni inferiori appare di scarsa rilevanza in
concreto, trattandosi di compiti professionalmente semplici e di livello equivalente. Peraltro, in
astratto, non pare compatibile l’esistenza di un potere discrezionale della Direzione di modificare i
compiti già assegnati al detenuto, con il complesso e oggettivo meccanismo di collocamento interno
descritto al precedente paragrafo.
Diritti sindacali
Particolarmente delicato è il tema del riconoscimento dei diritti sindacali dei detenuti che lavorino
all’interno dell’istituzione penitenziaria, come dipendenti dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda il diritto di associazione sindacale, non pare ravvisabile nello status di detenuto
alcun limite all’iscrizione dei condannati lavoranti ad associazioni sindacali già esistenti, sempre
che l’organizzazione sindacale cui il soggetto si rivolga non ponga, all’interno del proprio statuto o
atto costitutivo, vincoli all’accettazione della domanda di iscrizione, correlati, per esempio,
all’incensuratezza o al più generico concetto di buona condotta morale e civile dei richiedenti
l’ingresso nell’associazione. In questo caso, sarà l’organizzazione sindacale stessa a dover valutare
la sussistenza o meno delle condizioni per poter
accogliere la domanda del detenuto, sulla base dei propri atti costitutivi e delle clausole dagli stessi
previste, alla stregua di qualunque altra associazione. Allo stesso modo, nulla vieta che i detenuti
costituiscano organizzazioni sindacali associandosi tra di loro, in virtù del principio costituzionale
della libertà di associazione sindacale.
Certamente più problematico appare l’esercizio dei diritti sindacali in ambito penitenziario, dal
momento che i vari momenti comuni della vita penitenziaria si inquadrano, di regola, entro uno
schema organizzativo predeterminato da parte dell’autorità, senza che, normalmente, siano lasciati
margini al di spiegarsi di autonome iniziative dei detenuti a sfondo partecipativo. Si tratta di
verificare, in altri termini, lo spazio che potrebbero avere iniziative di tipo assembleare e
rappresentative. rispetto alle quali, peraltro. non pare sostenibile
una inammissibilità teorica di strutture di tipo partecipativo, laddove non si pongano in contrasto
con le esigenza di sicurezza all’interno degli istituti.
Quanto al diritto di sciopero, che è un diritto costituzionalmente garantito, la dottrina appare
nettamente divisa tra chi evidenzia come non sussista alcuna incompatibilità con lo stato di
detenzione e chi, al contrario, ritiene impossibile il ricorso allo sciopero in presenza dello status di
detenuto.
Cessazione del rapporto
In tema di cessazione del rapporto, va osservato come in questa materia risulti necessariamente
esclusa una diretta applicabilità di alcune nozioni giuslavoristiche, quali la giusta causa e il
giustificato motivo per il recesso. Invero, l’ordinamento penitenziario prevede una disciplina
15
speciale per l’allontanamento dal posto di lavoro del detenuto, definito di esclusione dalle attività
lavorative (art. 53 Regolamento) in cui si prevede che il provvedimento relativo possa essere
adottato dalla Direzione dell’istituto solo in presenza di fatti o comportamenti commessi durante il
lavoro.
Nel Regolamento previgente (art. 50), erano contemplate due ipotesi tipiche: il sostanziale rifiuto
dell’adempimento dei compiti e la mancanza di rendimento. Con una scelta condivisibile, la
disposizione è stata modificata. limitando al solo caso del sostanziale rifiuto nell’adempimento dei
suoi compiti e doveri lavorativi l’esclusione dall’attività lavorativa del detenuto.
e abbandonando l’equivoca formula della mancanza di rendimento, che si prestava ad abusi, in
misura molto maggiore dell’ipotesi rimasta in vigore. La disposizione evidenzia l’equivoco di fondo
che permea tutta la disciplina del lavoro inframurario, dal momento che in essa, da un lato, viene
descritto un comportamento che, immediatamente, richiama alla mente il concetto civilistico di
insubordinazione, riscontrabile in tutta la contrattazione collettiva come causa di licenziamento per
giusta causa del lavoratore, e la nozione di inesatto adempimento della prestazione lavorativa, quale
tipica causa di risoluzione del contratto a prestazioni sinallagmatiche. Dall’altro, si definisce la
sanzione come esclusione dalle attività lavorative, ponendo l’accento sulla conseguenza più
rilevante per il detenuto, cioè la perdita di quella limitata libertà di movimento e di contatti
all’interno del carcere che contraddistingue la posizione dei lavoranti.
Esaminando l’unica ipotesi attualmente prevista dal Regolamento, va osservato come la lettera della
norma sia stata modificata, in quanto si stabilisce l’esclusione dalle attività lavorative nei casi in cui
il detenuto manifesti “un sostanziale rifiuto nell’adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi”:
l’originaria disposizione regolamentare si esprimeva, invece, in termini di “un sostanziale rifiuto
dell’adempimento dei suoi compiti”. È rimasta la qualificazione del rifiuto come “sostanziale”, che
permette, ancora, di interpretare la regola nel senso che, per legittimare un provvedimento così
grave, quale la rimozione dal lavoro, il rifiuto deve riferirsi al nucleo essenziale dei compiti
assegnati al condannato e non a semplici elementi di dettaglio. L’aggiunta dei doveri lavorativi e la
trasformazione della proposizione rende, tuttavia, più generica la previsione, collegando, in modo
più sfumato, il comportamento sanzionabile con l’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto
di lavoro.
Del resto, la realtà dei fatti conferma quell’ambiguità latente in tutta la materia: chiunque abbia un
minimo di esperienza di vita carceraria sa bene che i casi di rimozione dal lavoro avvengono, in
larga misura, per motivi disciplinari. collegati a fatti indipendenti dal comportamento sul posto di
lavoro del detenuto.
D’altro canto, l’art. 77 del Regolamento, nell’elencare i comportamenti passibili di una delle
sanzioni disciplinari previste dall’art. 39 Legge n° 354/1975, al n° 3 prevede “il volontario
inadempimento di obblighi lavorativi” che, certamente, è espressione ben diversa dal sostanziale
rifiuto nell’adempimento dei compiti e dei doveri lavorativi, risultando connotata da un elemento
soggettivo molto marcato. In altri termini, il sistema risultante dal complesso delle norme
esaminate, perfettamente allineato con l’impostazione trattamentale dell’obbligo di lavoro, tende a
colpire l’atteggiamento del detenuto che non lavori o lavori poco e malamente, sotto un duplice
profilo, sia privandolo di quell’elemento del trattamento per il quale si è dimostrato immeritevole e
inadatto. sia colpendolo sotto il profilo disciplinare. Nella pratica, però, l’allontanamento dal lavoro
viene utilizzato illegittimamente per sanzionare comportamenti che nulla hanno a che fare con lo
svolgimento dell’attività lavorativa, operando come ulteriore sanzione per infrazioni disciplinari di
altro genere.
La sovrapposizione tra potere punitivo dello Stato e rapporto di lavoro emerge con tutta chiarezza:
in questo caso, molto più difficile risulta, in concreto, identificare il momento di esercizio del potere
derivante dall’uno e dall’altro rapporto da parte del medesimo soggetto, titolare di entrambi, che ne
fa uso in modo indifferenziato.
Evidentemente, un simile utilizzo dell’istituto della rimozione, in violazione delle disposizioni
dell’ordinamento penitenziario, può essere contrastato attraverso il reclamo al Magistrato di
16
Sorveglianza ai sensi dell’art. 69 lett. b) Legge n° 354/1975, che concerne l’osservanza delle norme
riguardanti le condizioni di esercizio del potere disciplinare.
Mercede e retribuzione
La retribuzione del detenuto lavoratore è definita dalla legge come mercede: l’art. 22 Legge n°
354!1975 stabilisce che “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente
stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e
al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico
previsto dai contratti collettivi”.
Prevede, altresì, che, allo scopo di fissare le mercedi, sia costituita una commissione, composta:
a) dal direttore generale, che la presiede;
b) dal direttore dell’ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale;
c) da un ispettore generale;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano
nazionale.
La semplice lettura della norma permette di notare, in primo luogo, che il legislatore utilizza
l’espressione “mercede”, invece di “retribuzione”, quasi a marcare la scarsa produttività del lavoro
carcerario e la giustificazione, sotto questo angolo visuale, della sua riduzione sul piano retributivo.
Al lavoratore viene assicurato un compenso, non coordinato sinallagmaticamente alla prestazione,
cioè non correlato ad essa in termini di corrispettività, e di ammontare inferiore a quello previsto
per il lavoro libero. In secondo luogo, vi è comunque un riferimento, per la determinazione delle
remunerazioni dovute, alla quantità e qualità del lavoro prestato e agli indici di adeguatezza fissati
dalla contrattazione collettiva.
La previsione legislativa non vale, peraltro, a far ritenere che sia direttamente accolto in ambito di
lavoro carcerario inframurario il principio di corrispettività tra lavoro e retribuzione,
conformemente ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
In effetti, la Corte Costituzionale si è occupata del tema della retribuzione in varie sentenze, delle
quali la più nota è la n° 49 del 18 febbraio 1992 con cui è stato dichiarato illegittimo, per contrasto
con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 23 Legge 354/1975, nella parte in cui stabilisce una riduzione
dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti, da versarsi alla Cassa per il
soccorso e l’assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle Regioni e agli enti
locali.
Da tale sentenza, che pure ha avuto l’importante conseguenza di permettere la restituzione delle
somme trattenute ai condannati dopo la soppressione della Cassa e sino all’abrogazione della norma
da parte della Legge Gozzini, a far data dal 31 ottobre 1986, non è dato ricavare alcuna
argomentazione in ordine alla vigenza del principio di proporzionalità e sufficienza della mercede,
in modo analogo a quanto accade per la retribuzione dei lavoratori liberi, in quanto la pronuncia di
illegittimità costituzionale, per disparità di trattamento tra i condannati e gli altri cittadini, è stata
affermata in relazione al venir meno del vincolo di solidarietà tra autori e vittime del reato,
conseguente alla soppressione della Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime e alla
destinazione delle somme trattenute al soddisfacimento di interessi generali, che ha reso
ingiustificate le trattenute stesse. In altri termini, la Corte ha ritenuto che “essendosi sostituiti alla
Cassa enti portatori di interessi plurimi, sono venuti meno la specifica destinazione delle trattenute
di cui trattasi al soddisfacimento dei bisogni delle vittime delle azioni delittuose e il vincolo di
solidarietà tra detenuti e vittime dei delitti, sicché le trattenute sono dirette a soddisfare finalità di
beneficenza pubblica. E siccome il relativo onere deve gravare sull’intera collettività e non solo sui
detenuti che lavorano. sussiste violazione del richiamato art. 3 della Costituzione, ponendosi
un’irrazionale ingiustificata discriminazione tra i detti detenuti e gli altri cittadini”.
17
Più interessanti risultano, al contrario, le affermazioni contenute nella già citata sentenza n° 1087
del 1988, con la quale la Corte dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
22 Legge n° 354 1975, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.: la soluzione accolta dalla
Corte è, comunque, una soluzione di compromesso, perché si basa sulla distinzione non solo
tipologica, ma ontologica, tra lavoro carcerario e lavoro esterno, assimilabili, ma non identici, che
rende ragionevole e giustificata la disparità di trattamento economico. La pronuncia arriva, però, ad
ammettere l’operatività della garanzia costituzionale di cui all’art. 36 Cost. anche per il lavoro
carcerario, ricostruendo l’art. 22 cit. nel senso che la remunerazione fissata in base a tale
disposizione, per essere legittima, deve risultare conforme ai principi di proporzionalità e
sufficienza di cui al dettato costituzionale. La conclusione è che, in caso contrario, il detenuto potrà
rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere la disapplicazione dell’atto amministrativo di
determinazione della mercede.
Si tratta, come è evidente, di una soluzione poco convincente e contraddittoria con le premesse da
cui muove, dal momento che l’affermazione della esistenza in capo al detenuto di un diritto
tutelabile ex art. 36 Cost. avanti il giudice ordinario dovrebbe portare alla esclusione di un potere
discrezionale dell’Amministrazione penitenziaria nella determinazione della mercede che, per
rispondere ai requisiti di proporzionalità e sufficienza richiesti dalla Corte, non potrebbe che essere
parametrata ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
La soluzione indicata dalla Corte resta quella della parificazione delle situazioni concrete attraverso
la soluzione giudiziaria, con tutti i limiti e le possibili difformità di giudizio che questo comporta, a
cui deve essere aggiunto il rischio, recentemente non più solo teorico, di un arretramento della
giurisprudenza in ambito di tutela giurisdizionale del lavoratore detenuto.
La specialità dei lavori domestici
In conclusione, si è visto come per i lavori c.d. domestici alle dirette dipendenze
dell’Amministrazione penitenziaria risulti poco agevole applicare il nuovo e diverso criterio
interpretativo nell’individuazione dei diritti del lavoratore detenuto già delineato e giungere alla
conclusione che tali diritti sono gli stessi che ineriscono al rapporto di lavoro di ogni soggetto, salvo
le necessarie limitazioni derivanti dalle esigenze di un regime detentivo e quindi gli indispensabili
adattamenti legati alla condizione soggettiva di una delle parti del rapporto stesso.
A riprova del perdurante carattere di specialità di tale tipologia di lavoro, si può citare un parere
sull’incidenza dell’effettuazione di lavoro domestico all’interno dell’istituto, in relazione alla
maturazione dell’anzianità di iscrizione nella lista di disoccupazione di lunga durata, reso
recentemente dalla direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro, in risposta a un
quesito avanzato, in proposito, dalla Commissione Regionale per l’impiego della Lombardia, nella
seduta del 3 maggio 1999, in cui è stata condivisa la soluzione prospettata, favorevole alla
possibilità per il detenuto, impiegato nei lavori domestici, di maturare l’iscrizione in lista quale
disoccupato di lunga durata. Soluzione, questa, prospettata proprio in considerazione del carattere
obbligatorio di tale lavoro e della remunerazione, inferiore rispetto a quanto previsto nei contratti
collettivi nazionali. per lo svolgimento delle medesime mansioni.
Il lavoro intramurario alle dipendenze di terzi: le lavorazioni
Le lavorazioni dopo la riforma del 1993: la privatizzazione del lavoro inframurario.
La seconda tipologia di lavoro inframurario è rappresentata dalle c.d. lavorazioni, gestite in proprio
dall’Amministrazione penitenziaria, ovvero da imprese esterne, che sono dirette alla produzione di
beni su commessa o da porre liberamente sul mercato. Il previgente art. 45 del Regolamento
prevedeva che le lavorazioni penitenziarie fossero gestite e organizzate, secondo le direttive
18
dell’Amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti, le quali potevano avvalersi della
collaborazione di imprese pubbliche.
Il quadro di rapporti delineato dall’art. 45 cit. risultava, tuttavia, superato dalla nuova formulazione
dell’art. 20 Legge n° 354/1975, come modificato dalla Legge n° 296/1993, che ha innovato
profondamente il sistema tradizionale delle lavorazioni, aprendo il carcere a chiunque possa avere
risorse e interesse alla formazione e all’utilizzo produttivo dei detenuti: la scelta di fondo, come è
stato notato, va nel senso della privatizzazione, superando il limite che, nel sistema originario della
legge, era posto alla possibilità di costruire un rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore
detenuto, quando la prestazione andava svolta all’interno del carcere.
Cosi, l’art. 20 I comma Legge n° 354/1975 stabilisce che all’interno degli istituti possono essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private, che possono
essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, ovvero da
aziende private convenzionate con la regione.
Il nuovo art. 20 bis Legge cit. prevede, a sua volta, al I comma, che il Provveditore Regionale possa
affidare, con un contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all’amministrazione. In altri termini, si riconosce l’incapacità dell’Amministrazione penitenziaria a
risolvere i problemi della crisi del lavoro penitenziario, accresciuti, come detto, dalla riduzione delle
possibilità di ammissione a lavori esterni attraverso le misure alternative, dando spazio a
professionalità diverse e specialistiche rispetto a quelle penitenziaristiche.
Anche dal punto di vista dello sbocco dei prodotti, viene a superarsi la logica precedente,
riconoscendo, al II comma dello stesso art. 20 bis cit., all’Amministrazione penitenziaria, la
possibilità di promuovere la vendita dei prodotti delle lavorazioni, mediante convenzioni da
stipulare con le imprese pubbliche e private che dispongano di una propria rete di distribuzione
commerciale.
L’incentivazione alle aziende esterne per commissionare forniture viene poi realizzata, attraverso la
previsione del III comma della norma in esame di pagamenti differiti, in deroga alle norme della
contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, secondo gli usi e le consuetudini
vigenti. Il risultato della scelta legislativa di privatizzare le lavorazioni è l’ingresso del mercato nel
lavoro carcerario e, con esso, la gestione diretta delle attività lavorative da parte dell’imprenditore
esterno, pubblico o privato che sia: la conseguenza, sul piano del lavoro del detenuto, è che viene a
cadere completamente l’opzione di fondo contenuta nella Legge Gozzini volta a differenziare il
lavoro carcerario intramurario, intercorrente, sempre e comunque, con l’amministrazione, e quindi,
caratterizzato da un rapporto di specialità, e il lavoro che si svolge all’esterno, in tutto assimilato al
lavoro libero. Infatti, l’imprenditore che gestisce le lavorazioni stipula con i detenuti lavoratori
contratti di diritto privato, così che viene compiutamente superata la distinzione, sotto il profilo
dell’applicabilità della disciplina standard, tra lavoro inframurario e lavoro extramurario, sostituita
dalla distinzione tra lavoro alle dipendenze di terzi e lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione
penitenziaria, unico a restare ancorato alle finalità terapeutiche trattamentali e, quindi, non assimila
bile pienamente al lavoro libero.
Questa impostazione viene ribadita e confermata nel nuovo Regolamento che, in questa materia,
recepisce le modificazioni alla legge 354/1975 della novella del 1993 e si spinge ancor più avanti
nella strada della privatizzazione del carcere.
L’art. 47 del Regolamento, che sostituisce il previgente art. 45, prevede, infatti, una duplice
possibilità per le lavorazioni, e cioè di essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti
secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati ovvero, allo stesso modo, di
“essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative
sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni”.
In questa seconda ipotesi, viene introdotto lo strumento delle convenzioni per regolare i rapporti tra
le direzioni degli istituti e le imprese, sotto il profilo dell’utilizzo dei locali e delle attrezzature già
esistenti negli istituti, nonché delle modalità di addebito all’impresa delle spese sostenute per lo
svolgimento dell’attività produttiva.
19
Ancor più rilevante, seppur naturale conseguenza del nuovo assetto legislativo, è l’affermazione,
contenuta sempre nel I comma della disposizione regolamentare, che i detenuti e gli internati che
prestano la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente
dalle imprese che gestiscono le lavorazioni stesse.
La produzione delle lavorazioni è destinata a soddisfare, nell’ordine, le commesse
dell’Amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e, da ultimo,
di privati: mentre le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono
distribuite dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, le direzioni possono accogliere
direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
Infine, se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di manodopera delle
lavorazioni, l”amministrazione può organizzare e gestire la produzione di determinati beni, posti in
vendita liberamente sul mercato, anche attraverso imprese pubbliche.
Innovativa risulta, poi, la previsione che le convenzioni di cui al I comma, particolarmente con
cooperative sociali, possano avere ad oggetto anche servizi interni all’istituto, quali la
somministrazione del vitto, la pulizia e la manutenzione dei fabbricati, dal momento che
l’espressione “servizi interni”.
cui fa riferimento la norma, corrisponde ai tradizionali lavori domestici, svolti dai detenuti alle
dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Ciò significa, quindi, che si ammette la
possibilità di configurare un sistema differenziato di gestione dei servizi interni ( o lavori domestici,
che dir si voglia): oda parte di cooperative sociali, convenzionate con l’amministrazione, come pure
di aziende pubbliche o private, ex art. 2 Legge 22 giugno 2000 n° 193, ovvero direttamente ad
opera dell’amministrazione, con una corrispondente differenziazione del rapporto di lavoro del
detenuto, che non è più giustificata da una diversa finalizzazione dell’attività, tutta allo stesso modo
produttiva di servizi, bensì solo dalla natura del datore di lavoro e dalla sua organizzazione.
Queste disposizioni del Regolamento, come pure le norme introdotte con la Legge 22 giugno 2000
n° 193, rappresentano la chiara manifestazione della volontà legislativa di realizzare la
privatizzazione del carcere, attraverso l’allargamento dello spazio di operatività del privato sociale e
imprenditoriale da settori più propriamente produttivi, quali le lavorazioni, a settori
tradizionalmente oggetto di diretta gestione pubblica, quali, appunto, quelli dei lavori domestici.
Cooperative e imprese
L’imprenditore esterno che gestisce le lavorazioni, come detto, può essere indifferentemente un
soggetto pubblico o privato, ne ha alcuna rilevanza la forma societaria in cui viene esercitata
l’attività imprenditoriale.
Anche prima della riforma del 1993, lo svolgimento di attività lavorativa in forma cooperativa,
all’interno o all’esterno del carcere, ha rappresentato un momento di grande trasformazione del
lavoro penitenziario. Nata verso la metà degli anni ottanta, l’esperienza delle cooperative ha
coinvolto soci detenuti insieme a soci liberi, ex detenuti o meno. Nella maggior parte degli statuti,
lo scopo sociale specifico è costituito dall’ottenimento di continuità occupazionale alle migliori
condizioni economiche, sociali e professionali a favore dei detenuti, come pure dalla creazione di
occupazione in favore di persone libere, in modo tale da aumentare l’integrazione dei detenuti con
la società civile.
La costituzione di società cooperative di cui siano membri, in qualità di soci, condannati detenuti e
persone libere ha, comunque, comportato una serie di problemi giuridici, ricollegabili alla
situazione dei soci detenuti che ne hanno determinato l’emarginazione in una situazione di
subalternità all’interno delle cooperative stesse. Prima di tutto, si è posto il problema dell’incapacità
ad agire dei detenuti, conseguente alloro stato di interdizione legale, che influisce sul momento
costitutivo della cooperativa, dato che il contratto sociale si stipula con atto pubblico. Anche se è
stato autorevolmente affermato, sin dall’inizio, dalla dottrina che la capacità di agire, riconosciuta ai
detenuti dall’art. 20 Legge n° 354 1975, per l’esercizio del diritto al lavoro in ogni forma e
20
manifestazione, implica necessariamente il riconoscimento di una capacità di agire per la creazione
di strutture ed organismi adatti allo svolgimento delle attività lavorative in forma associata, in
pratica, ogni difficoltà è stata superata con la costituzione formale della cooperativa da parte di soci
fondatori dotati di piena capacità e il successivo inserimento, previa delibera degli organi della
cooperativa stessa già legalmente costituita e omologata, dei soci interdetti.
Ora, il problema risulta parzialmente risolto dall’art. 5 II comma Legge 22 giugno 2000 n° 193, che
ha nuovamente inserito ulteriori commi al più volte novellato art. 20 Legge n° 354/1975. Il nuovo
XVIII comma stabilisce che: “Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento
di rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991 n° 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o
civili”. Rimane, al contrario, immutato per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative
diverse da quelle espressamente richiamate dalla norma.
Allo stesso modo, resta insuperabile l’ostacolo relativo all’amministrazione della cooperativa: l’art.
2382 c.c. vieta espressamente che possano essere nominate, come amministratori e sindaci, persone
interdette, così che solo i soci non detenuti possono ricoprire cariche sociali e rappresentare
all’esterno la cooperativa, anche per escludere impugnazioni di terzi e-x art. 1441 II comma c.c.
Quanto all’assemblea dei soci, può ipotizzarsi uno svolgimento di essa anche all’interno
dell’istituzione carceraria, in modo da farvi partecipare i soci detenuti, mentre l’ingresso dei soci
liberi potrebbe essere richiesto e autorizzato ai sensi dell’art. 17 Legge n° 354/1975 ovvero, laddove
ne sussistano le condizioni, la possibilità per i soci detenuti di ottenere un permesso premio per
partecipare all’esterno all’assemblea, ai sensi dell’art. 30 ter Legge n° 354 cit., che prevede la
concessione di tale strumento premiale anche al fine di coltivare interessi di lavoro, quale è appunto
la partecipazione agli organismi collegiali della cooperativa di cui si è soci.
Infine, la cooperativa, come ogni altro imprenditore pubblico o privato, è tenuta ai prelievi sulle
somme versate al socio detenuto come retribuzione o utili finanziari ai sensi degli artt. 48 e 51 u.c.
Regolamento.
Incentivi e limiti allo sviluppo del lavoro cooperativistico
Il ruolo fondamentale svolto dall’esperienza cooperativistica, nel favorire e incrementare lo
sviluppo del lavoro dei detenuti, ha ottenuto un riconoscimento anche nell’ambito del Protocollo
d’intesa sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero di grazia e giustizia il 22 febbraio
1999, nel quale l’ente locale e il Ministero s’impegnano congiuntamente ad avviare una attività
sistematica per informare detenuti, imprese e cooperazione sociale su opportunità, servizi e
agevolazioni per l’inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali.
Da parte sua, la Regione Lombardia si impegna a riservare e assegnare una quota parte delle proprie
commesse alle iniziative produttive inframurarie gestite dalle imprese e da cooperazione sociale e
consorzi, mentre il Ministero di giustizia assicura gli ambienti idonei per l’attività di lavoro in
ambito inframurario.
Il limite legislativo allo sviluppo dell’esperienza cooperativa in carcere era rappresentato,
comunque, dall’impossibilità di qualificare le cooperative in cui lavorano detenuti impegnati in
attività inframurarie, quali cooperative sociali ex Legge 8 novembre 1991 n° 381. Come è noto, le
cooperative sociali sono incentivate all’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie
svantaggiate, in quanto usufruiscono di sgravi fiscali nel caso in cui assumano almeno il 30% di
lavoratori appartenenti a tali categorie, tassativamente indicate nella legge stessa.
Il problema nasceva dal fatto che l’art. 4, I comma, Legge 381 cit., nella sua formulazione
originaria, definiva quali persone svantaggiate, oltre alle categorie degli invalidi, degli ex degenti in
ospedali psichiatrici, dei soggetti in trattamento psichiatrico, dei tossicodipendenti ed alcoolisti, dei
minori in difficoltà familiare e in età lavorativa, “i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n° 354, come
modificati dalla legge 10 ottobre 1986”.
21
Sulla base di questa disposizione, come è evidente, le cooperative erano incentivate ad assumere
esclusivamente persone ammesse a misure alternative alla detenzione, dal momento che nel
concetto di persona svantaggiata, con tutti i benefici economici che ne derivano, non rientravano i
detenuti ristretti negli istituti e neppure quelli ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 Legge n°
354/1975.
L’esigenza di introdurre questo allargamento delle disposizioni della Legge 381/1991 è stata
condivisa, allo stesso modo, dalla Regione Lombardia e dal Ministero di giustizia che, nel già
ricordato Protocollo d’intesa, si sono impegnati a “promuovere gli opportuni passi per estendere
anche ai detenuti i benefici previsti per i soggetti a rischio dalla legge 8 novembre 1991 n° 381,
nonché per estendere gli stessi benefici previsti per le cooperative sociali e consorzi anche a favore
delle imprese, di qualunque natura giuridica che, con le dovute garanzie di rispetto della
legislazione sul lavoro, offrano opportunità occupazionali alle persone detenute o comunque
sottoposte a misure limitative della libertà personale”.
La Legge 22 giugno 2000 n° 193 (c.d. Legge Smuraglia)
Nel corso dell’attuale legislatura, sono stati perciò presentati alcuni disegni di legge, accomunati dal
fine di perseguire una politica di promozione dell’occupazione dei detenuti in carcere, attraverso lo
strumento delle cooperative sociali e la conseguente previsione di sgravi fiscali e contributivi a
favore di queste ultime, come pure dei datori di lavoro pubblici e privati intenzionati ad offrire
opportunità di lavoro ai detenuti.
La Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato ha esaminato i tre disegni di legge in
argomento, dei quali due, il n° 3157, d’iniziativa Smuraglia, Fumagalli Carulli e Manconi, utilizzato
come testo-base, e il simile n° 1212, d’iniziativa Manconi e Peruzzotti, incidono essenzialmente
sulla Legge n° 381 cit., mentre il n° 3479, d’iniziativa Siliquini e Mulas, privilegia un’impostazione
volta a modificare la disciplina dell’ordinamento penitenziario.
Il testo, licenziato con parere favorevole dalla Commissione, già nel 1998, e definitivamente
approvato nel giugno 2000, corrisponde alle attese dei settori più avanzati del mondo carcerario.
Come si legge nella relazione che accompagnava il disegno di legge, si tratta di un provvedimento
legislativo che, pur avendo un oggetto circoscritto, affronta una problematica, valutata di grande
rilevanza sociale, “poiché si propone di promuovere un più agevole accesso da parte dei detenuti
alle opportunità lavorative”.
L’art. 1, I comma, della legge modifica l’art. 4 I comma Legge n° 381 1991, nel senso di
ridisegnare ed ampliare la nozione di soggetti svantaggiati: accanto agli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, agli ex degenti di istituti psichiatrici, ai soggetti in trattamento psichiatrico, ai
tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari e ai
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio
sociale, dell’affidamento particolare per tossicodipendenti, della detenzione domiciliare e della
semilibertà, vengono inseriti nella categoria delle persone svantaggiate anche gli ex degenti di
ospedali psichiatrici giudiziari, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.
Per quanto riguarda quest’ultima categoria, l’estensione ai condannati ammessi al lavoro all’esterno
conferma lo spostamento di questo beneficio dall’ambito delle modalità trattamentali della pena a
quello delle misure alternative alla detenzione.
La distinzione, poi, nella lettera della legge tra “persone detenute o internate”, da un lato,
e”condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione”, dall’altro, consente di
ritenere inseriti nella categoria delle persone svantaggiate non solo i condannati e gli internati,
sottoposti alle misure di sicurezza della casa di lavoro e della colonia agricola, ammessi o meno alle
misure alternative, ben si anche gli imputati e gli internati, infermi e seminfermi di mente, sottoposti
alle misure di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia.
22
Quanto alle agevolazioni fiscali, fermo restando l’azzeramento dei contributi dovuti dalle
cooperative sociali sulle retribuzioni dei soggetti svantaggiati previsti nel testo originario della
disposizione, per le retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e agli ammessi al lavoro
all’esterno, viene introdotto, dall’art. 1 II comma Legge n° 193/2000 che introduce il comma III bis
dell’art. 4 Legge n° 381/1991, un sistema di agevolazioni ad aliquote ridotte, in misura percentuale
da definire, con cadenza biennale, dal Ministero di giustizia di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Tali sgravi contributivi si applicano, inoltre, per un
ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.
La differenziazione delle agevolazioni, riduttive delle aliquote complessive della contribuzione a
carico delle cooperative sociali, lascia, comunque, perplessi: riesce, infatti, difficile comprendere la
riduzione differenziata della contribuzione in presenza di identici handicap sociali, pur se in soggetti
svantaggiati con status giuridici distinti. L’esempio più facile è quello del tossicodipendente, che, a
seconda del suo status giuridico, di persona libera ovvero detenuta a regime ordinario ovvero
ammessa ad una misura alternativa alla detenzione o, infine, al lavoro all’esterno ex art. 21 Legge
354/1975, potrà trovare occupazione presso una cooperativa sociale con riduzioni diverse della
aliquota contributiva sulla sua retribuzione.
La seconda importante novità della Legge Smuraglia è rappresentata dall’estensione di questo
sistema differenziato di agevolazioni contributive alle imprese pubbliche o private che “organizzino
attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o
internate” (art. 2 Legge n° 193/2000). In questo modo, viene ad aggirarsi il limite logico
invalicabile per lo sviluppo dell’esperienza cooperativistica in carcere, rappresentato
dall’impossibilità giuridica di qualificare come sociali, ai sensi dell’art. 1, Legge n° 381 1991, le
cooperative operanti in carcere e composte da soli detenuti, impegnati in attività intramurarie.
Sotto questo profilo, il legislatore ha cercato di ridurre, se non interamente colmare, la debolezza
intrinseca del lavoro dei detenuti rispetto a quello libero, consentendo e favorendo la
privatizzazione non solo delle attività produttive in senso proprio, bensì anche dei servizi negli
istituti, tradizionalmente attribuiti alla diretta gestione da parte dell’Amministrazione penitenziaria.
La conseguenza, non esplicitata nelle disposizioni in esame, è quella della coesistenza, all’interno
dei singoli istituti, d’identiche posizioni lavorative, riconducibili, tuttavia. ai vari tipi di lavoro
penitenziario, e quindi caratterizzate da un livello di maggiore o minore specialità nei confronti
della disciplina standard, in base alla modalità scelta per la gestione del servizio, pubblica, privata o
attraverso cooperative sociali.
In altri termini, un detenuto impiegato nella somministrazione del vitto, per esempio, potrà essere
considerato, nell’accezione qui seguita, sulla base della distinzione tradizionale della Corte
Costituzionale, come addetto ai lavori domestici, in quanto dipendente dell’amministrazione,
oppure addetto alle lavorazioni, intese come produzioni di servizi, in quanto dipendente di una
cooperativa o di una impresa pubblica o privata, con tutte le disparità di trattamento giuridico che la
natura del datore di lavoro implicherà.
Lo strumento designato dal legislatore, per regolamentare i rapporti con gli operatori economici
interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro, è rappresentato dalle convenzioni :
attraverso l’inserimento di un nuovo XIII comma nell’art. 20 Legge 354/1975, viene previsto che le
Amministrazioni penitenziarie stipulino con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali
apposite convenzioni, relative all’oggetto e alle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa,
alla formazione e al trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica (art. 5 Legge
n° 193/2000).
Il trattamento retributivo, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa
vigente per il lavoro penitenziario (art. 2 Legge 193 cit.): ciò comporta che la convenienza
economica per le imprese pubbliche o private intenzionate a utilizzare manodopera detenuta è
costituita esclusivamente dalle agevolazioni contributive, di cui agli art. 4, comma III bis, Legge n°
381/1991 e 2, Legge n° 193/2000, e dagli sgravi fiscali previsti dall’art. 3 Legge n° 193/2000. Le
23
modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali sono determinate annualmente, sulla base
delle risorse finanziarie stanziate dall’art. 6 Legge n° 193 cit., con apposito decreto del Ministro
della giustizia da emanare, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno (art. 4
Legge n° 193 cit.).
Costituzione del rapporto
La nuova impostazione del legislatore del 1993 si riflette anche sulle modalità di costituzione del
rapporto: come già osservato, la novità, introdotta con la Legge n° 296/1993 ed esplicitata all’art.
47 Regolamento, è rappresentata dall’abrogazione del divieto di costituire un rapporto di lavoro
diretto tra datore di lavoro e detenuto, anche quando la prestazione viene espletata all’interno del
carcere.
Ora, la scelta originaria di escludere ogni possibilità in questo senso era motivata dalla volontà di
eliminare, dopo le esperienze del passato, ogni rischio di sfruttamento del lavoro dei carcerati da
parte degli imprenditori pubblici e privati, ma si trattava di una scelta evidentemente
contraddittoria, dal momento che venivano previste eccezioni, come, per esempio, nel caso di
detenuto ammesso al lavoro all’esterno ex art. 21 O.P., rispetto al quale era già possibile
l’instaurazione di un rapporto diretto con il datore di lavoro, in una situazione in cui, certamente,
non è da escludersi il pericolo di uno sfruttamento del lavoro del condannato.
Attualmente, quindi, venuta meno la necessità di configurare il rapporto di lavoro del ristretto,
sempre e comunque, con l’amministrazione penitenziaria, l’imprenditore pubblico o privato
organizza e gestisce direttamente le attività lavorative e stipula rapporti di lavoro di diritto privato
con i condannati cui offre opportunità lavorative.
Il ruolo ritagliato per l’Amministrazione penitenziaria è quello delineato dall’art. 25 bis II comma
ss. Legge n° 354/1975, inserito dalla Legge n° 296/1993: le lavorazioni penitenziarie sono
organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’amministrazione, sentite le
direzioni degli istituti e le commissioni regionali per il lavoro penitenziario, istituite a norma del I
comma della norma in esame. Tali commissioni sono presiedute dal provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria e composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni
imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel
settore del lavoro e della formazione professionale con l’intervento di un funzionario dell’ufficio
regionale del lavoro (art. 25 bis cit., I comma).
I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e
qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto; sono fissati in una
tabella predisposta dalla direzione dell’istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti
relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto. In questa tabella sono,
altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all’esterno presso imprese pubbliche o private o
associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni
cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno degli istituti (art. 25 bis cit., III
e IV comma). Annualmente, la direzione dell’istituto elabora ed indica il piano di lavoro, in
relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria
disponibile e alle strutture produttive (art. 25 bis cit., V comma).
La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro
annuale sono approvati dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sentita la
commissione regionale per il lavoro penitenziario (art. 25 bis cit., VI comma).
Infine, l’ultimo comma stabilisce che nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività
lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata. Appare evidente, dalla
semplice lettura del complesso normativo delineato dalla novella del 1993, che all’amministrazione
penitenziaria viene riservata solo la funzione di disciplinare tecnicamente, attraverso i meccanismi
descritti delle tabelle, del piano di lavoro e delle convenzioni, l’incontro tra domanda ed offerta di
24
lavoro, mentre viene meno ogni altro suo intervento. Cosi, il tema del lavoro carcerario viene
riconsegnato al mercato, riducendo o eliminando del tutto ogni ostacolo normativo che si frapponga
alla privatizzazione.
Svolgimento del rapporto
Una volta instauratosi il rapporto di diritto privato, sul paradigma normativo dell’art. 2094 c.c.. tra il
condannato e l’impresa impegnata nelle lavorazioni inframurarie, si tratta, ancora una volta, di
verificare quali diritti nascenti in capo al lavoratore libero possano essere riconosciuti al lavoratore
detenuto, alla luce della privatizzazione delle lavorazioni stesse e della natura dell’attività esercitata.
per definizione finalizzata alla produzione di beni o servizi.
In linea generale, occorre preliminarmente osservare come non possa essere esclusa l’applicabilità
della contrattazione collettiva ai rapporti instaurati tra l’imprenditore e i detenuti che lavorano alle
sue dipendenze. laddove la fonte collettiva sia stata richiamata nel contratto individuale di lavoro
ovvero l’uno e gli altri siano aderenti ad organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Esaminando i singoli istituti, come già rilevato in tema di lavoro inframurario alle dipendenze della
Amministrazione nel precedente capitolo, l’art. 20 XVII comma Legge n° 354/1975, in ordine allo
svolgimento del rapporto, stabilisce significativamente che la durata della prestazione lavorativa
non possa superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e che, alla stregua di tali leggi, è garantito il
riposo festivo. Di conseguenza, anche in questo caso, la durata della giornata lavorativa non può
superare il limite giornaliero delle otto ore e deve essere garantito un giorno di riposo settimanale,
fatte salve, nei limiti di cui sopra, le previsioni dei contratti collettivi, per esempio, in materia di
riduzione di orario di lavoro.
Già in precedenza è stato messo in ampio rilievo l’incomprensibile silenzio del legislatore in
materia di ferie: anche in questa ipotesi di lavoro inframurario, al di là dei problemi di legittimità
costituzionale della normativa vigente, appare agevole richiamare lo strumento premiale specifico,
costituito dai permessi-premio (di durata non superiore a quindici giorni ogni volta e per
complessivi giorni quarantacinque per ogni anno di espiazione di pena), che ben potrà essere
coordinato con la fruizione delle ferie, ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, per
l’inapplicabilità nel caso concreto della disciplina di cui all’art. 30 ter Legge n° 354/1975, ribadire il
diritto del detenuto lavoratore a un periodo retribuito di non effettuazione dell’attività lavorativa,
dedicato al riposo o alle attività sportive e ricreative esistenti (e usufruibili) all’interno dell’istituto.
Quanto ai diritti non ricava bili direttamente da norme di rango costituzionale, nessuna disposizione
è rinvenibile con riferimento al diritto alle mansioni e alla qualifica contrattuale che assume
maggiore rilevanza in questa tipologia di lavoro inframurario. L’assenza di previsioni specifiche
importa l’applicabilità della regola di cui all’art. 2103 c.c., sul divieto di assegnazione di mansioni
inferiori e sulla promozione automatica, in caso di svolgimento di mansioni superiori rispetto al
livello di inquadramento, per effetto del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di
lavoro tra imprenditore e detenuto, con conseguente applicazione delle norme vigenti di diritto del
lavoro. Senza entrare nel catalogo dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro, in conclusione, risulta
evidente l’applicabilità di tutti gli istituti riconducibili alla disciplina standard, come semplice
effetto del mutato atteggiarsi del rapporto di lavoro, conseguente alla novella del 1993.
Diritti sindacali
Più articolato deve essere l’esame del tema del riconoscimento dei diritti sindacali. Per il diritto di
associazione sindacale, non pare ravvisabile nello status di detenuto alcun limite all’iscrizione ad
associazioni sindacali già esistenti, sempre che, come già osservato in precedenza, l’organizzazione
sindacale cui il soggetto si rivolga non ponga, all’interno del proprio statuto o atto costitutivo,
vincoli all’accettazione della domanda di iscrizione, correlati, per esempio, all’incensuratezza o al
più generico concetto di buona condotta morale e civile dei richiedenti l’ingresso nell’associazione.
25
In questo caso, sarà l’organizzazione sindacale stessa a dover valutare la sussistenza o meno delle
condizioni per poter accogliere la domanda del detenuto, sulla base dei propri atti istitutivi e delle
clausole dagli stessi previste, alla stregua di qualunque altra associazione.
Certamente più problematico appare l’esercizio dei diritti sindacali in ambito penitenziario: invero,
sotto questo profilo, il limite nasce proprio dalla condizione di detenuto del lavoratore, dal momento
che, come già osservato in precedenza, i vari momenti della vita penitenziaria, che si so stanziano
nello svolgimento di attività in comune, si inquadrano, di regola, entro uno schema organizzativo
predeterminato da parte dell’autorità penitenziaria, senza che, normalmente, siano lasciati margini
al dispiegarsi di autonome iniziative dei detenuti a sfondo partecipativo.
In altri termini, si tratta di verificare l’applicabilità dell’art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n° 300
e, in generale, lo spazio che potrebbero avere iniziative di tipo assembleare e rappresentative,
condotte dai detenuti in relazione a problemi ed esigenze di tipo sindacale e lavorativo.
L’unico limite ravvisabile in questo ambito deve essere rappresentato dalle reali esigenze di
sicurezza all’interno dei singoli istituti, che possono rendere legittime delle limitazioni rispetto alle
previsioni legislative, per esempio sull’ingresso di sindacalisti esterni per partecipare all’assemblea.
D’altro canto, spesso la contrattazione collettiva e quella di livello aziendale contengono la
disciplina di modalità di esercizio del diritto di riunione durante l’orario di lavoro, giudicate dalla
giurisprudenza del tutto legittime, ove non contrastino con le previsioni legislative. In realtà, per
quanto riguarda la titolarità dei diritti sindacali, il problema è rappresentato dalla circostanza che,
nella maggioranza dei casi, l’imprenditore-datore di lavoro assume la veste giuridica della
cooperativa, con tutti i limiti che ciò comporta in termini di applicabilità della disciplina standard
del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative, compresa la materia sindacale.
Quanto al diritto di sciopero, che è un diritto costituzionalmente garantito, come già notato nel
precedente capitolo, la dottrina appare nettamente divisa tra chi mette in evidenza che, comunque,
non sussiste alcuna incompatibilità con lo stato di detenzione e l’esercizio del diritto di sciopero,
echi, al contrario, ritiene impossibile il ricorso allo sciopero in presenza dello status di detenuto. In
argomento, mentre sembrano condivisibili le perplessità di una compatibilità tra l’esercizio del
diritto di sciopero e la condizione di detenuto, nel caso di addetti ai lavori domestici, dove la
particolare natura del datore di lavoro determina un limite all’applicabilità della normativa standard,
con il risultato di rendere meno ampio l’ambito della tutela giuridica riconoscibile ai detenuti,
nessuna incertezza deve sussistere nel caso delle lavorazioni, rispetto alle quali la differenziazione
dal lavoro libero si ricollega solamente alla condizione soggettiva del prestatore d’opera e al luogo
in cui si svolge la prestazione.
Cessazione del rapporto
Esaminando il tema della cessazione del rapporto, va osservato come in questa materia risulti
necessario individuare il punto di interferenza tra la disciplina penitenziaristica e quella
giuslavoristica: in altri termini, in questo caso, la sussistenza di un diretto rapporto di lavoro di
diritto privato tra l’imprenditore che gestisce le lavorazioni e il prestatore d’opera detenuto non
esclude l’applicabilità delle nozioni giuslavoristiche della giusta causa e del giustificato motivo,
oggettivo o soggettivo, quali circostanze fondanti un legittimo recesso, come pure del procedimento
previsto dall’art. 7 Legge n° 300 1970 per il licenziamento disciplinare e dalla Legge n° 108 1990,
sotto il profilo dei requisiti formali del licenziamento.
Dal canto suo, l’ordinamento penitenziario prevede una disciplina speciale per l’allontanamento dal
posto di lavoro del detenuto, definito di esclusione dalle attività lavorative, all’art. 53 del
Regolamento, che è già stato esaminato a proposito dei lavori domestici. Tale disposizione
regolamentare prevede che l’esclusione dalle attività lavorative possa essere adottata dalla direzione
dell’istituto solo in presenza di fatti o comportamenti commessi durante il lavoro e consistenti nel
sostanziale rifiuto nell’adempimento dei compiti e dei doveri lavorativi da parte del detenuto
lavoratore.
26
La disposizione non può intendersi riferita ai soli lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione, in
quanto si prevede che sia sentito, se del caso, il parere del preposto alle lavorazioni e del datore di
lavoro, così da confermarne l’applicabilità agli addetti alle lavorazioni. D’altro canto, l’art. 53 cit..
che corrisponde al previgente art. 50 Regolamento, contiene le medesime previsioni della norma
precedente, con l’unica significativa differenza che viene meno il richiamo alle sanzioni disciplinari
e viene imposto al direttore, prima di adottare il provvedimento, di sentire non solo il parere del
preposto alle lavorazioni, ma anche del datore di lavoro (e dei componenti del gruppo di
osservazione e trattamento), conformemente alla duplice previsione dell’art. 47 Regolamento di
lavorazioni gestite direttamente dalla direzione ovvero da imprenditori.
Si tratta, dunque, di coordinare l’incidenza della normativa penitenziaria sul potere di autonomia
negoziale delle parti nell’ambito del rapporto di lavoro: in primo luogo, va osservato come tale
incidenza possa riconoscersi solo nei confronti di una delle parti del contratto di lavoro, cioè quella
sottoposta alla misura privativa della libertà, mentre non può avere alcuna influenza diretta sull’altra
ne sui rapporti tra le parti del contratto stesso.
In secondo luogo, la distinzione tra rapporto punitivo e rapporto di lavoro comporta che la
cessazione del secondo sia compiutamente disciplinata dalla normativa standard: il datore di lavoro
sarà, quindi, vincolato dalla disciplina lavoristica e potrà intimare il licenziamento solo per giusta
causa o giustificato motivo, per iscritto e con comunicazione dei motivi, ove richiesto dal prestato
re d’opera, secondo le previsioni dell’art. 2 Legge n° 604/1966. Naturalmente, in concreto le
fattispecie di giusta causa e giustificato motivo potranno assumere caratteristiche particolari in
relazione alla qualità del lavoratore e al luogo ove si svolge la prestazione, ma la valutazione della
legittimità del recesso intimato al lavoratore detenuto andrà operata secondo i parametri elaborati
dalla dottrina e giurisprudenza lavoristica.
Più complessa appare la questione con riferimento al caso in cui il detenuto presti la propria attività
lavorativa nell’ambito di una cooperativa come socio lavoratore, dal momento che la giurisprudenza
appare consolidata nell’escludere, laddove non sia ravvisabile alcuna utilizzazione fraudolenta dello
schema cooperativistico, la riconducibilità alla fattispecie del lavoro subordinato delle prestazioni di
un socio di cooperativa, svolta in conformità dei fini statutari. Di conseguenza, la cooperativa non
incontra i vincoli sopra delineati in materia di recesso individuale, che resta regolato dalle norme di
diritto comune.
Una volta intimato validamente il recesso da parte del datore di lavoro, la direzione dell’istituto
deve semplicemente prendere atto del venir meno della posizione lavorativa, con le ovvie
conseguenze sul piano della posizione del prestatore d’opera all’interno del carcere: in questo caso,
l’esclusione del condannato dall’attività lavorativa, che segue la manifestazione di volontà
rappresentata dal recesso dal contratto di lavoro di una delle parti, nell’ambito della sua autonomia
negoziale, rappresenta la conseguenza necessitata di tale atto unilaterale e si pone su un piano
estraneo alla previsione dell’art. 53 Regolamento.
Allo stesso modo, il provvedimento del direttore dovrà seguire l’atto di dimissioni del lavoratore,
che costituisce parimenti una manifestazione di volontà uguale e contraria a quella del
licenziamento. Nell’ipotesi inversa, in cui, al contrario, il provvedimento di esclusione dalle attività
lavorative preceda un qualche atto di autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro, si tratta
di verificare come ciò si rapporti sul piano privatistico: ora, la circostanza che venga previamente
sentito il datore di lavoro, nell’impianto dell’art. 53 cit. non pare avere una valenza assimila bile a
quella di un vero e proprio atto di recesso, quanto, piuttosto, di un aspetto procedimentale, collegato
alla necessità per il direttore di acquisire informazioni sulla condotta del detenuto, trattandosi di un
parere obbligatorio, ma non vincolante. D’altro canto, la formulazione della norma è
sufficientemente generica da poter ricomprendere anche situazioni riconducibili ai concetti di giusta
causa e di giustificato motivo soggettivo.
Il provvedimento del direttore, in questo caso, costituirà motivo legittimo di recesso per il datore di
lavoro, che potrà motivare il licenziamento con il riferimento all’esclusione dalle attività lavorative.
Restano ovviamente salve le tutele azionabili dal detenuto lavoratore che, in tali casi, opereranno su
27
un duplice piano giurisdizionale: poiché frequentemente, nella pratica, la rimozione dal lavoro viene
utilizzata illegittimamente per sanzionare comportamenti che nulla hanno a che fare con lo
svolgimento dell’attività lavorativa, funzionando come ulteriore sanzione per infrazioni disciplinari
di altro genere, sarà possibile per il detenuto reclamare, ai sensi dell’art. 69 VI comma lett. b) Legge
n° 354/1975, il provvedimento della direzione, sotto l’aspetto penalistico della eventuale
inosservanza delle norme riguardanti le condizioni di esercizio del potere disciplinare, e agire, sotto
il profilo civilistico, nei confronti del datore di lavoro.
La retribuzione
Sotto il profilo della retribuzione, la novella del 1993 non ha importato alcuna modificazione
espressa delle norme, ma il nuovo sistema di privatizzazione delle lavorazioni non può risultare
privo di conseguenze sul piano degli aspetti del trattamento economico: l’applicabilità delle
disposizioni dell’art. 22 Legge n° 354/1975 ed in particolare delle limitazioni retributive previste da
tale norma è stata giustamente messa in dubbio alla luce delle stesse affermazioni della Corte
Costituzionale nella più volte citata sentenza n° 1087 del 1988, dal momento che la riduzione della
retribuzione, rispetto ai valori minimi tabellari contenuti nella contrattazione collettiva, risulterebbe
priva di motivazione in presenza di un rapporto di diritto privato, disciplinato, quindi, dal diritto
comune nei suoi elementi essenziali, tra cui la retribuzione appunto.
Una volta pervenuti a tale conclusione, è chiaro che si porrebbe in termini ancor più evidenti il
problema di fondo di tutte le lavorazioni, e cioè quello della convenienza economica per una
impresa esterna di utilizzare manodopera detenuta: la debolezza intrinseca del lavoro dei detenuti
rispetto a quello libero ha una qualche speranza realistica di essere ridotta, se non integralmente
colmata, solo con quella politica di forti incentivi contributivi e fiscali alle imprese che intendano
impegnarsi nella produzione di beni e servizi all’interno degli istituti, impiegando detenuti,
inaugurata dalla Legge Smuraglia.
Il lavoro extramurario: lavoro all’esterno e semilibertà
Lavoro all’esterno e semilibertà: presupposti e procedure di ammissione
Prima di esaminare, dettagliatamente, il tema del lavoro svolto dai detenuti all’esterno
dell’istituzione penitenziaria, seguendo lo schema già utilizzato per il lavoro inframurario, occorre
definire l’ambito, entro il quale si può, correttamente, parlare del lavoro come presupposto
dell’ammissione a una modalità di esecuzione extramuraria della pena. Infatti, non è corretto
parlare, genericamente, di misure alternative, posto che, all’interno del catalogo delle alternative
alla detenzione a regime ordinario previste dall’ordinamento penitenziario, una sola misura, e cioè
la semilibertà, richiede la presenza di un lavoro extramurario, come presupposto normativo
all’ammissione al beneficio.
Da questo punto di vista, l’ossessione lavoristica, innescata da alcune prassi giurisprudenziali della
Magistratura di Sorveglianza, ha portato a costruire l’attività lavorativa come presupposto
necessario per l’ammissione a molte misure alternative, per esempio all’affidamento in prova al servizio sociale, mentre lo svolgimento di attività
lavorative (ovvero istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, secondo la formula
contenuta nell’art. 48 Legge n° 354/1975) è richiesto dalla legge solo per l’ammissione al regime di
semilibertà.
Per quanto riguarda, poi, il lavoro all’esterno, di cui all’art. 21 Legge n° 354/1975 e che costituisce
la seconda tipica ipotesi di lavoro extramurario, va notato come, almeno nel disegno originario
dell’ordinamento penitenziario, non configuri una vera e propria misura alternativa alla detenzione.
Già la Legge n° 663/1986, c.d. Legge Gozzini, aveva sostituito l’originario testo dell’art. 21 cit.,
introducendo varie novità, tra cui, certamente, la più interessante era quella di aver subordinato il
28
provvedimento di ammissione della direzione dell’istituto all’autorizzazione del Magistrato di
Sorveglianza. Di fronte a queste modifiche, si poteva con una certa fondatezza sostenere che il
lavoro all’esterno si era spostato dall’ambito delle modalità trattamentali a quello delle misure
alternative alla detenzione, sia pure in senso lato: formalmente, rimaneva distinto dalla semilibertà,
ma nella prassi la sostanza dell’istituto era divenuta quella di una modalità di esecuzione della pena
extramuraria, sia pure meno stabilmente garantita, in assenza di un vero procedimento
giurisdizionalizzato per la concessione e per la revoca, e con uno spazio di libertà più ridotto.
La successiva evoluzione normativa ha confermato questa parificazione: in primo luogo, la Legge
121uglio 1991 n° 203 ha limitato l’ammissione al lavoro all’esterno alle stesse condizioni restrittive
cui sono subordinate le misure alternative.
In secondo luogo, l’art. 1 I comma Legge 22 giugno 2000 n° 193 prevede l’inclusione dei
condannati ammessi al lavoro all’esterno nella nozione di persone svantaggiate, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 Legge n° 381/91, analogamente a quanto già stabilito per gli ammessi alle misure
alternative alla detenzione, confermando lo spostamento di questo beneficio dall’ambito delle
modalità trattamentali della pena a quello delle misure alternative alla detenzione in senso proprio.
Esaminando, ora, presupposti e procedure di ammissione di questi due istituti, va osservato come la
competenza per la concessione (come pure per la revoca) della semilibertà spetti al Tribunale di
Sorveglianza, nell’ambito delle regole procedimentali del processo di sorveglianza di cui agli artt.
677 ss. c.p.p.: l’ammissione va disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento,
quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società (art. 50 IV
comma Legge n° 354/1975).
Ora, senza entrare in dettagli del procedimento di concessione della semilibertà, che esulano dal
tema del lavoro penitenziario, alcuni punti devono essere ribaditi. In primo luogo, risulta evidente
come l’accertamento dell’esistenza dell’attività lavorativa, cui il detenuto indica di volersi dedicare
se ammesso alla misura alternativa, sia parte fondamentale del procedimento di sorveglianza. Tale
accertamento si tradurrà, sul piano dell’acquisizione probatoria, in un’attività istruttoria, da parte
del Tribunale di Sorveglianza, il cui risultato, cioè le informazioni assunte in proposito, dovranno
essere lette in udienza, alla presenza delle parti processuali, nel pieno rispetto del principio del
contraddittorio. Sul piano della valutazione decisoria, invece, dovrà concretarsi in un’adeguata
motivazione, in senso positivo o negativo, delle condizioni per il reinserimento del condannato.
In secondo luogo, il Tribunale di Sorveglianza non potrà valutare la certezza delle prospettive future
di tale attività in termini di assolutezza, bensì di fiera relatività: ciò significa che, per esempio,
nessun ostacolo può essere frapposto alla concessione della misura in presenza di un contratto di
lavoro a tempo determinato, ovviamente di durata significativa, ovvero a tempo parziale, sempre
che, in tale ultimo caso, il programma trattamentale disegni compiutamente le altre attività
risocializzanti, cui il detenuto si dedicherà nel corso delle restanti ore della giornata, per esempio
attività di lavoro autonomo ovvero di cura di familiari, in quanto utili al suo reinserimento sociale,
secondo le previsioni dell’art. 101 Regolamento.
Inoltre, l’ammissione al regime di semilibertà potrà essere disposta anche in relazione ad un’attività
di tipo autonomo, come le collaborazioni coordinate e continuative di tipo parasubordinato,
estremamente diffuse nell’attuale mercato del lavoro: in presenza di un contratto tra le parti e di una
qualche organizzazione imprenditoriale del contraente datore di lavoro, sarà verificabile quel
carattere di relativa certezza delle prospettive lavorative future del condannato, cui fa cenno la
giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Allo stesso modo, nessuna tipologia di lavoro può, in ipotesi, essere esclusa per l’ammissione al
lavoro all’esterno, così che dovranno essere prese in considerazione sia le collaborazioni coordinate
e continuative che i rapporti a termine, sia il lavoro autonomo che la prestazione in favore di
cooperative sociali, nei limiti in cui permettano di realizzare le “condizioni idonee a garantire
l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15 Legge n° 354/1975” (art. 21 I comma Legge n°
354 cit.).
29
Rispetto al regime di semilibertà, in ogni caso, più semplice e meno garantita risulta la procedura di
ammissione (e di revoca) del lavoro all’esterno. L’ammissione, infatti, è disposta con
provvedimento della direzione dell’istituto, ex art. 48 I comma Regolamento, che diventa esecutivo
dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Quest’ultimo, nell’approvare con decreto il
provvedimento di ammissione, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista,
della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire il
pericolo che il soggetto ammesso commetta altri reati.
Non è prevista, quindi, alcuna giurisdizionalizzazione della procedura di ammissione, nel senso che
non è prevista l’applicazione del procedimento di sorveglianza. Peraltro, la circostanza che il
decreto di approvazione sia adottato da un organo giurisdizionale non può essere priva di
conseguenze, sul piano della qualificazione del decreto in termini di mero atto amministrativo
ovvero giurisdizionale.
La Corte di Cassazione si è sempre pronunciata nel senso della natura amministrativa del
provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, argomentando che si tratta di un atto privo di
autonomia dispositiva, che s’inserisce in un procedimento amministrativo. Per tali ragioni, la Corte
ne ha escluso l’impugnabilità, anche sotto il profilo del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
“non potendosi la materia, riservata all’autorità carceraria, farsi rientrare in quella relativa alla
libertà personale.
In senso diametralmente opposto si è, invece, pronunciato il giudice amministrativo, che non solo
ha declinato la propria giurisdizione, ma si è anche espresso per la ricorribilità in Cassazione ex art.
111 Cost. del decreto stesso.
In effetti, nel sistema originario della legge sull’ordinamento penitenziario, il previo assenso del
Magistrato di Sorveglianza per l’ammissione al lavoro all’esterno si configurava come un mero atto
endo - procedimentale, privo di rilevanza esterna, in quanto inserito all’interno di una procedura
amministrativa, di competenza dell’autorità penitenziaria.
Dopo le modifiche della Legge n° 663/1986, tuttavia, tale ricostruzione non appare più corretta: già
la nuova titolazione dell’art. 21 Legge n° 354 cit. “lavoro all’esterno”, in luogo dell’originario
“modalità di lavoro”, appare significativa. Decisivo, poi, è il rilievo che è stato accentuato il
controllo di legalità sul provvedimento della direzione, attraverso l’intervento di un giudice terzo,
che compie valutazione autonome, sulla base dei parametri indicati all’art. 48 IV comma
Regolamento.
Resta, comunque, irrisolto il nodo della motivazione del decreto stesso: in proposito, è stato
osservato come l’art. 69 V comma Legge n° 354/1975 parli in modo generico di decreto, laddove,
in analoghe norme, il legislatore utilizzi l’espressione “decreto motivato”, così da far ritenere non
necessaria la motivazione del diniego all’approvazione dell’ammissione al lavoro all’esterno.
Peraltro, tale affermazione contrasta con il dato sistematico, che evidenzia una linea di tendenza alla
giurisdizionalizzazione dell’esecuzione della pena, che si coglie nell’indicazione normativa dei
parametri cui il Magistrato di Sorveglianza deve attenersi, nella sua decisione.
La partecipazione degli enti locali all’inserimento lavorativo dei detenuti
La legge della Regione Piemonte 8 gennaio 1990 n° 1 rappresenta un interessante esempio di
iniziativa di un ente locale, per tentare di offrire concrete opportunità lavorative a detenuti che
possono accedere al lavoro all’esterno e alla semilibertà. La vicenda si presta ad alcune riflessioni,
perché non solo la legge ebbe un iter piuttosto travagliato, ma venne anche sollevata una questione
di legittimità avanti la Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio, che ne sosteneva
l’incostituzionalità, in quanto adottata, al di fuori delle competenze regionali di cui all’art. 117
Cost., nella materia penitenziaria di stretta riserva statale.
La legge in esame, intitolata “Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro
all’esterno per lavori socialmente utili a protezione dell’ambiente”, configura la possibilità di
utilizzare i condannati, ammessi al lavoro extramurario, in progetti in materia di tutela
30
dell’ambiente, presentati da Comuni e Comunità montane, progetti finanziati dalla regione stessa,
anche sotto il profilo dei costi della manodopera e degli oneri assicurativi, previdenziali e
assistenziali. Malgrado venga utilizzato il termine “attività lavorativa”, è esplicitamente escluso che
l’impiego dei detenuti nei progetti determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
con l’ente territoriale, in considerazione delle esclusive finalità sociali. La scelta tecnica è stata,
quindi, quella di qualificare l’attività come, comunque, prestata alle dipendenze
dell’Amministrazione penitenziaria, così da superare l’ostacolo costituito dall’interdizione legale
dei condannati, che impediva l’instaurazione di un rapporto diretto con l’ente pubblico.
La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità
sollevata dal Governo : nella sentenza, la Corte ha chiarito come la legge regionale non costituisca
in alcun modo una indebita interferenza nell’ordinamento penitenziario di stretta competenza
statuale, limitandosi ad offrire una opportunità di possibile impiego dei detenuti in attività,
caratterizzate da scopi di utilità sociale, e lasciando salvo il controllo esclusivo della stessa
Amministrazione penitenziaria sul personale impiegato e sulla durata dell’esperimento.
La Corte ha ribadito, anzi, che la partecipazione degli enti locali nell’opera di reinserimento dei
detenuti è in piena sintonia con le finalità proprie dell’ordinamento penitenziario. secondo quanto
previsto dalla stessa Legge n° 354/1975.
In questa stessa ottica si è mossa la Regione Lombardia che, nel capitolo 4 del Protocollo d’intesa
con il Ministero di grazia e giustizia 22 febbraio 1999, già citato, si è impegnata ad assicurare uno
stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti, degli
ammessi alle misure alternative e delle persone dimesse, e le reali esigenze occupazionali del
mercato del lavoro regionale. Relativamente alle attività di avviamento al lavoro, la Regione
Lombardia e il Ministero di giustizia s’impegnano nel Protocollo:
• ad avviare una attività sistematica per informare i detenuti, le imprese e la cooperazione sociale
su opportunità, servizi e agevolazioni per l’inserimento lavorativo e la nascita di attività
imprenditoriali;
• a coordinare e incrementare le forme di mediazione (borse lavoro, abbattimento degli oneri
finanziari) a favore di imprese che assumono detenuti ammessi al lavoro all’esterno, a misure
alternative e persone dimesse;
• a rafforzare l’attuale rete di Servizi di Inserimento Lavorativo, sostenendone le competenze a
favore dei detenuti e delle persone dimesse.
La legge regionale 18 gennaio 1999 n° 1 “Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego”,
nell’ambito della disciplina dei compiti conferiti agli enti locali, ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre
1997 n° 469, in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro, all’art. 10 chiarisce
come la Regione Lombardia promuove misure di politica attiva del lavoro, finalizzate
all’allargamento e alla qualificazione della base occupazionale, in relazione alle politiche formative
ed ai servizi per l’impiego ed attraverso l’uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali.
L’azione regionale è finalizzata al sostegno, tra gli altri, ai soggetti appartenenti alle categorie
deboli, attraverso interventi di erogazione di incentivi alle imprese, per l’assunzione a tempo
indeterminato di ex detenuti e detenuti ammessi al lavoro esterno e di promozione di misure di
orientamento, accompagnamento e formazione volte a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta
di lavoro, a favore dei soggetti deboli.
Infine, è previsto che il Consiglio regionale definisca annualmente, con una propria deliberazione, i
criteri di attuazione degli interventi previsti dallo stesso art. 10, individuando i soggetti beneficiari,
le tipologie e l’entità dei finanziamenti concedibili come pure il riparto delle risorse su base
provinciale.
La parificazione al lavoro libero relativamente alla costituzione del rapporto
Esaminando ora i vari aspetti del lavoro extramurario, secondo lo stesso schema già seguito per il
lavoro inframurario, occorre, in linea generale, osservare come il punto di interferenza tra la
31
disciplina penale e quella lavoristica incida sul potere di autonomia negoziale di una sola delle parti,
e cioè quella sottoposta alla misura privativa della libertà personale.
In altri termini, come sarà chiarito considerando lo svolgimento del rapporto di lavoro, nei suoi vari
aspetti, la discriminazione della legge penale, nei confronti delle parti del contratto di lavoro, potrà
influire direttamente solo sulla posizione del lavoratore detenuto, mantenendosi, cosi, su un piano
distinto, anche se necessariamente correlato, rispetto a quello dell’autonomia negoziale delle parti.
Tale caratteristica era già stata evidenziata, con riferimento alle lavorazioni, nel nuovo assetto
legislativo conseguente alla riforma del 1993, ma appare ancora più marcata nell’ambito del lavoro
extramurario. Il primo aspetto, in cui tale influenza e, nello stesso tempo, separatezza, dei piani
privatistico e penalistico deve essere evidenziata, è quello relativo alla costituzione del rapporto:
come già detto, l’art. 20 Legge n° 354/1975 stabilisce che al lavoro extramurario si applicano la
disciplina generale sul collocamento ordinario e agricolo, nonché l’art. 19 Legge 28 febbraio 1987
n° 56.
In questa sede non verranno affrontate le questioni specifiche, relative alla disciplina del
collocamento, bensì il rapporto tra l’atto autorizzativo al lavoro extramurario, sia esso decreto di
approvazione del lavoro all’esterno del Magistrato di Sorveglianza ovvero ordinanza di ammissione
alla semilibertà del Tribunale di Sorveglianza, da un lato, e conclusione del contratto di lavoro con
successiva comunicazione alla sezione circoscrizionale per l’impiego, dall’altro.
In particolare, già in precedenza, quando era vigente la disciplina del collocamento pubblico, si
sosteneva che la conclusione positiva del procedimento di accertamento della sussistenza dei
requisiti di idoneità al lavoro extramurario, da parte degli organi della giurisdizione rieducativa,
costituisse condizione essenziale alla conclusione del contratto di lavoro, ma non potesse influire
sul rilascio del nulla-osta da parte dell’ufficio di collocamento, atto vincolato unicamente al
verificarsi delle condizioni normativamente previste.
Di conseguenza, l’atto di ammissione al lavoro extramurario poteva precedere o, anche, seguire
l’atto di avviamento al lavoro esterno del detenuto. Parallelamente, l’eventuale mancata
concessione della misura alternativa impediva il sorgere del rapporto di lavoro, costituendo,
peraltro, giustificato motivo di rifiuto del posto di lavoro, tale da impedire la decadenza dal diritto
all’indennità di disoccupazione e la cancellazione dalla lista di disoccupazione.
In conclusione, il procedimento di collocamento e il procedimento di ammissione alla misura
alternativa agivano autonomamente, in base ai criteri che sovrintendevano alle distinte discipline
che li regolavano, rappresentando procedure diverse, che si intersecavano nel punto di incidenza
della legge penale sullo status di detenuto del contraente lavoratore.
Attualmente la situazione appare molto semplificata, per effetto della riforma del collocamento di
cui alla Legge 28 novembre 1996 n° 608: una volta venuta meno la necessità del nullaosta
all’avviamento al lavoro, a seguito della generalizzazione della regola dell’assunzione diretta, al
datore di lavoro è fatto obbligo di inviare alla sezione circoscrizionale per l’impiego una
comunicazione scritta contenente una serie di elementi, entro cinque giorni dall’assunzione. Tale
comunicazione sostituisce il precedente procedimento di autorizzazione, che consentiva un
controllo amministrativo sulla richiesta nominativa, eccezione alla regola, e dovrà essere effettuata
una volta stipulato il contratto di lavoro, indipendentemente dalla presenza o meno dell’atto di
ammissione al lavoro extramurario.
La parificazione al lavoro libero relativamente allo svolgimento del rapporto
Per quanto riguarda lo svolgimento del rapporto di lavoro extramurario, risulta evidente
l’applicabilità di tutti gli istituti riconducibili alla disciplina standard, fatte salve alcune eccezioni in
materia, per esempio, di espletamento di lavoro notturno, difficilmente compatibile con lo status di
detenuto ammesso alla semilibertà o al lavoro all’esterno. L’art. 48 XI comma del Regolamento
esplicita tale applicabilità, affermando che “I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno
32
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli
obblighi inerenti alla esecuzione della misura”.
Naturalmente, in caso di lavoro esterno, sarà applicabile al lavoratore condannato il contratto
collettivo, vigente all’interno dell’azienda presso cui è occupato, allo stesso modo in cui viene
applicato agli altri dipendenti, sotto il profilo c.d. normativo.
Esaminando i singoli istituti, come già rilevato in tema di lavoro inframurario, l’art. 20 XVII
comma Legge n° 354 cit., in ordine allo svolgimento del rapporto, stabilisce significativamente che
la durata della prestazione lavorativa non possa superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e che,
alla stregua di tali leggi, è garantito il riposo festivo. Di conseguenza, anche in questo caso, la
durata della giornata lavorativa non può superare il limite giornaliero delle otto ore e deve essere
garantito un giorno di riposo settimanale, fatte salve le previsioni dei contratti collettivi, per
esempio in materia di riduzione di orario di lavoro.
Già in precedenza, è stato messo in rilievo l’incomprensibile silenzio del legislatore in materia di
ferie: in questa ipotesi di lavoro extramurario, appare agevole richiamare gli strumenti penitenziari
specifici, costituiti dai permessi-premio, per gli ammessi al lavoro all’esterno, e dalle licenze, di cui
all’art. 52 Legge n° 354/1975, per i semiliberi, (concedibili entrambi per quarantacinque giorni per
ogni anno di espiazione di pena), strumenti che potranno essere coordinati con la fruizione delle
ferie. Nei casi in cui la fruizione di permessi e licenze non sia possibile, occorre ribadire il diritto
del detenuto lavoratore a un periodo retribuito di non effettuazione dell’attività lavorativa, dedicato
al riposo o alle attività sportive e ricreative esistenti (e usufruibili) all’interno dell’istituto.
Quanto ai diritti non ricavabili direttamente da norme di rango costituzionale, come già visto,
nessuna disposizione è rinvenibile nell’ordinamento penitenziario con riferimento al diritto alle
mansioni e alla qualifica contrattuale. Tuttavia, l’equiparabilità alla normativa standard comporta
l’applicabilità della regola di cui all’art. 2103 c.c. sul divieto di assegnazione di mansioni inferiori e
sulla promozione automatica, in caso di svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di
inquadramento. Per quanto riguarda, poi, l’eventuale trasferimento da una unità produttiva ad
un’altra del lavoratore detenuto, sotto il profilo privatistico, i poteri del datore di lavoro non
differiscono da quelli esercita bili nei confronti di qualunque altro suo dipendente.
Dal punto di vista penitenziario, si tratterà, invece, di predisporre la modifica del programma di
trattamento, con riferimento al nuovo luogo di lavoro e al percorso per raggiungerlo, sulla base
della comunicazione del datore di lavoro e della relativa attività istruttoria, ove ritenuta necessaria,
del Magistrato di Sorveglianza, in caso di semilibero, ovvero del direttore dell’istituto, nel caso di
ammesso al lavoro all’esterno.
La parificazione al lavoro libero relativamente ai diritti sindacali
Con riferimento al tema del riconoscimento dei diritti sindacali, la parificazione dei lavoratori
all’esterno con i lavoratori liberi, non comporta difficoltà particolari. Per quanto riguarda il diritto di
associazione sindacale, come già più volte ricordato, non pare ravvisabile nello status di detenuto
alcun limite all’iscrizione ad associazioni sindacali già esistenti, sempre che l’organizzazione
sindacale, cui il soggetto si rivolga, non ponga, all’interno del proprio statuto o atto costitutivo,
vincoli all’accettazione della domanda di iscrizione, correlati, per esempio, all’incensuratezza o al
più generico concetto di buona condotta morale e civile dei richiedenti l’ingresso nell’associazione.
In questo caso, sarà l’organizzazione sindacale stessa a dover valutare la sussistenza o meno delle
condizioni per poter accogliere la domanda del detenuto, sulla base dei propri atti istitutivi e delle
clausole dagli stessi previste, alla stregua di qualunque altra associazione.
Certamente agevole appare, poi, nel caso di lavoro extramurario, l’esercizio dei diritti sindacali, dal
momento che, sotto questo profilo, nessun limite può nascere dalla condizione di detenuto che
lavora all’esterno della struttura penitenziaria, in termini di diritto a partecipare alle iniziative di
tipo assembleare e rappresentative, condotte sul posto di lavoro, nel rispetto delle previsioni
legislative e della contrattazione collettiva nazionale e di livello aziendale.
33
Quanto al diritto di sciopero, che è un diritto costituzionalmente garantito, come già notato in
precedenza, la dottrina appare nettamente divisa, tra chi mette in evidenza che, comunque, non
sussiste alcuna incompatibilità tra lo stato di detenzione e l’esercizio del diritto di sciopero e chi, al
contrario, ritiene impossibile il ricorso allo sciopero, in presenza dello status di detenuto. In
argomento, nessuna incertezza deve sussistere nel caso del lavoro svolto all’esterno, rispetto al
quale la differenziazione dal lavoro libero si ricollega solamente alla condizione soggettiva del
prestato re d’opera e non può incidere sul piano delle relazioni tra detenuto lavoratore e impresa
datrice di lavoro.
La parificazione al lavoro libero relativamente alla cessazione del rapporto
Il tema della cessazione del rapporto, analogamente a quello della costituzione, rappresenta un
punto di necessaria interferenza tra disciplina privatistica e penale. La distinzione tra rapporto
punitivo e rapporto di lavoro comporta che la cessazione del secondo sia compiutamente
disciplinata dalla normativa standard: il datore di lavoro sarà vincolato dalla disciplina lavoristica e
potrà intimare il licenziamento individuale solo per giusta causa o giustificato motivo, per iscritto e
con comunicazione dei motivi, ove richiesto dal prestatore d’opera, secondo le previsioni dell’art. 2
Legge n° 604/1966, ovvero il licenziamento collettivo nel rispetto della procedura di cui alla Legge
n° 223/1991, mentre la valutazione della legittimità del recesso intimato al lavoratore detenuto
andrà operata secondo i parametri elaborati dalla dottrina e giurisprudenza lavoristica.
Quanto al caso in cui il detenuto presti la sua attività lavorativa esterna nell’ambito di una
cooperativa come socio lavoratore, come già rilevato, la giurisprudenza appare consolidata
nell’escludere, laddove non sia ravvisabile alcuna utilizzazione fraudolenta dello schema
cooperativistico, la riconducibilità delle prestazioni di un socio di cooperativa, svolta in conformità
dei fini statutari, alla fattispecie del lavoro subordinato.
Di conseguenza, la cooperativa non incontra i vincoli sopra delineati in materia di recesso
individuale che resta regolato dalle norme di diritto comune. Il problema più complesso è costituito,
invece, dalle conseguenze che la perdita dell’attività lavorativa per effetto di un licenziamento
ovvero di dimissioni determina sull’ammissione alla semilibertà o al lavoro all’esterno. In primo
luogo, per quanto riguarda la semilibertà, la misura alternativa può essere revocata solo quando “il
soggetto non si appalesi idoneo al trattamento” (art. 51 Legge n° 354/1975), così che non esiste
alcun automatismo tra perdita dell’attività lavorativa, in se considerata, e revoca della misura
alternativa. Per quanto, invece, riguarda l’ammissione al lavoro all’esterno, non sussiste alcuna
norma che ne disciplini le condizioni della revoca, rimessa alla valutazione discrezionale della
Direzione dell’istituto, in relazione agli esiti del programma di trattamento personalizzato. Va
notato, tuttavia, come la revoca stessa divenga esecutiva solo dopo l’approvazione del Magistrato di
Sorveglianza, secondo la nuova previsione dell’art. 48 XV comma del Regolamento.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in più occasioni, ha accolto una tesi particolarmente
restrittiva in tema di revoca della semilibertà, configurandone come presupposto il semplice venir
meno dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla valutazione dei motivi di questa perdita e,
quindi, dell’inidoneità o meno del soggetto a continuare il trattamento extramurario, anche se ciò è
in contrasto con la lettera della legge sull’ordinamento penitenziario.
L’argomentazione, alquanto semplicistica, di questa restrittiva interpretazione giurisprudenziale trae
origine dalla considerazione che “il concreto ed effettivo svolgimento di un’attività lavorativa non
solo è il presupposto indispensabile per l’ammissione al regime di semilibertà, ma è anche
condizione per il permanere della misura alternativa: il provvedimento di revoca è perciò doveroso
in tutti i casi in cui l’attività lavorativa esterna non può più essere prestata, e quindi anche nel caso
di licenziamento senza colpa”.
Ora, la lettera dell’art. 51 Legge n° 354/1975, non supporta, in alcun modo, tale ricostruzione
dell’istituto della revoca. Al contrario, la formulazione della norma fa chiaramente riferimento alla
valutazione del comportamento del soggetto, ammesso alla misura alternativa, rivelatosi incapace di
34
gestire in modo corretto il beneficio. Ciò significa che si tratterà di verificare, caso per caso, se la
perdita del posto di lavoro, per le cause e le modalità con cui si è realizzata, sia, effettivamente,
manifestazione dell’inidoneità al trattamento extramurario. Nella gran parte dei casi, un
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, in quanto caratterizzato da un
inadempimento, più o meno rilevante, agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, sarà indice
dell’incapacità del detenuto a gestire l’ammissione alla misura alternativa. Viceversa, le dimissioni
del lavoratore per giusta causa , ovvero un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero
un licenziamento collettivo, in quanto ricollegabili ad eventi del tutto indipendenti dal
comportamento del semilibero, non dovranno avere alcuna influenza sul giudizio di idoneità dello
stesso al trattamento extramurario. In questi ultimi casi, si tratterà di modificare il programma di
trattamento per un congruo spazio di tempo.
in modo tale da rendere possibile per il detenuto l’avvio della ricerca di una nuova occupazione
lavorativa e l’instaurazione di una trattativa in tal senso, supportato anche dagli operatori
penitenziari.
La parificazione al lavoro libero relativamente a retribuzione e obblighi a carico del datore di
lavoro
Come già evidenziato in precedenza, la dottrina sin dall’inizio ha ritenuto inapplicabile ad ogni
forma di lavoro extramurario l’art. 22 Legge n° 354/1975, nella parte in cui prevede che la
retribuzione dei detenuti possa essere inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di
settore. Inserita in un rapporto di scambio, la retribuzione dovrà conformarsi ai caratteri di onerosità
e corrispettività, tipici del contratto di lavoro, commisurandosi alla quantità e qualità del lavoro
prestato, secondo gli stessi parametri individuati dalle parti collettive per la generalità dei lavoratori.
Analogamente agli altri momenti del rapporto di lavoro carcerario, sussiste, anche per questo
aspetto, un punto di necessaria interferenza tra disciplina civilistica e penale: la distinzione tra
rapporto punitivo e rapporto di lavoro comporta l’estraneità del primo alla definizione del contenuto
dell’obbligazione retributiva.
Tale estraneità agisce non solo sulla determinazione del corrispettivo, rimessa alla libera
contrattazione collettiva e individuale delle parti, ma anche sotto il profilo dell’impossibilità di
configurare, a carico del datore di lavoro, posizioni di obbligo nei confronti dello Stato, il cui
comando, concretizzatosi nel rapporto punitivo, può indirizzarsi esclusivamente verso il lavoratore
detenuto. La questione è, sostanzialmente, quella, alquanto dibattuta, del dovere legale, imposto al
datore di lavoro, dall’art. 54 I comma Regolamento per i semiliberi e dall’art. 48 X comma
Regolamento per gli ammessi al lavoro all’esterno, di versare la retribuzione del dipendente alla
direzione carceraria, per rendere possibile l’applicazione delle norme riguardanti le trattenute
dovute a fini risarcitori e di rimborso delle spese legali e di mantenimento. In proposito, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, affermando che la norma regolamentare, il previgente
art. 51 I comma, analogo all’attuale art. 54 I comma , contiene una disposizione che integra la
previsione legislativa, senza contrastare in alcun modo con la ratio della semilibertà.
Le argomentazioni della Corte si fondano sul rilievo che la stipulazione del contratto di lavoro e lo
svolgimento del conseguente rapporto non sono rimesse all’esclusiva autonomia del detenuto, dal
momento che le vicende della misura alternativa interagiscono sul rapporto. Conseguentemente, il
detenuto in semilibertà resta, comunque, detenuto e non può essere esonerato dal divieto di disporre
di moneta all’interno dell’istituto, in deroga alle limitazioni stabilite dallo stesso regolamento per
l’ammontare dei beni provenienti dall’esterno.
Peraltro, tale interpretazione sovrappone il piano del rapporto punitivo, intercorrente tra il detenuto
e lo Stato, a quello del rapporto di lavoro, intercorrente tra il lavoratore (detenuto) e il suo datore di
lavoro. Certamente, al lavoratore semilibero, in quanto detenuto, devono essere applicate le norme
in materia di prelievi sulla remunerazione e di peculio, contenute negli artt. 24 e 25 Legge n° 354
1975 e 56 e 57 del Regolamento, ma l’aspetto in discussione è se il versamento della retribuzione
35
possa essere imposto direttamente al datore di lavoro, ovvero al solo lavoratore detenuto, in
occasione del pagamento del compenso. La soluzione più corretta appare essere quest’ultima, in
quanto il datore di lavoro assume, semplicemente, la veste di necessario collaboratore del lavoratore
nell’adempimento dell’obbligo che gli deriva dalla posizione di detenuto.
Il collocamento e gli aspetti previdenziali
La nuova disciplina dell’art. 19 Legge n° 56/1987
Il tema del collocamento dei detenuti è stato oggetto di una specifica disciplina contenuta nell’art.
19 Legge 28 febbraio 1987 n° 56. Si tratta di una norma che prevede, al I comma, nuove
competenze degli organi pubblici del collocamento, dal momento che viene assegnata alla
commissione circoscrizionale per l’impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, il
compito di stabilire le modalità cui le sezioni circoscrizionali debbono attenersi, per promuovere
l’offerta ai detenuti di adeguati posti di lavoro extramurario, da parte di imprese idonee a
collaborare al trattamento penitenziario.
Come da più parti osservato, la disciplina dettata dall’art. 19 Legge n° 56 cit. mirava a colmare un
vuoto normativo lasciato dall’ordinamento penitenziario, anche dopo la riforma del 1986,
predisponendo un intervento, demandato a un organismo specializzato. istituzionalmente preposto
all’organizzazione del mercato del lavoro, e, quindi, in grado di conoscere maggiormente entità e
provenienza della domanda di lavoro.
La dottrina, in sede di commento della nuova normativa sul collocamento dei detenuti ammessi al
lavoro extramurario, ha posto in evidenza come il sistema originario della Legge n° 354 1975
individuasse nell’Amministrazione penitenziaria il soggetto incaricato di selezionare la domanda di
lavoro proveniente dall’esterno e di farla incontrare con l’offerta di lavoro.
Infatti, era l’Amministrazione penitenziaria che, ai sensi dell’art. 46 del previgente regolamento,
doveva individuare le imprese idonee a collaborare al trattamento penitenziario, nel senso di
imprese in grado di offrire adeguati posti di lavoro.
L’unico collegamento tra il servizio pubblico di collocamento e il collocamento carcerario era
costituito dalla possibilità per la direzione di avvalersi dei locali uffici del lavoro. In effetti, la
disciplina originaria delineava un procedimento opposto a quello del collocamento tradizionale: non
era, infatti, il datore di lavoro a richiedere l’avviamento di un lavoratore, bensì un terzo,
l’Amministrazione penitenziaria, che, sulla base di proprie valutazioni discrezionali, riteneva una
certa azienda idonea a collaborare al trattamento e ad offrire adeguati posti di lavoro, inserendosi tra
il datore di lavoro e il possibile prestatore d’opera. Il sistema non aveva raggiunto alcun risultato
positivo, sia per la scarsa propensione, in generale, delle direzioni ad assumersi responsabilità,
considerate estranee alle competenze tipiche, sia per la difficoltà di individuare le aziende idonee,
che, su richiesta preventiva dell’istituto carcerario, fossero disponibili ad offrire un’occasione di
lavoro extramurario, adeguato al trattamento per un determinato detenuto.
La nuova impostazione del legislatore tende a sostituire alla gestione interna del collocamento dei
detenuti una gestione mista, che coinvolge l’Amministrazione penitenziaria, da un lato, e gli organi
istituzionalmente investiti del compito di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro, dall’altro,
in modo da individuare un organo di mediazione, autonomo tra aspettative della popolazione
carceraria e sistema sociale esterno ad essa.
Iscrizione al collocamento e anzianità figurativa
Il II comma dell’art. 19 Legge n° 56 cit. stabilisce che i detenuti e gli internati hanno facoltà di
iscriversi nelle liste di collocamento. Nel sistema normativo precedente, tale iscrizione era preclusa
dalla ricostruzione teorica del lavoro penitenziario come lavoro diverso da quello subordinato, come
36
pure dalla prassi degli uffici di collocamento di richiedere necessariamente la presenza fisica del
lavoratore, ai fini dell’iscrizione alle liste e della conferma dello stato di disoccupazione.
La disposizione in esame, al contrario, fissa il principio teorico della compatibilità tra iscrizione e
detenzione, articolando, poi, la disciplina in modo tale da superare i problemi pratici nascenti dalla
particolare condizione soggettiva del lavoratore. Infatti, per i detenuti, gli effetti derivanti dallo stato
di disoccupazione, e cioè la permanenza nelle liste di collocamento e il mantenimento del diritto
all’indennità di disoccupazione, sono conseguenti alla segnalazione periodica dello stato
disoccupazione che la direzione dell’istituto penitenziario è tenuta a fare, su richiesta dello stesso
interessato. Ciò significa che non solo il detenuto può iscriversi durante la detenzione, ma anche
che, se era già iscritto prima dell’inizio dello stato di carcerazione, ha facoltà di mantenere tale
iscrizione per tutta la durata della pena.
Inoltre, con riferimento alle situazioni pregresse, il VI comma dell’art. 19 cit. prevede che agli ex
detenuti, che si iscrivano alle liste di collocamento entro quindici giorni dalla data di scarcerazione,
sia riconosciuto un periodo di anzianità figurativa, in relazione alla durata del periodo di detenzione,
secondo criteri da stabilirsi in sede amministrativa. La regola vale essenzialmente a disciplinare il
regime transitorio successivo all’entrata in vigore della legge; tuttavia, secondo autorevole dottrina,
la circostanza che il II comma della disposizione in esame faccia riferimento alla facoltà di
iscrizione al collocamento induce a ritenere che periodi di anzianità convenzionale possano essere
riconosciuti anche a coloro che non si avvalgono di tale facoltà, riservandosi di presentare domanda
di iscrizione solo dopo la scarcerazione.
La segnalazione periodica all’ufficio di collocamento dello stato detentivo, da parte della Direzione
dell’istituto per i detenuti e internati che ne facciano richiesta, si configura come un vero e proprio
obbligo per l’Amministrazione penitenziaria, che può essere chiamata a risponderne, in caso di
omessa comunicazione, avanti il Magistrato di Sorveglianza attraverso lo strumento del reclamo ex
art. 69 Legge n° 354/1975.
Peraltro, una volta compiuto tale adempimento di segnalazione del nominativo del detenuto
richiedente all’ufficio di collocamento e all’I.N.P.S., l’Amministrazione penitenziaria non può
ritenersi responsabile della mancata corresponsione dell’indennità di disoccupazione da parte
dell’istituto previdenziale ne, d’altro canto, il Magistrato di Sorveglianza ha l’obbligo o il potere di
intervenire per la liquidazione dell’indennità stessa. Il compito della direzione si esaurisce, infatti,
nell’indicazione di chi intende avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 19 II comma cit.
Inoltre, tale facoltà è prevista anche per il detenuto che presti attività lavorativa di tipo c.d.
domestico, all’interno dell’istituto, alle dipendenze dell’amministrazione: come già osservato in
precedenza, lo svolgimento di tale attività lavorativa è stato considerato non ostativo, ai fini della
maturazione, dell’iscrizione in lista del detenuto quale disoccupato di lunga durata, alla luce del
riconoscimento del carattere prevalentemente, se non esclusivamente, riabilitativo di una simile
occupazione.
Il diritto all’indennità di disoccupazione
Esaminando, ora, in modo più specifico le questioni relative all’indennità di disoccupazione,
occorre mettere in evidenza la portata innovativa della disciplina introdotta con l’art. 19 Legge n°
56/1987. Tale norma prevede, infatti, che lo stato di interdizione non costituisce causa di decadenza
dal diritto all’indennità di disoccupazione, ordinaria e speciale. In precedenza, al contrario, l’art. 20
Legge n° 354/1975 veniva interpretato nel senso restrittivo di sancire l’estensione ai lavoratori
detenuti solo dell’assicurazione contro la malattia e del diritto agli assegni familiari. Veniva, perciò,
esclusa tale estensione all’assicurazione contro la disoccupazione, in relazione alla diversità delle
cause sottostanti lo stato di disoccupazione dei detenuti rispetto a quelle protette dalla legge.
In effetti, l’art. 20 XVII comma Legge n° 354 cit. ha una formulazione così ampia, da non
giustificare simili distinzioni tra le varie tutele previdenziali. La dottrina più avveduta non aveva
mancato di mettere in evidenza, sin dall’inizio, i riflessi negativi derivanti da una simile lettura
37
restrittiva della norma al momento della dimissione del detenuto, sotto il profilo della mancata
maturazione dei requisiti contributivi minimi. L’art. 19 III comma Legge n° 56 cit. permette, con la
sua esplicita formulazione, di superare tutte le incertezze interpretative sopra riportate.
Inoltre, è stato autorevolmente osservato come il diritto all’indennità di disoccupazione derivi
semplicemente dalla circostanza, per il detenuto, di non essere utilizzato nelle lavorazioni, salva la
segnalazione del suo stato all’I.N.P.S., indipendentemente dalla iscrizione al collocamento esterno.
Ciò, in base alla considerazione che sarebbe illogico, vista l’esistenza di un duplice sistema di
collocamento, interno ed esterno, e di poteri, in materia di assegnazione al lavoro, della direzione
penitenziaria e dell’autorità giudiziaria, ritenere che la disponibilità al lavoro e l’involontarietà dello
stato di disoccupazione di chi è detenuto si manifestino necessariamente attraverso l’atto di
iscrizione al collocamento, che è una facoltà e non un obbligo.
Il IV comma dell’art. 19 cit. stabilisce, ancora, l’incumulabilità dell’indennità di disoccupazione
con la retribuzione, sino a concorrenza dell’ammontare della retribuzione medesima. Si tratta di una
previsione che contraddice un principio cardine del sistema della sicurezza sociale, e cioè quello
dell’incompatibilità tra corresponsione dell’indennità in esame ed esplicazione di una attività
lavorativa. L’eccezione si spiega, ricordando la particolarità del lavoro carcerario: il legislatore ha
considerato che, a differenza del lavoratore libero, che può valutare, in linea di massima, tra offerte
di lavoro adeguate alla propria professionalità e tutela previdenziale, il lavoratore detenuto non gode
di tale facoltà, sia per i profili riabilitativi che, ancor oggi, lo svolgimento di una attività lavorativa
implica (per esempio, in termini di ammissione alle misure alternative), sia per la scarsa possibilità
pratica di scegliere tra più occasioni professionali. Ha, quindi, ritenuto di dover ovviare alle
situazioni in cui il detenuto è impiegato in lavori che non gli assicurano un reddito superiore a
quello rappresentato dalla sola indennità di disoccupazione, consentendo il cumulo tra i due importi,
in modo tale da far raggiungere al lavorante un reddito non inferiore a quello del disoccupato.
Le modificazioni alla disciplina generale del collocamento
L’art. 20 XI comma Legge n° 354/1975 stabilisce, come più volte ricordato, che al lavoro
extramurario si applica la disciplina generale sul collocamento ordinario e agricolo nonché l’art. 19
Legge 56/1987, mentre il XII comma contiene una clausola generale di chiusura che richiama, per
quanto non espressamente previsto, la disciplina generale sul collocamento. Peraltro, negli ultimi
anni si è assistito ad una radicale modificazione della disciplina tradizionale del collocamento, sia
sotto il profilo della, ormai completa, liberalizzazione delle assunzioni sia sotto il profilo delle
competenze in materia, che sono state decentrate dal Ministero del lavoro agli enti regionali e locali.
Senza voler entrare nel dettaglio della nuova disciplina e ai soli fini che possono interessare il
mondo del lavoro penitenziario, occorre evidenziare, in primo luogo, come, in base alla Legge 28
novembre 1996 n° 608, l’assunzione diretta costituisca la regola prevista per tutti i datori di lavoro
privati e per gli enti pubblici economici, sia per il collocamento ordinario che per quello agricolo.
L’art. 9 bis I comma Legge n° 608/1996 stabilisce, poi, che restano ferme le norme in materia di
iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento, così che viene confermata la disposizione in
base alla quale i datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento. Del tutto superato risulta, invece, il sistema previgente, basato sul rilascio del
preventivo nullaosta di avviamento.
Sono posti, infatti, a carico del datore di lavoro esclusivamente degli obblighi di comunicazione agli
uffici pubblici e al lavoratore assunto. In particolare, il II comma dell’art. 9 bis L. n° 608/1996
prevede che, entro cinque giorni dall’assunzione, il datore di lavoro debba inviare alla sezione
circoscrizionale per l’impiego una comunicazione scritta, contenente il nominativo del lavoratore
assunto, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica e il trattamento economico e
normativo, che sarà applicato nel corso del rapporto.
Il III comma della stessa norma stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore,
all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione
38
effettuata sul libro matricola, così da consentire il controllo diretto dell’interessato sulla regolarità
della propria assunzione.
Ai sensi del D.Lgs. n° 152/1997, il contratto di lavoro scritto. la lettera di assunzione, ovvero la
dichiarazione di cui al III comma dell’art. 9 bis cit.. debbono tassativamente indicare l’identità delle
parti, il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto, la durata dello stesso, precisando se si tratta di
rapporto a tempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova, l’inquadramento, il
livello e la qualifica attribuite al lavoratore, l’importo della retribuzione con l’indicazione degli
elementi costitutivi della stessa, l’orario di lavoro.
la durata delle ferie o le modalità di fruizione delle stesse e, infine, i termini di preavviso in caso di
recesso. Naturalmente, nell’ipotesi più comune di applicazione di un contratto collettivo nazionale
di lavoro, è consentito un parziale rinvio a quest’ultimo, con riferimento alle informazioni sul
periodo di prova, la retribuzione, l’orario e il preavviso. Tali informazioni vanno consegnate al
lavoratore entro trenta giorni dalla data di assunzione.
Ora, con riferimento agli obblighi di informativa al lavoratore detenuto ammesso ad una
occupazione extramuraria, non paiono sussistere problemi di interpretazione, nel senso che avrà
diritto a ricevere la comunicazione come qualunque altro dipendente assunto. Qualche incertezza
esiste, invece, per la alla sezione circoscrizionale, che va inviata giorni dall’assunzione”.
Come è noto a chi ha maturato una sia pur minima esperienza di offerta di lavoro extramurario a un
detenuto, è normale che trascorra un lungo lasso di tempo tra il momento in cui viene sottoscritta
dal datore di lavoro la dichiarazione di disponibilità all’assunzione e l’effettivo inizio della
prestazione lavorativa. Ovviamente, ciò è dovuto alla necessità che si esaurisca compiutamente il
procedimento penale di ammissione alla misura alternativa, qualunque esso sia, con il compimento
di tutte le verifiche del caso.
Sotto il previgente sistema” si era sempre affermata l’autonomia del rilascio del nullaosta da parte
dell’ufficio di collocamento, rispetto all’accertamento giudiziale dell’idoneità del detenuto allo
svolgimento del lavoro extramurario. Di conseguenza, si riteneva che l’atto di ammissione al lavoro
extramurario del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza potesse precedere ovvero, anche,
seguire l’avviamento al lavoro da parte della sezione circoscrizionale. avviamento, in questo
secondo caso, espresso sotto forma di nullaosta provvisorio.
condizionato dall’esito positivo della procedura avanti la Magistratura di Sorveglianza.
Attualmente, la questione si presenta in termini del tutto diversi, perché, scomparso il nullaosta
preventivo, l’unico obbligo per l’imprenditore è costituito dalla comunicazione alla sezione
competente entro cinque giorni dall’assunzione. La questione diventa, allora, quella di determinare
il momento da cui decorre il termine sopra indicato, ed, in particolare. se tale decorrenza debba
collegarsi al provvedimento di ammissione alla misura extramuraria ovvero alla stipulazione del
contratto di lavoro, precedente o successiva al primo.
La dichiarazione di disponibilità all’assunzione, infatti, nella maggior parte dei casi, non presenta i
caratteri di un vero e proprio contratto di lavoro, mentre l’esito positivo del procedimento penale di
ammissione all’attività lavorativa extramuraria costituisce certamente condizione essenziale alla
conclusione dello stesso. Pertanto, il datore di lavoro potrà legittimamente sottoscrivere, prima, una
semplice dichiarazione, in cui s’impegna ad assumere il detenuto, nel caso in cui venga ammesso
alla misura alternativa. La stipulazione del contratto vero e proprio potrà avvenire solo dopo che
tale condizione si sia realizzata e da tale data decorrerà, poi, il termine per la comunicazione dei dati
identificativi del contratto di lavoro alla sezione circoscrizionale. In caso contrario, si finirebbe per
avere un contratto, condizionato dalla decisione degli organi della giurisdizione rieducativa, con
inizio del rapporto differito ad un momento incerto e futuro, e la comunicazione all’ufficio pubblico
di un’assunzione che potrebbe non venire mai ad esistenza, nel caso di mancata concessione della
misura alternativa al lavoratore detenuto.
Il decentramento nelle politiche del lavoro ex D.Lgs. n° 469/1997.
39
Altre rilevanti novità sono quelle relative al decentramento amministrativo in materia di mercato del
lavoro. Con le leggi n° 59 e n° 127 del 1997 e il successivo D.Lgs. n° 469/1997, è stato
completamente modificato il panorama delle competenze in materia di mercato del lavoro, attuando
il decentramento di funzioni e ruoli dagli uffici del Ministero del lavoro agli enti regionali e locali.
L’intero mercato del lavoro viene decentrato a livello locale, compresi gli aspetti che interessano in
questa sede, con riferimento ai c.d. soggetti deboli: in particolare, alle Regioni vengono conferite, in
materia di politica attiva del lavoro, le funzioni di collaborazione all’elaborazione di progetti,
relativi all’occupazione di soggetti ex detenuti. La Legge n° 59/1997 impegnava gli enti locali a
provvedere entro sei mesi, dotandosi di uno strumento normativo, allo scopo di consentire
l’effettivo avvio del decentramento introdotto alla data fissata per il 10 gennaio 1999, ma molte
regioni, tra cui la Lombardia, non hanno provveduto a deliberare, neppure entro l’ulteriore termine
concesso di novanta giorni.
Solo con la Legge Regionale n° I, del 15 gennaio 1999, è stato emanato il provvedimento
legislativo regolante le funzioni e i compiti conferiti agli enti locali in materia di mercato del lavoro.
L’obiettivo dichiarato della legge regionale è quello di garantire l’integrazione dei servizi per
l’impiego resi sul territorio, delle politiche attive del lavoro e delle politiche formative, per
sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente, che incentivi l’incontro tra domanda e offerta.
Per quanto specificamente interessa in questa sede, va osservato, in primo luogo, come vengano
attribuiti alla Provincia tutti i compiti in materia di collocamento e servizi per l’impiego e quelli
comunque connessi ai servizi di collocamento.
In secondo luogo, l’azione regionale di politica attiva del lavoro viene finalizzata anche al sostegno
ai soggetti deboli, ipotizzando quali strumenti di intervento, da un lato, incentivi alle imprese, per
l’assunzione a tempo indeterminato di detenuti ammessi al lavoro all’esterno e, dall’altro lato,
misure di orientamento, accompagnamento e formazione, volte a promuovere l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro a favore di tali soggetti.
Come già rilevato in precedenza, il Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e il Ministero di
giustizia, sottoscritto in data 22 febbraio 1999, segue queste linee di intervento, impegnandosi ad
assicurare “uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei
detenuti, degli ammessi a misure alternative e delle persone dimesse, e le reali esigenze
occupazionali del mercato del lavoro regionale”.
A tal fine, la Regione Lombardia si è impegnata ad utilizzare le informazioni e le conoscenze sulla
domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio, attraverso il
collegamento tra i propri organi e servizi, le istituzioni e i soggetti privati regionali.
Questa conoscenza sarà dedicata ad attivare un servizio permanente di orientamento a favore dei
detenuti, degli ammessi alle misure alternative e delle persone dimesse e a sostenere le iniziative di
formazione professionale che presentano una forte connessione con la domanda, al fine di
assicurare al detenuto una reale opportunità di inserimento lavorativo.
Ministero e Regione si sono accordati per rendere disponibile l’intera offerta formativa esterna al
carcere e presente sul territorio regionale ai detenuti e agli ammessi alle misure extramurarie, per
promuovere l’introduzione di strumenti, in grado di rilevare il credito formativo del singolo
soggetto, le sue aspettative e capacità lavorative, come pure di interventi di motivazione al lavoro e
di sostegno all’integrazione, in favore di detenuti e di ammessi alle misure alternative.
L’impegno della Regione si risolve nell’istituzione di un servizio permanente di orientamento e
tutoring in favore di tali soggetti, attraverso la creazione di un Centro regionale di servizi, esterno
all’istituzione penitenziaria, in grado di supportarli. concretamente, nella fase di reinserimento.
La tutela assicurativa e previdenziale
Come più volte accennato, l’art. 20 XVII comma Legge n° 354/1975 sancisce l’estensione ai
lavoratori detenuti della tutela assicurativa e previdenziale, prevista per ogni altro lavoratore. Ciò
significa la vigenza delle norme in materia di assicurazione contro infortuni, invalidità, vecchiaia,
40
disoccupazione e di corresponsione degli assegni familiari. La questione dell’assicurazione contro
la disoccupazione è già stata affrontata in precedenza , esaminando l’art. 19 L. n° 56/1987, mentre,
per quanto riguarda in particolare infortuni e malattie professionali, l’art. 4 n° 9 D.P.R. 30 giugno
1965 n° 1124 ricomprende, in questo tipo di assicurazione obbligatoria, anche i detenuti che, per il
servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti a uno dei lavori indicati
nell’art. 1 dello stesso D.P.R., mentre l’art. 127 n° 3 ne esclude i detenuti addetti a lavori condotti
direttamente dallo Stato.
La materia è, peraltro, regolamentata da una serie di convenzioni, stipulate tra il Ministero di
giustizia e l’I.N.A.I.L., che hanno esteso ai casi d’attività lavorativa svolta dal detenuto per
l’Amministrazione penitenziaria la tutela assicurativa relativa alle prestazioni previste dalle leggi
vigenti. Al contrario, hanno escluso dal loro ambito d’applicazione i detenuti ammessi allo
svolgimento di attività lavorative esterne agli istituti penitenziari, per i quali, quindi, trovano
applicazione le norme del citato D.P.R. 1124.
41
La tutela dei diritti
Il problema della ripartizione delle competenze.
La scarsità degli interventi giurisdizionali in materia di lavoro carcerario, è il dato che appare
evidente nel momento in cui si affronta il tema della tutela dei diritti. Certamente, il primo motivo
cui ricondurre tale situazione è la difficoltà ad instaurare controversie rispetto a lavori, in
maggioranza domestici, scarsamente remunerati, rispetto ai quali viene ad essere disincentivato il
ricorso allo strumento giudiziario.
D’altro canto, la povertà del panorama si ricollega, anche, alla scarsa visibilità sociale dei soggetti
coinvolti nel problema, rispetto alla collettività che, da parte sua, sembra quasi infastidita dal
doversi rapportare a individui facenti parte delle fasce deboli, quando si tratta di riconoscerli come
destinatari di specifici interventi e diritti.
Tuttavia, la questione centrale che ha pregiudicato e limita, ancor oggi, in modo rilevante, ogni
effettività dei diritti dei lavoratori detenuti, sul piano della tutela processuale, è la
giurisdizionalizzazione ridotta di tali diritti, conseguente alla loro inefficace azionabilità sul piano
giurisdizionale.
L’art. 69 V comma Legge n° 354, nella sua formulazione originale del 1975, prevedeva che il
Magistrato di Sorveglianza decidesse i reclami dei detenuti. in materia di attribuzione della qualifica
lavorativa, di mercede e remunerazione, di svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e di
assicurazioni sociali, con un ordine di servizio, cioè un atto amministrativo non impugnabile.
La natura non giurisdizionale del procedimento disciplinato dall’art. 69 Legge n° 354/1975 era
indiscussa, mentre la dottrina del tempo dibatteva, esclusivamente, il problema dell’individuazione
dell’efficacia dello stesso ordine di servizio. sotto il profilo della sua vincolatività nei confronti
dell’Amministrazione penitenziaria.
La soluzione, accolta peraltro solo da parte della dottrina e da alcuni esponenti di rilievo della
Magistratura di Sorveglianza. fu di riconoscere effetto obbligatorio e vincolante all’ordine di
servizio, argomentando che, in caso contrario, si sarebbe dovuto ammettere un potere meno ampio e
incisivo del Magistrato di Sorveglianza rispetto al previgente sistema, malgrado il risalto attribuito
dalla riforma del 1975 alla giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale.
Il legislatore del 1986 risolse il problema, attuando in modo più completo la giurisdizionalizzazione
del procedimento di decisione dei reclami del detenuto. Venne previsto un procedimento speciale,
regolamentato attraverso il rinvio dell’art. 69 VI comma Legge n° 354 cit. al procedimento
giurisdizionale camerale di cui all’art. l4 ter Legge n° 354 cit. e l’ordine di servizio venne sostituito
da un’ordinanza.
Il Magistrato di Sorveglianza decide, quindi, con ordinanza, impugnabile soltanto per cassazione,
secondo la procedura di cui all’art. 14 ter cit., sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti
l’osservanza delle norme riguardanti:
a)
l’attribuzione della qualifica lavorativa;
b)
la mercede;
c)
la remunerazione;
d)
lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro; e) le assicurazioni sociali.
L’art. l4 ter, richiamato dalla norma in esame, pone, a sua volta, le regole procedimentali del
reclamo: in primo luogo, relativamente alla sua proposizione, in secondo luogo, con riguardo alla
sua trattazione, in un’udienza in camera di consiglio, in terzo luogo, sotto il profilo del rispetto del
principio del contraddittorio, realizzato attraverso la partecipazione personale del difensore del
reclamante e del pubblico ministero nonché attraverso la possibilità per l’interessato e
l’amministrazione penitenziaria di inviare memorie, ed, infine, con riferimento alla decisione del
giudice sotto forma di ordinanza.
La soluzione accolta dal legislatore del 1986 postula il carattere di giudice naturale,
tendenzialmente universale, della Magistratura di Sorveglianza, per quanto riguarda “i diritti del
42
detenuto coinvolti nel corso e a causa o in occasione del trattamento penitenziario”, secondo
l’espressione utilizzata dalla Corte Costituzionale in una recente decisione.
Oggi, la centralità della Magistratura di Sorveglianza appare, tuttavia, piuttosto discutibile e
sostanzialmente ancorata ad una concezione superata dei rapporti di lavoro all’interno e all’esterno
del carcere. Tale ricostruzione interpretativa non può ritenersi prevalente, rispetto al contrapposto
principio di tendenziale omnicomprensività del rito speciale del lavoro, per le controversie
riconducibili allo schema standard del rapporto di lavoro subordinato, dal momento che
quest’ultimo rappresenta, ormai, il lavoro carcerario comune, anche all’interno degli istituti.
Una volta realizzatasi la privatizzazione del lavoro inframurario alle dipendenze di terzi, attraverso
la riforma legislativa del 1993, confermata dal nuovo Regolamento e dalle indicazioni della Legge
Smuraglia, la scelta legislativa in favore dei diversi lavori penitenziari, individuati e distinti dalla
Corte Costituzionale nella più volte citata sentenza 30 novembre 1988 n° 1087, si è modificata, sia
in termini qualitativi che quantitativi. Di conseguenza, si è ampliato il campo del lavoro alle
dipendenze di imprenditori, privati o pubblici, e, corrispondentemente, si è ridotto quello del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica, relegato, ormai, ai soli c.d. lavori domestici.
In questo mutato orizzonte legislativo, è allora difficilmente sostenibile che le controversie proposte
dal lavoratore detenuto possano essere decise con lo strumento processuale dell’art. 69 VI comma
Legge n° 354 1975, in situazioni diverse da quelle dei dipendenti dell’Amministrazione. È evidente,
infatti, che, solo in quest’ultimo caso, l’Amministrazione penitenziaria ne viene coinvolta, come
diretto datore di lavoro, e lo schema, sopra riportato, di un processo in camera di consiglio, con
l’intervento del P.M., la presenza del solo difensore del detenuto e la possibilità per il datore di
lavoro di presentare esclusivamente memorie scritte, può realizzarsi correttamente, senza alcuna
lesione del diritto di difesa, trattandosi di un’Amministrazione pubblica, in quanto tale tenuta al
rispetto della legge.
In ogni altra ipotesi, sia di lavoro extramurario che di lavorazioni inframurarie, il diritto derivante
dal rapporto di lavoro verrebbe rivendicato dal lavoratore detenuto nei confronti di un datore di
lavoro, diverso dall’Amministrazione penitenziaria, e cioè di un imprenditore, pubblico o privato,
ovvero di una cooperativa, alla luce dell’avvenuta privatizzazione del sistema lavorativo carcerario
e la conseguente perdita di rilevanza della direzione penitenziaria nella titolarità, organizzazione e
gestione dell’attività lavorativa inframuraria, estranea all’originale impianto della Legge n° 663
1986. Ora, sostenere che il detenuto debba reclamare, secondo il rito dell’art. 14 ter cit., avanti il
Magistrato di Sorveglianza e alla presenza del pubblico ministero, un atto di autonomia privata,
posto in essere da un imprenditore privato oda una cooperativa sociale, che dovrebbero essere
assimilati, sotto questo profilo, all’Amministrazione penitenziaria, e cioè ad una pubblica
amministrazione, cui si riferisce espressamente la norma, in quanto datori di lavoro di un detenuto
lavoratore all’interno o all’esterno della struttura detentiva, contrasta, in primo luogo, sul piano
sostanziale, con i principi dell’autonomia privata.
Poi, sul piano processuale, con il principio del contraddittorio, perché riduce, sensibilmente, i diritti
di difesa del datore di lavoro, che non avrebbe alcuna possibilità di contraddire, se non attraverso la
presentazione di memorie scritte, al di fuori dei principi che disciplinano le controversie di lavoro.
Allo stesso modo, limita la possibilità di agire del lavoratore al solo piano dell’impugnabilità di un
atto, per di più manifestazione di autonomia privata, per inosservanza della legge, secondo uno
schema superato persino in materia di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici.
Infine, finisce per ancorare il solo tema della tutela dei diritti a quella concezione della valenza
terapeutica del lavoro penitenziario, che le novità legislative e la prassi quotidiana hanno
largamente superato, incorrendo, in questo modo, in una vistosa contraddizione. Da un lato, infatti,
si legittima il ricorso ad un procedimento speciale, riaffermando l’imprescindibile collegamento tra
lavoro e trattamento penitenziario, in ogni attività lavorativa del detenuto, e, dall’altro, si ribadisce
il perseguimento dell’obiettivo di sottoporre la vita negli istituti carcerari ai principi e alle regole
generali dello Stato di diritto, in relazione all’assimilazione del lavoro carcerario a quello ordinario.
43
L’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale
Quest’ultima affermazione è contenuta, appunto, nella già citata sentenza 8 febbraio 1999 n° 26
che, riguardando il tema generale della tutela dei diritti dei detenuti nei confronti degli atti
dell’Amministrazione penitenziaria, contiene affermazioni di grande rilevanza.
In particolare, la Corte ribadisce il principio del primato della persona umana e dei suoi diritti,
esclude che la restrizione della libertà personale possa comportare il disconoscimento di posizioni
soggettive, attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria, e ne trae
la naturale conseguenza sul piano della tutela dei diritti, affermando che al riconoscimento della
titolarità di diritti deve corrispondere il riconoscimento del potere di farli valere, davanti a un
giudice, in un procedimento di natura giurisdizionale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, già da tempo, aveva dimostrato di aver presente la
varietà di situazioni lavorative che, solo apparentemente, possono essere ricondotte ad un unico
modello di lavoro carcerario e la necessità di intervento di un giudice dei diritti. In proposito, va
ricordato come, sin dal 1978, la Corte Costituzionale aveva escluso la legittimazione dei Magistrati
di Sorveglianza a sollevare questioni di costituzionalità nell’ambito del giudizio sui reclami in
materia di lavoro, sul presupposto che fosse carente, in tale ipotesi, l’esercizio di una potestà
giurisdizionale.
La Corte, argomentando dalla inesistenza nel procedimento per reclamo ex art. 69 Legge n°
354/1975 di garanzie a difesa delle parti, affermò che la tutela giurisdizionale vera e propria
dovesse essere affidata al giudice dei diritti. Di conseguenza, di fronte all’inottemperanza
dell’Amministrazione penitenziaria agli ordini di servizio del Magistrato di Sorveglianza in materia
di lavoro, il rimedio seguito fu quello, suggerito dalla stessa Corte, di rivolgersi al giudice ordinario,
che, nel caso di specie, era il Pretore del Lavoro. In questa materia, in sostanza, la Corte si attestò
sin dall’inizio su una posizione di riconoscimento dell’insufficienza della tutela apprestata con il
procedimento amministrativo, instaurato dal reclamo del detenuto in materia di lavoro, rilevando
come quest’ultimo non fosse in grado di sostituire la tutela giurisdizionale, riservata al giudice dei
diritti secondo le regole della competenza ordinaria, “non essendovi motivo di distinzione, a tale
proposito, tra il normale lavoro subordinato e il lavoro dei detenuti”.
Tale affermazione, peraltro, deve essere coordinata con l’altra fondamentale, desumibile parimenti
dalla giurisprudenza della Corte, di cui alla citata sentenza 30 novembre 1988, n° 1087, sulla
distinzione fondamentale tra lavoro intramurario, a sua volta suddiviso in lavoro domestico e
lavorazioni, e lavoro extramurario.
Come già osservato introducendo in termini più generali il tema, la logica della differenziazione
attraversa la stessa disciplina del lavoro carcerario, riducendo, sotto il profilo della nozione e della
disciplina, quello inframurario a modalità trattamentale penitenziaria e valorizzando quello
extramurario come modalità alternativa di esecuzione della pena.
L’evoluzione successiva della giurisprudenza della Corte Costituzionale si è mossa nel senso di
giungere progressivamente all’accoglimento della distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di
legittimità nell’ambito dei provvedimenti di competenza della Magistratura di Sorveglianza. tra
provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della pena, attratti nell’area
dell’amministrazione, e provvedimenti riguardanti la misura e la qualità della pena, attratti nell’area
giurisdizionale. alla stregua della riserva di legge. Il punto attuale di approdo della giurisprudenza
costituzionale è rappresentato dal riconoscimento della tutela giurisdizionale dei diritti, la cui
violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizioni della libertà
personale e dipenda da atti dell’amministrazione ad esso preposta. Con riferimento a tali situazioni,
la Corte afferma la tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti spettante alla
Magistratura di Sorveglianza, garanzia che “comporta il vaglio di legittimità pieno non solo del
rispetto dei presupposti legislativi dettati all’amministrazione per l’adozione delle misure, ma anche
dei loro contenuti, con particolare riferimento all’incidenza su non comprimibili diritti dei detenuti e
44
degli internati, la cui garanzia rientra perciò, nel sistema attuale, nella giurisdizione del giudice
ordinario”.
L’involuzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione
Dopo un lungo periodo di silenzio, durato quasi dieci anni, la Corte di Cassazione ha, nuovamente,
affrontato il tema della tutela dei diritti dei detenuti lavoratori in due sentenze, 21 luglio 1999 n°
490 e 14 dicembre 1999 n° 899, rese a Sezioni Unite, in conseguenza dell’inesatta prospettazione
della questione, in termini di difetto di giurisdizione. Entrambe le decisioni hanno concluso per
l’affermazione della competenza del Magistrato di Sorveglianza, in ordine alle controversie relative
al lavoro prestato dai detenuti all’interno o all’esterno dello stabilimento penitenziario, a seguito
dell’entrata in vigore della Legge 10 ottobre 1986 n° 663, che ha modificato l’art. 69 Legge n° 354:
1975, introducendo uno speciale procedimento giurisdizionale, in quanto tale idoneo ad assicurare
la difesa dei diritti del detenuto ammesso al lavoro.
Queste decisioni della Cassazione non introducono alcun elemento di novità, laddove affermano
che, dopo l’introduzione della c.d. Legge Gozzini, il procedimento dell’art. 69 cit., per i reclami in
materia di lavoro dei detenuti, si è giurisdizionalizzato pienamente. In apparenza, poi, si allineano
alla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, ed in particolare ai principi contenuti nella
citata sentenza n° 261/1999, ma, in realtà, ne accolgono una lettura superficiale, che non tiene conto
della varietà delle tipologie di lavoro penitenziario e della riforma legislativa del 1993, così da
realizzare una sostanziale involuzione dell’interpretazione giurisprudenziale.
Nel suo ultimo intervento in materia, la Cassazione aveva, al contrario, affermato che l’attività di
lavoro, svolta dal condannato all’interno della struttura carceraria, come le altre svolte alle
dipendenze di terzi o in regime di semilibertà, va qualificata come inerente ad un rapporto di lavoro
subordinato con l’Amministrazione penitenziaria e, quindi, assoggettato alla competenza del Pretore
in funzione di giudice del lavoro.
La Corte non si era preoccupata, in questa decisione, di cogliere le differenze strutturali e genetiche
dei diversi tipi di lavoro penitenziario, ma era, comunque, pervenuta, da un presupposto
tradizionale, quello della funzione rieducativa del lavoro, ad un’interpretazione evolutiva.
Il punto centrale dell’argomentazione della Suprema Corte era l’assimilabilità del lavoro carcerario
al lavoro libero, derivante dalle innovazioni introdotte dalla Legge n° 6631986 all’ordinamento
penitenziario. Tale assimilabilità non assurge al livello di identità, in quanto la funzione rieducativa
del lavoro penitenziario e la sua appartenenza allo schema riabilitativo ne escludono la
riconducibilità al diverso schema normativo del lavoro libero, ma è, in ogni caso, sufficiente a
ritenere la competenza del giudice del lavoro.
Le due sentenze del 1999, allo stesso modo, sembrano non recepire la diversità delle situazioni tra
gli ammessi al lavoro all’esterno e gli addetti al lavoro all’interno dell’istituto, tra gli addetti ai
lavori domestici e gli addetti alle lavorazioni.
Peraltro, nel seguire l’ultimo orientamento della Corte Costituzionale, trascurano la diversità del
contesto normativo in cui si è posta la sentenza n° 26/1999 di quest’ultima. La Corte, in questa
decisione, sancisce l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 Legge n° 354 cit., in quanto i
reclami concessi ai ristretti dalla prima norma danno origine ad un procedimento privo di quei
requisiti minimi, idonei a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale, assicurati
dalla seconda ai reclami in materia di attività lavorativa e disciplinare.
La tutela che la Corte intende assicurare è quella nei confronti degli atti dell’Amministrazione
penitenziaria, lesivi di diritti dei detenuti. Da questo punto di vista, la sua affermazione che il
procedimento di cui all’art. 69 cit. garantisca il diritto costituzionale di azione in giudizio non
esaurisce affatto l’ambito della tutela dei diritti dei lavoratori detenuti, dal momento che non
riguarda la lesione di diritti correlati alla posizione di lavoratore, indipendenti da provvedimenti
emessi dall’autorità carceraria.
45
Ciò emerge, chiaramente, dalla lettura dell’ordinanza di rimessione, che si riferisce al caso di due
detenuti, che avevano reclamato il provvedimento della direzione dell’istituto che aveva trattenuto
delle pubblicazioni, spedite in abbonamento e da familiari, in ragione del loro contenuto,
asseritamente osceno. Allo stesso modo, dal testo della decisione dei giudici costituzionali, si ricava
che “la presente questione di legittimità costituzionale riguarda (...) specificamente la tutela
giurisdizionale dei diritti la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a
restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell’amministrazione ad esso preposta”.
La Cassazione, volendo seguire quest’impostazione argomentativa in materia di lavoro, nelle due
decisioni in esame deve utilizzare, come presupposto delle sue conclusioni, l’ormai inesatta
affermazione che “il lavoro penitenziario è svolto all’interno dello stabilimento carcerario ovvero
all’esterno, ma sempre in favore della pubblica amministrazione, con inserimento del lavoratore
nella organizzazione e per il conseguimento degli scopi di questa”.
Si tratta di una premessa non più corretta e corrispondente al dato normativo: dall’analisi delle varie
figure di lavoro penitenziario individuate, si desume, in primo luogo, come il lavoro penitenziario
svolto all’esterno sia, di regola, in favore di soggetti del tutto diversi dalla pubblica
amministrazione, senza alcun inserimento nella organizzazione pubblica. In secondo luogo, come il
lavoro svolto all’interno del carcere possa essere in favore di soggetti estranei all’Amministrazione
penitenziaria, per scopi tipicamente imprenditoriali o cooperativistici, e con inserimento del
detenuto nella struttura organizzativa di tali datori di lavoro.
Il passo successivo della Corte di Cassazione è quello di ricavare dalla sentenza n° 2699 il principio
della natura giurisdizionale del procedimento ex art. 69 cit., per giungere alla conclusione che tale
procedimento è la soluzione giuridicamente più ragionevole, attese “le peculiarità del rapporto
inserito in un contesto di attività del detenuto strettamente connesse e conseguenziali alla pena e,
pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale”.
La tutela avanti la Magistratura di Sorveglianza
Il criterio di ripartizione della competenza proposto risulta allora evidente: la tutela avanti la
Magistratura di Sorveglianza, attraverso il procedimento speciale di cui all’art. 69 VI comma Legge
n° 354 cit., deve essere limitata alle sole pretese dei detenuti addetti ai lavori c.d. domestici, rispetto
alle quali mantiene ragionevolezza giuridica lo schema originariamente previsto per tutte le ipotesi
di lavoro penitenziario.
Come si è ampiamente analizzato in precedenza, solo con riferimento a questi ultimi,
l’Amministrazione penitenziaria è anche il diretto datore di lavoro del detenuto; in quanto tale,
esercita il potere che le deriva congiuntamente a quello che le compete per effetto dell’esercizio del
potere punitivo dello Stato.
In questa ipotesi si realizzano, quindi, tutte le condizioni erroneamente attribuite dalle recenti
decisioni della Corte di Cassazione alle varie forme di lavoro penitenziario; in particolare, vale
esclusivamente per i lavori domestici l’affermazione che si tratti di lavoro svolto in favore della
pubblica amministrazione, con inserimento del lavoratore nell’organizzazione e negli scopi di
questa.
Inoltre, solo con riferimento a questa tipologia di lavoro penitenziario, si può ancora parlare di un
carattere di specialità dell’attività lavorativa svolta dal detenuto, dal momento che la particolare
natura del datore di lavoro, lo Stato stesso, e dell’attività esercitata determinano un duplice limite
alla applicabilità della normativa standard, con il risultato di rendere differenziato l’ambito della
tutela giuridica riconoscibile ai detenuti.
Sotto questo profilo, la scelta di attribuire la decisione delle controversie al Magistrato di
Sorveglianza, cioè al giudice penale che sovrintende all’esecuzione della pena e ne garantisce la
legittimità in rapporto alle leggi vigenti, risulta giuridicamente ragionevole, attese “le peculiarità del
rapporto inserito in un contesto di attività del detenuto strettamente connesse e conseguenziali alla
pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale”. In altri termini,
46
risulta coerente con la funzione di garanzia dei diritti dei detenuti nei confronti
dell’amministrazione, attribuita alla Magistratura di Sorveglianza dall’ordinamento penitenziario,
nel suo impianto tradizionale.
Dal punto di vista processuale, poi, lo schema di procedimento. delineato dall’art. 69 VI comma cit.
attraverso il richiamo all’art. 14 ter cit., risulta del tutto funzionale. L’esercizio, da parte
dell’amministrazione carceraria, dei poteri che le competono come datore di lavoro si concreta,
infatti, in atti, che incidono, direttamente, sull’attribuzione della qualifica, come pure sulla
remunerazione, mentre, in materia di assicurazioni sociali, è già stata evidenziata l’esistenza di
particolari convenzioni con gli istituti assicurativi, da parte del Ministero di giustizia. La
costruzione del procedimento come reclamo contro un atto amministrativo, pretesamente lesivo di
diritti, costituisce, quindi, una diversità strutturale rispetto al rito del lavoro, correlata alle
particolarità del rapporto che ne viene coinvolto.
In ogni caso, la natura giurisdizionale, pacificamente riconosciuta al procedimento delineato
dall’art. 69 VI comma cit., permette di ritenere salvaguardati i diritti fondamentali di difesa del
reclamante. Ciò vale, soprattutto, per il mancato rispetto, in tale procedura, del principio del doppio
grado di giurisdizione, dal momento che l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è solo
ricorribile in Cassazione. In proposito, occorre ricordare come la Corte Costituzionale abbia in più
occasioni ribadito la legittimità di simili disposizioni P), valutate non incompatibili con i precetti
della Costituzione.
La tutela avanti il Giudice del lavoro
Con riferimento ad ogni altro tipo di lavoro carcerario, la competenza a conoscere delle
controversie tra il detenuto prestatore di lavoro e il suo datore di lavoro spetta, al contrario, al
Giudice Unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro.
Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nelle sentenze della Corte di Cassazione del 1999 e
appena esaminate, è sufficiente osservare che tale riparto di competenza non vale a determinare una
perdita di effettività della tutela giurisdizionale, dal momento che non interrompe quella dialettica
con l’Amministrazione penitenziaria. parzialmente sovrapposta a quella delle parti, che dovrebbe
caratterizzare l’attività del Magistrato di Sorveglianza.
In realtà, al di là della notazione che tale dialettica diretta si è dimostrata scarsamente presente (e
basti pensare all’evoluzione storica del procedimento per reclamo e ai problemi nascenti dai passati
rifiuti dell’Amministrazione penitenziaria a dare esecuzione ai provvedimenti della Magistratura di
Sorveglianza, come pure alle odierne difficoltà, sia pure in presenza di strumenti giurisdizionali più
efficaci), resta decisivo il rilievo che, in questi casi, i processi si svolgono tra due soggetti privati,
senza alcun coinvolgimento diretto dell’Amministrazione penitenziaria, analogamente ad ogni altro
processo del lavoro.
Infatti, le pretese verranno fatte valere da un lavoratore, ancorché detenuto, nei confronti del suo
datore di lavoro, necessariamente soggetto distinto dall’amministrazione, secondo le norme di legge
e di contratto applicabili al rapporto di lavoro in essere tra le parti. Ciò, anche nel caso in cui il
datore di lavoro sia organizzato in forma cooperativa e il lavoratore detenuto sia socio d’opera, alla
luce delle più recenti decisioni della Corte di Cassazione in materia.
Le situazioni in cui si può ipotizzare il ricorso allo strumento giurisdizionale specializzato del rito
del lavoro sono quelle in cui, solitamente, controvertono lavoratori e datori di lavoro, quali il
riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, la condanna per differenze retributive, il
riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso e così via.
Per quanto attiene, poi, il problema dell’impugnazione dei licenziamenti, è stato già ampiamente
esaminato il diverso piano in cui debbono porsi ed essere valutati la cessazione del rapporto di
lavoro, sottoposto alle regole della legislazione lavoristica, e le eventuali conseguenze della perdita,
colpevole o meno, dell’occupazione lavorativa sul regime detentivo del lavoratore.
47
In questa sede, è sufficiente ricordare come, risultando il datore di lavoro vincolato dalla disciplina
lavoristica standard, oggetto del giudizio potrà essere solo la legittimità e fondatezza del
licenziamento individuale o collettivo, valutata secondo i parametri elaborati dalla dottrina e
giurisprudenza civilistica in materia.
Sotto altro profilo, il rischio d’utilizzo del rito del lavoro è piuttosto quello di un sovraordinamento
degli strumenti rispetto alle esigenze e alle capacità di chi dovrebbe fruirne: il processo del lavoro,
sia pure con i contemperamenti che la giurisprudenza, soprattutto in tempi recenti, vi ha apportato.
resta, comunque, un processo che necessita di una assistenza tecnica di livello elevato, per il sistema
di rigide preclusioni che lo contraddistingue e che ne condiziona l’esito.
D’altro canto, questo è il prezzo da pagare, per far transitare il lavoro penitenziario fuori dalla
dimensione assistenziale, in cui è stato confinato sino ad oggi: certamente, non si tratta di un costo
eccessivamente elevato, se solo si pensa ai benefici che da tale mutamento possono derivare, in
termini di maggiore giustizia sostanziale e sicurezza sociale.
48