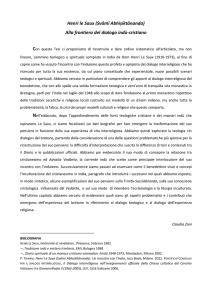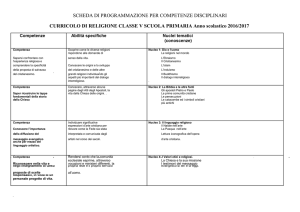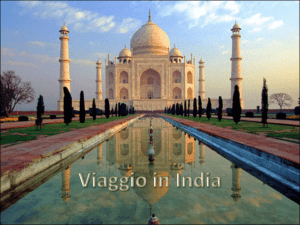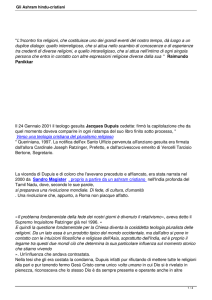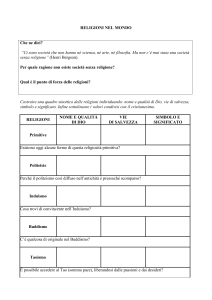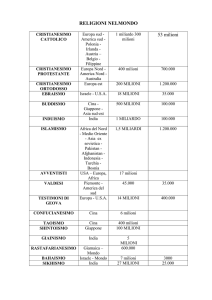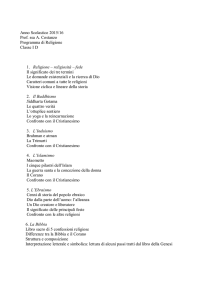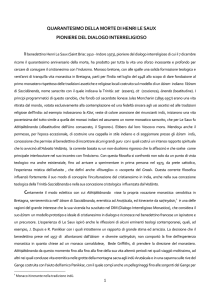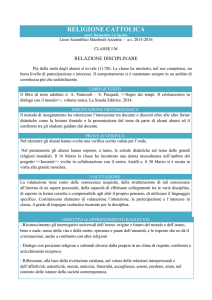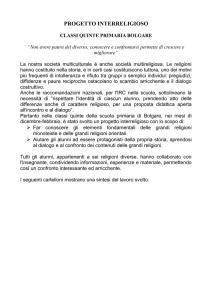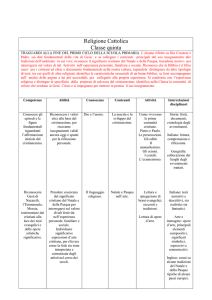Dialogo monastico
India
u
na giada ancor più bella
L’ a s h r a m c r i s t i a n o S h a n t i v a n a m , i e r i e o g g i
S
hantivanam è un monastero hindu-camaldolese, un
ashram cristiano, fondato
nel 1950 nel Sud dell’India.
Come ricordato qualche settimana fa al Pontificio istituto di studi
arabi e d’islamistica (PISAI) di Roma in
un incontro sull’avvicinamento cristiano-islamico, Shantivanam e particolarmente Henry Le Saux, uno dei due
fondatori, sono considerati gli ispiratori del «Dialogo interreligioso monastico» e quindi del dialogo interreligioso
in generale. L’ashram è stato un esempio profetico d’incontro fra monaci di
diverse culture e si è visto che il massimo di comprensione interreligiosa verificatasi fino ad ora ha avuto luogo
proprio fra esperienze contemplative –
essendo la contemplazione una carat-
teristica monastica. E l’India, per la
complessità e la profondità delle sue
tradizioni, è il terreno per eccellenza
del confronto religioso. Con tutte le sue
problematicità.
La storia di Shantivanam ebbe inizio nel 1947 quando Henry Le Saux
(1910-1973), monaco benedettino originario della Bretagna, decise di raggiungere il missionario belga Jules
Monchanin (1895-1957), che si trovava in India dal 1939. Entrambi anelavano a un cristianesimo dal respiro più
ampio di quello che conoscevano. Le
Saux trovò in Monchanin, il cui nome
circolava in Francia grazie ai rapporti
amicali e agli scambi epistolari con De
Lubac, Daniélou, Massignon, Teilhard
de Chardin, il suo riferimento.
Monchanin aveva una buona pre-
parazione teologica e filosofica – cosa
non comune fra i missionari di allora
–; si rendeva conto della profondità e
ricchezza della spiritualità hindu e voleva sperimentare un qualche tipo di
ponte fra le due parti. Negli anni trascorsi in India aveva riformulato il
senso della sua missione: non solo portare il cristianesimo all’India ma anche l’India al cristianesimo. Un movimento a doppio senso che sarebbe
servito a fecondarsi reciprocamente, a
scoprire le potenzialità, le ricchezze
sopite in entrambi le tradizioni. Monchanin aveva in mente il pensiero patristico greco e, forte anche della lontananza fisica dall’Europa, riusciva a
vedere l’assetto attuale della Chiesa
come un prodotto occidentale che, se
proposto tal quale in un contesto così
Shantivanam: le tombe dei suoi grandi monaci.
Il Regno -
at t ua l i t à
20/2014
699
lontano quale l’India, non avrebbe
potuto che essere imposizione e rimanere corpo estraneo.
Secondo Paolo Trianni, docente
di Teologia delle religioni all’ateneo
Sant’Anselmo, e profondo conoscitore
dell’esperienza di Shantivanam, «Monchanin credeva in una Chiesa universale, una Chiesa di tutti, e tale non poteva
essere se soltanto latina e greca. Greca
nell’impianto concettuale e latina
nell’organizzazione strutturale. Monchanin diceva: oggi l’esigenza di adottare come rivestimento della Chiesa
quello di altre civiltà implica qualche
rinuncia, un ritorno alle origini, una
dissociazione dell’essenziale dall’accidentale e soprattutto una interiorizzazione tramite un’intensa vita contemplativa, un primato della mistica sulla
liturgia, sulla teologia, sulla filosofia religiosa e sulle istituzioni».
Un cammino della cui complessità
Monchanin era ben consapevole, ricordando come la sintesi fra cristianesimo e pensiero greco avesse richiesto
quattro secoli di storia, protraendosi
lungo tutto l’arco del Medioevo. Per
capire la portata innovativa del suo
messaggio bisogna ricordare che quelli
erano tempi preconciliari e che la
Chiesa dell’India era molto chiusa
quando i due francesi apparvero sulla
scena. «Monchanin e soprattutto Le
Saux – sostiene Trianni – smossero tutto. La Chiesa indiana poi si è aperta;
fin troppo, tanto da destare sospetti a
Roma. Il card. Ratzinger riteneva che
il relativismo interno alla Chiesa avesse
in India una delle sue radici».
Monchanin,
Le Saux, Ramana
Anni dopo, la riflessione di Monchanin riemergerà nella domanda che
il sacerdote cattolico indo-spagnolo
Raimon Panikkar (1918-2010), amico
di Le Saux e frequentatore di Shantivanam, pose a Paolo VI: per essere cristiani bisogna essere spiritualmente semiti e intellettualmente greci? Shantivanam si rivelò dunque, nella sua modestia di poche capanne di fango ai limiti di un paesino qualsiasi, una fucina
di pensiero. Per Trianni, quella è stata
la matrice fondamentale della successiva storia della Chiesa nel paese. E
avrebbe anche germinato nel concilio
Vaticano II proprio attraverso la cono-
700
Il Regno -
at t ua l i t à
20/2014
scenza che De Lubac, padre conciliare,
aveva del pensiero di Monchanin.
Dunque Monchanin, insieme a Le
Saux, fondò il Saccidananda ashram, il
monastero della Trinità. In sanscrito
sat vuol dire «essere», citta «consapevolezza», ananda «beatitudine».
Ashram viene tradotto in «eremo» e
tradizionalmente era il luogo in cui i
giovani studiavano e si preparavano
per il matrimonio e per l’impegno sociale tornandovi poi dopo averlo espletato. Gandhi auspicava per tutti i suoi
seguaci una permanenza in ashram. Il
Saccidananda viene anche chiamato
Shantivanam, foresta della pace, per
via del boschetto vicino. Se Monchanin forniva gli strumenti filosofici per
concettualizzare l’esperimento, il contributo di Le Saux fu l’impostazione
monastica, che permetteva di trovare
nell’esperienza contemplativa un possibile aggancio con l’induismo. E suo
contributo furono anche l’impeto e
l’audacia.
In un gioco delle parti, proprio in
virtù del lavoro di Monchanin, a Le
Saux fu possibile lanciarsi in una immersione «totale» nell’induismo, un’esperienza molto sofferta, come prevedibile, ma proprio a partire dal suo personale scontro/incontro fra le due appartenenze si può capire cosa significhi
nella carne il dialogo interreligioso. E
come un concreto avvicinamento non
proceda per contrapposizioni assolute,
bianco/nero. Il nome nuovo che Le
Saux assunse come samnyasin, rinunciante, è Abhishiktananda, «colui la cui
gioia è l’Unto del Signore».
Siamo nel 1952, una fase ancora
relativamente a-problematica per Le
Saux. Egli annota nel diario: «Sogno
un’India cristiana perché penso che
soltanto in tal caso l’India troverà la
pienezza spirituale. L’induismo si fonderà con il cristianesimo senza perdere
alcuno dei suoi valori positivi; lì le sue
contraddizioni si risolveranno, i suoi
simboli coglieranno la verità e forse assumeranno un senso più profondo (...).
Si tratta d’incorporare nel mio cristianesimo tutti i valori positivi dell’induismo (...) rifiutando soltanto ciò che è
nettamente e sicuramente incompatibile e di reinterpretare sulla base dei
valori cristiani ciò che non può entrare
tale e quale». Pagine scritte nei giorni
in cui per la prima volta saliva al sacro
monte Arunacala, vicino Pondicherry.
Voleva «vedere» il celebre maestro Ramana Maharishi, che marcherà in maniera indelebile il suo percorso.
La prima impressione fu deludente.
Ramana, incurante dei devoti prostrati, leggeva i giornali, sbrigava corrispondenza, discuteva di come cucinare
certi cibi. A Le Saux parve di trovarsi
di fronte a un qualsiasi nonnetto, per di
più mal rasato e seminudo. Mesi più
tardi scriverà che solo se il cristianesimo avesse proposto figure come Ramana, di assoluta santità, distacco e
misericordia, avrebbe potuto essere
credibile in India. Ramana incarnava
il principio advaita della non-dualità.
In tale ideale, che percorre buona parte del pensiero religioso indiano, Le
Saux individuava il proprio punto di
riferimento, che sarebbe rimasto dominante fino a poco prima della sua morte. Cominciava a sentirsi lacerato fra
due amori. Si domandava: «Cosa significa questa angoscia per avere trovato la pace lontano dal luogo e dalla
forma degli impegni primitivi, alle
frontiere stesse della Chiesa? (...) Ormai ho troppo gustato l’advaita per potere ritrovare la pace “gregoriana” di
un monaco cristiano e ho troppo gustato questa pace “gregoriana” per non
essere angosciato nel mio advaita»
(1953).
Il paradigma inclusivista
Fino a poco tempo prima della morte, Le Saux oscillerà fra la convinzione
di una radicale incompatibilità fra cristianesimo e induismo e quella di una
loro complementarietà, per poi finalmente riuscire a trovare una possibile
integrazione. Non conosciamo i passaggi di quest’ultima fase perché annotati in quelle pagine finali del diario che
il discepolo preferito, Marc Chaduc,
affidò al Gange. Non a caso oggi Le
Saux è letto e apprezzato anche in ambienti induisti. La guida di Shantivanam sarebbe poi passata a un altro benedettino, l’inglese Bede Griffiths, figura molto meno tormentata che traghetterà l’ashram nell’alveo camaldolese, la
congregazione allora guidata da dom
Benedetto Calati. Oggi l’ashram conta
nove monaci, tutti indiani.
A questo punto può essere interessante fare il punto sui principali orientamenti teologici nel rapporto del cri-
stianesimo con le altre religioni, quello
che un tempo era oggetto della sola
«teologia della missione». Attingiamo
alla chiara sintesi del pastore e teologo
valdese Fulvio Ferrario, che in La teologia del Novecento scrive: «Nel dibattito
recente si parla di esclusivismo a proposito della linea che nega alle altre religioni un decisivo significato di rivelazione e la possibilità di condurre alla
salvezza. Viene invece detta inclusivista la linea che ravvisa nelle altre religioni semi di verità, linea altrettanto
presente nella tradizione cristiana. Il
suo primo teorico può essere considerato Giustino Martire (II sec) che sviluppa la teoria del “Verbo seminale”, il
Logos. Le due linee, nella concretezza
della missione, spesso finiscono per
mescolarsi».
«Nel Novecento – prosegue Ferrario –, nel clima di apertura che si esprime, tra l’altro, nel Vaticano II, il paradigma inclusivista trova la sua sistemazione teorica nella dottrina del “cristianesimo anonimo”: secondo il teologo
gesuita Karl Rahner sono cristiani senza saperlo, anonimi quindi, anche “gli
uomini di buona volontà” presenti in
altre religioni. Se l’opzione esclusivista
finisce per essere percepita dalle Chiese
cristiane come impraticabile e pericolosa, sia teologicamente sia politicamente, l’inclusivismo, dopo un prima
fase lineare, basata su certezze teoriche
molto salde riguardo il contenuto veritativo della fede cristiana, evidenzia i
suoi aspetti problematici. Se la critica
“da destra” (da una prospettiva, diciamo, filoesclusivista), che paventa una
dissoluzione dell’identità cristiana, risulta nel complesso assai debole, più
forti sono le critiche “da sinistra”. L’altro verrebbe occupato, assimilato dal
cristianesimo che, d’altro canto, rischia
di trovare quello che già sa, perdendo
così occasioni di apprendimento e conversione».
Ferrario ricorda tre tentativi di allargare i confini dell’inclusivismo. Il
primo è la teoria del «Cristo più grande», che presuppone un’eccedenza
della rivelazione rispetto alla figura storica dell’uomo Gesù. È il pensiero di
Raimon Panikkar che, discepolo di Le
Saux, soggiornò a Shantivanam e, col
suo pensiero, ha contribuito alla costruzione dell’identità teologica indiana. Un secondo tentativo passa per la
valorizzazione della teologia dello Spirito Santo che opererebbe al di là delle
Chiese e dello stesso Gesù. Un inclusivismo pneumatologico. Infine c’è il cosiddetto «teocentrismo», quando si
giunge a pensare che il paradigma inclusivista sia troppo concentrato sul
Cristo per potere veramente dialogare
con le altre religioni, e quindi dalla centralità del cristianesimo si passa alla
consapevolezza che al centro c’è Dio e
tutte le religioni, compresa la nostra,
sono al suo servizio. Siamo chiaramente su posizioni non più cristiane.
Il dialogo possibile
A questo proposito ricordiamo come nel 1998 sia stata avviata dalla
Congregazione per la dottrina della fede un’indagine a carico del teologo gesuita belga Jacques Dupuis, il cui libro
Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, edito dalla Queriniana
nel 1997, dopo essere stato inizialmente lodato, aveva destato sospetti di relativismo. Dupuis, ancora novizio, era
partito come missionario per l’India
nel 1948 rimanendovi 34 anni; aveva
insegnato teologia dogmatica al
Vidyajyoti College of Theology di Delhi e aveva frequentato Shantivanam,
affinando il suo pensiero nelle discussioni con Le Saux e Panikkar. Poi era
stato chiamato a insegnare a Roma, alla Gregoriana. Nel libro inquisito, Dupuis legittimava le altre tradizioni religiose come mediatrici di salvezza, una
salvezza però asimmetricamente complementare a quella compiuta in Cristo, che rimane decisiva. Dupuis uscì
provato da tale esperienza ma non
condannato.
Inclusivismo, pluralismo, complementarità, asimmetria sono il lessico di
una riflessione accademica che, secondo Trianni, è in una situazione di stallo: «Siamo a un punto fermo – mi dice
in un’intervista – per quanto riguarda
sia la teologia delle religioni, che studia
in quale maniera il cristianesimo si può
rapportare alle altre religioni, sia il dialogo interreligioso. Troppo diverse le
visioni metafisiche: l’hindu è panteista,
il cristiano trinitario, per il musulmano
Cristo è solo un profeta di Dio. L’unico
dialogo possibile è quello delle esperienze religiose. Non ci si incontra sul
piano del dogma ma su quello della
convivenza».
Alla domanda su cosa intendiamo
veramente con il termine dialogo,
Trianni risponde: «Il dialogo ha molte
sfumature. Dialogo è quando riconosco che nelle tue Scritture c’è una ricchezza e le utilizzo per la mia vita spirituale. Considerare i testi delle altre religioni come i semi di cui parlava Giustino per tentare di convivere in pace, arricchirsi mutualmente e, obbiettivo più
alto, trovare la verità». E, ancora, porsi
domande sul rapporto con le altre religioni è interrogativo prettamente cristiano? «In maniera così formalizzata,
sì. Anzi cattolica direi; il mondo protestante mi sembra più chiuso. Siamo
all’avanguardia in questo. Certo in India ci sono state figure di dialogo come
Gandhi, che aveva adottato una prospettiva relativistica».
Ne parlo con dom George Nelljanil, che è stato priore di Shantivanam
per 17 anni e ora lo è del monastero
camaldolese di San Gregorio al Celio,
a Roma. Ne parlo in italiano perché
padre George, che proviene da una famiglia cattolica di tradizione siro/malabarita del Kerala, ha studiato a Roma, a Sant’Anselmo. La grazia con cui
si muove è la stessa con cui mi accolse a
Shantivanam nel gennaio 2005. Sorride e sembra non preoccuparsi troppo
delle sottigliezze teologiche che screziano il dibattito sull’inclusivismo.
Preparare un’India cristiana
«I nostri fondatori non erano come
gli altri missionari che andavano a battezzare e a costruire missioni», annotava nel diario Le Saux nel 1952. «Ma
devo rispondere innanzitutto alla domanda sulla conversione. Non sarei un
cristiano autentico se non desiderassi di
tutto cuore che il mio popolo (l’indiano, ndr) ricevesse la piena illuminazione del Vangelo. Ma io non ho alcun
desiderio di conversioni individuali.
Che altri (le) facciano (...). Quel che sogno è la cristianizzazione della mia
gente. Non si tratta di utilizzare qualsiasi mezzo per catturare anime più deboli o senza difesa (...). Si tratta di preparare un’India cristiana (...), di aprire
una via. Non per il desiderio di aprirla,
ma di entrarci senza secondi fini, semplicemente perché mi sento nello stesso
tempo profondamente cristiano e profondamente hindu».
Padre George continua: «Nella
Il Regno -
at t ua l i t à
20/2014
701
Chiesa dominava ancora il principio
“extra ecclesiam nulla salus” e i fondatori di Shantivanam furono innovatori.
Cercarono di vivere come dei samnyasin, come dei rinuncianti. Vestiti di
arancione, studiavano le scritture indiane, praticavano la meditazione, facevano yoga, ascoltavano maestri spirituali; erano cioè integrati alla vita
esterna».
La Chiesa in India, concentrata al
Sud, era allora chiusa, poco vitale. Soprattutto la componente più recente,
quella che risale alla colonizzazione
portoghese del XVI secolo (che praticava la conversione in massa di fuori
casta che nel cristianesimo – così come
anche nell’islam – vedevano una via di
emancipazione sociale) – e agli anglicani del XIX. La componente più antica,
di rito siriaco, che la tradizione fa risalire all’apostolato di Tommaso, in parte
ora affiliata alla Chiesa cattolica romana, è invece molto più integrata al tessuto sociale»
Dom Nelljanil racconta di un nuovo modo di vivere il cristianesimo in
India. «Esistono oggi i “cristiani senza
Chiesa”. Attraverso Cristo cercano
Dio dentro di loro, l’identità con lui.
Nell’induismo le possibilità sono infinite, non c’è dottrina, non vige il “non
avrai altri dei all’infuori di me”. All’induismo non fa problema che uno abbia
un legame personale ed esclusivo con
un Dio particolare. I “cristiani senza
Chiesa” questo legame ce l’hanno con
Cristo e certo non possiamo essere noi
a dir loro che non possono. Ma non sono battezzati: questo sì che creerebbe
una rottura con la famiglia e la comunità…». Rimangono, insomma, hindu.
La società indiana è quella delle caste, solo formalmente bandite dalla
Costituzione del 1947: una società tradizionalmente immobile. Dalle parole
di padre George emerge la consapevolezza di una differenza antropologica.
«In India il senso del sacro è molto diverso: tutto è sacro. In Occidente non
si guarda alla realtà come a un insieme
ma vige una divisione per cui si vedono
solo parti di essa e le si studiano in chiave di causa ed effetto. Vai in chiesa e
sarai salvato. Nella realtà quotidiana
occidentale Dio è sentito come una realtà fuori di sé e dentro c’è il vuoto. In
India, invece, Dio è dentro. Nella religione cristiana saremo salvati con la
702
Il Regno -
at t ua l i t à
20/2014
croce di Cristo; lì, piuttosto con la scoperta dell’identità con Dio».
Un importante soggetto del dialogo
interreligioso è oggi il già citato «Dialogo interreligioso monastico» (DIM). Il
suo primo nucleo risale al 1957 e fu la
risposta dei benedettini e dei cistercensi
all’enciclica di Pio XII che invitava a
fondare monasteri nelle Chiese giovani. Ci furono incontri in vari paesi. Nel
1968 i monaci cristiani si trovarono a
Bangkok in mezzo al loro corrispettivo
buddhista e nacque così l’idea del dialogo con i monaci di altre religioni».
Interreligioso e monastico
A raccontarcene l’evoluzione è il
benedettino belga dom Benoit Standaert, al momento impegnato in un percorso di conoscenza con gli sciiti iraniani. «All’interno del DIM ci si disse:
non possiamo più continuare a tenere
un discorso culturale e religioso solo
occidentale. Progressivamente si è
quindi affermata una nuova prospettiva: non più missionaria o apologetica
(difendere il cristianesimo contro gli altri, i “pagani”). Il vero dialogo non ricerca conversioni e non fa proselitismo.
Il discorso apologetico sparisce (un lavoro duro su se stessi, che non finisce
mai). L’altro è considerato in sé, nel
pieno rispetto della sua alterità».
«Dopo il Concilio – prosegue padre
Benoit – la riflessione nell’ambiente
cattolico è cresciuta poco a poco arrivando a distinguere nel dialogo quattro
livelli: il teologico per specialisti, il sociale-politico-culturale, quello di vita
(cioè la condivisione della vita quotidiana quale l’andare al mercato) e
quello spirituale. Il DIM si è concentrato su quest’ultimo: in primo luogo cercando di dialogare da monaco (cristiano) a monaco (buddhista, per esempio).
Poi, a seconda dei diversi contesti, con
religioni dove non esistono monaci,
quali l’islam (ricordo i fratelli di Tibhirine, con Christan de Chergé, il loro
priore) e l’ebraismo».
Dom Standaert spiega che «non ci
sono “risultati”. L’amicizia che ne deriva non può essere chiamata un risultato. C’è certamente sempre più comprensione dell’altro. Si giudica meno
da fuori, si ammira una cultura di preghiera quale quella dei musulmani o la
potenza della meditazione dei monaci
zen in Giappone che non corrisponde
a nulla di quello che abbiamo noi. Il silenzio di un pasto nel monastero di
Tenry-ji a Kyoto non ha un corrispondente nei nostri conventi. L’ospitalità è
il momento fondamentale nella prassi
del dialogo. In genere gli orientali non
amano per niente il dialogo fatto di parole. Per loro avviene piuttosto attraverso l’espressione gestuale. Per me lo
spazio cristico della nostra fede e lo
spazio spirituale dell’altro – che sia
buddhista, hindu o musulmano – non
si escludono a vicenda. Concedendo
tempo al renderci visita, riusciamo a
comunicare sempre meglio. Nutriamo
la segreta convinzione che questi umili
passi conducano alla solidarietà tra popoli e alla pace planetaria».
«Henri Le Saux – conclude il benedettino – fu un generoso “pioniere” nel
suo incontrare la tradizione indiana
advaita. Fu un esempio di come l’esperienza spirituale conduca più lontano
della volontà di armonizzare tra loro
sistemi intellettuali, destinati all’incompatibilità se si rimane solo su quel livello. Il maestro zen Hozumi Roshi, al
termine di tre settimane passate in diversi monasteri europei, raccontò un
detto cinese: quando uno vuole rendere una pietra di giada ancor più bella,
ne prende un’altra, poi sfrega e leviga
le due pietre l’una contro l’altra. Forse
questo è lo scopo e il risultato del dialogo: maggiore bellezza».
A distanza di dieci anni chiedo a
una delle persone incontrate a Shantivanam cosa l’ashram abbia rappresentato per lei. Giancarla Goracci, che insegna in un liceo romano, mi risponde:
«Shantivanam è stato come l’affacciarmi alla finestra di un mondo altro, dove
potevo trovare i segni chiari di un cristianesimo capace di tessere nel tempo
i fili di un dialogo interreligioso e intrareligioso. Tra gli ospiti vi erano persone che venivano dalla Corea, dall’Australia, dalla Germania e non tutti si riconoscevano in un credo religioso, eppure tutto scorreva con semplicità e
gioia. Ho percepito, specie dopo la lettura di alcuni testi di Bede Griffiths, un
dialogo autentico e appassionato tra
culture e religioni. In fondo da questo
viaggio-pellegrinaggio cercavo proprio
una destabilizzazione delle sicurezze di
una fede abitudinaria».
Laura Clemente