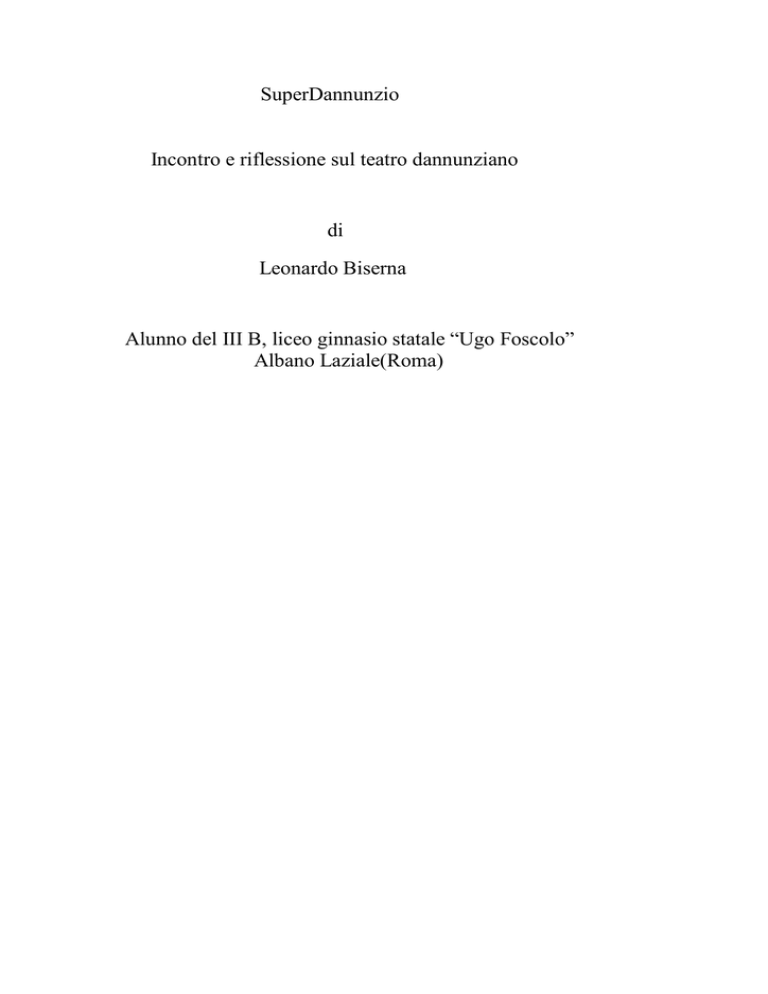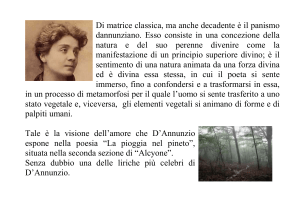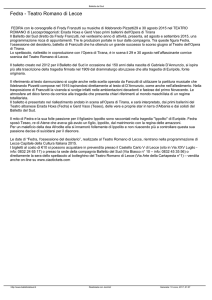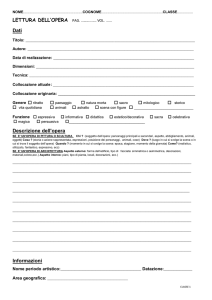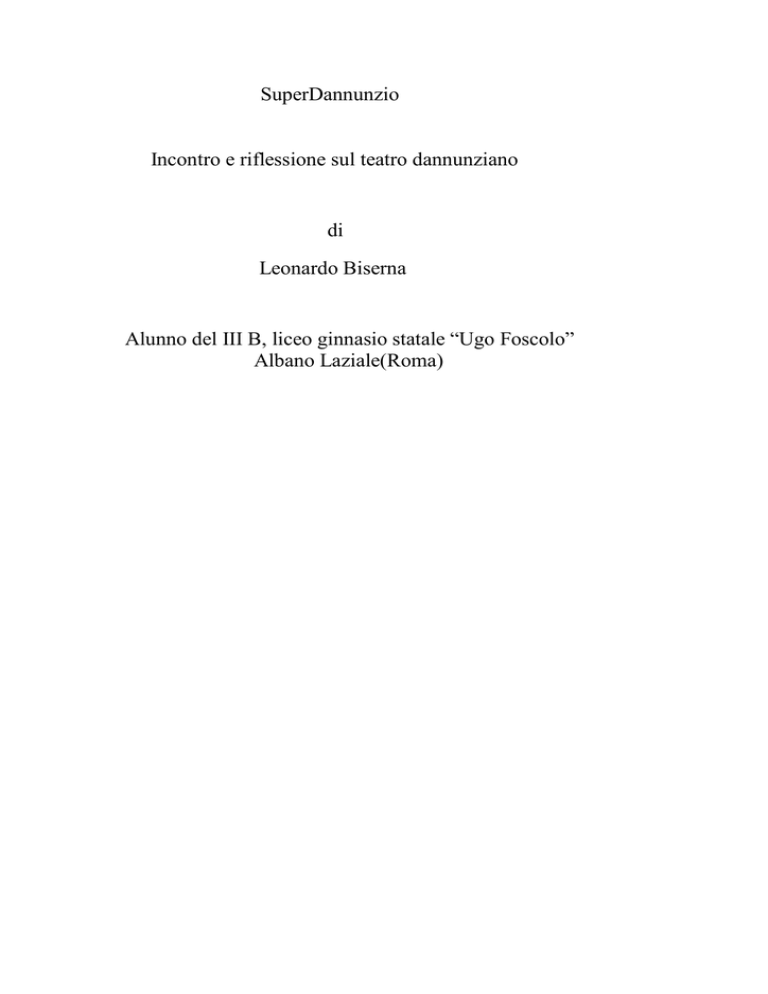
SuperDannunzio
Incontro e riflessione sul teatro dannunziano
di
Leonardo Biserna
Alunno del III B, liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”
Albano Laziale(Roma)
Non avevo mai avuto un buon rapporto con D’Annunzio, autore che consideravo pesante, arcaico,
spesso odioso per quei suoi modi e quei suoi gesti così esagerati ed esasperati. Come la gran parte
dei miei coetanei, mai avrei pensato di leggere una sua opera e, anche se lo avessi fatto, ne
sarebbero venuti solo tedio e disgusto. Quando in terza media ebbi modo di incontrare il poeta,non
ero entusiasta di studiarlo, anzi, a fatica ero riuscito ad apprendere quel poco che i libri di testo
offrono, ovvero le liriche I pastori e La pioggia nel pineto e alcuni titoli di romanzi e opere teatrali
quali Il piacere, Il fuoco e La figlia di Iorio.
Terminata la parte di programma dedicata all’autore, dichiarai il mio addio ad ogni ipotetica e
futura esperienza dannunziana. Neanche iniziata, per me si era già conclusa un’epoca.
Era un pomeriggio di giugno, assolato come tanti, quando mi aggiravo per le strade di Velletri. I
palazzi erano torridi e, al tempo stesso, silenziosi. Dovevo tornare a casa. Ma, stranamente,
qualcosa mi tratteneva lì, senza che riuscissi a capirlo: un’agitazione interiore che non riuscivo a
palcare. Il caldo mi stava uccidendo. Intento, quindi, a cercare un po’ di fresco, decisi di andare alla
biblioteca comunale; avrei chiesto in prestito qualche libro da leggermi nelle ore di canicola.
Soprattutto, da quando ero venuto a sapere che la XIII edizione dei “Colloqui fiorentini” era
incentrata su D’Annunzio, avevo compreso che quella che due anni prima avevo ritenuto
un’ esperienza conclusa e superata, in realtà doveva essere ricominciata daccapo. E, anche se
sapevo che non avrei potuto partecipare ai Colloqui, spinto da una grande sete di curiosità, chiesi di
poter avere in prestito Il Piacere, opera celeberrima di cui avevo spesso sentito parlare e che ero
intenzionato a leggere; per un caso del destino, quel romanzo non era al momento disponibile in
sede, ma avrei potuto prenotarlo; sarebbe arrivato due settimane dopo. Nel frattempo mi posi la
domanda: “E in queste due settimane come posso restare senza nulla da leggere?”. Mi pareva
ingiusto. Avevo capito che ogni esperienza dannunziana sarebbe stata impossibile. Eppure il
desiderio di toccare le sue parole, di scoprirlo mi soverchiavano. E fu allora che chiesi, con fare
timido: “Ma qui, a Velletri, non c’è nessuna opera dell’autore che potrei avere subito in prestito?”. I
bibliotecari, allora, si dettero immediatamente alla ricerca sui loro computer e ne venne fuori una
sfilza di titoli; alcuni mi parevano belli, altri meno. Ma ce n’era uno in particolare che mi colpiva
molto, mi rievocava qualcosa di stupendo e affascinante: Le vergini delle rocce. “Mi scusi, potrei
avere quello?” chiesi.
“Certo! Vado subito al deposito e glielo cerco”.
Attesi alcuni minuti. La signora tornò con un libro piccolo, semilucido, con due calle sulla copertina
fresche e dolci. Rimasi col fiato nei polmoni. Mi parve quasi un’ apparizione simbolica.
Tornato a casa, cominciai da subito a sfogliare le prime pagine. Quelle citazioni di Leonardo, e le
iscrizioni in latino, e l’attesa del principe da parte delle vergini mi parvero tutte cose davvero
meravigliose, ma quella lingua, e quel tono sempre drammatico, e le figure di Oddo e Antonello, e
le voci alla fontana mi crearono un forte turbamento. Ero caduto in uno stato di crisi. Mia madre ne
fu testimone, quando le raccontavo quelle cose che tanto mi avevano contristato, e lei che in
silenzio mi ascoltava. Cercai di aiutarmi con le note a piè di pagina. Mi sforzai di proseguire fino in
fondo. Non dovevo desistere, no, per niente!
Fu verso la fine di luglio quando, arrivato alla centonovantaseiesima pagina del libro, mi resi conto
che quell’autore che tanto avevo odiato e guardato sempre con un certo fastidio, in realtà aveva
scritto un qualcosa di magnifico e immortale. Sorpresa più grande fu quando iniziai L’Innocente.
Lì mi resi conto che per quasi un secolo la maggior parte dei critici che tanto si era impegnata a
trovare difetti negli scritti dannunziani, in realtà non aveva tenuto conto di uno dei punti
fondamentali della sua scrittura: la diversità di ogni opera dall’altra. E se nelle Vergini dominava
uno stile arcaico con note tendenti a un poema rinascimentale, ne L’Innocente lo stile era
incredibilmente fluido, coinvolgente, straordinariamente moderno, lontano da quell’idea che in
passato mi ero fatto sull’autore e i suoi volumi. Ricordo ancora quella sera d’agosto: tanto ero preso
dalla storia, che lessi tutta la parte in cui Tullio medita e compie il suo delitto (all’incirca cento
pagine), che restai sveglio fino alle quattro del mattino pur di arrivare fino all’ultimo rigo.
Non dimenticherò mai quella stupenda angoscia davanti a quelle parole. Da quel momento iniziai
senza pausa a leggere un volume dopo l’altro, Il trionfo della morte, Il fuoco e una serie
interminabile di drammi incantevoli.
È stato grazie al contributo della mia professoressa di lettere, Susanna Bisi, che ho deciso di
approfondire meglio la questione dannunziana e, pur non partecipando al concorso, di scrivere un
breve resoconto della mia esperienza.
Ho voluto incentrare la mia ricerca soprattutto su teatro dannunziano, che mi ha particolarmente
colpito per la sua grande originalità e profondità. Per questo studio prenderò in considerazione
cinque drammi: due, più celebri, Fedra e La città morta; tre, invece, meno famosi, ma non per
questo meno importanti, Sogno di un mattino di primavera, Sogno di un tramonto di autunno e La
Gioconda, tre vere perle di un teatro ancora tutto da riscoprire.
I.
D’Annunzio e il suo teatro “cinematografico”
Mi sono sempre chiesto il motivo per cui quasi tutte le tragedie dannunziane, quando vennero
rappresentate per la prima volta, terminarono tutte in clamorosi fiaschi o in esiti incerti, nonostante
vantassero interpreti del calibro di Eleonora Duse o Ermete Zacconi, mostri sacri del teatro italiano
di ogni tempo. D’Annunzio stesso, colto da uno stato di disperazione, divenne anche il regista di
Francesca da Rimini, operando direttamente sulle scene e dirigendo personalmente la creazione di
costumi e arredi. Eppure, nonostante si fosse piegato a lavorare diciotto ore al giorno, la prima si
rivelò un fallimento totale. Solo nel 1904, con La figlia di Iorio, l’autore ottenne un grandissimo
successo. I drammi successivi, però, non si rivelarono mai così felici come questo. Per decenni, solo
La figlia di Iorio ha avuto il degno riconoscimento di capolavoro, mentre gli altri drammi vennero
spesso trascurati.
Perché tutto questo?
Quando iniziai a leggere Fedra mi accorsi che, nonostante la complessità, l’opera non presentava
elementi tali che ne impedissero la messa in scena. Ma quello che più di tutto mi stupì non
consisteva tanto nella lingua, quanto nel modo con cui l’autore, a differenza di altri drammaturghi,
dispone le scene e i personaggi nel corso degli atti. D’Annunzio non cura soltanto le battute degli
attori, ma arriva persino a descrivere gli atteggiamenti psicologici che devono avere e, soprattutto,
dà grandissima importanza all’ambiente in cui si muovono. In un’epoca in cui gli sfondi erano
costituiti solo da pannelli dipinti, e i costumi erano pezzi di seconda mano di fattura grossolana,
D’Annunzio supera la tradizione e decide di ampliare gli spazi, di abbattere quell’illusione scenica
propria del teatro e di dare un realismo e una profondità propri dell’illusione cinematografica. Non a
caso gli aggettivi “vasto” e “luminoso” sono i più ricorrenti, insieme ai loro sinonimi, nelle
didascalie che precedono ogni atto. Nel Sogno di primavera c’è, secondo le indicazioni dell’autore,
“un loggiato vasto, in un’antica villa toscana…aperto su colonne di pietra, chiaro e tranquillo”;
ritengo opportuno soffermarsi su questi particolari, perché sono alla base di tutta la scena
dannunziana. Attraverso gli archi “appare un giardino intercluso da siepi di cipresso e di bossolo
donde si levano, a distanze eguali, densi alaterni tagliati a foggia di urne rotonde”; in mezzo si nota
un pozzo di pietra; a destra e a sinistra, poggiati ai muri di cinta, ci sono dei prolungamenti delle
tettoie di alcune serre, dove si trovano al riparo, su vari ordini, degli agrumi in dei “grandi vasi
d’argilla”; più in là si vede un cancello e, oltre, un bosco selvaggio dove “gioca il sole mattutino:
visione di forze e di gioie senza limiti”; infine, “innumerevoli vasi di mughetti in fiore” che, con la
loro delicatezza, fanno da contrasto con le siepi austere e tristi, “cosicché il giardino suscita
l’ imagine umana d’un volto pensieroso di sotto a una fresca ghirlanda”.
Ora, dopo averlo letto, verrebbe naturale pensare: “Ma come si può ricreare su un palcoscenico, per
quanto possa essere grande, una scena così ricca e dettagliata?”. I mezzi di cui si poteva disporre nel
1897 non erano così all’altezza di consentire una tale resa. E quindi si comprende il perché di tanti
insuccessi. Finora la maggior parte dei drammaturghi non si era preoccupata di dare una così grande
importanza alla scena.
Vastità e luminosità ritornano nelle atmosfere autunnali dell’ altro Sogno. Qui c’è una luce più cupa
perché il dramma si svolge al tramonto. La vastità, invece, viene comunicata dalle architetture
rinascimentali di una bellissima villa veneta “su la riva della Brenta”. Numerosi in quest’ opera i
riferimenti a Il Fuoco, il romanzo veneziano dell’autore; ambedue gli scritti, non a caso, sono stati
stesi nello stesso periodo. Tornando al dramma, si noti come in un’unica scena vengano condensati
una meravigliosa scala a chiocciola, un atrio colmo di statue e di preziosissimi arredamenti, e una
serie di cancelli in ferro finemente battuto. Oltre a questi si nota un giardino dall’aspetto autunnale
e, al di sopra, “vaste nuvole immobili e raggianti”; la luce, come ho detto prima, ha le tinte
dell’autunno; “le ombre appaiono quasi fulve, come quelle degli antri ov’è adunato molto oro”.
Come il lettore avrà visto, l’impostazione che dà D’Annunzio all’opera non è solo quella di un
copione teatrale, ma soprattutto quella di una sceneggiatura di un film, dove ogni particolare è
importanti e gli spazi dove si muovono gli attori sono ampi e realistici; è risaputo, inoltre, che in
ogni film la luce assume un ruolo fondamentale, più che nel teatro. Ricordo inoltre che nel 1895 i
fratelli Lumiére brevettarono il primo apparecchio da presa ed eseguirono anche la prima
proiezione.
Dieci anni dopo l’ impostazione cinematografica risulterà ancora più evidente in Fedra, dove i tre
atti non si configurano come una narrazione continua, ma come quadri staccati, ognuno con una
scena diversa e con vicende differenti (I atto- ritorno di Teseo con le ceneri dei sette eroi caduti a
Tebe; uccisione della schiava Ipponoe da parte di Fedra; II atto- follia di Fedra; amore tra lei e
Ippolito; morte di Ippolito; III atto- funerali di Ippolito e morte di Fedra). Quello che maggiormente
mi ha colpito è come in ogni atto D’Annunzio definisca non solo arredi e costumi, ma anche le luci
e le ombre, e il modo con cui esse debbano ricadere, anzi “rivestire” i personaggi. Nel I atto
troviamo ad esempio: “Appare, nel palagio di Pitteo, il grande e nudo lineamento di un atrio che gli
occhi non abbracciano intero, sembrando il vano e la pietra spaziare più oltre da ogni parte, con
sublimi colonne, con profonde muraglie, con larghi aditi aperti fra alte ante. Per alcuno degli aditi
non si scorge se non l’ignota ombra interna; ma l’ardente luce occidua e il soffio salmastro entrano
per alcun altro che guarda la pianura febea di Limna, il porto sinuoso di Celènderi, la faccia
raggiante del Mare Sarònico e la cerula Calàuria sacra all’ippico re Poseidone”. Si noti come il
senso di vastità ritorni superbamente nelle architetture greche dell’atrio.
Sempre nel I atto, durante il colloquio tra Fedra e la schiava tebana Ipponoe, “un bagliore come
d’incendio entra pel propileo, dalla parte del Mare; vince la face, agita le ombre, percote le mura e
le colonne; irradia il volto della Titanide vertiginosa (Fedra)”. La luce, quindi, gioca con i
personaggi e si fa carico dei sentimenti e degli stati interiori dei personaggi, in questo caso della
follia omicida di Fedra.
II.
Suoni e silenzi
Altro elemento di rilievo è il rapporto che i personaggi hanno con il suono e, soprattutto, con il
silenzio. Ma che cosa intende veramente l’autore con il termine ‘silenzio’? Se si legge Il Fuoco,
nella seconda parte (non a caso intitolata L’Impero del Silenzio), nel colloquio che avviene tra
Daniele Glauro e Stelio Effrena tra le calli veneziane, viene definito molto chiaramente il concetto
di silenzio: “ L’essenza della musica non è nei suoni … [ma] nel silenzio che precede i suoni e nel
silenzio che li segue”. Il silenzio dannunziano, quindi, non si riferisce solo all’assenza di voci, suoni
e rumori, ma soprattutto ad un momento in cui, cessato il suono, l’ascoltatore deve cercare di
condensare e riflettere su ciò che ha sentito, interiorizzando un’esperienza esteriore. Questo
processo ricorre in quasi tutta la produzione dannunziana, dalla poesia alla prosa al teatro, ma è
proprio nel teatro che questa raggiunge il suo culmine: i personaggi sono coinvolti interamente nel
suono. Nel “Sogno di primavera” (scena II) la “demente” Isabella, quando parla con il dottore, dice:
“Udite questo tintinnio d’argento? Com’è sottile! Udite?”. E il dottore: “È il sussurro delle api”.
“Oh no,no…- ribatte Isabella- voi non udite”. “Io sono vecchio omai: il mio orecchio è ottuso”. Più
in là, sempre nella scena terza, la “demente” replica: “Udite questo tintinnio argentino? Sono i
mille e mille campanelli dei mughetti, che tintinnano all’aria che li muove. Udite? Somiglia a quel
tintinnio fuggitivo che s’ode a traverso le stanze quiete della casa dove qualcuno deve morire”. Nel
corso di queste battute l’autore ci dice che la donna si pone sempre in un atteggiamento di ascolto.
Ne La città morta Anna, essendo cieca, ha sviluppato fortemente tutti gli altri sensi. Lei ha la
capacità di vedere oltre e di percepire persino i più singoli moti interiori delle persone che la
circondano. Nella prima scena dell’atto terzo, la cieca racconta alla nutrice della passeggiata fatta
con Bianca Maria alla fonte Perseia, e le dice: “La terra respira. Dianzi, quando sono discesa alla
fonte con Bianca, non si sentiva un alito: nulla! Era la calma perfetta, senza mutamento. Non
dicevamo una parola, per non turbarla. Soltanto la fonte piangeva e rideva… Siete mai stata attenta
alla voce di quella fonte, nutrice?”. E lei risponde: “L’acqua dice sempre la stessa cosa”. Anna,
stizzosa, replica: “Non è vero… L’acqua diceva un’infinità di cose che entravano in me come una
persuasione”.
Questa battuta potrebbe esaurire da sé il paragrafo. Eppure D’Annunzio nella sua continua
sperimentazione, in Fedra estende il concetto di silenzio anche nel modo in cui vengono disposte le
parole nel testo. Nel I atto Fedra crede di sentire il latrato dei cani di Ippolito, e dice alla nutrice:
“
O Gorgo
non udisti il latrato dei suoi cani?”
E Gorgo:
“ Non udii”.
Ma la Cretese ribatte:
“
Sì, sì, sempre s’ode, ovunque
s’ode, ovunque. N’è sorda
l’aria, n’è rauco il vento. Sempre s’ode”.
Quello che colpisce non è tanto il modo con cui si svolge la scena, che presenta la stessa struttura
dei due brani analizzati precedentemente (ovvero, un personaggio che sente dei suoni; il suo
interlocutore che non li sente; il personaggio che con forza ne riconferma la presenza), ma è nella
struttura dei versi. L’autore, attraverso le battute, spezza gli endecasillabi e li pone nel testo come se
seguissero delle linee oblique che a volte tendono ad aprirsi verso l’alto, altre a chiudersi verso il
basso, creando un effetto ondulatorio che riproduce proprio il propagarsi di un’eco. Nel corso del
dramma questo schema si ripete numerose volte come, ad esempio, nell’atto secondo, quando le
ancelle sentono latrare i cani di Ippolito, che sta tornando dalla caccia. Dice Fedra:
“ È il latrato del Cane di sotterra
quello che sempre s’ode, sempre s’ode?
Agave, Stilbe, avete udito?”
E loro:
“
- Latrano
i molossi d’Ippolito
sotto la Rupe.
- Il figlio dell’Amàzone
ancóra insegue il cavallo di Adrasto,
che fugge il laccio.
- S’ode
clamore dietro il tempio della Sòspite.
-Qualcuno chiama”.
III.
D’Annunzio e la religione
Prima di parlare del tema centrale di questo studio, è bene accennare al rapporto che D’Annunzio
ha con la religione. Molte delle opere dannunziane sono chiaramente ispirate alle tesi
superomistiche di Nietsche, anche se talvolta l’autore non rispecchia chiaramente il pensiero del
filosofo. Questo paragrafo, però, non tratterà tanto il rapporto tra l’autore e Nietsche, ma tenderà
piuttosto a considerare il valore che D’ Annunzio attribuisce alla religione, seguendo le teorie del
filosofo.
In un mondo come quello di fine Ottocento, dominato dalle società di massa, dalla tecnologia e dal
positivismo scientifico l’uomo deve ritrovare il suo essere originario e ritornare ad avere una
relazione diretta con la natura, accettandone con vitalità e determinazione sia le cose belle, sia
quelle brutte e dolorose. Le superstizioni e la religione, quindi, non dovranno più stare alla base
dell’uomo moderno, ma egli stesso, in prima persona, con la sua volontà e la sua potenza, dovrà
affrontare il destino. Dio, pertanto, non assume più il ruolo ricoperto in passato, ma diventa una
figura secondaria, talvolta scompare del tutto.
Questo processo è ben descritto nel cap. IV del Trionfo della morte, dove il monastero di
Casalbordino diventa simbolo di una massa umana incapace di reagire, che si appoggia ai culti
religiosi quasi fino all’isteria e alla disperazione. La religione è qui motivo di sarcasmo e
dissacrazione.
Nel teatro, invece, l’autore elabora molto più approfonditamente gli studi che Nietsche aveva
compiuto sul teatro greco antico. Il filosofo, infatti, sosteneva che “la tragedia greca non è
pessimismo […] non è tentativo di affrancarsi dal terrore mediante la ‘purificazione’ […]
ma è la volontà di accettare fino in fondo ogni aspetto del divenire della vita.”1.
Questo tema, che trova grande respiro nelle pagine de Il Fuoco è uno dei punti fondamentali del
teatro dannunziano. Secondo l’autore, il teatro antico non è solo una fonte inestinguibile di
argomenti ogni volta attuali ed affascinanti, capaci di suscitare nello spettatore sempre nuove
emozioni, ma è anche una celebrazione, gioiosa e dolorosa al tempo stesso, della vita in ogni sua
forma. In origine la tragedia, infatti, nacque come forma d’arte sacra, destinata ai culti bacchici che,
come molti sanno, erano molto sentiti dal popolo greco ed erano caratterizzati anche da canti e
danze vivaci. Il dramma dannunziano, quasi a mo’ di sfida, tenta incredibilmente di interpretare
queste caratteristiche della tragedia classica con scenari moderni, secondo la concezione
dannunziana dell’attualizzazione del mito e del tragico, che non sono riconducibili ad un epoca
remota.
La città morta, ad esempio, presenta, specie nel quinto atto, questo tentativo dell’autore di compiere
tale unione. La morte di Bianca Maria, anche se il dramma è ambientato ai tempi degli scavi di
Schliemann a Micene (1876 circa), assume il carattere di una catarsi, di una “purificazione” e come
tale viene presentato dall’omicida Leonardo all’amico Alessandro: “Credi tu, credi tu… che io la
profanerei se la toccassi? No, no… Ora io sono puro: sono tutto puro… S’ella ora si levasse,
potrebbe camminare su la mia anima come su la neve immacolata… S’ella rivivesse, tutti i miei
pensieri per lei sarebbero come gigli, come gigli…”.
In Fedra l’autore compie un ulteriore passo in avanti, superando la tradizione passata, che
rappresentava una donna vittima di una colpa ereditata dalla madre (Fedra, infatti, era nata
dall’amore adultero tra Zeus e Pasife). Qui lei è orgogliosa delle sue origini e, anche se pienamente
cosciente dell’errore materno, non se ne sente affatto colpevole; al contrario, ella, dea dalle
sembianze umane, non accetta la subordinazione ad altre divinità, tanto è vero che, nel corso
dell’opera, viene più volte definita “dispregiatrice degli Iddii”, eccetto che di Tanato, cioè la Morte:
“Fuorché d’uno/…fuorché del solo che non ami i doni/ né l’ara né il libame né il peàne;/ fuorché di
quell’un solo” 2. Nel corso del dramma, inoltre, ricorrono frequentemente le immagini del labirinto
1
2
E. Severino, Storia della filosofia contemporanea, Milano, Rizzoli Editore, 1986, p. 115.
Ivi, atto primo.
e della sagari, ovvero la scure usata dalle Amazzoni, simboli di un passato mitico e indefinito. A
differenza degli altri testi teatrali, scritti con un linguaggio molto più semplice e scorrevole, in
questo viene usato uno stile molto più elaborato e complesso, a rappresentare proprio questa unione
con un mondo arcaico, popolato da mostri e da dei. Inoltre la follia della donna viene spesso
rapportata con quella delle Baccanti, o Tiadi, durante la celebrazione dei riti in onore di Dioniso.
Etra, verso la metà del primo atto, le esclama: “Fedra, Fedra, deliri come Tiade/ notturna! Un acre
morbo/ t’abita nei precordii,/ e tu non sai.”
Alla fine del dramma Fedra non subisce una vera morte, ma ritorna alla sua originaria forma divina,
collegata ai culti di Artemide, dea della caccia, di Ecate, dea dell’oltretomba, e della luna,
rappresentata proprio da lei3. Come sappiamo, queste tre figure nella mitologia antica venivano
sempre collegate insieme.
IV.
La vittoria sul tempo (il desiderio nel teatro dannunziano)
E qui si arriva al tema centrale dello studio, argomento di questa edizione dei Colloqui: il desiderio
e l’atto di desiderare.
Se un lettore si accingesse a leggere un dramma dannunziano,qualsiasi sia esso, La città morta, o La
figlia di Iorio o La Gloria o Fedra, noterebbe fin da subito che la parola che ricorre più
frequentemente è proprio “desiderio”, insieme al verbo corrispondente “desiderare”, talvolta
sostituiti dai suoi sinonimi. Tutti i personaggi, siano essi Francesca da Rimini, o Ruggero Flamma,
o “la demente” Isabella, o Silvia Settala, vivono desiderando, sono arsi dal desiderio e in nome di
quello basano il senso della propria vita. Tutto ciò che è vitale, bello, autentico si ricollega al
desiderio. Ma il desiderio si può rivelare solo una vana speranza e, quindi, da arma per la vita, può
diventare arma per la morte dello spirito e del corpo.
Se si legge La Gioconda risulta ben chiaro il modo con cui l’autore intende il concetto di desiderio.
La prima battuta che apre l’opera viene pronunciata da Silvia Settala: “Oh, sia benedetta la vita! Per
aver tenuta sempre accesa una speranza, oggi io posso benedire la vita”. Suo marito, lo scultore
Lucio Settala, infatti, traviato dalla sua amante Gioconda Dianti, per salvare il proprio onore davanti
alla moglie aveva tentato il suicidio nel suo studio artistico, al Mugnone. Mentre veniva soccorso
dal suo maestro Lorenzo Gaddi, Silvia si trovava a Pisa dalla madre insieme alla figlia Beata.
Accorsa alla notizia di suo marito, diede prova di grande dedizione, desiderando che il suo amato
tornasse a vivere: “… E la forza di lei, l’incredibile resistenza di lei alla veglia e al disagio per
intere settimane, la vigilanza fiera e silenziosa con cui ella custodiva la soglia come per impedire il
passaggio alla Morte”4. Si noti quindi come l’uomo, per poter superare i disagi della vita, ha come
unica arma il desiderio. Silvia, pur sapendo dell’errore commesso dal marito, coglie l’occasione per
ricongiungersi a lui, ritrovando l’equilibrio originario, poiché adesso l’amante è lontana.
Ma, come ho detto prima, il desiderio si può rivelare un’arma a doppio taglio. E Silvia, pur avendo
ardentemente desiderato questo ricongiungimento e fatto il possibile per realizzarlo, si ritroverà
vittima sia della falsità del marito, sia della crudeltà di Gioconda. E a nulla varrà la lotta che lei
terrà contro l’amante nello studio al Mugnone: alla fine la donna malvagia e crudele vince, e lei,
sola e abbandonata, a causa della caduta di una scultura durante il litigio, perde anche le braccia,
riducendosi a portare un paio di moncherini che la condizioneranno per sempre.
Questo risvolto drammatico del desiderio ritorna anche nei due Sogni. Nel Sogno di Primavera, se
da una parte la “demente” Isabella sogna per la sorella Beatrice uno sposo che la renda felice e non
la faccia soffrire e diventare pazza, come era successo per lei con l’amore infelice per Giuliano,
dall’altra ogni tentativo di Virginio, fratello dell’ucciso, e di tutti gli altri personaggi di riportarla
alla ragione si riveleranno vani.
3
Mi riferisco qui a quanto ha attentamente notato la prof.ssa Marcella Petrucci nel corso della conferenza tenutasi il
12/12/2013 nell’Aula Magna del nostro Liceo.
4
Ivi, atto primo, scena seconda.
Nel Sogno d’autunno la dogaressa Gradeniga, che, a causa della meretrice Pentea, ha perso il
proprio amato, disperatamente, ricorrendo alle proprie spie e a una maga che è solita compiere riti
di magia nera, tenta disperatamente di riaverlo indietro, facendo morire la meretrice che si trova
insieme a lui sul bucintoro, la barca da parata del doge. Ma alla fine, dal momento che
l’imbarcazione va in fiamme, non solo muore Pentea, ma, anche se l’autore non lo dice
esplicitamente, pure il suo amato.
Ne La città morta il ritrovamento di quindici cadaveri ricoperti d’oro a Micene da parte di Leonardo
(nella realtà storica fu Schliemann a fare questa scoperta epocale) viene percepita come una vittoria
dell’uomo sul Tempo. Questo, all’interno de Il Fuoco, è uno degli argomenti centrali del colloquio
tra Daniele e Stelio. L’uomo, essendo per natura mortale, non può superare il tempo, ma desidera
farlo. Nonostante ciò l’uomo può dar vita a cose che superano anche il tempo come, ad esempio,
attraverso l’arte. Il ritrovamento di Leonardo viene percepito dall’autore come un ricongiungimento
totale al mondo mitico della Grecia arcaica. Le vicende degli Atridi tornano a rivivere nel presente,
dopo quasi 2500 anni, con tutti i loro risvolti cupi e tragici tanto che, dopo due anni di scavi,
Leonardo, euforico nel primo atto per il ritrovamento, man mano impazzisce e, atto dopo atto,
arriva fino al quinto, dove compie con estrema freddezza il suo delitto.
A mio parere D’Annunzio non solo dà una dimensione tragica del desiderio, ma anche una morale:
egli, infatti, ci dimostra come il non saper controllare i propri desideri possa portare da uno stato di
bene ad una condizione di nevrosi e, un passo dopo, di follia.
V.
Falsità e ipocrisia
Spesso la produzione dannunziana è stata tacciata di incoerenza e falsità, specie i romanzi, da parte,
ad esempio, di critici di scuola crociana. Questi sono arrivati persino a dividere all’interno delle
opere le parti che, secondo loro, erano “coerenti”, da quelle “incoerenti”, provocando danni gravi e
irreversibili. Fortunatamente molti critici, oggi, stanno cercando di riparare a questo, rivalutando
l’autore nella sua totalità.
Molte volte mi sono chiesto: “Ma che cosa si intende con il termine “falsità” e perché l’opera
dannunziana è stata e viene spesso associata a questa parola?”. Dopo un’attenta analisi ne ho
concluso che quello che molti comunemente chiamano “falsità” non è nient’altro che un particolare
tipo di prodotto di quel periodo storico, ovvero quello a cavallo del XIX - XX sec., dove gli studi
scientifico- psicologici stavano facendo luce sul cervello umano e sulla sua complessa struttura.
L’uomo scoprì, pian piano, che la propria psiche non andava più considerata come un elemento
unico ed omogeneo, ma come un insieme diviso in più strati che poteva essere indagato e studiato
anche attraverso il sogno. È proprio in quest’epoca che la psicologia diventa una scienza dai tratti
ben definiti. I casi clinici come, ad esempio, la follia e lo sdoppiamento di personalità, ma anche
fenomeni che non sono riconducibili a malattie, ma solo ad attitudini del comportamento umano,
quali la nevrosi, non vengono più analizzati in modo superficiale e blando ma, al contrario, sono
sottoposti a rigorose osservazioni scientifiche.
È logico pensare, quindi, che tutta l’arte del periodo e, in particolar modo, la letteratura siano state
fortemente influenzate da questo nuovo cambiamento della società e della cultura. D’Annunzio,
soprattutto, pone particolare attenzione, specie nei romanzi e nel teatro, nel descrivere i pensieri e le
reazioni dei personaggi in relazione all’ambiente in cui si trovano e alle persone con cui
interagiscono. La psicosi, la depressione, la gelosia morbosa e l’ipocrisia assumono un carattere
centrale all’interno della narrazione.
Il tema della follia trova largo spazio nel Sogno di primavera. Isabella diventa pazza dopo che suo
marito le ha ucciso l’amante Giuliano tra le sue braccia, bagnandola di sangue. Da quel momento lei
non può più vedere il colore rosso perché le causa stati di crisi acuta e perdita di senno. Nel corso
del dramma inutili saranno i tentativi di riportare la donna alla ragione: il suo stato è stato è senza
ritorno, anzi, come afferma il dottore nella seconda scena, “ella non è morta, ma è discesa
nell’assoluto mistero”.
L’ipocrisia, e qui si arriva al nodo centrale della questione, non deve essere interpretata come
incapacità dell’autore di dare coerenza ai personaggi dell’opera, ma come una forma di impotenza
da parte dei personaggi stessi di ritrovare in sé un’ identità univoca e genuina.
Si guardi La città morta, ad esempio: Alessandro mostra al meglio la concezione dannunziana di
ipocrisia. Anna sa che il marito è innamorato di Bianca Maria ma, al tempo stesso, facendo finta di
non sapere niente di questo amore adultero, non fa nulla per impedirlo, anzi, lo accetta, mostrando
un profondo senso di sacrificio nei confronti del coniuge; inoltre lei, essendo cieca, si considera
sempre verso di lui come “una catena pesante, un vincolo intollerabile”, oppure come “una larva
semiviva”. Lei, infine, nell’atto terzo cerca di convincere anche Leonardo riguardo questo amore
infedele. L’archeologo, però, invaso da una follia incestuosa, non accetta che la sorella, che lo ha
sempre seguito fedelmente nel corso dei suoi scavi, abbia una propria vita. Da questo punto in poi il
dramma assume un ritmo sempre più accelerato, fino ad arrivare alla terza scena del quarto atto
dove Alessandro, usando un linguaggio ambiguo e infido, tiene un colloquio con la moglie e, fra
tante domande, le chiede in quale modo ella sia riuscita a carpire da Leonardo il suo “segreto”. Ma
che cosa intende Alessandro con il termine “segreto”? Forse allude al suo amore adultero per
Bianca Maria, oppure al fatto che Leonardo gli aveva rivelato nel secondo atto le sue intenzioni
omicide nei confronti della sorella?
Al termine di questo colloquio, però, non viene data risposta, anzi, nasce un equivoco con la
moglie, come se con questo l’autore volesse significare la profonda incoerenza dell’uomo.
Ma non è finita qui. All’inizio dell’atto V Alessandro accorre alla fonte Perseia avendo avuto un
triste presentimento. Trova Leonardo addossato a un macigno e, per terra, Bianca Maria distesa. Qui
si rivela tutta l’ipocrisia dell’uomo che, anziché accusare l’amico, pensa al modo con cui
nascondere il cadavere cosicché Anna non possa scoprirlo.
L’ipocrisia emerge ancora più marcatamente nella figura di Lucio Settala che, dopo aver tentato il
suicidio, grazie alle cure della moglie, ritorna a vivere. Ancora convalescente, le fa un intenso
discorso che, per molti aspetti, ricorda quello che fece Tullio Hermil alla moglie a Villalilla, ne
“L’Innocente”:
“Tutte le pene che hai sofferte, le ferite che hai ricevute senza un grido, le lacrime che nascondesti
perché io non avessi onta o rimorso, i sorrisi di cui velavi le tue agonie, l’infinita pietà pel mio
errore, il coraggio invincibile dinanzi alla morte, la lotta affannosa per la mia vita, la speranza
tenuta sempre accesa al mio capezzale, le veglie, le cure, l’incessante palpito, l’attesa, il silenzio, la
gioia, tutto quel che v’è di profondo, tutto quel che v’è di dolce e d’eroico in te, tutto io conosco,
tutto io so ,cara, cara anima; e, se la violenza è valsa a spezzare un giogo, se il sangue è valso a
riscattarmi, (oh, lasciami dire! Io benedico la sera e l’ora che mi portarono moribondo in questa
casa del tuo martirio e della tua fede per ricevere un’altra volta dalle tue mani- da queste divine
mani che tremano- il dono della vita”.
A questo punto il lettore potrebbe pensare che il ricongiungimento tanto sperato da Silvia sia
avvenuto. Eppure, il giorno dopo, Lucio riceve una lettera da Gioconda. L’uomo, quindi, si ritrova
nuovamente diviso tra la moglie e l’amante. A nulla, ripeto, servirà la lotta che Silvia terrà faccia a
faccia con Gioconda, pur di tornare ad avere il marito per sempre con sé. Alla fine Lucio tornerà a
vivere con Gioconda, abbandonando per sempre la moglie e sua figlia Beata.
Conclusione
Quello su cui spesso non sono stato d’accordo è che per decenni D’Annunzio è stato quasi sempre
letto in chiave autobiografica, ma i lettori dovrebbero anche ricordare che mescolare vita e opera
d’arte è uno degli errori più gravi che si possa commettere. Molti non si sono resi conto che
D’Annunzio, al di là della sua esistenza, della sua condotta e del suo agire politico, ci ha lasciato
uno stupendo affresco dell’Italia e dell’Europa dei suoi tempi che, per modernità, ancora oggi ci
lascia stupiti. Attraverso le sue sperimentazioni e la sua capacità creativa ha forgiato opere sempre
nuove e molteplici, mettendo in luce i vari aspetti dell’uomo.
E quindi dico a tutti gli scenografi e ai registri teatrali di riproporre D’Annunzio con più frequenza
sui palcoscenici, di lasciare che il pubblico torni a godere dei suoi drammi, molti dei quali sono stati
spesso fraintesi o sottovalutati. E, quello che più di tutto è importante, di superare certi falsi miti,
certi tabù, certi pregiudizi, perché non è giusto che tanta bellezza venga dimenticata.
Bibliografia
D’Annunzio- Tutto il teatro (voll. 1 e 2), a cura di Giovanni Antonucci, Roma, Newton & Compton
editori, 1995. Introduzione di G. Antonucci e G. Oliva.
Antonucci e Gianni Oliva.” Roma, Newton & Compton editori, 1995.
G. D’Annunzio, Il Fuoco, Milano, Oscar Mondadori, 1981. Introduzione di G. Ferrata.
G. D’annunzio, Fedra, Roma, Oscar Mondadori, 2001. Introduzione di Pietro Gibellini; note a c. di
Tiziana Piras.