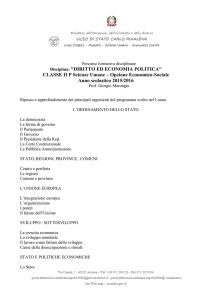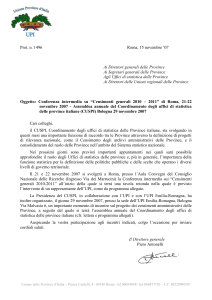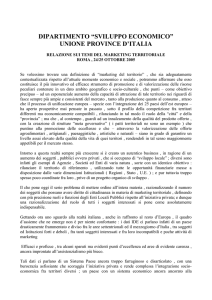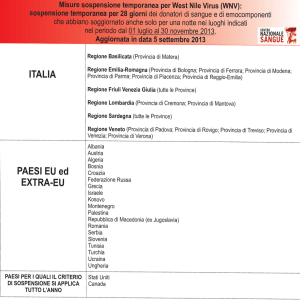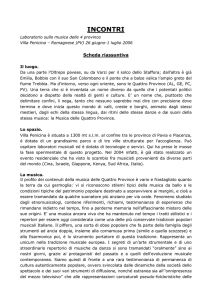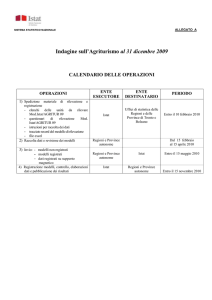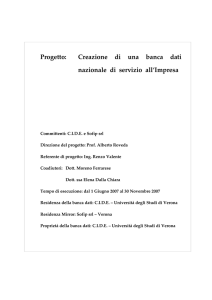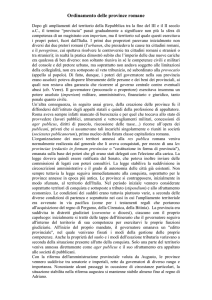1
Apologie / Enti locali e storia nazionale
Le sette vite della Province
Periodicamente date per morte, accusate di essere un centro di sperpero del denaro pubblico, le
Province hanno dietro di sé storie e ragioni che affondano le proprie radici lontano nel tempo. Dal
Rinascimento al Risorgimento molte provincie attuali trovano nel passato remoto l’origine dei
propri confini e della propria diversità. Una delle ricchezze della storia italiana che andrebbe meglio
conosciuta
di Aldo A. Mola
Come i gatti, in Italia le Province hanno sette vite. Da decenni se ne annuncia la cancellazione,
eppure vegetano e si moltiplicano. Perché? Perché arrivano da lontano. Il segreto della loro vitalità
non sono solo i voraci interessi locali che vorrebbero una università, un ospedale, un tribunale ecc.
ecc. per ogni abitante e all’incontrollabile deriva verso l’elefantiasi burocratica. In realtà le province
reggono al logorio del tempo proprio perché arrivano da lontano, dall’antica Roma. Più ancora: esse
rispondono a geografia, antropologia e storia profonda. Con varie denominazioni sono presenti in
tutti gli Stati europei, che a loro volta, del resto, altro non sono che circoscrizioni politicoamministrative sorte, ornate di simboli e tradizioni, con varia fortuna lungo i millecinquecento anni
dalla decomposizione dell’Impero romano. Non a caso, proprio quando più forte rullò il tamburo
che ne presagiva la fine le province hanno dato un colpo di reni. L’11 settembre 2008, nel quadro di
attuazione del federalismo fiscale, il governo ha adottato la proposta del ministro Roberto Calderoli
(Lega Nord) di riconoscere alle province autonomia di entrate e di spesa con imposizione di tributi
propri e partecipazione ai fondi perequativi. Sette grandi province verranno elevate ad “aree
metropolitane”. Si riapre il braccio di ferro tra province e regioni, specialmente quelle a statuto
speciale che per difendersi e riaffermarsi pagano il prezzo all’ente rivale e istituiscono “province
regionali” (con un aumento di spese da molti considerato preoccupante).
Le province odierne presero corpo con la legge Rattazzi del 23 ottobre 1859 n. 3702. Il “Piemonte”
non era più regno di Sardegna ma rimaneva lontano dall’immaginare che appena un anno dopo
sarebbe divenuto “d’Italia”. Tra aprile e luglio Vittorio Emanuele II di Savoia e Napoleone III,
imperatore dei Francesi, avevano sconfitto l’imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo
costringendolo all’armistizio di Villafranca. Vienna avrebbe ceduto la Lombardia (meno il distretto
di Mantova) a Napoleone III che a sua volta l’avrebbe assegnata al re di Sardegna in cambio della
Savoia, francofona, e della contea di Nizza, innegabilmente liguro-piemontese come
veementemente protestò Giuseppe Garibaldi, che vi era nato e divenne straniero. Fautore dello
scambio, il Conte di Cavour si dimise in totale dissenso con la linea del Re, a ben vedere saggia
come quando si è costretti alla prudenza. Il sovrano lo sostituì col fedelissimo Alfonso La Marmora,
affiancato da Urbano Rattazzi all’Interno. Poiché durava lo stato di guerra, il governo agì con pieni
poteri. Varò molte leggi durevoli, a conferma che, libero dalle pastoie di estenuanti dibattiti
parlamentari, l’esecutivo sa fare meglio del legislativo. Tra i tanti provvedimenti adottati spiccano
la riforma della scuola dalle elementari all’Università, varata dal milanese conte Gabrio Casati,
ministro dell’Istruzione pubblica, e, appunto, la legge su comuni e province.
In Piemonte le province risalivano al 1561, quando Emanuele Filiberto, vincitore sui francesi a San
Quintino (1557), tornò a governare il Ducato, riorganizzandolo da cima a fondo: un’opera
accelerata col trasferimento della capitale da Chambéry a Torino e con l’adozione dell’italiano
quale lingua ufficiale dello Stato. Le province ricalcavano antiche ripartizioni del territorio,
rispondenti al passaggio di contee e marchesati dall’ordinamento romano a quello medievale,
ritagliato sulle caratteristiche dei territori anche se con qualche bizzarria, relitto del cammino
2
storico. Per esempio la provincia di Saluzzo ereditò i confini dell’antico Marchesato (1100-1548),
che però aveva feudi nelle Langhe (Dogliani, Castiglion Falletto: terre di vini già famosi) mentre
dal 1511 la sua diocesi si estense molto oltre i suoi confini amministrativi, come del resto valeva, e
vale, per l’arcidiocesi di Torino, a tacere di quelle di Milano e di Napoli. Anche gli altri Stati
italiani, piccoli e grandi, avevano ripartizioni analoghe, con ordinamenti frutto della stratificazione
determinata da processi caratterizzati da ritmi discontinui e difformi. Il 1° maggio 1816 re
Ferdinando I delle Due Sicilie divise il regno in 16 province “al di qua del Faro” e un anno dopo
ripartì le tre Grandi Valli di Mazara, Noto e Demòne in sette Valli minori (simili alle province
continentali). Provvedimenti analoghi vennero introdotti in Lombardia dal 1815, nel Veneto, nei
Ducati e nel Granducato di Toscana che ebbe sette prefetture e quattro sottoprefetture. Dopo il
trauma della Repubblica Romana del 1849, lo Stato Pontificio venne riorganizzato in quattro
legazioni comprendenti venti province o delegazioni, 45 distretti, 177 governi e 1220 comuni. Alla
radice la circoscrizione amministrativa in tutti gli Stati rimase il Comune. Dopo l’annessione di
Roma e del Lazio al Regno d’Italia (proclamato il 17 marzo 1861) se ne contavano circa 8.381, poi
cresciuti a 10.154 dopo l’annessione di Trento e Trieste, ma poi sfoltiti dal governo Mussolini che li
ridusse a 7.300 aggregando molti piccoli comuni e creando circoscrizioni comunali allargate.
Il cammino più coerente e armonico delle province fu quello del ducato e poi regno sabaudo.
Quando venne annesso alla Repubblica Francese (1798) il suo territorio “di terraferma” fu
riorganizzato in dipartimenti, suddivisi in arrondissements (circondari), cantoni e comuni,
rispettivamente governati da prefetti, sottoprefetti e maires (sindaci). La cesura tra il nuovo e
l’antico fu accentuata perché, come già in Francia, i dipartimenti presero nome dai fiumi, o da
eventi famosi. La provincia di Torino divenne Dipartimento dell’Erìdano, antico nome del Po;
Vercelli prese nome dalla Sesia, Cuneo dalla Stura, Alessandria dalla vittoria napoleonica sugli
asburgici a Marengo (giugno 1800). Cairo Montenotte, in posizione strategica sull’Appennino
liguro-piemontese dette nome alla provincia di Savona in ricordo della prima vittoria di Napoleone
sull’Armata sarda nel 1796. Anche i dipartimenti del Regno d’Italia (Lombardo-veneto e oltre)
presero nomi dalla geografia. Milano, la città di Sant’Ambrogio e Ludovico il Moro, gloriosa di
storia, divenne capoluogo del dipartimento dell’Olona. Dopo l’annessione all’Impero, Roma
degradò a dipartimento del Tevere, mentre Firenze fu dipartimento dell’Arno. Per imporsi, la
“rivoluzione” mirò a destoricizzare. Utilizzò la geografia per sradicare la memoria del passato e
sostituirla con la gloria presunta del presente. La datazione ebbe inizio dall’avvento della
repubblica, poi dall’autoincoronazione di Napoleone. Illusioni di breve durata…
Dopo la Restaurazione del maggio 1814, Vittorio Emanuele I spazzò via le denominazioni francesi
e riorganizzò il regno in tre intendenze generali (Torino, Chambéry e Genova), varie intendenze e
sottointendenze affidate a alti funzionari di nomina regia, come i sindaci a capo dei comuni, assistiti
da consigli comunali ordinari e raddoppiati in vigore dal 1775 e integrati da un consiglio aggiunto
dai poteri più ampi rispetto a quello ordinario. Una babele che accontentava e complicava. Nel 1826
Carlo Felice stabilì che i consigli ordinari e i segretari comunali erano nominati dal Re o dagli
intendenti. In tal modo ne ridusse ne l’autonomia. Il suo successore, Carlo Alberto di SavoiaCarignano, suo parente di tredicesimo grado, nel 1847 istituì libertà di stampa ed elettività dei
consigli comunali, provinciali e divisionali: circoscrizioni istituite dal 1842 e più volte riformate. Le
divisioni corrispondevano ai dipartimenti e le province agli arrondissements di età napoleonica.
Esse ebbero a capo intendenti e viceintendenti. Pochi mesi dopo, lo Statuto del 1848 istituì la
monarchia rappresentativa: con un Senato di nomina regia e vitalizio e una Camera eletta a
suffragio ristretto (4 marzo 1848). Il 23 marzo 1848 il Regno di Sardegna scese in guerra contro
l’Impero d’Austria. L’8 maggio venne eletta la Camera mentre aveva luogo la prima “infornata” di
senatori. Invece le elezioni dei consigli comunali, provinciali e divisionali furono rinviate a
novembre. I primi, presieduti da sindaci di nomina regia affiancati da vicesindaci nominati
dall’intendente, operarono col concorso di assessori effettivi e supplenti. I consigli provinciali
3
elessero i loro presidenti, ma il potere effettivo su delibere e amministrazione rimase nelle mani dei
viceintendenti. Lo stesso avvenne nei consigli divisionali, che elessero i presidenti mentre gli
intendenti presiedevano la deputazione, che era elettiva ma veniva controllata a vista
dagl’intendenti, che del resto erano persone di grande preparazione. In seno alle deputazione essi
non avevano potere di voto, ma di veto sì.
Tra sindaci e assessori locali, consiglieri provinciali e divisionali, deputati provinciali
(corrispondenti agli assessori odierni), deputati alla Camera e senatori si innescò un circolo virtuoso
che vide un alto numero dei dirigenti elettivi passare dall’una all’altra carica. A quel modo si formò
un ceto politico-amministrativo di ampia e collaudata esperienza, favorito da eventi apparentemente
contradditori. La Camera subalpina, l’unica sopravvissuta al fallimento della Prima guerra
d’Indipendenza (1848-49), venne sciolta e rieletta tre volte in cinque anni mentre si susseguirono
otto diversi governi in soli quattro anni (ministeri Balbo, Casati, Alfieri, Perrone, Gioberti, Chiodo,
de Launay e Azeglio). Essi fecero ruotare decine di persone in posizioni di responsabilità eminenti.
Anziché incidere negativamente quel turbinio fece emergere valori veri, personalità di spicco come
Camillo Cavour, Urbano Rattazzi, Alfonso La Marmora, Carlo Boncompagni, Giovanni Durando,
Massimo d’Azeglio... Nel decennio seguente si moltiplicarono i progetti di riforma dei consigli
comunali e provinciali. Tra i più interessanti vi fu quello di Gustavo Ponza di san Martino, ministro
dell’Interno con Cavour, già intendente generale a Genova, studioso di amministrazione locale sulla
scia di Pietro de’ Rossi di Santa Rosa, il ministro al quale l’arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni,
aveva negato il viatico della buona morte perché membro del governo che aveva varato le “leggi
Siccardi” che abolirono il foro separato per gli ecclesiastici colpevoli di reati comuni e
confiscarono per pubblica utilità i beni degli ordini religiosi contemplativi. Perno della riforma di
Ponza erano i poteri del governatore (ex intendente) cui spettava il controllo della vita politica e
della forza militare per assicurare l’ordine pubblico, sul modello dei prefetti francesi.
Alla vigilia dell’unità il regno di Sardegna aveva quindi di fronte a sé due vie: l’esempio della Gran
Bretagna, ispirato da ampie autonomie locali, e quello della Francia che da Luigi XIV a Napoleone
aveva imposto il potere centrale su quelli locali utilizzando la macchina di intendenti e prefetti che
erano “prefetti di polizia”, cioè pronti a utilizzare la forza pubblica per imporre l’ordine. Il governo
piemontese e poi italiano imbocco una terza via, ispirata all’esperienza del Regno dei Belgi: meno
centralistica ma al tempo stesso guardinga nei confronti di camarille locali use a spacciarsi come
alfieri delle libertà. Dopo un lungo braccio di ferro tra la coalizione liberaldemocratica (il centrosinistra di Cavour e Rattazzi) e i conservatori e clericali (Clemente Solaro della Margarita, Ottavio
Thaon di Revel, don Giacomo Margotti che dalle colonne del giornale “Armonia” sparava a zero
contro la maggioranza governativa) la riforma Rattazzi voltò pagina. I comuni superiori a 30 mila
abitanti eleggevano consigli di 30 membri, con durata quinquennale, che si radunavano
ordinariamente due volte l’anno e votavano la giunta (sei assessori effettivi e due supplenti); il
sindaco nominato dal re per un triennio ed era confermabile se rieletto consigliere.
Nelle Province (nuova denominazione delle Divisioni), ripartite in circondari (ex province), il
potere esecutivo era rappresentato dal governatore, poi prefetto, anziché dall’intendente. Le
province con popolazione superiore ai 500 mila abitanti eleggevano un consiglio di 60 membri, che
a sua volta votava il presidente e la deputazione, presieduta dal governatore (o prefetto) che
conservava potere di veto ma non di voto. La riforma giunse in un buon momento: l’ordinamento
Rattazzi venne infatti esteso alle terre via via annesse, dalla Lombardia ai Ducati padani, alle
legazioni pontificie, Granducato di Toscana e, dopo la debellatio del regno delle Due Sicilie e
l’occupazione di Umbria e Marche, all’Italia centro-meridionale. In tal modo il re, il governo
tramite il Ministro dell’Interno e la macchina dei governatori (prefetti) ebbe il controllo dei sindaci
e delle deputazioni provinciali.
4
Nel 1888 il governo presieduto da Francesco Crispi, che tenne sempre per sé l’Interno come poi
fece il suo antagonista Giovanni Giolitti, varò la grande riforma degli enti locali, che rese elettivi i
sindaci delle città con più di 10 mila abitanti, mentre i consigli provinciali elessero il presidente
della deputazione, libera dal controllo diretto del prefetto, che rimase alla testa della neonata giunta
provinciale amministrativa, organo di controllo di legittimità delle delibere di province e comuni:
un filtro importante per arginare l’avventurismo di amministrazioni che, più libere, in tanti casi
s’impegnarono in spese senza copertura. Del resto il governo si riservò sempre la facoltà si
sciogliere i consessi locali e di sostituire sindaci e presidenti con commissari regi e prefettizi. Nel
1915 venne varato il testo unico degli enti locali. Nel 1920 si svolsero elezioni che vararono con
successo blocchi moderati per contenere l’avanzata di socialisti ed estremisti. Grazie al loro sistema
di elezione (ogni consigliere era eletto in un mandamento: e questo favoriva alleanze di moderati)
le province si rivelarono più refrattarie dei comuni al vento dei partiti di massa e del cambiamento
impresso dal Partito nazionale fascista dopo l’avvento di Benito Mussolini alla presidenza del
consiglio dei ministri. Dopo la schiacciante vittoria elettorale dell’aprile 1924, in cui ottenne circa il
66,6 % dei consensi e due terzi dei seggi, il governo centrale procedette per gradi. Con la legge 4
febbraio 1926 n. 237 i sindaci dei comuni inferiori ai cinquemila abitanti vennero sostituiti da
podestà di nomina prefettizia, eventualmente assistiti da una consulta sostitutiva del consiglio
comunale elettivo. Con legge 3 settembre 1926 n. 1910 l’ordinamento podestarile venne esteso a
tutti i comuni del regno senza che la vita dei comuni ne risentisse negativamente. Anzi, per
razionalizzare l’amministrazione locale e ridurne il costo il governo avviò l’accorpamento dei
comuni minori e promosse l’avvento di circoscrizioni comunali di grande estensione. Altrettanto
avvenne con le province. Nel 1927 i consigli provinciali non ancora commissariati furono sciolti e
sostituiti da commissioni reali alla cui testa venne insediato un prèside assistito da commissari. In
secondo tempo alle Commissioni reali subentrarono i Rettorati, con prèsidi, vicepresidi e rettori:
notabili, alti ufficiali in congedo o magistrati a riposo, ex parlamentari, senatori, professionisti,
notabili, che prestarono la loro opera senza remunerazione, per mero sevizio verso la pubblica
amministrazione, e quindi la Patria, come del resto avveniva per i presidenti e i consigli di
amministrazione di casse di risparmio, istituti bancari (per esempio il San Paolo di Torino), banche
popolari e di interesse pubblico.
Alla caduta del Fascismo, molti ritennero che le province fossero da cancellare. Al tempo stesso
Luigi Einaudi lanciò la famosa (e vana oltre che improvvida) parola d’ordine: “Via il prefetto!”.
Iniziò l’età delle regioni, che però s’affacciarono subito con vesti preoccupanti: gli statuti speciali.
Il 4 aprile 1944 il nuovo governo Badoglio, che governava con decreti, varò il regio decreto legge
che ripristino il testo unico del 1915 cancellando (ma solo in parte) quello del 1934. Nel 1946 i
consigli comunali furono eletti a suffragio universale maschile e femminile. Il 2-3 giugno venne
eletta l’Assemblea chiamata a varare la Costituzione della Repubblica nata dal discusso referendum.
I consigli provinciali rimasero nelle mani di commissari nominati dai comitati provinciali di
liberazione nazionale in attesa che ne fosse chiarita la sorte. Molti le dettero per spacciate. Invece
nel 1951 esse riemersero con l’elezione di consigli che a loro volta sceglievano il presidente, a capo
della giunta provinciale, elettiva. Rimasero in vita sia le giunte provinciali sia i poteri di
scioglimento dei consigli locali. Tale ordinamento durò nei vent’anni successivi al varo delle
regioni a statuto ordinario, nei cui consessi entrarono molti ex presidenti e assessori provinciali,
forti di lunga esperienza di amministrazione locale. Con la legge 8 giugno 1990 n. 1248 da enti
autarchici territoriali, quali erano stati definiti in età fascista e durati in seguito, le province
divennero istituti di partecipazione e furono chiamati a darsi uno statuto. La legge 23 marzo 1993 n.
81 introdusse l’elezione diretta del presidente della provincia, con potere di designazione della
giunta, mentre il presidente del consiglio venne eletto dai consiglieri. Anziché estinguersi le
province crebbero di numero, sovente con articolazioni territoriali sconcertanti.
Ora sono quasi il doppio rispetto alla proclamazione del Regno e nulla ne lascia presagire il
tramonto anche se si moltiplicano le proposte di loro scioglimento o riorganizzazione funzionale.
5
Proprio perché rispondono alla storia profonda del Paese e ne rispecchiano la complessità le
province sono state trascurate dalla storiografia. Perciò oggi disponiamo di alcune storie di singole
province ma manca un’opera d’insieme, a conferma dello strabismo della storiografia accademica e
non. Se davvero il 150° dell’unità nazionale volesse dare un segnale di vita potrebbe cimentarsi
nella sua realizzazione o quanto meno avviarla in modo organico.
Aldo A. Mola
BOX
Le province in cifre.
Tre province con più di tre milioni di abitanti (Roma, Milano e Napoli) hanno consigli elettivi di 45
membri e 12 assessori; 20 contano fra 700 mila e tre milioni di abitanti ed hanno consigli di 36
membri e 12 assessori; 49 province hanno fra 300 e 700 mila abitanti, con consigli di 30 membri e
giunte di 10 (alcune di esse, come Barletta-Andria-Trani e Forlì-Cesena sono di recente
istituzione); infine 38 province hanno meno di 300 mila abitanti, con 24 consiglieri (25 nelle
province siciliane) e otto assessori. Tra queste ultime si contano le province di recente istituzione.
Alla proclamazione del regno (17 marzo 1861) le province erano 59; salirono a 69 dopo
l’annessione di Mantova, del Veneto (1866) e di Roma (1870). Crebbero a 76 con l’acquisizione del
Trentino e della Venezia Giulia. Nel 1924 sorsero le province di Fiume, Pola e Zara. Con regio
decreto legge del 2 febbraio 1927 n. 1, il governo Mussolini istituì 17 nuove province (Aosta,
Vercelli, Varese, Savona, Bolzano, Gorizia, Pistoia, Pescara, Rieri, Terni, Viterbo, Frosinone,
Brindisi, Matera, Ragusa, Castrogiovanni, poi Enna, e Nuoro). Seguirono quelle di Littoria (1934),
Asti (1935) e Lubiana (1941). Nel 1945 la Provincia di Aosta divenne regione; Littoria venne
denominata Latina; le province di Istria e Carnaro vennero cedute alla Iugoslavia. Da 92 le province
crebbero a 95 con l’istituzione delle consorelle di Pordenone, Isernia e Oristano, cui nel 1992 si
aggiunsero quelle di Verbano-Cusio-Osola, Biella, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo
Valentia. Nel 2001 in Sardegna sorsero le province regionali di Olbia,Tempio, Oglistra, Medio
Campidano e Carbonia-Iglesias. Con l’istituzione delle province di Monza e Brianza, Fermo e
Barletta-Andria-Trani alla vigilia del 150° anniversario dell’Unità d’Italia le province sono 110. Il
23 ottobre 2009 la presidente della Provincia di Cuneo, Gianna Gancia (Lega Nord), la più giovane
d’Italia, ha rievocato il 150° della nascita delle Province varando un importante ciclo di iniziative
storiografiche, culturali e popolari.