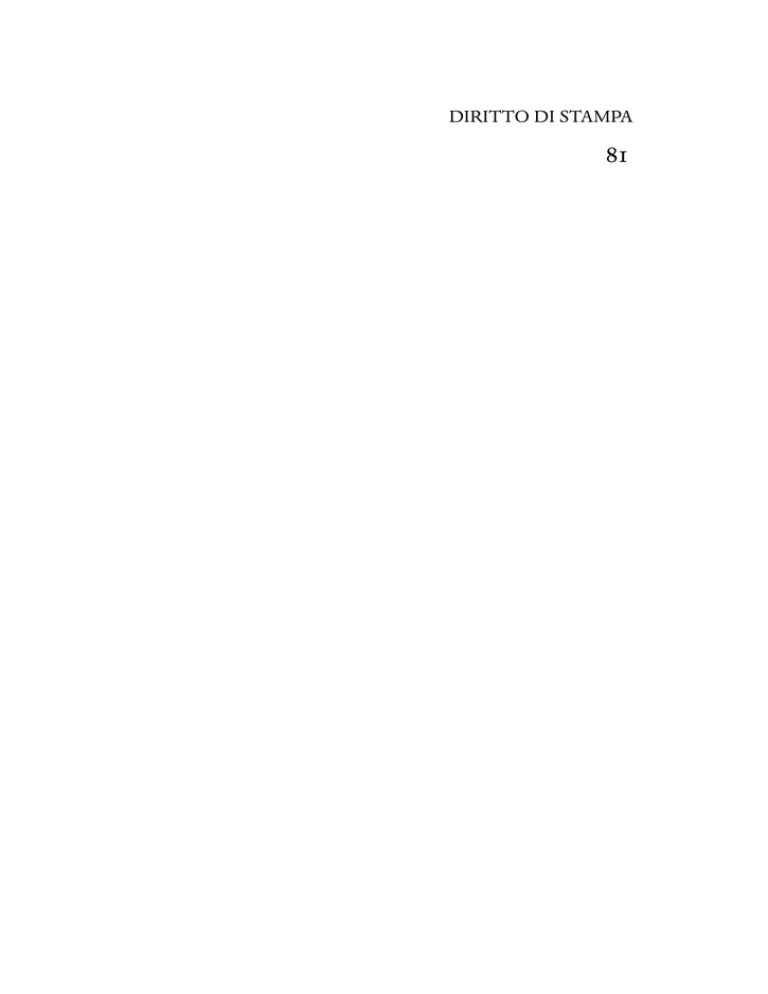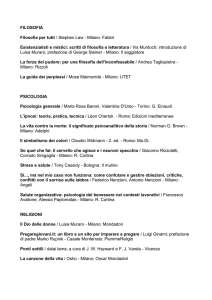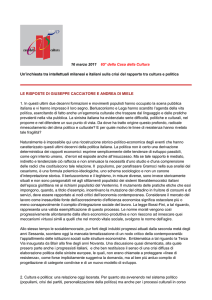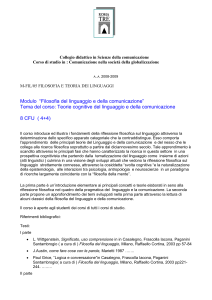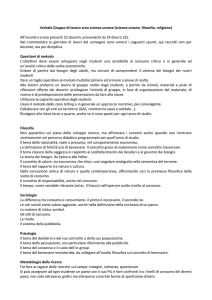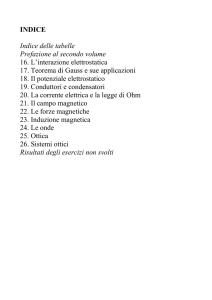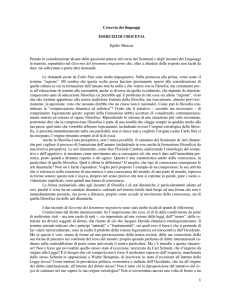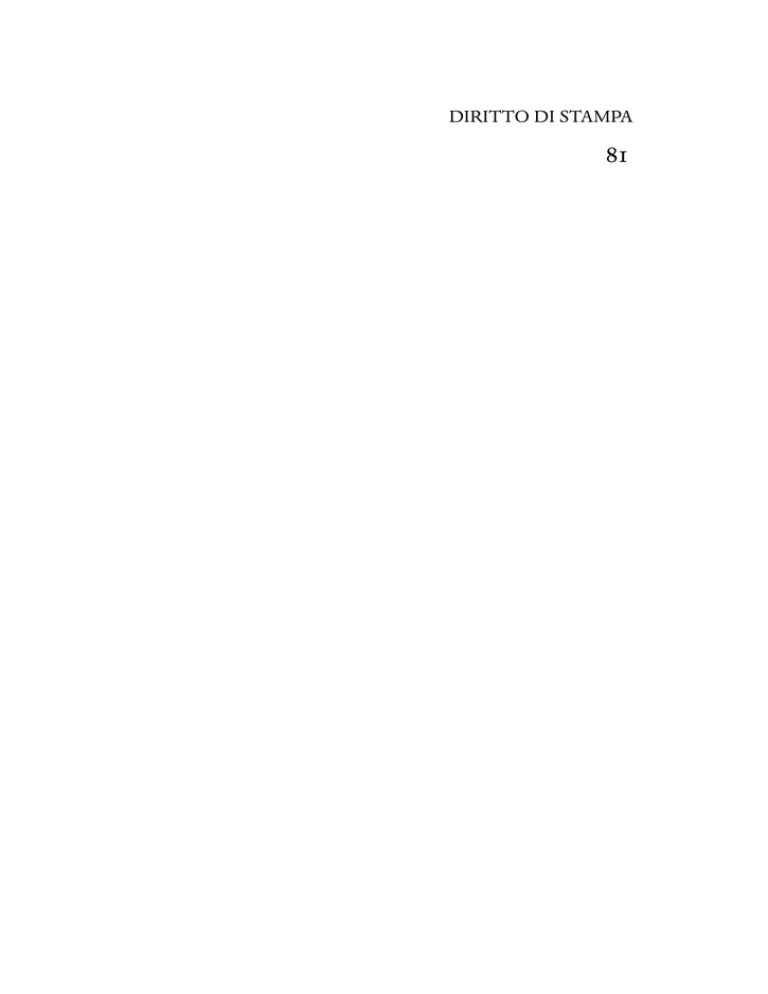
DIRITTO DI STAMPA
DIRITTO DI STAMPA
Il diritto di stampa era quello che, nell’università di un tempo, veniva a meritare
l’elaborato scritto di uno studente, anzitutto la tesi di laurea, di cui fosse stata
dichiarata la dignità di stampa. Le spese di edizione erano, budget permettendo, a
carico dell’istituzione accademica coinvolta. Conseguenze immediate: a parte la
soddisfazione personale dello studente, del relatore e del correlatore, un vantaggio
per il curricolo professionale dell’autore, eventuali opportunità di carriera accademica e possibili ricadute positive d’immagine per tutti gli interessati. Università
compresa.
La dignità di stampa e, se possibile, il diritto di stampa erano quindi determinati dalla cura formale della trattazione, dalla relativa novità del tema di studio,
dall’originalità del punto di vista e magari dai risultati “scientifici” della tesi: e
cioè quel “vuoto” che, in via di ipotesi, si veniva a riempire in un determinato
“stato dell’arte”, e dunque dal valore metodologico, anche in termini applicativi,
della materia di studio e dei suoi risultati tra didattica e ricerca. Caratteristica del
diritto di stampa, in tale logica, la discrezionalità e l’eccezionalità. La prospettiva di
contribuire, così facendo, alla formazione di élites intellettuali. Sulla scia di questa
tradizione, e sul presupposto che anche l’università di oggi, per quanto variamente
riformata e aperta ad un’utenza di massa, sia pur sempre un luogo di ricerca,
nasce questa collana Diritto di stampa. Sul presupposto, cioè, che la pubblicità
dei risultati migliori della didattica universitaria sia essa stessa parte organica e
momento procedurale dello studio, dell’indagine: e che pertanto, ferme restando
la responsabilità della scelta e la garanzia della qualità del prodotto editoriale, il
diritto di stampa debba essere esteso piuttosto che ridotto. Esteso, nel segno di un
elevamento del potenziale euristico e della capacità critica del maggior numero
possibile di studenti. Un diritto di stampa, che però comporta precisi doveri per la
stampa: il dovere di una selezione “mirata” del materiale didattico e scientifico a
disposizione; il dovere di una cura redazionale e di un aggiornamento bibliografico
ulteriori; il dovere della collegialità ed insieme dell’individuazione dei limiti e delle
possibilità dell’indagine: limiti e possibilità di contenuto, di ipotesi, di strumenti,
di obiettivi scientifici e didattici, di interdisciplinarità. Un diritto di stampa, che
cioè collabori francamente, in qualche modo, ad una riflessione sulle peculiarità
istituzionali odierne del lavoro accademico e dei suoi esiti.
Questa Collana, dunque, prova a restituire l’immagine in movimento di un
laboratorio universitario di studenti e docenti. E l’idea che alcuni dei risultati più
apprezzabili, come le tesi di laurea prescelte, possano mettersi nuovamente in
discussione mediante i giudizi e gli stimoli di studiosi competenti.
Chiara Fornasiero
Il coraggio dell’adulto nel fidarsi del bambino
Ritornare bambini a partire dal pensiero di Igor Sibaldi
Prefazioni di
Luigi Vero Tarca
Laura Candiotto
Copyright © MMXV
ARACNE editrice int.le S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Quarto Negroni,
Ariccia (RM)
()
----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: gennaio
A Laura C. e Riccardo M.
che mi hanno dato la fiducia
e il coraggio per scrivere questo testo
e a chi mi ha consigliato di pubblicarlo
Indice
9
Prefazione
di Luigi Vero Tarca
19 Prefazione
di Laura Candiotto
25 Introduzione
33
Capitolo I
Quale bambino?
1.1. Un tema filosofico?, 33 - 1.2. Semplici difficoltà, 35 1.3.I bambini nella Bibbia. Principali passi biblici
considerati, 38 - 1.4. Quanti anni hai bambino?, 41 - 1.5.
Bambino o bambini?, 47 - 1.6. Bambino o bambina?, 49 1.7. L'errore del “bambino concreto”, 51 - 1.8. Igor Sibaldi
filosofo?, 58 - 1.9. Caratteristiche del bambino in Sibaldi,
62.
67
Capitolo II
La fiducia del bambino
2.1. Le pulizie dell'anima, 67 - 2.2. L'accorgersi, 78 - 2.3
Gli altri siamo noi, 97 - 2.4. Cattivi bambini, 107 - 2.5. I
lacci del passato, 116.
125 Capitolo III
Il pensiero del cuore
3.1. Il problema delle emozioni nel “ritornare bambini”, 125
- 3.2. Il sentire del cuore bambino, 127 - 3.3. Il senso della
7
felicità, 133 - 3.4. Il desiderio del bambino, 144 - 3.5. Il
volere, 149 - 3.6. Il verbo chiedere, 156 - 3.7. Un'ipotesi di
conciliazione, 160.
173 Capitolo IV
In intimità con la realtà
187 Conclusione
193 Bibliografia
201 Indice dei nomi
Prefazione
di Luigi Vero Tarca
Il coraggio di “pensare” il bambino.
La filosofia si dice in molti modi. E la si fa, in molti modi. Non solo il contenuto, ma anche i suoi metodi – e quindi lo stile/gli stili del
fare filosofia – si declinano ormai secondo una pluralità praticamente
illimitabile e con una multiformità fino a ieri impensabile. Oggi il tradizionale rigore del pensare concettuale viene prevalentemente inteso
– a torto o a ragione (per la verità forse spesso più a torto che a ragione) – come una sorta di rigor mortis, così che si conclude che la vita
del pensiero esige altre forme di manifestazione, diverse da quelle logiche e razionali. Del resto ogni forma di vita ha una sua coerenza e
una sua forma di esattezza, quindi pure di rigore, anche laddove questo venga ad assumere forme diverse da quelle consuete. E anche gli
oggetti e i contenuti del pensare filosofico possono essere imprevedibilmente diversi da quelli tradizionali ai quali siamo avvezzi.
Ora, mentre è scontato per tutti che se parliamo dell’essere stiamo
facendo filosofia, qualcuno potrebbe mettere in dubbio che un discorso che riguarda i bambini, e addirittura il “ritornare bambini”, sia propriamente filosofico. E in questo senso ci vuole davvero un certo coraggio nel presentare un discorso che richiede ai filosofi, proprio per
essere davvero tali, di “ritornare bambini”. Ci vuole coraggio; tuttavia
l’apertura che caratterizza programmaticamente la ricerca filosofica
attuale non solo ci consente, ma in qualche misura addirittura ci impone di raccogliere la proposta, anche se naturalmente non ci esime dal
compito di esplorare anche tale problema da un punto di vista filosofico in un senso più tradizionale.
9
10
Prefazione
Il lavoro di Chiara Fornasiero, che qui presentiamo, ci mostra appunto come un discorso riguardante un tema così “infantile”, quindi
apparentemente molto lontano dalla “serietà” e dalla “gravità” tipica
della speculazione filosofica, possa essere ricco non solo di spunti e di
riferimenti filosofici, ma di vere e proprie aperture di pensiero. Perché
– tanto per stare a un caso paradigmatico e abbastanza facile – proprio
il dischiudersi di uno sguardo nuovo sull’essere bambino ci consente
forse di comprendere meglio qual è davvero la posta in palio quando,
seguendo lo Heidegger di Essere e tempo, comprendiamo la necessità
di liberarci dal “si dice”, cioè dall’impersonalità del “man”. “Man”
che, se trasferito dalla lingua tedesca in quella inglese – appellandoci a
quella che potremmo chiamare una licenza infantile, anziché poetica
(cosa che qui ci sentiamo autorizzati a fare) – ci mostra come, seguendo in particolare la lezione della Luce Irigaray, la dittatura
dell’impersonale copra il maschilismo della nostra tradizione; osservazione che – mi permetto di aggiungere – è profondamente connessa
alla scoperta, caratteristica del pensiero contemporaneo, che dietro la
neutralità dell’impersonale si nasconde l’imposizione dell’apparato
epistemico (di quel Gestell di cui ci parla ancora Heidegger ma in un
periodo successivo, quello della Questione della tecnica) nel quale
culmina la storia della episteme (epì−histemi).
Ma queste parole rischiano di fornire un’impressione errata del libro che stiamo proponendo. In esso non si parla, se non di sfuggita o
implicitamente, di Heidegger e delle questioni filosofiche da lui sollevate. Ma qui, in questa Prefazione, è opportuno ricordare come, quando si parla di bambini – e nel libro si parla proprio dell’essere bambino – se ne parli secondo un modo di dire che ha alle spalle, o, meglio,
che ha metabolizzato le esperienze del pensiero filosofico contemporaneo. Si tratta, insomma, di un discorso che, nella sua apparente semplicità e addirittura a volte nel suo “infantilismo”, come qualcuno potrebbe forse dire, è pienamente all’altezza della problematica filosofica attuale. Perché, per limitarci a un esempio significativo,
l’indeterminatezza che connota la figura del bambino (cosa che emerge in particolare dalla prima parte dello scritto) non è conseguenza di
una imprecisione gnoseologica, non è sintomo di una immaturità epistemologica, è invece espressione di una piena consapevolezza della
dimensione metaforica, e del valore simbolico, di tale nozio-
Prefazione
11
ne/esperienza. E allora questi tratti, queste “im−precisioni”, costituiscono un valore aggiunto al pensiero che si sta cercando di proporre,
piuttosto che un difetto o un limite del discorso svolto.
L’indeterminatezza della nozione di bambino, e dell’esperienza del
bambino, esperienza alla quale ci si dovrebbe convertire – perché appunto questo, cioè la necessità di ritornare bambini, è l’assunto fondamentale del libro – lungi dall’essere una mancanza di esattezza, è
qualcosa che nasce dalla consapevolezza di che cosa comporti quella
sorta di estensione universale del principio di indeterminazione che
oggi pare inevitabile1. L’esperienza del bambino è indefinibile e incatturabile (il bambino non è captivus, perché non può essere imprigionato nelle nostre gabbie mentali, ed è anche per questo che non è cattivo)
giacché il nostro stesso rapportarci ad essa modifica la nostra, di esperienza, e in una maniera tale che ciò trasforma complessivamente noi
stessi e il nostro approccio alla realtà. Questa sorta di radicale circolo
ermeneutico costituisce qualcosa di molto vicino all’esito finale
dell’esperienza che emerge dalla lettura di questo libro: l’apertura alla
dimensione del bambino rappresenta l’apertura di un’esperienza di illimitata libertà.
Anche in riferimento a questo punto il riferimento alla più alta speculazione filosofica è tutt’altro che fuori luogo, nel momento in cui
(qui sto pensando in particolare a Hegel) la libertà – ma cioè oggi, in
un contesto inevitabilmente planetario e quindi anche capace di fare i
conti con la sapienza orientale, la liberazione (il mok܈a) – viene vista
come il culmine dell’esperienza umana e quindi come la piena realizzazione dello spirito. Solo che qui, nel nostro libro, si scorge che questo compimento – cioè il raggiungimento di questo vertice dello Spirito – può avvenire solo grazie al fatto di ritornare bambini: solo lo spirito del bambino può essere davvero “assoluto”.
Del resto, da questo punto di vista la sapienza “filosofica” si viene a
trovare in compagnia di quella sapienziale in genere e in particolare di
quella religiosa. Nei Vangeli Gesù, il Maestro, invita a lasciare che i
pargoli vadano a lui (frase celebre, anche troppo); insegnamento che
viene ribadito nel momento in cui si dice che chi non diventerà come
1
Non, cioè, relativo solo all’ambito della fisica, come ci ha insegnato Werner Heisenberg.
12
Prefazione
un bambino non entrerà nel Regno dei Cieli. Ma anche da Oriente
giunge un messaggio simile, per esempio quando Shunryu Suzuki ci
parla della Mente di Principiante (Beginner). Un messaggio dal quale
potrebbe forse scaturire una pedagogia, una Bildung che, piuttosto che
a un imparare e un insegnare basati sulla programmazione, potrebbe
mirare a uno sprogrammare e a un disimparare, forse Derrida direbbe
a un decostruire, tutto ciò che sappiamo.
Ma il parallelo tra l’esperienza del bambino e l’esperienza filosofica non finisce qui. Se il telos finale è la conversione “infantile”, è il
nostro ritornare ad essere bambini, i modi in cui questo può accadere
sono diversi, e i suoi aspetti sono molteplici. E innanzitutto una via
fondamentale è naturalmente la meraviglia, che, se già da Aristotele
(peraltro sulla scia di Platone) all’inizio della Metafisica viene identificata – tramite il termine thauma cui è legato il verbo thaumazein –
l’esperienza che sta all’origine del filosofare, ancora nella nostra epoca porta Wittgenstein, nella Conferenza sull’etica, a individuare nel
meravigliarsi per l’esistenza del mondo l’esperienza etica par excellence. Ma da sempre, poi, la filosofia è attenzione per ciò che è ovvio:
ciò che, essendo sempre sotto gli occhi di noi tutti, proprio per questo
non riusciamo a notare e quindi a vedere. Non a caso l’attenzione è la
prima delle vie che ci vengono indicate da Chiara Fornasiero, sulla
scorta del pensiero di Igor Sibaldi, per tornare a essere bambini.
L’attenzione viene qui intesa come la capacità di vedere le cose nella loro “ciascunità” (William James). E allora ci troviamo, di nuovo,
nel cuore della speculazione filosofica. Perché – aprendo così una parentesi nella quale fanno capolino i temi filosofici che mi sono stati
più cari in questi anni – attraverso la “ciascunità” entriamo in contatto
con quella dimensione nella quale comprendiamo che ogni cosa (essendo l’implicazione analitica dell’ogni, cioè il tutto, con la singola,
determinata cosa) è, alla lettera, ognicosa, cioè il Tutto assolutamente
concreto, proprio nel suo essere quella specifica, singolare determinazione che essa è. Il punto filosoficamente rilevante, in relazione a questo pensiero che ha in vista quella che possiamo chiamare onnitudine,
è che se il determinare equivale a un negare, allora il discorso che cerca di testimoniare la “ciascunità” (cosa che, abbiamo assunto, implica
pensare la “onnitudine”) viene ad essere contraddittorio. Perché, dovendo distinguere, in relazione a ognicosa, il suo essere ogni dal suo
Prefazione
13
essere quella determinata cosa che è, finisce inesorabilmente (a causa
appunto dell’assunzione che distinguere equivale a negare) per trasformare quell’“ogni” – in quanto contrapposto, appunto in forza della
differenza−negazione, alla determinata cosa con cui pure coincide – in
una cosa a sua volta de−terminata, la quale non è dunque
l’onnitudine: non è ciò che pure deve essere. Solo il pensiero della pura differenza (questa l’espressione che adotto per nominare questa peculiare aspetto della differenza) consente di distinguere, e quindi di
pensare in maniera coerente, tale onnitudine, e quindi anche la “ciascunità” di cui qui si parla. Da questo punto di vista si potrebbe allora
ben dire che se, da un lato, la filosofia della pura differenza viene a
presentarsi come un pensiero sostanzialmente “infantile”, dall’altro lato, per converso, ne consegue che solo un pensiero siffatto (cioè anche
così complesso, raffinato e addirittura, forse, “sofisticato”) consente di
realizzare quell’esperienza “infantile” di cui in questo libro si parla e
della quale la “sapienza universale” è da sempre in cerca.
L’esperienza che viene evocata in questo lavoro della Fornasiero
rimanda dunque a una situazione nella quale ciò che conta, per la filosofia, resta pur sempre (per prendere a prestito le parole di Kant) “il
cielo stellato sopra di me”, e magari anche “la legge morale dentro di
me” (comunque si debba poi intendere questa legge morale), ma è poi
anche, e soprattutto, la capacità di vedere tutte le cose del mondo nella
loro “infantile”, assoluta identità, ovvero autenticità (autós). E questo
vale, in maniera del tutto particolare e significativa, per quelle individualità particolari che sono le persone.
La filosofia diventa così – pur conservando tutta la ricchezza,
l’altezza e la forza della propria speculazione – l’esperienza autentica
della realtà viva che sperimentiamo “qui ed ora”. Essa si presenta in
tal modo come pensiero delle cose di tutti i giorni, pensiero del quotidiano, pratica filosofica dell’esistenza quotidiana. Certo, la speculazione filosofica, implacabile, può tornare alla carica, e chiedere: Ma
quali sono queste cose che hai di fronte? Quali “cose”, in verità, o in
realtà, popolano il mondo? Certo, questo è un problema, e non possiamo farcela facile, nel rispondere a queste domande. Ma chi ha detto, appunto, che il modo corretto di vedere le ‘cose’ non sia quello del
bambino, per il quale – per esempio – gli amici che egli incontra nel
14
Prefazione
gruppo non sono semplicemente i membri di un gruppo (o di una
“classe”, come esigono tanto il logico più raffinato quanto la più semplice maestra elementare), ma sono ciascuno un’individualità propria,
che certamente appartiene a un insieme organico, restando però pur
sempre un qualcosa che viene vissuto nella sua immediata, irriducibile
individualità. La pratica filosofica nella vita quotidiana, intesa come
esperienza di questa singolarità, può essere chiamata anche una “mistica del quotidiano”. Ma il richiamo a Raimon Panikkar (al suo insegnamento, infatti, si ispira questa formula) evoca un altro rimando,
quello alla “nuova innocenza” della quale ci parla il pensatore indo−catalano. La “nuova innocenza” è un altro nome del “ritornare
bambini”; un diventare bambini che però è un nuovo diventare bambini. Restando adulti. E va detto, allora, che lo scritto che presentiamo è
ben consapevole delle ambiguità che caratterizzano la figura del bambino, in quanto ricco anche di tutti i suoi aspetti dubbi o negativi: il
suo narcisismo, il suo egoismo, il suo essere un “perverso polimorfo”
(Sigmund Freud), e così via.
Ci vuole coraggio, dunque, ad avere fiducia nei bambini, ad affidarsi a loro (sempre stando a Panikkar, la fede è innanzitutto fiducia,
affidamento). Ma è una ‘fede’ che viene premiata. Perché si giunge in
tal modo a realizzare uno sguardo che non è “semplicemente infantile”,
ma è addirittura capace di “trasformare”, in una maniera che può apparire quasi magica, lo stesso negativo. Infatti uno sguardo puramente
infantile consente non solo di sopportare meglio la sofferenza, ma addirittura di renderla qualcosa di parzialmente diverso dal suo stesso
essere dotata di negatività; come accade addirittura – e se ne parla nel
libro – per i dolori del parto, i quali si trasformano quasi magicamente
in qualcosa di nuovo, addirittura in un’esperienza diversa da quella
dolorosa, se collocati all’interno di un diverso modo di pensare e
quindi di sperimentare la realtà.
E qui, di nuovo, ci troviamo nel cuore delle questioni filosofiche.
Perché se è vero – come ho cercato di mostrare in altri contesti filosofici – che uno dei problemi principali del pensiero contemporaneo
consiste nello sfidare l’ultimo dio che resiste alla decostruzione che ha
deposto tutti gli immutabili/innegabili, cioè la negazione, allora la vera sfida del nostro tempo, per il pensiero, è la capacità di guardare il
mondo con uno sguardo diverso da quello negativo. Sfida difficile, in
Prefazione
15
verità; perché: come trovare qualcosa di diverso dal negativo, dal
momento che anche il non negativo (in quanto negativo del negativo)
è negativo? Come trovare, dunque, qualcosa di diverso dal negativo se
proprio ciò che si ponesse come diverso dal negativo sarebbe, per ciò
stesso, non negativo e quindi (come abbiamo appena visto) a sua volta
negativo? Sfida che richiede la capacità di aprirsi al pensiero della pura differenza di cui sopra si diceva, e che costituisce dunque la condizione della possibilità di quella trasfigurazione del negativo di cui tra
le altre cose si parla in questo libro. Non solo in riferimento ai dolori
del parto, cui si è già accennato, ma per esempio anche laddove si mostra come persino il “fallimento” in cui consiste la presa d’atto dei propri errori possa presentarsi come qualcosa di positivo appunto perché
proprio tale autoconfutazione ci consente di liberarci dalla gabbia delle proiezioni che ci impediscono di entrare in contatto con la realtà autentica, di riconoscerla quale essa è in se stessa. Tale contatto riguarda
non solo la realtà a noi “esterna”, ma anche la realtà autentica del nostro stesso essere. Certo, nell’epoca attuale il compito di “liberare”
l’umano dal negativo del dolore e della morte è stato avocato a sé dalla Tecnica, e dal suo incredibile sviluppo; ma una “conversione” dello
sguardo è praticamente indispensabile se si vuole che i trionfi della
Tecnica non si rovescino in una catastrofe di proporzioni immani. Solo
la nuova in−nocenza, cioè – stando all’etimologia – la non−violenza
(a−himsƗ), può rendere non−nocivo lo sguardo con cui l’apparato tecnico scruta il mondo.
Questo libro, come dicevo, è pienamente consapevole della complessità, e multiformità, dei temi trattati. Per esempio della difficoltà
di ricomporre – all’interno della prospettiva del tornare bambini che,
come sopra si diceva, accomuna Oriente e Occidente – le radicali differenze di questi due mondi. Per esempio, per gli occidentali ciò che
attrae dell’esperienza del bambino è la sua capacità di vivere appieno
la vita, è la forza delle emozioni con le quali egli affronta l’esistenza;
mentre per l’orientale il ritornare bambino, al contrario, sembra legarsi
prevalentemente alla figura del saggio, sostanzialmente distaccato rispetto al mondo delle emozioni. Ovvero, volendo esprimersi con una
generalizzazione estrema e quindi da prendersi con grande cautela,
mentre per il “bambino” orientale il primo impegno è a non nuocere (e
16
Prefazione
a presentarsi per questo appunto come un “saggio”), per quello occidentale esso consiste invece nel riscoprire, attraverso il ritorno alla
forza originaria delle emozioni propria dell’esperienza infantile, un
nuovo ‘attaccamento’ al mondo. E anche qui abbiamo a che fare con
una questione filosofica decisiva, che mi è capitato di affrontare qualche anno fa in occasione di un incontro su e con alcuni buddhisti. Uno
studioso del buddhismo aveva ricordato la famosa battuta: «La dottrina buddhista è quella del vuoto; ma se qualcuno si attacca al vuoto allora costui è veramente perduto». Certo, ha aggiunto subito qualcun
altro, perché il vero insegnamento del Buddha è il distacco, dal momento che l’attaccamento è la fonte originaria del dolore, sicché esso
resta tale anche se è attaccamento alla vera dottrina, quella del vuoto.
Ma allora (questa la domanda che un pensiero radicale non può fare a
meno di porsi): come si fa a praticare costantemente il distacco senza
attaccarsi ad esso? E, di conseguenza, che cosa succede se ci si attacca
al distacco? O, all’inverso: che cosa accade quando il distacco, facendosi principio universale, si rivolge al distacco stesso? Non si giunge
qui necessariamente a un’esperienza paradossale che possiamo formulare ricorrendo alla formula del “distacco dal distacco”? Non potremmo allora dare il nome di “con–tatto” a questa forma paradossale di
esperienza che ritorna a “toccare” le cose pur all’interno
dell’esperienza del distacco radicale? Siffatta peculiare forma di con–
tatto è forse, in fondo, una singolare forma di rispetto. Parola, questa
(“rispetto”), che ha probabilmente qualcosa a che fare non solo con
l’elemento speculativo implicito nella radice che il termine “specchio”
ha in comune con “speculare” (entrambi derivanti da spicere, o specere) ma anche con la Gelassenheit di cui ci parla Heidegger (e che ha
qualcosa a che fare con il lasciar essere le cose quelle che sono), ma
poi anche con l’impossibilità di toccare l’essere (toccarlo nel senso di
trasformarlo, cioè di alterarlo facendolo diventare altro da quello che
esso è), impossibilità di cui ci parla la filosofia di Emanuele Severino.
Incontriamo qui un’esperienza intima, ma di un’intimità in cui ciò che
è “intimior intimo meo” (Agostino) è sì il Dio (il signore del cielo
stellato di cui sopra), ma sono anche la casa, la brocca, la finestra, di
cui ci parla Rilke nella Nona delle Elegie Duinesi. Quell’intimità che
il pensiero femminile, per esempio quello della Irigaray, vede come
una chiave di volta per l’autentica comprensione della realtà, per quel
Prefazione
17
“con–tatto” con essa che può avvenire solo mediante una mano capace
di carezze piuttosto che di prese, anche delle prese che sono effettuate
con la mano della mente, cioè con i “concetti” (Begriff è connesso appunto a greifen: afferrare).
Mi pare allora tutt’altro che improprio concludere queste “variazioni” filosofiche sollecitate dal libro di Chiara Fornasiero con un riferimento a quella inocencia última che caratterizza l’esperienza vitale del
niñodios di cui ci parla Juan Ramon Jiménez nella splendida poesia
“Con la cruz del Sur” (Poesie, Guanda, Parma 1967, p. 246), quel
niñodios che è dios consciente de mí y mio. Forse anche attraverso le
parole della poesia la filosofia può ritrovare la capacità di pensare
quell’esperienza del bambino che ci si presenta qui come l’apertura di
un inaspettato spazio di verità libera.
Venezia, 12 Novembre 2014
Luigi Vero Tarca