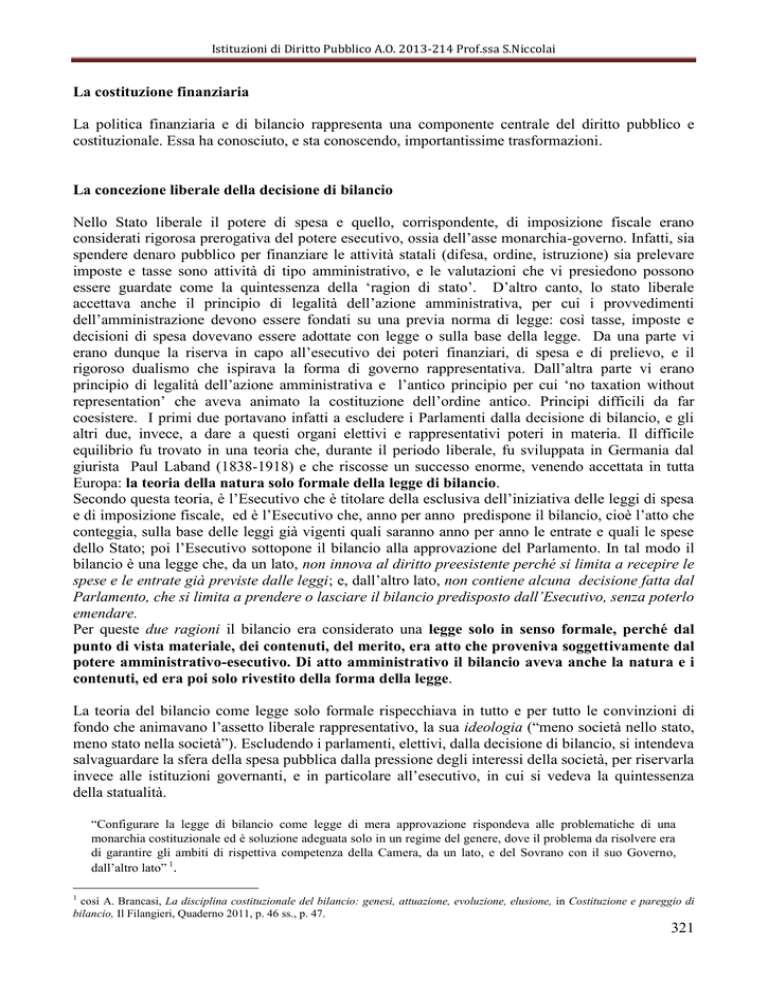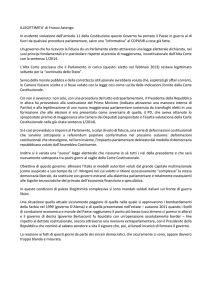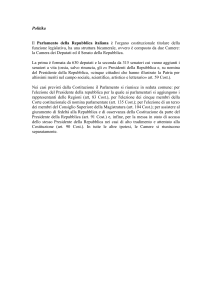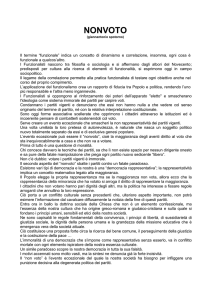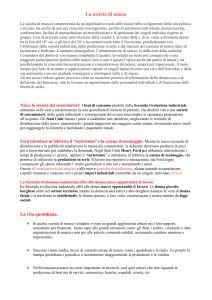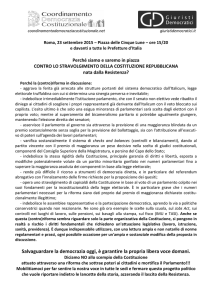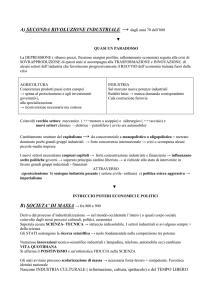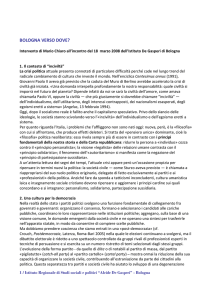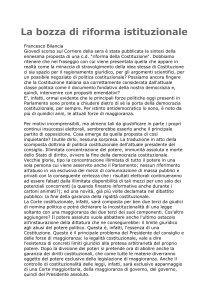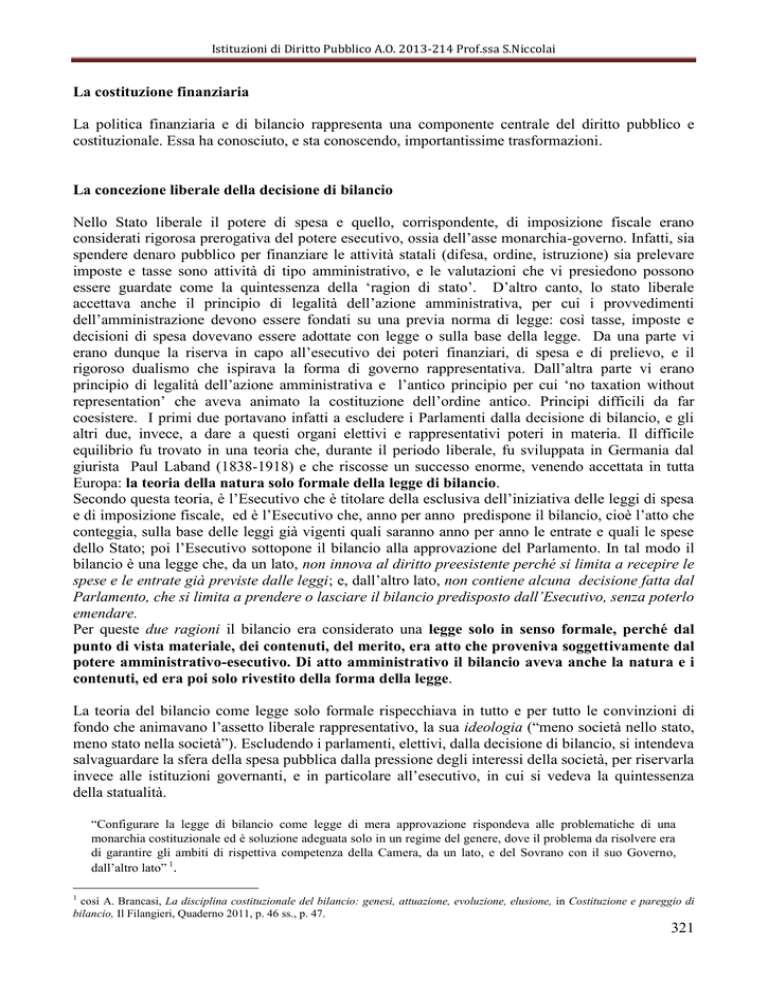
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
La costituzione finanziaria
La politica finanziaria e di bilancio rappresenta una componente centrale del diritto pubblico e
costituzionale. Essa ha conosciuto, e sta conoscendo, importantissime trasformazioni.
La concezione liberale della decisione di bilancio
Nello Stato liberale il potere di spesa e quello, corrispondente, di imposizione fiscale erano
considerati rigorosa prerogativa del potere esecutivo, ossia dell’asse monarchia-governo. Infatti, sia
spendere denaro pubblico per finanziare le attività statali (difesa, ordine, istruzione) sia prelevare
imposte e tasse sono attività di tipo amministrativo, e le valutazioni che vi presiedono possono
essere guardate come la quintessenza della ‘ragion di stato’. D’altro canto, lo stato liberale
accettava anche il principio di legalità dell’azione amministrativa, per cui i provvedimenti
dell’amministrazione devono essere fondati su una previa norma di legge: così tasse, imposte e
decisioni di spesa dovevano essere adottate con legge o sulla base della legge. Da una parte vi
erano dunque la riserva in capo all’esecutivo dei poteri finanziari, di spesa e di prelievo, e il
rigoroso dualismo che ispirava la forma di governo rappresentativa. Dall’altra parte vi erano
principio di legalità dell’azione amministrativa e l’antico principio per cui ‘no taxation without
representation’ che aveva animato la costituzione dell’ordine antico. Principi difficili da far
coesistere. I primi due portavano infatti a escludere i Parlamenti dalla decisione di bilancio, e gli
altri due, invece, a dare a questi organi elettivi e rappresentativi poteri in materia. Il difficile
equilibrio fu trovato in una teoria che, durante il periodo liberale, fu sviluppata in Germania dal
giurista Paul Laband (1838-1918) e che riscosse un successo enorme, venendo accettata in tutta
Europa: la teoria della natura solo formale della legge di bilancio.
Secondo questa teoria, è l’Esecutivo che è titolare della esclusiva dell’iniziativa delle leggi di spesa
e di imposizione fiscale, ed è l’Esecutivo che, anno per anno predispone il bilancio, cioè l’atto che
conteggia, sulla base delle leggi già vigenti quali saranno anno per anno le entrate e quali le spese
dello Stato; poi l’Esecutivo sottopone il bilancio alla approvazione del Parlamento. In tal modo il
bilancio è una legge che, da un lato, non innova al diritto preesistente perché si limita a recepire le
spese e le entrate già previste dalle leggi; e, dall’altro lato, non contiene alcuna decisione fatta dal
Parlamento, che si limita a prendere o lasciare il bilancio predisposto dall’Esecutivo, senza poterlo
emendare.
Per queste due ragioni il bilancio era considerato una legge solo in senso formale, perché dal
punto di vista materiale, dei contenuti, del merito, era atto che proveniva soggettivamente dal
potere amministrativo-esecutivo. Di atto amministrativo il bilancio aveva anche la natura e i
contenuti, ed era poi solo rivestito della forma della legge.
La teoria del bilancio come legge solo formale rispecchiava in tutto e per tutto le convinzioni di
fondo che animavano l’assetto liberale rappresentativo, la sua ideologia (“meno società nello stato,
meno stato nella società”). Escludendo i parlamenti, elettivi, dalla decisione di bilancio, si intendeva
salvaguardare la sfera della spesa pubblica dalla pressione degli interessi della società, per riservarla
invece alle istituzioni governanti, e in particolare all’esecutivo, in cui si vedeva la quintessenza
della statualità.
“Configurare la legge di bilancio come legge di mera approvazione rispondeva alle problematiche di una
monarchia costituzionale ed è soluzione adeguata solo in un regime del genere, dove il problema da risolvere era
di garantire gli ambiti di rispettiva competenza della Camera, da un lato, e del Sovrano con il suo Governo,
dall’altro lato” 1.
1
così A. Brancasi, La disciplina costituzionale del bilancio: genesi, attuazione, evoluzione, elusione, in Costituzione e pareggio di
bilancio, Il Filangieri, Quaderno 2011, p. 46 ss., p. 47.
321
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Quando ci si chiede come mai lo stato liberale italiano sia riuscito ad essere così ‘esoso’ sul piano
dell’imposizione fiscale e così ‘avaro’ nell’offerta di servizi, nella creazione di infrastrutture,
nell’adozione di investimenti duraturi – tanto da aver reso l’Italia il paese poverissimo, pressoché
sottosviluppato, che essa è stata non solo durante l’Ottocento, ma sino agli anni ’50 del Novecento –
bisogna pensare che la decisione di bilancio era rigorosamente riservata all’Esecutivo,
impermeabile cioè agli interessi della società, e in tal modo lo Stato poteva procedere in modo
sordo alle esigenze di sviluppo, crescita e democratizzazione per quanto avvertite da strati
larghissimi della popolazione. Quando ci si chiede come mai, cionondimeno, in quel periodo non
siano mancati disordini finanziari sboccati in scandali enormi, come quello della Banca Romana, né
speculazioni e fatti corruttivi (segno di interrelazioni occulte tra poteri politici ed economici); o
come mai le nostre banche siano rimaste coinvolte nei crolli borsistici del 1929 tanto da
giustificare, durante il fascismo, il loro salvataggio pubblico con la creazione dell’Iri, che fu una
sorta di nazionalizzazione del sistema del credito, bisogna pensare che la rigorosa riserva
all’esecutivo del potere di bilancio, mentre osta certamente a che la domanda di spesa emerga in
modo trasparente nella contesa politica, non osta a che essa prenda vie indirette e non trasparenti
quando a esprimerla sono poteri sociali ed economici forti che, per farsi valere, possono prescindere
dalla via parlamentare.
Il ‘bilancio in pareggio’, l’ideale perseguito dai governi liberali, non era andato esente, dunque, da
squilibri, abusi e ingiustizie: la sua incapacità di garantire sviluppo era stata tollerabile solo in un
contesto autoritario e repressivo quale era stato quello dello Stato liberale italiano; né le restrizioni
da esso imposte erano state bilanciate da significative prestazioni nel senso della trasparenza
effettiva della spesa.
La consapevolezza dei limiti dell’ideologia del bilancio in pareggio, insieme alla impossibilità di
riproporre tal quale la tesi della riserva della funzione di bilancio all’esecutivo in una democrazia
parlamentare, portarono i Costituenti ad affrontare il tema del bilancio in un modo diverso e più
aperto rispetto all’eredità culturale liberale. Essi, scrivendo l’art. 81 della nostra Costituzione, che è
la norma dedicata alla decisione di bilancio, non adottarono espressamente la formula per cui la
legge di bilancio ha carattere solo formale e funziona solo come ‘approvazione’ o ratifica di
decisioni già prese dal Governo; né stabilirono espressamente che il bilancio deve essere in
pareggio. Essi disegnarono invece una costituzione finanziaria improntata ad una diversa idea,
quella dell’ equilibrio di bilancio, e caratterizzata dalla aperta consapevolezza del carattere
politico della decisione di bilancio.
Il bilancio nella Costituzione repubblicana
I due termini “pareggio” ed “equilibrio” già nel loro significato nel linguaggio corrente ci fanno
capire la differenza tra le due concezioni del bilancio, quella adottata dallo stato liberale e quella
che è stata caratteristica sinora della costituzione democratica. Mentre il ‘pareggio’ è un dato
aritmetico-contabile (a tot spese devono corrispondere tot entrate, punto), l’equilibrio è un dato
dinamico, progettuale e valutativo (uno Stati può stabilire di avere più spese che entrate, se sa che
quelle certe spese vengono fatte per investimenti nell’occupazione, sanità e ricerca, che daranno sul
medio-lungo periodo notevole crescita, traducendosi, sul medio lungo periodo, in entrate). Il
bilancio, in altri termini, non può avere disavanzo ed essere in pareggio; il bilancio può avere
disavanzo (certo: programmato, controllato, consapevole) ed essere in equilibrio. La regola che
presiede alla costituzione finanziaria italiana è dunque quella per cui la finanza pubblica è
orientata alla ricerca dell’equilibrio strutturale tra prelievo, debito e spese pubbliche. Ad
essere perseguito è pertanto non il pareggio di bilancio ma la ragionevole sostenibilità del bilancio.
322
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Con la scelta nel senso dell’equilibrio di bilancio, il Costituente ha rimesso “alla scelta e alla responsabilità delle forze
politiche (Governo e Parlamento) l’equilibrio strutturale tra prelievo obbligatorio (tasse, imposte e contributi), debito e
spese pubbliche: l’uso di questa libertà è stato a volte virtuoso a volte molto discutibile; ma tuttavia lo stesso dilemma
nella scelta strutturale delle fonti di coperture delle spese si pone e si porrà sempre di più e nessuna norma
costituzionale può stabilire quale sia la ricetta corretta per correggere gli equilibri di una fase economica o per garantire
crescita e occupazione”2.
Queste parole di Paolo De Ioanna, Consigliere di Stato e uno dei massimi esperti italiani di
procedure parlamentari di bilancio, ci conducono al cuore del tema della costituzione finanziaria:
con il passaggio alla democrazia costituzionale si è avuta la consapevolezza, negata nello stato
liberale, che la decisione di bilancio è una decisione politica, non un mero fatto
amministrativo, e pertanto deve appartenere, insieme, sia al Governo che al Parlamento, ossia
alle forze politiche. Lo Stato, che è fondamentale attore economico, con la decisione di bilancio
concorre in modo determinante al benessere dell’economia, all’andamento del mercato.
Insieme a questa consapevolezza se ne è avuta un’altra, e cioè che le decisioni di politica economica
sono ‘politiche’ anche nel senso che visioni e teorie economiche ve ne sono molte e diverse, e
scegliere ai suggerimenti di quale teoria affidarsi per affrontare una congiuntura negativa, o
sfruttarne una positiva (“scegliere tra spese e spese: cultura, innovazione, infrastrutture,
salari pubblici, sanità, previdenza, ecc.; e tra entrate e entrate: lotta effettiva all’evasione,
progressività dell’imposizione fiscale, perequazione, ecc.” 3) è decisione politica, non ‘tecnica’.
Per questo motivo l’art. 81 della Costituzione non dice quasi nulla su come il bilancio deve essere
fatto, non sposa una o un’altra teoria economica, ma delinea (o meglio: delineava sino alla riforma
dell’aprile 2012), alcune grandi regole procedurali in cui convogliare il processo di decisione di
bilancio. Il modello di bilancio disegnato dall’art. 81 era, per scelta, uno in grado di convivere con
diverse opzioni di politica economica e finanziaria.
Nell’aprile 2012, con la legge costituzionale n. 1, l’art. 81 della Costituzione e altre disposizioni
collegate sono stati oggetto di una riforma che ha voluto introdurre importanti cambiamenti che
sembrano comportare un completo cambiamento di filosofia: lo scopo della riforma è introdurre il
pareggio di bilancio come regola di composizione del bilancio, e incorporare in Costituzione una
precisa teoria economica (contraria all’uso del disavanzo di bilancio in funzione di riequilibrio
economico), che diventa così l’unica legittimamente utilizzabile in sede di decisione di bilancio.
Si tratta di un cambiamento a 360 gradi che sembra riportare gli orologi ai tempi dello stato liberale,
compresa la sostanziale riserva al Governo della decisione di bilancio; una scelta che, secondo molti
osservatori, non è in grado di convivere con l’idea ‘aperta’ di società scelta dalla Costituzione, che
richiede anche una concezione ‘aperta’ dell’economia, come realtà vivente che deve poter essere
pensata e affrontata secondo visioni politiche diverse nel tempo.
Nelle pagine che seguono ricostruiremo sinteticamente le vicende della nostra Costituzione
finanziaria, i motivi e gli effetti della recente revisione costituzionale.
La Costituzione finanziaria e le sue vicende
Secondo il vecchio testo dell’art. 81, che ha retto la Costituzione finanziaria italiana fino all’aprile
2012:
2
P. De Ioanna, La nuova cornice costituzionale: economia, istituzioni e dinamica delle forze politiche, in Costituzione e pareggio di
bilancio, cit., p. 57.
3
Ibid.
323
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi4.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Come dicevamo, l’art. 81 non impone che il bilancio sia in pareggio (perché impone l’obbligo di
copertura solo alle singole leggi che importano spese, non all’intero bilancio). In altri termini, la
legge di bilancio non è tenuta a essere la mera conta delle spese e delle entrate risultanti dalla
legislazione vigente. Il pareggio di bilancio è una tecnica che la costituzione permette, ma non
impone. Infatti, dato che, a tenore testuale dell’art. 81, l’obbligo di copertura (ossia di ‘pareggio’)
vale solo per le singole leggi di spesa, e non per l’intero bilancio, la Costituzione ammette che la
legge di bilancio possa prevedere il ricorso all’indebitamento. Questo consiste nella emissione,
da parte dello Stato, di titoli di debito pubblico che vengono venduti, a un certo tasso di interesse,
sul mercato finanziario, per finanziare spese future, cioè spese non previste da leggi vigenti ma che
potranno essere previste da leggi approvate dopo il bilancio. A questo scopo, si è, come vedremo,
fatto ricorso alla iscrizione in bilancio di ‘fondi speciali’ in previsione di spese future destinate a
essere coperte col ricorso all’indebitamento.
Va anche notato che la Costituzione ammette esplicitamente, esplicitamente, parlando di leggi di
spesa, che la relativa iniziativa non sia riservata al solo Governo, ma possa essere esercitata anche
dal Parlamento.
Con questo disegno della Costituzione finanziaria potevano convivere e hanno convissuto diverse
concezioni della politica di bilancio.
Nei primi anni dell’esperienza repubblicana ha prevalso una visione rigida, più ancorata alla
tradizione liberale, per cui il bilancio non è che, anno per anno, la ‘conta’ delle leggi di spesa
approvate e delle relative forme di copertura. Questa concezione fu adottata in Italia nel dopoguerra
e sino alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, col risultato che il grande debito pubblico
ereditato dalla guerra diminuì molto, ma il paese, che intanto veniva mantenuto nello stato di
‘inattuazione’ del progetto costituzionale di società da politiche molto conservatrici e poco sensibili
alle istanze di democratizzazione5, crebbe pochissimo
In seguito, con gli anni Sessanta, i governi aderirono a diverse concezioni di politica economica,
quelle legate al nome dell’economista J.R. Keynes, per cui un bilancio in disavanzo promuove
sviluppo. Ricorrendo all’indebitamento, infatti, gli stati possono promuovere investimenti che sul
lungo periodo garantiscono la capacità dell’economia nazionale di rimanere stabile anche se
attraversa congiunture negative (come la svalutazione di una moneta concorrente, che deprime le
esportazioni). Queste teorie favorivano dunque l’idea che lo stato potesse farsi finanziatore di
investimenti, di spese destinate a creare occupazione e sviluppo, ricorrendo all’indebitamento 6;
invalse anche una concezione che prese il nome di teoria della programmazione, per cui la
4
Questa disposizione si riferisce all’ipotesi in cui la legge di bilancio non venga approvata entro il termine (31 dicembre di ciascun
anno). In mancanza di legge di bilancio approvata, lo stato non può procedere a spese o prelievo o ricorso al prestito; pertanto, è
previsto in queste ipotesi l’esercizio ’provvisorio’, ossia che lo stato proceda come se la legge di bilancio fosse stata approvata, in
attesa della definitiva approvazione. Tuttavia anche per poter esercitare provvisoriamente il bilancio, il Governo ha bisogno di una
legge del parlamento che lo autorizzi.
5
Ricordiamo i giudizi di Costantino Mortati che abbiamo riportato nel cap. VI.
6
Le autorità internazionali come il Fondo Monetario Internazionale erano d’accordo con queste politiche, e anzi le favorivano, come
abbiamo ricordato nel capitolo VI. Non è improbabile che garantire benessere agli strati più bassi delle popolazioni degli stati
occidentali fosse un fine considerato pregevole nel quadro internazionale di allora, che vedeva la separazione del mondo in due
blocchi, allo scopo di contrastare il modello sovietico e la sua presa sulle classi lavoratrici.
324
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
decisione di bilancio non deve essere vista solo come il momento in cui si fanno i conti, si tirano le
somme, ma anche come il momento in cui si fanno dei programmi rispetto al futuro, o meglio come
il momento in cui, all’interno di una programmazione pluriennale dell’economia, si verifica a che
punto si è, se si devono fare aggiustamenti, modifiche, nel piano di spesa e di entrata, per realizzare
gli obiettivi programmatici. All’idea del bilancio come strumento di programmazione fu di grande
supporto la teoria del costituzionalista Valerio Onida, l’autore della tesi secondo cui il bilancio
poteva portare iscritti dei ‘fondi speciali’ destinati a coprire spese future che, come tali, non erano
soggette a obbligo di copertura.
Con gli anni ’60, insomma, si aprì una nuova stagione in cui il ricorso all’indebitamento venne
considerato una fonte di finanziamento accessibile al bilancio oltre al prelievo fiscale. Ciò fece
crescere moltissimo le risorse utilizzabili nelle spese pubbliche; il ricorso all’indebitamento doveva
avvenire in un quadro programmato di sviluppo dell’economia, della società, dei servizi, delle
infrastrutture. Nel 1966 con la sentenza n. 1 di quell’anno la Corte costituzionale sancì la
legittimità del ricorso all’indebitamento come forma di copertura finanziaria degli oneri
finanziari futuri.
Fino al 1981 valeva d’altro canto la regola non scritta per cui la Banca d’Italia, istituto centrale di
emissione, acquistava sul mercato finanziario tutti i titoli emessi dallo Stato e che fossero rimasti
invenduti, e li acquistava al tasso di interesse predeterminato dallo Stato. Questo aveva una chiara
funzione di calmiere del costo del debito pubblico: non solo lo Stato fissava i tassi di interesse a un
livello sostenibile, ma il fatto che la Banca d’Italia comprasse i titoli invenduti garantiva che tutto il
debito fosse sempre coperto, e non potesse essere oggetto di manovre speculative. Fino alla metà
degli anni ’70 le Banche vedevano d’altronde molto limitata la loro possibilità di agire in modo
speculativo sui mercati finanziari, intanto perché gli accordi di Bretton Woods, abbandonati
unilateralmente dagli USA nel 1971, fissavano la convertibilità dell’oro in dollaro, limitando di
fatto la disponibilità di moneta e costringendo a mantenere una relazione stabile tra crescita
finanziaria e crescita reale delle economie; negli anni successivi, e particolarmente a partire dal
crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale, intorno alla fine degli anni ’80, i mercati
finanziari sono stati ‘deregolamentati’ con l’autorizzazione concessa a investitori non istituzionali (i
Fondi di investimento), la creazione di nuovi strumenti borsistici, e l’abolizione per le banche del
divieto (che era stato introdotto dopo la crisi del 1929) di utilizzare i depositi dei clienti per
speculare in borsa7).
Ma fintantoché tutte queste componenti non si sono realizzate, il ricorso all’indebitamento come
modo di finanziamento della spesa pubblica avveniva in modo controllato, “protetto” : gli acquirenti
del debito italiano erano banche italiane, investitori italiani (molto spesso famiglie) e l’Istituto
nazionale di emissione, cioè la Banca d’Italia. Il rischio che qualcuno chiedesse allo stato di
liquidare il debito (ossia di versarne il valore nominale) era inesistente, e buona parte
dell’indebitamento pubblico era in realtà il risparmio degli Italiani (che acquistavano i titoli di stato
come forma garantita di investimento dei risparmi).
Tutto questo corrispose anche a un periodo di notevoli cambiamenti nella forma di governo,
nell’assetto dei rapporti tra partiti e tra Parlamento e Governo, che, come diremo nel capitolo a ciò
dedicato, videro una crescita di ruolo del Parlamento, un ampliamento delle maggioranze di
governo, una certa ‘distensione’ nei rapporti tra le forze politiche e l’inaugurarsi di una stagione di
attuazione costituzionale contrassegnata da scelte come l’istituzione del servizio sanitario
nazionale, le norme di protezione del lavoro, l’ampliamento delle tutele previdenziali e sociali e un
grande intervento pubblico nell’economia. Si tratta di scelte che si traducono in altrettante spese
7
Cfr. M. Magatti, La grande contrazione, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 25 ss.
325
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
permanenti che gravano sul bilancio: per cui, crescendo anno per anno le spese di sanità,
previdenza, assistenza, istruzione, investimento, cresceva in parallelo il ricorso all’indebitamento.
In questo contesto, che fu di grandissima crescita della nostra come di altre economie europee 8,
maturarono e si consolidarono principi interpretativi per cui la legge di approvazione del bilancio è
‘formale’ solo rispetto al passato, ossia non può modificare in peggio il saldo delle spese e delle
entrate previgente, non può rifiutarsi di coprire spese previste dalla legge (abrogando cioè leggi di
spesa o modificandole), ma non per questo non può contenere disposizioni sostanzialmente
innovative e rivolte al futuro, quali quelle che impegnano a spese nuove, coperte da fondi speciali e
garantite dall’indebitamento.
Questo portava il ricorso all’indebitamento a crescere, perché le spese permanenti legate ai grandi
investimenti sociali di sanità, previdenza, istruzione, investimento erano stabilmente iscritte in
bilancio e in sé crescenti; per cui inevitabilmente cresceva il ricorso all’indebitamento per le spese
nuove.
Per affrontare questo problema, che implicava una inesorabile crescita del disavanzo pubblico, fu
approntata nel 1978 una importante riforma del processo finanziario, con la legge di contabilità n.
468. Il processo di bilancio fu ridisegnato intorno a una procedimentalizzazione che ha retto sino al
2009 e che aveva al centro un nuovo tipo di legge, la legge finanziaria.
La legge finanziaria serviva a risolvere due problemi: quello nascente dal fatto che la legge di
bilancio non può ‘riassettare’ le leggi di spesa previgenti , riducendone o modificandone gli importi,
ma d’altro canto può ricorrere all’indebitamento per spese future. La somma di queste due cose
creava il rischio della crescita incontrollata del ricorso all’indebitamento. Secondo il modello di
decisione finanziaria introdotto dal 1978, ogni anno il Parlamento doveva approvare un documento
di programmazione economico finanziaria che individuava in modo orientativo i limiti di ricorso
all’indebitamento, le caratteristiche della spesa pubblica, gli orientamenti generali di investimento.
Questo documento era a sua volta specificazione, anno per anno, di un documento pluriennale di
programmazione. In questo quadro, la legge finanziaria doveva, anno per anno, fissare il tetto
massimo del ricorso all’indebitamento; d’altro canto, in quanto legge come tutte le altre, essa
poteva correggere, riducendole nel complesso o variando i saldi, le spese previste da altre
leggi, operazione non consentita alla legge di bilancio. Siccome la legge finanziaria veniva
approvata in parallelo al bilancio, alla fine erano i saldi previsti dalla legge finanziaria a offrire il
conto delle entrate e delle spese che veniva riportato in bilancio, e il bilancio doveva sortire così
aggiornato agli equilibri sostenibili della finanza pubblica.
Il quadro che si era instaurato negli anni ’60 iniziò a cambiare radicalmente quando, nel 1981,
avvenne il ‘divorzio’ tra la Banca d’Italia e il Ministero del Tesoro: lo scambio di lettere tra
queste due istituzioni, ampiamente discusso in Parlamento, con cui questa decisione fu ratificata è
guardato oggi come un vero e proprio momento di revisione costituzionale ‘di fatto’ dell’assetto
8
Tra il 1950 e il 1990 la crescita del Prodotto interno lordo è stata pari a una media del +4,36% in Italia, +4,05% in Germania, +
3.86% in Francia; i primi segnali di flessione della crescita si avvertono tra il 1984 e il 1989; tra il 1999 e il 2011 la crescita in Italia
si riduce a +0,68%, in Germania a +1,32%, in Francia a +1,61%, ricorda Giuseppe Guarino (professore emerito di diritto
amministrativo e già Ministro delle Finanze e l‘Industria) nel suo saggio Euro: Venti anni di depressione (1992-2012), in Nomos, Le
attualità del diritto, n. 2/2012, p. 1 ss., il quale scrive anche: “Il debito della PA al 31 dicembre 1991 ammontava (in lire) a 1.448.150
miliardi, alla stessa data la ricchezza finanziaria delle famiglie ammontava a 1.860.372 miliardi di lire. Corrispondeva dunque al
167.70% del debito, il quale a sua volta corrispondeva al 100.8% del PIL. La proprietà dell’abitazione raggiungeva in quel tempo in
Italia una percentuale (64% delle famiglie) superiore a quella in qualsiasi altro Paese del mondo. (…) Dove è andata a finire l’enorme
ricchezza finanziaria del 1991 delle famiglie italiane? Si è rapidamente volatilizzata. Si crearono grandi illusioni con investimenti in
derivati. Esplose la crisi finanziaria del 2008/2009, dello straordinario fattore rappresentato dalla ricchezza delle famiglie, che
corrispondeva all’1.62% del debito pubblico, non è rimasto quasi niente”.
326
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
della Costituzione economica9. Si trattò di un riflesso del nuovo assetto economico globale che
aveva cominciato a delinearsi con la rottura degli accordi di Bretton-Woods, la fine della
convertibilità del dollaro in oro, l’apertura di una dimensione ‘globale’ delle economie. In questo
quadro, la ‘protezione’ dei ‘debiti sovrani’ tramite le banche centrali nazionali non era più
compatibile con una economia finanziaria che non ammette recinti chiusi agli investimenti
finanziari. Il ricorso all’indebitamento continuò, ma cominciò a rappresentare un problema, nella
misura in cui esponeva il paese alla fluttuazione dei mercati finanziari. Si trattò dell’insorgere di
problemi che avrebbero richiesto scelte politiche consapevoli, responsabili e lungimiranti;
purtroppo però proprio a partire dai primi anni ’80, i rapporti politici interni sono caratterizzati dalla
crisi del sistema dei partiti, dalla instabilità di assetti nella forma di governo. Per un sistema politico
fragile e conflittuale, è stata assai difficile la adozione di impostazioni durevoli e condivise in
materia economica e sociale.
In particolare, ha pesato negativamente il fatto che, nella attuazione pratica, la legge finanziaria è
stata nella maggior parte dei casi intesa ( anziché, come era stata pensata, come lo strumento
per rivedere anno per anno la sostenibilità del complesso delle spese pubbliche in un quadro
di equilibrio), come un’occasione per intrdourre nuove e disparate disposizioni di spesa, non
di rado nascenti da esigenze particolaristiche, “fino a ricomprendere una miriade di interventi di
sostegno economico di carattere localistico e microsettoriale”10 così che le leggi finanziarie sono
state causa di crescita dell’indebitamento, anziché strumento di realizzazione dell’equilibrio
finanziario. E’ intuibile che nel cattivo uso della legge finanziaria o in genere delle politiche
finanziarie e di bilancio si insinuano in modo decisivo i problemi e le caratteristiche del rapporto
italiano tra politica, istituzioni e società, che hanno visto spesso prevalere spinte clientelari, un uso
del denaro pubblico ai fini di costruzione del consenso. Finalità e interessi, cioè, contingenti e di
corto raggio, hanno probabilmente avuto il sopravvento su un impegno in politiche di spesa
lungimiranti nell’obiettivo del benessere generale.
Politiche di bilancio e integrazione europea
Intorno alla metà degli anni ’90, la crescita del debito pubblico rappresentò un problema anche ai
fini della nostra partecipazione alla Comunità europea, dove viene in quel periodo avviato il
progetto di trasformazione in Unione economica e monetaria, con il Trattato di Maastricht
(T.U.E. : Trattato sull’Unione europea, firmato nel 1992), il quale, definendo le tappe da
seguire in quella direzione, individua anche come centrale una convergenza tra le economie dei
paesi membri, e mise a tema l’esigenza di un coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie,
di bilancio dei Paesi membri.
Nel Trattato di Amsterdam (1997) venne formalizzato il cd. Patto di stabilità, il quale, in
armonia con i parametri di Maastricht prevede che i Paesi aderenti all’euro devono avere un deficit
pubblico non superiore al 3% del PIL, e un debito pubblico non superiore al 60% del PIL e tendente
al rientro (cioè alla diminuzione e verso il pareggio). Il Trattato di Amsterdam prevedeva che il
bilancio degli Stati fosse monitorato dall’Unione europea, per il tramite della Commissione e
all’interno di procedure di coordinamento (gli stati sottopongono i loro bilanci all’esame della
Commissione, ne ricevono le raccomandazioni); in caso di superamento dello scostamento del
deficit dal limite del 3% il Trattato prevedeva l’avvio di una procedura di infrazione (lo Stato è
‘denunciato’ dalla Commissione e può essere condannato a una sanzione pecuniaria).
9
Di “prima sostanziale modifica della nostra costituzione economica materiale”parla De Ioanna, cit., p. 56, che altresì osserva: “Gli
anni ’80, successivi al divorzio, sono stati per ragioni tutte politiche quelli del risanamento mancato”.
10
R. Bin e G. Pitruzzella, Diritto pubblico, cit., p. 199.
327
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Essendo la posta in palio l’ingresso nell’Unione europea, il nostro paese, pur nelle enormi difficoltà
legate alla recente traumatica crisi del sistema politico legate a Tangentopoli, con un insieme di
misure avviate nei primi anni 1990 riuscì a ‘rientrare’ nei parametri di Maastricht nel biennio
1996/1998. La convergenza dei diversi paesi membri nei parametri di Maastricht rese possibile, nel
2000, l’avvio della moneta unica.
Questa vicenda esemplifica, secondo più di un Autore, che il modello di bilancio prefigurato
nell’art. 81, l’insieme di strumenti predisposti dalla nostra legislazione contabile (i documenti di
programmazione, la legge finanziaria), gli accorgimenti di procedura parlamentare (nel corso degli
anni ’80 e ’90 la sessione di bilancio in Parlamento si è perfezionata come una sessione dotata di
tempi certi, di importanti meccanismi conoscitivi e decisionali, tra cui il ruolo di ‘filtro’ della
Commissione bilancio, incaricata di controllare la compatibilità finanziaria dei provvedimenti
legislativi all’esame del Parlamento) sono stati in grado, come si esprime Paolo De Ioanna, di
permetterci di ‘salvarci da noi stessi’ dal rischio legato alla crescita incontrollata del deficit
pubblico, ossia dell’indebitamento.
Come vedremo, sono stati i ‘governi tecnici’ Amato Dini e Ciampi a guidare il paese in questa fase.
Una importante caratteristica delle politiche europee in materia finanziaria e di bilancio è che a
partire dal ‘Patto di Stabilità’ l’Unione europea si è data norme che, secondo alcuni, hanno reso più
rigidi i vincoli sulle politiche nazionali di bilancio rispetto a quanto il Trattato prevedeva, e hanno
progressivamente condizionato le politiche economiche nazionali in modi che si sono rivelati
controproducenti.
Politiche di bilancio e integrazione europea
I parametri di Maastricht presentano una caratteristica molto diversa dalla nostra scelta
costituzionale verso l’equilibrio di bilancio, che può convivere ed ha convissuto con diverse idee di
politica economica. Sono infatti parametri di tipo aritmetico-contabile che stabiliscono che i bilanci
devono essere tendenzialmente in pareggio e indicano anche quando un bilancio è compatibile con
il pareggio e quando non: il disavanzo, cioè l’eccedenza delle spese rispetto alle entrate non deve
essere superiore al 3% del PIL, e il ricorso all’indebitamento non può coprire più del 60% del
debito. Tuttavia, pur nella loro ‘rigidità’ questi parametri lasciano gli stati sovrani nel manovrare lo
spazio che sta all’interno di quei parametri, cioè di decidere se e come gestire un debito fino al 3% e
l’indebitamento fino al 60%. Maastricht, in altri termini, presupporrebbe un equilibrio flessibile tra
tendenza al pareggio e alla convergenza delle economie e adattamenti nazionali in relazione alle
esigenze dei singoli mercati e delle singole economie.
Secondo alcuni Autori, nonostante Maastricht lasciasse questi spazi di flessibilità alle economie
nazionali e alle relative politiche di bilancio, di fatto l’Unione ha praticato una politica molto più
restrittiva. Con un regolamento approvato all’indomani del Trattato di Amsterdam, il regolamento
n. 1466 del 1997 (rimasto in vigore sino al 6.12.2011) l’Unione ha impegnato gli Stati a
raggiungere un saldo del bilancio delle spese della pubblica amministrazione ‘prossimo al pareggio
o in attivo’. In sostanza, essa ha vincolato gli stati al pareggio di bilancio, ha precluso il ricorso
all’indebitamento e sostituito una regola rigida e ‘uguale per tutti’ (laddove ogni economia è diversa
dall’altra, e ciascuna attraversa fasi differenti), all’apprezzamento politico e aderente alle
circostanze concrete che una buona politica di bilancio richiederebbe11. Mentre i Trattati
ammettono che gli stati utilizzino ancora l’indebitamento sia pure nel limite massimo del 3% e
abbiano un debito complessivo fino al 60% (e dunque conservino in questi limiti una loro
‘sovranità finanziaria’ pur in un quadro di convergenza) il regolamento del 1997, sostituendo al 3%
11
Per questa ricostruzione v. G. Guarino, Euro, cit., p. 16-17.
328
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
il vincolo al pareggio e cioè l’obbligo di diminuire sino allo 0% il rapporto tra indebitamento e
PIL, avrebbe limitato la possibilità per gli stati di guidare le proprie economie di fase in fase, perché
il vincolo alla parità di bilancio limita l’accesso degli stati al mercato, al credito, col quale
potrebbero finanziare lo sviluppo12.
Nella prima metà degli anni 2000 più di un governo nazionale – tra cui il nostro – aveva
apertamente dichiarato di considerare il patto di stabilità, come interpretato dal regolamento
1466/97, troppo rigido. D’altro canto, oltre che troppo rigido in astratto, il patto si era rivelato
inefficace in concreto: per esempio, benché prevedesse sanzioni per gli stati che non rispettavano i
parametri, alcuni stati lo hanno violato apertamente (Francia e Germania) senza subire procedura di
infrazione; altri, come noi, hanno subito la procedura di infrazione ma non hanno avuto sanzioni
perché sono rientrati nei parametri (nel caso dell’Italia, siamo rientrati nei parametri nel 2008, dopo
esservi rientrati e ri-usciti di nuovo intorno alla prima metà del 2000).
Nel 2008, in concomitanza con l’esplosione di una gravissima crisi finanziaria mondiale13, è iniziata
una nuova fase di pressione nel senso del rafforzamento del coordinamento europeo delle politiche
12
Così G. Guarino, op. cit., p. 21.
La crisi finanziaria di questi ultimi anni è molto difficile da comprendere nelle sue cause e meccanismi di funzionamento. Tuttavia
appaiono verosimili le ricostruzioni secondo le quali, nella sua essenza, si tratta di una crisi derivante dalla esposizione irresponsabile
delle Banche e degli istituti di credito in operazioni finanziarie sconsiderate che hanno esposto molte Banche al rischio di fallimenti.
Negli Stati Uniti, si è parlato di ‘bolla immobiliare’: le banche concedevano, negli anni ’90, prestiti per l’acquisto di case anche a
persone che non davano alcuna garanzia di poter onorare i mutui. Le banche però si trovarono esposte in modo enormemente
maggiore rispetto alle cifre che avevano effettivamente dato in prestito. La crisi infatti non dipende dalle persone che hanno preso
mutui senza poterselo permettere, ma dal modo in cui le banche investono i denari che raccolgono tramite il risparmio, o il valore dei
beni che posseggono tramite le ipoteche, che esse stabiliscono quando danno un prestito.
Le operazioni borsistiche dominanti sono oggi quelle che scommettono sul valore futuro di un certo bene, scommettono sulle
variazioni di prezzo di questo o quell’altro bene (cd. futures), senza preoccuparsi molto della effettiva solidità del soggetto
economico che emette il titolo (cd. titoli spazzatura o di seconda scelta, subprime). Accade così che i titoli scambiati in borsa non
riflettono il valore reale del bene che rappresentano, ma aspettative. Per esempio, un titolo che rappresenta petrolio ha un valore
reale, poniamo, di 10; ma oggi viene scambiato a 100 perché ci si aspetta che una crisi determinerà una salita del prezzo del petrolio;
domani, in cui si crede che la crisi stia per scoppiare, viene scambiato a 1000; una Banca compra tonnellate di titoli petroliferi e
nominalmente si arricchisce molto; ma solo nominalmente, perché il valore reale di quel titolo è sempre 10; e magari la crisi attesa
non scoppia, anzi la produzione del petrolio cresce e la domanda cala, ecco che il titolo scende improvvisamente da 1000 a 5, e la
Banca è in perdita. Ora, da che cosa è data la base monetaria su cui si costruisce il mercato dei futures e dei subprimes? Dai risparmi
e dalle ipoteche che le banche possiedono. Ecco che, mentre quando il mercato dei futures e dei suprimes va bene sono solo gli
investitori, cioè le banche stesse, a guadagnarci, quando il mercato va male a perdere sono quei risparmiatori che le avevano affidato
le somme di denaro, o iscritto le ipoteche, che sono state la base per gli investimenti fatti dalle Banche scommettendo sul futuro o
sulla ‘spazzatura’. Così, dalle scommesse ‘virtuali’ fatte sul mercato finanziario, derivano perdite enormi nell’economia reale.
Le Banche sono i principali soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite i Fondi di investimento, acquistano il debito pubblico
degli Stati. Il patrimonio pubblico, e lo stato dell’economia nazionale (prodotto interno lordo) sono le ‘garanzie’ del debito dello
Stato: le banche prestano sul presupposto che una economia è abbastanza solida da, in teoria, poter garantire la solvibilità del debito
che contrae.
Ora, qual è lo scenario che la crisi finanziaria del 2008 ha aperto: le Banche rischiavano di fallire, per colpa dei loro investimenti
sbagliati e sconsiderati e delle legislazioni e accordi economici sovranazionali che loro consentono di farli ( non si riesce infatti a
rendere obbligatorio per le Banche rispettare una proporzione adeguata tra la grandezza del patrimonio che esse posseggono
effettivamente e quello che producono mediante gli investimenti azionari; se una Banca potesse investire solo nei limiti di una certa
proporzione rispetto al patrimonio che possiede realmente, ciò limiterebbe gli effetti delle crisi che attraversa. Se invece una Banca,
con un patrimonio reale di 10, può investire fino a 100.000, è chiaro che quando gli investimenti vanno male essa non è in grado di
fronteggiare la crisi che ne deriva). Se le Banche fallissero, sarebbero trascinati anche gli Stati, perché le Banche non potrebbero più
comprare il loro debito e quindi finanziarli; di qui l’interessamento degli Stati nella imponentissima crisi di liquidità sofferta dalle
Banche trascinate dalla crisi dei ‘futures’ e dei ‘subprimes’ iniziata negli Usa. Per rimediarvi, essi hanno versato ingenti quantitativi
di denaro (prelevati ovviamente tramite la leva fiscale) alle Banche. Ci si potrebbe aspettare che allora le Banche, in cambio, fossero
state richieste di garantire prestiti agli Stati e finanziamenti alle loro politiche. Al contrario: le Banche (i cui organismi istituzionali
sono il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la Banca Centrale Europea) hanno posto agli Stati la condizione per
cui esse non presteranno denaro agli Stati, non compreranno il debito pubblico, agli Stati che ne hanno ‘troppo’ e che quindi
rischiano di essere insolvibili. Il meccanismo è apparentemente piuttosto chiaro, e non poco inquietante. Il debito pubblico serve agli
stati per finanziare la spesa pubblica, e cioè in larga parte servizi alla collettività. Dal punto di vista finanziario, però, sono risorse
perdute: finanziando la spesa pubblica le Banche si privano di risorse che per loro sarebbe molto più conveniente scambiare in borsa,
dove producono molta più ‘ricchezza’. Esse quindi hanno interesse a che il debito pubblico statale diminuisca, perché, come
torneremo a dire anche nel testo, in tal modo diminuiscono le risorse che esse investono in quella direzione, risorse che restano
13
329
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
fiscali e di bilancio. Un forte debito pubblico espone lo stato che ne è titolare a molti rischi, primo
tra tutti quello di non riuscire a collocare i suoi titoli di debito sul mercato, e perciò a trovarsi in
stato di illiquidità, tecnicamente di ‘fallimento’ per non avere il denaro con cui pagare i conti dello
stato. Se uno stato della zona Euro ‘fallisce’ ne risente tutta l’Unione, forse ne è a rischio
l’esistenza stessa. L’Unione ha così intensificato in un modo fortissimo le sue iniziative indirizzate
a portare sotto il controllo della Ue le politiche di bilancio nazionali. Sotto la minaccia delle
speculazioni del mercato finanziario, gli stati sono spinti a mettere in pratica quello sforzo verso il
‘pareggio di bilancio’ che, nonostante le norme che lo prevedevano, la Ue non era riuscita a
imporre.
In questa direzione ci si è mossi in una maniera da alcuni giudicata contraddittoria. Nel 2010 è
stato introdotto il semestre europeo, risultato di una serie di proposte avanzate nel corso del 2010
dalla Commissione (e successivamente varate dopo l’approvazione del Parlamento e del Consiglio
europeo). Il semestre europeo è una procedura che ha il fine di rafforzare la governance economica
dell’Unione, cioè il coordinamento da parte della Ue delle politiche finanziarie e di bilancio degli
Stati. Come si trova ben spiegato anche nel sito nel nostro ministero del Tesoro:
“A partire dal 2011, il primo semestre di ogni anno è caratterizzato da un ciclo di cooperazione politica intensa tra le
istituzioni UE e i 27 Stati membri relativa sia all’agenda economica che alla sorveglianza sui bilanci. Si tratta di un
elemento centrale della governance economica rafforzata. Il Semestre si apre in gennaio con la presentazione, da parte
della Commissione, dell’Analisi annuale della crescita, che definisce le priorità per l’UE in termini di riforme
economiche e risanamento di bilancio. Queste priorità vengono poi discusse e avallate a marzo dal Consiglio europeo di
primavera. In aprile gli Stati membri presentano alla Commissione e ai loro pari i Programmi nazionali di riforma e i
Programmi di stabilità o di convergenza. Su questi programmi la Commissione emette poi raccomandazioni, che
vengono avallate dal Consiglio europeo di giugno e adottate formalmente dal Consiglio dell’UE a luglio. Gli Stati
membri tengono conto di questi orientamenti nel redigere i bilanci nazionali, che sono discussi in seno ai parlamenti
nazionali secondo le norme vigenti nella seconda metà dell’anno. Ciò garantisce che la discussione dei bilanci nazionali
avvenga, per la prima volta, con una visione allargata all’Europa”.
L’idea è dunque che il processo di bilancio si svolga, anno per anno, in due tempi: nella prima parte
dell’anno c’è il coordinamento europeo; nella seconda parte dell’anno il processo di bilancio a
livello nazionale, che dovrebbe incorporare gli orientamenti ricevuti a livello europeo.
Quindi, nel 2011, l’Unione europea ha ritirato il regolamento 1466, e ne ha adottato uno nuovo, il
1175/2011, che ammette, nel suo preambolo, che nel decennio precedente erano stati fatti errori per
colpa di una concezione troppo rigida del pareggio di bilancio; e il nuovo regolamento, sotto certi
profili, parrebbe tornanre alla maggiore flessibilità consentita dai parametri di Maastricht. Tuttavia,
nello stesso periodo, tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, 25 dei 27 Stati dell’Unione, tra cui
‘embedded’ nel welfare statale invece di potere essere centuplicate negli scambi finanziari. (v. su questi processi, in modo assai
chiaro e compiuto, A. Baranes, Finanza per indignati, Ponte alle Grazie, Firenze, 2012).
Nel sistema dell’Unione europea, la Banca centrale europea è un organismo indipendente che coordina e dirige le banche centrali dei
paesi membri e costituisce un interlocutore di primo piano nei confronti degli organi politici. Lungi dall’essere ‘dirette’ dalla politica,
le Banche, grazie al loro costituire un sistema indipendente, sono nella posizione istituzionale di dirigere quest’ultima. Secondo molte
opinioni, il coordinamento che l’Unione europea esercita sulle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri traduce in
consigli, raccomandazioni e misure concrete imposte agli Stati le esigenze manifestate dalla Banca centrale. E’ diventato uso corrente
definire queste esigenze come politiche di austerità, cioè di riduzione della spesa pubblica. I paesi finanziariamente più deboli, cioè
quelli che hanno un maggiore debito pubblico, hanno subito in modo traumatico gli effetti della situazione sin qui descritta, che in
poche parole consiste, da parte delle Banche, di cercare di ottenere dagli Stati risorse economiche con cui rimediare a una loro crisi
che sin da subito è stata anche crisi delle finanze statali (in quanto possedute dalle banche). In Grecia, il cui debito pubblico era in
gran parte posseduto da banche altamente esposte nel possesso di ‘titoli spazzatura’ cioè di titoli azionari borsistici che non
incorporano valore reale, ed erano perciò sull’orlo del fallimento e non più in grado di garantire il debito statale, quest’ultimo è stato
coperto in parte da prestiti europei, ma sotto la condizione che la Grecia riducesse il suo debito pubblico, ossia le spese dello stato, tra
cui primariamente le spese per il personale e il funzionamento della pubblica amministrazione; ciò che ha condotto, per fare un solo
esempio, alla mancata apertura dell’anno accademico nell’Università di Atene nel 2013-2014 e a una crisi sociale imponentissima.
330
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
alcuni appartenenti alla zona euro14, e altri non, hanno stipulato un Trattato di Stabilità Fiscale
(Fiscal Compact) che ripropone, rendendoli però molto più rigidi dal punto di vista delle sanzioni
da cui sono assistiti, i parametri di Maastricht, e che sollecita gli Stati a introdurre nelle loro
Costituzioni la regola del pareggio di bilancio.
Il Fiscal Compact è dunque un trattato stipulato tra Stati aderenti alla Ue e non un atto della Unione
europea. In quanto Trattato internazionale e non atto normativo della Ue, per diventare vincolante
ha bisogno della ratifica di tutti gli Stati firmatari. La sua entrata in vigore è stata fissata per il 1
gennaio 2013, data in cui il processo di ratifica doveva essere terminato, ed in effetti è terminato.
L’Italia ha ratificato il Fiscal Compact con legge nel luglio 2012.
Molti si interrogano sulla stessa legittimità del Fiscal Compact, che viene giudicato un modo per
perseguire una modifica dei Trattati in forme non previste. Il Fiscal Compact persegue la
modificazione del diritto dell’Unione per due strade: da una parte, in quanto vincola gli stati
firmatari a introdurre nei propri ordinamenti regole obbligatorie corrispondenti al Fiscal Compact
medesimo (si modifica così il diritto dei paesi membri); dall’altra, prevedendo che quando il suo
processo di ratifica sarà terminato i suoi contenuti saranno inglobati nei Trattati.
Il Fiscal Compact ha posto disposizioni molto precise e altamente vincolanti, che si possono così
riassumere:
-Ogni stato deve avere un deficit pubblico strutturale non superiore allo 0.5 per cento del PIL o
all’1% del PIL per i paesi che, al momento della stipula del Fiscal, hanno un debito pubblico
inferiore al 60%. Per l’Italia, che supera questa soglia, ciò significa che anche una volta raggiunto
lo scostamento dello 0,5% non potrà mai superarlo, quindi alcuni stati dovranno sempre tenere il
loro deficit allo 0.5% e altri avranno la possibilità di portarlo all’1%.
-Obbligo per gli Stati che (come l’Italia) hanno un deficit pubblico superiore al 60% del PIL di
rientrare sotto al 60% a un ritmo pari a 1/20 per ogni annualità.
-Obbligo per tutti gli stati di mantenersi con un deficit pubblico al di sotto del 3% del PIL pena
sanzioni automatiche.
-Invito agli Stati a inserire in Costituzione la regola del pareggio di bilancio.
-Attribuzione alla Corte di Giustizia dell’Unione del poter di giudicare la corretta implementazione
nel diritto nazionale delle norme del Fiscal Compact.
Oltre a irrigidire i parametri di convergenza stabiliti nel Trattato di Maastricht, il Fiscal Compact
irrigidisce le sanzioni (mediante un creato il controllo sul diritto finanziario interno attribuito alla
Corte di Giustizia), e sollecita gli stati membri a introdurre nella loro costituzione la regola del
‘pareggio di bilancio’.
Nel 2012 il coordinamento delle politiche europee è stato ulteriormente rafforzato dalla
approvazione di due regolamenti europei (cd. Two Packs) che stabiliscono che gli Stati devono
sottoporre all’esame della Commissione europea la legge di stabilità (che, come vedremo subito, ha
sostituito la legge finanziaria), per un esame preventivo, e soltanto dopo che la Commissione ha
14
Non tutti gli Stati aderenti all’Unione adottano l’euro (primo tra questi la Gran Bretagna). Si chiamano stati dell’Eurozona quelli
(17 su 27) che hanno la moneta unica.
331
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
espresso il suo parere, che può comportare anche l’indicazione di rivedere, ‘correggere’, la
manovra, la legge di bilancio viene sottoposta al Parlamento nazionale. Questa nuova procedura,
che rende più stringente il coordinamento cui è destinato il Semestre europeo, entrerà in vigore nel
2014.
Ragioni e problemi delle scelte europee in materia finanziaria e di bilancio
C’è molta discussione intorno alla opportunità, da un lato, e alle ragioni, dall’altro lato, delle
politiche finanziarie che l’Unione persegue; ma molti aspetti problematici risalgono sicuramente a
un dato, e cioè al mancato compimento del processo di integrazione politica.
Il disegno collegato all’Unione monetaria, sancito a Maastricht, doveva nel tempo completarsi con
una evoluzione costituzionale del progetto di integrazione comunitaria, tale da permettere, tra gli
stati membri, un livello di integrazione politica molto avanzato, il quale a sua volta era ed è la
premessa necessaria per completare l’Unione monetaria con quei poteri fiscali e di bilancio
analoghi a quelli con cui gli stati nazionali erano in passato usi a difendere le proprie economie
(stampando moneta per risolvere problemi di liquidità, in primo luogo, cosa preclusa alla Banca
Centrale Europea dagli attuali accordi, e che continua invece a rappresentare il metodo con cui una
economia esposta alla crisi come e più della nostra, quella statunitense, è riuscita sinora a
proteggersi dalle tempeste finanziarie degli ultimi anni).
Gli anni successivi a Maastricht dovevano in effetti portare a una trasformazione istituzionale
dell’Unione europea in una sorta di vera e proprio stato federale. A questo scopo, si lavorò, intorno
ai primi anni 2000, al progetto di dare vita a una Costituzione per l’Europa, con la predisposizione
di un nuovo ‘Trattato Costituzionale’, che doveva essere il fondamento di una Unione europea
ormai del tutto emancipata dalla sua origine pattizia di organismo sovranazionale e trasformata in
vera e propria entità politica autonoma. Ma il nuovo Trattato non superò la prova delle ratifiche
nazionali in quei paesi, come la Francia, in cui venne sottoposto a referendum, e dove prevalse
l’ostilità verso le concezioni eccessivamente liberiste dell’economia che il Trattato faceva proprie, e
forse il timore per la perdita di potere dello Stato nazionale. Il risultato che invece si è riusciti a
raggiungere, il Trattato di Lisbona del 2009, o Trattato sul Funzionamento dell’Unione, è molto
lontano dall’aver conferito agli organi comunitari, la statura di organi di un governo europeo
comune, espressivi nel loro complesso di una ‘polis’, di una cittadinanza europea. In questo quadro
si sono invece rafforzati invece la Commissione, il Consiglio Europeo (espressivo dei Capi di Stato
e di Governo), i ‘Vertici’ sovranazionali e la Banca Centrale, un circuito nel quale alcuni vedono il
diretto rapporto tra esecutivi statali e ‘poteri forti’ dell’economia mondiale, che riduce e menoma
l’espressione di orientamenti politici dal basso, cioè da parte dei cittadini e dei loro concreti
interessi.
La tesi che assegna responsabilità al dominio ‘tecnocratico’ della Commissione
Il fallimento del progetto di integrazione politica ha significato che mentre l’Unione europea ha
acquistato enormi poteri di condizionamento sulla politica interna degli Stati, essa ha continuato a
funzionare principalmente attraverso organi poco o per nulla collegati alle popolazioni europee, che
non sono da esse indirizzati, e non hanno davanti ad esse responsabilità politica. Tra gli organi
dell’Unione l’unico elettivo è il parlamento, che non ha poteri normativi autonomi. Il vero e proprio
governo dell’Unione è rappresentato dalla Commissione, composta da persone nominate dai
governi nazionali ma tenute a operare nell’interesse dell’Unione, quindi ‘indipendenti’ rispetto ai
332
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
loro governi. Questo conferisce alla Commissione, secondo molti, i caratteri di un organismo
burocratico autoreferenziale, che cioè non verifica la tenuta, la credibilità e gli effetti delle
politiche che intraprende alla luce del dibattito pubblico e dei movimenti di opinione ma tiene conto
solo dei punti di vista interni alle ‘tecnocrazie’ che la esprimono e che dialogano con lei, prima tra
tutte la Banca Centrale Europea, e di teorie dettate da assetti di interessi che possono essere ben
lontani da quelli delle popolazioni europee. Visioni che, peraltro, la Commissione riuscirebbe a
imporre agli Stati in quanto dotata della risorsa più condizionante (l’informazione, la conoscenza
del funzionamento della Ue, la disponibilità di dati), e soprattutto grazie all’assenza di una autorità
capace di affrontare e risolvere con quote di autonomia le questioni che involvano interessi unitari
delle proprie collettività:
“se il regime non è in sé democratico né di mercato, non è escluso che l’organismo di vertice si disinteressi delle
15
collettività e si preoccupi solo della propria sopravvivenza ” .
La tesi che imputa il risorgere dei nazionalismi statali
Secondo altri, nella fase di mancata realizzazione dell’Unione politica si sono affermate nella Ue
spinte ‘centrifughe’, cioè in pratica spinte a far fallire il progetto dell’Unione politica e a riaffermare
gli interessi statali. Alcuni Stati, economicamente più forti degli altri, riuscirebbero a imporre
visioni ad essi più convenienti; questo spiegherebbe come mai influentissime decisioni (come il
Fiscal Compact) sono state prese mediante procedimenti di deliberazione estranei al circuito
decisionale della Ue.
Gli anni che ci separano dalla realizzazione dell’Unione monetaria avrebbero in altri termini visto
come il realizzarsi, all’interno, intorno, sotto o in parallelo al processo di integrazione comunitaria
(che avrebbe dovuto evolversi verso una crescente fusione degli ordinamenti nazionali) il risorgere
di metodi nazionalistici di conduzione delle politiche, in cui ogni stato fa valere il suo peso e i suoi
interessi. Così vi è chi scrive che
“Si delinea il pericolo di una inquietante trasformazione: dalla prima comunità sovranazionale giuridicamente
ratificata in termini democratici, si potrebbe arrivare ad una intesa intergovernativa per l’esercizio di un dominio
burocratico, post-democratico”16.
In questo contesto, che alcuni descrivono come quello della lotta tra forze centrifughe (che vogliono
solo servirsi dello scenario Ue per affermare politiche di potenza nazional-finanziarie così
sovvertendo il progetto di integrazione politica) e forze centripete (quelle che invece vogliono
realizzare l’integrazione politica europea) lo snodo delle politiche finanziarie diventa centrale. Le
forze centrifughe (i governi, i mercati, le istituzioni bancarie e finanziarie specialmente)
approfitterebbero della crisi finanziaria per affermare un nuovo modello d’Europa, in cui, bypassate
le istituzioni ‘democratiche’ nazionali, i Vertici che riuniscono i capi di Stato e di Governo,
manovrando la Commissione, trasmetterebbero direttamente agli stati le indicazioni dei mercati, le
quali vogliono economie in crescita, più produttive, per ottenere la quale si punta su una ricetta che
prevede da un lato la riduzione della spesa pubblica per servizi, e, dall’altro lato, la ridefinizione
del mercato del lavoro in una chiave di estrema flessibilizzazione.
15
Questa tesi è propugnata da G. Guarino nello scritto citato, p. 60. L’accusa che Guarino rivolge alla Commissione (un soggetto
autoreferenziale che guida una Europa la quale, senza un centro politico, è preda di un processo di frammentazione e parcellizzazione
delle sedi decisionali nel quale guadagna spazio solo la Commissione, paragonata da Guarino a un ‘robot’), deve probabilmente
essere letta anche in termini politici. La tesi è stata formulata dall’anziano studioso e autorevole uomo di stato quando in Italia era
presidente del Consiglio Mario Monti, già membro della Commissione europea. Come si comprende dal frammento citato, Guarino
ritiene che non solo la Ue non è democratica, ma non è più nemmeno ispirata a meccanismi di mercato, perché i rigidi limiti imposti
alle economie tramite la regola del pareggio si traducono in altrettanti condizionamenti esterni ai mercati nazionali, alterando la
regola fondamentale (libertà e parità di concorrenza) della Ue.
16
” P. De Ioanna, op.cit. p. 50.
333
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
La tesi che inquadra le politiche economiche europee nelle finalità del ‘neoliberismo’
Un’altra serie di letture legge le vicende dell’Unione europea in una chiave ampia che le inquadra
nelle trasformazioni dell’economia dal 1971 (la fine degli accordi di Bretton Woods e l’inizio della
globalizzazione) a oggi. Secondo queste interpretazioni nel periodo a noi più vicino si è determinata
una inversione del rapporto tra stato ed economia che aveva presieduto alla costruzione degli
equilibri successivi alla seconda guerra mondiale. In quello scenario, alla sovranità territoriale degli
stati corrispondeva la sovranità economica, della quale una condizione fondamentale era il carattere
nazionale dei mercati, compresi quelli finanziari (situazione ben espressa dalla prassi della Banca
d’Italia di acquistare il debito pubblico italiano). Il ‘welfarismo’, che prevedeva che gli Stati
riservassero ampia parte delle loro risorse economiche alla creazione di strutture amministrative
destinate a offrire servizi alla comunità (dalla scuola alla sanità, alla previdenza sociale, al sostegno
delle imprese mediante il credito, al supporto di investimenti infrastrutturali) corrispondeva inoltre a
una sorta di politica di ‘accreditamento’ della maggiore bontà dei sistemi occidentali capitalistici
rispetto a quelli orientali comunisti. La struttura dell’economia, basata sulla produzione industriale,
si accordava alla costruzione di un modello di vita basato sull’impiego stabile della forza lavoro,
alla quale lo Stato offriva anche, mediante i sistemi democratici-rappresentativi, una forma di
espressione politica. La rottura di tutte e tre queste condizioni (e cioè: la globalizzazione
dell’economia; il venir meno della divisione del mondo in blocchi; la scoperta di modi di produrre
ricchezza legati agli investimenti finanziari anziché alla produzione di beni materiali 17), avrebbero
comportato un enorme rafforzamento delle forze economiche, che oggi riuscirebbero a imporre le
loro necessità agli stati18. Queste forze economiche troverebbero un tramite negli organismi europei,
riuscendo a imporre tramite essi una visione del ruolo dello stato nell’economia favorevole ai loro
interessi, che vanno nel senso di ‘liberare’ ogni risorsa economica sottoutilizzate. A questo genere
apparterrebbero strutture come la sanità pubblica o la scuola pubblica, che gravano sui bilanci dello
stato e sottraggono enormi potenziali agli scambi economici. Finché queste strutture sono state utili
per garantire la pace sociale il loro costo appariva tollerabile. Venute meno quelle condizioni, e cioè
venuto meno il rischio che la popolazione scontenta scegliesse per via politica alternative diverse
allo status quo, quelle strutture appaiono costi inutili (di qui le regole che, vincolando gli stati al
pareggio di bilancio, di quelle strutture impongono la drastica riduzione, se non l’eliminazione). In
questo senso si osserva in modo suggestivo che una nuova ‘antropologia’ va emergendo.
Diversamente da quello fatto proprio da Costituzioni post belliche come la nostra (che mettevano al
centro il ‘lavoratore’ coi suoi diritti, un progetto di stato sociale e una grande sottolineatura della
partecipazione politica), il ‘modello di individuo’ presupposto dalla fase attuale che l’alleanza tra
sistemi economici e politici persegue è uno che ‘non presuppone tanto la disciplina della forza
lavoro e della sovranità politica, quanto la produzione, la formazione e la gestione del ‘capitale
umano imprenditoriale’, individui, cioè, permanentemente assoggettati al ‘rischio di impresa’”.
Starebbe emergendo cioè
“Una nuova ‘civilizzazione economica’ fondata su soggettività nuove prodotte attraverso il gioco della competizione,
dell’indebitamento, della precarizzazione, della polverizzazione del legame sociale, del consumo”19
17
E andrebbe aggiunto: la delocalizzazione dei processi produttivi in aree del mondo in cui il costo del lavoro è inferiore, la quale
comporta anche che la ‘forza lavoro’ che un tempo gli stati assumevano come blocco sociale esistente al proprio interno (in quanto
composto da cittadini) e che naturalmente richiedeva elementi di partecipazione politica tali da permettergli di avere una influenza
sulla vita pubblica, è oggi lontana dalla costruzione degli itinerari politici nazionali.
18
Del resto, sin dall’origine degli Stati nazionali (e cioè sin dall’epoca assolutistica) “il capitalismo ha sempre cercato la forma
politica a sé più corrispondente”, secondo una espressione del grande storico Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo
nell’età di Filippo II, II voll. (1949), trad. it. Einaudi, Torino, 1953.
19
Così A. Arienzo, Stato minimo e minimo di Stato. Sulla governance commissaria di mercato, in Aa.Vv., Il dirito del comune, ed.
Ombre Corte, 2013, p. 203 e 207, che rinvia anche all’opera, dal titolo espressivo, di M. Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato.
Saggio sulla condizione neoliberista, DeriveApprodi, Roma, 2012.
334
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Riflessi nel nostro paese
Tutto questo ha avuto importanti riflessi nel nostro Paese.
Nel 2009 è stata introdotta una legge di riforma della finanza pubblica, la legge n. 196, che ha
sostituito alla vecchia legge finanziaria la nuova legge di stabilità, peraltro con contenuti analoghi
ma che si muove in un ambito di scelte molto più vincolato. La nuova legge di contabilità dello
stato, infatti, che è la legge che disciplina la formazione della legge di stabilità e del bilancio,
prevede una classificazione molto rigorosa delle spese inscrivibili in bilancio (spese contabili,
inderogabili, legate a fattori legislative, a adeguamento del fabbisogno, modulabili e non
modulabili). Queste classificazioni servono a massimizzare la funzione di controllo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sia nei confronti delle spese delle amministrazioni pubbliche
che di quelle locali.
Nell’aprile del 2012 è stata poi approvata una revisione costituzionale che ha introdotto una nuova
versione dell’art. 81.
Il nuovo art. 81 Cost.
La legge cost. n. 1 del 2012, intitolata: “Introduzione in Costituzione del principio di pareggio di
bilancio”, ha modificato il testo della Costituzione in particolar modo riscrivendo l’art. 81, e l’art.
97 (in materia di pubbliche amministrazioni) 117 e 119 (in materia di regioni e enti locali)20.
Nel nuovo testo, l’art. 81 prevede che
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico, e previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuove o maggiori spese provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a 4 mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi stabiliti con legge
costituzionale.
Ad una prima lettura questa disposizione evidenzia alcune caratteristiche:
-la prima è quella di un ricorso a un linguaggio molto tecnico, molto preciso e dettagliato, che
ricorda più un manuale di economia che il fraseggio di un testo costituzionale (“ciclo economico”,
“fasi avverse”, “fasi favorevoli”);
20
1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico». «Art. 117. La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi intemazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (….)armonizzazione dei bilanci
pubblici; (materia prima affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni); «Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare 'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea”.
335
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
-la seconda è quella di ricorrere alla espressione ‘equilibrio tra entrate e spese’, in cui la parola
‘equilibrio’ equivale a ‘tendenza al pareggio tra le spese e le entrate’. Il ricorso all’indebitamento è
consentito solo in alcune ipotesi e non come metodo di ricercare l’equilibrio del bilancio. In tal
modo, a differenza del previgente art. 81, la nuova versione incorpora come obbligatorio un certo e
solo modo di fare il bilancio (e precisamente quel modo che non contempla il ricorso
all’indebitamento in funzione di sviluppo);
- la terza è quella di avere abrogato la previsione secondo cui “con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”, dalla quale si era sempre ricavata
l’incapacità della legge di bilancio di abrogare le leggi di spesa previgenti. L’abrogazione di questo
comma “permette al bilancio di modificare le altre leggi, dando la massima esaltazione alla
preminenza dell’interesse finanziario e della sua cura” [in quanto per es. una legge di spesa che
sostiene il diritto alla salute può vedersi posta nel nulla in nome dell’interesse al pareggio di
bilancio] (De Ioanna);
- la quarta è quella di avere sottolineato che la iniziativa del bilancio e in genere della politica
finanziaria è riservata al Governo (le Camere ‘approvano’ ciò che il Governo ‘presenta’: sono
espressioni in cui risuona l’idea liberale per cui, per le Camere, il bilancio è un prendere o lasciare).
- la quinta, in apparente controtendenza rispetto alla precedente (che sembra voler allontanare il
Parlamento dal processo decisionale di bilancio) è quella, invece, di rimettere al Parlamento, con
legge a maggioranza assoluta, la configurazione della legge di bilancio. Sul senso di questa
previsione torneremo più avanti21;
Il primo giudizio che gli interpreti hanno dato di questo complesso di caratteristiche del nuovo art.
81 è di aver voluto introdurre un determinismo nella decisione di bilancio che sembra voler
togliere spazio alla politica, ma forse di averlo voluto fare soprattutto ‘mediaticamente’ in quanto
proprio la rimessione alle Camere del potere di delineare la legge di bilancio può significare che si è
voluto affermare il principio con “riserva di disattenderlo” (Brancasi).
Bisogna però, prima di tirare conclusioni sul punto, anche considerare l’art. 5 della legge cost. n.
1/2012, che completa la riforma dell’art. 81, il quale stabilisce che:
1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale,
disciplina,
per
il
complesso
delle
pubbliche
amministrazioni,
in
particolare:
a)
le
verifiche,
preventive
e
consuntive,
sugli
andamenti
di
finanza
pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del
ciclo
economico,
all'inefficacia
degli
interventi
e
agli
eventi
eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo
economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi
eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli
effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un
piano
di
rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del
rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al
quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle
regole
di
bilancio;
21
Questa fondamentale revisione costituzionale (con la quale il Fiscal Compact è incorporato nel nostro ordinamento) è stata
approvata quando era in carica il governo ‘tecnico’ guidato da Mario Monti. L’approvazione della riforma è avvenuta in tempi
rapidissimi, e in un modo piuttosto coperto all’opinione pubblica. Nel giorno della sua approvazione solo un quotidiano ne dette la
notizia.
336
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli venti eccezionali
di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il
finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali
inerenti
ai
diritti
civili
e
sociali.
2.
La
legge
di
cui
al
comma
1
disciplina
altresì:
a)
il
contenuto
della
legge
di
bilancio
dello
Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione,
come
modificato
dall'articolo
4
della
presente
legge
costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza
pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa
delle pubbliche amministrazioni.
E’ questo articolo 5, secondo alcuni attenti osservatori, il vero elemento di innovazione e di
condizionamento. Di per sé, infatti, il testo dell’art. 81 nuovo, pur essendo frutto della “marcata
dalla prevalenza di scuole economiche liberiste (e delle forze economico sociali che le alimentano),
potrebbe essere comportare solo il rafforzamento di un “metodo di credibile programmazione
pluriennale del bilancio, che si è cercato inutilmente di far valere negli ultimi trent’anni”22.
L’art. 5 della legge costituzionale n.1, invece, va ben al di là di questo. Esso, ritendono molti
Autori, tende a escludere dalla decisione di bilancio la scelta politica e a subordinare gli organi
rappresentativi alla funzione di ratificare decisioni imposte da ideologie calate in visioni
economiche.
La legge cornice di finanza pubblica
L’art. 5 della legge cost. n. 1/2012 farebbe questo in due modi. Da una parte, l’art. 5 ‘cerca di dare
dignità di principi costituzionali a semplici regole contabilistiche”23. La legge cornice di finanza
pubblica che l’art. 5 prevede è praticamente pensata come la traduzione in norme giuridiche di
vincoli e tecniche di controllo della finanza pubblica, di fatti economici e di parametri di giudizio
che dovrebbero ‘imbrigliare’ la decisione politica di bilancio (la legge cornice di finanza pubblica
dovrebbe fare quello che fa un manuale di contabilità: stabilire quale è la causa degli scostamenti
rispetto alle previsioni, quali di essi sono dovuti al ciclo economico, quali all’inefficacia degli
interventi, quali agli eventi eccezionali; quando c’è una ‘grave crisi economica’, quando una crisi
finanziaria, quando una calamità). E’ in questo modo che si realizzerebbe la subordinazione della
politica a una concezione economica, in controtendenza con le scelte proprie delle democrazie, in
cui sono le visioni politiche, in quanto espressive degli interessi, dei bisogni e dei valori diffusi
nella società, a utilizzare le concezioni economiche per perseguire quella concezione della
convivenza, dei suoi valori e dei suoi fini che è di volta in volta condivisa dalla società. Perciò è
stato osservato che:
“Un’area monetaria integrata che intende andare verso assetti federali ha bisogno di vincoli e regole fiscali; ma c’è un
profilo più contingente, legato alla prevalenza di forze politiche determinate e ad una specifica visione delle cause della
crisi dell’euro, per cui queste regole sono conformate sulla base di specifiche interpretazioni della crisi e della netta
prevalenza della forza dei mercati finanziari.
Siamo di fronte alla prevalenza di una ben determinata ermeneutica della crisi, che rifiuta di riconoscere tre punti
fondamentali:
22
23
P. De Ioanna, op. cit., p. 46.
P. De Ioanna, op. cit., p. 54.
337
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
uno, che la globalizzazione è fonte di gravi problemi (ormai nessuno più sostiene che “la globalizzazione ci ha
arricchito tutti”: rischi finanziari, migrazioni, diseguaglianza, povertà globale e mutamenti climatici sono tutti temi che
vanno affrontati in modo coordinato dalle economie, ma con una visione istituzionale e politica alternativa ai soli
interessi dei mercati finanziari e chiaramente orientata alla difesa dei diritti in tutte le formazioni statuali;
due, che la scelta di lasciare debito da pagare ai figli e ai nipoti (dunque il ricorso all’indebitamento) può essere
perfettamente razionale se quel debito è servito a dotare l’economia di investimenti a fecondità differita (reti di
trasporto, energia, istruzione);
tre, che la crisi attuale non risale alle politiche statali di bilancio e finanziarie ma prevalentemente a una irresponsabile
condotta degli attori finanziari e creditizi privati.”
Così, mentre il valore della sostenibilità economica del debito e la sua utilizzabilità solo anticiclica,
sanciti nel nuovo art. 81, sono tutto sommato coerenti con l’idea costituzionale originaria del
bilancio come ricerca di un equilibrio finanziario,
“ciò che sembra inappropriato è la cavillosa e inutile definizione del limite massimo degli scostamenti, secondo una
ripetizione meccanica della formula dei vincoli comunitari, che appare solo strumentale a tenere stretta la disciplina sui
paesi indebitati ma ha molto discutibili agganci sul piano teorico e pratico. Sono infatti gli stessi economisti a insegnarci
che l’economia è un vivente fatto anche di istituzioni, di valori, di determinanti tecnologiche, demografiche, e
pertanto è assai dubbio che una regola finanziaria rigida, largamente convenzionale, riesca a dominare e tenere
le esigenze di uno sviluppo economico sostenibile e socialmente accettabile in una vasta area storicamente
differenziata, che usa una moneta unica e vuole procedere verso un’integrazione economico-sociale più profonda”24.
Il Fiscal Council
L’art. 5 esprime una scelta di scavalcamento della politica rappresentativa sulla decisione di spesa,
e lo fa anche prevedendo il nuovo “Fiscal Council”, l’ “organismo indipendente di finanza
pubblica” al quale le Camere dovranno “attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di
finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio”.
L’idea che presiede alla creazione di questo organismo25 si apre a giudizi molto duri, sebbene chi li
esprime non possa essere sospettato di radicalismo politico o fondamentalismo democratico.
“E’ lo sbocco, un poco ideologico, di una corrente di pensiero tecnocratico che ritiene e pratica una visione delle cose
che innesta a organismi indipendenti la ricostruzione della ‘neutralità’ dei processi economici. Questa visione può
produrre una dislocazione nuova del potere: c’è un luogo (potere) in cui si producono i dati su cui si deve esercitare la
discrezionalità politica. Ma intervenire su conoscenza e sui luoghi della conoscenza significa cambiare la struttura del
potere. C’è quindi un profilo che interroga sulla idea stessa di democrazia rappresentativa. Siamo di fronte ad una linea
di pensiero che si basa sul presupposto della sfiducia nella politica: la politica tende a produrre deficit eccessivi per i
comportamenti opportunistici e short sight dei politici (di qualunque schieramento). Gli organismi indipendenti
sarebbero il rimedio. Si vuole tracciare il parallelismo tra la politica monetaria che produce eccesso di inflazione e la
politica di bilancio che produce eccesso di deficit. Ma se nel primo caso la soluzione è stata individuata
nell’indipendenza della banca centrale dal potere politico, nel caso della politica di bilancio pensare di attribuirne
l’esercizio ad un organismo non eletto significa discutere delle forme di dislocazione del potere in una democrazia
rappresentativa. I parlamenti sono nati per stabilire quanto tassare, come tassare e come spendere le risorse pubbliche.
E’ impensabile che il parlamento sia espropriato da queste decisioni 26.
24
P. De Ioanna, op. cit., p.46, 54, 62, 63 e p. 61, da dove anche il paragrafo riportato in precedenza tra virgolette.
Che è stato istituito dalla legge n. 243/2012 col nome di “Ufficio parlamentare di bilancio” e come “organismo indipendente per
l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio”. E’ composto
di tre membri, nominati con decreto dei Presidenti delle due Camere all’interno di una lista di dieci nomi indicate dalle Commissioni
Bilancio delle due Camere a maggioranza dei due terzi. La struttura dovrebbe essere operativa a partire dal 1 gennaio 2014.
26
De Ioanna,p. 64, il quale inoltre osserva come l’insieme di controlli contabili introdotti sulla decisione di bilancio sia statale che
locale esprime” sin dalle prime mosse con cui il processo culminato nella revisione del 2012 ha preso l’avvio, ossia la legge contabile
196 /2006 , dando al Ministero dell’Economia e delle Finanze il controllo pieno sulle decisioni di spesa sia statali che locali, una
istanza di “controllo e centralizzazione che sono l’esatto opposto di autonomia gestionale, responsabilità del dirigente, autonomia di
scelta dell’ente territoriale, e in cui ‘i costi standard sono stati costruiti come tecnica di controllo fiscale che ha poco a che fare col
25
338
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Gli effetti sulla forma di stato e di governo, e sul ruolo della politica rappresentativa
Tutti i commentatori concordano che la riforma dell’art. 81 è il momento culminante di un processo
di arretramento del Parlamento, delle forze politiche (dunque dei cittadini) dalla decisione di
bilancio, che viene rimessa in mano agli esecutivi e decisa tra questi ultimi e gli esecutivi degli altri
paesi europei in un contesto più sensibile ai desiderata dei mercati che alle richieste e ai bisogni
della società. Per questo motivo, ciò che avviene a livello di costituzione finanziaria ha dirette
implicazioni sulla forma di governo, e sulla stessa forma di stato.
Molti dubitano infatti della compatibilità di una politica di bilancio orientata rigidamente al
pareggio con il progetto di società voluto dalla Costituzione, e prevedono che l’esito di queste
politiche sarà un grave impoverimento generalizzato, a causa della riduzione dell’estensione delle
attività di servizio della pubblica amministrazione e degli investimenti pubblici. Il principale vizio
che viene individuato nella riforma dell’art. 81 e nella legge cost. n. 1 /2012 è quello di avere
pensato di imbrigliare il ‘vivente’ che è l’economia in una regola contabile che, si teme, vuol solo
premiare interessi economici potenti e non volgersi a soddisfare bisogni reali.
In questa chiave, alcuni leggono anche il senso della condizione, posta nella legge di riforma di
bilancio, che gli interventi del Parlamento in materia avvengano con decisioni prese ‘a maggioranza
assoluta’, o il senso delle stesse preoccupazioni, presenti nel Fiscal Compact, che i parlamenti
‘partecipino’ alla decisione di bilancio, o il fatto che i membri del Fiscal Council debbano essere
scelti dalle Commissioni parlamentari competenti per materia con la maggioranza dei due terzi.
Sono preoccupazioni, queste volte a coinvolgere i parlamenti nelle decisioni di bilancio, che
esprimono una alta sensibilità per la qualità della democrazia, o altro? Secondo alcuni interpreti, a
farsi strada è una nuova concezione della politica parlamentare e partitica, vista dalle tecnocrazie
finanziarie come strada per la costruzione del consenso sociale di massa nei confronti della
‘ermeneutica della crisi’ da esse promossa, quella secondo cui non si può uscire dalla crisi se non
‘tagliando’ la spesa pubblica, riducendo gli investimenti, rimpicciolendo la pubblica
amministrazione e i servizi che offre. In altri termini, ricercare la partecipazione dei Parlamenti e il
coinvolgimento delle opposizioni, servirebbe a controllare gli esiti del processo democratico,
garantendo che essi non contraddicano quella ‘eremenutica’; esprimerebbe
“la necessità di far sì che pure le forze di opposizione, che magari, in occasione della elezione successiva, si apprestano
a diventare maggioranza, siano compartecipi delle scelte di politica economico finanziaria del Governo, siano tenute
informate e spinte a prendere pubblicamente posizione sull’indirizzo politico finanziario” onde non poter poi
disconoscere quanto fatto da un precedente Governo, sia pure di colore politico diverso 27.
Sarebbe il definitivo avversarsi di un sogno antidemocratico – intuito, come ricorderemo, da
Marcuse - che non ammette che dalla società nascano diverse prospettazioni del mondo, e che si
servirebbe di ‘forme democratiche’ per imporre una visione ‘unica’.
Il complesso e ambiguo significato dell’auspicato ‘coinvolgimento delle opposizioni’ nelle
decisioni di bilancio si riflette anche sui possibili effetti del nuovo “ Fiscal Council”. Secondo gli
intenti, il FC sarebbe un ‘meccanismo di tipo reputazionale’, un guardiano che controlla la politica
spendacciona e la denuncia all’opinione pubblica quando trucca il bilancio o basa le previsioni di
bilancio su previsioni troppo ottimistiche. Tuttavia, siccome il Fiscal Council non può impedire che
federalismo. E’ una tendenza inarrestabile o obiettiva se si vuole controllare la spesa, o è essa spessa alla base della perdita di
controllo? Siamo passati dalla retorica del federalismo che non c’è alla centralizzazione che c’è”.
27
N. Lupo, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Costituzione e pareggio di bilancio, cit.,
p. 134.
339
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
politiche di bilancio dissennate siano adottate, poi comunque il giudizio resterebbe agli elettori, e la
democrazia non sarebbe così tanto minacciata. Ma il problema è allora, in quale contesto, in quale
‘stato di salute’ della democrazia un organismo di questo genere viene innestato. Dove la stampa
libera e pluralistica è carente; dove manca una opinione pubblica istruita e attenta, dove i media
sono concentrati nelle mani di pochi, il suo innesto può essere molto pericoloso. Il che ci porta a
notare che una buona democrazia non è solo quella che vive nel momento elettorale, o attraverso i
partiti (che magari controllano gli organi di informazione, o ‘gestiscono’ gli orientamenti
dell’opinione pubblica). Quando è così, c’è il rischio che ciò che la maggioranza in parlamento fa,
specie se una maggioranza allargata alle opposizioni, non si trovi mai a confrontarsi col dissenso
attivo, costruttivo e percepibile dell’ opinione pubblica.
Linee ricostruttive
Anche coloro che sentono molto chiaramente i rischi di deriva antidemocratica legati alla attuale
fase di crisi finanziaria e ai modi in cui essa viene affrontata, riconoscono che una più ordinata
politica dei conti pubblici è un bene nell’interesse delle singole nazioni e del progetto di
integrazione federalisticamente inteso. Essi negano che ci fosse bisogno di riformare l’art. 81 per
perseguire politiche più rigorose: il vecchio art. 81 era adattabile a diverse modalità di politica
economica e di bilancio. Soprattutto, essi sostengono, non sono le regole contabili a poter governare
efficacemente i processi economici. Ma neppure il nuovo art. 81 impedisce come tale di affrontare
in modo costruttivo, aperto, democraticamente responsabile le sfide del presente. Sono tre i punti di
una possibile ‘ripartenza’:
-
Nel lungo termine, per offrire soluzioni valide alla crisi non bastano le misure contingenti di
contenimento degli spread28 o di iniezioni di liquidità nelle banche, che sono le politiche di
corto raggio sinora adottate con grande costo per i sistemi nazionali. “Per sottrarsi alla
stretta delle agenzie di rating e al chiarissimo conflitto di interessi che ne segna il metodo di
lavoro e le relative ‘note’ (cioè i ‘voti’ dati ai debiti sovrani), occorre mettere in campo,
praticare e realizzare obiettivi in termini di crescita, occupazione vera e competitività” (De
Ioanna). Occorre allora tornare alle cause vere della crisi in atto, che, come tutti ora
convengono, non è stata la indisciplina dei bilanci pubblici dei paesi mediterranei ma il
credito allegro e l’improvvido indebitamento del settore privato” (De Ioanna).
-
La costituzione economica materiale europea spinge verso la realizzazione di strumenti
fiscali e di bilancio tipici di un’area federale, ma perché ciò possa avvenire è necessario che
nel frattempo la Banca Centrale Europea, il bilancio pubblico europeo e gli investimenti
pluriennali sulle reti e sulle infrastrutture europee si muovano insieme, come strumenti
coerenti, propri di una unica area monetaria che crea ricchezza e opportunità. Se la
costituzione materiale evolverà in questa direzione e i mercati percepiranno che questa
evoluzione è chiara e irreversibile, il sentiero dell’Europa unita si aprirà di nuovo e sarà
anch’esso irreversibile. (De Ioanna).
-
La Costituzione economica deve trovare un punto di equilibrio trilaterale tra economia,
politica e diritto. Sottrarre all’autonomia della politica un grado cruciale nella sfera delle
scelte relative alla composizione delle politiche fiscali, è eludere e approfondire il problema.
Lo stesso approfondimento del processo di integrazione, se si invererà, non potrà che
produrre un superamento delle rigidità ora imposte alle economie nazionali: se lo sviluppo
28
Cioè del differenziale del rendimento dei titoli di stato, oggi considerato ‘segno’ del diverso stato di salute delle singole economie
nazionali.
340
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
ripartirà, la regola di pareggio dovrà essere collocata in un contesto che tratti in modo
specifico e appropriato le spese destinate ad investimenti pluriennali e a finalità differita,
da finanziare anche con la creazione di debito pubblico e privato.29
In altri termini, la nuova regola del pareggio non è un dato indiscutibile e la soluzione di tutti i mali,
anzi, mali nuovi può portare con sé, e, secondo molti, parecchi mali ha già portato, compreso lo
stato di depressione in cui l’economia della zona euro si trova da più di un decennio. La possibilità,
tutta politica, di tenere aperto il progetto costituzionale di società non è certamente bloccata dal
nuovo art. 81 ma richiede, per essere individuata e perseguita responsabilmente, di saper rivedere il
senso eccessivamente rigido, punitivo verso le società nazionali, e autoritario che la regola di
pareggio incorpora, e di saper al contempo salvare il buono di una nuova abitudine a concepire i
bilanci nazionali come elemento di un quadro più ampio.
29
De Ioanna, p. 78 e 79.
341
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
La forma di governo della Repubblica italiana
Nel nostro studio delle istituzioni pubbliche italiane abbiamo proceduto cercando di inserire il
modello di ‘democrazia costituzionale’ accolto dalla nostra Costituzione, del quale abbiamo
descritto le componenti (la forma di governo, i diritti e i doveri costituzionali, la giustizia
costituzionale, ecc.), nel quadro dell’insieme di trasformazioni e di vicende cui ha assistito la
seconda metà del Novecento e il primo decennio del XXI secolo, tra cui la crescente
internazionalizzazione delle politiche e delle economie; la trasformazione dei costumi, le persistenti
problematiche caratteristiche del sistema partitico italiano. A loro volta, tutte queste componenti si
sono riflesse in modo diretto o indiretto negli assetti concreti che la forma di governo ha assunto nel
corso del tempo e in particolare in un ganglio particolarmente espressivo delle dinamiche politiche e
istituzionali, che è quello della crisi e della formazione del nuovo Governo, che andiamo in questo
ultimo capitolo a ricostruire, partendo dalle disposizioni costituzionali più rilevanti in materia.
Art. 92.2. Cost. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, e, su
proposta di questi, i Ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
Ci è necessaria, inoltre, anche qualche precisazione terminologica.
Ricordiamo intanto che il Governo, secondo la nostra Costituzione, e a differenza delle Camere,
non ha una durata in carica prefissata: dura fino a quando ha la fiducia delle Camere. Per
comprendere i ritmi della vita del Governo, occorre poi tenere distinti due aspetti: l’essere in carica
e l’essere nella pienezza delle funzioni.
La condizione per cui il Governo è in carica inizia nel momento in cui il Governo è nominato, dal
Capo dello Stato, e presta giuramento di fedeltà alla Repubblica nelle sue mani, e cessa nel
momento in cui entra in carica il successivo Governo.
La condizione per cui il Governo ha la pienezza delle funzioni inizia nel momento in cui il
Governo riceve la fiducia delle Camere, e cessa nel momento in cui il Governo si dimette.
Pertanto, vi sono momenti in cui il Governo è in carica ma non ha la pienezza delle funzioni, e
questi momenti sono quelli del Governo in attesa di fiducia e del Governo dimissionario.
Il Governo in attesa di fiducia e il Governo dimissionario possono compiere solo atti di
ordinaria amministrazione, cioè atti che rappresentano esecuzione di scelte già deliberate o
adempimento di impegni già presi; inoltre, possono adottare atti improcrastinabili, necessari e
urgenti (decreti legge). Invece, gli atti di indirizzo politico, che introducono novità per il paese
(come la presentazione di un disegno di legge) sono riservati al governo che abbia la fiducia delle
camere. Dunque, quando c’è la crisi di governo significa che il governo in carica è dimissionario, e
cioè è in carica solo per l’ordinaria amministrazione o “compimento degli affari correnti”. Facciamo
l’esempio che per il 18 ottobre sia previsto un Consiglio dei ministri a Bruxelles, e per il 20 ottobre
un vertice internazionale in Italia. Il 16 ottobre il governo si dimette. I suoi ministri possono andare
a Bruxelles? Il presidente del Consiglio “uscente” può presiedere il vertice? Sì, perché sono ‘affari
correnti’; certo però potrà dire niente di vincolante per il paese, non potrà stipulare accordi nuovi,
perché non ha la fiducia.
342
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Una volta chiarite queste due diverse legittimazioni del Governo, che dipendono dall’avere o meno
la fiducia, occorre chiedersi quando si forma un nuovo Governo, quali sono le condizioni e le
circostanze che conducono all’esigenza di formare un nuovo Governo.
La formazione del Governo, ovviamente, è necessaria quando il Governo è dimissionario. Bisogna
però distinguere i casi in cui il Governo ha l’obbligo di dimettersi da quelli in cui si dimette per una
sua spontanea valutazione.
Il governo ha l’obbligo di dimettersi in tutte le situazioni in cui non può esservi dubbio che il
rapporto fiduciario è venuto meno. Tra queste situazioni una sola è obiettivamente prescritta in
Costituzione e cioè
a. quando, in corso di legislatura, il Governo ha ricevuto un voto di sfiducia delle Camere
(crisi parlamentare), situazione che evidenzia in modo inequivocabile che la condizione per
la permanenza in carica del Governo, l’esistenza del rapporto fiduciario, è venuta meno;
Tuttavia, si ritiene principio inerente la logica della forma di governo parlamentare che il governo
sia obbligato a dimettersi:
b. in caso di morte o impedimento permanente del Presidente Consiglio. Il Presidente del
Consiglio essendo la figura più eminente del Governo, si presume che la sua scomparsa
determini il venir meno del rapporto fiduciario.
c. Dopo lo svolgimento delle elezioni, quando si è formata una nuova rappresentanza
parlamentare. I governi italiani si sono tutti dimessi dopo le elezioni, tranne il Governo De
Gasperi VII, primo della storia repubblicana, che rimase in carica a cavallo delle elezioni del
18 aprile 1948. Le dimissioni del governo davanti alle nuove camere sono un potente
riconoscimento della primarietà della rappresentanza parlamentare nella forma di governo, e
della ‘dipendenza’ del governo da essa. (I governi del periodo statutario non si dimettevano
mai dopo le elezioni.)
Il Governo può inoltre decidere spontaneamente di dimettersi quando avverte di avere perduto il
sostegno della maggioranza in parlamento anche se ciò non è stato formalizzato da un voto di
sfiducia. In questi casi si parla di dimissioni spontanee dovute a una crisi extraparlamentare (che
cioè non è stata sancita in parlamento da un voto di sfiducia).
Un voto contrario in Parlamento non determina obbligo di dimissioni, dice espressamente la
Costituzione. Se il Governo, durante una votazione in Parlamento, va in minoranza, non significa
che sia obbligato a dimettersi. Tuttavia una serie di voti contrari possono essere presi dal Governo
come indice che la sua maggioranza non è più coesa, è venuta meno, e indurlo a presentare
spontaneamente le dimissioni. Può bastare, per converso, anche una sola votazione contraria,
quando, per esempio per l’importanza del provvedimento su cui si esprime, riveli una crisi
particolarmente grave nella maggioranza.
La differenza tra il caso in cui il Governo ha l’obbligo di dimettersi e quello in cui esso si dimette
spontaneamente è che nel primo caso il Capo dello Stato ha l’obbligo di accettare le dimissioni del
Governo (che avranno effetto a partire dalla nomina del nuovo). Nel secondo no, e il Capo dello
Stato può invitare il Governo a riflettere, e soprattutto lo può invitare a presentarsi in Parlamento
per ufficializzare le ragioni delle proprie dimissioni (parlamentarizzazione della crisi), e accettare
le dimissioni solo dopo che questo è avvenuto. La parlamentarizzazione della crisi è una prassi che
risponde all’esigenza di chiarire in modo pubblico le ragioni politiche di una crisi di governo
avvenuta dietro le quinte, in modo che l’elettorato possa conoscere, della crisi, le cause e le
responsabilità.
Norme scritte e non
343
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Si faccia attenzione all’espressione, usata poco sopra: “si ritiene inerente alla logica della forma di
governo parlamentare che il governo sia obbligato a dimettersi….”, oppure ai riferimenti, che siamo
venuti facendo, alle ‘prassi’ (come la parlamentarizzazione della crisi). Stiamo procedendo tenendo
presenti due tipi di fonti che ci indicano il diritto, nel senso dei comportamenti doverosi, o legittimi,
preferibili, oppure sconsigliabili, o addirittura illegittimi, in relazione a certe situazioni (come
appunto la crisi di governo). Una fonte è la norma scritta (la Costituzione, che dice che il governo
deve dimettersi quando subisce un voto di sfiducia). Un’altra fonte è di tipo storico-culturale. Molto
spesso nel ragionamento giuridico si fanno derivare ‘norme’ da presupposti culturali; si individua il
diritto sulla base di ragionamenti che non tengono conto solo delle norme scritte e anzi servono
spesso a interpretare queste ultime, poiché esse non prevedono tutte le possibili ipotesi e perché il
mutare delle circostanze rende possibile estrarne nuovi significati. La dottrina, vale a dire gli
studiosi, tenendo presenti sia la storia di un certo istituto (nel nostro e in altri paesi); il quadro
complessivo in cui esso è collocato; le intenzioni di coloro che lo disegnarono e i problemi che essi
tenevano in considerazione; ecc., ricostruisce un ‘modello’ che serve a indicare come dovrebbero
essere affrontati i casi non espressamente regolati (e serve anche a discutere della legittimità o meno
di norme che, per esempio mediante una riforma, si vogliano introdurre per regolarli). Di questi
modelli fanno parte anche le ‘prassi’, cioè i comportamenti che gli organi politici tengono
spontaneamente (senza che alcuna norma li obblighi in tal senso). Per esempio, nel nostro
ordinamento, come detto, è stato per prassi che, da dopo le elezioni del 18 aprile 1948, tutti i
governi si sono sempre presentati dimissionari alle Camere quando esse si riuniscono per la prima
volta dopo le elezioni. Questa prassi è sempre stata giudicata del tutto corrispondente ai caratteri di
fondo della forma di governo parlamentare per come la nostra Costituzione la disegna: una forma di
governo in cui centrale è l’importanza del parlamento, unico organo eletto direttamente dal popolo.
Che il Governo si dimetta davanti alle nuove Camere è chiaramente un omaggio alla sovranità del
corpo elettorale: dimettendosi in quel momento il Governo accetta e mostra la propria dipendenza
dalle Camere e dal corpo elettorale. Siccome questa prassi appare corrispondente allo ‘spirito’ della
Costituzione, essa è stata considerata anche doverosa. Tuttavia, le prassi cambiano. Dopo le
elezioni del febbraio 2013 il Governo Monti, che aveva rassegnato le dimissioni nelle mani del
Capo dello Stato, non si è presentato però al parlamento per una discussione sulla fiducia che
accertasse il suo stato di governo dimissionario. Cambiando, le prassi denotano altrettanti
cambiamenti, più o meno vistosi e profondi (ma di solito profondi, per quanto magari poco vistosi o
resi poco visibili all’opinione pubblica). Come vedremo nel corso di queste pagine, gli anni a noi
più vicini hanno conosciuto una serie di modifiche a prassi fino ad allora sempre osservate (una,
quella delle dimissioni del Governo davanti alle Camere neoelette), novità che, se si consolidassero
come ‘prassi’, cioè fossero sentite come legittime e doverose, segnalerebbero un notevole
allontanamento delle forma di governo vigente nel nostro paese dal ‘tipo’, dal ‘modello’ che si era
venuto consolidando e l’affermazione di un modello nuovo.
Il conferimento dell’incarico a formare il Governo
Una volta che il Governo è dimissionario si deve dunque procedere alla formazione del nuovo. Dal
punto di vista formale, cioè degli adempimenti che devono essere effettuati, le tappe sono le
seguenti: il Presidente della Repubblica nomina un certo uomo politico “Presidente del Consiglio
incaricato”, incaricato cioè di formare il nuovo Governo. Il personaggio “accetta l’incarico con
riserva”, con riserva cioè di riuscire davvero nell’intento. Compito del Presidente del Consiglio
incaricato è stilare il programma di Governo, trovare un accordo con altre forze politiche intorno ad
esso, e formare la lista dei ministri; dei sottosegretari, che sono gli immediati collaboratori dei
Ministri e rappresentano cariche molto importanti politicamente, e a individuare il nome
dell’eventuale Vice Presidente del Consiglio, che è una carica non necessaria che talvolta viene
affidata, per rispondere a esigenze di equilibrio politico, cioè di rappresentanza nel Governo di
esponenti forze politiche che lo sostengone. Se riesce, il Presidente del Consiglio incaricato torna al
344
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Quirinale, scioglie la riserva e accetta l’incarico di Presidente del Consiglio, quindi egli, insieme ai
Ministri, giura fedeltà alla Repubblica nelle mani del Capo dello Stato. In questo momento il nuovo
Governo è formato ed entra in carica (e le dimissioni del vecchio Governo, rimasto sino a
questo momento in carica per gli affari correnti, hanno effetto) e iniziano a decorrere i 10
giorni entro i quali il Governo deve presentarsi alle Camere per avere la fiducia. Una volta
ricevuta la fiducia, il Governo assume la pienezza delle funzioni e può cominciare a porre in
essere atti di indirizzo politico, che saranno gli atti volti all’attuazione del suo programma.
I soggetti che hanno voce nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato
Ma: come avviene la nomina del Presidente del Consiglio incaricato? Di chi è effettivamente questo
potere? Chi ha voce in capitolo su quella scelta? Quali criteri e limiti il Presidente della Repubblica
deve osservare nell’esercitarlo? I soggetti che possono avere voce in capitolo nella scelta del
Presidente del Consiglio incaricato (e, in genere, nella formazione di un nuovo Governo) sono più
di uno.
a) I partiti politici
La regola generale è che, in entrambi i casi astrattamente possibili vale a dire, sia che il Governo sia
caduto in corso di legislatura, sia che ci si trovi a inizio di legislatura, è che il Presidente della
Repubblica deve dare l’incarico di formare il Governo alla persona che appaia in grado di
formare intorno a sé una maggioranza, come è naturale dato che il Governo deve avere la
fiducia delle Camere, e la fiducia viene data da una maggioranza dei parlamentari, che
rappresenteranno il punto di riferimento dell’azione del Governo. La maggioranza di deputati e
senatori che hanno votato la fiducia sarà quella stessa maggioranza dalla quale il Governo si
aspetterà di vedere approvati i propri provvedimenti, la maggioranza che gli consentirà di realizzare
il suo programma, dunque è naturale che il Capo dello Stato, ponendosi il problema di dare
l’incarico per formare il Governo, cerchi di individuare una persona che può essere in grado di
coagulare intorno a sé una maggioranza. Questo fatto porta il potere di nomina sostanzialmente
verso i partiti, ed è naturale che sia così, posto che sono i partiti che esprimono i parlamentari, che
votano la fiducia (come del resto coloro che vanno a comporre il Governo come Ministri, e il
Presidente del Consiglio). Ciò è del resto ciò che i costituenti, quando hanno immaginato e definito
il procedimento di formazione del Governo, prevedevano: erano uomini di partito, sapevano che i
partiti cui appartenevano avrebbero costituito l’ossatura della forma di governo futura. Il ruolo dei
partiti nella formazione del Governo corrisponde a una norma non scritta tipica di una democrazia
parlamentare a base partitica quale è indubbiamente quella prefigurata dalla Costituzione.
b) Il Presidente della Repubblica
Titolare del potere di nomina è però il Presidente della Repubblica, e non si tratta e non si è mai
trattato di un potere soltanto formale: come torneremo a ricordare, il Presidente della Repubblica ha
certamente una influenza nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato (non si limita a
‘registrare’ le indicazioni dei partiti; anche perché queste possono non esserci, o avere difficoltà a
emergere, e compito del Presidente è svolgere un delicato lavoro di tessitura e mediazione che aiuta
i partiti a trovare intanto un accordo intorno alla figura del Presidente incaricato). Nemmeno però si
tratta di un potere ‘proprio’ del Presidente. E’ sempre stato considerato certo che il Presidente della
Repubblica non può nominare un “suo” uomo, nel senso di un uomo politico che gode della sua
sola fiducia. A ciò ostano precisi elementi formali: il Capo dello Stato non è un organo responsabile
politicamente, non è un organo di indirizzo politico, e inoltre è vero che ha il potere di nomina del
345
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Governo, ma non ha il potere di revoca, il che indica che, ben diversamente dal Monarca statutario,
il Presidente della Repubblica non instaura un rapporto fiduciario col Governo. Ma all’idea di
un Presidente del Consiglio uomo del Presidente della Repubblica osta soprattutto il fatto che il
Governo deve avere la fiducia delle Camere, dunque dei partiti: se il prescelto non ha il consenso di
questi, non avrà la fiducia e non vi sarà alcun Governo. Il tentativo di un Presidente della
Repubblica, Antonio Segni, nel 1964, di dare vita a un ‘proprio’ esecutivo contrapposto a quello che
si delineava negli accordi tra le forze politiche fu da queste rigettato. La prassi delle ‘consultazioni’,
in base alla quale, prima di conferire l’incarico, il Presidente incontra le diverse forze politiche, è
sempre stata considerata naturale e doveroso corollario della peculiare posizione che il Capo dello
Stato ha nelle crisi di governo, che è quella di mettersi a servizio delle forze politiche per facilitare
un accordo del quale esse sono le autrici e le depositarie. Le consultazioni, infatti, limitano la
discrezionalità del Presidente (che deve dare l’incarico alla persona che avrebbe il consenso dei
partiti, anche se egli non condivide questa scelta).
Che cosa succede se i partiti non sono in grado di esprimere una maggioranza che sostiene un
Governo, di indicare un possibile Presidente del Consiglio, e ogni tentativo del Presidente di
‘aiutarli’ a trovare un accordo fallisce? In queste situazioni il Presidente della Repubblica deve
sciogliere le Camere e indire le elezioni, dalle quali esca un assetto nuovo dei rapporti di forza tra
i partiti, tale da superare, auspicabilmente, lo stallo che si è creato. In situazioni di grave crisi
economico-finanziaria e di totale sbandamento del sistema dei partiti è accaduto che ricorrere ad
elezioni apparisse impossibile o fosse sconsigliato dagli stessi partiti: allora (nel 1993, 1994 e 1995)
il Presidente della Repubblica ha nominato tre governi ‘tecnici’ cioè guidati e composti da
personalità in tutto o in parte estranee al sistema dei partiti, ma comunque accettati da essi. Nel
2011 si è assistito a un fenomeno analogo, anche se caratterizzato da una autonomia di decisione del
Presidente della Repubblica - che ha indicato il possibile futuro Presidente del Consiglio prima delle
dimissioni ufficiali del Governo e dunque prima di sentire i partiti, mostrando con ciò piuttosto
chiaramente di voler prescindere dalle loro indicazioni - non paragonabile per intensità e
importanza a quella che si era registrata nel 1993-1995. In ogni caso, la figura del governo ‘tecnico’
è un unicum italiano e sotto molti profili rappresenta una prassi ritenuta più che discutibile da molta
parte della dottrina, perché riduce a un ruolo solo formale la fiducia delle Camere e il loro ruolo di
indirizzo e controllo sull’operato del Governo.
c) Il corpo elettorale
Sulla nomina del nuovo Governo hanno una naturale influenza i partiti, ma in che misura la loro
mediazione è necessaria? Sarebbe ammissibile, a Costituzione vigente, un governo eletto dal
popolo? No, perché il governo deve avere la fiducia delle Camere, non direttamente del corpo
elettorale. La mediazione dei partiti è, secondo la Costituzione vigente, resa necessaria dal fatto che
il Governo deve avere la fiducia delle Camere. Il ruolo dei partiti nella formazione del governo era
esaltato quando c’era la legge elettorale proporzionale e nessuno di essi poteva da solo disporre
della maggioranza assoluta nelle Camere.
Le leggi elettorali maggioritarie, che tendono a fare uscire dalle elezioni l’indicazione della
maggioranza di Governo, tendono però stesso anche ad attenuare l’influenza dei partiti sulla
formazione del Governo, o, più precisamente, a restringerla al solo partito o coalizione di partiti che
ha vinto le elezioni. La scelta del Governo viene spostata verso il corpo elettorale, attenuando la
mediazione partitica, o meglio: accentuando il ruolo del partito che vince le elezioni e azzerando
quello dei partiti che perdono le elezioni, con l’effetto di ridurre la dialettica tra i partiti e la
voce che le minoranze hanno nelle cose pubbliche.
Se si mettono insieme gli elementi che emergono da questo breve schema, e cioè, da una parte, la
recente decisa acquisizione di autonomia del Presidente della Repubblica dal sistema dei partiti
nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato, e la più risalente tendenza a scavalcare i partiti
nella fase di formazione del Governo per assegnarla al corpo elettorale, si vede abbastanza
346
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
chiaramente che la tendenza intorno alla quale si è mossa la forma di governo negli ultimi vent’anni
è stata quella di ricercare una autonomia del governo dal sistema dei partiti. Il che potrebbe non
suscitare alcun rimpianto, beninteso, data la grande crisi di credibilità che li affligge; ma lascia
scoperto il problema della rappresentanza politica, di una dialettica tra maggioranza e opposizione
equilibrata, di un rapporto effettivo tra elettorato e indirizzo politico.
Le vicende della crisi e formazione del Governo nella storia repubblicana e i loro riflessi
sull’assetto dei partiti, i poteri del Parlamento, il ruolo del Capo dello Stato.
Gli elementi che abbiamo raccolto ci dicono che il concreto assetto dei partiti, e il tipo di sistema
elettorale adottato, che lo condiziona, influiscono in modo determinante nel rendere più o meno
ampio lo spazio di valutazione che spetta al Presidente della Repubblica intorno alla nomina del
Presidente del Consiglio, e anche nel determinare quali sono i soggetti che hanno voce in capitolo
nella valutazione che il Presidente della Repubblica farà. Ora è il momento di provare a mettere
questi fattori in connessione tra loro e a vederne l’articolazione nel tempo.
L’epoca del proporzionale: i governi di coalizione a centralità democristiana dalle alleanze di
centro-destra alle alleanze di centro-sinistra.
Secondo quanto era accaduto per le elezioni all’Assemblea Costituente, e come sappiamo, il
sistema elettorale italiano è stato un sistema proporzionale fino al 1993. Era un sistema che
garantiva alle diverse componenti dell’elettorato di rispecchiarsi in modo eguale nel Parlamento.
Questo era molto importante, perché sin da prima che i lavori in Assemblea Costituente si
chiudessero, si delinearono elementi che avrebbero influito in modo decisivo sull’assetto dei partiti
e sulla forma di governo in Italia. Il corpo elettorale divideva le sue preferenze tra un grande partito
trasversale cattolico (la Democrazia Cristiana) e il Partito comunista, contornati da una serie di
partiti minori. Nel quadro della guerra fredda, di divisione del mondo in due blocchi, che sarebbe
stato siglato dal Patto Atlantico nel 1949, l’Italia si schierò con i paesi occidentali. Fu subito chiaro
che nessun esponente del Partico comunista avrebbe mai potuto aspirare a essere Presidente del
Consiglio, e neppure membro del Governo: il Pci e il Psi uscirono già nel 1947 dal ‘governo di
unità nazionale’ che era stato costituito dopo le elezioni all’Assemblea Costituente per non farvi
mai più ritorno, almeno nel caso del Pci.
La conventio ad excludendum.
La vita repubblicana si impostò dunque subito su una regola non scritta ma saldissima, chiamata
conventio ad excludendum (accordo a escludere) e che diceva appunto che il Pci (e inizialmente
neppure il Partito socialista) non poteva esser parte del Governo. Verosimilmente, lo stesso ampio
consenso dottrinale intorno alla regola non scritta per cui il Presidente deve dare l’incarico a una
forza politica che sia in grado di formare intorno a sé una maggioranza rifletteva la conventio ad
excludendum, perché quella regola significa che l’incarico non deve essere necessariamente dato al
partito che ha più voti degli altri, ma a quello che può coagulare intorno a sé una maggioranza.
Così, per il caso che si fosse realizzato il famoso ‘sorpasso’ (e cioè che il Partito comunista
superasse per numero di voti la Democrazia Cristiana) era precostituita la regola per cui nonostante
il successo elettorale il Partito comunista non avrebbe avuto l’incarico di formare il Governo.
Anche la legge elettorale proporzionale, se, sotto certi profili, ha un altissimo significato
democratico (lo abbiamo poco sopra menzionato: quello di dare a qualunque orientamento che
abbia un seguito nel corpo elettorale una chance di avere una rappresentanza parlamentare), trovava
forse la sua più profonda ragion d’essere nella ‘conventio’: siccome la legge elettorale
proporzionale rende più difficile a un partito di ottenere da solo la maggioranza assoluta (che gli
garantisce di avere alla prova dei fatti quella maggioranza semplice necessaria a governare), essa
sfavoriva l’eventualità che il Partito comunista vincesse le elezioni. E’ una cosa molto singolare, se
347
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
ci si pensa bene, che sistemi elettorali che favoriscono la cd. ‘alternanza’ (cioè il fatto che governi
di volta in volta il vincitore delle elezioni) sono stati adottati in Italia (e verosimilmente nel mondo)
solo in presenza di un sistema dei partiti in cui viene meno ogni componente di ‘alternativa’, cioè in
cui, sia che governi un partito, sia che governi un altro, fondamentalmente la ‘visione del mondo’
presupposta è comune, nel senso di molto simile. Non poter andare al Governo ha certamente
corrisposto in parte agli interessi dello stesso Partito comunista: nella vigenza della conventio ad
excludendum i suoi vertici potevano intessere con la DC quelle alleanze che, come vedremo,
portarono il Partito comunista a sostenere all’atto pratico molta parte delle politiche dei governi
democristiani in vista della promessa di un graduale ingresso del partito comunista nelle coalizioni
di governo; e potevano d’altronde dichiararsi nell’ “impossibilità” di perseguire invece quelle
politiche per cui molto del suo elettorato lo votava. In altri termini, è possibile che la condizione di
attesa e mediazione cui il sistema proporzionale sommato alla conventio ad excludendum metteva il
Partito comunista sia stata conveniente per una concezione verticistica della politica che ha sempre
caratterizzato questa formazione (per cui la base, il popolo, deve essere guidato da più consapevoli
vertici e frenato nelle sue aspirazioni che non si fondano su sufficienti consapevolezze); quella
condizione ha anche permesso al partito di elaborare la complessa partita, in termini di selezione dei
gruppi di volta in volta dominanti nel partito, nascente dallo svolgersi della complicata relazione
con l’Unione sovietica, da un lato, e con altri partiti della sinistra in Italia, in particolar modo col
partito socialista, dall’altro lato30.
I governi di coalizione
Il sistema elettorale proporzionale aveva dunque il ruolo essenziale di garantire ai partiti esclusi dal
Governo – e al loro elettorato - almeno una significativa rappresentanza in Parlamento, a
compensazione della loro non parità di chances sulla formazione del Governo. Se si tiene conto che
nella rosa dei partner impossibili di governo è stato ricompreso, almeno da un certo periodo in poi,
anche il Movimento sociale italiano, partito di destra erede dell’esperienza fascista, si comprende
come la DC sia diventata la naturale candidata a guidare i Governi e ad esprimere la maggioranza
dei Ministri al loro interno; tanto più che alle elezioni del 18 aprile 1948 le consegnarono quasi la
maggioranza dei consensi (48,5%, mentre il Fronte popolare, Pci+Psi, scende al 31%). Non
esprimendo però da sola la maggioranza, la DC si è sempre dovuta appoggiare a partiti piccoli, e i
governi hanno assunto la struttura di governi di coalizione.
All’inizio la DC orientò le sue alleanze verso i partiti conservatori (Pli, Pri, Psli), orientati
politicamente a centro-destra.
La posizione della DC si rivelò assai difficile: grande partito cattolico e interclassista, rischiava
continuamente di essere schiacciata e strumentalizzata da un lato dalla Chiesa, che voleva interferire
sui programmi e sulle scelte di direzione politica del paese, dall’altro dagli interessi americani,
mediati in Italia soprattutto dagli industriali. Come l’analisi dello storico Paul Ginsborg ha fin
troppo insistentemente dimostrato, la Dc degli inizi temeva di essere ridotta a comitato d’azione di
potenti gruppi di interessi e di non detenere un solo briciolo di autonomia.
Qui si inserì il grande progetto politico di Alcide De Gasperi, lo statista democristiano che fu
presidente del consiglio ininterrottamente dal 1945 al 1953: De Gasperi intendeva rafforzare la DC ,
e per farlo voleva rafforzare il Governo, facendo in modo che esso disponesse di una maggioranza
ampia e solida, che riducesse la possibilità delle opposizioni di assaltarlo in Parlamento e che lo
mettesse al riparo dalle influenze interessate dei suoi stessi amici (che operavano all’interno del
partito attraverso le sue ‘correnti’, che ne raggruppavano le diverse anime e orientamenti).
La tecnica immaginata fu una nuova legge elettorale, che abbandonasse il meccanismo
proporzionale sino a quel momento adottato, e funzionasse, invece, secondo un meccanismo
maggioritario tale da assegnare ad un partito come la DC, che in quel momento col proporzionale si
30
Per chi volesse approfondire, il romanzo di Ermanno Rea Mistero Napoletano rappresenta, nell’affascinante narrazione costruita
intorno alla ricostruzione dei motivi che spinsero negli anni ’50 una militante comunista al suicidio, una straordinaria indagine sulle
caratteristiche del partito comunista italiano.
348
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
muoveva già verso il 50% dei voti, una maggioranza sufficiente a governare da solo: ma nelle
elezioni del 1953, in cui il meccanismo (che passerà alla storia come “legge truffa”, subito
abrogata31) fu applicato, il premio di maggioranza non scattò. Però il passaggio è importante: con
esso compare un protagonista che non abbandonerà più la vicenda repubblicana: il tema del governo
forte ed autorevole, della ricerca di una ’autonomia “istituzionale” del Governo dai partiti, fatta
peraltro nel nome degli interessi di un partito, che tendeva a identificarsi con lo Stato. Sin dal suo
apparire, in altri termini, il tema del ‘rafforzamento del Governo’ appare il rivestimento di un più
concreto obiettivo, il consolidamento della parte politica che esprime il Governo.
La legge truffa: il primo capitolo di una ritornante tendenza a voler riformare le istituzioni e
il loro funzionamento per ‘salvare’ i partiti e rispondere al loro deficit di disciplina interna
Vale la pena soffermarsi un attimo di più sul passaggio rappresentato dalla vicenda della ‘legge
truffa’. Come abbiamo appena detto, essa fu giustificata come una risposta a una esigenza di
rafforzamento del Governo, e in pratica questo significava rafforzare il partito, a quel tempo la DC,
che normalmente esprimeva il Governo. Fin dal suo primo apparire, in altri termini, la riforma della
legge elettorale (che si ripresenterà nel 1993, nel 2005, e che, nel 2013 è ancora aperto)si presenta
come una scorciatoia per tentare di risolvere un carattere persistente e problematico, ai fini della
stabilità del Governo, dei partiti politici italiani (ante e post Repubblica), cioè la loro scarsissima
disciplina interna. Come è stato spiegato molto bene almeno sin dalla fine dell’800, il motivo di
fondo che rende tanto stabile la forma di governo parlamentare in Gran Bretagna (e per cui quando
governa un partito, si segue la politica da questo decisa; quando governa l’altro, si segue la politica
da quest’ultimo decisa: cd. ‘alternanza’), è la fedeltà degli eletti al partito32; questa stessa
condizione, peraltro, rende stabili i governi di coalizione tedeschi. Infatti non importa avere il 50%,
60% o 80% dei seggi in Parlamento, se poi i corrispondenti voti sono incontrollabili, se i gruppi
parlamentari, in corso di legislatura, si spaccano, si sciolgono e si rifondono, se i deputati della
maggioranza votano contro di essa, ecc. Siccome i partiti italiani non riescono – o non vogliono –
dare vita al proprio interno a una consimile disciplina, essi accusano le norme costituzionali sulla
forma di governo, e/o la legge elettorale, di causare l’instabilità di governo; laddove essa dipende
dal comportamento degli eletti e dai rapporti di forza interni ai partiti. La legge elettorale approvata
nel 2005, cd. Porcellum, che tanta perplessità ha suscitato per avere abolito il voto di preferenza
(onde i candidati sono eletti secondo l’ordine in cui il partito li mette in lista, ciò che dovrebbe
rafforzarne la dipendenza dal partito stesso33), è stata verosimilmente il tentativo più esplicito che i
partiti hanno fatto di ottenere dai propri eletti quella fedeltà così fondamentale per consentire al
31
Nelle considerazioni che abbiamo fatto sopra circa la convenienza che la legge elettorale proporzionale aveva per il PCI troviamo
alcune delle ragioni che spinsero, a quell’epoca, a suscitare nell’opinione pubblica la più forte ostilità verso quella legge, non a caso
negativamente chiamata ‘legge truffa’.
32
Questa precisazione si trova con esemplare chiarezza nel volumetto di W.T. Thornton, Parliament without Parties, in Macmillan’s
Magazine, XLI, 1880 (ristampato da Frewston Books Online 2011). La forma di governo inglese è stata sempre guardata dall’Italia
come un inarrivabile modello di buon funzionamento del regime parlamentare.
33
Il voto di preferenza in Italia è sempre stato all’origine di comportamenti particolaristici all’interno dei partiti. Ogni eletto, sapendo
di esserlo in forza di un ‘suo’ pacchetto di voti, se ne faceva forte per contrattare i propri comportamenti nei confronti del partito.
Inoltre il voto di preferenza è stato anche all’origine di comportamenti clientelari: grato ai suoi elettori, il deputato cerca di rendere il
favore impegnandosi a far dirottare risorse verso la zona territoriale da cui proviene, o il gruppo sociale che lo esprime. Queste sono
state le giustificazioni, nel 2005, che hanno portato all’abolizione del voto di preferenza. Tuttavia, siccome ciò non ha portato a una
significativa maggiore disciplina interna di partito, si deve ritenere che il modo in cui i candidati sono posti in lista dai partiti rifletta
di fatto rapporti di forza interni al partito.
34
Lo stesso Thornton la giudicava molto negativamente: in realtà, la sua opera era tutta dedicata a dimostrare che la tendenza
italiana al ‘trasformismo’ permetteva all’indirizzo politico di recepire i mutevoli orientamenti dell’opinione pubblica molto di più di
quanto non facesse il disciplinato sistema inglese, che rendeva gli eletti obbedienti ai capi partito anziché agli elettori; la debolezza
dei governi aveva in Italia per contrappeso a suo avviso un ‘intelligent criticism’ che arricchiva il dibattitto pubblico; e alla fine
promuoveva maggiore collegialità e concordia, dovendo la maggioranza sempre ricercare accordi con l’opposizione.
349
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
partito – e cioè al suo gruppo dirigente – quando esprime il Governo (e anche quando sta
all’opposizione) di farlo senza temere tradimenti dai suoi stessi membri. In sostanza, con quella
legge, così simile alla legge truffa (anzi, quest’ultima conferiva un premio di maggioranza più tenue
di quello garantito dal Porcellum, perché fissava una percentuale di voti da raggiungere affinché il
premio scattasse, mentre il Porcellum assegna il premio al partito che ha semplicemente ottenuto
più voti degli altri, per quanto bassa la percentuale complessiva raggiunta possa essere), i partiti
hanno scaricato propri problemi interni sugli elettori, riducendo la possibilità per gli elettori di
scegliere gli eletti. Tutto questo viene qui notato non per plaudire alla disciplina di partito34, ma per
far notare che molto spesso i partiti inviano agli elettori e all’opinione pubblica messaggi assai
distorti, che nascono dalla identificazione tra le loro esigenze e i loro problemi con le esigenze e i
problemi delle istituzioni. Essi dicono: ci vuole questa o quella riforma, una nuova legge elettorale,
o una riforma della costituzione che garantisca più forza al governo, per ottenere cose, come la
fedeltà degli eletti al partito, che nessuna disposizione è in grado di creare, perché sono realizzabili
solo mediante comportamenti orientati in un certo senso. I partiti hanno bisogno di controllare i loro
eletti, e dicono agli elettori che vogliono la stabilità di governo. Ce ne passa, anche perché molti di
coloro che, di periodo in periodo, inneggiano alla necessità di una nuova legge elettorale o di una
riforma costituzionale che dia ‘stabilità al governo’ sono i primi a essersi resi responsabili di quei
‘ribaltoni’, passaggi di gruppo parlamentare e ‘tradimenti’ vari, che sono alla radice della instabilità
del Governo in Italia. A questa assenza di veridicità, cioè di tendenza a dire il vero anziché il falso,
dalla nostra scena pubblica, sono da attribuire gli esiti spesso sconcertanti della nostra storia politico
costituzionale.
I governi di coalizione
Col fallimento del progetto De Gasperi, la formula del governo di coalizione divenne inevitabile:
ed ebbe avvio una traiettoria che – anche col favore del clima internazionale di “disgelo” negli anni
’60 - vide le alleanze di governo, inizialmente centriste (1953-58), spostarsi verso il centro sinistra,
con l’ingresso dei socialisti prima nella maggioranza che sostiene il Governo in Parlamento (19581963), cioè che non vota contro di esso al momento della fiducia, poi nella formula di governo,
ovvero con propri Ministri (1963-1976). Questa traiettoria incluse, in modo sempre più visibile,
l’esigenza e il problema dell’attrazione del Partito comunista nella maggioranza di governo. Ciò che
accadrà, ma solo nella forma del sostegno parlamentare del Pci al Governo, e non in quella
dell’entrata di suoi esponenti nella compagine ministeriale, nella fase c.d. della solidarietà
nazionale (1976-1979).
L’esperienza dei governi di coalizione sembra aver portato con sé una serie di inconvenienti, in
particolare quello della strutturale debolezza dell’indirizzo programmatico del Governo, che deve
tener conto delle diverse concezioni e interessi dei diversi partiti che lo compongono ed è esposto al
rischio di venire continuamente tradito.
A questo riguardo va peraltro tenuto presente che, all’epoca che stiamo considerando (e per i
successivi venti anni), quasi tutte le votazioni in Parlamento si facevano a voto segreto, ed era
facilissimo che deputati e senatori appartenenti a partiti di governo, votassero contro ai
provvedimenti di quest’ultimo in parlamento (cd. ‘franchi tiratori’). Nonostante il peso dei partiti
che lo compongano possa essere, e fosse di fatto, molto diverso, con la DC che da sola aveva il 30%
dei voti e, per esempio, il Pli che non arrivava al 2%, il governo di coalizione tende a dare ai partiti
piccoli un potere di ricatto che ne aumenta in modo sproporzionato il potere di influenza, posto che,
ritirando il proprio appoggio al governo, possono provocarne la caduta.
34
Lo stesso Thornton la giudicava molto negativamente: in realtà, la sua opera era tutta dedicata a dimostrare che la tendenza
italiana al ‘trasformismo’ permetteva all’indirizzo politico di recepire i mutevoli orientamenti dell’opinione pubblica molto di più di
quanto non facesse il disciplinato sistema inglese, che rendeva gli eletti obbedienti ai capi partito anziché agli elettori; la debolezza
dei governi aveva in Italia per contrappeso a suo avviso un ‘intelligent criticism’ che arricchiva il dibattitto pubblico; e alla fine
promuoveva maggiore collegialità e concordia, dovendo la maggioranza sempre ricercare accordi con l’opposizione.
350
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Come abbiamo anche in precedenza notato, ci sono peraltro che ci sono paesi, come la Germania,
che sono andati avanti per decenni con governi di coalizione senza avere alcuno di questi problemi.
Ogni istituto infatti funziona in un modo o nell’altro non per suoi caratteri propri, ma per il contesto
in cui opera: da noi, come osservavamo poco sopra, i partiti hanno visto i loro eletti dare più peso
alle proprie convenienze elettorali che all’impegno preso di sostenere il governo. Per spiegare
l’instabilità governativa da noi nel periodo consociativo (cioè il fatto che i Governi duravano poco,
le crisi erano frequentissime) occorre anche capire che, in quel periodo, la crisi di governo era quasi
un evento fisiologico, anziché patologico, perché la caduta di un governo, dando l’occasione di
formarne uno nuovo, era un momento di ridefinizione dei reciproci rapporti di forza tra i partiti,
che erano in continua evoluzione.
Così si può senz’altro dire che il governo di coalizione è stato nel nostro paese la proiezione
nelle istituzioni delle strategie dei partiti.
In effetti, è stato detto che la ricerca di una formula politica di governo (delle alleanze, cioè, su cui
costruire il Governo) era in quel contesto l’essenza stessa dell’attività di governo: quest’ultimo è la
risultante di complessi equilibri tra i partiti e le correnti al loro interno, in particolare le correnti
interne alla Democrazia cristiana, vale a dire i diversi raggruppamenti di uomini politici che si
riconoscevano in un ‘capocorrente’ a seconda dei propri orientamenti più o meno progressisti. Gli
equilibri tra i partiti e tra i partiti e le correnti condizionano la vita e il percorso dell’istituzione
Governo.
Sottesa ai lenti cambiamenti di coalizione, di personale politico, al succedersi di uomini politici ora
in questa o quella carica ministeriale, al variare numerico della presenza di rappresentanti di questo
o quel partito nella coalizione di governo vi era effettivamente una strategia politica precisa:
sarebbe sbagliato e molto riduttivo, in altri termini, pensare che tutti quegli accordi e ri-accordi
fossero fatti solo per passare il tempo mentre si rimaneva attaccati alle poltrone. La caduta e
ricomposizione dei governi, lo sfilarsi di una corrente della Dc da un esecutivo o l’ingresso di un
partito di minoranza erano altrettanti avvenimenti che assumevano senso rispetto a una strategia che
tendeva al progressivo ampliamento della base politica del governo. Era la strategia che,
secondo una parte della DC (ma con l’aperta ostilità di altre sue parti), doveva condurre all’ingresso
del PCI nel Governo, e della quale uno degli artefici fu il politico democristiano, già deputato in
assemblea costituente, Aldo Moro.
Questa strategia aveva anche il significato di tendere a realizzare una graduale integrazione nelle
istituzioni di una società articolata e in mutamento, al passaggio del potere da un blocco di destra a
alleanze più ampie capaci di rispecchiare la ricchezza di componenti della società civile. E’
verosimile, o almeno così si credeva allora, che l’alternativa sarebbe stata o il governo delle sole
destre o il governo delle sole sinistre, in un paese che, invece, divideva i suoi consensi elettorali e le
sue passioni politiche tra un centro cattolico (perennemente superiore al 30% nelle elezioni di
quest’epoca) e il partito comunista (che si muove lievemente sotto il 30% ed è il maggiore partito di
opposizione). C’erano dei buoni motivi per pensare che quello prescelto fosse il modo migliore di
procedere: nel 1964, sotto la minaccia della ‘strategia della tensione’35, la nostra giovane
democrazia aveva corso il rischio del colpo di stato di destra: è questo l’anno in cui il Presidente
della Repubblica Segni tentò di dare vita un proprio esecutivo contro la tendenza di una parte della
DC (cui pure egli apparteneva) di aprirsi ad alleanze a sinistra; nel 1970 le invocazioni di un
governo forte, di una svolta presidenzialista, assunsero il segno di una contrapposizione, da parte
delle forze conservatrici, verso le politiche di moderato progressismo su cui il paese era ormai
avviato. I governi di coalizione, in altri termini, furono ampiamente dovuti alla presa d’atto che o il
governo era appoggiato dai partiti, espresso e condizionato da essi, oppure non si sarebbe aperta che
35
La serie di attentati dalla matrice ignota che culminò nel 1969 con la Strage di Piazza Fontana, a Milano. Secondo alcune
ricostruzioni il Presidente della Repubblica Antonio Segni nel 1964 avrebbe appoggiato un piano militare che contemplava
l’eventualità dell’arresto di uomini politici di sinistra e di repressione armata delle manifestazioni di piazza (cd. Piano Solo). Poiché è
del 1963 il primo ingresso dei socialisti al Governo, si può capire mettendo insieme questi due dati quanto complesso fosse lo
scenario politico in cui si avviava l’esperienza dei governi di centro-sinistra.
351
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
una via autoritaria. Nel 1960 la strada di un governo autonomo dai partiti era stata tentata, col
Governo Tambroni, monocolore democristiano sostenuto dai voti missini che pretese di rimanere in
carica contro la volontà del partito e contro le manifestazioni di piazza ad esso contrarie, cui rispose
schierando le forze dell’ordine. Questo aveva reso piuttosto evidente che la rivendicazione
dell’autonomia dell’istituzione Governo rispetto ai partiti apparve poteva implicare, nel contesto di
allora, una svolta autoritaria.
I governi di coalizione dunque segnano un percorso che è andato nel senso di includere nel governo
un numero crescente di partiti e di attribuire un peso sempre maggiore alla sinistra; e li si ricorda
come ‘consociativi’ perché le loro prassi si basavano sul coinvolgevano l’opposizione nel governo,
anche se non all’interno dell’organo governo, ma altrove. Per esempio e tipicamente in Parlamento:
la prima volta che il Pci vota a favore di un provvedimento del governo è nel 1968, e si inaugura la
fase di una legislazione sociale e progressista.
La prassi consociativa ha determinato un’intera interpretazione costituzionale, influendo sul ruolo
del parlamento, sui poteri del governo, e in particolare sull’esercizio dei poteri normativi di
quest’ultimo e sulle movenze del rapporto fiduciario, e sulle attribuzioni del Presidente della
Repubblica.
Prassi consociativa e poteri normativi del governo: centralità parlamentare, abuso del decreto
legge, sorgere della questione di fiducia
In quest’epoca il Parlamento, in quanto luogo espressivo di tutte le componenti del sistema partitico
era la sede in cui vengono prese le decisioni, da quelle alte di politica generale alla piccola regia
della politica redistributiva (quella che stabilisce quali gruppi sociali o interessi beneficiano della
spesa pubblica). Questa stagione fu detta della “centralità parlamentare”, perché nessun
provvedimento del Governo poteva essere adottato, se non con un significativo apporto di voti
parlamentari che venivano dall’opposizione. In queste circostanze, il momento dell’esame di un
disegno di legge in parlamento era davvero cruciale e poteva riservare molte sorprese. In generale,
il procedimento era lento e lungo, perché era necessario assicurare anche una larga partecipazione al
dibattito, con relativi emendamenti e modifiche, da parte di quella qualificata minoranza che non
poteva mai essere al Governo; il Governo poteva facilmente andare in minoranza; quando un
provvedimento suscitava troppe riserve e difficoltà tra le varie forze politiche veniva ‘insabbiato’
(cioè il relativo esame in parlamento si fermava); ecc.
Talvolta, su grandi provvedimenti in materia di diritti civili o sociali, si è dato il caso in cui il
governo, e specialmente la Democrazia cristiana, è riuscito a portare a termine l’approvazione di
una legge grazie al voto favorevole dell’opposizione, cioè del Partito comunista, che otteneva in
cambio che il provvedimento assumesse contenuti sui quali questo partito era disposto a concordare
(è il caso delle grandi leggi in materia di diritto di famiglia; di istituzione del servizio sanitario
nazionale; di chiusura dei manicomi).
Più spesso, il Governo si trovava di fronte alla quasi certezza che qualunque atto di iniziativa
legislativa avesse presentato esso sarebbe stato insabbiato o stravolto dalla sua stessa maggioranza,
mentre non poteva contare sull’appoggio del Partito comunista perché non si trattava di grandi
misure in cui anche quel partito poteva ritrovarsi, ma di misure quotidiane di governo sulle quali
l’opposizione aveva scarsa ragione di dare una mano all’esecutivo in carica. Così, invalse la prassi
che tutte quelle misure che erano necessarie non per fronteggiare situazioni straordinarie, ma per
governare il paese, e che avrebbe richiesto troppo tempo approvare con legge, venivano adottate
con decreto legge. Ciò era politicamente conveniente per due motivi: intanto, il decreto è
immediatamente in vigore e quindi è, di fatto, un modo per “fare qualcosa”, per provvedere; poi,
siccome per convertire il decreto legge il parlamento ha un certo tempo a disposizione, ma non
moltissimo, durante il procedimento di conversione le varie forze politiche presenti in parlamento
erano più interessate a “saltare sulla diligenza” (la diligenza, in questa metafora, è il decreto legge
che passa di gran carriera in parlamento) e cercare, con modifiche ed emendamenti, di introdurre
352
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
nel decreto disposizioni gradite a sé, al proprio elettorato, che sarebbero rapidamente entrate in
vigore.
Nacquero così i “decreti omnibus” (i decreti fatti di tutto): il governo faceva un decreto legge in
materia di edilizia, per dare un sostegno al settore edilizio, e usciva una legge di conversione che
conteneva norme in materia di edilizia, e di ogni altra cosa potesse in qualche modo esservi
connessa (parcheggi, svincoli stradali, tariffe, concessioni, sanità). Questa è una chiara violazione
della logica stessa del decreto legge, che, dovendo avere carattere straordinario e fronteggiare
situazioni di emergenza, dovrebbe avere anche un contenuto omogeneo e coeso intorno all’obiettivo
cui il decreto risponde; ma nella misura in cui il decreto diventava il sostituto di un atto di iniziativa
legislativa (si disse al riguardo che in sostanza, quando il Governo presentava un decreto per la
conversione, esercitava un atto di iniziativa legislativa rafforzata) occorreva accettare che il
Parlamento lo modificasse (perché altrimenti il Parlamento si sarebbe trovato nella condizione di
doversi limitare a ‘ratificare’ provvedimenti del Governo, finendo per venire espropriato dalla
funzione legislativa, che invece detiene).
Si cominciò poi a verificare il caso sempre più frequente che, proprio per la ricchezza di
“manipolazioni” di cui i decreti erano oggetto, che i sessanta giorni non bastassero per l’esame, e
allora, per non far decadere il decreto, il governo lo ritirava dall’esame delle camere un giorno
prima della scadenza e il giorno stesso ne ripresentava un altro con identico contenuto, che ripartiva
il suo iter di conversione (che andava a saldarsi a quello già in corso). Con questo sistema
(reiterazione del decreto legge) i decreti restavano “provvisoriamente” in vigore anche per un paio
d’anni.
Invalse inoltre la prassi per cui il Governo, vedendo che il decreto in corso di conversione assumeva
contenuti troppo lontani da quelli che il governo aveva effettivamente inteso dettare, oppure che i
tempi della conversione diventavano imprevedibili, lunghissimi, iniziò a porre la questione di
fiducia sulla conversione del decreto.
La questione di fiducia è un atto (non previsto dalla Costituzione) con cui il Governo incide sul
rapporto fiduciario. Esso consiste nella dichiarazione rivolta dal Governo alle Camere che se un
provvedimento quel giorno in votazione non sarà approvato, il Governo intenderà questo voto
contrario come un voto di sfiducia e si dimetterà. I regolamenti parlamentari assegnano alla
questione di fiducia un effetto molto forte: essa fa decadere tutti gli emendamenti e il
provvedimento si vota per come il governo lo aveva originariamente presentato, oppure con
quei soli emendamenti che il governo decide di fare propri inserendoli nel testo del decreto (di
solito ricorrendo a un unico emendamento-fiume, detto maxi-emendamento).
La questione di fiducia è un perentorio (o disperato) richiamo del governo alla propria maggioranza,
che viene richiamata al suo dovere di sostenere il governo cui ha dato la fiducia, pena l’ “andare
tutti a casa”.
Il ricorso alla questione di fiducia sul decreto legge ha segnato la definitiva trasformazione
del decreto legge in un atto ordinario di legislazione e strumento di attuazione dell’indirizzo
politico. Oggi, anche se le cose sono molto cambiate nei rapporti tra Governo e parlamento, i
governi rispetto al periodo di cui parliamo, e nonostante il ‘consociativismo’ venga a parole tanto
deprecato, nessun governo ha mai rinunciato alla comoda e rapida via del decreto legge, che,
grazie alle prassi consolidatisi nello scenario della consociazione, rappresenta uno strumento cui il
governo ricorre si può dire quotidianamente per svolgere il proprio indirizzo politico.
E’ vero che, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, vi sono stati alcuni interventi della Corte
costituzionale che sono intervenuti per ‘correggere’ le prassi ormai consolidate in materia di
decretazione d’urgenza. In particolare, nel 1996 la Corte costituzionale ha emanato una sentenza, la
n. 360sa (pronunciandosi su un decreto, in materia di smaltimento dei rifiuti, che era stato emanato
nel 1994), ha dichiarato l’incostituzionalità della prassi della reiterazione dei decreti in mancanza
dei presupposti di necessità ed urgenza.
Tuttavia, proprio all’epoca di quella decisione il quadro politico diventava tale per cui il tempo
richiesto per la conversione dei decreti da parte del parlamento era molto minore che una volta
353
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
(oggi, per esempio, è un tempo brevissimo, essendo la maggioranza di governo, coi governi
maggioritari, divenuta relativamente più forte). In quel contesto i Governi avevano meno bisogno di
reiterare i decreti; è probabilmente per questo che solo a quell’epoca, e non certo in precedenza, la
Corte abbia posto in evidenza l’incostituzionalità della prassi della reiterazione. Se il problema
della reiterazione è dunque venuto sostanzialmente meno vuoi perché i Governi, sia pure in modo
relativo, hanno un maggiore controllo della loro maggioranza e dunque i decreti vengono convertiti
più rapidamente il dato di fatto del ricorso al decreto legge senza i presupposti di necessità ed
urgenza come costituzionalmente intesi è rimasto tal quale.
Ruolo dei partiti e del Presidente nella Repubblica nella formazione del Governo all’epoca
della consociazione
Nel periodo che stiamo descrivendo i partiti politici, tutti, sia di maggioranza, che di opposizione,
avevano voce in capitolo quando si trattava di formare un nuovo governo. Intanto, la rosa dei
partner possibili era molto ampia (un governo di coalizione contava mediamente cinque o sei
partiti) ma la disponibilità di ciascun partito (e delle diverse correnti democristiane) ad entrare in un
certo governo dipendeva da chi sarebbe stato presidente del consiglio, ovverosia dalle ‘garanzie’
che costui, per il suo profilo politico, dava in un senso o in un altro. Poiché il comportamento delle
opposizioni (o del secondo partito di maggioranza relativa, come si chiamava allora il PCI) in
parlamento era determinante per la sopravvivenza politica di un governo, certamente anche il modo
in cui la vedeva questo partito aveva un peso tutt’altro che secondario nella formazione del governo.
Tutto ciò ha influito moltissimo sul ruolo che il Capo dello Stato ha assunto nella formazione del
Governo, e in generale sulle aspettative che si nutrivano verso di lui e disegnavano ciò che egli era
autorizzato a fare o non autorizzato a fare. Il Presidente della Repubblica, destinato a stare in carica
sette anni, cioè un periodo lungo in cui molti spostamenti potevano accadere, doveva essere un
uomo politico gradito a una rosa vasta di partiti, e tale, per la sua biografia politica, da fare da
garante nel senso che gli spostamenti che si profilavano all’interno delle coalizioni potessero
avvenire: doveva essere cioè una figura ‘compatibile’ con un certo quadro politico presente, e coi
suoi svolgimenti futuri. Doveva essere una persona dotata di credibilità e autorevolezza verso le più
varie forze politiche, perché a lui toccava compiere tutte le mediazioni e le trattative il cui esito era
la scelta di un certo uomo politico come Presidente del Consiglio.
La prassi delle ‘consultazioni’ lunghe anche per settimane, che traghettavano da un governo a un
altro in quest’epoca, era la cifra di tutto questo: dal Capo dello Stato ci si attendeva un ruolo
‘maieutico’, la capacità di ‘far venire fuori’ la formula politica possibile. Il suo ruolo nella
formazione del governo si profilava come ancillare alle esigenze dei partiti e due esempi lo resero
chiaro. Uno lo abbiamo già ricordato: nel 1964, caduto il governo Moro I di centro sinistra, la
formazione del nuovo governo offriva l’occasione di contrastare il consolidamento di quella
formula progressista. Il Presidente della Repubblica Segni accarezzò l’idea di dare vita a un
“governo di emergenza, affidato a personalità cosiddette eminenti, a servitori disinteressati dello
stato, che nella realtà del paese qual è, sarebbe stato il governo delle destre, con un contenuto
fascistico-agrario-industriale” (sono parole dell’esponente socialista Pietro Nenni); l’idea –
contornata dalla convocazione al Quirinale di un generale dell’esercito poi implicato in un progetto
di colpo di stato, il generale De Lorenzo – fu arginata dai partiti. Questo episodio dichiarò
l’evidenza, e cioè che un governo del solo presidente non era possibile finché c’erano i partiti.
L’altra vicenda fu quella della Presidenza Leone: in un susseguirsi di scandali, Leone fu costretto
alle dimissioni: ma le analisi hanno ritenuto che le dimissioni di Leone corrisposero in realtà
all’esigenza del sistema dei partiti di allora (siamo a cavallo del 1978) di andare verso una formula
di governo allargata al PCI, di espungere Leone che, per il suo profilo molto conservatore, non si
prestava a questa operazione.
354
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Apogeo e crisi della fase consociativa: i governi di solidarietà nazionale
Il progetto di allargamento graduale della formula di governo al partito comunista doveva fare i
conti, da un lato, con l’ostilità verso di esso da parte di componenti della stessa DC e di molte
componenti di altri partiti; dall’altra, con la crescita elettorale del Partito comunista, che
evidenziava le contraddizioni della conventio ad excludendum. Le elezioni del 1976 segnarono un
forte avanzamento comunista; ma era ‘troppo presto’ per gli altri partiti e per la DC, per avere il Pci
nel Governo. Nell’impossibilità di dare vita a una qualunque altra formula, venne formato un
governo guidato da Giulio Andreotti, sorretto dalle astensioni di una maggioranza che raccoglieva
tutto l’arco costituzionale dei partiti, compreso il PCI, e che fu detto ‘governo della non sfiducia’.
Il Governo ‘delle astensioni’ di cui questo governo Andreotti non fu l’unico esempio è un governo
di minoranza, cioè privo dell’appoggio positivo di una maggioranza delle forze politiche
presenti in parlamento, e che in grado di ottenere la fiducia solo grazie alla astensione di uno
o più gruppi parlamentari presenti alla votazione. Secondo il regolamento della Camera, infatti,
le forze che si astengono dal voto non sono considerate presenti al voto, e questo abbassa la
maggioranza numerica per ottenere la fiducia, che è calcolata sui presenti. La collaborazione del
Pci al Governo riapparve con il quarto governo monocolore Andreotti, che ricevette la fiducia, nel
giorno del rapimento, da parte delle Brigate Rosse, di Aldo Moro – l’uomo politico che aveva
condotto a questa possibilità (Moro fu rapito mentre usciva di casa per andare a partecipare alla
votazione sulla fiducia). L’appoggio del Pci fu mantenuto fino al gennaio 1979 (Moro era stato
ritrovato assassinato nel maggio 197836), quando i comunisti uscirono dalla maggioranza dopo
avere chiesto un diretto ingresso nel Governo, e cioè di esprimere uno o più ministri, che non fu
concesso. Tutto questo portò alle elezioni anticipate nel 1979, che chiusero la stagione della
solidarietà nazionale e aprirono l’eclisse del partito comunista nella politica italiana, annunciarono
la decadenza della Dc e l’ingresso di nuovi attori, in particolare il Partito socialista, che non era un
partito nuovo, tutt’altro, ma seppe riorganizzarsi e riqualificarsi per ‘approfittare’ della crisi del
Partito comunista.
Il fallimento del progetto dell’unità nazionale ha avuto enormi conseguenze sulla storia politica e
costituzionale del Paese.
L’incapacità di prospettarsi un “dopo” al momento in cui “quasi”, coi governi di solidarietà
nazionale, il Pci era giunto al Governo, conferì ai rapporti tra i partiti e alle dinamiche della forma
di governo un asfittico tratto di autoreferenzialità: la strategia che aveva dato senso alle vicende
politiche post-belliche non esisteva più. Il piano delle alleanze di governo la propria funzionalità a
un decifrabile progetto politico-sociale e si ridusse sempre di più a mera tensione dei partiti a
conquistare e mantenere per se stessi una quota di potere.
Risaltarono perciò le tecniche “spartitorie” di composizione delle alleanze di governo: dove ogni
corrente e ogni partito si conquista una presenza bilanciata con le altre a seconda della propria
influenza, e dove ciascun ministro detiene una propria autonomia. Ciò che depresse il ruolo
direttivo del Presidente del Consiglio, e il piano programmatico dell’azione del Governo.
Il pentapartito e il tema del governo forte
Nel periodo post-solidarietà nazionale il sistema politico perde il suo duplice perno, rappresentato,
da un lato, dalla indiscussa titolarità della DC del compito di tenere in mano la ‘scacchiera delle
alleanze di governo’ tramite la presidenza del consiglio e, dall’altro lato, dal coinvolgimento del Pci
nelle decisioni importanti. Saltarono allora alcune prassi: in questa fase politica, che coinciderà con
la formula del “pentapartito”, cioè di governi composti da cinque partiti e a guida non
necessariamente democristiana, della sua preparazione e della sua crisi (1979-1992), la Presidenza
36
Per conoscere di più questa pagina importantissima della nostra storia, chi lo desidera può partire dal volumetto di Leonardo
Sciascia, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo, che, essendo stato pubblicato nell’autunno del 1978, cioè immediatamente a ridosso dei
fatti, riflette molto dall’interno quella stagione, i suoi protagonisti, le sue tensioni. Molto bello è anche il film di M. Bellocchio,
Buongiorno notte.
355
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
del Consiglio viene ceduta dalla DC prima al repubblicano Spadolini (1982), poi – e più
durevolmente – al socialista Bettino Craxi (1983-1987).
Nel 1984 il Partito comunista propose un referendum abrogativo sulla scala mobile, inteso ad
abrogare le norme che interrompevano l’adeguamento automatico delle retribuzioni al tasso di
inflazione; fortemente voluto da Enrico Berlinguer, questo referendum rappresentava un attacco del
Pci ai socialisti di Craxi, a quel tempo al Governo. Il referendum fu però osteggiato da moltissimi
internamente allo stesso partito comunista, che propendevano per l’alleanza con Craxi, e fu per il
Pci una sconfitta irrimediabile. Con la sconfitta del Partito comunista si aprì una nuova fase politica,
perché la governabilità “fondata sul ‘si può fare a meno del Pci’ sia nel confronto parlamentare sia
di fronte ai cittadini si mostrò vincente”37; questo determinò nel Partito comunista una crisi
strategica che avrebbe portato, nel 1991, allo scioglimento del partito.
A segnalare che il sistema dei partiti aveva perso il suo perno i suoi perni tradizionali, la VIII
legislatura, si aprì (1979) con l’intonazione del tema delle riforme, ed in particolare con
l’affermazione dell’esigenza di un governo “forte”.
Si trattava di una esigenza ancipite, che, in parte, esprimeva una volontà di rinnovamento resa
necessaria dal decadimento dei comportamenti politici; in parte, si faceva espressione e strumento
dell’interesse dei soggetti politici divenuti improvvisamente centrali nel sistema (perché
indispensabili a comporre una maggioranza di governo), ma elettoralmente deboli (e, tra
questi, essenzialmente del Partito Socialista di Bettino Craxi), per consolidare la propria
posizione a discapito degli altri concorrenti, e cioè degli altri partiti. Venute meno le condizioni
che avevano sino ad allora dato vita a prassi consolidate, era necessario individuare nuove regole.
Si delinearono due strade. Una tendeva verso una riforma della Presidenza del Consiglio in
funzione del rafforzamento del Presidente, ma nel quadro del mantenimento del sistema
parlamentare; l’altra, a scavalcare, con una riforma costituzionale, la forma di governo parlamentare
per andare a un sistema in cui un Presidente capo dell’Esecutivo è direttamente designato dal corpo
elettorale, cioè a una semplificazione delle forme di espressione politica, che resecasse la pluralità
di visioni di cui sono portatori i partiti e risolvesse la rappresentazione del corpo elettorale in
un’unica figura di Leader. Infine, sostenuta specialmente dai grandi partiti della passata stagione,
DC in testa, venne messa a tema anche una revisione in chiave maggioritaria del sistema elettorale.
L’idea era che un sistema maggioritario avrebbe comportato un ri orientamento del sistema politico
attorno a due grandi coalizioni, avviandolo verso un ritmo di alternanza, così consentendo anche al
Governo di raggiungere, senza bisogno di una riforma costituzionale, una nuova legittimazione, a
base elettorale e non più partitica.
Insieme al tema delle riforme costituzionali, si affacciò un metodo, per realizzarle, che si sarebbe
ripresentato nel 1997 e nel 2013, e che consiste nell’aggiramento del procedimento ordinario di
riforma costituzionale previsto dall’art. 138. Ricorrente tratto di questo metodo è la creazione di
una Commissione bicamerale, incaricata dello studio delle riforme necessarie. La Commissione
Bozzi (così dal nome del suo presidente, un uomo politico esponente del partito liberale) fu
insediata nel 1983. Era composta da 20 deputati e 20 senatori e lavorò per due anni, consegnando
alle Camere nel 1985 una relazione che però non ebbe seguito. E’ piuttosto chiaro che l’idea di dare
vita a una commissione bicamerale per lo studio delle riforme corrispondeva anche al tentativo di
individuare un organismo ristretto che permettesse ai partiti di trovare accordi per il futuro senza
immediati riflessi sull’Esecutivo in carica38.
37
Così E. Macaluso, P. Caldarola, Politicamente scorretto, La sinistra dalla Bolognina a oggi nel racconto controcorrente di un
protagonista, Dino Andino ed., 2012.
38
Una seconda bicamerale fu istituita nel 1992 e presieduta dal democristiano De Mita. La Commissione De Mita fu istituita da una
legge costituzionale, la n. 1/1993, che le assegnava poteri referenti nel procedimento di approvazione delle leggi costituzionali di
revisione. Anche questa commissione non raggiunse alcun risultato perché fu sciolta insieme alle Camere con lo scioglimento
anticipato del 1994.
356
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
I turbolenti anni del pentapartito non conquistano alcuno degli obiettivi di riforma costituzionale di
cui tanto si discusse, ma qualcosa iniziò a cambiare e cambiò effettivamente senza bisogno di
riforme costituzionali. Nel 1988 viene approvata la legge n. 400, sull’ordinamento della
Presidenza del Consiglio, che fu un primo riconoscimento di una maggiore statura istituzionale
dell’Esecutivo, specialmente con riguardo ai suoi poteri normativi. Fino a quel momento, i poteri
del Governo erano rimasti regolati da quel poco che della legge n.100/1926 rimaneva operante dopo
l’entrata in vigore della Costituzione (che aveva diversamente regolato in particolare i decreti legge
e i decreti delegati). La legge, da un lato, segna un tentativo, coerente con il disegno costituzionale,
di razionalizzazione della forma parlamentare e condivide, con altre leggi di questo periodo, la n.
142/1992 sulle autonomie locali e la n. 241/90 sul procedimento amministrativo, una capacità
riformatrice di discreto profilo, onestamente orientata ad agire sui gangli più deficitari del sistema,
col restituire vigore alle autonomie locali, trasparenza ed efficienza all’azione amministrativa, e
strumenti di azione al Governo. Dall’altro lato, la legge n. 400 offrì la piattaforma per un
rafforzamento dell’Esecutivo che va oltre le compatibilità del disegno costituzionale. Uno degli
obiettivi della legge n. 400/1988 fu indubbiamente quello di rafforzare i poteri regolamentari del
Governo, che ottenne una ‘scappatoia’ per introdurre norme senza passare dal procedimento
legislativo. Come sappiamo, con la legge n. 400 ha fatto la sua comparsi la delegificazione, il
meccanismo che consente la sostituzione dei regolamenti alla legge nella disciplina di intere
materie. L’avvento della delegificazione è molto importante, perché segnala che la stagione della
centralità parlamentare era finita: il fatto che la legge n. 400 la introducesse dimostrava che
ormai si riteneva che il Governo dovesse disporre di strumenti normativi e di politica che non lo
vincolassero a passare attraverso il Parlamento, a negoziare coi partiti, almeno non con tutti. Altro
sintomo di cedimento del Parlamento fu la creazione, ancora nella legge n. 400, della Conferenza
Stato Regione, un organo nel quale il Governo incontra gli esecutivi regionali, e raggiunge con essi
accordi e intese nel cui ambito esercitare le rispettive potestà legislative. Queste istituzioni
concertative tra esecutivi mettono tipicamente in posizione laterale le assemblee elettive.
Ambedue gli input (alla delegificazione e alla concertazione istituzionale) sarebbero peraltro
maturati solo dopo un po’ di tempo. L’esecutivo nazionale e regionale era, allora, ancora troppo
incerto per potersene avvalere convincentemente. Intanto però, il linguaggio politico e pubblicistico
delegittimava la cooperazione tra Parlamento e Governo (condannata come sintomo di
degenerazione consociativa) mentre i regolamenti parlamentari, riducendo i casi di voto segreto e
sanzionando il sempre più frequente ricorso del Governo alla questione di fiducia, preparavano un
rafforzamento dell’Esecutivo nel processo di produzione normativa.
La decretazione d’urgenza rimase però protagonista: è proprio in questo periodo che raggiunge il
suo culmine la prassi della reiterazione.
Questa prassi è la sigla di un sistema politico deprivato di progettualità e capacità decisionale
d’ampio raggio, ed estremamente debole, il cui tramonto sarebbe stato segnato dagli scandali di
“Tangentopoli”, come vengono designate le inchieste giudiziarie che rivelarono fenomeni corruttivi
in tutti i partiti, e portarono all’incriminazione del segretario del partito socialista, e primo uomo
politico socialista a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, Bettino Craxi.
Tangentopoli, la fine dell’assetto politico costituente, la virata verso il sistema elettorale
maggioritario.
Tangentopoli (o Mani Pulite) dette il via a un processo di scissioni e di ricostituzioni del grande
corpo democristiano (la DC cessa ufficialmente di esistere nel 1994); il Partito comunista intanto
ridefinì la propria identità, a partire da una serie di successivi cambi di nome e di composizione,
fino a scomparire ufficialmente, come poco sopra ricordato, nel 1991, anche per effetto del crollo
357
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
del mondo comunista; emersero nuove formazioni politiche, come la Lega, radicate territorialmente
e apertamente polemiche verso l’intero recente passato della storia repubblicana; nel 1994 sarebbe
stata la volta della ‘discesa in campo’ di un imprenditore privato, Silvio Berlusconi, che creò il
primo esempio di ‘partito personale’ in Italia, Forza Italia.
In sintesi, il sistema dei partiti italiano sofferse una lunga crisi di identità, che vide scomparire i
partiti che erano stati fino allora protagonisti e che avevano le loro radici nell’assetto costituente;
una crisi che frantumò il sistema dei partiti e lo mostrò ben lungi dall’esser capace di esprimere una
dialettica tra una maggioranza e una opposizione, e aprì invece gli argini alla pressione diretta degli
interessi di poteri privati sulle istituzioni, che è la chiave in cui si può leggere la ‘discesa in campo’
di Berlusconi.
Non sono pochi i commentatori che hanno fatto risaltare come sia la Lega Nord sia Forza Italia, il
partito di Berlusconi, si siano posti esplicitamente in opposizione ai principi della nostra
Costituzione (Berlusconi amava definirla ‘comunista’; la Lega aveva un programma apertamente
secessionista, che inizialmente pose problemi di compatibilità di questa formazione politica con
riferimento all’art. 5 della Costituzione: “La Repubblica è una e indivisibile”). Queste nuove
‘retoriche’ hanno segnato uno scarto enormemente significativo nella storia del Paese e sono
certamente una delle scaturigini di un progressivo venir meno, da parte delle forze politiche, dei
riferimenti alla Costituzione e alla sua attuazione, e dell’emergere di prospettazioni che, della
Costituzione, rilevano sotto vari profili la ‘inattualità’ e la necessità di riforma.
Nella convulsa fase di Tangentopoli, il ruolo di capro espiatorio toccò alla legge elettorale
proporzionale: una campagna d’opinione non sempre disinteressata sostenne prepotentemente che
erano sue le colpe del pluripartitismo, della scarsa efficienza decisionale del sistema, della
corruzione, del consociativismo … l’abrogazione avviene a furor di popolo nel 1993, ma (anche ad
ammettere la bontà dell’obiettivo) era ovvio che l’abrogazione del sistema elettorale proporzionale
non avrebbe significato che, immediatamente, il sistema politico si sarebbe ricostruito secondo
quella che si chiama una logica bipolare, cioè su due partiti o due grandi schieramenti che si
candidano alternativamente al governo, forti del sostegno di una stabile maggioranza. D’altronde,
era anche da prevedersi, come dicevamo, che cambiando la legge elettorale non cambiava
l’elettorato, i ‘nuovi partiti’ si affannarono a cercare di conquistare, soprattutto, i numerosi e
preziosi elettori ‘centristi’ che erano stati il sostegno della Democrazia Cristiana. Così, il sistema
dei partiti uscì ancora più polverizzato dalle prime prove del nuovo meccanismo elettorale, e del
tutto privo di un soggetto politico dotato di una legittimazione sufficiente a proporre una strategia
d’insieme condivisa dagli altri, mentre urgevano decisioni e riforme.
Vicende interne e integrazione europea
Nel 1992 l’Italia si è impegnata a riportarsi sui parametri di Maastricht, dei quali abbiamo parlato in
precedenza: la nostra appartenenza all’Unione europea, in vista dell’adozione della moneta unica
nel 2000, determinò doveri precisi, discendenti dall’obbligo di riportare il bilancio a convergenza
con le prescrizioni europee.
In quel tornante, il quadro internazionale e le problematiche interne si avvinghiarono: l’uno dette
una improvvisa sterzata alle altre, che, a loro volta, approfittarono degli input internazionali per
impostare, come vedremo, un certo tipo di uscita dal guado.
I riflessi della crisi del sistema partitico sui poteri del Presidente della Repubblica e del
Governo: i governi ‘tecnici’
In un quadro nel quale, sotto l’urgenza dei problemi del bilancio, l’azione di governo appariva
indefettibile, ma il sistema politico non esprimeva una maggioranza operativa, entrarono in scena i
governi tecnici, sulla cui formazione il Presidente della Repubblica ha un ruolo eminente: il
governo presieduto da Giuliano Amato dal giugno 1992 all’aprile 1993; il governo Ciampi
dall’aprile 1993 all’aprile 1994, che vide per la prima volta il governo presieduto da una personalità
358
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
che non veniva dal mondo politico (Amato era stato un importante esponente del Psi; Ciampi era
stato, invece, governatore della Banca d’Italia); il primo governo Dini, salito in carica dopo la
caduta del primo governo Berlusconi, dal gennaio 1995 al gennaio 1996, che fu l’unico dei tre i cui
ministri non erano di estrazione parlamentare, e, per la maggior parte, neppure membri di partito.
Si parla in tutti e tre casi di governi tecnici, anche se la loro composizione fu diversa e diverso il
loro rapporto col sistema dei partiti, perché questi governi proclamarono di non perseguire un
indirizzo politico proprio, cioè di non voler compiere scelte dipendenti da valutazioni di
opportunità, ma di proporsi unicamente di adottare le misure tecnicamente, oggettivamente,
imposte dalla situazione economica e in particolare dalla necessità di dare corso alle misure
necessarie per adeguare il Paese ai parametri di Maastricht.
Un primo riflesso della crisi del sistema dei partiti dopo Tangentopoli e nella fase del passaggio al
maggioritario fu dunque il cambiamento della posizione del Presidente della Repubblica nelle
crisi di governo. Nei casi ora citati, l’istituzione presidenziale assunse un ruolo di decisione, nella
scelta del presidente del consiglio incaricato e nella formazione del nuovo governo, mai fino ad
allora sperimentato.
La scelta dei ministri e la formazione del programma del governo Dini furono interamente co-decisi
dal Presidente della Repubblica (che era allora il democristiano Osca Luigi Scalfaro) e dal
Presidente del Consiglio incaricato, anch’egli un uomo che non veniva dalla politica: si trattava di
un programma di soli 4 punti, raggiunti i quali il governo si impegnava a dimettersi (anche se il
termine delle dimissioni di spostò un po’ alla volta in avanti), che erano altrettanti obiettivi orientati
alle ‘priorità nazionali’ e cioè al bilancio e alla manovra economica.
I governi tecnici hanno segnato inoltre, nel loro complesso, una stagione di notevolissima crescita
dei poteri del Governo. L’opinione che si era ormai radicata come indiscussa era che il Governo
deve poter decidere, fare, provvedere:, la già ricordata sentenza della Corte costituzionale del 1996,
che vietò la reiterazione dei decreti legge, confermò, rafforzandolo, l’orientamento del Governo
verso questi strumenti, legittimando un uso più perentorio del decreto legge, autorizzando
l’Esecutivo a pretenderne, da parte delle Camere, la conversione nei tempi previsti e, dunque,
riducendo l’intervento degli emendamenti, vale a dire la partecipazione delle minoranze.
I governi tecnici attinsero anche a piene mani agli strumenti normativi che la legge n. 400/1988
aveva predisposto. Esplose in questo periodo il ricorso al potere regolamentare e in particolare
alla delegificazione, il meccanismo che consente di sostituire la potestà regolamentare del governo
alle leggi già vigenti in una materia, e si rafforzò l’uso della delegazione legislativa. I governi
tecnici chiesero, e ottennero, amplissime deleghe, che si rivelarono un modo efficace e “comodo”
per il Governo di adottare atti con forza di legge evitando il procedimento parlamentare (e quel
minimo di confronto con le opposizioni che esso implica di necessità). Si configurò un modo di
normazione poi divenuto normale: il governo chiede al parlamento la delega a disciplinare una certa
materia, poi, nei decreti delegati, mette norme di delegificazione che autorizzano il governo (cioè se
stesso) ad emanare ulteriori regolamenti su ulteriori aspetti di quella materia o su altre che
prenderanno il posto delle leggi previgenti. ‘Naturale’ completamento dei regolamenti governativi
sono poi i regolamenti (decreti) ministeriali, con cui i singoli ministri adattano e completano,
integrano e modificano i regolamenti del Governo.
Elezione diretta del sindaco; riforma elettorale; riforma del pubblico impiego (privatizzazione);
avvio della riforma del sistema pensionistico, avvio e sviluppo della politica di dismissioni e
privatizzazioni del patrimonio pubblico, avvio della riforma della pubblica amministrazione: sono
solo alcuni dei provvedimenti adottati dai ‘governi tecnici’ i quali hanno costituito una sorta di
transizione non tra una formula di governo e un’altra, ma tra un modo di concepire il governo e un
altro. La loro esperienza ha costruito un modello di governo ‘forte’ consegnando agli Esecutivi
futuri una posizione e una quantità di poteri mai conosciuti prima. Essi hanno rafforzato in modo
359
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
decisivo quella che si chiama l’autonomia istituzionale del Governo, cioè la sua autonomia dalla
dinamica politica parlamentare.
L’impatto trasformativo di questa esperienza è stato profondissimo sul versante della pubblica
amministrazione, principale tramite, a sua volta, del rapporto tra Governo e società.
Dall’inizio dell’esperienza repubblicana sino ai primi anni ’90 il sistema amministrativo italiano
non aveva conosciuto significative trasformazioni, e tendeva ad assolvere una funzione non molto
dissimile da quella verso la quale si era avviato tra periodo statutario e fascismo: un apparato che è
molto presente nella società perché eroga servizi, è il datore di lavoro di moltissime persone, è,
anche, un canale di clientele, una fonte di spesa. Il sistema delle partecipazioni statali, l’intervento
pubblico nell’economia, la grande macchina amministrativa dei servizi pubblici coi suoi milioni di
dipendenti, avevano offerto un serbatoio di consenso ai partiti ma avevano anche sottolineato, nel
Governo, il ruolo di mediatore e di parte nelle relazioni economiche e sociali, restringendone il
margine decisionale, ancor più soffocato dall’immenso debito pubblico. Questa configurazione
dell’amministrazione si era perpetuata nonostante che la partecipazione dell’Italia all’Unione
europea implicasse da lungi la dismissione di molti apparati e di molte attività economiche gestite o
compartecipate dallo Stato – se non altro perché, rappresentando queste ultime, di solito, attività
aiutate da sovvenzioni pubbliche, o poste in posizione di monopolio, esse venivano a confliggere
con l’imperativo comunitario della libertà di concorrenza – ma con l’avvio degli anni ’90 cede, tutta
d’un colpo. La riforma del pubblico impiego (1993) muta i connotati di un rapporto di lavoro
considerato da sempre sinonimo di posto sicuro, regolato da leggi speciali: si passò in quel
momento a un registro di privatizzazione del rapporto (che venne ‘contrattualizzato’, cioè regolato
dalle norme comuni dei rapporti di lavoro anche privati) , mentre venne rafforzata la figura del
‘dirigente’, momento di trasmissione tra gli indirizzi politico amministrativi del governo e le
prestazioni dell’apparato, sicché il ruolo direttivo dell’Esecutivo nei confronti dell’amministrazione
è sottolineato. L’apparato amministrativo diminuì inoltre di dimensioni, mediante il processo di
dismissioni e privatizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, e di trasformazione della
condizione giuridica dei principali servizi statali (dal 1992), imputati, adesso, anziché direttamente
allo stato o a enti pubblici, a società per azioni. La novità rappresentata da queste ultime non è solo
che il loro capitale è in parte privato; è che le loro scelte di politica aziendale, il loro bilancio, il loro
personale, si imputano a loro stesse, assicurando al Governo un coinvolgimento che, se rimane
cospicuo (ad esempio, nel momento delle nomine dei vertici societari), è però meno visibile, il che
esime l’esecutivo dall’esser trascinato in modo diretto nei conflitti che dalle attività delle nuove
figure derivano. Un’altra importante innovazione istituzionale di questo periodo furono le autorità
indipendenti: enti separati dal Governo e destinati a regolare settori sensibili come le
telecomunicazioni, le borse, la circolazione dei dati personali. Prese il via in questo periodo anche il
processo cd. di federalismo amministrativo, che vede il passaggio della maggior parte dei
concreti compiti di gestione amministrativa dalle strutture statali a quelle degli enti locali e delle
Regioni (1997). La politica economica e finanziaria – e qui il processo aveva preso avvio ai primi
anni ’80 – conobbe limitazioni derivanti dall’accresciuto ruolo della Banca d’Italia, che ha
rafforzato enormemente i suoi poteri decisionali autonomi dal Governo da quando è stata inserita
nel sistema europeo delle Banche centrali (dal 1992).
Così, negli anni dei governi tecnici - nel periodo della massima debolezza del sistema politico, della
massima lontananza tra opinione pubblica e istituzioni; e nel periodo in cui meno fortemente che
mai i governi sono sostenuti dalla fiducia politica delle Camere e del corpo elettorale e inquadrati in
un nesso di responsabilità politica - il Governo ha conquistato una posizione di predominanza nella
produzione normativa, e, in quanto interlocutore e responsabile delle politiche comunitarie – che
sono decise dagli esecutivi nazionali – si è trovato investito di una visibilità e di un’autorevolezza
superiori a quelle delle Camere, per ritrovarsi in breve al centro del sistema istituzionale.
360
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
I governi ‘maggioritari’
Dopo la fase dei governi ‘tecnici’ la legge elettorale maggioritaria fu messa alla prova con risultati,
come dicevamo – e come era del resto largamente prevedibile – ben al di sotto delle aspettative
palingenetiche che erano state date in pasto all’opinione pubblica. La legge incoraggiava i partiti a
formare coalizioni pre-elettorali: in sostanza, due o più partiti si presentavano insieme, con
l’impegno che in quella stessa alleanza avrebbero formato il governo se avessero vinto le elezioni.
Le coalizioni pre-elettorali, però, si sfasciarono puntualmente dopo la formazione del Governo, con
tempi più o meno lunghi. Questo riportò di nuovo alla ribalta il tema della riforma costituzionale,
cioè, come abbiamo più volte osservato, il tentativo di rimediare tramite un rafforzamento dei poteri
del governo alla endemica indisciplina e debolezza delle formazioni politiche. Nel 1997,
riproponendo l’esempio della Commissione Bozzi, venne creata la Commissione D’Alema. A
differenza della Commissione Bozzi (cui era stata data vita con una delibera parlamentare), la
Commissione D’Alema fu prevista e istituita da una legge costituzionale, la n. 1/1997, che incaricò
la commissione (composta da 35 senatori e 35 deputati) di ‘elaborare progetti di revisione della
parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di stato, forma di governo e
bicameralismo, sistema delle garanzie”; le Camere avrebbero dovuto deliberare sui progetti
presentati da questa Commissione; sarebbe stato sufficiente il voto della maggioranza assoluta
(anziché quello dei due terzi richiesto dall’art. 138) e la legge così approvata sarebbe stata
sottoposta a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione (referendum necessario anziché
eventuale, quale è quello previsto dall’art. 138). Con la Commissione D’Alema il tema della
riforma della giustizia (cioè dell’ordinamento della magistratura) si affiancò per la prima volta a
quelli ormai tradizionali della riforma della forma di governo, del bicameralismo, delle regioni. I
lavori di questa Commissione, da molti interpretata come il tentativo di siglare un patto di
convivenza tra le forze di centro-sinistra e Berlusconi, si conclusero senza esito nel 1998.
Natura di vera e propria riforma costituzionale va però assegnata alla legge elettorale approvata nel
2005, fondata come sappiamo su un calcolo proporzionale dei voti con premio di maggioranza e
senza la possibilità per l’elettore di esprimere preferenze. Si tratta, come dicevamo, del più aperto
tentativo di realizzare il ‘sogno’ di assicurare al partito la fedeltà degli eletti. Tuttavia, frutto come
sempre di interessi incrociati (nessun partito, votando una nuova legge elettorale, vuole correre il
rischio di rimanere tagliato fuori dai futuri assetti di governo), la legge mentre garantiva ai partiti la
fedeltà degli eletti azzoppava poi la forza del partito vincitore, perché, a causa della diversa
modalità di attribuzione del premio di maggioranza alla Camera e al Senato (nel primo caso il
premio è ripartito al partito che ha avuto più voti sul piano nazionale, nel secondo è suddiviso tra i
partiti che hanno avuto più voti a livello regionale), la legge tende a creare, e di fatto ha creato, esiti
per cui il partito vincitore ha una forte maggioranza alla Camera ma ne ha una debolissima, affidata
a pochissimi voti, al Senato.
Nella fase dei governi maggioritari39 il sistema politico assume la struttura che viene detta
‘bipolarismo’ in base alla quale il governo è formato da coalizioni ampie ma aggregate in modo
tendenzialmente stabile e che si rappresentano come ‘alternative’ l’una all’altra. Mentre il governo
di coalizione dell’epoca del consociativismo tendeva al cambiamento della composizione delle
coalizioni, il governo ‘maggioritario’ vuole essere un sistema di coalizioni che si riproducono eguali
a se stesse e contrapposte l’una all’altra.
39
Primo Governo Prodi (maggio 1996-ottobre 1998, Partito Democratico della Sinistra, Partito popolare italiano, Lista Dini, Unione
Democratica, Verdi); Primo Governo D’Alema (ottobre 1998-dicembre 1999, ‘Ulivo’ – una coalizione con al centro il Partito
Democratico della Sinistra; Partito dei Comunisti Italiani, Unione Democratica di Centro) Secondo Governo D’Alema (dicembre
1999 aprile 2000); Secondo Governo Amato (Democratici di Sinistra, Partito popolare italiano, ecc.); Secondo Governo Berlusconi
(giugno 2001- aprile 2005, poi, dopo le dimissioni e il rimpasto, dall’aprile 2005 al maggio 2006); Secondo Governo Prodi (maggio
2006-maggio 2008), Quarto Governo Berlusconi (maggio 2008-novembre 2011).
361
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Dunque, anche per via dei condizionamenti provenienti dalla nuova legge elettorale (che impone ai
partiti di allearsi prima delle elezioni, e non dopo, in Parlamento), il Governo tende in questa fase a
configurarsi come il risultato non di alleanze tra partiti nate in Parlamento, ma di un’alleanza stretta
prima e proposta agli elettori. Questo non modifica la natura coalizionale dell’Esecutivo, e non
riduce il peso dei partiti della coalizione, certamente comporta una ulteriore compressione del ruolo
dell’arena del Parlamento. Infatti, in questo nuovo modello, in cui due coalizioni si fronteggiano
ognuna proponendo il suo leader come futuro Presidente del Consiglio, il vincitore passa
all’incasso della rendita di posizione di una maggioranza forte sommata agli strumenti di un
governo forte, cui si è aggiunto tutto quanto è stato ritenuto comodo conservare dell’interpretazione
costituzionale consolidatasi a partire dall’epoca del consociativismo, e arricchitasi nella fase dei
governi tecnici. Una interpretazione costituzionale, un insieme di prassi, della quale fa parte, in
primo luogo, la convinzione che con decreto legge o delega o delegificazione si possa far tutto, e, ad
esempio, disciplinare le materie coperte da riserva di legge (quelle, che perché attinenti alle libertà o
a fondamentali gangli organizzativi, come l’indipendenza della magistratura, la Costituzione vuole
rimessa alla legge, quale atto promanante dal più ampio confronto politico). In un quadro in cui,
però e a differenza di ogni altra stagione della vita politica italiana, un decreto legge è divenuto
veramente un atto del solo Governo, deciso in quattro e quattr’otto in Consiglio dei Ministri e
condotto a un’approvazione blindata da parte delle Camere, dove oramai le novelle apportate ai
regolamenti a partire dagli anni ’80 e poi negli ultimi anni ’90 – sul presupposto che occorresse
aiutare un governo troppo “debole” – hanno indebolito consistentemente le possibilità di
condizionamento da parte dell’opposizione, e alle quali comunque, grazie agli estesissimi poteri
regolamentari, detenuti anche dai singoli Ministri, il Governo può sempre più fare a meno di
ricorrere.
In questa fase politica viene approvata anche una rilevantissima revisione costituzionale, quella che
ha riformato l’intero titolo V della Costituzione, concernente i rapporti tra Stato e Regioni e i
poteri delle autonomie locali (legge cost. n. 1/2001), a ‘coronamento’ della fase ‘federalista’ avviata
alla fine degli anni 1990. Nell’assetto previgente, le Regioni ordinarie potevano legiferare solo in
una serie di materie, elencate dalla Costituzione, mentre ogni altra competenza legislativa era dello
Stato. La competenza regionale ordinaria era inoltre ‘concorrente’ nel senso che, sulle materie di
loro competenza, le regioni potevano legiferare attenendosi a ‘principi e criteri direttivi’ dettati da
una apposita legge statale o ricavabili dalle leggi vigenti (cd. potestà legislativa concorrente). Le
regioni speciali, invece, le cui norme di autonomia sono contenute negli Statuti che hanno rango di
legge costituzionale, avevano anche la competenza legislativa cd esclusiva, che le autorizzava, in
una serie di materie elencate negli Statuti, a legiferare in modo autonomo, ossia senza dover
rispettare i principi e criteri direttivi statali, sebbene in armonia coi principi dell’ordinamento
giuridico. Sia le regioni speciali sia quelle ordinarie, inoltre, avevano una competenza
‘integrativa’, nel senso che le leggi statali potevano attribuire alle regioni di dettare norme di
dettaglio ed esecutive. Con la riforma del titolo V il criterio di riparto delle competenze legislative è
stato rovesciato: ora è lo Stato ad avere una competenza legislativa ‘enumerata’ mentre le regioni
hanno la competenza ‘residuale’. La Costituzione contiene un elenco di materie sulle quali solo lo
Stato può legiferare; poi un elenco di materie oggetto di potestà legislativa ‘concorrente’ (lo Stato
detta le norme di principio, le Regioni completano la disciplina per il loro territorio); e per tutte le
materie non ricomprese nell’uno e nell’altro elenco le Regioni hanno competenza legislativa piena.
La riforma, oltre a introdurre un nuovo ente territoriale (la Città metropolitana, già contemplata
dalla legge n. 59/1997, e oggi, nel 2013, ancora al centro dei tentativi di riforma del sistema delle
autonomie locali allo studio del Governo), rafforzò l’autonomia finanziaria delle Regioni. Essa va
ricordata anche per avere espressamente stabilito che sia la legge statale che quella regionale sono
tenute al rispetto, oltre che della Costituzione, ‘dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali” (art. 117 c.1). La riforma del titolo V fu approvata mentre era in
carica un governo di ‘centro sinistra’ guidato da M. D’Alema.
362
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Il successivo Governo Berlusconi II (2001-2005) mise poi a punto una riforma costituzionale di
ampia portata, che ritoccava la riforma del titolo V, appena approvata, reintroducendo il principio
per cui le regioni hanno competenza in una serie di materie enumerate e non in maniera residuale;
riduceva il numero dei parlamentari; metteva fine al bicameralismo perfetto; rafforzava i poteri del
Presidente del Consiglio (cui attribuiva i poteri di revoca dei ministri e di scioglimento delle
Camere. Come ancora oggi si può leggere sul sito dell’allora governo Berlusconi, la riforma
intendeva ‘rafforzare la governabilità e il bipolarismo, togliendo potere alla partitocrazia’. La
riforma fu approvata dalle Camere a maggioranza assoluta; fu oggetto di una violentissima, o
quantomeno fermissima, opposizione da parte di molta opinione pubblica e accademica, che ne
denunciò in toto l’incostituzionalità, e il referendum confermativo che si svolse nel 2006 ne segnò
l’archiviazione. Come vedremo tra poco, molte delle idee proprie di quella riforma sono peraltro
ritornate al centro del processo di riforma promosso (per di nuovo presto incagliarsi) dal Governo
Letta nel 2013.
Non vi è dubbio che i Governi maggioritari abbiano significato un rafforzamento dell’Esecutivo di
tale portata, per cui tutti i commentatori, intorno al 2010 -2011, concordavano nell’esprimere
preoccupazione. La situazione che viene descritta dagli studiosi in questo periodo è la seguente.
Il governo controlla sostanzialmente l’intero processo normativo: le leggi di iniziativa parlamentare
si contano anno per anno sulle dita di una mano, mentre tutte le restanti leggi sono di iniziativa
governativa. Il che sarebbe il meno:
il ricorso al decreto legge assume carattere sistematico, specialmente per i grandi interventi in
materia economico finanziaria. Si calcola che circa il 95% delle decisioni di spesa approvate in
Parlamento dal 2006 al 2010 sia passato per disposizioni contenute in un decreto legge. E’
inveterata la prassi delle ‘catene di decreti legge’ (decreti legge con cui si interviene più volte sulla
stessa materia) e di decreti legge adottati per prorogare la scadenza di termini previsti dalla
legislazione vigente (cd. decreti ‘milleproroghe’); di decreti che sono tanto poco straordinari e
urgenti da contenere disposizioni ad attuazione differita; di decreti legge trasmessi al Presidente
della Repubblica per l’emanazione dopo una settimana dalla loro approvazione in Consiglio dei
Ministri, che è una approvazione ‘salvo intese’, vale a dire viene fatta su una bozza di decreto e
poi il contenuto del decreto viene deciso nel dettaglio fuori dal Consiglio dei Ministri, dal singolo
ministro e dai suoi apparati tecnici e nel dialogo con i portatori di interessi coinvolti; il genere,
antichissimo, dei decreti legge che contengono disposizioni eterogenee (decreti omnibus) si è
arricchito nelle ultime due legislature di un nuovo tipo, definito decreto ‘rampino’ con il quale si
introducono in un decreto legge disposizioni di contenuto limitato al fine di consentire, in sede di
conversione, che ad esse si aggancino intere normative di più ampio rilievo. Per esempio, il decretolegge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti
per le Olimpiadi di Torino, nel quale fu sin dall’origine inserito un articolo contenente ‘disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi’. Ciò ha consentito, in sede di conversione, di
introdurre una cospicua serie di modifiche al testo unico sugli stupefacenti, modifiche a loro volta
già previste in un disegno di legge del Governo, e che si è trovato ‘agganciato’ al rampino della
conversione.
Quanto alla delega legislativa, è pacifico che essa ha conosciuto dal 1992 una ‘nuova stagione’, in
cui essa è stata sistematicamente impegnata per adottare riforme di ampio respiro di importanti
settori dell’ordinamento e dell’amministrazione pubblica, conoscendo una trasformazione
strutturale per effetto delle cd. deleghe correttive, che consentono al governo di modificare i
decreti delegati. Questo significa, in sostanza, trasferire al governo la vera e propria funzione
legislativa sulla materia considerata. Sempre più generici per non dire inesistenti si sono fatti ‘i
principi e criteri direttivi’ della legge di delega, sicché il Governo ha scelta libera nel definire i
363
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
contenuti dei decreti delegati. Oggi si riconosce apertamente che l’utilizzazione della delega
legislativa risponde a una precisa strategia dell’esecutivo di controllo e governo della normazione.
La delegificazione ha avuto una grandissima espansione, ma è stata anche scavalcata da leggi che
hanno previsto al Governo (per consentirgli di aggirare il procedimento di formazione dei
regolamenti delegati, che prevede l’audizione delle commissioni parlamentari competenti per
materia) l’adozione di “atti di natura non regolamentare” dalla forma semplificata e dall’efficacia
analoga ai regolamenti.
Infine, “la tendenza al rafforzamento del potere normativo del Governo ha toccato il suo zenith con
la previsione delle ordinanze di emergenza, provvedimenti amministrativi cui è attribuita la forza
di derogare a leggi vigenti. Introdotti nel 1992 dalla legge istitutiva del servizio di protezione civile,
questi poteri sono stati estesi dalla legge 401 del 2001 anche a eventi non calamitosi, i cd ‘grandi
eventi’, la cui concreta determinazione è rimessa alla volontà del Governo”40.
Due temi hanno iniziato così a venire in evidenza.
Uno, è del tutto inedito, e di segno del tutto opposto a quello – il rafforzamento dell’Esecutivo – che
ha monopolizzato il dibattito italiano dal 1978 ad oggi: la “necessità di rivitalizzare il
procedimento legislativo parlamentare e di far sì che i suoi valori di fondo siano garantiti.
Quello che pare mancare, in effetti, è appunto la capacità del procedimento legislativo parlamentare
a fungere da momento di controllo sulle principali opzioni legislative e, conseguentemente, da
elemento essenziale di legittimazione delle opzioni normative, che così vengono compiute; la
dottrina è tornata cioè a sottolineare la necessità di ricostruire momenti in cui l’indirizzo politico del
Governo possa essere esplicitato e concretizzato, ma poi anche dibattuto, e, se nel caso, corretto,
alla luce di una dialettica con la stessa maggioranza, che quelle scelte è chiamata a condividere,
e, ovviamente, con l’opposizione, che può, a seconda dei casi, o condividerle o prospettare opzioni
alternative”.41
L’altro tema, non del tutto nuovo, ma oggi affermato con preoccupatissima urgenza, è quello della
necessità di una “paziente ricostruzione delle forma partito”42, nella consapevolezza che senza
una dinamica partitica equilibrata, sono a rischio le corrette coordinate del sistema, a partire
dall’esercizio dei poteri dei Presidente della Repubblica nella fase di crisi e formazione del
Governo.
La crisi costituzionale del 2010-2013: ritorno allo Statuto?
La democrazia italiana verso la “ depoliticizzazione”.
Il rafforzamento del Governo e l’indebolimento del Parlamento sono dunque i dati inequivocamente
maturati nel periodo che ci separa dalla fine del sistema elettorale proporzionale, e che la dottrina
aveva iniziato a osservare con grande preoccupazione. L’altro elemento caratterizzante è quello
della trasformazione del ruolo del Presidente della Repubblica, divenuto più visibile e centrale nelle
dinamiche politiche, a partire dalla stagione dei ‘governi tecnici’. Un nuovo decisivo attore è stato
rappresentato dalla crisi finanziaria esplora nel 2008, e dalla centralità assunta dall’Unione europea
nella gestione dei processi economici e finanziari.
Questo insieme di fattori è sfociato in quella che viene ormai ricostruita da molta parte della
dottrina come una vera e propria crisi costituzionale, segnata dalla successione di una serie di eventi
iniziati nel 2010 e nella quale ci troviamo attualmente.
40
Così V. Lippolis, La centralità del Governo nel sistema politico. La specificità del caso italiano, in Il Filangieri, Quaderno 2010,
p. 7 ss., da cui sono tratti anche alcuni dei dati citati in precedenza.
41
Così N. Lupo, Il ruolo normativo del Governo, ibid., p. 80 ss.
42
Così M. Luciani, Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità nazionale, in Rivista dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti, 2/2011, www.associazionedeicostituzionalisti.it.
364
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Novembre 2010: la posticipazione della mozione di fiducia al Governo Berlusconi IV
Nell’autunno del 2010 era in carica, dal maggio 2008, il IV Governo Berlusconi, composto da una
coalizione di cui facevano parte il “Popolo della Libertà” (in cui erano confluiti il partito di
Berlusconi, Forza Italia, e Alleanza Nazionale, una riedizione del vecchio Movimento Sociale
Italiano, guidata da Gianfranco Fini), e la Lega. La maggioranza entrò in crisi perché il leader
della ex Alleanza Nazionale e presidente della Camera, Gianfranco Fini, in conflitto con Berlusconi,
uscì dalla maggioranza, venne espulso dal Popolo della Libertà e formò un nuovo gruppo politico.
L’opposizione presentò alcune mozioni di sfiducia al Governo43.I Presidenti delle Camere però,
“col concorso, e probabilmente per impulso, del Presidente della Repubblica”44, decisero di
rinviare la discussione delle mozioni di fiducia a dopo l’approvazione finale delle leggi di
stabilità e di bilancio per il 2011.
Da un punto di vista immediatamente politico, questa decisione dette il tempo alla maggioranza di
ricomporsi: dal nuovo gruppo di fuoriusciti ne fuoriuscirono altri, che crearono un nuovo gruppo
auto-denominatosi dei ‘Responsabili’; essi si distaccarono dall’opposizione e quando poi le mozioni
di fiducia furono votate assicurarono la sopravvivenza del Governo. Dal punto di vista delle prassi
che ha espresso e favorito, dunque, la decisione di rinviare il voto sulla mozione di fiducia “ha
reintrodotto un coefficiente di trasformismo” che, ripresentando il caso di un Governo sostenuto da
gruppi parlamentari nati da scissioni della maggioranza, ha completamente annullato la logica
‘maggioritaria’ cui il sistema politico si era intonato dal 1993”, o ne ha rivelato il carattere fasullo.
Da un punto di vista costituzionale, il rinvio della discussione della mozione di fiducia è stata una
decisione senza precedenti, sicuramente anomala e non molto lontana dall’essere incostituzionale:
“la discussione sulla fiducia, per la sua stessa natura, non può essere anteposta a ogni altra
deliberazione, per quanto obbligatoria”45; tanto più che, per il caso che il bilancio non venga
approvato nel termine, la stessa Costituzione prevede l’ipotesi del cd ‘esercizio provvisorio’, cioè
che il Parlamento conceda al Governo di continuare a gestire il bilancio sulla base della legge
dell’anno precedente. Era la prima volta che veniva posto nel nulla un imperativo costituzionale, in
nome di una esigenza che prese il nome di ‘stabilità del governo’ e che significava che, nel contesto
di crisi finanziaria che si era ormai delineato, le esigenze delle politiche di bilancio venivano
prima della normale dinamica politica della forma di governo.
Il Governo Berlusconi rimase in carica, ma era sostanzialmente in crisi, morto sul piano politico e
questo stato di cose “ha alterato sempre di più il funzionamento del sistema e si è trascinato per un
intero anno”46. La sua sopravvivenza era una manifestazione del rilievo politico assunto dalla crisi
finanziaria che si era avviata negli Stati Uniti nel 2008 e che stava progressivamente e
inarrestabilmente coinvolgendo i paesi europei.
Queste le premesse del primo, e soprattutto del secondo atto della grande crisi costituzionale
attraversata dall’Italia.
La lettera di Bruxelles e l’entrata in campo di Napolitano
Nell’estate del 2011, mentre proseguiva la crisi non dichiarata del Governo Berlusconi, la Banca
centrale europea inviò all’Italia una lettera nella quale indicava in modo puntuale una serie di
provvedimenti che il Paese doveva adottare per affrontare la situazione finanziaria. Si è trattato di
un atto del tutto irrituale, col quale un organo che non ha alcun titolo in materia, e – è superfluo
notarlo - non è in alcun modo rappresentativo in senso democratico, ha indicato a un paese membro
della Ue concreti indirizzi politici. A partire da questo momento, con grandissima esplicitezza e
43
Che peraltro, trafitto da una crisi così forte, avrebbe dovuto dimettersi spontaneamente. Tuttavia è noto che quantomeno per
esigenze personali del Presidente del Consiglio Berlusconi, coinvolto in numerosi processi, e al quale la carica di parlamentare
garantiva l’immunità dagli arresti, e la posizione di presidente del consiglio la possibilità di influenzare l’approvazione di leggi che
potevano influire sugli esiti delle vicende giudiziarie che lo interessavano, l’ipotesi delle dimissioni era oltremodo improbabile.
44
U. Allegretti, Il percorso storico recente della forma di governo italiana: ai limiti della Costituzione, in Rivista dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, maggio 2013.
45
Come nota Allegretti nello scritto sopra citato.
46
Allegretti.
365
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
visibilità, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è assunto il compito di garantire che
l’Italia avrebbe ottemperato agli impegni che la Ue, o meglio la Banca centrale, ci imponeva. I
commentatori hanno subito registrato che il condizionamento che il Capo dello Stato esprimeva
sulle scelte del Governo corrispondevano alla assunzione da parte del Presidente della Repubblica
di sostanziali poteri di indirizzo politico che la Costituzione non gli riconosce; d’altronde, il fatto
che il governo fosse molto debole, faceva apparire in quel momento la situazione spiegabile nel
senso di una temporanea ‘supplenza’ del Presidente. In un breve volgere di tempo, si sarebbe visto
che questa interpretazione, che tendeva a riportare la centralità assunta dal Capo dello Stato a
compatibilità col modello costituzionale della forma di governo parlamentare a base partitica, non
coglieva del tutto nel segno.
Il Presidente della Repubblica revoca il Presidente del Consiglio e la nuova prassi delle
‘dimissioni a termine’ del Governo
Nell’ottobre 2011 la Camera dei Deputati bocciò il primo articolo della legge sul rendiconto
generale dello Stato. Il Governo riceveva una grave sconfessione; anche se la Costituzione non
obbliga alle dimissioni il Governo che riceva alle Camere un voto contrario, vi sarebbero state tutte
le premesse per dimissioni spontanee. Invece il Governo, su impulso del Presidente della
Repubblica, chiese la fiducia, e la ottenne, sia pure con una maggioranza risicatissima, e venne
anche approvata la legge sul rendiconto dello Stato. A questo punto “il Presidente del Consiglio fu
costretto dal Presidente della Repubblica ad annunciare le sue dimissioni, seppur a termine, cioè a
dopo la approvazione della legge di stabilità e del bilancio”47. Così si è realizzato un paradosso, per
cui il Governo si dimette dopo avere incassato il voto favorevole delle Camere su atti
particolarmente qualificanti del loro indirizzo48.
Anche le dimissioni ‘a termine’ del presidente del consiglio rappresentano un atto senza
precedenti e, analogamente alla mozione di sfiducia ‘rinviata’ l’anno prima, sono una scelta
che antepone le esigenze finanziarie alla espressione della dinamica politica. I commentatori
inoltre sottolineano che le ‘dimissioni a termine’ di Berlusconi furono “nella sostanza una
revoca del Presidente del Consiglio e dell’intero esecutivo”49, laddove il Presidente della
Repubblica, a differenza del Monarca statutario, non ha questo potere, perché è alle Camere, e non a
lui, che il Governo risponde.
L’idea che il Governo debba avere la fiducia del Capo dello Stato, del tutto estranea alla nostra
forma di governo costituzionale, idea che era sottesa alla ‘revoca’ di Berlusconi, fu chiaramente
all’opera nel passo successivo.
Il Presidente della Repubblica nomina un Governo di sua fiducia
La rapidissima soluzione della crisi del Governo Berlusconi è interamente dettata dal Capo dello
Stato che conferisce l’incarico a Mario Monti, un economista, già membro della Commissione Ue,
che pochi giorni prima era stato, in vista della sua nomina a Presidente del Consiglio, nominato
senatore a vita dal Presidente della Repubblica, che forse riteneva che sarebbe stato troppo
esorbitante nominare Presidente del Consiglio una persona del tutto estranea alla vita politica delle
istituzioni nazionali.
47
Così U. Allegretti.
Lo nota A. Ruggeri, L’art. 94 della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei Mercati” (Nota minima a
commento della nascita del Governo Monti), in Federalismi.it, 2011. Lo stesso è accaduto, in Grecia, col Governo Papandreu,
dimessosi dopo avere visto approvare dall’assemblea parlamentare il pacchetto di provvedimenti per il risanamento dei conti
pubblici, e di nuovo in Italia, come vedremo nel testo, con le dimissioni del Governo Monti.
49
Le virgolette rimandano sempre al lavoro di U. Allegretti citato sopra.
48
366
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Il Governo Monti è stato un governo tecnico diverso dai precedenti Amato, Dini e Ciampi, intanto
perché è stato composto da personale ‘interamente tecnico’ (cioè persone non appartenenti a
partiti politici50).
L’altra e più importante novità segnata dal governo Monti consiste nel fatto che, pur avendo
ricevuto la fiducia delle camere, e pur essendo dunque, almeno formalmente, ‘parlamentare’, in
realtà e in modo evidente si è fondato sulla fiducia del Capo dello Stato, che ha agito al suo
interno come vero e proprio ‘organo politico’51.
“La forma di governo parlamentare accolta dalla Costituzione subisce in questo periodo una trasformazione
in senso dualistico, che ricorda molto da vicino l’assetto della monarchia liberale statutaria”52.
Infine, si è trattato di un governo tecnico che, con maggiore evidenza di ogni altro che lo avesse
preceduto, veniva definito tecnico quando ‘era pacifico che avrebbe assunto decisioni stricto
sensu politiche e di estremo impegno e gravità e che avrebbe potuto portarle a buon esito
soltanto se sorretto dalla fiducia parlamentare”53.
In queste condizioni, ‘governo tecnico’ significa in buona sostanza governo al quale il
parlamento non può negare la fiducia perché vige l’implicita premessa secondo cui l’esistenza
e permanenza in carica del governo risponde a una necessità non negoziabile.
La fiducia delle Camere, nel caso del Governo Monti, fu dunque un dato puramente formale
laddove il vero rapporto fiduciario che reggeva questo Governo era col Presidente della
Repubblica, da un lato, e dei mercati finanziari, dall’altro lato. Come è stato scritto:
“Lo spettro dei mercati si è intravisto lungo tutto il corso della vicenda che ha portato alla formazione del
nuovo Governo. E così abbiamo assistito a consultazioni parallele, quelle ufficiali del Capo dello Stato e
quelle, diciamo così, ‘ombra’, svolte da Monti ancor prima di ricevere l’incarico (quando però quest’ultimo
era nell’aria, largamente preannunziato dai mezzi di informazione), le une e le altre tenutesi di domenica; la
usuale riserva nell’accettazione dell’incarico è poi durata solo un giorno, e il dibattito parlamentare,col voto
che lo ha concluso, svoltosi a spron battuto e esauritosi entro il fine settimana, nella non taciuta speranza di
riuscire a rincuorare i mercati in vista della riapertura del lunedì successivo”54 .
Il peculiare rapporto tra il Governo Monti e il Presidente della Repubblica è continuato “per tutta la
permanenza in carica del governo Monti, il quale sempre si riferirà per le sue decisioni
fondamentali agli orientamenti fatti valere dal Presidente della Repubblica”. Questo è accaduto in
modo vistoso anche al momento delle dimissioni.
Notevole caratteristica delle dimissioni del Governo Monti è stata infatti anche la circostanza, resa
pubblica dallo stesso Presidente del Consiglio, per cui egli ha comunicato al Quirinale la sua
intenzione di dimettersi ma non la ha comunicata preventivamente ai suoi Ministri. Oltre a
confermare la particolare relazione di fiducia personale che, non in accordo con la configurazione
costituzionale dei rapporti tra questi due organi, ha legato il Presidente del Consiglio Monti al
Presidente della Repubblica Napolitano, questa circostanza equivale a una decisa interpretazione
in senso monistico e gerarchico dell’organo ‘Governo’. E’ vero che, come abbiamo ricostruito in
queste pagine, noi proveniamo da una evoluzione lunga ormai almeno vent’anni che vede
l’affermarsi nei fatti di una posizione di preminenza del Presidente del Consiglio sulle altre
componenti del Governo, non del tutto armonica con il disegno paritario e collegiale che
50
Si può notare incidentalmente che, in Italia, la qualifica di ‘tecnico’ viene scambiata con quella di ‘indipendente’, perché il tecnico
è appunto qualcuno che non appartiene a un partito politico e in questo senso sarebbe indipendente dai partiti. Tuttavia non basta
questo a rendere una persona ‘indipendente’, posto che un tecnico può essere espressione di gruppi di interesse, o di istituzioni.
51
Allegretti.
52
Allegretti.
53
Così A. Ruggeri, op. cit.
54
A. Ruggeri, op. cit.
367
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
dell’organo la Costituzione disegna, tuttavia una simile completa esautorazione della collegialità
dell’Esecutivo, se si vuole un simile declassamento del ruolo costituzionale dei singoli Ministri e
del Consiglio dei Ministri si è fatta registrare come un dato notevole.
La decisione del presidente del Consiglio Monti di dimettersi fu espressamente attribuita al fatto
che, il segretario del principale tra i partiti che sostenevano il governo aveva espresso in Parlamento
l’intenzione del suo gruppo di non votare alcuni provvedimenti del governo stesso. Il dubbio che, da
un punto di vista costituzionale, vi fossero in questo caso i requisiti sufficienti per giustificare le
spontanee dimissioni del Governo, può senza dubbio essere posto. A imporsi era semmai la
necessità di seguire la prassi della ‘parlamentarizzazione’ della crisi: il Capo dello Stato avrebbe
dovuto invitare il Governo a presentarsi in parlamento per chiarire la permanenza, o meno, di una
maggioranza a suo sostegno. E’ vero infatti che la crisi nasceva da affermazioni di un deputato in
parlamento; ma altro sono le affermazioni di un singolo, altro il dibattito e lo schieramento di punti
di vista che può emergere in una discussione dedicata espressamente a valutare se il governo ha o
meno la fiducia delle camere, con utile approfondimento pubblico sia delle ragioni della crisi, sia
delle diverse posizioni delle varie forze politiche.
“Bypassare” la regola costituzionale secondo cui il Governo non ha l’obbligo di dimettersi a seguito
di voto contrario delle Camere significa porre nel nulla il valore di quella regola, che è molto
preciso: essa significa che il Governo non può pretendere dal Parlamento che sia sempre d’accordo
con lui: non si può - in un sistema che ponga a suo fondamento la responsabilità politica del
Governo nei confronti delle Camere - arrivare al punto, che per timore che il Governo si dimetta, la
dialettica parlamentare venga completamente esautorata. E’ una delle regole in cui viene espressa
con più chiarezza la scelta della Costituzione di privilegiare il pluralismo e la dialettica politica nei
confronti della mera esigenza di stabilità del Governo. Nei confronti di questa regola, e del preciso
significato ordinamentale che incorpora (che si può, sia pure con un po’ di brutale semplificazione,
esprimere dicendo che il parlamento non è agli ordini del governo, o il ratificatore delle sue
decisioni) crea indubbiamente notevoli problemi di compatibilità, come abbiamo in precedenza
notato, la tendenza degli esecutivi a porre molto frequentemente la questione di fiducia,
“minacciando” il parlamento di dare le dimissioni se il provvedimento su cui il governo ha posto la
fiducia non viene approvato. Ancora di più ne ha posti nel dicembre 2012 la scelta di Monti di
dimettersi in seguito alle dichiarazioni in Aula di un parlamentare.
Bisogna anche ricordare che nel nostro ordinamento costituzionale non è il governo, ma il capo
dello stato, che scioglie le Camere. Di conseguenza le dimissioni del Governo non possono essere
date col motivo (e neppure con l’intento, almeno non con intento giuridicamente rilevante, seppure
è certo ammissibile che il governo possa politicamente perseguire questo scopo) di provocare lo
scioglimento delle Camere e il ricorso a nuove elezioni, poiché questo tipo di valutazioni non
spettano al Governo, ma ad altro organo costituzionale, e inoltre perché, apertasi la crisi di governo,
la prima valutazione da fare è comunque se sia possibile ricostituirne un altro (e, in caso di
dimissioni spontanee, anche se sia possibile per il governo ritrovare la sfiducia delle Camere). Nel
caso delle dimissioni del Governo Monti è innegabile che, trovandosi a fine legislatura e in un
contesto in cui un eventuale anticipo della data delle elezioni politiche era nei fatti in discussione,
esse sono state rese nella consapevolezza di provocare lo scioglimento anticipato delle Camere. Ciò
permette di avanzare ulteriori dubbi di ‘correttezza costituzionale’ di quelle dimissioni, tanto più
considerando il carattere ‘tecnico’ di questo esecutivo, sorretto dalla fiducia dei partiti ma non
espresso da essi e fondato su un mandato non a perseguire un suo indirizzo politico, ma ad
assicurare al paese l’adozione dei provvedimenti e la stabilità istituzionale giudicate necessarie in
un periodo di grave crisi economica e di turbolenza politico-finanziaria mondiale. In altri termini, se
è ammissibile e comprensibile che il leader di una forza politica calcoli che, dimettendosi, è
probabile che si andrà ad elezioni, magari in un periodo o contesto al suo partito favorevole, molto
meno questo tipo di valutazioni sono comprensibili in un governo ‘tecnico’, per il quale, in
considerazione proprio della specialità del mandato, converrebbe individuare, per convenzione altre
cause di dimissioni (es.: raggiungimento dell’obiettivo che dà motivo al suo mandato; superamento
368
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
dei problemi cui la sua costituzione ha risposto), ma non certo motivazioni latu o stricto sensu
politiche. E’ effettivamente di difficile armonizzazione il fatto, da un lato, che l’esecutivo tecnico
sia in carica per garantire la stabilità finanziaria del paese, e poi, con le sue dimissioni, la metta a
rischio.
Ultima osservazione da fare sulle dimissioni del Governo Monti è che si trattò del secondo caso di
dimissioni ‘annunciate’ o ‘sotto condizione’ (il Governo annunciò che si sarebbe dimesso dopo
l’approvazione in Parlamento della Legge di Stabilità).
Le ‘dimissioni del governo sotto condizione’ sono una novità che genera ambiguità in quanto, fino a
che la condizione sospensiva non si produce, il governo è nella pienezza delle funzioni; ma
indubbiamente, nelle cose, è anche un po’ dimissionario, ciò che non facilita la individuazione dei
corretti limiti della sua azione, mentre in uno stato di diritto è importante la chiarezza sulla
condizione giuridica di questo o quell’organo, perché importante avere la possibilità di controllarne
e farne risaltare la correttezza dell’operato.
Il Governo Monti ha anche segnato una fase in cui il disordine nella produzione normativa ha
raggiunto il suo estremo, a causa di un ricorso senza precedenti alla decretazione d’urgenza. Col
Governo Monti, infatti, in primo luogo è divenuta prassi che i requisiti di straordinaria necessità e
urgenza dei decreti siano dati per impliciti, in quanto risalenti alla situazione economica e
finanziaria. Si è teso così a instaurare una prassi per cui ogni misura economico finanziaria o
concernente innovazioni istituzionali deve essere assunta dal Governo con decreto legge, prassi
tendente ad affermare una riserva dell’Esecutivo in queste materie (si ricordi che secondo la nostra
Costituzione il titolare della funzione legislativa è il Parlamento, il Governo non dispone di riserve
di competenza normativa e il ricorso agli atti con forza di legge è configurato come eccezionale).
L’uso abnorme della decretazione d’urgenza da parte del Governo Monti è testimoniato da questi dati
(raccolti ed esposti in un seminario del 2013 dalla Prof.ssa Roberta Calvano): il decreto ‘Salva Italia’
contiene l’autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale (materia sulla quale vige una riserva di
legge e di assemblea); e impegna il governo all’adozione di un decreto legge; il decreto ‘Cresci Italia’ dà una
delega al Governo; il decreto ‘Semplifica Italia’ contiene 7 delegificazioni per le quali è autorizzato un
procedimento in deroga a quello stabilito nell’art. 17 della legge n.400/88; i tre decreti legge rimandano
complessivamente a 400 provvedimenti attuativi (regolamenti del Governo e atti ministeriali).
La tendenza alla concentrazione nel Governo, tramite il decreto legge, dei poteri normativi è stata in
qualche modo rafforzata dalla sent. n. 22 / 2012 della Corte costituzionale che ha sottolineato
l’illegittimità della prassi di approvare i decreti con emendamenti introdotti in fase di conversione
non omogenei rispetto al loro oggetto (sentenza della quale il Capo dello Stato, nel febbraio 2012,
impegnò solennemente i Presidenti delle Camere a tener conto)55. Questa raccomandazione, da un
lato è coerente con il modello astratto del decreto legge, quello cioè previsto dalla Costituzione (che
dovrebbe affrontare con misure immediate una situazione eccezionale), ma, pronunciata quando il
decreto legge ha assunto i caratteri che ha assunto, significa in sostanza tendere a eliminare dal
procedimento legislativo (che oggi si svolge prevalentemente nella forma della conversione dei
decreti), in una serie di materie su cui, a colpi di decreti, il Governo è venuto a costruire una propria
(incostituzionale) ‘riserva’ di potere normativo.
Le elezioni e il rifiuto da parte del Capo dello Stato di dar corso a un governo di minoranza
espresso dalle nuove elezioni
A seguito delle dimissioni del Governo Monti, essendo ormai prossima la scadenza della
legislatura, il Presidente della Repubblica sciolse le Camere e indisse le elezioni, i cui risultati
indicarono nel PD il partito di maggioranza relativa, secondo il PDL e terza una nuova forza
55
Altre importanti decisioni della Corte costituzionale, delle quali non è qui possibile tener conto, sono suonate come
conferme delle prassi e delle scelte di merito del Governo Monti: in part. la sent. 70 e la 1012 del 2012 hanno dato una
nuova lettura dell’art. 81, che anticipa i contenuti della di poco successiva riforma costituzionale.
369
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
politica, il Movimento Cinque Stelle. Con un gesto privo di precedenti il Governo Monti non si
presentò alle Camere per dare le dimissioni neppure dopo le elezioni. Intanto, il Capo dello Stato
dette l’incarico al leader del Partito di maggioranza relativa, Luigi Bersani; secondo i commentatori:
“un elemento particolarmente problematico è dato dalle condizioni con le quali è stato conferito e condotto”
questo incarico. Infatti si trattò di un mandato vincolato dal presidente della Repubblica alla verifica di un
‘sostegno parlamentare certo’. Ora, è ovvio e naturale in un governo parlamentare che quest’ultimo debba
avere un sostegno parlamentare certo, ossia una maggioranza. Quindi si trattava di una clausola superflua che
però aveva un senso ben preciso: il Capo dello Stato non avrebbe autorizzato la presentazione alle Camere di
un Governo ‘minoritario’ che pure in quella situazione era l’unico che corrispondeva alle indicazioni del
corpo elettorale.
Dunque, prosegue Umberto Allegretti:
“La apposizione di quella clausola in termini rigidi e apertamente pubblicizzata indeboliva la posizione
dell’incaricato nelle trattative coi gruppi parlamentari, privandolo del netto appoggio del presidente alla
formazione di un governo da parte dell’incaricato, così che indubbiamente influì sulla verifica negativa.
Eppure, il sistema costituzionale ammette governi di minoranza, e ve ne sono stati molti esempi nel corso
della storia: e anche se, presentandosi alle Camere, il Governo non avesse ottenuto la fiducia sarebbe stato
espressione, sia pur non completa, della situazione post-elettorale: situazione migliore che mantenere in vita
un governo tecnico espressione di una legislatura superata, quale il Governo Monti. Un tale nuovo governo
avrebbe assicurato l’ordinaria amministrazione sino all’eventuale scioglimento delle Camere che avrebbe
potuto essere disposto dal nuovo presidente della Repubblica, dato che la carica era in scadenza”.
Invece, nel fallimento del ‘tentativo Bersani’ e sempre in carica, ancorché dimissionario, il Governo
Monti, il Parlamento ha rieletto il Presidente Napolitano.
La rielezione del Presidente della Repubblica non era mai avvenuta prima e la dottrina è sempre
stata orientata a considerarla una ipotesi inammissibile o altamente sconsigliabile perché, in
contrasto con la natura ‘super partes’ dell’organo Presidente, questa eventualità lo lega a una certa
formula di governo, implicando un suo ruolo politico. Si sottolinea perciò che
“le regole procedurali dell’investitura presidenziale sono accuratamente rivolte a evitare l’instaurazione di un
rapporto politico tra Presidente e Parlamento”56.
Ciò che si è, invece, puntualmente verificato: rieleggendo Napolitano le Camere lo hanno come
investito di una ‘fiducia’ in forza della quale lo hanno delegato ad assumere le decisioni che egli
riteneva migliori in ordine alla conduzione politica del paese:
“la richiesta di protezione implica sempre l’offerta di obbedienza: alla resa delle forze politiche non poteva
che corrispondere, dunque, l’acquisizione di una posizione dominante del Presidente della Repubblica nella
definizione della base parlamentare del Governo, nella sua composizione e nella sua stessa agenda”57.
Il discorso di insediamento ha avuto i toni di un ‘indirizzo’ del Monarca alle Camere statutarie: il
Capo dello Stato ha indicato al Parlamento e al Governo alcuni specifici obiettivi programmatici: la
riforma della legge elettorale, la modifica della seconda parte della Costituzione ‘almeno allo scopo
di infrangere il tabù del bicameralismo paritario’58 e più in generale l’attuazione delle proposte di
56
G. Scaccia, La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri della forma di governo, in Rivista AIC, maggio 2013.
G. Scaccia, op. cit.
58
E’ strano che il Capo dello Stato definisca un ‘tabù’ un istituto caratterizzante della Costituzione repubblicana. Volerlo modificare
non giustifica che lo si squalifichi, anche considerando che il bicameralismo paritario intendeva rispondere a precise esigenze di
tutela delle minoranze e di ampiezza e trasparenza del dibattito politico, ed è un peccato esse non vengano riproposte con vigore
come esigenze da salvaguardare anche in un sistema che abbia ‘superato’ il bicameralismo paritario.
57
370
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
riforma costituzionale elaborate da un gruppo di ‘saggi’ che, anche qui con iniziativa senza
precedenti, il Presidente aveva nominato nel marzo 2013.
Una “coalizione di creazione presidenziale”
In attuazione degli accordi che hanno presieduto alla sua rielezione, il Presidente Napolitano ha
conferito un incarico di Governo a Enrico Letta, strettamente condizionato a una composizione che
ha preso subito il nome di ‘larghe intese’ cioè data dalla alleanza tra Pd e PDL, due forze che si
erano presentate come alternative e in competizione alle elezioni.
“Governo di scelta del Presidente, dunque, sia nella individuazione del suo capo – si sa che il partito di cui
Enrico Letta è esponente di rilievo si è rimesso alla designazione presidenziale – sia in quella della
composizione della coalizione sia (vien ritenuto) nella scelta di alcuni ministri. Nonché nell’indicazione delle
priorità dell’indirizzo da seguire nell’azione dell’esecutivo, incluse quelle delle riforme costituzionali. Si
tratta di un governo di coalizione tra due forze contrapposte, col quale si realizza un auspicio tenacemente
perseguito da Napolitano sin dagli inizi del mandato presidenziale e in prima battuta col Governo Monti, cioè
la conciliazione tra le varie forze politiche e la loro convergenza non solo nelle scelte istituzionali ma anche
sulle grandi direttrici di politica economica ed estera59”.
Ritorno allo Statuto? La rinnovata attualità del modello ‘liberale’
E’ evidente, che perseguire questo obiettivo ha significato condizionare in modo molto forte la
dinamica politica e parlamentare (le elezioni politiche, già possibili nel 2010, si sono svolte
all’inizio del 2013) e mettere in secondo piano i risultati elettorali e la stessa eventualità delle
elezioni (cui sarebbe stato ben lecito ricorrere immediatamente dopo l’incerto esito delle elezioni
del 2013). L’idea che nel complesso emerge dalla situazione che si è delineata dopo la caduta del
governo Berlusconi è quella, effettivamente del tutto corrispondente alle ideologie liberali del
passato, che la direzione politica dello Stato debba essere condizionata in un modo sempre
meno intenso dai risultati elettorali, dalle preferenze del corpo elettorale, dagli orientamenti
dell’opinione pubblica, ma debba essere guidata dalle scelte di coloro che per esperienza ed
estrazione sono da ritenersi più idonei a comprendere ciò che il bene della Nazione
imporrebbe.
Da parte di molti teorici contemporanei, del resto, queste antiche caratteristiche del modello liberale
(imperniato sull’idea che la guida dello stato debba essere rimessa alla ‘pars melior’, agli esperti, ai
competenti, e sottratta il più possibile alle influenze dell’opinione pubblica e del corpo elettorale),
vengono oggi riproposte in termini di una nuova teoria politica che prende il nome di
‘depoliticizzazione’.
‘Depoliticizzazione’ delle democrazie significa appunto attenuazione se non eliminazione del
vincolo che, nelle democrazie, da un lato rende gli organi politici responsabili davanti al corpo
elettorale della attuazione di indirizzi politici, dall’altro lato li impegna a perseguire solo gli
indirizzi politici che sono stati accettati dal corpo elettorale. I teorici della depoliticizzazione
ritengono che ciò renda i governi impotenti ad adottare politiche efficaci, specialmente quando le
politiche ‘necessarie’ consistono in misure di restrizione della spesa pubblica e innalzamento del
carico fiscale che i cittadini difficilmente condividono, in quanto non ne verificano il beneficio per
sé, e anzi le temono60.
59
Allegretti.
Uno dei teorici della ‘depoliticizzazione’ è P. Pettit, che ha sostenuto questa tesi nel saggio Depoliticizing Democracy, del 2004. In
senso contrario v. Pierre Bourdieu, Against the policy of Depoliticization, 2002. Secondo Pettit la democrazia non è ‘collective will’,
ma ‘public evaluation’, ed è una cosa ‘troppo importante’ per essere lasciata nelle mani dei politici; questi ultimi, troppo preoccupati
del consenso, non sono in grado di curare l’interesse generale. L’espressione ‘depoliticizzazione’ era stata usata nel 1996 dal filosofo
J. Habermas (Depoliticization and the Public Sphere) per descrivere ciò che accade quando attività svolte in mercati organizzati
sopprimono con l’espressione di volontà o bisogni degli individui. Agli occhi dei teorici della ‘depoliticizzazione’ le democrazie
sono sistemi inefficienti, perché il voto riflette ‘interessi acquisiti nel presente’, dunque tende a essere refrattario verso i cambiamenti
e gli aggiustamenti che viceversa sono continuamente necessari per rendere un sistema istituzionale capace di operare nel contesto di
60
371
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Un’altra riforma in deroga all’art. 138
Il governo ‘delle larghe intese’ che, se si fonda su una ampia maggioranza parlamentare è anche un
governo che non corrisponde ad alcuna ipotesi che fosse stata prospettata agli elettori, e dunque ha
scarsissima per non dire nulla legittimazione elettorale, ha avviato, e anzi messo al centro del suo
programma, la riforma della seconda parte della Costituzione.
Ciò ha suscitato, in alcuni, perplessità, anche per il metodo seguito. Il fatto che quest’ultimo si
richiami in qualche modo alla serie di precedenti rappresentata dalle varie Commissioni per le
riforme che come abbiamo visto si sono succedute dal 1982 a oggi, ha anzi fatto sorgere la
preoccupazione che da una serie di scelte istituzionali di dubbia legittimità stia nascendo una prassi
o una consuetudine che contempla la ‘disapplicazione’ del procedimento ordinario di revisione
costituzionale quando si affronta il tema della riforma della forma di governo61 .
Il Governo ha costituito, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, un comitato di
complessivamente 42 personalità del mondo accademico, col compito di discutere e redigere
progetti di revisione dell’intera seconda parte della Costituzione. E’ stato fatto notare che ‘non
esiste alcun precedente storico che veda affidato a un ristretto numero di accademici (sia pure di alta
qualificazione) una funzione di questo tipo” e che sebbene l’istituzione del Comitato sia stata
presentata come “la risposta a una esigenza di carattere tecnico essa in realtà è servita al Governo
per arrogarsi “in modo del tutto improprio, il compito di avviare in Parlamento la discussione della
Riforma della Costituzione, sulla base di propri testi”, “nascondendo” le proprie scelte politiche
sotto l’aura di imparzialità e ‘istituzionalità’ che si pensa derivi dal fatto che, a formalizzarle, è poi
chiamato il ‘comitato dei saggi’. In seguito, il governo ha proposto all’esame delle Camere una
legge costituzionale di deroga all’art. 138, che ricorda molto da vicino la legge cost. n. 1/ 1997 che
dette vita alla Commissione d’Alema.
La nuova Commissione per le riforme è stata denominata “Comitato parlamentare per le riforme
costituzionali ed elettorali”, destinata ad essere composto da 20 deputati e 20 senatori. La deroga al
procedimento dell’art. 138 era inoltre consistente nel fatto che le leggi costituzionali approvate da
questo Comitato sarebbero state approvate col voto della sola maggioranza assoluta (non la
maggioranza dei due terzi), con abbreviazione a un mese di intervallo tra le due deliberazioni delle
Camere, e con la fissazione di termini rigidi al dibattito parlamentare, ma sarebbero state poi tutte
sottoposte a referendum. Non è mancato chi ha notato la profonda contraddittorietà tra questa
‘procedura derogatoria’ e i principi cui si ispira la nostra Costituzione.
In essa, come in tutte le democrazie europee post-belliche, il referendum viene circondato da una
serie di limitazioni. Il referendum è un atto di democrazia diretta, col quale il corpo elettorale si
esprime direttamente, e decide direttamente, su una certa questione. La nostra Costituzione
contempla due tipi di referendum, il referendum abrogativo e quello cd confermativo nel
procedimento di revisione costituzionale.
L’improprio utilizzo del referendum abrogativo nel modello ‘derogatorio’ di revisione
costituzionale
una economia altamente globalizzata, che richiede ‘adattabilità’. Il votante, secondo questi teorici, è condizionato da una visione
short-termed e self-interested; se le istituzioni fossero condizionate dal voto elettorale, sarebbero incapaci di “far inghiottire alle
masse la necessaria dose di disciplina” (queste citazioni dal volume di N. Bergrruen e N. Garnfled, Intelligent Governance for the
XXI Century, 2012. Questi Autori, che lodano il Governo Monti come esempio ben riuscito di metodo ‘depolitizzante’, affermano
che le istituzioni hanno bisogno di un certo spazio di ‘opacità, per schermare le loro decisioni dalla pressione popolare e dalla tirannia
della maggioranza”; tra le loro proposte, vi è quella di introdurre un sistema per cui il voto che gli elettori esprimono alle elezioni,
anziché uguale, sia ‘graduato’ su una scala da 1 a 5 a seconda della capacità verificata da appositi controlli e istruzioni, di
quell’elettore di ‘capire’ la questione su cui si esprime. E’ l’addio al principio ‘una testa un voto’ su cui si fonda il suffragio
universale).
61
Per questa perplessità v. Paolo Caretti, citato infra.
372
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Il referendum abrogativo (art. 75 Cost.) si sviluppa dalla proposta di un comitato di promotori che
devono raccogliere almeno 500-000 firme intorno a un quesito che essi intendono sottoporre agli
elettori. La Corte costituzionale controlla l’ammissibilità del quesito, che non può vertere su alcuni
tipi di leggi, e precisamente: le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali (art. 75 Cost.), e, secondo la giurisprudenza della Corte, le
leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le leggi ‘costituzionalmente necessarie’ che sono
quelle necessarie a permettere il funzionamento di organi costituzionali; le leggi ‘a contenuto
costituzionalmente vincolato’ che contengono alcune scelte così corrispondenti ai principi e ai
valori costituzionali che devono considerarsi come loro attuazione, e pertanto indisponibili, le leggi
‘connesse’ a quelle espressamente enunciate nell’art. 75.
Il referendum confermativo è invece il referendum che, su richiesta di cinquecentomila elettori,
un quinto dei membri di una Camera o cinque consigli regionali, può essere proposto quando una
legge costituzionale viene approvata, anziché con la maggioranza dei due terzi, con la sola
maggioranza assoluta. Nell’intento del Costituente, il ricorso a questo tipo di referendum
rappresenta una possibilità per il corpo elettorale di impedire una riforma elettorale voluta dalla sola
maggioranza di governo; è uno strumento estremo di difesa delle minoranze.
Così configurando il referendum, la nostra Costituzione ha espresso una scelta inequivoca, quella
per cui il referendum, il pronunciamento popolare, non deve essere chiamato da organi politici, da
istituzioni, per un qualunque fine (legittimare la propria azione, o sconfessare quella di un altro
organo). Un meccanismo di questo genere era previsto nella Costituzione della Repubblica di
Weimar (l’ordinamento assunto dalla Germania dopo la prima guerra mondiale e che la cui
sfortunata esperienza fu il preludio alla salita al potere di Hitler): lì il Capo dello Stato poteva
ricorrere all’appello al popolo (cioè indire il referendum) contro un pronunciamento del parlamento.
Questo modello è stato rifiutato dalla nostra Costituzione perché vede operare il referendum contro
e in alterazione della dinamica politico-rappresentativa.
Oltre a riprendere la discutibile idea adottata nella legge costituzionale che creò la Commissione
D’Alema, quella appunto di trasformare il referendum da eventuale a necessario/obbligatorio, la
proposta di deroga all’art. 138 operata dal Governo Letta semplifica all’osso la discussione
parlamentare sui progetti di revisione. Tutto questo conferisce al procedimento di revisione
immaginato dal Governo nel 2013 un carattere del tutto opposto al procedimento di revisione
come fissato dalla Costituzione, che prevede un amplissimo spazio al dibattito parlamentare, tempi
lunghi per la ponderazione e la discussione di modifiche della Costituzione, e che, come ripetiamo,
assegna al referendum un ruolo solo eventuale e una funzione di controllo, oppositiva alle decisioni
della maggioranza, perché vuole evitare l’utilizzo dell’appello al popolo in chiave plebiscitaria “a
supporto di questa o quella maggioranza politica”62.
Il Governo delle ‘larghe intese’ si è trasformato nel novembre 2013 in un governo di ‘piccole
intese’ perché il Partito delle Libertà si è scisso tra una componente facente capo a Berlusconi, e
che ha ripreso il nome di ‘Forza Italia’ e è andata all’opposizione, e una nuova componente, detta
Nuovo Centro, che è rimasta a sostenere il Governo. Questo ha per il momento interrotto il
procedimento di revisione costituzionale, perché il Governo non dispone più della maggioranza dei
due terzi necessaria a approvare la legge costituzionale di deroga all’art. 138.
Tuttavia, senza bisogno di revisioni formali della Costituzione modifiche ben profonde nel
funzionamento della forma di governo, e nel rapporto tra corpo elettorale, partiti e istituzioni, si
sono innestate in modo apparentemente profondo. Tant’è che l’annuncio, nel dicembre 2013, della
sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la vigente legge elettorale,
per assegnare un eccessivo premio di maggioranza e non prevedere il voto di preferenza, non è
62
P. Caretti, L’ennesimo ‘revival’ della Grande Riforma costituzionale in funzione palingenetica, in Costituzionalismo.it, luglio
2013.
373
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
stato sentito come un vincolo a sciogliere le Camere al più presto e a svolgere una consultazione
elettorale usando la legge elettorale quale ‘residua’ dalla dichiarazione di incostituzionalità63, in
modo da ottenere un Parlamento di nuovo pienamente legittimato e possibilmente un Governo
rispondente agli orientamenti del corpo elettorale. Al contrario, la dichiarazione di incostituzionalità
della legge elettorale è stata sentita dal Governo e dal Presidente della Repubblica come una
condizione che richiede al Governo di rimanere in carica finché non otterrà almeno una riforma
costituzionale, la rimozione del ‘tabù’ del bicameralismo e, in funzione di questo nuovo assetto, una
nuova legge elettorale.
Si ripresenta cioè, come carattere dominante del periodo, l’esigenza della istituzione governo di
procedere e funzionare nonostante ed eventualmente contro gli orientamenti del corpo elettorale,
secondo una tendenza che, come dicevamo in precedenza, riattualizza le concezioni non
democratiche tipiche del periodo liberale, nella cornice delle nuove concezioni che propugnano la
necessità e l’inevitabilità di ‘depoliticizzare’ le democrazie.
Vistosa è d’altro canto nel periodo attuale la forza con cui si manifestano le prassi trasformistiche e
le tendenze all’indisciplina della maggioranza nei confronti del Governo che pure sostiene, prassi
così tipiche della nostra storia istituzionale. Nell’attuale fase però a queste prassi vengono forgiate
risposte che sembrano volerle usare come giustificazione per una ulteriore impermeabilità del
Governo dal Parlamento e dunque la sua irresponsabilità.
Nel dicembre 2013 si è infatti verificato un caso del tutto nuovo: il Governo ha posto la fiducia al
Senato sulla conversione di un decreto ‘Milleproroghe’, dopo aver recepito una serie di emenamenti
approvati dal Senato. Poi, dietro richiesta del Presidente della Repubblica, ha ritirato il decreto; e il
Presidente della Repubblica ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere, richiamandoli al loro
dovere di impedire la messa in votazione di emendamenti non coerenti con l’oggetto del decreto in
corso di conversione.
Premesso che l’obbligo delle Camere di non votare emendamenti ‘eterogenei’ significa obbligo di
non votare alcun emendamento quando i decreti sottoposti dal Governo sono di per sé disomogenei
(quale per definizione è un decreto ‘Milleproroghe’, che interviene su scadenze e adempimenti
relativi alle più varie attività private e pubbliche), implicando così una contrazione sicuramente
eccessiva dei poteri dell’organo legislativo, nella vicenda di fine dicembre 2013 va segnalata anche
una ingerenza assolutamente inedita del Governo nelle procedure parlamentari. Si è sempre ritenuto
infatti, dalla maggioranza della dottrina, che il Governo non possa ritirare il decreto quando una
delle Camere ne ha iniziato l’iter di approvazione (anche perché questo contraddice platealmente
l’urgenza e l’indifferibilità che dovrebbero presiedere alla emanazione del decreto).
Il dato di fondo cui risalgono gli ‘sregolati’ emendamenti parlamentari è che, da un lato, il Governo
abusa dei decreti per cui il parlamento è costretto a svolgere in modo distorto la sua funzione;
dall’altro lato, è che il Governo non ha una maggioranza fedele. Tutto questo però tende a essere
ignorato, e le colpe delle disfunzioni del sistema vengono addossate alla dialettica parlamentare.
63
La Corte costituzionale considera la legge elettorale una legge ‘costituzionalmente necessaria’; una legge ordinaria che però è
talmente coessenziale al funzionamento della democrazia, che neppure per un giorno può ammettersi che non ve ne sia una vigente.
Perciò, nella sua giurisprudenza in tema di ammissibilità del referendum, la Corte ha stabilito che i quesiti debbano essere
‘manipolativi’ cioè congegnati in modo che, se la legge vigente viene abrogata, residui comunque un testo in base al quale potrebbero
svolgersi le elezioni anche indipendente da che una nuova legge venga approvata. Si tratta in altri termini di prevedere che dal testo
vigente siano cancellate parole, frasi, segni di interpunzione, in modo che il testo letto come risulta da queste cancellazioni ecc. sia un
testo applicabile. Dato che la Corte ha sempre affermato questo, vi è da ritenere che anche nel momento in cui è stata essa stessa ad
annullare la legge elettorale vigente, dichiarandola incostituzionale, lo abbia fatto con un intervento ‘manipolativo’ che elimina parti
della legge vigente ma lascia un testo in vigore. La sentenza e le sue motivazioni, peraltro, con scelta non del tutto convincente,
saranno rese note a distanza di diverse settimane dalla emanazione della sentenza, che è stata resa ai primi di dicembre del 2013.
374
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
Errata corrige: nel capitolo VI il nome del Presidente dell’Eni, Enrico Mattei, è per errore
indicato come ‘Ugo Mattei’ (che è invece un professore di diritto privato comparato).
375
Istituzioni di Diritto Pubblico A.O. 2013-214 Prof.ssa S.Niccolai
376