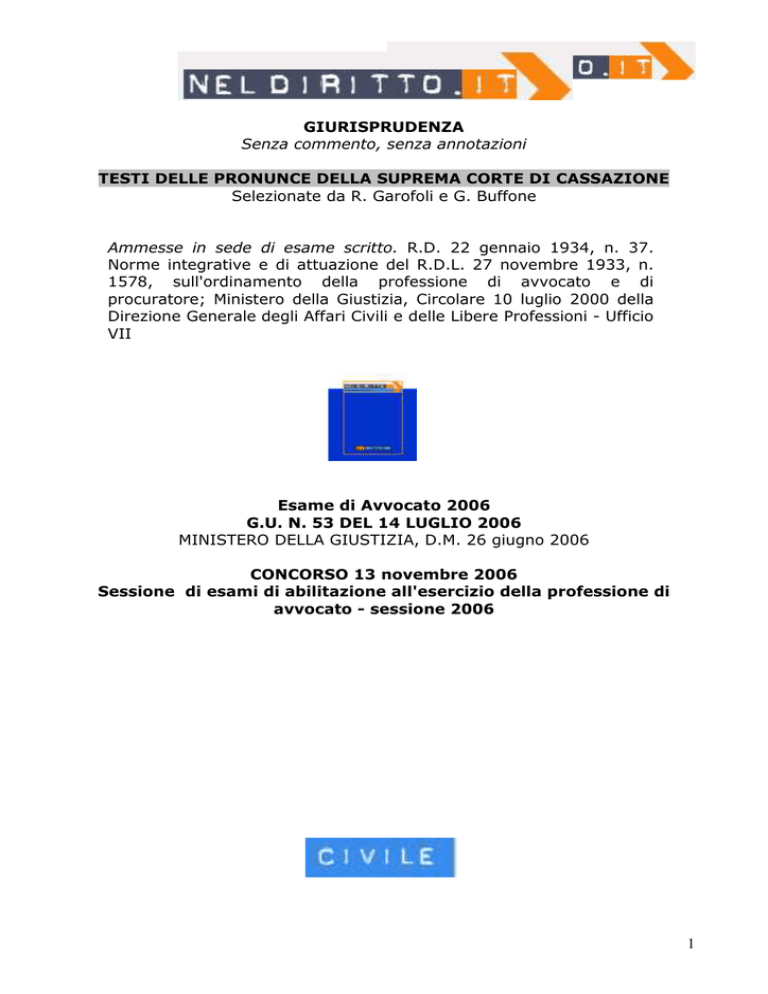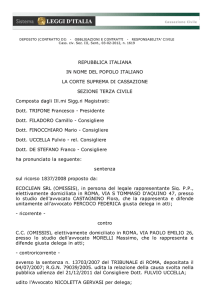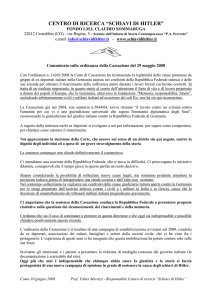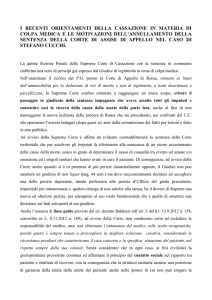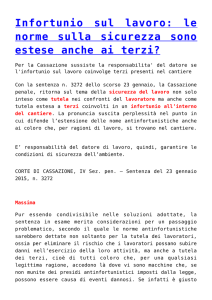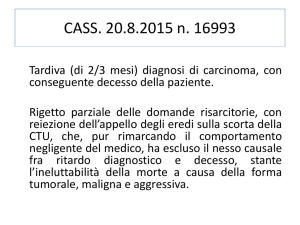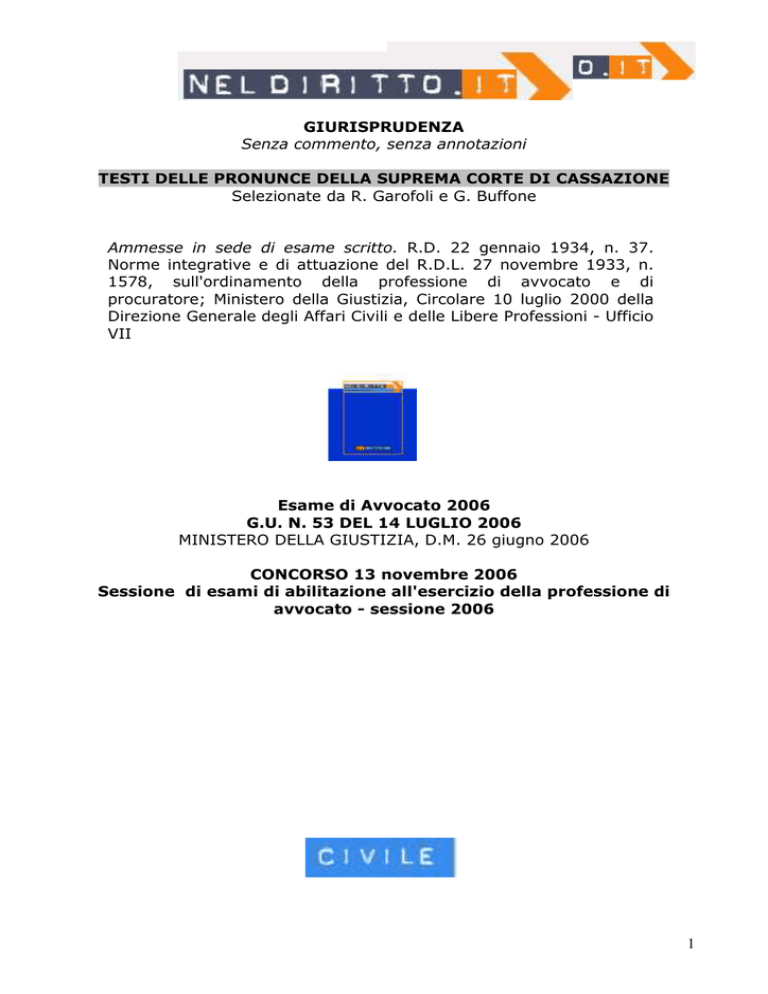
GIURISPRUDENZA
Senza commento, senza annotazioni
TESTI DELLE PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Selezionate da R. Garofoli e G. Buffone
Ammesse in sede di esame scritto. R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di
procuratore; Ministero della Giustizia, Circolare 10 luglio 2000 della
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio
VII
Esame di Avvocato 2006
G.U. N. 53 DEL 14 LUGLIO 2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, D.M. 26 giugno 2006
CONCORSO 13 novembre 2006
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato - sessione 2006
1
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA
DIRITTO
CIVILE
Indice
1. RIDUZIONE DELLA CLAUSOLA PENALE: Cassazione Sezione seconda
civile sentenza 28 settembre 2006, n. 21066 - Corte di cassazione
Sezioni unite civili Sentenza 13 settembre 2005, n. 18128
2. PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA ALTRUI: Cassazione, Sezioni
unite civili, sentenza 18 maggio 2006, n. 11624
3. GIURISDIZIONE - DIRITTO ALLA SALUTE: Cassazione, Sezioni Unite
civili, Sentenza n. 17461 del 1° agosto 2006
4. INCARICHI SENZA COPERTURA: Corte di cassazione, sezioni unite
civili, 10 giugno 2005, n. 12195
5. QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI: Corte di cassazione, Sezioni
Unite civili, Sentenza 12 giugno 2006 n. 13524
6. CONDOMINIO MINIMO: Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 31
gennaio 2006 n. 2046
7. GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE RISARCITORIE: Cass. Civ.
SS.UU., ordinanze giugno 2006 nn. 13659, 13660, 13911
(Occupazioni illegittime)
8. REVOCATORIA FALLIMENTARE: vendita bene per estinguere debito
privilegiato, Cass. Civ. SS.UU., sentenza 20 marzo 2006 n. 7028
9. DANNO NON PATRIMONIALE: danno esistenziale, demansionamento,
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 24.03.2006 n° 6572
10.
ANNO DA ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: Cass. Civ., Sezioni
Unite, sentenze 20 marzo 2006 nn. 7029, 7030, 7031
11.
ESPONSABILITA’ DELLA P.A. PER OMESSA MANUTENZIONE DELLE
STRADE, ART. 2051 C.C. : Cass. Civ., sentenza 6 luglio 2006 n.
15383
12.
DIRITTO A NON NASCERE SE NON SANI: Cass civ. sentenza 14
luglio 2006 n. 16123 (responsabilità del medico per nascita
indesiderata)
13.
ATTO COMMISSORIO E CONTRATTO CD. DI SALE & LEASE BACK:
Cass civ. sentenza 14 marzo 2006 n. 5438
14.
TUTELA CONSUMATORE, INVESTIMENTO MOBILIARE, apparenza del
4
18
22
30
36
43
48
57
60
D
66
R
70
79
P
86
2
diritto, concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. : Cass.
Civ. sentenza 7 aprile 2006 n. 8229
15.
ACCORDI DEI CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE; REVOCATORIA:
Cass. civ. sentenza 12 aprile 2006 n. 8516
16.
RESPONSABILITA’ DELLA BANCA PER ERRONEO PAGAMENTO
DELL’ASSEGNO: Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 6
ottobre 2005, n. 19512 (contra: sentenza 26210/2005)
17.
SINISTRI STRADALI – EFFICACIA CID – assicuratore, assicurato,
danneggiato: Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 5 maggio
2006, n. 10311
18.
OBBLIGO DEL VENDITORE DI RIMUOVERE IL VIZIO DELLA COSA –
Compravendita, azioni edilizie: Corte di cassazione, Sezioni Unite
civili, sentenza 21 giugno 2005 n. 13294
19.
ISARCIMENTO DANNI – CONVIVENTE MORE UXORIO: Cassazione ,
sez. III civile, sentenza 29.04.2005 n° 8976
20.
RRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO: Cassazione , SS.UU. civili,
sentenza 23.12.2005 n° 28507
21.
CCEZIONE DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE: Cassazione ,
SS.UU. civili, sentenza 27.07.2005 n° 15661
22.
ELIBERE ASSEMBLEARI – CONDOMINIO: - CASSAZIONE CIVILE,
Sezioni Unite, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
23.
MMISSIONI – SALUTE: Cass. Civ. sentenza 11 aprile 2006 n. 8420
24.
PPALTO PA: Cass. Civ. sentenza 29 aprile 2006, n. 10052
25.
SPESE CONDOMINIALI: Cass. Pen. Sentenza 27.12.2004 n. 23994
26.
NATOCISMO BANCARIO: Cass. Civ. SS.UU. 4.11.2004 n. 21095
27.
ONCORRENZA – ANTITRUST: Cass. Civ. SS.UU. sent. 4 febbraio
2005, n. 2207
93
97
100
105
113
R
122
I
125
E
128
D
131
I
139
A
141
148
A
151
C
156
3
4
CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE – SENTENZA 28 SETTEMBRE
2006, N. 21066
Presidente Spadone – Relatore Ebner
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1994, Fucile Matteo conveniva
la Tre Monti Residence Spa innanzi al Tribunale di Messina per sentirla
dichiarare inadempiente all’obbligazione di consegna dell’unità immobiliare (un
appartamento ed accessori) promessa in vendita ad esso Fucile con contratto
preliminare in data 23 giugno 1992; e per sentirla quindi condannare alla
restituzione della complessiva somma di lire 130.000.000 -ricevuta a titolo di
acconto sul prezzo pattuito in lire 100.000.000 - con la rivalutazione monetaria
e gli interessi di legge; nonché al pagamento della ulteriore somma di lire
51.000.000, comprensiva del doppio della caparra versata, dell’indennizzo per
la ritardata consegna dell’immobile, e del risarcimento di ogni altro danno
subito
da
esso
attore
per
tale
inadempimento.
La società convenuta costituitasi, contestava il fondamento di ogni avversa
domanda e ne chiedeva il rigetto, instando comunque per la riduzione della
penale.
In via riconvenzionale, poi, chiedeva: in primo luogo, la pronuncia di sentenza
costitutiva ex articolo 2932 Cc, che tenesse luogo del contratto definitivo di
vendita non concluso: previo, pagamento della somma di lire 48.375.831, oltre
le rate di mutuo a partire dal 31 dicembre 1993 e gli interessi;ed autorizzando,
in difetto, l’iscrizione, dell’ipoteca legale; inoltre la condanna dell’attore al
risarcimento
del
danno
per
il
ritardato
pagamento.
In corso di causa la convenuta mutava la domanda di adempimento del
contratto preliminare in quella di risoluzione, per inadempimento del
promissario acquirente, e chiedeva altresì la condanna del Fucile al
risarcimento
dei
danni,
da
liquidarsi
in
separata
sede.
Con sentenza 1580/01, l’adito Tribunale dichiarava risolto il contratto
preliminare per inadempimento della convenuta società e condannava la stessa
a restituire all’attore la somma di lire 130.000.000, nonché al pagamento della
penale peraltro nella ridotta misura di lire 10.000.000: con gli interessi di legge
sulle anzidette somme dal 9 dicembre 1993 al soddisfo;dichiarava non dovuta
la rivalutazione monetaria.
Infine, rigettava la domanda riconvenzionale della Tre Monti Residence Spa.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, chiedendone la,
integrale riforma:con la declaratoria che la promittente venditrice non era
tenuta alla consegna dell’immobile, stante l’inadempimento del promissario
acquirente all’obbligazione di pagamento del prezzo dell’immobile, pattuito in
sede
di
preliminare.
L’appellante chiedeva inoltre, l’accoglimento della domanda riconvenzionale di
5
risoluzione del contratto preliminare e la condanna del Fucile al risarcimento
dei danni, da liquidarsi separatamente; previa declaratoria del diritto di essa
appellante a trattenere la somma di lire 77.000.000 - pari all’importo
effettivamente versato dal Fucile - a compensazione dei danni patiti da essa
società.
Costituitosi, l’appellato chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione
ed il conseguente rigetto della stessa; in via di appello incidentale, poi, la
condanna della promittente venditrice al pagamento, a titolo di penale, della
somma
di
lire
41.000.000,
oltre
rivalutazione
ed
interessi.
All’esito del giudizio, la Corte di appello di Messina, con sentenza 399/02,
depositata il 23 luglio 2002, rigettava l’appello della Tre Monti Residence Spa-,
inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del Fucile, condannava
la predetta società al pagamento della penale nella misura contrattualmente
prevista di lire 5 1.000.000, con gli interessi legali dal 9 dicembre 1993 al
soddisfo;
confermava,
nel
resto,
l’impugnata
sentenza.
3. Avverso tale sentenza, notificata il 4 dicembre 2002, ha proposto ricorso per
cassazione la società Tre Monti Residence, con atto notificato il 28 gennaio
2003,
sostenuto
da
sei
mezzi
di
doglianza.
Resiste con controricorso l’intimato Fucile.
Motivi della decisione
4. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso, sollevata dal controricorrente sotto due distinti profili, e cioè per la
mancanza di un’autonoma esposizione dei fatti della causa, essendosi la
società Tre Monti limitata a riprodurre il testo della sentenza impugnata; ed
inoltre per la genericità dei motivi posti a base del ricorso stesso.
L’eccezione
è
priva
di
fondamento.
Invero, per quanto attiene al requisito di cui all’articolo 366 comma 1 n. 3 Cpc,
questa Corte (Cassazione, Su, 2602/03) ha definitivamente chiarito che la
necessità della esposizione sommaria dei fatti di causa risponde non ad un
esigenza di mero formalismo, essendo invece preordinata a garantire la
conoscenza dei fatti di causa al fine di intendere, senza il ricorso ad altre fonti,
il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato;
sicché, la relativa prescrizione deve ritenersi osservata quando nel ricorso sia
riportata l’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, allorché
tale esposizione fornisca gli elementi per la precisa ricostruzione delle vicende
processuali.
Orbene, poiché nella specie dal ricorso - seppure attraverso la riproduzione
della sentenza impugnata - è dato ricavare, con dovizia di particolari, lo
svolgersi di tali vicende, deve conseguentemente ritenersi osservato il disposto
del
menzionato
articolo
366
n.
3
Cpc.
Del pari, risulta osservato il requisito di cui all’articolo 366 comma 1 n. 4 Cpc,
6
posto che ciascuno dei sei motivi del ricorso in esame non si risolve in generici
rilievi circa l’erroneità della sentenza impugnata per cessazione, ma esplicita
specifiche censure alla sentenza stessa, con puntuale indicazione anche delle
norme di legge asseritamente violate così da consentire, senza il sussidio di
altre fonti, l’immediata individuazione delle questioni da risolvere.
5.
Ciò
posto
devono
essere
esaminati
i
motivi
del
ricorso.
5.1 Con un primo motivo la ricorrente società deduce violazione degli articoli
1218, 1362, 1453 e 1455 Cc nonché dell’articolo 132 Cpc, e correlato difetto di
motivazione.
I Giudici di appello non avrebbero valutato comparativamente, ai fini della
pronuncia di risoluzione del preliminare, anche il comportamento inadempiente
del Fucili.
In particolare non avrebbero tenuto conto che dalla documentazione prodotta
dalla società Tre Monti Residence in primo grado emergeva in modo inequivoco
che soltanto il promissario acquirente si era reso inadempiente alle proprie
obbligazioni regolate convenzionalmente da termini perentori; non certo la
promittente venditrice che aveva fatto ripetutamente offerta della propria
prestazione, afferente la consegna dell’immobile promesso in vendita.
5.2 Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 1184,
1362,
1457
Cc;
132
Cpc
nonché
carenza
di
motivazione.
I Giudici di appello, quanto all’addebito alla Tre Monti Residence Spa del ritardo
nella messa a disposizione dell’immobile, non avrebbero considerato che la
società non era affatto vincolata al rispetto di un termine essenziale;e che,
comunque, la società aveva fatto - ripetutamente - offerta di consegna
dell’immobile, mentre il Fucile non solo non aveva provveduto a regolare
l’aspetto economico del rapporto contrattuale, benché più volte sollecitato al
rispetto dei termini pattiziamente previsti, al riguardo, con carattere di
essenzialità; ed anzi aveva rifiutato espressamente, con lettera dell’1 dicembre
1994,
di
dare
esecuzione
al
preliminare
stesso.
In ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe svolto alcuna indagine, invece
necessaria, sulla gravità dell’inadempimento della società in relazione alla
mancanza di interesse del Fucile all’adempimento, resa manifesta dal carteggio
intercorso
fra
le
parti
ed
acquisito
in
causa.
5.3 Con un terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 1218,
1362, 1453, 1460 Cc e 132 Cpc, per avere i Giudici di appello omesso di
esaminare la domanda di risoluzione contrattuale e quella connessa, di
condanna generica al risarcimento dei danni, proposte dalla Tre Monti
Residence Spa e fondate sul comportamento inadempiente del Fucile, che non
aveva pagato l’intero prezzo convenuto e neppure mai aderito ai ripetuti inviti
alla
presa
in
consegna
dell’immobile.
5.4 Con un quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 2697 Cc
e
115,
13
2
Cpc
nonché
difetto
assoluto
di
motivazione.
La Corte di merito avrebbe omesso di rilevare che la condanna della società
alla restituzione dell’importo di lire 130.000.000 non aveva fondamento, in
quanto l’effettivo acconti sul prezzo, versato alla società, era pari alla minor
somma di lire 77.000.000, come documentalmente dimostrato dalla società
stessa: la quale, del resto, fin dal Patto di costituzione in giudizio aveva
dedotto che il Fucile era debitore della residua somma di lire 123.000.000 - a
7
fronte del prezzo dell’immobile, determinato in complessive lire 200.000.000.
In ogni caso, i Giudici di appello non avrebbero tenuto conto che, in base alla
documentazione versata in atti dal Fucile, non risultava alcuna prova certa
dell’avvenuto versamento di acconti in misura superiore a quella lire
77.000.000 - effettivamente percepita dalla società.
5.5 Con un quinto motivo si deduce violazione degli articoli 1384, 1453 e 1460
Cc.
La Corte territoriale erroneamente avrebbe riconosciuto al promissario
acquirente il diritto alla penale contrattuale, nonostante che lo stesso fosse
inadempiente al contratto preliminare - in particolare all’obbligo di pagare
l’intero prezzo pattuito per la vendita - ed il contratto non fosse comunque
risolvibile per colpa della società, adempiente o comunque non responsabile di
alcun inadempimento grave.
6. Le doglianze formulate con i primi cinque motivi del ricorso - che investono
la sentenza pur sotto diversi profili, sul punto della affermata risoluzione del
contratto preliminare per (solo) fatto e colpa della promittente venditrice ed al
conseguente riconoscimento a favore del Fucile del diritto al pagamento della
penale contrattuale - debbono essere congiuntamente esaminate, stante la
loro stretta connessione. Ritiene la Corte che esse siano prive di fondamento,
avendo la Corte territoriale offerto del raggiunto convincimento circa l’esclusiva
addebitabilità alla società Tre Monti Residence dell’inadempimento al
preliminare de quo ampia articolata e non contraddittoria motivazione, senza
altresì incorrere in errori di diritto.
I Giudici di appello hanno accertato, in primo luogo, che il termine per la
consegna dell’immobile finito, fissato nel preliminare al 28 febbraio 1993, non
fu rispettato dalla società la quale del resto neppure effettuò la consegna
nell’ulteriore termine di mesi sei da tale data; ed hanno argomentato che a tale
ulteriore termine doveva riconoscersi natura perentoria nonostante ogni
formale contraria previsione contrattuale, essendo stato riconosciuto - con lo
stesso preliminare - al promissario acquirente il diritto di ritenere risolto il
contratto e di ottenere il rimborso di quanto versato nonché la corresponsione
della penale di lire 51.000.000, appunto in caso di mancata consegna
dell’immobile
finito
entro
sei
mesi
dalla
data
iniziale
.
Gli stessi Giudici hanno altresì accertato - richiamandosi sul punto anche alla
motivazione della sentenza di primo grado (riprodotta a pagg 10 ed 11 della
sentenza ora in esame: ndr) - che la società Tre Monti non aveva dato prova
che, alla data del 28 agosto 1993, l’immobile era in effetti del tutto terminato
ed abitabile (onde non assumeva rilievo che la soc. Tre Monti avesse
comunicato al Fucile, in data 5 aprile 1993, che i lavori erano quasi ultimati) ;
con la conseguenza che nessun inadempimento - circa il versamento del
residuo prezzo - poteva essere addebitato al promissario acquirente, facultato
a ritenere risolto il contratto.
La Corte territoriale ha poi accertato con puntuali riferimenti alle risultanze
documentali di causa (pagg. 24-25 sentenza impugnata) , che il Fucile ebbe a
versare, a titolo di acconto sul prezzo non la somma di lire 77.000.000 - come
8
assunto dalla società ricorrente - bensì la maggior somma di lire 130.000.000:
ritenendo, di conseguenza che di tale somma correttamente il Fucile aveva
chiesto il rimborso.
Infine, la Corte di appello di Messina ha ritenuto dovuta la penale in
considerazione dell’accertato (esclusivo) inadempimento della società
promittente
venditrice
alle
sue
obbligazioni.
Orbene, si tratta di accertamento in fatto, incensurabile (salvo ciò che si dirà
oltre, a § 7, circa la misura della penale, che la Corte di merito ha ritenuto
dovuta nella misura contrattualmente prevista) in questa sede, in quanto
basato sull’apprezzamento delle risultanze processuali, che, come del tutto
pacifico, è demandato in via esclusiva al Giudice del merito: il quale nel caso in
esame ha dato - come si è in precedenza rilevato - adeguata e non illogica
spiegazione del convincimento circa il carattere assorbente dell’inadempimento
della società valutato di entità tale (e perciò stesso di non scarsa importanza,
ai sensi dell’articolo 1455 Cc) da giustificare la risoluzione del contratto per
fatto
e
colpa
della
società
medesima.
D’altro canto, a questa Corte non è consentito un nuovo esame delle risultanze
processuali sulla base della diversa interpretazione e valutazione che la parte
interessata ne proponga ma soltanto di verificare l’adeguatezza e la coerenza
delle ragioni che sostengono la decisione, oltre che, ovviamente, di accertare
che
la
decisione
stessa
sia
conforme
a
diritto.
Orbene nella specie, le conclusioni raggiunte, oltre che indiscutibili sul piano
della adeguatezza e coerenza motivazionale, neppure evidenziano errori di
diritto: posto che la Corte territoriale una volta accertato e valutato come di
non scarsa importanza l’inadempimento della società ad un termine di
accertata natura essenziale, correttamente (arg. ex articolo 1460 Cc) ha
ritenuto giustificato il rifiuto del promissario acquirente di versare il residuo
prezzo ed ha conseguentemente pronunciato la risoluzione del contratto
preliminare de quo per esclusiva colpa della promittente venditrice.
7. Con un sesto motivo la ricorrente deduce violazione dell’articolo 1384 Cc e
degli
articoli
342
e
343
Cpc
nonché
vizio
di
motivazione.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo l’appello
incidentale del Fucile nonostante fosse stato proposto in epoca (23.11.2001)
successiva a quella (31.7.2001) di effettiva prima udienza di trattazione dalla
causa, nella quale il Fucile si era costituito con comparsa, svolgendo anche
difese
nel
merito.
Inoltre, del pari erroneamente avrebbe ritenuto dovuta la penale nella misura
contrattualmente fissata senza considerare che l’ammontare della stessa
poteva essere in ogni caso ridotta dal Giudice, nonostante la contraria
pattuizione delle parti.
La doglianza, laddove investe la sentenza sotto il profilo dell’error in
procedendo non è fondata; mentre è da condividere in relazione al potere del
Giudice
di
ridurre
la
misura
della
penale.
In
proposito
va
rilevato
quanto
segue.
Vero è per un verso, che - ai fini dell’ammissibilità dell’appello incidentale per
prima udienza deve ritenersi, secondo il previgente testo dell’articolo 343
comma 1 Cpc (applicabile nella specie, in quanto ai sensi dell’articolo 90 legge
9
353/90 per giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 devono intendersi
quelli iniziati in primo grado prima della suddetta data:Cassazione 13147/03) ,
quell’udienza in cui vi sia stato lo svolgimento di attività processuale ai sensi
dell’articolo
350
Cpc.
Senonché, nella specie, l’udienza del 31 luglio 2001 risulta essere stata tenuta,
su istanza di parte, al fine di decidere, ex articolo 351 Cpc, sulla sospensione
della provvisoria esecuzione della sentenza appellata: sicché ogni attività
processuale ed ogni difesa svolta in tale udienza non può essere presa in
considerazione ad altri fini.
La proposizione dell’appello incidentale deve ritenersi pertanto essere
tempestivamente avvenuta all’udienza del 23 novembre 2001, la prima
effettivamente
tenuta
ai
sensi
degli
articoli
343
e
350
Cpc.
In ordine poi alla questione della penale contrattuale, va osservato quanto
segue.
Dalla impugnata sentenza risulta che nel contratto preliminare, alla clausola n.
8, le parti inserirono una penale, a carico della società, per tutti i casi di
risoluzione del preliminare per fatto e colpa alla stessa addebitabile, di lire
51.000.000, “irriducibile, anche in deroga all’articolo 13 84 Cc”.
I Giudici di appello - in diverso avviso dal Tribunale di Messina - hanno ritenuto
irriducibile tale penale, stante la espressa previsione delle parti in tal senso.
Ritiene
la
Corte
che
tale
soluzione
non
sia
condivisibile.
Invero, occorre tenere conto che il potere di riduzione della penale ad equità è
stato riconosciuto al Giudice dall’articolo 1384 Cc a tutela dell’interesse
generale dell’ordinamento (Cassazione, Su 18128/05), sicché trattandosi di un
c.d. potere-dovere, lo stesso può essere esercitato anche d’ufficio, al fine di
ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente
meritevole di tutela.
In tale quadro interpretativo - che il Collegio pienamente condivide - è
evidente la non correttezza giuridica della conclusione cui è giunta sul punto la
Corte di merito, ritenendo che la previsione contrattuale della irriducibilità non
consentisse perciò stesso la riduzione della penale:in tal modo essendosi
riconosciuto all’autonomia privata di paralizzare l’esercizio di un potere invece
riconosciuto
al
Giudice
nel
superiore
interesse
dell’ordinamento.
6. Conclusivamente, i primi cinque motivi debbono essere rigettati; va invece
accolto,
per
quanto
di
ragione,
il
sesto.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto:
con rinvio - occorrendo ai fini del decidere ulteriori accertamenti di fatto, e
comunque essendo l’eventuale riduzione della penale, correlata all’esercizio di
poteri tipicamente discrezionali (Cassazione 6380/01;Cassazione 7528/02) non
attribuiti al Giudice di legittimità - alla Corte di appello di Reggio Calabria, la
quale
provvederà
anche
sulle
spese
del
presente
giudizio.
PQM
10
La Corte accoglie per quanto di ragione, il sesto motivo del ricorso;rigetta i
restanti;cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio
Calabria.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.03. 2006
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 13
SETTEMBRE 2005, N. 18128
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio di Via Ischia di Castro, in Roma, convenne in giudizio, davanti al
Giudice di pace, il condomino G.S. e ne chiese la condanna al pagamento della
somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli
artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire
1.045.281,
dovute
per
spese
di
condominio.
Il S. chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del
regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per
il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via
riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle.
Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del
regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal S.
Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del
regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., applicabile in tutte
«le convenzioni di interessi» e «quindi anche in quelle contenute in un
regolamento condominiale di natura contrattuale». Chiese anche che le
suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione
fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora.
Il condominio non si costituì in giudizio.
Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando:
- che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo
comma dell'art. 1815 c.c. perché le somme dovute dal condomino, per il caso
di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali,
non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di
denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura
11
contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato
il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento;
- che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino
ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio;
- che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento
della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora dei condomino, poiché
era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale
previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, c.c.
G.S.
Il
ha
proposto
condominio
ricorso
intimato
per
la
non
cassazione
ha
della
svolto
suddetta
sentenza.
attività
difensiva.
La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con
ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per
l'eventuale assegnazione alla sezioni unite, avendo ravvisato l'esistenza di un
contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di
ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. (questione dedotta con il
primo motivo del ricorso).
Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione
del contrasto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esame dei motivi occorre premettere che il Tribunale ha qualificato come
clausola penale la sanzione prevista, negli artt. 18 e 23 nel regolamento di
natura contrattuale, a carico dei condomini inadempienti nel pagamento dei
contributi
dovuti.
Tale qualificazione non è posta in discussione dalle parti ed anzi il ricorrente su
detta qualificazione poggia il motivo di ricorso, con il quale denuncia come
erronea la decisione del giudice di merito nella parte in cui ha negato che il
giudice possa ridurre d'ufficio la penale.
Pertanto, il ricorso deve essere esaminato da questa Corte sulla base di tale
avvenuta
qualificazione.
2. È preliminare l'esame del secondo motivo, perché con esso si deduce la
nullità della clausola penale, cosicché se la censura fosse fondata cadrebbe la
necessità di esaminare il primo motivo, con il quale la sentenza impugnata è
censurata, invece, per avere negato il potere del giudice di ridurre la penale in
assenza di una richiesta di parte.
3. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione ed erronEa applicazione
dell'art. 1815, secondo comma, c.c. e difetto di motivazione in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c.
12
Si deduce che - non contestata l'usurarietà del tasso di interesse previsto nella
penale - «la c.d. funzione calmieratrice prevista dall'art. 1815 c.c., come
modificato dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, trova applicazione sempre,
allorquando ricorra nel contratto un vantaggio usurario, quale che sia il
rapporto obbligatorio sottostante, creandosi in caso contrario una indebita
sperequazione nel trattamento delle clausole penali e delle clausole fissanti
tassi di interessi moratori, che altro non sono che una sanzione per il mancato
pagamento
nei
tempi
stabiliti
della
obbligazione
pecuniaria».
4. La censura è infondata.
Il ricorrente, sostanzialmente, invoca l'applicazione dei criteri fissati dalla l. 7
marzo 1996, n. 108 per attribuire carattere usurario alla somma dovuta in
forza della penale pattuita.
Senonché - a prescindere da ogni altro rilievo in ordine alla esattezza o meno
della tesi prospettata - il ricorrente non considera che i criteri fissati dalla l. n.
108 dei 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non
trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore
della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica
contenuta nell'art. 1, primo comma, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito,
con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2001, n. 24), norma riconosciuta non in
contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 Corte cost. (principio
ripetutamente affermato da questa Corte: v., tra le più recenti, Cass. 25 marzo
2003, n. 4380; Cass. 13 dicembre 2002, n. 17813; Cass. 24 settembre 2002,
n. 13868).
Ora poiché, come è pacifico, la convenzione alla quale il ricorrente attribuisce
natura usuraria, è anteriore alla entrata in vigore della l. 7 marzo 1996 n. 108,
già per questa sola ragione la sua disciplina non le si può applicare e pertanto
appare superfluo l'esame del problema relativo alla trasponibilità della
disciplina dell'art. 1815 c.c. ad una clausola, come quella oggetto della
presente controversia, che trae origine da un rapporto in cui non è
identificabile una causa di finanziamento.
5. Con il primo motivo del ricorso si denuncia: Violazione ed erronea
applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. - Difetto di motivazione. Il tutto in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Si deduce l'erroneità dell'assunto del Tribunale in ordine alla ritenuta non
riducibilità d'ufficio della penale e si richiama a sostegno della censura la
sentenza n. 10511/1999 di questa Corte.
13
6. La censura pone il problema se il potere di ridurre la penale, conferito al
giudice dall'art. 1384 c.c., possa essere esercitato d'ufficio ovvero se sia
necessaria la domanda o la eccezione della parte tenuta al pagamento.
6.1. Il dato normativo, come detto, è costituito dall'art. 1384 c.c. secondo cui
«La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore
aveva all'adempimento».
6.2. Fin dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione è stata concorde nell'affermare che il potere del giudice di
ridurre la penale non può essere esercitato d'ufficio, pur manifestando
nell'ambito di questo orIentamento, notevoli oscillazioni in ordine al modo ed ai
tempi in cui le parti avrebbero dovuto esercitare il loro riconosciuto dovere di
sollecitare la pronuncia del giudice, giungendo, in taluni casi, ma con
affermazione poi superata dalla successiva prevalente giurisprudenza, a
ritenere che la richiesta di riduzione della penale dovesse ritenersi implicita
nell'affermazione di nulla dovere a tale titolo.
Tale orientamento è stato, tuttavia, posto in discussione dalla sentenza n.
10511/1999 di questa Corte, la quale ha, invece, ritenuto che la penale possa
essere ridotta dal giudice anche d'ufficio.
Questo nuovo orientamento non ha però trovato seguito nella successiva
giurisprudenza della Corte, che (fatta eccezione per la sentenza n. 8188/2003
che ad esso si è adeguata) ha ribadito l'orientamento tradizionale, con le
sentenze n. 5324/2003, n. 8813/2003, n. 5691/2002, n. 14172/2000.
6.3. Queste sezioni unite, chiamate a risolvere il richiamato contrasto,
ritengono di dover confermare il principio affermato dalla sentenza n.
10511/1999,
cui
si
è
adeguata
la
sentenza
n.
8188/2003.
6.4. Non vi è dubbio che la svolta operata dalla sentenza n. 10511/1999 è
stata influenzata da due concorrenti elementi.
Il primo relativo al riscontro nella giurisprudenza, che fino ad allora aveva
negato il potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale, di taluni cedimenti,
individuati nel fatto che, in alcune delle pronunzie, l'ossequio al principio
tradizionale appariva solo formale, poiché si giungeva talvolta a ritenere la
domanda di riduzione implicita nell'assunto della parte di nulla dovere a titolo
di
penale
ovvero
l'eccezione
relativa
proponibile
in
appello.
Il secondo fondato sull'osservazione che l'esegesi tradizionale non appariva più
adeguata alla luce di una rilettura degli istituti codicistici in senso conformativo
ai precetti superiori della Costituzione, individuati nel dovere di solidarietà nei
rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), nell'esistenza di un principio di
14
inesigibilità come limite alle pretese creditorie (Corte cost. n. 19/1994), da
valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di correttezza
(artt.
1175,
1337,
1359,
1366,
1375
c.c.).
6.5. Quanto al primo elemento sopra ricordato, non v'è dubbio che le variegate
posizioni assunte dalla giurisprudenza, in ordine ai tempi ed ai modi in cui la
richiesta di riduzione della penale debba avvenire ed alle ragioni per le quali la
stessa possa essere richiesta, denotano quanto meno una debolezza dei
fondamenti giuridici sui quali si basa la tesi della non riducibilità d'ufficio della
penale, nonché una implicita contraddittorietà, individuabile specie in quelle
pronunce le quali affermano che la norma dell'art 1384 c.c. - che attribuisce al
giudice il potere di diminuire equamente la penale - non ha la funzione di
proteggere il contraente economicamente più debole dallo strapotere del più
forte, bensì mira alla tutela e ricostitUzione dell'equilibrio contrattuale,
evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non
enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente (v.
Cass. 6 aprile 1978, n. 1574), ovvero ritengono che la riduzione della penale,
per effetto di parziale adempimento dell'obbligazione, a norma dell'art. 1384
c.c., non integra un diritto del debitore, ma è rimessa all'equa valutazione del
giudice, in relazione all'interesse dei creditore al tempestivo ed integrale
adempimento (v. Cass. 7 luglio 1981, n. 4425).
6.6. Quanto al secondo elemento non può che condividersi la necessità di una
lettura della norma di cui all'art. 1384 c.c. che meglio rispecchi l'esigenza di
tutela di un interesse oggettivo dell'ordinamento alla luce dei principi
costituzionali richiamati.
6.7. Naturalmente una lettura di questo tipo, consentita dal fatto che l'art.
1384 c.c. non contiene alcun riferimento ad un'iniziativa della parte rivolta a
sollecitare l'esercizio del potere di riduzione da parte del giudice, non può
prescindere dalla necessità di sottoporre a vaglio le argomentazioni addotte
dalla giurisprudenza che ritiene necessaria quella iniziativa e di verificare nel
contempo se sussistano altre ragioni, che consentano quella lettura della
norma adeguata ai principi costituzionali posti bene in luce dalla sentenza n.
10511/1999.
6.8. Gli argomenti addotti dalla giurisprudenza che nega il potere del giudice di
ridurre d'ufficio la penale sono principalmente tre.
6.8.1. Il primo argomento si fonda sul principio generale, al quale l'art. 1384
c.c. non derogherebbe, secondo cui il giudice non può pronunciare se non nei
limiti
della
domanda
e
delle
eccezioni
proposte
dalle
parti.
Senonché questo argomento non appare decisivo e sembra fondarsi
sull'assunto della esistenza di un fatto che è, invece, da dimostrare.
Occorre partire dal testo dell'art. 112 c.p.c., secondo cui «Il giudice deve
pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può
15
pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle
parti».
Ora, il giudice che riduca l'ammontare della penale, al cui pagamento il
creditore ha chiesto che il debitore sia condannato, non viola in alcun modo la
prima proposizione del richiamato art. 112 c.p.c., atteso che il limite postogli
dalla norma è, in linea generale, che egli non può condannare il debitore ad
una somma superiore a quella richiesta, mentre può condannarlo al pagamento
di
una
somma
inferiore.
Ma l'art. 112 c.p.c. dispone anche che il giudice non può pronunciare d'ufficio
su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
La norma lascia intendere che vi sono, oltre alle eccezioni proponibili soltanto
dalle parti, anche eccezioni che non lo sono e, in quanto tali, rilevabili d'ufficio.
Se così è, allora, il problema della riducibilità della penale non è risolto dall'art.
112 c.p.c., ma dalla risposta al quesito se la riduzione della penale sia oggetto
di una eccezione che può essere proposta soltanto dalla parte.
Nel codice civile sono espressamente individuate varie ipotesi di eccezioni
proponibili soltanto dalla parte; in via esemplificativa: art. 1242, primo
comma. c.c. - eccezione di compensazione; art. 1442, comma quarto, c.c. eccezione di annullabilità del contratto, quando è prescritta l'azione; art. 1449,
secondo comma, c.c. - eccezione di rescindibilità del contratto, quando l'azione
è prescritta; art. 1460, primo comma, c.c. - eccezione di inadempimento; art.
1495, terzo comma, c.c. - eccezione di garanzia, nella vendita, anche se è
prescritta l'azione; art. 1667, terzo comma, c.c. - eccezione di garanzia,
nell'appalto - anche se l'azione è prescritta; art. 1944, secondo comma, c.c. eccezione di escussione da parte del fideiussore; art. 1947, primo comma, c.c.
- beneficio della divisione nella fideiussione; art. 2938 c.c. - eccezione di
preScrizione; art. 2969 c.c. - eccezione di decadenza, «salvo che, trattandosi
di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le
cause
d'improponibilità
dell'azione».
L'art. 1384 c.c., al contrario delle ipotesi sopra indicate, non fa alcuna
menzione della necessità della eccezione della parte o, quantomeno, della
necessità che il giudice debba essere sollecitato ad esercitare il potere di
riduzione
della
penale
conferitogli
dalla
legge.
Il silenzio della norma sul punto non depone certamente a favore della tesi
secondo cui la riduzione della penale debba essere chiesta dalla parte, ma fa
propendere, se mai, a favore della tesi contraria, specie se si guardi ad altre
previsioni del codice civile nelle quali l'intervento del giudice è visto in funzione
correttiva della volontà manifestata dalle parti (v. Cass. sez. un. 17 maggio
1996, n. 4570, che espressamente parla di «funzione correttiva» del giudice,
non solo nell'ipotesi della riduzione della penale manifestamente eccessiva (art.
1384 c.c.), ma anche nei casi di riduzione dell'indennità dovuta per la
16
risoluzione della vendita con riserva di proprietà (art. 1526 c.c.) e di riduzione
della
posta
di
giuoco
eccessiva
(art.
1934
c.c.).
6.8.2. Il secondo argomento addotto è che la riduzione della penale fissata
dalle parti è prevista dalla legge come istituto a tutela degli specifici interessi
del debitore, al quale quindi deve essere rimessa, nell'esercizio della difesa dei
propri diritti, ogni iniziativa al riguardo ed ogni consequenziale valutazione
della eccessività della penale ovvero della sua sopravvenuta onerosità, in
relazione
alla
parte
di esecuzione
che
il contratto ha
avuto.
Anche questo argomento si fonda su un dato non dimostrato e cioè che
l'istituto della riduzione della penale sia predisposto nell'interesse della parte
debitrice.
Intanto una affermazione di questo tipo appare contraddetta dall'osservazione
che la penale «può» ma non «deve» essere ridotta dal giudice, avuto riguardo
all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; dal che si desume che non
esiste un diritto del debitore alla riduzione della penale e che il criterio che il
giudice deve utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva ha natura
oggettiva, atteso che non è previsto che il giudice debba tenere conto della
posizione soggettiva del debitore e del riflesso che sul suo patrimonio la penale
può avere, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, mentre il
riferimento all'interesse del creditore ha la sola funzione di indicare lo
strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente
eccessiva o meno.
Ne discende che, pur sostanziandosi la riduzione della penale in un
provvedimento che rende in concreto meno onerosa la posizione del debitore e
che deve essere adottato tenuto conto dell'interesse che il creditore aveva
all'adempimento, il potere di riduzione appare attribuito al giudice non per la
tutela dell'interesse della parte tenuta al pagamento della penale, ma,
piuttosto,
a
tutela
di
un
interesse
che
lo
trascende.
Del resto il nostro ordinamento conosce altri casi in cui l'intervento equitativo
del giudice pur risolvendosi in favore di una delle parti in contesa non è
tuttavia predisposto specificamente per la tutela di un suo interesse.
Si pensi all'ipotesi in cui una delle parti abbia chiesto il risarcimento del danno
in forma specifica; il giudice, in questo caso, anche se l'esecuzione specifica sia
possibile, ha tuttavia il potere di disporre che il risarcimento avvenga per
equivalente «se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente
onerosa
per
il
debitore»
(art.
2058
c.c.).
È un potere che il giudice può esercitare pacificamente d'ufficio avuta presente
l'obiettiva difficoltà che il debitore può incontrare nell'eseguire la prestazione
risarcitoria; la difficoltà, appunto perché obiettiva, non riguarda però la
situazione economica del debitore, ma piuttosto l'esecuzione stessa della
prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno,
17
costo ed utilità. L'onerosità per il debitore viene cioè in rilievo come metro di
giudizio perché il giudice possa effettuare la sua valutazione e non come
interesse tutelato dalla norma.
Si pensi ancora al potere attribuito al giudice di liquidare il danno con
valutazione equitativa se lo stesso non può essere provato nel suo preciso
ammontare (art. 1226 c.c.), pacificamente esercitatile indipendentemente dalla
richiesta delle parti.
Già, quindi, dall'esame critico della giurisprudenza maggioritaria, emergono
elementi per affermare che il potere di riduzione della penale è concesso dalla
legge al giudice per fini che prescindono dalla tutela dell'interesse della parte,
che al pagamento della penale sia tenuta per effetto del suo inadempimento o
ritardato adempimento.
6.8.3. Il terzo argomento addotto dalla giurisprudenza prevalente è che il
giudice, nell'esercizio dei poteri equitativi diretti alla determinazione
dell'oggetto dell'obbligazione della clausola, non dispone di altri parametri di
giudizio che di quelli dati dai contrapposti interessi delle parti al fine esclusivo
di verificare se l'equilibrio raggiunto dalle parti stesse, nelle preventiva
determinazione delle conseguenze dell'inadempimento, sia equo o sia rimasto
tale.
Ma anche questo argomento non appare decisivo ove si consideri che la
mancata allegazione (o la impossibilità di riscontri negli atti acquisiti) della
eccessività della penale incide sul piano fattuale dell'accertamento della
sussistenza delle condizioni per la riduzione della penale medesima, ma non
sull'esercizio
officioso
del
potere
del
giudice.
In proposito è sufficiente ricordare ciò che accade in tema di nullità del
contratto, che il giudice può dichiarare d'ufficio purché risultino dagli atti i
presupposti della nullità medesima (Cass. n. 4062/1987), senza che per
l'accertamento della nullità occorrano indagini di fatto per le quali manchino gli
elementi necessari (Cass. n. 1768/1986, 4955/1985, 985/1981), e più di
recente Cass. n. 1552/2004, secondo cui «La rilevabilità d'ufficio della nullità di
un contratto prevista dall'art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia
obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta
nullità risultare "ex actis" ossia dal materiale probatorio legittimamente
acquisito al processo, essendo i poteri officiosi dei giudice limitati al rilievo
della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio
gravante su di essa», nonché da ultimo Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n.
21095.
6.8.4. Sembra, quindi, che nessuno dei tre argomenti prospettati dalla
giurisprudenza maggioritaria sia decisivo per la soluzione del quesito oggetto
del contrasto, mentre, come in parte anticipato, vi sono argomenti che
appaiono sufficientemente probanti a sostegno della tesi fin qui minoritaria, i
18
quali assumono una valenza decisiva alla luce dei principi costituzionali posti in
luce dalla sentenza n. 10511/1999.
6.9. Poiché nella discussione sull'esistenza del potere del giudice di ridurre
d'ufficio la penale è stato spesso introdotto il tema dell'autonomia contrattuale
è bene prendere le mosse proprio da tale punto.
L'art. 1322 c.c. - la cui rubrica è appunto intitolata all'autonomia contrattuale attribuisce alle parti:
a)
il
potere
di
determinare
il
contenuto
del
contratto;
b) il potere di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una
disciplina particolare.
Nel primo caso l'autonomia delle parti deve svolgersi «nei limiti imposti dalla
legge», nel secondo caso la libertà è limitata per il fatto che il contratto deve
essere diretto «a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico».
La legge, quindi, nel riconoscere l'autonomia contrattuale delle parti, afferma
che essa ha comunque dei limiti.
L'osservanza del rispetto di tali limiti è demandato al giudice, che non può
riconoscere il diritto fatto valere, se esso si fonda su un contratto il cui
contenuto non sia conforme alla legge ovvero sia diretto a realizzare interessi
che
non
appaiono
meritevoli
secondo
l'ordinamento
giuridico.
L'intervento del giudice in tali casi è indubbiamente esercizio di un potere
officioso attribuito dalla legge.
Se nel nostro ordinamento non fosse stato previsto e disciplinato l'istituto della
clausola penale e, tuttavia, le parti avessero introdotto in un contratto una
clausola con tale funzione, il giudice, chiamato a pronunciarsi in ordine ad una
domanda di condanna del debitore al pagamento della penale pattuita per
effetto dell'inadempimento, avrebbe dovuto formulare, d'ufficio, un giudizio
sulla validità della clausola; giudizio che avrebbe potuto avere esito negativo,
ove fosse stato ravvisato un contrasto dell'accordo con principi fondamentali
dell'ordinamento, ad esempio per il fatto che la penale doveva essere pagata
anche se il danno non sussisteva.
In questo caso vi sarebbe stato un controllo d'ufficio sulla tutelabilità
dell'accordo delle parti e, ove il controllo si fosse concluso negativamente, la
tutela non sarebbe stata accordata.
Nel nostro diritto positivo questo controllo non è necessario perché l'istituto è
riconosciuto e disciplinato dalla legge (artt. 1382 e segg. c.c.).
19
Nel disciplinare l'istituto la legge ha ampliato il campo normalmente riservato
all'autonomia delle parti, prevedendo per esse la possibilità di predeterminare,
in tutto o in parte, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal debitore
inadempiente (se si vuole privilegiare l'aspetto risarcitorio della clausola),
ovvero di esonerare il creditore di fornire la prova del danno subito, di
costituire un vincolo sollecitatorio a carico del debitore, di porre a carico di
quest'ultimo una sanzione per l'inadempimento (se se ne vuole privilegiare
l'aspetto sanzionatorio), e ciò in deroga alla disciplina positiva in materia, ad
esempio, di onere della prova, di determinazione del risarcimento del danno,
della
possibilità
di
istituire
sanzioni
private.
Tuttavia, la legge, nel momento in cui ha ampliato l'autonomia delle parti, in
un campo normalmente riservato alla disciplina positiva, ha riservato al giudice
un potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso di questa
autonomia.
Così operando, la legge ha in sostanza spostato l'intervento giudiziale, diretto
al controllo della conformità del manifestarsi dell'autonomia contrattuale nei
limiti in cui essa è consentita, dalla fase formativa dell'accordo - che ha
ritenuto comunque valido, quale che fosse l'ammontare della penale - alla sua
fase attuativa, mediante l'attribuzione al giudice del potere di controllare che la
penale non fosse originariamente manifestamente eccessiva e non lo fosse
successivamente
divenuta
per
effetto
del
parziale
adempimento.
Un potere di tal fatta appare concesso in funzione correttiva della volontà delle
parti
per
ricondurre
l'accordo
ad
equità.
Vi sono casi in cui la correzione della volontà delle parti avviene
automaticamente, per effetto di una disposizione di legge che ne limita
l'autonomia e che sostituisce alla volontà delle parti quella della legge (in tali
casi l'accordo delle parti, che non rispecchia il contenuto tipico previsto dalla
legge, non viene dichiarato nullo ma viene modificato mediante la sostituzione
della parte non conforme); ve ne sono altri, in cui una inserzione automatica
della disciplina legislativa, in sostituzione di quella pattizia, non è possibile
perché non può essere determinata in anticipo la prestazione dovuta da una
delle parti, che quindi non può essere automaticamente inserita nel contratto;
in tali casi la misura della prestazione è rimessa al giudice, per evitare che le
parti utilizzino uno strumento legale per ottenere uno scopo che l'ordinamento
non consente ovvero non ritiene meritevole di tutela, come è reso evidente,
proprio in tema di clausola penale, dal fatto che il potere di riduzione è
concesso al giudice solo con riferimento ad una penale che non solo sia
eccessiva, ma che lo sia «manifestamente», ovvero ad una penale non più
giustificabile nella sua originaria determinazione, per effetto del parziale
adempimento dell'obbligazione.
In tale senso inteso, il potere di controllo appare attribuito al giudice non
nell'interesse della parte ma nell'interesse dell'ordinamento, per evitare che
l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali la tutela delle posizioni
20
soggettive delle parti appare meritevole di tutela, anche se ciò non toglie che
l'interesse della parte venga alla fine tutelato, ma solo come aspetto riflesso
della funzione primaria cui assolve la norma.
Può essere affermato allora che il potere concesso al giudice di ridurre la
penale si pone come un limite all'autonomia delle parti, posto dalla legge a
tutela di un interesse generale, limite non prefissato ma individuato dal giudice
di volta in volta, e ricorrendo le condizioni previste dalla norma, con
riferimento al principio di equità.
Se così non fosse, apparirebbe quanto meno singolare ritenere, sicuramente
con riferimento all'ipotesi di penale manifestamente eccessiva, in presenza di
una clausola valida (si ricordi che è valida la clausola ancorché manifestamente
eccessiva), che l'esercizio del potere del giudice di riduzione della penale debba
essere condizionato alla richiesta della parte, quasi che, a questa, fosse
riconosciuto uno jus poenitendi, e, quindi la facoltà di sottrarsi all'adempimento
di un'obbligazione liberamente assunta (quella appunto del pagamento di una
penale
che
fin
dall'origine
si
manifestava
come
eccessiva).
Se si considera che il potere di riduzione della penale può essere esercitato
solo in presenza di una clausola che sia valida (e quindi esente da vizi che ne
determino la nullità o l'annullabilità) più coerente appare allora qualificare
detto potere come officioso nel senso sopra specificato, di riconduzione
dell'accordo, frutto della volontà liberamente manifestata dalle parti, nei limiti
in cui esso appare meritevole di ricevere tutela dall'ordinamento.
Non è privo di significato il fatto che la giurisprudenza, pur affermando la tesi
della necessità della domanda o eccezione della parte al fine di sollecitare il
potere di riduzione affidato al giudice, non ha potuto tuttavia non riconoscere
(come del resto la quasi unanime dottrina) la natura inderogabile della
disposizione di cui all'art. 1384 c.c., attributiva al giudice del potere di ridurre
la penale, riconoscendo che essa è posta principalmente a salvaguardia
dell'interesse generale, per impedire sconfinamenti oltre determinati limiti di
equilibrio contrattuale (v. in tal senso Cass. 4 febbraio 1960, n. 163 e
successivamente, in modo conforme circa la natura inderogabile della norma,
Cass., sez. un., 5 dicembre 1977, n. 5261; Cass. 7 agosto 1992, n. 9366;
Cass. 29 marzo 1996, n. 2909; Cass. 5 novembre 2002, n. 15497 - queste
ultime tre in motivazione), in tale modo riconoscendo l'esistenza dei
presupposti per un intervento officioso dei giudice, non tanto per la tutela di
interessi individuali, ma piuttosto per una funzione correttiva di riequilibrio
contrattuale (se si vuole privilegiare la tesi della natura risarcitoria della
penale) ovvero di adeguatezza della sanzione (se si vuole privilegiare la tesi
della funzione sanzionatoria).
Aspetto quest'ultimo particolarmente sottolineato da Cass. 24 aprile 1980, n.
2749, secondo cui il potere conferito al giudice dall'art. 1384 c.c. di ridurre la
penale manifestamente eccessiva è fondato sulla necessità di correggere il
potere di autonomia privata riducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento
21
di essa, mediante l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo
contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del
creditore all'adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva
incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione
contrattuale.
Pare, quindi, a queste sezioni unite, che la lettura della norma interessata,
svolta nel quadro dei principi generali dell'ordinamento e dei principi
costituzionali posti in luce dalla sentenza n. 10511/1999, consenta di giungere
alla conclusione che il potere del giudice di ridurre la penale possa essere
esercitato d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente
eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale e stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso,
la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in
caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una
eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.
7. È questa lettura della norma che porta ad affermare il principio che «il
potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall'art. 1384 c.c. al
giudice,
può
essere
esercitato
anche
d'ufficio».
8. In questi termini deve essere accolto il secondo motivo del ricorso con rinvio
della causa ad altra sezione del Tribunale di Roma che si atterrà al principio
sopra enunciato.
9. È di conseguenza assorbito il terzo motivo, con il quale, denunciandosi:
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto di
motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce che in
conseguenza della fondatezza delle tesi esposte dal ricorrente le spese del
giudizio di merito (primo e secondo grado) sarebbero dovute essere poste a
carico del condominio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il secondo motivo del ricorso,
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la
regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
del Tribunale di Roma.
22
CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI – SENTENZA 18 MAGGIO 2006,
N. 11624
Presidente Carbone – Relatore Bucciante
Pm Iannelli – parzialmente conforme – Ricorrente La Gamba ed altri
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha Pronunciato la
risoluzione, per inadempimento di Mirella Profeti, di un contratto preliminare
con il quale costei si era obbligata a vendere a Wladimiro La Gamba e Teresa
Virdò un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la
promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di lire
17.000.000,
nonché
al
rimborso
delle
spese
di
giudizio.
Impugnata in via principale da Wladimiro La Gamba e Teresa Virdò,
incidentalmente da Mirella Profeti, la decisione è stata riformata dalla Corte di
appello di Firenze, che con sentenza del 21 marzo 2000, in parziale
accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato il contratto risolto per
inadempimento del La Gamba e della Virdò, ha rideterminato in lire
16.000.000 la somma che doveva essere loro rimborsata, ha confermato il
rigetto della domanda di risarcimento di danni formulata dalla Profeti, ha posto
a carico degli appellanti principali metà delle spese di entrambi i gradi di
giudizio, compensandole tra le parti per l’altra metà. A queste pronunce il
giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che «unica ragione della
mancata stipula va - ricondotta alla mancata proprietà del bene da parte della
promittente venditrice, ma appare pacifico che in realtà anche tale questione
era stata risolta precedentemente (il che assorbe ogni rilievo relativo
all’effettiva conoscenza di tale altruità da parte dei La Gamba) essendosi la
Profeti presentata munita di procura a vendere del tutto rituale, relativa al
bene de quo e rilasciata dai proprietari due giorni prima e davanti allo stesso
notaio»; che «è d’altronde indiscusso che in caso di preliminare di vendita
l’obbligo-del promittente venditore è quello di procurarsi la proprietà del bene
o di ottenere dal proprietario il consenso o l’autorizzazione alla vendita –
Cassazione, 3677/96; 367/77; 8228/90 - per cui non è dato vedere cosa possa
imputarsi alla Profeti che era perfettamente in grado di vendere il bene alla
data prefissata»; che «né può sostenersi - come sembrano fare i La Gamba che
essi
acquistando
da
“altri”
potevano
risultare
meno
garantiti, rispetto alla Profeti: invero nei loro confronti e in relazione alle
garanzie loro spettanti per legge, unico interlocutore era e restava la Profeti
personalmente e direttamente, per cui solo sulla Profeti continuavano a
ricadere tutte le garanzie in materia di vizi o di evizione - v. Cassazione,
3963/84»; che «non vi è alcuna prova (che la Profeti nemmeno ha chiesto di
fornire)»,
in
ordine
ai
danni
da
lei
lamentati.
Wladimiro La Gamba e Teresa Virdò hanno proposto ricorso per cassazione, in
base a un motivo. Mirella Profeti si è costituita con controricorso, formulando a
23
sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, e ha depositato una
memoria.
Motivi della decisione
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno
riunite in un solo processo, in applicazione dell’articolo 335 Cpc.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale Wladimiro La Gamba e
Teresa Virdò lamentano che la Corte di appello «ha applicato il disposto
dell’articolo 1478 Cc anziché quanto previsto dall’articolo 1479 Cc», pur se «al
momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la
Sig.ra Profeti Mirella non aveva messo a conoscenza i promittenti acquirenti
che l’immobile fosse di proprietà di altri» e in tali casi «è possibile per il
compratore chiedere la risoluzione del contratto salvo che il venditore non
abbia, nel frattempo, acquistato la proprietà della cosa», mentre «nella
fattispecie ciò era tanto più importante perché esistevano, come è stato
riconosciuto da tutti i tenti, problemi di esercizio del diritto di prelazione da
parte di terzi, con la conseguenza che i ricorrenti non avrebbero più avuto la
garanzia da parte del loro originale contraddittore e promittente venditore».
Secondo i ricorrenti principali, pertanto, Mirella Profeti avrebbe dovuto
acquistare lei stessa l’immobile in questione e poi trasferirlo a loro, sicché
legittimamente avevano rifiutato di farselo alienare direttamente dagli effettivi
proprietari, per il tramite della stessa Profeti in veste di loro procuratrice.
In ordine alle modalità di adempimento dell’obbligazione assunta dal
promittente venditore di una cosa altrui, nella giurisprudenza di legittimità è
insorto un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle
Su.
In prevalenza, questa Corte si è orientata nel senso che la prestazione può
essere eseguita, indifferentemente, acquistando il bene e ritrasmettendolo al
promissario, oppure facendoglielo alienare direttamente dal reale proprietario,
in quanto l’articolo 1478 Cc - relativo al contratto definitivo di vendita di cosa
altrui, ma applicabile per analogia anche al preliminare dispone che il venditore
«è obbligato a procurarne l’acquieto al compratore», il che può ben avvenire
anche facendo al che Il terzo, al quale il bene appartiene, lo ceda egli stesso al
promissario (v., tra le più recenti, Cassazione, 13330/00, 2656/01, 15035/01,
21179/04,
24782/05).
Talvolta si è però deciso che l’obbligazione in questione deve invece essere
adempiuta acquistando il bene e ritrasferendolo, in particolare nel caso in cui
l’altra parte non fosse stata consapevole dell’altruità, poiché l’articolo 1479 Cc
– anch’esso dettato per la -vendita definitiva, ma estensibile a quella
preliminare - abilita il compratore a «chiedere la risoluzione del contratto, se,
quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e
se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà» (v.
Cassazione 7054/90, 2091/99, relative, rispettivamente, a un contratto
definitivo
e
a
uno
preliminare
di
vendita
di
cosa
altrui).
24
Ritiene il collegio che debba essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale
maggioritario.
Stante la latitudine delle citate previsioni normative, non vi è ragione per
escludere che la prestazione possa essere eseguita “procurando” il
trasferimento del bene direttamente dall’effettivo proprietario, senza necessità
di un doppio trapasso; il comma 2 dell’articolo 1478 menziona bensì l’acquisto
che eventualmente compia l’alienante, nel caso di vendita (definitiva) di cosa
altrui, ma come una particolare modalità di adempimento, alla quale
eccezionalmente riconnette l’effetto di far diventare senz’altro proprietario il
compratore.
Né una diversa soluzione può essere adottata per il caso in cui il promissario
avesse ignorato, al momento della conclusione del preliminare, la non
appartenenza del bene al promittente. Il disposto dell’articolo 1479 Cc, che
consente al compratore in “buona fede” di chiedere la risoluzione del contratto,
è coerente con la natura - di vendita definitiva - del negozio cui si riferisce,
destinato, nell’intenzione delle parti, a esplicare quell’immediato effetto
traslatIvo che è stabilito dall’articolo 1376 Cc, ma è impedito dall’altruità della
cosa: altruità che invece non incide sul sinallagma instaurato con il contratto
preliminare, il quale ha comunque efficacia soltanto obbligatoria, essendo
quella reale differita alla stipulazione del definitivo, sicché nessun nocumento,
fino alla scadenza del relativo termine, ne deriva per il promissario.
Dall’articolo 1479 Cc, pertanto, non può desumersi che egli sia abilitato ad
agire per la risoluzione - e quindi ad opporre l’exceptio inadimpleti contractuo
se l’altra parte, nel momento in cui vi è tenuta, é comunque in grado di fargli
ottenere
l’acquisto,
direttamente
dal
proprietario.
D’altra parte, il ritenere esatta tale modalità di adempimento è in sintonia con
l’essenza e la funzione del contratto preliminare di vendita, quali sono state
individuate nelle più recenti elaborazioni dottrinali, che hanno superato la
concezione tradizionale dell’istituto e che qualche riflesso hanno avuto anche in
giurisprudenza.
Il contratto preliminare non è più visto come un semplice pactum de
contrahendo, ma come un negozio destinato già a realizzare un assetto di
interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il definitivo,
sicché il suo oggetto è non solo e non tanto un facere, consistente nel
manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto
alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto un sia pure futuro dare: la
trasmissione della proprietà, che costituisce il risultato pratico avuto di mira dai
contraenti. Se il bene già appartiene al promittente, i due aspetti coincidono,
pur senza confondersi, ma nel caso dell’altruità rimangono distinti, appunto
perché lo scopo può essere raggiunto anche mediante il trasferimento diretto
della cosa dal terzo al promissario, il quale ottiene comunque ciò che gli era
dovuto, indipendentemente dall’essere stato - o non - a conoscenza della non
appartenenza della cosa a chi si era obbligato ad alienargliela.
Né vale obiettare che l’identità del venditore, come i ricorrenti principali
deducono, non è indifferente per il compratore, il quale può risultare meno
tutelato, relativamente all’evizione e ai vizi. in proposito, in consonanza con le
menzionate opinioni dottrinali, la giurisprudenza si é orientata nel senso che la
conclusione del definitivo, per tali profili, non assorbe né esaurisce gli effetti
25
del preliminare, il quale continua a regolare i rapporti tra le parti, sicché il
promittente alienante resta responsabile per le garanzie di cui si tratta (v., da
ultimo,
Cassazione,
15035/01).
Si deve quindi affermare che il promittente venditore di una cosa che non gli
appartiene, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la
propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente
dall’effettivo
proprietario.
Alla stregua di questo principio, il ricorso principale va rigettato, dovendoci
riconoscere che la «Corte di appello correttamente ha ritenuto superfluo
accertare se Wladimiro La Gamba e Teresa Virdò fossero stati inizialmente
ignari dell’altruità dell’immobile in questione, essendo anche in tale ipotesi
ingiustificato il loro rifiuto di addivenire alla conclusione del contratto definitivo,
dato che Mirella Profeti si era munita di una procura rilasciatale, dagli effettivi
proprietari del bene, che la abilitava a effettuarne la vendita in nome loro.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce che la Corte d’appello ha
dichiarato la risoluzione del contratto preliminare de quo per inadempimento di
controparte senza condannarla al risarcimento del danno richiesto che
all’inadempimento consegue per legge non tenendo conto che tale domanda di
risarcimento del danno. che spetta in ogni modo alla Comparente, era stata
avanzata anche in via equitativa».
La doglianza va disattesa, poiché con la sentenza impugnata si è rilevato che
nessuna prova, in ordine ai danni asseritamente subiti, era stata data né
offerta da Mirella Profeti: prova che comunque avrebbe dovuto essere fornita,
relativamente all’an poiché è soltanto per la determinazione del quantum che si
può fare luogo alla liquidazione in via equitativa, ove non ne sia dimostrabile il
preciso
ammontare
(v.,
per
tutte,
Cassazione,
16112/05).
Con il secondo motivo del ricorso incidentale Mirella Profeti lamenta che «una
volta liquidate come da dIspositivo le spese di primo e secondo grado la Corte
di appello non ha imposto a controparte la restituzione delle some che le erano
state
liquidate
a
titolo
di
spese
legali
dal
Primo
giudice».
Neppure questa censura può essere accolta, in quanto dalle conclusioni
riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata risulta che la domanda di
restituzione
di
cui
si
tratta
non
era
stata
formulata.
Anche
il
ricorso
incidentale
deve
essere
pertanto
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in
considerazione della reciproca loro soccombenza.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese
del giudizio di cassazione.
26
CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, SENTENZA N. 17461 DEL 1°
AGOSTO 2006
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. La Terza)
Le Sezioni Unite affrontano, con ampia motivazione, l’ elaborazione
giurisprudenziale in ordine alla devoluzione delle controversie implicanti
pretese relative alla tutela del diritto alla salute, ripercorrendo e rielaborando
la materia. Affermano le Sezioni Unite che, in relazione al bene-salute è
individuabile un "nucleo essenziale", in ordine al quale si sostanzia un diritto
soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psicofisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di
indispensabilità, gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle
quali è configurabile un mero potere accertativo della P.A. in ordine alla
ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di tali condizioni, e allorquando
non vengano denunziati pregiudizi alla salute, anche in termini di aggravamenti
o di non adeguata guarigione, la domanda diretta ad ottenere prestazioni con
modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente, rispetto a quelle
apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di
interesse legittimo, stante la discrezionalità riconosciuta all'autorità
amministrativa di soddisfare, tempestivamente, le esigenze del richiedente tra
le possibili opzioni, anche attraverso un'opportuna integrazione tra le
potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate,
offrendo la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del
servizio sanitario. Nella specie le S.U., con riferimento alla domanda, proposta
da alcuni emodializzati, diretta alla declaratoria del diritto a parcheggiare lungo
un determinato viale di accesso al centro medico ove fruire delle cure
necessarie, hanno cassato, con rinvio, l'impugnata sentenza, non
adeguatamente motivata in ordine alla configurabilità, o meno, di un concreto
danno alla salute e alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la
tutelabilità della pretesa.
Presidente Carbone – Relatore La Terza
Svolgimento del processo
Con atto di appello depositato in data 23 aprile 1998, Luigi Nonni, Ludovico
Scenga, Nicolino Forte, Biagio Maglioni e Giorgio Faccenda impugnavano la
sentenza del 2 dicembre 1997, con la quale il Pretore di Tivoli aveva rigettato
la domanda dagli stessi proposta nei confronti del suddetto Comune diretta alla
declaratoria del diritto a parcheggiare lungo il viale Trieste di Tivoli, per potere
27
facilmente accedere al centro medico ivi situato onde usufruire delle cure
necessarie come emodializzati. A sostegno della domanda gli appellanti
deducevano il loro diritto a fruire delle cure necessarie allo statua di invalidi
presso l’unico Centro sito nel territorio comunale, e denunziavano una errata
valutazione da parte del primo giudice sulla possibilità di accedere ad altre
strutture mediche più compatibili con le loro esigenze, attesa l’inesistenza di
altri centri similari nel territorio del Comune di Tivoli. Su tali assunti instavano
per la riforma della impugnata sentenza e per l’accoglimento della loro iniziale
domanda.
Dopo la costituzione del Comune, che spiegava anche appello incidentale con il
quale ribadiva le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di
incompetenza funzionale del giudice del lavoro, il Tribunale di Roma con
sentenza del 12 luglio 2002 dichiarava il diritto degli appellanti a parcheggiare
con la propria autovettura - nei limiti di tempo necessari alla fruizione delle
cure di emodialisi cui si sottoponevano - nella zona antistante al Centro di
terapia medica di Tivoli, sito sul viale Trieste n. 2/b, e condannava il Comune
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e di quelle della
espletata consulenza.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che la controversia in
esame andavadevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto si era
inteso dagli appellanti, invalidi al 100%, fare valere il loro diritto soggettivo
alla
salute,
garantito
in
via
assoluta
dalla
Costituzione
ed insuscettibile, come tale, di affievolimento o compressione; precisava che
era competente funzionalmente in materia il giudice del lavoro, per essere ad
esso affidata la tutela del diritto del cittadino alla salute ed alle correlate
prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti della Pa; e osservava,poi,
nel merito che la pretesa azionata risultava fondata perché non era stato
contestato dall’appellato che il Centro medico di Tivoli fosse l’unico autorizzato
a praticare la dialisi inconvenzione con il servizio sanitario nazionale, e perché i
diversi ed alternativi servizi di parcheggio approntati dal Comune non erano
idonei a garantire le condizioni di salute degli interessati. Ed invero, il
nuovo parcheggio attrezzato dal Comune imponeva a ciascun dializzato un
sforzo - per la maggiore distanza da percorrere per raggiungere il proprio
automezzo - incompatibile con le condizioni in cui versava dopo il trattamento
sanitario; ed inoltre il pulmino del Centro, che era stato autorizzato a fungere
da navetta ed a sostare davanti al Centro stesso per la salita e discesa degli
utenti, non poteva rappresentare una soluzione alternativa al parcheggio dati i
non preventivabili tempi di attesa. Avverso detta sentenza il Comune di Tivoli
propone
ricorso
per
cassazione,
affidato
a
tre
motivi.
Le controparti sono rimaste contumaci.
Motivi della decisione
28
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denunzia violazione dell’articolo
360 n. 1 Cpc, illogicità manifesta della decisione e difetto di motivazione,
assumendo che la causa doveva essere decisa dal giudice amministrativo
perché il Comune aveva approvato con una deliberazione formale la
sistemazione delle aree urbane, compresa quella interessata che coinvolgeva
un punto nodale della circolazione stradale, quale quella della statale Tiburtina.
Si era, quindi, in presenza di un atto amministrativo attraverso cui la Pa aveva
esercitato i poteri di disciplinare discrezionalmente i criteri di viabilità, sicché le
posizioni giuridiche interessate non potevano che configurarsi come interessi
legittimi. Evidenzia ancora l’impossibilità per il giudice ordinario di condannare
l’amministrazione ad un facere o ad un pati. In ogni caso non poteva, ai fini del
riparto della giurisdizione, qualificarsi come diritto soggettivo la pretesa
avanzata in giudizio - e rivendicata in contrasto con il diritto di tutti i cittadini,
utenti della strada, a circolare secondo gli standard di sicurezza imposti dal
codice della strada - a parcheggiare in una zona invece di altra, equidistante
dal centro sanitario, e senza un accertato e concreto danno capace di ledere il
diritto
alla
salute.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 38 e 442
Cpc e per illogicità e contraddittorietà della decisione, deducendo che la stessa
aveva errato nel ritenere che la fattispecie in oggetto rientrasse nella
competenza
funzionale
del
giudice
del
lavoro.
Con il terzo motivo il Comune censura la sentenza impugnata ai sensi
dell’articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc per violazione del disposto dell’articolo 2697 Cc
e della normativa del codice della strada e del relativo regolamento (D.Lgs 285
e Dpr 495/92) nonché per contraddittoria ed insufficiente motivazione. Più
specificamente il ricorrente addebita alla decisione del Tribunale di Roma di
non avere tenuto conto che il Centro sito in via Trieste non si era mai
adoperato per permettere nella sua struttura la fermata per i mezzi di
locomozione dei pazienti sicché non potevano trasferirsi oneri da porsi a carico
della clinica convenzionata in capo alla Pa; che con ordinanza sindacale 131/96
prot. 13439 era stata autorizzata la fermata nelle vicinanze del Centro delle
vetture a disposizione degli emodializzati diversamente da quanto era accaduto
in passato; che la addotta circostanza della impossibilità di accedere ad altri
centri di emodialisi era stata espressamente contestata e che, invece - come
evidenziato anche dal primo giudice -il contrario risultava documentalmente
provato attraverso la “mappatura del SSN”; che in ogni caso gli emodializzati
non avevano assolto all’onere probatorio su di essi gravante di dimostrare di
non potere accedere, senza conseguenze pregiudizievoli alla salute, ad altre
strutture capaci di fornire le stesse prestazioni sanitarie di cui erano
destinatari.
2. Ai fini di un ordinato iter argomentativo si impone l’esame del primo motivo
di ricorso riguardante l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
eccezione che ha determinato la rimessione della controversia a queste Su.
La soluzione di detta questione rende opportune alcune preliminari
puntualizzazioni sul c.d. diritto alla salute che, garantito dall’articolo 32
Costituzione, cui viene riconosciuta una portata immediatamente precettiva e
non meramente programmatica(cfr. Corte costituzionale 104/82), non coincide
con il solo diritto alla integrità fisica, tutelando infatti lo stato di benessere non
29
solo
fisico
ma
anche
psichico
del
cittadino.
2.1. Per evidenziare l’assoluta rilevanza assunta nell’attuale assetto
ordinamentale di tale diritto è sufficiente rammentare come dal giudice delle
leggi: sia stata riconosciuta la incostituzionalità di normative (quali quelle
finanziarie del 1984 e del 1985) dirette a disconoscere il rimborso delle spese
per le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite presso
strutture private non convenzionate, uniche detentrici delle relative
apparecchiature, in ragione della necessità di garantire “piena ed esaustiva
tutela” al “diritto primario e fondamentale” della salute umana, così che
“l’esclusione in assoluto ... di qualsivoglia ristoro, ancorché ricorrano particolari
condizioni di indispensabilità non parimenti sopperibili, incide sulla garanzia di
cui innanzi” (così:Corte costituzionale 992/98); sia stato affermato che “la
salute è un valore protetto dalla Costituzione come fondamentale diritto
dell’individuo ed interesse della collettività”, tanto da essere “costantemente
riconosciuto come primario sia per la sua inerenza alla persona umana sia per
la sua valenza di diritto sociale” (cfr. in tali sensi: Corte costituzionale
37/1991); sia stato ancora rimarcato come il rispetto del principio
fondamentale sancito dall’articolo 32 Costituzione debba valere come criterio
interpretativo della legislazione ordinaria(cfr. al riguardo: Corte costituzionale
127/90 in materia della c.d. normativa antismog e dell’incidenza
dell’inquinamento sulla salute della collettività); e sia stato, infine, in materia
di “ambiente”, messo in evidenza come dalla legge statale 36/2001 (legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) siano stati, in una funzione non solo di immediata tutela ma
anche di prevenzione del bene-salute, fissati tra l’altro “limiti di
esposizione”(come valori di campo non superabili “in alcuna condizione di
esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della
salute”, nonché “i valori di attenzione” (come valori di campo da non superare,
a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine <negli ambienti
abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate> (cfr. articolo
3 legge 36/2001) (in tali precisi termini: Corte costituzionale 307/03, sub 6 ).
2.2. Nello scrutinare i numerosi dicta della Corte costituzionale in materia si è
osservato in dottrina come sia ormai stata superata l’iniziale lettura restrittiva
che vedeva l’articolo 32 Costituzione rivolto ai soli poteri pubblici e che si è
ormai guadagnato alla salute la qualifica di diritto soggettivo, fondamentale ed
assoluto, e si è pure aggiunto che allo stato si individua un “nocciolo duro” del
diritto - insopprimibile quale che siano le esigenze della collettività - imposto
dallo stesso principio di solidarietà sociale che ne permette, solo a determinate
condizione, la restrizione. In tale contesto il “principio personalista”, di cui
l’articolo 2 Costituzione configura la più chiara espressione, e quello della
solidarietà sociale ed economica, caratterizzante il disposto dell’articolo 38
Costituzione, fanno, dunque, della salute un diritto che, nel soddisfare istanze
generalizzate della collettività, è diretto a tutelare -in modo efficace e paritario
alle altre le fasce deboli della cittadinanza, garantendo in tal modo pienamente
i diritti del malato, considerato come “persona” prima che come paziente da
assistere
e
curare.
2.3. Nella direzione di un progressivo ampliamento dell’ambito di operatività
dell’articolo 32 Costituzione si è mossa pure la giurisprudenza di questa Corte
30
di cassazione, ribadendo più volte che sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto soggettivo al
rimborso delle spese ospedaliere sostenute dall’assistito all’estero (senza la
preventiva autorizzazione della Regione) in caso di ricovero reso necessario da
motivi di urgenza, costituiti da una situazione di pericolo di vita o di
aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, residuando in tali
ipotesi
in
capo
all’autorità
amministrativa un potere discrezionale di tipo meramente tecnico in ordine
all’apprezzamento dei motivi di urgenza(cfr. in tali sensi: Cassazione, Su,
85/1999, cui adde Cassazione 7537/99, sempre per l’affermazione che il
rimborso delle spese - in ragione della gravità delle condizioni di salute e
nell’impossibilità di ottenere dalle strutture pubbliche e convenzionate
prestazioni adeguate - riveste il carattere di diritto soggettivo perfetto
tutelabile dal giudice ordinario cui va riconosciuto il potere di disapplicare l’atto
amministrativo - e, quindi, anche il decreto ministeriale - che non preveda o
escluda
detto
rimborso).
L’indicato indirizzo risulta ormai essersi consolidato, essendosi più volte
riconosciuto al diritto alla salute, come detto, la dimensione di diritto assoluto
e primario ed essendosi conseguentemente negato - a fronte delle già
individuate situazioni di urgenza - l’esercizio di poteri discrezionali (compresi
quelli autorizzativi) da parte della Pa e, quindi, la configurabilità di atti
amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi dell’articolo 5 della legge
2248/1865 all. E), condizionanti il diritto all’ assistenza (cfr. ex plurimis:
Cassazione, Su, 12249/03; 10737/98; 12218/90, ed, in epoca più recente:
14197/05;
13548/05;
11334/05).
3. Ai fini di un più completo excursus sui precedenti giurisprudenziali volti
all’esigenza di assicurare, anche nei confronti della Pa, il rispetto del diritto alla
salute, ritenuto diritto “forte”,che impone una “difesa a tutta oltranza contro
ogni iniziativa ostile”(cfr. in tali precisi termini: Cassazione, Su, 5172/79), è
opportuno segnalare come già in passato in relazione ad interventi riguardanti
l’ambiente naturale (in un settore cioè rappresentativo di valori anche essi
costituzionalmente protetti e definito di natura trasversale per le diverse
competenze che lo caratterizzano) si sia giunti a negare - pur in un
presenza di una stretto legame tra titolarità di interessi individuali da parte di
singoli
cittadini
coinvolti dai suddetti interventi e titolarità di interessi, cosìddetti diffusi, facenti
capo
a
collettività unitariamente considerate – alla Pa ogni potere ablatorio tale
da fare degradare il diritto alla salute ad interesse legittimo (cfr. Cassazione,
Su,
1463/79
in
materia
di
localizzazione
di
centrali
nucleari).
3.1. Ed ancora il carattere di assolutezza del diritto scrutinato e la sua
elaborazione sul versante dei rapporti intersoggettivi hanno trovato riscontro:
sia nell’affermazione che il diritto alla salute “è sovrastante all’amministrazione
di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse
pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di
pregiudicarlo nel fatto indirettamente”, perché incidendo in un diritto
fondamentale la Pa “agisce nel fatto”, dal momento che “non essendo
giuridicamente configurabile un suo potere in materia, esso per il diritto non
31
provvede”, ma “esplica comunque, e soltanto attività materiale illecita” (cfr. in
questi precisi termini: Cassazione, Su, 2092/92 in una fattispecie di
realizzazione di un impianto di depurazione in prossimità di una abitazione); e
sia nell’assunto che la tutela giudiziaria del diritto alla salute può essere
preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima che l’opera pubblica sia
messa in esercizio nei modi previsti, si riesca ad accertare - con riguardo alla
situazione che verrà a determinarsi a seguito di detto esercizio - un pericolo di
compromissione per la salute di chi agisce in giudizio(cfr., in una fattispecie di
realizzazione
di
un
elettrodotto,
Cassazione
9893/00).
4. E sempre sul versante del diritto alla salute e, più specificatamente della
tutela del malato, va segnalato come la giurisprudenza di questa Corte ricalchi
in grandi linee quella comunitaria che - pur riconoscendo che gli articoli 59 e
60 del Trattato CE(coincidenti, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato
di Amsterdam, con gli articoli 49 e 50) non sono violati dalla normativa di uno
Stato membro, che subordina alla previa autorizzazione della cassa malattia di
appartenenza il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per il ricovero
presso un Istituto ospedaliero situato in altro stato membro - ha affermato che
l’autorizzazione non può essere negata quando risulti che il trattamento
sanitario
considerato
assuma
i
caratteri
dell’”usualità”(nel
senso che sia adeguatamente provato e riconosciuto dalla scienza medica
internazionale), e dalla “necessità” (nel senso che non sia possibile ottenere
definitivamente
un
trattamento
identico
che
presenti
lo stesso grado di efficacia presso un istituto che abbia concluso una
convenzione
con
la
cassa
malattia
cui fa parte l’assicurato) (cfr. Corte giust. 12 luglio 2001, causa C-157/99,
richiamata da Cassazione, Su, 11334/05 cit.);ed ha altresì statuito che la
suddetta autorizzazione non possa essere rifiutata sempre che le cure in
questione figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato
membro
nel
cui
territorio
risiede l’interessato e sempre che un trattamento identico (o con lo stesso
grado
di
efficacia)
non
possa essere tempestivamente ottenuto nel territorio dello Stato (cfr. Corte
giust.
23
ottobre
2003,
causa
C-56/01).
5. A volere riassumere quanto sinora esposto può, seppure con qualche
approssimazione,
affermarsi
che
nel nostro ordinamento si rinvengono a fronte di situazioni “soggettive a nucleo
variabile” – in relazione alle quali si riscontra un potere discrezionale della Pa
capace di degradare (all’esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi
coinvolti) i diritti ad interessi legittimi o di espandere questi ultimi
sino ad elevarli a diritti – “posizioni soggettive a nucleo rigido”, rinvenibili
unicamente in presenza di quei diritti, quale quello alla salute, che - in ragione
della loro dimensione costituzionale e della loro stretta inerenza a valori
primari della persona - non possono essere definitivamente sacrificati o
compromessi, sicché allorquando si prospettino motivi di urgenza suscettibili di
esporli a pregiudizi gravi ed irreversibili, alla Pa manca qualsiasi potere
discrezionale di incidere su detti diritti non essendo ad essa riservato se non il
potere di accertare la carenza di quelle condizioni e di quei presupposti richiesti
perché la pretesa avanzata dal cittadino assuma, per il concreto contesto nel
32
quale viene fatta valere, quello spessore contenutistico suscettibile di
assicurarle
una
tutela
rafforzata.
6. Quanto sinora detto fornisce le coordinate per risolvere la questione di
giurisdizione
sollevata
dal
Comune
di
Tivoli.
6.1. È giurisprudenza costante che la giurisdizione si determina sulla base della
domanda e che, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto
“petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione
della
concreta
statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
“causa
petendi”,
ossia
della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed
individuata
dal
giudice
stesso
con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono
manifestazione
e
dal
quale
la domanda viene identificata(cfr. sul criterio del “petitum sostanziale” tra le
tante: Cassazione, Su, 8374/06; 10243/03; 3508/03); ed è stato altresì
precisato che l’applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto
criterio implica senza dubbio l’apprezzamento di elementi che attengono anche
al merito (con la conseguenza che la corte di cassazione è in materia di
giurisdizione anche giudice di fatto) ma non comporta che la statuizione sulla
giurisdizione (la quale - come la competenza - va determinata con riguardo ai
fatti allegati dall’attore, essendo in contrario irrilevanti le difese del convenuto)
possa
confondersi
con
la
decisione sul merito né, in particolare/ che la decisione possa essere
determinata
“secundum
eventum
litis”, sicché non esiste alcuna contraddizione logico-giuridica in una sentenza
che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la
giurisdizione del giudice che l’ha emessa e, in un momento logicamente
successivo, valutando le risultanze dell’istruttoria svolta, neghi la
sussistenza in concreto del rapporto stesso(cfr. in tali esatti termini:
Cassazione 1470/94, cui adde tra le altre: Cassazione 8057/01).
Ed a conforto dell’assunto che la statuizione sulla giurisdizione vada in ogni
caso tenuta distinta dalla decisione sul merito - si da non configurasi alcuna
incompatibilità logico-giuridica tra la iniziale qualificazione del rapporto ai fini
della individuazione del giudice competente e la declaratoria di insussistenza
del rapporto stesso intervenuta in un momento successivo con la decisione
della controversia all’esito dell’istruttoria - i giudici di legittimità hanno fatto
riferimento
agli
articoli
187,
comma
2
e
3, e 279 Cpc, ed ancora alla suscettibilità della suddetta statuizione di passare
autonomamente
in cosa giudicata formale nonché al principio che le sentenze dei giudici di
merito
che
abbiano
pronunciato sulla giurisdizione, proprio perché non di merito, non sono idonee
a
spiegare
effetti
al
di
fuori del processo in cui sono emesse(cfr. al riguardo in motivazione:
Cassazione, Su, 1470/94 cit.,ed ancora Cassazione 8057/01 cit.) .
6.2. Corollario di quanto sinora detto – e ribadendosi ancora una volta la netta
33
distinzione tra declaratoria nel corso del giudizio sulla giurisdizione e sentenza
definitiva di merito – è che dovendosi la giurisdizione determinare, come si è
ora rimarcato, sulla base del cosìddetto “petitum sostanziale” - il quale si
identifica soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia - è bene ribadirlo
sui
soli
fatti
indicati
a
fondamento
della pretesa fatta valere con l’atto iniziale della lite - va devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale, proponendosi a
fondamento della stessa il diritto alla salute e la necessità di interventi resi
necessari per motivi di urgenza (al fine di scongiurare concreti pericoli di
vita o di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione della
stessa) si chieda alla Pa, cui si addebita il sorgere della denunziata situazione,
una condotta volta a tutelare il suddetto diritto che, per trovare espresso
riconoscimento nell’articolo 32 Costituzione, si configura come diritto
soggettivo
perfetto
non
degradabile
ad
interesse
legittimo.
6.3. La sentenza impugnata, alla stregua di quanto ora detto, va pertanto sul
punto confermata per avere il Tribunale riconosciuto la giurisdizione del giudice
ordinario sul presupposto che gli invalidi emodializzati hanno posto alla base
della loro richiesta (ripristino del diritto di parcheggio di cui in precedenza
usufruivano) il diritto alla salute, di cui hanno lamentato un grave pregiudizio
per essere la fruizione delle cure rese estremamente difficoltose e disagevoli ad
opera del Comune di Tivoli, che aveva proceduto ad interventi sulla viabilità,
costringendo gli emodializzati a parcheggiare il loro automezzo ad una
maggiore distanza dal Centro, fornitore delle prestazioni sanitarie.
7. In ragione del ruolo nomofilattico, assegnato istituzionalmente a questa
Corte, va rigettato anche il secondo motivo del ricorso con il quale il Comune di
Tivoli
ha
eccepito
il
difetto
della
competenza
funzionale del giudice del lavoro a decidere la presente controversia, atteso
che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale - avverso il quale non
sono state avanzate in questa sede ragioni capaci di metterne in dubbio la
validità – le controversie relative alla previdenza ed assistenza sanitaria
obbligatoria (nonché alle correlate prestazioni), per rientrare tra le cause
espressamente menzionate dall’articolo 409, comma 1, Cpc, sono devolute alla
competenza del giudice del lavoro(cfr. sul punto tra le altre: Cassazione
7456/83, in relazione ad una fattispecie riguardante proprio il trattamento di
dialisi, cui adde, negli stessi termini e con un rinnovato richiamo agli articoli
442
e
444
Cpc,
Cassazione,
Su,
12218/90).
8. Risulta, di contro, fondata la censura spiegata con il terzo motivo di ricorso,
attraverso il quale si addebita al Tribunale di Roma di non avere fatta corretta
applicazione della regola fissata dall’articolo 2697 Cc sulla ripartizione
dell’onere della prova, e di con avere sorretto l’accoglimento della domanda
degli
invalidi
emodializzati
con
adeguata
motivazione.
8.1. Sulla base della scrutinata giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
consolidatasi nelle materie in cui il diritto alla salute va contemperato con altri
diritti anche essi costituzionalmente protetti - e nelle quali il giudice è tenuto al
difficile compito di bilanciare gli interessi in gioco definendone i rispettivi
limiti - può enunciarsi il seguente principio: “In relazione al bene-salute è
individuabile
un
“nucleo
essenziale”, che configura un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a
34
garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura
allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non
altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere
accertativo della Pa in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette
condizioni. In assenza, però, di dette condizioni e allorquando non vengano
denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini di aggravamenti o di non
adeguata guarigione - la domanda volta a ottenere le dovute prestazioni con
modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle
apprestate dalla Pa, ha come presupposto una situazione soggettiva di
interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta alla autorità
amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente
scegliendo tra le possibili opzioni praticabili - anche attraverso una opportuna
integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private
convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena
efficienza del servizio sanitario.
8.2. L’ora riportato principio si colloca nell’ambito delle ripetute statuizioni dei
giudici costituzionali e di quelli di legittimità. Ed invero, a dimostrazione della
veridicità di tale assunto, è sufficiente rammentare come i primi abbiano ancora una volta sul presupposto della natura della salute come diritto
individuale assoluto - emesso, come si è già ricordato, decisioni caducatorie di
norme che non consentano di assumere a carico del servizio sanitario
nazionale la spesa per prestazioni di alta specializzazione ottenibili
soltanto presso strutture private non convenzionali sempre che si sia in
presenza della “indispensabilità” (intesa come idoneità delle medesime a
produrre effetti diagnostici e terapeutici più certi e completi di quelli riferibili
alle metodiche in uso presso il servizio pubblico;così Corte costituzionale
992/88 cit. e come, a loro volta, i giudici di legittimità abbiano anche essi
riconosciuto una 2tutela forte” al diritto alla salute in presenza di situazioni
d’urgenza e di esposizione a pericoli di danni irreparabili alla integrità fisica
(cfr. ex plurimis: Cassazione, Su, 85/1999 cit.; 8882/94), a fronte dei quali la
Pa può eventualmente apprezzare soltanto i dati fattuali addotti
dall’interessato, secondo i criteri della discrezionalità tecnica, che non basta ad
alterare la consistenza del diritto soggettivo, giacché l’inosservanza di tali
criteri nell’accertamento della concreta sussistenza di una posizione soggettiva
non esprime alcun potere di supremazia, tanto da essere consueta anche nei
rapporti interprivati, e da non comportare, quindi, in quelli pubblici, alcun
fenomeno
di
affievolimento(così:
Cassazione,
Su,
4647/02).
9. Alla stregua delle considerazioni svolte e del principio di diritto sopra
enunciato la motivazione della sentenza impugnata si presenta non adeguata
nella parte in cui non ha esplicitato le ragioni su questioni di certo rilevanti ai
fini della decisione. Ed invero, tra l’altro, da parte del giudice d’appello non è
stato chiarito se il denunziato spostamento del parcheggio determinasse un
concreto danno alla salute degli emodializzati o fosse causa, in ragione di una
sempre limitata distanza dal Centro sanitario, soltanto di un meno agevole
accesso per gli utenti dello stesso Centro (senza però alcun rilevante
pregiudizio per la loro integrità fisica); non è stato precisato – mediante un
lineare, coerente ed esaustivo percorso argomentativo - se gli emodializzati, su
cui incombeva il relativo onere probatorio, avessero provato l’impossibilità di
35
accedere ad altri presidi o strutture capaci di garantire la necessaria assistenza
nel
pieno
rispetto
della
loro
salute,
nonostante la dedotta permanente contestazione degli elementi posti a base
della
domanda
degli
attuali
intimati e nonostante l’agevole accertamento (anche attraverso la “mappatura”
del
Servizio
sanitario
nazionale) della effettiva dislocazione di altri centri per la dialisi extracorporea,
e della loro agevole accessibilità. Ed, infine, in nessun passaggio motivazionale
è stata esplicitata la ragione per la quale non sia stata accertata in modo
esauriente la praticabilità – anche nell’ambito di una doverosa sinergia tra
strutture
pubbliche e strutture convenzionate capaci di assicurare alti standard di
conoscenze specialistichee di efficienza pratica - di soluzioni alternative a
quella seguita dal Comune di Tivoli, e più specificatamente non sia stata né
esaminata né, tanto meno, valutata la capacità di soddisfare le esigenze degli
emodializzati attraverso l’adibizione di spazi, a disposizione dello stesso Centro
sanitario, a parcheggi deputati ad assicurare un agevole accesso ai luoghi
attrezzati per la dialisi, od anche attraverso alcuna delle iniziative che il
Comune di Tivoli ha sostenuto di avere preso a favore degli emodializzati.
10. Per concludere, va rigettato sia il primo motivo, dovendosi dichiarare la
giurisdizione del giudice ordinario, che il secondo motivo del ricorso. in
accoglimento, invece, del terzo motivo la sentenza impugnata va cassata ed, ai
sensi dell’articolo 384 Cpc, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va rimessa ad altro giudice, designato nella Corte d’appello di Roma, che
procederà ad un nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei
principi innanzi formulati.
11. Al giudice del rinvio va rimessa la statuizione anche delle spese del
presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiarando al giurisdizione del
giudice ordinario, nonché il secondo motivo ed, in accoglimento del terzo
motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Roma anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
36
Enti locali: se l'incarico è privo di copertura, il professionista non ha
diritto al compenso
La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad
un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è
valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se contenga la previsione
dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi
fronte; in mancanza, la delibera è nulla, e tale nullità si estende al contratto di
prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista,
escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, 10 GIUGNO 2005, N.
12195
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli ingegneri G.M. e S.C. chiesero al presidente del Tribunale di Catanzaro di
emettere decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione provinciale di
Catanzaro per il pagamento della somma di lire 109.425.255, a titolo di
onorari, cui ritenevano di avere diritto per la progettazione di un complesso
scolastico.
Il presidente adito emise il provvedimento in data 19 settembre 1990 e
l'Amministrazione provinciale propose opposizione adducendo di aver già
adempiuto
la
propria
obbligazione.
Instauratosi il contraddittorio il Tribunale di Catanzaro, con sentenza
depositata il 15 dicembre 1994, revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che
l'Amministrazione provinciale realmente avesse adempiuto l'obbligazione
prevista nella convenzione regolatrice del rapporto. Specificamente, in essa era
stato fissato un importo massimo di spesa che, se si fosse rivelato insufficiente
per l'esecuzione dell'intera opera, avrebbe comportato la redazione di un
progetto stralcio del progetto esecutivo generale, restando stabilito che, per
tale prestazione, al professionista sarebbe stato corrisposto "un compenso pari
al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto stralcio
applicato sull'importo dello stralcio stesso oltre al rimborso delle spese a norma
di
tariffa"
(sentenza
impugnata,
pag.
3).
In questo quadro il Tribunale pervenne alla conclusione che l'avvenuto
versamento
dell'importo
ridotto,
siccome
previsto,
esonerasse
37
l'Amministrazione
da
ogni
obbligo
ulteriore.
L'ing. M. propose appello, adducendo l'erronea qualificazione del rapporto
obbligatorio, sul presupposto che la clausola ora menzionata andasse
interpretata nel senso che essa attribuiva ai professionisti il diritto, al
compenso per il progetto generale, con una pattuizione, di cautela per
l'Amministrazione, secondo la quale i redattori avevano diritto anche ad un
compenso minore per il progetto stralcio in quanto avevano elaborato il
progetto complessivo, del quale lo stralcio costituiva un minus. In via gradata
spiegò
azione
di
arricchimento,
ai
sensi
dell'art.
2041
c.c.
La Provincia di Catanzaro si costituì per resistere al gravame e propose appello
incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva
compensato le spese processuali relative al giudizio di primo grado.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 15 aprile 1999,
rigettò entrambe le impugnazioni e compensò le spese del grado.
La Corte distrettuale, dopo aver giudicato inammissibile l'azione (subordinata)
d'indebito arricchimento, perché proposta per la prima volta in secondo grado,
osservò che sia la delibera di conferimento dell'incarico sia la convenzione
adottata in esecuzione della prima non indicavano la previsione di spesa,
limitandosi ad ipotesi affermative di riferimento l'una alla possibilità di
finanziamento "a mezzo di mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti o
con altro istituto di credito" e l'altra al bilancio senza imputazioni ad uno
specifico capitolo o ad un anno.
Tali caratteri e carenze comportavano, ad avviso di quel collegio, la nullità
rilevabile d'ufficio degli atti menzionati, perché il difetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 284 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, provocava detta conseguenza non
soltanto sull'atto deliberativo ma anche sul connesso atto negoziale per
contrasto con norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c., come affermato
dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, nonché dallo stesso orientamento
del
legislatore
(art.
55
l.
142/1990).
Da tanto derivava il rigetto dell'appello principale, mentre la compensazione
delle spese processuali disposta dal Tribunale era giustificata dai caratteri
particolari della fattispecie e dall'indirizzo non univoco della giurisprudenza.
Contro la suddetta sentenza l'ing. M. ha proposto ricorso per cassazione,
affidato
ad
un
unico
motivo
illustrato
con
due
memorie.
L'Amministrazione provinciale di Catanzaro ha resistito con controricorso.
La seconda sezione civile di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato,
con ordinanza interlocutoria depositata il 21 gennaio 2003 ha rilevato che nella
giurisprudenza di legittimità esiste contrasto sul principio, affermato dalla
sentenza impugnata, alla stregua dei quale il difetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 284 del r.d. 383 del 1934 comporta - trattandosi di norma imperativa 38
la nullità dell'atto deliberativo, da cui deriva la nullità del conseguente atto
negoziale ex art. 1418 c.c. Infatti è stato anche osservato che un contratto di
diritto privato non può essere invalidato per effetto dell'inosservanza di una
norma di contabilità pubblica, qualificabile come norma di azione, che disciplina
l'attività interna della P.A. senza rilevanza nei confronti dei terzi contraenti
(tale
sarebbe
la
norma
dettata
dal
citato
art.
284).
Pertanto la sezione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai
sensi
dell'art.
374
c.p.c.
La causa, quindi, è stata assegnata alle sezioni unite civili di questa Corte ed è
stata chiamata all'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte distrettuale - depositata il 15 aprile 1999 e,
a quanto risulta, non notificata - il M. ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione con atto notificato il 22 novembre 1999, depositato il 26 novembre
successivo.
Il controricorso proposto dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro risulta
notificato il 6 giugno 2000 e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 370, primo
comma, c.p.c. Ne discende l'inammissibilità, del detto controricorso (stante il
carattere
perentorio
dei
suddetto
termine),
fermo
restando
per
l'Amministrazione il diritto di partecipare alla discussione orale in forza della
procura
speciale
a
suo
tempo
rilasciata
al
difensore.
2. Con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione dell'art.
284 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e degli artt. 1418 e ss. c.c., in relazione all'art.
360,
primo
comma,
n.
3,
c.p.c.
Richiamata la motivazione della sentenza impugnata, afferma che essa sarebbe
del tutto contraria all'ormai consolidato orientamento di questa Corte, espresso
(tra
le
altre)
dalla
sentenza
27
febbraio
1998,
n.
2235.
Alla stregua dei principi ivi enunciati (trascritti in ricorso) non sarebbe
comprensibile l'assunto della Corte di merito secondo cui la nullità dell'atto
deliberativo, per difetto dei requisiti posti dall'art. 284 del r.d. 3 marzo 1934,
n. 383, troverebbe riscontro in un "consolidato orientamento giurisprudenziale"
relegando al rango di "orientamento minoritario" ed ormai superato quello che
considera irrilevanti i vizi predetti; e neppure sarebbe dato comprendere come
(la sentenza impugnata) abbia potuto individuare nell'art. 55 della l. 142/1990
la riaffermazione di un principio generale dell'ordinamento finanziario degli enti
locali, mentre sarebbe pacifico che detta legge ha innovato la disciplina
preesistente.
Il ricorrente, poi, sostiene che vari richiami alla giurisprudenza di questa Corte,
operati dalla sentenza impugnata, sarebbero inesatti, sicché l'unico precedente
39
conforme alla tesi fatta propria da detta pronuncia sarebbe costituito dalla
sentenza n. 8410 dei 1990, che peraltro avrebbe utilizzato argomenti
contrastati dalla successiva (citata) sentenza n. 2235 dei 1998.
3. Si deve premettere che il ricorrente non muove censure specifiche alla
pronunzia impugnata, nella parte in cui ha rilevato di ufficio la nullità della
delibera concernente l'affidamento dell'incarico e della conseguente
convenzione, limitandosi ad addurre nell'esposizione del fatto che mai la
Provincia aveva allegato tale nullità e notando che, se l'allegazione ci fosse
stata, la questione sarebbe stata trattata davanti ai giudici del merito.
Va aggiunto che, secondo l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza
impugnata, «sia la delibera di conferimento dell'incarico, che la convenzione,
adottata in esecuzione della prima, non indicavano la previsione di spesa,
limitandosi a delle ipotesi alternative di riferimento l'una alla possibilità di
finanziamento "a mezzo di mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti o
con altro istituto di credito" e l'altra al bilancio senza imputazioni ad uno
specifico capitolo o ad un anno" (sentenza cit., pag. 6); ed anche questo profilo
non
ha
formato
oggetto
di
censure.
Pertanto il tema da decidere si risolve nel seguente quesito: se la nullità
dell'atto deliberativo di un ente pubblico locale (nel caso di specie,
Amministrazione provinciale), col quale viene conferito un incarico
professionale, per difetto dei requisiti stabiliti dall'art. 284 del r.d. 3 marzo
1934, n. 383, determini la nullità anche della convenzione tra l'ente e il
professionista con la quale il rapporto è costituito, oppure se gli eventuali vizi
della suddetta deliberazione possano assumere rilievo nell'ambito interno
dell'organizzazione dell'ente ma non incidano sulla validità ed efficacia del
contratto privatistico di prestazione d'opera professionale e, quindi, sul diritto
al
compenso
del
professionista.
3.1. Sulla soluzione del quesito ora formulato si registra nella giurisprudenza di
questa Corte il contrasto segnalato dall'ordinanza di rimessione alle sezioni
unite.
Più
esattamente
si
sono
manifestati
due
orientamenti.
Secondo il primo, la delibera con la quale i competenti organi comunali o
provinciali affidano ad un professionista l'incarico della compilazione di un
progetto per un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente
soltanto qualora contenga la previsione dell'ammontare dei compenso dovuto
al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni
determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione
d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità
a costituire titolo per il pagamento del compenso professionale ed implicando il
diritto dell'ente alla ripetizione di eventuali acconti versati in esecuzione del
contratto stesso (Cass., 29 luglio 1967, n. 2021; 24 giugno 1972, n. 2144; 27
maggio 1975, n. 2131; 3 luglio 1979, n. 3724; 5 settembre 1980, n. 5134; 9
40
marzo 1983, n. 1760; 14 marzo 1983, n. 1890; 18 agosto 1990, n. 8410; 30
maggio
2002,
n.
7910).
In forza di un secondo orientamento, invece, qualora un ente locale,
esercitando una facoltà conferitagli dalla legge (art. 285, comma 21, r.d. n.
383 del 1934), si avvalga per la redazione di un progetto di opera pubblica di
un professionista privato, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli
atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano
espressione non di poteri pubblicistici ma di autonomia negoziale privatistica.
Ciò comporta che il diritto del professionista al compenso, insorto quando la
deliberazione comunale di conferimento dell'incarico si sia adotta nella
costituzione del rapporto di prestazione d'opera professionale, resta insensibile
ad eventuali vizi di detta deliberazione, rilevanti soltanto nell'ambito interno
dell'organizzazione
dell'ente
territoriale,
quale
quello
derivante
dall'inosservanza dell'obbligo d'indicare l'ammontare della spesa e dei mezzi
per farvi fronte (Cass., Sezioni unite, 17 novembre 1984, n. 5833; Cass., 11
maggio 1990, n. 4039; 30 agosto 1995, 9115; 28 maggio 1996, n. 4929; 27
febbraio
1998,
n.
2235;
13
febbraio
2003,
n.
2139).
Il primo dei suddetti orientamenti è affidato alle seguenti considerazioni:
Il precetto dettato dall'art. 284 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, ha carattere
imperativo e mira ad impedire che l'ente pubblico assuma un'obbligazione
senza rendersi conto del suo ammontare e senza conoscere se e come farvi
fronte. La delibera, come momento essenziale ai fini della validità del contratto
successivo, e cioè come momento centrale della formazione del consenso (e
non mero atto autorizzativo nei riguardi del legale rappresentante dell'ente,
affinché stipuli il contratto) deve corrispondere alle norme particolari dei diritto
pubblico che regolano la formazione dei contratti della P.A., e pertanto la sua
invalidità si riflette sulla validità dei contratto. Nell'ipotesi contemplata dall'art.
284 cit. si tratta di una nullità testuale che investe anche il contratto, sotto il
profilo della violazione di norme imperative, ex art. 1418, comma 2, c.c. (così
Cass.
n.
5134
del
1980,
in
motivazione).
Il secondo orientamento, invece, trova il principale punto di riferimento nella
citata
sentenza
delle
Sezioni
unite
n.
5833
del
1984.
In base a tale pronuncia (affidata alle Sezioni unite perché era stata addotta
una questione di giurisdizione e, perciò, non emessa in sede di composizione di
contrasto) l'eventuale incompletezza o irregolarità formale nella previsione
della spesa occorrente per il compenso dovuto al professionista non potrebbe
pregiudicare il diritto di questo. Invero, formatasi ritualmente nella sede
propria la volontà dell'ente in relazione al conferimento dell'incarico ad un certo
professionista per una data opera, e divenuta efficace la delibera in
conseguenza delle prescritte ratifiche, la costituzione del rapporto di
prestazione d'opera nella fase attuativa della delibera stessa ed il suo
svolgimento producono tutti gli effetti giuridici propri di quel contratto e quindi
anche l'obbligazione dell'ente di corrispondere le competenze al professionista.
41
Le carenze e le irregolarità del procedimento amministrativo in ordine alla
previsione della relativa spesa e dei mezzi per fronteggiarla potrebbero
produrre conseguenze nell'ambito interno dell'organizzazione dell'ente, non
esclusa la responsabilità degli amministratori che concorsero a deliberare quel
provvedimento, ma non potrebbero incidere negativamente: sui diritti acquisiti
dal privato professionista in forza del contratto di prestazione d'opera (le
sentenze successive si muovono, in sostanza, nella stessa prospettiva).
4. Il collegio ritiene che il contrasto debba essere composto secondo le linee
tracciate
dal
primo
degli
orientamenti
ora
riassunti.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 284, primo comma, r.d. 3 marzo
1934, n. 383 (normativa disciplinante la fattispecie in esame ratione temporis),
le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, che importino spese,
devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte. Il successivo
art. 288 dello stesso r.d. statuisce la nullità delle deliberazioni "prese in
adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi
deliberanti o che contengano violazioni di legge". Dal combinato disposto dei
due precetti discende che le deliberazioni - che importino spese e non indichino
l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte - sono nulle perché adottate in
violazione di legge, stante il carattere tassativo della prima disposizione
("devono
indicare").
La ratio di essa non può essere riduttivamente individuata soltanto in
un'esigenza di contabilità pubblica. Se è vero che la norma ha di mira la
regolarità e il buon andamento finanziario delle amministrazioni locali, è vero
del pari che questi obiettivi sono perseguiti in funzione dell'interesse pubblico
all'equilibrio economico, e quindi al buon andamento, di dette amministrazioni,
in un quadro di certezza e di trasparenza che ha fondamento costituzionale
(art.
97).
Del resto, si tratta di un principio generale che si è perpetuato
nell'ordinamento degli enti locali territoriali, com'è dimostrato, dal fatto che
anche la l. 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie
locali, stabilisce nell'art. 55, comma 5, che "gli impegni di spesa non possono
essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte
del responsabile del servizio finanziario", aggiungendo subito dopo che "senza
tale attestazione l'atto è nullo di diritto". Non rileva qui stabilire se tale
precetto abbia carattere innovativo o meno rispetto alla precedente
disposizione del citato art. 284. E' sufficiente notare che anche la nuova
disciplina delle autonomie locali ha ritenuto necessario prevedere un'espressa
comminatoria di nullità per gli impegni di spesa assunti senza preventiva
attestazione della copertura finanziaria, adottando una formula che appare
ancor più rigorosa rispetto a quella precedente, e ciò conferma la peculiare
valenza dell'interesse pubblico che il legislatore ha inteso tutelare.
Ciò posto, la tesi - secondo cui gli eventuali vizi della delibera in ordine alla
42
previsione della relativa spesa e dei mezzi per farvi fronte potrebbero produrre
conseguenze nell'ambito interno dell'organizzazione dell'ente, ma non
sarebbero idonei ad incidere negativamente sui diritti acquisiti dal privato
professionista in forza del contratto di prestazione d'opera - non può essere
condivisa.
Invero, nella formazione dei contratti soggetti alla c.d. evidenza pubblica (nel
cui novero rientrano anche quelli dei comuni e delle province) coesistono due
procedimenti: il primo si traduce in un provvedimento (deliberazione a
contrarre da parte degli organi qualificati) con cui si esterna lo scopo da
perseguire nonché il modo con cui s'intende realizzarlo, e tale manifestazione
di volontà costituisce il presupposto dell'atto negoziale che perciò si pone in
rapporto strumentale col provvedimento; il secondo si svolge tra le parti
contraenti ed ha ad oggetto la formazione della volontà secondo le norme
privatistiche, con alcune varianti correlate specialmente alle procedure da
seguire
per
la
scelta
del
contraente.
Orbene, è vero che, come questa Corte ha più volte affermato con particolare
riguardo alla conclusione del contratto d'opera professionale (quando ne sia
parte la P.A.), la deliberazione dell'ente - fino a quando non risulti tradotta in
un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante dell'ente stesso e dal
professionista - è atto con efficacia interna all'ente pubblico, non costituente
neppure proposta contrattuale, sicché non è idonea a determinare la
costituzione del relativo rapporto negoziale (v., ex multis, Cass., 25 novembre
2003, n. 17891; 5 novembre 2001, n. 13628; 16 ottobre 1999, n. 11687; 14
marzo
1998,
n.
2772).
Ciò, tuttavia, non significa che tutti i vizi della fase amministrativa e (per
quanto qui rileva) della delibera siano privi d'incidenza sul contratto stipulato in
forza di essa. L'affermazione può essere condivisa in relazione a carenze o vizi
che rendano la delibera stessa soltanto annullabile, non in presenza di una
violazione
di
legge
che
ne
comporti
la
nullità.
Infatti, come già si è notato, il contratto e la delibera, ancorché tra loro distinti,
sono collegati poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio
obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica.
Pertanto la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla
validità del contratto, perché la volontà dell'ente non si può ritenere
ritualmente formata nella sede propria e, sul piano negoziale, il contratto viene
ad essere stipulato in contrasto con una norma imperativa (quale il combinato
disposto dei citati artt. 284, 288 deve ritenersi, alla stregua delle
considerazioni sopra svolte), con le conseguenze di cui all'art. 1418, comma 1,
c.c.
Conclusivamente, il contrasto segnalato deve essere risolto con l'affermazione
del
seguente
principio
di
diritto:
Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 r.d. 3 marzo 1934, n.
43
383, la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano
ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica
è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se contenga la previsione
dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi
fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che
si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il
professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso".
La sentenza impugnata risulta conforme a tale principio, sicché il ricorso deve
essere
respinto.
La natura della questione trattata, tuttavia, consente di ravvisare la
sussistenza di giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara compensate
tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
44
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA 27 12
GIUGNO 2006 N. 13524
La quota di riserva spettante ai legittimari si determina all’apertura
della successione
(Presidente Carbone; Relatore Triola; Pm - parzialmente difforme - Iannelli;
Ricorrente Caselli; Controricorrente e ricorrente incidentale Caselli)
LA MASSIMA Successioni - Successione legittima e necessaria Individuazione della quota di riserva spettante ai singoli legittimari Riferimento alla situazione concreta determinatasi a seguito del
mancato esperimento dell’azione di riduzione - Esclusione Riferimento
al
momento
dell’apertura
della
successione
Ammissibilità. (Cc, articolo 536) Ai fini dell’individuazione della quota di
riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari
nell’ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione
esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si
viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o
prescrizione) dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Svolgimento del processo
Con atto notificato l'1-4 luglio 1987 Maria Caselli conveniva davanti al
Tribunale di Torino il fratello Vincenzo Caselli, nonché i nipoti Enrico, Alberto e
Maria Rosa Kiss, ed esponeva:
•
•
•
•
che in data 17 gennaio 1987 era deceduta Lucia Bertolone, madre di
essa attrice e di Vincenzo Caselli e di Thea Caselli, quest'ultima premorta
lasciando a succederle per rappresentazione alla madre i figli Enrico,
Alberto e Maria Rosa Kiss;
che con atto in data 6 agosto 1980 Lucia Bertolone aveva venduto a
Vincenzo Caselli la nuda proprietà su un immobile costituente il suo
intero patrimonio;
che tale atto dissimulava una donazione nulla per difetto di forma o
comunque una donazione lesiva della propria quota di legittima;
sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la
nullità della donazione, con conseguente apertura anche in suo favore
della successione legittima o che, nell'ipotesi di validità dell'atto in
questione, ne venisse disposta la riduzione nella misura necessaria ad
assicurarle la quota di legittima cui aveva diritto.
Vincenzo Caselli, costituitosi, contestava il fondamento delle domande.
Enrico,
Alberto
e
Maria
Rosa
Kiss
rimanevano
contumaci.
Con sentenza non definitiva in data 3 novembre 1992 il Tribunale di Torino
rigettava le domande proposte dall'attrice, che proponeva appello, che veniva
rigettato dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 8 febbraio 1995.
Maria Caselli proponeva ricorso per cassazione, che questa S.C. accoglieva con
sentenza in data 18 marzo 1997 n. 2885, ritenendo insufficiente la motivazione
45
con la quale era stata esclusa la simulazione dell'atto in data 6 agosto 1980 ed
insussistente in ordine alla subordinata ipotesi della configurabilità di un
negotium
mixtum
cum
donatione.
Maria Caselli provvedeva alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte di
appello di Torino, che con sentenza non definitiva in data 6 agosto 2001
escludeva la sussistenza della simulazione dell'atto in data 6 agosto 1980 e
disponeva l'ulteriore corso del giudizio al fine di accertare la sussistenza o
meno
di
un
negotium
mixtum
cum
donatione.
Contro tale decisione Maria Caselli, dopo avere fatto riserva di impugnazione,
proponeva ricorso immediato e tale ricorso è stato dichiarato inammissibile da
questa S.C. con sentenza in data 30 marzo 2006 n. 7502.
Con sentenza in data 15 novembre 2002 la Corte di appello di Torino,
frattanto, aveva ritenuto, sulla base della C.T.U. all'uopo disposta, che con
l'atto in data 6 agosto 1980 era stato realizzato un negotium mixtum cum
donatione, che, costituendo donazione indiretta, non era soggetto ai requisiti di
forma
previsti
per
le
donazioni
dirette.
A questo punto si poneva il problema di individuare la quota di riserva
spettante a Maria Caselli in una situazione caratterizzata dal fatto che la
legittima nel suo complesso era pari ai due terzi dell'asse ereditario, avendo
Lucia Bertolone lasciato due figli superstiti e tre nipoti destinati a subentrare
per rappresentazione alla terza figlia, ma questi ultimi non erano venuti alla
successione.
In sostanza, si trattava di stabilire se la quota pari ai 2/9 in teoria spettante a
Enrico, Alberto e Maria Rosa Kiss si doveva accrescere in favore delle altre due
quote pari a 2/9 ciascuna spettanti a Maria Caselli e Vincenzo Caselli.
La Corte di appello di Torino dava risposta negativa a tale quesito in base alla
seguente
motivazione.
È vero che la mancata accettazione dell'eredità dei nipoti Kiss è venuta ad
equivalere ad una rinuncia, ma la quota di legittima che è riservata dalla legge
non può essere modificata dalla rinuncia di altri eredi. E questo per una serie di
ragioni
tra
loro
autonome.
In
primo
luogo
il
dato
letterale
della
disposizione
normativa.
L'art. 537 cc che dispone la riserva a favore dei legittimari parla di figli e non di
eredi accettanti.
In secondo luogo vale la «ratio» della disposizione normativa.
Riservando ai figli una parte del patrimonio la legge ha, per così dire, posto un
limite inderogabile alla volontà del testatore, nel senso che gli ha impedito di
escludere totalmente il passaggio dei suoi beni ai figli col predeterminare a
favore
di
questi
ultimi
delle
quote
minime
di
riserva.
Peraltro la mancata accettazione di un erede non può costituire un ulteriore
elemento
di
coartazione
della
volontà
del
testatore.
In terzo luogo, se è vero che la mancata accettazione dei nipoti Kiss ha
comportato la prescrizione decennale del diritto, tuttavia la prescrizione non
può
essere
rilevata
di
ufficio.
Contro tale decisione, nonché contro la sentenza non definitiva in 6 agosto
2001, Maria Caselli ha proposto ricorso per cassazione, ripetendo, per quanto
riguarda la sentenza non definitiva, il motivo del ricorso già proposto contro la
stessa sentenza ed investendo con tre motivi la sentenza definitiva.
46
Vincenzo Caselli ha resistito con controricorso ed ha anche proposto ricorso
incidentale, con un unico motivo, al quale resiste con controricorso Maria
Caselli.
Con ordinanza in data 22 aprile 2005 la Seconda sezione civile di questa S.C.
ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l'opportunità di
assegnare la causa alle Sezioni unite, in considerazione del fatto che ai fini
della decisione occorre risolvere alcune questioni di particolare rilevanza
giuridica, cui la dottrina dà contrastanti soluzioni e che non sono state
affrontate ex professo da questa S.C.; in particolare occorre stabilire: a) quale
sia il criterio di determinazione della quota di riserva nella ipotesi in cui vi siano
più legittimari pretermessi, dei quali uno solo abbia esperito l'azione di
riduzione delle disposizioni testamentarie; b) se a tale ipotesi possa ritenersi
applicabile l'art. 522 cod. civ.
Motivi della decisione
Va
preliminarmente
disposta
la
riunione
dei
ricorsi.
Con l'unico motivo del ricorso principale diretto contro la sentenza non
definitiva Maria Caselli censura la motivazione con la quale la Corte di appello
di Torino ha escluso che la vendita effettuata in data 6 agosto 1980 da M.
Lucia Bertolone a Vincenzo Caselli dissimulasse una donazione nulla per difetto
di forma.
La doglianza è infondata. La ricorrente in via principale, infatti, da un lato,
propone una diversa valutazione delle prove testimoniali rispetto a quella
effettuata dai giudici di merito, mentre, invece, ai fini della sussistenza del
denunciato vizio di motivazione avrebbe dovuto chiarire come le conclusioni cui
la Corte di appello di Torino è pervenuta non siano congruenti, dal punto di
vista logico, con il contenuto delle prove testimoniali ritenute attendibili;
dall'altro, pretende che assurgano al livello di presunzioni elementi indiziari dal
valore probatorio non univoco. Con il primo dei motivi del ricorso principale
diretti contro la sentenza definitiva Maria Caselli censura la valutazione del
donatum
data
dai
giudici
di
merito
e
deduce
testualmente.
Con riferimento alla sentenza n. 1609/2002 occorre quindi osservare come la
Corte di Appello di Torino ha, a sommesso parere dell'esponente, omesso di
considerare che l'operazione posta in essere, cioè la vendita a prezzo vile della
nuda proprietà dell'immobile, abbia comportato un duplice beneficio in favore
del Vincenzo Caselli: uno immediato cioè l'acquisto a prezzo di gran lunga
inferiore al reale della nuda proprietà dell'immobile, il secondo differito al
momento in cui, con il decesso della de cuius, il Vincenzo sarebbe divenuto
nudo proprietario dell'immobile. Per calcolare quindi correttamente il beneficio
ricevuto la Corte di Appello avrebbe dovuto relazionare il prezzo pattuito e
ritenuto pagato nell'agosto del 1980 al valore della piena proprietà
dell'immobile
al
tempo
dell'apertura
della
successione.
La Corte di Appello ha invece effettuato un calcolo aritmetico attraverso il
quale viene semplicemente trasposta la percentuale del prezzo asseritamente
pagato nel 1980 sul valore della nuda proprietà a quella data per concludere
che nella medesima percentuale è da considerare il beneficio ricevuto dal
47
donatario al momento in cui l'usufrutto si consolidò nella nuda proprietà.
In realtà sarebbe stato corretto, giusto il disposto della norma di cui all'art.
747 cc in punto momento che deve aversi presente per la valutazione del
valore dell'immobile, calcolare il valore della donazione e quindi la quota del
bene immobile oggetto di donazione alla data dell'apertura della successione.
Poiché nel tempo la svalutazione del denaro e la rivalutazione dei beni immobili
in termini di valore nominale non ha andamento sempre coincidente (e poi ogni
immobile - bene infungibile per eccellenza - fa storia a sé), e in ogni caso,
poiché con la consolidazione dell'usufrutto il beneficio ricevuto dal donatario è
individuabile nella piena proprietà del bene, la quota del donatum doveva
essere effettuata parametrando il sacrificio economico sopportato dal Caselli
Vincenzo (37 ml nel 1980) al beneficio ricevuto all'apertura della successione
(ovvero il valore della piena proprietà dell'immobile al tempo dell'apertura della
successione).
La Corte di Appello di Torino ha invece del tutto omesso detta operazione
trasfondendo la percentuale del «pagato» sul valore della nuda proprietà al
1980 alla quota ideale di donazione (e infatti 37,5 ml rappresentano proprio il
22,22% - la Corte ha finito con l'arrotondare a 22,25% - di 168.750.000 valore
della nuda proprietà al 1980 secondo il seguente calcolo aritmetico
168.750.000/100
=
1.687.500;
37.500.000/1.687.500
=
22,22).
Il Giudice del merito ha quindi concluso che il donatum fosse una quota ideale
pari
al
77,75%
(100-22,25)
dell'immobile.
Detto criterio di calcolo non tiene in nessun conto il criterio di cui al citato art.
747 c.c. e soprattutto non considera che con il decesso dell'usufruttuaria il
donante ha conseguito l'ulteriore beneficio della consolidazione dell'usufrutto.
L'esponente aveva proposto invece il seguente diverso criterio di calcolo:
somma di 37.500.000; rivalutata al gennaio 1987 pari a L. 76.500.000;=.
Detta somma rivalutata rappresenta una percentuale del 12,96% del valore
alla stessa data della piena proprietà del compendio immobiliare
(590.000.000). Ne derivava quindi che la percentuale del donatum era da
individuarsi nell'87,04% e non già nella minore percentuale del 77,75.
Anche a non voler condividere detto criterio di calcolo, in ogni caso, il Giudice
del merito avrebbe dovuto individuare criteri atti a rapportare, come sopra
visto, il presunto sacrificio economico del Caselli Vincenzo al 1980 con il
beneficio complessivo da calcolarsi al momento dell'apertura della successione.
Il motivo, a prescindere dalla sua teorica fondatezza o meno, è inammissibile,
in quanto investe una questione che non risulta trattata nella sentenza
impugnata, né viene espressamente denunciata una omessa pronuncia, il che
sarebbe stato necessario, in considerazione delle conclusioni che risultano
formulate
nell'epigrafe
della
sentenza
impugnata.
Con il secondo dei motivi del ricorso principale diretti contro la sentenza
definitiva Maria Caselli sostiene che nella specie il negotium mixtum cum
donatione doveva considerarsi nullo per difetto di forma, in applicazione del
criterio
della
c.d.
prevalenza.
Il motivo è infondato, alla stregua quantomeno della più recente
giurisprudenza di questa S.C., la quale ha affermato che per il negotium
mixtum cum donatione non è necessaria la forma dell'atto pubblico
richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma
48
dello schema negoziale adottato, senza far menzione del criterio della
c.d. prevalenza (cfr. sent. 21 gennaio 2000 n. 642; 10 aprile 1999 n. 3499).
Con il terzo dei motivi del ricorso principale diretti contro la sentenza definitiva
Maria Caselli ripropone la tesi secondo la quale il mancato esercizio dell'azione
di riduzione da parte dei nipoti ex sorore comportava l'accrescimento (anche)
in suo favore della quota di legittima agli stessi in teoria spettante.
Si tratta del problema con riferimento al quale la causa è stata assegnata a
queste
Sezioni
unite.
Questa S.C. ha avuto occasione di affermare che se più sono i legittimari
(nell'ambito della categoria dei discendenti) ciascuno ha diritto ad una frazione
della quota di riserva e non all'intera quota, o comunque ad una frazione più
ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri (non) facessero valere il
loro diritto (sent. 22 ottobre 1975 n. 3500, 1978 n. 5611).
Tale orientamento, peraltro, si pone in implicito contrasto con la giurisprudenza
formatasi con riferimento alla ipotesi in cui disponibile e legittima variano in
funzione della esistenza di più categorie di legittimari o del numero di
legittimari
nell'ambito
di
una
stessa
categoria.
Ad es., in base all'art. 542, primo comma, cod. civ., se chi muore lascia, oltre
al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un
terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; in base all'art. 542,
secondo comma, cod. civ., quando, invece, i figli, legittimi o naturali, sono più
di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al
coniuge spetta un altro quarto.
Con riferimento ad entrambe le ipotesi si pone il problema se il mancato
esercizio dell'azione di riduzione da parte del coniuge pretermesso comporta
che la legittima dell'unico figlio o dei più figli si «espanda», diventando
rispettivamente pari alla metà o ai due terzi del patrimonio del de cuius,
secondo quanto previsto dall'art. 537, primo e secondo comma, cod. civ.
Con riferimento alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 542 cod.
civ. si pone il problema se il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte
dell'unico figlio comporta la espansione della legittima del coniuge, in modo da
farle raggiungere la misura prevista dall'art. 540, primo comma, cod. civ.
Con riferimento, infine all'ipotesi prevista dall'art. 542, secondo comma,
cod. civ. si pone il problema se l'esperimento dell'azione di riduzione da parte
di uno solo dei figli comporta che la legittima allo stesso spettante debba
essere determinata secondo quanto disposto dal primo comma.
La giurisprudenza di questa S.C. si è mostrata favorevole alla tesi della c.d.
espansione della quota di riserva con riferimento all'ipotesi di mancato
49
esercizio dell'azione di riduzione da parte del coniuge superstite (sent. 26
ottobre 1976 n. 3888; 9 marzo 1987 n. 2434; 11 febbraio 1995 n. 1529).
Si è, in proposito, affermato (sent. 9 marzo 1987, cit.) che ... occorre tenere
presente che, a norma dell'art. 521 c.c. la rinunzia all'eredità è retroattiva nel
senso che l'erede rinunziante si considera come se non fosse mai stato
chiamato all'eredità. È dunque impossibile far riferimento alla situazione
esistente al momento dell'apertura della successione, dal momento che tale
situazione è soggetta a mutare, per effetto di eventuali rinunzie, con effetto
retroattivo. È quindi alla situazione concreta che occorre far riferimento, e non
a quella teorica, riferita al momento dell'apertura della successione,
indipendentemente dalle vicende prodottesi in seguito; devesi dunque far
riferimento agli eredi che concretamente concorrono nella ripartizione dell'asse
ereditario e non a quelli che in teoria a tale riparto avrebbero potuto
partecipare.
Tale orientamento è conforme a quanto sostenuto in dottrina, in cui
ugualmente si è invocato il principio della retroattività della rinuncia fissato
nell'art. 521 c.c. e si è sostenuto che un argomento a favore dello stesso
sarebbe desumibile dall'art. 538 cod. civ., che regola la riserva spettante agli
ascendenti «se chi muore non lascia figli legittimi», in quanto la norma
dovrebbe applicarsi soltanto nel caso in cui l'ereditando non abbia avuto figli o
questi siano tutti presenti o assenti; se invece sopravvivessero figli capaci di
succedere e tutti rinunziassero, si dovrebbe concludere nel senso che o rimane
ferma a beneficio degli ascendenti la quota riservata di due terzi stabilita
dall'art. 537, oppure che non sorge alcun diritto di riserva in favore degli
ascendenti, conclusioni, l'una e l'altra, evidentemente inammissibili.
Si tratta di un orientamento che il collegio ritiene di non poter
condividere.
Appare, in primo luogo, inopportuno il richiamo agli effetti della rinuncia di uno
dei chiamati in tema di successione legittima, secondo quanto previsto dagli
artt. 521 e 522 cod. civ., per vari motivi.Nella successione legittima il c.d.
effetto retroattivo della rinuncia di uno dei chiamati e il conseguente
accrescimento in favore degli accettanti trovano una spiegazione logica nel
fatto che, diversamente, non si saprebbe quale dovrebbe essere la sorte della
quota del rinunciante. La situazione è ben diversa con riferimento alla c.d.
successione necessaria. Il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad
ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio
del de cuius anche contro la volontà di quest'ultimo. Mancando una chiamata
congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla ipotesi di
pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata
ereditaria il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a
cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall'altro, non
esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al
legittimario che non eserciti l'azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i
legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di
quella
di
cui
quest'ultimo
avrebbe
potuto
disporre.
La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l'adesione
alla tesi finora sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza. Dalla formulazione
50
degli artt. 537, primo comma («se il genitore lascia»), 538, primo comma («se
chi muore non lascia»), 542, primo comma («se chi muore lascia»), 542,
secondo comma («quando chi muore lascia»), cod. civ. risulta chiaramente che
si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla
situazione esistente al momento dell'apertura della successione; non viene
preso, invece, in considerazione, a tal fine, l'esperimento dell'azione di
riduzione
da
parte
di
alcuno
soltanto
dei
legittimari.
Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare
e possibilità di applicare il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio)
per una estensione in via analogica delle norme in tema di successione
legittima. La tesi criticata, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della
successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti
una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche (come rovescio della
medaglia) quella di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti, in
considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo
patrimonio in favore di terzi. È evidente che l'esigenza di certezza in questione
non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata,
successivamente all'apertura della successione, in funzione del numero di
legittimari
che
dovessero
esperire
l'azione
di
riduzione.
Non possono, poi, essere taciuti gli inconvenienti pratici connessi alla adesione
della
c.d.
espansione
della
quota
di
riserva.
Occorre, a tal fine, partire dalla considerazione che l'esercizio dell'azione di
riduzione è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale e che non è
prevista una actio interrogatoria, al contrario di quanto avviene con riferimento
all'accettazione dell'eredità (art. 481 cod. civ.). Ne consegue che all'apertura
della successione ogni legittimario può esperire l'azione di riduzione solo con
riferimento alla porzione del patrimonio del de cuius che gli spetterebbe in
base alla situazione familiare di quest'ultimo a tale momento. Solo dopo la
rinunzia all'esercizio dell'azione di riduzione da parte degli altri legittimari o la
maturazione della prescrizione in danno degli stessi potrebbe agire per
ottenere un supplemento di legittima, con evidente incertezza medio tempore
in ordine alla sorte di una quota dei beni di cui il de cuius ha disposto per
donazione
o
per
testamento
a
favore
di
terzi.
Né utili argomenti a favore della tesi criticata possono desumersi dall'art. 538
cod.
civ.
In primo luogo, nel ragionamento sopra trascritto è incomprensibile il
riferimento ad una quota pari a due terzi riservata in favore dagli ascendenti
dall'art. 537 cod. civ., dal momento che tale disposizione fa riferimento alla
quota
riservata
ai
figli
legittimi
o
naturali.
Non si comprende, poi, perché sarebbe inammissibile la conclusione (cui si
perverrebbe aderendo alla tesi che il collegio ritiene preferibile) secondo la
quale, ove sopravvivessero al de cuius figli legittimi e tutti rinunziassero non
sorgerebbe alcun diritto di legittima a favore degli ascendenti.
Va, innanzitutto, rilevato che non è chiaro se la rinunzia viene riferita
all'accettazione dell'eredità o all'esperimento dell'azione di riduzione.
Nel primo caso un problema di tutela degli ascendenti non si porrebbe
neppure, in quanto in loro favore si aprirebbe la successione legittima ex art.
569 cod. civ., dovendo i figli legittimi, a seguito della rinunzia all'eredità,
51
considerarsi
come
mai
chiamati
alla
successione.
Nel secondo caso la esclusione della configurabilità di una quota di riserva in
favore degli ascendenti sarebbe espressione della scelta del legislatore di
garantire il conseguimento di una quota del patrimonio del de cuius solo ai
parenti più prossimi (oltre che al coniuge) esistenti al momento dell'apertura
della successione. I parenti di grado successivo, che sono considerati come
legittimari solo in mancanza di quelli di grado più vicino, pertanto, non possono
essere rimessi in corsa in caso di mancato esercizio dell'azione di riduzione da
parte
di
questi
ultimi.
In definitiva, il legislatore ha considerato iniquo il fatto che il de cuius disponga
dell'intero suo patrimonio a favore di estranei nel caso in cui abbia solo
discendenti o solo ascendenti; non ha considerato, invece, iniquo il fatto che
rimangano fermi gli atti con i quali il de cuius, il quale lasci discendenti e
ascendenti, abbia disposto dell'intero suo patrimonio a favore di estranei, nel
caso in cui i discendenti (unici legittimari considerati) non esperiscano l'azione
di
riduzione.
Alla luce delle considerazioni svolte si può, pertanto, concludere che ai fini
della individuazione della quota di riserva spettante alle singole
categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa
categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento
dell'apertura della successione e non a quella che si viene a
determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o
prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei
legittimari.
Alla luce delle considerazioni svolte è evidente che anche il terzo dei motivi del
ricorso principale diretti contro la sentenza definitiva va rigettato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale Vincenzo Caselli si duole del fatto che
la Corte di appello di Torino, per quanto riguarda la valutazione dell'immobile
oggetto della vendita in data 6 agosto 1980, nella quale è stato individuato un
negotium mixtum cum donatione, e la rivalutazione dello stesso al momento
dell'apertura della successione, abbia recepito le conclusioni del C.T.U., senza
tenere
conto
delle
critiche
rivolte
all'operato
dello
stesso.
Il motivo è infondato, in quanto non viene specificamente censurata la
esattezza dell'elemento decisivo sul quale si sono fondate le valutazioni del
C.T.U. recepite dalla sentenza impugnata e cioè i dati compartivi desumibili dal
mercato immobiliare per costruzioni similari, in base anche alle concrete
risultanze ancora in possesso delle agenzie immobiliari operanti in loco.
In
definitiva,
entrambi
i
ricorsi
vanno
rigettati.
In considerazione della problematicità della questione con riferimento alla
quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite di questa S.C., ritiene il
collegio che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
52
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 31 gennaio 2006
n. 2046
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto
Dott. CORONA Rafaele - rel. Presidente di sezione
Dott. DUVA Vittorio - Consigliere
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere
Dott. CICALA Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo
studio dell'avvocato VITO CASTRONUOVO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ALDINO MICHELE E VINCENZO G.C. PAPALEO, giusta delega in calce
al ricorso;
- ricorrente contro
C.A., L.G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 45, presso lo
studio dell'avvocato FRANCESCO BONIFACIO, rappresentati e difesi
dall'avvocato BONIFACIO CARLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 244/1999 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata
il 28/12/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/01/2006 dal
Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che
ha concluso per il rigetto del primo motivo, rinvio per il resto ad una sezione
semplice.
Svolgimento del processo
Con citazione 16 novembre 1989, C.N. convenne, davanti al Tribunale di
Lagonegro,
i
coniugi
C.A.
e
L.G.
R..
Espose di essere proprietario, in ragione della metà assieme ai convenuti, di un
edificio sito in (OMISSIS) via (OMISSIS), e di aver effettuato delle riparazioni
alle parti comuni (beneficiando del contributo previsto dalla L. n. 219 del 1981,
per i danni subiti dal fabbricato a seguito del sisma del (OMISSIS) e del
(OMISSIS)).
Domandò la condanna dei convenuti alla restituzione della quota da loro
dovuta
pari
a
L.
7.334.737.
53
I convenuti chiesero l'assoluzione da ogni avversa pretesa e il Tribunale, con
sentenza 5 dicembre 1995 - 5 gennaio 1996, rigettò la domanda.
Decidendo sull'impugnazione principale proposta dal C. e sull'appello
incidentale proposto da coniugi C.A. e L.G.R. (limitatamente alle spese), la
Corte d'Appello di Potenza, con sentenza 17 novembre - 28 dicembre 1999,
respinse ambedue le impugnazioni. Premesso che la legislazione speciale non
aveva introdotto nessuna deroga alla disciplina civilistica, concernente il
rimborso delle spese per la conservazione delle cose comuni erogate da un
proprietario, al condominio costituito da due soli partecipanti si applicava la
norma di cui all'art. 1134 cod. civ., che al condomino riconosce il diritto al
rimborso soltanto per le spese urgenti, ragion per cui non operava la
disposizione dettata in tema di comunione in generale dell'art. 1110 cod. civ.,
secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione era subordinato
solamente alla trascuranza degli altri comproprietari. Nel condominio composto
da due soli condomini non si applicavano soltanto le disposizioni stabilite
dall'art. 1136 cod. civ. relativamente alla costituzione ed alle votazioni in
assemblea.
Ha proposto ricorso per Cassazione C.; hanno resistito con controricorso C.A. e
L.G.R..
Con ordinanza interlocutoria 10 marzo 2004, la Seconda Sezione civile ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite, avendo rilevato un contrasto di giurisprudenza in materia di rimborso
delle spese per la conservazione delle cose comuni nel caso di condominio
composto da due soli partecipanti (il cosiddetto "condominio minimo"), giacchè
dalla Corte Suprema talora era stata affermata l'applicabilità dell'art. 1110 cod.
civ. (Cass., Sez. 2^, 18 ottobre 1988, n. 5664), talaltro era stata ritenuta la
applicabilità dell'art. 1134 cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 26 maggio 1993, n. 5914
e Cass., Sez. 2^, 4 agosto 1997, n. 7181).
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
delle norme di cui agli artt. 1110 e 1134 cod. civ., poichè erroneamente la
sentenza della Corte d'Appello aveva ritenuto applicabile al condominio
costituito da due soli partecipanti la disposizione di cui all'art. 1134 cod. civ.,
anzichè quella prevista dall'art. 1110 c.c., ragion per cui al condomino, che
aveva sostenuto le spese necessaire per la conservazione delle cose comuni,
doveva riconoscersi il diritto al rimborso alla sola condizione della trascuranza
dell'altro partecipante. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la
violazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, artt. 9, 10, 12 e 14 e successive
modificazioni, perchè erroneamente la sentenza impugnata non aveva
considerato la deroga alle norme civilistiche apportate dalle norme speciali, con
il diritto del condomino di procedere all'esecuzione delle opere, in sostituzione
ed a spese del proprietario inadempiente. Con il terzo motivo, infine, il
ricorrente censura ancora la violazione delle norme speciali ricordate sopra,
che dalla sentenza impugnata non erano state ritenute applicabili a tutti gli
immobili danneggiati dal sisma, in ragione dello stato di urgenza dei lavori per
adeguare gli edifici alla normativa antisismica, a pena di decadenza dal
beneficio
del
sussidio
statale.
2.1.- La questione di diritto, che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere per
54
decidere la controversia, è se, nel caso di edificio in condominio composto da
due soli partecipanti (il cosiddetto "condominio minimo"), il rimborso delle
spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino sta
regolato dalla norma di cui all'art. 1134 cod. civ., che riconosce il diritto al
rimirano soltanto per le spese urgenti; ovvero se, in considerazione della
peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due
soli proprietari, e dalla susseguente inapplicabilità del principio di maggioranza,
la fattispecie venga ad essere regolata dalla norma dettata dall'art. 1110 cod.
civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla
mera
trascuranza
degli
altri
condomini.
Il diverso il regime del rimborso delle spese anticipate dal condomino e dal
comproprietario, a seguito della inerzia degli altri partecipanti (o
dell'amministratore) - è noto - si fonda sul diverso presupposto oggettivo
dell'urgenza
e
della
trascuranza.
In materia di condominio negli edifici, il concetto di urgenza, impiegato nell'art.
1134 cod. civ., viene ricavato dal significato proprio della parola, che designa
la stretta necessità: la necessità immediata ed impellente. Afferma la
giurisprudenza che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 cod. civ. concernente
il rimborso delle spese per le cose comuni fatte da un condomino, va
considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass.,
Sez. 2^, 26 marzo 2001, n. 4364); la spesa, la cui erogazione non può essere
differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia
(Cass.,
Sez.
2^,
12
settembre
1980,
n.
5256).
Trascuranza, invece, significa negligenza, trascuratezza, omessa cura come si
dovrebbe. Relativamente alle spese necessarie per la conservazione delle cose
comuni, l'art. 1110 cit. riconduce il diritto al rimborso alla semplice inattività
(Cass.,
Sez.
2^,
3
agosto
2001,
n.
10738).
Il maggior rigore della disciplina in tema di condominio negli edifici rispetto alla
comunione dipende dalla diversa utilità dei beni, che formano oggetto dei
differenti diritti; l'utilità strumentale per i beni in condominio e l'utilità finale
per i beni in comunione. La indivisibilità dei beni in condominio (art. 1119 cod.
civ.) dipende dalla utilità strumentale, essendo strettamente legata al
godimento delle unità immobiliari. Dalla virtuale perpetuità del condominio
deriva l'opportunità che i condomini non interferiscono nella amministrazione
delle parti comuni dell'edificio. Dalla normale divisibilità nella comunione,
invece, segue che il comunista insoddisfatto dell'altrui inattività, se non vuole
chiedere lo scioglimento (art. 1111 cod. civ.), può decidere di provvedere
personalmente.
2.2 - L'espressione "condominio" designa il diritto soggettivo di natura reale (la
proprietà comune) concernente le parti dell'edificio di uso comune e, ad un
tempo, l'organizzazione del gruppo dei condomini, composta essenzialmente
dalle figure dell'assemblea e dell'amministratore: organizzazione finalizzata alla
gestione
delle
cose,
degli
impianti
e
dei
servizi.
La specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici - la tipicità, che
distingue l'istituto dalla comunione di proprietà in generale e dalle altre
formazioni sociali di tipo associativo - si fonda sulla relazione che, nel
fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni
formano oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio). Le norme dettate
55
dagli artt. 1117, 1139 cod. civ. si applicano all'edificio, nel quale più piani o
porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse e un
certo numero di cose, impianti e servizi di uso comune sono legati alle unità
abitative
dalla
relazione
di
accessorietà.
L'art. 1117 cod. civ., elencati a titolo esemplificativo talune cose, impianti e
servizi di uso comune, stabilisce che "sono oggetto di proprietà comune"... "in
genere tutte le parti dell'edificio necessarie per l'uso comune" (n. 1); i locali
destinati "per simili servizi in comune" (n. 2); le opere, le istallazioni, i
manufatti "di qualunque genere che servono all'uso o al godimento comune".
Secondo l'interpretazione consolidata, ai fini della attribuzione del diritto di
condominio la norma conferisce rilevanza al collegamento tra le parti comuni e
le
unità
immobiliari
in
proprietà
solitaria:
collegamento, che può essere materiale o funzionale. Il primo tipo di legame,
consistente nella incorporazione tra entità inscindibili, ovvero nella
congiunzione stabile tra entità separabili, si concreta nella necessità delle cose,
dei servizi e degli impianti per l'esistenza o per l'uso dei piani o delle porzioni di
piano; il secondo si esaurisce nella destinazione funzionale delle parti comuni
all'uso o al servizio delle unità immobiliari (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9
giugno 2000, n. 7889). Il collegamento tra beni propri e comuni, consistente
nella necessità per l'esistenza o per l'uso, ovvero nella destinazione all'uso o al
servizio, si definisce come relazione di accessorietà, perchè l'espressione mette
in evidenza, ad un tempo, il legame funzionale e la connessione materiale. Il
termine accessorietà, sul piano funzionale, enuncia il difetto di utilità fine a se
stessa e la subordinazione strumentale delle parti comuni; esprime, altresì, la
connessione materiale, che determina la mancanza di autonomia fisica dei beni
comuni rispetto ai beni in proprietà esclusiva e, nondimeno, non esclude la loro
perdurante individualità giuridica nell'orbita della incorporazione o della
relazione
stabile.
Il regime del condominio negli edifici - inteso come diritto e come
organizzazione - si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani
o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone diverse,
ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose,
impianti e servizi comuni. Il condominio si costituisce (ex lege) non appena,
per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato
vengono
ad
appartenere
a
soggetti
differenti.
Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in
proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e
dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione
di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne
la
gestione,
è
regolata
dalle
norme
sul
condominio.
In definitiva, l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia
non dipende dal numero delle persone, che ad esso partecipano.
Prima di chiudere sul punto, conviene ribadire le ragioni, che determinano la
disciplina differente del condominio e della comunione in generale. La ragione
di fondo è la diversa utilità dei beni, che formano oggetto del condominio e
della comunione: rispettivamente, l'utilità strumentale e l'utilità finale. Le parti
comuni dal codice sono considerate beni strumentali al godimento dei piani o
delle porzioni di piano in proprietà esclusiva; cose in comunione costituiscono
56
beni autonomi, suscettibili di utilità fine a se stessa e come tali sono
considerate.
2.3.- D'altra parte, nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il
condominio negli edifici non si applichino al "condominio minimo", composto da
due soli proprietari. Per la verità, le due sole norme concernenti il numero dei
partecipanti riguardano la nomina dell'amministratore ed il regolamento di
condominio (L'art. 1129 cod. civ. fissa l'obbligatorietà della nomina
dell'amministratore
quando
i
condomini
sono
più
di
quattro;
l'art. 1138 prevede che il regolamento di condominio debba essere approvato
dall'assemblea quando il numero dei condomini è superiore a dieci). Nessuna
norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo (due) dei
condomini.
Pertanto, se nell'edificio ameno due piani o porzioni di piano appartengono in
proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come
situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della
relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza,
indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme
specificamente
previste
per
il
condominio
negli
edifici.
2.4.- Si contesta l'applicabilità di talune delle norme di organizzazione (artt.
1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 cod.
civ.), specialmente di quelle riguardanti il funzionamento del collegio sulla base
del
principio
di
maggioranza.
Ciò sulla base dell'asserita inapplicabilità del metodo collegiale e del principio
maggioritario
in
presenza
di
due
soli
condomini.
Ma non è esatta l'affermazione che l'impossibilità di impiegare il principio
maggioritario renda inapplicabili ai condomini minimi le norme procedimentali
sul funzionamento dell'assemblea e determini automaticamente il ricorso alle
norme sulla comunione in generale (tra le altre: Cass., Sez. n, 30 marzo 2001,
n. 4721; Cass., Sez. 2^, 26 maggio 1993, n. 5914; Cass., Sez. U, 6 febbraio
1978,
n.
535;
Cass.,
Sez.
n,
24
aprile
1975,
n.
1604).
Nessuna norma contempla l'impossibilità, logica e tecnica, che le decisioni
vengano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario. In altre
parole, nessuna norma impedisce che l'assemblea, nel caso di condominio
formato da due soli condomini, si costituisca validamente con la presenza di
tutti e due i condomini e all'unanimità decida validamente. Dalla
interpretazione logico- sistematica non si ricava la necessità di operare sempre
e comunque con il metodo collegiale e con il principio maggioritario, quindi il
divieto categorico di decidere con criteri diversi dal principio di maggioranza
(per esempio, all'unanimità): si ricava la disciplina per il caso in cui non si
possa decidere, a causa della impossibilità pratica di formare la maggioranza: il
che
vale
non
soltanto
per
il
condominio
minimo.
La disposizione dell'art. 1136 cod. civ. è applicabile anche al condominio
composto da due soli partecipanti: peraltro, se non si raggiunge l'unanimità e
non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto diventa
necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del
collegato
disposto
degli
artt.
1105
e
1139
cod.
civ..
L'ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre, nelle quali la
57
maggioranza in concreto non si forma. Si pensi al caso del condominio
composto da più partecipanti, in cui gli schieramenti opposti si equivalgono e
non
si
determinano
maggioranza
e
minoranza;
oppure al caso di un condominio, del pari composto da più partecipanti, in cui
un impianto risulti destinato al servizio di due soli condomini, i quali da soli
sono chiamati a deliberare sulla gestione. In entrambi i casi, se in concreto la
maggioranza non si forma si ricorre all'autorità giudiziaria ex art. 1105 cod.
civ.
cit..
A fortiori non sussistono ostacoli all'applicazione anche al condominio minimo
delle norme concernenti la situazione soggettiva (artt. 1117, 1118, 1119,
1122, 1123, 1124, 1135, 1136, 1137, 1138 cod. civ.) Quindi, nulla osta che
nel caso delle spese anticipate da un condomino trovi applicazione l'art. 1134
cod. civ.. Per la verità, il contemperamento di interessi dettato da questa
disposizione si fonda sulla relazione di accessorietà tra beni propri e comuni,
essendo la disciplina del rimborso delle spese per le cose, gli impianti ed i
servizi comuni dell'edificio stabilita in funzione del carattere strumentale di
queste parti rispetto al godimento dei piani o delle porzioni di piano in
proprietà solitaria, avuto riguardo alla necessità che i condomini sulla gestione
interferiscano
il
meno
possibile.
2.5.- In conclusione, il condominio si istaura, sul fondamento della relazione di
accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servizi rispetto ai piani o le porzioni di
piano in proprietà solitaria, ogni qual volta nel fabbricato esistono più piani o
porzioni di piano in proprietà esclusiva; la relazione di accessorio a principale
conferisce all'istituto la fisionomia specifica, per cui si differenzia dalla
comunione e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo; d'altra parte,
nessuna disposizione prevede l'inapplicabilità delle norme concernenti il
condominio negli edifici al "condominio minimo", composto da due soli
partecipanti, posto che le sole norme in materia concernenti il numero dei
condomini riguardano la nomina dell'amministratore e la formazione del
regolamento (gli artt. 1129 e 1138 c.c.). Tutto ciò considerato, nel caso di
edificio in condominio composto da due soli condomini (il cosiddetto
"condominio minimo"), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti
comuni anticipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma
stabilita dall'art. 1134 cod. civ., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto
soltanto per le spese urgenti: ovverosia, soltanto per le spese impellenti, che
devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere
differita
senza
danno.
Il
primo
motivo
di
ricorso
deve
essere
respinto.
3.- Deve essere rigettato, del pari, il secondo motivo, che al primo è
strettamente
connesso.
La L. speciale 14 maggio 1981, n. 219 non deroga affatto alle disposizioni del
codice civile in materia di condominio. Al contrario, la L. speciale, art. 12 cpv.,
ultimo conferma che le deliberazioni collegiali concernenti le opere di
ricostruzione o di riparazione devono essere approvate con la maggioranza di
cui all'art. 1136 cod. civ., comma 2: in piena conformità, quindi, con quanto
dispone in generale lo stesso art. 1136 c.c., comma 4, per la ricostruzione
dell'edificio
o
le
riparazioni
straordinarie
di
notevole
entità.
Allo stesso tempo, le norme concernenti i contributi per la riparazione degli
58
immobili non irrimediabilmente danneggiati riguardano, di regola, i soggetti
titolari del diritto di proprietà alla data del sisma (legge citata, art. 10).
Peraltro, i contributi per la riparazione previsti in favore del proprietario, a
norma della legge citata, art. 11, possono essere assegnati eccezionalmente
anche al conduttore o ad altri detentori alla duplice condizione che: a) sia
decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, con lettera raccomandata,
che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire
direttamente le opere necessaria senza che il proprietario abbia presentato al
sindaco la prescritta domanda di autorizzazione; b) nel termine di 90 giorni
dall'autorizzazione del sindaco, il proprietario non abbia dato inizio ai lavori.
Nella specie, nessuna di tali modalità procedimentali si deduce essere stata
osservata.
4.- Appare del tutto nuovo e, come tale, inammissibile il terzo motivo di
ricorso.
E' risaputo che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di
inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del
giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove e nuovi temi non trattati nella fase di merito.
Orbene, non risulta prospettata in appello la doglianza concernente l'urgenza
ex se delle opere occorrenti per adeguare l'edificio alla normativa antisismica,
posto che in sede di gravame C.N., con il primo motivo aveva lamentato la
mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica indispensabile per
valutare l'applicabilità nella fattispecie della disposizione di cui all'art. 1110
cod. civ. e, con il secondo, aveva censurato l'affermazione circa l'insussistenza
della
prova
relativa
alla
ultimazione
dei
lavori.
5.- Rigettato il ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente
le spese processuali.
P.
Q.
M.
La
Corte,
pronunziando
a
Sezioni
Unite:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ORDINANZA 13 GIUGNO N. 13659
ORDINANZA 13 GIUGNO N. 13660
ORDINANZA 15 GIUGNO 2006, N. 13911
(MOTIVAZIONE CENTRALE IDENTICA)
(Presidente Carbone – Relatore Carbone
Pg Nardi – difforme – Ricorrente S. ed altri
Controricorrente Cooperativa Edilizia Solidarietà Srl)
(Omissis)
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S. I., L. M. T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18,
presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZETTI, rappresentati e difesi
59
dall'avvocato ANTONINO B0NGI0RN0 GALLEGRA, giusta delega a margine del
ricorso;
- ricorrente
contro
COOPERATIVA EDILIZIA SOLIDARIETÀ S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GROTTAROSSA 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLINO STELLA,
rappresentata e difesa dall'avvocato ACHILLE ALDO OCCHIONERO, giusta
delega a margine del controricorso;
- controricorrente contro
COMUNE DI LAVAGNA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato
ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ANTONIO GRIFFI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
214/03 del Tribunale di CHIAVARI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/05 dal
Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo
NARDI il quale, visto l'art. 375 c.p.c, chiede che la Corte di Cassazione, a
sezioni unite, dichiari il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
§1. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 24 gennaio 2003 I. S. e M. T. L. convenivano in
giudizio dinanzi al tribunale di Chiavari il Comune di Lavagna e la cooperativa
edilizia Solidarietà a r.l.
Premesso che erano proprietari di un fabbricato ad uso officina in Lavagna; che
il sindaco del Comune, con ordinanza n. 697 del 6 novembre 1987, aveva
disposto, nell'ambito di un PEEP, lo sgombero e la demolizione del locale, e che
il provvedimento veniva eseguito dalla delegata cooperativa Solidarietà; che
tali provvedimenti venivano annullati con decisione del t.a.r. Liguria del 14
dicembre 1993, sulla considerazione che una parte dell'immobile non era
contemplata nel procedimento di attuazione del PEEP, e che alla prima
occupazione d'urgenza non era seguita la presa di possesso del bene; che il
Consiglio di Stato, con la decisione in data 28 febbraio 2002, passata in
giudicato, aveva confermato tale sentenza; chiedevano che i convenuti fossero
condannati al risarcimento dei danni cagionati dal comportamento
dell'amministrazione, non più sostenuto da alcun valido provvedimento.
Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario, sostenendo che la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di cui
all'art. 34 del d.l.vo n. 80 del 1998, il quale attribuisce alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di edilizia e di
urbanistica.
Gli attori hanno, quindi, proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, al
quale hanno resistito con controricorso il Comune e la cooperativa Solidarietà.
§ 2. Le ragioni svolte dalle parti sulla questione di giurisdizione
60
2.1. I ricorrenti sostengono che la controversia è devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario in quanto: a) il PEEP, sul quale si basa parte della procedura
espropriativa, è stato annullato con decreto del Presidente della Repubblica; b)
in ogni caso, parte del fabbricato era stato demolito dalla cooperativa al di fuori
delle previsioni del PEEP; e) che, conseguentemente, la fattispecie deve essere
inquadrata nei termini della ed. occupazione appropriativa, e non di danno da
provvedimento illegittimo, ipotesi in cui sussisterebbe la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.35, comma 4°, della legge 21 luglio
2000, n. 205.
2.2. I controricorrenti sostengono che la giurisdizione appartiene al giudice
amministrativo per le seguenti considerazioni:
1. con deliberazione della Giunta
Provinciale è stata disposta
l'espropriazione dell'area sulla quale si trovava il fabbricato demolito.
Tale provvedimento, come pure gli atti propedeutici, non è stato
impugnato dagli interessati, che si sono limitati a proporre opposizione
alla stima, il cui giudizio è ancora pendente;
2. l'ordinanza di sgombero veniva annullata dal Consiglio di Stato perché
non era stata ritenuta precisa la descrizione dell'immobile ivi contenuta;
e) la dichiarazione di pubblica utilità esiste perché contenuta nel PEEP, atto che
non è stato impugnato dai ricorrenti;
d) il giudizio è stato introdotto nella vigenza della legge 21 luglio 2000, n. 205,
il cui art. 7, comma 3°, lett.jb;, che ha sostituito l'art. 34, 1° e 2° comma, del
d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni .pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica
ed edilizia; tale materia concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio;
5. l'accertata illegittimità del provvedimento di sgombero e di demolizione
non inficia il procedimento espropriativi per cui non può trattarsi, né di
occupazione usurpativa, né di occupazione appropriativa, in quanto
l'immobile non incorpora un'opera pubblica, costituendo area acquisita
per l'utilizzo dell'indice di fabbricabilità;
6. l'accertata illegittimità dell'ordinanza potrebbe, al più, portare al
risarcimento del danno da atto illegittimo e la relativa domanda deve
essere proposta dinanzi al giudice amministrativo, che ha giurisdizione
esclusiva ai sensi dell'art. 35, 4° e 5° comma, del d.l.vo n. 80 del 1998,
così come sostituito dall'art. 7, comma 3°, della legge n. 205 del 2000.
§3. Motivi della decisione
3.1. Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi sulla questione di
giurisdizione in tema di responsabilità civile della p.a. connessa ad attività
provvedimentale.
L'argomento, a partire dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha dato origine,
com'è noto, ad un vasto dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, in
particolare dopo le decisioni di parziale illegittimità costituzionale pronunciate
dal giudice delle leggi con le sentenze 6 luglio 2004 n. 204 e 28 luglio 2004 n.
281, sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla
61
legge 21 luglio 2000, n. 205 ("'Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa"): decisioni alle quali si è di recente aggiunta la sentenza 3
maggio 2006 n. 191, con cui è stato dichiarato in parte illegittimo l'art. 53,
comma 1, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 ("Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità").
Orbene, due sono gli aspetti di questo tema, cui le sezioni unite sono chiamate
a dare risposta: come, dopo la legge 205 del 2000, è ripartita tra giudice
ordinario e giudice amministrativo la tutela giurisdizionale intesa a far valere la
responsabilità della p.a. da attività provvedimentale illegittima; se la parte si
può limitare a chiedere il risarcimento del danno, senza dover anche chiedere
l'annullamento e quale sia il regime di tale diversa forma di tutela
giurisdizionale, una volta che la si ammetta.
E, per una corretta impostazione del problema - sia sulle modifiche del riparto
di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, intervenute negli
anni dal 1992 al 2000, sia sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità
degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come novellati dall'art. 7 1. 21 luglio 2000, n. 205 - è opportuno prendere l'avvio
dalle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza 204, sui
lavori preparatori della Costituzione.
3.2. In quella sede, come ha osservato la Corte, si ribadì l' indispensabile
riassorbimento nella Costituzione dei principi fondamentali della l. 20 marzo
1865, n. 2248, ali. E", ispirati al principio dell'unità della giurisdizione, ma vi
emerse il contrasto tra la tesi - perdente - a favore del giudice unico
("l'esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e amministrativa
appartiene esclusivamente ai giudici ordinari") e quella vincente, per il
mantenimento di giudici diversi da quelli ordinari, quali Consiglio di Stato e
Corte dei conti ("una divisione dei vari ordini di giudici . . . ognuno dei quali fa
parte a sé").
La regola tradizionale del riparto della giurisdizione - se si tratta di diritti
soggettivi la giurisdizione è del giudice ordinario, se é fatto valere un interesse
legittimo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo - trova il proprio
antecedente storico e logico negli artt. 2 e 4 1. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E,
tuttora vigenti. Se la legge è uguale per tutti, anche per la p.a., il cittadino che
ha subito un pregiudizio ad un suo diritto può rivolgersi al giudice ordinario e il
giudice si limiterà a conoscere gli effetti dannosi dell'atto amministrativo, senza
sindacare le scelte discrezionali, del tutto autonome, della p.a.
La legge del 1865 realizza così il principio dell'unità della giurisdizione, ma
questa regola si rivelerà non idonea ad assicurare una tutela adeguata al
cittadino, sia per la grande quantità di controversie che la legge abolitiva del
contenzioso riservava all'autorità amministrativa, così sottraendola al sindacato
giurisdizionale, sia per una certa timidezza del giudice ordinario nel dare
applicazione ai principi sanciti dall'allegato E della legge del 1865.
È in questa situazione che, nel 1889, si registra la scelta per l'introduzione del
sindacato sugli atti amministrativi da parte di un organo consultivo, il Consiglio
di Stato, la cui natura giurisdizionale viene poi esplicitamente affermata con la
legge n. 642 del 1907 istitutiva della V Sezione del Consiglio di Stato.
62
L'area delle situazioni tutelabili davanti a un giudice è in tal modo ampliata.
L'assetto così realizzato trova conferma nel t.u 26 giugno 1924, n. 1054 sul
Consiglio di Stato.
Questo assetto non viene d'altro canto inciso dalla introduzione della
"giurisdizione esclusiva".
La giurisdizione sui diritti è devoluta al Consiglio di Stato in casi tassativamente
enumerati, a conferma della regola generale posta alla base del riparto.
Si tratta di una giurisdizione esclusiva, obiettivamente diversa, allora, da quella
voluta dal legislatore in questi ultimi anni.
Limitata a pochi "casi di confine", la sua introduzione è spiegata con la
difficoltà di distinguere nell'aggrovigliato intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi, anche se la sua introduzione stava ad indicare un chiaro
recupero della logica propria del contenzioso amministrativo abolito nel 1865.
Tale è l'assetto cristallizzato nella Costituzione del 1948, che all'art. 24 dà
riconoscimento sostanziale alla tutela sia del diritto soggettivo che dell'interesse legittimo e mentre all'art. 103, primo comma, limita la giurisdizione del
giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi alle "particolari materie" indicate dalla legge, nell'art. 113 rimette alla legge di indicare il giudice che può
annullare l'atto amministrativo e le conseguenze dell'annullamento.
Questo assetto continua a riflettersi nella legislazione successiva, sino al d. lgs.
31 marzo 1998, n. 80.
Invero, come nei nove "particolari" casi enucleati nell'art. 8 r.d. 30 settembre
1923, n. 2840 (ribaditi negli artt. 29 del t.u. 1054 del 1924 e 7 della l. 1034
del 1971) così in quelli successivamente introdotti (tra gli altri: art.11 l.
1185/1967; art. 16 l. 10/1977; art. 35 1. 47/1985; art. 11 l. 210/1985; artt.
11 e 15 l. 241/1990; art. 33.1. l.287/1990; art. 7.11. d.lgs. 74/1992; art.4.7.
1. 109/1994; art. 2.25. l. 481/1995; art. 1.26. l. 249/1997), sono sempre
rimaste riservate al giudice ordinario le questioni attinenti ai diritti patrimoniali
conseguenziali, compreso il risarcimento del danno.
Ma, vale la pena dì notarlo, è in questo assetto normativo che la
giurisprudenza
ha
nel
tempo
elaborato,
e con costanza applicato, i principi dell'irrisarcibilità dell' interesse legittimo,
della degradazione del diritto ad interesse e della pregiudizialità
amministrativa.
Sicché non sarà senza ragione, se questo assetto normativo ed il bagaglio dei
concetti che sono valsi a dargli spiegazione, apparirà richiedere modifiche, una
volta che si affermerà, con il d. lgs. SO del 1998, la contraria regola della
risarcibilità dell'interesse legittimo.
3.3. Facendo un passo indietro e tornando al riparto delle giurisdizioni, va
detto che il dibattito restava aperto, non tanto sull'ubi consistam del riparto,
non più contestato, quanto sull'esatta individuazione dei rispettivi territori, dei
diritti e degli interessi, che non vivevano in mondi separati, poiché gli uni e gli
altri costellavano il rapporto tra privato e p.a., vagando da un rapporto di
coesistenza ad uno di successione, in situazioni dal confine incerto, a volte
dubbio, di "facile trapasso" (Cass., sez. un., 5 dicembre 1987 n. 9095 e 9096).
Il sistema - al di là di qualche decisione provocatoria della Cassazione, rimasta
isolata (Cass., sez. I, 3 maggio 1996 n. 4083), o di eccezioni di incostituzio-
63
nalità, poi disattese (Corte cost., 8 maggio 1998 n. 165) - è durato dal 1865
fino al 1992 (un periodo lungo ben 127 anni).
A metterlo in crisi sono stati i principi comunitàri in tema di appalti pubblici di
lavori o forniture.
L'introduzione di una fattispecie di risarcibilità degli interessi legittimi lesi, in
violazione del diritto comunitario, viene alla luce con l'art. 13 1. 19 febbraio
1992, n. 142 (legge comunitaria del 1991).
In attuazione della direttiva del consiglio Ce n. 665/89 del 21 dicembre 1989,
si riconosceva, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, la possibilità di
ottenere, dopo L'annullamento dell'atto lesivo da parte del giudice
amministrativo, il risarcimento del danno dal giudice ordinario.
Tuttavia, l'itinerario da percorrere apparve subito particolarmente gravoso, in
quanto si obbligava il privato ad adire prima il giudice amministrativo per l'annullamento e, poi, il giudice ordinario per il risarcimento del danno, così
mettendo in discussione il principio di effettività della tutela giurisdizional/e
sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Il legislatore italiano, in un primo tempo, estese la norma anche agli appalti dei
settori esclusi (art. 11 l. 19 dicembre 1992, n. 489) e poi agli appalti di servizi
(art. 11, lett. i) , l. 22 febbraio 1994, n. 146: legge comunitaria per il 1993),
ma, per negare la valenza dirompente sul precedente riparto, si preferì
considerarla una norma di settore e non di portata generale" (Cass., sez. un.,
20 aprile 1994 n. 3732). Di qui un deciso cambiamento di rotta con la
soppressione del richiamo dell'art. 13 della legge 142 del 1992 contenuto nel
terzo comma dell'art. 32 l. 11 febbraio 1994, n. 109, per effetto della novella
introdotta dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modifiche nella l. 2
giugno 1995, n. 216.
La rivoluzionaria disposizione" è stata infine espressamente abrogata
dall'ultimo comma dell'art. 35 d. lgs. 80 del 1998 (divenuto ultimo comma
dell'art. 7 1. 205 del 2000), insieme con ogni altra disposizione che prevede la
devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno
conseguente all'annullamento di atti amministrativi".
Si può dunque dire, per un verso, che la disposizione introdotta con la l. 142
del 1992 ha contribuito a smantellare il precedente sistema orientato ad evitare il risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo; e per altro verso
che per il suo mezzo sono state poste le premesse perché la Corte
costituzionale sìa stata indotta a riconoscere nella concentrazione delle tutele
dinanzi allo stesso giudice una piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.
3.4. È nel quadro sino ad ora descritto che il legislatore di fine secolo introduce
una nuova specie di giurisdizione esclusiva, separata anche dalla giurisdizione
di legittimità e ancorata a "settori" dell'ordinamento pubblico, con rilevante
presenza di un pubblico interesse.
Il Governo con il d. lgs. 80 del 1998 - anche superando i limiti della delega
conferita dall'art. 11, comma 4, lett. g), l. 15 marzo 1997, n. 59 - e, dopo la
dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost., 17 luglio 2000, n. 292), il
Parlamento con la 1. 205 del 2000, attribuiscono i ''settori particolari" degli appalti e servizi pubblici nonché dell'edilizia e urbanistica ad una "nuova*'
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa anche ai diritti
patrimoniali conseguenzialì e al risarcimento del danno.
64
Il legislatore, inoltre, estende la nuova giurisdizione non solo alle vecchie
ipotesi di "servizi pubblici, edilizia ed urbanistica", ma a qualsiasi fattispecie di
giurisdizione esclusiva vecchia o nuova.
Si porta a compimento l'indirizzo che vede nella giurisdizione esclusiva "il ramo
più fertile e cioè più proiettato nel futuro della giurisdizione amministrativa ".
Nel contempo, la risarcibilità dell'interesse legittimo, già prevista dal d. lgs. 80
del 1998 (ma ricondotta dalle sentenze della Corte costituzionale 292 del 2000
e 281 del 2004 nei limiti della delega conferita con la 1. 59 del 1997) è estesa
all'intero ambito delle situazioni giuridiche giustiziabili davanti al giudice
amministrativo.
3.5. In conclusione, l'ordinamento ha ora accolto il principio della risarcibilità
della lesione dell'interesse legittimo in conseguenza dell'illegittimità dell'atto
amministrativo, prevedendo - in attuazione della regola della concentrazione che il giudice amministrativo può conoscere di tutte le questioni relative
all'eventuale risarcimento del danno e disporlo.
3.6. Il tessuto normativo che è alla base della soluzione da adottare si può così
sintetizzare.
L'art. 35 del d. lgs. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lettera e), della
legge 205 del 2000, nel comma 1 stabilisce che "Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto".
Il citato articolo, nel comma 4 (sostituendo il primo periodo del terzo comma
dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971), prevede che "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizio-ne, conosce anche di tutte
le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".
A sua volta, il comma 2 disciplina le modalità di determinazione della somma
dovuta, disponendo che " . . il giudice amministrativo può stabilire i criteri in
base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio
devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro
un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso
previsto dall'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione
della somma dovuta."
3.7. La dichiarazione di incostituzionalità non ha colpito la normativa appena
ricordata; ha invece riguardato l'art. 7 della l. 205 del 2000 per la mancata
esclusione dall'ambito della giurisdizione esclusiva delle controversie "nelle
quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità", con il ritorno alla dicotomia "diritti soggettivi - interessi
legittimi", ripudiando il diverso criterio dei "blocchi di materie" che mirava a
trasformare il giudice amministrativo nel "giudice dell' amministrazione".
Si afferma in proposito che la giurisdizione esclusiva introdotta dalla l. 205 del
2000 appare configgere con i parametri costituzionali ed è qualitativamente
diversa dalla precedente, che riguardava specifiche controversie "connotate
non già da una generica rilevanza pubblicistica, bensì dall'intreccio di situazioni
soggettive qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi".
65
Si precisa che l'adozione, da parte del legislatore del 1998-2000, di un'idea di
giurisdizione esclusiva, ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo
settore dell'ordinamento, di un rilevante pubblico interesse, avrebbe
presupposto la modifica dell'art. 103 Cosf. , mai approvata, nel senso che "la
giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la pubblica
amministrazione nelle materie indicate dalla legge" (Atto Camera 7465, XIII
Legislatura). Viceversa, il vigente art. 103, comma 1, Cost. non ha conferito al
legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità
nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare «particolari
materie», nelle quali, «la tutela nei confronti della pubblica amministrazione»
investe «anche» diritti soggettivi". Il collegamento delle "materie"
assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la
natura delle situazioni soggettive è espresso dall'art. 103 Cost. laddove
statuisce che quelle materie devono essere "particolari" rispetto a quelle già
devolute alla giurisdizione generale di legittimità, in cui la p.a. agisce come
autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al
giudice amministrativo.
In conclusione, il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della
giurisdizione esclusiva, ma con riguardo a "materie particolari" in cui la
giurisdizione naturale sugli interessi attrae la cognizione dei diritti concorrenti e
strettamente connessi. Ciò comporta che la mera partecipazione della p.a. al
giudizio non è sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice
amministrativo - "il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice
«della» pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo
comma, Cost." - e, inoltre, non è sufficiente "il generico coinvolgimento di un
pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al
giudice amministrativo".
Sono, pertanto, sottratte alla funzione unificante della Corte di cassazione le
sole pronunce che investano i diritti soggettivi nei confronti dei quali, nel
rispetto della "particolarità" della materia nel senso sopra chiarito, il legislatore
ordinario abbia legittimamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo su diritti e interessi, nonché quelle che riguardano le forme di
tutela che il giudice amministrativo ritenga di accordare all'interesse legittimo.
3.8. Si tornerà sulle conseguenze che, dalle precedenti affermazioni di
principio, la Corte ha tratto a proposito del modo in cui il legislatore ha
configurato le materie di giurisdizione esclusiva delineate negli artt. 33 e 34 del
d. lgs. 80 del 1998 modificati dalla l. 205 del 2000: punto sul quale la Corte si
è ancora soffermata nella sentenza 191 del 2006 a proposito del ruolo che, nel
campo dell'espropriazione, assumono comportamenti volti alla anticipata
realizzazione di opere, pur sempre dichiarate di pubblica utilità.
3.9. Qui interessa soffermarsi sul punto che la dichiarazione di
incostituzionalità non ha investito le disposizioni contenute nell'art. 35 del d.
lgs, 80 come riformulate dall'art. 7, lett. e), della l. 205 del 2000.
La Corte ha osservato che "il potere riconosciuto al giudice amministrativo di
disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia»
attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore,
66
rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per
rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione".
Su questa parte della motivazione della sentenza 204, la Corte è tornata nella
sentenza 191 di questo anno.
Ha in particolare considerato come sia da escludere che "per ciò solo che la
domanda proposta dal cittadino abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del
danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario": ed ha osservato che dove
la legge - come fa l'art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 - costruisce il risarcimento
del danno, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, come strumento di tutela affermandone - come è stato detto il carattere «rimediale», essa non viola alcun precetto costituzionale e, anzi,
costituisce attuazione del precetto dell'art. 24 Cost. laddove questo esige che
la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia resa in tempi ragionevoli".
In altri termini" - ha osservato la Corte - al precedente sistema che, in
considerazione
della
natura
intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente
all'annullamento del provvedimento amministrativo, attribuiva al giudice
ordinario «le controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi» (così l'art, 35, comma 5, del d. lgs. n.
80 del 1998, come modificato dell'art. 7, lett. e della legge n. 205 del 2000) il
legislatore ha sostituito (appunto con l'art. 35 cit.) un sistema che riconosce
esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione
pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di
risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per
l'illegittimo esercizio della funzione".
13.10. Il lungo cammino sin qui percorso nel ricostruire la vicenda normativa è
valso a rendere intelligibile quale si debba oggi considerare il punto d'arrivo
nella ricerca della soluzione del primo degli aspetti segnalati all'inizio,
ovverosia in base a quali criteri si trovi oggi ad essere stabilito il riparto tra le
giurisdizioni.
Rilevano a questo fine due momenti ed in particolare la situazione soggettiva
del cittadino considerata nel suo aspetto statico e gli effetti che l'ordinamento
ricollega all'azione amministrativa una volta che questa sia esercitata.
La tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione
spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti
compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo
sopporti, quante volte l'azione della pubblica amministrazione non trovi
rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come
tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti
per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.
A questo fine, si ritiene che vada richiamato il principio di diritto affermato
dalla Corte costituzionale nella sentenza 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal
collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le
forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che
nella giurisdizione di annullamento.
Il che non si verifica quando l'amministrazione agisca in posizione di parità con
i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile
67
a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito
ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come
indiretto ascendente della vicenda.
Esemplificando, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice
ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla
lesione di diritti incomprimibili, come la salute (Cass. 7 febbraio 1997 n. 1187;
8 agosto 1995 n. 8681; 29 luglio 1995 n. 8300; 20 novembre 1992 n. 12386;
6 ottobre 1979 n. 5172) o l'integrità personale.
Deve ancora essere convenuta davanti al giudice ordinario, quante volte la
lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (Cass. 29 luglio 2005
n. 15916; 2 maggio 2003 n. 6719): qui si è nell'ambito delle controversie
meramente risarcitorie già contemplate nell'art. 33, comma 2, d. lgs, 80 del
1998, nel testo anteriore alla riformulazione attuatane con la sentenza 204 del
2004, la cui previsione non è più necessaria, nella misura in cui in esse è
ravvisabile, più in generale, la reazione a meri comportamenti lesivi
dell'amministrazione.
Nel settore delle occupazioni illegittime, sono poi chiaramente ascrivibili alla
giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa", caratterizzate dal
tratto, che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione
in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto.
E alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso in cui il decreto di
espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione a bene, la cui
destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta
giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta
scadenza del suo termine d'efficacia.
Dove per contro la situazione soggettiva, nei termini che si sono indicati, si
presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria ne va chiesta al giudice
amministrativo.
Conviene a tale riguardo soffermarsi su alcune fattispecie la cui classificazione
ha sin qui dato luogo a discussione ed il cui tratto peculiare si rinviene nella
circostanza che oggetto della domanda non è l'annullamento di un atto, ma
appunto solo il risarcimento del danno.
Riconducibili alla giurisdizione del giudice amministrativo appaiono i casi in cui
la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato è postulata come
conseguenza d'un comportamento inerte, si tratti di ritardo nell'emissione di un
provvedimento risultato favorevole o di silenzio.
Ciò che viene qui in rilievo è bensì un comportamento, ma il comportamento si
risolve nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato
all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse
legittimo pretensivo (Ad. pi. 15 settembre 2005 n. 7), non di un diritto
soggettivo.
Presenta analogie con questa situazione, quella valutata dalla Corte
costituzionale nella sua più recente decisione, dove parimenti l'accesso al
giudice amministrativo non è segnato da una domanda di annullamento, ma si
considera che ad attrarre la fattispecie nell'orbita della sua giurisdizione possa
valere la presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere: quel
68
potere, in particolare, che si è manifestato nella dichiarazione dì pubblica
utilità.
3.11. Resta da affrontare quello che all'inizio si è indicato come secondo
aspetto problematico della tutela del cittadino di fronte all'attività
provvedimentale illegittima della pubblica amministrazione, ovverosia la
possibilità di domandare la sola tutela risarci toria.
Da quando nell'ordinamento si è preso a considerare risarcibile la lesione di un
interesse legittimo, è emerso il tema se il privato si possa limitare a rivendicare
per il diritto o l'interesse leso la sola tutela risarcitoria e quale possa essere il
trattamento processuale di tale domanda.
3.12, Sino alla più recente sentenza della Corte costituzionale, si erano
manifestate sul punto due posizioni ermeneutiche in assoluto contrasto tra
loro.
Secondo una prima, più diffusa opinione, "tutta amministrativa", il d. lgs. 80
del 1998 e la l. 205 del 2000 avrebbero attribuito, in via generale, al giudice
amministrativo la cognizione delle pretese di risarcimento del danno da atti
illegittimi della p.a., in sede di giurisdizione esclusiva (in virtù del comma 1
dell'art. 35) o di legittimità (in virtù del comma 4), che entrambe hanno ora
assunto il connotato di giurisdizione "piena".
In tal senso è apparso orientarsi il Consiglio di Stato, secondo cui la ratio della
riforma iniziata con il d.lgs. 80 del 1998 e completata con la legge 205 del
2000 è stata quella di concentrare davanti ad un unico giudice, quello
amministrativo, in coerenza con l'art. 24 Cost., ogni forma di tutela, anche risarcitola, nei confronti della p.a., quando viene in gioco la lesione di interessi
legittimi (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002 n. 3338/ Ad. plen. 26 marzo
2003 n. 4/ Ad plen, 30 agosto 2005 n. 8).
In particolare, alcune pronunce (Ad plen. 4 del 2003) hanno fatto propria la
tesi per cui le norme richiamate avrebbero previsto, come necessaria
condizione per l'accesso alla tutela risarcitoria, che nel termine di decadenza
per l'impugnazione fosse anche esperita con esito favorevole l'azione di
annullamento, ancorché la tutela risarcitoria possa essere richiesta non
insieme, ma successivamente.
Ciò in ragione del principio della ed. pregiudiziale amministrativa.
L'annullamento avrebbe dovuto essere richiesto in via principale nel termine di
decadenza, perché al giudice amministrativo non è consentita la cognizione
incidentale della illegittimità degli atti amministrativi né esso è munito del
potere di disapplicazione.
Consegue che, se la tutela di annullamento non è richiesta nel termine per
l'impugnazione del provvedimento, questo diviene inoppugnabile, precludendo
l'accesso non solo alla tutela risarcitoria erogabile dal giudice amministrativo,
ma anche a quella che potesse essere chiesta al giudice ordinario, facendo
valere l'atto illegittimo come elemento costitutivo dell'illecito civile (secondo la
sent. 500 del 1999 delle S.U.).
Il Consiglio di Stato aveva peraltro ammesso che l'azione risarcitoria potesse
essere proposta in taluni casi davanti al giudice amministrativo come domanda
autonoma (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002 n. 3338) .
E ciò, oltre che nei casi di danno da ritardo, in quelli in cui l'annullamento del
provvedimento vi sia già stato, ad opera dello stesso giudice amministrativo
69
(ad esempio in epoca in cui la giurisdizione amministrativa non era ancora una
giurisdizione "piena") od a seguito di annullamento su ricorso amministrativo o
straordinario o di annullamento di ufficio.
Nello scenario così delineato, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle
pretese risarcitorie del cittadino che si assume leso in una posizione giuridica
sostanziale (di diritto o di interesse legittimo) dall' esercizio illegittimo della
funzione amministrativa non dovrebbe concorrere con una, sia pur residuale,
giurisdizione del giudice ordinario. Ovvio che il giudice amministrativo, nato
come giudice dell'atto e non del rapporto, avrà non poche difficoltà a
distinguere il danno specie sotto il profilo della determinazione del quantum del
danno risarcibile: dovrà mutuare le regole civi-listiche sul concetto stesso di
danno come fatto, sul nesso di causalità, anche ipotetico (si pensi all'art. 1221
ce), sui criteri di valutazione ex art. 1223, 1225, 1226, 1227 co 1 (concorso di
cause) e co. 2 (danni evitabili con l'ordinaria diligenza) ce.
Una diversa ricostruzione, "tutta civilistica", è stata prospettata da parte della
dottrina, muovendo dai principi affermati dalla sent. 500 del 1999 delle S.U.
Punto di partenza ne è la qualificazione della pretesa risarcitoria come diritto
soggettivo, sia nei confronti del privato che della p.a., in una concezione che
nega rilevanza ai successivi interventi normativi, i quali non potrebbero
scalfire, con il mero collegamento processuale, la tutela sostanziale
riconosciuta al diritto soggettivo, nei confronti di chiunque azionato.
Si è mossi dalla considerazione che, secondo la Corte costituzionale, il potere
riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non
costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia» attribuita alla sua
giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico
demolitorio (e/o conformativo) , da utilizzare per rendere giustizia al cittadino
nei confronti della p.a.".
Il profilo di connessione processuale non avrebe escluso tuttavia che la tutela
sia apprestata ad una posizione sostanziale avente natura di diritto soggettivo:
il diritto al risarcimento del danno ingiusto.
Il danno ingiusto, determinato dalla lesione di un interesse giuridicamente
rilevante (sia esso diritto soggettivo o interesse legittimo: sent. 500 del 1999),
sarebbe fonte di una obbligazione di risarcimento (ex art. 2043 ce. o ex art.
1218 ce. secondo il possibile diverso atteggiarsi della responsabilità della p.a.)
mentre la parte che chiede il risarcimento aziona sempre un diritto soggettivo.
La sentenza 204 del 2004 della Corte costituzionale avrebbe, quindi, solo
negato che il novellato art. 35 abbia istituito una nuova giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo avente ad oggetto il diritto al risarcimento del
danno.
Il punto rilevante, nella decisione della Corte, sarebbe stato là dove si è
rilevato che l'attribuzione dell'ulteriore strumento della tutela risarcitoria,
venuto ad aggiungersi a quello classico della tutela di annullamento, è valsa a
configurare la giurisdizione del giudice amministrativo, in attuazione del
precetto dell'art. 24 Cost., come giurisdizione atta a garantire piena ed
effettiva tutela alle situazioni soggettive ad essa devolute, per evitare al
cittadino di doversi rivolgere a due diversi ordini di giudici, cioè a quello
amministrativo per conseguire prima l'annullamento e poi a quello ordinario
70
per ottenere il risarcimento del danno, come diritto patrimoniale
consequenziale.
E' stato messo in dubbio che la Corte abbia inteso riferirsi soltanto alla
giurisdizione esclusiva (art. 35, comma 1), ovvero anche a quella generale di
legittimità (art. 35, comma 4), ma si è considerato corretto attribuire ampia
valenza alla ravvisata estensione dei poteri del g.a. in entrambe le
giurisdizioni, che risultano quindi connotate da pienezza.
La Corte non si sarebbe peraltro in alcun modo espressa sulla natura del
risarcimento del danno.
Se, quindi, si tiene ferma la qualificazione del diritto al risarcimento del danno
ingiusto come diritto soggettivo, resterebbe valido il principio di ordine
generale secondo cui il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario (art. 2
della l.a.c.a).
Di qui la conseguenza che il giudice della tutela risarcitoria sarebbe stato, di
regola, il giudice ordinario.
A questa regola l'art. 35, commi 1 e 4, avrebbe apportato deroga (secondo il
criterio della connessione), col consentire che il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, possa disporre, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto e che nell'esercizio della sua giurisdizione (di legittimità) possa
conoscere di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno e
agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Non sarebbe stato tuttavia corretto sostenere che si tratti di una
concentrazione necessaria, con attrazione inscindibile della tutela risarcitoria al
seguito di quella di annullamento, in presenza di un atto amministrativo da
impugnare.
La concentrazione sarebbe infatti funzionale, in termini di pienezza ed
effettività della tutela, alle esigenze del cittadino che chiede giustizia nei confronti della p.a., e pertanto non la si potrebbe ritenere doverosa e tale da
dover essere praticata come unica via esclusiva.
Né, d'altra parte, sarebbe desumibile dal testo normativo - così come
interpretato costituzionalmente - che al riconoscimento, in positivo, al giudice
amministrativo del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto
(comma 1) e di conoscere delle questioni relative all'eventuale risarcimento del
danno (comma 4), si unisca, in negativo, la totale sottrazione di eguale potere
al giudice ordinario.
Il giudice amministrativo avrebbe potuto conoscere di questioni relative al
risarcimento del danno e, cioè, di questioni attinenti ad un diritto soggettivo la
cui cognizione è di regola attribuita al giudice ordinario, nel caso in cui il
cittadino si fosse avvalso della facoltà di richiedere a tale giudice la tutela
risarcitoria congiuntamente a quella di annullamento. In questa ipotesi, come è
stato osservato, le norme in esame realizzerebbero una deroga alla
giurisdizione per ragioni di connessione.
Si è ancora notato che la prevista concentrazione troverebbe giustificazione nel
tipo di tutela che, oltre a quella di annullamento, il giudice amministrativo può
somministrare: una "tutela ulteriore" che è di completamento rispetto a quella
primaria della quale postula l'esito positivo, nel senso che serve a rimuovere i
pregiudizi che l'annullamento non ha potuto eliminare.
71
E' per effetto della dipendenza della tutela ulteriore da quella di annullamento
che il giudice amministrativo può prendere in esame questioni relative al
risarcimento (ed agli altri diritti patrimoniali consequenziali) solo se gli è
richiesto e ritiene di concedere l'annullamento dell'atto lesivo.
Quanto alle conseguenze della omessa richiesta della tutela di annullamento
nel termine di decadenza, con conseguente inoppugnabilità dell'atto, si è
rilevato che la decadenza preclude la via della tutela di annullamento e, di
conseguenza, della tutela risarei-toria di completamento (da erogare nelle
peculiari forme di cui all'art. 35, comma 2) .
Non sarebbe invece precluso il ricorso alla sola tutela risarcitoria.
Si è rilevato, infatti, che in un sistema in cui al cittadino sono riconosciuti sia la
tutela di annullamento, sia quella risarcitoria (e questa nella duplice
connotazione di tutela di completamento che al g.a. è dato somministrare ex
art, 35, comma 2, e di tutela risarcitoria secondo le regole del diritto civile),
non necessariamente le due forme di tutela debbono essere spese entrambe.
Se il danneggiato dall'esercizio illegittimo del potere amministrativo non si
vuole avvalere, non avendone interesse, della tutela costitutiva di annullamento del provvedimento lesivo della sua posizione giuridica sostanziale, ma
ritiene, invece, conforme al suo concreto interesse avvalersi della sola tutela risarcitoria, potrà farlo, in via autonoma, davanti al giudice ordinario.
Quest'ultimo non dovrà giudicare in via incidentale della legittimità dell'atto, in
funzione della sua disapplicazione (art. 4, comma 1, l.a.c.a.), ma dovrà valutare il provvedimento solo come fatto, come elemento costitutivo dell'illecito.
Non si porrebbe un problema di pregiudizialità in senso tecnico, poiché tale
problema si poneva solo quando, prima della sentenza n. 500 del 1999, era
necessario attendere l'annullamento per poter risarcire il danno arrecato dal
sacrificio di situazioni di diritto degradato ad interesse. Una volta riconosciuto
che la lesione dell'interesse protetto obbliga anche la p.a. al risarcimento del
danno, è venuto meno il nesso di dipendenza della risarcibilità dal previo annullamento dell'atto.
Nelle ipotesi in cui l'annullamento non fosse stato chiesto, potrebbe
eventualmente porsi un problema attinente al merito della decisione, sotto il
profilo se nel danno risarcibile rientri la situazione determinata dal
provvedimento di cui non si sia voluto do-mandare l'annullamento.
Nelle ipotesi in cui l'annullamento sia stato già disposto dallo stesso giudice
amministrativo (in epoca in cui la giurisdizione amministrativa non era ancora
una giurisdizione "piena"), a seguito di ricorso straordinario, o d'ufficio, ovvero
nel caso in cui manchi l'atto, come avviene per il danno da ritardo, si sarebbe
potuto egualmente adire per la tutela ri-sarcitoria il giudice ordinario, poiché
l'estensione della cognizione del giudice amministrativo alle questioni relative
al risarcimento postula che la relativa tutela sia stata richiesta congiuntamente
a quella di annullamento.
3.13. La sopravvenuta decisione della Corte costituzionale spiana la strada e
indirizza la scelta verso la concentrazione della tutela risarcitoria presso il
giudice amministrativo, ma lascia impregiudicato il punto del trattamento
processuale della tutela risarcitoria.
3.14. Le Sezioni unite - nell'esercizio della funzione di riparto della
giurisdizione (artt. 31, 41, 360 n. 1, 362 c.p.c; art. 37, secondo comma, L. 11
72
marzo 1953, n. 87) ad esse attribuito dal nuovo codice di rito (dopo la
soppressione del Tribunale dei conflitti, istituito con L. 31 marzo 1877, n.
3761, ed. legge Mancini-Peruzzi) - ritengono che sia necessario accedere ad
una soluzione, che, mentre tiene conto dei principi costituzionali che legano la
tutela giurisdiziona le offerta dai due ordini di giudici alle situazioni soggettive,
alla luce del criterio enunciato dall'art. 103 Cost., fa propri i valori di effettività
e concentrazione delle tutele sottesi all'art. Ili Cost. - e in particolare al
principio della ragionevole durata dei processi - che la Corte costituzionale ha
assunto come criterio-guida di interpretazione delle altre norme in materia di
giustizia.
3.15. In quest'ottica, va adeguatamente ricordato che alla tutela risarcitoria
dell'interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione questa
Corte è pervenuta non già estendendo la detta tutela dai diritti soggettivi agli
interessi legittimi, bensì affermando che, sul piano della tutela risareitoria, non
si può fare differenza tra interessi che trovano protezione diretta
nell'ordinamento
e
interessi
che
trovano
protezione
attraverso
l'intermediazione del potere amministrativo.'
Questa svolta - che cancella sul piano sostanziale, con riferimento alla tutela
risarcitoria, il divario tra diritti ed interessi altrimenti rilevanti - matura in un
momento storico in cui il legislatore ha imboccato la strada che lo porterà a
configurare la giurisdizione del giudice amministrativo come una giurisdizione
piena ed esige, di conseguenza, che sia data una più coerente lettura al
sistema del riparto di giurisdizioni, in particolare una lettura che leghi la
potestas iudicandi alla natura della situazione soggettiva.
La tesi "tutta civilistica" non può essere condivisa allorché disattende la svolta
voluta dal legislatore di assicurare all'interesse legittimo una tutela piena,
concentrata dinanzi a un unico giudice per il principio di effettività che reca in
sé la ragionevolezza dei tempi di tutela.
La soluzione, fatta propria dal legislatore del 2000 e in linea con la portata di
"norma di sistema" riconosciuta dalla Corte costituzionale all'art. 24 Cost. con
la sentenza 204 del 2004, da ultimo ribadita, è coerente con la riaffermazione
del criterio tradizionale del riparto fondato non sulla distinzione tra le tecniche
di tutela, bensì sulla natura sostanziale delle situazioni soggettive.
D'altra parte, questa ricostruzione è coerente anche con il processo di
evoluzione che caratterizza l'interesse legittimo, che va perdendo la sua
tradizionale funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all'interesse
pubblico, per assumere un più marcato connotato sostanziale, coerentemente
del resto con l'evoluzione della stessa nozione di interesse pubblico, al cui
perseguimento si accompagna un aumento della discrezionalità, ma anche
della connessa responsabilità dell' amministrazione.
Deriva da ciò che - in linea di principio e salvo quanto si è già considerato - la
giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo non può che spettare al giudice
amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche
della tutela risarcitola, in forma specifica o per equivalente: tecniche che non
possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della
giurisdizione.
3.16. Del pari non può essere condivisa la soluzione ed. "amministrativa",
dove, da una parte, pone un nesso inscindibile, non richiesto dalle norme di
73
legge né dal quadro costituzionale, tra tutela di annullamento e tutela
risarcitoria (Ad. Plen. n. 4 del 2003), dall'altra, sembra ricomprendere nella
giurisdizione amministrativa ogni contesto caratterizzato dalla presenza della
funzione pubblica senza esigere che di tale funzione si sia avuto un concreto
esercizio, nei modi e forme tipici del potere amministrativo, che soli consentono di riconoscere l'atto come espressione di un potere esistente.
Dal primo punto di vista non è privo di rilievo il considerare che la teoria della
pregiudizialità amministrativa, intesa come dipendenza del diritto al risarcimento dal previo annullamento, era maturata in un contesto nel quale da un
lato si escludeva la risarci-bilità del pregiudizio sofferto per il sacrificio di
situazioni di interesse legittimo, dall'altro si era omologato al trattamento di
questa situazione quella del diritto soggettivo degradato ad interesse.
Né è senza importanza considerare che la soggezione a termine di decadenza è
prevista dalla legge per l'azione di annullamento e, in questo sistema,
l'accertamento incidentale dell'illegittimità viene negato non solo per escludere
che vizi prima non rilevati possano esserlo dopo dando luogo all'annullamento
di provedimenti che presuppongonio quello non impugnato, ma anche perché
gli effetti dell'azione di annullamento non si esauriscono nel rapporto tra
amministrazione e soggetto leso e, ben spesso, si rifrangono su altri soggetti in
conflitto con chi sollecita l'annullamento.
Ma, non di questo si tratta quando non l'annullamento dell'atto è preteso,
bensì l'accertamento della illiceità della situazione determinata dalla sua
adozione ed esecuzione, accertamento che esaurisce la sua rilevanza nel
rapporto tra soggetto leso e pubblica amministrazione.
Queste considerazioni, unitamente ai ricordati processi di cambiamento che
caratterizzano l'interesse legittimo e la sua relazione con l'interesse pubblico,
giustificano ampiamente l'abbandono di un approccio di tipo tradizionale.
Ammettere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento
dell'atto illegittimo e dannoso, anziché dal solo accertamento della sua illegittimità significherebbe restringere la tutela che spetta al privato di fronte alla
pubblica amministrazione ed assoggettare il suo diritto al risarcimento del
danno, anziché alla regola generale della prescrizione, ad una Verwirkung
amministrativa, tutta italiana.
La conclusione da accogliere è dunque che, dopo l'irruzione nel mondo del
diritto della risarcibilità -effettiva e non solo dichiarata - anche dell'interesse
legittimo, e dopo i ricordati tentativi dei primi anni novanta della doppia tutela
(espressamente abrogata sia dall'art. 35 d. lgs. 80 del 1998 sia dall'art. 7, lett.
e), della 1. 205 del 2000), il legislatore di fine secolo non ha inteso ridurre la
tutela risarcitoria al solo profilo di completamento di quella demolìtaria, ma,
mentre l'ha riconosciuta con i caratteri propri del diritto al risarcimento del
danno, ha ritenuto di affidare la corrispondente tutela giudiziaria al giudice
amministrativo, nell'intento di rendere il conseguimento di tale tutela più
agevole per il cittadino.
3.17. In definitiva, si può affermare che entrambe le tesi su esposte ("tutta
civilistica" e "tutta amministrativistica") conducono ad una possibile diminuzione dell'effettività della tutela del cittadino, in violazione dei principi derivanti
dall'art. 24 Cost.
74
Quella civilistica, perché finisce per frammentare o moltiplicare le sedi e i tempi
della tutela giurisdizionale, per giunta secondo una direttrice che si allontana
dalla regola del riparto.
Quella amministrativistica, perché rischia di assicurare all'interesse legittimo
una protezione che comprime l'ambito della tutela risarcitoria riducendone, per
modalità o contenuti, la portata.
Essa altresì, secondo alcuni svolgimenti già segnalati, finisce con l'estendere
l'area della giurisdizione amministrativa al di là della connessione con
l'esercizio in concreto del potere pubblico.
In una situazione del genere, l'osservazione secondo la quale il legislatore del
2000 ha opportunamente concentrato le forme di tutela dell'interesse legittimo
in una sola seóe giudiziaria deve essere accompagnata dalla consapevolezza
della perdurante vigenza degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, ali. E,
che configurano comunque a tutela del cittadino la giurisdizione ordinaria come
presidio per tutte le materie in cui si faccia questione "di un diritto civile o politico".
Il nostro sistema si basa appunto sull'art. 2907 ce, cui fa riscontro l'art. 99
c.p.c, ed è un sistema di civil lavi, in cui il riconoscimento della posizione
soggettiva da tutelare, cristallizzata dal riconoscimento costituzionale (artt. 24
e 113 Cost.), precede la tutela giurisdizionale.
In un sistema del genere, l'art. 2 della legge del 1865 - secondo una lettura
coerente con le disposizioni di cui al Titolo IV della Costituzione - costituisce, in
definitiva, una norma di chiusura del sistema, che attribuisce al giudice
ordinario il potere-dovere di assicurare la pienezza della tutela, quando altri
valori di pari rilievo costituzionale non rendono legittimo il ricorso a diversi
modelli di tutela.
3.18. Quante volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica
amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del
destinatario del provvedimento e l'atto sia capace di esplicare i propri effetti
perché il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la
tutela giudiziaria deve dunque essere chiesta al giudice amministrativo.
Gli potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la
tutela risarcitoria completiva.
Ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela
risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente
all'azione di annullamento.
3.19. A proposito di questo secondo enunciato, merita da un lato soffermarsi
qui sulle considerazioni, già svolte, che hanno condotto a questa
interpretazione delle norme attributive della giurisdizione e dall'altro renderne
esplicite le conseguenze.
Si è notato che, in rapporto alla tutela risarcito-ria, è venuta meno sul piano
del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell'ordinamento trovano protezione.
L'evoluzione dell'ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi
legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele: com'era stato per le situazioni
di diritto soggettivo, di norma dotate, oltre che di tutela risarcitoria, anche di
una tutela ripristinatoria, completata dal diritto al risarcimento del danno, così
per gli interessi legittimi una tutela risarcitoria autonoma è stata affiancata alla
75
tutela reale di annullamento, la sola di cui le situazioni di interesse legittimo
erano prima dotate, e la tutela di annullamento è stata inoltre conformata in
modo da comprendervi il risarcimento del danno, che con l'annullamento non si
può elidere.
Se dal piano delle forme di tutela ci si sposta a quello del riparto della funzione
di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi nei confronti della pubblica
amministrazione, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme
che hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sul risarcimento
del danno, consente di riconoscere loro la portata d'avere dato al giudice
amministrativo giurisdizione anche solo in rapporto alla tutela risarcitoria
autonoma.
Ma ciò perché, nel bilanciamento tra valori rilevanti sul piano costituzionale, è
da riconoscere legittimità ad una norma che mentre concentra la tutela
giurisdizionale presso il giudice amministrativo, non reca pregiudizio alla tutela
sostanziale delle situazioni soggettive sacrificate dall'agire illegittimo della
pubblica amministrazione.
D'altra parte, questa interpretazione è la sola che riesce a rendere operanti
insieme, per le situazioni soggettive di cui ora ci si occupa, il valore della
giurisdizione piena e quello di una tutela sostanziale degli interessi legittimi
non difforme da ogni altra situazione protetta in rapporto alla tutela risarcitoria.
Sicché dalla premessa discende in modo necessario la conseguenza che il
giudice amministrativo non possa, allo stato della legislazione, se non
esercitare la giurisdizione, che le norme gli attribuiscono quanto alla tutela
risarcitoria autonoma, prescindendo dalle regole proprie della giurisdizione di
annullamento.
Si può obiettare, che è nella disponibilità del legislatore disciplinare la tutela
delle situazioni soggettive assoggettando a termini di decadenza l'esercizio
dell'azione.
Tuttavia, una norma che oggi manca e che in modo esplicito assoggettasse ad
un termine di decadenza la domanda di solo risarcimento del danno davanti al
giudice amministrativo non potrebbe essere formulata nel senso di rendere il
termine sostanzialmente eguaio a quello cui è soggetta la domanda di
annullamento, perché ciò varrebbe a porre il diverso problema della legittimità
di una disciplina che tornasse a negare la tutela risarcitoria autonoma per le
situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere della
pubblica amministrazione.
Resta da esplicitare un altro aspetto che inerisce in modo necessario all'avere
affermato che l'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha dato al giudice
amministrativo la giurisdizione sulla domanda autonoma di risarcimento del
danno.
Tutela risarcitoria autonoma delle situazioni di interesse legittimo significa
tutela che spetta alla parte per il fatto che la situazione soggettiva è stata
sacrificata da un potere esercitato in modo illegittimo e la domanda con cui
questa tutela è chiesta richiede al giudice di accertare l'illegittimità di tale
agire.
Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla inoppugnabilità
del provvedimento né il diritto al risarcimento può essere per sé disconosciuto
76
da ciò che invece concorre a determinare il danno, ovverosia la regolazione che
il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica
amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità.
Dunque, il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti
indicati, si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per motivi
attinenti alla giurisdizione, il giudice amministrativo avrà infatti rifiutato di
esercitare una giurisdizione che gli appartiene.
3.20. Al termine di questo lungo excursus, i principi di diritto enunciati da
queste Sezioni Unite sono i seguenti:
1. la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un
concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al
procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme
che lo regolano;
2. spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che
l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate
dall'esercizio illegittimo del potere e tra queste forme di tutela rientra il
risarcimento del danno;
e) il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua
decisione, a norma dell'art. 362, primo comma c.p.c., si presta a cassazione da
parte delle sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame
del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la
ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento
dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.
3.21. Applicando tali principi nel caso di specie, deve ritenersi che la domanda
risarcitoria proposta nella presente causa deve ritenersi devoluta al giudice
amministrativo, in quanto la condotta causativa di danno si riconnette
direttamente all'esercizio di attività provvedimentale ( approvazione del PEEP,
occupazione d'urgenza, ordinanza di sgombero e demolizione del fabbricato ) .
Secondo le nuove regole sul riparto della giurisdizione e i principi affermati
dalla Corte Costituzionale, l'azione risarcitoria deve essere esercitata
esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo, anche se i provvedimenti
dell'amministrazione - la cui emanazione ed esecuzione hanno causato danni,
siano essi consistenti in lesione di diritti o d'interessi legittimi - sono stati
annullati dallo stesso giudice in sede di giurisdizione di legittimità o a seguito di
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
L'attuazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di
concentrazione della tutela comporta che anche quella di tipo risarcitorio deve
essere necessariamente, ed esclusivamente, attribuita al giudice cui è
attribuita giurisdizione sulla legittimità dell'atto, giurisdizione che non può
subire alcuno spostamento, a favore del giudice dei diritti soggetti vi, per
l'effetto retroattivo - ripristinatorio dell' annullamento.
Poiché i provvedimenti causativi di danno sono stati annullati in sede
giurisdizionale o di ricorso amministrativo non si pongono, ai fini della
decisione sulla giurisdizione nella presente causa, i problemi connessi alla
regola della pregiudizialità amministrativa.
La complessità e novità della questione giustificano una pronuncia di
compensazione delle spese.
77
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite; dichiara la giurisdizione del
giudice amministrativo; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del le Sezioni Unite civili, il 15
giugno 2006
78
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA 28 MARZO 2006, N. 7028
Fatto e Diritto
Svolgimento del processo
T.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di
Bari, confermativa della statuizione di primo grado, con la quale è stata accolta
la domanda di revoca, ex art. 67 L. Fall., comma 2, nei suoi confronti proposta
dal curatore del fallimento di G.M., in relazione alla vendita, per il prezzo di L.
160.000.000, di un locale commerciale effettuata, in favore di esso T., dal G.,
nell'anno anteriore alla dichiarazione del di lui fallimento.
Con i due motivi dell'odierna impugnazione - illustrati anche con memoria e
resistiti dalla curatala con controricorso - il T. ha denunciato violazione del
citato art. 67 L. Fall. e vizi di motivazione in ordine, rispettivamente, alla
revocabilità del negozio in questione - erroneamente, a suo carico,
presupposta dalla Corte di merito, non ostante l'intervenuta destinazione di
parte del correlativo prezzo (L. 98.000,000) alla estinzione di un credito
assistito da ipoteca sull'immobile compravenduto - ed alla scientia decoctionis,
che quei giudici avrebbero, del pari erroneamente, ritenuto nella specie
sussistente.
Con ordinanza interlocutoria n. 193 del 5 gennaio 2005, la Sezione 1^ di
questa Corte - previamente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso
formulata dalla controparte in ragione del dedotto difetto di firma dell'avvocato
- ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha quindi assegnato la causa a
queste Sezioni unite, per una ravvisata "non consonanza di indirizzi
giurisprudenziali" con riferimento alla questione posta con il primo mezzo
impugnatorio.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente confermata la reiezione, per infondatezza, dell'eccezione
di inammissibilità del ricorso, per difetto di sottoscrizione del difensore,
formulata dalla curatela sul rilievo della insufficienza dell'unica sottoscrizione,
come nella specie apposta, in calce alla allegata dichiarazione relativa al valore
della causa.
Ciò in quanto - come già rilevato nella riferita ordinanza della Sezione 1^ - la
suddetta dichiarazione, sul valore della causa, è, appunto, redatta su foglio
che, non solo segue, senza soluzione di continuità, quelli utilizzati per la
stesura del ricorso ma è ad esso "congiunto materialmente".
Per cui non v'è dubbio che tale dichiarazione debba ritenersi apposta "in calce"
al ricorso (cfr. L. n. 141 del 1997, art. 83, comma 3) e che, per tale ragione,la
correlativa sottoscrizione sia, a sua volta, oggettivamente riferibile anche al
ricorso stesso.
2. La questione sottesa al primo motivo del ricorso e portata, come detto,
all'esame di queste Sezioni unite, è propriamente la seguente: se sia o meno
oggettivamente revocabile, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., comma 2, la vendita
eseguita dall'imprenditore - poi fallito entro un anno - il quale abbia utilizzato
parte del prezzo riscosso per il pagamento di credito privilegiato (nella specie
assistito da ipoteca gravante sullo stesso immobile oggetto della vendita).
79
2.1. Sul punto, risalente giurisprudenza si è effettivamente già pronunciata nel
senso, come ricordato dal ricorrente, della irrevocabilità di una siffatta vendita
ove, e per la misura in cui, si accerti che il denaro corrisposto a titolo di prezzo
dall'acquirente sia stato destinato all'estinzione di crediti privilegiati: così,
appunto, Cass. 9 novembre 1956 n. 4211, 18 maggio 1971 n. 1472, 28 aprile
1975 n. 1626, 4 maggio 1983 n. 3050.
Ma sono rimasti al riguardo insuperati i rilievi formulati da autorevole dottrina
in ordine all'assenza di previsioni normative che autorizzino e rendano in
concreto possibile l'attuazione di una revoca parziale della vendita di un unico
immobile.
Rilievi dei quali l'ultima delle citate sentenze (n. 3050/1983) si è pur mostrata
avvertita, ma dai quali ha ritenuto di poter prescindere per la ragione che,
nella specie, il giudice del merito, disposta la revoca, aveva condannato il terzo
acquirente al rimborso di parte del valore del bene, determinato in una somma
di denaro, e sul punto non vi era stata censura.
Mentre da quella data (1983) nessun'altra pronuncia è più intervenuta sullo
specifico tema della parziale revocabilità, ex art. 67 L. Fall., della vendita di un
unico immobile; nè la questione si è mai prospettata con riguardo alla
revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c..
2.2. E però, comunque, sulla premessa della natura indennitaria della
revocatoria fallimentare - da cui appunto le sentenze su menzionate hanno
desunto il corollario che gli effetti utili di quella azione vadano "contenuti nei
limiti del danno causato dall'atto impugnato" - che la giurisprudenza successiva
ha evidenziato quelle "dissonanze", in ragione delle quali la Sezione IA ha
ritenuto opportuna la rimessione della questione a queste Sezioni unite.
Ed infatti, mentre un filone di pronunzie, tendenzialmente maggioritario, ha
optato per una configurazione distributiva, e non più indennitaria, della
revocatoria di cui al comma secondo dell'art. 67 L. Fall. - affermando che, in
relazione alla stessa, il danno della massa è "in re ipsa", ovvero presunto in via
assoluta, e consiste nella pura e semplice lesione della "par condicio
creditorum" (cfr. Cass. 20 settembre 1991 n. 9853; 16 settembre 1992 n.
10570; 12 novembre 1996 n. 9908; 19 febbraio 1999 n. 1390; 12 gennaio
2001 n. 403; 14 novembre 2003 n. 17189) - altra serie di pronunzie, sia pur
con riferimento alla diversa fattispecie del pagamento infrannuale effettuato
dall'imprenditore a creditore - privilegiato, ha ritenuto subordinata la revoca di
quell'atto alla effettiva ricorrenza di un danno, in concreto, per la massa.
E ciò o appunto (in un primo tempo) sul presupposto del carattere solo relativo
della presunzione di danno ai creditori correlata all'atto in questione, vincibile
attraverso la prova contraria della sua insussistenza nel caso concreto (cfr. nn.
7649/1987; 5857/1988), ovvero (in prosieguo) argomentando dal "difetto di
interesse ad agire del curatore" nel caso in cui il convenuto dimostri che
l'eventuale accoglimento della domanda non arrechi alcuna utilità alla
massa)trattandosi di somma che, ove pur recuperata, dovrebbe, in sede di
riparto, essere poi comunque a lui attribuita, in quanto titolare di diritto di
prelazione poziore rispetto a quello degli altri creditori (così, da ultimo, sent. n.
20005 del 14 ottobre 2005; e, in precedenza, n. 495 del 18 gennaio 1991; n.
2751 dell'8 marzo 1993; n. 8096 del 28 aprile 2004; n. 12558 dell'8 luglio
2004; n. 5713 del 16 marzo 2005).
80
3. Tanto premesso e valutato, ritiene ora però il Collegio che, ai fini della
soluzione del quesito come sopra proposto, non venga in realtà in rilievo la
circostanza che il prezzo della vendita, eseguita dall'imprenditore poi fallito
entro l'anno, sia stato da questi destinato solo in parte al pagamento di un
credito assistito da privilegio (e che resti di conseguenza assorbito il problema
di ammissibilità di una revoca parziale della vendita di un unico bene
immobile), dovendosi - a monte - escludere che una destinazione anche
integrale, del prezzo ricavato da una siffatta vendita, al pagamento di creditori
privilegiati dell'imprenditore poi fallito, possa assumere valenza ostativa
all'esercizio dell'azione di cui al comma secondo dell'art. 67 L. Fall..
E ciò in ragione del carattere distributivo, e non indennitario, di detta azione,
che va qui riaffermato, in consonanza con l'indirizzo interpretativo aperto dalla
citata sentenza n, 9853 del 1991 ed alla stregua di una lettura della norma in
esame che univocamente si impone alla stregua dei canoni dell'ermeneutica,
letterale, teleologico e sistematico.
Avendo, per altro, riguardo, per quest'ultimo profilo, al coordinamento - che
presuppone l'enucleazione dei rispettivi tratti differenziali - della revoca, che
qui ne occupa, degli atti a titolo oneroso (e dei pagamenti) compiuti entro
l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rispetto, per un verso, alla
revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 cod. civ., e ss., per altro verso, alla
revocatoria fallimentare degli atti onerosi infrabiennali con "notevole
sproporzione" in danno dell'imprenditore, di cui all'art. 67 L. Fall., comma 1, n.
1.
Come è stato, infatti, anche di recente esattamente ribadito (da Cass. n.
17189/2003) il fondamentale elemento di discrimine tra la revocatoria
ordinaria (che anche il curatore è legittimato ad esperire ex art. 66 L. Fall.) e
quella fallimentare, sotto il profilo del danno, è rappresentato dalla circostanza
che la seconda si riferisce, per definizione, ad atti posti in essere quando il
debitore si trova in una situazione di insolvenza già inveratasi; mentre, agli
effetti della revocatoria ordinaria, l'atto di disposizione viene in rilievo in
correlazione ad una insolvenza solo potenziale, per cui appunto si richiede la
dimostrazione di un pregiudizio alle ragioni del creditore, costituito dalla
insufficienza dei beni residui, ad offrire la garanzia patrimoniale prevista
dall'art. 2740 c.c. (e non da una semplice diminuzione della stessa: cfr. n.
16915/03).
Ulteriore distinzione va poi, come detto, operata nell'ambito della stessa
revocatoria fallimentare.
E, per tal profilo, corretto è il rilievo, svolto nella sentenza capofila n.
9853/1991 e nelle successive (già citate) conformi, per cui, mentre nella
previsione dell'art. 67 L. Fall., comma 1, n. 2, l'oggettivo danno al patrimonio
della parte, poi fallita, riconducibile al requisito della "notevole sproporzione"
richiesto per la revoca dell'atto oneroso di disposizione da essa compiuto,
costituisce elemento da inglobare nel più ampio concetto di "eventus damni"
per la massa dei creditori, non così è nell'ipotesi del negozio oneroso
infrannuale di cui al successivo comma secondo, ove è assente il riferimento ad
un analogo requisito di danno.
Emergendo così, anche dalla stessa diversa formulazione delle due regole
giuridiche (pur) contenute nel medesimo articolo, come, nel secondo caso (in
81
prospettiva di una più incisiva salvaguardia nei confronti degli atti compiuti
dall'imprenditore commerciale nel periodo più prossimo alla sua dichiarazione
di fallimento), prema al legislatore non tanto il rapporto commutativo del
negozio quanto il recupero, comunque, di ciò che, uscendo dal patrimonio del
debitore nell'attualità di una situazione di insolvenza, sottragga il beneficiario
alla posizione di creditore concorrente (perchè, in tal modo, già soddisfatto),
con automatico vulnus del principio della par condicio creditorum.
E spiegandosi pure, quindi, in tale prospettiva perchè la norma sancita nel
capoverso dell'art. 67 L. Fall. accomuni, nella sua eccezionalità, alla sorte dei
contraenti a titolo oneroso quella dei creditori che abbiano (pur legittimamente
secondo le regole civilistiche) ricevuto dall'imprenditore, poi fallito, il
pagamento di propri crediti liquidi ed esigibili.
Dal che la conclusione - coerentemente da tali premesse desunta dalla
giurisprudenza che si condivide (sent.ze nn. 9853/91; 10570/92; 11216/95;
9908/96; 1390/99; 403/01; 17189/03 citt.) - che il presupposto oggettivo
della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall'imprenditore nell'anno
anteriore alla dichiarazione del suo fallimento si correli non alla nozione di
danno quale emerge dagli istituti ordinari dell'ordinamento bensì alla specialità
del sistema fallimentare, ispirato all'attuazione del principio della par condicio
creditorum, per cui il danno consista nel puro e semplice fatto della lesione di
detto principio, ricollegata, con presunzione legale assoluta, al compimento
dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore.
3.1. Il contrario orientamento - che ritiene tale presunzione suscettibile
viceversa di prova contraria e, anche in prospettiva di una verifica
dell'interesse ad agire da parte del curatore, ammette il convenuto in
revocatoria a dimostrare l'eventuale assenza in concreto di un danno alla
massa ricollegabile all'atto di disposizione vietato, in correlazione alla
intervenuta utilizzazione del prezzo che l'imprenditore abbia ricavato dalla
vendita (e dalla destinazione del pagamento da lui effettuato) in favore di un
creditore assistito da privilegio - si scontra inevitabilmente, infatti, con la
considerazione che è solo nella fase finale di riparto dell'attivo, e non anche
quindi già anticipatamente nella fase dell'esercizio delle revocatorie, che è
possibile verificare se esistano o meno altri creditori privilegiati, di grado
poziore o pari rispetto a quello beneficiario del pagamento vietato, e se, in
caso affermativo, sia possibile l'integrale soddisfazione di tutti (come
implicitamente ammesso anche da Cass. 9149/1997 cit.).
3.2. La natura distributiva della azione di cui al capoverso dell'art. 67 L. Fall.
non è stata, del resto, revocata in dubbio anche nel corso del dibattito e dei
lavori che hanno preceduto la recente riforma della legge fallimentare,
essendosi talora proposta una rimodulazione di quella norma in senso
indennitario
ovvero,
alternativamente,
anche
auspicato
un
suo
ridimensionamento, con abrogazione della revocabilità dei pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili.
Ma a questi indirizzi non si è poi dato seguito, essendo prevalsa la diversa
scelta (in linea con l'evoluzione della disciplina concorsuale dei principali paesi
europei) di ridurre semplicemente (dimezzandolo) il periodo sospetto per
l'esercizio dell'azione in esame (art. 67 cpv., L. Fall., nuovo testo, come
sostituito dal D.L. art. 35, n. 2, convertito in L. n. 80 del 2005), con
82
l'introduzione anche, per altro, di talune eccezioni alla regola (implicitamente
confermative quindi della stessa), come (per quel che più direttamente attiene
alla fattispecie considerata) quella di non revocabilità delle vendite a giusto
prezzo di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti od affini entro il terzo grado(art. 67 cit.,
comma 3, lett. c, nuovo testo).
4. Il contrasto di indirizzi interpretativi sottostante alla questione in esame va
conclusivamente, quindi, risolto con l'affermazione del principio per cui, ai fini
della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito
entro un anno, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., comma 2, l'eventus damni è "in re
ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum,
ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa
conseguente all'atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il
solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte
dell'acquirente. Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia
stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore
privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca
gravante sull'immobile comprevenduto) non esclude la possibile lesione della
par condicio, nè fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore,
poichè è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel
pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche
successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi
insinuarsi.
5. La sentenza impugnata ha fatto di tal principio corretta applicazione.
Per cui resiste alla censura avverso di essa, sul punto, formulata con il primo
motivo del ricorso.
6. Destituito di fondamento è, per altro, pure il residuo secondo mezzo
impugnatorio.
Poichè - diversamente da quanto con esso sostenuto - anche per il profilo della
scientia decoctionis quella sentenza si sottrae a critica. Avendo, infatti, la Corte
di merito, con congrua, logica e giuridicamente corretta motivazione, ritenuto
nella specie raggiunta la dimostrazione della consapevolezza dello stato di
insolvenza del venditore da parte del compratore. Non solo (come si assume)
sulla base dei numerosi protesti anche per cifre di non elevato importo)
esistenti, alla data dell'atto, a carico del venditore ma anche in considerazione
del fatto che tale situazione non poteva essere ignorata dall'acquirente che
gestiva un'attività commerciale in locale contiguo a quello del G., il quale del
resto, anche in sede di stipula aveva espressamente dichiarato la propria
qualità di imprenditore.
7. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
8. Possono comunque compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006.
83
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA 2 FEBBRAIO-24 MARZO 2006, N. 6572
PRESIDENTE CARBONE – RELATORE LA TERZA
PM MARTONE – DIFFORME – RICORRENTE RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 31 gennaio 2000, il Tribunale del lavoro di Roma
dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalle Ferrovie dello Stato Spa a
F. C. e per l’effetto condannava la società suindicata alla reintegrazione nel
posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni
maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, nonché
al risarcimento del danno derivante dal demansionamento, che faceva
decorrere dal 1992, pari a lire 486.660.000.
A seguito dell’impugnazione dalla società, la Corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava nullo, per violazione
dell’articolo 112 Cpc, il capo di sentenza concernente la reintegra nel posto di
lavoro perché ad essa il ricorrente aveva rinunciato e dichiarava inammissibile,
perché nuova, la domanda di reintegra proposta in grado di appello; dichiarava
altresì l’illegittimità del licenziamento intimato il 29 maggio 1998 e condannava
la società a pagare al C., a titolo di risarcimento danni derivanti dall’illegittimo
licenziamento, una somma pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione;
ravvisata altresì l’esistenza del demansionamento, che faceva decorrere dal
1996, condannava la società appellante al pagamento della somma, pari a sei
mensilità di retribuzione, di lire 186.696.000, in luogo della maggior somma
liquidata a tale titolo in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dal dì della maturazione, i primi sino al saldo, la seconda sino alla
data della sentenza.
In punto di danno da demansionamento, la Corte di appello riteneva
indiscutibile che l’inattività del C. avesse prodotto una serie di risultati negativi
i quali – ancorché non direttamente attinenti alla sfera economica – si
presentavano come conseguenze patrimoniali di un danno di diversa natura ed
erano, quindi, legittimamente suscettibili di valutazione. In particolare, la Corte
di appello indicava la lesione della personalità professionale e morale del
prestatore, il discredito che l’avvenuto declassamento aveva comportato a suo
carico nell’ambiente di lavoro e il pregiudizio che tutta la vicenda, la cui
responsabilità era da ascrivere alla società appellante, aveva comportato sul
curriculum vitae e sulla carriera del C., quali circostanze che, pur non avendo
un immediato prezzo economico, si ripercuotevano indubbiamente, oltre che
nell’ambito personale e morale, anche sotto il profilo patrimoniale. Nella specie
– attese le caratteristiche del pregiudizio e considerato che l’impossibilità di
prova di cu parla l’articolo 1226 Cc, va’intesa in senso relativo e con
riferimento ai mezzi e facoltà di cui la parte è fornita – il danno doveva essere
necessariamente oggetto di valutazione equitativa da parte del giudice, ed a tal
fine la Corte territoriale faceva ricorso, come chiesto dal lavoratore, al disposto
84
dell’articolo 9 del contratto collettivo, il quale prevede, nell’ipotesi di
mutamento di funzioni, il diritto del dirigente, di risolvere il rapporto con diritto
ad una indennità pari a quella sostitutiva del preavviso, che doveva essere
limitata, stante il minore periodo di dequalificazione riconosciuto rispetto alla
sentenza di primo grado, in misura pari a sei mensilità.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Rete Ferroviaria
Italiana Società per azioni, già Ferrovie dello Stato di Trasporti e Servizi per
azioni, sulla base di quattro motivo, cui ha resistito con controricorso F. C., il
quale ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui la
società ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memorie.
La trattazione dei ricorsi è stata rimessa alle Su per la risoluzione del contrasto
di giurisprudenza concernente la questione dell’onere probatorio in caso di
domanda di risarcimento danni del demansionamento professionale del
lavoratore prospettata con il quarto motivo del ricorso principale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 Cpc, in relazione agli articoli 99,
414, 420, 436 e 437 Cpc, in ordine al capo della sentenza relativo alla
liquidazione, in conseguenza della ravvisata illegittimità del licenziamento,
dell’indennità supplementare di cui all’articolo 30, comma 10, del Ccnl Dirigenti
Ferrovie dello Stato 29 maggio 1990, giacché la domanda in tal senso, non
contenuta nel ricorso introduttivo, sarebbe stata inammissibilmente proposta
dal C. solo nelle note autorizzate dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 n. 5
Cpc, insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione su punto determinante
della controversia in tema di criteri di liquidazione della indennità
supplementare.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 416,
115 e 116 Cpc, in relazione all’articolo 2697 e all’articolo 2103 Cc e difetto di
motivazione. La censura si riferisce all’accertamento del giudice di appello circa
l’avvenuto demansionamento del C. nel periodo successivo al 1996. In
proposito, ricorda che sin dall’atto della sua costituzione in giudizio aveva
formulato articolate deduzioni circa il riassetto dell’organigramma di Fs del
1997, richiedendo in proposito prova per interpello del ricorrente e per testi, al
fine di dimostrare l’effettività e la dimensione del processo ristrutturativi in atto
dal 1997 in poi, il coinvolgimento dei settori cui il C. era stato preposto, il suo
esito con ridefinizione dell’organigramma e dei compiti di tutta la struttura
coinvolta, l’evidenza, all’esito, di eventuali posizioni di esubero, quale quella
del C. e l’incollocabilità del medesimo in posizioni consimili, nonché l’attività
svolta dal C. in tale periodo presso la società Metropolis. La Corte d’appello
aveva considerato del tutto generiche e infondate le difese di essa società
concernenti il processo di ristrutturazione aziendale in atto nell’anno 1997,
senza però palesare, sostiene la società ricorrente, i motivi per i quali i fatti
esposti e dedotti ad oggetto di prova sarebbero generici, e, soprattutto, perché
le relative difese sarebbero infondate.
85
Con il quarto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli
115, 116, 414 e 420 Cpc, in relazione all’articolo 2697 Cc e agli articoli 432
Cpc e 1226 Cc. Si assume che nessuna prova era stata offerta, né tanto meno
nessun fatto specifico era stato allegato in linea assertiva in ordina alla
dimostrazione di un qualsivoglia danno derivante a carico del C. per la
lamentata dequalificazione, e comunque nessuna domanda poteva essere
accolta a tale titolo per difetto di prova. La sentenza, prosegue la ricorrente,
sarebbe errata per avere individuato il presupposto della condanna risarcitoria
non già sulla base delle allegazioni della parte, che difettavano completamente
(rasentando il ricorso la nullità assoluta), ma in vere e proprie “illazioni
imperscrutabili e putative”. Inoltre, la motivazione sarebbe assolutamente
apparente, o comunque insufficiente, non consentendo di verificare da quali
elementi del processo il giudice avrebbe tratto il convincimento della
verificazione del pregiudizio. Tali ipotesi (non suffragate da fatti di sorta, né da
prova di essi) nella loro genericità ed astrattezza non integrerebbero la prova
specifica del danno – il cui onere gravava a carico del ricorrente – e quindi del
presupposto che consente di ricorrere, nella determinazione del quantum, alla
valutazione equitativa, vigendo anche nella giurisprudenza relativa all’articolo
1226 Cc il principio secondo il quale l’equità è solo un criterio di
determinazione di una riconosciuta pretesa. In subordine, con il medesimo
motivo di ricorso, la ricorrente censura anche l’applicazione dei criteri
liquidativi del danno con ricorso all’equità ex articoli 432 Cpc e 1226 Cc.
Con il primo motivo, il ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’articolo 360
n. 3 e 5, Cpc violazione e/o falsa applicazione degli articoli 420 e 416 Cpc, in
relazione agli articoli 2696 e 2103 Cc, sulla valutazione del danno da
demansionamento con riferimento all’articolo 9 Ccnl dirigenti Fs, nonché
omessa o contraddittoria motivazione in relazione agli articoli 2103 e 2087 Cc,
in ordine alla determinazione del medesimo e omessa insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia, per
avere escluso il demansionamento, pure riconosciuto dal giudice di primo
grado, per il periodo 1992-1996; per avere ritenuto compensativi incarichi privi
di contenuto operativo; per avere disatteso la clausola del Ccnl (articolo )) pur
ad essa facendo riferimento; per non avere tenuto conto del danno emergente
consistente nella perdita, conseguente alla rimozione dell’incarico di direttore
finanziario, dei premi ex articolo 38 Ccnl e dell’indennità di funzione ex articolo
37 del medesimo Ccnl.
Con il secondo motivo, il C. deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo
112 Cpc, sulla domanda di reintegra nel posto di lavoro, contestando che in
alcun atto vi è stata rinuncia a tale domanda da parte di esso ricorrente, né
valida rinuncia da parte del procuratore.
Con il terzo motivo si deduce la nullità del licenziamento in relazione al difetto
di poteri del funzionario che lo aveva disposto. La inefficacia della procura al
direttore delle risorse umane 27 luglio 1997 in materia di assunzione e
licenziamento dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato regolato dalla
contrattazione collettiva.
La violazione e falsa applicazione dell’articolo 435 Cpc in relazione agli articoli
416 e 420 Cpc e all’articolo 2697 Cc. Insufficiente, omessa e contraddittoria
motivazione su un punto determinante della controversia.
86
Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc,
violazione o falsa applicazione dell’articolo 429 comma 3 Cpc, in materia di
rivalutazione monetaria e interessi su somme dovute a titolo di risarcimento
del danno. Omessa motivazione su un punto determinante della controversia.
Appare logicamente preliminare – rispetto alla questione oggetto del contrasto,
di cui al quarto motivo del ricorso principale ed al primo motivo del ricorso
incidentale – la trattazione del terzo motivo del ricorso principale, perché con
esso si critica la sentenza per avere ravvisato l’esistenza, dal 1996, del dedotto
demansionamento e quindi il presupposto stesso da cui è stato fatto
discendere il diritto al risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo in ricorso non si contesta una circostanza decisiva affermata
nella sentenza impugnata, e cioè essere pacifico – avendolo ammesso la stessa
società – che il C., una volta dimessosi da tutte le cariche precedentemente
rivestite, lasciata la società Metropolis e rientrato presso le Ferrovie dello
Stato, era rimasto del tutto inoperoso. La società invero si giustifica allegando,
e lamentando la mancata ammissione di prova sul punto, il profondo riassetto
organizzativo, delinea compiutamente in ricorso il nuovo organigramma, con
l’indicazione di tutte le numerose direzioni e del personale che ne era
rispettivamente a capo, al fine di dimostrare una sorta di impossibilità
sopravvenuta di assegnare al C. una qualsiasi mansione. Ma il riassetto
organizzativo che si intende provare non appare però decisivo per infirmare le
conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, giacché proprio la complessità
della organizzazione, la pluralità di settori di intervento, con articolazione in
molteplici direzioni (che comprendevano l’amministrazione, la finanza operativa
e straordinaria, gli acquisti, il patrimonio, il settore legale, la tesoreria, il
bilancio, la contabilità, il settore fiscale ed altro) portano invece logicamente ad
escludere l’esistenza di detta impossibilità, rendendo poco credibile che non si
fosse in condizione di reperire – nell’ambito di un ragionevole periodo di tempo
quale è quello trascorso dal 1996 al licenziamento del maggio 1998 – una
posizione compatibile con la qualifica e le competenze professionali del C.. In
particolare, mentre si deduce che il medesimo era esperto in materia fiscale,
non si spiega in ricorso il motivo per cui il medesimo non potesse trovare utile
collocazione in detto settore, che pure risulta essere stato variamente
articolato (adempimenti fiscali, imposte dirette, Iva ed altre imposte indirette e
contenzioso).
Il terzo motivo del ricorso principale è quindi infondato.
Parimenti infondato è il primo motivo del ricorso incidentale, con cui si lamenta
che non sia stato ravvisato il demansionamento fin dal 1992, allorquando il C.
era stato rimosso dalla posizione di direttore dell’area finanziaria e patrimonio,
avente un peso che non sarebbe stato adeguatamente valutato dai giudici di
merito.
La prospettiva in cui si muove il ricorrente appare invero erronea, non
potendosi il demansionamento ritenere integrato solo dalla revoca di un
incarico di direzione, ancorché prestigioso, e remunerativo, essendo pur
sempre rimesso al datore il cosiddetto ius variandi, ossia l’assegnazione a
mansioni diverse, purché equivalenti a quelle svolte da ultimo; ed infatti,
diversamente opinando, ne conseguirebbe la impossibilità di modificare in
87
alcun modo l’organizzazione aziendale, il che però si porrebbe in patente
contrasto con i poteri riservati all’imprenditore dall’articolo 2094 Cc ed anche
con i principi di rango costituzionale (articolo 41 Costituzione). E quanto alla
equivalenza delle nuove mansioni, assegnate dopo la revoca di quell’incarico,
nella sentenza impugnata sono state puntualmente indicate le funzioni di
vertice svolte dal 1992 al 1996 (dal 30 aprile 1992 al 30 aprile 1994, era stato
assistente dal presidente per la diversificazione delle attività ferroviarie e
responsabile per le Diversificate e il Patrimonio; contemporaneamente era
stato consigliere di amministrazione di Metropolis fino al 18 novembre 1996 e
vice presidente della medesima società del 18 maggio 1993 al 28 giugno
1996); inoltre non si indicano in ricorso gli elementi comprovanti la tesi
difensiva svolta, per cui detti incarichi sarebbero stati privi di contenuti
operativi e che la società Metropolis avrebbe agito solo sulla carta, per cui non
si può ascrivere alla sentenza impugnata né di averli pretermessi, né di averli
incongruamente valutati.
Il primo motivo del ricorso incidentale va quindi rigettato.
Quanto al quarto motivo del ricorso principale, concernente i danni derivanti
dal demansionamento per il periodo dal 1997 al 1998 ravvisati e liquidati dai
giudici di merito, è effettivamente sussistente un contrasto nella
giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte. La questione è la
seguente: se, in caso di demansionamento o di dequalificazione, il diritto del
lavoratore al risarcimento del danno, soprattutto di quello cosiddetto
esistenziale, suscettibile di liquidazione equitativa, consegua in re ipsa al
demansionamento, oppure sia subordinato all’assolvimento, da parte del
lavoratore, all’onere di provare l’esistenza del pregiudizio.
Invero entrambi gli indirizzi convergono nel ritenere che la potenzialità nociva
del comportamento datoriale può influire su una pluralità di aspetti
(patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione) e concordano sulla risarcibilità
anche del danno non patrimoniale, ammettendo il ricorso alla liquidazione
equitativa, ma divergono o presentano una inconciliabile diversità di accenti e
di sfumature quanto al regime della prova.
1. Sono ascrivibili al primo indirizzo le pronunce di cui a Cassazione 13299/92,
11727/99, 14443/00, 13580/01, 15868/02, 8271/04, 10157/04, le quali,
ancorché con motivazioni diversamente articolate alla stregua delle pronunzie
oggetto di esame, hanno ritenuto che «In materia di risarcimento del danno
per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione
alle quali era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può essere
determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi
dell’articolo 1226 Cc, anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da
parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base
all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla
natura, all’entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre
circostanze dal caso concreto».
2.Sono ascrivibili al diverso indirizzo che richiede la prova del danno
Cassazione 7905/98, 2561/99, 8904/03, 16792/03, 10361/04, le quali
enunciano il seguente principio «Il prestatore di lavoro che chieda la condanna
del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche sulla sua eventuale
componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto danno biologico)
88
subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione
lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a
determinare la dequalificatine del dipendente stesso, deve fornire la prova
dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova
che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione
equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di
ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché
non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta
datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la
prova in base alla regola generale di cui all’articolo 2697 Cc». Con dette
pronunzie si sono generalmente confermate le sentenze di merito che avevano
rigettato la domanda di risarcimento del danno per essere stata la
dequalificatine fatta genericamente derivare dalla privazione di compiti
direttivi, per non essere stati precisati i pregiudizi di ordine patrimoniale
ovvero non patrimoniale subiti, e per non essere stati forniti elementi
comprovanti una lesione di natura patrimoniale, non riparata dall’adempimento
dell’obbligazione retributiva, ovvero una lesione di natura non patrimoniale.
Le Su ritengono di aderire a quest’ultimo indirizzo.
1. La tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza è quella che prospetta la
responsabilità datoriale come di natura contrattuale. Ed infatti, stante la
peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, e cioè
sia quello che attiene alla lesione della professionalità, sia quello che attiene al
pregiudizio alla salute o alla personalità del lavoratore, si configura come
conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale:
nel primo caso il danno deriva dalla violazione dell’obbligo di cui all’articolo
2103 (divieto di dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione
dell’obbligo di cui all’articolo 2087 8tutela dell’integrità fisica e della personalità
morale del lavoratore) norma che inserisce, nell’ambito del rapporto di lavoro, i
principi costituzionali. In entrambi i casi, giacchè l’illecito consiste nella
violazione dell’obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una situazione
in inadempimento contrattuale regolato dall’articolo 1218 Cc, con conseguente
esonero dall’onere della prova sulla sua imputabilità, che va regolata in stretta
connessine con l’articolo 1223 dello stesso codice. Vi è da aggiungere che
l’ampia locuzione usata dall’articolo 2087 Cc (tutela della integrità fisica e della
personalità morale del lavoratore) assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i
danni non patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni
imposte dall’articolo 2059 Cc (sulla evoluzione di detta tematica vedi Corte
costituzionale 233/03 e l’indirizzo inaugurato da Cassazione 7283/03),
verificare se l’interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in
quanto protetto a livello costituzionale, perché la protezione è già chiaramente
accordata da una disposizione del Cc.
2. Dall’inadempimento datoriale non deriva però automaticamente l’esistenza
del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della
potenzialità lesiva dell’atto illegittimo. L’inadempimento infatti è già sanzionato
con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si
produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma, non può infatti non
valere, anche in questo caso, la distinzione tra “inadempimento” e “danno
risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di ci all’articolo 1218 e 1223,
89
per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano
“conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento, lasciando così
chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli articoli
2087 e 2103 Cc, da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in
tal senso chiaramente si è espressa la Corte costituzionale 372/94). D’altra
parte – mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio
che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato,
attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la
obbligazione fosse stata esattamente adempiuta – ove diminuzione non vi sia
stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è
configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno
opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla
vittima, mentre l’attribuzione ad essa di una somma di denaro in
considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il
configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta
sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel
nostro ordinamento.
3. È noto poi che dall’inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente,
una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale,
danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita
di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cosiddetto esistenziale, che
possono anche coesistere l’una con l’altra.
Prima di scendere all’esame particolare, occorre sottolineare che proprio a
causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si
rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del
lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi
giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di
essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e
le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la
prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare l’esistenza della
dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non
potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo
il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova
attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri
istruttori ufficiosi previsti dall’articolo 421 Cpc – non può invece mai sopperire
all’inere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le
circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cassazione Su
1099/98).
4. Passando ora all’esame delle singole ipotesi, il danno professionale, che ha
contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia
nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale
acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità,
ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità
di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in
presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di una
attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque
caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a
90
venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile
periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori
potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in
concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero
state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state
frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti
elementi, da allegare necessariamente ad opera dell’interessato, sarebbe
difficile individuare un danno alla professionalità, perché – fermo
l’inadempimento – l’interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti
pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale
controprestazione dell’impegno assunto di svolgere l’attività che gli viene
richiesta dal datore.
5. Più semplice è il discorso sul danno biologico, giacchè questo, che non può
prescindere dall’accertamento medico legale, si configura tutte le volte in cui è
riscontrabile una lesione dell’integrità psico fisica medicalmente accertabile,
secondo la definizione legislativa di cui all’articolo 5 comma 3 della legge
57/2001 sulla responsabilità civile auto, che quasi negli stessi termini era stata
anticipata dall’articolo 13 del D.Lgs 38/2000 in tema di assicurazione Inail (tale
peraltro è la locuzione usata dalla Corte costituzione con la sentenza 233/03).
6. Quanto al danno non patrimoniale all’identità professionale sul luogo di
lavoro, all’immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto
fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel
luogo di lavoro, tutelato dagli articoli 1 e 2 della Costituzione (cosiddetto danno
esistenziale) è in relazione a questo caso che si appunta maggiormente il
contrasto tra l’orientamento che propugna la configurabilità del danno in re
ipsa e quello che ne richiede la prova in concreto.
Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo
scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore
come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito
datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di
vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua
quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della
sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla
natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno
morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di
scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse
verificato l’evento dannoso.
Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione
che ne fa l’interessato sull’oggetto e sul modo di operare dell’asserito
pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso
nell’atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente
elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno
all’immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come
automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti,
essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile
di determinazione secondo il sistema gabellare – al quale si fa ricorso per
determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali
91
applicabili in relazione alla lesione dell’indennità psico fisica – necessità
imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può
fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di
vita.
Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell’isolamento, della
forzata inoperosità, dell’assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle
proprie, perché questi elementi integrano l’inadempimento del datore ma,
dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò,
concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore,
alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita. Non può infatti escludersi, come
già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di
lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze
pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito
l’interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così
sussiste l’inadempimento, ma non c’è pregiudizio e quindi non c’è nulla da
risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza
378/94 per cui «È sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno,
ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a
quello indicato dall’articolo 1223 Cc, costituita dalla diminuzione o privazione di
un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato».
6. Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione
della prova da fornire, si osserva che il pregiudizio in concreto subito dal
lavoratore potrà ottenere pieno ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza
considerarlo scontato aprioristicamente. Mentre il danno biologico non può
prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece
essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva,
che dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in
senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti – se è vero
che la stessa categoria del “danno esistenziale” si fonda sulla natura non
meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del
pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse
da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso
– all’onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento
processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova
testimoniale su tali circostante di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato
che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume
rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non
relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui
il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cassazione
9834/02) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole
di cui all’articolo 2727 Cc venga offerta una serie concatenata di fatti noti,
ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non
in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno
del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e
ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste
in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione
dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del
92
soggetto; da tutte queste circostante, il cui artificioso isolamento si
risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cassazione
13819/03)
complessivamente
considerate
attraverso
un
prudente
apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia
all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex articolo 115 Cpc a quelle nozioni
generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione delle prove.
D’altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del
danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma
equitativa, perché questa, per non trasmodare nell’arbitrio, necessità di
parametri a cui ancorarsi.
7. Applicando detti criteri al caso di specie, la Corte territoriale afferma essere
indiscutibile che il dedotto demansionamento ha sicuramente prodotto una
serie di risultati negativi ed indica a tale fine la lesione della personalità
professionale e morale, il discredito derivante dal declassamento nell’ambiente
di lavoro ed il pregiudizio sul cv e sulla carriera dell’istante.
In primo luogo detti rilievi prescindono integralmente dalle allegazioni del
ricorrente, perché non se ne riporta in alcun modo il tenore, anzi l’espressione
usata «Si pensi alla lesione della personalità professionale e morale al
“discredito” nell’ambiente di lavoro» sembra alludere a conclusioni cui il
Giudice è pervenuto autonomamente, in altri termini, non risultano posti a
base della decisione fatti introdotti dalla parte nel processo, così
contravvenendo all’obbligo di decidere iuxta alligata ed provata di cui
all’articolo 115 Cpc.
Inoltre ciò di cui si da conto è, non già – come si dovrebbe – il danno
conseguenza della lesione, e cioè l’esistenza dei riflessi pregiudizievoli prodotti
nella vita dell’istante attraverso una negativa alterazione dello stile di vita, ma
l’esistenza della lesione medesima, essendosi fatto ricorso ad una formula
standardizzata, tale da potersi utilizzare in tutti i casi di dedotta
dequalificazione, con conseguente rischio di risolvere dette controversie con
l’apposizione di un formulario “fisso” e quindi con elusione delle specificità delle
singole fattispecie. Del tutto generico e immotivato è poi il riferimento al
pregiudizio al cv ed alla carriera, non facendosi alcuna indicazione sulle
concrete aspettative dell’interessato nel futuro svolgimento della vita
professionale che sarebbero state frustrate dall’inadempimento datoriale, né
alla conoscenza della vicenda al di fuori dell’ambiente di lavoro, né alla perdita
di [omissis] del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. La
causa va poi rimessa alla sezione lavoro per la decisione sugli altri motivi.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il quarto motivo del ricorso principale e
cassa la sentenza impugnata in relazione al medesimo motivo. Rigetta il terzo
motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale. Rimette
la causa alla Sezione lavoro per la decisione sugli altri motivi.
93
CASSAZIONE CIVILE , SEZ. UN., 28 MARZO 2006, N. 7029
CASSAZIONE CIVILE , SEZ. UN., 28 MARZO 2006, N. 7030
CASSAZIONE CIVILE , SEZ. UN., 28 MARZO 2006, N. 7031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE
Vincenzo
- Presidente Aggiunto Dott. PRESTIPINO
Giovanni
- Presidente di sezione Dott. MORELLI
Mario Rosario
- Consigliere Dott. GRAZIADEI
Giulio
- Consigliere Dott. VIDIRI
Guido
- Consigliere Dott. BONOMO
Massimo
- Consigliere Dott. BERRUTI
Giuseppe Maria
- rel. Consigliere Dott. BUCCIANTE
Ettore
- Consigliere Dott. BOTTA
Raffaele
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO ITALSEMOLE S.R.L., in persona del Curatore pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio
dell'avvocato STANISLAO AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato
INZITARI BRUNO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro
BANCA ROMA S.P.A. (ora CAPITALIA S.P.A.);
- intimata e sul 2^ ricorso n. 05430/03 proposto da:
CAPITALIA S.P.A. - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO CAPITALIA (già
BANCA DI ROMA S.P.A.), in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo
studio dell'avvocato ALESSI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende,
giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro
FALLIMENTO ITALSEMOLE S.R.L., in persona del Curatore pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIACO 8, presso lo studio
dell'avvocato STANISLAO AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato
BRUNO INZITARI, giusta delega a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 930/02 della Corte d'Appello di BARI,
depositata il 04/11/2002;
94
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/02/2006 dal Consigliere Giuseppe Maria BERRUTI;
uditi gli avvocati Bruno INZITARI, Giuseppe ALESSI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso
principale, accoglimento del secondo motivo, rinvio per il resto ad
una sezione semplice.
Inizio documento
Fatto
Con citazione del 5 settembre 1999 il fallimento srl Italsemole, in persona del
curatore conveniva davanti al Tribunale di Foggia la spa Banca di Roma per
sentirla condannare in suo favore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
2043 c.c. in ragione della abusiva concessione di credito alla srl predetta,
quando era in bonis, in quanto effettuata in presenza di elementi tali da
doverne far riconoscere la situazione di impresa insolvente. Precisava che il
credito così concesso aveva tenuto artificiosamente in vita la srl, suscitando nel
mercato la falsa opinione che si trattasse di impresa economicamente valida.
La banca convenuta si costituiva e resisteva eccependo anzitutto la nullità della
citazione, l'incompetenza del Tribunale adito, la carenza di legittimazione attiva
del curatore per esservi quella dei singoli creditori danneggiati dal preteso
illecito, e la prescrizione quinquennale dell'azione. Quindi, quanto alle azioni
revocatorie ne eccepiva la inammissibilità per superamento del periodo
sospetto, che a suo avviso andava calcolato dalla sentenza del Tribunale di
Foggia senza che dovesse darsi alcun rilievo a quella antecedente del Tribunale
di Nola, cassata dalla Corte Suprema che aveva dichiarato la competenza del
Tribunale pugliese. Ne eccepiva altresì il difetto di interesse con riferimento alla
domanda risarcitoria il cui accoglimento avrebbe soddisfatto interamente i
creditori.
Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 898 del 2001, non definitiva, rigettava le
domande revocatorie per superamento del periodo previsto dalla legge;
affermava la propria competenza territoriale sulla domanda risarcitoria della
Curatela nonchè la legittimazione attiva della stessa, e rigettava la relativa
eccezione
di
prescrizione.
La Banca di Roma proponeva regolamento facoltativo di competenza e la Corte
di Cassazione con ordinanza n. 1236 del 2001 confermava la competenza
territoriale del Tribunale di Foggia ex art. 20 c.p.c., pur escludendo quella ex
art.
24
L.
Fall..
La banca proponeva anche appello al quale resisteva il fallimento che
proponeva a sua vola appello incidentale. La Corte di Bari, respinta la reiterata
eccezione di nullità della citazione, in parziale riforma della prima sentenza
dichiarava il difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare a proporre
l'azione risarcitoria, fondata l'eccezione di prescrizione della domanda stessa
ed infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria dovendosi il
periodo sospetto calcolare avendo riguardo alla sola sentenza del Tribunale di
Foggia e non anche a quella, cassata, del Tribunale di Nola, giacchè ciò
avrebbe dato luogo a due distinti periodi sospetti. Per quanto soprattutto
attiene all'odierno giudizio, riteneva, aderendo alla pronuncia della Corte di
95
Cassazione resa nelle citata ordinanza n. 12368 del 2001 che l'azione aquiliana
in parola non costituisse azione di massa, in quanto la parte danneggiata dalla
abusiva concessione del credito bancario non si identifica con la collettività dei
creditori ma con ciascuno di essi, cosicchè rispetto ad ognuno dei pretesi
danneggiati occorre valutare, caso per caso, la sussistenza dell'illecito e del
pregiudizio. Rilevava in proposito che la curatela non aveva allegato un
pregiudizio risentito dall'intero ceto creditorio dal momento che la domanda
identificava il danno risarcibile nella differenza tra le attività fallimentari e le
passività nei confronti di soggetti diversi dalle banche, tra i quali soli dunque
andrebbe suddiviso il risultato dell'eventuale esito favorevole della azione
risarcitoria.
La Corte barese negava che al curatore si possa riconoscere un generale
potere di rappresentante dei dritti dei creditori del fallimento e, al di fuori dello
strumento della revocatoria, quello di far valere in nome loro la eventuale
responsabilità
di
terzi.
Riteneva quindi che l'azione in parola fosse da assimilarsi a quella di cui all'art.
2395 c.c. e che fosse pertanto ininfluente ogni riferimento all'art. 146 L. Fall.,
per pervenire alla affermazione della legittimazione di cui si tratta, e negava la
applicabilità
alla
vicenda
della
previsione
dell'art. 240
L. Fall..
Quanto alla eccepita prescrizione delle azioni proposte dalla curatela riteneva
che il decorso del relativo periodo si doveva considerare iniziato già alla data
del 30 luglio 1994, nella quale le banche non approvarono il piano di rientro
presentato dalla impresa, giacchè da tale evento, molto pubblicizzato, i
creditori
non
potettero
dedurre
la
solvibilità
della
stessa.
Contro questa sentenza vi è ricorso per Cassazione da parte della curatela del
fallimento con quattro motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale condizionato la Banca di Roma, ora Capitalia s.p.a.. Resiste al
ricorso incidentale condizionato con altro controricorso la Curatela del
fallimento.
Le
parti
hanno
depositato
memorie.
La causa è stata rimessa all'esame di queste Sezioni Unite per la soluzione
della questione di massima di particolare importanza relativa alla
legittimazione attiva del curatore fallimentare.
Inizio documento
Diritto
1.1
ricorsi
vanno
preliminarmente
riuniti.
2. Vanno esaminati, prima del ricorso principale, il primo ed altresì il secondo
motivo del ricorso incidentale, ancorchè questo sia espressamente condizionato
all'accoglimento del principale, giacchè con essi la Banca propone questioni
pregiudiziali di rito che incidono su quella di massima il cui esame è stato
demandato
a
queste
Sezioni
Unite.
2.a. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Banca lamenta il mancato
esame da parte della Corte Barese di un motivo di appello da essa proposto
relativo alla già eccepita incompetenza del Tribunale di Foggia.
2.b. Osserva il collegio che la sentenza impugnata, sia pure senza farne un
capo di decisione formalmente evidenziato, ha tuttavia trattato la questione ed
ha dato conto di avere esaminato la eccezione di incompetenza, rigettandola,
rilevando che la questione era stata risolta dalla ordinanza delle Sezioni Unite
n. 12368 del 2001. In tal modo dunque la Corte di merito ha anche motivato in
96
ordine alla ritenuta competenza, giacchè ha espressamente richiamato,
condividendolo,
il
dictum
delle
Sezioni
Unite.
Il
motivo
è
infondato.
2.c. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta il mancato rilievo
della nullità della domanda originaria di risarcimento dei danni da abusiva
concessione del credito, sotto il profilo della mancanza di specificazione. La
citazione infatti, come la Corte Barese non ha notato, non indicava i singoli
finanziamenti
che
sarebbero
stati
effettuati
commettendo
l'abuso.
2.d. Osserva il collegio che la domanda della curatela è stata interpretata dalla
Corte di merito come fondata sulla allegazione di un complessivo
comportamento professionale del banchiere protratto per un certo periodo, il
cui effetto è stata la produzione nel mercato della percezione della impresa
sovvenuta come ancora finanziatale. La domanda, rileva la sentenza
impugnata sul punto, si conclude con la richiesta di un risarcimento
commisurato alle passività bancarie complessive. Esattamente la Corte Barese
ha ritenuto la domanda, così intesa, specificata nei suoi elementi. La doglianza
è
dunque
anch'essa
infondata.
3. Con il primo motivo del ricorso principale la Curatela lamenta la violazione e
la falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. nonchè la motivazione insufficiente,
contraddittoria ed omessa sul punto decisivo dell'affermata carenza di
legittimazione attiva del curatore a proporre l'azione risacitoria. Sostiene che
siccome il curatore è legittimato a proporre, quale avente causa dal fallito, ogni
azione che questi avrebbe potuto proporre, egli nella vicenda ha fatto valere
per l'appunto un pregiudizio subito dalla Italsemole per effetto della abusiva
concessione di credito da parte della banca. Il valore economico di un
finanziamento secondo questa prospettazione è neutralizzato dal suo costo
complessivo, cosicchè esso assume rispetto al patrimonio del soggetto
finanziato,
un
valore
negativo.
La condotta della banca, illecita perchè connotata non già dal rispetto dei
principi di sana e corretta gestione del credito, ma invece diretta a mantenere
artificiosamente in vita un imprenditore decotto, avrebbe cagionato al
patrimonio della società per l'appunto con i non dovuti finanziamenti un danno
diretto, il cui ristoro può essere chiesto dal curatore allo stesso titolo per il
quale
avrebbe
potuto
chiederlo
l'imprenditore
danneggiato.
3.a. Deve, a questo punto, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del
motivo, avanzata dalla banca resistente sotto il profilo della sua novità. La
banca infatti sostiene che la domanda risarcitoria era stata avanzata
esclusivamente sotto il profilo della spettanza al Curatore della tutela
immediata dei diritti della massa e non dei diritti derivati al creditore da
pretese
lesioni
del
patrimonio
della
società
fallita.
3.b. Osserva il collegio che la citazione introduttiva del primo giudizio allega a
fondamento della accusa di illecita concessione di credito bancario, la direzione
a mantenere "artificiosamente in vita" una impresa decotta, "suscitando nel
mercato la falsa opinione si trattasse di impresa economicamente valida". La
direzione a mantenere artificiosamente in vita l'impresa non è, in questa
prospettazione, allegazione distinta da quella della produzione della falsa
opinione del mercato, corrispondente cioè a circostanza fattuale a sua volta
distinta e capace di dare luogo ad evento ulteriore, come sostiene la curatela
97
rispondendo sul punto alla eccezione della banca. Essa è, piuttosto, il
presupposto della seconda. Si manteneva in via artificiosamente un' impresa
che era insolvente e con ciò appunto si suscitava nel mercato una errata
percezione della sua realtà finanziaria ed economica. Effetto questo che a sua
volta conduceva i terzi a contrattare o a continuare a contrattare con la
società.
Detta prospettazione unitaria della condotta della banca da parte della
Curatela, trova conferma nella sottolineatura di circostanze dalle, quali,
secondo l'attrice, doveva emergere una sorta di complicità tra i vertici della
impresa ed i funzionari della banca, tendente a rendere apparenti le istruttorie
ed ad evitare che esse facessero emergere la vera situazione della impresa.
Attività scorretta che peraltro nello stesso atto introduttivo viene attribuita
all'intero ceto bancario interessato e che viene valutata come estesa a tutto il
gruppo
Casillo
del
quale
la
srl
Italsemole
era
componente.
Siffatta impostazione della domanda, e dunque la causa pretendi, si riflette sul
petitum. Tant'è che la domanda risarcitoria viene specificata in citazione
nell'ammontare delle passività non bancarie della fallita, detratte le attività.
Infatti, in assoluta coerenza alla predetta interpretazione della domanda la
sentenza impugnata a foglio 13 e 14 rileva la novità della prospettazione della
curatela secondo la quale il diritto leso consisteva anche nella impossibilità
nella quale la fallita società era stata messa relativamente all'esercizio delle
azioni revocatorie e ritiene di non poterla esaminare. Ciò in quanto, appunto,
l'azione originariamente esercitata dal curatore era relativa alla tutela della
massa dei creditori, lesi da una attività bancaria che li aveva indotti a ritenere,
tutti indistintamente, effettivamente sussistente una organizzazione di impresa
che invece era una apparenza, frutto del predetto artificio finanziario.
3.c. Va peraltro osservato che il danno da abuso di credito cagionato nei
confronti dei terzi, creditori inclusi, ha natura aquiliana. Esso è il pregiudizio
che segue alla insufficienza del riparto, pur dopo l'esperimento delle azioni
esecutive. Esso, diversamente dalla diminuzione che subisce il patrimonio del
creditore per effetto dell'inadempimento, risale anche alla attività di un
soggetto diverso dall'inadempiente, e richiede per il suo accertamento, prima
ancora che per la sua liquidazione, l'esperimento delle azioni, per l'appunto di
massa,
che
tendono
alla
conservazione
della
garanzia
generica.
Consegue che le due responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale risalgono
a fatti pregiudizievoli distinti ed autonomi, i quali possono dare luogo a distinti
eventi dannosi. La rispettiva allegazione in giudizio a fondamento della
domanda risarcitoria, a prescindere dalla questione della legittimazione a
proporre quest'ultima, deve essere differenziata non potendo l'una essere
dedotta
automaticamente
dall'altra.
In conclusione nella vicenda in esame il dedotto danno al patrimonio della
società non è mai stato allegato autonomamente, ma solo quale indistinto
elemento del danno alla massa. Un danno diretto ed immediato al patrimonio
della fallita, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come
successore nei rapporti del fallito e titolare dei diritti sorti in capo a questi, non
venne
mai
dedotto.
La questione, come tale, è nuova perchè avanzata per la prima volta in questa
sede,
e
pertanto
inammissibile.
98
4. Con il secondo motivo di ricorso la Curatela del Fallimento lamenta la
violazione degli artt. 2043, 1175, 1375, 2740, 2741 c.c., degli artt. 51 e 52 L.
Fall., degli artt. 99 e 100 c.p.c., degli artt. 6 e 31 L. Fall. nonchè la
motivazione carente sul punto della legittimazione attiva del curatore
fallimentare. Sostiene che il comportamento della banca, contrario a
correttezza e buona fede, ha leso il diritto della massa alla realizzazione del
credito nella esecuzione concorsuale. Sostiene che la banca con l'allegato
comportamento non solo ha violato i doveri del proprio stato, ma ha realizzato
il proprio interesse con il danno contemporaneo dei creditori della fallita
diminuendo la soddisfazione che questi avrebbero potuto realizzare attraverso
il riparto. Ciò tanto con riferimento ai creditori anteriori al compimento
dell'illecito quanto a quelli successivi. Il motivo quindi rileva che la banca ha
operato perchè attraverso la abusiva concessione del credito venisse allargato
il passivo, così pregiudicando il patrimonio della fallita e facendo
oggettivamente diminuire le quote spettati ai partecipanti al riparto- L'iniziativa
del curatore dunque sarebbe diretta a tutelare la intera massa al maggior
riparto possibile. L'interesse della fallita alla conservazione del patrimonio e
quello dei creditori ad un più ampio riparto sarebbero coincidenti.
4.a. Osserva il collegio che in via di principio non si può ritenere, come sembra
presupporre la ricorrente, che nel sistema fallimentare il curatore sia titolare di
un potere di rappresentanza di tutti i creditori, indistinto e generalizzato. Il
sistema piuttosto prevede che la funzione del curatore sia diretta a conservare
il patrimonio del debitore, garanzia del diritto del creditore, attraverso
l'esercizio delle cosìdette azioni di massa, dirette ad ottenere, nell'interesse del
creditore, la ricostituzione del patrimonio predetto, come avviene per l'appunto
attraverso l'esercizio delle azioni revocatorie e surrogatorie. Tale principio
peraltro non è assoluto, come ancora pare ritenere il ricorrente, ma va
armonizzato con quello secondo il quale siffatta legittimazione ad agire,
sostitutiva dei singoli creditori, non sussiste in presenza di azioni esercitabili
individualmente in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo e diretto
del creditore nei confronti di soggetti diversi dal fallito, come avviene mediante
le azioni di cui agli artt. 2395 e 2449 c.c. (vedi cass. n. 18147 del 2002).
Il quesito sottoposto alla Corte è dunque se la azione di danno da abusiva
concessione di credito possa essere ritenuta azione di massa, nel senso
precisato, con conseguente legittimazione attiva del curatore fallimentare. La
risposta, anche sulla scorta della dominante opinione scientifica, deve essere
negativa.
4.b. L'azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai
possibili beneficiari del suo esito positivo. Essa nell'immediato perviene
all'effetto di aumentare la massa attiva, quali che possano essere i limiti
quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno. Essa tende
direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore, inteso come sua
garanzia generica e comunque esso sarà suddiviso attraverso il riparto.
Non appartiene a tale novero di azioni ogni pretesa che richiede l'accertamento
della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori. Nè vi
appartiene ogni azione che, per quanto diffusa possa essere una specifica
pretesa, necessita pur sempre dell'esame di specifici rapporti e del loro
svolgimento, non essendo sufficiente ad assicurarne l'eventuale beneficio la
99
mera
appartenenza
ad
un
ceto.
4.c. Va dunque anzitutto rilevato che l'azione risarcitoria di cui si tratta nella
sua ontologia costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo
creditore, analogamente alle azioni che traggono origine da atti degli
amministratori della società fallita che danneggiano il terzo, ai sensi dell'art.
2395
c.c..
Il danno che deriva da siffatta attività andrà, comunque, caso per caso
valutato nella sua esistenza e nella sua entità, essendo ben ipotizzabile che
creditori che pur hanno diritto di partecipare al riparto non hanno titolo per il
risarcimento di cui si tratta, non avendo ricevuto danno dalla continuazione
della
attività
di
impresa.
4.d. Inoltre la posizione dei singoli creditori nei confronti di siffatta attività di
sovvenimento abusivo dell'imprenditore si differenzia a seconda che i crediti
siano antecedenti oppure successivi alla stessa. La circostanza temporale
infatti può escludere oppure costituire il presupposto del pregiudizio, negando
pertanto il carattere indifferenziato che struttura l'azione di massa.
Il creditore antecedente l'abusiva concessione del credito avrà titolo a dolersi
per la partecipazione al riparto, pur sempre all'esito delle azioni conservative
del patrimonio da ripartire, dei creditori successivi. Questi ultimi, invece,
esclusivamente dell'eventuale incapienza e per tale parte soltanto.
4.e. Va ancora osservato, sviluppando un argomento cui si è cennato innanzi ai
soli fini processuali rilevanti nell'esame del primo motivo, che la odierna
ricorrente partecipò al contratto che dette luogo alla abusiva concessione del
credito. Essa dunque da quel contratto non trasse un credito nei confronti della
banca, oggi rivendicabile dal curatore. Piuttosto dette luogo, nella stessa
costruzione proposta dalla curatela, all'illecito di cui si discute.
Dunque non può ragionarsi in termini di compensazione delle colpe, come
pretende la curatela, giacchè l'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c., non può
applicarsi al caso in cui entrambe le parti del rapporto danno vita,
consapevolmente, al medesimo illecito, riguardando la norma codicistica la
fattispecie nella quale distinte condotte, diversamente efficienti a produrre
l'evento di danno, ma tuttavia l'una avente titolo nella colpa, concorrono a
produrre
l'evento
pregiudizievole.
Nelle vicenda in esame si ha che l'abuso del credito affermato si è perfezionato
mediante la conclusione di un contratto al quale la s.r.l. partecipò con i suoi
organi, a tanto legittimati dai suoi statuti. Potrebbe, al più, ipotizzarsi una
responsabilità di costoro per mala gestio, ma questa esclude comunque
l'azione risarcitoria di cui si tratta per la ragione che alcun diritto di credito
verso il proprio contraente in capo alla società finanziata abusivamente potette
nascere, da un fatto illecito prodotto anche da attività infedele dei suoi
rappresentanti.
Ragionare diversamente, pare il caso di osservare, vorrebbe dire ammettere
che la banca dopo di avere subito l'azione risarcitoria, e dunque avere conferito
alla massa l'equivalente del pregiudizio arrecato, possa poi, non essendo
venuta meno la sua qualità di creditore del fallito, partecipare al riparto della
massa così costruita e riprendere quanto versato. Siffatto duplice eventuale
ruolo della banca, creditrice e insieme responsabile di un pregiudizio, viene
autorevolmente indicato in dottrina come ulteriore ragione di esclusione della
100
legittimazione
di
cui
si
tratta.
4.f. Osserva ancora la Corte che la abusiva concessione del credito per
perfezionarsi e produrre pregiudizio, non deve essere collegata di necessità
all'evento fallimento, come la suggestiva prospettazione del ricorrente sembra
supporre. Essa infatti rimane illecita e dunque possibile fonte di pregiudizio
aquiliano, ancorchè non venga seguita dal fallimento ed addirittura prima
ancora
che
questo
si
verifichi.
Una concessione di credito estranea alle regole di corretta amministrazione del
medesimo, mantenendo artificialmente in vita una impresa quando essa invece
dovrebbe uscire dal mercato, le consente di continuare una concorrenza che
altrimenti non eserciterebbe. Con ciò essa, quale ne possa essere la sorte,
produce danno di natura concorrenziale al concorrente, il quale a prescindere
dal fallimento, può esercitare azione risarcitoria nei confronti della impresa
stessa,
oltre
che
della
banca.
Si deve dunque dedurre che l'effetto dannoso della attività illecita di cui si
tratta non è di necessità e dunque esclusivamente la erronea percezione della
solvibilità della impresa finanziata. Lo specifico effetto piuttosto è
potenzialmente plurimo, e dipende dalla relazione giuridica con il terzo
danneggiato. Situazione tutt'affatto estranea a quella caratterizzata dalla
omogeneità
delle
azioni
di
massa.
Nella fattispecie in esame il fallimento della impresa abusivamente finanziata,
come autorevole dottrina ha chiarito, si pone che evento storico, non
essenziale a renderla rilevante. Laddove invece, ad esempio un pagamento
effettuato con modalità anomale, rileva quale oggetto di una revocatoria
fallimentare,
solo
se
è
seguita
dal
fallimento.
In questo senso peraltro deve essere intesa la giurisprudenza della Corte di
Cassazione che si è occupata dell'abuso del credito al fine di determinare la
competenza territoriale sulla relativa domanda (oltre alla già citata ord. n.
12369
del
2001,
vedi
la
n.
13934
del
2003).
Essa osserva che tale competenza si individua con riferimento al luogo nel
quale si è verificato l'evento dannoso, che non è costituito dal fallimento, fatto
estraneo alla struttura del danno, ma dall'aggravamento del dissesto
economico della impresa artificiosamente tenuta in vita. Evento che per
l'appunto si realizza laddove essa svolge la sua attività economica.
4.g. Tale considerazione toglie utilità alla prospettazione ulteriormente
avanzata dalla ricorrente relativa alla piena coincidenza del pregiudizio alla
massa con quello al patrimonio della società, di cui s'è detto nel rilevare la
inammissibilità quale motivo di ricorso, e che viene in questa sede adoperata
quelle
argomentazione
di
rincalzo.
4.h. Pare infine utile precisare che la interpretazione che si è appena sostenuta
è coerente con la linea di tendenza che emerge dalle recenti riforme nella
materia fallimentare (D.L. n. 35 del 2005, L. n. 80 del 2005 e D.Lgs. n. 122 del
2005). Mentre infatti le finalità recuperatorie della azione revocatoria risultano
ribadite, viene ulteriormente rafforzata la opinione oramai risalente che
sostiene lo sganciamento dell'istituto dalle forme di tutela nei confronti
dell'illecito, e dunque viene ulteriormente sottolineata la differenza con la
azione ordinaria. Cosicchè pare di dovere concludere che ogni pretesa che pur
riguardando il patrimonio del fallito, allega a fondamento un illecito da questi
101
subito, sfugge alla logica della universalità e della concorsualità, tipiche delle
azioni
esecutive
di
massa.
Con ciò, va pure rimarcato, confermandosi quella autorevole lettura dell'art.
240 L. Fall., che considera, a fronte di un illecito, eccezionale la doppia
legittimazione
ad
agire
del
curatore
e
del
creditore.
Il
motivo
deve
essere
respinto.
5. Vanno dunque rigettate le prime due doglianze del ricorso incidentale e le
prime
due
doglianze
del
ricorso
principale.
Gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per la assegnazione alla Sezione
Semplice che dovrà esaminare le restanti questioni.
P.Q.M.La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo ed il secondo motivo del
ricorso incidentale ed il primo ed il secondo motivo del ricorso principale.
Rimette gli atti al Primo Presidente per la assegnazione della causa alla sezione
semplice
per
l'esame
delle
restanti
questioni.
102
CASS. CIV. -SEZ. III- 6 LUGLIO 2006, N. 15383- PRES. NICASTROEST. SEGRETO
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 18.11.1998, Andrea Bollesi, proponeva appello
avverso la sentenza del giudice di pace di Ancona n. 3 02/1998, con la quale veniva
respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti dallo stesso in occasione del
sinistro occorso il 30.7.1996, in Ancona, mentre alla guida della propria autovettura
percorreva via Passo Varano ed, a seguito dello spostamento improvviso sulla
sinistra dell'auto che lo precedeva, finiva con la ruota posteriore in un tombino
scoperto, non segnalato, il cui coperchio era appoggiato in vicinanza dell'apertura,
riportando danni.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il 13.6.2002, rigettava l'appello.
Riteneva il tribunale che nella specie, trattandosi di bene appartenente al demanio
stradale comunale, non era ipotizzabile una responsabilità del Comune a norma
dell'art. 2051 ce, ma solo ai sensi dell'art. 2043 ce, ove fosse stata ravvisabile
un'insidia stradale; che nella fattispecie l'attore avrebbe potuto far valere la
responsabilità da custodia nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Servizi (dotata
di propria soggettività giuridica), in quanto gli operai di tale azienda avevano
sollevato il coperchio del telaio; che nessuna colpa poteva ravvisarsi a carico del
Comune, in quanto lo scoperchiamento del tombino costituiva un caso fortuito
posto in essere da un terzo, che escludeva il nesso di causalità.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore.
Non ha svolto attività difensiva il convenuto.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 2051 ce, in relazione all'art. 2967 ce.., nonché la violazione
dell'art. 21 del Cod. strad. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione.
Assume il ricorrente che erratamente la sentenza ha ritenuto che la responsabilità
del Comune per danni dall'uso di strada comunale fosse ristretto alle sole ipotesi di
danni da insidia stradale ex art. 2043 ce, mentre andava affermata la
responsabilità dell'ente, quale custode a norma dell'art. 2051 e e ; che, ove anche
fosse stata ritenuta la custodia del bene da parte della Azienda, cui erano stati
appaltati i lavori di manutenzione della strada, ciò non escludeva che rimaneva
custode della stessa anche il Comune, essendo essa aperta al traffico, con i
conseguenti obblighi imposti dall'art. 21 cod. strad.; che conseguentemente nessun
caso fortuito poteva ritenersi sussistere; che, in ogni caso, l'apertura del tombino
integrava un'insidia stradale per l'attore, che, proseguendo a ridosso della vettura che
lo precedeva, non era in grado di avvistare la detta apertura.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Osserva questa Corte che esistono quattro orientamenti giurisprudenziali in merito
alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni
demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente
manutenzione di strade pubbliche. Secondo 1'orientamento predominante questa
tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 ce. Si osserva, infatti, che
la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e
controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di
regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e
103
diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem
laedere (art. 2043 ce), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene
demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile
e non prevedibile, che dia luogo al ed. trabocchetto o insidia stradale.
Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 ce,
della p.a. per danni riportati dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile o
almeno prevedibile (26/05/2004, n.10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass.
28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742; Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte
altre).
La giurisprudenza nei primi anni del 1900 iniziò ad affermare il principio della
responsabilità della P.A. conseguente alla violazione colposa delle regole di
prudenza e di esperienza nell'ambito della attività amministrativa, fissando il limite
oltre il quale la discrezionalità (e la correlata insindacabilità del suo
comportamento da parte dell'autorità giudiziaria) doveva arrestarsi, e sostenendo la
rilevanza sul piano civilistico della inosservanza delle regole di prudenza, perizia e
diligenza anche con riguardo alla specifica materia della manutenzione stradale. In tale
contesto la giurisprudenza in un primo tempo elaborò la figura della insidia o
trabocchetto quale elemento sintomatico della attività colposa dell'amministrazione,
ricorrente allorché la strada nascondeva una insidia non evitabile dall'utente con
l'ordinaria diligenza,- successivamente, peraltro, tale nozione divenne un indice
tassativo ed ineludibile della responsabilità della P.A., e l'onere probatorio in ordine
alla sua sussistenza ricadeva a carico del danneggiato.
Tale orientamento costituisce sostanzialmente ancor oggi un elemento fondamentale
per l'affermazione della responsabilità della P.A. ex art. 2043 ce. con riferimento ai
danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche,
ricondotta infatti all'inosservanza del principio del "neminem laedere", ma sempre a
condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla
non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
2.2.Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p.a.,
proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla
disciplina di cui all'art. 2051 ce, assumendo che la p.a., quale custode di detta
strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051
ce, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come
conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza
dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha 1 ' onere di
provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che
provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22.4.1998, n.
4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3 giugno
1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
In particolare dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno
dell'abitato (art. 16 lett. b della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discende
non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15
novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia con conseguente
operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi
dell'art. 2051 ce .
Per danni causati da beni demaniali, è fortemente sostenuto in dottrina che il ritenere
non applicabile alla stessa per tale categorie dei beni la responsabilità da custodia,
104
ma solo quella ex art. 2043 ce, costituirebbe un ingiustificato privilegio e, di
riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.
3.1.Un orientamento intermedio, che è andato sempre più sviluppandosi negli
ultimi tempi, ritiene che l'art. 2051 ce, in tema di presunzione di responsabilità
per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - in realtà -trova
applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni
demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e
diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in
situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad
impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 3 0 ottobre 1984 n. 5567), ovvero,
ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata
estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse
(Cass. 5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592;
Cass. 15/01/2003, n.488; Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n.11446).
3.2. Una recente sentenza di questa Corte (20.2.2006, n. 3651) ribadisce il principio
che, poiché custode dei beni demaniali è la P.A., essa risponde dei danni
provocati da detti beni a norma dell'art. 2051 ce. La peculiarità di questa sentenza
è nell'escludere che la responsabilità del custode ex art. 2051 ce costituisca una
responsabilità oggettiva, cioè "una responsabilità senza colpa", poiché
fondamento della responsabilità è la violazione del dovere di sorveglianza, gravante
sul custode. Secondo tale arresto il caso fortuito, che esclude la responsabilità,
non costituisce un elemento esterno che incide sul nesso causale, ritenendo, invece
che la prova del fortuito (prova liberatoria) attiene alla prova che il danno si è
verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, per cui la
prova del fortuito attiene al profilo della mancanza di colpa da parte del custode, mentre
l'estensione del bene demaniale e l'uso diretto della cosa da parte della collettività
sono elementi sintomatici per escludere tale presunzione di colpa a carico del
custode. Tale sentenza, quindi, non solo inquadra la responsabilità della P.A. per
danni da beni demaniali nell'ambito dell'art. 2051 ce, ma soprattutto riporta la
responsabilità del custode nell'ambito della responsabilità per colpa, nella specie
presunta.
4. La problematica in questione è stata esaminata dalla Corte Costituzionale
(10/5/1999 n. 156) , che ha ritenuto infondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, ce. in rapporto agli
artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in
alcune sentenze, "la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da
parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del
potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe
essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura
demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice
con
riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità".
La Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, richiamato il principio di
autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare
attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per
salvaguardare appunto la propria incolumità", ha tra l'altro considerato la nozione
di insidia "come una sorte di figura sintomatica di colpa, elaborata dalla esperienza
giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una
valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere
105
probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice
della responsabilità in esame" (sull'infondatezza della sollevata questione di
incostituzionalità, vedasi anche Cass. S.U. n. 10893/2001). 5.1.11 problema che si
pone, soprattutto per effetto della sentenza n. 3651/2006, è, in primo luogo, quello di
riesaminare il tipo di responsabilità del custode, al fine di sperimentarne l'applicabilità nei
confronti del titolare di beni demaniali. La giurisprudenza costante di questa Corte
ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 ce, ha
base:
a)
nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla
cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere
fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il
controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In questo senso, in buona
sostanza, è anche la suddetta Cass. n. 3651/06.
5.2. A fronte del suddetto tradizionale orientamento giurisprudenziale
tradizionale, che individuava nella norma in questione un caso di presunzione
di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe stato pur sempre il fatto
imputabile dell'uomo (nella specie del custode), che era venuto meno al suo dovere di
controllo e vigilanza perché la cosa non producesse danni a terzi (in questo senso,
in buona sostanza, è anche la suddetta Cass. n. 3651/06) , la maggioranza della
dottrina recente ritiene che il comportamento del responsabile è estraneo alla
fattispecie e fa quindi giustizia di quei modelli di ragionamento che si limitano ad
accertare la colpa del custode, sia essa presunta o meno, parlando in proposito di
caso di responsabilità oggettiva. La responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia (art. 2051 ce.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in
concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno
di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non
presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto
per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la
responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso
e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in
relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente
dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile
bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte
immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di
accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea
alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove
largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a
nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti
nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis
Cass.
10/03/2005, n.5326; Cass.10/08/2004, n.15429, Cass. 15/03/2004, n.5236; Cass.
15/01/2003, n.472; Cass. 20/08/2003, n.12219; Cass. 9/04/2003, n.5578; Cass.
15/01/2003, n.472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
5.3.Ritiene questa Corte di dover ribadire tale orientamento.
Solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo).
106
La responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non
l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie.
Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla
struttura della normativa; né può esservi reintrodotto attraverso la figura della
presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite
previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude
che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa.
Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in
custodia.
La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella
custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di
"presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".
5.4.Osserva questa Corte che il dato lessicale della norma in esame ritiene
sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il
responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera
dell'art. 2051 ce, emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per
quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa (fait de la chose - art. 1384, e 1,
Code Napolèon) , per cui detto comportamento è irrilevante.
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è sì colui che essenzialmente ha la cosa
in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di
custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Qui la nozione di
"custodia" non ha la stessa valenza del diritto romano né quella propria della
responsabilità contrattuale, per cui non comporta l'obbligo comportamentale del
soggetto di controllare la cosa per evitare che essa produca danni: essa non
descrive nuli'altro che la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene. Il
custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la
cosa ha provocato danni a terzi. Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove
trovasi la norma in questione e cioè tra altre (artt. 2047, 2048 e 2050 ce, art. 2054
ce, 1° comma) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla
responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha
appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.
5.5.11 fortuito esclude la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 ce. Esso va
inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso
danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass.
10/03/2005, n.5326; Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass. 26 febbraio 1994, n.
1947).
Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode,
ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché
il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che
attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie
degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 ce), ma alle modalità di causazione del
danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in
quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento
esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente
verificatosi.
All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento
lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
107
5.6. Va, quindi, riassorbita la tesi sostenuta da Cass. n. 3651/06, secondo cui il
caso fortuito altro non costituirebbe che la presenza di un evento che esclude la colpa
del custode, con la conseguenza che anche questa ipotesi di responsabilità sarebbe
di tipo soggettivo, con presunzione di colpa a carico del custode, salva la prova
liberatoria della mancanza di colpa, cioè, in positivo, della presenza del fortuito.
Tale impostazione risente del principio
della tradizione romanistica e di una
parte della dottrina classica tedesca, secondo cui " nessuna responsabilità
sussiste senza colpa", per cui casus = non culpa, mentre la dottrina moderna
riconosce pacificamente la presenza di ipotesi di responsabilità oggettiva,
considerandole come approdo delle legislazioni moderne. Anche in Germania, il cui
sistema è strenuamente preoccupato della centralità della colpa sul piano
dell'affermazione di principio ($ 823 del BGB), la Gefahrdungshaftung si è
sviluppata come un vero e proprio sistema di responsabilità oggettiva
rigorosamente legislativo, per quanto esterno al BGB.
A fronte delle resistenze verso un tipo di responsabilità fondata sulla pura causalità,
si è osservato che il criterio di imputazione reagisce sul rapporto di causalità. Un
rapporto causale concepito allo stato puro tende all'infinito. La responsabilità
oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di
imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali
svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima funzione che da
sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti. Nella
responsabilità oggettiva sono i criteri di imputazione ad individuare la sequenza
causale, tendenzialmente infinita, alla quale fare riferimento ai fini della responsabilità.
Tale criterio di imputazione nelle specifiche fattispecie di responsabilità oggettive è
fissato dal legislatore con una qualificazione del soggetto, su cui viene fatto ricadere
il costo del danno.
La ratio di tale accollo del costo del danno non è più la colpa, ma un criterio
oggettivo, che tuttavia rimane fuori dalla norma.
Esso fu individuato nella deep pocket (tasca ricca) negli ordinamenti del
common law e nella richesae oblige, nella tradizione francese, mentre
nell'affinamento dottrinale successivo si è ritenuto che la ratio vada individuata
nel principio dell'esposizione al pericolo o all'assunzione del rischio, ovvero
nell'imputare il costo del danno al soggetto che aveva la possibilità della eoet.benefit analysis, per cui doveva sopportarne la responsabilità, per essersi trovato,
prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più
conveniente, sicché il verificarsi del danno discende da un'opzione per il medesimo,
assunta in alternativa alla decisione contraria.
5.7.Sennonché, ciò che va ribadito, è che quanto sopra individua la ratio del
criterio di imputazione del rapporto di causalità ad un determinato soggetto e non
ad altri, effettuata a monte dal legislatore, ma non comporta un ulteriore elemento di
integrazione della fattispecie di responsabilità, costituito da un sindacato da parte del
giudice sulla scelta effettuata dal soggetto su cui la norma accolla il costo del danno.
Nella responsabilità oggettiva il giudizio è puramente tipologico e consiste
nell'appurare se l'evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli
che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro
semplice accadere.
In questi termini è esatta la centralità del nesso causale nelle ipotesi di
responsabilità oggettiva.
108
Mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento
materiale è appunto costituito da condotta,nesso, causale, ed evento naturalistico o
giuridico) , ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto
in quanto tale.
E tuttavia un "fatto" è pur sempre necessario perché la responsabilità sorga,
giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza di una delle fattispecie
normative di cui agli artt. 2043 e segg. ce. ( sia di responsabilità oggettiva che
soggettiva), le quali tutte si risolvono nella descrizione di un nesso, che leghi
storicamente un evento ad un soggetto chiamato a risponderne.
il "danno" rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di
conseguenze risarcibili o evento dannoso, retto il primo dalla causalità materiale ed il
secondo da quella giuridica.
Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il
danno conseguenza del fatto lesivo(questo inteso come condotta, nesso causale
ed evento lesivo).
Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria.
5.8.Proprio in conseguenza di ciò si è consolidata nella cultura giuridica
contemporanea l'idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che esistono
due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la
responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di
fatto, è analoga a quella penale, artt. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento
lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto
dell'obbligazione risarcitoria. A questo secondo momento va riferita , la regola
dell'art. 1223 ce, per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che
siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (ed. causalità giuridica, per
cui si è dubitato che la norma attenga al nesso causale e non piuttosto alla
determinazione del quantum del risarcimento, selezionando le conseguenze
dannose risarcibili).
Ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana la
giurisprudenza e la dottrina prevalenti fanno applicazione dei principi penalisti di cui
agli artt. 40 e 41 c.p..
5.9.Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme
restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del
secondo (ed. teoria della condicio sine qua non) : ma nel contempo non è sufficiente
tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante,
dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle
soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono inverosimili
(ed. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale(Cass. 16/12/2004,
n.2343; Cass. 26/03/2004, n.6071; Cass. 3/12/2002, n.17152; Cass. 29/07/2004,
n.14488; Cass. 19/08/2003, n.12124; Cass. 22/10/2003, n.15789; Cass.
15/01/2003, n.484).
Secondo tale teoria della causalità adeguata, elaborata dalla dottrina tedesca ( e
sostanzialmente anche secondo la variante italiana della cosiddetta teoria della
causalità umana) per l'imputazione oggettiva dell'evento occorrono due presupposti:
uno positivo (la raffigurazione della condotta dell'agente come condizione necessaria)
ed uno negativo, cioè la mancanza di fattori esterni eccezionali, da valutarsi non ex
post, ma ex ante.
109
Detta causalità adeguata (nella sua tradizionale formulazione "positiva") comporta che
la rilevanza giuridica della "condicio sine qua non" è commisurata all'incremento, da
essa prodotto, dell'obiettiva possibilità di un evento del tipo di quello effettivamente
verificatosi.
5.10.Sennonché, una volta ritenuto che nella responsabilità aquiliana, il nesso di
causalità materiale è regolato dalle norme penalistiche , non può poi decamparsi da
esse allorché si tratti del caso fortuito, previsto dall'art. 45 c.p., che esclude la
punibilità di "chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore".
La dottrina e la giurisprudenza penalistiche tradizionali ritenevano che il caso fortuito
presupponesse il nesso causale e che esso operasse nell'ambito della colpevolezza,
quale causa di esclusione della stessa (ed in questi termini sembra muoversi anche
la suddetta sentenza civile n. 3651/06) . Sennonché, da oltre quaranta anni, la dottrina
penalistica dominante ritiene che il fortuito costituisca una causa di esclusione del
nesso causale in quanto l'art. 45 c.p. , nel far seguire al verbo " ha commesso" la
preposizione "per", sta ad indicare "a causa di".
In ogni caso la suddetta dottrina rileva, in modo pienamente condivisibile, che solo
la concezione del fortuito come esclusione del nesso causale si coordina con il
precedente art. 41 cpv., secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto
di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento e
soprattutto con il principio di regolarità causale o causalità adeguata.
Infatti la considerazione oggettiva del fortuito, inteso come avvenimento
obbiettivamente non prevedibile come verisimile, è l'unica compatibile con la
teoria della causalità adeguata. Allorché si dichiara che la valutazione del fortuito,
come causa di esclusione della colpevolezza e non del nesso di causalità (ovvero
come causa concorrente), presuppone già risolta la questione del rapporto di
causalità tra la condotta e l'evento verificatosi, si finisce per creare un duplicato del
caso fortuito, uno di natura oggettiva e l'altro di natura soggettiva. Ciò è
inesatto, giacché non può tenersi conto del casus due volte, prima in sede di
causalità e poi in sede di colpevolezza.
Sotto il profilo eziologico il caso fortuito svolge a monte la stessa funzione che la
"causalità adeguata" svolge a valle relativamente all'evento, ma pur sempre
nell'ambito dell'elemento materiale e non in quello soggettivo: esclusione
dell'imputabilità per imprevedibilità ed inevitabilità oggettiva (nel primo caso del
fatto causante, nel secondo dell'evento causato).
6.1. Così riportata la responsabilità da cose in custodia nell'ambito della
responsabilità oggettiva, occorre stabilire quali siano i limiti ed il contenuto della
"custodia", che è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 ce. ed è il
criterio che consente di identificare il soggetto tenuto a risarcire il danno cagionato dalla
cosa, al fine di esaminare se ed in quali limiti la P.A. possa essere responsabile ex art.
2051 ce, quale custode di beni demaniali, per poi esaminare, nei casi positivi, in
quali termini possa per essa operare l'esimente del caso fortuito.
Secondo una tesi il concetto di custodia si deve collegare a quello di uso, godimento,
sfruttamento economico della cosa: al custode si imputa la responsabilità, giacché è al
soggetto che trae profitto dalla cosa, secondo il brocardo cuius conmoda eìus et
incomoda, che deve addebitarsi la responsabilità.
La tesi è stata ulteriormente sviluppata dai teorici del rischio-profitto, che hanno
ritenuto che la custodia si sostanzia nel dovere di controllo sul rischio derivante dalla
110
cosa, distinguendo tra rischi tipici e rischi atipici, rimanendo a carico del
custode solo i primi.
6.2.Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, cui questa
Corte aderisce, la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive
un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione
qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio,
sulla scia del Gardien (dell'art. 1384 Code Napoleon) e del Besitzherr (§ 854
B.G.B.). Responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario, come
nei casi di responsabilità oggettiva di cui agli artt. 2052, 2053 e 2054, ult. e, C.C.,
ma il custode della cosa.
E' dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e
la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di "
governo della cosa".
La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale)
tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia ( ma la fa solo presumere),
allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la
potestà sulla cosa, (ad esempio il conduttore o il concessionario).
Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la
cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di
escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il
danno.
Solo così intendendo il contenuto della custodia, si dà ragione del criterio di
imputazione costituito dalla relazione di custodia tra il soggetto custode e la cosa
che ha prodotto il danno.
Infatti - come detto - il criterio di imputazione esiste anche nelle ipotesi di responsabilità
oggettiva, ma non è più fondato su criteri soggettivi, ma su criteri oggettivi, come tali
tipologici. Il concetto di responsabilità implica quello di sanzione per un fatto che
l'ordinamento connota negativamente nei confronti di colui sul quale ne fa gravare il
costo. 6.3.Poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa,
certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla
natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso
sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo
del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di
pericolo.
Va qui, specificato che, attraverso questa analisi del concetto di "custodia" nel suo
contenuto di "potere di governo" della cosa, non si vuole reintrodurre in modo
surrettizio, un elemento di soggettività della responsabilità ex art. 2051 ce,
inserendolo nell'elemento della custodia,
da cui discenderebbe che il custode,
che avesse tuttavia controllato senza colpa, sarebbe esente da responsabilità per il
danno verificatosi.
Non vi è dubbio, come sopra detto, che il custode risponde dei danni prodotti dalla
cosa
non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma più
semplicemente per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa
danneggiante, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità
oggettiva.
6.4. Ciò comporta che la possibilità o meno del potere di controllo va
egualmente accertata in termini oggettivi nello specifico caso di predicata custodia.
111
Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non
vi è responsabilità della p.a., ai sensi dell'art. 2051 ce.
6.5.Indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la
notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti;
ma tali elementi non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una
costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o
la non applicabilità dell'art. 2051 ce. - non si atteggiano univocamente in
relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del
giudice di merito.
Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà
invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma
dell'art. 2051 ce, per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la
controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre gli estremi, la responsabilità di cui
all'art. 2043 ce. 6.6. Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità
in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in
relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione,
alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso
tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche
le aspettative della generalità degli utenti.
Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393
(vecchio codice della strada) e del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo cod.
strad.) e per loro natura destinato alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli
indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e
dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di
cui all'art. 2051 ce. (Cass. n.298/03; Cass. n. 488/2003).
6.7.Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del
demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del
centro abitato (art. 41 quinqiues 1. 17.8.1942, n. 1150; come modificato
dall'art. 17 1. 6.8.1967, n. 765; art. 9 d.p.r. 6.6.2001, n. 380; art.4 d. lgs.
30.4.1992, n. 285). infatti la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro,
dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi
che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza
costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e
vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti
oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale. 6.8.Ove l'oggettiva
impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 ce, come detto, la
tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di
cui all'art. 2043 ce.
in merito a questa va specificato che la responsabilità della p.a. per danni
conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non
può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto: questi, come è stato rilevato,
sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a.,
ma ciò non esclude che
possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo
della p.a.. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli
utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non
trova alcuna base normativa nella Generalklausel di cui all'art. 2043 ce, con
112
un'indubbia posizione di privilegio per la p.a. (in questo senso, già Cass.
14.3.2006, n. 5445).
Una volta ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2 043 ce non vi è una
ragione, normativamente fondata, né per effettuare una limitazione del contenuto
precettivo della norma né per un diverso riparto dell'onere probatorio. In questo caso
graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale ( e
segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare
il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti
impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o
trabocchetto- la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.". 7.1.Sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri
nell'art. 2043 ce. sia che rientri nell' art. 2051 ce, è rilevante l'eventuale
comportamento colposo del danneggiato ,poiché esso incide sul nesso causale.
In un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo
centrale, diventa fondamentale accertare se
1'evento eziologicamente derivi
in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone,
quindi, 1'eventuale apporto causale.
Come sopra detto, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto
del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di
costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare
dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente
comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998,n. 6640; Cass. 7 aprile
1988, n. 2737).
7.2.Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227, e. 1, ce, il
quale nel contempo dà base normativa al suddetto principio, presupponendolo.
Tale norma prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del
danneggiato: essa è un approdo dei codici moderni.
In passato, invece, l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva
venir meno la responsabilità del danneggiante, tranne che sussistesse il dolo di
costui.
Nei sistemi di common
low
si parlava di contributory negligence,
contributory
negligence
ed attualmente di comparati ve negligence.
Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di
autoresponsabilità, segnatamente previsto dall'art. 1227, e. 1 ce, oltre che da
altre norme, che imporrebbe ai, potenziali danneggiati doveri di attenzione e
diligenza. L'autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per
indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali
responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli.
7.3.Senza entrare nella questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del detto
principio di autoresponsabilità, va solo rilevato che la dottrina più recente, che questa
Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'art
1227, e. 1, ce. sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi
piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far
carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto la
colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 e .e., va intesa non nel senso di criterio di
imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto
illecito dì cui all'art. 2043 ce), bensì come requisito legale della rilevanza causale
del fatto del danneggiato. 7.4. La regola di cui all'art. 1227 ce. va inquadrata
113
esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio
che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura
a se stesso(Cass. civ. 26/04/1994, n.3957; Cass. 08/05/2003, n.6988) .
La colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 ce, va intesa non nel senso di criterio di
imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto
illecito di
cui all'art. 2043 ce), bensì come requisito legale della rilevanza
causale del fatto del danneggiato. * Proprio perché è rimasta superata la teoria
del principio autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del
comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227, 1 e, ce,
è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente
idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo
giuridico, cui si richiama l'art. 41, e 2, c.p.c, allorché il danno trovi la sua causa
nel comportamento omissivo di altro soggetto.
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante
la genericità dell'art. 1227,e I, ce sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi
di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche
nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della
colpa generica.
Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato
nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto,
per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo colposo del
danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di
causalità delle cause precedenti.
7.5.In questa ottica la diligenza del comportamento dell'utente del bene
demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in
relazione all'affidamento
che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di
quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e
di tempo.
Per il principio dell'affidamento il fatto che una persona agisca come membro di un
determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper
riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e
capacità del gruppo.
Qui non si tratta di introdurre - specularmente - in relazione alla posizione del custode
l'elemento dell'esigibilità o meno di una diversa condotta , poiché 1'inesigibilità,
indipendentemente dal punto se abbia ingresso nella struttura dell'illecito civile, in
ogni caso non potrebbe operare che nell'ambito dell'elemento soggettivo, come
avviene nella struttura dell'illecito penale (ove peraltro la figura e controversa e non
riconosciuta dalla giurisprudenza), con la conseguenza che essa sarebbe irrilevante
in ipotesi di responsabilità oggettiva.
Qui il problema si pone solo in relazione al comportamento colposo o meno del
danneggiato, il quale è connotato dall'affidamento, secondo criteri oggettivi e non
soggettivi, che egli ripone nel ritenere esigibile da parte della p.a. custode, una
determinata condotta di custodia in relazione ad un determinato bene.
In questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta
applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o
escludendolo o dando un apporto concorrente.
In applicazione di tale principio, la diligenza che è richiesta al danneggiato
nell'uso del bene demaniale, costituito nella specie da strada, sarà diversa a
114
seconda che si tratti di una strada campestre o del corso principale della città, pur
facendo capo entrambe allo stesso demanio stradale dello stesso Comune, proprio
perché il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo-custodia
(che quindi ritiene esigibile) in relazione ai due tipi di strada dello stesso demanio.
7.6.Così inquadrato sotto il profilo eziologico (ex art. 1227, ci, ce.) il comportamento
colposo del danneggiato-utente del bene demaniale (nella fattispecie: stradale), va
osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice
difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza
nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e
richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si
fonda il comportamento colposo del danneggiato (Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass.
9.10.2000, n. 13403; Cass. 3.12.1999, n. 13460).
Ciò vale sia nel caso di azione proposta ex art.2051 ce. che ex art. 2043 ce. .
8.1.
Sulla base di quanto sopra esposto vanno affermati i seguenti principi di
diritto:
"La responsabilità ex art. 2051 ce per i danni cagionati da cose in custodia , anche
nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e,
perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che
sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi
al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza,
per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che
attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale
dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un
elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e
che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante".
8.2.
"La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art.
2051 ce, non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni
demaniali ( nella fattispecie: del demanio stradale) ogni guai volta sul bene
demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia,
intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e
l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure
sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A.,mentre elemento
sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è
che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel
perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze,
proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del
giudice di merito".
8.3. "Ove non sìa applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 ce,
per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente
pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale
dettata dall'art. 2043 ce, che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della
P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In
questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene
demaniale ( e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio a configurare il comportamento colposo della P.A. daini" i-uu., sulla quale ricade l'onere
della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica
115
dell'insidia o trabocchetto- la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o
prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
8.4. "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 ce, quanto in
ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 ce, il comportamento colposo del
soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli
abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento
soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso,
integrando, altrimenti,un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 ce primo
comma, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in
proporzione ali'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
9. Nella fattispecie, quindi, è errata in diritto l'impugnata sentenza per avere escluso
già in astratto che il Comune di Ancona potesse essere responsabile ex art. 2051
ce, quale custode della strada in questione, senza valutare se in concreto fosse
possibile esercitare il controllo e la vigilanza sul demanio stradale di quella
città,vagliando anche le figure sintomatiche suddette (punto 8.2).
10.1. Quanto al punto secondo cui in ogni caso la custodia faceva capo
all'Azienda di manutenzione servizi e non al Comune, per essere stati alla prima
affidati i lavori di manutenzione, va osservato che è stato già precisato, in via
generale, che, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del
potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba
continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene
meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex
art. 2051 ce, da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito (Cass., n.
5007/96; Cass., n. 5539/97).
E' stato in particolare affermato da questa Corte che, con riguardo a lavori
stradali eseguiti in appalto su concessione dell'Anas, che abbiano comportato
insidia o trabocchetto causativi di sinistro, per mancanza di cartelli di segnalazione e
conseguente invisibilità della esatta ubicazione del pericolo, è configurabile la
concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore - in relazione al suo obbligo di
custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonché di
adottare tutte le cautele prescritte dall'art. 8 e strad. e relativo regolamento - quanto
dell'Anas, in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in
concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del
traffico (Cass. 25/09/1998, n.9599; Cass. 25/09/1990, n.9702).
10.2.Ne consegue che, se l'area di cantiere è stata completamente enucleata,
delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con assoluto divieto del
traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area non potrà che
risponderne esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode della stessa.
Se, invece, l'area su cui vengono realizzati i lavori è ancora contestualmente
adibita a tale traffico, ciò denota che l'ente titolare della strada ne ha conservato la
custodia, sia pure insieme all'appaltatore, utilizzando la strada ai fini della
circolazione.
Né potrebbe ritenersi in questo caso che l'estensione del bene demaniale nel suo
complesso escluda la possibilità della custodia da parte dell'Ente. Qui infatti ciò
che viene in rilievo è esclusivamente l'area adibita promiscuamente ai lavori ed
alla circolazione, per cui essa è necessariamente di ridotte dimensioni. Inoltre se
per tale area si ritiene possibile la custodia da parte dell'appaltatore, non si vede la
116
ragione per cui non sia possibile la custodia anche da parte dell'Ente titolare della
strada, che ne ha conservato il potere di fatto ai fini della circolazione degli utenti.
10.3.Ciò comporta che la responsabilità per danni subiti dall'utente a causa
dei lavori in corso su detta strada graverà su entrambi detti soggetti, salvo poi
l'eventuale azione di regresso dell'ente proprietario della strada nei confronti
dell'appaltatore dei lavori a norma dei comuni principi in tema di responsabilità
solidale (art. 2055, e 2, ce.) , tenuto anche conto della violazione degli obblighi di
segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere, depositi e cantieri
stradali (art. 21 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) nonché di quelli assunti
dall'appaltatore della manutenzione della strada nei confronti dell'ente proprietario, in
base a specifica convenzione.
10.4.Né può ritenersi, come assume la sentenza impugnata, che "il fatto del
soggetto assuntore dei lavori" (id est: dei suoi dipendenti) costituisca
un'ipotesi del "fatto del terzo", integrante caso fortuito e quindi idoneo ad
interrompere il nesso causale tra la custodia ed il danno ingiusto.
Ciò potrebbe essere esatto (sia pure in presenza anche di altri elementi) se l'Ente,
titolare della strada, fosse il solo custode della stessa, ma nella situazione in cui si
sia ritenuto che detta custodia è congiunta nell'area del sinistro, il soggetto preposto ai
lavori, in rapporto al fatto di custodia, non è più un terzo, ma è solo un custode
congiunto. Poiché in questa ipotesi la responsabilità è oggettiva { e quindi prescinde
dalla imputabilità per comportamento almeno colposo) e si fonda sulla sola relazione
di fatto con la cosa, entrambi i soggetti rispondono solidalmente del danno ingiusto a
norma dell'art. 2051 ce.
11.L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo
motivo, relativo alla condanna delle spese processuali.
Pertanto va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di
cassazione ad altra sezione del tribunale di Ancona che si uniformerà ai principi di
diritto, esposti al punto 8.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa l'impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra
sezione del tribunale di Ancona. Così deciso in Roma, lì 8 giugno 2006.
117
CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE – SENTENZA 14 LUGLIO 2006,
N. 16123PRESIDENTE FIDUCCIA – RELATORE MASSERA
RICORRENTE VILLANUCCI ED ALTRO
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva in data 1 aprile - 7 maggio 1998 il Tribunale di
Pordenone, pronunciando sulla domanda proposta da Franca Villanucci e
Pierantonio Pignat, in proprio e quali esercenti la potestà di genitori sulle figlie
minori Fabrizia e Fabiana, tra l’altro, accertava la solidale responsabilità
extracontrattuale della USL n. 12 del Livenza e di Franco Magoni, aiuto
primario del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di Sacile,
nei confronti della Villanucci e del Pignat e la concorrente responsabilità
contrattuale della USL n. 12; stabiliva che la RAS era tenuta a manlevare
quest’ultima nei limiti della quota assicurata, pari al 75% del massimale e che
l’Assitalia era tenuta a manlevare il Maioni sino alla concorrenza del massimale
assicurato; respingeva la domanda di manleva svolta dal Maioni nei confronti
della RAS e le domande di Villanucci e Pignat quali esercenti la potestà sulle
figlie
minori.
Con sentenza in data 30 marzo - 18 aprile 2001, la Corte di Appello di Trieste
respingeva tutti gli appelli e, quindi, confermava in toto la sentenza del
Tribunale,
con
integrale
compensazione
delle
spese
del
grado.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il Tribunale aveva
proceduto alla difficile ricostruzione di una domanda prospettata in termini
oscuri e ambigui in ordine sia al petitum, sia alla causa petendi, ritenendo, in
esito ad una interpretazione faticosa ma esatta, che fossero state azionate
cumulativamente tanto la responsabilità contrattuale, quanto quella
extracontrattuale; quindi aveva accertato la responsabilità extracontrattuale
del Maioni per la mancata informazione, nella quale concorreva la USL per il
rapporto di servizio che legava i due soggetti, e la responsabilità contrattuale
della USL per effetto dell’articolo 1228 Cc, mentre aveva escluso la
ravvisabilità della responsabilità contrattuale del medico dipendente, mancando
la prova che costui avesse svolto prestazioni ambulatoriali a pagamento; la
esecuzione di una serie di attività (visite ginecologiche, esami ecografici, parto)
in ambito ospedaliero provavano l’avvenuta stipulazione per facta concludentia
del contratto tra la Villanucci e la struttura pubblica sanitaria; il Maioni aveva
omesso di informare la paziente delle malformazioni del feto rilevate in sede di
esame ecografico e di indicare le malformazioni sulla relativa scheda o cartella;
non risultavano invece provati gli ulteriori comportamenti censurabili che gli
attori imputavano al sanitario; la domanda di quantificazione del danno era
inammissibile, stante il rinvio contenuto nella sentenza impugnata al prosieguo
della causa; le figlie minori non rivestivano la qualità di danneggiate, la nata
malformata poiché non era ancora nata -quindi non poteva essere ritenuta
118
soggetto danneggiato - al momento in cui erano stati tenuti i comportamenti
illeciti addebitati al Maioni, l’altra non essendo stato neppure specificato quale
comportamento del Maioni l’avrebbe danneggiata e quali danni avesse in
concreto subito; i massimali assicurati non dovevano essere rivalutati non
essendo
ciò
giuridicamente
configurabile
e
non essendosi verificato alcun ritardo colposo da parte delle compagnie
assicuratrici; mancava la prova di un contratto del Maioni con la RAS; i
comportamenti del medico erano riferibili alla USL in quanto la sua condotta,
nella fattispecie concreta, era sicuramente coerente con le finalità istituzionali
della struttura sanitaria e il relativo vincolo non era stato spezzato neppure
dalla commissione di un reato essendo il fatto addebitato solo un abuso
commesso nell’ambito dell’attribuzione dell’ente e delle competenze del
dipendente
e
non
per
finalità
personali
egoistiche.
Avverso la suddetta sentenza la Víllanucci e il Pignat, in proprio e nella qualità,
hanno
proposto
ricorso
per
cassazione
affidato
a
tre
motivi.
Hanno proposto separati ricorsi incidentali, ciascuno articolato in due motivi, la
RAS, il Maioni e la Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale già USL
n.
12
del
Lívenza.
I ricorrenti principali, il Maioni e la Asl hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre disporre la riunione dei quattro ricorso, come previsto
dall’articolo
335
Cpc.
Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione degli articoli 5
Legge Regione Friuli Venezia Giulia 25/1985, legge 833/78 e 39 del Codice
Deontologico,
nonché
vizio
di
motivazione.
Le norme citate affermano rispettivamente il diritto individuale dell’utente
all’informazione in termini comprensibili, la finalità in capo al Servizio Sanitario
Nazionale dell’educazione sanitaria che logicamente presuppone l’informazione,
il dovere del medico di dare completa informazione al paziente in conformità
alla sua volontà. Per queste ragioni l’informazione costituisce una
imprescindibile
integrazione
della
prestazione
sanitaria.
La censura, seppur basata su argomentazioni totalmente condivisibili è
inammissibile per manifesta carenza di interesse, in quanto la Corte territoriale
ha addebitato al Maioni proprio le omesse informazioni in ordine alle
malformazioni
riscontrate
nella
nascitura.
La Villanucci e il Pìgnat sostengono che la mancata informazione ha loro
impedito sia di ricorrere alla interruzione della gravidanza o di recarsi in un
paese estero avente un regime giuridico meno rigoroso di quello italiano, sia di
avere
un
approccio
meno
brutale
con
la
realtà.
Ma queste argomentazioni non dimostrano l’erroneità della sentenza
impugnata, poiché essa ha evidenziato appunto sia un illecito contrattuale di
natura professionale (la mancanza di informazione), sia un illecito
professionale di natura extracontrattuale (la lesione del diritto assoluto
119
all’informazione), in relazione ai quali ha confermato la condanna generica al
risarcimento
del
danno
inflitta
dal
Tribunale.
D’altra parte è noto (Cassazione 2793/99) che il risarcimento del danno per il
mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza non consegue
automaticamente all’inadempimento dell’obbligo dì esatta informazione che il
sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o
malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza
delle condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194/78 per ricorrere
all’interruzione
di
gravidanza.
I ricorrenti lamentano anche il mancato invito alla donna a sottoporsi ad
ecografia alla ventesima settimana, oltre alle altre praticate alla prima, alla
quattordicesima,
alla
trentesima
e
alla
trentasettesima.
La contestazione implica imprescindibili valutazioni di merito non consentite in
sede di legittimità e sulle quali si è pronunciata la Corte d’Appello.
D’altra parte gli elementi testuali ricavabili dalla sentenza impugnata e dal
ricorso non consentono di stabilire se l’esecuzione della ecografia di cui si
lamenta l’omissione avrebbe fornito elementi più significativi e tempestivi
rispetto a quelli risultanti delle ecografie praticate, che gli stessi ricorrenti
riconoscono
essere
state
in
numero
superiore
al
consueto.
Quanto, poi, alle modalità, tecnica e qualità degli accertamenti strumentali
eseguiti, è agevole rilevare che si tratta di temi preclusi in questa sede, così
come
i
riferimenti
alla
consulenza
tecnica
medico
legale.
Considerazioni dei tutto analoghe valgono per la villocentesi, che la sentenza
impugnata afferma essere stata effettuata per volontà della Villanucci,
avendola costei prenotata prima di sottoporsi alla visita ginecologíca effettuata
dal Maioni (anche questa circostanza viene contestata ma trattasi di questione
di fatto non diversamente ricostruibile in questa sede) e che la pericolosità di
tale
pratica
all’epoca
non
era
ancora
nota.
In altri termini, i limiti istituzionali del giudizio di legittimità non consentono di
apprezzare quella “condotta negligente e omissiva” che i ricorrenti addebitano
al Maioni e che la Corte territoriale ha negato in base all’apprezzamento
motivato delle risultanze processuali. In conseguenza di ciò nessuna
responsabilità è stata attribuita dai due giudici di merito - e certamente non
può esserlo dalla Corte dì Cassazione -al sanitario e all’ente ospedaliero in
ordine alle cause che hanno determinato le malformazioni all’origine della
controversia.
Il
primo
motivo
risulta,
dunque,
infondato.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione degli articoli
2059 - 2056 - 2043 Cc, 1223 Cc e 32 Costituzione, nonché vizio di
motivazione.
La censura concerne il rigetto della domanda di risarcimento a favore delle due
minori, che la Corte d’Appello non ha ritenute soggetti danneggiati. Quanto a
Fabiana, che è appunto la minore affetta dalle gravissime malformazioni,
all’epoca dei comportamenti illeciti attribuiti al Maioni soltanto concepita, i
ricorrenti pongono in evidenza che l’evoluzione giurisprudenziale è nel senso di
riconoscere, in presenza di lesioni gravi del nascituro, la tutela dell’individuo
sin
dal
momento
del
concepimento.
Quanto alla sorella maggiore Fabrizia, assumono che, nella sua qualità di
120
congiunta, ha subito un pregiudizio che investe molteplici versanti.
Il tema concernente la prima minore viene proposto facendo leva su una nota
sentenza di questa stessa sezione che, tuttavia, non è pertinente in quanto
risolve la ben diversa fattispecie in cui le lesioni riportate dal nascituro erano
direttamente imputabili a comportamento colposo dei sanitari, situazione da
escludere nella specie in virtù delle considerazioni vedute con riferimento al
primo
motivo.
Invece il tema particolare proposto dal caso concreto si sostanzia nello stabilire
se la violazione del dovere di informazione cui il sanitario era tenuto e la
conseguente mancata interruzione della gravidanza possano dar luogo al
risarcimento
del
danno
subito
dal
nascituro.
Questa stessa sezione si è già occupata della questione (Cassazione Sezione
terza, 14488/04) stabilendo che l’ordinamento positivo tutela il concepito e
l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non anche
verso la “non nascita”, essendo pertanto (al più) configurabile un “diritto a
nascere” e a “nascere sani”, suscettibile di essere inteso esclusivamente nella
sua positiva accezione: sotto il profilo privatistico della responsabilità
contrattuale o extracontrattuale o da “contatto sociale”, nel senso che nessuno
può procurare al nascituro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o
commissivo colposo o doloso ); sotto il profilo - latamente - pubblicistico, nel
senso che debbono venire ad essere predisposti tutti gli istituti normativi e
tutte le strutture di tutela cura e assistenza della maternità idonei a garantire
(nell’ambito delle umane possibilità) al concepito di nascere sano. Non è invece
in capo a quest’ultimo configurabile un “diritto a non nascere” o a “non nascere
se non sano”, come si desume dal combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6
della legge 194/78, in base al quale si evince che: a) l’interruzione volontaria
della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della
gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave
(successivamente a tale termine ) ; b) trattasi di un diritto il cui esercizio
compete esclusivamente alla madre; e) le eventuali malformazioni o anomalie
del feto rilevano esclusivamente nella misura in cui possano cagionare un
danno alla salute della gestante, e non già in sé e per sé considerate (con
riferimento cioè al nascituro) . E come emerge ulteriormente: a) dalla
considerazione che il diritto di “non nascere” sarebbe un diritto adespota (in
quanto ai sensi dell’articolo 1 Cc la capacità giuridica si acquista solamente al
momento della nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del concepito articoli 462, 687, 715 Cc - sono subordinati all’evento della nascita, ma
appunto esistenti dopo la nascita sicché il cosiddetto diritto di “non nascere”
non avrebbe alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in costanza
della quale proprio esso risulterebbe peraltro non esistere più; b) dalla
circostanza che ipotizzare un diritto dei concepito a “non nascere”
significherebbe configurare una posizione giuridica con titolare solamente (e in
via postuma) in caso di sua violazione, in difetto della quale (per cui non si fa
nascere il malformato per rispettare il suo “diritto di non nascere”) essa
risulterebbe pertanto sempre priva di titolare, rimanendone conseguentemente
l’esercizio definitivamente precluso. Ne consegue che è pertanto da escludersi
la
configurabilità
e
l’ammissibilità nell’ordinamento del c.d. aborto “eugenetico”, prescindente dal
121
pericolo
derivante
dalle
malformazioni fetali alla salute della madre, atteso che l’interruzione della
gravidanza
al
di
fuori
delle
ipotesi di cui agli articoli 4 e 6 legge 194/78 (accertate nei termini di cui agli
articoli 5 ed 8 ) , oltre a risultare in ogni caso in contrasto con i principi di
solidarietà di cui all’articolo 2 Costituzione e di indisponibilità del proprio corpo
ex articolo 5 Cc, costituisce reato anche a carico della stessa gestante (articolo
19 legge 194/78 ), essendo per converso il diritto del concepito a nascere, pur
se con malformazioni o patologie, ad essere propriamente - anche mediante
sanzioni penali - tutelato dall’ordinamento. Ne consegue ulteriormente che,
verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio
danno da inadempimento contrattuale l’essere egli affetto da malformazioni
congenite per non essere stata la madre, per difetto d’informazione, messa
nella condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all’aborto
ovvero di altrimenti avvalersi della peculiare e tipicizzata forma di scriminante
dello stato di necessità (assimilabile, quanto alla sua natura, a quella prevista
dall’articolo 54 Cp) prevista dall’articolo 4 legge 194/78, risultando in tale
ipotesi comunque esattamente assolto il dovere di protezione in favore dì esso
minore, così come configurabile e tutelato (in termini prevalenti rispetto anche - ad eventuali contrarie clausole contrattuali: articolo 1419, secondo
comma,
Cc)
alla
stregua
della
vigente
disciplina.
Ne consegue che la tutela dell’individuo che, con la nascita acquista la
personalità giuridica nella fase prenatale è limitata alle lesioni imputabili ai
comportamenti colposi dei sanitari, ma non si estende alle situazioni diverse
come quella di specie, ove a carico del Maioni la Corte di merito ha accertato
non errori diagnostici e/o terapeutici, ma la mancata informazione a i genitori e
indicazione nella cartella clinica di malformazioni a lui non imputabili.
Ne consegue che correttamente essa ha escluso l’esistenza di un danno
risarcibile a favore di Fabiana e anche della sorella Fabrizia, in quanto non
destinataria del diritto all’informazione, soltanto la cui omissione è stata
imputata
al
Maioni
e,
quindi,
alla
USL.
La Corte si rende conto che la decisione adottata comporta un vulnus ai diritti
delle due minori, ma ritiene che la soluzione positiva di casi come quello di
specie non possa essere ricercata nella elaborazione giurisprudenziale ove
manchi il supporto indispensabile di una normativa che la consenta.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano violazione dell’articolo 91
Cpc
in
tema
di
compensazione
delle
spese
giudiziali.
La censura presuppone l’accoglimento delle tesi esposte nei precedenti motivi
e,
quindi,
rimane
travolta
dal
rigetto
di
esse.
In
definitiva
il
ricorso
principale
va
rigettato.
Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale la RAS lamenta violazione
dell’articolo 112 Cpc e vizio di motivazione assumendo che la domanda dei
coniugi Pignat è stata accolta per ragioni del tutto diverse da quelle
prospettate, in quanto al Maioni era stata imputata una condotta negligente,
imprudente e imperita, ma non la mancata informazione circa la
malformazione.
La censura risulta infondata poiché (Cassazione 11639/02) l’interpretazione
della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia
122
espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era
compresa nel “thema decidendum”, tale statuizione, ancorché erronea non può
essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo
comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una
certa questione debba ritenersi ricompressa tra quelle da decidere, il difetto di
ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che
quella medesima motivazione sia erronea; la sentenza non può pertanto essere
annullata per ultrapetizione se preliminarmente non si annulli quella parte di
essa in cui si sono spiegate le ragioni che hanno indotto alla trattazione della
questione. In tal caso, l’errore del giudice non si configura come “error in
procedendo”, ma attiene esclusivamente al momento logico relativo
all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a
principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza
nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede
di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione di cui
all’articolo 350 n. 5 Cpc, giacché la ricostruzione del contenuto di tali atti è
compito
istituzionale
del
giudice
del
merito.
La Corte d’Appello, con apprezzamento di merito insindacabile in quanto
sufficientemente e razionalmente motivato, ha spiegato di condividere
l’interpretazione che della oscura e confusa domanda il Tribunale aveva
accreditato e di ritenere compresa nella domanda la prospettazione della
responsabilità extracontrattuale del Maìoni per omessa informazione.
In effetti gli attori avevano prospettato nell’atto di citazione e negli atti ulteriori
una serie di questioni tra cui l’omessa informazione a partire dalla trentesima
settimana, anche se essa non costituiva l’argomento centrale della loro
domanda e da essa hanno tratto spunto i giudici dì merito, che invece hanno
escluso i denunciati comportamenti negligenti nella esecuzione dei controlli.
Con il secondo motivo la RAS censura la motivazione della sentenza impugnata
con riferimento alla sussistenza del reato dì cui all’articolo 328 Cp e di una
condotta
dolosa
del
medico.
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto colpevole il deficit informativo del
Maìoni e hanno legittimamente valutato al riguardo anche l’esito del giudizio
penale (le pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata trattano proprio la
questione).
Il relativo accertamento fa leva su apprezzamenti di fatto e su considerazioni di
merito razionalmente esposte, cui la ricorrente contrappone altre di segno
opposto e basate su circostanze (l’esperienza maturata dal Maioni in un
precedente caso analogo) che non possono essere addotte in sede di
legittimità.
In definitiva, il ricorso incidentale della RAS è privo di pregio e va rigettato.
Il ricorrente incidentale Maioni con il primo motivo denuncia violazione degli
articoli 112 Cpc e 2697 Cc e vizio di motivazione con riferimento alle
prospettazioni contenute nella domanda introduttiva del giudizio di primo
grado.
La censura è infondata per le ragioni già addotte in riferimento all’analoga
doglianza espressa dalla RAS. Giova aggiungere che lo stesso ricorrente
ammette che uno dei presupposti della domanda era costituito dal riferimento
all’articolo 328 Cp e che la Corte d’Appello ha spiegato che essa era stata
123
proposta in termini talmente ampi da includervi tutte la possibili conseguenze e
tutti i possibili danni provocati dai comportamenti censurati, inclusi quelli
derivati
dalla
mancata
informazione.
E’ opportuno rilevare ancora, per ragioni di completezza, che non è
contraddittorio stigmatizzare l’oscurità e ambiguità della domanda e poi, una
volta completata l’opera di interpretazione, affermarne l’ampiezza dei
contenuti.
Con il secondo motivo il Maioni lamenta violazione degli articoli 328, 47, 54 e
55 Cp, 2045 e 2059 Cp, nonché vizio di motivazione, in quanto la Corte
territoriale non si è pronunciata sulle proprie censure (assume che ha
esaminato solo gli appelli incidentali della RAS e della USL) non affrontando il
tema della sussistenza del reato dì cui all’articolo 328 Cp, non considerando
che l’esistenza della malformazione alla 30° settimana avrebbe riguardato una
situazione clinica già definita, non reversibile né emendabile, cosi come non ha
considerato un caso precedente e la possibilità che il sanitario avesse errato
nel ritenere non dovuta l’informazione o che sussistesse l’esimente di cui
all’articolo 54 Cp; infine, assume che non si era pronunciata sulla censura
relativa alla posizione del Pignat, che egli aveva contestato essere destinatario
del
dovere
di
informazione.
Premesso che dal testo della sentenza impugnata si evince che l’appello del
Maioni non è stato pretermesso, osserva la Corte che, a prescindere dal rilievo
che il ricorrente non ha ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso,
omettendo di indicare le specifíche argomentazioni sottoposte all’esame della
Corte territoriale, è determinante il rilievo che le questioni concernenti la
sussistenza delI’ipotesi delittuosa configurata dall’articolo 328 Cp e
l’applicabilità dell’articolo 47 Cp (la stessa prospettazione del ricorrente sembra
riferibile più ad un errore di diritto che di fatto, risultando il dovere di
informazione da una normativa specifica) e dell’articolo 54 Cp risultano
superate dalla sentenza penale di questa stessa Corte, cui la sentenza
impugnata fa esplicito riferimento condividendone e recependone le
conclusioni.
Per il resto la stessa Corte territoriale ha osservato che gli attori non hanno
mosso alcun addebito al Maioni sotto il profilo della mancata possibilità dì
scelta di una eventuale interruzione della gravidanza come conseguenza della
mancata
o
ritardata
informazione.
Quanto alla sussistenza del danno e della estensione del medesimo al Pignat
occorre rilevare (Cassazione, Sezione terza, 9709/03 ) che la pronuncia di
condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ex
articolo 278 Cpc, integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel
fatto, e non anche l’accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata
alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale
prescinde dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con
la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel
giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento concreto
della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si
sia
in
concreto
verificato.
La sentenza impugnata ha fondato la propria statuizione sulla diminuzione del
trauma psico-fisico che i genitori avrebbero comunque subito in virtù di una
124
preparazione adeguata all’evento, ove l’informazione fosse stata tempestiva.
Spetterà alla sentenza definitiva stabilire se in concreto tale danno vi sia stato,
chi
lo
abbia
subito
e
quale
ne
sia
stata
l’entità.
Tuttavia occorre rilevare sul piano generale che la posizione “contrattuale”
anche del padre è stata ormai condivisibilmente affermata dalla sentenza
20320/05
di
questa
Corte.
Pertanto anche il ricorso incidentale del Maioli risulta infondato.
Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Azienda per i Servizi Sanitari
propone il tema della violazione degli articoli 2697, 1218, 2043 e seguenti del
Cc e vizio di motivazione della sentenza impugnata assumendo che manca la
prova dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra la Villanucci e la Usl 12 e
che, in ogni caso, non è configurabile alcun rapporto contrattuale con il Pignat.
La prima argomentazione è infondata poiché la Corte territoriale è pervenuta
all’affermazione contestata facendo leva su una serie di indizi (le visite
ginecologiche si sono svolte in ambito ospedaliero, gli esami ecografici sono
stati eseguiti negli ambulatori dell’ospedale, il parto è avvenuto in ospedale)
che ha ritenuto gravi, precisi e concordanti e confortati dalle nozioni di comune
esperienza
dell’id
quod
plerumque
accidit.
Al riguardo si tratta di un accertamento di fatto che - stante la congruità e
razionalità della motivazione - sfugge al sindacato della Corte regolatrice.
Non costituisce violazione dell’articolo 2697 Cc, ma corretta applicazione della
ripartizione dell’onere probatorio, la considerazione della sentenza che,
ritenuto provato in base a quanto sopra sintetizzato il contratto stipulato per
facta concludentia tra la Villanucci e la struttura pubblica, gravava sulla USL
dimostrare che il sanitario aveva svolto la propria attività nell’ambito dì visite
ambulatoriali a pagamento che poteva compiere nell’ambito della sua attività
di
libero
professionista.
Non vi è dubbio che l’effettuazione delle visite in ambiente ospedaliero,
coordinata con gli ulteriori elementi fattuali valorizzati dalla Corte d’Appello,
determini la riconducibilità dell’attività del sanitario alla USL, sulla quale
gravava,
dunque,
l’onere
di
dimostrare
il
contrario.
D’altra parte appare condivisibile anche l’ulteriore affermazione del giudice di
merito circa il mezzo attraverso il quale (le proprie registrazioni) la USL
avrebbe potuto agevolmente dimostrare il proprio assunto, laddove non è dato
vedere di quale altro strumento probatorio, oltre le evidenziate presunzioni,
disponesse la Villanucci per dimostrare il rapporto con la USL.
Ugualmente priva di pregio è la seconda argomentazione sottoposta all’esame
della Corte, la cui infondatezza deriva sia dalla estensione soggettiva del
rapporto contrattuale affermata dalla giurisprudenza appena sopra citata
(Cassazione 20320/05), sia dai principi che disciplinano il ricorso per
cassazione.
L’Azienda per i Servizi Sanitari ha sostanzialmente prospettato una violazione
di legge in tema di definizione dei limiti soggettivi di un contratto, ma ha
omesso di dimostrare di averla già sollevata nel giudizio di appello.
Poiché dal testo della sentenza emessa in quel grado si evince il contrario, in
ottemperanza al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione era
onere della ricorrente dimostrare - riproducendo testualmente il relativo motivo
di appello - di averne specificamente investito la Corte territoriale.
125
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale prospetta violazione degli
articoli 28 Costituzione, 2043 e seguenti e 2949 Cc nonché vizio di motivazione
circa la riferibilità alla USL del comportamento del dipendente.
La censura è esposta in termini che la rendono inammissibile prima che
infondata.
Inammissibile poiché la ricorrente incidentale non prende in esame le
argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata, ma si limita a riproporre la
propria tesi facendo leva su massime ‘tratte da pronunce di questa Corte che
non attengono al tema specifico trattato dalla Corte territoriale.
Infondata poiché è ormai jus receptum (Cassazione n. 1798 del 2006) la
riferibilità del contratto all’ente ospedaliero anche in mancanza di un formale
rapporto di lavoro con il sanitario essendo sufficiente la prestazione d’opera
come ausiliario necessario, cioè un mero rapporto di occasionalità necessaria.
Pertanto anche questo ricorso incidentale deve essere rigettato.
La natura della causa, le tesi rispettivamente sostenute dalle parti, il loro esito
consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa totalmente le spese del giudizio di
cassazione.
126
CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE – SENTENZA 16 NOVEMBRE
2005-14 MARZO 2006, N. 5438
PRESIDENTE FIDUCCIA – RELATORE PER CONTE LICATESE
PM CENICCOLA – DIFFORME – RICORRENTE CENTRO LEASING SPA –
CONTRORICORRENTE SEP Srl
Svolgimento del processo
Il 1° settembre 1992 la Spa Centro Leasing acquistava dalla Spa Edile
Triveneta un capannone industriale, per concederlo in locazione finanziaria alla
Spa Olimpia, con la quale aveva già, in data 4 agosto 1992, sottoscritto un
contratto della durata di otto anni, verso un canone mensile di lire 23.554.032,
in
aggiunta
a
quello
iniziale
di
lire
358.201.900.
La società Olimpia, a far data dall’1 febbraio 1993, si rendeva inadempiente
all’obbligo di pagare il canone, costringendo la Centro Leasing a valersi della
clausola risolutiva espressa e a chiedere, inutilmente, il rilascio dell’immobile.
Il 22 aprile 1994 il Tribunale di Bolzano dichiarava,il fallimento della
conduttrice Olimpia e la Centro Leasing rinnovava, sempre vanamente, la
richiesta di rilascio alla curatela, chiedendo poi di essere ammessa al passivo
per il complessivo importo per canoni ed accessori, di lire 210.692.493.
Essendo intervenuto anche, nella stessa data, il fallimento della Edile
Triveneta, la Centro Leasing si insinuava altresì al passivo di quest’ultimo per
lo stesso importo, dovuto in forza della prestata fidejussione. Il giudice
delegato ai fallimenti decretava, il 29 novembre e il 16 dicembre 1994, di non
ammettere
il
credito.
La società Centro Leasing proponeva opposizione ai sensi dell’articolo 98 della
legge fallimentare, alla quale resisteva la curatela, asserendo che i contratti a
suo tempo stipulati tra la Centro Leasing e le società fallite avevano costituito
una fattispecie negoziale complessa e indiretta, unitariamente convenuta in
frode alla legge per ottenere una garanzia commissoria vietata.
Anche il fallimento della Edile Triveneta chiedeva il rigetto della pretesa
creditoria, sull’assunto della nullità del contratto di trasferimento dell’immobile
alla Centro Leasing e degli atti susseguenti, cioè della locazione finanziaria e
della
garanzia
fidejussoria.
In pari tempo la Centro Leasing azionava in separato giudizio le proprie ragioni
inerenti al mancato rilascio dell’immobile già locato alla società Olimpia e ai
danni per l’indebita occupazione, che terminava solo il 26 luglio 1996.
Intervenuta l’omologazione dei concordati fallimentari delle società olimpia e
Edile Triveneta, tutte le cause venivano riassunte dalle predette società,
tornate “in bonis” e dalla Srl Sep, assuntrice di entrambi i concordati.
Riuniti i giudizi, il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 27 giugno 2000,
dichiarava la nullità di tutti i contratti “inter partes” per violazione del divieto di
patto commissorio; dichiarava la Edile Triveneta, ovvero la Srl Sep, unica
proprietaria dell’immobile in questione; rigettava le domande della Centro
Leasing.
127
Con sentenza dell’11 febbraio 2002, la Corte d’appello di Trento, Sezione
Distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame della Centro Leasing. Ricorre per
la cassazione la soccombente, con sei motivi, cui resiste con controricorso la
Srl
Sep.
Non si sono costituite le altre due società. La ricorrente ha depositato una
memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo, denunciando omessa motivazione sui tre punti decisivi della
controversia (la pretesa interposizione fittizia della Spa Olimpia nel contratto di
“leasing”, la pretesa anormalità del contratto di “sale and lease back”, la
pretesa partecipazione della Centro Leasing alla frode alla legge) , la ricorrente
deduce che la sentenza impugnata si limita alla semplice elencazione delle
circostanze di fatto della causa e si affida, per il resto, a proposizioni prive, per
la loro genericità, di valore argomentativo (“appare di tutta evidenza che”;
“così stando le cose ritiene la Corte che”; “ritiene la Corte che i dati oggettivi
più sopra esposti ( ... ) portino senz’altro a concludere”; “condizioni che non
corrispondono ad un normale contratto di “sale and lease back”“).
Col secondo motivo, denunciando lo stesso vizio, ribadisce gli errori di logica e
le incongruenze in cui sono caduti i giudici di Bolzano. nel motivare sui ricordati
tre punti decisivi della controversia e nel pervenire apoditticamente alla
decisione senza confutare i contrari elementi di fatto recati in giudizio dalla
società Centro Leasing; senza dettagliare le pretese deviazioni dallo schema
tipico del “lease back”; mettendo assieme assunti fra loro inconciliabili, quello
della pretesa interposizione fittizia della Spa Olimpia e quello del preteso rilievo
di soggetto giuridico autonomo riferito al gruppo imprenditoriale costituito dalle
società Olimpia e Edile Triveneta. Passa quindi ad esemplificare le più vistose
di
tali
lacune
e
incongruenze.
Col terzo mezzo, denunciando la violazione degli articoli 13, 2331 e 2359 Cc,
rileva che due società di capitali (Olimpia e Edile Triveneta) non possono
costituire un unico soggetto giuridico, trattandosi sempre e comunque di
soggetti distinti e indipendenti, che rappresentano centri di imputazione di
rapporti giuridici del tutto autonomi e non confondibili tra loro, anche in caso di
controllo azionario fra l’una e l’altra società: tant’è che la Olimpia e la Edile
Triveneta hanno dato luogo a due procedure fallimentari diverse, con masse
attive e passive diverse, poi concluse da autonomi e separati concordati.
Se quindi la sentenza di appello davvero si fondasse sulla premessa che la
Olimpia
e
la
Edile
Triveneta costituivano un unico soggetto giuridico, ne scaturirebbe la
violazione
delle
norme
sopra
richiamate.
Col quarto mezzo, denunciando la violazione degli articoli 1344 e 1345 Cc,
ribadisce l’assenza di motivazione sulla pretesa interposizione fittizia della
società Olimpia e soggiunge che la semplice “consapevolezza” della Centro
Leasing di contrattare con un unico soggetto non sarebbe idonea ad integrare
128
le fattispecie degli articoli 1344 o 1345 Cc, occorrendo una precisa
determinazione finalizzata al conseguimento di un risultato contrattuale illecito.
Seppure il motivo illecito fosse comune alle società Olimpia e Edile Triveneta, si
sarebbe dovuto dedurre una (inesistente) comunanza di intento illecito anche
nella sfera soggettiva della Centro Leasing, che al contrario i giudici di Bolzano
non
hanno
né
dedotto
né
solo
asserito.
Col quinto mezzo, denunciando la violazione degli articoli 1526 Cc, 345 Cpc e
98 della legge fallimentare nonché vizio di motivazione, quanto al quarto
motivo di appello, la ricorrente ricorda di non aver proposto, a differenza della
controparte, nessuna domanda ai sensi dell’articolo 1526 Cc, ma di avere
semplicemente chiesto, per l’uso dell’immobile da parte della società Olimpia
dall’inizio della locazione finanziaria (1° ottobre 1992) sino alla risoluzione del
contratto (21 marzo 1994), l’adempimento del contratto di “leasing”, che
consisteva nel pagamento dei canoni spettanti: è questo l’oggetto della
domanda di ammissione al passivo dei due fallimenti, che ha costituito il
“petitum” della odierna ricorrente nei procedimenti promossi ai sensi
dell’articolo 98 della legge fallimentare e nelle successive impugnazioni fino ad
oggi.
La Spa Centro Leasing non ha perciò introdotto domande nuove di sorta e
comunque si sarebbe semmai trattato di un mezzo di eccezione ben
proponibile
per
la
prima
volta
anche
in
appello.
Col sesto mezzo, denunciando omessa o insufficiente motivazione sui ricordati
tre punti decisivi della controversia nonché violazione degli articoli 13, 1344,
1345, 2331 e 2359 Cc, censura il rigetto della domanda di risarcimento
promossa in conseguenza della procrastinata occupazione dell’immobile., da
parte della curatela del fallimento, dal 22 aprile 1994 al 26 luglio 1996; rigetto
motivato col rilievo che la nullità dei rapporti rende inaccoglibile la richiesta
risarcitoria, quando invece i contratti di compravendita e di locazione
finanziaria
sono
perfettamente
validi.
Il
terzo
motivo
è
infondato.
Per vero la sentenza non afferma mai che le due società (Olimpia e Edile
Triveneta) costituissero un unico soggetto giuridico, ma soltanto mette in
evidenza che esse avevano una indubbia comunanza di interessi sostanziali,
dato il rapporto di controllante e controllata corrente tra loro. Nel dire che le
due società non erano “dei soggetti completamente distinti”, il giudice di
appello vuole soltanto rimarcare che le loro posizioni furono nella specie
coincidenti, in quanto nella identica misura interessate all’intera operazione.
Non disconosce perciò la Corte, come paventa la ricorrente, l’elementare verità
delle distinte personalità giuridiche della Olimpia e della Edile Triveneta, tant’è
vero che essa parla di “gruppo di società” e ne discute sempre come di
soggetti
giuridicamente
diversi
e
distinti.
Il primo, il secondo e il quarto mezza, da esaminare congiuntamente per le
loro
connessioni
logico-giuridiche,
sono
invece
fondati.
La sentenza impugnata, per respingere il secondo e il terzo motivo dell’appello,
osserva essere di tutta evidenza che i contratti intercorsi tra le parti
costituiscano un’unica fattispecie negoziale complessa e non potersi seriamente
sostenere che l’Edile Triveneta e l’Olimpia fossero dei soggetti completamente
distinti; tant’è vero che l’Olimpia possedeva il 98% del capitale sociale
129
dell’Edile
Triveneta.
A ciò va aggiunto, continua la sentenza, che presupposto e finalità della
compravendita del le settembre 1992, dalla società Edile Triveneta alla società
Centro Leasing, era la stipula del contratto di “leasing” tra la società Centro
Leasing e la società Olimpia, quest’ultimo, del resto, già convenuto il 4 agosto
1992, e che l’uso dell’immobile “de quo” non è assolutamente mutato dopo la
stipula di entrambi i contratti, dal momento che esso è continuato ad essere
promiscuamente usato dall’ Edile Triveneta, dall’Olimpia e da un’altra società
del gruppo (la Nuova Hydro Srl, pure fallita); la qual cosa dimostra che non vi
era alcuna necessità operativa di stipulare il contratto di “leasing”, visto che
l’uso
dell’immobile
non
subiva
modificazione
alcuna.
Consegue perciò, ad avviso del giudice di appello, che l’intera operazione
aveva finalità esclusivamente finanziarie e non operative. Infatti l’intero prezzo
d’acquisto di lire 1.500.000.000 nemmeno è stato pagato alla venditrice Edile
Triveneta, dacché lire 300.000.000 sono state trattenute dalla Centro Leasing,
come prima rata del canone di locazione dovuto dalla Olimpia, e l’ulteriore
importo di 300 milioni è rimasto depositato presso il notaio rogante, a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Olimpia nei confronti
della Centro Leasing: importo che la venditrice Edile Triveneta non ha quindi
incassato.
Nemmeno va trascurato, argomenta ancora il giudice di appello, che, per le
obbligazioni scaturenti dal contratto, avrebbe dovuto prestare cauzione
eventualmente la locataria Olimpia e non la venditrice Edile Triveneta, né che,
a fronte di un prezzo complessivo (dichiarato) di 1.500.000.000, appare
piuttosto esiguo il prezzo previsto per il riscatto finale (lire 150.000.000).
È convinta dunque la sentenza impugnata, sulla scia del Tribunale, che
l’interposizione della Olimpia fosse solo apparente e destinata in sostanza a
coprire la funzione di garanzia di trasferimento con clausola di retrocessione,
una volta andato a buon fine il finanziamento (sostanzialmente di soli 900
milioni) che la Centro Leasing ha messo a disposizione del gruppo di società
facenti
capo
alla
Olimpia.
Dopo aver accennato alla posizione di terzo del curatore fallimentare, come
tale abilitato a provare l’interposizione con ogni mezzo e anche per
presunzioni,
la
sentenza
giudica
che
i
dati
oggettivi
più sopra esposti (stipula dapprima della locazione con la Olimpia e poi della
compravendita con la Edile Triveneta; immutato uso degli immobili “de quibus”
prima e dopo la stipula dei contratti stessi, da parte delle varie società facenti
capo all’Olimpia; concessione, da parte della Edile Triveneta, di una
fidejussione per la restituzione del finanziamento, cioè del prezzo
apparentemente incassato per la vendita dell’immobile; corrispondenza tra la
prima rata del canone dovuto dalla Olimpia e l’importo di lire 300.000.000 che
la Olimpia avrebbe dovuto pagare alla Edile Triveneta; l’ulteriore garanzia
conferita dalla Edile Triveneta col deposito cauzionale di lire 300.000.000
presso il notaio rogante, importo che quindi la Centro Leasing non ha pagato)
portino senz’altro a concludere non solo che tra la Edile Triveneta e la Olimpia
vi fosse interposizione e che i vari contratti da queste ultime stipulati con la
Centro Leasing siano da interpretare e valutare unitariamente; ma altresì per
la perfetta consapevolezza di quest’ultima di contrattare, sostanzialmente, con
130
un unico soggetto, al chiaro scopo di porre in essere un negozio di “sale and
lease back” in frode alla legge, cioè volto ad eludere il divieto di patto
commissorio (articolo 2744 Cc), nel senso che la creditrice Centro Leasing, a
fronte di un finanziamento a favore del gruppo di società facenti capo alla
01impia, avrebbe ottenuto una garanzia reale, il tutto in violazione del
principio
della
“par
condicio
creditorum”.
Che poi le società Edile Triveneta e Olimpia, soggiunge e conclude la sentenza,
versassero in difficoltà economiche risulta confermato dal fallimento
sopravvenuto per entrambe nel biennio successivo; ma sono comunque le
stesse caratteristiche del negozio complessivo posto in essere dalla Centro
Leasing con le società sopra indicate a dare la conferma che quest’ultima fosse
perfettamente a conoscenza di siffatte difficoltà, tant’è vero che il
finanziamento è stato concesso alle condizioni sopra descritte, condizioni che
non corrispondono ad un normale contratto di “sale and lease back”.
Il giudice di appello passa quindi all’esame del quarto e del quinto motivo di
gravame. Da un lato dichiara inammissibile per novità (articolo 345 Cpc) la
domanda indennitaria e risarcitoria, ai sensi dell’articolo 1526 Cc, per l’uso
dell’immobile da parte della società olimpia nell’arco della locazione (ottobre
1992/ marzo 1994); dall’altro rigetta la domanda risarcitoria per la
procrastinata occupazione dell’immobile da parte del fallimento, dalla
dichiarazione di questo (22 aprile 1994) fino al 26 luglio 1996, poiché, stante
la nullità dei contratti “de quibus”, la Centro Leasing non ne è mai diventata
proprietaria.
In definitiva, ritenuta la nullità dei contratti di vendita dell’immobile, di
locazione finanziaria e di fidejussione, viene confermato il rigetto delle
opposizioni allo stato passivo dei fallimenti e riconosciuto il diritto di proprietà
dell’immobile in capo all’assuntrice del concordato (la Sep Srl).
È bene premettere che la complessa operazione di “sale and lease back” dà
luogo a un contratto sinallagmatico con cui un’impresa vende un bene
strumentale di sua proprietà ad una società finanziaria (concedente), la quale
ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla
stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone periodico e con la
possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto, mediante l’esercizio
di un diritto di opzione, per un prezzo normalmente molto inferiore al valore
del
bene.
La circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del
venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici di
“leasing” e con la possibilità di riacquisto al termine del contratto, ha indotto
dottrina, e giurisprudenza a interrogarsi circa la liceità dell’operazione di “lease
back” (altrimenti detta locazione finanziaria di ritorno), stanti le indubbie
somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di
garanzia; e segnatamente a chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il
contratto di “lease back” possa costituire il mezzo per eludere l’applicazione di
una norma imperativa (articolo 1344 Cc), ovvero che, sotto le spoglie del
contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall’articolo 2744 Cc.
La giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta a ritenere, in linea di
massima, astrattamente valido lo schema contrattuale del “lease back”, in
quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare,
131
caso per caso, l’assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di
finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad
aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto
dall’articolo 2744 CC, e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la
nullità, ai sensi del cit. articolo 1344, in rel. all’articolo 1418 comma 2 Cc.
Orbene, gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono
essenzialmente tre, cosi individuati: la presenza di una situazione di credito e
debito tra la società finanziaria (concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice,
preesistente o contestuale alla vendita; le difficoltà economiche dell’impresa
venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di
debolezza; la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo
versato dall’acquIrente, che confermi la validità di tale sospetto. Soltanto il loro
concorso vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il “lease back”,
contratto d’impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il
divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge
(sull’intero tema, cfr. Cassazione 13580/04; 4612/98; 4095/98; 6663/97;
10805/95).
L’accertamento del carattere fittizio di un contratto di “sale and lease back”,
per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale
socialmente tipico del contratto in questione, costituisce naturalmente
un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità solo se adeguatamente
e
correttamente
motivata
(Cassazione
9324/03).
Tutto ciò premesso, quanto al primo elemento, la sentenza perviene alla
conclusione dell’esistenza, sotto l’apparente “lease back”, e con l’espediente
altresì di un’ interposizione fittizia di Persona, di una vendita con clausola di
retrocessione, in funzione di garanzia di un finanziamento, secondo l’implicito
assunto, contestualmente concesso, di lire 900.000.000; ma sulla base
tuttavia di elementi indiziari dei quali, sebbene unitariamente considerati,
sfugge la significatività e concludenza ai fini della ventilata frode complessiva
che
si
vorrebbe
dare
per
dimostrata.
Quanto poi al secondo elemento sintomatico, non basta constatare come le
società (la utilizzatrice Olimpia e la sua controllata Edile Triveneta) siano fallite
il 22 aprile 1994, dopo meno di due anni (circa venti mesi dopo), per indurne
uno stato economico di insolvenza o di semplice difficoltà del quale (come la
sentenza lascia intendere) vi sarebbe stato approfittamento da parte della
concedente Centro Leasing. Ed infatti, di fronte a quest’unico argomento, è
facile alla ricorrente obiettare (pag. 24 e 25 del ricorso) di aver provato in
causa che, all’epoca del contratto (10 settembre 1992), le società non erano
protestate né a loro carico pendevano pignoramenti, sequestri, procedure
esecutive o ricorsi di fallimento, e proclamare altresì che le stesse chiusero in
utile gli esercizi 1991-92, che il relativo patrimonio netto era positivo, che
esisteva, per contenzioso attivo pendente, la probabilità seria di significative
sopravvenienze
attive.
È di palmare evidenza che il non lungo intervallo trascorso tra la stipula del
contratto di “leasing” e il fallimento non prova nulla circa le effettive condizioni
economiche delle due società collegate, non potendosi certo applicare nella
materia in esame la presunzione “juris et de jure” di insolvenza sancita
dall’articolo 67 della legge fallimentare a tutt’altri. non estensibili, fini, e
132
nemmeno potendosi ragionevolmente presumere, solo per quella “consecutio”
cronologica, che la società Olimpia o la Edile Triveneta o ambedue versassero
in un semplice stato di difficoltà economiche, premonitore dell’insolvenza vera
e
propria.
Sul terzo e ultimo punto, infine, la sentenza tace su un’eventuale sproporzione
tra il valore di mercato dell’immobile trasferito e il corrispettivo versato
dall’acquirente, limitandosi ad evidenziare soltanto l’esiguità del prezzo finale
di riscatto (lire 150.000.000), quando si è visto che è normale, in linea di
massima, che il prezzo finale sia molto inferiore al valore di acquisto del bene.
Non manca in proposito di osservare la ricorrente (pag. 23 del ricorso) che il
prezzo pattuito per la vendita sarebbe stato valutato dal consulente tecnico
d’ufficio “pienamente in linea con il valore di mercato del bene”, ciò che rende
ancora
più
vulnerabile
la
decisione.
Si deve concludere che la sussistenza della frode alla legge e, con essa, del
vietato, sottostante patto commissorio, con la conseguente nullità dell’intera
operazione, viene giustificata dal giudice di appello, piuttosto che col ricorso ai
soli indici rivelatori concordemente individuati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (dei quali tutti dalla surriferita motivazione non si ricava la
prova), attraverso una serie di proposizioni meramente assertive, le quali
pongono l’accento su elementi di altra natura, di incerto o nullo valore
indiziario ai fini dell’assunto, e si traducono quindi in altrettante petizioni di
principio, che danno per dimostrato quanto invece si doveva dimostrare.
Di
qui
l’esigenza
di
un
riesame
dell’intera
questione.
I capi concernenti l’adempimento del contratto di “leasing” e il pagamento dei
relativi canoni pretesi dalla Centro Leasing con l’istanza di ammissione al
passivo rigettata dalla Corte d’appello nonché il risarcimento per la protratta
occupazione dell’immobile da parte della curatela dipendono strettamente dalla
soluzione che sarà data, in sede di rinvio, alla preliminare questione della
validità o nullità del complesso negozio e le corrispondenti censure (quinto e
sesto
motivo)
sono
pertanto
assorbite.
In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti dianzi spiegati, ovvero per quanto di
ragione, col rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
Cassazione,
al
giudice
di
pari
grado
designato
nel
dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di
Trento.
133
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza 7 aprile 2006, n. 8229
(Presidente G. Losavio, Relatore R. Rordorf)
Svolgimento del processo
Il sig. M.V., con atti notificati il 13 ed il 25 settembre 1997, citò in giudizio
dinanzi al Tribunale di Monza il sig. D.V. e la Ing Group Società Sviluppo
Investimenti Sim s.p.a. (in seguito indicata solo come Sviluppo Investimenti
Sim).
L'attore riferì che per diversi anni egli era stato cliente della società convenuta
compiendo investimenti mobiliari per il tramite del sig. D., all'epoca promotore
finanziario della Sviluppo Investimenti Sim; che in due riprese, il 15 luglio ed il
15 settembre del 1992, egli aveva sottoscritto schede di prenotazione di
certificati di deposito bancari al tasso del 14% annuo, versando a mani del sig.
D., nella prima occasione, assegni bancari al portatore per l'importo di L.
40.000.000 e, nella seconda occasione, altri analoghi assegni per l'ulteriore
importo di L. 30.000.000; che il promotore non aveva però dato corso agli
investimenti concordati, giacchè non aveva trasmesso gli assegni alla Sviluppo
Investimenti Sim, ma se ne era indebitamente appropriato.
Il sig. M., pertanto, chiese la condanna in proprio favore del sig. D. al
risarcimento dei danni in misura pari all'importo complessivo degli assegni a
suo tempo versati, maggiorato degli interessi al tasso annuo del 14% di cui
avrebbe beneficiato se gli investimenti fossero stati eseguiti nei termini
convenuti; e chiese altresì che la medesima condanna fosse pronunciata in
solido nei confronti della Sviluppo Investimenti Sim, quantunque il sig. D.
avesse cessato di esserne promotore a partire dal 31 luglio 1992, in
applicazione di quanto disposto dalla L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, nonchè
dei principi sull'apparenza del diritto.
Il sig. D. rimase contumace.
Si costituì invece la Sviluppo Investimenti Sim, chiedendo il rigetto della
domanda proposta nei propri confronti dall'attore, al quale imputò l'esclusiva
responsabilità dell'accaduto per avere egli effettuato i versamenti a mani del
promotore mediante assegni bancari al portatore e, quindi, in violazione delle
condizioni contrattuali che avrebbero invece imposto l'uso di assegni intestati
direttamente alla società d'intermediazione mobiliare. La convenuta negò,
comunque, di dover rispondere del comportamento posto in essere dal
promotore dopo la cessazione del rapporto di preposizione, avendo essa fatto
tutto quanto necessario per recuperare la modulistica ed ogni altro materiale
utilizzato dal medesimo promotore nella vigenza del mandato. Chiese, in via
subordinata, che venisse accertato il concorso di colpa dell'attore nella
produzione del fatto lesivo, e propose domanda di rivalsa nei confronti del sig.
D. per quanto eventualmente essa fosse condannata a risarcire all'attore.
Il tribunale, con sentenza emessa il 14 marzo 2000, accolse le domande
proposte dal sig. M. nei confronti di entrambi i convenuti, che condannò quindi
in solido al risarcimento dei danni, quantificati in complessive L. 79.800.000
(pari all'importo di L. 70.000.000, maggiorato del 14%), con interessi legali e
rivalutazione monetaria. Il sig. D. fu anche condannato (oltre che al
134
risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore) a rivalere la
Sviluppo Investimenti Sim di quanto quest'ultima avrebbe dovuto
corrispondere al sig. M. per effetto della sentenza.
Chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla Sviluppo Investimenti
Sim, nella perdurante contumacia del sig. D., la Corte d'appello di Milano, con
sentenza depositata il 19 febbraio 2002, confermò integralmente la decisione
di primo grado.
Ritenne innanzitutto la corte milanese che non potesse imputarsi al cliente
alcuna colpa, esclusiva o concorrente, per non aver consegnato al promotore
assegni intestati direttamente alla società d'intermediazione, in quanto siffatta
previsione non figurava in modo chiaro sulle schede di prenotazione
specificamente riferibili alle operazioni di cui si discute e, soprattutto, in quanto
già in occasione di precedenti investimenti, compiuti senza inconvenienti
tramite il medesimo promotore, il sig. M. aveva emesso assegni non intestati
alla Sviluppo Investimenti Sim, la quale tuttavia aveva accettato i relativi
pagamenti senza nulla obiettare. Quanto poi al fatto che, al tempo del secondo
dei due versamenti di cui si tratta, il sig. D. non era più promotore della
Sviluppo Investimenti Sim, la medesima corte osservò che, nondimeno, egli
era rimasto in possesso della documentazione precedentemente fornitagli dalla
società mandante ed a questa intestata, della quale si era appunto servito nel
caso di specie: onde a detta società era da imputare l'incolpevole affidamento
del cliente, convinto della permanenza del rapporto di mandato, non avendo la
società d'intermediazione neppure provveduto ad informare il cliente
medesimo della cessazione di quel rapporto nè a ritirare il tesserino di
appartenenza del sig. D. all'albo dei promotori. L'ammontare della condanna fu
infine stimata corretta dalla Corte d'appello, anche per la parte relativa agli
interessi che il cliente avrebbe percepito a seguito degli investimenti
commissionati ma non effettuati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Sviluppo
Investimenti Sim, formulando tre motivi di censura, illustrati con successiva
memoria.
Il sig. M. ha replicato depositando controricorso.
Nessuna difesa ha svolto invece, neppure in questa sede, il sig. D.
Motivi della decisione
1. I tre motivi di ricorso investono, rispettivamente, le tre principali questioni
sulle quali la corte d'appello si è pronunciata con l'impugnata sentenza, e cioè:
1) se sussistessero, nel caso in esame, di estremi di una colpa esclusiva o
concorrente del cliente danneggiato dall'illegittimo comportamento del
promotore finanziario, del cui illecito la società d'intermediazione preponente è
stata chiamata a rispondere; 2) se sussistesse una situazione di apparenza del
diritto, colpevolmente imputabile alla società d'intermediazione, in forza della
quale quest'ultima debba esser tenuta responsabile anche della condotta
illecita posta in essere dal promotore dopo la cessazione del rapporto tra la
società ed il promotore medesimo; 3) se sia attribuibile al cliente, a titolo di
risarcimento, una somma comprensiva degli interessi convenzionali che lo
stesso cliente avrebbe percepito ove l'investimento da lui disposto fosse stato
eseguito nei termini contrattualmente convenuti.
135
Conviene esaminare separatamente le tre questioni.
2. Non è in discussione il fatto che il denaro affidato dal cliente al promotore
della Sviluppo Investimenti Sim per essere investito in certificati di deposito
bancario fu invece distratto a proprio favore dal promotore medesimo. E' un
fatto accertato in causa e, comunque, pacifico. Altrettanto certo è che un tal
fatto sia idoneo a generare il diritto del cliente al risarcimento del danno subito
e che la pretesa risarcitoria, ove ricorrano le condizioni previste (allora vigente)
dalla L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, possa esser fatta valere anche nei
confronti della società d'intermediazione per la quale il promotore operava.
Già nel corso del giudizio di merito è stata però prospettata dall'odierna
ricorrente la configurabilità di una colpa esclusiva - o quanto meno concorrente
- del cliente; colpa che la ricorrente ricollega al fatto che il sig. M. eseguì i
versamenti consegnando al promotore assegni bancari al portatore,
quantunque le schede di prenotazione predisposte dalla società Sviluppo
Investimenti Sim e sottoposte alla sottoscrizione del cliente prevedessero
espressamente che i pagamenti avrebbero dovuto esser fatti mediante assegni
bancari o circolari intestati alla società.
Entrambi i giudici di merito hanno negato che tale circostanza potesse sia
escludere il diritto al risarcimento di un danno che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 2), sia ridurre
l'ammontare del risarcimento per avere il fatto colposo del danneggiato
concorso a cagionare il danno (art. cit., comma 1).
A tal riguardo, in particolare, la corte d'appello ha osservato che sarebbe
dubbia la sussistenza della pattuizione concernente le suindicate modalità di
pagamento, essendo essa riportata su moduli predisposti per l'investimento in
fondi diversi, ma non anche sugli specifici moduli relativi ai certificati di
deposito di cui si discute nella presenta causa; ed ha aggiunto che sarebbe
comunque decisivo il rilievo per cui, già in diverse precedenti occasioni, lo
stesso cliente, nell'effettuare investimenti tramite il medesimo promotore,
aveva consegnato a costui assegni al portatore che erano stati accettati ed
incassati dalla società d'intermediazione senza formulare alcuna obiezione nè
nei confronti del cliente nè nei confronti del promotore medesimo, ad onta del
fatto che il regolamento emanato dalla Consob espressamente vietasse una
simile prassi e la sanzionasse addirittura con la radiazione del promotore
dall'albo.
2.1. La ricorrente censura tali affermazioni, ravvisando in esse violazioni di
diritto (con riferimento agli artt. 1227, 2697 e 2702 c.c., nonchè artt. 115 e
116 c.p.c.) e difetti di motivazione.
In particolare essa riferisce di aver prodotto in giudizio, in data 30 settembre
1999, cinque assegni bancali emessi dal sig. M. nel 1991 in relazione ad
operazioni d'investimento mobiliare eseguite per il tramite del promotore sig.
D., non intestati alla Sviluppo Investimenti Sim e posti all'incasso non da
quest'ultima, bensì dallo stesso sig. D. o da terze persone. Di tali documenti
non v'è cenno nella motivazione dell'impugnata sentenza, ma da essi invece a parere della ricorrente - si sarebbe dovuto trarre la prova del fatto che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, la Sviluppo Investimenti
Sim non aveva avuto alcuna contezza della prassi già in precedenza
136
scorrettamente seguita dal proprio promotore con l'accettazione di assegni non
intestati alla società d'intermediazione.
Erano state altresì prodotte - osserva ancora la ricorrente - le schede di
prenotazione dei certificati di deposito bancali, sottoscritte dal sig. M., nelle
quali risultava espressamente indicato che il pagamento doveva aver luogo a
mezzo di assegni intestati alla società d'intermediazione, onde non sarebbe
comprensibile il dubbio espresso dalla corte d'appello in ordine all'effettiva
vigenza di una siffatta pattuizione, non rispettata però dal cliente. Il quale,
inoltre, aveva omesso di rilevare tempestivamente il mancato invio, ad opera
della società, delle lettere di conferma degli investimenti relativi agli anni 1991
e 1992: ciò che avrebbe dovuto metterlo sull'avviso ed indurlo a compiere
immediate verifiche, anzichè attendere oltre un anno per accorgersi
dell'accaduto, giacchè simili lettere di conferma gli erano sempre state
recapitate in occasione degli investimenti da lui effettuati negli anni precedenti.
Avrebbe dunque errato la corte d'appello nel ritenere inapplicabile nel caso di
specie la citata disposizione dell'art. 1227 c.c., comma 2, o almeno quella del
comma 1 del medesimo articolo.
3. Non ritiene il collegio che tali censure siano meritevoli di accoglimento.
Vi osta infatti un rilievo di carattere preliminare che porta ad escludere
l'applicabilità, in un caso come quello in esame, delle disposizioni dettate da
entrambi i commi del citato art. 1227 c.c..
3,1. Occorre muovere dalla considerazione che la L. n. 1 del 1991, art. 5,
comma 4 (poi sostituito dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e quindi dal D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, ma ancora applicabile ratione temporis ai
fatti di causa) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli
"eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai
promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale".
Non interessa in questa sede soffermarsi a discutere se quella così configurata
sia o meno una forma di responsabilità oggettiva, nè quali siano i suoi rapporti
sistematici con la responsabilità contemplata, in via generale, dall'art. 2049
c.c. a carico dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti imputabili ai
domestici ed ai commessi.
Conviene
invece
sottolineare
come
la
suindicata
responsabilità
dell'intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fatto
illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria
all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr.
Cass. n. 20588 del 2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d'essere,
per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali
l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone
benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso, ed in
termini più specifici, nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai
destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite
del promotore, giacchè appunto per le caratteristiche di questo genere di
offerte più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa. E tale
garanzia il legislatore ha inteso rafforzare, tra l'altro, anche e proprio
attraverso un meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario
nei riguardi dei comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che
137
l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano
e sui quali nessuno megliodell'intermediario è concretamente in grado di
esercitare efficaci forme di controllo.
In questo quadro si collocano, ovviamente, anche le disposizioni regolamentari
che la Consob è stata chiamata a dettare, in base al disposto della citata L. n.
1 del 1991, art. 5, comma 8, ed in particolare quelle menzionate nella lettera
f) di detto comma, ossia le regole che i promotori debbono osservare "nei
rapporti con la clientela al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori". Tra
esse rileva qui, specificamente, l'art. 14, comma 9, del regolamento emanato
dalla Consob con Delib. n. 5388 del 2 luglio 1991 (vigente all'epoca dei fatti di
causa), che fa obbligo al promotore di ricevere dal cliente esclusivamente: "1)
titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purchè siano
muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel
prospetto informativo o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia
prescritto; 2) titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati a favore di
chi presta il servizio di intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore".
Ora, è pacifico che nel caso in esame, come s'è detto, tale disposizione non fu
osservata dal promotore, il quale ebbe a ricevere assegni emessi dal sig. M. al
portatore. Ma quella regola - come pure già si è sottolineato - è unicamente
diretta a porre un obbligo di comportamento in capo al promotore e trae la
propria fonte da una prescrizione di legge (la citata L. n. 1 del 1991, art. 5,
comma 8, lett. f) espressamente volta alla tutela degli interessi del
risparmiatore. Non è perciò logicamente postulatole che essa, viceversa, si
traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo, tale per cui
l'eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si risolva in
un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del
cliente danneggiato dall'altrui atto illecito.
Nè il mero fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita
nei moduli sottoscritti dal cliente può mutare la funzione di quella regola e
trasformarla, da obbligo di comportamento del promotore in vista della tutela
dell'investitore, in un onere gravante su quest'ultimo in funzione della tutela
dell'intermediario rispetto ai rischi di comportamento infedele del promotore. A
parte il rilievo che l'implicito presupposto dal quale muovono tutte le
disposizioni volte a conformare a regole prefissate il comportamento di
intermediari e promotori è proprio l'insufficienza delle tradizionali forme di
autotutela dell'investitore affidate alla mera sottoscrizione di moduli e
formulati, ove si ammettesse la possibilità per l'intermediario di scaricare in
tutto o in parte sull'investitore il rischio della violazione di regole di
comportamento gravanti sui promotori, si finirebbe evidentemente per
vanificare lo scopo della normativa che, come s'è visto, per ragioni di carattere
generale attinenti alla tutela degli investitori (e perciò del risparmio), mira
invece proprio a responsabilizzare l'intermediario per siffatti comportamenti del
promotore.
Non s'intende con ciò negare, in assoluto, che possa trovare spazio
l'applicazione dell'art. 1227 c.c. (comma 1 o 2, a seconda dei casi), qualora
l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto
meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da
parte del promotore, di regole di condotta su quest'ultimo gravanti. Al dovere
138
di tutela reciproca dei contraenti, insito nel principio generale di buona fede,
anche il cliente dell'intermediario è certamente tenuto. Per le ragioni dianzi
chiarite, deve però escludersi che la mera allegazione del fatto che il cliente
abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità
difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle
valga, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del
promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento
dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito,
e quindi precluda la possibilità d'invocare la responsabilità solidale
dell'intermediario preponente; e deve parimenti escludersi che un tal fatto
possa essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito
dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore al fine di
ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto.
L'enunciazione di tale principio, destinato evidentemente ad assorbire e
rimpiazzare la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, rende superfluo
l'esame delle considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine al modo in cui si
sono concretamente configurate le modalità di pagamento nei pregressi
rapporti intercorsi con il sig. M., mai avendo la ricorrente dedotto che
quest'ultimo fosse consapevole della violazione delle regole di condotta
gravanti sul promotore.
3.2. Neppure può esser dato peso in questa sede all'asserita tardività con la
quale il cliente avrebbe reagito all'illecito del promotore, non accorgendosi del
fatto che la società d'intermediazione non gli aveva inviato le consuete lettere
di conferma degli investimenti da lui disposti e non segnalando perciò subito la
cosa alla medesima società. Di una tal questione non si fa cenno
nell'impugnata sentenza, e la ricorrente non indica se ed in quale atto difensivo
del giudizio di merito essa l'avesse invece sollevata, limitandosi ad un generico
richiamo alle risultanze documentali e ad un documento prodotto da parte
avversa, ma senza fornire elementi idonei a dimostrare l'effettiva incidenza
causale che il lamentato ritardo di reazione del cliente avrebbe avuto sulla
produzione del danno.
4. Il secondo motivo di ricorso investe il tema della responsabilità della società
d'intermediazione per la seconda delle due indebite appropriazioni di denaro
del cliente, compiuta dal sig. D. nel settembre del 1992, quando da ormai circa
un mese e mezzo egli aveva cessato di essere promotore della Sviluppo
Investimenti Sim.
La Corte d'appello, richiamando i principi della cosiddetta apparenza del diritto,
ha ravvisato la sussistenza della responsabilità dell'intermediario preponente in
considerazione essenzialmente di ciò: che il sig. M., pur essendo da tempo
cliente della Sviluppo Investimenti Sim per il tramite del promotore sig. D.,
non era stato informato dalla società della cessazione di ogni rapporto tra
questa ed il predetto sig. D.; che quest'ultimo era stato lasciato in possesso del
materiale a suo tempo fornitogli dalla Sviluppo Investimenti Sim per
l'espletamento dell'attività di promotore ed aveva perciò potuto continuare ad
utilizzare i moduli intestati alla società; che la Sviluppo Investimenti Sim non si
era neppure attivata per assicurarsi che il sig. D. fosse privato del tesserino di
promotore, onde costui aveva potuto esibirlo traendo in inganno il cliente in
occasione dell'operazione di cui si tratta.
139
4.1. La ricorrente lamenta anche a tale proposito sia violazioni di legge (con
riferimento agli artt. 1398, 2697 e 2702 c.c., artt. 115 e 166 c.p.c.) sia vizi di
motivazione della sentenza impugnata.
Essa sostiene: che il sig. M., pur avendo effettivamente avuto rapporti in
precedenza con la Sviluppo Investimenti Sim, non poteva più dirsi cliente di
quest'ultima nel luglio del 1992 (quando il sig. D. aveva dato le proprie
dimissioni da promotore), onde nessuna specifica informazione gli era in
proposito dovuta; che nessun addebito di colpa potrebbe comunque esser
mosso alla ricorrente, la quale aveva tempestivamente chiesto già nel luglio
1992 al promotore dimissionario di restituire i moduli in suo possesso e di
riconsegnare il tesserino alla competente Commissione regionale per l'albo dei
promotori; che altrettanto tempestivamente, appena venuta a conoscenza nel
settembre del 1993 degli illeciti compiuti dal sig. D., essa ne aveva informato
gli organi preposti alla vigilanza ed aveva sporto denuncia alla magistratura
competente. Circostanze tutte alla stregua delle quali la conclusione cui è
prevenuta la corte territoriale risulterebbe priva di basi logiche e giuridiche.
5. Nemmeno questo motivo di ricorso è accoglibile.
5.1. Nessun errore di diritto è rilevabile in quanto statuito sul punto dalla corte
d'appello.
Non sembra infatti dubbio - e neppure la ricorrente in realtà lo pone in dubbio che in un caso come quello di cui qui si tratta possano trovare applicazione i
principi dell'apparenza del diritto, elaborati dalla giurisprudenza soprattutto
nella materia della rappresentanza negoziale; e che, quindi, un intermediario
finanziario possa esser chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno
di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste
abbia commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti
incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un
comportamento colpevole (ancorchè magari solo omissivo) dell'intermediario
medesimo.
A questo principio si è attenuta la sentenza impugnata, che per questa ragione
non può dunque essere censurata, essendo per il resto evidente che la
ravvisabilità nei singoli casi di una situazione di apparenza del diritto, nei
termini sopra indicati, dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la
cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice del merito
e, come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per eventuali difetti
logici o giuridici della motivazione.
5.2. Si tratta perciò di stabilire se, nel presente caso, il giudice del merito
abbia motivato in modo giuridicamente e logicamente corretto il proprio
ragionamento. Ed è in rapporto a ciò che viene in evidenza soprattutto il tema
della colpa addebitata dalla corte territoriale alla società d'intermediazione,
sulla base degli elementi già dianzi ricordati, il cui fondamento la ricorrente
però contesta.
A questo riguardo, può effettivamente dubitarsi che una società
d'intermediazione disponga in concreto dei mezzi necessari per conseguire con
certezza la restituzione, da parte di un promotore dimissionario, di tutta la
modulistica prima fornitagli per esercitare la sua attività in favore della
medesima società; e può escludersi che competesse a quest'ultima di attivarsi
direttamente per ritirare il tesserino professionale che, viceversa, in base
140
all'art. 6, lett. f), dell'allora vigente e già citato regolamento n. 5388 della
Consob, avrebbe dovuto essere ritirato dalla competente commissione
regionale per i promotori.
Non sembra invece possibile dubitare del fatto - da solo invero decisivo - che la
Sviluppo Investimenti Sim dovesse diligentemente comunicare la cessazione
del proprio rapporto con il promotore a chi, come il sig. M., aveva avuto nel
tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con detta società per il tramite
di quel promotore ed era perciò logicamente incline ad identificare in costui
appunto un promotore di quella società d'intermediazione.
La circostanza che i promotori possano svolgere la loro opera nell'interesse di
una sola società d'intermediazione (cd. obbligo di monomandato, già posto
dall'allora citata L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 3) e la naturale conseguente
identificazione da parte dei terzi del promotore come inserito nella struttura
organizzativa di detta società, per effetto di un atto di preposizione da questa
proveniente, rende evidente il rischio che i terzi - ed in specie i clienti adusi ad
avere rapporti con la società tramite quello specifico promotore - possano
continuare ad identificare in costui un referente della medesima società pur
quando in realtà il rapporto di preposizione sia invece venuto meno. Emerge
perciò anche in questo campo quell'esigenza d'informazione tempestiva del
terzo alla quale, sia pure con una norma non di per sè applicabile alla presente
fattispecie, il legislatore si è mostrato ben sensibile dettando l'art. 1396 c.c..
Certo, non può pretendersi che l'intermediario informi della cessazione del
rapporto di preposizione tutti coloro che in passato siano entrati in qualche
modo con lui in contratto per il tramite del promotore cessato. Ma un tale
dovere d'informazione, connesso al dovere di protezione dell'altro contraente
che naturalmente si estende anche a tutto quanto immediatamente consegue
alla relazione contrattuale, è invece configurabile nei confronti di coloro i quali,
essendosi sempre e ripetutamente avvalsi del promotore poi dimissionario,
hanno intrattenuto rapporti con la società d'intermediazione in un arco di
tempo che ragionevolmente può far supporre la loro attitudine ad effettuare
ulteriori investimenti per il tramite di quel medesimo promotore.
Ora, in punto di fatto, la corte d'appello ha accertato che il sig. M. aveva
compiuto investimenti con l'intermediazione dell'anzidetta società fino a
quattro mesi prima di quando il sig. D. presentò le proprie dimissioni da
promotore. Questo accertamento, appunto perchè attiene ad una circostanza di
fatto, non può evidentemente esser rimesso in discussione in sede di
legittimità e, sulla base di esso, tenuto anche conto dei doveri di diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente che già l'art. 6,
comma 1, lett. a), dell'allora vigente L. n. 1 del 1991 poneva a carico
dell'intermediario, non può dubitarsi che fosse dovuta un'informazione come
quella di cui si discute, perchè inerente ad un fatto nuovo idoneo a dispiegare
effetti sul modo in cui fino ad allora si erano svolti i rapporti tra intermediario e
cliente; rapporti non necessariamente continuativi, ma comunque frequenti e
reiterati, dei quali, per ciò stesso, sarebbe stato logico attendersi ulteriori
sviluppi.
Sotto questo profilo la motivazione che ha indotto la corte territoriale a
ravvisare una colpa della ricorrente nell'affidamento incolpevolmente riposto
141
dal cliente nell'esistenza del rapporto di preposizione si appalesa corretta ed
adeguata a sorreggere l'anzidetta conclusione.
6. Privo di fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso,con cui si
lamenta la violazione dell'art. 1248 c.c., oltre che difetti di motivazione
dell'impugnata sentenza.
L'assunto della ricorrente, secondo la quale la condanna al risarcimento dei
danni in favore del sig. M. avrebbe dovuto esser circoscritta nel quantum
all'importo delle somme da quest'ultimo versate e poi distratte dal promotore,
maggiorate dei soli interessi legali e non di interessi al tasso annuo del 14%, in
difetto di pattuizione scritta in tal senso, è palesemente infondato.
Non è qui in questione, infatti, la corresponsione di interessi dovuti in forza di
una specifica pattuizione tra il debitore ed il creditore, è questione invece del
risarcimento del danno sofferto in conseguenza della violazione, da parte di un
soggetto cui una determinata somma era stata affidata, dell'obbligo di
investirla conformemente alle disposizioni ricevute. E poichè, in punto di fatto,
la sentenza impugnata indica (e la stessa ricorrente nella premessa del ricorso
conferma) che quella somma avrebbe dovuto essere investita in certificati di
deposito bancari dei quali era prevista la restituzione a scadenza con aggiunta
di interessi annui al tasso del 14%, risulta conforme a diritto e congruamente
motivata la statuizione con cui la Corte di merito ha condannato i convenuti ad
un risarcimento comprendente anche la misura degli interessi che il cliente
avrebbe percepito qualora le somme da lui affidate al promotore fossero state
impiegate come dovevano.
7. Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna della società ricorrente al
rimborso delle spese processuali del controricorrente, che vengono liquidate in
Euro 3.000,00 (tremila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso
delle spese processuali del controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00
(tremila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
142
CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE – SENTENZA 30 GENNAIO-12
APRILE 2006, N. 8516
PRESIDENTE PROTO – RELATORE NAPOLEONI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 10 dicembre 1996 il fallimento Gruppo Editoriale
Marotta di Carlo Marotta conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Taranto
la signora Maria Francesca Primerano, moglie consensualmente separata del
Marotta, esponendo che in sede di separazione consensuale, omologata dal
medesimo Tribunale l’11 luglio 1998, il Marotta e la Primerano avevano
stabilito che la casa coniugale sita in Taranto, alla Via Palermo n. 4, acquistata
in regime di comunione dei beni, sarebbe rimasta nella esclusiva disponibilità
del
marito.
Questi, per parte sua, avrebbe corrisposto alla moglie – oltre all’assegno di
mantenimento per lei stessa e la figlia, di cu era affidataria – un ulteriore
assegno mensile di lire 750.000, quale contributo alle spese per il reperimento
di
altro
alloggio.
Con successivo ricorso al Tribunale di Taranto del 29 gennaio 1994, omologato
con decreto del 3 febbraio 1994, i coniugi avevano peraltro chiesto ed ottenuto
la modifica delle anzidetto condizioni, convenendo, in specie, che la casa di
proprietà comune veniva destinata ad abitazione della Primerano. A tal fine, il
Marotta aveva costituito sull’immobile, per la quota di sua spettanza, il diritto
di abitazione in favore della consorte per l’intera durata della di lei vita,
venendo correlativamente dispensato dal contributo mensile di lire 750.000, in
precedenza
pattuito.
Di tale atto, trascritto nel registri immobiliari, il fallimento chiedeva la revoca ai
sensi degli articoli 69 e 67, comma 1, n. 1, della legge fallimentare, in quanto
stipulato
in
pregiudizio
dei
creditori
dell’imprenditore
fallito.
Nella resistenza della convenuta, la domanda veniva accolta dal Tribunale adito
con sentenza del 13 giugno 2000, successivamente confermata, a seguito del
gravame della Primerano, dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di
Taranto,
con
sentenza
del
4
luglio
2002.
La Corte territoriale negava in specie validità alla tesi dall’appellante, secondo
cui l’accordo intervenuto in modo di separazione consensuale rimarrebbe
estraneo alla sfera di operatività degli articoli 67 e 69 della legge fallimentare
osservava, al riguardo, come la disposizione del comma 1 dell’articolo 69 - in
forza della quale gli atti di cui al precedente articolo 67, compiuti tra i coniugi
nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale, sono revocati so il
coniugo non prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniugo fallito dovemmo considerarsi applicabile a tutti gli atti ponti in camere tra i coniugi in
costanza di matrimonio, ancorché in pendenza di uno stato di separazione
personale. E ciò sia perché la modifica consensuale della condizioni della
separazione, se pur soggetta ad omologazione da parte del tribunale, resta un
143
atto di natura patrizia; perché il citato articolo 69 legge fallimentare, sul
presupposto che il coniugo rappresenti il “complice naturale” dell’imprenditore
insolvente nel compimento di atti pregiudizievoli ai creditori, lo sottopone ad
una disciplina più rigorosa di quella prevista in rapporto alla generalità dei
terzi.
La Corte di merito riteneva sussistente, inoltre, la sproporzione - contentata
viceversa anch’essa dall’appellante - tra quanto concesso dal fallito con l’atto
impugnato (il diritto di abitazione nulla metà dell’immobile di sua spettanza) e
quanto da lui ricevuto (l’esonero dall’obbligo di versare mensilmente al coniuge
separato la soma di lire 750.000). A tale conclusione inducevano sia il pregio
dell’immobile (composto da dieci vani e mezzo “più accessori”, con annesso
giardino); sia l’slavato valore di “capitalizzazione” del diritto di abitazione,
stante la giovane età della beneficiaria (nata nel 1957); sia, infine, la
circostanza che, a seguito dell’accordo modificativo, il Marotta veniva a
sobbarcarsi la spese per il reperimento di un diverso alloggio, quando invece
l’obbligo di versamento mensile originariamente assunto avrebbe avuto
termine - in correlazione alla sua finalità - allorché la Primerano fosse venuta a
godere
di
altra
idonea
abitazione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Primerano sulla base di
due motivi, cui resiste il curatore del fallimento Marotta con controricorso,
illustrato
da
successiva
memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di
norme di diritto” (articolo 360, n. 3, Cpc), assumendo che - contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte di merito -l’accordo intercorso tra i coniugi in modo
di separazione consensuale, regolarmente omologato dal tribunale, non
potrebbe essere estrapolato dall’insieme della condizioni in cui è incorporato e
ricompreso nell’ambito applicativo dell’articolo 67 della legge fallimentare, che
riguarda
“rapporti
del
tutto
autonomi
sul
piano
economico”.
In ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe completamente ignorato che la
disposizione invocata dalla curatela a fondamento della domanda richiede che
la prestazione del fallito sorpassi notevolmente la controprestazione.
2. Con il secondo motivo la Primerano lamenta “omessa ad insufficiente
motivazione” (articolo 360, n. 5, Cpc), censurando che la Corte territoriale
abbia rigettato il proprio gravame senza alcuna valida motivazione sia per
quanto concerne l’ambito di applicazione dell’articolo 67 della legge
fallimentare, sia, e soprattutto, per quel che attiene alla sproporzione tra la
prestazioni, apoditticamente affermata dai giudici di appello in assenza di
qualsiasi elemento di prova: prova che sarebbe stato per converso onere del
curatore fornire.
3.1.
Il
primo
motivo,
nella
parte
in
cui
a
volto
a
contentare
144
l’assoggettabilità a revocatoria fallimentare della pattuizione oggetto
di giudizio, non è fondato.
In accordo con i postulati della concezione c.d. “privatistica” della separazione
consensuale - a cui favore militano tanto il tenore letterale degli articoli 158,
comma 1, Cc e 711, comma 4, Cpc, quanto i limiti si poteri di controllo del
giudica prefigurati dall’articolo 158, comma 2, Cc -questa Corte ha difatti
ripetutamente affermato che l’accordo di separazione costituisce un atto di
natura essenzialmente negoziale – più precisamente, un negozio giuridico
bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo
nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della
“patrimonialità”) - rispetto al quale il provvedimento di omologazione si
atteggia a mora condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto
provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia
Compatibile con le norma cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di
controllare, la termini più pregnanti, che l’accordo relativo all’affidamento e al
mantenimento dei figli non contrasti con l’interesse di questi ultimi. Con la
conseguenza, tra l’altro, che l’avvenuta omologazione lancia affatto
impregiudicata la facoltà delle parti di esperire nei confronti della convenzione
l’azione di annullamento per vizi della volontà, in base alle regole generali
(Cassazione, 6625/05; 17902/04; 17607/03; 3149/01).
Al tempo stesso, questa Corte ha costantemente riconosciuto la validità dello
clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva
regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni
immobili (Cassazione, 43061/97; 12110/92; con particolare riguardo ai riflessi
fiscali, 11458/05; 7493/02), ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra
cui, in primis, per quanto al presento interessa, il diritto di abitazione (cfr., in
tal nonno, già la remota Cassazione, 1594/63): clausola che presentano,
peraltro, una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia
contrattuale della parti interessato (cfr. Cassazione, 12897/91), dando vita,
nella sostanza a veri e propri contratti atipici, con particolari
presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle
convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti
comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sonni
dell’articolo 1322 Cc (Cassazione, 11342/04; 12110/92; 9500/87; 3299/72;
con riguardo altresì a clausola inserita in un accordo per la separazione di
fatto, Cassazione, 7470/92).
Pattuizioni del genere considerato, nondimeno, ben possono rivelarsi lesive, in
concreto. dell’interesso dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del
coniuge disponente eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o
logico-giuridico ai frappone alla loro impugnazione – ove ricorrano i relativi
presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo,
Cassazione, 5741/04) che fallimentare.
145
Tali azioni non possono ritenersi precluse, difatti, né dall’avvenuta
omologazione dell’accordo di separazione, cui resta affatto estranea la funzione
di tutela dei terzi creditori, e che, per quanto detto, lascia comunque inalterata
la natura negoziale della pattuizione, né contrariamente a quanto assume
l’odierna ricorrente dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal
complesso della altro condizioni della separazione.
È del tutto evidente, in effetti, che nell’ipotesi considerata si discute non già di
una (peraltro difficilmente concepibile) revocatoria “della” separazione,
quanto piuttosto di una revocatoria “nella” separazione l’impugnativa
mira a colpire, cioè, non la separazione in sé, ma il segmento della fattispecie
complessa in cui si annida il vulnus alla aspettative di soddisfacimento del ceto
creditorio.
Il che, peraltro, è perfettamente ammissibile a fronte della rimarcata
autonomia delle pattuizioni di cui si va discorrendo, non giovando addurre, in
direzione contraria, che l’ablazione del singolo “tassello” finisce inevitabilmente
per squilibrare i rapporti fra i coniugi separati, quali risultanti dal complessivo
assetto convenzionale. Al di là, infatti, della generale facoltà accordata al
soccombente in revocatoria dall’articolo 71 legge fallimentare, la tutela del
coniuge, che abbia visto modificata in peius la propria posizione a seguito del
vittorioso esperimento della revocatoria, resta affidata alla facoltà di allegare
l’anzidetta modifica quale fatto sopravvenuto idoneo a legittimare la revisione
delle residue condizioni della separazione, a norma dell’articolo 711, comma 5,
Cpc.
Né, infine, una preclusione all’esperimento dell’azione revocatoria potrebbe
essere ravvisata nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la
costituzione del diritto reale minore siano stati concretamente pattuiti in
funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente
più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli: obbligo di fonte legale,
rientrante, come tale, nel cosiddetto contenuto necessario dell’accordo di
separazione. È agevole replicare, difatti, che nel frangente l’azione revocatoria
non pone in discussione la sussistenza dell’obbligo in sé, quanto piuttosto le
modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell’ambito di
un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente “convenzionale”.
3.2. Le conclusioni ora esposta si impongono d’altro canto a fortiori allorché –
come nella fattispecie in esame - il trasferimento immobiliare o la costituzione
del diritto reale minore non facciano parte dell’originario -pacchetto- delle
condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece
oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente tra i coniugi,
esaurendone in pratica i contenuti.
146
Per un verso, infatti, al lume della giurisprudenza di questa Corte, le
modificazioni degli accordi, convenuto dai coniugi successivamente
all’omologazione della separazione, trovando fondamento nel principio
di autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 Cc, sono valido ed
efficaci anche a prescindere dall’intervento del giudice ex articolo 710
Cpc, ove non varchino il limito di derogabilitá consentito dall’articolo
160 Cc (Cassazione, 5829/98; 657/94; 22701/93; 2481/82). Onde diviene
ancor più difficile ravvisare un ostacolo alla revocabilità dell’accordo
modificativo nell’avvenuta omologazione, neppure indispensabile al fini
dell’efficacia dell’accordo stesso.
Per altro verso, poi, risulta ancor più palese, nel caso considerato, l’autonomia
dell’atto dispositivo rispetto ai complessivi accordi di separazione e, di
conseguenza, la sua distinta impugnabilità con l’azione revocatoria al fine di
evitare il pregiudizio ai creditori del coniuge disponente che ad esso
eventualmente consegua.
4. Il secondo motivo- che, per l’identità di oggetto, può essere esaminato
congiuntamente alla seconda parte del primo motivo – è anch’esso infondato.
La sussistenza della sproporzione tra le prestazioni delle parti, richiesta dalla
disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, n. 1, della legge fallimentare – in
base alla quale la curatela ha proposto la domanda di revoca – lungi dall’essere
stata ravvisata dalla Corte di merito in termini puramente assertivi, è stata
affermata sulla scorta di un’articolata analisi della fattispecie concreta, che si
sottrae a censura in questa sede, in quanto scevra da incongruenze e da vizi
logici.
La Corte territoriale ha soppesato infatti comparativamente, da un lato, l’entità
della prestazione del coniuge poi fallito alla luce della consistenza oggettiva
dell’immobile sul quale il diritto di abitazione è stato costituito e del valore di
tale diritto in rapporto alla prevedibile durata della vita del coniuge
beneficiario; dall’altro lato, il vantaggio corrispettivo conseguito dal disponente
(esonero dall’obbligo di corrispondere a un assegno mensile di lire 750.000),
ponendo l’accento – ai fini della conclusiva valutazione di carenza di congruità
– sulla circostanza che mentre tale obbligo era stato prefigurato ab origine
come temporaneo, essendo destinato a cessare, stante la sua causale, allorché
la Primerano fosse venuta a disporre di una idonea residenza; di contro, l’atto
impugnato poneva il Marotta nella necessità di affrontare a propria volta le
spese
per
il
reperimento
di
altra
abitazione.
5.
Il
ricorso
va
pertanto
rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
147
La Corte, rigetta il ricorso, condanna Maria Francesca Primerano al rimborso
delle spese processuali in favore del fallimento Gruppo Editoriale Marotta di
Marotta Carlo, liquidate in euro 1600 di cui euro 100 per esborsi ed euro 1500
per onorari, oltre spese generali ed accessorie di legge.
148
Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 6 ottobre 2005, n. 19512
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso in data 21 aprile 1997 della curatela del fallimento Riviera Motori di
B. e P. s.n.c., il Presidente del Tribunale di Imperia emise decreto con cui
ingiunse alla Banca di Roma s.p.a. di pagare alla ricorrente la somma di lire
53.150.000 - oltre interessi e spese - pari all'importo di sei assegni circolari
non trasferibili emessi nel 1991 dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. a favore
della società poi fallita, girati per l'incasso alla Banca di Roma - Filiale di
Ventimiglia e da quest'ultima pagati a persona diversa dal prenditore.
L'ingiunta si oppose, eccependo la prescrizione dell'azione nel presupposto che
si verteva in tema di responsabilità extracontrattuale. In corso di giudizio,
chiese di provare per testi di avere pagato correttamente gli assegni in
questione a soggetto, tale Giuseppe L., delegato all'incasso dal B., legale
rappresentante della s.n.c. prenditrice e interessato a che le somme riscosse
non figurassero nei bilanci ufficiali della società amministrata.
L'adito tribunale respinse l'opposizione e stessa sorte la Corte di appello di
Genova riservò al gravame della Banca di Roma. Premise la Corte ligure che le
obbligazioni ex lege nascenti da "ogni altro atto o fatto previsto dalla legge"
costituiscono, per l'art. 1173 c.c., un tertium genus definito quasi contrattuale,
la cui violazione importa responsabilità contrattuale in quanto connessa a una
obbligazione specifica inserita in un rapporto obbligatorio con fonte legale,
comunque preesistente alla violazione stessa, in ciò distinguendosi dalla
responsabilità aquiliana conseguente a un'obbligazione costituitasi ex novo.
Osservò, quindi, che la fonte della responsabilità della banca opponente
andava ravvisata nella violazione dei doveri su di essa incombenti per legge, ai
sensi dell'art. 43 legge sul diritto d'assegno, ovverosia nel mancato rispetto
dell'obbligo di diligente accertamento della legittimazione cartolare del
prenditore all'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso. Il sorgere
della relazione intersoggettiva aveva preceduto la causazione del danno
chiaramente connesso alla violazione di un'obbligazione specifica, in cui il
responsabile è pre-individuato così come è determinato il contenuto
dell'obbligo risarcitorio, commisurato all'interesse tutelato dalla legge. Si
verteva, pertanto, nell'ambito di una responsabilità contrattuale, con gli effetti
che ne derivano sotto il profilo della prescrizione dell'azione risarcitoria.
Corretta era anche la sentenza in relazione al rigetto della richiesta istruttoria,
non essendo possibile ritenere che lo specifico dovere imposto alla banca
negoziatrice possa essere stato disinvoltamente
disatteso da
un
comportamento ai limiti della responsabilità penale quanto alla banca
medesima, resa edotta dei rapporti intercorrenti tra il B. e il L. e delle ragioni
149
che avevano indotto il primo a non apparire come prenditore degli assegni; in
ogni caso, le prove dedotte non apparivano idonee a dimostrare l'esistenza di
un legittimo atto di delega all'incasso degli assegni ed erano, come tali,
irrilevanti ai fini del decidere.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dalla Banca di Roma con ricorso
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il fallimento della Riviera Motori di B. e P. s.n.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziata la violazione del r.d. 1736/1933 e degli artt.
2043 e 2947 c.c., la Banca di Roma critica la sentenza per avere la Corte ligure
ravvisato nel comportamento della banca girataria per l'incasso, che abbia
violato il dovere di identificazione del presentatore all'assegno circolare non
trasferibile, una responsabilità ex contractu nei confronti dell'intestatario del
titolo, laddove, ai sensi dell'art. 43 r.d. citato, tale responsabilità va qualificata
come extracontrattuale e, quindi, assoggettata alla prescrizione quinquennale,
essendo il banchiere giratario per l'incasso del tutto estraneo al rapporto
cartolare. Peraltro, la somma portata dagli assegni fu pagata a persona diversa
dal prenditore e conosciuta dalla banca, che appose il timbro "per conoscenza
e garanzia", dietro precise disposizioni del B. che, nella qualità di
amministratore della Riviera Motori s.n.c., aveva sottoscritto la girata "pagate
dall'ordine Banca di Roma". Non sussisteva, quindi, colpa per mancata
diligenza nell'identificazione del presentatore dei titoli, posto che il versamento
è stato effettuato al soggetto indicato dal prenditore e con il pieno consenso di
costui.
Il motivo è da disattendere in entrambe le sue articolazioni.
Anche se nell'impianto del mezzo, incentrato sulla natura della responsabilità
della banca girataria per l'incasso in caso di inesatto pagamento, è prospettata
quasi quale argomentazione di rincalzo (peraltro, senza l'indicazione precisa
della norma pretesamente violata dal giudice a quo), la tesi della presunta
assenza di responsabilità nella specie da parte della Banca di Roma, avente
priorità nell'ordine logico delle questioni, è palesemente destituita di ogni
minimo fondamento giuridico.
Come correttamente statuito dai giudici di merito (la cui motivazione in diritto
sul punto va però integrata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con le considerazioni di
cui infra), la violazione dell'art. 43 legge sul diritto d'assegno è manifesta. Per
effetto di questa norma, è la banca girataria per l'incasso che è tenuta a
identificare il presentatore girante, accertare che egli sia il prenditore del titolo
e provvedere al pagamento dell'assegno, che avverrà di norma dopo che la
banca trattaria abbia accertato l'autenticità della firma del proprio cliente e
inviato la valuta alla banca girataria per l'incasso; questa, peraltro, può anche
150
anticipare la valuta effettuando pur sempre il pagamento al prenditore
personalmente e non ad altro soggetto. Nella specie è incontestabilmente
accertato che, nonostante la clausola di non trasferibilità, gli assegni circolari in
questione, girati per l'incasso alla Banca di Roma dalla beneficiaria Riviera
Motori di B. e P. s.n.c., vennero pagati dal cassiere, anziché a quest'ultima, a
tale Giuseppe L., apponendo prima della relativa firma la dicitura "per
conoscenza e garanzia". L'irregolarità del pagamento è dunque evidente, data
la presenza della firma del L. (formalmente "per conoscenza e garanzia", ma
sostanzialmente "per quietanza"), il cui intervento - figurante sui titoli in
termini di attestazione dell'identità del prenditore, a maggior tutela del
cassiere sportellista - era in realtà inteso a sostituire il prenditore medesimo
nella percezione delle somme e non ad asseverarne la legittimazione a
riscuotere. Il tutto in violazione dell'obbligo, espressamente posto a carico
della banca negoziatrice dall'art. 43 legge sull'assegno, di diligente
accertamento, all'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso, della
legittimazione cartolare del prenditore, che costituisce fonte della facoltà di
negoziare il titolo e, con la girata, di investire la banca dei poteri del
mandatario. In definitiva, essendo l'assegno circolare intrasferibile, la clausola
"per conoscenza e garanzia", apposta accanto alla sottoscrizione del L., non
era certamente idonea a legittimare il pagamento in favore di persona diversa
dalla società prenditrice.
Anche il nucleo centrale del mezzo in esame è infondato.
A termini dell'art. 43 legge sull'assegno (r.d. 1736/1933) «L'assegno bancario
emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al
prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi
non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può
ulteriormente girarlo».
Soggiunge il comma 2 di detto articolo «Colui che paga un assegno non
trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per
l'incasso risponde del pagamento».
La regola, in virtù del rinvio operato dall'art. 86, comma 1, ultima parte legge
sull'assegno, si applica anche all'assegno circolare, in quanto non sia
incompatibile con la sua natura.
È pacifico in giurisprudenza (Cassazione 6778/1990, 10111/1993) e presso la
dottrina maggioritaria che tale disciplina, e la conseguente responsabilità in
caso di sua violazione, vale per "colui che paga" e quindi non soltanto per la
banca trattaria ovvero per la banca emittente, in ipotesi di assegno circolare,
ma anche per l'eventuale banchiere giratario per l'incasso. Si nota
convincentemente, al riguardo, che quantunque non sia corretto parlare di
"pagamento" in riferimento alla banca girataria per l'incasso, dovendosi
piuttosto dire che essa non "paga", non essendo a ciò obbligata sotto il profilo
cartolare, ma anticipa la valuta acquistando la legittimazione all'esercizio del
diritto cartolare, tuttavia l'espressione "colui che paga", in una interpretazione
che tanga conto altresì di quanto immediatamente prima prescrive l'ultimo
151
comma dell'art. 41 (dove chiaramente si dice "il trattario o il banchiere"), abbia
appunto il senso di estendere anche al banchiere giratario per l'incasso le
conseguenze per il pagamento dell'assegno effettuato contra legem. Non
essendo tenuto il trattario a verificare l'autenticità delle firme, la protezione dei
terzi interessati in caso di falsa o irregolare girata per l'incasso sarebbe
compromessa se il banchiere giratario non fosse obbligato a tale verifica, cioè
all'identificazione dell'intestatario girante.
Contrasti presso la giurisprudenza di questa Corte, come anche in dottrina, si
sono registrati in ordine alla natura della responsabilità in cui incorre il
banchiere giratario per l'incasso che, in violazione dell'art. 43 legge
sull'assegno, paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore.
Secondo un primo indirizzo, sorto in tema di assegno bancario (non
trasferibile), la banca negoziatrice agirebbe quale sostituita nel mandato (art.
1717 c.c.) impartito dal traente dell'assegno alla propria banca trattaria. Più in
particolare, si è ritenuto che la banca girataria per l'incasso di un assegno
bancario non trasferibile sia da considerare non soltanto mandataria del
prenditore-girante, ma anche sostituta della banca trattaria nell'esplicazione
del servizio di pagamento dell'assegno, cui quest'ultima è obbligata nei
confronti del traente in base alla convenzione di cheque. Subentrando alla
banca trattaria, la banca girataria si sostituisce ad essa nel dovere di
identificazione del presentatore del titolo con l'uso della dovuta diligenza
professionale, mediante le cautele e gli accorgimenti suggeriti dal caso
concreto. Sotto questo profilo, la banca girataria viene chiamata a rispondere
del negligente pagamento non solo nei confronti della banca trattaria, ma
anche nei confronti del traente, ai sensi dell'art. 1717, ultimo comma, c.c. In
altri termini, il traente può esercitare verso la banca che ha effettuato il
pagamento irregolare la medesima azione contrattuale che avrebbe potuto
esercitare in forza della convenzione di assegno nei confronti della banca
trattaria, non potendo i di lui diritti ricevere una tutela diversa secondo che il
pagamento venga richiesto alla banca trattaria o ad altra banca girataria per
l'incasso (cfr. Cassazione 3928/1977, 6929/1986, 4187/1987, 6377/2000 - la
quale, tuttavia, distingue l'ipotesi del pagamento in violazione della causa di
intrasferibilità dell'assegno circolare, rispetto al quale il richiedente a nome
altrui resta un terzo estraneo al rapporto cambiario ed ha solo un'azione
extracontrattuale contro la banca che abbia pagato l'assegno a persona diversa
dall'intestatario - 14359/2001).
Per altro orientamento, anch'esso sorto in fattispecie di assegno bancario non
trasferibile, detta responsabilità sussiste erga omnes e si configura come
aquiliana o extracontrattuale non potendo qualificarsi il banchiere giratario alla
stregua di sostituto della banca trattaria o emittente nell'adempimento della
convenzione di assegno, come tale posto in rapporto diretto con il traente, ma
dovendosi piuttosto considerarlo, in quanto investito e attivato dalla procura
all'incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale
riceve il pagamento (così Cassazione 6778/1990, 10111/1993, 1641/1996,
1023/1998, 1087/1999, 9902/2000, 12425/2000).
152
Ad avviso di questa Corte, nessuno dei due indirizzi merita di essere seguito.
Non il primo che identifica nel banchiere giratario per l'incasso il sostituto della
banca trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno, ponendolo
perciò in rapporto con il traente che può esercitare contro di lui l'azione
contrattuale fondata, appunto, sulla convenzione d'assegno. Una tale
costruzione è incompatibile con la considerazione che il banchiere giratario è
totalmente estraneo sia alla convenzione di assegno sia al rapporto di
emissione del titolo; esso, investito e attivato dalla procura all'incasso, figura
soltanto quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve
il pagamento. Vero è che la banca trattaria o emittente non potrebbe mai, in
caso di girata per l'incasso, procedere direttamente al controllo della
legittimazione e all'identificazione del presentatore, cionondimeno appare
superfluo ogni richiamo ai principi in tema di mandato, posto che anche per ciò
che attiene alla negoziazione dei titoli di credito valgono le stesse regole
dettate per il pagamento; anzi, la previsione legislativa della possibilità di
girare per l'incasso l'assegno non trasferibile esclusivamente a un banchiere
assume un preciso significato proprio in considerazione della responsabilità
professionale e della funzione di pubblico interesse degli istituti di credito, cioè
dell'estrema sicurezza offerta dalla particolare qualità del soggetto
intermediario. In ogni caso, l'interpretazione dell'art. 43 legge sull'assegno
offerta dalle sentenze che si iscrivono in questo indirizzo, se può apparire
confacente in tema di assegno bancario (per il quale è, in realtà, avanzata) la
cui struttura si spiega sullo schema della delegazione di pagamento, non
sembra per altro verso riproponibile per l'assegno circolare; è infatti
largamente contestato che all'atto dell'emissione dell'assegno circolare si
stipuli un contratto di mandato, in relazione al quale potrebbe aversi la
sostituzione (o il submandato nei confronti) della banca girataria.
Ma neanche il secondo orientamento è persuasivo. Deve, in generale,
premettersi che esso pare ispirato all'intento pratico di evitare che la
configurazione della responsabilità sub specie contrattuale possa condurre a
una sorta di deresponsabilizzazione dell'istituto negoziatore, il quale, ove fosse
considerato quale mero sostituto della banca trattaria ed esecutore delle
istruzioni di quest'ultima, ben potrebbe limitarsi a pagare la somma al
presentatore una volta che la trattaria, ricevuto l'assegno in compensazione,
non abbia sollevato eccezioni sulla sua regolarità. Di qui l'esigenza di investire
la banca girataria di un titolo autonomo di responsabilità, la cui rilevanza non
viene meno per via della concorrente condotta della banca trattaria.
Ma, a parte ciò, la tesi non è condivisibile sul piano dei principi generali in tema
di obbligazioni. Com'è noto, la responsabilità extracontrattuale - nonostante
l'ampia portata della dizione dell'art. 2043 c.c., che fa riferimento a "qualunque
fatto doloso o colposo" - ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga
formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto, non legato
all'attore da alcun rapporto giuridico precedente o, comunque, indipendente da
tale eventuale rapporto, sicché essa può configurarsi solo per effetto della
violazione di una norma di condotta. Ove a fondamento della pretesa dedotta
in
giudizio
venga
enunciato
l'inadempimento
di
un'obbligazione
153
volontariamente contratta, o anche derivante dalla legge (art. 1173 c.c.), non
vi è luogo per l'illecito aquiliano, ma è ipotizzabile unicamente una
responsabilità contrattuale o legale derivante da un preesistente vincolo
obbligatorio specifico posto in essere tra le parti dalla volontà delle stesse
ovvero direttamente da una disposizione di legge.
Orbene, non v'è dubbio che l'obbligazione per l'istituto negoziatore di pagare
l'assegno solo al prenditore o al beneficiario deriva direttamente dalla
disposizione di legge innucleata nell'art. 43 legge sull'assegno, a sua volta
richiamata dall'art. 86 stesso decreto. Anzi, da tale disposizione sembra
promanare il richiamo a una più stretta diligenza proprio dell'istituto
negoziatore di assegni in ragione degli aspetti pratici e sostanziali
dell'operazione di pagamento. A questo proposito, si rammenta che la banca
girataria riceve materialmente il titolo dal proprio cliente, trovandosi così a
gestire in forma individuale la presentazione dell'assegno in versamento, con
maggiori possibilità di riscontare eventuali irregolarità nella circolazione del
titolo o contraffazioni. Di contro, l'azienda trattaria e quella emittente si
vedono normalmente consegnare il titolo in stanza di compensazione,
all'interno di una rimessa comprendente una moltitudine di altri titoli, per
giunta con tempi assai ristretti per poterne eccepire l'irregolarità (verificandosi,
in caso contrario, la presunzione di "pagato" che consegue allo spirare dei
termini delle procedure interbancarie). A ciò si aggiunge che solo l'azienda
girataria per l'incasso ha la possibilità di un diligente vaglio sulla persona del
presentatore (ivi comprese le sue qualità) e sulla natura del documento di
identificazione esibito, elementi tutti che devono concorrere a integrare un
pagamento diligente e liberatorio. In diversi termini, l'art. 43 legge
sull'assegno,
per
agevolare
l'incasso
dell'assegno
(assolutamente)
intrasferibile, ne ammette la girata per l'incasso esclusivamente a un banchiere
sul cui vaglio fa affidamento, rendendolo - per così dire - mallevadore verso la
trattaria (o la banca emittente dell'assegno circolare) della esatta
identificazione del prenditore e infine responsabile dell'inesatto pagamento, che
si pone in evidente contrasto con i principi che reggono il servizio bancario e
impongono al banchiere comportamenti conformi alle regole della specifica
professionalità.
Quindi, promanando direttamente dalla legge, la responsabilità della banca
girataria per l'incasso non si configura come obbligazione ex delicto, ma, per
l'appunto, come obbligazione ex lege, riconducibile in base all'art. 1173 c.c., ad
ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità
dell'ordinamento giuridico. Trattasi, in fin dei conti, di fattispecie tipica di
obbligazione che, pur non avendo natura contrattuale, non può per ciò solo
essere ricondotta nello schema generale dell'art. 2043 c.c., trovando invece il
suo archetipo nell'art. 1173 c.c. Il fondamento della correlativa azione
risarcitoria è unico e non vi è bisogno di diversificarne il titolo (contrattuale,
extracontrattuale, cartolare) a seconda del soggetto che si ritiene danneggiato.
Il criterio per individuare il soggetto titolare della pretesa dovrà essere fondato
sull'individuazione della sfera giuridica patrimoniale sulla quale è in concreto
caduto il danno. In linea generale, il pregiudizio derivante dal pagamento
dell'assegno circolare a soggetto diverso dal prenditore potrebbe ripercuotersi
154
sul richiedente, ovvero sul prenditore, ovvero infine sulla stessa banca
emittente se nella negoziazione si sia inserita una banca girataria per l'incasso.
Corretto è, quindi, il percorso giuridico seguito dalla sentenza qui impugnata.
Il banchiere giratario per l'incasso che paga un assegno circolare non
trasferibile a persona diversa dal beneficiario indicato dal titolo incorre in una
responsabilità, nei confronti del beneficiario, che non ha natura contrattuale,
non essendovi rapporto negoziale di sorta tra banca e beneficiario medesimo,
né extracontrattuale, che riguarda il comportamento illecito per la violazione
dell'obbligo generico del neminem laedere, bensì quasi contrattuale ai sensi
dell'ultima parte dell'art. 1173 c.c. L'obbligazione deriva appunto direttamente
dalla legge, ovverosia dalla norma di cui all'art. 43 legge sull'assegno, la quale
prevede l'obbligo, a carico del banchiere giratario per l'incasso, di pagare solo
ed esclusivamente al soggetto ordinatario ed il correlativo diritto, a favore di
tale soggetto, di chiedere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale patito. Ne
consegue che il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità nei
confronti della banca negoziatrice è quello ordinario decennale e non quello
quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per la domanda risarcitoria
da fatto illecito.
Con il secondo motivo, viene denunziata omessa e insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole
la ricorrente che la Corte, al pari del tribunale, pur avendo ravvisato nella
fattispecie una ipotesi di responsabilità contrattuale, ha respinto la prova per
testi intesa a dimostrare che la banca non aveva alcuna colpa per avere agito
su espressa disposizione del prenditore degli assegni. Né, a proposito della
indicazione del L. quale delegato all'incasso da parte del B., poteva obliterarsi
che costui aveva agito nella veste di legale rappresentante della Riviera Motori
s.n.c.
Il motivo è inammissibile sotto due profili.
Valutare se la prova non ammessa riguardasse un punto decisivo della
controversia richiede, da parte della Corte di cassazione, il raffronto tra il fatto
da provare e le circostanze dedotte a contenuto della prova nel giudizio di
appello. Perché la Corte sia posta in grado di compiere tale valutazione è
necessario che la parte interessata indichi nel ricorso il contenuto dei capitoli di
prova, diversamente il motivo di ricorso viene a mancare del requisito della
specificità. Ciò da tempo la giurisprudenza della Corte viene affermando
attraverso l'enunciazione del principio secondo cui il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova
testimoniale, ha l'onere di indicare specificamente - occorrendo anche
mediante integrale trascrizione in ricorso - le circostanze che formavano
oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e
sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per
cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere tale
verifica solo in base alle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è
155
consentito sopperire con indagini integrative (solo per indicare le più recenti,
sentenze 19138/2004, 9711/2004, 9290/2004, 5369/2004, 17904/2003,
15751/2003, 9712/2003).
Orbene, nel caso, la ricorrente si è limitata a dedurre di avere formulato una
istanza di ammissione di prova testimoniale, ma di questa non ha poi indicato
il contenuto.
Ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo sta nel fatto che con esso non
risulta censurata la ratio decidendi autonoma espressa a riguardo dalla Corte
del merito, per la quale la prova (oltre che inammissibile) era anche irrilevante
in quanto, dalla articolazione dei relativi capitoli, appariva inidonea a
dimostrare la esistenza di un legittimo atto di delega all'incasso dei titoli.
Infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso va rigettato con condanna della
sua proponente alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 2.700 di cui 2.500 per onorari d'avvocato oltre
spese e accessori di legge.
156
CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI – SENTENZA 13 OTTOBRE 20055 MAGGIO 2006, N. 10311
PRESIDENTE CARBONE – RELATORE LO PIANO
PM MACCARONE – CONFORME – RICORRENTE COCCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cocco Salvatore convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Alghero,
Sanna Sebastiano e la Spa Lloyd Italico, assicuratrice per la responsabilità
civile dell’auto di quest’ultimo, e ne chiese la condanna, in solido, al
risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale, la cui
responsabilità era da attribuire al Sanna, come dallo stesso riconosciuto con la
sottoscrizione del modulo di constatazione del sinistro (c.d. CID).
Si costituì in giudizio la compagnia di assicurazione, che chiese il rigetto della
domanda, deducendo la inattendibilità di quanto risultante dal CID.
Sanna
Sebastiano
rimase
contumace.
Il Giudice di pace, ritenuto il concorso di colpa del Sanna, nella misura del
20%, e del Cocco, nella misura dell’80%, condannò il Sanna e la compagnia di
assicurazione, in solido, a pagare al Cocco il 20% dei danni da questi subiti,
condannandolo a pagare alla compagnia assicuratrice l’80% delle spese.
La sentenza fu appellata, in via principale, dal Cocco, che chiese affermarsi
l’esclusiva responsabilità del Sanna, con la conseguente condanna dello stesso
e della compagnia di assicurazione all’integrale risarcimento dei danni, e, in via
incidentale, dalla compagnia di assicurazioni, che chiese l’integrale rigetto della
domanda
proposta
nei
suoi
confronti.
Sanna Sebastiano rimase contumace anche nel giudizio d’appello.
Il Tribunale di Sassari, in accoglimento dell’appello incidentale, respinse la
domanda proposta dal Cocco nei confronti del Sanna e della compagnia di
assicurazione,
sulla
base
delle
seguenti
considerazioni:
- la tesi del Cocco (secondo cui l’incidente si sarebbe verificato perché
l’autoveicolo del Sanna, che egli stava sorpassando, in un tratto di strada
rettilineo, aveva, a sua volta, iniziato una manovra di sorpasso del veicolo che
lo precedeva, intersecando cosi la traiettoria. della propria auto e
determinandone l’uscita di strada) non era provata, cosi come non era provato
il nesso di causalità tra i danni lamentati dal Cocco ed il sinistro;
la ricostruzione del sinistro, contenuta nel modulo CID, non poteva costituire
prova nei confronti della compagnia assicuratrice, perché il detto modulo non
risultava essere stato ad essa tempestivamente trasmesso e perché non
risultava essersi verificato uno «scontro tra veicoli», requisito richiesto
dall’articolo 5 del Dl 857/76; - gli elementi risultanti dal modulo CID - al quale
poteva essere attribuita soltanto il valore di prova atipica - apparivano in
insanabile contrasto con la documentazione fotografica acquisita agli atti, con
le osservazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e con la circostanza che
sull’auto del Sanna non erano state riscontrate tracce di collisione;
del tutto da condividere erano, quindi, le conclusioni cui era pervenuto il
157
consulente tecnico d’ufficio, secondo cui i danni riscontrati sull’autoveicolo del
Cocco non erano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dalle parti,
cosicché, se l’incidente si era effettivamente verificato, non si era svolto,
comunque,
con
le
modalità
indicate;
pertanto, non era da ritenere sussistente la prova del fatto e del nesso di
causalità con i danni dei quali il Cocco aveva chiesto il risarcimento.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso Cocco Salvatore.
La Spa Lloyd Italico e Sanna Sebastiano non hanno svolto attività difensiva.
La causa, dapprima assegnata alla terza sezione civile, è stata rimessa alle Su
essendosi ravvisata una questione di massima di rilevante importanza in
relazione
ai
motivi
addotti
a
sostegno
del
ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denuncia: Violazione degli articoli 112, 339,
342
Cpc
in
relazione
all’articolo
360
n.
3
Cpc.
Si deduce che la sentenza di primo grado, che aveva pronunciato la condanna
in solido del Sanna e della Spa Lloyd Adriatico, era stata impugnata solo da
quest’ultima, che aveva chiesto la reiezione della domanda contro di lei
proposta dal Cocco; nessuna impugnazione era stata invece proposta da Sanna
Sebastiano, con la conseguenza che il giudice d’appello non avrebbe potuto
rigettare la domanda, avanzata nei confronti del predetto dal Cocco e già
accolta,
sia
pure
parzialmente,
dal
giudice
di
primo
grado.
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’articolo
116 Cpc e degli articoli 2054, 2697 e 2735 Cc, nonché dell’articolo 5, comma 1
e 2, del Dl 857/76 convertito nella legge 39/1977 in relazione all’articolo 360
nn.
3
e
5
Cpc.
La
censura
svolge
le
seguenti
argomentazioni:
Il Tribunale ha immotivatamente disatteso le risultanze del modulo CID, che
con riferimento al Sanna aveva valore di confessione stragiudiziale, nel quale
erano con precisione indicati l’ora ed il luogo del fatto, i mezzi coinvolti, il teste
presente, le modalità del sinistro, la dichiarazione del Sanna di avere costretto
con la sua manovra il Cocco a «stringere a sinistra», nonché il punto di
contatto
tra
i
due
mezzi;
- v’era la prova della collisione tra i due veicoli e la dinamica del sinistro era
stata confermata dal teste indicato nel modulo CID ed aveva trovato riscontro
nel
l’interrogatorio
libero
e
in
quello
formale
del
Cocco;
- la prova del sinistro e delle sue modalità era stata data dal Cocco a mezzo di
prove documentali ed orali e tale prova non poteva essere superata dalla
consulenza basata su mere deduzioni, tra l’altro, erronee e contraddittorie;
- la prova del nesso causale tra i danni ed il sinistro era stata fornita e del
resto la sentenza del giudice di pace sul punto non era stata impugnata; il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’articolo 5 del Dl 857/76 trovi
applicazione soltanto nel caso di «scontro» tra i veicoli inteso nel senso di
contatto materiale tra gli stessi idoneo a cagionare danno ad entrambi, mentre
158
è da considerare «scontro» «qualsiasi contatto tra i mezzi cha causalmente
provochi, di per sé ovvero in conseguenza di manovre illegittime e colpose, un
sinistro»; - il modulo CID era pienamente probante nei confronti della
compagnia assicuratrice, perché gli elementi in esso indicati avevano trovato
riscontro negli altri elementi di prova acquisiti al processo; la valenza
probatoria del modulo CID non poteva essere inficiata dal rilevato ritardo con
cui, secondo il Tribunale, esso era stata trasmesso alla compagnia
assicuratrice; ciò perché: nessun termine era previsto dalla legge per l’invio del
modulo; nessuna eccezione era stata sollevata in proposito dalla compagnia di
assicurazione; il modulo era stato consegnato tempestivamente dal Cocco alla
propria compagnia assicuratrice; il Tribunale ha immotivatamente ritenuto che
la compagnia assicuratrice avesse fornito la prova contraria, su di essa
incombente, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, Dl 857/76.
Con riferimento ai detti motivi, la terza sezione civile di questa Corte, ha
rilevato che gli stessi pongono una questione di massima di particolare
importanza (articoli 374 e 376 Cpc) e, pertanto, ha rimesso gli atti al Primo
Presidente, che ha disposto la trattazione della causa da parte di queste Su.
L’ordinanza, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, osserva che in essa
sono
rinvenibili
due
principi:
uno, secondo cui il litisconsorzio previsto dall’articolo 23 della legge 990/69,
che impone al danneggiato che esercita l’azione diretta (articolo 18) nei
confronti dell’assicuratore di chiamare in giudizio il responsabile del danno,
«soddisfa l’esigenza che sulla responsabilità dell’assicurato e dell’assicuratore
si statuisca in un unico contesto, in modo uniforme», cosicché l’impugnazione
proposta dal solo assicuratore impedisce che sulla responsabilità del
danneggiante,
chiamato
in
giudizio,
si
formi
il
giudicato.
L’altro, secondo cui «il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale
redatto ai sensi del Dl 857/76, convertito con modificazioni in legge 39/1977,
(quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte,
compresa la data) ha valore probatorio di confessione esclusivamente nei
riguardi del suo autore, mentre genera soltanto una presunzione iuris tantum
nei confronti dell’assicuratore, come tale superabile con prova contraria», con
la possibilità, quindi, che la responsabilità dell’assicurato venga affermata in
base alla sua confessione, mentre l’azione diretta nei confronti del
l’assicuratore venga respinta ove egli fornisca la prova contraria.
Con riferimento al caso in esame l’ordinanza osserva che il Tribunale ha
respinto la domanda proposta nei confronti del responsabile del danno che, con
la sottoscrizione del modulo, aveva ammesso fatti per sé sfavorevoli; con ciò il
Tribunale aveva fatto applicazione del primo principio, secondo cui la decisione
deve essere unitaria, sia per l’assicurato, sia per l’assicuratore, ma aveva
disatteso il secondo principio, secondo cui la dichiarazione di fatti sfavorevoli al
responsabile del danno, contenuta nel modulo da lui sottoscritto, ha valore di
confessione
stragiudiziale.
Il Tribunale osserva ancora che se il Tribunale avesse affermato la
responsabilità dell’assicurato, in base alla sua confessione, e rigettato la
domanda nei confronti dell’assicuratore, ritenendo che questi avesse offerto la
prova contraria rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato nel modulo CID,
avrebbe rispettato il secondo principio, ma avrebbe disatteso il primo.
159
L’ordinanza, a questo punto, prospetta, sia pure in via dubitativa, le seguenti
possibili
soluzioni:
- un’applicazione dell’articolo 2733 Cc in linea coi primo principio, nel senso
che la confessione di uno soltanto dei litisconsorti necessari sia bensì
liberamente apprezzabile dal giudice, ma in modo conforme per tutti i
litisconsorti, come affermato da Cassazione, 198/87; ma a ciò, secondo
l’ordinanza, sembra ostare la lettera e la ratio dell’articolo 5, comma 3, Dl
857/76, che ha anche funzione dissuasiva di tentativi di frode in danno
dell’assicuratore;
- ritenersi che l’impossibilità di un apprezzamento (e di conseguenze) difforme
per il confitente e per il litisconsorte non confitente sia da riservarsi ai soli casi
di litisconsorzio sostanziale in cui sia dedotto un unico rapporto, con la
conseguente possibilità di valutare diversamente la confessione dell’assicurato
nei casi di cui all’articolo 23, legge 990/69: ammettendosi, cioè, che la sua
confessione (tramite il modulo di constatazione amichevole) non abbia effetto
solo per l’assicuratore che abbia offerto la prova contraria ai sensi dell’articolo
5, comma 3, Dl 857/76; ciò, però, secondo l’ordinanza, comporterebbe lo
scostamento dal primo principio, dovendo allora riconoscersi la possibilità che
lo stesso fatto sia ritenuto vero per l’assicurato, e non vero per l’assicuratore,
quantomeno nei casi in cui sia il solo assicuratore del responsabile (e non
anche il solo assicurato) a dover essere mandato indenne dalla pretesa
risarcitoria
del
danneggiato.
Sembra a queste Su che, al fine di dare una risposta ai quesiti posti con
l’ordinanza di cui sopra - che trovano fondamento nelle questioni poste con i
motivi del ricorso - occorra partire dall’analisi della struttura dell’azione diretta
del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, disciplinata dall’articolo 18 della
legge 990/69, e dall’accertamento delle ragioni del litisconsorzio che il
successivo articolo 23 impone di realizzare nei confronti del responsabile del
danno.
In particolare occorre verificare se il procedimento litisconsortile disciplinato
dai suddetti articoli tolleri che si possa giungere ad una decisione che non sia
unica per tutte le parti che vi devono necessariamente partecipare.
Tale accertamento appare necessario perché, se ben si osserva, più o meno
consapevolmente, la tesi prevalente nella giurisprudenza, che, pure
riconoscendo nella fattispecie considerata la ricorrenza di un litisconsorzio
necessario previsto dalla legge, afferma che la confessione del danneggiante
assicurato fa piena prova nel rapporto tra questi ed il danneggiato, mentre può
essere liberamente apprezzata dal giudice nel diverso rapporto tra assicurato
ed assicuratore, si fonda sulla tesi che non in tutti i casi in cui è necessaria la
partecipazione al giudizio di una pluralità di parti sussiste anche la necessità
che la sentenza sia unica per tutte, donde il diverso senso da attribuire
all’espressione lifisconsorzio necessario, che nell’articolo 102 Cpc, esprime solo
l’esigenza che al giudizio partecipino più soggetti, mentre nell’articolo 2733,
comma 3 del codice civile, si riferisce non a tutti i casi di litisconsorzio ma solo
a quelli in cui la decisione deve essere uguale per tutte le parti in causa.
Ai sensi dell’articolo 19 17 Cc, che disciplina l’assicurazione della responsabilità
civile, di cui l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante dalla
circolazione dei veicoli costituisce una specie, l’assicuratore è tenuto a tenere
160
indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto
durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza
della
responsabilità
dedotta
nel
contratto.
E giurisprudenza costante di questa Corte che l’assicurazione della
responsabilità civile non può essere inquadrata tra i contratti a favore dei terzi
giacché per effetto della stipulazione non sorge alcun rapporto giuridico diretto
ed immediato tra il danneggiato e l’assicuratore, ma l’obbligazione
dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è distinta
ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato è tenuto
nei confronti del danneggiato. Talché quest’ultimo non ha azione diretta contro
l’assicuratore (v. in tal senso Cassazione 8382/93 e successivamente,
Cassazione 2678/96; 4364/97; 4364/00;
10418/02; nonché Cassazione
8650/96, la quale ha precisato che il principio opera anche quando l’indennità
sia stata pagata direttamente al terzo danneggiato, ai sensi dell’articolo 1917,
comma
2,
Cc).
In deroga a questa disciplina, l’art 18 della legge n. 990 del 1969, dispone che
il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un
natante, per i quali a norma della medesima legge vi è obbligo di
assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l’assicurazione. Con il secondo comma, la suddetta norma inoltre dispone che
fino alle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, indicate nella
tabella A allegata alla legge, l’assicuratore non può opporre al danneggiato,
che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né
clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento
del danno, ed altresì stabilisce che l’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa
verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
rifiutare
o
ridurre
la
propria
prestazione.
Fin da Cassazione Su, 5218 e 5219/83 la giurisprudenza di questa Corte è
costante nel ritenere che la legge 990/69, prevedendo l’azione diretta del
danneggiato contro l’assicuratore, ha creato - accanto al rapporto, sorto dal
fatto illecito, tra il danneggiato e l’assicurato ed al rapporto contrattuale fra il
responsabile e l’assicuratore - un terzo rapporto che, sul presupposto del primo
ed in attuazione del secondo, obbliga ex lege l’assicuratore verso il
danneggiato; in sostanza l’assicuratore non resta più estraneo al rapporto tra il
suo assicurato ed il terzo danneggiato, ma viene inserito quale parte e
protagonista attivo nel rapporto risarcitorio dipendente dall’illecito di cui
l’assicurato è responsabile, con la conseguenza che la richiesta del danneggiato
lo rende contraddittore diretto e p rimario per l’accertamento e la
quantificazione dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato e lo costituisce
debitore
verso
lo
stesso
terzo
della
relativa
prestazione.
Secondo lo schema delineato dalla legge 990/69, il danneggiato, allorquando,
trascorso inutilmente il termine di cui all’articolo 22, agisce nei confronti
dell’assicuratore per essere risarcito del danno, non chiede che l’assicuratore
sia condannato ad adempiere in suo favore l’obbligo che il predetto ha nei
confronti dell’assicurato in base al contratto, ma fa valere un diritto suo proprio
nei confronti del predetto assicuratore. Ciò è sufficientemente provato dal fatto
che, secondo la legge, l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che
161
agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né
clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento
del
danno.
L’ accoglimento della domanda del danneggiato presuppone che siano
accertate:
- l’esistenza di un contratto di assicurazione tra l’assicuratore convenuto e colui
che è indicato come responsabile del danno; l’esistenza di una danno e la
responsabilità
del
soggetto
assicurato.
Tali accertamenti, anche so non esplicitamente formulati, costituiscono oggetto
della domanda che il danneggiato propone nei confronti dell’assicuratore, la
quale
ha
quindi
il
seguente
contenuto:
a) si accerti che Tizio è responsabile dei danni che Caio ha subito a seguito di
incidente
stradale;
b) si accerti che Tizio è assicurato per la responsabilità civile con la società X;
c) si condanni la società X, obbligata ai sensi dell’articolo 18 della legge
990/69,
al
risarcimento
dei
danni
subiti
da
Caio.
L’accertamento negativo in ordine ad una sola delle indicate circostanze
importa che la domanda proposta nei confronti dell’assicuratore ai sensi
dell’articolo
18
della
legge
990/69
debba
essere
respinta.
Infatti, in assenza di un contratto di assicurazione non sorge alcun obbligo di
indennizzo a carico del l’assicuratore convenuto e, del resto, una volta
accertata l’esistenza del rapporto assicurativo l’obbligo di indennizzo diretto da
parte del l’assicuratore non sussiste se non sussiste anche la responsabilità
dell’assicurato in ordine al fatto dannoso, o perché questo non si è verificato, o
perché pur essendosi verificato non è connotato dalle caratteristiche
attribuitegli, ovvero ancora perché, pur essendo connotato da quelle
caratteristiche.
non
comporta
alcun
obbligo
risarcitorio.
L’articolo 18 propone una situazione di questo tipo. Vi è da un lato un soggetto
che assume di essere rimasto danneggiato da un sinistro stradale, il quale
agisce in giudizio e dall’altro l’assicuratore che la legge costituisce come
obbligato al risarcimento del danno cagionato dal proprio assicurato. Si hanno
pertanto due soggetti danneggiato ed assicuratore legittimati rispettivamente
ad agire e resistere nel giudizio in forza di un rapporto sostanziale che prevede
un’obbligazione del secondo direttamente nei confronti del primo.
Senonché, come si è visto, l’accertamento dell’esistenza del contratto di
assicurazione e quello relativo alla responsabilità dell’assicurato, i quali
costituiscono oggetto della domanda proposta dal danneggiato nei confronti
dell’assicuratore, riguardano rapporti rispetto ai quali la titolarità è del
responsabile
del
danno.
t, infatti l’assicurato che ha, con la stipulazione del contratto, costituito il
rapporto assicurativo che, sebbene non perda la sua caratteristica di contratto
finalizzato a tenerlo indenne dal rischio del risarcimento dovuto a causa di una
sua responsabilità civile, rende. tuttavia, l’assicuratore direttamente
responsabile nei confronti del danneggiato estraneo al rapporto contrattuale; è
d’altra parte il danneggiante l’autore dell’illecito che fa sorgere il diritto al
risarcimento da parte del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.
In una situazione di questo genere l’articolo 23 della legge 990/69 ha previsto
che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del l’assicuratore deve
162
essere
chiamato
il
responsabile
del
danno.
Si tratta di un litisconsorzio che è necessario non solo perché è previsto dalla
legge, ma anche perché l’accertamento dei due rapporti in cui è coinvolto il
responsabile del danno non costituiscono un mero presupposto per
l’accoglimento della domanda proposta dall’assicurato nei confronti
dell’assicuratore, ma costituiscono invece uno degli oggetti della domanda.
Tale accertamento non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i
soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio
affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei
confronti dell’assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità
dell’assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l’altra, e ciò
non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base
alla struttura dell’azione cosi come disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge
990/69, se si ha presente che l’obbligazione del l’assicuratore di pagare
direttamente l’indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto
assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell’assicurato.
Né è sostenibile che l’univoco accertamento che il giudice compie in ordine
all’azione promossa dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore vale solo
con riferimento al rapporto diretto che la legge istituisce tra i due.
Si consideri come nessuno abbia mai dubitato che l’accertamento della
esistenza del contratto di assicurazione e della responsabilità dell’assicurato,
compiuto nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assi
curatore, valga anche nel rapporto tra assicuratore e responsabile del danno.
Nessuno ha mai sostenuto, infatti, che l’assicuratore condannato a risarcire il
danno, il quale, in separato giudizio svolga l’azione di rivalsa nei confronti
dell’assicurato, assumendo di aver indennizzato il danneggiato pur avendo
avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione,
possa vedersi opporre dall’assicurato che egli non era responsabile del danno e
che il contratto di assicurazione non esisteva, quando questi fatti siano stati
accertati nel giudizio promosso dal danneggiato ai sensi dell’articolo 18, al
quale
abbia
partecipato
anche
l’assicurato.
Allo stesso modo l’assicurato che faccia valere la responsabilità del
l’assicuratore perché questi con il suo comportamento omissivo ha fatto
lievitare il danno oltre i limiti del massimale e, quindi, chiede di essere tenuto
indenne dall’assi curatore, in base al rapporto di assicurazione tra i due
esistente, di quanto abbia dovuto pagare al danneggiato, non può vedersi
opporre dell’assicuratore che il rapporto accertato nel giudizio intercorso tra il
danneggiato e l’assicuratore e la responsabilità accertata nello stesso giudizio
non
esistono.
Se ciò è vero nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, deve essere pure vero
nei rapporti tra danneggiato e assicurato, con riferimento all’accertata
responsabilità del danno. Questa responsabilità una volta accertata o negata
nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, in
contraddittorio con l’assicurato, è accertata o negata anche nei rapporti tra
danneggiato
e
assicurato.
Ma, come si è detto prima, nel giudizio tra danneggiato ed assicuratore
l’esistenza del rapporto di assicurazione e la responsabilità dell’assicurato non
possono essere contemporaneamente affermate e negate. O esistono e la
163
domanda va accolta o non esistono ed allora la domanda va respinta, aspetto
questo ben colto da Cassazione 10693/98 laddove afferma, richiamando
Cassazione 5793/82, che la controversia si svolge in maniera unitaria tra i tre
soggetti del rapporto processuale ed abbraccia inscindibilmente sia il rapporto
di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo.
La situazione non muta se il danneggiato, nel giudizio promosso contro
l’assicuratore ai sensi dell’articolo 18 della legge 990/69, oltre a chiedere la
condanna dell’assicuratore chiede anche la condanna del responsabile del
danno; in tale caso la domanda nei confronti di quest’ultimo si articola nei
seguenti
punti:
a) si accerti che Tizio è responsabile dei danni che Caio ha subito a seguito di
incidente
stradale;
b) si condanni Tizio al risarcimento del danno subito da Caio.
Ma la domanda sub a) proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile
del danno è la stessa domanda sub a) proposta dal danneggiato nei confronti
dell’assi curatore, attiene ad un medesimo fatto, impone l’accertamento delle
medesime circostanze e delle medesime conseguenze giuridiche; ciò che la
differenzia dall’altra e che alla domanda di accertamento della responsabilità si
aggiunge quella di condanna del responsabile al risarcimento del danno. Ora,
se come si è sopra chiarito, l’accertamento della responsabilità dell’assicurato,
nell’azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti del l’assicuratore
deve avvenire in modo unitario nei rapporti di tutte e tre le parti che
partecipano al giudizio, e tale accertamento vale anche nei rapporti tra
danneggiato e responsabile, ne consegue che nell’azione promossa dal
danneggiato nei confronti del responsabile per ottenere da costui il
risarcimento del danno, tale accertamento non può differire da quello svolto in
sede
di
azione
diretta.
La suddetta ricostruzione dell’azione diretta e della sussistenza in essa di un
litisconsorzio necessario che impone oltre alla partecipazione al giudizio del
responsabile del danno anche una decisione unitaria nei confronti dei soggetti
partecipanti allo stesso, giustifica come nell’ipotesi di azione proposta dal
danneggiante nei confronti del solo responsabile del danno non sia prevista la
necessaria partecipazione al giudizio dell’assicuratore quale litisconsorte.
Invero in quest’ultima ipotesi il rapporto sostanziale dedotto in giudizio
intercorre tra le parti che formalmente vi partecipano e la situazione accertata
in quel giudizio solo indirettamente influisce sul rapporto assicurativo, il quale
potrebbe essere solo eventualmente introdotto mediante una chiamata in
garanzia, ovvero essere introdotto con altro giudizio, ovvero ancora non essere
mai
evocato.
Se
quanto
sin
qui
detto
è
esatto
ne
discende:
a) che va ribadita la giurisprudenza di questa Corte, risalente alla Su,
Cassazione, Su, 5220/83, secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei
natanti, qualora il danneggiato, esercitando l’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore, evochi in giudizio quest’ultimo ed il responsabile assicurato
(articoli 18 e 23 della legge 990/69), e, chiedendo un risarcimento eccedente i
limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei
confronti dello assicuratore, anche domanda contro l’assicurato, le domande
164
medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza,
trovando presupposti comuni nell’accertamento della responsabilità risarcitoria
dell’assicurato e dell’entità del danno risarcibile, con la conseguenza che
l’impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti
comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualunque parte proposta,
impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a tutte le
parti (v. di recente: Cassazione 15039/04; 10125/03; 5877/99, 255/99;
9919/98);
b) che, in materia di dichiarazioni rese dal responsabile del danno, va respinta
qualsiasi tesi che porti a concludere che, nel giudizio instaurato ai sensi
dell’articolo 18 della legge 990/69, e nel caso in cui sia stata proposta soltanto
l’azione diretta e nel caso in cui sia stata proposta anche la domanda di
condanna nei confronti del responsabile del danno, in base a dette dichiarazioni
si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, in ordine ai
rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed
assicuratore
dall’altro.
È bene che questo. punto sia affrontato e chiarito, a prescindere dal fatto se la
dichiarazione del responsabile del danno sia contenuta o meno nel cosiddetto
CID, con la precisazione che quanto si parla di dichiarazioni confessorie si fa
riferimento a quelle dichiarazioni in cui siano ammessi fatti che, valutati alla
stregua delle regole in materi5possano portare alle affermazione della
responsabilità del soggetto che le ha rese, e non quindi alle dichiarazioni che
consistano
in
mera
assunzione
di
responsabilità
o
di
colpa..
Questo secondo punto deve, inoltre, essere affrontato in relazione all’ipotesi in
cui la dichiarazione, ritenuta avente valore confessorio, sia resa dal
responsabile del danno che sia anche litisconsorte necessario nel giudizio
promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, e cioè dal proprietario del
veicolo assicurato, secondo quella che è la quasi unanime giurisprudenza di
questa Corte. Questa ipotesi si realizza prevalentemente nel caso, ricorrente
nella specie, in cui il conducente del mezzo si identifica con il proprietario del
veicolo.
Sono estranee al presente giudizio invece le questioni che attengono alla
confessione resa dal conducente del veicolo, il quale non sia anche proprietario
del
mezzo.
Orbene una volta chiarito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei
confronti dell’assicuratore il responsabile del danno, che deve essere chiamato
nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, ed una
volta affermato che la decisione deve essere uniforme per tutti e tre i soggetti
ed è, inoltre, idonea a regolare i rapporti tra gli stessi (non quindi solo il
rapporto tra danneggiato ed assicuratore, ma anche quello tra quest’ultimo ed
il responsabile del danno, in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo, e
tra il predetto responsabile ed il danneggiato in ordine alla responsabilità del
sinistro), appare consequenziale che dalla valutazione delle dichiarazioni di
colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno, non possono
derivare conclusioni differenziate in ordine ai rapporti sopra individuati.
La norma attraverso la quale si realizza questo effetto è quella di cui al comma
3 dell’articolo 2733 Cc, secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata
165
dal giudice; questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo
comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l’ha fatta; infatti
viene esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume
soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non
solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli
altri litisconsorzi. La norma è applicabile alla fattispecie in esame, poiché si
verte in tema di accertamento di fatti, da effettuarsi in modo unitario, i quali,
come si è in precedenza affermato, hanno efficacia e rilevanza comuni per
tutte
e
tre le parti che la legge indica come litisconsorzi necessari del giudizio
promosso dal danneggiato ai sensi dell’articolo 18 della legge 1969/90.
In applicazione dei suddetti principi perde rilievo la questione sollevata nel
secondo motivo del ricorso relativa al valore confesso rio o meno da attribuire
alle
dichiarazioni
rese
della
parti
nel
modello
CID.
Non hanno rilievo neppure le questioni sollevate, sempre con il secondo
motivo, con riferimento alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata,
secondo cui l’articolo 5 della del Dl 857/76 non troverebbe applicazione nella
specie essendo mancato uno «scontro» tra i due veicoli e perché il modello CID
sarebbe
stato
inviato
con
ritardo
all’assicuratore.
Infatti, il Tribunale, nonostante abbia affermato che, per le AMA suddette
ragioni, il modulo CID non potesse avere valore di «presunzione legale» nei
confronti dell’assicuratore, ha finito poi per prendere in esame la ricostruzione
dei fatti contenuta nel predetto modulo e con ampia ed argomentata
motivazione, basata su dati obiettivi e sulle osservazioni del consulente
tecnico, ha, in accordo con questi, concluso che i danni riscontrati sull’auto del
Cocco non erano compatibili con la dinamica del sinistro cosi come descritta
dalle parti e che, ammesso che il sinistro si fosse effettivamente verificato, lo
stesso era comunque avvenuto con modalità diverse da quelle descritte.
Ora se si considera che, come da costante giurisprudenza di questa Corte di
Cassazione, il modulo CID quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e
completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris
tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con
prova contraria e che tale prova può emergere non soltanto da un’altra
presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato
con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di
causa,
ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio, ne consegue che la sentenza
impugnata si sottrae alle censure in diritto svolte dal ricorrente, perché,
nonostante
le
richiamate
-contrarie
affermazioni,
essa
ha finito per applicare di fatto correttamente la norma che si assume violata.
Le censure che. invece, si richiamano alla violazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.
sono inammissibili, atteso che esse si risolvono nella pretesa di una diversa
valutazione
degli
elementi
di
prova
esaminati
dal Tribunale, il cui convincimento è sostenuto da argomentazioni immuni da
vizi logici e, come rilevato nel paragrafo che precede, anche da vizi giuridici.
Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese in assenza di svolgi mento di attività
difensiva
delle
parti
intimate.
166
PQM
La Corte di cassazione, a Su, rigetta il ricorso.
167
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA 21
APRILE-21 GIUGNO 2005 N. 13294
(PRESIDENTE CARBONE; RELATORE ELEFANTE; PM - DIFFORME PALMIERI; RICORRENTE LITOSTAMPA SRL; CONTRORICORRENTE
TESSITURA DELLA TORRE SAS)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22/12/1987, la Tessitura Della Torre s.a.s.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26/11/1987 per il
pagamento di L. 5.944.035, e - messo dal Presidente del Tribunale di Busto
Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata
creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate
plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce
(scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano
stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto,
previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine,
la
riduzione
del
prezzo.
Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione,
deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei
vizi.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di
riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della
somma
di
L.
6.804.301.
Proponeva appello la soc. Litostampa, deducendo fra l'altro che l'obbligazione
di garanzia prevista dall'art. 1490 C.C. si era estinta per novazione in
considerazione della nuova obbligazione assunta dalla venditrice che, nel
riconoscere l'esistenza dei vizi, si era impegnata ad eliminarli: pertanto non
erano esperibili i rimedi di cui all'art. 1492 C.C., in particolare l'acto quanti
minoris, ma se mai soltanto quella di risarcimento del danno per
inadempimento della nuova obbligazione. Con sentenza n. 344/00 dell'815/02/2000, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione, osservando,
per quel che qui rileva, che il riconoscimento dei vizi con l'impegno di eseguire
le riparazioni necessarie ad eliminarli non dà luogo di per sé alla novazione
dell'intero contratto di vendita, se non sia provata in concreto la volontà delle
parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con diverso oggetto
o
titolo,
come
richiesto
dagli
artt.
1230
e
1231
C.C.
168
Pertanto, non sussistendo la novazione della originaria obbligazione di garanzia
del venditore per i vizi, rimane fermo l'iniziale contratto di compravendita,
conseguentemente, ove, gli interventi riparatori restino senza esito, ovvero
abbiano un effetto inidoneo ad eliminare il sopravvenuto squilibrio tra le
prestazioni delle parti, il compratore conserva il diritto di domandare a sua
scelta
la
risoluzione
del
contratto
o
la
riduzione
del
prezzo.
Contro tale sentenza la soc. Litostampa ha proposto ricorso per cassazione, al
quale la soc. Tessitura Della Torre ha resistito con controricorso.
La seconda sezione civile, con ordinanza del 16/12/2003, ha rilevato la
presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti in ordine alla riconducibili
dell'impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi della cosa venduta
nell'ambito della novazione oggettiva dell'obbligazione di garanzia.
Per la composizione del contrasto, il Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, 2°
comma, C.P.C., ha rimesso la questione alle sezioni unite.
Motivi della decisione
1.
Il
ricorso
contiene
tre
motivi.
a) Il primo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492,
1495 e 1230 C.C. Sostiene la ricorrente che a seguito della novazione
dell'originaria obbligazione di garanzia per effetto dell'impegno assunto dal
venditore di riparare la cosa difettosa, non era ammissibile l'azione di riduzione
del prezzo, riconducibile, ai sensi dell'art. 1490 C.C., esclusivamente alla
garanzia per vizi: nel caso di inadempimento della nuova obbligazione assunta dal venditore in sostituzione di quella di garanzia e non rientrante per
il suo contenuto fra quelle derivanti dal contratto di compravendita - il rimedio
esperibile
era
soltanto
quello
del
risarcimento
del
danno.
b) Il secondo motivo concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492
e 1495 C.C. sotto un diverso profilo. La ricorrente censura la sentenza
impugnata per aver - nel ritenere ammissibile il rimedio della riduzione del
prezzo nel caso di inadempimento della nuova obbligazione assunta dal
venditore - erroneamente applicato il principio di diritto formulato dalla
Suprema Corte (con la decisione richiamata: Cass. 27/11/1985, n. 5889),
secondo cui il compratore può chiedere, ai sensi dell'art. 1455 C.C., la
risoluzione del contratto: tale norma esclude l'acto quanti minoris.
c) Il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2909
C.C. e 324 C.P.C. La ricorrente deduce che erroneamente la sentenza
impugnata ha ritenuto l'esistenza del giudicato in ordine all'ammissibilità
dell'azione quanti minoris, senza considerare che aveva formato oggetto
dell'appello
da
essa
proposto.
2. In relazione ai primi due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti
ragioni di connessione, l'ordinanza di remissione ha rilevato l'esistenza di un
contrasto all'interno della giurisprudenza di questa Corte nei seguenti termini.
2.1. Con pronunce conformi la Suprema Corte ha affermato e ribadito che,
qualora il venditore riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita
ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nell'originario
contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte
un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non
169
soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del
contratto di vendita (art. 1495 C.C.), restando soggetta all'ordinaria
prescrizione decennale (v., fra tante, Cass. 19/6/2000, n. 8294; 12/5/2000, n.
6089; 11/5/2000, n. 6036; 24/4/1998, n. 4219; 29/8/1997, n. 8234;
20/2/1997,
n.
1561;
12/6/1991,
n.
6641).
2.2. Tali pronunce appaiono in contrasto con altre dalle quali, con riferimento
all'istituto della novazione oggettiva in generale (art. 1230 C.C.), si ricava il
principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale
l'effetto estintivo dell'obbligazione, che è proprio della novazione, presuppone
sempre - anche se si acceda alla concezione più ampia della novazione
medesima, che la ravvisa in ogni ipotesi di mutamenti di carattere quantitativo
dell'oggetto o di modifiche di modalità o di elementi di una medesima
prestazione - che sia accertata comunque la sussistenza dell'animus novandi,
che deve essere provato in concreto (Cass. 12/9/2000, n. 12039; 14/7/2000,
n. 9354); con l'ulteriore corollario che la modifica dell'oggetto del contratto
integra una novazione quando dà effettivamente luogo ad una nuova
obbligazione incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria, e non
anche quando le parti regolino semplicemente le modalità relative
all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto ed il
titolo
(Cass.
22/5/1998,
n.
5117;
7/3/1983,
n.
1676).
2.3. Secondo l'ordinanza di remissione, ove si ritengano applicabili i principi
enunciati nelle sentenze da ultimo citate, sarebbe quanto meno problematico
aderire alla soluzione offerta dalle pronunce più sopra menzionate ed ai criteri
dalle stesse indicati, con riguardo alla ritenuta novazione dell'obbligazione
discendente dall'art. 1490 C.C. a carico del venditore e alle conclusioni che ne
sono state tratte, in punto di inammissibilità dell'azione di riduzione ex art.
1492, comma 1, C.C., nel caso di riconoscimento dei vizi della cosa venduta e
di assunzione dell'obbligo di eliminarli; sembrando tutt'altro che ragionevole
ritenere «novata» l'originaria obbligazione del venditore, che pertanto non
sarebbe più quella di cui all'art. 1490 C.C., con conseguente impossibilità per
l'acquirente di esperire le azioni di garanzia offertegli dalla legge, pur in totale
carenza dell'animus novandi e della causa novandi, che ne costituiscono
elementi
imprescindibili.
3. Il contrasto giurisprudenziale rilevato con l'ordinanza di remissione, in
sostanza, se comporti novazione dell'originaria obbligazione di garanzia
l'impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa consegnata, con
conseguente preclusione dell'esperibilità delle azioni edilizie, in particolare di
quella
di
riduzione
del
prezzo
(actio
quanti
minor).
3.1. Prima di procedere all'esame del contrasto nei termini in cui e stato
enunciato, è opportuno effettuare una, sia pur sintetica, ricognizione
dell'orientamento della Corte e della dottrina, partendo dalle norme
codicistiche, in tema di obbligazione di garanzia per vizi della cosa venduta e in
relazione
all'istituto
della
novazione.
4. Secondo l'art. 1476 C.C., «le obbligazioni principali del venditore sono:
1)
quella
di
consegnare
la
cosa
al
compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non
è
l'effetto
immediato
del
contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa».
170
L'art. 1477, 1° comma, C.C. stabilisce che «la cosa deve essere consegnata
nello stato in cui si trovava al momento della vendita». A sua volta l'art. 1490,
1° comma, C.C. definisce il contenuto della garanzia per vizi, sancendo che «il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la
rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore». Ai sensi del 1° comma dell'art. 1492 C.C. (effetti della
garanzia) «nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua
scelta la risoluzione del contratto (art. 1453 ss.) ovvero la riduzione del prezzo
salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione».
5. Secondo giurisprudenza, l'obbligazione di garanzia discende dal fatto
oggettivo del trasferimento di un bene affetto da vizi che lo rendano inidoneo
all'uso cui i destinato o ne diminuiscano in misura apprezzabile il valore,
mentre possibili profili di colpa del venditore rilevano, ex art. 1494 C.C., ai soli
eventuali (e diversi) fini risarcitori (Cass. 8/3/2001, n. 3425; 12/5/2000, n.
6089;
22/8/1998,
n.
8338).
In alcune sentenze è detto che l'azione di inadempimento del contratto di
compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli art.
1453 e ss. C.C., ma dalle norme speciali di cui agli art. 1492 e ss. C.C., che
prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale, ed in
particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta,
che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione
del prezzo previste dall'art. 1492 C.C., sia quella di risarcimento dei danni
prevista dall'art. 1494 c.c. (Cass. 5/5/2000, n. 6234; Cass. 4/9/1991, n.
9352).
6. In dottrina, il fondamento dell'istituto è controverso, anche se gli autori
sono concordi nel ritenere che, nonostante l'espressione letterale, l'art. 1476 n.
3) C.C., non configura, acconto a quelle di cui ai numeri 1) e 2), una autonoma
obbligazione avente ad oggetto la prestazione di garanzia: le obbligazioni del
venditore sono quelle di trasferire la proprietà della cosa e di consegnarla nello
stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.
Qualora la cosa risulti difettosa, la garanzia di cui agli artt. 1490 e 1492 C.C.,
nel prevedere la soggezione del venditore ai rimedi della risoluzione del
contratto o della riduzione del prezzo, dà luogo a un'ipotesi di responsabilità
per inadempimento indipendentemente da colpa, in considerazione dello
squilibrio fra le attribuzioni patrimoniali derivanti dall'obiettiva esistenza dei
vizi
al
momento
della
conclusione
del
contratto.
6.1. Secondo alcuni autori, la specialità e la esclusività della garanzia per vizi
opera nel senso che il compratore, nel caso in cui il venditore non sia in colpa,
non possa esperire l'azione di adempimento per ottenere dal venditore la
riparazione o la sostituzione della cosa difettosa: unici rimedi esperibili sono la
risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. La consegna di cosa affetta
da vizi o priva delle qualità promesse è stata da altri ricondotta all'ipotesi della
responsabilità contrattuale per inadempimento e da taluni all'inesatta esecuzione
del
rapporto.
6.2. È stato pure rilevato che la riparazione della cosa, esulando dal contenuto
della prestazione contrattuale, potrebbe assumere rilievo soltanto sotto il
profilo del risarcimento del danno in forma specifica (art. 2058 C.C.). D'altra
parte, il compratore non potrebbe chiedere la sostituzione del bene difettoso,
171
perché in tal caso verrebbe chiesto al venditore un secondo adempimento.
6.3. La maggior parte degli autori, in considerazione della natura delle
obbligazioni poste a carico dell'alienante (aventi ad oggetto un dare) e del
contenuto della garanzia per vizi, ritiene che il venditore non può essere tenuto
a un'obbligazione di facere, che possa consistere nella riparazione o
sostituzione del bene: il che troverebbe conferma anche nel rilievo che tali
rimedi sono normativamente previsti in ipotesi circoscritte, per evitare che il
danneggiante sia costretto a sopportare un sacrificio economico sproporzionato
rispetto al valore del bene (ad esempio, la sostituzione della cosa è
espressamente prevista dall'art. 1512, 2° comma, C.C., per il caso in cui il
venditore abbia prestato la garanzia di buon funzionamento; in tema di
appalto, l'art. 1668 C.C. prevede espressamente a favore del committente la
possibilità di chiedere l'eliminazione della difformità e dei vizi a cura e spese
dell'appaltatore).
7. Stabilisce l'art. 1230 C.C. che «L'obbligazione si estingue quando le parti
sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o
titolo
diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non
equivoco». In tema di modalità che non importano novazione, il successivo art.
1231 C.C. dice che il rilascio di un documento o la sua rinnovazione,
l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione
accessoria
dell'obbligazione
non
producono
novazione.
7.1. Elementi essenziali per la novazione oggettiva, che costituisce un modo di
estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, sono: l'obbligazione
originaria da novare (obligatio novanda), la volontà delle parti di estinguerla e
di sostituirla con una nuova (animus novandi), la diversità della nuova
obbligazione
per
l'oggetto
o
il
titolo
(aliquid
noti).
7.2. Secondo la giurisprudenza, il mutamento dell'oggetto o del titolo deve
riguardare la causa dell'obbligazione, per cui le modifiche accessorie non hanno
alcuna rilevanza (Cass. 2/4/2004, n. 6520; 12/9/2000, n. 12039). L'animus
novandi, inteso come manifestazione non equivoca dell'intento novativo, deve
essere comune ai contraenti (Cass. 9/4/2003, n. 5576; 19/11/1999, n. 12838)
e non può essere presunto ma deve essere provato in concreto (Cass.
27/7/2000,
n.
9867;
7/3/1983,
n.
1676).
La necessità di una volontà diretta in modo non equivoco alla novazione
oggettiva dell'obbligazione, stante il principio generale di conservazione degli
effetti del negozio, sta a significare che l'intento estintivo-sostitutivo deve
essere certo, senza peraltro che siano richieste espresse dichiarazioni di
volontà, essendo sufficiente anche un comportamento concludente o una
manifestazione tacita, ravvisabile nelle ipotesi di incompatibilità oggettiva
(Cass. 1998, n. 5399; 1987, n. 9620; 1983, n. 1676). È da escludere che
l'intento
novativo
possa
farsi
risalire
a
una
volontà
presunta.
8. Il panorama giurisprudenziale, in tema di riconoscimento dei vizi e
assunzione dell'obbligo di eliminarli da parte del venditore, è il seguente.
8.1. Alcune sentenze espressamente affermano l'esistenza della novazione
oggettiva dell'originaria obbligazione di garanzia in presenza dell'impegno
assunto dal venditore di riparare o sostituire la cosa difettosa (Cass.
12/5/2000, n. 6089; 19/6/2000, n. 8294; 13/1/1995, n. 381; 5/9/1994, n.
172
7651). In particolare si dice che qualora il venditore, tenuto per legge alla
garanzia per vizi, riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita
ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia, rientrante nel contenuto
dell'originario contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico
di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di
garanzia), non soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione previsti dal
contratto di vendita restando soggetta alla ordinaria prescrizione decennale
(Cass.
12/5/2000,
n.
6089).
Si precisa, altresì, che mentre il semplice riconoscimento dei vizi rende
superflua la denuncia del compratore, il riconoscimento che il venditore faccia,
verificatasi la decadenza, e l'impegno che egli assuma di eliminarli, dà luogo ad
una nuova obbligazione con estinzione per novazione dell'obbligazione
originaria (Cass. 13/1/1995, n. 381; 5/9/1994, n. 761). Tale indirizzo,
nell'evidenziare la differenza fra il mero riconoscimento dei vizi (che ha il
limitato effetto di rendere superflua la denuncia da parte del compratore) e
l'impegno assunto dal venditore di eliminarli o di sostituire la cosa (che può
avvenire anche per facta concludentia), sottolinea il verificarsi della novazione
oggettiva dell'originaria obbligazione di garanzia, in quanto sostituita da una
nuova, che avendo ad oggetto un facere, non rientra nella previsione di cui
all'art. 1490 C.C.: ne consegue l'inapplicabilità della disciplina dettata in tema
di
decadenza
e
di
prescrizione
dall'art.
1495
C.C.
8.2. Altre sentenze si limitano a sostenere che l'impegno del venditore di
eliminare i vizi della cosa difettosa o di sostituirla determina la costituzione di
un'obbligazione che, essendo nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di
garanzia, è sempre svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione
decennale, indipendentemente dalla volontà delle parti (Cass. 29/8/1997, n.
8234; 14/11/1994, n. 9562). Non fanno riferimento all'effetto estintivosostitutivo dell'originaria obbligazione di garanzia e non parlano di novazione
oggettiva, ma sottolineano soltanto che l'obbligazione del venditore di
eliminare i difetti della cosa è svincolata, indipendentemente dalla volontà delle
parti, dai termini di cui all'art. 1495 C.C. (Cass. 13/12/2001, n. 15758).
8.3. Similmente numerose decisioni (Cass. 17/4/2001, n. 5597; 11/5/2000, n.
6036; 24/4/1998, n. 4219; 20/2/1997, n. 1561; 12/6/1991, n. 6641) si
soffermano unicamente ad analizzare, in relazione agli oneri imposti al
compratore dall'art. 1495 C.C., i presupposti, le modalità, la natura e gli effetti
del riconoscimento dei vizi da parte del venditore, rilevando che il
riconoscimento può avvenire anche per facta concludentia e che esso
impedisce la decadenza del compratore per l'omessa denuncia ovvero può
integrare la rinuncia del venditore a far valere la decadenza già verificatasi
(Cass.
1/4/2003,
n.
4893;
16/7/2002,
n.
10288).
8.4. Esclude espressamente la configurabilità della novazione soggettiva Cass.
29/12/1994, n. 11281 così argomentando: «poiché rientra tra le obbligazioni
del venditore la prestazione di una cosa immune da vizi indicati nell'art. 1490
C.C., l'assunzione dell'impegno di eliminare i vizi, che eventualmente
esistessero nella cosa oggetto della vendita, non è che uno dei modi con i quali
si assicura e si attua l'esatto adempimento dell'obbligazione; essa, di per sé,
non dà luogo all'esistenza di un accordo diretto a modificare uno degli elementi
essenziali dell'obbligazione stessa, posto che la scelta di uno dei rimedi offerto
173
dalla garanzia, come non apporta un obiettivo mutamento del vincolo
obbligatorio, così nemmeno implica necessariamente le volontà di sostituire
alla
precedente
una
nuova
e
diversa
obbligazione».
9. Secondo l'ordinanza di remissione, l'orientamento della Corte che attribuisce
natura novativa dell'originaria obbligazione di garanzia all'impegno assunto dal
venditore di riparare o sostituire la cosa difettosa si porrebbe in contrasto con i
principi formulati in tema di novazione oggettiva dell'obbligazione.
L'effetto estintivo dell'obbligazione, proprio della novazione oggettiva, è detto
nella citata ordinanza, presuppone che sia accertata la sussistenza dell'animus
novandi, sicché la modifica dell'oggetto del contratto integra una novazione
quando dà effettivamente luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il
persistere di quella originaria e non anche quando le parti regolino modalità
relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente senza alterarne l'oggetto o
il
titolo.
9.1. Ma al riguardo le sentenze (sub 8.1), secondo le quali l'impegno assunto
dal venditore dà luogo a una nuova ed autonoma obbligazione che
sostituendosi a quella di garanzia ne determina l'estinzione per novazione
oggettiva, evidenziano che sono le parti a costituire una nuova ed autonoma
obbligazione in luogo di quella originaria derivante dal contratto di
compravendita. Pertanto, l'obbligazione di riparare o sostituire la cosa difettosa
è ritenuta nuova ed autonoma, in quanto non rientra nel contenuto della
garanzia (ovvero fra le obbligazioni contrattuali poste a carico del venditore)
ed è caratterizzata dall'avere un oggetto diverso (aliquid novi) rispetto a quello
di garanzia derivante dal contratto di compravendita, determinandone il
mutamento e non semplicemente la «modifica» della relativa modalità di
esecuzione. Il sorgere di una nuova obbligazione, secondo tali sentenze,
assumerebbe rilievo anche sotto il profilo dell'animus novandi, in quanto
l'esistenza dell'accordo novativo andrebbe accertato verificando se, con
l'accettazione da parte del compratore della nuova obbligazione assunta dal
venditore, le parti abbiano inteso sostituire l'originaria obbligazione ed
estinguerla per novazione (potendo la volontà delle parti di estinguere la
precedente obbligazione risultare, come si e detto, anche per facta
concludentia). Ma tale indagine, risolvendosi nella verifica in concreto della
natura novativa o meno dell'accordo, costituisce accertamento di fatto,
riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se immune da
vizi logici e giuridici (v. ex plurimis: Cass. 5/5/1998, n. 4520; 20/2/1997, n.
1661).
9.2. Le sentenze (sub 8.2), che focalizzano l'indagine esclusivamente sulla non
operatività dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 C.C.
per effetto dell'impegno l'assunto dal venditore di eliminare i vizi, danno rilievo
assorbente alla manifestazione unilaterale di quest'ultimo, non facendo alcun
riferimento all'effetto estintivo-sostitutivo della precedente obbligazione, che in
assenza di un accordo delle parti non potrebbe evidentemente prodursi. In
realtà tali sentenze appaiono ispirate dall'esigenza di tutelare il compratore dai
rigorosi termini di decadenza e prescrizione imposti dall'art. 1495 C.C., e,
pertanto, l'impegno assunto dal venditore e stato considerato come svincolato
da detti termini. Al riguardo è stato pure affermato (Cass. 26/6/1995, n.
7216), analizzando la natura e la portata della dichiarazione del venditore, che
174
bisogna scindere gli effetti che sono ad essa direttamente collegati da quelli
che postulano, con l'accettazione del compratore, il perfezionamento della
novazione: nella prima ipotesi l'impegno del venditore, dando luogo al
riconoscimento del debito, ha soltanto efficacia interruttiva della prescrizione
ex
art.
2944
C.C.
9.3. Infine, le sentenze (sub 8.3), che si sono limitate a considerare gli effetti
e le modalità del solo riconoscimento dei vizi, non hanno dovuto esaminare la
natura e gli effetti dell'obbligazione di riparare o sostituire la cosa difettosa,
che
non
era
oggetto
del
thema
decidendum.
10. Pertanto, un vero e proprio contrasto giurisprudenziale non appare
sussistere. Tuttavia, nei termini in cui i stato denunciato, deve essere risolto in
base
alle
seguenti
considerazioni.
11. La garanzia per vizi, che si giustifica in relazione ad una serie di particolari
istituti di tutela - di prevalente origine commerciale - che caratterizzano lo
scambio di beni, attiene alla prestazione traslativa e, sebbene trovi specifica
regolamentazione nella vendita (negozio nella pratica dominante), non v'è
dubbio che è suscettibile di più ampia applicazione ai contratti di alienazione.
11.1. In realtà, sulla natura della garanzia - connessa ai tradizionali istituti di
tutela del compratore e sulla posizione che essi assumono rispetto alle comuni
regole di tutela creditoria - mancano soluzioni chiare: suggestioni storiche e
concettuali concorrono a rendere l'istituto non facilmente inquadrabile, anche
se è generalmente inserito nel sistema della responsabilità contrattuale, e
quindi
dell'inadempimento
indipendentemente
da
colpa.
11.2. Così, sinteticamente, la garanzia, di volta in volta, è stata ricondotta
all'invalidità del negozio (per anomalia funzionale della causa), all'assunzione
del rischio (come precetto primario di tipo assicurativo), ad una speciale forma
di responsabilità (collegata all'obbligo del venditore di consegnare la cosa
qualitativamente esatta), fino ad essere intesa come violazione dell'impegno
del venditore in ordine dell'esatto risultato traslativo, in quanto la regola del
consenso traslativo, derivante da una pratica negoziale in cui era divenuta
superflua la consegna come formalità condizionante il trasferimento della
proprietà, non annulla l'impegno negoziale dell'alienante circa la conformità del
bene al contenuto esplicito o implicito della sua offerta (un bene sano e senza
difetti
occulti).
12. Il consenso traslativo richiede un accenno, sia pure fugace, alla
distinzione, riguardo al modo e al momento di perfezione del vincolo, tra
contratti consensuali e contratti reali; nonché, riguardo all'efficacia che sono
destinati ad avere immediatamente, tra contratti con efficacia reale (o
traslativi)
e
contratti
obbligatori.
12.1. Nel diritto moderno i contratti si perfezionano di regola con il semplice
consenso delle parti (cd. principio consensualistico). Secondo l'art. 1376 C.C.
«Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato». In
tema di compravendita, il contratto è perfetto nel momento in cui si raggiunge
l'accordo. Il consenso, formatosi secondo legge, produce gli effetti voluti:
indipendentemente, e quindi anche prima, del trasferimento del possesso e del
175
pagamento del dovuto. Logicamente tali affermazioni sono relative al rapporto
inter partes tra i contraenti, mentre relativamente all'efficacia erga omnes il
consenso potrebbe essere non più sufficiente, con conseguente applicazione
della regola della consegna (art. 1155 C.C.) nell'ipotesi di pluralità di vendite
dello stesso immobile, o della trascrizione (art. 2644 C.C.) nell'ipotesi di
vendita
dello
stesso
immobile
a
più
acquirenti.
12.2. Ci sono alcuni contratti speciali, per i quali il consenso, pur sempre
necessario, non basta, nel senso che il contratto è perfetto soltanto con la
consegna della cosa, con la tradizione alla controparte dell'oggetto del
contratto (ad esempio: comodato (art. 1803 C.C.), mutuo (art. 1813 C.C.),
deposito (1766 C.C.), pegno (2784 C.C.), riporto (1548 C.C.), trasporto (art.
1678 C.C.) etc.). Prima della consegna non c'è contratto, ma c'è uno degli
elementi della fattispecie complessa (consenso + traditio) di cui è formato il
contratto reale. Pertanto la consegna non è effetto obbligatorio del contratto,
ma
un
elemento
costitutivo
dello
stesso.
La categoria dei contratti reali, che ha prevalentemente un significato storico,
conserva anche una funzione e un valore di carattere pratico, ben visibili, per
esempio, nel pegno, dove la consegna della cosa mobile dà al creditore una
certezza di garanzia, e nel deposito, dove la consegna della cosa costituisce il
presupposto
necessario
per
l'esercizio
dell'attività
di
custodia.
12.3. La distinzione tra contratti obbligatori (ad es. locazione, mandato,
comodato etc.) e contratti con efficacia reale (o traslativa, ad es.
compravendita, permuta, donazione etc.) rileva nel senso che i primi
producono soltanto effetti obbligatori (in quanto, senza realizzare
automaticamente per il semplice consenso l'effetto voluto, fanno assumere alle
parti l'obbligazione di un certo atto da compiere e di un comportamento da
osservare), mentre i secondi producono anche effetti reali perché, accanto e
oltre l'effetto principale di trasferire o costituire diritti, fanno sorgere, tra le
parti,
obbligazioni
da
adempiere.
12.4. Nei contratti con efficacia reale, se sono consensuali (come la
compravendita), il trasferimento o la costituzione del diritto reale si attuano
per effetto immediato del consenso (principio consensualistico: art. 1376 C.C.).
Nel mutuo, invece, che è un contratto reale, la proprietà sulla cosa fungibile si
trasferisce nel momento in cui il contratto e perfetto, cioè nel momento in cui
avviene
la
tradizione
(consegna)
della
cosa
prestata.
Il criterio distintivo del contratto reale si riferisce alla formazione del contratto,
cioè al suo perfezionarsi, quello del contratto con efficacia reale si riferisce,
invece,
agli
effetti.
12.5. L'individuazione del momento in cui si attua l'efficacia reale ha molta
importanza, specie dal punto di vista pratico. Così, ad esempio, nel contratto di
compravendita, nel preciso istante in cui passa la proprietà passa anche il
rischio del perimento della cosa per caso fortuito, in virtù del principio res perit
domino, affermato nell'art. 1465 C.C.; per cui, se prima del pagamento del
prezzo, un incendio distrugge la cosa venduta, il venditore ha diritto di ricevere
il prezzo, anche se più non farà la consegna del bene al compratore.
In generale, invece, secondo il disposto dell'art. 1463 C.C., la parte liberata
per la soppravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere
la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le
176
norme
relative
alla
ripetizione
dell'indebito.
13. Sempre in tema di tutela del compratore bisogna ricordare che la
giurisprudenza (per lo più confortata dal sostegno della dottrina dominante)
tende sempre più a ridurre il numero delle fattispecie riconducibili ai vizi
redibitori (e alla mancanza di qualità essenziali), estendendo invece la
categoria dell'aliud pro alio, in presenza della quale è noto che il compratore
risulta svincolato dall'onere di denuncia e dalla prescrizione breve.
13.1. La legislazione in tema di tutela del consumatore e responsabilità del
produttore (L. 21/12/1999, n. 526 e d.p.r. 24/5/1988, n. 244) incoraggia le
posizioni interpretative favorevoli all'acquirente nel caso di consegna di cosa
difettosa.
14. Come si è visto, la giurisprudenza allorché adotta lo schema della
novazione oggettiva per inquadrare l'ipotesi del venditore che si impegna ad
eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata (ovvero ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), richiede un accordo
delle parti inteso a conseguire l'effetto estintivo-novativo dell'originaria
obbligazione di garanzia. Qui la novazione non è un effetto automatico
dell'impegno, quanto piuttosto una conseguenza dell'accordo (espressione
dell'autonomia negoziale) delle parti (significativo dell'animus novandi).
14.1. Negli altri casi l'espressione «novazione» e usata in senso atecnico, dato
che la giurisprudenza, posta di fronte al quesito relativo alle conseguenze della
mancata realizzazione del risultato cui il venditore si era impegnato - cioè
l'eliminazione dei vizi - non esita ad affermare che «ove gli interventi riparatori
del venditore... restino senza esito, ovvero... abbiano un effetto inidoneo ad
eliminare il sopravvenuto squilibrio fra le prestazioni delle parti, l'acquirente
conserva il diritto di chiedere la risoluzione del negozio traslativo» (Cass.
27/11/1985, n. 5889). L'uso atecnico del termine novazione è evidente, atteso
che è sufficiente l'inattuazione del nuovo obbligo per far rivivere ciò che c'era
prima,
cioè
la
garanzia.
15. La dottrina che nega che l'impegno del venditore costituisca vera e propria
obbligazione autonoma - ritenendo l'impegno di eliminare i vizi un momento
della fase attuativa della vendita, nel senso che esso e semplicemente
preordinato alla realizzazione dell'operazione economica originariamente
divisata dalle parti - esclude in radice l'esistenza di un fenomeno novativo,
atteso che nella novazione il nuovo obbligo è del tutto autonomo dal vecchio.
15.1. Parimenti resta fuori discussione che si possa parlare di fenomeno
novativo in relazione a quelle teorie che fondano la natura delle garanzie
edilizie su basi diverse dall'inadempimento di un'obbligazione: ciò per
l'evidente assenza di un elemento essenziale della fattispecie novativa, cioè
l'obbligazione
da
novare.
15.2. Ma ad analogo risultato si perviene ove si collochino le garanzie edilizie
nell'ambito dell'inadempimento dell'obbligazione di far acquistare utilmente la
proprietà della cosa (ovvero nell'ambito della c.d. violazione dell'obbligo
traslativo). Non può, infatti, sfuggire come in tal caso l'impegno del venditore a
riparare la cosa viziata non abbia affatto valore novativo della precedente
obbligazione, ma attuativo della stessa, nel senso che esso è esclusivamente
preordinato ad attuare il risultato economico che il compratore si prefigurava di
ottenere
dal
contratto
di
compravendita.
177
15.3. In realtà l'impegno del venditore non rappresenta un quid novi con
effetto estintivo-modificativo della garanzia, ma semplicemente un quid pluris
che serve ad ampliarne le modalità di attuazione, nel senso di consentire al
compratore di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui d'art. 1495
C.C., particolarmente brevi, come la prescrizione annuale, rispetto a quella
decennale.
15.4. Si tratta di assegnare un significato, ai fini dell'esercizio delle azioni
edilizie e del relativo termine prescrizionale, alla circostanza che fra le parti è
in corso, per l'impegno assunto dal venditore, un tentativo di far ottenere al
compratore il risultato che egli aveva il diritto di conseguire fin dalla
conclusione del contratto di compravendita. E altro significato non può essere
che quello di svincolare il compratore dai termini e condizioni per l'esercizio
delle azioni edilizie, atteso che queste non vengono da lui esercitate in
pendenza degli interventi del venditore finalizzati all'eliminazione dei vizi
redibitori, al fine di evitare di frapporre ostacoli, secondo la regola della
correttezza (art. 1175 C.C.), alla realizzazione della prestazione cui il venditore
è
tenuto.
16. Avuto riguardo alle considerazioni svolte e ai principi espressi, risolvendo il
prospettato contrasto giurisprudenziale, queste Sezioni Unite ritengono che
l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso
cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintivasostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 C.C.) dell'originaria obbligazione di
garanzia (art. 1490 C.C.), ma consente al compratore di essere svincolato dai
termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 C.C., ai fini
dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del
prezzo) previste in suo favore (art. 1492 C.C.), sostanziandosi tale impegno in
un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 C.C.).
Solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia),
il cui accertamento i riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere
l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o
titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione
oggettiva.
17. Il principio comporta il rigetto dei primi due motivi di ricorso, atteso che la
corte d'appello, con motivazione congrua ed idonea, ha escluso che le parti
avessero introdotto nel regime negoziale mutamenti dell'oggetto o del titolo
dell'obbligazione con la volontà di porre in essere la sostituzione di un nuovo
rapporto a quello originario in base all'impegno assunto dal venditore di
eliminare i vizi dei beni consegnati; onde, vigendo la garanzia, legittimamente
ha ritenuto che il compratore poteva esperire l'actio quanti minoris (art. 1492
C.C.), svincolato dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 C.C.
18. Il terzo motivo non ha pregio e la ricorrente non ha interesse a dedurre la
censura, giacché, indipendentemente dal fatto che si fosse formato o meno il
giudicato in ordine alla ammissibilità della domanda di riduzione del prezzo, la
corte di merito ha comunque esaminato la questione ed ha ritenuto, per le
ragioni sopra esposte, che era ammissibile l'actio quanti minoris.
19. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato. Ricorrono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
178
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
179
Risarcimento dei danni per le lesioni cagionate alla persona con cui si
convive
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA 29 aprile 2005, n. 8976
(Presidente Giuliano – relatore Chiarini)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 16 aprile 1996 O. Bruno, unitamente a M. Anna e al
figlio di costei, M. Antonio, convenivano dinanzi al tribunale dì Milano R.
Renato, R. Renzo e la Ras Assicurazioni Spa chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni da essi subiti a seguito dell’incidente verificatosi il 27
dicembre 1992, in cui l’auto dell’O., condotta dalla sua convivente M. Anna, era
stata investita dall’auto condotta da R. Renato, di proprietà di R. Renzo.
A causa della collisione la M. riportava gravi lesioni e fratture,con conseguente
invalidità temporanea totale per quindici mesi, e postumi permanenti del 50%,
incidenti sulla capacità lavorativa al 100%, si che ad esso O. erano derivati, di
riflesso, gravi danni, morale e biologico, per complessive lire 250.000.000,
oltre al danno patrimoniale per l’autovettura.
Con sentenza dell’11 marzo 1998 il tribunale di Milano rigettava la domanda
dell’O. perché sfornita di prova in mancanza di indicazione del periodo di
convivenza, delle conseguenze su di essa e sull’O. dopo l’incidente, nonché
dell’anno di immatricolazione e dello stato di conservazione dell’auto.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29 settembre 2000, accoglieva
l’appello dell’O. limitatamente al risarcimento del danno all’auto.
Confermava per il resto il rigetto del gravame sulla considerazione che la
convivenza con la M. aveva avuto inizio da breve tempo - nell’anno
dell’incidente - e difettavano altri elementi probatori in ordine ad aspetti
rilevanti del rapporto, incidenti sui lamentati danni, non avendo l’O. neppure
dedotto una sua patologia conseguita alle lesioni della sua convivente.
Analoghe considerazioni valevano per la richiesta di risarcimento del danno
morale.
Avverso questa sentenza ricorre per due motivi l’O., cui resiste la Spa Riunione
Adriatica di Sicurtà. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Gli altri
intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi dalla decisione
Preliminarmente va disposto lo stralcio dei documenti allegati alla memoria
dell’O. perché in Cassazione la produzione dei documenti è ammissibile
soltanto nei limiti indicati dall’articolo 372 Cpc e con le formalità previste da
detta norma.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce: “violazione e falsa
applicazione degli articoli 2059, 2043 Cc; violazione degli articoli 2697 e 143
Cc, in relazione agli articoli 360 nn 3 e 5 Cpc”.
L’O. ha dimostrato la convivenza con la M. e tale stato è rilevante per il nostro
ordinamento ai fini anche del risarcimento del danno, si che aver condizionato
180
questo diritto alla durata della convivenza o ad altri aspetti del rapporto, viola
gli articoli 2043 e 2059 Cc. Il convivente more uxorio ha infatti diritto ad
ottenere il risarcimento del danno morale (analogo a quello della famiglia
legittima: articolo 2059 Cc), patrimoniale (per il contributo alla vita quotidiana:
articolo 2043 Cc), e biologico, come quello sofferto per la morte o lesioni di
prossimi congiunti.
2.-Con il secondo motivo l’O. deduce: “Violazione e falsa applicazione degli
articoli 2043 e 2059 Cc sotto un ulteriore profilo: diritto dell’O. ad ottenere il
risarcimento del danno biologico; violazione dell’articolo 360 n. 5 Cpc”.
La Corte d’appello ha negato il risarcimento del danno biologico che può
sussistere tutte le volte che l’evento incide sull’integrità psichica e sulle
manifestazioni della vita, incrinando l’equilibrio personale, e certamente il
grado di invalidità residuato alla M. (60%), ha leso lo status complessivo di
convivente di esso ricorrente.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente perché connessi, sono
infondati.
Occorre preliminarmente considerare che, dalla libera determinazione dei
conviventi di fatto di non contrarre il vincolo del matrimonio, e quindi di non
assumere gli obblighi che l’ordinamento impone vicendevolmente ai coniugi
(coabitazione, fedeltà, solidarietà, assistenza materiale e morale), consegue
l’inesistenza di qualsiasi diritto, sia di natura personale che patrimoniale, di un
convivente verso l’altro, ed infatti è pacifico che qualsiasi prestazione
patrimoniale fra loro, se non costituisce adempimento di una regolamentazione
negoziale, non può esser pretesa, ma determina soltanto l’effetto della soluti
retentio (articolo 2034 Cc). Da qui la difficoltà per l’interprete, in assenza di
disciplina normativa di carattere generale sui requisiti indispensabili affinché
un’unione di fatto - anche nell’ipotesi in cui i conviventi, o uno di essi, non sia
libero di stato - sia meritevole di tutela giuridica di fronte ai terzi, di enucleare
un modello di convivenza dalla disciplina dettata da ragioni dì solidarietà
sociale (quali ad esempio i decreti luogotenenziali 968/16, articolo 8 e
1726/18, articolo 12, ispiratori della legge 313/68 in materia di pensioni di
guerra; il decreto luogotenenziale 1450/17, articolo 1, lett. b, in tema di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, il Dpr 1124/65, in
tema dì assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, norme
peraltro emanate in un’epoca in cui nel nostro ordinamento non vi era il
divorzio, ancorché le ragioni dì solidarietà sociale a cui esse sono ispirate
hanno indotto il giudice delle leggi - sentenza 404/88 - a dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 6, comma 1, legge 392/78 nella parte
in cui non prevedeva, tra gli altri successibili nella titolarità del contratto di
locazione di immobile ad uso abitativo, in caso di morte del conduttore, il
convivente more uxorio, al quale peraltro già la legislazione vincolistica aveva
esteso la fruibilità di alcuni benefici).
In relazione alla disciplina della responsabilità civile dalla circolazione dei
veicoli non è superfluo rilevare che il legislatore, nell’estendere l’assicurazione
obbligatoria per la RCA al convivente, aveva previsto la risarcibilità del danno
patrimoniale e morale soltanto per il convivente superstite della vittima
deceduta - così regolamentando un’ipotesi che da tempo aveva trovato
riconoscimento giuridico nella giurisprudenza - ed aveva a tal fine disciplinato i
181
requisiti della convivenza (articolo 20 legge 12 gennaio 1992, tra cui la durata
di essa per un periodo non inferiore a cinque anni) - in tal modo consentendo
all’interprete di superare ogni questione scaturente dalla necessità di
raccordare i principi in tema di responsabilità civile, tra cui quello secondo il
quale il fatto dannoso, a norma dell’articolo 2043 Cc, deve essere contra ius e
cioè deve ledere un diritto, e l’esigenza sociale di riconoscere rilevanza
giuridica ad interessi e ragionevoli aspettative non in contrasto con la legge,
derivanti dalla convivenza - ma la legge non fu promulgata proprio per la
mancanza di criteri obbiettivi per la liquidazione del danno biologico.
Comunque il dato comune che emerge dalla legislazione vigente e dalle
pronunce giurisprudenziali, è che la convivenza assume rilevanza sociale, etica
e giuridica in quanto somiglia al rapporto di coniugio, anche nella continuità nel
tempo.
Ne consegue che colui che chiede il risarcimento dei danni derivatigli, quale
vittima secondaria, dalla lesione materiale, cagionata alla persona con cui
convive dalla condotta illecita del terzo, deve dimostrare l’esistenza e la
portata dell’equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato con la medesima, e
perciò, per poter esser ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve
esser dimostrata l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti,
con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal
fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata
da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto
la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal
legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica
di fronte ai terzi.
Quanto poi alla prova di tali elementi strutturali e qualificativi, concreti e
riconoscibili all’esterno, presupposti dì esistenza della convivenza more uxorio
e parametri caratterizzanti la stessa, può esser fornita con qualsiasi mezzo
(articolo 2697 Cc), mentre il certificato anagrafico (Dpr 223/89) può tutt’al più
provare la coabitazione, insufficiente a provare altresì la condivisione di pesi e
oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica
analoga a quella matrimoniale.
I giudici di appello, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria dell’O.
in conseguenza delle lesioni riportate dalla M., non si sono discostati da tali
principi avendo riscontrato la mancanza di prova su alcuni requisiti
indispensabili, tra cui la stabilità della convivenza e la durata della medesima al
momento del fatto dannoso, la cui prova era altresì necessaria per determinare
il danno biologico e morale dell’O., perché la liquidazione dei predetti tipi di
danno deve esser personalizzata, e quindi va tenuto conto di tutte le
particolarità del caso concreto.
Quanto al danno patrimoniale dell’O., è appena il caso di aggiungere che dalla
sentenza impugnata si desume che esso nei precedenti gradi è stato chiesto
limitatamente ai danni all’auto, e quindi in ogni caso non può esser ampliato in
questa sede.
Concludendo, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di
Cassazione tra le parti costituite.
182
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di
Cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2005.
Depositato in cancelleria il 29 aprile 2005
183
Durata ragionevole del processo: eredi legittimati a richiedere
l'indennizzo
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA 23 DICEMBRE 2005, N. 28507
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 aprile 2002 C.C.S. conveniva in giudizio dinanzi
alla Corte d'appello di Genova la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
sentirla condannare al pagamento di una somma a titolo di equo indennizzo dei
danni patrimoniali e non patrimoniali per la non ragionevole durata di cinque
giudizi da lui promossi dinanzi al TAR per la Toscana, rispettivamente il 6
giugno 1990, il 9 novembre 1993, il 28 novembre 1997, il 16 febbraio 1998 e il
6 marzo 1998, tuttora in attesa di fissazione dell'udienza di discussione.
Con decreto del 18 giugno-17 luglio 2002 la corte adita rigettava la domanda
osservando preliminarmente che il ricorrente non aveva titolo per far valere
eventuali danni riferibili a ritardi maturati prima del 18 aprile 2001, data di
entrata in vigore della l. n. 89 del 2001. Quindi, passando a esaminare i vari
processi pendenti, affermava che per il primo di essi, promosso dalla sig.ra
M.T.S., madre del ricorrente che in qualità di erede aveva provveduto alla
riassunzione, la domanda non poteva trovare accoglimento poiché la
riassunzione era avvenuta solo il 4 settembre 2001, e non era trascorso
neppure un anno dal momento in cui era divenuto parte processuale; che per il
secondo e il terzo la domanda era priva di fondamento essendo decorsi solo tre
anni dalla presentazione dell'istanza di prelievo; che parimenti infondata.
Contro
Non
ha
la
sentenza
presentato
ricorre
difese
per
la
cassazione
Presidenza
con
del
due
Consiglio
motivi
dei
C.C.S.
Ministri.
Con ordinanza del 9 marzo-26 giugno 2002 è stata disposta la rimessione degli
atti al Primo Presidente che ha provveduto all'assegnazione del ricorso alle
Sezioni unite per la risoluzione della questione di particolare importanza
relativa all'individuazione del momento in cui sorge il diritto alla durata
ragionevole del processo nonché del contrasto di giurisprudenza relativo
all'accertamento del momento iniziale ai fini del computo del termine di durata
del processo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione
dell'art. 6, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
ratificata con la l. 848/1955, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e si contesta
l'affermazione secondo cui solo dalla data di entrata in vigore della l. 89/2001
sarebbe sorto il diritto all'equa riparazione, prima non esistente nel vigente
sistema positivo, con la conseguente esclusione della legittimazione degli eredi
alla proposizione della domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata di un
processo instaurato dal loro dante causa prima di tale data.
184
La questione è stata sinora decisa in senso negativo dalla giurisprudenza di
questa Corte la quale ha considerato che la l. 89/2001 contempla senza
limitazioni temporali le violazioni del canone di ragionevole durata del processo
verificatesi dopo la ratifica della Convenzione dei diritti dell'uomo, ma che, in
assenza di una espressa previsione di retroattività della norma interna
costitutiva del diritto all'equo indennizzo, resta esclusa la nascita di tale diritto
in capo a un soggetto deceduto prima della sua entrata in vigore e,
conseguentemente, la sua trasmissibilità agli eredi (Cassazione 17650/2002;
360/2003); e ciò anche se la parte, poi deceduta, avesse già proposto ricorso
alla Corte di Strasburgo in quanto la fattispecie riparatoria prevista dalla
normativa comunitaria non costituiva un diritto azionabile dinanzi a un giudice
diverso da quello europeo. Tali considerazioni trovavano un ulteriore elemento
di conferma nel rilievo che la norma transitoria dell'art. 6 della l. 89/2001
aveva natura di norma sostanziale e non processuale e non prevedeva alcun
traslatio iudicii ma consentiva unicamente una circoscritta e limitata
applicazione retroattiva del nuovo istituto dell'equa riparazione con riferimento
ai soli giudizi per i quali si fosse già avuto il tempestivo deposito del ricorso
dinanzi alla Corte di Strasburgo e non fosse ancora intervenuta una
dichiarazione di ricevibilità del ricorso stesso (Cassazione 5264/2003).
Ciò premesso, merita accoglimento l'invito a riconsiderare la fondatezza di tale
orientamento interpretativo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, sulla base
dell'evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni unite le quali, con le sentenze
in data 1339/2004, 1340 e 1341 hanno identificato il fatto costitutivo
prefigurato dall'art. 2 della l. 89/2001 proprio nel mancato rispetto del termine
ragionevole di durata del processo stabilito dall'art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, e hanno negato, conseguentemente, che la
fattispecie prevista dalla norma interna assumesse connotati diversi da quelli
stabiliti dalla Convenzione, rispetto alla quale essa andrebbe considerata non
già costitutiva del diritto all'equa riparazione per la non ragionevole durata del
processo, bensì unicamente istitutiva della via di ricorso interno, prima
inesistente, diretta ad assicurare una tutela pronta ed efficace alla vittima della
violazione del canone di ragionevole durata del processo in attuazione del
disposto dell'art. 13 della Convenzione il quale stabilisce il diritto a un ricorso
effettivo davanti a un'istanza nazionale il cui esperimento preventivo opera, a
norma dell'art. 35, come condizione di procedibilità del ricorso alla Corte di
Strasburgo che, ai sensi dell'art. 34, era proponibile in via immediata e diretta
prima
dell'introduzione
del
ricorso
negli
ordinamenti
nazionali.
Va ricordato al riguardo che l'art. 1 della Convenzione stabilisce che «le Parti
Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti
e le libertà definiti dal titolo primo della Convenzione», tra i quali è compreso il
diritto ad un processo equo e di durata ragionevole (art. 6), che dev'essere
tutelato attraverso il ricorso a un'istanza nazionale (art. 13), la cui introduzione
nell'ordinamento vigente è avvenuta tardivamente, solo a seguito del
moltiplicarsi delle condanne nei confronti dello stato in sede comunitaria per il
pregiudizio
derivante
dalla
non
ragionevole
durata
dei
processi.
185
La l. 848/1955, provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione,
ha introdotto nell'ordinamento interno i diritti fondamentali, aventi natura di
diritti soggettivi pubblici, previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran
parte coincidenti con quelli gia indicati nell'art. 2 Cost., rispetto al quale il
dettato della Convenzione assume una portata confermativa ed esemplificativa
(Corte
costituzionale,
388/1999).
La natura immediatamente precettiva delle norme convenzionali a seguito di
ratifica dello strumento di diritto internazionale è stata già del resto
riconosciuta esplicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte che ha
affermato l'avvenuta abrogazione dell'art. 34, comma 2, del r.d.l. 511/1946,
nella parte in cui escludeva la pubblicità della discussione della causa nel
giudizio disciplinare a carico di magistrati per contrasto con la regola della
pubblicità delle udienze sancito dall'art. 6 della Convenzione che pone precisi
limiti alla discussione della causa a porte chiuse (Sezioni unite 7662/1991);
parimenti ha riconosciuto il carattere di diritto soggettivo fondamentale,
insopprimibile anche dal legislatore ordinario, al diritto all'imparzialità del
giudice nell'amministrazione della giustizia, con richiamo all'art. 6 della
Convenzione (Cassazione 4297/2002), e, infine, ha espressamente
riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo
l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la
norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto (Cassazione
10542/2002).
Deve essere quindi superato l'orientamento secondo cui la fonte del
riconoscimento del diritto all'equa riparazione dev'essere ravvisata nella sola
normativa nazionale (Cassazione 11046/2002; 11987/2002; 16502/2002;
5664/2003; 13211/2003) e ribadito il principio che il fatto costitutivo del diritto
all'indennizzo attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della
norma contenuta nell'art. 6 della convenzione, di immediata rilevanza nel
diritto
interno.
Né appare meritevole di consenso la distinzione adombrata in sede di
discussine orale, tra diritto ad un processo di ragionevole durata, introdotto
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (o addirittura ad
essa preesistente come valore costituzionalmente protetto), e diritto all'equa
riparazione, che sarebbe stato introdotto solo con la l. 89/2001, in quanto la
tutela assicurata dal giudice nazionale non si discosta da quella
precedentemente offerta dalla Corte di Strasburgo, alla cui giurisprudenza è
tenuto a conformarsi il giudice nazionale (Sezioni unite 1340/2004).
Da ciò consegue che il diritto all'equa riparazione del pregiudizio derivato dalla
non ragionevole durata del processo verificatosi prima dell'entrata in vigore
della l. 89/2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli
eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si
lamenta la non ragionevole durata, col solo limite che la domanda di equa
riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si
186
sia
pronunciata
sulla
sua
ricevibilità.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso non preclude l'esame del secondo
motivo, avente natura autonoma, con il quale si lamenta il vizio di motivazione
su un punto decisivo della controversia con riferimento all'affermazione, posta
a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di equa riparazione per
l'eccessiva durata dei processi pendenti dinanzi al giudice amministrativo,
secondo cui la mancata o tardiva presentazione dell'istanza di prelievo
escluderebbe la permanenza di un interesse alla decisione in capo al ricorrente,
non essendo dato riscontare l'esistenza di una presunzione generale in tal
senso.
Va premesso al riguardo che nel sistema vigente prima dell'entrata in vigore
della l. 205/2000 - al quale deve farsi riferimento per i giudizi dei quali si
lamenta nella specie la non ragionevole durata - il processo amministrativo
richiede, dopo il deposito del ricorso, un solo necessario, infungibile impulso di
parte costituito dalla presentazione nei due anni dal deposito del ricorso (o
dall'ultimo atto della procedura quando venga ordinata un'attività istruttoria o
la causa sia stata cancellata dal ruolo) di un'apposita istanza di fissazione, in
mancanza della quale la causa si estingue per perenzione; una volta
presentata tale istanza, infatti, il processo è dominato dal potere di iniziativa
del giudice e non costituisce, perciò, adempimento necessario l'istanza di
prelievo del ricorso dal ruolo, prevista dall'art. 51, comma 2, r.d. 642/1907,
che ha il solo fine di fare dichiarare il ricorso urgente onde ottenerne la
trattazione anticipata sovvertendo l'ordine cronologico di iscrizione delle
domande
di
fissazione
dell'udienza
di
discussione.
Orbene, con riferimento al problema dell'individuazione del momento iniziale
dal quale decorre la durata del procedimento amministrativo instaurato prima
dell'entrata in vigore della l. 205/2000 la giurisprudenza prevalente afferma
che esso coincide con quello della presentazione dell'istanza di prelievo,
ritenendo sufficiente a tal fine l'onere posto a carico del ricorrente di
avvalersene per trarre il ricorso da una condizione di quiescenza e ottenerne
l'effettiva trattazione, in considerazione del fatto che l'art. 2, comma 2, della l.
89/2001 esclude l'addebitabilità all'Amministrazione dei tempi imputabili alla
negligente condotta della parte che non si sia avvalsa dello strumento
acceleratorio posto a sua disposizione, sicché solo dal momento della
presentazione di tale istanza il decorso del tempo potrebbe considerarsi
parametro esclusivo di valutazione del comportamento del giudice adito al fine
di valutare la ragionevolezza della durata del processo (Cassazione
15445/2002;
15992/2002;
6180/2003;
22503/2004).
A tale interpretazione si contrappone un orientamento minoritario secondo cui
la mancata presentazione dell'istanza di prelievo non può influire sul calcolo dei
termini del processo, ma potrebbe incidere unicamente sulla determinazione
dell'entità dell'equa riparazione spettante con riferimento al dettato dell'art.
2056 c.c. richiamato nell'art. 2 della l. 89/2001, che a sua volta richiama l'art.
1227, il quale al secondo comma esclude il risarcimento dei danni che il
187
danneggiato avrebbe potuto evitate usando l'ordinaria diligenza, col risultato
che la durata irragionevole del processo, ancorché accertata, non potrebbe
porsi esclusivamente a carico dello Stato (Cassazione 3347/2003).
Va segnalato che successivamente alla ordinanza di rimessione degli atti al
Primo Presidente, è intervenuta una nuova pronuncia (Cassazione
23187/2004) con la quale, in adesione all'orientamento ripetutamente
espresso dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha già proceduto alla
revisione dell'interpretazione sinora prevalente affermando che la lesione del
diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le
cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di
tempo decorso dall'instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa
incidere la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo.
Tale interpretazione, che ha incontrato il consenso delle decisioni che si sono
succedute sulla questione in esame (Cassazione 18759/2005; 19801/2005),
merita ulteriore conferma in considerazione del fatto - evidenziato nella
motivazione della citata pronuncia - che la presenza di strumenti sollecitatori
non sospende né differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda,
né implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento
del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la
valutazione del comportamento della parte al solo fine dell'apprezzamento
dell'entità
del
lamentato
pregiudizio.
In conclusione il ricorso merita accoglimento e conseguentemente il decreto
impugnato dev'essere cassato con rinvio della causa ad altro giudice il quale si
conformerà
ai
principi
di
diritto
innanzi
enunciati.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa il
decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di
appello di Genova, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del
giudizio di cassazione.
188
Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudice
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA 27-07-2005, n. 15661
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27 febbraio 1998 al Pretore di Pistoia, Franco L. chiedeva
accertarsi una malattia professionale, consistente in artrosi contratta a causa
della sua attività di aiuto cuoco dipendente da un'Azienda sanitaria locale, e
condannarsi l'Inail alla corresponsione della relativa rendita.
Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva l'eccezione di prescrizione
estintiva, sollevata in base all'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con
decisione del 1 aprile 1998, confermata consentenza del 6 maggio 2001 dal
Tribunale, il quale Osservava che, eccepita la prescrizione da parte dell'Istituto,
soltanto in appello, ossia tardivamente, il lavoratore-appellante aveva sollevato
la controeccezione di interruzione, già prospettabile nell'udienza di discussione
in primo grado. Quanto ad una lettera in atti, con data del 5 luglio 1996, essa
era stata redatta da un'"associazione sindacale" non legittimata all'interruzione
della prescrizione poichè non investita del relativo potere dal titolare, ossia dal
lavoratore.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il L. mentre l'Inail resiste con
controricorso. Con ordinanza del 16 aprile 2004 la Sezione lavoro di questa
Corte rilevava un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione
dell'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato
oppure in senso stretto, ossia non rilevabile d'ufficio da parte del giudice (nella
specie, sulla base di un documento ritualmente allegato), onde trasmetteva gli
atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni unite ai
sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. il Primo Presidente decideva in conformità.
Memorie utrinque.
Motivi della decisione
1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, privo
dell'indicazione delle norme in tesi violate dal giudice d'appello, e contenente
un mero riepilogo delle argomentazioni svolte nel giudizio di merito.
L'eccezione, sostanzialmente denunciante la inosservanza dell'art. 366, nn. 3 e
4, cod. proc. civ., non può essere accolta poichè il ricorrente, seppure in forma
non impeccabile e certamente non consueta, formula le sue censure con
contenuto e con richiamo dinorme di diritto ( art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)
sicuramente identificabili.
2. Con un primo motivo, in sostanza denunciante la violazione degli artt. 112
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 2943 cod. civ., e 112 cod. proc. civ., egli
osserva di avere allegato al ricorso di primo grado (documento n. 8) una
lettera con cui la UIL Ital, ente di patronato, in data 2 agosto 1996 ossìa
certamente entro il triennio di cui all'art. 112 d.P.R. cit., chiedeva all'Inail il
riconoscimento della malattia professionale, e con ciò la prestazione
previdenziale. Tale atto, interruttivo della prescrizione in quanto valido a
189
costituire in mora il debitore (art. 2943 cit.), avrebbe dovuto essere esaminato
dal Pretore d'ufficio, vale a dire anche in difetto di un'eccezione di interruzione
della prescrizione.
Con un secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 1 d.c.p.s. 29 luglio
1947 n. 804, sostiene, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale
(peraltro con erroneo riferimento alle associazioni sindacali), il potere dell'ente
di patronato di rappresentare i lavoratori iscritti quanto alla richiesta di
prestazioni previdenziali, e quindi di interrompere la prescrizione dei relativi
crediti.
3. Il primo motivo è fondato.
Con esso il ricorrente pone alla Corte la questione se l'eccezione di interruzione
della prescrizione debba considerarsi come eccezione in senso lato, ossia
rilevabile anche dal giudice in ogni stato e grado del processo purchè sulla base
di elementi probatori ritualmente acquisiti, oppure come eccezione in senso
stretto, ossia non rilevabile d'ufficio e perciò assoggettata, nel processo del
lavoro,alle preclusioni disposte nei capoversi degli artt. 416 e 437 cod. proc.
civ. (e nel processo ordinario nell'art. 345, secondo comma, dello stesso
codice).
E' da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di
eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod.
cit., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che
possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come
norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla
nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte.
Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito,
escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così,fra i numerosi possibili
esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di
compensazione; nell'art. 1442, quarto comma, quanto all'eccezione di
annullabilità del contratto;
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia qui in questione, nell'art. 2938
quanto all'eccezione di prescrizione.
Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi
alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta
a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte, la quale
tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n. 1099,
ha provveduto alla sistemazione della materia.
La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa
viene considerata come "mera difesa" (non è stato accolto il termine
"obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di
quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o
estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso
lato".
La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella
consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti
che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge
un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il
diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore
190
costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinati fatti non ha
di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il
tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero
seguita da un accertamento giudiziale.
Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo
da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione),
il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perchè si verifichi il
mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della
volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva
esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il
giudice desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte.
Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a
valersi dell'eccezione non è necessariamente legato all'interesse a resistere alla
pretesa attrice e, ulteriore conseguenza, la volontà di non valersi di quel mezzo
rende facilmente tollerabile - per usare espressioni di una ormai risalente
dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la
soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà.
La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del
1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001
n. 226, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno,
nonchè dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943 e 21
agosto 2004 n. 16501. 4. Malgrado la sistemazione della materia nel senso
testè illustrato, sulla questione, ora in esame, della qualificazione
dell'eccezione di interruzione della prescrizione, permane un contrasto di
giurisprudenza.
Prima della citata pronuncia di queste Sezioni unite n. 1099 del 1998 la
giurisprudenza della Corte la definiva costantemente come eccezione in senso
stretto, non affrontando però la generale questione del concetto di eccezione
processuale e le relative distinzioni, ma semplicemente parlando di
"controeccezione", da opporre a quella, omogenea, di prescrizione (tra le
numerose, Cass. 7 dicembre 1996 n. 10904, 1 ottobre 1997 n. 9583, 25
ottobre 1997 n. 10526).
Non mancava tuttavia una giurisprudenza secondo cui, estintosi il giudizio ed
iniziato un nuovo processo, il giudice di questo poteva rilevare l'interruzione
istantanea, prodotta dal primo atto introduttivo ex art. 2945, terzo comma,
cod. civ., in presenza della sola eccezione di prescrizione (Cass. 6 agosto 1966
n. 2167, 24 ottobre 1974 n. 3111, 24 ottobre 1978 n. 4810).
L'affermazione dell'eccezione in senso stretto permaneva anche dopo la sent.
n. 1099 del 1998, con numerose pronunce, che unificavano ancora il regime
dell'eccezione ex art. 2938 e della controeccezione,senza peraltro confutare,
almeno espressamente, gli argomenti di detta sentenza (tra le più recenti,
Cass. 20 giugno 2002 n. 9016, 27 giugno 2002 n. 9378, 12 luglio 2002 n.
10137, 14 novembre 2002 n. 16032, 28 luglio 2003 n. 15188, 14 luglio 2004
n. 14276).
Cass. 25 marzo 2002 n. 4219 contrasta esplicitamente la sentenza delle
Sezioni unite attraverso il richiamo al principio di speditezza del processo, , che
verrebbe ostacolato dalla rilevabilità officiosa dell'eccezione in questione in
ogni stato e grado; di questa pronuncia si dirà oltre.
191
L'opposta asserzione, ossia quella della rilevabilità d'ufficio, si trova in Cass. 28
marzo 2000 n. 3276, la quale ritiene che l'eccezione di prescrizione devolva al
giudice l'accertamento di ogni fatto relativo alla vicenda estintiva, compreso
quello interrutti vo, il cui rilievo è perciò sottratto all'iniziativa esclusiva della
parte interessata. L'argomentazione di questa soluzione èespressamente
appoggiata sul qui più volte citato precedente del 1998. 5. Non ritengono ora
queste Sezioni unite che fra l'eccezione di prescrizione, ascritta dall'art. 2938
cod.civ. al novero delle eccezioni in senso stretto, e la controeccezione di
interruzione ex artt. 2943-2945, di natura non definita dal legislatore, sussista
una somiglianza tale da consentirne la stessa disciplina processuale. Nè il
principio di speditezza, ora espressamente canonizzato nel capoverso dell'art.
111 Cost. e da bilanciare sempre con le garanzie di difesa di cui al precedente
art. 24 (Cass. 22 aprile 2005 n. 8540), permette di ravvisare preclusioni
processuali prive di base normativa ed anzi contrarie ad un sistema legale che
vede come eccezionale, per quanto detto sopra, la riserva alla parte del
poteredi eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto soggettivo
dedotto in giudizio.
Nessuno sostiene che l'eccezione di interruzione, vale a dire l'affermazione
dell'avvenuto compimento di un atto d'esercizio del diritto, giudiziale o
stragiudiziale ( art. 2943 cod.civ.) oppure dell'altrui riconoscimento (art.
2944), corrisponde al contenuto di un diritto potestativo di realizzazione
giudiziale ossia ad un'azione costitutiva e perciò stesso possa senz'altro
ricondursi alla figura delle eccezioni in senso stretto non di espressa previsione
legale.
Ma deve altresì escludersi che a questo risultato possa condurre un'asserita
identità di sostanza fra l'eccezione di prescrizione e quella di interruzione, tale
da permettere la sussunzione di quest'ultima, pur sempre e per ragioni di
sostanza, sotto la previsione dell'art. 2938.
Il titolare passivo del diritto soggettivo dedotto in giudizio dall'attore, ossia il
debitore oppure il proprietario quanto ai diritti reali limitati (l'istituto della
prescrizione estintiva è di portata generale, come risulta dall'art. 2934: "ogni
diritto"), fu correttamente definito in dottrina come a sua volta titolare di un
diritto potestativo di provocare l'estinzione del diritto trascurato, ottenendo la
liberazione dal debito oppure dal peso gravante sul proprio fondo. Infatti
l'effetto estintivo della prescrizione non si produce automaticamente allo
scadere del termine ma entra nella disponibilità del soggetto passivo del
diritto, cosiddetto "prescrivente", il quale decide se sollevare o meno la relativa
eccezione. Ciò spiega perchè l'art. 2937, primo comma, parli di irrinunciabilità
della prescrizione da parte di "chi non può validamente disporre del diritto".
Questa espressione, introdotta colcodice del 1942 e assente in quello del 1865,
si riferisce verosimilmente alla non disponibilità della materia controversa,
anche se può rilevarsene l'improprietà giacchè colui che rinunzia alla
prescrizione non è il titolare del diritto prescritto bensì il soggetto passivo, che
della prescrizione potrebbe avvalersi.
L'espressione impropria, che attribuisce un "diritto" al prescrivente, spiega in
ogni caso perchè la scadenza del termine di prescrizione sia stata definita come
species adquirendi a favore del prescrivente (cfr. da ult. Cass. 24 marzo 1994
n. 3445), in conformità all'antico carattere unitariamente acquisitivo delle
192
prescrizioni, oggi distinte in usucapione e prescrizione estintiva: carattere
unitario posto in evidenza dai romanisti e conservato nell'art. 2105 cod.civ.
1865, secondo cui la prescrizione è "il mezzo con cui, col decorso del tempo e
sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto o è liberato
dall'obbligazione" (la liberazione comporta l'acquisto di una posizione di
vantaggio).
Esclusi i casi eccezionali di rilevabilità d'ufficio della prescrizione (cfr. Cass. 16
agosto 2001 n. 11140), la scadenza del termine attribuisce al titolare passivo
del diritto prescrivendo la potestà di farne valere l'effetto estintivo o, al
contrario, di non giovarsene, preferendo di servirsi di altri mezzi di difesa in
giudizio: per tali ragioni il legislatore include l'eccezione di prescrizione fra
quelle in senso stretto.
6. Diverso è il carattere dell'eccezione di interruzione. Qui l'attore, di fronte
all'eccezione di prescrizione, non può considerarsi titolare di alcuna posizione
soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio ma semplicemente è in grado
di contrapporre all'eccipiente un fatto dotato di efficacia interruttiva.
L'interesse a giovarsi di questo atto è compreso nell'interesse sottostante il
diritto azionato, nè certo potrebbe sottostare ad una distinta azione costitutiva.
Il legislatore collega immediatamente l'effetto interruttivo ai fatti previsti dagli
artt. 2943 e 2944 cod.civ. onde l'eccezione non amplia i termini della
controversia ma - come si è rilevato in dottrina - concorre a realizzare
l'ordinamento giuridico nell'orbita della domanda, su cui il giudice deve
pronunciarsi tota re perspecta, ossia prendendo in considerazione d'ufficio gli
atti interruttivi.
Spetta dunque a lui di decidere la questione di prescrizione, ritualmente
introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938, tenendo
conto del fatto, anche dedotto in giudizio prima dell'eccezione, idoneo a
produrre l'interruzione, qualora l'attore abbia affermato il proprio diritto
ritualmente e rettamente provandone sussistenza e persistenza.
La situazione processuale non è diversa da quella che si verifica a proposito
dell'eccezione di rinuncia alla prescrizione, che questa Corte quasi sempre
ritiene rilevabile d'ufficio (Cass. 13 ottobre 1976 n. 3409, 7 febbraio 1996 n.
963, 14 maggio 2003 n. 7411).
Non vale affermare in contrario, come fa Cass. n. 9209 del 2002 cit., che
eccezione di prescrizione ed eccezione di interruzione sono caratterizzate dalla
medesima natura e debbono essere assoggettate allo stesso regime a fini di
speditezza del procedimento e per "sgombrare il campo dalla questione": il
principio di speditezza, già implicito nell'art. 24 Cost. ed ora espresso, come s'è
ricordato, nel capoverso dell'art. 111, si realizza nelle forme di legge ("...La
legge ne (del processo) assicura la ragionevole durata") e non comporta
l'obliterazione della distinzione fra eccezioni rilevabili d'ufficio e non, voluta dal
legislatore.
In altre parole la sent. n. 9209 del 2002 opera una completa assimilazione fra
eccezione in senso stretto e controeccezione, che è priva di fondamento
positivo: si pensi all'eccezione di compensazione ed alla controeccezione di
pagamento.
In conclusione si deve affermare il principio di diritto secondo cui l'eccezione di
interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere
193
rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base
di prove ritualmente acquisite agli atti.
Nel caso di specie la sentenza impugnata non nega la rituale produzione del
documento epistolare di contenuto interruttivo, nè la produzione è negata dal
controricorrente, il quale nell'ultimapagina del suo scritto difensivo vi fa
esplicito riferimento (lettera 5 luglio 1996), limitandosi a negarne la
provenienza dal creditore, ossia dal soggetto legittimato ad interrompere la
prescrizione. E' altresì pacifico il detto contenuto interruttivo, ossia la
manifestazione della pretesa creditoria, avente ad oggetto la prestazione
previdenziale (cfr. Cass. 28 giugno 1979 n. 3618, 27 giugno 1997 n. 5733).
Il primo motivo, in conclusione, dev'essere accolto.
7. Parimenti fondato è il secondo motivo.
Già da tempo questa Corte ha affermato che la richiesta della prestazione
previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato (circa
questa qualifica, da riferire all'istituto che in concreto effettuò la richiesta, le
parti non controvertono) per conto dell'assicurato interrompe la prescrizione
del relativo diritto, anche in difetto di delega, stante il potere di
rappresentanza attribuito ai detti istituti dall'art. 1 d.lgs. C.P.S. n. 804 del
1947 (Cass. 13 giugno 1980 n. 3749, 16 dicembre 2002 n. 17997, 21 agosto
2004 n. 16523).
Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altro
collegio d'appello, che si pronuncerà sul merito della pretesa dell'attore e
provvedere sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di
Firenze, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2005.
194
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE,
SENTENZA N. 4806 DEL 07/03/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da impugnazione proposta (con atto di citazione
del 19 febbraio 1997) da due condomini, F.M. e A.G., del complesso
immobiliare sito in Roma, via Tor de' Schiavi 3819, avverso tre delibere
dell'assemblea del condominio (adottate il 18 settembre 1995, il 15 dicembre
1995 e il 23 settembre 1996) concernenti l'approvazione del consuntivo
relativo alle spese ordinarie per l'anno 1995/1996, la ripartizione delle spese
per alcuni lavori straordinari e il riparto della tassa di occupazione suolo
pubblico. Le ragioni dell'impugnazione erano la mancanza nel verbale
dell'indicazione dei condomini che avevano partecipato all'assemblea e
dell'entita’ delle spese deliberate; l'errata ripartizione, essendo stata effettuata
sulla base di fittizi valori millesimali ed essendo state poste a loro carico spese
sostenute per l'esclusiva utilita’ di condomini di altra palazzina.
Il Tribunale - ritenute le ragioni prospettate (come l'utilizzo di criteri contrari
alla legge per la ripartizione delle spese) quali motivi di nullita’ delle delibere rigettava la domanda nel merito, sostenendo che risultavano documentalmente
smentite le omissioni nel verbale e l'utilizzo di tabelle millesimali fittizie e che
la dedotta errata ripartizione delle spese era sfornita di prova.
Con sentenza 1354/2000, la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile
l'appello principale del M. e G.; in accoglimento dell'appello incidentale del
condominio e in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava i due
condomini decaduti dal diritto di proporre impugnazione avverso le suddette
delibere per decorrenza del termine di legge, perche’ i vizi dedotti erano da
inquadrare nell'ambito dell'annullabilita’ e non della nullita’ delle delibere. In
particolare la Corte d'appello riteneva il vizio di omessa comunicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea vizio del procedimento rientrante
nell'annullabilita’, e le delibere di ripartizione in concreto delle spese
condominiali, anche se adottate in violazione dei criteri legali o convenzionali,
annullabili, in quanto rientranti nell'esercito delle attribuzioni assembleari ex
art. 1135 c.c., dovendo la loro impugnazione avvenire entro il termine di
decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., non rispettato.
I condomini M. e C. hanno chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando
tre motivi di censura.
Il condominio ha resistito con controricorso.
La seconda sezione civile, con ordinanza del 18 novembre 2003, ha rilevato la
presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti in ordine alla
riconducibilita’ dei vizi delle delibere assembleari nell'ambito della nullita’ o
annullabilita’.
Per la composizione del contrasto, il Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374,
secondo comma, c.p.c. ha rimesso la questione alle sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso contiene tre motivi.
a) Il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 1136, sesto comma, c.c.
Affermano i ricorrenti che dalla lettera della legge, secondo cui "l'assemblea
non puo’ deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla
195
riunione", deriverebbe che la delibera stessa e’ nulla e non annullabile, qualora
l'assemblea deliberi senza che anche uno solo dei condomini sia stato invitato
alla riunione.
b) Il secondo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 1137, secondo e
terzo commi, c.c. Premesso di aver dedotto con i motivi d'appello l'omissione
nel verbale dei nominativi dei condomini presenti (ovvero assenti, assenzienti e
dissenzienti), dei valori dei millesimi e dell'entita’ delle spese deliberate ed
approvate, i ricorrenti sostengono la nullita’ di tali delibere e non
l'annullabilita’, che la Corte d'appello avrebbe ritenuto incorrendo nella falsa
applicazione dell'art. 1137 cit. In particolare sottolineano che il verbale deve
contenere gli elementi indispensabili per il riscontro della validita’ della
costituzione assembleare: l'indicazione dei condomini e dei millesimi sono
essenziali ai fini della verifica della prescritta maggioranza ex art. 1136 c.c.
c) Il terzo motivo concerne la violazione dell'art. 1123, terzo comma, c.c. I
ricorrenti assumono che, essendo state poste a loro carico spese - quali la
tassa di occupazione del suolo pubblico, lavori straordinari per posti auto e per
un ascensore - che dovevano essere a carico solo dei condomini che ne
traevano utilita’, la delibera e’ nulla.
2. I motivi sono stati contestati dal condominio che, dopo aver evidenziato
rispetto al primo che i ricorrenti nei precedenti gradi di giudizio non si sono mai
doluti della mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea,
ha sostenuto che, comunque, tutte le dedotte ipotesi sono riconducibili
nell'ambito dell'annullabilita’ e non della nullita’.
3. E' bene premettere, per quanto riguarda il primo motivo, che la questione
della mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e’
entrata nel thema decidendum, evidentemente perche’ ritenuta strettamente
connessa con quella della mancata indicazione dei nominativi dei condomini,
tant'e’ che di essa espressamente si occupa la sentenza impugnata (fine pag.
5, inizio pag. 6), donde l'infondatezza del profilo di inammissibilita’ prospettato
dal condominio.
4. Il contrasto giurisprudenziale rilevato con l'ordinanza di remissione e’ se
comportino la nullita’ o la annullabilita’ della delibera: a) la mancata
comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, anche ad un solo
condomino; b) l'omessa indicazione, nel verbale, dei condomini presenti e
dell'entita’ delle spese deliberate e approvate; c) l'errata ripartizione delle
spese.
5. Prima di procedere all'esame del contrasto, e’ opportuno effettuare una, sia
pur sintetica, ricognizione dell'orientamento della Corte e della dottrina in tema
di nullita’ e annullabilita’ delle delibere dell'assemblea condominiale.
5.1. La Corte, in generale, ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere
con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla formazione della
volonta’ della prescritta maggioranza; quelle con maggioranze inferiori alle
prescritte; le delibere prive degli elementi essenziali; quelle adottate con
maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o
dal regolamento condominiale; le delibere con oggetto impossibile o illecito, a
volte specificandolo come oggetto contrario all'ordine pubblico, o alla morale, o
al buon costume; le delibere con oggetto che non rientra nella competenza
dell'assemblea; le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi
196
comuni o sulla proprieta’ esclusiva di ognuno dei condomini; le delibere
comunque invalide in relazione all'oggetto.
5.2. Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al
regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi
annullabili quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione dell'assemblea; quelle genericamente affette da irregolarita’ nel
procedimento di convocazione; le delibere viziate da eccesso di potere o da
incompetenza, che invadono cioe’ il campo riservato all'amministratore; le
delibere che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione
all'oggetto.
6.1. In particolare, premesso che l'art. 1137 c.c. ha un'ampia portata ma non
si riferisce a quelle decisioni assembleari che sono senza effetto alcuno in forza
di principi generali indiscutibili, e percio’ attaccabili in ogni tempo da chiunque
vi abbia interesse, alcuni autori ritengono nulle le delibere prive dei requisiti
essenziali, in quanto prese da assemblee non regolarmente costituite (anche
perche’ non sono stati invitati tutti i condomini) o con maggioranze inesistenti
o apparenti; ovvero quelle aventi un oggetto impossibile o illecito; quelle
esorbitanti dalla sfera dei compiti dell'assemblea; quelle che ledono i diritti di
ciascun condomino sulle cose e servizi comuni o sul proprio piano o
appartamento. Considerano annullabili le delibere affette da vizi formali, prese
in violazioni di prescrizioni convenzionali, regolamentari attinenti al
procedimento di convocazione e di informazione dell'assemblea.
6.2. Altri autori, operando un accostamento con i principi generali e le
disposizioni dettate in tema di delibere societarie, ritengono nulle le delibere
aventi ad oggetto materie sottratte alla competenza della assemblea, la
ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli legali, contenuto illecito
o impossibile, la menomazione dei diritti spettanti a ciascun condomino, e
quelle contrarie a norme imperative. Sono, invece, annullabili le delibere
assunte a seguito di un procedimento viziato, ovvero inficiate da eccesso di
potere
perche’
invadono
il
campo
riservato
alla
competenza
dell'amministratore.
7. Il denunciato contrasto e’ sintetizzabile nei seguenti termini.
7.1. Sull'omessa comunicazione dell'avviso, sino al 2000 e’ rimasto fermo il
principio, affermato dalla Corte in numerose pronunce (v. fra le tante: Cass. 1°
ottobre 1999, n. 10886; 19 agosto 1998, n. 8199; 12 giugno 1997, n. 5267;
27 giugno 1992, n. 8074; 9 dicembre 1987, n. 9109; 15 novembre 1977, n.
4984; 16 aprile 1973, n. 1079; 12 novembre 1970, n. 2368), della nullita’
della delibera. In alcune sentenze, la sanzione della nullita’ e’ espressamente
ricondotta alla difettosa costituzione dell'organo deliberante, risultando
irrilevante l'incidenza o meno del voto sulle prescritte maggioranze (Cass. 12
febbraio 1993, n. 1780; 15 novembre 1977, n. 4984). In altre la nullita’ e’
ricondotta all'esigenza che tutti i condomini siano preventivamente informati
della convocazione dell'assemblea, cosi’ da poter essere partecipi del
procedimento di formazione della delibera stessa, con la conseguenza che non
determinano la nullita’ le mere irregolarita’, quali la convocazione ad opera di
persona non qualificata (Cass. 2 marzo 1987, n. 2184) o l'incompletezza
dell'ordine del giorno (Cass. 21 giugno 1977, n. 4035) che danno luogo alla
197
sola annullabilita’. A volte la nullita’ e’ fatta discendere espressamente dall'art.
1136, sesto comma, c.c.
7.2. A partire dal 2000, cambiando orientamento, la Corte (Cass. 5 gennaio
2000, n. 31; 5 febbraio 2000, n. 1292; 1° agosto 2003, n. 11739) afferma che
la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
condominiale ad un condomino determina la semplice annullabilita’ della
delibera. Il mutamento di indirizzo della Corte trae argomento: a) dal
combinato disposto degli artt. 1105, terzo comma, e 1109 c.c., in base al quale
la mancata preventiva informazione dei partecipanti alla comunione determina
semplicemente l'impugnabilita’, nel termine di decadenza di trenta giorni, delle
deliberazioni assunte da parte dei componenti della minoranza dissenziente; b)
dal parallelismo e dall'identita’ di ratio (individuata nell'esigenza di certezza dei
rapporti giuridici, messa a rischio dalla possibilita’ di dedurre in ogni tempo la
nullita’) esistente tra la disciplina in materia di societa’ di capitali (artt. 2377,
2379 c.c., logicamente prima della riforma introdotta col d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, di cui si dira’ in seguito) e quella in materia condominiale (art.
1137 c.c.) in tema di delibere dell'assemblea (dei soci, nel primo caso, e dei
condomini, nel secondo), la prima delle quali espressamente limita le ipotesi di
nullita’ delle delibere assunte dall'assemblea dei soci ai soli casi
dell'impossibilita’ e dell'illiceita’ dell'oggetto.
7.3. In particolare, i vizi dell'oggetto come causa di nullita’ sono ricollegati con
i confini posti in materia di condominio al metodo collegiale e al principio di
maggioranza. Secondo la Corte «tanto la impossibilita’ giuridica, quanto la
illiceita’ dell'oggetto derivano dal difetto di attribuzioni in capo all'assemblea,
considerato che la prima consiste nella inidoneita’ degli interessi contemplati
ad essere regolati dal collegio che delibera a maggioranza, ovvero a ricevere
dalle delibere l'assetto stabilito in concreto, e che la seconda si identifica con la
violazione delle norme imperative, alle quali l'assemblea non puo’ derogare,
ovvero con la lesione dei diritti individuali, attribuiti ai singoli dalla legge, dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni». Di conseguenza la formula dell'art. 1137
c.c. deve interpretarsi nel senso che per «"deliberazioni contrarie alla legge" si
intendono le delibere assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme
prestabilite dall'art. 1136 (ma pur sempre nei limiti delle attribuzioni
specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c.)». Inoltre, «mentre le
cause di nullita’, afferendo all'oggetto, raffigurano le uniche cause di invalidita’
riconducibili alla "sostanza" degli atti, alle quali l'ordinamento riconosce
rilevanza e, costituendo vizi gravi, non sono soggette a termine per
l'impugnazione; invece «sono inficiate da un vizio di forma le deliberazioni
quando l'assemblea decide senza l'osservanza delle forme procedimentali
stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i condomini alla
formazione della volonta’ collettiva per gestire le cose comuni» e, attenendo al
procedimento di formazione, producono un vizio non grave che, se non fatto
valere nei termini prescritti, non inficia gli atti.
Le diverse cause di invalidita’ sono state, quindi, ricondotte al tipo di interesse
leso: interessi sostanziali inerenti all'oggetto delle delibere, per la nullita’;
strumentali, in quanto connessi con le regole procedimentali relative alla
formazione degli atti, per l'annullabilita’.
198
8. Con riferimento al verbale delle delibere dell'assemblea dei condomini, un
vero e proprio contrasto giurisprudenziale non sembra emergere, registrandosi
soltanto alcune puntualizzazioni e specificazioni.
8.1. Infatti, la Corte, in alcune pronunce (v. ex plurimis: Cass. 22 maggio
1999, n. 5014; 19 ottobre 1998, n. 10329) ha espressamente affermato
l'annullabilita’ ex art. 1137 c.c. della delibera il cui verbale contiene delle
omissioni, precisando che la redazione del verbale costituisce una delle
prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalita’
richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del
giorno, etc.), la cui inosservanza comporta l'impugnabilita’ della delibera, in
quanto non presa in conformita’ della legge.
8.2. Principio che si ritrova implicitamente alla base di altre pronunce, dove la
Corte ha affermato l'annullabilita’ delle deliberazioni assembleari nel caso in cui
non siano individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini
assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali
(Cass. 22 gennaio 2000, n. 697; 29 gennaio 1999, n. 810).
8.3. E' stato pure affermato che la sottoscrizione del presidente subentrato in
luogo di quello che all'inizio ha presieduto concreta una irregolarita’ formale,
comportante annullabilita’ (Cass. 29 ottobre 1973, n. 2812); e, in generale, la
stessa redazione per iscritto del verbale, prescritta dall'art. 1136, ultimo
comma, c.c., non e’ prevista a pena di nullita’, tranne il caso in cui la delibera
incida su diritti immobiliari (Cass. 16 luglio 1980, n. 4615).
9. Parimenti per quanto riguarda le delibere in materia di ripartizione delle
spese (se si esclude l'isolata e risalente pronuncia n. 1726 del 4 luglio 1966)
non sembra sussistere contrasto nella giurisprudenza, atteso che la Corte - a
partire del 1980 - ha costantemente distinto, sulla base di un medesimo
criterio, le ipotesi di nullita’ (v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7359; 15 marzo 1995,
n. 3042; 3 maggio 1993, n. 5125; 19 novembre 1992, n. 12375; 5 dicembre
1988, n. 6578; 21 maggio 1987, n. 4627; 5 ottobre 1983, n. 5793; 5 maggio
1980, n. 29289) da quelle di annullabilita’ (cfr. Cass. 9 febbraio 1995, n. 1455;
8 giugno 1993, n. 6403; 1° febbraio 1993, n. 1213; 5 agosto 1988, n. 4851; 8
settembre 1986, n. 5458), in molti casi facendo espresso riferimento all'art.
1123 c.c.
9.1. In particolare, partendo dal rilievo che le attribuzioni dell'assemblea ex
art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto
dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre
deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo ad incidere sui
diritti individuali del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose
comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per
legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca, la
Corte (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7359; 15 marzo 1995, n. 3042; 3 maggio
1993, n. 5125; 19 novembre 1992, n. 12375) ha affermato la nullita’ della
delibera che modifichi i suddetti criteri di spesa (sia nell'ipotesi di
individuazione dei criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c., sia
nell'ipotesi di cambiamento dei criteri gia’ fissati in precedenza),
9.2. Conseguentemente la Corte ha riconosciuto l'annullabilita’ della delibera
nel caso di violazione dei criteri gia’ stabiliti quando vengono in concreto
199
ripartite le spese medesime (Cass. 9 febbraio 1995, n. 1455; 8 giugno 1993,
n. 6403; 1° febbraio 1993, n. 1213).
10. Il contrasto, che come evidenziato riguarda essenzialmente l'omessa
comunicazione dell'avviso di convocazione, ex art. 66, comma 3, disp. att. c.c.,
ha visto divisa anche la dottrina, la quale ha assunto posizioni di segno diverso
sia rispetto all'utilizzo degli artt. 1105 e 1109 c.c., sia rispetto al parallelismo e
identita’ di ratio con la disciplina in materia di societa’ di capitali.
10.1. Alcuni autori dubitano della pertinenza del richiamo all'art. 1105, comma
3, c.c. in tema di comunione: l'omessa informazione preventiva sull'oggetto
della deliberazione non puo’, infatti, essere assimilata senz'altro all'omessa
convocazione. Cio’ per la decisiva considerazione che il principio maggioritario
in tanto puo’ operare in quanto tutti gli aventi diritto siano posti in condizione
di intervenire in assemblea per partecipare alla discussione e alla votazione.
Nei riguardi del condomino non convocato la riunione assembleare e le relative
deliberazioni sarebbero res inter alios acta. Ne’ puo’ dirsi, sotto altro profilo,
che la convocazione di un condomino attenga, comunque, solo al procedimento
da osservare per la formazione della volonta’ assembleare, determinando
l'omissione un error in procedendo.
10.2. Secondo altri autori e’ stato individuato un riscontro normativo
direttamente afferente al vizio di convocazione ed espressamente regolato
come annullabilita’ in un settore non distante dal regime condominiale. Inoltre,
il richiamo risulta utile per la sua diretta attinenza alla ricostruzione della
disciplina codicistica del metodo collegiale: nella comunione, come nel
condominio, le decisioni comuni vengono assunte in collegio e l'obbligo di
informativa sulle materie oggetto di discussione e’ finalizzato al successivo
svolgimento dell'assemblea, di cui l'art. 1105 c.c. prescrive in definitiva la
convocazione; in tal senso e’ di rilievo l'azione di annullabilita’ prevista dall'art.
1109 c.c. quale rimedio idoneo contro le decisioni illegittime della
maggioranza, poiche’ nel condominio il metodo collegiale riveste la medesima
rilevanza che nella comunione ordinaria, ove pure e’ posto a tutela dei diritti
delle minoranze.
10.3. Quanto al parallelismo e identita’ di ratio con la disciplina in materia
societaria, un orientamento dottrinario distingue tra la «mancata convocazione
di alcuni soltanto dei soci» e «mancata convocazione dei soci» (ovvero
mancata convocazione dell'assemblea) non seguita da assemblea totalitaria,
ritenendo che, mentre in quest'ultimo caso ricorre un'ipotesi di nullita’ radicale
(rectius: di inesistenza), nel primo, invece, una situazione di semplice
annullabilita’, ai sensi dell'art. 2377 c.c. Peraltro, in generale, si e’ affermato
che il richiamo alla disciplina della societa’ per azioni non sembra corretto,
essendo il condominio pervaso dalla logica proprietaria a differenza della
materia societaria, dove l'interesse del gruppo trova spesso maggiore tutela
dell'interesse del singolo sacrificato in funzione dello scopo comune.
10.4. Altro orientamento dottrinario, al contrario, ritiene condivisibile il
parallelismo con la disciplina societaria, avuto riguardo alle invocate esigenze
di certezza nei rapporti tra i condomini e tra il condominio e terzi. Vi e’ chi
sostiene che nel condominio (differentemente dalla disciplina positiva dei
contratti e di quella in materia di societa’) l'art. 1137 c.c. assoggetterebbe ad
un unico regime decadenziale le violazioni della legge e del regolamento, senza
200
possibilita’ di distinzione tra annullabilita’ e nullita’. Non manca chi, partendo
da una rilettura dell'art. 1139 c.c., che per quanto non espressamente previsto
in materia di condominio rinvia alle norme sulla comunione, e dal presupposto
che tale norma non e’ di chiusura (altrimenti sarebbe «di clausura»), ma
consente un rinvio interno fra sistemi laddove sussistano elementi di sufficiente
omogeneita’, condividendo le cosiddette concezioni miste del condominio,
giunge a condividere la concezione della "complessita’ sistematica", che vede
nel condominio «un sistema di sistemi», e dunque «un istituto giuridico che
trova la sua consistenza nell'avvalersi di regole gia’ proprie di altri istituti, quali
quelli attinenti ai rapporti fra parti di proprieta’ individuale e parti comuni,
quelle
relative
all'assemblea,
quelle
infine
che
si
riferiscono
all'amministratore». E, quindi, con riferimento alla modalita’ di convocazione e
gestione dell'assemblea, sono da prendersi in considerazione, secondo l'autore,
anche le norme del codice dettate per la societa’ per azioni.
11. Ritengono le Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di diritto e
definire il contrasto, che debba privilegiarsi l'interpretazione secondo la quale
la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
condominiale, anche ad un solo dei condomini, comporta non la nullita’, ma
l'annullabilita’ della delibera condominiale, in base alle seguenti considerazioni.
11.1. Conviene premettere che in tema di condominio negli edifici, il codice
non contempla la nullita’.
L'art. 1137 c.c., al comma 2, espressamente stabilisce che, contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni
condomino dissenziente puo’ fare ricorso all'autorita’ giudiziaria; al comma 3
aggiunge che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla
data di comunicazione per gli assenti.
Il breve termine di decadenza e la individuazione delle persone legittimate
(ben poche) alla impugnazione dimostrano essere contemplata una ipotesi di
annullabilita’, posto che sia in tema di negozio (artt. 1441 e 1442 c.c.), sia in
tema di delibere societarie (art. 2377, comma 20, c.c.), il termine per la
impugnazione e le persone legittimate a proporre l'azione contrassegnano le
ipotesi di annullabilita’; al contrario, per le ipotesi di nullita’ tanto in tema di
negozio (art. 1421 e 1422 c.c.) quanto in tema di delibere societarie (art. 2379
c.c.), l'azione di nullita’ non e’ soggetta a termine e, allo stesso tempo, e’
legittimato ad esercitarla chiunque vi ha interesse, inoltre la nullita’ puo’ essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
11.2. Dottrina e giurisprudenza ravvisano l'essenza della nullita’ nella
mancanza o nella grave anomalia di qualche elemento intrinseco dell'atto, tale
da non consentire la rispondenza alla figura tipica individuata dall'ordinamento.
La nullita’ e’ considerata lo strumento con cui la legge nega fondamento a
quelle manifestazioni di volonta’ attraverso le quali si realizza un contrasto con
lo schema legale e con gli interessi generali dell'ordinamento. Di conseguenza,
attraverso la sanzione della nullita’, l'ordinamento, esprimendo un giudizio di
meritevolezza, nega la propria tutela a programmazioni che non rispondono a
valori fondamentali.
11.3. L'art. 1418 c.c. elenca una serie di ipotesi in cui il contratto, per gli
specifici vizi in esso previsti - la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art.
201
1325, l'illiceita’ della causa, l'illiceita’ dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345
e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 - viene
espressamente sanzionato con la nullita’. Altre norme, poi, prevedono tale
sanzione ora nello stesso codice civile, ora in leggi specifiche (cfr. art. 1418,
comma 3).
11.4. Alcune norme di legge vietano il compimento di determinati negozi,
senza pero’ stabilire la specifica sanzione in caso di inosservanza del relativo
divieto. Si parla in tali ipotesi di nullita’ c.d. virtuale, argomentandosi dal 1°
comma dell'art. 1418 c.c., il quale dispone che «il contratto e’ nullo quando e’
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente». Cio’
vuol dire che se la legge dispone diversamente, ossia una diversa sanzione (ad
esempio, l'annullabilita’), sara’ questa sanzione a doversi applicare; se, pero’,
non e’ prevista una sanzione per la violazione di una precisa norma imperativa,
dovra’ applicarsi quella della nullita’, in quanto cio’ e’ detto proprio nel 1°
comma dell'art. 1418.
11.5. Regole esattamente inverse, invece, valgono in materia testamentaria,
societaria e del lavoro: in tali ambiti, infatti, e’ l'annullabilita’ ad essere
virtuale, in quanto le ipotesi di nullita’ sono specificamente limitate a singole e
particolari ipotesi (per il testamento cfr. l'art. 606 c.c.; per le societa’ di capitali
l'art. 2332 c.c.; per il rapporto di lavoro l'art. 2126 c.c.).
12. In materia di condominio, la nullita’ non prevista e’ piuttosto una creazione
della dottrina e della giurisprudenza per impedire l'efficacia definitiva delle
delibere mancanti degli elementi costitutivi (o lesive dei diritti individuali); per
la verita’, fissare l'efficacia definitiva di una delibera gravemente viziata per
difetto di tempestiva impugnazione non sembra giusto.
In assenza di specifica previsione normativa, sembra logico doversi ammettere
la nullita’ soltanto nei casi piu’ gravi.
12.1. Al riguardo, nell'ambito del condominio negli edifici acquista rilevanza la
distinzione tra momento costitutivo e momento di gestione. Invero,
l'espressione «condominio negli edifici» designa tanto il diritto individuale sulle
cose, gli impianti ed i servizi comuni attribuito ai proprietari dei piani o delle
porzioni di piano siti nel fabbricato, quanto l'organizzazione degli stessi
proprietari, cui e’ affidata la gestione delle parti comuni. I vizi riscontrabili nel
momento costitutivo, che riflette l'insorgenza del diritto individuale e la stessa
situazione soggettiva di condominio, con conseguente rilevanza della volonta’
individuale di ogni singolo partecipante, onde il principio e’ quello
dell'autonomia, che si avvale dello strumento negoziale, certamente sono piu’
gravi di quelli verificabili nel momento di gestione, che riguarda
l'organizzazione del condominio per quanto attiene le sole cose comuni, dove
vige il metodo collegiale e il principio maggioritario, che comportano la
subordinazione della volonta’ dei singoli al volere dei piu’.
12.2. Come sopra accennato, a favore della nullita’ della delibera per la
mancata convocazione di un solo condomino si adducono due argomenti.
Anzitutto, la lettera dell'art. 1136, comma 6, c.c., secondo cui l'assemblea non
puo’ deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla
riunione, mediante comunicazione di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
Donde l'inferenza che, in mancanza della convocazione anche di un solo
condominio, non sussisterebbe il potere dell'assemblea di deliberare. Il
202
principio maggioritario - si aggiunge - in tanto puo’ operare in quanto tutti i
condomini siano stati posti in condizione di intervenire in assemblea, di
partecipare alla discussione e alla votazione, D'altra parte, si conclude, la
convocazione non attiene al solo procedimento, perche’ nei confronti del non
convocato il procedimento non inizia e quindi non puo’ verificarsi alcun error in
procedendo: la convocazione attiene alla sostanza della applicazione del
principio maggioritario.
12.3. Gli argomenti non persuadono e nel sistema si rinvengono considerazioni
contrarie di maggior peso.
Premesso che il procedimento di convocazione e’ unico e non si frantuma in
tanti procedimenti quanti sono i singoli condomini da convocare, la lettera
dell'art. 1136, comma 6, c.c. non raffigura un ostacolo insormontabile; la
norma puo’ essere intesa, con riferimento alla funzione, nel senso che la
proposizione secondo cui l'assemblea non puo’ "validamente" deliberare se
tutti i condomini non sono stati convocati, deve intendersi nel senso che, in
difetto di convocazione di un condomino, la delibera non e’ definitivamente
valida, essendo suscettibile di impugnazione (nel prescritto termine di trenta
giorni).
12.4. La delibera approvata con il principio maggioritario non va confusa con la
statuizione assunta con il negozio plurilaterale. Mentre il negozio plurilaterale
non e’ valido, se non vi partecipano tutte le parti necessarie, contrassegno
precipuo del principio maggioritario e’ la imputazione all'intero collegio di
quello che e’ il volere della maggioranza; quindi riconoscere l'efficacia della
deliberazione sulla base delle maggioranze prescritte e non necessariamente
sul fondamento della volonta’ di tutti i partecipanti. Se in base al metodo
collegiale e al principio maggioritario si vincolano anche tutti i condomini
assenti o dissenzienti non deve menar scandalo la mancata convocazione di un
condomino il quale, peraltro, non resta privo di tutela, poiche’ puo’ impugnare
quando la delibera gli viene comunicata.
12.5. Rileva poi la portata del collegato disposto degli artt. 1105, comma 3, e
1109, n. 2, e p. ult., c.c., che, in tema di comunione, stabilisce l'impugnazione
della delibera entro il termine di decadenza di trenta giorni nel caso di omessa
preventiva informazione a tutti i partecipanti. E' pur vero che l'art. 1105 c.c.
parla di preventiva informazione e non di convocazione. La terminologia
differente si spiega con la considerazione che nella comunione non e’ prevista
l'assemblea, ma la semplice riunione dei comproprietari interessati. Tuttavia la
sostanza della norma e’ che il difetto di informazione - certamente assimilabile
alla omessa convocazione - non configura una causa di nullita’, ma di semplice
annullabilita’. Da qui risulta ragionevole dubitare che l'art. 1136, comma 6,
c.c., disciplinando la stessa fattispecie e usando un formula consimile, alla
mancata convocazione di un condomino ricolleghi non la annullabilita’ ma la
conseguenza piu’ grave della nullita’.
13. A queste considerazioni specifiche conviene aggiungere argomenti desunti
dalla teoria degli atti giuridici.
Come sopra detto, in generale, si considera nullo l'atto quando manca ovvero
e’ gravemente viziato un elemento costitutivo, previsto secondo la
configurazione normativa. Pertanto, a causa dell'assenza ovvero del grave vizio
dell'elemento considerato essenziale, l'atto si considera inidoneo a dar vita alla
203
nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformita’
con la sua funzione economico-sociale. Per contro, si considera annullabile
l'atto in presenza di carenze o di vizi ritenuti meno gravi, secondo la
valutazione compiuta dall'ordinamento. Annullabile e’, dunque, l'atto che, non
mancando degli elementi essenziali del tipo, presenta vizi non gravi, che lo
rendono idoneo a dare vita ad una situazione giuridica precaria, che puo’
essere rimossa.
13.1. In tema di deliberazioni delle societa’ di capitali, come e’ noto, le cause
di nullita’ sono circoscritte (art. 2379 c.c.), in funzione della certezza dei
rapporti societari, i quali riguardano un numero cospicuo di persone. Le stesse
esigenze di certezza dei rapporti si rinvengono in tema di condominio negli
edifici, dove i rapporti riguardano i condomini, che raffigurano un numero di
persone maggiore di quelle che al singolo contratto sono interessate. Pertanto,
appare corretto e coerente con i principi limitare le cause di nullita’ ai vizi
afferenti alla sostanza degli atti, vale a dire alla impossibilita’ o alla illiceita’
dell'oggetto. Tanto la impossibilita’ giuridica quanto l'illiceita’ dell'oggetto
derivano dal difetto di attribuzioni in capo all'assemblea, posto che la prima
consiste nella inidoneita’ degli interessi contemplati ad essere regolati dal
collegio che delibera a maggioranza, ovvero a ricevere dalle delibere l'assetto
stabilito in concreto, e la seconda si identifica con la violazione delle norme
imperative, dalle quali l'assemblea non puo’ derogare, ovvero con la lesione dei
diritti individuali, attribuiti ai condomini dalla legge, dagli atti di acquisto o
dalle convenzioni.
13.2. La formula dell'art. 1137 c.c. deve interpretarsi nel senso che per le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio si intendono
le delibere assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prescritte
dall'art. 1136 c.c. per la convocazione, la costituzione, la discussione e la
votazione in collegio, pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli
artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c. Sono inficiate da un vizio di forma le
deliberazioni quando l'assemblea decide senza l'osservanza delle forme
procedimentali stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i
condomini alla formazione della volonta’ collettiva per gestire le cose comuni.
Pertanto, se gli stessi condomini interessati ritengono che dal provvedimento
approvato senza l'osservanza delle forme prescritte non derivi loro un danno,
manca il loro interesse a chiedere l'annullamento. Il difetto di impugnazione in
termine puo’ assumere significato di personale successiva adesione alla
delibera.
13.3. Sul punto e’ opportuno soffermarsi brevemente. Per la verita’, la
configuratone della mancata convocazione del condomino come vizio
procedimentale, da cui ha origine la semplice annullabilita’, non significa
privare della tutela il condomino non convocato. Invero, essendogli
riconosciuto il potere di impugnare nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, egli ha modo di far valere le sue ragioni. Peraltro, la
configurazione proposta esclude il rischio che le delibere assembleari possano
essere impugnate anche dopo il trascorrere di un lunghissimo tempo, sol
perche’ un requisito formale non e’ stato osservato, con conseguenze
gravissime sulla gestione del condominio.
204
14. Un ultimo argomento proviene dal nuovo assetto dell'art. 2739 c.c. stabilito
dalla riforma societaria.
14.1. In attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge-delega n.
366/2001, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel regolare le assemblee della
societa’ per azioni, ha dettato nuove norme sui vizi delle deliberazioni,
modificando gli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c. e aggiungendo due nuovi artt.,
2739-bis e 2739-ter, oltre l'art. 2734 bis. Il nuovo sistema ha innovato, in
primo luogo, il regime di invalidita’ degli atti, sotto il duplice profilo della causa
e degli effetti, in entrambe le fattispecie di annullabilita’ e nullita’. In secondo
luogo, ha modificato il procedimento di impugnazione delle delibere invalide, in
coerenza con le nuove norme sul processo in materia di diritto societario, e
affiancando all'azione reale una speciale azione personale e risarcitoria dei
danni causati dalla deliberazione viziata.
14.2. Nel sistema adottato, la regola generale, come nel precedente assetto, e’
quella secondo cui la violazione di legge o di statuto induce la annullabilita’.
Invece, la nullita’ consegue ad una serie di violazioni particolarmente gravi
della legge, e la relativa disciplina, anziche’ richiamare - come faceva il vecchio
art. 2379 - le regole generali sulla nullita’ dei contratti, di cui agli artt. 1421,
1422 e 1423 c.c., contiene disposizioni particolari e introduce nuove ipotesi. Le
ipotesi di nullita’ sono tre (art. 2379) e per ciascuna e’ dettata una disciplina
intesa al contenimento della fattispecie e delle sue conseguenze; la disciplina
comune consiste nella impugnabilita’ da parte di chiunque vi abbia interesse
nel termine di tre anni (con l'eccezione di ipotesi particolari) e alla rilevabilita’
d'ufficio, nei casi e nei termini previsti.
14.3. Secondo i primi commenti la riforma avrebbe privilegiato l'interesse della
societa’ alla stabilita’ delle delibere e l'esigenza del mercato alla stabilita’ dei
rapporti giuridici, senza pregiudicare peraltro l'interesse dei singoli soci a non
subire dei pregiudizi per l'illegalita’ delle delibere sociali.
15. Avuto riguardo alle considerazioni svolte e ai principi espressi, queste
Sezioni Unite ritengono che debbano qualificarsi nulle le delibere prive degli
elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario
all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che
non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti
individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta’ esclusiva di ognuno dei
condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbano,
invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare
costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella
prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari,
attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea,
quelle genericamente affette da irregolarita’ nel procedimento di convocazione,
quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione
all'oggetto.
16. Il contrasto giurisprudenziale, pertanto, va risolto affermandosi che la
mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione
dell'assemblea condominiale comporta non la nullita’, ma l'annullabilita’ della
delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni
previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti
205
dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e’
valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
17. Il principio comporta, quindi, il rigetto del primo motivo di ricorso.
18. Anche il secondo motivo e’ da rigettare, perche’ (come sopra detto) questa
Corte ha costantemente affermato l'annullabilita’ ex art. 1137 c.c. della
delibera il cui verbale contiene delle omissioni, anche relative alla mancata
individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti e al
valore delle rispettive quote (Cass. 22 gennaio 2000, n. 697; 29 gennaio 1999,
n. 810).
19. Infine pure il terzo motivo e’ infondato, perche’ la delibera ha riguardato
non la determinazione e fissazione dei criteri legali ovvero convenzionali per la
ripartizione delle spese, ma, nell'ambito di tali prefissati criteri, la ripartizione
in concreto tra i condomini delle spese relative a lavori straordinari ritenuti
afferenti a beni comuni (posti auto o vano ascensore) e tassa di occupazione di
suolo. E' stato sempre riconosciuto che la delibera, assunta nell'esercizio delle
attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, nn. 2 e 3, c.c. relativa alla
ripartizione in concreto delle spese condominiali, ove adottata in violazione dei
criteri gia’ stabiliti, deve considerarsi annullabile, non incidendo sui criteri
generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 c.c., e la relativa impugnazione
va proposta nel termine di decadenza (trenta giorni) previsto dall'art. 1137,
comma ultimo, c.c. (v. Cass. 9 febbraio 1995, n. 1455; 8 giugno 1993, n.
6403; 1° febbraio 1993, n. 1213).
20. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con
condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di
cui euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali e accessori come per
legge.
206
Immissioni: proprietà, esigenze della produzione e tutela del diritto
alla salute
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
(PRESIDENTE F. SABATINI, RELATORE G.B. PETTI)
SENTENZA N. 8420 DELL'11 APRILE 2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25 maggio 1983 i coniugi Z. Luigi e P. Maria Teresa
convenivano dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno, V. Maria, proprietaria di un
fondo e di una azienda confinante, e proponevano una serie di domande,
anche di natura risarcitoria, dirette da un lato a rendere stabile una scarpata
esistente sulla linea di confine del fondo e dall'altro ad eliminare le immissioni
di odori nauseanti provenienti dall'allevamento di polli e di altro bestiame,
gestito dalla convenuta. La V. si costituiva contestando il fondamento delle
pretese ed in via riconvenzionale chiedeva la demolizione della sovrastante
vasca di raccolta di acque piovane ed il risarcimento dei danni provocati dalla
franatura della scarpata, nonché la condanna per la realizzazione delle opere di
consolida mento.
La lite era istruita con prove orali e documentali e l'espletamento di ben tre
consulenze tecniche di ufficio.
Con sentenza del 19 novembre 1997 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva
solo in parte la domanda proposta dai coniugi Z. e condannava la V. al
risarcimento dei danni, liquidati ai V. attuali, nella misura di £ 46.553.333,
oltre interessi dalla domanda al saldo VcIevalutativ. di £ 23 milioni.
In relazione alla costruzione del muro di contenimento il Tribunale ripartiva tra
le parti le responsabilità della frana, nella misura di 1/3 a carico degli attori e
di 2/3 a carico della V.. Accoglieva la domanda riconvenzionale della V. in
ordine ai danni cagionati dalla frana del 1992 e condannava gli attori al
pagamento dei relativi danni (v. amplius in dispositivo); compensava tra le
parti le spese del giudizio.
Contro la decisione proponevano appello principale il V., in relazione alla
instabilità della scarpata ed alle opere di consolidazione, ed appello incidentale
i coniugi Z., in ordine al riparto delle responsabilità, alle immissioni ed ai
relativi danni.
Con sentenza del 20 settembre 2001 la Corte di appello di Ancona così
decideva: rigetta l'appello principale della V. ed in accoglimento per quanto di
ragione dell'appello dei coniugi Z. ordina alla V. la immediata cessazione dello
allevamento dì galline e la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in £ 20
milioni per ciascun coniuge; condanna la V. alla rifusione dei due gradi del
giudizio e conferma nel resto la impugnata sentenza. Contro la decisione
ricorre la V. proponendo due motivi di censura illustrati da memoria; resistono
le controparti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce la omessa motivazione su punti decisivi della
controversia, ovvero la contraddittorietà e insufficienza della stessa.
207
Le censure in particolare riguardano due punti:
a. il punto della causalità ( della frana, indi-cata nel supplemento della CTU (4
marzo 1994) secondo un doppio fattore, sia per la naturale inclinazione di
coinvolgimento delle acque piovane, sia per colpa dei coniugi Z. che avevano
lasciato aperto a lungo il rubinetto della vasca di contenimento delle acque
provocandone la tracimazione delle stesse;
b. un secondo punto decisivo concerne la valutazione della utilità del muro di
contenimento e la legittimità della sua collocazione sul terreno della V.
In ordine alla prima censura si rileva che essa difetta di autosufficienza e di
decisività: di autosufficienza poiché la consulenza è interpolata e la causalità
non appare indicata chiaramente in termini alternativi o di concorrenza; di
decisività in quanto il ragionamento della Corte di appello si fonda sull'analisi
degli esiti delle varie consulenze e perviene al convincimento di un concorso di
cause e di colpe imputabili in maniera prevalente alla V. e minore per i vicini
del fondo. (Vedi ff 6 e 7 della motivazione) . Si tratta dunque di un prudente
apprezzamento di fatto,che si avvale delle indicazioni tecniche peritali, ed è
congruamente motivato senza errori di tecnica o di logica giuridica.
In ordine alla seconda censura si osserva che la costruzione del muro giova ad
entrambi i contendenti, ed è stata disposta in prevenzione di futuri danni, onde
la collocazione del muro sulla proprietà della V. è misura di prevenzione
esigibile e realizzabile con 1' assenso della medesima, anche in relazione alle
autorizzazioni necessarie per la sua edificazione. Eventuali impedimenti posti
dalla V. la renderanno ci vilmente responsabile per ulteriori danni.
Inoltre si osserva che entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia sulla
costruzione di un muro di contenimento,sia pure in disputa sulle responsabilità.
Non sussiste pertanto alcun error in iudicando sul punto.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce 1'error in iudicando per la violazione dello
art.844 del codice civile. La tesi è che essendo l'attività di allevamento
preesistente alla edificazione del fondo vicino, il criterio della prevenzione
doveva prevalere, unitamente alle esigenze della produzione, sulle minori
esigenze olfattive dei vicini. Si deduce infine la contraddittorietà della
motivazione, sulla base della errata indicazione del numero della galline e sulla
relativa intuizione del lezzo insostenibile.
In senso contrario si osserva che la norma codificata sulle immissioni, nel
prevedere la valutazione, da parte del giudice, delle esigenze della produzione,
con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un
determinato uso, è stata correttamente applicata alla fattispecie in esame,
considerando anche la valenza della qualità della vita e della salute dei vicini
dell'azienda, nella quale la produzione si è svolta senza la predisposizione di
misure di cautela idonee ad evitare o limitare 1'inquinamento atmosferico.
Si tratta di una interpretazione estensiva della norma, costituzionalmente
orientata, in relazione al fattore salute, che è ormai intrinseco nella attività di
produzione oltre che nei rapporti di vicinato (cfr. Cass. 3 febbraio 1999 n.915,
Cass.4 aprile 2001 n.4963). La valutazione del fatto storico e la sua corretta
sussunzione sotto la norma in esame appare dunque giuridicamente esatta,
legittimando la statuizione preclusiva del prolungamento di un'attività
sostanzialmente nociva alla salute dei vicini del fondo.
208
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore
del resistente, delle spese ed onorari del giudizio di cassazione, liquidati come
in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente V. Maria a rifondere a Z. e P.
Maria Teresa le spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che
liquida in complessive Euro 4100,00 di cui euro 100,00 per spese, oltre
accessori e spese generali come per legge.
Roma 8 febbraio 2006.
209
CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE – SENTENZA 8 MARZO-29
APRILE 2006, N. 10052
PRESIDENTE OLLA – RELATORE GIUSTI
MASSIMA
Anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del
contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice
dell'opus, un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art.
1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede
oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di
cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle
attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie
affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto
obbligatorio. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di
norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle
condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un
doveroso intervento collaborativo del creditore: tanto avviene allorché la
modifica del progetto originario (nella specie, costruzione di un edificio
scolastico) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative,
legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal caso,
l'opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità
costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per
eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi. Ne consegue che
la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché
ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle
sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare impossibilità della
prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono
destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria
all'adempimento da parte del debitore.
Svolgimento del processo
210
1. Il Tribunale di Napoli – pronunciando sulla domanda, proposta da Campa
Pasquale, titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti del Comune
di Frattaminore, per sentire dichiarare risolto, per inadempimento dell’Ente
territoriale, il contratto di appalto stipulato inter partes per la costruzione di un
edificio scolastico, oltre che per ottenere la condanna del committente al
risarcimento dei danni, nonché sulla domanda riconvenzionale con la quale il
Comune aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per
inadempimento dell’impresa – con sentenza depositata il 25 febbraio 2000, in
accoglimento della domanda attrice, dichiarava la risoluzione del contratto (sia
per il mancato pagamento, da parte del Comune, di quanto dovuto per il
quinto stato di avanzamento dei lavori, sia per il mancato adeguamento del
progetto, da parte del medesimo ente e nonostante l’espressa sollecitazione
dell’impresa, alla normativa di legge in tema di edilizia scolastica e di sicurezza
degli impianti), e condannava la Pa al pagamento della somma di lire
487.276.819, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
2. Su gravame del Comune committente, al quale resisteva il Ciampa, la Corte
d’appello di Napoli, con sentenza n. 107 depositata in data 16 gennaio 2002, in
parziale riforma della pronuncia del Tribunale, riduceva a lire 310.597.450,
oltre accessori, il debito risarcitorio del Comune, e dichiarava compensato, per
la metà, la spose di entrambi i gradi del giudizio, condannando l’Ente locale al
pagamento,
in
favore
del
Ciampa,
dell’altra
metà.
2.1. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale - dopo avere escluso, in
accoglimento della censura mossa dall’appellante, l’inadempimento del
Comune con riguardo al pagamento del quinto ed ultimo stato di avanzamento
(sul rilievo che i lavori eseguiti non avevano raggiunto l’importo
contrattualmente stabilito) - riteneva legittima la sospensione dei lavori
disposta, in corno d’opera, dall’appaltatore in data 26 luglio 1993, dopo che
agli, in dal marzo dello stesso anno, aveva segnalato la necessità di adeguare il
progetto alla nuova normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici
dettata dalla legge 46/1990, e parimenti legittimo il suo rifiuto di ottemperare
all’ordine dell’Amministrazione di eseguire l’opera secondo l’originario progetto;
e ciò in quanto, in conseguenza dell’ordine impartito dal Comune committente,
che aveva respinto la segnalazione e insistito per l’esecuzione del progetto,
non sarebbe venuta meno la responsabilità penale e risarcitoria
dell’appaltatore per eventi lesivi della integrità personale degli alunni e degli
insegnanti, che si fossero verificati a causa della realizzazione dell’istituto
scolastico
in
modo
difforme
dalla
prescrizioni
di
legge.
Ad avviso della Corte partenopea. la mancata consegna dei progetti di
adeguamento dell’opera alle prescrizioni di legge integrò la mora della
Amministrazione creditrice, perché rese impossibile l’esecuzione della
prestazione dell’appaltatore debitore, il quale aveva interesse a ricevere il
progetto per poterai liberare dall’obbligo assunto col contratto di appalto e per
conseguire
la
controprestazione.
Di qui la conferma della pronuncia di risoluzione del contratto, sotto il profilo,
appunto,
della
mancata
cooperazione
del
creditore.
2.2. La Corte d’appello accoglieva, inoltre, il motivo di impugnazione
concernente l’accollo all’Amministrazione delle spese di guardiania sostenute
dall’appaltatore dal momento della sospensione dei lavori, ritenendo che fosse
211
mancata la prova dell’esecuzione della prestazione di vigilanza e di custodia del
cantiere.
3. Avverso questa sentenza, con atto notificato il 10 ottobre 2002 il Comune di
Frattaminore ha interposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di
censura.
Ha resistito con controricorso Ciampa Pasquale, il quale, a sua volta, ha
proposto
ricorso
incidentale,
con
due
motivi.
Il Comune di Frattaminore ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. A norma dell’articolo 335 Cpc, deva essere disposta la riunione dei ricorsi
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, proposti, in via principale,
dal Comune di Frattaminore e, in via incidentale, da Ciampa Pasquale.
2. Con il primo motivo dal ricorso principale (violazione e falsa applicazione
dell’articolo 348 dalla legge 240/65, all. 7, dell’articolo 30 del capitolato
generale d’appalto per le opere di competenza del ministero dei Lavori pubblici,
approvato con il Dpr 1063/62, e dell’articolo 16 del regolamento per la
direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con il Rd 350/1895), Il
Comune di Frattaminore ai duole che la Corte d’appello abbia erroneamente
ritenuto legittima la sospensione dei lavori decisa, unilateralmente, dal Ciampa
durante l’esecuzione dell’opera pubblica costituente oggetto del contratto di
appalto.
Sostiene il ricorrente che, nell’ambito della disciplina regolante l’appalto
pubblico, nessuna norma attribuirebbe all’appaltatore il potere di sospendere i
lavori: costui sarebbe abilitato esclusivamente a formulare osservazioni in
ordine alla ragioni che possono suggerire o imporre una sospensione, e tale
provvedimento potrebbe essere adottato esclusivamente dall’ingegnere capo,
in
presenza
di
tassativa
circostanze.
Ad avviso del Comune, la disciplina sull’abbattimento delle barriere
architettoniche e sulla sicurezza degli impianti costituiva jus superveniens
rispetto alla stipula del contratto di appalto ad alla predisposizione del
progetto: sicché - forma rimanendo l’inammissibilità di qualsivoglia potere di
unilaterale sospensione da parte dell’appaltatore - le varianti al progetto
originario, in quanto correlato a sopravvenuto disposizioni legislative,
avrebbero dovuto essere regolate dall’articolo 343 della legge 2248/65, all. F.
In base a quest’ultima disposizione, soltanto all’Amministrazione committente
è riservata la facoltà, ove lo ritenga opportuno e necessario, di attivare la
procedura amministrativa a forma vincolata ed a contenuto predeterminato per
l’approvazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ampliando il
contenuto dell’originario contratto di appalto di opera pubblica anche con
riferimento ai tempi contrattuali di esecuzione dell’opera, ovvero promuovendo
la stipula di un altro contratto di appalto, con contenuti nuovi e diversi,
prevedendo
i
costi
di
esecuzione
ad
i
fondi
per
finanziarli.
212
Il ricorrente in via principale rileva inoltre che le protese modifiche progettuali,
richieste dall’appaltatore mentre stava realizzando le opere murario, non
incidevano in alcun modo sulle lavorazioni in corso e non potevano, quindi,
giustificarne la sospensione, tanto più che - per comune esperienza - la
realizzazione di tutte le opere pretestuosamente invocato dall’appaltatore in
aggiunta al progetto originario, in quanto accessorie e pertinenziali, ben
potevano essere realizzabili anche su opere perfettamente completato, come è
dimostrato dal fatto che il legislatore, nella invocata normativa, ha
specificamente previsto sia i tempi aia la modalità per la realizzazione di
strutture
di
adeguamento
su
opere
già
interamente
ultimate.
In conclusione, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ammesso che una
valutazione discrezionale dell’appaltatore può sostituirsi al giudizio
dell’Amministrazione committente, sostituendosi addirittura ad essa, finendo
con l’affermare che l’appaltatore, con la propria decisioni, può superare la
procedura di collaudo: collaudo che - viceversa - dovrebbe considerarsi un
adempimento
obbligatorio,
necessario
ed
indispensabile
da
parte
dell’Amministrazione committente, la quale nolo attraverso tale procedimento,
conclusivo della procedura di appalto di opera pubblica, verifica la rispondenza
dell’opera al contratto e alla regola d’arte (c.d. collaudo tecnico) e l’idoneità
dell’opera medesima al servizio o alla funzione pubblica cui essa è destinata
(c.d. collaudo amministrativo), con tutto le conseguenza connesse ad un
eventuale
giudizio
negativo.
3.
Il
motivo
è
infondato.
3.1. È esatto che - in base al principio della continuità dell’esecuzione dei lavori
(principio che, pur essendo comune tanto all’appalto privato quanto a quello di
opere pubbliche, in quest’ultimo assume una maggiore intensità in ragione
della necessità che venga assicurato il tempestivo e regolare compimento
dell’opera) - l’appaltatore di opere pubbliche non può, di regola, sospendere di
propria iniziativa i lavori. Secondo la disposizioni sui lavori pubblici, applicabili
ratione temporis “l’impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o
rallentare la esecuzione del lavori” (articolo 348 comma 3 della legge
2249/1865,
all.
F);
soltanto
all’amministrazione
committente,
ad
esclusivamente per causo determinato, è dato disporre sospensioni
temporanee nell’esecuzione dei lavori (articolo 16 del regolamento approvato
con il Rd 350/05; articolo 30 del capitolato generale d’appalto per le opere di
competenza del ministero dei Lavori pubblici, approvato con il Dpr 1063/62).
Inoltre l’appaltatore non può neppure, di sua iniziativa, eseguire le addizioni e
le variazioni che ritenga indispensabili: quando riconosca una siffatta necessità,
devo avvertire il direttore dei lavori e provocare la predisposizione, da parte
della stazione appaltante, di varianti in corso d’opera. Difatti, la variazioni nono
destinato a determinare delle modificazioni del contratto, le quali possono
essere introdotto soltanto dagli organi competenti a manifestare la volontà
della Pa e ad impegnare quest’ultima (articolo 343 della legge sui lavori
pubblici; artt. 20 e ss. del regolamento di cui al Rd 350/95).
3.2. Sennonché, occorre osservare che la preminenza della posizione riservata
alla
Pa
committente,
derivante dall’essere l’opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla
natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche (cfr. Cassazione,
213
Su, 10525/96, Sezione prima, 5232/85, 9794/94): anche nell’appalto di opere
pubbliche, pertanto, è configurabile, in capo all’amministrazione committente,
creditrice dell’opus, un dovere – discendente dall’espresso riferimento
contenuto nell’articolo 1206 Cc (là dove questa norma richiama il compimento,
da parte del creditore, di quanto a necessario affinché il debitore possa
adempiere l’obbligazione) e, più in generale, dai principi di correttezza e buona
fede oggettiva, che permeano la disciplina della obbligazioni e del contratto,
con particolare riguardo al momento della sua esecuzione di cooperare
all’adempimento dell’appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività,
distinte rispetto al comportamento dovuto dal debitore, necessario affinché
quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto
obbligatorio, ossia la soddisfazione dell’interesso della stessa stazione
appaltante.
In questo contesto, l’elaborazione di varianti in corso d’opera - di norma
costituente una mera facoltà della Pa committente (esercitabile in presenza
delle condizioni previsto dalla legge) - può configurarsi come espressione di un
doveroso intervento collaborativo del creditore, al fine di rendere possibile
l’adempimento
dell’appaltatore.
Ciò avviene, in particolare, quando, come nella specie, la modifica del progetto
originario (di un immobile destinato a scuola) sia resa necessaria da
sopravvenute disposizioni imperativa, legislativo e regolamentari, sulla
sicurezza degli impianti (legge 46/1990; Dpr 447/91): in tal caso, infatti,
l’opera. che fosso realizzata secondo le inizialmente progettato modalità
costruttive e istruzioni tecniche, esporrebbe l’appaltatore a responsabilità per
eventi lesivi dell’incolumità e dell’integrità personale di terzi (cfr. Cassazione,
Sezione
prima,
2328/93;
Sezione
terza,
14905/02;
7515/05).
Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione
appaltante, benché ritualmente intimata, dei progetti di adeguamento
dell’opera alla sopravvenute prescrizioni di legge, ben può determinare
Impossibilità della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul
quale sono destinate a ricadere la conseguenze dell’omessa cooperazione
necessaria
all’adempimento
da
parte
del
debitore.
E non rilevano, in senso contrario, né i poteri della Pa in sede di collaudo,
atteso che l’esito positivo di questo non fa venir meno la responsabilità
dell’appaltatore nei confronti dei terzi (cfr. Cassazione, Sezione prima,
4026/74; Sezione seconda 1290/00) né la - peraltro genericamente accampata
- previsione di tempi di adeguamento alla sopravvenuta normatIva per
immobili già ultimati ad adibiti ad edificio scolastico, poeto che nella specie si
versa nella diversa ipotesi di contratto di appalto per opera In corno di
costruzione.
3.3. La Corte partenopea ha fatto corretta applicazione di questo principio, con
una valutazione sorretta da adeguata e congrua motivazione. Difatti, il giudice
del merito - avendo accertato che la sospensione dei lavori fu disposta, in
corno d’opera, nel luglio 1993, dall’impresa, dopo che cosa, fin dal marzo dello
stesso anno, aveva segnalato la necessità di adeguare il progetto alla nuova
normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici - ha ritenuto legittimo
il rifiuto dell’appaltatore di ottemperare all’ordine dell’Amministrazione di
eseguire l’opera secondo l’originario progetto, non più in linea con la
214
prescrizioni imposte dalla normativa sopravvenuta, osservando che non
sarebbe venuta meno la responsabilità penale e risarcitoria del Ciampa per
eventi lesivi della integrità personale degli alunni e degli insegnanti, che si
fossero verificati a causa della realizzazione dell’istituto scolastico in modo
difforme dalle prescrizioni di legge; e, avendo accertato che la prestazione del
debitore ora divenuta impossibile per la perdurante more della stazione
appaltante nel necessario intervento collaborativo, ha dichiarato la risoluzione
del
contratto,
addebitandone
la
responsabilità
all’Amministrazione.
Il motivato apprezzamento del giudica del merito, frutto di una analitica
ricostruzione della risultanze processuali e privo di mende logiche e di errori
giuridici,
si
sottrae
alle
censure
del
Comune
ricorrente.
4. Con il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia), il ricorrente in via principale si
duole della omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, del motivo
di appello riguardante le prospettazioni addotto a sostegno della domanda
riconvenzionale, sulla quali il giudica del marito non si sarebbe affatto
pronunciato. Nel dispositivo della sentenza mancherebbe un qualsiasi cenno
alla domanda riconvenzionaie, sicché la Corte d’appello non avrebbe statuito
alcunché
su
un
punto
decisivo
del
thema
decidendum.
Assume il ricorrente che dalla esperita consulenza tecnica d’ufficio sarebbe
emerso che il Comune di Frattaminore avrebbe subito gravi danni in
conseguenza della perdurante mancata ultimazione dei lavori e della
intervenuta maggiorazione dei prezzi, il prodursi di tali danni sarebbe
strettamente legato, sotto il profilo del nesso di causalità, alla sospensione
unilaterale
ad
illegittima
dei
lavori
da
parte
dell’impresa.
5.
Il
motivo
è
infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cassazione, Sezione prima,
1735/63; Sezione seconda, 2190/66, Sezione prima 676/73, Sezione lavoro,
4546/83, Sezione seconda, 3693/95, Sezione terza, 4079/05), non è
configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda sia
implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, con la quale venga
accolta
una
tesi
incompatibile
con
tale
domanda.
Nella specie, il rigetto della domanda riconvenzionale, con la quale il Comune
aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa
appaltatrice, per avere questa unilateralmente ad illegittimamente sospeso i
lavori, è implicito nella pronuncia della Corte d’appello in ordine alla domanda
principale, con la quale si è statuito, per un verso, che quella sospensione ora il
riflesso dell’impossibilità temporanea della prestazione per fatto imputabile al
creditore e, per l’altro verso, che lo scioglimento del contratto di appalto si è
prodotto
a
causa
della
mancata
cooperazione
del
creditore.
6. Con il primo motivo, il ricorrente incidentale denuncia l’illegittima ed erronea
motivazione
della
sentenza
in ordine
alle
spose
di guardiania.
Essendo la guardiania espletata da personale della stanza impresa, sarebbe
irrilevante che lo stesso non fosse munito di specifica qualifica di guardia
giurata.
Inoltre, l’attore in primo grado aveva specificamente articolato una prova
testimoniale sull’avvenuto espletamento del servizio, senza che il Tribunale
avesse ravvisato la necessità di metterla, risultando la circostanza provata
215
documentalmente.
La Corte d’appello si sarebbe basata, per escludere il rimborso delle speso di
guardiania, sul verbale del comandante della polizia municipale, mentre tale
documento sarebbe privo di rilievo giuridico, attesa la provenienza da un
organo
funzionale
e
dipendente
dello
stesso
Comune.
7.
Il
motivo
è
inammissibile.
7.1. La Corte partenopea ha ritenuto non provata l’esecuzione della
prestazione di vigilanza e di custodia del cantiere da parte dell’impresa
appaltatrice durante il periodo di sospensione dei lavori, dando una
motivazione congrua e logicamente argomentata di tale convincimento.
Secondo la Corte d’appello, in mancanza elementi deponenti nel senno
dell’avvenuto svolgimento di tale servizio, l’impresa avrebbe dovuto fornire la
dimostrazione della pretesa creditoria mediante l’esibizione di libri paga e
matricola e mediante attestato del possesso, da parte del soggetto incaricato
dell’espletamento di tale servizio, della qualifica di guardia particolare giurata,
proveniente dall’autorità di pubblica sicurezza. Secondo la Corte di Napoli, non
solo ara mancata questa prova, ma doveva anzi ritenersi che il servizio non
fosso stato mai concretamente espletato, sia perché il comandante della polizia
municipale di Frattaminore constatò, nelle periodiche visito da lui effettuato,
che il cantiere ora incustodito, sia perché lo stesso Ciampa ebbe a denunciare il
furto di materiale dal cantiere per l’assenza del guardiano diurno, seppure
motivata
da
contingenti
ragioni
di
saluto.
7.2. Il motivo si risolve, in sostanza, in una inammissibile richiesta di revisione
del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del
merito alla soluzione della questione esaminata, evidente apparendo come il
ricorrente in via incidentale, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della
sentenza gravata sotto il profilo di cui all’articolo 360, comma 1, numero 5),
Cpc, ai limiti ad invocare - peraltro in modo assai generico, e senza neppure
indicare il contenuto del documento da cui emergerebbe l’avvenuta esecuzione
della prestazione di custodia né le circostanze sulla quali avrebbe dovuto
vertere la prova testimoniale non Ammessa - una diversa lettura delle
risultanza di fatto o! come accertate e ricostruite dal giudica di merito.
La censura ometto di considerare che tanto la valutazione delle risultanze
probatorie, quanto il giudizio sul contenuto e sulla portata delle quaestionis
facti posta dalle singolo fattispecie sottoposte al vaglio del giudice di merito così come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenuto più
idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudica del merito, il quale, nel fondate la propria decisione, non
incontra altro limito che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,
senza essere peraltro tenuto ad affrontate e discutere ogni singola risultanza
processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.
È principio di diritto ormai consolidato (cfr., ex multis, Cassazione, Sezione
terza, 15805/05) quello per cui l’articolo 360, comma 1, numero 5), Cpc non
conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il
potere di riesaminare il merito della causa, consentendolo, per converso, il solo
controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, delle
valutazioni compiuto dal giudice del merito, al quale soltanto - va ripetuto
spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove
216
controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra cose, quella
funzionali
alla
dimostrazione
dei
fatti
in
discussione.
Il ricorrente in via incidentale, nella specie, pur denunciando, apparentemente,
una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente
(perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di
legittimità) sollecita una nuova valutazione delle risultanze del processo ad
opera di questa Corte, onde trasformare il processo di cassazione in un terzo
giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente il contenuto di fatti e
vicende del processo, la maggiore o minore attendibilità di questa o di quella
risultanza processuale, le opzioni del giudice di appello non gradito e per ciò
solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altra più consone alle
aspettative
della
parte.
8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Ciampa si duole che la Corte
d’appello abbia erroneamente compensato per la moti le spese del doppio
grado: essendo invece stata acclarata la esclusiva responsabilità del Comune,
nessuna compensazione delle spese, neppure parziale, sarebbe stata, per il
principio
di
soccombenza,
legittima.
9.
Il
motivo
a
inammissibile.
9.1. In tema di regolamento delle spose processuali, il sindacato della Corte di
cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spose non
possono essere posto a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula
da tale sindacato, e rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del
marito, la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale,
sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti
motivi. La valutazione della ricorrenza dei giusti motivi è rimessa al prudente
apprezzamento del giudica e sfugge al controllo di legittimità, sempre che a
giustificazione della disposta compensazione non siano addotto ragioni illogiche
o
erronee
(ex
multis,
Cassazione,
Sezione
lavoro,
16162/04).
9.2. Nella specie la Corte d’appello ha compensato per la metà tra le parti la
spese del doppio grado “In considerazione dell’esito complessivo della lite”,
tenendo implicitamente conto del fatto che la protesa dell’impresa,
ridimensionata in appello, è stata accolta soltanto in parte, e quindi
adducendo, con adeguata argomentazione, un motivo in astratto idoneo a
giustificare
la
adottata
pronuncia
di
compensazione
parziale.
La statuizione della Corte territoriale si sottrae alla censura del ricorrente in via
incidentale, che sollecita un riesame, nel merito, della valutazione operata
dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza dei giunti motivi.
10. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono rigettati.
Tale esito, unitamente alla novità, in parte, delle questioni trattate nell’esame
del primo motivo del ricorso principale, giustifica l’integrale compensazione
delle
spese
della
fase
di
legittimità.
PQM
217
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente tra le parti le spese
della fase di legittimità.
218
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA 27 DICEMBRE 2004, N. 23994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente Dott. MENSITIERI Alfredo ConsigliereDott. SCHETTINO Olindo - ConsigliereDott. SETTIMJ Giovanni Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere
Svolgimento del processo
Con ricorso del condominio Lungotestene in persona dell'amministratore Mario
S., il G.D.P. di Agropoli ingiungeva con decreto 156/97, ad Angelo B. il
pagamento di L. 4.539.908 per quote condominiali relative ad un
appartamento condominiale.
Su opposizione del B., che eccepiva di non essere proprietario dell'immobile, il
G.D.P. di Agropoli con sentenza N. 190/97, revocava il decreto ingiuntivo
dichiarando l'ingiunto carente di legittimazione passiva.
Su impugnazione di S. Mario, il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza
17.2.2000, in riforma della sentenza impugnata confermava il decreto
ingiuntivo emesso nei confronti del B. condannandolo al pagamento delle spese
di entrambi i gradi del giudizio.
- Afferma il Tribunale, in ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva
dell'appellante (per essersi il S. costituito in giudizio personalmente e non nella
qualità di amministratore del condominio), che, se è vero che nell'atto di
appello il S. non si qualifica come amministratore del condominio, è altrettanto
vero che lo stesso non ha inteso costituirsi personalmente come si evince: dal
fatto che a margine della procura rilasciata dal S. è stampigliata la dicitura:
"amministratore", facendo ciò chiaramente intendere che il mandato ad litem è
stato conferito per conto del legale rappresentante del condominio; dal fatto
che il S. difende la sua posizione di amministratore del condominio, nel quale il
B. avrebbe ingenerato l'incolpevole affidamento che egli era il proprietario
dell'immobile; nel fatto che conclusivamente, nell'atto di appello, è il
condominio Lungotestene ad effettuare la vocatio in ius; - quanto alla dedotta
nullità della procura ad litem per la mancata certificazione da parte del
difensore, dell'autografia della firma dell'appellante, afferma il Tribunale che la
mancata sottoscrizione della procura da parte dell'avvocato costituisce una
mera irregolarità sanabile in corso di causa, come nella specie è avvenuto, con
la sottoscrizione dell'avvocato che ha certificato l'autografia della sottoscrizione
del mandante, non essendo necessaria l'attestazione dell'avvocato che la firma
del mandante sia avvenuta in sua presenza.
Afferma il Tribunale che l'esecuzione di incompetenza per valore del giudice
adito è infondata in quanto la controversia è di valore determinabile e
calcolando gli interessi da applicare al capitale di L. 4.539.908, al tasso del
10% annuo per il periodo 14.8.96 (data della delibera con cui è stata ripartita
la spesa) 31.12.96 ed al tasso del 5% per il periodo 31.12.96 e 23.4.97 (data
219
di emissione del decreto ingiuntivo), la somma ingiunta non supera il valore di
L. 5.000.000 e quindi la competenza del G.D.P. ex art. 7 c.p.c..
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del B., ribadita
l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto anche in tema di
condominio ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle
quote condominiali, afferma il Tribunale che, nella specie, il comportamento
tenuto
dal
B.
(coniuge
convivente
con
l'effettiva
proprietaria
dell'appartamento) il quale avendo la disponibilità dell'immobile ha partecipato
uti dominus alle assemblee condominiali, pagato le quote condominiali,
sottoscritto le ricevute rilasciate dall'amministratore, ricevuto la corrispondenza
inviatagli ad personam dall'amministratore, ha creato in capo al medesimo
l'apparenza della titolarità della quota condominiale inducendo legittimamente
l'amministratore a credere che egli fosse il proprietario formale dell'unità
immobiliare.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il B..
Resiste, con controricorso, il condominio.
Motivi della decisione
Deduce il B. a motivi di impugnazione: la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, nonchè l'omessa contraddittoria e comunque insufficiente
motivazione per avere il Tribunale erroneamente:
1) accolto un atto di appello NULLO perchè proposto da S. Mario che, non
qualificandosi quale amministratore del condominio Lungotestene, era privo di
legittimazione attiva ad impugnare la sentenza del G.D.P. affermando: che la
qualifica di amministratore era desumibile dal fatto che sul mandato vi era la
stampigliatura "amministratore", e che dal contesto dell'atto si arguiva che il S.
difendeva le posizioni del condominio; NONOSTANTE:
a) la stampigliatura contenesse l'indicazione generica di "amministratore"
senza specificare nemmeno il nome del condominio:
b) la ritenuta difesa degli interessi del condominio da parte del S. seppur
legittimava il medesimo a contraddire, da altro lato contrastava con il
riconoscimento che lo stesso era estraneo agli interessi processuali;
2) ritenuto valido il mandato conferito al difensore del condominio, nonostante
la mancata certificazione da parte del difensore medesimo della autografia
della firma dell'appellante;
3) ritenuto l'"affidamento incolpevole" dell'amministratore del condominio nel
considerare il B. proprietario dell'appartamento, nonostante le bollette
condominiali approntate dall'amministratore fossero intestate a C. Pasqualina,
proprietaria effettiva dell'immobile in forza del rogito 21.11.77 e tra la
medesima ed il marito B. prima del rogito fosse stata convenuta la separazione
dei beni;
4) ritenuto la controversia, rientrante nella competenza per valore del G.D.P.,
NONOSTANTE:
a) la domanda fosse di valore indeterminato, superiore a L. 5.000.000,
richiedendosi anche gli interessi alla scadenza delle singole quote, per un
ammontare indeterminato, senza che il ricorrente avesse limitato il valore nei
limiti di competenza del giudice adito, con la conseguenza che la controversia
rientrava nella competenza per valore del Tribunale;
220
b) la domanda, anche a ritenere gli interessi, determinabili con opportuni
calcoli, rientrasse nella competenza per valore della Pretura di Vallo della
Lucania in quanto aggiungendo alla parte capitale pari a L. 4.539.908, gli
interessi maturati al 23.4.97 pari a L. 605.318 il valore ammonterebbe a L.
5.145.226, superiore alla competenza del G.D.P. e rientrante nella competenza
del Pretore;
5) omesso di pronunciarsi sulle contestazioni in ordine all'an ed al quantum
sollevate dal ricorrente fin dall'atto di opposizione.
La prima doglianza è infondata, in quanto il ricorrente non fa altro che ripetere
argomenti ai quali ha già risposto il Tribunale di Vallo della Lucania, senza
chiarire quale sarebbe l'errore nel quale lo stesso sarebbe incorso.
La seconda doglianza è infondata, in quanto, in base alla giurisprudenza di
questa S.C., la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia
della firma del conferente la procura ad litem costituisce una mera irregolarità,
che non comporta la nullità della procura stessa, in quanto tale nullità non è
comminata dalla legge; nè detta formalità incide sui requisiti indispensabili per
il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del
rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore
nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni
e prove, l'autografia della firma non autenticata, sent. 17 dicembre 1998 n.
12625). Da un punto di vista logico va, poi, esaminata la doglianza, con la
quale il ricorrente ribadisce che:
a) la domanda riconvenzionale, tenuto conto della indeterminatezza della
misura degli interessi era di valore indeterminabile, per cui andava affermata
la competenza per valore del Tribunale di Vallo della Lucania;
b) la domanda riconvenzionale, sommando somma capitale ed interessi,aveva
un valore superiore a lire 5.000.000, con conseguente incompetenza del
Giudice di pace e competenza del Tribunale di Vallo della Lucania. Le doglianze
sono infondate, in quanto:
a) la indeterminatezza degli interessi richiesti non comportava la
indeterminabilità degli stessi, tenendo conto della determinatezza dei
parametri in base ai quali gli stessi andavano calcolati;
b) il ricorrente si limita ad opporre un proprio calcolo, senza indicare gli
elementi in base ai quali lo stesso è stato effettuato e senza contestare la
correttezza di quelli utilizzati dalla sentenza impugnata per giungere a diversa
conclusione.
E', invece, fondata la doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva del
ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, non ha tenuto conto che secondo la
più recente giurisprudenza di questa S.C. in tema di ripartizione delle spese
condominiali è passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria per il
recupero della quota di competenza colui che sia effettivamente individuato
come proprietario esclusivo dell'unità immobiliare, non potendo l'azione stessa
essere proposta contro colui il quale, con le sue dichiarazioni e comportamenti,
anche
univoci,
abbia
ingenerato
nell'amministratore
il
ragionevole
convincimento che si tratti dell'effettivo condomino, in quanto in materia
condominiale non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del
diritto, mancando una relazione di terzietà tra il condomino e il condominio,
che non ha una soggettività giuridica diversa da quella dei semplici condomini.
221
(Cfr. sent.: 25 novembre 2003 n. 17897; 30 agosto 2002 n. 12709; 8 aprile
2002 n. 5035).
La doglianza relativa alla omessa pronuncia sulle contestazioni in ordine all'an
ed al quantum viene ad essere assorbita.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti esposti e la sentenza impugnata va
cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Salerno che
provvedere all'applicazione dei principi esposti, nonchè a liquidare le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2004.
222
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
SENTENZA 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095
(Presidente Carbone – Relatore Morelli
Pm Palmieri – parzialmente conforme – ricorrente Credito Italiano Spa –
controricorrente Carlino ed altri)
Svolgimento del processo
Il Credito Italiano Spa ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15
gennaio 2001, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della
pronunzia di primo grado, ha accolto la opposizione proposta da Franco e
Carlino Stefana avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza. emesso nei
confronti dei due predetti intimati, quali fideiussori della Fas Spa, per l’importo
complessivo di lire 1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo
passivo finale del conto corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime
erogazioni di credito in favore della società garantita.
Con le quattro complesse serie di motivi, di cui si compone l’odierno ricorso - la
cui ammissibilità e fondatezza è contestata dagli intimati con separati
controricorsi - il Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere,
a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae origine il
debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell’escluderne, in particolare, la validità in relazione alla clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore alle
note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del
30 marzo e successive conformi che, in contrasto con la precedente
giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un “uso
normativo” ai sensi dell’articolo 1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli Stefana per il
periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della legge
154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per la validità delle
fideiussioni omnibus;
d) nell’escludere, infine, la debenza dell’intero credito, azionato con il decreto
opposto, per ritenuta (a torto) carenza di documentazione, imputabile
all’istituto, che consentisse di scorporare dall’importo preteso in via monitoria
quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione e detrarre, dallo
stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli interessi.
Su istanza della parte ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa alle
Su, ravvisando, in quella sub b), questione di massima di particolare
importanza.
Motivi della decisione
1. La questione di massima, in ragione della cui particolare importanza gli atti
della presente causa sono stati rimessi a queste Su, ai sensi dell’articolo 374,
cpv, Cpc si risolve nello stabilire se - incontestata la non attualità di un uso
normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista
bancario - sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al
nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive
223
conformi) che lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con
la precedente giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare all’esame della riferita questione, quello delle
eccezioni pregiudiziali - sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino
Stefana - di inammissibilità del ricorso “per difetto di specialità della procura
alle liti” e “per intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale resa dalla
Corte di Cagliari” nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione - con cui il difetto di specialità, per “assenza di
riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza impugnanda”, è
(impropriamente), in particolare, riferito, non già alla procura rilasciata al
difensore (che tali riferimenti puntualmente, invece, contiene), ma all’atto
fonte dei poteri del soggetto che detta procura ha conferito - è infondata. Si
deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura speciale non sia nella
specie riferibile - come ex articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe - alla parte od a
chi ha il potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta “da un dirigente e non
dal legale rappresentante del Credito Italiano ricorrente”. E tale rilievo non
coglie nel segno, dacché il dirigente dell’ente - contrariamente all’avverso
assunto - ha conferito il mandato alla odierna impugnazione nella veste
appunto di “legale rappresentante” del Credito italiano, così (correttamente)
spesa sulla base dello Statuto dell’ente che, all’articolo 29, testualmente
prevede che «la rappresentanza anche [e quindi: non solo] processuale della
società spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti ... nonché ai
dirigenti ... con facoltà di designare mandatari speciali per il compimento di
determinate operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni
poteri».
2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l’ulteriore eccezione di
“giudicato formale interno”, che tale vis preclusiva pretende, con evidente
forzatura, di conferire all’ordinanza (del 31 maggio 1999), con la quale la Corte
di merito - in via istruttoria e strumentale alla decisione, non certo decisoria si è limitata invece a nominare un Ctu per l’espletamento di una perizia
contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole voci (tra cui quella
relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui risultava il complessivo
importo per cui la Banca aveva agito in via monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto, l’esame del primo motivo del ricorso, con il
quale si denunzia la violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione
all’articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte di appello nel
rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica. Atteso che, con tal
mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente preliminare, e
virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla validità o meno
della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo Collegio, però, non
sussiste. La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
(tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale),
effettivamente è stata, infatti, rilevata “di ufficio” nella fase di gravame. Ma ciò
la Corte di Cagliari ha fatto in corretta applicazione del principio per cui la
nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base della domanda può essere
rilevata, appunto, di ufficio,anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione
2772/98).
224
È pur vero, per altro, che il potere che il citato articolo 1421 conferisce in tal
senso al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali dell’ordinamento
giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli 99 e
112 Cpc, e che le esigenze a tali principi sottese - rispettivamente di verifica
delle condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una
parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l’eccezione di nullità,
dell’altra, che il giudice ritenga (come nella specie) di integrare con il rilievo di
aspetti della patologia del negozio che la parte, interessata alla improduttività
dei correlativi effetti, non abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque
dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione che, se da un
lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda
proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del contratto
dedotto dall’attore, la deduzione in tal senso del convenuto non può costituire,
od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico
con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che già esiste. Sia
impostata quella deduzione come eccezione, come domanda riconvenzionale
per la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si tratta pur sempre di
mera difesa, attenendo all’inesistenza, per mancato perfezionamento o per
nullità, del fatto giuridico, il contratto, dedotto dall’attore a fondamento della
domanda, che dunque non condiziona l’esercizio del potere officioso di rilievo
della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione
5341/84). Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale, proposta in
via monitoria dal Credito italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei
fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di
conto corrente, stipulato dal debitore principale.
Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità, da parte del giudice, dì
aspetti di nullità di quel contratto il fatto che gli intimati (aventi veste
sostanziale di convenuti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)
abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su profili, di invalidità ed
inoperatività della fideiussione, da essi prestata. E ciò a prescindere dalla
considerazione che, eccependo comunque anche l’inesistenza di valida prova
del credito contro di loro azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in
radice lo stesso debito principale.
4. Può ora passarsi all’esame della questione di massima di cui retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall’articolo 1283 del Cc
(Anatocismo) e, in particolare, dall’inciso “salvo usi contrari” che, in apertura
della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata,
per cui «gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla
domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi».
4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate
sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in
consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente
(6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95;
3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio - reiteratamente, poi,
confermato dalle successive sentenze 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498,
225
8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato
riscontro anche il legislatore (che, con l’articolo 25 del D.Lgs 342/99 ha,
all’uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra
banca e cliente) – (principio) per cui gli “usi contrari”, idonei ex articolo 1283
Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi “normativi” in senso
tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie
anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed
incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico,
rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad
avvalorare il “revirement” giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle
pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico essenziale l’enunciazione
del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la
conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa
maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli “usi contrari”,
suscettibili di derogare al precetto dell’articolo 1283 Cc, sono non i meri usi
negoziali di cui all’articolo 1340 Cc ma esclusivamente i veri e propri “usi
normativi”, di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione
generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento
(usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non
dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in
quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte
dell’ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che «dalla
comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati
all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a
norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero
esistenti nell’ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli
istituti di credito, in conformità con le direttive dell’associazione di categoria,
insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al
tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un
precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l’opinio juris ac necessitatis,
se non altro per l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa
introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente».
4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura portante del nuovo
indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la banca ricorrente mette in
discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la
contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo
profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla
rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione
trimestrale degli interessi bancari. Si sostiene, infatti, in contrario che la
giurisprudenza del ‘99 abbia correttamente accertato l’inesistenza attuale, ma
erroneamente escluso l’esistenza pregressa della consuetudine in parola.
E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di constatare
che «la convinzione degli utenti del servizio bancario della normatività dell’uso
di capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è
venuta meno dopo lungo tempo» [id est: la consuetudine si è estinta per
226
desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento
sottostante] «proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di
prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio
precedente orientamento».
Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argomenta: a) che
l’opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente
sarebbe stata esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un
quadro normativo, come evolutosi a partire dai primi anni ‘90, non certo
retrodatabile all’epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso, quella prassi
si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi bancari, che ne
avrebbero pienamente presupposto la normatività; b) che, comunque, la
stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente
ritenuto, ove pur erroneamente, l’esistenza di un uso normativo di
capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito
“elemento di fondazione o consolidazione dell’uso stesso”. Nessuno dei riferiti,
pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere.
4.5. L’evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla
legislazione degli anni ‘90, in direzione della valorizzazione della buona fede
come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del
consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina
dell’usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del
cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale)
relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzzione trimestrale
degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile
sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della
controparte più debole.
Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in
precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla
base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più
semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non
negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in
conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla
parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva. quindi,
altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del
prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di
inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso
negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il
precetto dell’articolo 1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del
1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile che la “fondazione” di un uso normativo,
relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche
modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al
revirement del 1999. Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo
a norme di condotta poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta
dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra
che quella ricognitiva, dell’esistenza e dell’effettiva portata, e non dunque
anche una funzione creativa, della regola stessa.
227
Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa
che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri
poi però erronea nel presupporre l’esistenza di una regola in realtà
insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter
retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una
regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente
presupponendola, l’avrebbero con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo alla
giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tralaticie pronunzie nell’arco
di un ventennio) su cui fa leva l’istituto ricorrente. La quale - a prescindere
dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare
nei clienti una “opinio iuris” del meccanismo di capitalizzazione degli interessi,
inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli stipulati con la
banca - non avrebbe potuto, comunque, conferire normatività ad una prassi
negoziale (che si è dimostrato essere) contra legem.
4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell’accertamento di nullità delle
clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato
subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale - nell’intento di
evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già citato D.Lgs 342/99, una
norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di
capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati
anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della
materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25.
Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale,
per eccesso di delega e conseguente violazione dell’articolo 77 Costituzione,
dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000.
L’eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione
degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi
che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme
anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse
non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione
dell’articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).
4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola anatocistica inserita nel
contratto da cui deriva il credito azionato in via monitoria dall’istituto, la
sentenza impugnata resiste dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal
Credito ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di violazione degli articoli 1367 Cc e 10 legge
154/92 - con la quale si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente
escluso che per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla legge 154 cit. il
tetto massimo di garanzia, che ne condiziona l’ulteriore validità, possa essere
anche “unilateralmente” fissato dalla Banca, come nella specie, l’istituto in
concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 - si scontra contro l’accertamento
in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto alla riferibilità di quella missiva a
fideiussione diversa da quelle azionate nel presente giudizio. Dal che
propriamente l’inammissibilità della censura in esame per difetto di interesse.
228
5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza d’appello secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l’accertamento del credito
azionato nei confronti dei fideiussori “per non avere l’istituto assolto
pienamente al suo onere probatorio” - si sottrae al sindacato di legittimità,
come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua attinenza all’area delle
valutazioni, relative alle risultanze probatorie, riservate alla discrezionalità di
giudizio del giudice del merito. Né l’istituto ricorrente può fondatamente
sostenere che la rilevazione di ufficio, solo in fase di appello, della questione di
nullità della capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività
difensiva. Poiché la Corte territoriale - al fine di accertare quanto
effettivamente dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) - ha
disposto apposita Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l’istituto ha avuto
evidentemente modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non
ha fatto in modo compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con
l’odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti di
questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
229
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA 4 FEBBRAIO 2005, N. 2207
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2002 Mario Ricciarelli conveniva
davanti al Giudice di pace di Avellino la S.p.a. Unipol Assicurazioni per sentirla
condannare al pagamento della somme corrispondenti al 20% di quanto da lui
versato a titolo di premio relativamente alla polizza assicurativa r.c.a.
30/728795339, per il periodo settembre 1998-settembre 1999. Chiedeva in
subordine che fosse il giudice adito a determinare in via equitativa quanto a lui
spettante. Sosteneva che tale somma, comunque determinata, gli era dovuta
giacché la polizza suddetta era stata stipulata secondo le condizioni
determinate dal cartello delle società assicuratrici, il cui effetto era stato di
maggiorare i prezzi in modo uniforme per tutto il mercato nazionale, in
violazione della l. 287/1990, dei principi di correttezza e buona fede e con
pregiudizio di essa particolare, più debole in quanto obbligata a contrarre.
Deduceva che l'autorità garante della concorrenza e del mercato aveva inflitto
alla Unipol, per violazione del divieto di cui all'art. 2 della predetta legge
antitrust, il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di lire
33.050.995.445.
La convenuta resisteva ed oltre a contestare il fondamento della pretesa,
eccepiva l'incompetenza del giudice per esservi la competenza della Corte
d'appello, ai sensi dell'art. 33 della l. 287/1990. Deduceva anche il
incompetenza
per
territorio
dello
stesso
Giudice
di
pace.
Il giudice di primo grado riteneva la propria competenza sotto ogni profilo,
quindi accoglieva la domanda condannando la Unipol al pagamento in favore
dell'attore della somma di lire 151.684, pari ad euro 78,34, indebitamente
riscossa
quale
effetto
dell'intesa,
vietata
dalla
legge.
La sentenza in esame prendeva atto della notorietà della questione, che aveva
sollevato scalpore sia in Italia che all'estero, ed altresì del provvedimento
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva inflitto alla
Unipol la sanzione innanzi menzionata. Dava atto che a tale decisione l'Agcm
era pervenuta a seguito di una compiuta istruttoria, il cui risultato era stato
l'accertamento dell'avvenuto scambio di informazioni tra le imprese del ramo,
che aveva dato a sua volta luogo ad un comportamento delle stesse del tutto
omogeneo e tale pertanto da impedire al contraente di individuare un
230
assicuratore che, praticando effettiva concorrenza, offrisse prezzi migliori di
quello
nella
specie
pagato.
Sulla base di tale premessa la sentenza impugnata spiegava anche il più alto
livello
dei
prezzi
di
tali
polizze
rispetto
alla
media
europea.
Quindi, quanto alla questione della competenza, riteneva che ai sensi dell'art.
33 della legge Antitrust la domanda di risarcimento del danno che fonda la
competenza della Corte d'appello consegue al pregiudizio che hanno subito gli
imprenditori terzi rispetto al cartello o alla posizione dominante, ovvero gli
imprenditori in concorrenza con quegli imprenditori che vi hanno aderito, e che
risultano a tal titolo vittime dell'intesa o della posizione dominante. La predetta
azione pertanto non riguarda i soggetti oltre che terzi rispetto alla intesa i
anche non concorrenti dei partecipi alla stessa, e dunque non riguarda le
domande avanzate da soggetti non imprenditori, ancorché anch'essi subiscano
il
cartello
o
il
dominio.
Riteneva che il giudice al quale siffatte domande provenienti da soggetti diversi
dagli imprenditori vanno rivolte deve essere individuato alla stregua dei criteri
di cui all'art. 1469-bis n. 18 e nella specie, trattandosi di domanda di
ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Ciò perché la
sanzione di nullità dell'autorità antitrust colpisce il cartello e non colpisce i
contratti che, successivamente al cartello, vengono conclusi con i singoli
automobilisti. Costoro, secondo il Giudice di pace, si trovano nella situazione di
pagare più di quanto una contrattazione che non fosse derivata dal cartello
avrebbe implicato. Infine il Giudice di pace riteneva di far uso del potere di
determinare secondo equità, atteso il valore della causa in riferimento all'art.
113
c.p.c.,
la
somma
spettante
al
Ricciarelli.
Contro questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione la Unipol, affidato
a
cinque
motivi.
Ha
resistito
il
Ricciarelli
con
controricorso.
La causa, assegnata alla terza Sezione civile della corte di Cassazione, è stata
rimessa al primo presidente con ordinanza 15538/2003. In essa il collegio,
preso atto di un indirizzo della Corte Suprema (Cassazione 17475/2002)
secondo il quale i consumatori ovvero i soggetti non imprenditori e pertanto
terzi rispetto alla intesa, non sono legittimati ad esperire l'azione di nullità della
stessa di cui all'art. 33 della l. 287/1990, ha ipotizzato l'opportunità di
rimettere la questione della legittimazione ad agire e dunque della competenza
della Corte d'appello in unico grado, per la sua particolare importanza, alle
Sezione
unite.
Con provvedimento del primo Presidente la causa è stata rimessa alla odierna
udienza di queste Sezioni unite. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
231
1. Con il primo motivo di ricorso la Unipol deduce la violazione dell'art. 33,
comma 2, della l. 287/1990 e dell'art. 2033 c.c. nonché la motivazione
omessa, illogica ed insufficiente sul punto del rigetto della sua eccezione di
incompetenza per materia del giudice adito. Sostiene che il primo giudice ha
errato nel ritenere che legittimati alla azione prevista dalla legge Antitrust
possano essere solo gli imprenditori esclusi dal cartello e pertanto da questo
danneggiati, ed ha errato ancora nel qualificare l'azione in parola come
restitutoria e dunque estranea alla previsione di cui all'art. 33 della legge
antitrust. Sostiene infatti che la legge ha attribuito alla Corte d'appello in unico
grado di merito una competenza, ratione materiae, che prescinde dai soggetti
che esercitano il relativo diritto. Deduce pure che siffatto criterio di
competenza non può essere eluso attraverso la qualificazione della domanda
come restitutoria anziché risarcitoria, giacché anche la restituzione del
cosiddetto sovrapprezzo seguirebbe ad una nullità, almeno derivata, del
contratto concluso tra la società assicuratrice ed il cliente automobilista, e
l'accertamento
di
tale
nullità
è
devoluto
alla
Corte
d'Appello.
1.a. Osserva il collegio che le due questioni proposte, quella relativa alla
legittimazione ad agire e quella relativa alla posizione giuridica dei contratti
conclusi tra impresa assicuratrice e cliente "a valle" dell'accordo illecito tra gli
imprenditori, costituiscono aspetti del medesimo problema. Ciò in quanto la
posizione giuridica del terzo, estraneo all'intesa, che afferma di averne subito
gli effetti ne determina la legittimazione ad agire. Tali questioni vanno trattate,
pertanto, con una visione complessiva della materia che, movendo da una
corretta nozione di intesa, consenta di definire la posizione di quegli che non vi
ha
partecipato.
1.b. La l. 287/1990, come è noto, rappresentò una novità nel panorama
nazionale che, pur della vigenza del Trattato Ce e dunque anche dei principi
desumibili dagli artt. 85 (oggi 81) e ss., era tuttavia imperniato sulla logica
codicistica della concorrenza sleale, e dunque sulla tutela dell'imprenditore
dalla attività scorretta del concorrente. Infatti benché anche la tutela suddetta
si sia evoluta nella interpretazione della dottrina e dei giudici facendo si che si
attenuasse fortemente l'originaria impronta deontologica e corporativa e si
prendesse atto della nozione costituzionale del mercato come luogo della
libertà di impresa che attribuisce un rilievo pubblico anche al conflitto
interindividuale (Cassazione 11859/1997), essa conserva il carattere
fondamentale di strumento dì tutela del corretto rapporto di concorrenza.
La sussistenza di siffatto rapporto tra le parti che controvertono innanzi al
giudice è il presupposto della sua operatività e mantiene pertanto la
dimensione essenzialmente interindividuale dei conflitti. La normativa che
difende l'imprenditore dalla concorrenza sleale, dunque, ancorché la si possa
ritenere consapevole della dimensione necessariamente concorrenziale del
mercato, provvede pur sempre alla riparazione dello squilibrio che ad uno
specifico rapporto di concorrenza viene cagionato dalla scorrettezza di un
concorrente.
232
La novità del Trattato CE è stata l'introduzione della tutela della struttura e
della logica competitiva del mercato. Questo in quanto luogo nel quale si
esplicita la pretesa di autoaffermazione economica della persona attraverso
l'esercizio della impresa, è perciò stesso luogo della competizione, cosicché
ogni comportamento di mercato che riduce tale competitività perché
diminuisce la possibilità per chiunque di esercitare liberamente la propria
pretesa
di
autoaffermazione,
è
illecito.
In particolare, poiché l'esercizio della concorrenza presuppone l'autonomia
delle imprese concorrenti nell'esercizio delle rispettive scelte di mercato, è
illecito ogni fatto che porta a ridurre questa autonomia, assimilando o
avvicinando i comportamenti di mercato all'esecuzione di accordi antecedenti
ovvero comunque conformandoli oggettivamente ad un certo grado di
collaborazione
che
sostituisce
o
riduce
la
competizione.
1.c.
Detta
affermazione
merita
qualche
ulteriore
considerazione.
L'art. 2 della legge antitrust chiarisce che "sono considerati intese" una serie di
comportamenti, come gli accordi, le pratiche concordate ed addirittura le
deliberazioni di consorzi ed associazioni di imprese. Essi sono vietati se hanno
"per oggetto o per effetto dì ridurre o falsare in modo consistente il gioco della
concorrenza...". Pertanto se al di là della loro veste giuridico formale, tali
attività in realtà mirano ad eliminare ovvero addirittura eliminano o riducono la
autonomia di mercato dei soggetti che le compiono, esse integrano l'illecito di
cui si tratta. La norma si conclude, al n. 3, con la perentoria statuizione: "le
intese
vietate
sono
nulle
ad
ogni
effetto".
L'elencazione del n. 2 dell'art. 2 in parola, considerata esemplificativa,
sorregge la lettura della norma innanzi anticipata giacché consente
all'interprete di delineare i tipi dei comportamenti anticompetitivi. Le fattispecie
elencate, e cioè la fissazione diretta o indiretta dei prezzi di acquisto o di
vendita ovvero di altre condizioni contrattuali, l'impedimento e la limitazione
della produzione o dello sbocco o dell'accesso al mercato, l'impedimento degli
investimenti e dello sviluppo tecnico delle imprese, tutte le forme di
ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento, l'applicazione di
condizioni ingiustificatamente diverse a categorie di imprenditori omogenee,
l'imposizione nei contratti con i concorrenti di prestazioni prive di relazione con
la natura del rapporto, sono classici comportamenti anticompetitivi. La loro
funzione è di sostituire all'esercizio individuale e perciò stesso libero del potere
di impresa, un potere esercitato collettivamente estraneo alle forme societarie
nelle quali si esercita l'impresa collettiva ed esente dai controlli che la legge in
proposito prevede. Tali pratiche rafforzano la posizione dei loro autori
riducendo l'efficacia della concorrenza da parte degli esclusi ed eliminando
quella
tra
i
partecipi.
1.d. Va osservato ancora che la l. 287/1990, la quale ai sensi della prima parte
dell'art. 1 deve essere letta come attuazione dell'art. 41 Cost., deve peraltro
essere interpretata in base ai principi dell'ordinamento comunitario. Pertanto in
233
armonia con la norma del Trattato (vedi quanto alla cosiddetta regola de
minimis nel diritto comunitario della concorrenza causa Sirena n. 40/70,
sentenza 18 febbraio 1971, e causa Volk n. 5/69, sentenza 9 luglio 1969) essa
fa rilevare una dimensione quantitativa della intesa traducendola in carattere
della stessa. La legge vieta le intese che abbiano per effetto o per oggetto di
impedire, restringere o falsare "in maniera consistente" il gioco della
concorrenza "all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante".
La norma ripete quasi letteralmente il tenore dell'art. 81 del Trattato, salvo che
per la norma comunitaria la rilevanza quantitativa è data ovviamente
dall'ambito comunitario. Ma ciò che conta rispetto al problema che ne occupa è
il rilievo dimensionale della fattispecie, che si spiega con il fatto che oggetto
della tutela della l. 287/1990, come già del Trattato, è appunto la struttura
concorrenziale del mercato di riferimento, la quale ragionevolmente non viene
messa in discussione da un comportamento che per quanto ontologicamente
rispondente alla fattispecie di cui si tratta, per la sua dimensione, non incide
significativamente
sull'assetto
che
trova.
In definitiva, poiché, come è stato scritto argutamente, la legge non si occupa
dell'intesa tra i barbieri di piccolo paese, il dato quantitativo conferma che
oggetto immediato della tutela della legge non è il pregiudizio del concorrente
ancorché questo possa essere riparato dalla repressione della intesa (cfr.
quanto al pregiudizio al commercio comunitario, presupposto di applicabilità
dell'art. 81, causa Grundig 58/64, sentenza 13 luglio 1966, e causa
Montecatini, C 235/92, sentenza 8 luglio 1999, ex multis), bensì un più
generale
bene
giuridico.
Tuttavia tale più ampia tutela accordata dalla legge nazionale antitrust, in
armonia con il Trattato, non ignora la plurioffensività possibile del
comportamento di vietato (cfr. Cassazione 827/1999). Un'intesa vietata può
ledere anche il patrimonio del singolo, concorrente o meno dell'autore o degli
autori della intesa. Ciò spiega che la l. 287/1990 all'art. 33, che contiene tanto
una norma di giurisdizione, quanto una norma di competenza, si preoccupi con
quest'ultima di individuare anche il giudice dell'accertamento della nullità, che
è il presupposto della eliminazione del pregiudizio in una prospettiva
esplicitamente
risarcitoria.
La legge infatti mentre affida al Giudice amministrativo (TAR del Lazio) la
giurisdizione sulle impugnative avverso le deliberazioni della Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, stabilisce pure che "Le azioni di nullità e di
risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di
urgenza in relazione alla violazione, delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV
sono promossi davanti alla Corte d'appello competente per territorio".
Alla Corte d'appello, dunque, deve rivolgersi chi allega il comportamento di
mercato tenuto da un imprenditore tale da ledere la struttura concorrenziale
del medesimo, e dunque ne chieda la dichiarazione di nullità presupposto
dell'eventuale
risarcimento
(Cassazione
827/1999).
234
1.e. Va appena osservato che siffatta struttura della giurisdizione che
comunque risale alla repressione della intesa appare datata, perché influenzata
dalla impostazione che al momento, in cui la legge venne emanata era
dominante. La previsione, che risale alla concezione del doppio binario di tutela
di cui alla legge sul contenzioso amministrativo del 1865, n. 2248, artt. 4 e 5,
non a caso appare coerente con quella contenuta nella legge comunitaria
142/1992 che, all'art. 13, regolando la tutela giurisdizionale conseguente alla
violazione delle normativa comunitarie in materia di appalti pubblici, stabiliva
che il risarcimento del danno poteva essere domandato al Giudice ordinario da
parte di quegli che avesse ottenuto dal Giudice amministrativo l'annullamento
dell'atto
amministrativo.
Detta norma è stata abrogata dall'art. 35 u.c. del d.lgs. 80/1998 abrogazione
confermata dall'art. 7, lett. c), della l. 205/2000), ma soprattutto l'assetto
della giurisdizione ancora riconoscibile agli inizi degli anni novanta, è stato
superato dalla legge e dalla giurisprudenza del giudice delle leggi (Corte
Costituzionale 204/2000 e 281/2004). Ciò contribuisce a spiegare come,
attribuendo al Giudice amministrativo la giurisdizione sull'atto di Agcm e
dunque nell'ambito di questa il potere di dire se l'intesa affermata si è
realizzata, la legge antitrust 287/2000 abbia voluto accorciare il giudizio di
merito introdotto da una domanda di nullità e di conseguente risarcimento del
danno stabilendo un unico grado innanzi alla Corte d'appello competente per
territorio. Cosicché anche quegli che non ha partecipato al giudizio innanzi al
TAR, perché non ha resistito alla impugnativa della sanzione irrogata da Agcm,
proposta dall'affermato autore della intesa, o non vi ha potuto partecipare
perché in quella sede era carente di interesse, si trova a perdere un grado di
giudizio allorché si rivolge al Giudice ordinario. Situazione processuale che non
trova ostacoli di carattere costituzionale (art. 125 Cost.), e che comunque
appare coerente con l'esigenza di favorire la sollecita soluzione di controversie
che
attengono
all'assetto
del
mercato.
1.f. Sembra a questo punto al collegio di potere esprimere talune conclusioni,
utili
alla
soluzione
dei
quesiti
ad
esso
sottoposti.
La diversità di ambito e di funzione tra la tutela codicistica dalla concorrenza
sleale e quella innanzi detta della legge antitrust esclude si possa negare la
legittimazione alla azione davanti al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 33, n. 2,
della l. 287/1990, al consumatore, terzo estraneo alla intesa. Contrariamente a
quanto ritenuto da Cassazione 17475/2002, la legge antitrust non è la legge
degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di
chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del
suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio
conseguente
alla
rottura
o
alla
diminuzione
di
tale
carattere.
Pare opportuno notare peraltro che mentre siffatta esclusione della
legittimazione in parola non è prevista espressamente dalla legge, questa
peraltro, all'art. 4, laddove prevede il potere discrezionale della Agcm di
235
autorizzare un' intesa che possiede i caratteri che giustificherebbero il divieto,
indica tra i presupposti della discrezionalità che fonda "il beneficio del
consumatore". La legge dunque non ignora, nella materia della intesa,
l'interesse del consumatore al punto da prevedere una ipotesi in cui esso,alla
cui tutela la ideologia antitrust è funzionale, può essere tutelato per un
"periodo limitato" addirittura da un allentamento del divieto del più classico
comportamento
anticoncorrenziale.
Il consumatore, che è l'acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude
la filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto la funzione illecita di
una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta
effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che
sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto strumento non si
può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a
strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà
anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile.
Va detto pure, atteso il rilievo interpretativo dei principi dell'ordinamento
comunitario nella materia, che la sentenza della Corte di Giustizia, Courage,
(453/1999) tende ad ampliare l'ambito dei soggetti tutelati dalla normativa
sulla concorrenza, in una prospettiva, sembra al collegio, che valorizza proprio
le azioni risarcitorie, quali mezzi capaci di mantenere effettività alla struttura
competitiva
del
mercato.
1.g. E' appena il caso di precisare dal momento che la sentenza impugnata
sembra sovrapporre le due figure che quanto fin qui espresso non è
contraddetto dalla considerazione dell'abuso di posizione dominante, che è
fattispecie diversa da quella che rileva nella controversia e che dunque non
viene
in
esame.
1.h. Nella delineata prospettiva dunque il contratto cosiddetto "a valle"
costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso in
realtà,
oltre
ad
estrinsecarla,
la
attua.
E' ben vero, come si fa rilevare in atti, che la legge vieta anche le intese che
abbiano anche solo per "oggetto" la distorsione di cui si tratta, oltre che per
"effetto", ma ciò si spiega in considerazione del doppio livello di intervento che
essa prevede, quello amministrativo della Agcm e quello riparatorio di cui alla
azione di nullità e risarcimento. L'autorità garante è organo di
amministrazione, ancorché caratterizzato da ampiezza di poteri sui generis.
Essa opera anche in vista dì un pericolo, e dunque in considerazione della
esigenza economica di prevenire l'effetto distorsivo del fenomeno di mercato. Il
giudice, che dirime controversie e non si occupa di fenomeni, può essere
officiato solo in presenza o in vista almeno di un pregiudizio. Dunque innanzi
alla Corte d'appello deve essere allegata un'intesa di cui si chiede la
dichiarazione di nullità, ed altresì il suo effetto pregiudizievole, il quale
rappresenta l'interesse ad agire dell'attore secondo i principi del processo, da
togliere
attraverso
il
risarcimento.
236
Il contratto cosiddetto "a valle", ovvero il prodotto offerto al mercato, del quale
si allega, come nel caso di specie, la omologazione agli altri consimili prodotti
offerti nello stesso mercato, è tale da eludere la possibilità di scelta da
particolare del consumatore. La realizzazione consapevole di siffatta situazione
rientra in modo strutturale nel comportamento oggettivo di mercato che
giustifica la azione individuale di cui all'art. 33. Pertanto la previsione del
risarcimento del danno sarebbe meramente retorica se si dovesse ignorare,
considerandolo
circostanza
negoziale
distinta
dalla
"cospirazione
anticompetitiva" e come tale estranea al carattere illecito di questa, proprio lo
strumento attraverso il quale i partecipi alla intesa realizzano il vantaggio che
la legge intende inibire. Se un'intesa fosse ancora luogo nelle intenzioni dei
partecipi e non avesse dato ancora ad alcun effetto, mentre vi sarebbe spazio,
a parte la difficoltà dell'indagine, per la proibizione e la sanzione da parte di
Agcm, giacché la legge, giova rammentare, vieta gli accordi che abbiano per
oggetto oltre che per effetto la distorsione della concorrenza, non vi sarebbe
interesse da parte di alcuno ad una dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 33
della l. 287/1990, la cui ratio è di togliere alla volontà anticoncorrenziale "a
monte" ogni funzione di copertura formale dei comportamenti "a valle". E
dunque di impedire il conseguimento del frutto della intesa consentendo anche
nella
prospettiva
risarcitoria
la
eliminazione
dei
suoi
affetti.
1.i. Non conduce a conclusione diversa nemmeno la considerazione della
fattispecie
restitutoria
di
cui
all'art.
2033
c.c.
Come è noto essa si distingue dalla fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043
c.c. per l'assenza di qualunque profilo di colpa o dolo nell'accipiens (Cassazione
3060/1984). Orbene, una parte che chiede dichiararsi la nullità di una intesa,
allega un fatto illecito nella cui struttura vi è l'elemento psicologico del dolo o
della colpa. Pertanto, quale che sia la forma della domanda di ripristino della
situazione patrimoniale che si assume lesa, essa prescinde dalla fattispecie di
indebito oggettivo. Quegli che chiede la restituzione di ciò che ritiene di avere
pagato in esecuzione di un negozio concluso per effetto della intesa nulla,
allega pur sempre quest'ultima e l'impossibilità giuridica che essa produca
effetti.
Ritiene pertanto la Corte, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti
dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente il danno ingiusto ex
art. 2043 c.c. (Sezioni unite, 500/1999) che colui che subisce danno da una
contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a
monte, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori
della collusione, ha a propria disposizione, l'azione di cui all'art. 33 della l.
287/1990.
Cosicché, pare utile precisare conclusivamente, a qualificare la domanda ed a
determinare la competenza nel caso che ne occupa è la richiesta di
accertamento di una intesa e quindi di dichiararla nulla presupposto della
domanda di eliminarne gli effetti anche attraverso l'eliminazione del
237
sovrapprezzo.
Pertanto, poiché le sentenze del Giudice di pace ancorché emesse secondo
equità sono soggette al rispetto delle norme di rito tra le quali quelle che
attengono alla competenza del giudice (Cassazione 10486/2001 ex multis) e
dei principi informatori della materia (Cassazione 743/2005) quali nella specie
quelli che definiscono l'intesa vietata e la sua struttura e rispetto a questa, le
posizioni dei terzi, il motivo esaminato è fondato. Pertanto, la competenza a
conoscere della causa, è della Corte d'appello di Napoli, come peraltro, sia pure
in subordine, chiede la stessa ricorrente. Ciò in quanto il privato ha adito il
Giudice di pace di Avellino ai sensi degli art. 19 e 20 c.p.c., come pure afferma
la ricorrente, ovvero invocando i fori alternativi da esse norme previsti.
2. La trattazione del secondo motivo mediante il quale Unipol lamenta la
violazione degli artt. 320, 183, 184 c.p.c., è assorbita dall'accoglimento del
primo motivo giacché la questione è rimessa al giudizio davanti al giudice
dichiarato
competente.
3. La trattazione del terzo motivo mediante il quale viene allegata la violazione
dell'art. 1469-bis c.c., relativamente alla ritenuta competenza del foro del
consumatore nonché quella del quarto e del quinto motivo mediante i quali la
parte ricorrente allega la violazione degli artt. 2033, 1322, 1372 c.c., la
inadeguatezza della motivazione sui relativi punti, la violazione dell'art. 113 e
115 c.p.c. ed ancora dell'art. 2033 c.c., sono parimenti assorbite.
4. Va pertanto accolto il ricorso e va dichiarata la competenza della Corte
d'appello di Napoli. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le
parti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, Sezioni unite Civili, accoglie il primo motivo del ricorso,
dichiara assorbita trattazione dei restanti motivi, e dichiara la competenza della
Corte d'appello di Napoli. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
238
239