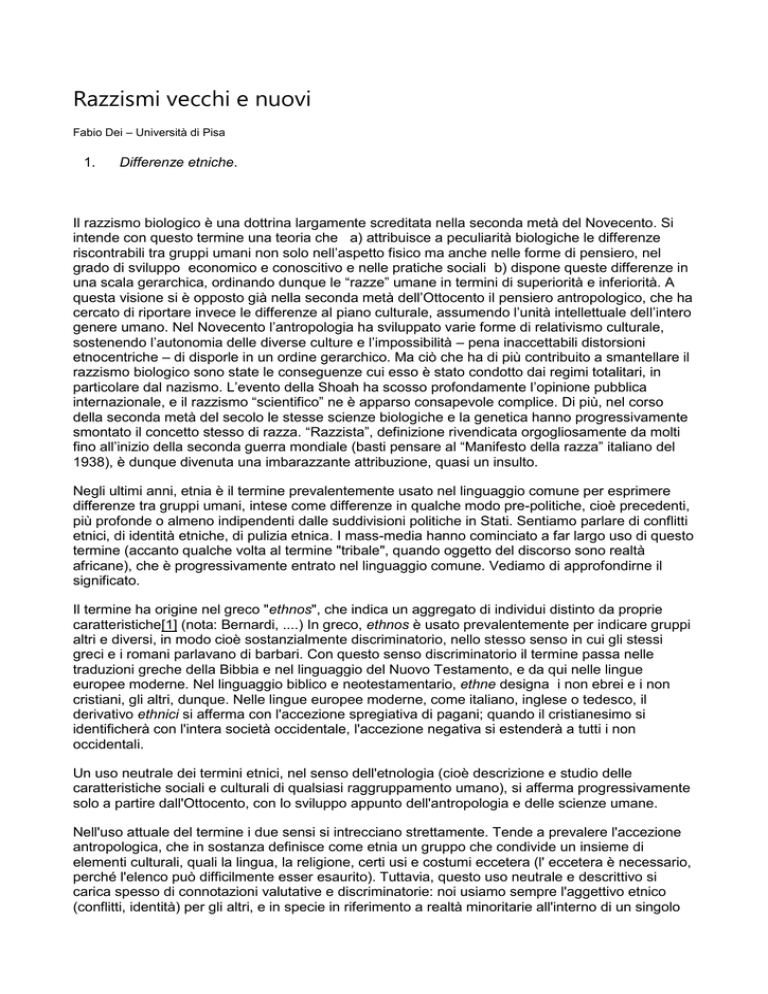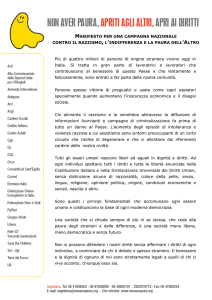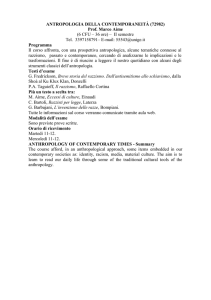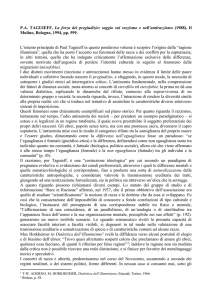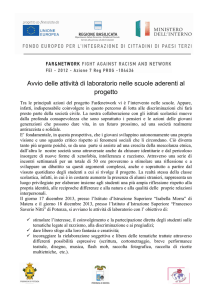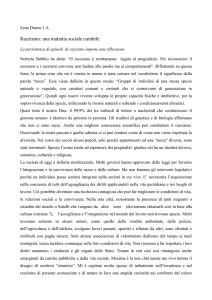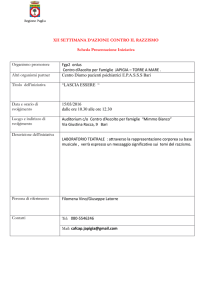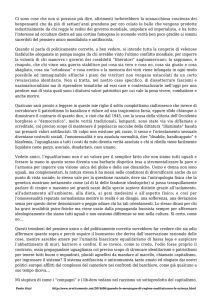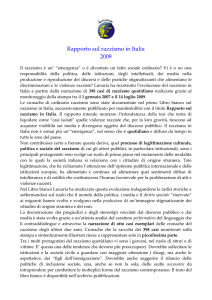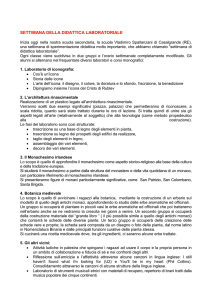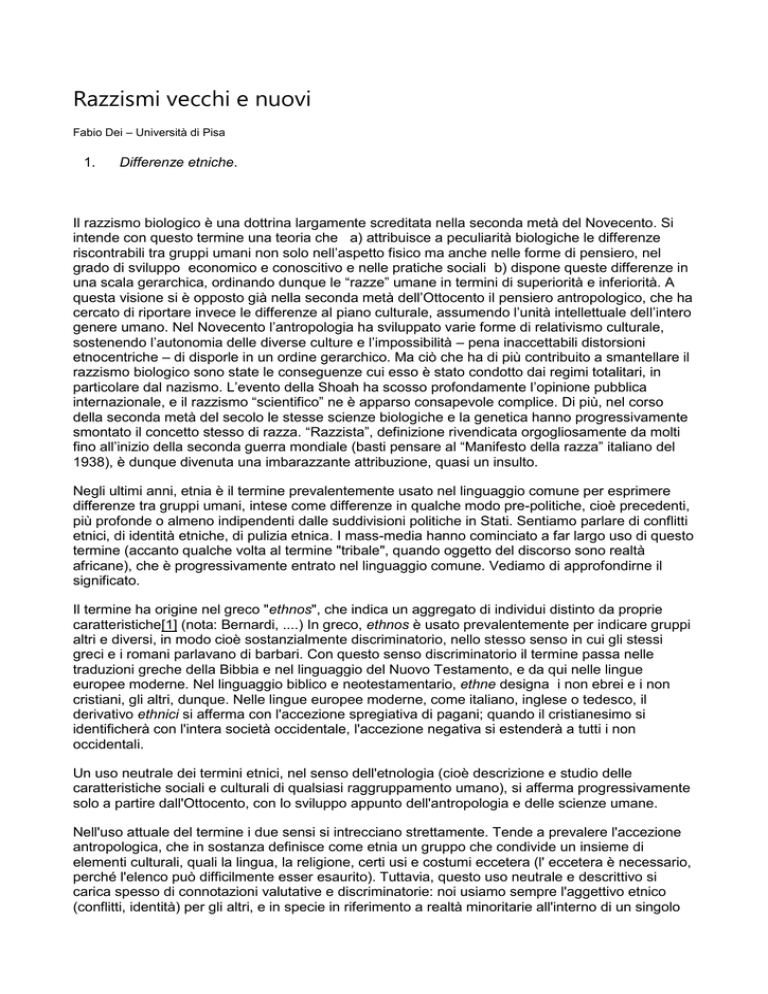
Razzismi vecchi e nuovi
Fabio Dei – Università di Pisa
1.
Differenze etniche.
Il razzismo biologico è una dottrina largamente screditata nella seconda metà del Novecento. Si
intende con questo termine una teoria che a) attribuisce a peculiarità biologiche le differenze
riscontrabili tra gruppi umani non solo nell’aspetto fisico ma anche nelle forme di pensiero, nel
grado di sviluppo economico e conoscitivo e nelle pratiche sociali b) dispone queste differenze in
una scala gerarchica, ordinando dunque le “razze” umane in termini di superiorità e inferiorità. A
questa visione si è opposto già nella seconda metà dell’Ottocento il pensiero antropologico, che ha
cercato di riportare invece le differenze al piano culturale, assumendo l’unità intellettuale dell’intero
genere umano. Nel Novecento l’antropologia ha sviluppato varie forme di relativismo culturale,
sostenendo l’autonomia delle diverse culture e l’impossibilità – pena inaccettabili distorsioni
etnocentriche – di disporle in un ordine gerarchico. Ma ciò che ha di più contribuito a smantellare il
razzismo biologico sono state le conseguenze cui esso è stato condotto dai regimi totalitari, in
particolare dal nazismo. L’evento della Shoah ha scosso profondamente l’opinione pubblica
internazionale, e il razzismo “scientifico” ne è apparso consapevole complice. Di più, nel corso
della seconda metà del secolo le stesse scienze biologiche e la genetica hanno progressivamente
smontato il concetto stesso di razza. “Razzista”, definizione rivendicata orgogliosamente da molti
fino all’inizio della seconda guerra mondiale (basti pensare al “Manifesto della razza” italiano del
1938), è dunque divenuta una imbarazzante attribuzione, quasi un insulto.
Negli ultimi anni, etnia è il termine prevalentemente usato nel linguaggio comune per esprimere
differenze tra gruppi umani, intese come differenze in qualche modo pre-politiche, cioè precedenti,
più profonde o almeno indipendenti dalle suddivisioni politiche in Stati. Sentiamo parlare di conflitti
etnici, di identità etniche, di pulizia etnica. I mass-media hanno cominciato a far largo uso di questo
termine (accanto qualche volta al termine "tribale", quando oggetto del discorso sono realtà
africane), che è progressivamente entrato nel linguaggio comune. Vediamo di approfondirne il
significato.
Il termine ha origine nel greco "ethnos", che indica un aggregato di individui distinto da proprie
caratteristiche[1] (nota: Bernardi, ....) In greco, ethnos è usato prevalentemente per indicare gruppi
altri e diversi, in modo cioè sostanzialmente discriminatorio, nello stesso senso in cui gli stessi
greci e i romani parlavano di barbari. Con questo senso discriminatorio il termine passa nelle
traduzioni greche della Bibbia e nel linguaggio del Nuovo Testamento, e da qui nelle lingue
europee moderne. Nel linguaggio biblico e neotestamentario, ethne designa i non ebrei e i non
cristiani, gli altri, dunque. Nelle lingue europee moderne, come italiano, inglese o tedesco, il
derivativo ethnici si afferma con l'accezione spregiativa di pagani; quando il cristianesimo si
identificherà con l'intera società occidentale, l'accezione negativa si estenderà a tutti i non
occidentali.
Un uso neutrale dei termini etnici, nel senso dell'etnologia (cioè descrizione e studio delle
caratteristiche sociali e culturali di qualsiasi raggruppamento umano), si afferma progressivamente
solo a partire dall'Ottocento, con lo sviluppo appunto dell'antropologia e delle scienze umane.
Nell'uso attuale del termine i due sensi si intrecciano strettamente. Tende a prevalere l'accezione
antropologica, che in sostanza definisce come etnia un gruppo che condivide un insieme di
elementi culturali, quali la lingua, la religione, certi usi e costumi eccetera (l' eccetera è necessario,
perché l'elenco può difficilmente esser esaurito). Tuttavia, questo uso neutrale e descrittivo si
carica spesso di connotazioni valutative e discriminatorie: noi usiamo sempre l'aggettivo etnico
(conflitti, identità) per gli altri, e in specie in riferimento a realtà minoritarie all'interno di un singolo
Stato-nazione, o a realtà che storicamente si collocano al di fuori di chiare identità nazionali e
statali. Noi non siamo mai "etnici", e non lo è mai la grande cultura, quella dominante. Etnici sono
gli altri, i più arretrati o i più poveri, le minoranze.
Ora, il rischio principale che corrono le nozioni di etnico e di etnia, come del resto la nozione di
cultura, nel loro passare dal linguaggio specialistico delle discipline sociali al linguaggio politico e al
senso comune, è la reificazione. L'aggettivo etnico, e ancor più il sostantivo etnia, tendono a esser
letti secondo il modello delle cartine politiche degli atlanti: colori diversi punteggiano un mondo
suddiviso in entità compatte e autonome, dalla consistenza quasi naturale, esclusive e distintive.
Come si può appartenere a uno e ad un solo Stato, così si appartiene a una sola etnia-cultura. Più
che come un processo costantemente in divenire, l'appartenenza culturale ed etnica è intesa come
proprietà immutabile di un gruppo umano e di tutti gli individui che ne fanno parte.
Di questa tendenza alla essenzializzazione o reificazione, peraltro, l'antropologia non è affatto
innocente. Per una serie di ragioni, che sono al contempo epistemologiche, di metodo, teoriche e
ideologiche), essa ha fornito un'immagine eccessivamente statica, compatta e "divisionista" delle
culture, e di conseguenza delle etnie. Si potrebbe dire, con un paradosso, che l'antropologia ha
naturalizzato le culture, ci ha abituato a pensarle come cose che esistono prima e
indipendentemente dai processi storici, da un lato, e dall'altro dagli individui che ne fanno parte, i
quali sarebbero quasi imprigionati al loro interno. I paradigmi che l'antropologia classica ha fornito
per pensare la diversità culturale sono quelli dell'isola, della riserva indiana, del deserto, del
villaggio isolato nella giungla; tutti modelli che accentuano l'esclusività, la compattezza interna, i
confini netti, la staticità, e nascondono gli elementi di continuo mutamento, di scambio reciproco, di
sincretismo, che caratterizzano invece la vita culturale[2].
Ora, ammesso (e non concesso) che questo modello divisionista fosse adeguato alle realtà
esotiche e "primitive" classicamente studiate dall'antropologia, esso non è certo adeguato alla
realtà attuale di un pianeta dominato da processi di globalizzazione, da flussi comunicativi e di
circolazione di persone, merci e idee senza precedenti. La situazione economica, politica e
culturale di questa fine secolo fa saltare completamente la coerenza del modello classico. Dar
conto delle differenze e delle identità culturali di oggi a partire dalla nozione relativistica di etnieculture originarie e autentiche è implausibile. L'antropologia ha dovuto rivedere in profondità la
propria attrezzatura teoretica e, da alcuni decenni, si è impegnata in un processo di critica o
decostruzione proprio dei concetti di cultura, etnia, identità. Oggi si riconosce comunemente che le
realtà sociali indicate da tali termini non hanno nulla di essenziale o autentico, e sono sempre il
frutto di contingenti processi storici e dinamiche politiche, spesso meno antichi e profondi di quanto
si creda[3].
Nel senso comune e nel linguaggio dei media, tuttavia, l'uso reificato decisamente persiste.
Quando si parla di conflitti etnici, come nel caso della ex-Jugoslavia, o di guerre "tribali", come si
continua a dire per i contesti africani, con termine ancor più equivoco, si presuppone uno scontro
fra realtà etniche chiare e distinte, che preesistono al conflitto attuale e anzi ne sono la causa. Si
assume una essenza etnica più reale e più forte di ogni vicenda politica: un po' come se le
appartenenze etniche fossero lo sfondo immutabile sul quale si articolano le contingenti e mutevoli
faccende della politica. Non si prende abbastanza in considerazione la possibilità che, almeno in
parte, il discorso etnico, i sentimenti di appartenenza, il senso delle differenze siano la
conseguenza e non la causa dei conflitti.
2. Razzismo differenzialista
Ora, la tendenza alla reificazione dei termini etnici e culturali rischia di produrre una nuova
assolutizzazione delle differenze, e finisce per avvicinarne l'uso a quello del vecchio concetto di
razza. In particolare, il rischio è che il discorso etnico-culturale sia usato strumentalmente come
supporto o giustificazione "scientifica" di pratiche di discriminazione che potremmo a pieno titolo
chiamare razziste. Vorrei citare tre esempi di un simile uso strumentale, limitandomi però - per
motivi di spazio oltre che di compentenza - a discutere solo l'ultimo. Il primo esempio riguarda il
caso già ricordato dei conflitti etnici nella penisola balcanica. Qui la propaganda nazionalista quella serba in modo e con forza particolare - ha fatto perno su una presunta irriducibilità
dell'appartenenza etnica, ponendola alla base di rivendicazioni territoriali e di strategie di controllo
politico. Ciò che più colpisce, nel caso della ex-Jugoslavia, è la facilità con cui le istanze identitarie,
in sé per così dire innocenti, sono sfociate in strategie biopolitiche molto vicine a quelle del
nazismo, con la pratica sistematica della deportazione di massa, del massacro, e di quella
peculiare forma di violenza che è il cosiddetto "stupro etnico" [4].
Il secondo esempio, molto meno drammatico ma di altrettanta evidenza nell'ultimo decennio del
Novecento, è quello dei regionalismi. Possiamo considerare il caso del leghismo italiano come
emblematico dell'uso strumentale delle categorie dell'identità etnico-culturale. Un movimento nato
in tempi assai recenti, attorno a rivendicazioni di ordine essenzialmente politico-economico, ha
sentito il bisogno di una legittimazione ideologica che facesse riferimento alle essenze etniche
“irriducibilmente” diverse del Nord e del Sud. Lo ha fatto attraverso grossolane operazioni di
invenzione della tradizione, improvvisando improbabili rituali e richiamandosi a presunte radici
"celtiche": con l'effetto di trasformare una rete di differenze socio-culturali che sono indubbiamente
reali nella immaginosa e antistorica creazione di un'essenza padana[5].
Il terzo esempio, che vorrei brevemente discutere, riguarda certe forme odierne di ideologia e
pratica razzista, in particolare quello che viene comunemente definito neorazzismo differenzialista
o fondamentalismo culturale. Come detto, la vecchia accezione del termine razzismo si può dire
oggi, nella seconda metà del XX secolo, sostanzialmente esaurita, insieme ad alcune sue
conseguenze - come l'orrore per la mescolanza biologica tra le razze e dunque per i matrimoni
misti, l'idea di poter costruire gerarchie di popoli sulla base di caratteristiche biologiche ed
ereditarie. E' oggi impensabile per qualsiasi attore politico - non importa quanto xenofobo o
antisemita - adottare un linguaggio anche lontanamente imparentato a quello hitleriano,
impregnato di metafore sugli ebrei come agenti infestanti, bacilli portatori di contagio e di impurità
che devono essere distrutti per la buona salute della società intesa come un organismo. Ma da
dove vengono allora le idee odierne di pulizia etnica ? Quali basi culturali fondano gli atteggiamenti
discriminatori verso gli immigrati, le politiche xenofobe, il pregiudizio, la discriminazione - fatti
sociali che non sono certo scomparsi insieme al concetto biologico di razza?
Al posto del vecchio razzismo biologico si è affermata una forma di neo-razzismo, o, come alcuni
studiosi lo chiamano, razzismo differenzialista[6]. Questa concezione, paradossalmente, riesce a
volgere a sostegno di pratiche razziste proprio le tradizioni culturali che nel Novecento più si sono
opposte al razzismo - come il discorso culturalista ed etnicista sopra descritto. La nuova destra
xenofoba non parla più di razze e di differenze naturali ma di culture o etnie, per indicare le radici
storiche e culturali che tengono insieme un popolo e lo distinguono da altri. Non si rivendica più la
superiorità di alcuni popoli e culture su altre. Si accetta il principio del relativismo culturale, che
come abbiamo visto è l'esatto opposto dell'etnocentrismo e per certi versi del razzismo: ogni
cultura ha valore in sé, non può esser giudicata sulla base di criteri appartenenti a un'altra cultura:
e tutte le culture del mondo hanno uguale dignità e in linea di principio uguale importanza.
Ma, proprio sulla base di questi principi di apertura e tolleranza, si giunge a riaffermare l'antica
esigenza xenofoba. Proprio per il valore intrinseco di ciascuna cultura; proprio perché la vita di
ognuno di noi, i nostri valori, le nostre convinzioni morali sono radicate in una ben precisa identità
culturale - per tutti questi motivi, le culture e le identità non devono essere confuse e mescolate.
Occorre preservarne l'integrità e l'autenticità di fronte alla confusione, al mescolamento, e anche di
fronte al rischio dell’omologazione che investe il mondo contemporaneo. Questo punto affonda le
radici in alcune formulazioni antropologiche anche di grande prestigio, come quelle di Lévi-Strauss,
che ha sostenuto la necessità di un certo grado di "sordità" reciproca fra le culture; se la diversità
culturale è il bene massimo da preservare per l'umanità, poiché il progresso stesso è consentito
non dalla prevalenza di una cultura su tutte le altre, ma dalla compresenza di molte culture diverse,
allora occorre certo favorire il dialogo e lo scambio, ma anche difendere le rispettive identità e
confini, evitare contaminazioni troppo profonde che facciamo perdere appunto il senso della
diversità. L'omologazione culturale, il caotico mescolamento, sembrano per Lévi-Strauss i massimi
pericoli della contemporaneità[7]. La sua posizione, opportunamente forzata, è stata utilizzata dai
movimenti contrari all'immigrazione in molti paesi europei. Un ruolo di avanguardia in questa
direzione è stato svolto dalla cosiddetta nuova destra francese, con il contributo di teorici piuttosto
sofisticati come Alain de Benoist, secondo il quale "tutti i popoli devono preservare e coltivare le
proprie differenze", e "l'immigrazione è condannabile perché attenta all'identità della cultura di
accoglienza così come all'identità degli immigrati" [8].
Il motto di questi movimenti, tradotto in linguaggio comune, potrebbe essere : "noi non siamo
razzisti, ma pensiamo che, per il bene comune, ognuno se ne dovrebbe restare a casa propria". I
movimenti migratori di massa, come quelli dall'Africa verso l'Europa, producono sradicamento e
perdita delle identità culturali, sia per gli ospitanti che per gli ospiti. La chiusura delle frontiere,
dunque, è necessaria per proteggere entrambi. L'argomento dell'inuguaglianza biologica è
sostituito dall'assolutizzazione delle differenze tra le culture. Accade così che la separazione e la
xenofobia possono esser sostenute in nome di valori come la tolleranza, il rispetto dell'altro e della
sua dignità, il diritto alla differenza, senza bisogno di parlare né di razze né di superiorità-inferiorità.
Se torniamo per un attimo al caso dei Balcani, possiamo trovare delle analogie. Milosevic è stato
paragonato a Hitler. Si può osservare nel nazionalismo serbo qualche affinità con il
pangermanismo e il nazionalismo tedesco (e non solo tedesco) della prima metà del secolo; c'è
anche in comune una certa mistica della terra se non del sangue, e la tendenza a radicare in
gloriose tradizioni storiche, più o meno inventate e deformate, il presunto destino della patria. Ma è
interessante notare che in questo caso l'odio, la discriminazione e la pulizia etnica non si
accompagnano a un linguaggio esplicitamente razzista, ad affermazioni di superiorità e inferiorità,
limitandosi a rivendicare la differenza, a pretendere una segregazione integrale dei popoli che
rispecchi la presunta assoluta differenza etnico-nazionale. Ciò non significa che ciò che accade ed
è accaduto sia meno terribile.
3. Caratteri distintivi dei neorazzismi
Dunque, il neorazzismo si fonda oggi su nuove basi ideologiche, che si confondono con argomenti
a favore della tolleranza, del relativismo, nonché con i richiami, di per sé giusti, alla valorizzazione
delle identità culturali delle comunità umane. Ciò rende più difficile riconoscere oggi il razzismo,
come atteggiamento sia ideologico sia pratico, rispetto alle sue più classiche ed evidenti
manifestazioni che il senso comune generalmente condanna, dal nazismo al Ku Klux Clan. Non
solo: diviene più complesso anche capire che cosa voglia dire essere antirazzisti, come in linea di
principio la gran parte di noi aspira ad essere. Vorrei concludere l'intervento con alcune
osservazioni su questi punti.
Prima di tutto, come riconoscere un razzismo che non si dichiara come tale? E' facile prendere
posizione, ed esempio, di fronte al "Manifesto della razza" del 1938 che invitava "gli italiani a
proclamarsi francamente razzisti" [9]. Oggi nessuno (con eccezioni irrilevanti) si proclama
francamente tale, né gruppi politici e culturali né individui; ciò non significa che non circolino
largamente atteggiamenti ideologici e comportamenti pratici che presentano forti continuità con il
razzismo classico, autorizzandoci a usare ancora questo termine (piuttosto che sostituirlo
semplicemente con "pregiudizio", xenofobia" e simili [10]). Dobbiamo riconoscere questi
atteggiamenti e comportamenti al di sotto della veste culturalista sotto cui si presentano; d'altra
parte, non possiamo prendere troppo alla leggera l'imputazione di razzismo, attribuendola
ciecamente a ogni discorso o atto politico che affronti criticamente il problema della diversità e del
rapporto con gli "altri". Non ha molto senso considerare ipso facto razzista, ad esempio, ogni
politica di controllo sull'immigrazione, o di limitazione allo sviluppo demografico per i paesi in via di
sviluppo - un errore nel quale i movimenti antirazzisti si lasciano talvolta trascinare, come vedremo
tra breve.
Dunque, quali sono i punti in comune tra vecchio e nuovo razzismo, tra il razzismo biologico,
gerarchizzante e "universalista" della prima metà del secolo e quello culturale, differenzialista e
relativista della seconda metà? Una delle teorie più sistematiche avanzate in risposta a questa
domanda è quella dello studioso francese Pierre-André Taguieff, che individua tre atteggiamenti
intellettuali e tre tipi di pratiche come denominatori comuni, rispettivamente, dell'ideologia e del
comportamento razzista.
PARTIAMO DALLE BASI IDEOLOGICHE. LA PRIMA DI ESSE È PER TAGUIEFF LA
categorizzazione essenzialista degli individui o dei gruppi, che implica la riduzione dell'individuo
allo statuto di un qualsiasi rappresentante del suo gruppo di appartenenza o della sua comunità
d'origine elevata a comunità di natura o d'essenza, fissa e insormontabile. Nascere tali, significa
essere e dover rimanere tali [11].
In altre parole, l'appartenenza a una categoria produce un giudizio aprioristico e totalizzante su un
individuo, a cui sono associati immediatamente tutti gi attributi stereotipi della categoria. Così
funzionava il termine "ebreo" nella cultura tedesca degli anni '30 e '40, o il termine "negro" in
società (formalmente o di fatto) di apartheid ; così, anche se con conseguenze meno drammatiche,
tendono a funzionare oggi da noi i termini "immigrato", extracomunitario", "albanese", e così via.
Non è ad esempio razzista constatare gli alti tassi di criminalità fra certe categorie di immigrati; lo è
considerare qualcuno criminale per il fatto di appartenere a quelle categorie. Taguieff coglie qui un
punto importante: la sua definizione ha tuttavia bisogno di una integrazione. La riduzione degli
individui a "essenze" è infatti un meccanismo assai diffuso nella vita sociale, in riferimento a ogni
tipo di alterità e diversità, e su ordini di grandezza molto diversi: "i milanesi", "i romani", "gli
americani", oppure "i politici", o "gli juventini" e così via. Perché tale meccanismo assuma carattere
razzista occorre sia in gioco qualcos'altro, e cioè un'asimmetria di potere. In altre parole, razzista è
l'essenzializzazione di una categoria debole o subalterna da parte di gruppi o individui
relativamente privilegiati, che vedono in essa, a torto o a ragione, una minaccia per la propria
posizione. Questo punto è colto efficacemente in un'altra celebre definizione di razzismo, proposta
dal sociologo Albert Memmi. Il razzismo è a suo parere
l'enfatizzazione, generalizzata e definitiva, di differenze, reali o immaginarie, che l'accusatore
compie a proprio vantaggio e a detrimento della sua vittima, al fine di giustificare i propri privilegi o
la propria aggressione.[12]
Il senso comune è pieno di enfatizzazioni ed essenzializzazioni, etniche e non: questi sono anzi i
meccanismi retorici fondamentali per alcuni generi di discorso, come l'umorismo. Si pensi agli
stereotipi sui tedeschi efficienti ma troppo rigidi, sugli statunitensi spacconi e presuntuosi, sui
giapponesi conformisti e maniacali e così via. Se questi stereotipi sono innocui, lo stesso non si
può dire di quelli, largamente correnti nell'Italia di oggi, sugli albanesi violenti, fannulloni,
pretenziosi. Gli enunciati "i tedeschi sono tutti uguali" e "gli albanesi sono tutti uguali", pur identici
nella sintassi, hanno implicazioni razziste profondamente diverse.
Tornando a Taguieff, il secondo ingrediente ideologico del razzismo (che presuppone il primo) è a
suo parere la stigmatizzazione. Una volta categorizzati secondo una presunta immutabile essenza,
gli "altri" possono esser stigmatizzati, cioè subire un processo di esclusione simbolica, imperniato
sulla "creazione di un certo numero di stereotipi negativi"[13]. Ad essi si attribuiscono difetti
congeniti, "tare", impurità di vario tipo, qualità pericolose che li rendono minacciosi. Il "nemico"
viene disumanizzato, demonizzato, bestializzato, e ciò crea una distanza psicologica e morale che
spiega anche le manifestazioni di violenza, nonché il peculiare rapporto vittime-carnefici che
caratterizza gli eccidi nazisti come i pestaggi degli immigrati di colore. Una conseguenza della
stigmatizzazione è la mixofobia, cioè la paura della mescolanza e dell'ibridazione, che spesso si
manifesta attraverso un linguaggio patologizzante, con l'ossessione di un "contagio" metaforico o
reale - con il che si torna nelle immediate vicinanze del linguaggio hitleriano e dell'antisemitismo
nazista.
Il terzo elemento caratterizzante del razzismo viene chiamato da Taguieff "barbarizzazione", e
consiste nella "convinzione che certe categorie di esseri umani non siano civilizzabili (e dunque,
come presupposto, che non siano civilizzate), che non siano perfettibili, non siano educabili,
convertibili, assimilabili"[14]. Taguieff sostiene che la teoria della inuguaglianza biologica tra le
razze è solo una incarnazione storica di questa tendenza, che può manifestarsi attraverso altri
linguaggi e teorie. Si tratta del più altro grado di distanziamento e esclusione dell'altro: in quanto
"barbaro", esso non è solo diverso, inferiore, pericoloso, ma rappresenta l'antitesi stessa della
civiltà: è colui che non riconosce i valori fondamentali, che non rispetta le distinzioni centrali
all'esistenza stessa della civiltà. La barbarizzazione implica l'impossibilità di ogni assimilazione, e
dunque apre la strada a politiche eliminazioniste, di radicale separazione xenofoba e persino di
genocidio.
Dal punto di vista degli atteggiamenti pratici, Taguieff distingue tre tipi o livelli di azioni logicamente
giustificabili dalla precedenti condizioni, anche se non ne sono la necessaria conseguenza. Si
tratta in primo luogo delle pratiche di segragazione, discriminazione, espulsione; in secondo luogo,
di forme dirette di persecuzione e di violenza essenzialista (diretta cioè contro una categoria in
quanto tale), e infine del genocidio, cioè dello sterminio di tutti i rappresentanti di una categoria di
popolazione[15]. Come si vede, sembra quasi che Taguieff abbia costruito il suo schema teorico
ricalcando i livelli successivi della persecuzione nazista contro gli ebrei. Rispetto alle
interpretazioni che considerano la Shoah come un unicum storico, egli sembra però pensare che i
nazisti non abbiano che condotto alle estreme - e per certi versi logiche - conseguenze un
atteggiamento ideologico e pratico assai più diffuso; che, dunque, il genocidio sia sempre inscritto,
come possibilità, nei livelli di base della discriminazione razzista.
Naturalmente, Taguieff non sostiene che le pratiche di persecuzione violenta siano semplici
conseguenze di convinzioni teoriche o ideologiche. Le cose sono più complesse. Da un lato, infatti,
le idee e i comportamenti razzisti non insorgono da soli nella testa della gente, e possono esser
ricondotti a una serie di cause "strutturali" (economiche, sociali, politiche, etc.). Dall'altro, anche sul
piano soggettivo, lo sviluppo di atteggiamenti razzisti non discende semplicemente da "credenze"
o convinzioni politiche, e neppure da dinamiche psicologiche più o meno universali. Citando
ancora Memmi, si può dire che l'atteggiamento razzista ha tutta la complessità e la profondità di
un' "esperienza vissuta", nella quale esperienze personali di vita, emozioni e passioni, credenze,
interessi economici, convinzioni politiche, ragioni e impulsi irrazionali, influenza della cultua di
massa e dell'immaginario sociale e così via si legano in un groviglio difficile da districare [16](v.
Taguieff p. 69).
4. Antirazzismo.
Abbiamo visto prima come le mutate basi ideologiche del razzismo rendano più difficile non solo
riconoscerlo, ma anche opporvisi coerentemente. L'antirazzismo corre oggi due tipi di rischi. Il
primo è quello di usare gli stessi strumenti ideologici e culturali del neorazzismo differenzialista; il
secondo è il rischio di riprodurre gli stessi meccanismi di essenzializzazione, stigmatizzazione e
barbarizzazione che, come detto, caratterizzano il razzismo stesso. Partiamo anche qui da
Taguieff, autore che più di ogni altro ha gettato le basi di una critica - per quanto costruttiva all'antirazzismo contemporaneo.
L'antirazzzismo classico, impregnato di culturalismo e di differenzialismo, non può più funzionare
da dispositivo critico efficace, dal momento che le sue tesi e argomentazioni tendono a confondersi
con quelle del neorazzismo, differenzialista e culturale. Di qui, la presa di coscienza della
necessità di ripensare l'antirazzismo e di abbandonare la funzione rituale e il significato
strettamente commemorativo di quest'ultimo. [17]
L'argomento è chiaro, anche se espresso in modo forse troppo radicale. Non è affatto detto che
tutto l'antirazzismo classico, elaborato in risposta alle teorie sull'inuguaglianza biologica e sul
naturale ordine gerarchico delle razze, sia da buttare; non è detto che i vecchi argomenti
culturalisti e relativisti siano colpevoli di "connivenze" con il razzismo per il solo fatto di esser stati
strumentalmente usati dai nuovi teorici della xenofobia. Tuttavia, il problema che Taguieff pone è
reale: i vecchi argomenti non bastano più, e risultano anzi fortemente ambigui. L'antropologia
culturale, che per buona parte del secolo è stata baluardo dell'antirazzismo relativista, risente
particolarmente di tutto ciò. I testi classici che essa ha opposto al razzismo, da Modelli di cultura di
Ruth Benedict a Razza e storia di Lévi-Strauss, rischiano di divenire oggi armi nelle mani del
"nemico". Che fare, dunque?
Mi si consenta di proseguire con una ulteriore citazione da Taguieff:
L'antirazzismo non può limitarsi all'indignazione morale retrospettiva e all'anatema commemorativo
se non per squalificarsi, collaborando alla propria scomparsa per la mancanza di "razzisti"
conformi all'identikit consueto. Né i Gobineau né gli Hitler possono oggi esser trovati lì dove li si
cerca, e i nuovi razzisti non somigliano più a queste figure del passato. L'antirazzismo militante
deve finalmente cessare di commettere degli errori tattico-strategici, il principale dei quali è quello
di sbagliare nemico, di non identificare il nuovo vero nemico, e di continuare a prendere come
propri obiettivi i luoghi ripugnanti della memoria. [18]
Anche qui, il tono di Taguieff mi pare eccessivo. Egli sottovaluta forse il ruolo della memoria del
passato e della celebrazione rituale: se è la memoria della Shoah ciò a cui si riferisce parlando di
"indignazione morale retrospettiva" e di "anatema commemorativo", mi pare che non ne
comprenda il giusto peso. Il fatto che la memoria del passato non sia sufficiente non implica che
non sia necessaria: troppo spesso la cronaca ci rammenta come quelle "figure del passato" non
siano poi così lontane (dal caso Haider alle periodiche “scoperte” della vitalità del neonazismo in
Europa). Ma credo che il rischio di sbagliare nemico cui Taguieff fa cenno abbia un altro e più
importante significato: si riferisce al rischio, per l'antirazzismo, di mettere in atto le stesse
procedure di stigmatizzazione, di costruzione di un nemico assoluto e astratto - il "razzista" tipiche del pensiero razzista stesso.
Il "razzista" diviene figura negativa centrale di un grande mito repulsivo, seguace del Male
assoluto, in un modello dicotomico che interpreta le vicende del mondo come scontro tra un Male
assoluto e un Bene assoluto. Si sviluppa cioè un antirazzismo dogmatico, cui si aderisce su base
meramente ideologica e rituale. In uno scritto precedente a quello finora citato, Taguieff scriveva
che
è un paradosso ormai comune dell'antirazzismo il fatto che i suoi sostenitori rovescino
sull'avversario "razzista" i modi di rappresentazione e di stigmatizzazione che gli attribuiscono. Si
pensi a espressioni come "Sporco razzista !", o come in Francia si è talvolta detto, "Gasiamo i
lepenisti!". Gli spiriti antirazzisti sono impregnati di razzismo. [19]
Il rischio non è dunque solo combattere nemici che non ci sono più, ma anche scegliersi nuovi
nemici su basi puramente ideologiche. Mi pare si tratti di un rischio estremamente reale per un
certo antirazzismo militante, troppo preoccupato di dividere il mondo in buoni e cattivi. Ma è un
rischio anche per l'analisi culturale del razzismo. Un solo esempio. Un importante filone di studi
degli ultimi decenni è l'analisi retorica del discorso razzista. Dovendo scoprire un razzismo
dissimulato e non esplicito, gli studiosi mettono a punto sofisticati strumenti d'indagine e vanno a
cercarne le manifestazioni nei luoghi apparentemente più innocenti, nelle strutture della
"conversazione" quotidiana, nei messaggi delle news televisive o della pubblicità, nell'umorismo o
nei giornaletti per bambini, nei libri di testo scolastici e così via. [20] I risultati sono molto
interessanti: un discorso comune che per lo più si dichiara antirazzista risulta di fatto impregnato di
stereotipi, di pregiudizi, di valutazioni essenzialiste e stigmatizzanti verso gli altri (soprattutto, per
quanto riguarda Italia ed Europa, verso gli immigrati "extracomunitari"). Valutazioni meno crude ed
esplicite, ma in definitiva non troppo diverse da quelle che dominavano l'immaginario collettivo in
epoca colonialista.
Ogni studio che ci mostra la diffusione, in estensione come in profondità, di questo sostrato di
pregiudizi, non manca di stupirci, e di mettere in crisi la nostra poco fondata convinzione di vivere
all'interno di una cultura aperta, tollerante, sempre pronta a rispettare e valorizzare l'alterità. Tutto
quanto può scalfire questa ingenua e autoindulgente immagine di noi stessi è certamente salutare.
Tuttavia, vi sono in questi studi degli aspetti discutibili: almeno due di essi saltano immediatamente
agli occhi. Il primo problema è per così dire la forza eccessiva degli strumenti analitici messi in
campo: essi funzionano troppo bene, e riescono a scoprire razzismo dietro ogni tipo di discorso.
Nulla può resistervi. I messaggi che si presentano esplicitamente come antirazzisti sono i preferiti
di questo tipo di analisi: applicando ad essi interpretazioni ancor più raffinate, si dimostra come la
loro struttura retorica profonda sia connotata da un più essenziale razzismo. Le analisi compiute
da van Dijk sulla conversazione quotidiana e sulle notizie giornalistiche e televisive riguardanti
l'immigrazione sono appunto di questo tipo: assai penetranti da un lato, ideologiche e pregiudiziali
dall’altro. Partendo dall’assunto che l’intero universo della comunicazione di massa e della
conversazione quotidiana è un meccanismo di trasmissione di pregiudizi razziali, funzionali alle
politiche xenofobe dei governi democratici, è possibile dimostrare che qualsiasi discorso preso in
esame ha finalità razziste, palesi o nascoste. Non c’è limite alle possibilità dell’interpretazione:
anzi, quanto più un discorso si proclama antirazzista, più subdola e profonda è la sua intenzione
razzista. Ci si può chiedere se sia possibile almeno immaginare un messaggio - un articolo di
giornale, un servizio televisivo - che non risulti razzista secondo quel metodo interpretativo: e ho
l'impressione che la risposta sarebbe negativa. In altre parole, si dà l’avvio alla caccia al discorso
razzista senza stabilire in anticipo i requisiti minimi di un discorso non-razzista. Inoltre, come in
molti sistemi teorici “chiusi”, ogni critica alle interpretazioni proposte può esser respinta sulla base
di un’attribuzione di razzismo (proprio come si usava deridere come “borghesi” le critiche al
marxismo, o attribuire le obiezioni alla psicoanalisi alle “resistenze inconsce” degli interlocutori).
Se è così, tralasciando ogni considerazione di validità epistemologica, si può almeno dire che
questa non sembra una strada molto promettente per riconoscere i "veri nemici".
Il secondo problema posto dall'analisi del discorso razzista è la sua tendenza a non distinguere
diversi livelli del pregiudizio: in particolare, a porre sullo stesso piano l'etnocentrismo e il razzismo
vero e proprio, i pregiudizi depositati nel linguaggio dagli enunciati consapevolmente e
aggressivamente discriminatori. E' vero che la distinzione può essere poco chiara in molti casi, e
che i pregiudizi più profondi e pericolosi sono spesso proprio quelli più invisibili e inconsapevoli,
incardinati in usi linguistici considerati come "naturali". E' vero anche che il richiamo a naturali
tendenze etnocentriche può essere usato come giustificazione di reali atteggiamenti discriminatori.
E tuttavia, non si può far coincidere l'analisi del discorso razzista con il rilevamento degli aspetti
etnocentrici della nostra cultura, non foss'altro perché questi ultimi sono troppo numerosi e
pervasivi. La cultura occidentale (come molte altre) si è costituita storicamente attorno alla
distinzione di un ambito della "civiltà" da quello della "barbarie", della "normalita" dalla "anormalità",
del "buon gusto" dal "cattivo gusto" e così via. Tali distinzioni, che informano profondamente la
nostra esperienza quotidiana del mondo e della socialità e stanno alla base di grandi apparati
simbolici, non hanno ovviamente nulla di "naturale": si sono anzi costituite in stretta relazione con
la storia dell'Occidente e con le sue pratiche di dominio sugli altri. Hanno certamente a che fare
con secoli e forse millenni di discriminazione e persecuzione, con il colonialismo, lo schiavismo, il
razzismo. La loro diffusione ci dice molto sulla storia dell'Occidente (per inciso, questa stessa
categoria è ovviamente etnocentrica); ma la stessa profondità del loro radicamento le rende
inadatte a distinguere nell'attualità gli atteggiamenti razzisti da quelli non razzisti.
Prendiamo un esempio. L'opposizione bianco-nero è per noi densa di connotazioni estetiche,
morali ed emotive strettamente collegate ai temi della diversità etnica e potenzialmente razziste. Al
bianco si associano la purezza, l'innocenza, il bene, al nero il male, il peccato, la sporcizia e
l'impurità, la paura. Si minacciano i bambini con storie sull' "uomo nero"; si rappresenta il diavolo
come un essere nero o scuro, e così via. E' ovvio che tali connotazioni sono prodotti di popoli di
pelle chiara che storicamente hanno sottomesso e sfruttato popoli di pelle scura; ed è altrettanto
evidente che questo ampio sistema di rimandi simbolici si proietta oggi sui nostri rapporti con gli
immigrati di colore. E' importante analizzare quanto a fondo agiscano questi meccanismi nel nostro
linguaggio e nel nostro senso comune, che in virtù di questa consapevolezza possono mutare con
relativa rapidità e farsi, per così dire, politicamente più corretti. Ma l'ampia diffusione di simili
connotazioni simboliche non può da sola rappresentare un indicatore di razzismo ideologico nel
senso di Taguieff, cioè di meccanismi di riduzione essenzialista degli altri, di stigmatizzazione e di
barbarizzazione; tanto meno, può rappresentare un indicatore di razzismo pratico, vale a dire di
dominanti tendenze all'esclusione, alla segregazione, alla persecuzione violenta.
In altre parole, le analisi del discorso razzista sembrano usare talvolta reti a maglie troppo strette,
che catturano ogni tipo di pesce, e non sono in grado di discriminare il "vero nemico" da quegli
atteggiamenti che, ispirati da un reale rispetto verso gli altri e da sentimenti autenticamente
egalitari, non riescono tuttavia ad affrancarsi da quella rete di pregiudizi etnocentrici che pervade
in profondità il nostro linguaggio e il nostro immaginario.
5. Abbandonare l’identità culturale?
Per concludere, vorrei tornare all'antropologia culturale. Principale sostenitrice, per gran parte del
Novecento, dell'approccio differenzialista e relativista contrapposto al razzismo biologico e
gerarchizzante, l'antropologia sta oggi attraversando un periodo di profonda revisione concettuale
e teoretica. La sua idea di un mondo suddiviso in un numero finito, per quanto ampio, di unità
etnico-culturali discrete, distintive, simmetriche e per certi aspetti eticamente incommensurabili (nel
senso di irriducibili a criteri di giudizio sovra-culturali), non sembra più un buon modello per
pensare la diversità. Proprio mentre le categorie di "etnia" e "cultura" entravano a far parte del
senso comune, l'antropologia ne sviluppava una profonda critica - in parte come reazione al loro
uso strumentale in funzione neorazzista, in parte per la loro inadeguatezza di fronte ai fenomeni
della globalizzazione e del meticciato culturale che caratterizzano la fine del ventesimo secolo.
Negli ultimi vent'anni, gli studi antropologici si sono prevalentemente preoccupati di contrapporsi
alle concezioni essenzialiste e naturalistiche di etnie e culture. Non esistono essenze etniche e
culturali pure e oggettive, rintracciabili per così dire in natura. Se l'antropologia ha accreditato a
lungo questo punto di vista, per una propria distorsione epistemologica, si tratta oggi di recuperare
il terreno perduto e di decostruire tali concetti; si tratta cioè di mostrare come le identità etniche e
culturali risultino sempre da processi storicamente contingenti, siano il frutto di pratiche sociali
consapevolmente guidate da agenti particolari in riferimento a particolari interessi.
Gli esempi sopra considerati - conflitti etnici, leghismo, razzismo differenzialista - non
rappresenterebbero usi anomali, degenerati o meramente strumentali del vocabolario dell'etnicità.
Si tratterebbe anzi di casi tipici e rivelatori. Alcuni agenti sociali vogliono far credere alla presenza
di differenze etniche astoriche e irriducibili, che determinerebbero inevitabilmente strategie e
conflitti politici. L'antropologia, con il suo linguaggio culturalista, è a lungo caduta in questo tranello,
accreditando ingenuamente le pretese etniche. Si tratta oggi di cambiare rotta, riconoscendo un
ordine delle cose esattamente inverso: interessi e conflitti in senso lato politici determinano
l'accentuazione e persino la creazione di strategie di differenziazione etnica. Per riprendere
un'affermazione di Ugo Fabietti, non di etnie o identità etniche è corretto parlare, bensì di "processi
di etnicizzazione voluti o favoriti dall'esterno oppure dagli stessi gruppi che competono, in
determinate circostanze sempre circoscrivibili sul piano storico, per l'accesso a determinate risorse
materiali e simboliche" [21]. In altre parole: non esistono identità etniche pure e autentiche, e il
linguaggio dell'etnicità rappresenta sempre una vernice ideologica che copre più profonde e
strutturali dinamiche di tipo economico e politico.
Ma di fronte a questa critica o auto-critica, ormai ampiamente diffusa nel discorso antropologico, si
aprono due possibili e molto diversi atteggiamenti. Da un lato, la critica sembra sfociare nella
completa dissoluzione del linguaggio dell'etnia e della particolarità culturale nel linguaggio
dell'ecomomia politica, considerato come l'unico reale. Le rivendicazioni etniche e identitarie non
sarebbero altro che strategie consapevolmente e strumentalmente adottate all'interno di scontri di
potere e di controllo delle risorse economiche. Per quanto gli attori sociali avvertano come reale la
propria o l'altrui etnicità, ne siano cioè investiti cognitivamente ed emotivamente, essa mantiene
nondimeno carattere di "falsa coscienza" - non fa parte delle condizioni strutturali che determinano
i conflitti e i comportamenti sociali, delle condizioni che in definitiva muovono la storia.
Dall'altro lato, tuttavia, la critica alla naturalizzazione dell'identità etnica non contrasta
necessariamente con la valorizzazione delle peculiarità culturali locali, e con la convinzione della
loro irriducibilità rispetto al lessico politico-economico. Alcuni antropologi - come Clifford Geertz,
per citare il nome più noto - pensano che sia vero esattamente il contrario: e cioè che per
comprendere le complesse vicende del mondo attuale, con i processi di globalizzazione
economica e culturale da un lato, e dall'altro l'esplosione di vecchi e nuovi particolarismi locali di
tipo etnico, politico e religioso, occorra integrare le classiche categorie della politica con quelle
dell'analisi culturale. In questa prospettiva le differenze culturali, per quanto disperse
caleidoscopicamente e non riducibili a identità compatte, stabili ed esclusive, mantengono una loro
concretezza antropologica. L'esser nati in un certo luogo, parlare una lingua, credere in una
religione e così via non sono residui di particolarismo che vengono a turbare la razionalità della
sfera politica: sono invece elementi antropologicamente costitutivi di cui la teoria politica deve
imparare ad occuparsi. Scrive dunque Geertz che abbiamo bosogno di una nuova politica:
una politica che nell’autoaffermazione etnica, religiosa, di razza, linguistica o regionale non veda
una mancanza di ragionevolezza arcaica o innata, da reprimere e da superare, una politica che
non tratti questi generi di espressione collettiva come una spregevole follia o un abisso buio, ma
sappia invece affrontarli come affronta la disuguaglianza, l’abuso di potere e altri problemi sociali.
[22]
Dunque, si configura una fondamentale contrapposizione tra chi ritiene che l'analisi politica debba
affinarsi sviluppando una sensibilità antropologica per le differenze e le identità culturali, e chi, al
contrario, pensa che l'antropologia stessa debba esser depurata dal linguaggio vago ed equivoco
dell'identità, per volgersi alle più concrete e reali dinamiche di potere che regolano i rapporti tra
gruppi umani. Questa contrapposizione, che mi sembra dominare l'attuale dibattito antropologico,
poggia su modi radicalmente diversi di intendere il soggetto della cultura e della storia, vale a dire
l'agente umano. Da un lato si presuppone un agente umano astratto, universale, tendenzialmente
cosmopolita, mosso da una razionalità in senso lato economica, rispetto alla quale ogni
rivendicazione locale di identità appare come residuo di irrazionalità oscurantista e strumentale.
Dall'altro, si sottolinea l'irriducibile pluralità delle culture e delle appartenenze etniche come
costitutiva della soggettività umana: si pensa a una comunità che, come scriveva Lévi-Strauss, si
realizza non in astratto ma all'interno e per la mediazione di culture particolari. [23]
Trovo, per concludere, che tutto questo ci riporti a ridosso del problema di una nuova fondazione
teorica dell'antirazzismo. Quest'ultimo è oggi dibattuto tra un quadro di riferimento universalista e
uno relativista - o perlomeno, come si è espresso Geertz, "anti-anti-relativista". [24] I sostenitori
della prima ipotesi reagiscono al razzismo differenzialista assumendo un modello forte di comune
umanità come riferimento; il dialogo, la tolleranza e il rispetto tra gruppi, etnie, culture diverse
possono fondarsi solo sul comune riconoscimento di principi etici universali, come i fondamentali
diritti umani. Questa prospettiva assume la sostanziale uniformità morale di tutti gli esseri umani, e
interpreta i particolarismi come ostacoli storicamente contingenti che soggetti interessati
frappongono al progetto di una integrale eguaglianza. Così ogni autocompiacimento
particolaristico, ogni valorizzazione delle differenze e ogni "politica del riconoscimento" [25], non
importa con quanta buona fede siano sostenute, finiscono per apparire politicamente regressive o
oggettivamente filo-razziste: un principio, questo, che porta talvolta alla condanna dell'intera
disciplina dell'antropologia culturale e, ancora più a monte, delle principali tradizioni di pensiero
scettico e anti-universalista [26].
Il problema, con questo approccio, è chi e come stabilisce i principi universali che fondano la
comune umanità. Come mettere d'accordo gli universalismi concorrenti di culture diverse? Come
formulare principi universali in modo non-etnocentrico, oppure convincere gli altri che il nostro
etnocentrismo è migliore del loro? Può sembrare si tratti di astrusità filosofiche, ma non è così.
Basta considerare qualche esempio di rapporti pratici e di convivenza fra culture - cristiane e
islamiche, poniamo - per convincersene. In linea di principio, il riconoscimento della diversità pone
limiti ai principi universali (i quali, per definizione, non possono accettare eccezioni);
l'universalismo intransigente, d'altra parte, pone limiti inevitabili alla tolleranza per i
particolarismi[27]. Dovremmo allora chiederci se sia possibile costruire un antirazzismo in grado di
salvare al contempo l'istanza universalistica e la politica del riconoscimento; in grado di non
rinunciare all'impegno per la universalizzazione di fatto di certi diritti, e neppure all'ideale di una
comune umanità integralmente realizzata, senza per questo ignorare il fatto che non esistono
"cittadini del mondo", e che le persone vivono all'interno di condizioni locali caratterizzate talvolta
da grumi irriducibili di differenze culturali.
[1] B. Bernardi, “Il fattore etnico: dall’etnia all’etnocentrismo”, Ossimori, 4, 1994, pp. 13-36; v. anche A. Rivera, “Etniaetnicità”, in R. Gallissot, A. Rivera, L’imbroglio etnico, cit., pp. 77-98
[2] Si vedano su questo punto U. Fabietti, L’identità etnica, Roma, NIS, 1995 e C. Geertz, Mondo globale, mondi locali.
Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo, Bologna, Il Mulino, 1999
[3] Il dibattito degli ultimi venti anni su etnia ed etnicità è molto ampio e di difficile definizione. Fra i testi disponibili in
lingua italiana, rimando per una sintesi teorica a L. Li Causi, “Ridimensionare l’etnia? Note metodologiche sul fenomeno
etnico”, Ossimori, 6, 1995, pp. 13-19, e all’antologia curata da V. Maher, Questioni di etnicità, Torino, Rosenberg &
Sellier, 1994. Per quanto riguarda lo smascheramento del carattere recente e “inventato” di molte tradizioni etniche,
grande influenza ha esercitato il volume curato dagli storici E.J.Hobsbawm-T.Ranger, L’invenzione della tradizione,
trad.it. Torino, Einaudi, 1987
[4] Una pratica, quest’ultima, che lo stesso nazismo non praticava, per la peculiarità del suo pensiero razzista,
ossessionato dal timore della contaminazione; v. in proposito V. Nahoum-Grappe, “L’uso politico della crudeltà e
l’epurazione etnica in ex-Jugoslavia (1991-1995)”, in F. Heritier (a cura di), Sulla violenza, trad.it. Roma, Meltemi,.1997,
pp.190-227.
[5] V. R. Biorcio, La Padania promessa, Milano, Il Saggiatore, 1997
[6] Questa definizione è stata esplorata in modo particolarmente sistematico nell’opera dello studioso francese PierreAndré Taguieff; si vedano P.-A. Taguieff, La forza del pregiudizio. Saggio sul razzismo e l’antirazzismo, trad. it. Bologna,
Il Mulino, 1988 e, per una più sintetica esposizione, Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti, trad. it. Milano,
Cortina, 1999. Per la nozione – per certi versi analoga – di “fondamentalismo culturale v. V. Stolcke, “Talking culture.
New boundaries, new rethorics of exclusion in Europe”, Current Anthropology, 36 (1), 1995, pp. 1-24
[7] Posizioni espresse con forza particolare in C. Lévi-Strauss, Lo sguardo da lontano, trad. it. Torino, Einaudi, 1984,
Prefazione e cap. 1, e che rivedono criticamente quanto sostenuto precedentemente dallo stesso autore nel daggiod egli
anni ’50 “Razza e storia”, cit. Per una stimolante discussione dei rapporti tra il “primo” e il “secondo” Lévi-Strauss v. C.
Geertz, “Gli usi della diversità”, trad.it. in La società degli individui, III (8), 2000. Per una feroce critica di segno
“antirazzista” a Lévi-Strauss si veda M.G.O’Callaghan - C. Guillamin, “La moda «naturalistica» nelle scienze umane”,
trad. it. In Democrazia e diritto, XXIX (6), 1989, pp. 181-202. V. anche G. Riccardo, “Immagini dell’etnologia e immagini
della società. A proposito di alcune letture del razzismo contemporaneo”, Problemi del socialismo, 21, n.s., 1989, pp.4559 e F. Dei, “Giudizio etico e diversità culturale nella riflessione antropologica”, in R. De Vita (a cura di), Società in
trasformazione ed etica, Siena, 1992, pp. 53-79
[8] Cit. in R. Gallissot - A. Rivera, L’imbroglio etnico, cit., pp. 183, 187
[9] Sulle elaborazioni scientifiche del razzismo nell’Italia fascista si vedano R. Maiocchi, Scienza italiana e razzismo
fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1999 e G. Israel - P. Nastasi, Scienza e razza nell'Italia fascista, Bologna, Il Mulino,
1998
[10] Peraltro, a fronte della più comune rilettura in chiave etnica delle antiche differenze razziali, è importante rilevare la
persistenza di una dinamica opposta: vale a dire, la tendenza a razzializzare le differenze etniche e culturali. Questo
fenomeno è stato rilevato spesso negli Stati Uniti, dove le categorie razziali prevalenti, quelle di “bianco” e “nero”, sono
spesso proiettate su un mosaico etnico molto più vario e complesso. Questo è uno dei motivi che ha spinto l’attuale
antropologia americana a restituire centralità alla nozione di razza. Un motivo parallelo ha a che fare col sostegno di
molti antropologi alle strategie politiche delle minoranze di colore o afro-americane le quali, nel denunciare il persistente
razzismo della società statunitense, rivendicano in positivo l’appartenenza razziale, sottolineandone i demarcatori
somatici. A parere di molti, l’antirazzismo americano della seconda metà del secolo ha percorso una strada sbagliata,
trasformando gli USA in un società “cieca ai colori” (color blind): questa indifferenza alle caratteristiche somatiche, il “fare
come se non ci fossero”, è in realtà un modo di nascondere le profonde sperequazioni che ancora dividono gli afroamericani dai bianchi; dunque, una più effettiva pratica antirazzista ha oggi bisogno di recuperare e affinare la
percezione del colore. In alcuni movimenti culturali, come il cosiddetto “afrocentrismo”, questa riscoperta della razza
rischia di assumere la forma paradossale di un modello invertito di determinismo biologico: l’origine africana, visibile nel
colore della pelle anche se non percepita storicamente, sarebbe il nucleo portante dell’identità culturale, fondando
particolari propensioni e capacità. Per un richiamo radicale (e a mio parere non privo di ambiguità) dell’antropologia
culturale alla riflessione e all’uso politico del linguaggio razziale si vedano i saggi raccolti in un recente numero
monografico dell’autorevole rivista American Anthropologist: F.Harrison (a cura di), “contemporary issue forum: Race
and racism”, American Anthropologist, 100 (3), 1998.
[11] P.-A. Taguieff, Il razzismo, cit. , p. 64
[12] A. Memmi, Il razzismo, trad.it. Genova, Costa & Nolan, 1989; cit. in R. Gallissot – A.Rivera, L’imbroglio etnico, cit., p.
180
[13] P.-A. Taguieff, Il razzismo, cit., pp. 64-5
[14] Ibid., p. 66
[15] Ibid., pp. 67-8
[16] Ibid., p. 69
[17] Ibid., p. 50
[18] Ibid.
[19] P.-A. Taguieff, “Riflessioni sulla questione antirazzista”, trad. it. in Problemi del socialismo, 2, n.s. 1989, p.26
[20] L’autore probabilmente più rappresentativo di questo filone di studi è probabilmente Teun A. van Dijk, di cui si può
vedere in traduzione italiana Il discorso razzista. La riproduzione del pregiudizio nei discorsi quotidiani, Messina,
Rubbettino, 1994. Nel panorama antropologico italiano sono importanti i lavori di Clara Gallini, Giochi pericolosi.
Frammenti di un immaginario alquanto razzista, Roma, Manifestolibri, 1996 e Paola Tabet, La pelle giusta, Torino,
Einaudi, 1997.
[21] U. Fabietti, L’identità etnica, cit., p.19
[22] C. Geertz, Mondo globale, mondi locali, cit., p. 52
[23] C. Lévi-Strauss, Razza e storia, cit., p. 107
[24] C. Geertz, “Anti-anti-relativismo”, trad it in Il mondo 3, 1 (2), 1994, pp. 72-86
[25] Per un approfondimento della nozione di politica del riconoscimento si veda J. Habermas – C. Taylor,
Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento , trad. it. Milano, Feltrinelli, 1998
[26] Una posizione tanto radicale quanto densa di ambiguità in questo senso mi appare quella di V. Stolcke,
“Talking culture. New boundaries, new rethorics of exclusion in Europe”, cit.
[27] Si veda su questi punti A. Santiemma (a cura di), Diritti umani. Riflessione e prospettiva antropologica, Roma,
Editrice Universitaria La Goliardica, 1999: in particolare, per una critica agli assunti universalisti, il saggio d P. Clemente,
“La muffa la sentono gli stranieri. Qualche nota perplessa sui «diritti umani» degli immigrati”, ivi, pp. 57-74.
Ultimo aggiornamento Sabato 19 Dicembre 2009 12:45