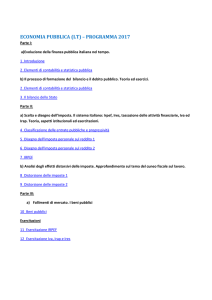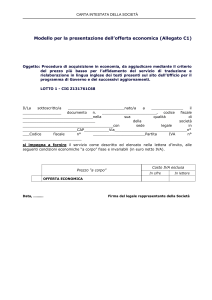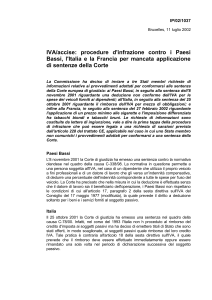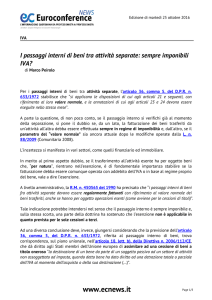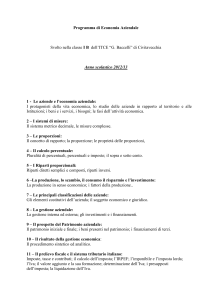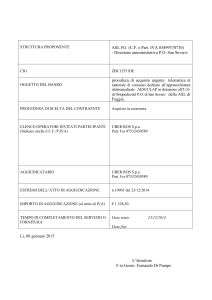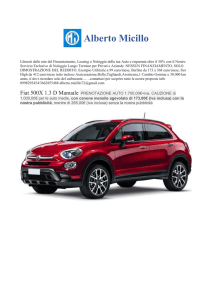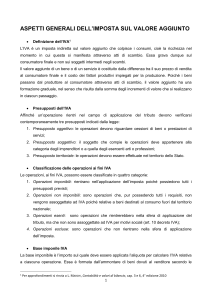NORMATIVA IRAP: DIRETTIVE COMUNITARIE
E POTERI DEI GIUDICI INTERNI
La pronuncia della Comm. Trib. Prov. di Padova richiama nuovamente l’attenzione degli
operatori del diritto sull’ormai dibattuta questione della compatibilità del Decreto istitutivo IRAP
(D.lgs. n. 446 del 1997) con l’art. 33 della dir. 77/388/CE (c.d. Sesta Direttiva IVA), contenente il
divieto per gli Stati membri di introdurre imposte sulla cifra d’affari diverse dall’IVA. La pronuncia della
Commissione Tributaria offre, tuttavia, notevoli spunti di riflessione, in particolare per quanto riguarda
le questioni di diritto comunitario ivi trattate.
In primo luogo, la Commissione analizza le differenze sussistenti tra IVA ed IRAP, per giungere
alla conclusione che tra le due imposte non vi è analogia ma una sostanziale diversità e che, pertanto,
l’IRAP non viola il divieto posto dall’art. 33 della Sesta Direttiva IVA. In secondo luogo, i giudici
tributari affrontano il problema della disapplicazione del diritto interno da parte dei giudici nazionali in
caso di contrasto della norma interna con la normativa comunitaria. Posto che nel caso di specie la
normativa comunitaria (ovvero l’art. 33 della Sesta Direttiva IVA) non avrebbe efficacia diretta, la
Commissione ritiene di non poter procedere alla disapplicazione della normativa nazionale
(segnatamente il Decreto IRAP).
Con riferimento alle caratteristiche dell’IRAP e dell’IVA, la Comm. Trib. Prov. non ha dubbi sul
fatto che le due imposte siano assolutamente diverse tra loro e che pertanto l’IRAP si sottragga al
divieto imposto dall’art. 33 della Sesta Direttiva IVA.
Non sarebbe corretto, infatti, includere l’IRAP tra le imposte sui consumi, dal momento che
questa non sarebbe riconducibile a dette imposte per struttura, presupposti, metodo di calcolo, soggetti
passivi nonché per l’incidenza generale sul sistema produttivo.
In primo luogo - osserva la Commissione - l’IRAP si determina in base al valore complessivo
della produzione netta (principio di globalità dell’imposta) mentre l’IVA consiste in un tributo sul
consumo proporzionale al prezzo del singolo prodotto, qualunque sia il numero delle transazioni
intervenute nel processo di produzione o di distribuzione anteriore alla fase dell’imposizione. L’IRAP,
dunque, colpirebbe la ricchezza nella fase della sua produzione e si riferirebbe alla globalità della
produzione stessa, influenzando solo indirettamente il prezzo del prodotto, mentre l’IVA si riferirebbe
esclusivamente alla singola cessione dei prodotti o prestazione di servizi, colpendo solamente il
consumatore finale. Presupposto dell’IVA, dunque, in tale prospettiva è la singola cessione del bene o la
concreta prestazione di servizi mentre presupposto dell’IRAP è l’esercizio di un’attività autonomamente
organizzata volta alla produzione o scambio di beni ovvero alla produzione di servizi.
Ancora, l’IVA colpisce le importazioni e provvede invece alla detassazione delle esportazioni,
mentre l’IRAP va ad incidere esclusivamente sul valore economico prodotto in Italia. In altre parole,
l’IVA non si paga sulle esportazioni, perché è appunto un’imposta sui consumi, mentre l’IRAP si paga
sulla esportazioni, incidendo di fatto sui redditi.
La Commissione conclude mettendo in evidenza che l’IRAP è ispirata al principio di globalità
dell’imposta, dal momento che colpisce l’intero reddito finale, non trovando applicazione alcuna il
sistema delle detrazioni, che risulta invece fondamentale in materia di IVA.
In sostanza, l’IRAP non sarebbe nemmeno qualificabile come tributo sul volume d’affari ai
sensi dell’art. 33 della Sesta Direttiva IVA ma si risolverebbe in un’imposta sulla capacità contributiva
globale dell’impresa, che andrebbe desunta dal valore netto della produzione.
Le conclusioni cui giunge il giudice tributario in questa sede sono in linea con quanto più volte
ribadito da una parte della dottrina.
È stato affermato, infatti, che se sia considera la “sostanza economica” delle possibili
manifestazioni di capacità contributiva, la diversità dell’IVA e dell’IRAP emerge in modo chiaro ed
1
evidente1. L’IVA è un’imposta sui consumi, il cui meccanismo consente di tassare l’incremento di valore
in ogni fase del processo produttivo ma relativamente alla sola componente dei beni di consumo (nella
determinazione dell’imposta, infatti, si riconosce la deducibilità totale degli acquisti dei beni di
investimento). L’IRAP, invece, è un’imposta sui redditi e costituisce un’imposta sul valore aggiunto in
senso proprio, nel senso che fa riferimento alla somma delle remunerazioni di tutti i fattori produttivi
impiegati (in questo caso, nella determinazione dell’imposta viene riconosciuta la deducibilità delle spese
per beni strumentali solamente nella quota degli ammortamenti)2.
Come già evidenziato, dunque, l’IVA è un’imposta sui consumi, anche se i modi di intendere
giuridicamente il concetto di consumo possono essere diversi. L’IRAP, invece, resta un’imposta sui
redditi anche se colpisce solamente una parte di essi; la manifestazione economica cui si rivolge l’IRAP
sarebbe dunque, in questo senso, una species del genus “reddito”3.
Passiamo ora ad esaminare gli aspetti di diritto comunitario che vengono in rilievo nella
pronuncia in commento.
La Commissione ritiene che l’art. 33 della Sesta Direttiva IVA (direttiva in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra d’affari) ponga un
divieto impreciso, vago e generico e che, pertanto, non sia una norma dotata di efficacia diretta.
Come è noto, tale norma prevede espressamente che non è vietato “ad uno Stato di mantenere
o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle sommesse, accise, imposte
di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla
cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi tra Stati
membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera”.
La Corte di giustizia ha sempre interpretato tale disposizione nel senso che rimane preclusa agli
Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di
imposte sulla cifra d’affari4. Tale norma, infatti, ha lo scopo di impedire che il funzionamento dell’IVA a
livello comunitario sia compromesso da eventuali provvedimenti fiscali di uno Stato membro che
vanno ad incidere sulla circolazione dei beni e dei servizi in modo analogo all’IVA.
Secondo il giudice tributario, che considera esclusivamente il tenore letterale della norma, l’art.
33 della Sesta Direttiva IVA non indicherebbe o chiarirebbe in alcun modo il limite obiettivo,
quantitativo o qualitativo di similarità o di analogia strutturale o funzionale del tributo da confrontare
con l’IVA. La fissazione di tali limiti, a giudizio della Commissione Tributaria, sarebbe indispensabile ai
fini dell’effettiva operatività del divieto comunitario; in assenza di indicazioni relative a detti limiti la
norma non potrebbe produrre effetti diretti.
In proposito si ricordi che, come più volte chiarito dalla Corte, affinché una norma comunitaria
possa essere considerata direttamente efficace deve presentare i requisiti della sufficiente precisione e
dell’incondizionatezza5. In altre parole, sono dotate di efficacia diretta tutte le disposizioni comunitarie
che siano sufficientemente chiare e precise e la cui applicazione non richieda l’emanazione di ulteriori
atti di esecuzione, ivi comprese dunque quelle che impongono obblighi di non fare. Con riferimento a
tale ultimo aspetto, si consideri poi che la giurisprudenza sull’effetto diretto è nata proprio con
riferimento ad una norma rivolta agli Stati membri, che prevedeva a carico degli stessi un obbligo di non
facere. Più precisamente nel caso Van Gend en Loos del 19636, la Corte aveva riconosciuto efficacia diretta
all’art. 12 del Trattato (ora abrogato), il quale vietava tra gli Stati membri l’imposizione di dazi doganali.
V. in tal senso R. Lupi, Prelievo che colpisce in direzioni differenti, in Il Sole 24 ore, 17 marzo 2005, p. 25; cfr. anche R. Lupi, R.
Montagnani, Dialettica IVA – IRAP e primi confronti giuristi – economisti, in Dialoghi di Diritto Tributario, n. 1/2005.
2 G. Arachi, A. Zanardi, Un colpo a tutti i sistemi tributari, in Il Sole 24 ore, 22 marzo 2005, p. 26.
3 Cfr. R. Lupi, cit., Il Sole 24 ore.
4 Cfr. sentenza 3 marzo 1988, Bergandi, causa 252/86 (par. 10 e 11); sentenza 13 luglio 1989, Wisselink e a., cause riunite
93/88 e 94/88 (par. 13 e 14); sentenza 31 marzo 1992, Dansk Denkavit e Poulsen Trading, causa C-200/90 (par. 10); sentenza
17 settembre 1997, Fricarnes, causa C-28/96 (par. 36); sentenza 29 aprile 2004, GIL Insurance, causa C-308/01 (par. 31).
5 Per un approfondimento sul punto, v. S. Amadeo, Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano, 2002,
pp. 127 e ss..
6 Sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend en Loos, causa 26/62.
1
2
A quest’obbligo, infatti, non faceva riscontro alcuna facoltà degli Stati membri di subordinarne
l’efficacia all’emanazione di un provvedimento di diritto interno.
Ciò posto, risulta pertanto evidente che le norme che impongono dei divieti non possono
generalmente, per loro stessa natura, disciplinare le singole fattispecie “in via alternativa”, così come
sembrerebbe richiedere invece la Comm. Trib. Prov. di Padova.
Per quanto concerne, infine, le conseguenze derivanti dall’efficacia diretta di una norma
comunitaria, si rammenta che esse risiedono principalmente nella possibilità per i singoli di invocare
dette norme in giudizio. Una norma dotata di efficacia diretta è infatti idonea a produrre diritti ed
obblighi in capo ai singoli e conferisce agli stessi la possibilità di far valere dinanzi al giudice nazionale la
posizione giuridica soggettiva vantata in forza della norma comunitaria7.
Posto che l’art. 33 della VI Direttiva IVA non avrebbe efficacia diretta, i giudici di Padova,
nell’interpretare tale disposizione, si spingono oltre. Essi ritengono, infatti, che l’art. 33 non contiene
una disciplina alternativa e incompatibile con le norme nazionali. Tale norma, dunque, non sarebbe
direttamente applicabile in luogo della norma nazionale in base al principio del primato del diritto
comunitario. Secondo la Commissione non si tratterebbe allora di applicare direttamente il diritto
comunitario al posto del diritto nazionale “ma di cancellare, disapplicandolo, quest’ultimo”, prerogativa che
spetterebbe alla Corte di giustizia, adita non in via pregiudiziale ex art. 234 TCE bensì ad iniziativa della
Commissione o di altri Stati membri.
Orbene, tali affermazioni della Commissione non sembrano trovare fondamento alcuno
nell’ordinamento comunitario. Va ricordato, in primo luogo, che una cosa è la disapplicazione di una
norma da parte di un giudice con effetti limitati al giudizio a quo, altra è la rimozione di tale norma
dall’ordinamento, che può avvenire esclusivamente per abrogazione da parte del legislatore ovvero a
seguito di una declaratoria di incostituzionalità ad opera della Corte Costituzionale.
Per converso il giudice nazionale ha il “potere-dovere” di procedere alla disapplicazione del
diritto nazionale a tutela dei diritti dei singoli originanti nell’ordinamento comunitario, qualora egli
ritenga che la norma nazionale sia in contrasto con una norma comunitaria avente effetti diretti. Tale
potere-dovere, come vedremo, gli è stato riconosciuto sia dalla giurisprudenza comunitaria che da
quella della Corte costituzionale italiana.
Il giudice nazionale può comunque, qualora lo ritenga opportuno, adire in via pregiudiziale la
Corte di giustizia. La capacità di una norma comunitaria di produrre effetti diretti costituisce infatti
questione che attiene all’interpretazione della norma e rientra pertanto nella competenza pregiudiziale
della Corte di giustizia8. Non è dato capire, dunque, in base a quale principio sarebbe preclusa al giudice
nazionale la facoltà di adire la Corte di giustizia.
Poco chiaro risulta altresì il richiamo ad un non meglio precisato procedimento instaurato
davanti alla Corte di giustizia “ad iniziativa della Commissione europea ovvero di altri Stati eventualmente interessati
all’applicazione del divieto”, che darebbe luogo ad una “pronuncia di invalidità della stessa legge istitutiva
dell’IRAP”. Sembra che con tali espressioni il giudice tributario abbia inteso fare riferimento al ricorso
per infrazione, disciplinato dagli artt. 226 e 227 TCE. Come è noto, tale procedimento ha ad oggetto la
violazione da parte di uno Stato membro di uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del Trattato e
può essere promosso ad iniziativa della Commissione, custode della legalità comunitaria, nonché
(ipotesi questa meno frequente) ad iniziativa di uno Stato membro. Nel caso di infruttuoso esperimento
della fase precontenziosa, la fase contenziosa, che si viene ad instaurare successivamente, si conclude
con una sentenza di mero accertamento della Corte di giustizia. In caso di accoglimento del ricorso,
infatti, la Corte si limita a riconoscere che lo Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso
derivanti dal Trattato. La pronuncia della Corte non sarà dunque una sentenza di accertamento
costitutivo con la quale viene annullato un provvedimento nazionale riconosciuto incompatibile con il
Trattato ma, appunto, una sentenza di mero accertamento.
Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2003, pp. 162 e ss.; v. anche S. Prechal, Directives in EC Law, Oxford, 2005; T. C.
Hartley, The foundations of European Community Law, Oxford, 2003, p. 197 e ss..
8 Cfr. L. Daniele, Diritto dell’Unione europea – Dal piano Schuman al progetto di Costituzione per l’Europa – Sistema istituzionale,
ordinamento, tutela giurisdizionale, Milano, 2004, p. 161.
7
3
Dopo aver sostenuto che lo strumento del rinvio pregiudiziale non sarebbe quello più adatto
per procedere alla disapplicazione di una norma interna, la Commissione Tributaria muta
sostanzialmente orientamento affermando che per poter procedere alla disapplicazione del diritto
interno a favore del diritto comunitario, il giudice nazionale dovrebbe attendere una pronuncia della
Corte di giustizia, adita eventualmente in via pregiudiziale. Non vi è dubbio, invece, sul fatto che il
giudice nazionale può anche d’ufficio procedere alla disapplicazione della norma interna qualora
riconosca che la norma comunitaria ha efficacia diretta e non è assolutamente necessaria, dunque, una
preventiva pronuncia della Corte.
Sostenere poi che nel caso di specie un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 234
TCE non consentirebbe comunque di superare la presunta genericità ed aspecificità del divieto posto
dall’art. 33 della Sesta Direttiva significa sostanzialmente negare la funzione di interpretazione del diritto
comunitario attribuita alla Corte di giustizia, le cui sentenze sono altresì vincolanti per il giudice
remittente.
È vero, come riconosciuto dalla Commissione Tributaria, che l’applicazione delle norme è
riservata al giudice nazionale. L’interpretazione del diritto comunitario è tuttavia riservata alla Corte di
giustizia, come indicato espressamente dall’art. 220 TCE9 e come altresì riconosciuto dalla stessa Corte
Costituzionale italiana, che ha definito la Corte di giustizia “interprete qualificata del Trattato di Roma ”10.
A tal proposito, si ricordi che non è attribuito alla Corte il potere di interpretare le norme degli
Stati membri o di pronunciarsi sull’incompatibilità di una norma nazionale con una norma comunitaria,
compiti esclusivi del giudice nazionale che ha effettuato il rinvio. Nel caso in cui alla Corte vengano
proposte questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con il diritto comunitario di specifiche norme
interne, la Corte – pur essendo di fatto incompetente a pronunciarsi su tali questioni – sovente fornisce
al giudice nazionale gli elementi interpretativi che gli consentono di valutare l’eventuale compatibilità
delle norme interne con il diritto comunitario. In questo modo, si permette che ai giudici nazionali di
utilizzare il rinvio pregiudiziale per ottenere sostanzialmente dalla Corte un giudizio sulla norma interna.
Tali ipotesi sono note in dottrina come ipotesi di c.d. uso alternativo del rinvio pregiudiziale11.
Ritornando alla questione della disapplicazione del diritto interno (in quanto in contrasto con la
normativa comunitaria dotata di efficacia diretta) da parte del giudice nazionale, giova ricordare che,
come già evidenziato, tale potere è stato sempre riconosciuto al giudice nazionale, non solo dalla Corte
di giustizia ma anche dalla Corte costituzionale italiana.
Proprio in tema di direttive, la Corte di giustizia, nel noto caso Van Duyn, ha affermato che
sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dal Trattato alla direttiva escludere la possibilità
che l’obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati. La portata di una direttiva
sarebbe di fatto limitata se i singoli non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici
nazionali non potessero prenderla in considerazione come norma di diritto comunitario12.
Già con la sentenza Simmenthal del 197813 la Corte di giustizia aveva chiarito che “il giudice
nazionale, incaricato di applicare nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto
comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza di
propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza
doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale”. Tale orientamento è poi stato recepito anche dalla Corte Costituzionale
italiana con la sentenza Granital del 1984, la cui pronuncia aveva ad oggetto alcuni regolamenti
comunitari. Successivamente la giurisprudenza ha riconosciuto al giudice il potere di applicare
L’art. 220 TCE statuisce che “la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il
rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente trattato”.
10 Cfr. Corte cost. sentenza 23 aprile 1985, n. 113, BECA.
11 Cfr. L. Daniele, cit., p. 248.
12 Sentenza 4 dicembre 1974, Van Duyn, causa 41/74.
13 Sentenza 9 marzo 1978, Simmenthal, causa 106/77.
9
4
direttamente non solo i regolamenti ma anche tutte le fonti normative comunitarie dotate di effetti
diretti14 nonché le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia15.
Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto di tutta evidenza come sia riconosciuto al giudice
nazionale il potere di disapplicare la norma interna qualora questa si ponga in contrasto non solo con la
normativa comunitaria dotata di efficacia diretta ma anche eventualmente con i principi interpretativi
resi dalla Corte di giustizia adita in via pregiudiziale16.
Un’ultima riflessione sul ruolo del giudice interno. La Comm. Trib. ritiene che attribuire al
giudice interno il potere di “cancellare” una norma statale comporterebbe il riconoscimento allo stesso
giudice di “un ruolo in qualche modo politico”. Orbene, come già chiarito, il potere di “cancellare” una
norma non spetta senz’altro al giudice tributario bensì ad altri organi.
Per quanto riguarda poi il riferimento fatto dalla Comm. Trib. alle sentenze della Corte di
giustizia adita in via pregiudiziale ed al riflesso di queste sul ruolo del giudice nazionale, si ritiene che tali
pronunce non comportino alcun ampliamento dei poteri del giudice remittente. La questione va
piuttosto posta in altri termini, ovvero in termini di uniforme applicazione del diritto comunitario. La
competenza pregiudiziale, infatti, è finalizzata principalmente “ad evitare divergenze nell’interpretazione del
diritto comunitario che i tribunali nazionali devono applicare” ma ha anche come scopo quello di “garantire tale
applicazione, offrendo al giudice il mezzo per sormontare le difficoltà che possono insorgere dall’imperativo di conferire al
diritto comunitario piena efficacia nell’ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri”17.
Non è dato cogliere dunque alcun tentativo di modifica dei poteri del giudice nazionale da parte
della Corte di giustizia, avendo questa esclusivamente la funzione di essere di ausilio ai giudici nazionali
nell’interpretazione del diritto comunitario.
Suscita infine qualche perplessità il fugace cenno fatto dalla Commissione Tributaria alla
giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente, si suppone, all’art. 33 della Sesta Direttiva IVA.
Fermo restando quanto già esposto in merito al potere interpretativo delle norme comunitarie da parte
del Corte di giustizia, non si può non considerare il precedente giurisprudenziale costituito dalla
sentenza Dansk Denkavit del 31 marzo 199218. In tale sede il giudice comunitario ha affermato che il
divieto imposto agli Stati membri dall' art. 33 della Sesta direttiva IVA, essendo chiaro, preciso e
incondizionato, soddisfa le condizioni subordinatamente alle quali le disposizioni di una direttiva
possono essere fatte salve dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Tale norma conferisce quindi ai privati
diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
Nel caso di specie assume poi un particolare rilievo il caso Becker del 198219. Tale pronuncia, pur
avendo ad oggetto una diversa disposizione della Sesta Direttiva IVA20, chiarisce non solo la portata di
detta Direttiva ma anche la questione dell’efficacia diretta delle direttive. La Corte parte dal presupposto
che la Sesta Direttiva IVA è una direttiva di armonizzazione che riserva agli Stati membri, sotto vari
aspetti, un margine di discrezionalità implicante determinate facoltà e opzioni. Sebbene tale Direttiva
Cfr. Sentenza 18 aprile 1991, n. 168, Giampaoli: tale sentenza ha esteso anche alle direttive quanto già affermato per i
regolamenti con la sentenza Granital.
15 Cfr. sentenza 23 aprile 1985, n. 113, BECA.
16 Con riferimento alla questione relativa al valore che possono assumere le norme comunitarie all’interno degli ordinamenti
degli Stati membri, si osservi, inoltre, che sono state riconosciute al diritto comunitario anche forme di efficacia indiretta.
Una di tali forme è stata individuata non solo dalla giurisprudenza comunitaria ma anche della Corte costituzionale italiana
nel c.d. obbligo di interpretazione conforme (cfr. sentenza 10 aprile 1984, Von Colson; sentenza 13 novembre 1990,
Marleasing, causa C-106/89; sentenza Corte Cost. italiana n. 170 del 8 giugno 1984, Granital; per un approfondimento v. S.
Amadeo, Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano, 2002, pp. 215 e ss.). Nel caso in cui, infatti, si
vada ad interpretare le norme nazionali, sarà necessario procedere alla loro interpretazione in conformità a quanto previsto
dal diritto comunitario, anche quando questo non sia direttamente efficace. Orbene, in presenza di norme comunitarie
dotate di effetti diretti, il giudice nazionale applicherà direttamente la norma comunitaria disapplicando la norma nazionale
configgente; in ipotesi di interpretazione conforme, il giudice nazionale applicherà comunque la norma interna, interpretata
però alla luce di quanto disposto dalla normativa comunitaria.
17 Sentenza 16 gennaio 1974, Rheinmuehlen, causa 166/73.
18 Sentenza Dansk Denkavit, cit..
19 Sentenza 19 gennaio 1982, Becker, causa 8/81.
20 La sentenza aveva ad oggetto l’art. 13 lett. della Direttiva, in materia di esenzioni.
14
5
implichi incontestabilmente, a favore degli Stati membri, un margine di discrezionalità più o meno
ampio per l’attuazione di talune delle sue disposizioni, “non si può tuttavia negare ai singoli il diritto di far
valere quelle disposizioni che, tenuto conto del loro oggetto specifico, sono atte ad essere isolate dal contesto ed applicate come
tali. Questa garanzia minima, a favore degli amministrati lesi dalla mancata attuazione della direttiva, deriva dal
carattere vincolante dell’art. 189 [ora art. 249], paragrafo 3 del Trattato”. Come è noto tale disposizione
prevede che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, restando salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.
Secondo la Corte, quest’obbligo sarebbe reso del tutto inoperante qualora fosse consentito agli Stati
membri di annullare anche gli effetti che talune disposizioni di una direttiva sono atte a produrre in
forza del loro contenuto. Il giudice comunitario conclude dicendo che “non si può quindi far valere il
carattere generale della direttiva di cui trattasi o l’ampiezza del potere discrezionale che essa lascia d’altra parte agli Stati
membri, per negare qualsiasi efficacia a quelle disposizioni che, tenuto conto del loro oggetto, sono atte ad essere utilmente
fatte valere in giudizio.”21
La Comm. Trib. Prov. di Padova sembra tuttavia non aver seguito le indicazioni fornite dalla
Corte di giustizia nel caso Becker né tanto meno ha ritenuto di doversi conformare all’interpretazione
dell’art. 33 della Sesta Direttiva IVA resa dal giudice comunitario nel caso Denkavit, giudicando il divieto
di cui all’art. 33 sopra citato “assolutamente generico e impreciso, e come tale non direttamente applicabile dal giudice
nazionale”.
Non ci resta che attendere, impazienti, la pronuncia della Corte di giustizia con l’auspicio che
anche i giudici nazionali si rendano più sensibili alle problematiche sollevate dall’applicazione del diritto
comunitario.
Flavia Tomat
Dottoranda di Ricerca in Diritto dell’Unione europea
Università degli Studi di Trieste
21
Sentenza Becker, cit., par. 28 – 30.
6