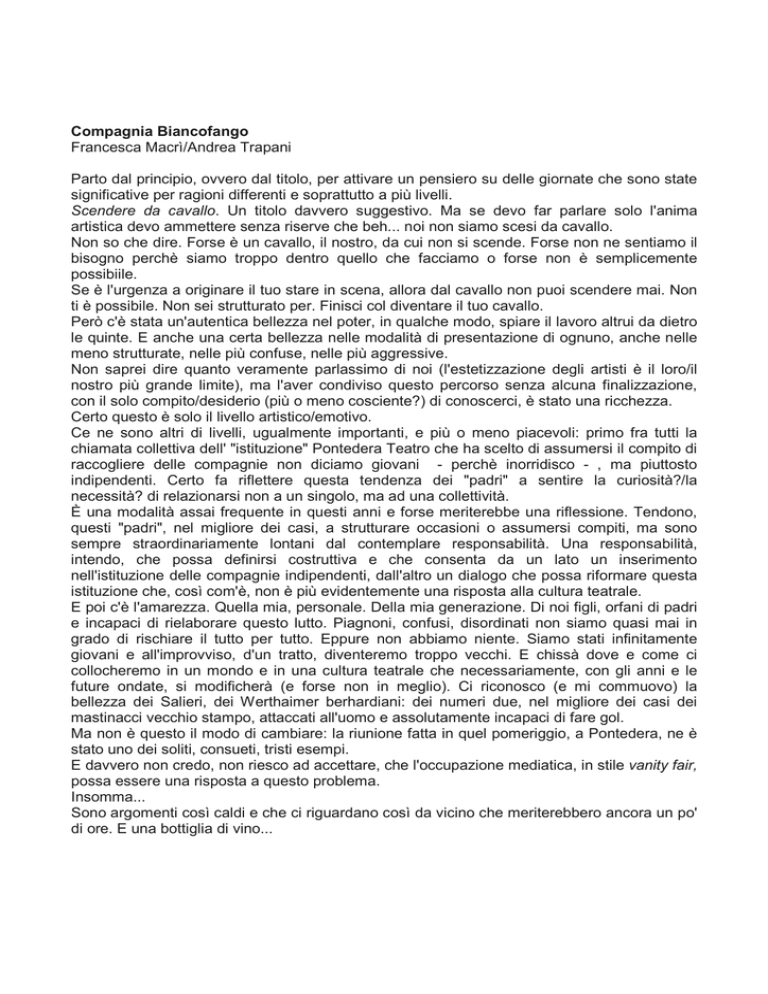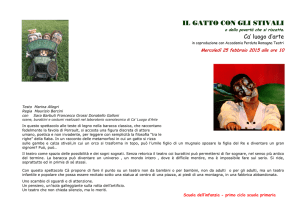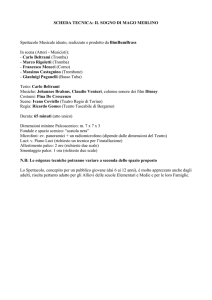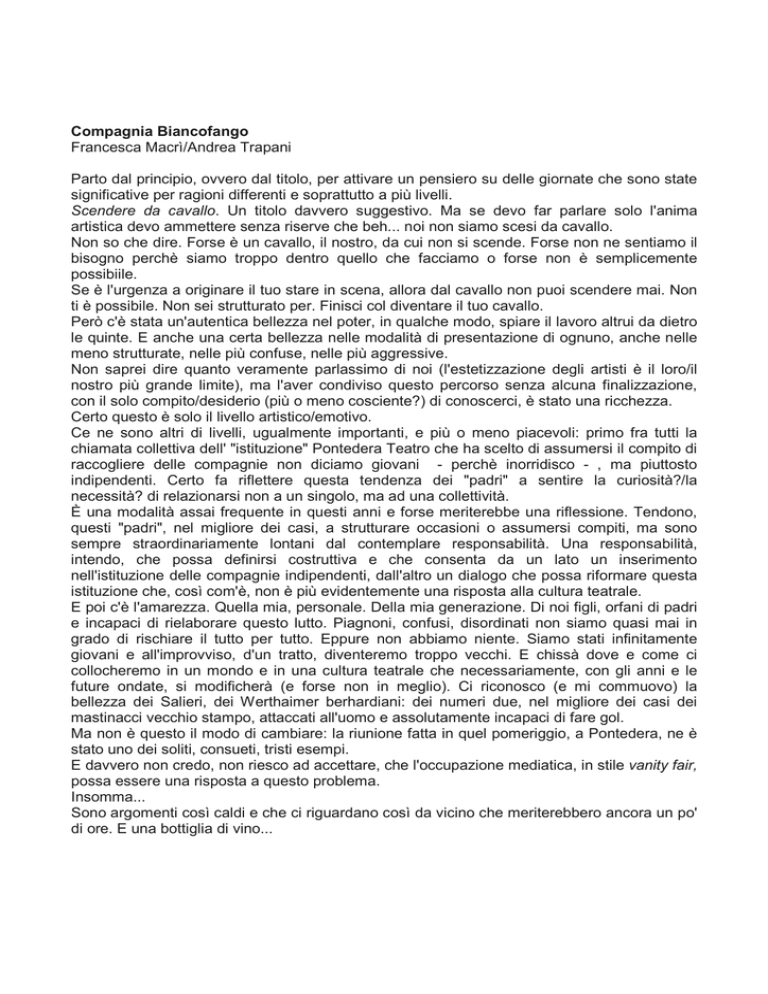
Compagnia Biancofango
Francesca Macrì/Andrea Trapani
Parto dal principio, ovvero dal titolo, per attivare un pensiero su delle giornate che sono state
significative per ragioni differenti e soprattutto a più livelli.
Scendere da cavallo. Un titolo davvero suggestivo. Ma se devo far parlare solo l'anima
artistica devo ammettere senza riserve che beh... noi non siamo scesi da cavallo.
Non so che dire. Forse è un cavallo, il nostro, da cui non si scende. Forse non ne sentiamo il
bisogno perchè siamo troppo dentro quello che facciamo o forse non è semplicemente
possibiile.
Se è l'urgenza a originare il tuo stare in scena, allora dal cavallo non puoi scendere mai. Non
ti è possibile. Non sei strutturato per. Finisci col diventare il tuo cavallo.
Però c'è stata un'autentica bellezza nel poter, in qualche modo, spiare il lavoro altrui da dietro
le quinte. E anche una certa bellezza nelle modalità di presentazione di ognuno, anche nelle
meno strutturate, nelle più confuse, nelle più aggressive.
Non saprei dire quanto veramente parlassimo di noi (l'estetizzazione degli artisti è il loro/il
nostro più grande limite), ma l'aver condiviso questo percorso senza alcuna finalizzazione,
con il solo compito/desiderio (più o meno cosciente?) di conoscerci, è stato una ricchezza.
Certo questo è solo il livello artistico/emotivo.
Ce ne sono altri di livelli, ugualmente importanti, e più o meno piacevoli: primo fra tutti la
chiamata collettiva dell' "istituzione" Pontedera Teatro che ha scelto di assumersi il compito di
raccogliere delle compagnie non diciamo giovani - perchè inorridisco - , ma piuttosto
indipendenti. Certo fa riflettere questa tendenza dei "padri" a sentire la curiosità?/la
necessità? di relazionarsi non a un singolo, ma ad una collettività.
È una modalità assai frequente in questi anni e forse meriterebbe una riflessione. Tendono,
questi "padri", nel migliore dei casi, a strutturare occasioni o assumersi compiti, ma sono
sempre straordinariamente lontani dal contemplare responsabilità. Una responsabilità,
intendo, che possa definirsi costruttiva e che consenta da un lato un inserimento
nell'istituzione delle compagnie indipendenti, dall'altro un dialogo che possa riformare questa
istituzione che, così com'è, non è più evidentemente una risposta alla cultura teatrale.
E poi c'è l'amarezza. Quella mia, personale. Della mia generazione. Di noi figli, orfani di padri
e incapaci di rielaborare questo lutto. Piagnoni, confusi, disordinati non siamo quasi mai in
grado di rischiare il tutto per tutto. Eppure non abbiamo niente. Siamo stati infinitamente
giovani e all'improvviso, d'un tratto, diventeremo troppo vecchi. E chissà dove e come ci
collocheremo in un mondo e in una cultura teatrale che necessariamente, con gli anni e le
future ondate, si modificherà (e forse non in meglio). Ci riconosco (e mi commuovo) la
bellezza dei Salieri, dei Werthaimer berhardiani: dei numeri due, nel migliore dei casi dei
mastinacci vecchio stampo, attaccati all'uomo e assolutamente incapaci di fare gol.
Ma non è questo il modo di cambiare: la riunione fatta in quel pomeriggio, a Pontedera, ne è
stato uno dei soliti, consueti, tristi esempi.
E davvero non credo, non riesco ad accettare, che l'occupazione mediatica, in stile vanity fair,
possa essere una risposta a questo problema.
Insomma...
Sono argomenti così caldi e che ci riguardano così da vicino che meriterebbero ancora un po'
di ore. E una bottiglia di vino...
Carrozzeria Orfeo
Abbiamo pensato, nel nostro intervento, di concentarci soprattutto sulle fasi conclusive del
progetto, per poter ripercorrere il senso di questa bellissima esperienza presso il Teatro Era.
Per quattro intense giornate, ogni gruppo ha provato a raccontare ai colleghi presenti gli
elementi essenziali della propria poetica, cercando connessioni, condividendo esperienze e
delineando le adesioni, le differenze e le rotture del proprio modo di pensare l'arte rispetto alla
tradizione, alla situazione attuale, alle tendenze del sistema e alle mode. La cosa che
abbiamo notato, interessante da sottolineare, è che per molti artisti l'obbligo di raccontarsi e
farsi comprendere dai colleghi, che giustamente non hanno esitato a proporre domande e
chiedere delucidazioni, si è rivelato molto utile per fare chiarezza anche dentro se stessi. Le
domande e le provocazioni non hanno solo contribuito a favorire una precisione
terminologica, lessicale e tecnica nel sapersi comunicare, ma hanno stimolato gli artisti a
condividere una visione e una direzione poetica individuale e precisa.
"Scendere da Cavallo" per guardarsi intorno e capire dove vogliamo andare artisticamente,
eticamente ed umanamente al di là di frasi fatte, di "pippe intellettuali", astrazioni, citazioni,
considerazioni troppo generiche. Scendere da cavallo ci ha "costretti" a mettere un faro su noi
stessi senza essere in scena, senza la protezione dello spettacolo, delle luci e del testo che
dobbiamo recitare. Crediamo che ognuno abbia tentato ti togliere le proprie croste, i propri
pregiudizi, le proprie difese. Molti di noi dopo il primo giorno hanno addirittura tolto la propria
sciarpetta da attore o intellettuale di sinistra perché forse stavamo capendo che il nostro
teatro ha bisogno di meno attori e più esseri umani.
Nel momento in cui si è parlato della possibilità di dare una continuità al progetto sono
emerse idee e proposte molte diverse, ma soprattutto differenti modalità di pensiero e
riflessione sui significati e le potenziali prospettive dei quattro giorni passati insieme.
Qualcuno era interessato ad un'esperienza residenziale collettiva all'interno della quale ogni
artista potesse assistere alle prove dei colleghi di altri gruppi. Altri hanno proposto una
produzione che coinvolgesse la totalità delle compagnie. Altri ancora hanno suggerito l'ipotesi
di organizzare uno "scendere da cavallo 2", estendendo l'invito ai colleghi europei.
Il nostro punto di vista, per quanto discutibile, credo sia stato chiaro: abbiamo interpretato
l'occasione e il regalo di Pontedera Teatro" come uno stimolo, come l'innesco di qualcosa da
proseguire anche da soli. Non intendo dire che in generale saremmo contrari alla
prosecuzione del progetto, ma sicuramente riflettiamo sul fatto che Roberto Bacci più che uno
spazio, del cibo e delle risorse, ci abbia regalato un pensiero. Un pensiero di solidarietà, di
confronto, contaminazione e scambio tra diversi artisti che quotidianamente più che colleghi
si relazionano come concorrenti. Un pensiero sulla possibilità reale di perseguire nuove
dinamiche nel sistema all'interno del quale lavoriamo. Un pensiero che ci chiede una visione
più ampia nel nostro vivere il teatro. Abbiamo inteso questo progetto più che come una
collaborazione come una staffetta, un passaggio di testimone.
Roberto Bacci ci ha fatto capire chiamaramente, talvolta con provocazioni dirette, talvolta in
modo più sottile, che non gli interessava garantire necessariamente una continuità a
"Scendere da cavallo" perchè avere la certezza che una seconda edizione ci avrebbe messo
nuovamente in una condizione di troppa sicurezza e comodità, mentre lui ha lavorato proprio
sul contrario: sul disequilibrio e la scomodità.
Implicitamente credo abbia detto: «Siete in grado di rifarlo da soli se davvero lo volete? Siete
pronti ad un atto di maturità che vi faccia riscoprire questo mestiere non solo come atto
performativo, ma come pratica etica? Ne avete compreso il senso? Sveglia!».
Ed è questo secondo noi il punto centrale, il significato profondo di quest'esperienza.
"Scendere da cavallo" ha creato un confine preciso tra il "sistema" che conosciamo ed alcune
possibilità per il "sistema" che vogliamo contribuire a creare.
Ed ecco che improvvisamente ti accorgi di essere in una stanza con altri quaranta colleghi e
per quanto tu non ti stia esibendo ti accorgi che quello che sta accadendo è "teatro di ricerca"
nel senso meno inflazionato, generico, astratto e ghettizzante del termine. Teatro di ricerca
come abbandono di una dimensione esclusivamente performativa, infantile ed egoistica, a
favore di una presa di coscienza etica e collettiva, e quindi politica.
Noi abbiamo imparato ad essere felici e grati per quello che riceviamo. Una compagnia deve
assolutamente capire che ci sono delle cose che ha il diritto e il dovere di pretendere dal
"sistema" ed altre che non gli sono affatto dovute. Noi siamo stati selezioni per partecipare a
quattro giornate stupende, un privilegio che non diamo per scontato. Siamo convinti che
questi momenti insieme se pur brevi, al di là di possibili riedizioni future, ci abbiano aiutato a
comprendere ancora meglio quale sia il nostro posto, quale il senso e quali le direzioni,
perché se riflettiamo per un istante ci accorgiamo di non essere altro che piccoli tramite, fragili
medium di qualcosa di certamente più grande.
"Scendere da cavallo" ci ha chiesto di fare un passo indietro, per osservare tutto ciò che
viene prima dei nostri spettacoli e delle nostre ambizioni. Ci ha chiesto, in fondo, un piccolo
atto di umiltà e mentre scriviamo ci viene da sorridere e al tempo stesso ci rincuora il pensiero
che qualunque cosa tu faccia o dica il "TEATRO" sarà sempre più intelligente di te.
Reso-conto di un dono a forma di pausa con-divisa.
Carullo-Minasi
«Moltiplicare, non assommare…» ha detto Roberto Bacci.
Queste le parole che per noi hanno meglio sintetizzato e compreso la forza e l’incanto di
questa grande occasione di comunicazione, nella suo più antico e sincero significato
etimologico, cum-munis: mettere insieme i doni.
Così, nel “Tempio Sacro del Teatro Era”, alla presenza di giovani, meno giovani, ma
professionisti tutti dediti all’arte dell’azione, c’eravamo anche noi, a parlare per ultimi,
tentando la nostra discesa da cavallo, regalando la nostra piccolezza.
Non è stato facile, ma neanche poi tanto difficile. È stato un gioco, un gran bel gioco, per il
quale trovare delle regole comuni, senza pretesa competitiva alcuna, su temi o forse solo su
parole cui troppo spesso, per la qualità del mestiere medesimo, si è condannati a riflettere
nella solitudine della ricerca personale.
Così, nell’inaspettata definizione d’un dizionario con-diviso, le parole son diventate attive:
alcune le abbiamo insieme ri-scoperte, altre si sono più e più volte ribaltate, altre le si sono
abbandonate.
Tutto ciò è accaduto in una profonda dinamica dialettica, volta alla migliore valorizzazione
della diversità dei tanti partecipanti e delle molteplici inevitabili possibilità di cui la diversità
medesima, da intendersi quale imprescindibile valore, si è fatta portatrice.
Così, arrivato il momento della nostra discesa - piccoli, autoironici e caustici come sempre abbiamo proprio battuto le orme calde della complessità, della varietà e della molteplicità e,
con un pizzico d’orgoglio, siamo partiti da quello che siamo, dalla nostra storia personale e
professionale dunque dal nostro salvifico limite tradotto in questa nostra prima, tanto
fortunata opera, dal titolo Due passi sono.
«È dal limite che vien fuori l’opera d’arte»: sono parole di Tadeusz Kantor.
Abbiamo giocato, nel nostro intervento, a proclamare la sovranità dell’essere
meravigliosamente diversi gli uni dagli altri e dell’essere, quali autori/attori, straordinariamente
molteplici rispetto a noi stessi, proprio partendo dalla nostra tanto pazza società che,
contrariamente, compie di continuo il grave delitto d'uniformazione delle menti e dei corpi,
consentendo che s’investa la propria intera esistenza a dimenticarsi, a cancellarsi, per
compiere lo strano rito del rassomigliarsi tutti fra tutti.
Noi, con i nostri piccoli atti teatrali, dichiariamo la nostra rivoluzione: non ci sforziamo di
essere molto diversi da quello che siamo, crediamo che sia la diversità a rendere uguali gli
uomini, a renderli tutti sostanzialmente e non piuttosto solo formalmente liberi!
È nato così Due passi sono: da noi, per noi, con noi, con la grande speranza ed illusione di
una riconoscibilità per tutti. Non è stata un'idea a muoverci, ma più propriamente la forte
necessità di far qualcosa di concreto, di riscattare la voglia e la forza di essere vivi.
Volevamo, tramite il limite in cui ci siamo trovati immersi per uno stato di momentanea
difficoltà fisica di Giuseppe, raccontare l'indescrivibile forza di cui è portatore l'uomo. Più che
per concetti, abbiamo avuto l'intuizione di operare per giochi di relazione, d'improvvisazione
scenica che poi hanno costituito la base di elaborazione del testo. I primi cinque minuti,
previsti per la prima selezione di Scenario a Palermo, sono stati elaborati con forte gioia ed
incanto, solo seduti al tavolo di un bar con un piccolo taccuino dove, con perizia, abbiamo
segnato i punti di una struttura in possibile divenire. Parlavamo di una quotidianità, che poi
era quella che al momento ci capitava di vivere, caratterizzata da una miriade di prescrizioni e
divieti, che rendevano la possibile guarigione di Pe, assolutamente invivibile. Lo spettacolo è
sì, per certi aspetti, autobiografico ma la scommessa più grande è stata quella di
trasformare la vicenda della malattia in pretesto per potere raccontare un qualcosa di più
ampio, che certo non doveva ridursi a mera vicenda personale. Abbiamo trasformato la
malattia in qualcosa di estremamente divertente, nascostamente invertendo i ruoli e rendendo
colei che avrebbe dovuto aiutare, la vera ammalata da dirigere verso la giusta rotta del fuori e
della libertà.
Abbiamo proceduto per sottrazione: più si è tolto, più ci è stato restituito. In tal senso,
nonostante si fosse partiti dal tema della malattia, della quotidianità patologizzata in vista di
un’ipotetica salvezza fatta di prescrizioni e negazioni, lo spettacolo è misteriosamente - quasi
per opposizione – approdato ai temi dell’amore, della creazione, della libertà, della
conoscenza, del potere desiderare nonostante l’apparente impossibilità.
Nelle varie fasi di definizione della scena, al livello orizzontale della vita/non vita dei due
protagonisti si è reso necessario aggiungere una linea verticale “filosofica/clandestina” che
creasse un congiungimento con le vicende dell’essere umano.
Traendo spunto dall’immagine della scala infinita del Simposio di Platone, il nostro testo ha
passato in rassegna - frammento per frammento, scalino per scalino - piccoli ma infiniti varchi
di luce, molecole di polvere di stelle tentando di volere dare luogo, forma, diritto e giustezza
all’aspirare ad un percorso di conoscenza condiviso. Amore non è vicenda personale tra due,
sia pure formalmente appaia come tale, ma è vicenda universale che deve attenere
poeticamente ciascun uomo nella sua completezza, nella ricerca di quella verità essenziale
fatta di infinito desiderio di conoscenza.
Il nostro è un dialogo dalla struttura ludica volto alla ricerca di una possibile ascesa, nella
direzione di un’immortale via di uscita.
Due passi sono è un inno alla semplicità, vuole glorificare la vita e lo fa parlando del
desiderio. Ma figlio di questo spettacolo non è il desiderio dell’effimero, della cruda materia
ma il desiderio fatto di valore, di quel valore unico che è la vita.
Amore è creazione: ci son mille modi di creare, bisogna a ciò educarsi, bisogna trarre
insegnamento dalla vita per giustificare la vita stessa, di ciascuno, per tutti.
È stato motivo di grande orgoglio poter aver fatto coincidere il nostro impegno autoriale (data
la vittoria del Premio “Scenario per Ustica”) con l'impegno del risveglio delle coscienze.
Crediamo che solo questa sia la strada possibile in un'era quale la nostra, volta
all'aggregazione acritica e al disconoscimento dell'attività del pensiero. Spegnendo la
candelina della nostra rinascita, siamo riusciti a sperare che ciascuna coscienza potesse
avere la forza e la voglia di venire fuori, che i desideri potessero ancora essere espressi e
realizzati.
Il teatro altro non è che impegno civile, e questo è il più bel premio che il teatro ci poteva
consegnare.
Così come un dottore crea un danno oggettivamente riconoscibile e deprecabile se
erroneamente taglia una parte sana al posto di un'altra, così l'attore/autore/regista che sia, ha
la grande responsabilità di rivolgersi al pubblico senza creare né indifferenza o
incomprensione verso l'oggetto di cui si tratta, né danno. Un danno alla coscienza è stimabile
come un grande e grave danno all'umanità tutta.
Il teatro è per tutti e di tutti, non si può certo accettare che la gente non vada a teatro perché
dice di non poterlo capire. Se non lo si capisce vuol dire che non funziona, e se non funziona
bisogna che migliori. Se non comunica vuol dire che non assolve alla sua funzione prima. Chi
fa teatro ha una grande responsabilità, così come chi lo promuove e chi lo gestisce. In
Russia, in Polonia, chi fa teatro è considerato un grande uomo, quasi un eletto, ci si inchina
dinnanzi a tal tipo di maestri perché promotori di idee, strumenti di innovazione del pensiero,
esseri unici, irripetibili nella loro essenza.
Un racconto, il nostro, che ha voluto condensare uno dei tanti modi possibili di intendere i
temi della Verità, forse anche detta Necessità e del suo possibile, meglio, inevitabile
rapporto con la Realtà.
Abbiamo tentato di farci portavoce sì della nostra poetica, ma in realtà d’un più ampio
progetto politico/civile cui speriamo il teatro possa votarsi definitivamente senza commettere
più errori, all’insegna della migliore e più responsabile presa d’atto della complessità dell’atto
o rito teatrale che, perché accada, deve sottendere la cura del rapporto tra tutti i fili d’una
trama comune assai labile ed effimera. V’è da custodire autori, attori, pubblico, critica,
curatori, organizzatori, insomma intervenienti tutti al rito del teatro, al rito dell’atto, dell’atto
scenico che, se miracolosamente accade, può e deve diventare atto civile1.
Prendendo in prestito dalla terminologia giuridica la definizione di azione processuale,
ragioniamo intorno ad un metodo che sia quello del processo e del suo percorso perché
qualcosa possa genuinamente accadere. L’Azione è il miracolo che contraddistingue il teatro,
è quell’Epifanìa da accogliere nel suo mistero, se si tenta di nominarla o spiegarla più non
esisterà. Il nostro teatro tenta di mettere in scena il processo medesimo, tramite un dialogo
volto alla ricognizione della Vera Verità2, col forse troppo ambizioso obiettivo di potere
contrastare i contorcimenti, l’espressività e la falsità che circondano l’era contemporanea.
1
Materiale questo così genericamente accennato di analisi e studio, tramite lo Ione di Platone ed i saggi di T. Kantor e G.
Craig, del futuro monologo di Cristiana dal titolo “Conferenza tragicheffimera sui concetti ingannevoli del Teatro”.
2
Non ci facciamo promotori di un metodo ma, con metodo, tentiamo di seguire un processo per le nostre stesse idee,
perché queste vengano trovate e non immaginate prima. E’ questa ricerca che ci ha condotti verso il nostro nuovo
spettacolo, da titolo “T/Empio -critica della ragion giusta-”.
Abbiamo provato a condurvi in questo nostro percorso paradossalmente a ritroso, alla riscoperta della semplicità e delle sue infinite variabili. Vi promettiamo che faremo di tutto per
mantenere questa poetica, nell’illusione che ci consentano di maturare in un una nuova
ritrovata infanzia. Ci sono mille regole impartite per dimenticare di essere uomini e solo
pochi passi per cominciare ad elaborare, a processare e, forse, reimparare a camminare. Ed
allora eccoci dinnanzi a voi: uomini noi/uomini voi, con la paura e l’orgoglio di errare e di
tremare, ma con la grande volontà di osare. Replica dopo replica tenteremo di non essere
due singoli ma coppia e, con il ricordo di voi, possibile gruppo alla ricerca d’un oggetto
comune: la felicità della Cura, dell’ Amore dunque della Creazione.
Ci interessa potere continuare a credere che sia possibile l’incontro di uomini uniti non da
un’attività comune, ma da una qualità dell’anima: la grandezza, forse?
Immaginiamo queste righe come fossero impronte, in grado di raccontare il cammino
che ci ha condotti fino a voi con la speranza di rincrociare i vostri passi e cominciare
nuovi viaggi su per le vette di questa Crosta, chiamata Terra, che merita di svolazzare
tra le inquietudini dell’atmosfera che ci vogliono far credere cupa.
Con affetto,
Cri e Pe.
Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco
Inizieremo a scrivere tutto quello che ci è piaciuto e che ha contribuito a fare di questa
esperienza una tappa importante del nostro percorso e del percorso con i nostri compagni di
lavoro.
Roberto Bacci ha posto in essere un momento molto complesso ma allo stesso tempo
semplicemente organico e preciso negli obiettivi. Non abbiamo avuto mai la sensazione che
vi fosse qualcosa di diverso da quello che effettivamente è stato. Ha parlato riferendosi ai
quattro giorni come una «regia di uno spettacolo lungo quattro giorni». E possiamo affermare
che il respiro, l'organizzazione, la tempistica della pratica di cui siamo stati attori e spettatori e
critici, era quella di un'opera ben strutturata di un regista visionario.
E continuiamo con l'ammirazione provata per gli altri gruppi.
Abbiamo parlato schiettamente, apertamente, anche con i silenzi, senza commenti. Per noi vi
era una comprensione profonda delle dinamiche e crediamo che tutti fossero coscienti quanto
noi. Difficile poter vivere in altri contesti questa tolleranza del pensiero altrui. Senza
atteggiamento borghese, senza forzature alla convivialità.
Non possiamo non ricordare che sono passati 10 anni tra uno “Scendere da cavallo” e
questo. Dieci anni per rinnovare la volontà di ricominciare, legata ad un pensiero ed una
visione del teatro molto precisa. Una ricerca dello sconosciuto nel senso di fresco, genuino,
acerbo. In fondo abbiamo anche pensato al nostro percorso. Insomma, per quel che ci
riguarda, sono passati 12 anni incredibili e per una sorta di coerenza all'instabilità siamo scesi
dal cavallo in corsa per capire, per ritrovare, per ricominciare nell'eterna fragilità
dell'immateriale.
Fragile? È doveroso chiarire. Non parliamo di assenza di forza. Perché la fragilità è forza
aperta. In questi quattro giorni la nostra fragilità ha avuto una condivisione più ampia, più
critica. Abbiamo accettato questo stato di esposizione, come possibilità. Abbiamo rafforzato
l'idea che ogni occasione, che abbia alla base il molteplice e il contraddittorio, sia il luogo da
cercare. Perché non bastano quattro mura e un gruppo di persone: abbiamo bisogno del
patibolo alle nostre convinzioni.
Il saluto con Roberto Bacci: «…andate altrove...».
Confessiamo che abbiamo provato rabbia a lasciare Pontedera. Quella rabbia che ogni
giorno proviamo per il nostro lavoro mendicante in lotta e in ascolto con l'impossibilità. Dura
poco, molto poco. Il desiderio di libertà, di nomadismo ci riportano sulla strada.
Ma questi quattro giorni non sono stati solo il padrone di casa e i colleghi teatranti.
Partiamo da qualche mese prima, da un'altra occasione.
Durante una giornata di lavoro al focus sulla critica organizzato al Tga di Palermo, veniva
posta una domanda: “voi teatranti permettereste ad un critico di partecipare alle vostre
prove?”. La nostra risposta categorica: “NO”.
Sono passati quattro mesi. Oggi la nostra risposta è “NO”. Perché la domanda continua a non
essere soddisfacente.
Partecipare....
Bisogna chiarire, per evitare derive. Il critico che dichiara fin da subito la sua presenza e la
sua funzione, evita qualsiasi intervento o pressione artistica. È una lente con un'ottica precisa
e un fuoco allenato. Depositario di esperienze dirette del teatro. Insomma conoscenza e
coscienza profondi con cui interagire, aprire varchi, ragionare. Non scriviamo di sensibilità
perché la reputiamo alla base di chi sceglie di fare il critico da grande. Esistono casi che
purtroppo contraddicono le nostre parole, ma questa è un'altra storia.
Sul lavoro degli altri gruppi, non riusciamo a scrivere, perché avremmo avuto bisogno di
approfondire alcuni punti che sono rimasti avvolti dalla nebulosa. Questo crediamo che sia un
pensiero condiviso da tutti. Non è stato facile stare dentro le due ore. Solo con la conoscenza
profonda di se stessi, cioè del proprio percorso, riesci a condensarlo in due ore. Esempio
vivente, Richards. In un'ora ha parlato proprio di 30 anni. Come? Dopo l'incontro ci siamo
confrontati. Ci sono dei momenti, delle situazioni, delle esperienze che rimangono come orme
sulla terra e che ti permettono di tornare indietro, di percorrere il cammino nella direzione
opposta. Ci sono orme più profonde di altre. Certo le condizioni di lavoro di Richards sono
archeologia di ricerca teatrale. Oggi sarebbe impensabile creare dal nulla quella bellezza e
quelle condizioni di ricerca.
“Scendere da cavallo” è anche una provocazione. Abbiamo provato un certo dolore a dover
parlare del nostro lavoro… L'incontro con Richards ha acuito il dolore.
La strada è lunga per noi. Abbiamo scelto di non creare una compagnia, che in qualche modo
protegge gli appartenenti e rappresenta ancora un modello di pratica teatrale.
Ecco cosa avremmo voluto approfondire. Siamo sicuri che i modelli di pratica teatrale, che
hanno caratterizzato gli ultimi venti anni, siano ancora garanzia di produttività artistica, di
creatività, di ricerca?
Una domanda rimbalzata nei quattro giorni: “ma noi dove ci collochiamo?”.
Speriamo non nel nuovo capitolo di spesa del ministero, che ti obbliga alla ragione sociale
post contemporanea, pur di starci dentro. Continuiamo ad essere convinti che non bisogna
cercare le condizioni per organizzare un altro appuntamento, un altro “scendere da cavallo”.
Le esperienze sono uniche. Sentiamo la necessità di cercare quelle venature di libertà per far
scorrere il libero pensiero. Questo sì.
Non vogliamo la cristallizzazione in nome di una bella esperienza vissuta. Quello che
potevamo condividere è stato condiviso nel rispetto delle regole del gioco. Va bene così.
Adesso è il nostro turno, gli ospiti diventano ospitanti. Creare un nuovo addensamento, una
nuova concentrazione.
Ma su quali argomenti? La resistenza, la militanza che poniamo con il nostro lavoro?
Parliamo della volontà di non cambiare la nostra progettualità per la paura di rimanere fuori
da un mercato, che non esiste. Parliamo dell'atto volontario di ignorare chi afferma che non
sei necessario. La buona pratica è quella giornaliera, non ha niente a che fare con gli
appuntamenti sporadici. Bisogna costruire il tempo. Riappropriarsene.
Sentiamo la necessità di osservare il teatro che non facciamo e che non faremo. Perché?
Preferiamo chiederci: Dove? Come? Chi?
«…Saliamo sul cavallo e sproniamolo con parole nuove, visioni, immagini, perdizioni. Vorrei
che i maestri avessero il giusto peso, ma anche la giusta misura»: ci riallacciamo volentieri
alle parole di Cristiana Minasi.
Carmelo Bene anelava ad essere dimenticato dal Teatro, ignorato. La lotta però è dura,
perché quando nessuno ti cerca più, ti senti abbandonato.
Da occasioni come quella ospitata ed organizzata a Pontedera usciamo con una speranza ed
una proposta. La prima la custodiamo gelosamente, la seconda si può sintetizzare nella
concertazione di nuove regole per un futuro incontro, seguendo le necessità e le
problematiche che ci appartengono.
Delinearle dentro un tempo, che sarà il nostro tempo denso. Noi saremo lì.
Educazione Fisica/Veronica
Salire in 17 su un cavallo è complicato.
Comunque per salire e scendere servono gli stessi movimenti solo che nel secondo caso
vengono fatti in senso contrario. A noi piacciono le operazioni contrarie.
Certo ci abbiamo provato - le cose facili non ci sono mai piaciute - ma è evidente che non
potevamo perdere troppo tempo per cercare di starci comodi e non è giusto gravare sul
povero cavallo con troppe responsabilità, il suo groppone non può reggere tanto peso. Allora
abbiamo imparato a fare altro: ci sono scudieri, chi sistema il terreno, chi foraggia l'animale,
chi assicura le redini e gli zoccoli. Questo lavoro sul campo ci ha stimolato e ci ha preso al
punto che dopo un po' ci siamo chiesti se c'era ancora il cavallo o se alcuni di noi l'avevano
mai visto.
Ecco forse perché abbiamo molta confidenza con la pratica. Come se tutti noi sapessimo
come si fa a montare e da un momento all'altro potessimo salire in groppa, ma a terra si
imparano tante cose che sul cavallo spesso si perdono di vista, vuoi perché la passeggiata ci
fa dimenticare i pensieri e la fatica della salita, vuoi perché da sopra il destriero lo sguardo è
obbligato in una sola direzione.
Il cavallo, se cresciuto con cura e attenzione, magari non avrà uno stile raffinato e un assetto
da manuale ma sarà capace di tutto, anche di correre come un pazzo se gli sarà data
occasione.
Mi sento davvero fortunata ad aver partecipato attivamente a "Scendere da cavallo".
Essere dalla parte di coloro che vengono chiamati a raccontare un'esperienza che magari
possa suggerire un modo a qualcun'altro - o altresì riconfermare il proprio - è già la
presentazione di un progetto che pretende ASCOLTO, da dare e ricevere. Bene!
Non mi sono sentita forzata o obbligata ad osservare, ma privilegiata. Mi piace vedere svelati
i segreti dell'arte teatrale. Certo, è vero che la sensibilità di ognuno nei confronti di ciò che
osserva è unica e come tale non può sposarsi con tutto.
L' ultimo giorno si è parlato di quest'esperienza, se dare una continuità a questi incontri, se
volessimo condividere uno spazio comune.
Alle volte capita di tornarsene a casa con delle soluzioni, altre volte con una serie di domande
che ti frullano nel cervello.
Ci sarebbe mai venuto in mente in un altro momento tutto questo?
Le possibilità si creano anche da incontri fortunati, ma sarebbero state queste le compagnie
che avrei scelto per un eventuale percorso insieme? È possibile che compagnie diverse
riescano a gestire uno stesso spazio?
E se è qualcun'altro che sceglie, queste scelte vanno date per buone?
Sicuramente è stato un bene giocare - nel senso del divertimento che ho provato - al
massimo con le possibilità di questa occasione, ma per andare avanti da soli forse ci vogliono
delle volontà molto più forti?
Lasciarci osservare anche nelle nostre debolezze, ha reso speciale il momento in cui le
compagnie si mischiavano tra loro. Il nostro mestiere fortunatamente non ci rende soli.
Anche aver visto muovere i passi per lo studio di progetti in cantiere mi fa pensare di aver
partecipato al concepimento di una creatura. Le sale di Pontedera sono comunque state una
fase di gestazione per tutti, poi ognuno farà i conti col proprio parto.
Mi è sembrato un peccato che non ci fossero ancora più occhi a cogliere la bellezza di
un'occasione così particolare. Mi chiedo se non fossi stata invitata, queste porte si sarebbero
aperte per farmi sbirciare? Avrei capito il valore di un'esperienza del genere?
E se anche lo spettatore avesse in mano più strumenti per comprendere come si arriva a far
accadere lo spettacolo, potrebbe essere utile e interessante?
Mi è dispiaciuto, infatti, vedere tanta potenzialità e così poco pubblico pronto a raccoglierla.
In quei 4 giorni, mostrare il proprio processo creativo è stato importante, certo lo sguardo alle
volte sembrava unidirezionale come a vedere se il papà "brontolone" ci concedesse un cenno
di assenso con il capo. E allora mi sono chiesta, può nascere tutto questo fuori dalla casa del
papà?
Thomas Richards raccontava del teatro del papà e di come spesso ci ritroviamo a prendere
per buone delle pratiche solo perché altri le utilizzano (ad esempio fare training perché quel
maestro lo fa, anche se poi l'esercizio fine a stesso non ha senso di esistere se non è
funzionale ad un lavoro), o di come cerchiamo ogni modo per andare in opposizione a quel
metodo di lavoro (un po' come se volessimo farla pagare a quella maestra che all'uscita di
scuola ci ha severamente bloccato con lo sguardo la voglia di correre).
Si può intraprendere un percorso senza per forza seguire il criterio dell'essere "a favore" o
"contro", ma semplicemente essere un'ulteriore possibilità (passibile di influenze e non)?
Le parole che Richards ha utilizzato al volgere del suo racconto, non mi portano nessun
dubbio, né perplessità o domande a posteriori, ma una conferma: «Vedere la possibilità
nell'altra persona».
Un insegnamento valido e un bel modo anche per considerare questo incontro avvenuto
grazie a "Scendere da cavallo".
Le vie del fool
Quattro giorni fondamentali, all'interno della fortezza toscana del teatro contemporaneo.
Difficile deporre le armi. Infatti entriamo nella sala in punta di piedi. E quand'è il nostro turno
tremiamo molto più che al chi è di scena.
Giriamo molti paesi e città: facciamo spettacoli. Ma nello spettacolo sei protetto. Sai quel che
dirai. Sai “esattamente” cosa accadrà. E sorpattutto non c'è spazio per le domande. Scendere
da cavallo è diverso. Ti obbliga seduta stante ad un confronto. A rispondere a domande che
magari non ti eri neanche posto. Mettersi a nudo difronte al punto debole di ogni artista: il
processo creativo. Per giorni abbiamo cercato di preparci, di buttare giù una scaletta che
occupasse il tempo delle nostre due ore a disposizione. Abbiamo poi scelto la strada
dell'autenticità.
Siamo i primi, dopo Roberto Bacci, a esporre la nostra tesi e lo facciamo attraverso la formula
della dimostrazione-spettacolo. Andiamo a fondo sui processi creativi che abbiamo utilizzato
per Requiem For Pinocchio, Caligola e Macaron.
Abbiamo dato il nostro contributo. Abbiamo ascoltato in silenzio e con attenzione gli interventi
delle altre 10 compagnie cercando di coglierne i punti in comune e le diversità.
Durante quei quattro giorni non abbiamo controllato mai la mail della compagnia.
Ripensandoci a posteriori è stata un'occasione per prenderci cura del nostro lavoro, nel suo
aspetto più importante: quello artistico.
È stata un'occasione importante per rispondere di nuovo a quei “perché” che ci siamo posti
tanti anni prima, magari quando ancora studiavamo all'accademia.
Perché fare teatro? Perché fare un nuovo spettacolo?
Domande alle quali non ci rispondevamo da tempo perché inghiottiti dal sistema dei bandi,
della selezione e delle scadenze.
Torniamo a Roma più motivati. Abbiamo voglia di metterci a lavorare al nuovo spettacolo
perché al ritorno è più forte in noi la consapevolezza di quello che stiamo facendo. Del motivo
per cui stiamo lottando e, perché no?, del motivo per il quale lottano le altre compagnie che
hanno compiuto questo viaggio “a piedi” con noi a Pontedera.
Durante il viaggio di ritorno parliamo di “Scendere da cavallo” e metabolizzando i quattro
giorni portiamo con noi a casa un pensiero: Essere Teatro/Avere Teatro.
Passo una mattina accanto a un prato dove spunta un fiore bellissimo. Tre ipotesi: uno,
stacco il fiore per prenderlo tra le mani, lo annuso, più avanti lo getto via. Il fiore muore. Due,
mi avvicino, lo osservo bene, ci entro in relazione, poi me ne vado conservandone vivo il
ricordo nella mente. Il fiore continua a vivere. Tre, lo vedo. Lo stacco cercando di non
comprometterne le radici. Lo porto a casa. Lo travaso con la speranza che continui a vivere,
ma a casa mia, dove potrò vederlo ogni qualvolta io ne abbia voglia. Solo una di queste
opzioni equivale ad Essere, e le altre due equivalgono ad Avere. Noi speriamo di trovare nel
nostro cammino un Teatro che sia vita in quello spazio e in quel tempo, e non solo: che riesca
a rimandare ad un altrove vita in tutti gli spazi e in tutti i tempi possibili.
Siamo stati in contatto molte ore con i nostri colleghi, colleghi che spesso vediamo di sfuggita
nei festival, oppure di passaggio nella propria città. E grazie a quest'iniziativa abbiamo avuto
modo di approfondirne la conoscenza.
Torniamo a casa sapendo che abbiamo un lavoro importante da compiere: quello dell'artista.
Ripensiamo a Ionesco. Dice che ci sono due specie di conoscnza, anzi due linguggi e due
modalità. La modalità logico-scientifica e la modalità artistica. La scienza è conoscenza e
scoperta. L'arte è conoscenza, scoperta e creazione insieme. La scienza, quella tecnica, è
combinazione, combinazione ingegnosa, ma non creazione.
È l'arte ad assicurare la coscienza della nostra continuità, della nostra identità. È il serbatoio
dell'inconscio collettivo, in cui si trova il tesoro, come in un oceano dello spirito umano.
L'artista e la creazione portano il mondo in sé dalla preistoria al presente e ne anticipano
l'avvenire. L'arte collega l'arcaico con il moderno. Collega il nostro mondo nelle sue strutture
essenziali con l'aldilà del mondo. Perché di un secolo all'inizio, l'artista può percepirne la fine
e percepire la fine di qualcosa può dar vita ad un inizio.
Torniamo a casa, ma il viaggio continua. Buon proseguimento.
Macelleria Ettore
Accade che il pretesto per fare uno spettacolo sia un’occasione esterna a ragioni artistiche una produzione, una residenza, una scadenza, il debutto a un festival, ecc. In questo caso la
necessità artistica è sollecitata da un fattore estraneo e diventa urgente non perdere di vista
noi stessi, quello che vogliamo dire e come intendiamo farlo.
Accade però, ed è ciò che deve accadere più spesso, che il pretesto per fare uno spettacolo
nasca esclusivamente da noi, per noi. E allora partiamo da una domanda, la prima postaci
appena entrati nelle sale di Pontedera: “perché fare uno spettacolo?”.
Una domanda tanto semplice quanto ricca di trabocchetti e confusioni.
Fare uno spettacolo nasce dall’urgenza, prima di tutto. L’urgenza – nostra, personale - di dire
qualcosa. Ciò che è urgente per noi è la scoperta: di noi stessi e dei modi possibili che
abbiamo per raccontarci. Dunque l’esigenza è fortissima, ha a che vedere con la costruzione
di un’identità artistica. Solo attraverso la creazione di uno spettacolo noi possiamo ricercare la
nostra forma, la nostra poetica. I contenuti vanno di pari passo con la forma. Nella creazione
l’atto finale non è conosciuto, è un fine, certo, ma ciò che accadrà in quella sintesi finale
nasce da un percorso scaturito da contenuti, immagini, testi, suggestioni, deviazioni, curiosità
che lentamente prendono una forma a prescindere. E qui – per noi, prima ancora che per il
pubblico – avviene la scoperta. Fare uno spettacolo è quindi una ricerca di un linguaggio, per
arrivare a costruire una poetica.
Quando decidiamo di realizzare uno spettacolo, l’dea può arrivare da un testo, da
un’immagine, da un’idea di spazio e relazione attore-spettatore. Proprio per questo, ciascuno
dei nostri lavori ha una genesi propria.
Cechov#01, il primo, è nato da un’esigenza doppia: eravamo in tre, una regista e due attori (o
meglio un attore e un’attrice) e volevamo lavorare sulla relazione uomo-donna. Il Gabbiano
cui ci siamo ispirati è arrivato per amore di quel testo e di quell’autore. E tramite il lavoro in
sala, le scoperte cui siamo arrivati sono state: i burattini, il corpo in disarmonia con la parola,
e l’utilizzo delle voci-off.
Ed è partendo da questo punto di arrivo di Cechov#01 che è nata l’idea di NIP_Not Important
Person. Dai burattini ai manichini per disegnare una nostra visione della realtà, e l’utilizzo
delle voci off in tutto lo spettacolo per cogliere ancora di più il grottesco – o l’orrido – che c’è
in ognuno di noi.
Stanza di Orlando è nato invece dalla necessità di Maura Pettorruso (attrice) e Maria Paola Di
Francesco (scenografa) di affrontare Orlando della Woolf. Maura voleva mettersi in gioco a
livello attoriale con un materiale complesso che toccasse molteplici livelli interpretativi. Maria
Paola affrontava il romanzo come tesi di laurea all’Accademia di Belle Arti di Brera, e cercava
una declinazione pratica della propria ricerca sul costume/abito come veicolo della
personalità femminile. La loro proposta ha incontrato la necessità di Carmen (regista) di
indagare il processo creativo e percettivo di un’artista come la Woolf, il suo modo di vedere la
realtà e di scrivere, la sua concezione androgina dell’artista. Dall’incontro di queste tre
urgenze è nato Stanza di Orlando_ viaggio nella testa di Virginia Woolf, che sintetizza le
nostre istanze e le supera. Qui scopriamo un utilizzo del linguaggio, un uso della parola, e
della parola che diventa immagine evocativa che ci porterà poi all’ultimo spettacolo Alice delle
Meraviglie. Alice si spoglia della macchina scenica presente in Stanza di Orlando: la nuova
sfida è riuscire a evocare, a costruire un’immagine solida, fortemente palpabile per lo
spettatore semplicemente attraverso un testo, un’attrice su uno sgabello, e le luci. Con Alice
possiamo scoprire un nuovo tassello della nostra ricerca: la luce come attore in dialogo
serrato con l’attrice in scena.
Ma prima di Alice delle Meraviglie abbiamo affrontato un’altra sfida: Elektrika_un’opera
techno. Come Alice è figlia di Stanza di Orlando, così Elektrika è figlia della ricerca sul
burattino che qui si declina nell’utilizzo di una bambola meccanica e di un super-eroe a tratti
fumettistico. In Elektrika lavoriamo a strettissimo contatto con una cantautrice, Chiarastella,
che aveva già firmato le canzoni di NIP: il desiderio di coinvolgere Chiarastella in maniera
organica nel lavoro e la curiosità di scoprire, studiare, smontare il linguaggio operistico ci ha
spinti verso questa operazione artistica.
Grazie a questi cinque spettacoli abbiamo definito in noi il linguaggio, attraverso la scoperta di
ciò che li accomuna pur nelle grandi differenze, e abbiamo potuto vedere – incontrare la
nostra poetica: noi non raccontiamo una storia. La nostra narrazione procede per
accumulazione e bombardamento d’immagini: visive, verbali, acustiche. Il montaggio
definitivo delle immagini avviene nella testa dello spettatore. La sfida con lo spettatore è
questa: rendere il pubblico esposto e attivo. Lo spettatore è libero di entrare e uscire, è libero
di perdersi e ritrovarsi, di rinunciare alla comprensione logica e di abbandonarsi
all’associazione libera, oppure ostinarsi nella ricerca di una storia che non c’è. Se ciò avviene
– o meglio, quando ciò avviene – quello spettatore avrà vissuto un viaggio suo personale,
unico, e figlio della propria identità. Ognuno si porta a casa qualcosa, ognuno fa il proprio
montaggio e costruisce la propria visione.
Quello che cerchiamo, e ricerchiamo, è la possibilità di incontrare e raccontare la realtà come
la percepiamo dentro di noi.
La realtà è quello che viviamo e osserviamo, in noi e fuori di noi. A volte il contatto con la
realtà avviene nei nostri sogni, a volte è qualcosa di talmente concreto da risultare surreale. Il
modo di percepire la realtà è soggettivo e mutevole. Crediamo che non esista una sola realtà.
Ed è da qui che partiamo con il nostro modo di “fare teatro”. Per cogliere un contatto sincero
e autentico con la realtà possiamo solo stabilire un legame sincero e autentico tra la nostra
visione del reale e la percezione singola e personale di ciascuno spettatore. Stabilire un
contatto con la realtà significa interrogarci su qualcosa che ci riguarda profondamente a livello
personale e che riguardi l’individuo a livello universale: proviamo a cercare un modo di stare
dentro e fuori di noi.
Ed è quello che abbiamo provato a fare nello Scendere da cavallo: provare a mostrare il
dentro e il fuori, rimanendo. C’è stato il tentativo di mostrarci nudi, autentici, ma a nostro
parere il tentativo non è riuscito. Arrivati a Pontedera, avevamo una scaletta chiara, studiata,
ragionata a tavolino, condivisa con tutti, un’idea che forse avrebbe reso maggiore giustizia al
nostro modo di creare, che è essenzialmente un fatto di gruppo.
MACELLERIA ETTORE
Scaletta
1. Appena scesi da cavallo | Nomi, ruoli, competenze, gruppo |
2. Da dove veniamo: Napoli STANZA di ORLANDO | Milano DESERTO DEI TARTARI | Lari
Resistenza/foresteria | Frammenti video Carmen/Alice |
Prova live Alice Condividere il processo creativo
3. Chi siamo Montaggio video nostri spettacoli | Carmen parla con immagini e audio in
sottofondo |
4. Futuro Fringe / AMLETO | Montaggio immagini Cappella | + Videoclip Chiarastella |
Ma Scendere da Cavallo ha subito sortito il suo primo effetto: il dubbio!
Essere lì, a contatto con i nostri compagni di viaggio, in ascolto, a spiare, osservare, capire,
interrogarci, ha innanzitutto messo in crisi e noi stessi: quale poteva essere il modo giusto –
nostro – per mostrare davvero il nostro processo creativo? E ciò che, prima di entrare a
Pontedera, ci sembrava logico, corretto, personale, è diventato nebuloso e oscuro anche ai
nostri occhi.
Se Scendere da Cavallo voleva interrogare e farci interrogare, Scendere da Cavallo ha
portato a termine il suo compito.
Il fatto stesso di metterci in crisi nel come poter mostrare il nostro processo creativo, ha
generato la domanda successiva che ancora oggi ci portiamo dietro: la ricerca artistica di
Macelleria Ettore è esattamente ciò che la mia (di ciascuno di noi) personale ricerca artistica
va costruendo? E perché proprio questa? E se lo è, come e dove mettere il fuoco, il centro, il
fulcro? Esiste un obiettivo? Vale la pena raggiungerlo?
Scendere da Cavallo ha posto una linea precisa tra il prima e il dopo Pontedera.
Le molte domande ci portano a una crisi sincera rispetto al “come” comunicare chi siamo e
perché. I molti input rubati ai nostri compagni, le suggestioni e le pratiche che ci hanno
illuminati o resi scettici, ma comunque spostati rispetto a noi stessi, diventano ora materiale di
studio, e necessariamente si riversano sul nostro prossimo lavoro: Amleto? Sappiamo di
avere una residenza a Orvieto, sappiamo di dover debuttare a giugno al Napoli Fringe
Festival.
Ma non vogliamo ancora sapere altro. Vogliamo tentare un modo diverso di compiere la
nostra ricerca, sperimentare un modo nuovo per noi di confrontarci con un testo, con una
scrittura, con la scelta o la necessità di un certo tipo di linguaggio, struttura, immaginario. È
un tornare alle origini, i nostri primi lavori sono nati così. È un modo di accogliere domande e
necessità che sono scaturite proprio dalle giornate di Pontedera.
Che è poi il senso primario della nostra ricerca: trovare un’identità mutevole e incoerente
come la vita. Trovare un modo, un senso, uno scopo di indagare noi stessi e la realtà.
Proviamo a comunicare a più livelli domande e risposte che ci attraversano, che sono prima
di tutto vive dentro di noi. E cerchiamo di evolvere, spettacolo dopo spettacolo, restando
fedeli a noi stessi. Questo si declina in un linguaggio non sclerotizzato, ma in movimento,
aperto, che ci porti dentro la verità nell’artificio. Cerchiamo di creare pretesti perché il teatro
accada, almeno per un attimo, nei nostri spettacoli. In fondo, cerchiamo una forma semplice e
misteriosa di stare al mondo: la nostra. Scendere da Cavallo è stata una possibilità talmente
importante, talmente necessaria che non possiamo che augurarci una sua nuova “edizione”.
Ci piacerebbe incontrare di nuovo i nostri compagni di viaggio, per lavorare insieme per una
settimana su un tema, un contenitore dato. Ciascuno potrebbe mettere a disposizione il
proprio modo di lavorare: training, immaginario, scrittura, regia, attitudine scenica, concezione
dello spazio, gestione del tempo, visione, rapporto con lo spettatore. Si potrebbe creare una
sorta di grande laboratorio in cui ognuno possa mettersi in gioco e a nudo per un progetto
comune. Giocare insieme. Questo potrebbe arricchire a livello pratico il processo di
condivisione iniziato nella fase appena trascorsa.
Scenica Frammenti
Loris Seghizzi
Per avere un quadro completo rispetto ai quattro giorni dedicati al progetto “Scendere da
cavallo”, dobbiamo partire dalle origini di questa idea. Dico idea non a caso, perché proprio
grazie a un'idea nuova, per quanto sia possibile parlare di nuovo riferendoci al teatro, è nato
Collinarea Festival, la fonte da cui esce acqua fresca, un rigolo che alimenta il nostro lago dei
sogni.
Collinarea era un sogno divenuto realtà, pensato e diretto da Scenica Frammenti dal 1999, è
diventato nel corso degli anni un luogo conosciuto da chi ama il teatro e da chi ci si avvicina.
Lari, sede centrale del festival, in occasione di questo evento è frequentata da un pubblico
eterogeneo, dove la componente giovanile è molto forte. Lo possiamo definire un pubblico
affezionato e fiducioso. Affezionato all'insieme d'arte e umanità tangibile nel festival e
fiducioso verso chi organizza e le proposte che vengono fatte. Questo sodalizio tra spettatori
e interpreti è avvenuto grazie ad un lungo lavoro dedicato alla formazione del pubblico,
elemento per noi fondamentale nel teatro, oggi più che mai.
Il pubblico eterogeneo incontra sempre un cartellone altrettanto eterogeneo, composto da
artisti conosciuti affiancati da gruppi giovani o meno conosciuti del panorama teatrale italiano.
Proprio questi ultimi diventano così i veri protagonisti del festival; le scoperte, le rivelazioni, le
novità e spesso le conferme. Le compagnia conosciute si mettono automaticamente al
servizio dei nuovi, sono i big che fanno parlare del festival sui giornali ma sono i giovani che
lasciano traccia per un nuovo teatro. Questo a parer mio si può tranquillamente concretizzare
in filosofia di pensiero. Non credo nelle rottamazioni, tanto meno nelle sostituzioni immediate,
credo nel passaggio di testimone, nel dialogo tra i vecchi e i giovani del teatro sia a livello
artistico che organizzativo e di gestione.
Scendere da cavallo quindi è per Scenica Frammenti motivo di orgoglio, perché ha visto la
partecipazione di nove compagnie che provengono proprio da Collinarea.
Roberto Bacci e Pontedera Teatro, che dal 2012 collaborano alla realizzazione del festival,
hanno aperto le porte ad artisti che difficilmente trovano spazio negli stabili o nei circuiti di
potere.
Questo è un grande avvenimento che asseconda la filosofia di pensiero di cui sopra, è la
dimostrazione che qualcosa di importante sta accadendo in questo luogo della Toscana.
È giunto il momento, lo sarebbe da un bel po' a dire il vero, che chi ha meno spazio e meno
possibilità di fare, per tutti i motivi che conosciamo, in primis la situazione economica e
politica del paese, smetta di piangersi addosso da una parte e poi essere riverente con i
cosiddetti potenti dall'altra, ma affronti talvolta con irriverenza il sistema e chi lo controlla.
Bisognerebbe porsi in modo naturale e fiero di fronte a chi ci ha preceduto ed ha avuto il
privilegio e la fortuna di fare teatro negli anni d'oro ma spesso anche il merito di aver costruito
luoghi artistici tanto importanti iniziando in quegli anni formidabili.
È l'ora, lo è da un bel po', di finirla con i baciamano e i ruffiani. È l'ora, lo è da un po', di
incontrarsi, persone con persone, artisti con artisti, teatranti con teatranti. Incontrarsi.
La quattro giorni di Pontedera è stata soprattutto questo, un incontro non casuale ma nato da
un lungo lavoro.
Si sono trovate a dialogare compagnie di vario genere ma è stato significativo vedere che ci
sono punti di comunicazione validi per tutti. È stato senza dubbio un modo per andare un po'
più in profondità nella comprensione del lavoro dei gruppi, avere più chiaro il perché di ciò
che viene messo in scena. È molto bello conoscere, ti fa vedere le cose con altri occhi. Di
fatto, aver visto in alcuni casi sia il lavoro di preparazione sia lo spettacolo ha dato altra luce
quest'ultimo, svelando però il mistero che si nasconde dietro ad ogni messa in scena. Questo
è uno dei pensieri che, per esempio, mi tiene compagnia ogni volta che vado a teatro: “si
deve capire tutto di uno spettacolo?”. Credo di no.
Avere la soluzione talvolta esclude il ragionamento e, a parer mio, una componente
fondamentale del teatro, così come di qualsiasi arte, ovvero il dubbio.
Vedere tutti al lavoro, a dimostrare con quanta più precisione possibile quale fosse il proprio
metodo, mi ha dato da pensare, l'ho sentito in alcuni casi fasullo, in altri molto interessante.
Ad esempio quando dimostrare il proprio lavoro è equivalso a giocare insieme, eliminando
così la distanza che c'è tra chi guarda e chi agisce, tra chi rimane sul cavallo e chi scende...
Ecco perché il secondo giorno di lavoro ho voluto lanciare una provocazione, basata su un
nostro personalissimo gioco, quello che facciamo anche in prova per creare una bozza
drammaturgica, un delirio organizzato dove non ci interessava spiegare il nostro metodo, ma
far nascere un confronto umano tra le persone/artisti presenti. È sempre piuttosto semplice in
teatro provocare, basta parlare di verità e finzione, non citare Stanislavskij, Pirandello o
qualsiasi altro riferimento letterario; parlare di casualità, non parlare o parlare male di tecnica
e il gioco è fatto. Si innescano discussioni davvero interessanti e soprattutto si perde quella
finta pace che solitamente avvolge gli artisti quando si trovano tutti insieme. I pensieri veri
sono altri e non si esternano mai pubblicamente... Il falso buonismo, tutti che apprezzano
tutti, i sorrisi e le smorfie rischiavano a parer mio di ridurre il nostro incontro alla solita
rimpatriata tra colleghi. Non ho parlato di metodo ma, guarda caso, di pensiero.
Il metodo, parola usata moltissimo da tutti. Preferisco chiamarlo esercizio o, appunto,
pensiero. Forse esercizio di pensiero. Oppure pensiero sull'esercizio. Insomma, tanto per
essere chiari, non ho mai cercato di dare un nome diverso da prove a ciò che una compagnia
fa per creare uno spettacolo. Quando invio le schede inerenti allo stage però anche io scrivo
metodo, tanto per non essere frainteso. Training, lo ammetto, è molto d’effetto come parola,
poi è inglese e funziona a colpo sicuro, ma visto che è notoriamente legata all'uso del corpo,
esclude senza remore i narratori o tutti coloro che prima di Grotowski hanno fatto teatro. Non
proprio delle schiappe direi.
Vorrei proporre il training a mia madre, attrice di ottantuno anni, che viene dalla farsa; quello
fisico intendo, o meglio quello psico-fisico, ma ne uscirei sconfitto. Eppure anche lei ha il suo
modo di prepararsi, il suo training, ma non lo chiama così. Ma per risultare meno di parte e
restare a questi giorni pontederesi penserei a Peppe Carullo e Cristiana Minasi..
Si badi bene a non pensare che queste siano parole di protesta, o di rifiuto, niente affatto,
anche noi lavoriamo molto sul corpo dell'attore. Credo al contrario che sia cosa buona per chi
fa dell'arte il proprio mestiere essere aperto a tutto, quanto più possibile ed evitare la divisione
per razze: narrazione, ricerca, teatro danza, tecnologico, prosa... Perché sempre di teatro si
parla.
Forse dovremmo partire dalla semplicità.
Altra cosa invece sarebbe distinguere i professionisti dagli amatori. Oggi in Italia chiunque si
svegli la mattina con la voglia di fare teatro può permettersi di farlo, ma non solo: può
accedere a contributi pubblici (spesso comunali), entrare nelle scuole, improvvisarsi
insegnante e andare in scena. Se domattina mi svegliassi con la voglia di fare il fornaio, potrei
aprire un forno e fare un buonissimo pane? Credo che avrei delle difficoltà, prima di tutto
burocratiche, poi qualitative.
Ma sinceramente ho poche idee su come risolvere il problema.
Abbiamo visto scendere da cavallo i vari artisti in modi diversi e, una volta messi i piedi in
terra, dimostrare quanto il lavoro sia alla base di tutto. Le varie ricerche teatrali degli undici
gruppi hanno dato dimostrazione di quanto valore artistico sia espresso, ma anche
inespresso, tra le moltissime realtà meno conosciute che operano nel nostro paese. Ho molte
volte pensato in questi giorni ad un'Italia del teatro troppo nascosta, che a Pontedera come in
Collinarea e in molti altri luoghi è rappresentata da una piccolissima percentuale di artisti.
La sensazione avuta, come in altre occasioni, è che non si trovi la forza, o semplicemente
non si voglia, di creare contatti (per evitare di usare la parola “rete” così tanto inflazionata).
Nel momento in cui ci siamo ritrovati in una sala per cercare di capire come dare continuità a
questa esperienza, sono venute fuori tutte le difficoltà legate alla condivisione. A parer mio
queste dipende dalla nostra educazione. Gran parte degli artisti coinvolti sono nati negli anni
Settanta, quindi possiamo facilmente determinare che hanno cominciato ad entrare nel
mondo del teatro dall'inizio degli anni Novanta in poi. Abbiamo trovato le briciole. Quando ci
sono le briciole e c'è molta fame, difficilmente si riesce a dividere ma più facilmente si fa a
botte per accaparrarsi il poco cibo rimasto. Se a questo aggiungiamo che si parla di artisti
(affamati), la cosa si complica notevolmente perché l'ego è spesso una componente
preponderante tra chi svolge il mestiere del teatrante.
In sostanza voglio dire che la nostra realtà individualista non ci aiuta per niente. È un peccato
perché io sono tra quelli convinti che il teatro in Italia non sia assolutamente finito, ma sia vivo
e vegeto, ricco di valore artistico e talento. Dovremmo avere un altro atteggiamento, ripeto,
ma cambiare la cultura del modo di fare è cosa assai difficile.
In sostanza “Scendere da cavallo” per me ha rappresentato la metafora pertinente del nostro
tempo. Si sono viste capacità, si è vista applicazione e dedizione, idee; si è visto quel che
siamo e, ahinoi, quel che potremmo essere.
Teatro dei Venti
Stefano Tè
“Scendere da Cavallo” è stato a mio parere un progetto tanto semplice quanto efficace.
Undici compagnie si sono incontrate per concedere il proprio processo creativo allo sguardo,
uno dell’altro. La quattro giornate di Pontedera hanno mostrato però tutte le lacune di una
generazione di teatranti che non sa esporre praticamente il proprio modo di creare uno
spettacolo. Probabilmente nessuna di queste compagnie ha mai dovuto pensarsi in una
situazione del genere, ma questo non giustifica l’impaccio, l’imbarazzo che troppo spesso si è
diffuso nelle bellissime sale del Teatro Era. Probabilmente non essendo più attivi quegli
studiosi che hanno reso “mitico” un certo teatro degli anni ’70, le compagnie di oggi non si
devono misurare con il dover dimostrare come funziona la propria macchina creativa, se non
tramite lo spettacolo. Quei professori ti chiedevano “come” prima di “cosa”. Questa assenza
smorza forse l’idea di un teatro nel quale il processo valeva più del risultato, un mondo
teatrale nel quale lo spettacolo si collocava come esito di un percorso di ricerca senza il quale
non esistevano neanche le prove, figuriamoci lo spettacolo. Forse oggi non ce lo possiamo
permettere o forse non esiste perché troppo faticoso e i risultati si ottengono anche senza
studio. Oggi, che quasi non esiste più il processo di ricerca, come possiamo esporre il nostro
lavoro verso lo spettacolo se non con le chiacchiere? Con l’Io che domina il Sé.
Roberto Bacci, con questo progetto, ha messo a fuoco il limite delle nuove generazioni di
teatranti. Probabilmente sarebbe stato più azzeccato parlare di “Cadere da Cavallo”. Forse
sarebbe opportuno, per un eventuale prossimo incontro, stringere le maglie, avere delle
indicazioni più precise, almeno sapere su quale terreno precipitare. Si dovrebbe prendere in
esame la possibilità di un tempo di contatto più disteso, meno formale e ritagliato in uno
spazio di condivisione discostato dai “riflettori da conferenza”. Questo approccio,
probabilmente, potrebbe giovare maggiormente allo scambio.
Teatro delle Bambole
Andrea Cramarossa
Un raro momento che ha visto attori, registi, tecnici, drammaturghi, incontrarsi al Teatro Era di
Pontedera. Una importante opportunità di confronto, per guardarsi dentro, attraverso gli occhi
degli altri. Ciò che ho notato, prima di tutto, è l’amore incondizionato dei partecipanti verso
l’Arte Drammatica, verso il Teatro. Una esigenza affettiva che, evidentemente, non si può
spiegare e forse una spiegazione nemmeno ce l’ha. Vedere e ascoltare tanti artisti che hanno
amato e amano ciò che fanno, è stata una circostanza carica di unicità e per certi versi
confortante, facendoti sentire certamente meno solo. L’impostazione dell’incontro mi è
sembrata un po’ “accademica”; personalmente avrei preferito partecipare ad una serie di step
laboratoriali, dove poter mettere in pratica, seppur da esterno, le metodologie perseguite dai
vari artisti. Sarebbe bello riuscire ad organizzare una seconda fase di “Scendere da Cavallo”,
avendo a disposizione più tempo e magari poter seguire anche le prove eventuali di uno
spettacolo
che
in
quel
determinato
momento
le
compagnie
desiderano
realizzare.Personalmente, ho trovato questi incontri e questi contatti, seppur fugaci,
abbastanza destrutturanti e anche in grado, per un certo periodo di tempo, di mettermi in
discussione, farmi delle domande sul mio modo di andare in scena e di lavorare in teatro e
sulla efficacia di tale metodo; su quale sia la qualità della mia presenza sulla scena
contemporanea; sulla effettiva capacità di emozionare il pubblico, di lasciare qualcosa
nell’animo delle persone; che cosa determina il mio esistere teatralmente parlando; sulle
priorità rispetto alla qualità e alla quantità del messaggio artistico. Infine, ho compreso che la
ricerca intrapresa è tutt’altro che terminata ed è assolutamente sensibile di modifiche,
accorgimenti, intuizioni ed incontri come Scendere da Cavallo non possono che confermare o
“riassestare” il cammino intrapreso, se però si è in grado di ascoltare gli altri senza pregiudizi.
Nel mio percorso artistico, molto precoce a dire il vero, ho sempre sentito il bisogno di entrare
in contatto col mio mondo interiore attraverso l’arte e varie discipline artistiche: la danza
classica e contemporanea; la musica attraverso il canto jazz e leggero e l’improvvisazione
vocale ma anche, ultimamente, il canto lirico; la scrittura poetica e narrata, cinematografica e
teatrale; la fotografia e, naturalmente, l’Arte Drammatica, arte che sento profondamente
radicata in me come intensa espressione di tutte le altre arti e di quello che amo definire il mio
patrimonio artistico. Finché un giorno, per fortuna, ho incontrato sul mio cammino il “Metodo
Funzionale della Voce” di Gisela Rhomert, per mezzo dei miei Maestri, Maria Silvia Roveri e
Pierluigi Molinaro. Un incontro-scontro, oserei dire. Questo Metodo, così raffinato e
stupefacente, mi ha permesso davvero e con sincerità di entrare in contatto con me stesso,
senza mezzi termini, con obiettività, con rabbia e con dolcezza. Per farla breve, grazie a
questo Metodo, ho finalmente compreso non senza travagli e sofferenze, che l’arte per me
non era e non è un mezzo di conoscenza di me stesso, della mia personalità, bensì un mezzo
per conoscere l’arte stessa. Il punto di vista si è ribaltato: non ero più io ad usare l’arte, forse
più inconsciamente, per conoscermi e scandagliare il personale intrico di emozioni, ma era
l’arte che usava me per esprimere se stessa, senza troppi fronzoli e con fare immediato,
giacché l’arte è armonia e l’armonia risiede nella Natura e quindi in tutti gli esseri sia viventi
che inanimati. Gli artisti hanno – o dovrebbero avere – più chance rispetto agli altri esseri
umani: la capacità di ascolto, la lungimiranza, l’intuizione – se queste possono essere
potenzialità vere e sincere non ad uso del proprio ego; queste “tendenze” dell’artista, possono
con più facilità metterlo in contatto reale con un mondo interiore inespresso che non è quello
emotivo. Dunque, da cinque anni a questa parte, mi sono rimboccato le maniche e ho
lavorato senza tregua e senza indulgere troppo, duramente e severamente, su me stesso,
sperimentando ciò che avevo intuito. Primi risultati, alcuni un po’ impacciati, di questa ricerca,
sono stati gli spettacoli La lezione di Ionesco, Gimpel Tam (ovvero dell’idiota) da Isaac.
Singer, Psicosi delle 4 e 48 di Sarah Kane – momento culminante, quest’ultimo, del mio
nuovo teatro che ho definito Teatro Concettuale –, e, in parte, Cosa disse il vento alle falene
e L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Per me sono stati tutti eventi memorabili,
finalmente espressione di un teatro più vero e soprattutto più intenso. Il “Nuovo Metodo di
Approccio all’Arte Drammatica” si basa sullo studio del suono dell’attore come mezzo per
lavorare su se stesso e del suono del personaggio, in una seconda fase. Volendo
sintetizzare, questo Metodo di nuovissima concezione, prende spunto dall’analisi del suono e
dei suoi parametri, permette di lavorare su se stessi abbattendo sovrastrutture personali e
sociali, pregiudizi estetici e di “piacevolezza”, impulsi narcisistici, azione intesa come “fare”,
eliminazione progressiva delle pressioni mentali e fisiche con conseguente stato di
“svuotamento attivo”, non rilassatezza, bensì stato ideale di allerta come miglior condizione
naturale recettiva di ascolto di sé (in seguito anche dell’ambiente circostante, degli oggetti e
di tutte le forme viventi e astratte che lo riempiono). Questo stato può anche ottenersi
attraverso l’uso della volontà, ossia tramite un lavoro di controllo del cervello o pensato e
dettato e che ritengo – anche in casi più “dolci”, come lo yoga e il Feldenkrais – altamente
invasivi e a lungo andare inutili e troppo cervellotici per il lavoro dell’attore. Attraverso il
suono, questo percorso in totale libertà, può condurre a meccanismi di azione-re-azione
(principio di propagazione del suono: compressione – rarefazione) che non agiscono
tendenzialmente sul piano emotivo, privilegiando anzi quello sensoriale-percettivo, più
stimolante per la genesi creativa dell’attore in scena, considerando piuttosto il pubblico come
un coacervo di emozioni da attivare, senza che l’attore ne sia minimamente coinvolto.
Questo, che in un primo istante potrebbe essere confuso con il “distacco” dell’attore dal
personaggio, in realtà conduce l’attore ad un sentire più vero, più sincero, più coerente, più
concreto, più profondo, poiché non è un percorso di natura cerebrale e dipendente dalla
volontà e permette all’attore di essere sinceramente presente a se stesso sul palcoscenico,
purché egli sia in grado di lasciarsi andare, di affidarsi totalmente a “qualcos’altro” che non sia
solo l’immagine costruita del proprio sé. Questo Nuovo Metodo si propone di lavorare sul
paradosso dell’attore di Diderot, attraverso il suono e i suoi misteriosi anfratti, lasciando
all’artista veramente la libertà di esplorare la propria fisicità, senza inutili e fuorvianti
intromissioni meccaniche. Più un attore è portato o condotto a “fare”, training attoriale più o
meno canonico compreso, e più si allontanerà da se stesso e dalla verità che può esprimere
attraverso le vibrazioni che appartengono allo stato d’animo del personaggio scritto, ossia
dell’opera d’arte. Lo studio del testo teatrale e del personaggio è più complesso e
determinato, in questo processo, esclusivamente dalla possibilità che l’attore si dà nell’essere
totalmente in ascolto e nell’osservazione delle parti anatomiche che costituiscono l’apparato
vocale e fonatorio, foriere di enorme energia ed equilibrio tramite processi di autoregolazione
naturale. L’attore deve cercare di non fare ma di farsi guidare. Questo implica certamente
l’essere in grado di avere fiducia e fede in ciò che il suono del personaggio può accendere ed
evidenziare nella stimolazione fisica dell’attore, il quale dovrebbe poter acuire la capacità di
assecondare l’intuizione istintiva del proprio corpo, rispetto al sentire del personaggio, senza
chiedersi troppo meccanicamente e cerebralmente cosa il personaggio stia vivendo in quel
determinato momento, ma ponendo unicamente domande al suono e osservando le risposte
che esso può darci. Il personaggio è uno stato d’animo in continuo movimento e mutamento
nello svolgimento drammaturgico e deve diventare l’ordinatore del suono dell’attore.
Dunque, l’attore deve poter approfondire il rapporto che ha con sé stesso, attraverso il proprio
suono e il contatto percettivo-sensoriale dei propri organi fonatori, prima, e del resto del corpo
in un secondo momento. Questo gli consentirà di prendere coscienza delle proprie pressioni
(emotive, caratteriali, fisiologiche, mentali, comportamentali, psicologiche). Questo lavoro su
di sé non è mai a “senso unico” ma è sempre in relazione con lo spazio esterno (in seguito
anche con gli oggetti) e con il tempo e deve necessariamente essere guidato da una persona
esperta. Le stimolazioni, gli esercizi, il training, inevitabilmente, porteranno l’attore in contatto
con la propria laringe, centro per eccellenza della regolamentazione della pressione corporea.
Il contatto sempre più profondo con questo organo, consentirà all’attore di raggiungere una
condizione neutra (non di passività) ideale per l’ascolto di sé. Da qui dovrà procedere
all’individuazione del proprio stato d’animo che corrisponderà ad un organo fonatorio preciso
e ad una nota musicale, cioè a una frequenza. Tale individuazione avverrà sempre tramite il
“restare” nella sensazione, con l’ausilio dell’osservazione della pressione interna. Organo
fonatorio e nota musicale costituiranno “l’ordinatore” dello stato d’animo che, a sua volta,
sarà espressione di una particolare “oscillazione” corporea. Tale vibrazione oscillatoria sarà
quella presente in quel determinato momento nel corpo e nell’essere dell’attore che dovrà
compiere un cammino verso di sé senza giudizio e senza intromissioni intellettualistiche di
qualsiasi genere, ma lasciando fare, appunto, al corpo, e osservare. Tale punto di vista di
osservazione, faciliterà, in un secondo momento, il rapporto tra l’attore e lo spettatore. Lo
stato d’animo dovrà oscillare in tutto il corpo dell’attore, creando vibrazioni e passaggi
continui di energia che potrà essere individuata sotto varie “forme”: punti di luce e punti di
buio; immobilità luminosa; calore; espansione; dilatazione dei confini corporei ecc. ecc. Una
chiave di accesso al mondo sensoriale può essere costituita dal training isometrico. Tutto ciò
che l’attore potrà conoscere rispetto a sé stesso, costituirà il suo bagaglio personale,
ovviamente, ma soprattutto a livello percettivo-sensoriale. Tale patrimonio gli permetterà di
raggiungere la neutralità ideale per accostarsi al personaggio che è di per sé un’opera d’arte.
Come una persona, esso, possiede già una vibrazione oscillatoria precisa, decisa dal
drammaturgo, più o meno consapevolmente. L’attore potrà accostarsi al personaggio dopo un
lungo training vibrazionale (risonanza, eco, riverbero, fenomeni di battimento, ecc.) con gli
oggetti. La comprensione dello stato d’animo del personaggio avverrà attraverso il testo
(lavoro sensoriale con le parole e qualità della relazione che l’attore ha con esse) per poi
“trasferire” tutto alla qualità della relazione tra il personaggio e le sue parole. In seguito, si
individueranno i punti di pressione del personaggio, l’organo fonatorio maggiormente
coinvolto, le parti del corpo che risuonano con l’attivazione di tale organo fonatorio, la natura
dell’oscillazione, relazioni con gli oggetti e con lo spazio e il tempo, relazioni con gli altri
eventuali personaggi. In seguito si procederà con una serie ripetuta di improvvisazioni sulla
memoria passata del personaggio. Improvvisazioni che procederanno per intuizione o per dati
di fatti estrapolati dal testo. Alle normali improvvisazioni sulla memoria, ne seguiranno altre,
identiche, prive di parole ma come se fossero una “imitazione” dell’improvvisazione appena
fatta, per dare il tempo al corpo di sentire e interpretare col proprio linguaggio lo stato d’animo
individuato. In un altro momento, si passerà alla ricerca del cambiamento dello stato d’animo
del personaggio lungo tutto il periodo del testo da rappresentare. Nel 2007, il gruppo di studio
del Teatro delle Bambole, scopre una relazione immediata tra alcuni personaggi e gli organi
fonatori. Ad esempio: Amleto, Claudio, Gertrude e Ofelia, la laringe; Medea, Edipo, Creonte,
la laringe e la trachea; Salomè, la faringe. Tali evidenze non posseggono ancora sufficiente
letteratura e fasi esperienziali e sperimentali tali da poterle descriverle pienamente. Il gruppo
di ricerca le sta approfondendo con un programma intitolato “Dalla parola al legame”, ossia
come le parole si trasformino in legame fisico e come tali legami siano determinati dalle
parole (e dalla loro natura oscillatoria).
Un altro appuntamento importante nel cammino di crescita artistica e personale è avvenuto
attraverso l’incontro col “Teatro delle Orge” di Herman Nitsch. Tuttavia, tengo a precisare che
l’incontro con questi Maestri e i loro metodi e le loro ricerche e l’apprendimento di eventuali
tecniche, non ha portato ad una applicazione dei metodi stessi all’arte teatrale ma hanno
stimolato la creazione di un metodo nuovo specifico per il teatro. Ritengo, dagli studi
effettuati, che ogni essere umano abbia uno dei cinque sensi più sviluppato rispetto agli altri e
che sia il senso che “conduce” la persona a muoversi nell’ambiente che lo circonda e anche,
e soprattutto, nella ricerca interiore. Pertanto, anche i personaggi e la storia stessa da
rappresentare, saranno stati scritti a seconda del senso che predomina nel drammaturgo che
l’ha ideato. Inconsapevolmente, certo. Ma, compito del regista, in questo caso, è proprio
quello di risalire al “senso” predominante, attraverso una parafrasi obiettiva sensoriale del
testo. Conoscendo ciò, la scrittura stessa può partire da un senso rispetto ad un altro. Questo
non significa che gli altri sensi siano esclusi, ma saranno sensi che seguiranno il primo
impulso del senso principale. Ad esempio, nello spettacolo Il terzo uomo, i personaggi sono
stati costruiti attorno al senso dell’olfatto e in Concerto in sol maggiore per giardino d’infanzia
attorno a quello della vista. I sensi, tramite stimolazioni isometriche, possono condurci
agevolmente alla natura più intima dell’oscillazione e permetterci di osservarne le vibrazioni
nel corpo. Questo perché, per loro natura, sono le “porte” che permettono la comunicazione
tra il “dentro” e il “fuori” di noi. Fondamentale è imparare a non interpretare tali reazioni
sensoriali (amplificate da esercizi sul suono) in modo da rendere lo sguardo dell’osservatore
sempre più obiettivo e distaccato. Senza intromissioni, il corpo potrà reagire all’azione
intrapresa dai sensi e dal suono, in modo da poter cominciare la preziosa fase della
creazione artistica. L’interpretazione delle azioni sensoriali portano immediatamente nel
campo dei ricordi personali, dell’immedesimazione, della suggestione, rendendo tutto il lavoro
assolutamente soggettivo e relativamente vero. La verità da cercare è sempre quella
dell’opera d’arte, ossia del personaggio, non a livello intellettualistico e razionale o di controllo
ad esempio dei muscoli volontari, ma di essere strumento vibrante dell’arte rappresentata.
Ciò richiede meno controllo e più osservazione, meno razionalità e più fiducia, una
oscillazione costante tra il volontario e l’involontario, senza prediligere l’uno rispetto all’altro.