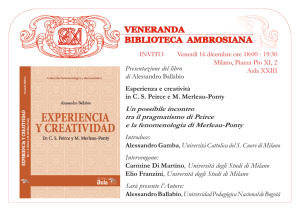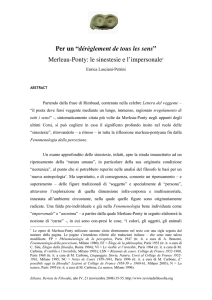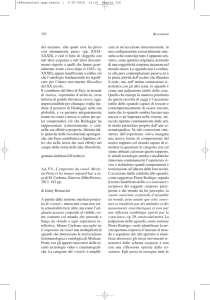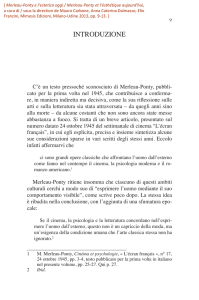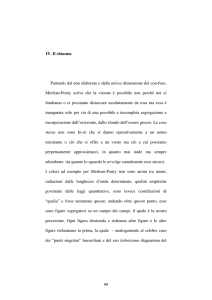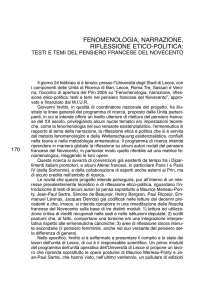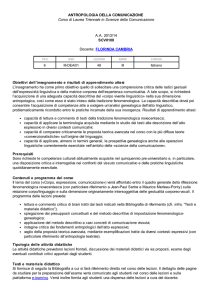RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XV
NUOVA SERIE - N. 44 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2001
Manni
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, attraverso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, e dello stesso Dipartimento.
2
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Antonio Delogu (Sassari),
Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio Ponsetto
(München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Daniela De Leo, Lucia De
Pascalis, Alessandra Lezzi.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia,
Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 336627/8;
fax (0832) 3366626.
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Nino Bixio,
11/b - 73100 Lecce - Tel. e Fax. 0832/387057. Iscritto al n. 389/1986 del Registro
della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo: Italia t 20,66 (L. 40.000),
Estero t 39,25 (L. 76.000), c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni s.r.l.,
Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà
diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata. Un fascicolo t 9,30 (L. 18.000), degli
anni precedenti il doppio.
SOMMARIO
DOSSIER MERLEAU-PONTY
5
Giovanni Invitto
A MO’ DI PREMESSA
IL LESSICO COME PRETESTO ERMENEUTICO
8
Marco Carbone
UN POSTO IN CUI SI PARLAVA MERLEAU-PONTIANO
10
Luce Irigaray
DIPINGERE L’INVISIBILE
17
Sandro Mancini
NELLA CORRENTE DELL’IPERDIALETTICA
IL MIO PERCORSO A PARTIRE DA MERLEAU-PONTY
24
Aniello Montano
DA SARTRE A MERLEAU-PONTY
32
Fulvio Papi
MERLEAU-PONTY SCRITTORE DELL’ESSERE
38
Bernhard Waldenfels e Regula Giuliani
TURBINE DEL TEMPO
IL TEMA DEL TEMPO IN MERLEAU-PONTY
59
Chiara Zamboni
MERLEAU-PONTY, LE AMICHE, L’ONTOLOGIA CARNALE,
LA POLITICA E GLI AMICI
70
Gaetano Scatigna Minghetti
RIFLESSIONI SULLA PROLIFERAZIONE DELLE LEGGI
77
Romualdo Rossetti
L’OCCIDENTE COME ENIGMA IN MASSIMO CACCIARI
Elisabeth Young-Bruehl
L’11 SETTEMBRE. UNA POSSIBILE LETTURA,
SEGUENDO HANNAH ARENDT
130
Recensioni
3
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o
Dipartimento di Filosofia – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola
facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà
superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche
su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa
comunicazione e approvazione dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
4
Nel 1961, quarant’anni fa, moriva Maurice Merleau-Ponty. Sandro Mancini
mi suggeriva di dedicare un “dossier” alla sua figura, soprattutto chiedendo
cosa la lettura di quel filosofo possa aver rappresentato per alcuni di noi. Io e
“Segni e comprensione” non potevamo che consentire a quella proposta. Qui
presentiamo alcune risposte significative e importanti testimonianze sul valore di un pensiero che non è, però, mai letto in maniera agiografica. La vigilanza critica è una delle eredità che Merleau-Ponty ha lasciato alla filosofia, non
solo occidentale. (G. I.)
DOSSIER MERLEAU-
DOSSIER MERLEAU-PONTY.
QUARANT’ANNI DOPO
A MO’ DI PREMESSA.
IL LESSICO COME PRETESTO ERMENEUTICO
di Giovanni Invitto
5
Ci si accostava, alla fine degli anni Sessanta, a Maurice Merleau-Ponty,
morto nel ’61, perché non poteva non attirare l’attenzione un filosofo che aveva
scritto, quasi contemporaneamente, sul Terrore staliniano e sulla pittura di
Cézanne, sull’incarnazione e sul cinema. Avvenne così il mio incontro con il suo
pensiero, mediato dalle traduzioni del Saggiatore, di Bompiani e di Sugar. Ma,
alle spalle di tutto, c’era il grande ponte costituito dalle letture di Enzo Paci e
della sua scuola milanese. A Bari, Giuseppe Semerari affiancava, non a caso,
la filosofia merleaupontyana dell’ambiguità a quella schellinghiana.
Poi ci fu la diaspora del gruppo paciano. Rimase “aut-aut”, rimasero singoli ricercatori. Ancora oggi fruiamo di quella semina. Ma è legittimo chiedersi
cosa possa aver ridimensionato la presenza dell’autore di Signes in un mosaico filosofico non sempre adeguatamente attento. L’invadente vicinanza di
Sartre? L’essere stata definita, quella merleaupontyana, un’opera incompiuta?
La torsione, in parte dichiarata, in parte apparente, del suo pensiero ontologico e della sua presa di posizione in campo politico? Interrogativi destinati a
rimanere senza risposta definitiva. E, comunque, sarebbe una risposta ininfluente per chi volesse cogliere ancora oggi l’essenza di quel pensiero.
Le singole letture merleaupontyane hanno continuato ad attraversare la
riflessione teoretica, psicologica, ideologica, estetica, scorrendo come tanti
rigagnoli quasi mai convergenti. Era, forse, inevitabile, tenendo conto del tessuto speculativo di quel pensiero.
6
Non che siano mancate le occasioni e i progetti di fare il punto unitario di
tante ermeneutiche. Già nell’’81, si pose il problema di un consuntivo dell’opera merleaupontyana. Erano trascorsi vent’anni dalla morte del filosofo e
alcuni di noi si interrogarono sulle famose “eredità”. Furono presenti molti lettori della prima generazione, di cui lo stesso Semerari e Fergnani avevano
assunto la leadership, dopo la scomparsa di Paci. Alcuni di essi furono presenti ma, come Andrea Bonomi, solo per testimoniare la loro guadagnata lontananza; altri, come Sergio Moravia, per dichiarare la loro vicinanza a questa
“filosofia dell’oltre”1.
Ciò che, a me personalmente, appariva determinante nel pensiero di
Merleau-Ponty era la sua fenomenologia che, senza remore, era insieme percorso ontologico ed ermeneutica esistenziale, sempre senza fasi antinomiche
e senza soluzioni di continuità. Anche le apparenti eresie erano già implicite
nelle premesse di un pensiero antidogmatico e antisistematico.
Dopo l’incontro leccese nel ventennio dalla morte, le iniziative ripresero.
Volumi, riviste2, studiosi di scuola o senza scuola, altri convegni continuarono
ad analizzare i testi di Merleau-Ponty alla continua ricerca di nuovi livelli di lettura3. Ma il filosofo, ancora una volta, come in vita, sembrava subalterno al
pensiero sartriano che vide, tra l’ ’80 e il ’90, la convergenza di una forte ripresa critica.
Poco ci si ricordava della fenomenologia della percezione in un contesto in
cui la suggestione delle immagini sartriane e del loro radicalismo non lasciavano spazio per parallelismi che non fossero con Husserl o Heidegger.
Sennonché dalle vecchie radici parve nascere una “nuova” schiera di lettori
“nuovi”, forse una lettura “nuova”4.
Si ebbe, e si ha ancora, l’impressione di una nuova generazione di merleaupontysti, maieuticamente accompagnati da esponenti illustri dei primi lettori, da Zecchi a Sini, da Neri a Franzini. Non si tratta solo di un dato generazionale, in senso anagrafico, perché questi studiosi hanno localizzato un
Merleau-Ponty autre, quello, sicuramente, ancora meno studiato, un MerleauPonty che affronta la regione dell’ontologia con lessico e intenzione diversi.
Corriamo sempre e tutti un rischio: quello di assolutizzare, “quel” MerleauPonty, “quei” testi, “quelle” problematiche, stralciandole da un pensiero corposo, fibroso, attraversato da suggestioni dispari nell’arco di circa un ventennio
di produzione. A chi, come me, era stato attratto da una ermeneutica fenomenologica applicata all’arte, alla politica, alla religione, all’esistenza, insomma,
poteva riuscire estraneo un Merleau-Ponty scorporato dalla produzione iniziale e pubblicata in vita. Gli scritti postumi, molti dei quali relativi a corsi di insegnamento, hanno sollevato problemi seri riguardo la definizione complessiva
del pensiero.
Oggi il quadro dei testi e dei lettori è notevolmente arricchito e molto più
articolato. L’impressione, convinta è, però, che la struttura portante sia ancora quella tratteggiata dai primi lettori di Merleau-Ponty. Perciò una rilettura progressiva, che partisse dal “lessico” merleaupontyano, potrebbe verificare alcune coordinate ermeneutiche, quando l’indice della produzione scritta del francese è pressoché completo.
DOSSIER MERLEAU-
Anche qui, però, parlare di lessico è strumentale, perché occorre vedere
dietro e accanto ai termini usati quale lavorio intellettuale sia depositato. La
nomenclatura usata da Merleau-Ponty può essere un pretesto per vedere, a
oltre quarant’anni, dalla fine di un pensiero, cosa di specifico avesse riproposto. C’è stata per lungo tempo, nei confronti di questo filosofo, una propensione riduttivistica: di cosa è debitore a… Qui l’elenco era sempre abbastanza lungo: Husserl, Heidegger, Marx, Freud, teoria della Gelstat, Bergson, strutturalismo. E potremmo continuare.
Il discorso è, ora, più sobrio e puntuale. Va alla radice della sua filosofia,
che è interrogazione e vigilanza sul sapere. Perché quello che si chiedeva
Merleau-Ponty è quello che ci si chiede ancora oggi: quale ragione e quale
senso possano essere concessi all’uomo e alla comunità umana. “Come
Cézanne si domanda se ciò che è uscito dalle sue mani offre un senso e sarà
capito, come un uomo di buona volontà, considerando i conflitti della sua vita,
giunge a dubitare che le vite siano fra loro compatibili, così il cittadino d’oggi
non è sicuro che il mondo umano sia possibile”5.
Chi aveva fatto l’elogio della filosofia, non poteva concludere che provvisoriamente, sottolineando la costanza, ma anche la precarietà della ragione
umana. Se Cézanne ha vinto contro il caso, concludeva Merleau-Ponty, anche
gli uomini possono vincere, purché valutino il rischio e il compito, da assolvere giorno per giorno6.
7
1
Cfr. gli Atti in Merleau-Ponty. Filosofia esistenza politica, a c. di G. Invitto, Napoli, Guida,
1982.
2
Nel 1986, io, Angela Ales Bello, Mario Signore trasformammo nella rivista “Segni e comprensione” una primitiva idea mia e di Angela Ales, quella di una sezione merleaupontyana del
Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche, che ha sede a Roma, con annesso bollettino.
Aderirono al gruppo costituente Antonio Ponsetto, Aniello Montano, Antonio Delogu.
3
Penso al convegno romano dell’’88, da cui gli Atti: La prosa del mondo. Omaggio a Maurice
Merleau-Ponty, a c. di A.M. Sauzeau-Boetti, Urbino, QuattroVenti, 1990, per conto dell’Istituto
Italiano di Studi Filosofici di Napoli. Ultimo in ordine di tempo, mentre scrivo, è stato il convegno
tenuto nel marzo del ’98 a Milano; gli atti, in edizione trilingue (francese, inglese, italiano) è apparso come n.1 della pubblicazione “Chiasmi International. Pubblicazione trilingue intorno al pensiero di Merleau-Ponty”. Titolo del volume: Merleau-Ponty. L’eredità contemporanea, Milano-ParisMemphis, Mimesis, Vrin, University of Memphis, 1999. Curatore del volume è stato Mauro
Carbone.
4
Si può dire che l’inizio della nuova stagione è datato 1986, quando nacque a Milano la
“Società di studi su Maurice Merleau-Ponty”, nel cui comitato scientifico ritroviamo ancora chi scrive, Angela Ales Bello, Mauro Carbone, Sandro Mancini e Pierre Dalla Vigna, che è anche editore
di “Chiasmi”, pubblicazione annuale della Società.
5
Préface a Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948, p.10; trad. it. a c. di P.Caruso, Milano, Il
Saggiatore, 1967, p.23.
6
Cfr. Ibidem.
UN POSTO
IN CUI SI PARLAVA MERLEAU-PONTIANO
A Verona, negli anni Ottanta, intorno a Guido D. Neri
di Mauro Carbone
8
Alla metà degli anni Ottanta c’è stato un posto, in Italia, in cui si parlava
merleau-pontiano. Dovendo scrivere della ricezione di Merleau-Ponty nel
nostro Paese, è importante ricordarlo. Quel posto si trovava nell’allora “Istituto
di Filosofia” dell’Università di Verona e si raccoglieva intorno a Guido Davide
Neri, morto a sessantacinque anni alla fine dello scorso marzo.
A Verona io ero arrivato nel 1981-82 per collaborare con Stefano Zecchi,
per il cui corso di Estetica avevo tenuto un seminario dedicato a L’occhio e lo
spirito. Nel frattempo Neri, che nel 1963 aveva tradotto La struttura del comportamento, si veniva sempre più interessando al pensiero dell’ultimo
Merleau-Ponty. Così, l’anno successivo mi coinvolse nel seminario che coordinava su Il visibile e l’invisibile. Lì conobbi quel suo modo così tipico di coniugare “ostinato rigore” di ricerca e grande disponibilità didattica. Spesso le discussioni del seminario si prolungavano in conversazioni più ristrette nel suo
studio o –com’era d’uso allora– in qualche caffè, occasioni in cui Guido regalava preziosi squarci di sapere e di memoria, curioso e grato per quello che i
suoi giovani interlocutori potevano, di ritorno, offrirgli. Fu così che, intorno a lui,
cominciò l’edificazione collettiva di quel posto in cui si parlava merleau-pontiano, alla quale fin da subito parteciparono attivamente Chiara Zamboni e
Barbara Cavaleri, che addirittura vi si formò, ma dalla quale venne sempre più
conquistato anche Paolo Gambazzi.
Dopo il trasferimento di Zecchi a Milano, la mia collaborazione con Neri
divenne stabile. I corsi o i seminari degli anni successivi sollecitarono le ricerche merleau-pontiane di ciascuno ad assumere contorni via via più definiti.
Forse erano accomunate soprattutto dall’interesse per le conseguenze filosofiche rivoluzionarie che l’ultimo Merleau-Ponty sa ricavare dalla sua fedeltà ai
paradossi dell’apparire. Ma in quelle di Guido c’era anche altro. In epoca di
proclamata crisi del marxismo, le sue non rinunciavano a interrogarsi, inoltre,
sulla fisionomia e il senso della storia, cercando nell’ontologia di MerleauPonty nuovi strumenti per indagarla.
Nel 1987-1988 Guido ci offrì l’occasione di presentare le nostre ricerche in
un ciclo d’incontri seminariali che era stato invitato a condurre a Brescia. Anche
pubblicamente, dunque, ormai facevamo gruppo, ma in un modo così spontaneo da risultare, almeno a me, tanto ovvio quanto inconsapevole, così come
restavo inconsapevole della rarità di quello stile di lavoro. Finché tutti insieme
collaborammo al numero monografico di “aut aut” dal titolo Merleau-Ponty.
Figure della nuova ontologia che Guido curò nel 1989 e che rappresentò una
DOSSIER MERLEAU-
tappa fondamentale per il rinnovamento degli studi merleau-pontiani in Italia.
Ma questo, che di quel posto di Verona in cui si parlava merleau-pontiano
fu il frutto più diretto, non ne fu certo l’unico. A esso non meno che a Lovanio
io debbo infatti l’elaborazione della mia tesi di dottorato, che grazie proprio al
sostegno veronese diventò, nel 1990, il libro Ai confini dell’esprimibile. Né
basta ancora, perché dal lavoro comune di allora, dalle discussioni appassionate e severe, dai continui e felici scambi di segnalazioni e suggestioni, nacquero progetti che solo successivamente –quando quel gruppo era ormai
almeno in parte disperso– trovarono realizzazione. Come la nuova edizione
del Visibile e l’invisibile (1993, il cui “indice tematico delle note di lavoro” è
debitore alla tesi di laurea di Barbara Cavaleri) e la traduzione italiana di
Linguaggio storia natura (1995), per entrambe le quali fu Neri a segnalarmi a
Pier Aldo Rovatti. Oppure come la pubblicazione della raccolta di “saggi sulla
filosofia di Merleau-Ponty” dal titolo Negli specchi dell’Essere (1993), che comprende la traduzione, già preparata da Guido per uno dei suoi corsi, di due
lezioni merleau-pontiane su Husserl e il concetto di Natura, nonché un’altra di
Barbara Cavaleri. Per arrivare sino agli intensi saggi più recentemente dedicati a Merleau-Ponty da Gambazzi e al suo volume dal titolo L’occhio e il suo
inconscio (1999).
È sorprendente rendersi conto di quanto debbano ancora a un posto di provincia dove una quindicina d’anni fa si parlava merleau-pontiano (Verona era
allora molto più provincia di ora) gli studi italiani sull’opera di Merleau-Ponty,
che nel frattempo sono andati trovando una sempre più diffusa capacità di
confronto internazionale.
Poco dopo la pubblicazione del primo numero di Chiasmi international
(1999), Guido mi fece avere uno scritto che gli aveva inviato in lettura un giovane laureato su Merleau-Ponty in cerca di suggerimenti e consigli. Me lo
accompagnava con un biglietto che esordiva dicendo “giovani merleau-pontiani crescono” e m’incoraggiava a usare quella rivista per coltivarli. Che, infatti, così continua a fare. Ma per formare la nuova generazione di studiosi di
Merleau-Ponty –compito su cui l’Italia si trova forse, rispetto ad altri Paesi, già
un po’ in ritardo– prima ancora di una rivista, serve soprattutto una pratica di
lavoro comune. Serve insomma un nuovo posto –non necessariamente un
luogo geografico– in cui, come un tempo intorno a Guido, si possa parlare
merleau-pontiano.
9
DIPINGERE L’INVISIBILE1
di Luce Irigaray
Ne L’Occhio e lo Spirito, come in altri suoi testi, Maurice Merleau-Ponty
rimugina il fatto che l’uomo sia capace di auto-affetto. L’uomo non sarebbe
solamente attivo – come tentano di esserlo gli scienziati dei nostri tempi, imponendoci modelli, tecniche, mondi assai estranei al nostro vissuto quotidiano –,
sarebbe anche passivo (9-13, 27-29)2. In questo senso l’uomo farebbe parte
dell’universo delle cose, sarebbe una cosa fra le altre cose.
Salvo per il fatto che sarebbe capace, o capace in un modo diverso, d’autoaffetto, che sarebbe capace di viversi come toccante e toccato – ciò che definirebbe la sua umanità, secondo Maurice Merleau-Ponty. Il proprio dell’uomo,
il propriamente umano, corrisponderebbe in un certo modo al medio-passivo:
io mi tocco, sapendolo e ricapitolando così in me sia l’attivo che il passivo.
10
Chi ha assistito al Collège de France – e io ero presente – alla lezione in
cui Maurice Merleau-Ponty spiegava, ri-scoprendolo davanti a noi, come la
sua mano destra poteva toccare la sua mano sinistra, come poteva toccarsi lui
stesso, può difficilmente dimenticare a qual punto si presentava così scisso
dagli altri, dandosi a vedere come un “oggetto” separato.
Come non pensare allora che stava conquistando la sua autonomia rispetto al mondo materno che l’aveva toccato, prima che lui non fosse capace di
assicurare un’attiva e voluta reciprocità di questo toccare. A differenza del piccolo Hans freudiano che includeva sua madre nel suo universo tramite l’oggetto bobina, Maurice Merleau-Ponty l’escludeva rinchiudendosi lui stesso
grazie a un tattile auto-affetto, di cui ci chiedeva di essere spettatori in quanto
dimostrazione di natura filosofica.
Invece di diventare uomo e conquistare così la sua umanità, Maurice
Merleau-Ponty si distaccava piuttosto dal suo divenire umano in quanto esso
è anzitutto relazionale. Si faceva cosa fra le cose, rinunciando alla prospettiva
sulle cose, per sfuggire a una primitiva sottomissione al toccare dell’altro, o
Altro: sua madre. Per dimenticare il tempo in cui era toccato senza toccare.
Perlomeno senza reciprocità nel toccare.
Ma se non prende in considerazione questo inizio, l’uomo non disporrà di
uno spazio o spaziatura fra l’attivo e il passivo nella percezione. E questo rinchiude il cerchio dell’auto-affetto che, a poco a poco, diviene autismo. Uno
spazio-tempo libero dovrebbe intervenire tra il momento del toccare e quello
dell’essere toccato, lo spazio o la spaziatura di una distanza rispetto all’immediatezza della percezione. Esso risulta da una capacità di differire il vissuto
della percezione, da quel momento sempre asimmetrica rispetto al percepito
dell’attivo o del passivo, in modo che il soggetto possa considerare ciò che la
produce – sia essa attiva o passiva.
È vero che Maurice Merleau-Ponty si cura di questo limite, ma soltanto in modo
difensivo nei confronti di un altro, o piuttosto di un’altra al cui ascendente vuole sfuggire, verso cui pretende affermare la sua autonomia. A tal fine costituisce un mondo
chiuso in cui l’intrecciarsi resta fra sé e sé, fra sé e un mondo che già si situa in se
stesso. Non c’è più, in sé, incrocio nel presente fra sé e l’altro/a. Non esiste più raddoppiamento di prospettiva rispetto al mondo che costringerebbe il filosofo che è
Maurice Merleau-Ponty a mantenere aperta la propria percezione in modo che
essa possa essere informata, interrogata, fecondata da quella dell’altro. Ciò che
richiede un rapporto fra attività e passività che necessita l’intervento di un pensare
che non sia soltanto coscienza di una percezione – che è dunque irriducibile al
semplicemente corporeo anche se il corpo vi partecipa. Non solo come “la sentinella che sta silenziosamente sotto le mie parole e i miei atti” e che “abitano”, come
io li “abito”, gli altri “con cui abito un solo Essere attuale, presente, come mai animale ha abitato quelli della sua specie, del suo territorio, del suo ambiente” (13, 29).
Maurice Merleau-Ponty resta intrecciato con gli altri con cui compone “un
solo Essere attuale”. Ma non è per questo in relazione attuale con l’altro in
quanto tale, nella sua percezione del mondo e dell’altro. Quali che siano i suoi
sforzi, Maurice Merleau-Ponty ricade nell’indifferenziato rispetto a questi altri
DOSSIER MERLEAU-
Una simile opposizione d’altronde è troppo caricaturale. Il toccare ha luogo,
anche a livello visivo, fra percepente e percepito in modo che colui che tocca,
o vede, non è semplicemente attivo, come non è semplicemente passivo colui
che è toccato, o visto. Il visto è in un certo modo attivo e il vedente in parte
passivo, in quanto vedere corrisponde ad essere toccato da un qualcosa o un
qualcuno – dalle onde luminose innanzitutto.
Questa capacità a distaccarsi da una semplice attività o passività nel vedere, l’ascoltare… lo stesso toccare richiede un’educazione della percezione
come attività non solo fisica ma anche psichica, e perfino spirituale. Lo spaziotempo risparmiato esige una rinuncia alla soddisfazione immediata del soggetto, che sia attiva o passiva. E ciò consente di considerare con rispetto l’origine o l’oggetto della percezione: che si tratti di cosa, mondo o anzitutto altro.
Il fatto di essere nello stesso tempo vedente e visto, toccante e toccato, non
sembra specifico dell’umano. Ma che siamo capaci di mettere in causa il fatto
che il nostro corpo solo intervenga, forse questo lo è. Ciò implica che non ci
prendiamo in modo narcisistico per il centro di ogni percezione: cosa che
secondo Maurice Merleau-Ponty significherebbe l’appartenenza all’umanità in
quanto tale. Il mondo chiuso che lui considera come propriamente umano mi
sembra piuttosto un mondo animale che sarebbe conscio di sé. Questo non
basta, mi pare, per definire un mondo umano. È anzi attraverso la capacità di
modulare la distanza, l’alternanza di apertura-chiusura nella relazione con l’altro che il divenire umano si caratterizza. E nell’intrecciare il mondo dell’altro con
il proprio mondo, in un molteplice incrociarsi in cui ciascuno riesce a rimanere
se stesso/a e a rispettare l’altro come altro. Ciò presuppone che uno spaziotempo – né semplice attività, neppure semplice passività – sia disponibile, in cui
accogliere l’esterno a sé, senza appropriarsene, senza farlo suo, cancellando
così il limite fra se stessi e l’altro/a, il limite di se stessi e quello dell’altro/a.
11
che lo “abitano” e con cui “abita un solo Essere attuale”. Compongono, in parte
in modo inconscio, un solo “Essere”, un solo Tutto, a cui la sua percezione partecipa senza potersi distinguere.
Lo sforzo per separare il proprio corpo da quello di sua madre non ha permesso a Maurice Merleau-Ponty di sfuggire all’indifferenziato rispetto a coloro
che compongono con lui il mondo attuale, i suoi “congeneri” (13, 29) umani.
Se lui può decidere – in parte sbagliandosi – che è “cosa fra le cose”, sembra
che l’essere uomo fra gli uomini sfugga al suo volere, alla sua coscienza. Da
un attivismo che critica a ragione, ripiomba nel passivo indifferenziato. Non ha
trovato in se stesso l’articolazione fra attività e passività che gli consentirebbe
di diventare un uomo. Manca a lui la relazione acconsentita e in qualche modo
reciproca con un altro, un’altra, differente da sé, con cui non compone, prima
di incontrarsi, un “solo Essere”. Gli manca lo spazio-tempo, la materia corporea disponibile grazie a cui sarebbe possibile nel presente percepire l’altro
come altro, compreso ciò che di questo altro gli rimarrà invisibile.
12
La natura, e meno ancora l’altro, non possono stare semplicemente all’interno di noi stessi, come sostiene Cézanne. E non offriamo loro un’ospitalità
adeguata se riserviamo loro solo in noi stessi un’“eco” o un “equivalente interno” (22, 35) di ciò che sono. Questo non corrisponde neanche alla via tramite
cui ci costituiremo un’interiorità appropriata. Ci facciamo così solamente e al
meglio specchio per il mondo, per l’altro. Senza interrogarci sulla morte che
così gli, e ci, diamo. Riflettere il mondo e l’altro equivale ad irrigidirli a partire
dalla nostra percezione: attitudine solipsistica e narcisistica una volta di più.
Il mondo e l’altro aspettano forse di essere sostenuti nella loro vita piuttosto
che di essere immobilizzati in un’immagine o un’idea di cui la nostra percezione
sia capace rispetto a loro. Così affidati ad un immaginario supposto capace di
dare loro accesso alla nostra carne. Ma l’immaginario, infatti, taglia anch’esso
dalle cose e dagli altri con cui non esisterà più nessuna comunione.
L’immaginario raddoppia il reale, investe internamente la carne con questa fodera, e impedisce così che essa sia porosa rispetto a ciò che è percepito. L’empatia
con e nel vivente invece preserva il suo volume, la sua asimmetria, la sua crescita – la sua o le sue differenze. Questa o queste salvaguardano la possibilità di
essere in comunione fuori da ogni confusione proveniente dall’indifferenziato.
In questo caso, in questo senso, ciò che è visto non è mai semplicemente
un qualcosa di visibile. Il mio sguardo è commosso dall’invisibile, percepito fra
l’altro nello sguardo dell’altro. Che mi tocca, e con cui sono in comunione – in
un tocco raddoppiato – al di qua e al di là di ogni spettacolo. E se vediamo in
un altro modo quando guardiamo insieme, in due, lo stesso paesaggio, questo non avviene per il fatto che sia intervenuto un qualcosa di visibile in più,
ma per il fatto che guardiamo in modo diverso a causa di questa condivisione
nel vedere. Il chiasmo non esiste dunque solamente fra io che vedo e io che
sono vista, io che tocco e io che sono toccata – in seno a uno stesso mondo,
il mio, o a partire da uno stesso “Essere”. Il mio sguardo, che acconsenta o no
a questo, che lo percepisca o no, vede in un altro modo se non sono sola, nel
presente, a guardare. La mia stessa percezione si trova modificata dalla con-
Quando Maurice Merleau-Ponty sostiene che la pittura “non evoca nulla,
anzitutto nulla di tattile” (27,38), dimentica, mi pare, che essa è sempre già tattile come la stessa vista. E se la pittura non evoca necessariamente il tattile in
modo tematico, e come tale, essa l’evoca necessariamente per il fatto che il
vedere equivale ad essere toccati – dalla luce, dai colori e, in qualche modo,
dal mondo e dalle cose. Ma certamente anche dall’invisibile luce dell’altro, che
mi attrae e mi ispira a meno che la mia carne sia diventata stagna al suo
approccio, che essa abbia perso certe sue proprietà o qualità.
In questo caso “vedere” può essere paragonato ad “avere a distanza” (27, 38),
come vorrebbe Maurice Merleau-Ponty e, secondo lui, la pittura “estende questo
strano possesso a tutti gli aspetti dell’Essere, che debbono in un modo o in un
altro farsi visibili per entrare in essa” (27, 38). Anche se “i suoi messaggi sensoriali rimangono discreti”, aggiunge tuttavia Maurice Merleau-Ponty, “punteggiature o cesure che l’occhio abita come l’uomo abita la sua casa” (27, 39).
Non si tratta ancora qui di dipingere l’invisibile, la stessa carne, fatta dal toccare che comporta lo sguardo – qualità che esso perderà quando si farà “specchio dell’universo” o “concentrazione” di questo universo (28, 39). Senza rispettare né riprodurre le distanze interne che animano questo in quanto vivente, interstizi nelle cose e fra le cose che uno specchio non riesce a trasformare in immagini, ad immaginare. Sicché il riflesso o la concentrazione del mondo che riproduce come messaggio di un filosofo o un pittore a tutti gli uomini sarà già sprovvisto di respiro, di vita, e anche di morte. La “similitudine” (28, 40) con il mondo
riprodotto sulla tela potrebbe realmente aver luogo soltanto se il pittore non si
accontentasse di guardare, ma tentasse di sentire qualcosa della sua esistenza.
Ciò che accade necessariamente attraverso altri sensi e altri metabolismi rispetto alla sola vista, anzitutto se è equiparata a un meccanismo speculare.
In tal caso la mano non è più al servizio di ciò che è visto – le cui tracce restituiscono il visto al visibile –, come è troppo spesso il caso in una tradizione occidentale dove si tratta di impadronirsi delle cose, e anche degli altri, grazie a un’operazione in cui la mano e lo sguardo si prestano reciprocamente assistenza.
Basta, per esserne convinti, rileggere ciò che filosofi come Sartre, lo stesso
Maurice Merleau-Ponty e, a suo modo, Lévinas scrivono sulla stretta amorosa,
e particolarmente sulla carezza. Nulla qui che alluda alla celebrazione dell’altro/a nella sua carne ma piuttosto evocazione di gesti di assoggettamento di
un’altra vita alle necessità della propria attraverso seduzione, cattura, possesso.
Il gesto di dipingere secondo Maurice Merleau-Ponty non si allontana molto
da simili gesti. Vuole testimoniare dell’abilità dell’uomo a fare così bene come la
montagna, ad appropriarsi di tutto il visibile che essa manifesta, comprese le
DOSSIER MERLEAU-
divisione con l’altro. E ciò non può spiegarsi attraverso la spartizione di una
fodera o il consenso rispetto a una somiglianza. Accade piuttosto perché della
carne circola fra il mondo e me, fra l’altro e me.
In tal modo il visibile rimane sempre aperto anche se, provvisoriamente, il
mio sguardo ne delimita un orizzonte, una cornice. Il che non significa una
somiglianza, a meno di tagliarlo dalla sua vita e di staccarmi dalla mia.
13
informali somiglianze: “luce, chiarore, ombre, riflessi, colore”, che “non sono completamente esseri reali” e che “solitamente non sono visti” (29, 40). L’abilità del
pittore sarebbe di farci vedere ciò che la maggior parte dei mortali non vede. Non
conserverebbe nondimeno una vista “profana” nella misura in cui rimane alla
superficie delle cose senza interrogarsi su ciò che sono in realtà? Esse non esisterebbero che in quanto disponibili per la vista del pittore e per la sua capacità
a misurarsi con la loro visibilità: cose così strappate dal loro ambiente, dalla loro
propria esperienza, dalla coesistenza con l’universo a cui appartengono. Esse
sono semplicemente disposte davanti allo sguardo del pittore, che interrompe,
con il suo vedere ed il suo visto, ciò in cui le cose co-appartengono le une alle
altre, e in cui co-appartengono anche all’ambiente in cui si trovano e dove si situa
colui che tenta di riprodurle senza fermarsi al sito che le ha rese possibili.
Se lo facesse, accetterebbe di immergersi in un ambiente che dà vita alle
cose e in parte a lui stesso. Ambiente da cui riceve ossigeno, ad esempio,
come accadeva nel seno di sua madre. Chi teme di tornare in un simile luogo
si chiude a questo ambiente di vita in cui siamo tutti immersi e dimentica che
lo condividiamo al di qua e al di là dei limiti del nostro corpo. Dimentica che
non siamo mai nati in modo definitivo come forma, mai incarnati in una maniera immutabile. E che noi co-apparteniamo alla carne del mondo, sicché pretendere di poter riprodurlo fa parte delle nostre pretese di tecnocrati attivisti. Si
tratta ancora di presunzioni di scienziati – ad esempio in esperienze visive, fra
l’altro grazie allo strumento specchio, alla tecnica speculare.
14
Non è necessario tuttavia inghiottirsi, essere “sommersi o sepolti” e dipingere per “risorgere”, come lo vorrebbe A. Marchand (31, 42). Basta vivere ed essere umilmente consci di ciò che questo presuppone come co-appartenenza al
mondo, da cui non siamo mai completamente staccati. In effetti, come potremmo vivere senza aria, senza luce, senza sole, senza terra sotto i nostri piedi e
cielo sopra le nostre teste, senza nutrimento…? Come distinguerci in modo definitivo dai viventi che siamo? Ciò che non significa che siamo cose fra le cose.
Da esse, dall’altro, dobbiamo differenziarci, ma apparteniamo nondimeno all’insieme dei viventi che popolano la terra e a ciò che vi rende la vita possibile.
A questo universo vivente noi co-apparteniamo e scambiamo, talvolta rovesciandoli, i ruoli fra di noi. E se un albero ci guarda, ciò non comporta di fatto
nulla di strano. Invece se lo facesse un tavolo sarebbe tutt’altra cosa. Allo stesso modo, diamo acqua alla pianta che ci dà aria. In molteplici modi, per la maggior parte invisibili, scambiamo con la vita che ci circonda. E pretendere di percepire un essere vivente solo mediante occhi-specchi e di darlo poi a vedere
agli altri, sembra un po’ ingenuo. E pure lo è credere che io possa diventare una
cosa fra le cose, che io possa trasformare le cose in spettacolo ed io nell’altro
o l’altro in me grazie all’unico potere speculare. Ciò implica che io abbia già
sostituito il reale con l’immaginario e, in qualche modo, la vita con la morte.
Senza negare che il pericolo esiste, diciamo che esso sembra risultare dal
poco di attenzione che l’uomo presta alla stessa vita e a chi gliela dà o ridà.
Equiparare la carne all’immaginario fa parte lo stesso del modo di fare di un
demiurgo di cui l’occhio sarebbe lo strumento privilegiato. Invece di contem-
Nel doppio speculare, la cosa sarebbe in qualche modo vista da parte a
parte, sarebbe totalmente visibile, salvo che essa sarebbe diventata estranea
a se stessa e che il suo riflesso corrisponderebbe a una falsa apparenza.
Sostenere che fermarsi a una simile percezione non altera la nostra visione
del mondo sembra risultare da una cecità alla stessa vita, e a ciò in cui comunichiamo o siamo in comunione con essa, in noi e fuori di noi.
In essa, le cose non sono mai semplicemente l’una esterna all’altra, perlomeno le cose viventi, se così si può dire. E l’attenzione che il pittore presta al
loro sconfinamento le une rispetto alle altre, nella profondità della loro messa
in prospettiva, non equivale ancora alla cura del loro proprio spessore o profondità, e della condivisione di questi con altre cose. Nello spazio, gli esseri
viventi non sono così separati come lo immaginiamo. Si uniscono grazie ad
un’alchimia di cui l’aria è il principale veicolo o medium. Lo spazio non è solo
un luogo in cui prendono posto le forme delle cose, esso è anche ciò attraverso cui comunicano o sono in comunione in modo spesso invisibile.
Ciò che consideriamo come un vuoto disponibile per la percezione delle loro
forme, o come un luogo che sta qui solo per l’apparire del loro stare qui, è già animato da un reale che rimane invisibile ma che permette a loro e a noi stessi di
vivere, e pure di essere toccati da onde che ci consentono di vedere il mondo, le
cose, gli altri. Rappresentarsi lo spazio come ciò che “riposa assolutamente in sé,
è dappertutto uguale a sé, omogeneo, e di cui le dimensioni ad esempio sono per
definizione sostituibili” (47, 52) corrisponde a un’idea un po’ campata in aria.
Maurice Merleau-Ponty vorrebbe che il suo corpo fosse suo, luogo carnale
di veggenza e di visibilità, e che esso fosse anche permutabile con le cose e gli
altri, ridotto alle proprietà di un’immagine o del suo supporto. Il corpo è tutt’altra cosa ancora: non solo lo “spazio natale” dell’anima e la “matrice di ogni altro
spazio esistente” (54, 56), ma anche il luogo in cui sono venuti ad inscriversi le
cose e gli altri, e pure la carne nata dall’incontro con le une e con gli altri. Non
è solo per artificio o effetto speculare che il mio corpo potrebbe diventare il
corpo dell’altro, è anche a causa di impronte e impressioni che questa carne
estranea a me lascia in me, o di una produzione nuova, non originaria, proveniente dalla comunicazione o dall’essere in comunione con un’altra carne. Il
mio spazio interno è dunque, per diversi motivi, modificato dalle cose, e più
ancora dagli altri che incontro. Esso è molteplicemente abitato e il mio modo di
guardare non si riduce mai alla semplice percezione del visibile esterno a me.
Io co-guardo con ciò e con chi già mi abita, fuori da ogni rappresentazione.
Il nostro corpo non è solamente posato o situato nello spazio, affiancato ad
altri corpi, o altre cose. È anche intreccio con questi e di questi in se stesso.
Costituisce così un luogo fatto di carne che non ha una grande analogia con lo
spazio partes extra partes di Cartesio. Ma questo non risulta dal solo fatto che
DOSSIER MERLEAU-
plare con rispetto e amicizia le cose e gli altri che lo circondano, accogliendoli su fondo di invisibilità vivente, lo sguardo diventa ciò che raddoppia, riflette,
riproduce, crea un mondo diverso senza legame presente con la vita che gli
dà vita, vita che si dà a vedere perlomeno nel suo sbocciare in forme apparenti. Il che non significa da parte a parte.
15
sia corpo: ciò avviene piuttosto perché esso è in relazione-con. Prima ancora
che di un pensiero del corpo, la filosofia difetta di un pensiero del nostro corpoanima come essenzialmente in relazione-con. Relazione che si modula in
modo diverso a seconda che il rapporto abbia luogo con un altro umano, un
altro vivente, o una cosa costruita, materiale, mentale o spirituale che sia.
16
Consisterebbe l’opera del pittore nel riprodurre il visibile per darlo a vedere a
chi non è capace di osservarlo o non ha occasione di vederlo? O piuttosto nel
fare percepire, grazie a materie e gesti specifici, ciò che il linguaggio o la musica – per fare solo due esempi – non sono in grado di fare percepire, segnatamente di invisibile? Ma perché avere così distaccato le due dimensioni? Perché
visibile e invisibile non sono stati considerati entrambi dal pittore, o da chi parla
di pittura? Non sarebbe forse perché implicano il vedere in modo diverso, in particolare nel suo rapporto con il toccare e la natura del tocco che vi interviene?
Su questo punto vale la pena di interrogare il testo di Maurice Merleau-Ponty,
certo a proposito della sua interpretazione di Cartesio ma anzitutto della mancanza di considerazione per la stessa vita e per l’intersoggettività. Intendo quest’ultima fra l’altro come incrocio di sguardi nella loro dimensione tattile. Incrocio in un
certo senso non solamente di sguardi – anche di vite, di respiri, di energie. In tal
modo un dipinto diventa una verità trasmessa, un messaggio amoroso, un’opera
da sempre comune, una creazione di mondo, un modo di dire ciò che le parole o
le note non avrebbero potuto dire. Perché si rivolgono prima di tutto all’orecchio. E
che, se tentano così di dire l’invisibile, non esprimono per questo l’invisibile nel visibile. Ciò che del mondo, delle cose e anzitutto dell’altro non percepirò. A meno che
non accetti che il suo sbocciare o irradiare in forme visibili sia nutrito da una vita,
un respiro, un’anima, presenti al di qua e al di là di ogni forma o figura.
Sostituire una simile invisibilità nel visibile con il linguaggio di un’altra percezione – parole o suoni, ad esempio – significa non riconoscere alla vista
tutte le sue possibilità: viventi, tattili, relazionali. E lo stesso vale se dimentichiamo di salvaguardare il silenzio nel parlare, o uno spazio libero fra attività
e passività nel toccare. Si tratta sempre di considerare i nostri sensi, le nostre
percezioni, come meccanismi – in qualche maniera biologici o tecnici – e non
come vie della e per la vita che ci anima, come anima anche il mondo e gli
altri. Vie che servono a comunicare o essere in comunione, prima e dopo ogni
cosa visibile. Vie che ci consentono di custodire, nutrire e fare crescere la
nostra vita, quella del mondo e degli altri. Ma pure di incamminarci in un divenire spirituale o divino, proprio e condiviso, che non ci costringa ad abbandonare o disprezzare il nostro corpo, la nostra carne.
1
La versione italiana del testo è stata realizzata da Luce Irigaray, con una rilettura di Maria
Collareda
2
I numeri di pagina si riferiscono al testo francese: L’Oeil et l’Esprit, Paris, Gallimard, Folio
Essais, 1988 e alla traduzione italiana: L’Occhio e lo Spirito (a cura di Giovanni Invitto), Lecce,
Milella, 1971, con qualche modifica nella scelta delle parole.
di Sandro Mancini
Ho incontrato il pensiero di Merleau-Ponty lungo il filo di una riflessione sull’originario che ha preso le mosse negli anni Settanta dall’incontro tra fenomenologia e marxismo, in particolare tra la problematica husserliana della
Lebenswelt e quella neomarxista della soggettività estraniata del lavoro vivo.
Da un allargamento di questa prospettiva nella direzione dell’ermeneutica e
dell’ontologia è nata la mia ricerca su M.P., collocata tra la fine di quel decennio e la prima metà degli anni Ottanta. Il suo esito principale è costituito dalla
monografia Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione1.
Il titolo vuole evocare quello che mi è parso il motivo ispiratore della filosofia
dell’ambiguità di M.P.: orientare la ricerca verso il senso nascente, là dove la
vita ricomincia cercando di aprirsi un varco nell’inerte rigidità del costituito.
La mia indagine ha inteso focalizzare soprattutto gli ultimi scritti del pensatore francese, in contrapposizione al cliché, allora invalso, di un’opinata contrapposizione tra un ‘primo’ M.P. esistenzialista e un ‘secondo’ M.P., ormai lontano dalla dimensione della soggettività e approdato alle sponde heideggeriane dell’Essere delle lontananze, dopo aver ripudiato l’iniziale ispirazione fenomenologica. Ho invece mostrato come l’ontologia indiretta abbozzata in Le
visible et l’invisible svolga il medesimo motivo della ricerca sulla percezione
delineata nella Phénoménologie de la perception, nell’ideale continuità di un’originale concezione dialettica dell’espressione.
Così, nella mia interpretazione, l’iperdialettica non è considerata come una
componente secondaria, o addirittura ipertrofica, della trama filosofica che si
andava delineando in Le visible et l’invisible, o ancor meno come un retaggio
obsoleto dell’opinata precedente fase umanistica. Essa è assunta al contrario
come un passaggio decisivo, in cui prende forma l’idea della reversibilità, sfociante in una concezione dell’essere policentrica e poliritimica. Nell’ontologia
iperdialettica il riferimento all’assoluto non scompare, ma vien meno soltanto
la funzione legittimante assegnatagli dalla metafisica, e questo è fluidificato
nella molteplicità dei piani dell’esperienza, ove funge da irrelativo della sterminata trama di relazioni di cui è intessuta la stoffa della chair. La dialetticità
dell’espressione impedisce anche che la dimensione della soggettività dilegui
con l’apertura alla nozione di struttura enucleata dalla linguistica di Saussure,
utilizzata piuttosto per istituire una relazione reversibile tra i piani, irriducibili
ma complementari, dell’esperienza vissuta e delle strutture che la informano.
Pur essendo ritornato in diversi articoli alla disamina della filosofia merleaupontyana, dopo la pubblicazione di Sempre di nuovo ho sviluppato la mia
ricerca su due piani paralleli, svolgendo in entrambi i temi e la dialettica del-
DOSSIER MERLEAU-
NELLA CORRENTE DELL’IPERDIALETTICA: IL
MIO PERCORSO A PARTIRE DA MERLEAU-PONTY
17
18
l’espressione enucleati dall’interpretazione di M.P.: un primo piano contiguo al
precedente, ancora collocato nella contemporaneità, e un secondo, situato in
una stagione apparentemente lontana dello spirito europeo, ma in effetti provvista di molteplici punti di convergenza con la nostra situazione: quella del
tardo Rinascimento.
Nella prima direzione ho prolungato il confronto, già istituito in Sempre di
nuovo, tra l’ontologia merleau-pontyana del “Logos selvaggio” e l’antropologia
del “pensiero selvaggio” elaborata da Lévi-Strauss. Proprio l’iperdialettica,
imperniata sulla sintesi di mescolanza e sulla chiasmaticità e reversibilità degli
opposti, mi ha fornito la chiave per comprendere la portata filosofica della
tematica del pensiero selvaggio di Lévi-Strauss, che ho interpretato come una
dialettica sincronica, riprendendo con una diversa curvatura una tesi avanzata negli anni ’60 da un Lyotard non ancora approdato ai noti lidi del postmoderno2: il nucleo della semantica lévi-straussiana del pensiero selvaggio, ulteriormente articolato nell’indagine sui miti amerindi, è la coappartenza dell’uomo e della natura sullo sfondo dell’indivisione primordiale della vita. Certo
Lévi-Strauss attinge la strumentazione filosofica per pensare l’identità originaria della vita più da Rousseau che da Merleau-Ponty, ma quel che conta è che
in entrambe le prospettive si svolge un parallelo percorso di critica delle pretese di dominio del Cogito, e di ridislocazione del trascendentale dal piano
della coscienza a quello della vita.
Da Rousseau Lévi-Strauss attinge le implicazioni morali dell’identificazione
primordiale dell’uomo con tutti i viventi, inoltrandosi su un sentiero che
Merleau-Ponty non ha percorso in prima persona, ma che è compatibile con
la sua interrogazione sul senso originario dell’esperienza. Essa è connotata
dall’estensione dell’ambito del dovere dall’umano al vivente in quanto tale, cui
viene riconosciuta un autonomo statuto valoriale, indipendente dagli scopi dell’azione umana. L’approfondimento di questa tematica mi ha portato, nei primi
anni ’90, allo studio di Jonas, in particolare della sua teorizzazione del “principio responsabilità”, in cui prende forma un nuovo paradigma etico, che estende l’obbligatorietà morale alla vita e all’ambiente. In quello studio –in cui tra
l’altro paragonavo la funzione che avrebbe svolto l’omonimo libro di Jonas nel
nuovo contesto culturale degli anni ’90 a quella esercitata negli anni ’60 da
L’uomo a una dimensione di Marcuse– la meditazione merleau-pontyana mi
ha aiutato a focalizzare due nodi dell’impensato jonasiano, poco valorizzati
nella scarsa letteratura critica allora esistente: da una parte l’interpretazione
del metabolismo, in cui questi scorge una dialettica primordiale dell’interno e
dell’esterno inscritta nel cuore della natura, preannunciante e prolungantesi
nel simbolismo proprio della vita animale e poi nella relazione dialettica del
sensibile e dell’intelligibile che si instaura nella vita umana, a partire dal nesso
originario di percezione e immaginazione, che qualifica essenzialmente l’uomo non soltanto come homo faber e homo sapiens, ma anche e non meno
come homo pictor3; dall’altra parte l’intuizione della spontaneità come carattere essenziale della vita, fonte perenne e sempre ricominciante di senso, convergente col tema merleau-pontyano della vita come “ordine della spontaneità insegnante”4. Ho infine individuato un ulteriore, significativo, punto di rac-
DOSSIER MERLEAU-
cordo tra queste due prospettive nella comune valorizzazione della vita infantile per la comprensione del senso dell’intersoggettività5.
Il secondo filone di ricerca germinato dal mio incontro col pensiero di M.P.
mi ha condotto allo studio della filosofia del Rinascimento, intrapreso alla fine
degli anni ’80 e condotto nell’arco dell’intero decennio successivo intorno alle
due figure, coeve e convergenti sotto il profilo del pensiero morale, di Michel
de Montaigne e di Giordano Bruno. È stato un cammino à rebours, in cui ho
ritrovato in questi due fondamentali crocevia della coscienza laica europea
temi e prospettive poi ripresi da M.P.: un cammino che mi ha poi consentito un
decentramento critico dalla ‘situazione’ filosofica del Nostro, e che mi ha spinto a riconsiderarlo alla luce di questi ulteriori percorsi critici. Così, al termine di
quel decennio di ricerca, sono tornato ancora una volta a M.P.: frutto di questo ritorno è la nuova edizione di Sempre di nuovo, pubblicata quest’anno per
i tipi di Mimesis.
Il pensiero del Rinascimento non è del tutto assente negli scritti di M.P.:
nella seconda metà degli anni ’40 egli dedica infatti due articoli a Machiavelli
e a Montaigne, entrambi ripresi in Signes, in cui sono ripubblicate anche le
prefazioni al volume Les philosophes célèbres, da lui curato nel 1956, col titolo Partout et nulle part. Nel Rinascimento M.P. trova il fascino di un nuovo inizio, l’aurorale ripresa di contatto con la vita sensibile non più delegittimata dal
dogmatismo della Scolastica, la fluidità del risvegliarsi e riabbeverarsi alla
fonte del senso autoctono del mondo della vita.
In questo quadro, mi è parso che l’incontro con Montaigne vada ben al di
là dello spazio dedicatogli nell’articolo del ’47, da cui pure ha preso le mosse
la ventennale ricerca di Starobinski sugli Essais6, e che fornisca una duplice
chiave, per comprendere sia Montaigne che M.P. In effetti M.P. non poteva non
incontrare l’autore degli Essais nel suo cammino, perché convergente è il
motivo ispiratore e l’atteggiamento con cui i due pensatori affrontano la loro
avventura intellettuale. “Nous recommençons tousjours à vivre”7: queste parole degli Essais, che ritengo suggellino il senso dell’impresa teorica di
Montaigne, indicano altrettanto bene quella di M.P. Prima ancora che tra pensieri, il loro si presenta come un incontro tra uomini, uniti nel tempo dalla forza
misteriosa delle affinità elettive. Junghianamente, si potrebbe dire che ciò che
li accomuna è il fatto che entrambi hanno integrato l’Anima non soltanto nella
sfera della loro esistenza, ma anche in quella della loro meditazione. Sia negli
Essais che negli scritti merleau-pontyani si ritrova infatti operante un medesimo senso della fluidità, nell’aderenza alle figure della vita sensibile così come
nella finezza dell’andamento di pensiero con cui entrambi gli autori seguono le
pieghe recondite della soggettività; un senso della liquidità che fa tutt’uno con
il comune estraniarsi dalla pesante solidità della logica del dominio, che accetta la vita solo per sussumerla nella rigidità degli apparati. In entrambi i casi poi
tutto ciò non contrasta, ma anzi felicemente si sposa con il pathos dell’autenticità, con l’energico richiamo ad appropriarsi dell’esistenza e a inverare in
una prassi coerente la misura dell’umana libertà. Inoltre non è affatto casuale
che, seppure in contesti ovviamente differenti, né l’uno né l’altro siano stati
pensatori sistematici, ma dilettanti, nel senso migliore del termine, sempre
19
20
pronti a ricominciare a pensare daccapo, disposti a prestare il loro orecchio e
la loro penna alle deboli voci del senso allo stato nascente, che cercano faticosamente un varco istitutivo tra l’inerte mole dei significati acquisiti.
Se il dato di questa convergenza è vero, la presenza di Montaigne in M.P.
non può essere limitata all’iniziale articolo del ’47, ed è proprio così; ritroviamo
infatti Montaigne tra i pochi autori analizzati nel corso sulla dialettica del 195556, e mi pare altamente significativa la scelta di M.P. di leggere gli Essais
come espressione di una dialettica vissuta: il mio libro su Montaigne ha preso
le mosse, e articolato, questa linea interpretativa8.
Negli scritti successivi Montaigne non è più esplicitamente menzionato, ma
ritengo che una eco di quella vecchia lettura sia udibile nella Prefazione a
Signes, dove l’autore si dilunga a polemizzare garbatamente con Sartre a proposito della sua introduzione –peraltro a mio parere molto bella– alla nuova
edizione da lui curata di Aden Arabie, una sorta di diario di viaggio dell’avventura araba del comune amico Paul Nizan9. M.P. ha qui una ragione esplicita
per intervenire sullo scritto di Sartre, perché è stato direttamente coinvolto
nelle vicende giovanili da questi rievocate. Parecchie, troppe, pagine della
Prefazione di Signes sono dedicate a confutare le implicazioni politiche contenute nel saggio sartriano; ma il suo discorso si fa più interessante dove
mostra come dietro le alte lodi che Sartre tributa all’amico morto giovane sul
campo di battaglia, e alla correlativa aspra rampogna che riserva invece per
se stesso e per il percorso della sua generazione nel dopoguerra, si giochi una
partita tutta interna a Sartre, alle prese coi suoi fantasmi. Ciò che irrita palesemente M.P. è il fatto che Sartre ha mancato l’occasione per ricordare il concreto tessuto delle relazioni intersoggettive in cui i tre amici, insieme a tanti
altri, sono stati allora aggrovigliati. Se Sartre non l’ha fatto, è perché è rimasto
vittima dell’illusione retrospettiva, in cui inevitabilmente si cade allorché si riveste il passato coi panni del presente, nell’implicito presupposto coscienzialista
che il presente detenga la vera rappresentazione del passato. Viceversa, se ci
si affida al principio di simultaneità immanente al tempo, che fa sì che le estasi temporali stiano tra loro in un rapporto orizzontale di reciprocità, si può dischiudere un autentico spazio di manifestazione agli eventi passati nel rispetto
della loro alterità, tornando a colloquiare con essi e mantenendo insieme la
consapevolezza della loro irrimediabile distanza: “Forse il tempo non scorre né
dall’avvenire né dal passato; forse è la distanza a costituire per noi la realtà
dell’altro, e soprattutto dell’altro perduto. Se potessimo guardare a distanza
noi stessi, questo distacco ci riabiliterebbe. Per riequilibrare quel che oggi
Sartre dice di sé e di Nizan ventenni, mancherà sempre quello che il Nizan cinquantenne avrebbe potuto dire della loro giovinezza. Per noi, erano due uomini che cominciavano, e cominciavano dagli estremi opposti”10.
Ma cosa c’entra la lettura merleau-pontyana degli Essais con Sartre e
Nizan? Analizzando la Prefazione di Signes, ho avuto l’impressione che quando Merleau-Ponty legge queste pagine sartriane, e ne scorge l’incapacità di
descrivere quella che non fu affatto –come lì invece appare– un’idilliaca amicizia, gli torni alla mente il celeberrimo capitolo degli Essais in cui l’autore ricorda la sua intensa relazione con Étienne de La Boétie, il giovane amico morto
DOSSIER MERLEAU-
troppo presto, allorché doveva –come Nizan– ancora dare il meglio di sé. Nella
sua replica M.P. è riuscito là dove Sartre ha fallito, perché ha saputo restituire i
termini effettivi di un concreto rapporto tra uomini in carne e ossa, nella sua
opacità e ambiguità. E non credo proprio che sia una mera coincidenza il fatto
che M.P. si esprima con parole molto simili a quelle di Montaigne, allorché si
sforza di trovare il senso ultimo, e ultimamente insensato, dell’effettiva amicizia
tra Sartre e Nizan: “Era destino che Sartre lo comprendesse solo trent’anni
dopo, perché era Sartre, ma anche perché lui era Nizan”11. Montaigne infatti,
ripercorrendo nella memoria i brevi anni trascorsi nella compagnia di La Boétie,
trova le parole più belle sulla loro amicizia, e sul valore universale dell’amicizia,
in questo allongeail della redazione finale degli Essais: “Si on me presse de dire
pourquoy je l’aymois, je sens que cela ne se peut exprimer, qu’en respondant:
Par ce que c’estoit luy; par ce que c’estoit moy”12.
Il mio libro su Montaigne fa dell’istanza merleau-pontyana del raccordo tra
vissuto e struttura la chiave per un’indagine sull’identità negli Essais che mette
capo a una sorta di scetticismo fenomenologico ante litteram, come in parte
M.P. ha colto nel suo articolo del ’47. Ne ho trattato diffusamente in Oh, un
amico!, per cui qui non mi ripeto. Mi limito a richiamarne l’esito speculativo: l’apertura di un inedito spazio di manifestazione alla dimensione irriflessa della
vita di coscienza, in cui si dà coesistenza degli incompossibili, e in cui la contraddizione, espunta dalla sfera sottoposta alla legislazione dell’intelletto, è
reimmessa nel movimento del farsi prassico della verità, a opera di un più profondo Logos: un esito, questo, in cui lo scetticismo si rivela non soltanto il
movimento del pensiero verso la verità, ma anche il movimento stesso della
verità, attuantesi perennemente nel rovesciamento delle certezze precostituite. Vi è quindi un robusto filo teoretico che congiunge l’anima fenomenologica
dello scetticismo montaignano alla dialettica dell’espressione di M.P., e che
non vien meno neppure nell’ultima ontologia indiretta della chair, anche se nei
materiali provvisori di Le visible et l’invisible il riferimento agli Essais non emerge tematicamente: lo spirito dello scetticismo fenomenologico continua ad animare l’ultimo corso della meditazione merleau-pontyana, orientandola a concepire la presenza dell’Essere nel pensiero come l’atto del suo continuo ritrarsi dalle forme dopo averle portate ad espressione, quando esse sono ormai
cristallizzate: uno scetticismo che non nega dunque l’Assoluto, ma opera
come il principio dialettico della sua fluidicazione13.
Anche la ricerca su Bruno è germinata nel fecondo terreno dell’incontro con
M.P.. La meditazione merleau-pontyana sulla chiasmaticità e reversibilità originarie mi ha fornito il filo conduttore per un attraversamento del labirintico territorio della “Nolana filosofia”; vi ho trovato infatti la chiave decisiva per venire
a capo dell’apparente aporeticità della rivoluzione onnicentrica promossa da
Bruno. Essa consiste nella reversibilità di identificazione e di separazione che
scandisce il duplice ritmo del processo di infinitizzazione attivato dal Nolano,
articolantesi nei due registri simultanei della presenza e dell’assenza, affermanti rispettivamente la generalizzazione del centro e la sua vanificazione.
La sfera infinita propone la tesi che Bruno elabori due strategie filosofiche
opposte e complementari, la via analogica della differenza e la via dialettica
21
22
dell’identità, e allestisca anche lo spazio teorico della loro comunicazione:
viene così a cadere la statica e astratta contrapposizione tra immanenza e trascendenza, che spesso ha connotato le correnti interpretative del pensiero
bruniano. Mi permetto di richiamare il passo in cui interpreto il motivo, cruciale in Bruno, della transformatio duplex del sé e della cosa, dell’interno e dell’esterno, alla luce dell’iperdialettica merleau-pontyana: “Nei Furori il culmine
della caccia della verità è il frutto della reversibilità dell’identità e della differenza, è il pensiero della reciprocità e coapparetenenza dei due movimenti
dell’entrare e dell’uscire, della complicatio e dell’explicatio, del descenso e dell’ascenso. L’ultima figurazione di questo percorso […] è la transformatio
duplex, che Bruno aveva posto al vertice della sua gnoseologia già nel De
umbris idearum: una dialettica senza sintesi compiuta, che non estingue le differenze dopo averle inglobate, ma le lascia accadere. Se ci si consente di
prendere a prestito un neologismo dell’ultimo Merleau-Ponty, è una ‘iperdialettica’ in cui la mediazione degli opposti è l’attualità dell’Uno, per il quale essere nella sua assoluta ed esclusiva unità è lo stesso che essere nella puntualità del differente: di modo che tanto più l’ente determinato si attua nella sua
peculiare specificità, tanto più attua l’Uno ad esso immanente.”14
Bruno e Montaigne da un lato, Merleau-Ponty dall’altro, si dispongono
idealmente alle due soglie della rivoluzione scientifica, nei due passaggi epocali della fine del ’500 e della seconda metà del ’900, in cui si decide l’affermarsi prima e il deflagrare poi di una delle anime della modernità: quella dualista e coscienzialista che trova la sua cifra filosofica nel paradigma cartesiano-kantiano del Cogito, in cui si saldano verità e sicurezza. Di contro a essa si
dispone quella dialettica, che trova nella vaghezza della figura della vita l’ispirazione per contrastare la riduzione del qualitativo al quantitativo e propugna
la “riabilitazione del sensibile”. Nei percorsi che potranno ancora scaturire da
questo progetto alternativo della modernità la fenomenologia merleau-pontyana rimarrà una viva fonte di ispirazione.
FrancoAngeli, Milano 1987; II edizione riveduta e accresciuta, Mimesis, Milano 2001.
Ho svolto questa indagine in due articoli apparsi nella seconda metà degli anni ’80, poi ripresi in Umano e nonumano tra vita e storia. Lévi-Strauss, Jonas e la ragione dialettica, Mimesis,
Milano 1996 (su Lyotard cfr. pp. 49-57).
3
Cfr. op. cit., pp. 116-7.
4
Cfr. op. cit., pp. 108-9 e M. MERLEAU-PONTY, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 118; tr. it. di
G. Alfieri, Segni, Milano, Il Saggiatore, 1967, p. 129.
5
Cfr. op. cit., p. 118.
6
Cfr. J. STAROBINSKI, Montaigne en mouvement, Gallimard, Paris 1982; II edizione ampliata
1993. Tr. it. della I edizione a cura di M. Musacchio, Montaigne. Il paradosso dell’apparenza, il
Mulino, Bologna 1989.
7
MONTAIGNE, Les Essais, II, XXVIII (Toutes choses ont leur saison), Éd. Villey - Saulnier, vol.
II, Puf, Paris 1988, p. 702.
1
2
DOSSIER MERLEAU-
8
Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, Gallimard, Paris
1968, pp. 85-87 e S. MANCINI, Oh, un amico! In dialogo con Montaigne e i suoi interpreti,
FrancoAngeli, Milano 1996.
9
Cfr. P. NIZAN, Aden Arabie, Maspéro, Paris 1960.
10
M. MERLEAU-PONTY, Signes, trad. it. cit., p. 52.
11
Ib., trad. it. cit., p. 51 (corsivo mio).
12
La citazione è tratta dal saggio I, 28, De l’amitié (Les Essais, vol. I, cit., p. 188, corsivo mio).
13
La prima parte del libro ripercorre i passaggi più salienti dell’autoritratto di Montaigne, enucleando l’idea di espressione che la sottende e focalizzando la questione dell’identità. Gli Essais
hanno il loro inizio in un atto di affermazione dell’identità dell’autore. Ma poi, man mano che l’autoritratto diventa il tema centrale dell’opera, tale affermazione si rovescia progressivamente nel
suo contrario. Il libro intende mostrare, in questa prima parte, come l’esito della ricerca interiore
di Montaigne non consista soltanto in uno scacco, perché se Montaigne non ha trovato l’arcano
di se stesso, pur tuttavia ha aperto un nuovo spazio di manifestazione a dimensioni fino ad allora
inesplorate della soggettività, come il corpo vissuto e l’inconscio. Alla luce degli esiti della prima
parte, la seconda affronta le idee di Montaigne. Sulla base della ricognizione della sua antropologia, il libro mostra come lo spirito scettico spinga l’autore dei Saggi a percorrere molteplici registri etici, senza appagarsi in nessuno, e come la sua riflessione morale sia attraversata da una
tensione irrisolta tra il piano descrittivo del relativismo dei costumi e quello prescrittivo di un obbligo universale di solidarietà con tutti i viventi. Si delinea così l’impensato della saggezza di
Montaigne, ossia il lato creativo dello scetticismo montaignano: esso non perviene all’identità dell’io, ma in questo scacco emerge infine che il senso dei fenomeni dell’esistenza non si attinge
nella ricerca di una loro opinata identità, bensì nel lasciar essere il loro movimento, che eccede le
pretese legislative della coscienza.
14
S. MANCINI, La sfera infinita. Identità e differenza nel pensiero di Giordano Bruno, Mimesis,
Milano 2000, p. 94.
23
DA SARTRE A MERLEAU-PONTY
di Aniello Montano
24
Maurice Merleau-Ponty non è stato un mio autore per esplicita e deliberata scelta. Non ho affrontato i testi del fenomenologo francese con il dichiarato
proposito di indagare e riflettere intorno ai temi da lui trattati e con l’intento primario di ricostruirli storicamente o di farne oggetto di analisi teorica. La lettura delle opere di Merleau-Ponty nacque da un bisogno indotto. Cercavo di
capire e documentare un passaggio assai significativo e delicato nella biografia intellettuale di Jean-Paul Sartre e mi accorsi che non era possibile procedere in quella impresa senza conoscere e comprendere le posizioni assunte e
difese da Merleau-Ponty negli anni immediatamente sucessivi alla seconda
guerra mondiale e alla resistenza antitedesca in Francia.
L’oggetto privilegiato della mia ricerca era e rimaneva Sartre. Al filosofo-letterato, campione dell’esistenzialismo francese, avevo già dedicato una monografia, alcuni saggi e la curatela di alcune parti dei Cahiers pour une morale,
una corposa raccolta di riflessioni sotto forma di appunti lasciata inedita dall’autore e pubblicata dopo la sua morte dalla figlia adottiva Arlette ElkaïmSartre1. Furono proprio le analisi delle tesi relative alla storia e alla dialettica
storica così come venivano tematizzate in alcune delle Notes costituenti il
corpo centrale dell’inedito che mi indussero a leggere Merleau-Ponty, a indagare intorno ai suoi rapporti con Sartre e all’influsso da lui esercitato su questi
intorno alla metà degli anni Quaranta.
Quelle Notes, stese e raccolte da Sartre negli anni 1947-1949, nella lettura e
nella interpretazione che ne davo, rappresentavano l’anello mancante nello sviluppo delle analisi sartriane sulla dialettica storica. A farmi pensare a un “anello
mancante” nello sviluppo del pensiero sartriano relativo alla storia e alla dialettica e, quindi, ad indurmi a tentare di recuperarlo, era stata la lettura di uno dei più
significativi saggi pubblicati in Italia negli anni Settanta sulla filosofia sartriana2. In
questo saggio, Franco Fergnani notava come le “puntigliose analisi critiche” condotte dal pensatore francese nei confronti del “materialismo” in un pamphlet del
1946, Matérialisme et révolution, non consentivano di sciogliere il “nodo del rapporto tra materialismo e dialettica”. Se sortivano l’effetto di ribadire l’adesione del
loro autore a quel filone teorico che riconosce una valenza storico-antropologica
ai concetti specifici del pensiero dialettico, quali le nozioni di negazione, sintesi e
totalità, non aprivano affatto al tentativo operato nel 1960, nella Critique de la raison dialectique, di integrare “materialità” e “dialettica”3. Fergnani, cioè, evidenziava un salto teorico, uno iato speculativo, tra le posizioni espresse nell’agile saggio del 1946 e quelle sostenute nella densa e corposa opera del 1960.
In Matérialisme et révolution, preoccupato del risvolto quietistico, attendistico
DOSSIER MERLEAU-
e, quindi, antirivoluzionario presente nel determinismo implicito nella dialettica
della natura, Sartre insisteva nell’evidenziare l’elemento attivistico e umanistico
della dialettica. Era fermamente convinto che il punto d’avvio del processo dialettico e l’elemento di garanzia per la sua validità fossero rappresentati esclusivamente da quel “pouvoir de néantisation” di cui è portatore l’uomo inteso come
coscienza. In questo pamphlet, Sartre è decisamente ancorato alla convinzione
secondo cui il materialismo, in quanto sinonimo di oggettivismo, di passività e di
inerzia, non è integrabile con le nozioni di libertà e di trascendenza progettuale
proprie del soggetto umano. La storia, perciò, è tutta spiegata con la capacità del
soggetto di riprendere e dare un senso al passato per superarlo verso un futuro
capace di illuminare e di guidare il presente. La storia non è connotata dalla temporalizzazione né dalla realizzazione di un fine predeterminato, inscritto già nelle
cose o suggerito da una situazione o da una realtà extra o superindividuale. “La
storia –scrive Sartre– non è caratterizzata né dal mutamento né dall’azione pura
e semplice del passato, ma è definita dalla ripresa intenzionale del passato ad
opera del presente: non può esistere una storia che non sia umana”4.
Al centro di questa nozione di storia si ritrova, dunque, il soggetto e, soprattutto, la categoria essenziale che lo connota: la libertà. Storia e libertà sono,
perciò, “possibilità categoriali del vissuto significante”5. Si scoprono e si realizzano nell’atto. Senza libertà, rivelantesi in un progetto umano, non c’è storia.
La libertà, però, non si esercita a vuoto. Non agisce sul piano della pura e rarefatta interiorità coscienziale. Si manifesta e opera sempre all’interno di una
situazione data. L’aver rifiutato con forza il materialismo, l’averlo considerato
l’equivalente dell’oggettivismo, dell’inerzia e della massività, per Sartre, non
significa ignorare “la realtà schiacciante del mondo materiale”6. Il soggetto –dal
filosofo francese individuato come “il rivoluzionario” in Matérialisme et révolution– è “un essere contingente, ingiustificabile, ma attivo; interamente immerso in una società che lo opprime, ma capace di superare questa società con i
suoi sforzi per cambiarla”7. È il creatore del senso da dare alla situazione e del
progetto per superarla. È, cioè, il portatore di una filosofia della trascendenza.
La polemica con il materialismo, pertanto, non punta a negare l’oggettività
opprimente di una situazione di disagio o di sofferenza. Esprime, invece, il
rifiuto di spiegare il moto di superamento della situazione data come un moto
avente “la sua origine nell’esistenza puramente materiale e naturale dell’individuo”8, o nelle “cose” stesse9 o, peggio ancora in una “Provvidenza”10. Il materialismo, in quanto “malumore di quelli che soffrono fisicamente e conoscono
la realtà della fame, delle malattie, del lavoro manuale e di tutto ciò che può
minare un uomo”11, può al massimo spingere a un primo rifiuto della situazione di fatto, ma non possiede in sé la spinta attraverso cui quella situazione può
essere superata e sostituita da un’altra. Il materialismo, perciò, può essere
considerato soltanto come “una dottrina del primo movimento”12, giammai una
dialettica storica. La capacità del soggetto di prendere le distanze dalla situazione data per assumere su di essa un “punto di vista”, che è unità indissolubile di comprensione e di azione e non una conoscenza pura, è la libertà. È,
cioè, la capacità della coscienza umana di progettare liberamente il futuro.
In Matérialisme et révolution, del 1946, così come in L’être et le néant, del
25
26
1943, tutta la dialettica storica, perciò, risulta incentrata nella coscienza umana.
Pur denunciando il dramma dell’oppressione dell’uomo da parte dell’uomo e lo
“scandalo insormontabile” della pluralità delle coscienze, Sartre non ne evidenzia la scaturigine prima. Non ne individua le categorie fondamentali. Il fondamento ultimo dell’oppressione e dell’alienazione, nonostante la finezza e la profondità di molte delle analisi condotte in quei testi, rimane ancora nell’ombra.
Non si giunge a una comprensione adeguata del primo movimento generatore
dell’oppressione e della violenza. Ci si limita ad affermare che gli uomini sono
immersi nel reale, che sono vittime di un’oppressione concreta dalla quale tentano di liberarsi con azioni egualmente concrete, ma perché la situazione concreta riveli il suo “coefficiente di avversità” si fa appello a un progetto umano
che la rischiari13. Solo a partire da questo progetto della coscienza prende avvio
la dialettica storica. Come se tra situazione di fatto e libertà umana non si
instaurasse alcun rapporto di condizionamento e di reciproca interazione. Quel
che manca, perciò, non è la individuazione degli elementi materiali che opprimono e condizionano l’uomo. È, invece, la individuazione e la messa in evidenza della correlazione tra materialità (l’oppressione concreta dell’uomo) e
dialettica (la libertà della coscienza umana e la sua trascendenza progettuale).
La correlazione e l’integrazione tra materialismo e dialettica troverà una più
compiuta realizzazione nella Critique de la raison dialectique, quando il filosofo individuerà nei bisogni umani e nella scarsezza dei mezzi messi a disposizione dalla natura per il loro soddisfacimento (la rarété) la prima spinta al
movimento dialettico e radicherà, quindi, la trascendenza progettuale del soggetto umano su un terreno materialistico-pratico.
Pur segnalando questo stacco tra le posizioni espresse nel pamphlet del
1946 e quelle messe a punto nella grande opera del 1960, Fergnani segnalava, però, anche l’esistenza di un legame tra i due scritti. Entrambi erano considerati espressione del bisogno di realismo avvertito da Sartre nel corso degli
anni Quaranta. Nella critica all’idealismo e al materialismo oggettivistico condotta in Matérialisme er révolution con la quale Sartre censurava il primo per
aver esaltato la soggettività a danno della “cosa” e il secondo per aver accentuato il ruolo della materialità a danno della soggettività, Fergnani scorgeva un
primo “germe di realismo”. “Germe” che, presente nell’opera del 1946 solo allo
stato “esigenziale”, annunciava quelle riflessioni giunte poi a piena maturazione nel “materialismo realista” nell’opera del 1960.
Le analisi di Franco Fergnani non potevano andare oltre queste osservazioni. Con la finezza delle sue considerazioni critiche, Fergnani coglieva contemporaneamente tanto lo stacco esplicito tra le due opere quanto la possibilità di
considerare la seconda come la piena ed esplicita realizzazione dei i “germi”
positivi impliciti nella prima. Quello che il critico non poteva cogliere ed evidenziare era il passaggio intermedio che, nel consentire di colmare quella distanza,
rendesse esplicita e portasse a realizzazione piena l’esigenza di concretezza
storica avvertita fin dai primi anni Quaranta. Un passaggio che facesse da ponte
per meglio comprendere ed esplicitare la via attraverso cui il “germe di realismo”
presente in Matérialisme et révolution sarebbe maturato trasformandosi nel
“materialismo realista” della Critique de la raison dialectique. A Fergnani man-
DOSSIER MERLEAU-
cava il testo dei Caihers pour une morale, l’anello mancante nella catena di
riflessioni articolatasi dalla metà degli anni Quaranta fini agli anni Sessanta.
Come e in che misura i Cahiers rappresentino il punto intermedio all’interno di questa catena di riflessioni credo di averlo già mostrato in altra sede14.
Quello che qui interessa esplicitare con maggiore chiarezza è la sollecitazione indirettamente offerta da Merleau-Ponty all’approfondimento e alla direzione delle riflessioni sartriane a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta,
quando il “germe di realismo” dà i primi frutti nelle Notes dei Cahiers, fino al
1960, quando matura pienamente nel “materialismo realista” della Critique.
A fornirci indicazioni utili per la comprensione dei rapporti tra i due filosofi
francesi e per la valutazione del ruolo svolto da Marleau-Ponty nel tentativo
operato da Sartre per trarsi fuori da quella sorta di coscienzialismo individualistico in cui si era impantanato, nonostante i tanti sforzi messi in atto da La trascendence de l’ego, fino a Matérialisme et révolution, è Sartre stesso in quello stupendo saggio che è Merleau-Ponty vivant. Scritto nel 1961, all’indomani
della morte dell’amico, Sartre, in questo saggio, ricostruisce i suoi rapporti
intellettuali con Merleau-Ponty, con quella serenità di spirito e quell’equanimità di giudizi che riesce a mettere in campo ogni volta in cui gli occorre di parlare di amici e interlocutori scomparsi.
Pur essendosi incontrati ai tempi della loro formazione scolastica e pur essendosi formati seguendo entrambi la fenomenologia husserliana, si avvicinarono
soltanto ai tempi della guerra, partecipando alla stessa esperienza di “Socialismo
e libertà”, nel 1941. Le lunghe discussioni e i comuni interessi per la fenomenologia e per la filosofia dell’esistenza non fecero scattare però, in quell’occasione,
una complicità intellettuale né una convergenza di punti di vista. Sartre era ancora troppo concentrato sulle “tensioni inquiete” della coscienza. Merleau-Ponty
aveva già scoperto, attraverso l’analisi della percezione, la tessitura che connette il nostro corpo al mondo e il mondo al nostro corpo. “Per imparare quello che
egli sapeva –scrive Sartre– mi occorse ancora un lustro”15. Nessuno dei due era
marxista, eppure, dopo la “bonaccia” del 1945, furono trattati in modo differente
dai comunisti. Sartre fu attaccato aspramente, Merleau-Ponty fu considerato “più
vicino”. Eppure, Merleau diffidava del marxismo, sospettando si trattasse di una
delle tante forme del “pensiero di sorvolo”, di una filosofia che considera il
“mondo” oggetto della riflessione, dimenticando che esso ci circonda, che è il
“nostro ancoraggio”, che la vita del singolo e “l’esistenza storica” sono “fatte dello
stesso tessuto”. Accettava il materialismo storico “come uno schema euristico”.
Insomma, era “marxista in mancanza di meglio”16.
L’incontro vero tra i due filosofi, quello che consentì l’osmosi, vale a dire il
transito da Merleau-Ponty a Sartre di nozioni fondamentali, tali cioè da consentire una svolta significativa nella percezione della realtà e nella considerazione del fondamento della dialettica storica, avvenne con la pubblicazione su
Les Temps Modernes degli articoli confluiti poi in Humanisme et Terreur. “Egli
–scrive Sartre– si orientava meglio di me nel mondo ambiguo della politica: lo
sapevo; ed è poco dire che mi fidavo di lui: quando lo leggevo mi sembrava
che egli mi rivelasse il mio pensiero […]. Io leggevo, mi istruivo e finivo con
l’appassionarmi alla lettura. Fu la mia guida, è stato Humanisme et Terreur a
27
28
farmi fare il salto. Questo piccolo libro così denso mi rivelò il metodo e l’oggetto: mi diede la spinta necessaria per strapparmi all’immobilismo”17.
Le riflessioni di Sartre e di Merleau-Ponty, come anche i loro scritti, da questo
momento in poi si avvicinano, talvolta si incrociano, si sfiorano, ma non registreranno mai una perfetta sintonia o un equilibrio stabile. Sartre e Merleau erano
partiti da modi precategoriali di sentire l’uomo la realtà troppo diversi per potersi
incontrare e insieme dimorare a lungo in una stessa visione del mondo. In quel
momento, però, in quel fatidico dopoguerra, Sartre assorbì e tesaurizzò la lezione dell’amico e, grazie a questa, impresse una svolta al suo pensare e al suo
agire. Da Humanisme et Terreur apprende soprattutto il valore del circolo delle
relazioni interumane con le relazioni degli uomini e con la natura: “Le nostre relazioni con gli altri si traducono nelle nostre relazioni con la natura e le nostre relazioni con la natura nelle nostre relazioni con gli altri”. Apprende, cioè, a cercare
nei problemi economici “l’equivalente esatto e la figura visibile” dei problemi filosofici18. Ed apprende, altresì, che ogni azione di un uomo su un altro non è esclusivamente effetto di una intenzionalità puramente coscienziale, in quanto “la
coscienza è impotente senza il suo corpo, e può agire sulle altre solo agendo sui
loro corpi […]. La storia è quindi essenzialmente lotta –lotta del signore e del
servo, lotta di classe– e ciò per una necessità della condizione umana e in ragione del paradosso fondamentale che l’uomo è indivisibilmente coscienza e corpo,
infinito e finito. Nel sistema delle coscienze incarnate, ciascuna può affermarsi
solo riducendo le altre a oggetti”19. La storia umana è possibile in quanto l’uomo
si “proietta nell’esteriorità”, è un essere che per realizzarsi ha bisogno degli altri e
della natura, che realizza la sua individualità impossessandosi di alcuni beni e,
perciò, “entra in conflitto con gli altri uomini”. Da Merleau-Ponty, Sartre è indotto
a riflettere sulla durezza dell’esistenza umana, sulla condizione di oppressooppressore dell’uomo. E a prendere atto che tale condizione affonda le sue radici nella struttura profonda dell’esistenza, in quell’essere coscienza-corpo di ogni
singolo che entra in un rapporto inevitabile con altre coscienze-corpo in una
trama inestricabile con la natura e le condizioni materiali della vita. Anche se in
forme diverse, a seconda dei regimi, si dà, dunque, una sola condizione fondamentale della vita umana: la condizione di oppressione20. La “vera moralità, perciò, non è la misura dei nostri pensieri e delle nostre volontà, non coincide con la
kantiana “volontà buona”. Si riferisce, invece “a ciò che facciamo”. Si misura sulle
nostre azioni e sugli effetti prodotti da queste sulla struttura del nostro essere
coscienza-corpo in relazione con altre coscienze-corpo e, insieme, strette in un
tessitura unitaria con il mondo naturale. Sartre aveva appreso, perciò, a procedere in una più minuta e precisa intelligenza della concretezza storica e a guardare con occhi più attenti al circolo evento-azione/azione-evento che, dopo Hegel
e Marx, ha preso il nome di praxis21. “In una parola –scrive Sartre– fu Merleau che
mi convertì: nel profondo del mio cuore ero un nostalgico della anarchia, frapponevo un abisso fra i vaghi fantasmi della collettività e l’etica precisa della mia vita
privata”22. Gli aveva insegnato che, senza una puntuale comprensione dei meccanismi economici e politici, i “valori” prodotti dalla libertà umana restano pure
affermazioni verbali. Non entrano a far parte dell’esistenza concreta.
Oltre all’oggetto su cui riflettere, Merleau-Ponty aveva insegnato a Sartre
DOSSIER MERLEAU-
anche il metodo, il modo come riflettere. In un articolo pubblicato qualche mese
prima di quelli raccolti in Humanisme et Terreur, Merleau-Ponty forniva la risposta alla domanda che Sartre si era posto in Matérialisme er révolution su come
un materialismo potesse essere dialettico, vale a dire su come potesse contenere in sé un elemento attivo in grado di innescare un movimento produttivo del
nuovo. Merleau, con la sua lezione, lascia capire che l’impostazione dualistica
di Sartre era di per se stessa di ostacolo alla comprensione della dialettica. La
“materia”, così come la “coscienza”, non può essere considerata a parte. Essa
è parte coessenziale del sistema della coesistenza umana23. Contribuisce a
fondare una situazione comune a tutti gli individui e a rendere possibile una
linea di sviluppo e un senso della storia. La potenzialità della situazione, che
Sartre riteneva potesse essere attivata dalla coscienza umana, in quanto
coscienza “libera”, immaginante e progettante, per Merleau poteva e doveva
essere sollecitata dalla “productivité humaine”24. Si trattava, cioè, di considerare “coscienza ” e “materia” come due aspetti inscindibili della praxis umana.
Con queste riflessioni di Merleau-Ponty, la filosofia francese usciva dal sua
perenne cartesianesimo, da quel cartesianesimo che aveva fino ad allora contagiato anche Sartre. Non è un caso, infatti, che nello stesso anno in cui pubblicava Matérialisme er révolution, curava una scelta di brani di Cartesio, premettendovi una larga introduzione. Il volume appariva nella collana “Les classiques de la liberté” e l’introduzione recava significativamente il titolo La liberté
cartésienne25. Da Merleau, Sartre apprendeva che il soggetto non può più essere considerato un soggetto epistemologico, il legislatore assoluto che fornisce
un senso alla situazione e all’esperienza. Ma è un prodotto-produttore, che con
la sua azione può trasformare la necessità in libertà. Merleau-Ponty, facendo
riferimento a Hegel, a Marx e a Husserl, indicava questa sua dottrina come “filosofia esistenziale”26. Offriva, cioè, un esempio di come fosse possibile integrare la fenomenologia, dottrina base dell’esistenzialsimo, con Hegel e Marx.
A partire dalla lettura di questi testi di Merleau, Sartre matura il progetto di
integrare l’esistenzialismo con la filosofia marxista. E, da questo progetto scaturirà, poi, l’altro ipotizzato e messo in essere alla fine degli anni Cinquanta,
all’epoca, cioè, della elaborazione dei temi che saranno al centro di Questions
de méthode e della Critique de la raison dialectique, dell’integrazione del marxismo con le scienze umane. Il primo testo in cui Sartre dà prova della svolta
verificatasi nella sua concezione filosofica sono appunto i Cahiers pour une
morale, redatti tra il 1947 e il 1949. Redatti, ma non stampati27. Come apprendiamo da Michel Contat, nonostante la consapevolezza nuova del ruolo svolto dalla “materia” nella dialettica storica, nel circolo evento-azione/azioneevento, cioè nella praxis umana, Sartre è convinto che la morale dei Cahiers
sfuma ancora nell’idealismo, resta ancora una morale astratta, non ancora vincolata alla prassi politica concreta28.
Sartre, dunque, pur avendo appreso la lezione di Merleau, riteneva di non
aver ancora realizzata la sua aspirazione a elaborare una morale poggiante
“sur des bases historiques et matérielles distinctes de celles du marxisme”29,
ma distinte anche da quelle dell’idealismo. È convinto che, pur avendo fatto
maturare alquanto il “germe” di realismo già coltivato in Matérialisme er révolu-
29
30
tion, non era riuscito a fondere e ad amalgamare la dialettica idealistica di
Hegel con quella materialistica di Marx. Pur subendo il fascino di entrambi, non
li accettava nella loro “unilaterale assolutezza”. Di Hegel condivideva e accoglieva il principio secondo cui la dialettica è prerogativa essenziale ed esclusiva della coscienza umana. Gli imputava, però, di aver riservato una scarsa considerazione agli elementi “passivi” della storia e di aver fatto solo un cenno,
senza adeguato sviluppo, a concetti fondamentali per la comprensione della
dialettica storica, come ad esempio il lavoro. Di Marx apprezzava l’impegno
nello sviluppo di quanto nell’hegelismo rimaneva privo di adeguata attenzione,
ma continuava a non perdonargli di aver voluto vedere, insieme a Engels, una
dialettica nella natura. Sotto la spinta della sollecitazione dei testi di MerleauPonty di questi anni, sentiva, però il bisogno di integrare Hegel con Marx. “Ma
che succede –si domandava– se noi supponiamo un ordine di identità, cioè di
fronte alla storia umana, qualcosa di reale, una natura che si caratterizza precisamente mediante il non dialettico? Cioè se tiriamo Hegel in direzione del
marxismo? In verità la situazione è difficile”30. Il concetto di ordine di identità, di
natura non dialettica presente in questo testo, nella Critique de la raison dialectique troverà la sua definita formulazione nel concetto di pratico-inerte.
Ma ormai la svolta è avviata. La “situation historique, presentata nei Cahiers,
grazie alla sollecitazione degli scritti di Merleau-Ponty, non è più la stessa di
quella presentata in L’être et le néant31. Sembra avere, invece, come referente il
soggetto radicato in un gruppo sociale, all’interno di una relazione anche economica, e non più soltanto psicologica, con gli altri. Non è più il soggetto singolo con la sua libertà, il suo “essere-sempre-al-di-là-di-ciò-che-è-stato-fatto”.
Pur di fronte alle esitazioni e all’incertezza di Sartre di non essere ancora
riuscito a mettere a punto una visione soddisfacente della storia e della dialettica storica, va affermato con chiara convinzione che la grande massa delle
riflessioni consegnate ai Cahiers, seppure non date alla stampa, rappresenta
comunque un passo, e non piccolo, in direzione del più maturo realismo maturato dal filosofo alla fine degli anni Cinquanta. Passo che spinge avanti la
riflessione sartriana in uno sviluppo evolutivo, realizzato comunque, nella continuità. A far maturare questa prima svolta sono state appunto le suggestioni e
le sollecitazioni provenienti dalle opere di Merleau-Ponty.
Sartre ne rimase affascinato e le lesse con attenzione e coinvolgente interesse. Ed io con lui.
J.-P. SARTRE, Cahiers pour une morale, par Arlette Elkaïm-Sartre, Paris 1983.
F. FERGNANI, La cosa umana. Esistenza e dialettica nella filosofia di Sartre, Milano 1978.
3
Ivi, p. 68.
4
J.-P. SARTRE, Materialismo e Rivoluzione, tr. it., a cura di F. Fergnani e P.A. Rovatti, Milano
1977, p. 63 (Matérialisme et révolution, “Les Temps modernes”, n. 9, juin 1946, pp. 1537-1563, n.
10, juillet 1946, pp. 1-32).
5
G. INVITTO, Sartre. Dal “gioco dell’essere” al lavoro ermeneutico, Milano 1988, p. 103.
6
J.-P. SARTRE, Materialismo e Rivoluzione, cit., p. 75.
7
Ivi, p. 101.
8
Ivi, p. 100.
1
2
DOSSIER MERLEAU-
9
Ivi, pp. 100-101, dove si legge: “La dialettica materialsistica è nata apposta per spiegare o
giustificare questo superamento verso l’avvenire, ma il suo sforzo tende, in definitiva, a mettere la
libertà nelle cose e non nell’uomo, il che è assurdo”.
10
Il riferimento alla “Provvidenza” in Materialismo e Rivoluzione è fatto per chiarire la contingenza e la ingiustificabilità dell’esistenza umana che né l’uomo “né una Provvidenza […] hanno
determinato”, ibidem, p. 99.
11
Ivi, p. 75.
12
Ibidem
13
Ivi, p. 121.
14
A. MONTANO, Il disincanto della modernità. Saggi su Sartre, Napoli 1994, soprattutto i primi
tre capitoli.
15
J.-P. SARTRE, Merleau-Ponty vivant, “Temps Modernes”, nn. 184-185, 1961, tr. it. MerleauPonty vivo, in Idem, Il filosofo e la pace, prefazione di M. Alicata, Roma1964, pp. 163-232, citazione tolta da p. 169; da cui d’ora in poi, citerò.
16
Ivi, p. 171.
17
Ivi, p. 181.
18
M. MERLEAU-PONTY, Umanesimo e Terrore, Prefazione di P. Flores d’Arcais, Milano 1978,
p. 115, per entrambe le citazioni.
19
Ivi, p. 116.
20
Cfr. ibidem: “Che l’oppressione dell’uomo da parte dell’uomo si manifesti senza maschera,
come nel dispotismo, dove la soggettività assoluta di un solo trasforma in oggetti tutti gli altri, che
si camuffi da dittatura della verità oggettiva come nei regimi che imprigionano, bruciano o impiccano i cittadini per la loro salvezza (e il camuffamento è vano, poiché una verità imposta è solo la
verità di pochi, cioè lo strumento della loro potenza), o che infine, come nello Stato liberale, la violenza sia posta fuori legge e realmente soppressa nel commercio delle idee, ma conservata nella
vita effettiva, sotto forma di coloniezzazione, della disoccupazione e del salario, si tratta solo di
differenti modalità di una situazione fondamentale”.
21
J.P. SARTRE, Merleau-Ponty vivo, cit., p. 183.
22
Ivi, pp. 182-183.
23
M. MERLEAU-PONTY, Marxisme et philosophie, “Revue internationale”, 6, 1946, pp. 518-526, ora
in Idem, Sens et Non-sens, Pris 1966, pp. 221-241, da cui citiamo. Cfr. anche E. Lévinas,
Sull’intersoggettività. Nota su Merleau-Ponty, in Idem, Fuori del soggetto, Genova 1992, pp. 103-108.
24
M. MERLEAU-PONTY, Marxisme et philosophie, cit., pp. 228-229.
25
Descartes 1596-1650, Introduction et choix par J.-P. Sartre, Editions des trois Collines,
Géneve-Paris, 1946. In un passaggio dell’introduzione, si legge: “Ainsi puis-je sentir, si je m’examine, que l’intellection n’est pas le résultat mécanique d’un procédé de pédagogie, mais qu’elle a
pour origine ma seule volonté d’attention, ma seule contention, mon seul refus de la distraction ou
de la précipitation et, finalement, mon esprit tout entier, à l’exlusion radicale de tous les facteurs
extérieurs. Et telle est bien l’intuition première de Descartes: il a compris, mieux que personne,
que la moindre démarche de la pensée engage tout la pensée, une pensée autonome qui se
pose, en chacun de ses actes, dans son independence plénière et absolue” (ivi, pp. 11-12).
26
M. MERLEAU-PONTY, Marxisme et philosophie, cit., p. 237.
27
Vedranno la luce soltanto con l’edizione, già citata, curata dalla figlia, Arlette Elkaïm Sartre,
nel 1983.
28
“Sartre explique l’échec de sa Morale de 47-49 par sa méconnaissance de la dialectique et
sa inexpérience de la lutte de classe. Il a cessé d’y travailler lorsq’il s’est aperçu que cette morale s’évaporait dans l’idéalisme et restait, malgré ses efforts, une ‘morale d’écrivain’ suspendue à
la lucidité d’une conscience abstrait au lieu d’être une morale de la praxis concrète, c’est-à-dire
politique” (Sur la bêtise. Un texte inédit de Jean-Paul Sartre, publié par M. Contat, “Magazine
Litteraire”, nn. 103-104, 1975, pp. 28-34, il passo citato è tolto da p. 28).
29
Sur la bêtise, cit., p. 28.
30
J.-P. SARTRE, Cahiers pour une morale, cit. p. 69, traduzione mia.
31
Laddove si leggeva: “Noi chiameremo situazione la contingenza della libertà nel plenum dell’essere del mondo in quanto questo datum, che è presente solo per non costringere la libertà, non si
rivela alla libertà che come già chiarito dal fine che essa sceglie. Così il datum non appare mai come
esistente bruto ed in-sé al per-sé: si manifesta come motivo, perché non si rivela che alla luce di un
fine che lo chiarisce” (J.-P. SARTRE, L’essere e il nulla, tr. it. di G. Del Bo, Milano 1975, pp. 589-590).
31
MERLEAU-PONTY SCRITTORE DELL’ESSERE
di Fulvio Papi
32
Come si riesce a trovare un autore, anche di grande importanza, anche
decisivo per il breve destino della propria vita, se non si percorre il breve spazio che conduce alla propria biblioteca e, al ritorno, si accumulano i suoi libri
sulla scrivania per progettare una nuova lettura? E se si prende questa strada
che cosa s’incontra subito all’apertura delle pagine?
Percorsi dei propri segni, devoti e irriverenti per la cura affrettata, ingenui e
perentori per il desiderio di far proprio il testo, filigrana di parole esemplari del
tempo che correvano con il proposito di “diventare”.
Appare certamente un interprete con i suoi segreti che, con il tempo, ha
smarrito non poco del suo credito perché, a dispetto del suo primo affannarsi
sulle pagine dell’autore, gli anni hanno navigato, per altre esperienze, interpretazioni custodite nella memoria, più sicure, più continuative e probabilmente, nella loro mutazione, più ingiuste. La propria archeologia lascia abissi tra i
marginalia dei libri e la memoria: ora siamo accaduti in una composizione soggettiva, sempre ambigua se esplorata con fedeltà, e, infine, casuale come gli
atomi di Epicuro di cui parla Althusser nelle sue ultime carte. Non si può vincere la memoria rispetto a un “da capo” che fugge all’orizzonte, e, allora, dall’archivio di questo press’a poco non resta che costruire in un testo la filosofia
sotterranea che ha vissuto lungamente come materiale metaforico privato,
pregando i lettori di scusare e portare pazienza.
Il luogo centrale del discorso è la Fenomenologia della percezione, di cui
traccerò quelli che mi sembrano i tre esiti fondamentali, si comprende, resi
possibili dal rapporto con altre esperienze, impegni, emozioni, letture, che, in
una storia di Merleau-Ponty, dovrebbero essere trovati con la pazienza e la
gioia della scoperta. Vedremo le tre linee: ora ricorderò molto brevemente
–come del resto tutti sanno– che la Struttura del comportamento del 1942
segna alcuni punti di non ritorno.
“Io non sono una conoscenza pura” dice Merleau-Ponty.
Il tesoro scartato con la pazienza rituale della riduzione fenomenologica è
un oggetto privo di consistenza, un rinvenimento cartaceo. La psicologia della
Gestalt e la concezione del corpo dell’Husserl più maturo, scovato a Lovanio,
hanno reso impraticabile la coscienza, l’io profondo, l’apparizione come premio filosofico del primo Husserl, dalla messa in scena della verità cartesiana.
La trasparenza si fa opaca e la coscienza è un modo di dire, che appartiene
al lessico, che rimane passivamente nella strategia discorsiva, mentre è il
corpo ad essere “il veicolo del proprio essere al mondo”, così anche l’autointerpretazione fenomenologica dell’essere qui (Dasein) di Essere e Tempo
trova la sua radice originaria.
DOSSIER MERLEAU-
La “fatticità” si incorpora e dalla relazione tra il corpo e il mondo derivano
forme di strutturazione progressiva per cui prima la dimensione psichica e poi
quella culturale integrano i livelli inferiori, per cui vi è un corpo vivente biologico e un corpo dialettico sociale: “Ciascuno di questi gradi è anima in rapporto
al precedente corpo rispetto al successivo”. In Husserl la parola spirito del
resto viene usata in un contesto molto simile.
Il tema si ripeterà nella Fenomenologia della percezione, ma quello che
crea forse qualche perplessità è l’ordine delle forme, la loro integrazione sicura. È certamente vero, come dice Merleau-Ponty, che l’unità dei sensi equivale a “siamo al mondo”, ma la vita sensibile ha pertinenza più o meno diretta
man mano che la sensibilità trova forme simboliche stabili al di là del quadro
percettivo immediato.
La sensibilità assume forme differenti e ciascuna forma disloca nuovamente la relazione corporea secondo una sua propria modalità, valorizza e mette
in secondo piano, normalizza la stessa capacità percettiva secondo la forza
che è propria di una forma. Non c’è mai relazione ordinata, complessiva: il
corpo accade come può, secondo le strutture intenzionali della forma, subisce
comandi disciplinari silenziosi. La musica richiede certamente gli occhi che
sono fondamentali a un certo livello dell’apprendimento, il corpo deve costruirsi secondo un insieme di abilità possibili, ma non originarie, l’udito (che può
essere anche immaginario), ma è fondamentale. La pittura richiede le mani (il
vecchio Rembrandt diceva che ormai erano solo le sue mani a dipingere), ma
sono gli occhi –anche come memoria visiva– a giocare la parte più rilevante.
Così è vero che la sessualità è “la brama individuale attraverso la quale
percepiamo il mondo”. Tuttavia il desiderio non è nemmeno così facilmente
riducibile come può essere pensato con il concetto di impulso, come avveniva
nel primo Freud. Impulso non è istinto, e la strada è già aperta per vedere una
continua educazione simbolica del desiderio, proprio come dice MerleauPonty a proposito della parola come evento che si impadronisce del corpo. Le
parole hanno “prese” sul corpo e circoscrivono zone di significato. Così, nel
discorso di Merleau-Ponty, vi è una continua tensione tra il corpo, che “è ciò
che apre al mondo e mi mette in situazione”, un originario precategoriale che
nessun pensiero può ridurre a un concetto, e l’andare verso forme che hanno
una loro stabilità simbolica. “Il nostro corpo non è oggetto di un io penso, ma
un insieme di significati vissuti che va verso il suo equilibrio”. L’equilibrio è raggiunto attraverso quel desiderio che fa sì che “l’uomo abbia una storia”.
Le cose mi appaiono più complicate: non c’è una così completa armonia di
forme. Il corpo come origine è il modo sicuro per abbandonare con felicità ogni
disegno di parole che, attraverso il loro significato, fanno apparire il mondo e
la sua intelligenza. La scrittura del mondo è sempre connessa con la dimensione dei corpi: l’intersoggettività simbolica, le forme intenzionali sono sempre
più complesse, ma la relazione con il corpo agisce sia come stabilità che come
instabilità. La temporalità non è un campo omogeneo: si può sostenere che vi
è la temporalità percettiva (l’autocostituzione del tempo), ma ci sono anche le
temporalità delle pratiche mondane, che hanno propri processi e ragioni di
autocomprensione.
33
34
È proprio vero che “noi non ci possediamo in ogni momento in tutta la nostra
realtà”, ma non solo perché la coscienza non è una sintesi, ma perché c’è una
continua dis-simmetria nell’organizzazione dell’esperienza. Dis-simmetria che
mi rende difficile accettare la proporzione di Merleau-Ponty secondo cui il rapporto tra parola e corpo, di principio, non è disambiguabile, ma il soggetto, nel
suo essere situato in un mondo fisico e sociale, ha un destino di libertà.
A mio modo di vedere, ha solo il destino che può avere, ha l’essere che gli
è consentito, dis-simmetria tra corpo e mondo simbolico: un “mondo della vita”
che occorre andare a vedere con pazienza per trovare la forma dominante del
suo senso-non senso.
Per Merleau-Ponty nel “destino di libertà” si apre una dialettica tra i significati disponibili, quelli che si stabiliscono in un mondo comune e quindi provocano il modo di viverlo, e un pensiero che rinnova quel pensiero che è già nella
parola e apre una nuova comprensione. Un “destino di libertà” che è l’avere affidato nel proprio modo di costruirsi, il compito di non definire intellettualmente la
libertà, ma di viverla come una tensione a: qualcosa richiama naturalmente il
“sempre di nuovo” di Husserl e la metafora dell’apertura di Heidegger.
È inevitabile che la linea retta del soggetto, così trovato, prosegua: nel
momento, nel mondo che ci è dato, così come ci è dato ora (il tempo stesso,
il fondamento della libertà), Il come si costruisce la destinazione alla libertà
non è un’evidenza teorica, è un problema che si risolve nella scelta e nell’azione. Il corpo ha preso la forma di soggetto e nella sua metamorfosi che l’ha
modificato, ma non dimenticato (almeno nella teoria), è divenuta un’esistenza
nella quale agisce la condanna del senso.
Come si poteva stare in un’esperienza estrema quale fu quella della
Resistenza, senza interpretarsi come soggetti, libertà, scelta, azione? Sono
tutti concetti che costruiscono il senso contingente della situazione, l’aria che
si deve respirare per poter vivere in quel momento. Ma quando questi concetti diventano lessico filosofico, durata dell’intelligenza, allora, secondo me,
diventano i selettori di senso dell’esperienza politica. Il patrimonio intellettuale
del “mandarino” (come diceva Simone de Beauvoir), il modo del capire il fare
politico e il suo senso.
Sartre, nel saggio Merleau-Ponty vivente, ricorda che nei primi periodi di
“Temps modernes” a trattare i temi politici con maggiore competenza era proprio Merleau-Ponty. Questa affermazione, se noi guardiamo al filosofo nella
prospettiva della sua estrema metafisica, appare persino incredibile. È a livello del senso comune evitare di considerare ogni vita filosofica come soggetta
a un’ulteriore teleologia, ma si può anche aggiungere che da un orizzonte filosofico possono derivare campi di interesse, investimenti affettivi, tonalità teoretiche, investimenti tematici molto diversi.
Un pensiero è sempre soggetto a un’autointerpretazione destinata all’ambiguità del suo senso e ogni quadro intenzionale ricostruisce l’esistenza in una
storia imprevista che porta i segni della sua contingenza. La dimensione politica è certamente stata per Merleau-Ponty la linea del “destino della libertà” di
cui era un’importante traccia nella Fenomenologia della percezione. Come del
resto autocomprendersi nella Resistenza, nel primo dopoguerra, nel tentativo
DOSSIER MERLEAU-
di trovare uno spazio politico a sinistra, senza accettare la disciplina staliniana del partito comunista e tentando di non essere estranei alla dimensione di
classe che costituiva la vita di quel partito, “il partito dei fucilati” degli anni dell’occupazione?
Non è qui il caso di riprendere i temi di Umanesimo e terrore e di Senso e
non-senso che furono una versione storicista ed esistenzialista del marxismo,
oggi poco interessante (occorre centrare bene il significato di “interesse”), ma
allora importante per chi non aveva intenzione di subire l’egemonia coatta del
“materialismo dialettico”.
La conclusione nel 1955, con Le Avventure della dialettica, dell’avventura
politica di Merleau-Ponty insegnava che non c’è mai nessuna storia obiettiva
che possa guadagnare per sé la necessità del pensiero e la garanzia, contemporaneamente della “vera libertà” nell’azione. La tragedia politica sartriana
delle mani necessariamente sporche deriva già da una messa in scena metafisica della politica, anche se apriori sarebbe stolto negare che si possano
dare situazioni particolari che richiedono decisioni ambigue e difficili. Era forte,
molto forte il teatro coattivo della storia, e non dimentichiamo il clima tragico,
la domanda estrema della guerra fredda fu quella di Sartre quando scrisse il
saggio I comunisti e la pace, prendendo posizione a favore dell’Unione
Sovietica e del movimento comunista. La scelta, diceva Sartre, non appartiene al giudizio in astratto, ma la sua sola possibilità è tutta certamente nella dialettica del mondo. Scegliere è prendere posizione, non giudicare. C’è una
superficialità soggettiva nel giudizio.
Merleau-Ponty si ribellò a questa chiusura, come se, al di là dell’oggettività del conflitto, fosse di diritto soppressa ogni soggettività intenzionale e fu
maltrattato dal “castoro” –come Sartre chiamava Simone de Beauvoir al tempo
dell’Università.
Per chi a quel tempo giocava la propria giovinezza, è una memoria ancora
intensa, anche se ormai sfocata nel tempo, poiché non appartiene ormai ad
alcun disegno d’azione. Le qualità dei tempi sono destinate a perdersi, è solo
un’illusione gradevole pensare che da qualche parte –la persona, la storia?–
trovino unità. Merleau-Ponty, con le Avventure della dialettica concluse la stagione, o meglio, la possibilità politica della sua filosofia: il suo a-comunismo
insegnava a non pietrificare in forma di pensiero filosofico il gioco delle forze
nel mondo e quindi a non obbiettivare la dialettica. Allora, per molti, fu il modo
per costruire quella posizione critica che risultò vincente dopo l’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956. Restarono in ombra i problemi filosofici più difficili.
La seconda linea –non è questione di successioni in un tempo spazializzato– è compresa in quello che fu un inedito, La Prosa del mondo. Sappiamo
che il percettivo, il precategoriale consente di trovare quello che la codificazione idealizzata dal linguaggio, sia quello comune che quello scientifico, non
consente di vedere più. La filosofia apre il problema, lo configura nel suo spazio, ripensa il lessico categoriale nella prospettiva della relazione del corpo
con il mondo, quindi indica la radice dell’esperienza. Ma il discorso teorico vale
per il campo filosofico, consente di comprendere le strategie dell’astrazione,
l’uso obiettivante del linguaggio, consente di considerare la chiusura della
35
36
memoria vivente attraverso cui ogni forma ha trovato se stessa, ma non può
dare una nuova apparizione all’esperienza.
La pittura, nel suo saper vedere, trova lo sguardo non guidato dagli stereotipi del guardare che definiscono una superficie nell’evidenza del linguaggio immobile. È la pittura che spezza l’orizzonte morto dell’esperienza, consente di vedere in un modo che l’abitudine ha oscurato, ritrova una modalità
della visione inaspettata perché perduta nella prassi comune.
C’è quindi un fare arbitrario che consente di fare esperienza, secondo quel
pensiero filosofico che indica nel tornare alle cose stesse la fine della riflessione astratta sul mondo, attraverso strategie verbali che nascondono la propria storia, cioè i depositi di senso che costituiscono la parola. E la parola?
Sappiamo che la parola è segno che conduce con sé una vicenda di pensiero ignota a chi consideri la parola nella sua astratta evidenza. Ma se la parola altro non è che significato, relazione, la parola può divenire, nel lavoro che
viene compiuto nel suo significato, un’apertura inedita dell’esperienza, una
nuova occasione di significati e quindi un’apertura di senso sul mondo.
È alla letteratura che spetta il compito di provocare aperture inattese dell’esperienza, configurazioni di mondo che sono inattese nel suo spazio codificato. E se la parola conduce storia, come si dice nella Fenomenologia della
percezione, la letteratura, in quanto lavoro nella parola, racconta storie che
mettono un ordine diverso nel dare senso, svelano un mondo differente.
Al centro di questa tesi vi è una lettura sbagliata della dicotomia di
Saussure tra langue e parole interpretata in senso dialettico, dove la langue
gioca il ruolo di un linguaggio e di un mondo chiuso e la parole, al contrario,
riflette la creatività di un soggetto che, lavorando sulla lingua, fa apparire nuovi
spazi di esperienza. Se dal punto di vista della strategia teorica era una lettura arbitraria di Saussure a intessere il discorso, ho sempre pensato che l’esempio letterario saliente fosse la Recherche di Proust.
Pittura e letteratura sono l’accadere di quell’apertura che il pensare fenomenologico introduce in quello che potremmo chiamare, con un ossimoro, “l’idealizzazione materiale del mondo”. Per quanto mi possa riguardare, è certamente questa dimensione dell’opera di Merleau-Ponty che ha agito più profondamente nella mia concezione della filosofia come scritturalità configurativa, anche se, ovviamente, quella che è la dimensione del soggetto è stata
ricostruita nella dimensione dell’autore. Il che consente di pensare alla filosofia come un fare aperto, finito, temporale, caduco, ma, proprio per questo, una
costruzione di senso.
La terza linea, che chiunque ha veduto in Merleau-Ponty, è quella che conduce allo sviluppo del percettivo e dell’antepredicativo nella dimensione di una
filosofia dell’essere. Il mutamento teorico è rilevante, ma il materiale lavorato
è ancora quello della Fenomenologia della percezione. L’essere assume, nella
sua modalità sensibile e percettiva, quello che era un movimento fungente dall’esperienza verso dimensioni intenzionali di forma. Un essere che sfugge di
principio a tutte le categorizzazioni possibili dell’intelletto filosofico, anzi, che
ne frustra la possibilità apriori.
È un tema di straordinario rilievo, che ha richiamato l’attenzione di interpreti
DOSSIER MERLEAU-
di prim’ordine. Comunemente si dice che sia stata la ripresa dell’ultimo
Heidegger a far nascere il problema dell’essere (come a suo tempo quello dell’esistenza). Per quanto questa tesi sia difficilissima da “provare”, può essere
che questa diagnosi sia esatta. Ma quello che, a mio giudizio, diviene fondamentale è che la prosa stessa di Merleau-Ponty, con una sorprendente abilità
creativa attraverso un tessuto semantico straordinariamente intenso, faccia
apparire esso stesso, in una visibilità scritturale la dimensione dell’essere.
L’essere non è detto attraverso il concetto che astrae, localizzato nell’oggettività del discorso, ma è fatto vedere attraverso l’invenzione della prosa e il coinvolgimento nel discorso che non indica al di là di se stesso, ma fa apparire ciò
che è.
Se questa lettura avesse una sua attendibilità, il corpo diventa il fluido
incentrato sul percepire e si mostra come essere attraverso l’apparizione linguistica. La scrittura filosofica è l’apparizione dell’essere.
L’essere non va verso, ripete se stesso attraverso il gioco complesso delle
relazioni percettive. Nella filosofia dell’essere si contaminano così, in una
forma ontologica, due dimensioni della Fenomenologia della percezione, l’antepredicativo e la parola, dando luogo a un ostensione dell’essere come opera
d’arte filosofica. Un capolavoro straordinario: la metafisica tolta dall’architettura astratta delle narrazioni per concetti e resa visibile attraverso un’impresa
che si trova accanto alla pittura e alla letteratura, dove la parola non abbandona mai il campo della percezione e della sensibilità, e, azzerando per quanto possibile la sua tendenza idealizzante, chiude il circuito nella forma dell’essere. Merleau-Ponty mi appare così lo scrittore della metafisica, ma quest’immagine viene da un archivio dell’essere accaduto così, laddove libri e autori
prendono le forme possibili nell’orizzonte del proprio senso.
37
TURBINE DEL TEMPO
IL TEMA DEL TEMPO NELL’OPERA DI MAURICE
MERLEAU-PONTY
di Bernhard Waldenfels e Regula Giuliani1
38
Ci sono temi centrali che accompagnano costantemente la riflessione di
Maurice Merleau-Ponty e che partecipano particolarmente dei cambiamenti di
pensiero che connotano questa riflessione. A questi appartengono il corpo
(Leib), l’espressione, lo spazio (Raum) ed infine anche il tempo (Zeit). Queste
idee-chiave entrate a far parte del fondamento della fenomenologia, hanno in
comune il fatto che con esse si intende non soltanto ciò che si mostra, ma
anche il fatto che esse compartecipano al mostrarsi (Sichzeigen) di questo e
di quello. Il tempo non rientra né nei fatti (Tatsachen), né nelle essenze
(Wesenheiten), né nelle datità empiriche, né nelle condizioni trascendentali
dell’esperienza; molto di più questo attraversa l’accadere esperienziale nel
quale ogni cosa ha la sua entrata e la sua uscita. Esso appare occasionalmente mentre lascia apparire. Per Husserl il tempo rientra nella sfera dell’esperienza trascendentale in cui quest’ultima diviene accessibile a se stessa
in una forma potenziata. Sin dall’inizio esso costituisce il focolaio di paradossi
nel momento in cui il tempo, da costituire come tutto ciò che si costituisce da
se stesso, emerge alla fine tra i suoi costituenti. L’adesso del presente vivente (lebendigen Gegenwart) significa molto di più di un dato temporale che si
lasci decifrare con l’aiuto di un segno temporale, ciò nonostante esso rimane
databile (datierbar). Tra l”adesso” e il 1 Aprile 1998 vi è una connessione nonostante le differenze emergenti. Il tempo si raddoppia o si moltiplica allo stesso modo del corpo che appare tra le cose corporee che devono il loro apparire a lui stesso. Tra i pregi del pensiero di Merleau-Ponty vi è quello che esso
mantiene queste tensioni (Spannungen) e le rende feconde anche in quei
punti dove Husserl riteneva dovessero essere risolte. I paradossi, particolarmente virulenti nella teoria sul tempo, producono un contrappeso
(Gegengewicht) alle tendenze fondamentalistiche che insistono su un primo
(auf einem Ersten) ed alle aspirazioni totalitarie che reclamano un tutto (ein
Ganzes); essi impediscono inoltre che i fenomeni quotidiani siano bollati come
volgari degenerazioni (Abarten) di una esperienza autentica. Ciò che accade
giornalmente può “esplodere” in ogni momento ed aprire esperienze temporali in grado di far saltare nella e a causa della temporalità l’orizzonte del temporale. Il titolo tardivo Il visibile e l’invisibile si lascia anche leggere come Il
temporale e il non temporale in modo tale che il non temporale, uguale al non
visibile, risulti posto come “il non temporale di questo mondo” e non sia di conseguenza rimosso nel regno ombroso delle idee eterne. Come nelle
Recherche di Proust le cui figure e scene ritornano quali fili conduttori nelle
opere di Merleau-Ponty, il tempo, perduto, misconosciuto e disdegnato, viene
II
La riflessione sul tempo, nella nostra tradizione europea, è segnata ai suoi
inizi da un forte doppio accordo (Doppelakkord): da un lato il tempo cosmico
di decorsi motori orientati ad uno scopo; dall’altro il tempo psichico che trova
il suo luogo di raccoglimento nel presente vissuto. Una volta si configura come
ricorrente movimento circolare (Kreisbewegung) in grado di liberare dalla
fugacità del tempo; un’altra esso si presenta come l’attimo (Nu) che ci strappa dalla dispersione temporale. Questa polarità (Polaritaet), associata fino ad
DOSSIER MERLEAU-
qui ed ora ritrovato, affratellato (verschwistert) agli eventi fondamentali della
nascita, della rinascita e della morte, dell’addio e del ritorno attraverso i quali
ognuno di noi passa; affratellato ugualmente agli eventi fondativi della storia
che non solo lasciano nascere il nuovo (Neues), ma cambiano anche le coordinate del mondo ed alla fine coinvolgono anche la nostra concezione del
tempo e della storia. Esaminando i brani in cui emerge la problematica del
tempo, si comincia, nell’opera iniziale La struttura del comportamento, con la
descrizione delle forme percettive e le strutture del comportamento corporeo.
Questi aspetti fondamentali vengono trattati nella Fenomenologia della percezione ed intrecciati non solo con la temporalità della esperienza corporea, ma
elevati sino a comprendere anche una autoaffezione (Selbstaffektion) che
lascia apparire non solo qualcosa, ma anche il Sé al quale appare questo e
quello e finanche se stesso. Infine la problematica temporale lascia nell’opera
incompleta Il visibile e l’invisibile tracce nuove di una architettonica temporale
nella quale tempo e spazio si alleano (sich verbuenden) ed il tempo stesso si
inscrive nello spazio. È evidente che le riflessioni di Merleau-Ponty crescono
a partire da un continuo dialogo con Bergson, Husserl ed Heidegger. Se si
volesse apporre a lato alle opere conosciute dal titolo Lezioni sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo, Essere e tempo, Il tempo e l’altro,
oppure Tempo e racconto un titolo corrispondente, questo sarebbe rispettivamente le corps et le temps, oppure La chair du temps. Infine si deve considerare che Merleau-Ponty negli ultimi anni di vita, nel corso della sua riflessione
sulla natura, rivolse una rinnovata attenzione alle rivoluzioni scientifiche della
concezione del tempo all’interno della fisica moderna e della biologia. In questo modo si levò un contrappeso a quella soggettivizzazione (Subjektivierung)
e interiorizzazione (Verinnerlichung) del tempo che si era lasciata guidare
eccessivamente dall’oggettivismo dei suoi antagonisti. Non è necessario
neanche accennare al fatto che anche la politica e la storia, la letteratura e l’arte informano in modo essenziale la concezione del tempo di MerleauPonty.Tutto ciò viene incluso in una regione del tempo (Zeitlandschaft) molto
ampia. In seguito saranno mostrate alcune vie che attraversano tale regione
con la attenzione il più possibile rigorosa verso gli specifici campi (Umfelder)
nei quali emerge la temporalità dei fenomeni ed infine il fenomeno del tempo
stesso. Ciò accade principalmente in modo indiretto, associato molteplicemente all’allontanamento di non soddisfacenti concezioni del tempo2.
39
40
oggi ai testi classici di Aristotele ed Agostino3, si rompe all’inizio della modernità. Si arriva infatti ad una contrapposizione tra tempo misurabile e omogeneo, che consente solo determinazioni relative come prima o dopo, e durata
vissuta (erlebter Dauer), avente il suo centro nell’ora (Jetzt) di un presente
assoluto. La concezione temporale oggettiva si orienta in base allo spazio,
allorché essa impiega gli schemi (Schemata) del punto-tempo e della lineatempo, mentre la concezione soggettiva del tempo, nel suo legame con lo spirito, l’anima o la coscienza risulta sottratta allo spazio. La contrapposizione tra
corpo ed anima prosegue nella antitesi kantiana tra senso esterno, spazialmente determinato, e senso interno, temporalmente determinato. Anche gli
sforzi iniziali condotti alla soglia del precedente secolo da Bergson ed Husserl,
da James e da Whitehead per rinnovare la concezione del tempo sono stati
lungamente influenzati, sin nella loro nomenclatura concettuale, da questa
situazione problematica. È degno di attenzione il fatto che Merleau-Ponty, dal
principio, inizi altrove, cioè da una “terza dimensione”, “al di qua del puro soggetto e del puro oggetto”; ciò significa al di qua di un tempo spazializzato (verraeumlichter) e vissuto4. In questo il suo pensiero eguaglia quello di
Heidegger, solo che il primo nel suo orientamento corporeo si lascia maggiormente stimolare da ricerche scientifiche e da innovazioni ed inoltre non crede
più alla anonimia delle esperienze quotidiane.
Nella sua opera dal titolo La struttura del comportamento emerge per la
prima volta il tema del tempo in connessione con le strutture spazio-temporali e le forme (Gestalten) che si trovano in tutti gli stadi del comportamento corporeo, già a partire da quello animale. La differenza tra uomo ed animale non
viene imputata ad un aggiungentesi logos o ad una inserentesi causalità libera, quanto piuttosto ascritta alla formazione della struttura e della forma che è
contrassegnata contemporaneamente da continuità e da discontinuità.
Merleau-Ponty si trova d’accordo con la Gestaltheorie, così come con la ricerca sull’ambiente (Umwelt) e sul comportamento5. Già in Jakob von Uexkuell,
la cui opera dal titolo Theoretische Biologie apparsa per la prima volta nel
1920 riscontrò grande attenzione in Scheler ed Heidegger, la “formatempo”(Zeitgestalt), rappresentante in effetti, in virtù della sua risoluta durata,
la regola creatrice in grado di dominare ogni figurazione, è contrapposta alla
antitesi bergsoniana tra tempo e durata, tra intelletto ed intuizione6. La proposizione che Viktor von Weizsaecker nella sua Der Gestaltkreis (1973, p.176)
così formula: “ Il mondo e le sue cose non sono nello spazio e nel tempo,
quanto piuttosto lo spazio ed il tempo sono nel mondo e presso le cose”7 rimase anche in Merleau-Ponty nella misura in cui questo “nel” e questo “presso”
non sono interpretati realisticamente, quanto piuttosto nel senso di un accadere strutturante la formazione del mondo e delle cose. Merleau-Ponty si riferisce in questo contesto a determinati esperimenti animali, ad esperimenti condotti per vie traverse riguardanti il comportamento conforme a scopo di cani,
all’orientamento in labirinti spaziali e temporali di ratti oppure al comportamento motorio e strumentale degli scimpanzé. Qui si tratta decisamente del
concetto di un movimento da non concepire più come cambiamento di luogo
(Ortveraenderung) dipendente da una forza, quanto piuttosto come un muo-
DOSSIER MERLEAU-
versi (Sichbewegen) che, retroagendo ed anticipando, andando oltre gli stimoli
dati attualmente ed alle differenze tra qui e lì, tra vicino e lontano che
Heidegger in Essere e tempo aveva tematizzato sotto il punto di vista di una
spazialità del Dasein, assegna già un senso temporale. Muovendomi con il
corpo io sono contemporaneamente là dove poco fa ero, dove immediatamente sarò o dove una volta o l’altra potrei essere. Il movimento si compie
nella forma di ritmi e melodie di movimento che lasciano nascere una sorta di
“spazio-tempo” (espace-temps) (SC 122, trad. ted. 127). Questa messa tra
parentesi dello spazio e del tempo che, nelle opere successive, ricoprirà un
ruolo crescente, deve essere distinta dalla posteriore spazializzazione del
tempo. Non è sorprendente che la melodia, appartenente sin da Agostino agli
esempi standard della teoria del tempo, sia stata ripescata in von Uexkuell per
caratterizzare il movimento, allo scopo di chiarire il legame interno tra differenti
fasi di movimento8. Merleau-Ponty, riprendendo prontamente queste sollecitazioni, regala così all’ascolto, alla notazione ed alla strumentazione musicale
una particolare attenzione; il motivo del ritmo, da chiarire necessariamente in
termini temporali, ricompare anche successivamente nella teoria del senso
inteso come forma intermodale di ordine9. Il comportamento, avendo una struttura e formando delle figurazioni, non ha luogo né fuori in un tempo oggettivo
o in uno spazio oggettivo, né all’interno di un ambito controllabile e dominabile con lo sguardo; esso molto di più viene scandagliato mediante attimi fecondi della ristrutturazione (Umstrukturierung) e della riconfigurazione
(Umgestaltung); “il singolo attimo occupa qui non un unico punto temporale,
ma, al contrario, nel momento decisivo dell’imparare, esce fuori un “adesso”
dalla fila dei “momenti degli adesso”; esige un certo peso; raccoglie in sé le
precedenti azioni di prova, determinando ed anticipando contemporaneamente il comportamento futuro; esso trasforma la singola situazione esperienziale
in una situazione tipica e la reazione effettuale in una capacità.” (SC 136, trad.
ted. 141). Lo schema duale della forma temporale apriori e della figura temporale empirica e cioè il coordinamento unilaterale del tempo al senso interno,
risulta insufficiente già a partire dal piano biologico, allorché figure e strutture
si materializzano senza essere assorbite di volta in volta dalla materia. La
separazione del comportamento dal qui ed adesso conduce a decisive differenze strutturali tra comportamento inferiore e comportamento superiore, tra
quello animale e quello umano; in ogni caso il distacco è solo relativo. Così
come le strutture comportamentali sono insediate più profondamente di ogni
coscienza delle strutture, alla stessa stregua anche le strutture temporali del
comportamento sono anteriori ad ogni coscienza del tempo (cfr. SC 239f.,
trad. ted. 257f.).
Nelle sue lezioni alla Sorbona Merleau-Ponty tratta dettagliatamente la
struttura ed i conflitti della coscienza infantile10. Tra l’altro vi si critica anche il
modo di procedere di Piaget che concepisce la razionalità infantile come semplice stadio anteriore di una ragione adulta. In questo modello la crescita infantile seguirebbe una logica di sviluppo nella quale le fasi in successioni culminerebbero come passaggi e come stadi precedenti verso un parametro adulto. Le singole fasi sono misurate relativamente allo scopo finale e valutate in
41
base a questo: corrispondentemente le precocità sono giudicate positivamente, mentre i ritardi in termini negativi. Merleau-Ponty preferisce al contrario una
“logica inciampante” (stolpernde Logik)11 che non valuta più le singole fasi
come progresso o regresso in funzione di una processo evolutivo, ma ammette anche che la perdita e l’impoverimento di possibilità rappresenti il lato rovescio di ogni accrescimento di possibilità: “Mai entra in azione qualcosa di completamente nuovo. Si manifestano molto di più anticipazioni, regressioni ed il
sussistere di elementi arcaici in forme nuove.”12
III
42
Nella Fenomenologia della percezione l’autore parte nelle prime due parti
del testo direttamente dalla esistenza corporea e dal mondo umano della percezione; di contro alle analisi intese in modo più ampio della prima opera, risulta ora una sorta di conduzione più ristretta nella quale appaiono in modo più
marcato i paradossi ed anche le patologie del tempo. Il tempo rientra in molti
modi all’interno delle analisi orientate corporeamente, prima di divenire propriamente un tema, alla fine, in un grande capitolo. Si inizi dalla sintesi percettiva (Wahrnehmungssznthesis) così come trattata nella seconda parte. Il syn,
che crea connessioni, fa dei molti un uno, delle parti un tutto, questo stesso rappresenta l’accadere ordinato per antonomasia, qualora si intenda con ordine
una connessione regolata (cioè non arbitraria) di questo e di quello (Waldenfels
1987, p.17). Espresso con un’altra dizione si tratterà del problema della formazione di senso (Sinnbildung). La filosofia trascendentale kantiana ci pone di
fronte alla alternativa di ipotizzare che la unità del molteplice (Mannigfaltigen)
sia o data o posta. Notoriamente Kant preferisce la seconda possibilità, poiché
nel primo caso l’ordine risulterebbe un trastullo della esperienza. Alle condizioni necessarie della esperienza appartiene anche la forma della intuizione del
tempo in grado di costituire un ordine della successione (Nacheinander) e della
simultaneità (Zugleich). Husserl che nel confronto con Kant si sforza di trasferire il logos nel “mondo estetico” della esperienza, ciò nonostante rimane legato al formalismo kantiano, come quando concepisce la sintesi temporale come
forma fondamentale ed universale all’interno della quale hanno luogo le particolari prestazioni dell’esperienza13. Merleau-Ponty fa un passo ulteriore nel
momento in cui egli non solo sottopone la sintesi percettiva a formali condizioni temporali, ma concepisce la stessa come temporalità, come una forma del
decorso temporale (PP 276-278; trad. ted. 279-281). Questa ipotesi è tutt’altro
che scontata; infatti essa premette che qualcosa di esperito non solo appare da
qualche parte nello spazio e nel tempo, ma possiede in qualche modo un suo
tempo ed un suo spazio. Se questa ipotesi valesse senza limitazione alcuna, si
ritornerebbe alle vecchie rappresentazioni di un ordine cosmico all’interno dei
cui fini ultimi tutto avrebbe prontamente il suo posto e sarebbe dato tutto il
senso. Naturalmente Merleau-Ponty non aveva in mente questo. Già il riferimento ai concetti della forma e della struttura ha mostrato che Merleau-Ponty
ricerca una via di mezzo che non lasci né alle cose, né al soggetto l’ultima paro-
DOSSIER MERLEAU-
la. La unità sensibile non è originariamente né data nelle cose, né posta attraverso un soggetto; essa nasce da una Synopsis, da nessuna Synthesis14. Nella
elaborazione di questo pensiero il tempo, insieme alla corporeità, ha un ruolo
rilevante. La sintesi del mondo della percezione e la contemporanea presa in
possesso del tempo sono espressamente da imputare al corpo. Se infatti il
corpo fosse nuovamente un qualcosa che appare nel mondo come una cosa,
allora non si guadagnerebbe alcunché; ogni riflessione ci insegnerebbe che il
corpo presuppone una coscienza del corpo e che un tempo ancorato nel corpo
ammette una simile coscienza del tempo. Ci sono non pochi fenomenologi
della coscienza che hanno affermato ciò in contrasto con Merleau-Ponty. La
risposta a questa obiezione può apparire complessa: una prima risposta è data
dalla comprensione temporale della percezione e del corpo. La attività sintetica del tempo non si limita ad ordinare il molteplice nella forma della simultaneità
e della successione, facendo sì che qualcosa cioè si presenti come prima, dopo
o simultaneo, ma essa comporta anche che la stessa attività del dare forma
(Gebung) proceda temporalmente. Lo sguardo che, nel suo movimento di fissazione mette in scena uno spettacolo che, all’inizio, è uno “spettacolo del
nulla”, assume esso stesso il carattere di uno sguardo in avanti (Vorblick) e di
uno indietro (Rueckblick) (PP 276f; trad. ted. 279f.). Si dice che qualcosa viene
allo sguardo; questo non significa che lì vi sia già qualcosa che preceda il rivolgersi del corpo ed i fenomeni percettivi; ciò significa molto di più che questi ultimi precedono se stessi (sich selbst vorausgehen): l’oggetto della percezione
che lo sguardo prospetticamente prende in considerazione come essente presente (Zu-sehendes) [letteralmente “stante a vedere”, n.d.cur.] risulta retrospettivamente come “anteriore alla sua apparizione” (comme antérieur à son
apparition), cioè come stimolo cui risponde lo sguardo, come motivo da cui si
lascia condurre. Lo sguardo non ha inizio presso o con se stesso ed in questo
senso esso non compie alcun porre o comporre. Questa autoanticipazione
(Selbstvorgaengigkeit), questo simultaneo essere prima (Voraussein) ed essere fuori, sopra sé, (Uebersichhinaussein) ha inizio con un “passato primordiale
che non è mai stato presente” (PP 280; trad. ted. 283); esso rimanda ad un
“futuro insufficiente” (unzugaengliche Zukunft) che non può mai essere presente (418; trad. ted. 417). Questo essere riconsegnato (Ausgeliefertsein) alla
nascita ed alla morte, che si ripete, in un certo modo, in ogni sensazione (PP
250; trad. ted. 253), non rappresenta alcun attributo del corpo, esso fissa molto
di più la sua modalità d’essere. Per questo motivo Merleau-Ponty non si stancherà mai di ripetere che non sono io che percepisco, ma che piuttosto si percepisce in me (PP 249; trad. ted. 253); che la percezione rimanda ad una anonima storia anteriore (Vorgeschichte) che non si apre ad alcuna presa (prise),
ma solo ad una ripresa (Wiederaufnahme, reprise) o ad una rimessa in scena
(Wiederauffuehrung) (277 f; trad. ted. 280 f.). Ciò che Husserl vede in attività
nella sintesi passiva della percezione cosale, che cioè essa “ha una sua storia
manifestantesi in se stessa” (Hua I, 112), vale anche per il corpo le cui acquisizioni, tradizioni ed abitudini conservano in sé una loro storia propria. MerleauPonty parla sempre di una “consistenza (épaisseur)”, come di uno “spessore
storico” del percepente o di uno “spessore del presente” del percepito (PP 275;
43
44
trad. ted. 278f.); egli intende con ciò che lo sguardo si irretisce nel labirinto spazio-temporale della percezione, sfuggendo sempre a se stesso. La percezione
non significa alcuna prestazione attiva che noi possiamo ascrivere solo a noi
stessi, poiché essa approfitta di una “lavoro già fatto” (ibidem).
Questa rielaborazione della percezione del tempo cui Merleau-Ponty dedica tutte le sue forze, produce più di una critica condotta ad alta voce ad una
“metafisica della presenza” che si risparmia il passaggio attraverso i fenomeni.
La rielaborazione si mantiene nei più disparati campi problematici, come per
esempio nell’ambito della percezione del profondo (Tiefwahrnehmung): la profondità spaziale, che in Merleau-Ponty riveste un ruolo importante sin nelle
opere più tarde come per esempio nelle sue riflessioni sulla pittura, scompare
qualora la si veda, nella doppia tradizione del razionalismo ed empirismo, come
una estensione vista in profilo, la si sottometta cioè ad uno sguardo per ogni
dove che vede anche ciò che non vedo. Il problema della apparenza, come
cioè si possano vedere oggetti distanti, si risolve quando, con Husserl, si parte
da una “campo di presenza” (Praesenzfeld) nel quale le dimensioni del qui-lì si
intersecano con la dimensione temporale. Vedo qualcosa, là in lontananza, in
modo simile a come la mia memoria incontra il già trascorso nella lontananza
temporale, non certo in tracce (Spuren) che appartengano al presente15.
In entrambi i casi si ha a che fare con una “sintesi di passaggio”
(Uebergangssynthese) che non collega nessun discreto dato spaziale o temporale, ma produce una connessione nel passaggio (PP 306f., trad. ted. 308f)16.
In modo simile si risolvono gli enigmi della percezione motoria. L’uccello in volo
è per noi percepenti non certo una cosa in movimento che assume un dopo l’altro posizioni spaziali discrete; al contrario lo sguardo accompagna il veduto
come “qualcosa di passaggio (quelque chose en transit)” (PP 318; trad. ted.
320)17. Alla fine il ritorno alla temporalità della percezione risolve anche la contraddizione della esperienza del mondo consistente nel fatto che la percezione
spinge verso una sintesi compiuta sebbene questa istanza rimanga inadempiuta a causa della limitazione prospettica della nostra esperienza18. La contraddizione scompare se si passa dal piano dell’essere a quello del tempo e si
concepisce “il tempo come misura dell’essere” in modo tale che niente di assoluto esiste in senso rigoroso, ma al contrario si temporalizza tutto ciò presso cui
vi è un “eccesso di esistenza”. “ Sono qui, così non sono né qui, né adesso”.
La trascendenza della lontananza irrompe nel mio presente; aggiunge al
mondo delle fessure (fissures) e delle lacune (lacunes) nelle quali la soggettività può annidarsi. Il tempo prende parte alla ambiguità che contrassegna il
mondo; anch’esso non appare in qualche luogo ed in qualche momento nel
mondo, né si trattiene dovunque e ininterrottamente, fuori cioè dal mondo. Il
senso di percezione rimane in ultima analisi “nebuloso (brouillé)”19
IV
Il mondo percettivo e la esistenza corporea non formano nessuna correlazione in senso rigoroso, poiché noi siamo ancorati corporeamente nel mondo
DOSSIER MERLEAU-
e partecipiamo corporeamente alla formazione di senso e di forma. Parlare
sulla temporalità delle cose significa anche, come si è visto, parlare anche
sulla temporalità del corpo. Tuttavia nella prima parte della Fenomenologia
della percezione, che si occupa esplicitamente del corpo, appaino più fortemente tratti determinati del tempo. Dalle opere precedenti è risaputo che il
movimento proprio del corpo non può essere pensato senza una struttura temporale; che vi è un certo tipo di memoria motoria che conserva sotto presa le
posizioni corporee dimenticate; e che ogni accenno di movimento con cui ha
inizio un movimento anticipa future posizioni del corpo. Certo questa intuizione verrà ulteriormente rafforzata nel capitolo sulla spazialità, culminando nella
assunzione che noi come esseri corporei non siamo né nello spazio, né nel
tempo ed altrettanto poco lo pensiamo; che noi al contrario siamo “spazio e
tempo” [zum Raum und zur Zeit sein, l’espressione è intraducibile in italiano.
Per analogia si pensi alla differenza tra “essere in casa” ed “essere a casa”,
n.d.cur] “abitandoli” (bewohnen) in mutevoli campi d’azione (PP 164, trad. ted.
170). L’abitare che prende forma nell’abituarsi (Eingewwoehnung) significa
che apparteniamo allo spazio-tempo e ci rapportiamo contemporaneamente a
questo. Così come secondo Helmut Plessner non siamo solo il nostro corpo,
ma possediamo questo contemporaneamente come corpo, così non siamo
solo situati temporalmente, ma abbiamo anche il tempo che concediamo a noi
ed agli altri oppure non concediamo, di cui necessitiamo, che regaliamo oppure scialacquiamo. Questa distanza verso noi stessi consegna alla esistenza
corporea un carattere precario che si manifesta particolarmente in disturbi
patologici tra i quali rientra anche una patologia del tempo. Tracce di ciò si trovano abbondantemente in Merleau-Ponty; egli in questo caso si lascia guidare da autori di formazione fenomenologica ed anche psicoanalitica come
Ludwig Binswanger, Kurt Goldstein, Eugène Minkowski, Paul Schilder ed
Erwin Straus. Un esempio particolarmente rimarchevole grazie al quale
Merleau-Ponty metterà in risalto sia la ambiguità del corpo che quella del
tempo, è il membro fantasma (Phantomglied) che sin da Descartes servirà
come caso paradigmatico di spiegazioni psico-fisiologiche (cfr. PP 92-105;
trad. ted. 102-114)20. Merleau-Ponty, diversamente dalle tradizionali ipotesi
che spiegavano l’insorgere del membro fantasma fisiologicamente come la
rappresentazione effettiva di una presenza o psicologicamente come erronea
rappresentazione di una presenza, interpreta questo fenomeno come presenza ambivalente di un membro perduto del corpo, cioè come intermediario tra
presenza ed assenza che emerga da una dissociazione tra esistenza corporea e temporale. La storia dell’individuo malato si consolida in questo caso in
un accadere infermo che arriva a colpire il nucleo della personalità. La perdita di un membro del corpo, nel caso di un pianista il cui braccio sia stato amputato, assume proporzioni traumatiche e si avvicina alla sofferenza causata
dalla perdita di una persona cara. Il non voler prendere per vero [cors. d. cur.]
la perdita può essere interpretato come una sorta di rimozione. La rimozione
conduce all’apparire delle cose, nel caso in questione il pianoforte, come
ancora maneggevoli, ma non per l’io attuale in prima persona, quanto piuttosto per un impersonale Si [cors.d.cur.] in terza persona. Il corpo abituale gua-
45
46
dagna la supremazia rispetto al corpo attuale, poiché la presenza perduta si
rifiuta di divenire passato e si sposta oltre ogni altro presente. Merleau-Ponty
chiama questo vivere nel passato, questo vivere di seconda mano
[cors.d.cur.], “scolastica dell’esistenza” (PP 99, 192; trad. ted. 108, 197). L’io
vive la vita di un io passato; la propria vita si disperde nelle esperienze passate, nei ricordi di esperienze e si cristallizza alla fine in una tipica generale e
congelata. La vita prosegue oltre, ma certamente tutti i nuovi contenuti di
esperienza sono inseriti in vecchie strutture come un vino novello in una vecchia botte. Merleau-Ponty non rimane in ogni caso fermo a questa descrizione del malato; egli deduce da ciò conseguenze valide per ogni esistenza
incarnata. La dissociazione patologica presuppone che la nostra esistenza
corporea, con l’eccezione di attimi intensi, non è mai completamente integrata. Una esistenza personale, liberamente scelta, che si apre ad un mondo storico, rimane legata alla esistenza anonima, prepersonale o impersonale dell’organismo che segue i suoi propri ritmi e cicli per esempio nel battito del
cuore, in quello del polso, nell’inspirare ed espirare, ma anche nell’alimentazione e nella riproduzione, così come negli stadi delle malattie ed infine nella
vecchiaia. Si ha a che fare in questo caso con lo stesso fenomeno cui si va
incontro nell’anonimia dell’accadere percettivo. La sublimazione della natura
nella cultura, la fusione di anima e corpo e la centratura (Zentrierung) della esistenza non riescono mai perfettamente. Ciò ha per conseguenza che i presenti litighino sulla loro importanza e che, nell’ambito temporale, abbiano
luogo conflitti che sfuggono semplicemente ad una concezione formalizzata
del tempo. “Ogni presente aspira a fissare la nostra vita; proprio questo lo contrassegna come presente”; in ciò esso (il presente) somiglia ad una ferita che
non si chiude mai completamente (PP 100; trad. ted. 110). In questa posizione aderiscono normalità e patologia; il passato non è mai completamente
messo fuori gioco, il futuro mai completamente assicurato ed in questo luogo
si immischiano “fantasmi” che ci vengono a trovare nei nostri sogni o negli attimi di scuotimento21. Nel capitolo sulla sessualità nel quale Merleau-Ponty si
avvicina, tramite Ludwig Binswanger, a Freud, egli affronta il caso di una
ragazza malata di afonia. Il disturbo del linguaggio prende qui la forma radicale di una perdita della voce22. L’autore cerca di mostrare come la storia si
risolva in “tempo naturale”, come essa si disperda in una serie di sempre
uguali momenti-ora (Jetztmomente), come ancora essa ritorni nuovamente in
se stessa fino al momento in cui l’incantesimo si interrompe, il movimento
verso gli altri, il futuro e il mondo si rinnovano come “un fiume ghiacciato che
inizia a sgelare” (PP 192, trad. ted. 197). Il movimento proprio del corpo è contrassegnato da abitudine, blocchi ed aperture. La metafora del fiume, che
diviene discutibile se si considera il fiume come movimento nello spazio o si
lascia confluire tutto in questo, guadagna una certa forza di persuasione quando, come fa Merleau-Ponty, si illustra con questa metafora il movimento proprio della vita che ci sorregge, ci trascina con sé, minaccia di consumarci e che
produce la sua propria articolazione nella forma di “onde temporali” (cfr. PP
318, 381; trad. ted. 320, 382). Da questi passaggi si evince come MerleauPonty riprenda ed elabori sollecitazioni di Bergson là dove la evidenza della
DOSSIER MERLEAU-
coscienza temporale o la apertura del Dasein si allontanano molto dalla esistenza corporea; lo stesso vale per il linguaggio del corpo di Freud, così come
per motivi corrispondenti delle opere di Proust e di Valéry23. Anche lì dove nel
capitolo finale della seconda parte si parla espressamente del mondo umano,
la natura, e con essa il tempo naturale, hanno un ruolo rilevante. Essa emerge nel cuore della mia storia. Una entità che, mediante la stessa nascita, è
data come un ente che deve essere compreso, ritrova in sé l’abbozzo di un io
naturale e di un tempo naturale che va indietro sino al grembo materno.
Questa “debolezza naturale” rimane e fa in modo che “il possesso del mio
tempo sia rimandato (différée) costantemente mediante me stesso”24. Il tempo
non può mai valere in senso pieno come mio tempo, così come il corpo non
può mai essere completamente il mio proprio corpo, poiché la mia coscienza
è attraversata costantemente da “forme oniriche e dileguate della coscienza
stessa” e rimane aderente ai campi sensibili del viso, dell’ascolto e del tatto
che “precedono la mia vita personale e gli rimangono estranei” (PP 399, trad.
ted. 398). Alla estraneità dell’altro, di cui si parla in seguito, corrisponde la
estraneità di un tempo e di una storia anteriore di cui non ci possiamo mai
completamente appropriare. Che cosa rimane per una diretta comprensione
del tempo, dopo aver percorso queste lunghe strade attraverso il labirinto spazio-temporale? Una tale comprensione la si trova nella terza parte di
Fenomenologia della percezione, incorniciata rispettivamente da un capitolo
sul cogito e da uno sulla libertà; per quanto sia chiaro che l’ancoraggio corporeo del tempo non lasci alcuno spazio sia per uno spostamento del tempo in
un mondo psichico interiore, sia per uno sdoppiamento della coscienza oggettiva del tempo mediante una autocoscienza riflessiva. Ciò che ancora manca
è unicamente una “fenomenologia della fenomenologia” che faccia del fenomeno del tempo ancora una volta un fenomeno senza ricadere in un dualismo
tra temporalità interna ed esterna25. La paradossalità del tempo menzionata
all’inizio si fa notare persistentemente in questa prospettiva radicalizzata. Ad
un primo sguardo il cogito sembra sfuggire nei suoi cogitata, nella salita verso
le idee, nel pensare il pensiero di Dio, al cambiamento (Wechsel) del tempo.
D’altra parte Merleau-Ponty insiste su un “tempo delle idee”, più segreto del
tempo naturale: “ la esistenza delle idee non coincide con il Dasein empirico
dei mezzi espressivi, al contrario le idee stesse durano o passano, il cielo intelligibile muta la sua colorazione” (PP 447f; trad. ted. 445). La perdita del tempo
o l’essere fuori del tempo [cors.d.cur.] (Ueberzetlichkeit) del pensato si mostra
come ciò che Husserl chiama onnitemporalità [cord.d.trad.] (Allzeitlichkeit)
(Hua, I, 155); essa rimanda alla temporalità del pensare, caratterizzata dalle
forme dell’acquisizione, della assunzione e della anticipazione, ed a quella
“storia interna” che, secondo Husserl, attraversa anche l’origine e la tradizione della geometria26. Come la certezza del veduto non può essere disgiunta
dal vedere, allo stesso modo la certezza del pensato da quella del pensare.In
questo modo il cogito stesso riceve una “consistenza temporale” (épaisseur
temporelle) (PP 456; trad. ted. 454). “Ogni attimo vuole l’eternità”, come
annunciato dallo Zarathustra di Nietzsche; sicuramente questa eternità “non è
un secondo ordine al di là del tempo; essa è la atmosfera del tempo stesso”;
47
48
essa si estrinseca come “sublimazione del presente” (PP 451; trad. ted. 448f.).
Merleau-Ponty, lettore di Freud e Proust, non si lascia trascinare da un attivismo futuristico che degrada il presente a fase di passaggio. Ciò che di nuovo
apporta il capitolo sulla temporalità, cade come un frutto maturo. Oltre a ciò
Merleau-Ponty si affida ampiamente alle lezioni di Edmund Husserl sulla
coscienza del tempo, ad Essere e tempo di Heidegger ed al suo libro su Kant.
Tuttavia non mancano qui accenti originali. Il compito centrale di una fenomenologia del tempo consiste nel comprendere il tempo come un fenomeno in
persona (en personne), alla stato nascente. Questo compito non viene soddisfatto quando si spera di trovare una soluzione nella realtà fisica delle cose,
nella realtà psichica degli stati di coscienza o in un pensare sintetizzante.
Manca ad un mondo incontrato nella realtà o ad un mondo idealmente precostituito ogni altrove, nel passato e domani, senza cui vi sarebbe solo una serie
di punti-ora, un tempo inteso quasi alla maniera di Zenone. Dove ci si mostra
allora il fenomeno del tempo? La doppia risposta che Merleau-Ponty da a
questa domanda finisce in una temporalizzazione che non si fonda su un qualcosa, né è posta da qualcuno, che dunque si sottrae alla differenza soggettooggetto. La prima risposta afferma: il tempo è passaggio (passage), un gonfiarsi (jaillissement), un afflusso (poussée) e contemporaneamente un esplodere (éclatement), uno spalancarsi (déhiscence), una unità che si produce nel
passaggio, cioè sulla via della differenziazione e della disintegrazione.
Qualcosa è nel momento in cui non è ancora e non è più (PP 479-81; trad. ted.
476-478). In questa prima risposta Merleau-Ponty riprende concetti di Husserl,
in particolar modo di Fink, come quelli di intenzionalità fungente, di sintesi di
passaggio, sintesi passiva, adombramenti ed orizzonti; si rifà anche a concetti heideggeriani come estasi, trascendenza o a quelli mutuati da Sartre di fuga
temporale dall’essere. Egli impiega anche in misura consistente metafore
come quella di fiume, di getto d’acqua, onda, fonte o turbine, tratte da elementi
acquatici; nel far questo certamente procede con cura. Da una parte accentua
qui il carattere di accadere, dall’altra il carattere ripetitivo delle forme delle
onde o dei ritmi motori che escludono la semplice fusione di momenti temporali discreti ed evitano con ciò la brusca contrapposizione bergsoniana tra
tempo e spazio27. Certamente la prima risposta non è sufficiente, perché il
mero passaggio sarebbe nuovamente un qualcosa per un qualcuno che stesse di fronte al tempo. Per questo motivo la seconda risposta afferma che il
tempo è qualcuno; espresso in modo tradizionale: il tempo è da intendere
come soggetto, il soggetto come tempo. È la stessa facoltà che tiene insieme
gli eventi temporali e li distanzia (PP 482f; trad. ted. 480). Con questa seconda risposta Merleau-Ponty ritorna nuovamente ad Husserl che concepisce la
coscienza del tempo come autoapparizione o presenza del Sé, come cioè presenza del Sé per se stesso; dall’altro lato si attiene ad Heidegger che, prendendo le mosse da Kant, considera il tempo come autoaffezione e quindi
come espressione di una identità finita28. La coscienza in questo modo si definisce attraverso la “dualità” interna di un essere che si autoaffetta e che è dato
a se stesso (PP 488; trad. ted. 485). Io non sono il creatore del tempo, né il
tempo mi affetta come qualcosa che mi viene incontro dall’esterno; la usuale
VI
Se l’opera tarda di Merleau-Ponty sposta ancora una volta gli accenti della
sua teoria del tempo, ciò dipende dall’orientamento verso un pensare strutturalista influenzato da Saussure, Lévi-Strauss e Lacan che mira con forza a dif-
DOSSIER MERLEAU-
differenza tra attività e passività fallisce a questo punto. Per questo motivo
Merleau-Ponty, come una volta Platone, si affida a concetti bastardi come
quello di una “spontaneità acquisita”, idea questa di cui fa menzione Sartre,
per poi rifiutarla; oppure egli designa la passività come una forma di “investimento” (investissement): una formulazione che ritorna successivamente, leggermente mutata, in Levinas allorché egli definisce la libertà come “investiture”, come “appoggio” (Belehnung) mediante l’altro29. In questo modo si capisce come Merleau-Ponty, di fronte al privilegiare30 da parte di Heidegger il futuro, insista sulla derivazione costante delle nostre decisioni dal presente e sull’esser sorretto quest’ultimo dal passato. Ciò ha poco a che fare con una
metafisica della presenza, perché il presente stesso è determinato come luogo
della dispersione, dell’essere-fuori-di-sé, tuttavia anche come luogo dell’essere-fuori-di-sé. La autodatità della nascita o la “generatività”, così come si dice
per Husserl, significa “ debolezza interna che ci impedisce ogni volta di raggiungere la consistenza di un individuo assoluto” (PP489; trad. ted. 486).
Come individuo assoluto sarei un evento nello spazio e nel tempo, sebbene
spazio e tempo sono ciò che sono solo se io contemporaneamente sono altrove, anche là dove non sono mai stato, nel tempo anteriore alla mia nascita, ed
anche là dove non sarò mai, cioè nel luogo-tempo dell’altro (PP 495; trad. ted.
492). La teoria della libertà con la quale si conclude la Fenomenologia della
percezione, rimane ugualmente influenzata da questa concezione del tempo.
L’autodatità esclude una libertà che cominci dalla pura spontaneità presso se
stessa ed ecceda ogni altra cosa. Disimpegno (dégagement) ed impegno
(engagement) sono una sola cosa. “ Assumendo un presente, comprendo
nuovamente il mio passato e lo trasformo; cambio il suo senso, mi libero e mi
distacco da esso. Faccio ciò solo quando mi impegno altrove.” (PP 519; trad.
ted. 516). Quando sono fuori me stesso, sono già presso altro; il campo temporale si rivela eo ipso come campo sociale e, a tale riguardo, come campo
storico. Come tuttavia mostrato dagli scritti politici e storico-filosofici, rimangono aperte qui alcune questioni: per esempio quelle relative alla dinamica dell’accadere temporale, al suo orientamento, alla sua ramificazione, così come
quella relativa agli ordinamenti divergenti del tempo che non si adattano senz’altro ad un ambito storico unitario e ad un dramma storico unitario. Entrambe
le citazioni che l’autore antepone al suo capitolo sul tempo: “Le temps est le
sens de la vie” (Claudel) e “il senso del Dasein è la temporalità” (Heidegger)
soffrono di una sottodeterminazione relativamente al fatto che vi è certamente senso, ma non il senso (cfr. PP 342; trad. ted. 344); infatti la questione relativa alle condizioni contingenti della formazione del senso non può essere
risolta con il semplice rimando al tempo31.
49
50
ferenze, divergenze, incompossibilità e cesure e con ciò rifiuta un hegelianismo, depositatosi come uno strato di vernice su alcuni passaggi delle opere
giovanili, aperto alla storia ed alla ragione, ma sempre tendente ad un intero
(Ganzes). Nell’opera postuma Il visibile e l’invisibile si trovano alcune annotazioni di lavoro che, nella loro forma rimossa, lasciano immaginare verso dove
sarebbe dovuto andare e verso dove sarebbe potuto andare la via successiva32. In generale si delinea la tendenza di liberare ancora più radicalmente la
temporalità dall’ancoraggio in una coscienza del tempo e dell’atto, dal legame
ad un vissuto soggettivo del tempo e dallo schema della mera successione. La
transizione dal corps propre alla chair, dalla perception alla vision, dagli atti del
vissuto e del comportamento alle strutture ed agli eventi influenza anche il
ripensamento del tempo che poggia nuovamente su motivi precedenti e trae
da questi nuovi argomenti. Importante per questo ripensamento è un confronto molto differenziato con Husserl ed un cauto avvicinamento a Bergson così
come all’Heidegger più tardo, in cui, in ogni caso, si evitano posizioni semplicemente a favore o contrarie. Qui si liberano nuclei problematici nei quali ritornano, in modo variato, i temi classici della teoria del tempo. La revisione incomincia dal piano iniziale del sentire e percepire, dove qualcosa “appare a se
stesso”. Merleau-Ponty si difende dalla ipotesi che “impressioni originarie”
(Urimpressionen) e “vissuti originari”(Urerlebnisse) siano presenze individuali
che subentrano l’uno all’altro nel corso del tempo. Non vi è qualcosa con cui
il nostro vissuto si fonde che esso (il nostro vissuto) afferri temporalmente o lo
annulli (ancora una volta il rifiuto di un determinato Bergson, Husserl, Sartre).
Avere la cosiddetta coscienza di… consiste piuttosto nella deviazione da…
(Abweichung von)33; detto nei termini della teoria della forma si tratta del risaltare di una figura sullo sfondo, cioè di una differenziazione preceduta da alcunché di identico, né d un qualcosa visibile, né da un qualcuno capace di vedere. La deviazione produce per prima cosa una vista (vue). Sin dall’inizio è in
gioco il “per sé”, non certo come conduttore del gioco, ma in forma derivata,
come “culmine della deviazione nella differenziazione- presenza presso sé è
presenza in un mondo differenziato” (VI 245; trad. ted. 246). La ritenzione non
produce alcuna attenuazione del “vissuto originario”; essa si sposta all’interno
della presenza attuale, “di una presenza per sé che è assenza da sé, contatto con il Sé mediante (durch) la distanza da Sé- figura sul fondo, il “qualcosa”
più semplice di tutti”(VI 246; trad. ted. 248). Questa autodifferenza che non elimina in alcun modo la nostra autoaffezione34 conduce fuori dalla circolarità di
un “essere prima” (Vor-Seins) o di un “io anteriore” (Vor-Ichs) che corra dietro
a se stesso ininterrottamente ed inutilmente nella forma di un vissuto “cattivo
infinito”. Se vi è un “prima” (vor), allora non vi è alcunché su cui si possa
costruire; questa organizzazione al contrario significa come tale una “organizzazione a posteriori” (Rueckgestaltung) (VI 243; trad. ted. 244). Si capisce che
Merleau-Ponty àncora nuovamente questa deviazione nella corporeità, nella
apertura nello spazio mediante lo schema corporeo, nella istituzione di un
tempo nella embriologia del comportamento35. La significazione dello schema
del corpo come formazione generante lo spazio-tempo attribuisce al corpo il
suo carattere centrante, come se tutto ruotasse intorno a questo. Ciò che
DOSSIER MERLEAU-
devia è già oltre se stesso, presso altro da se stesso. Un secondo plesso problematico concerne la struttura temporale del ricordare e dimenticare.
Merleau-Ponty osserva che la ritenzione di Husserl rappresenta solo un inizio
senza che in virtù di questa possa essere chiarita in modo soddisfacente la origine del dimenticare. In effetti il dimenticare si pone di traverso all’accadere
intenzionale; ciò che viene dimenticato, può avere un senso, ma certo questo
non vale per il dimenticare inteso come affondare (Absinken) nel passato. Il
chiarimento insufficiente del dimenticare ha come conseguenza che l’anima,
da Agostino sino a Bergson, deve tendere nuovamente come luogo di conservazione, e la situazione non diviene migliore, quando si materializza l’accadere dell’anima nella forma di tracce psichiche. Un ulteriore problema è
dovuto al fatto che la interpretazione della ritenzione come graduale affondamento non può chiarire perché proprio questo e non quello debba essere conservato e perché spesso ciò che giace dietro da tempo abbia la precedenza
rispetto a ciò che è passato or ora. Merleau-Ponty cerca una risposta a queste domande nel vedere stesso. La percezione ha luogo, al di là del punto di
vista del soggetto e dell’oggetto, nelle cose, nella forma cioè di una “modulazione”, di un “procedere tortuosamente” [letteralmente “serpeggiare” n.d.cur.],
così come si dice in Bergson (VI 247; trad. ted. 249). Non si tratta di qualcosa
che appare, per poi scomparire (verso dove?), ma piuttosto di qualcosa che è
lì deviando, come la traccia disegnata sul terreno da un serpente, da una linea
dritta, da un livello, da una norma, da un “campione di misura” (Heidegger); e
ciò da cui la linea disegnata dal serpente si allontana esiste solo nella deviazione da questa. Ciò che è visibile in questo modo, è “inscritto” nel mondo,
allorché esso lascia in questo le sue tracce36. A ciò corrisponde un dimenticare che non è da intendere negativamente come semplice oscuramento o
annullamento, altrettanto poco positivamente come un sapere nascosto da
qualche parte, quanto piuttosto come “essere verso…”, che si determina discontinuamente come deviazione da…, come indifferenziazione, come “sformato” [si preferisce tradurre l’intraducibile “Entstaltung” come l’opposto di
“Gestaltung”, n.d.cur.], come scomparire della deviazione e come livellamento
di un rilievo. Questo dimenticare rappresenta il rovescio del volgersi; esso gli
appartiene così come la percezione interna (Imperzeption) alla percezione.
Irrompere e sfuggire vanno insieme; il dimenticare ha inizio adesso ed è sempre iniziato37. La considerazione strutturale dell’accadere temporale ha come
conseguenza l’accostamento dello spazio e del tempo. Merleau-Ponty si
difende, come in precedenza, dal servirsi del tempo soggettivo contro quello
oggettivo, criticando di conseguenza la spazializzazione del tempo. “Infatti lo
spazio contiene in effetti altrettanto poco punti e linee come il tempo”. La forma
fa capire che “una linea è in realtà un vettore, un punto un centro di forze”38.
La cosa intesa come differenza significa che vi è sempre già qualcosa “dietro”,
oltre e lontano, in opposizione allo spazio classico inteso come l’essere separata l’una dall’altra (Auseinander) di cose identiche. Qui non si tratta più semplicemente dell’aver luogo del movimento proprio del corpo in un campo spazio-temporale; si tratta piuttosto di un intrecciarsi di spazio e tempo (VI franc.
e ted. 157). In questo modo gli oggetti spaziali hanno il loro specifico tempo:
51
52
allo stesso modo la casa che risplende all’orizzonte come qualcosa di passato o sperato; e dall’altro lato il tempo si inscrive nello spazio in modo tale che
“al contrario il mio passato abbia il suo spazio, i suoi percorsi, i suoi luoghi, i
suoi monumenti”. Al di sotto dell’ordinamento della successione e della simultaneità si trova una “rete senza nome, costellazioni di ore spaziali, punti d’evento”39. Questi pensieri, che si incontrano con le tarde riflessioni di Heidegger
su una topologia dell’essere, trovano il loro sostegno nella concezione spaziotemporale della fisica moderna che sostituisce la stretta opposizione tra simultaneità spaziale e successione spaziale con la costruzione di campi spaziotemporali includendo con ciò l’osservatore che misura nella costellazione40. La
inscrizione del tempo nello spazio conduce alla fine alla idea di un passato
architettonico o verticale. Merleau-Ponty, collegandosi alla indistruttibilità e
perdita del tempo dell’inconscio freudiano, si difende dalla interpretazione del
tempo inteso come una serie di vissuti o atti di coscienza e da una analisi
intenzionale che presupponga come luogo della riflessione un “luogo della
contemplazione assoluta”, condannando tutto ciò che è a “presentarsi alla
coscienza attraverso adombramenti” (VI 297f. trad. ted. 307ff). La critica, detto
brevemente, si rivolge contro la riconduzione del tempo in una coscienza interna del tempo; e in questa critica ad Husserl Merleau-Ponty si richiama tra l’altro a Eugen Fink. La giustificazione di questa critica della fenomenologia della
coscienza dovrebbe essere esaminata dettagliatamente, ma, indipendentemente da ciò, sono punti di vista oggettivi che Merleau-Ponty fa valere. Con il
pensiero di una verticalità dell’essere41 Merleau-Ponty ha presente diverse
cose. Come egli tenta di dimostrare, il passato non si lascia ordinare nell’orizzonte di un campo temporale, ma piuttosto esso si accatasta come una architettura che lasci rimbalzare da sé ogni sguardo frontale. Lo sguardo si spinge
nella lontananza, non in altezza o in profondità; il cielo, sotto cui, e la terra,
sopra cui ci muoviamo non sono regioni della Terra. Essi appartengono ai
costituenti della Terra, allo stesso modo in cui la nostra posizione eretta determina la nostra andatura e non può essere ridotta ad una posizione tra le altre.
Discorrendo su un passato architettonico o verticale, Merleau-Ponty manifesta la impossibilità di una riconducibilità del passato ad una coscienza del passato e, oltre a ciò, ad una coscienza originaria del presente: “Il passato “verticale” rivendica il diritto stesso di essere stato percepito; e in alcun modo avviene che la coscienza di aver percepito sorregga la coscienza del passato” (VI
297; trad. ted. 308). Il passato eccede insomma la attuale attribuzione di
senso; esso la precede contemporaneamente. In un certo senso il passato è
contemporaneo con il presente: contemporaneo non nel senso letteralmente
spaziale, che presuppone già un tempo, quanto piuttosto nel senso di una
contemporaneità di tempi differenti che non sono tenuti insieme mediante un
ordinamento universale del tempo (cfr. VI franc. e ted. p.157). Il presente di
turno non viene semplicemente rimosso mediante un nuovo presente e quello non è coordinato a questo così come una modificazione rispetto al suo
modo originario. Qui si deve distinguere tra gli eventi passati che hanno luogo
nel tempo e gli eventi fondativi agenti in continuazione che inaugurano un
nuovo tempo. Quando Merleau-Ponty accenna a Proust: “Le vere covate dei
DOSSIER MERLEAU-
biancospini sono le covate dei biancospini del passato” (VI 296; trad. ted.
307), questo non ha niente a che fare con una tradizionalistica preferenza per
il passato. Si tratta molto di più del fatto che le creazioni, simili alla propria
nascita, appartengono ad un “tempo prima del tempo”, ad un tempo che non
ci viene mai incontro di persona, ma che noi stessi continuamente ritroviamo;
esse vivono continuamente nella memoria primordiale di una “vita monumentale” e sono da ricondurre ad un tempo mitico42. Gli eventi chiave singolari non
sono parte stessa di un ordine che essi rendono accessibile; essi vanno oltre
la serie di abituali eventi temporali. Essi risultano come sovradeterminati,
uguali a precedenti eventi traumatici che secondo Freud sono accessibili solo
in “ricordi di copertura”43. Si capisce di conseguenza che per Merleau-Ponty il
presente significa più di una sensazione attuale, che esso “appresta una
matrice simbolica” (VI 246; trad. ted. 247) che conferisce agli eventi temporali una configurazione, una costellazione, un rilievo. Il tempo significa più di una
coscienza insieme ai suoi fenomeni di deflusso; il tempo è un (VI 298; trad.
ted. 309) turbine costruttore dello spazio e del tempo o uno strudel che sempre nuovamente interrompe il movimento normale delle cose o lievemente
muta l’accento simile a “turbini aperti nel mondo del suono” che dispongono
l’uno nell’altro e lasciano nascere modelli simili alla petite phrase nella sonata
di Vinteuil (VI 199; trad. ted. 198)44. Non solo il carattere frammentario dell’opera tarda, ma già il pensiero proprio di Merleau-Ponty ci dovrebbe trattenere
dal cercare, nei suoi percorsi intrecciati, una ultima informazione attraverso il
labirinto del tempo. Una registrazione delle sue riflessioni incontrerà sempre
momenti che si può denominare praegnans futuri, come il carattere dell’accadere temporale che eccede ogni paternità soggettiva e lascia anche alla natura il suo diritto; come la forza di organizzazione del tempo, che nella sua propria ritmica risulta più ricca ed elementare di tutti gli schemi e costruzioni;
come il nostro intreccio nel tempo che trasforma la vicinanza in lontananza, la
lontananza in vicinanza; come la anonimia di un tempo che accorda solo ai
nomi il suo potere di nominare; come l’intreccio chiasmatico tra tempo proprio
ed estraneo; come la posteriorità e anteriorità della nostra esperienza temporale che ci sorprende sempre di nuovo e ci sfida di nuovo; come il deviare dalla
giusta via dei decorsi normalizzati del tempo; come il carattere indiretto del
tempo che lega il grande tempo indietro ad una molteplicità polimorfa di specifiche modalità temporali. Rimangono problemi come quello relativo alla dinamica, alla forze trainanti dell’accadere temporale, alla cesure storiche del
tempo che sono più di mere onde temporali, agli ordinamenti temporali calendaristici o narrativi, al linguaggio ed alla simbolica del tempo, al tempo dei
sessi, alla rimozione temporale di pretese estranee ed altro ancora. Questi
problemi trovano tuttavia nella fenomenologia del tempo in carne ed ossa
(leibhaftig) di Merleau-Ponty una matrice feconda.
(traduzione a cura di Giorgio Rizzo)
53
Letteratura
54
BERGSON, H., L’évolution créatrice, in: Euvres, Paris 1959. Edizione tedesca:
Schoepferische Entwicklung, tradotta da G. Kantarowicz, Jena 1921.
FABECK, H. von, An den Grenzen der Phaenomenologie. Eros und Sexualitaet im Werk
Maurice Merleau-Pontys, Muenchen 1994.
FROSTHOLM B., Leib und Unbewusstes.Freuds Begriff des Unbewussten interpretiert
durch den Leib-Begriff Merleau-Pontys, Bonn 1978.
GIULIANI-TAGMANN, R., Sprache und Erfahrung in den Schriften von Maurice MerleauPonty, Bern/Frankfurt am Main/New York 1983.
HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, Tuebingen (settima edizione), 1953.
-, Kant und das Probelm der Metaphysik, Frankfurt am Main (terza edizione), 1965.
HENRY, M., Phénoménologie matérielle, Paris, 1990.
HUSSERL, E., Husserliana (Hua), Den Haag/Dordrecht, 1950 ff.
HYPPOLITE, J., Études sur Marx et Hegel, Paris, 1955.
LÉVINAS, E., Totalité et Infini, Den Haag, 1961. Traduzione tedesca: Totalitaet und
Unendlichkeit, Freiburg/Muenchen, 1987.
-, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Den Haag, 1974. Tedesco: Jenseits des Seins
oder anders als Sein geschieht, trad. di Th. Wiemer, Freiburg/Muenchen 1992.
LIEBSCH, B., Spuren einer anderen Natur. Piaget, Merleau-Ponty und die ontogenetischen Prozesse, Muenchen 1992.
MERLEAU-PONTY, M., Phénoménologie de la perception, Paris 1945. Tedesco.
Phaenomenologie der Wahrnehmung tradotto da R. Boehm, Berlin 1966 (=PP)
-, La structure du comportement, Paris (seconda edizione), 1949. Trad. ted. Die
Struktur des Verhaltens, tradotta da B. Waldenfels, Berlin 1976 (=SC).
-, Les aventures de la dialectique, Paris, 1955. Trad. ted. Die Abenteur der Dialektik,
tradotto da A. Schmidt e A. Schmitt, Frankfurt am Main, 1968.
-, Signes, Paris, 1960. Traduzione parziale in tedesco: Das Auge und der Geist, tradotto da H.W. Arndt, Hamburg, 1984.
-, Le visible et l’invisible, Paris, 1964. Trad. ted. Das Sichtbare und das Unsichtbare,
tradotto da R. Giuliani e B. Waldenfels, Muenchen 1986 (=VI).
-, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, Paris 1968 (=RC). Trad. ted.
Vorlesungen I, tradotto da A. Métraux, Berlin 1973.
-, La nature. Notes Cours du Collège de France, Paris 1995. Trad. ted. Die Natur, tradotto da M. Séglard-Koeller, Muenchen 1999.
-, Notes de Cours sur L’origine de la géométrie de Husserl, suivi de Recherches sur la
phénoménologie de Merleau-Ponty, a cura di R. Barbaras, Paris 1998.
-, Merleau-Ponty à la Sorbonne. Résumé de cours 1949-1952, Grenoble 1988. Trad.
ted. Keime der Zukunft. Vorlesungen an der Sorbonne 1949-1952, tradotto da
A. Kapust, Muenchen 1994.
MEYER, R.W., Bergson in Deutschland. Unter besonderer Beruecksichtigung seiner
Zeitauffassung, in Orth, 1982.
ORTH, E.W. (a cura di), Studien zum Zeitproblem in der Philosophie des 20. Jahrhunderts.
(Phaenomenologische Forschungen, vol.13), Freiburg/Muenchen 1982.
-, Zeit und Zeitlichkeit bei Husserl und Heidegger. (Phaenomenologische Forschungen,
vol.14), Freiburg/Muenchen 1983.
PLUEGGE, H., Der Mensch und sein Leib, Tuebingen 1967.
PROUST, M., A la recherche du temps perdu (Pléiade), Paris 1954. Trad. ted. Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit, tradotto da E. Reichel-Mertens, Frankfurt am
Main, 1953-57.
1
Il testo è stato tradotto dal tedesco da Giorgio Rizzo. Le citazioni presenti nelle note sono
state tradotte rispettando le edizioni citate dagli autori.
2
Si è d’accordo con E.W.Orth, allorché osserva come le riflessioni sul tempo corrano costantemente il pericolo o di terminare in astratte formule temporali, oppure al contrario di assolutizzare figurazioni del tempo. Cfr. la prefazione a Zeit und Zeitlichkeit bei Husserl und Heidegger,
Phaenomenologische Forschungen, vol,. 14. Questo volume, come il tredicesimo, offre composite analisi sulle varianti di una fenomenologia del tempo, incluse tematiche affini.
3
Questa polarità è alla base della opera in tre volumi di Paul Ricoeur dal titolo Tempo e racconto.
4
Cfr. Waldenfels, Phaenomenologie in Frankreich, 1983, p.150.
5
Nelle corrispondenti descrizioni delle strutture comportamentali (SC 113-133, trad. ted. 119138) sono citati autori come F.J.J.Buytendijk, K. Koffka e E.C. Tolman.
6
La ricezione di Bergson si è limitata, prima di tutto in Germania, troppo unilateralmente alla
critica di questo dualismo che ritorna in forma nascosta in autori come Oswald Spengler. Così si
dice nell’opera Tramonto dell’Occidente (citato da Meyer, 1982, p.23): “Lo spazio è un concetto,
il tempo una parola adottata per significare qualcosa di inafferrabile…”. In Francia, accanto a
Merleau-Ponty, autori come Minkowski, E. Levinas, J.Hyppolite e G. Deleuze si sono preoccupati di non far estinguere l’onda iniziale del bergsonismo che aveva contribuito a spianare il terreno
alla fenomenologia francese (cfr. Waldenfels 1983, pp.20-23).
7
V.v.Weizsaecker si appella a Sein und Zeit (1953, p.111): “ Lo spazio non è né nel soggetto,
né è il mondo nello spazio. Lo spazio è molto di più “nel” mondo…”. Merleau-Ponty non poté nella
elaborazione della sua prima opera utilizzare ancora il libro apparso nel 1940; egli tuttavia fa riferimento copiosamente alla revisione della teoria del riflesso di von Weizsaecker.
8
Il “mito” relativo ad una “determinazione del presente mediante il futuro” attaccato giustamente
dai critici del finalismo (cfr. Stegmueller 1929, p.530), nasce solo nel momento in cui il movimento
viene descritto come decorso di stati discreti sì da consentire l’entrata di un non ancora, e forse giammai esistente stato di cose nella spiegazione di un stato di fatto già sussistente. Una revisione sottraentesi alla alternativa tra meccanicismo e finalismo può aver luogo solo sul piano descrittivo. Cfr.
su questo punto la ricezione di questa problematica in connessione con la nuova biologia nelle lezio-
DOSSIER MERLEAU-
SARTRE, J.-P., L’être et le néant, Paris 1943. Trad. ted. Das Sein und das Nichts, tradotto da H. Schoeneberg e T. Koenig, Reinbek bei Hamburg 1991.
STEGMUELLER, W., Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen
Philosophie, vol. I: Wissenschaftliche Erklaerung und Begruendung,
Berlin/Heidelberg/New York 1969.
-, Hauptstroemungen der Gegenwartsphilosophie, voll. 2, Stuttgart 1975.
UEXKUELL, J.von, Theoretische Biologie, Frankfurt am Main 1973.
WAELHENS, A. de, Une philosophie de l’ambiguité.L’existentialisme de Maurice MerleauPonty, Louvain/Paris (terza edizione) 1968
WAHL, J., Vers le concret, Paris 1932
WALDENFELS, B., Phaenomenologie in Frankreich, Frankffurt am Main 1983.
-, Ordnung im Zwielicht, Frankfurt am Main1987.
-, Antwortregister, Frankffurt am Main 1994.
-, Deutsch-Franzoesische Gedankengaenge, Frankfurt am Main 1995.
-, Grenzen der Normalisierung. Studien zur Phaenomenologie des Fremden, voll.2,
Frankfurt am Main 1998.
-, Sinnesschwellen.Studien zur Phaenomenologie des Fremden, voll.3, Frankfurt am
Main 1999.
WEIZSAECKER, V. von, Der Gestaltkreis, Frankfurt am Main 1973.
55
56
ni sulla natura degli anni ’50 (RC, in particolare p.117, 129-137, 171-176; trad. ted. Vorlesungen I,
p.100, pp. 104-109, pp. 124-126, così come i corrispondenti passaggi nell’opera La natura. MerleauPonty non si esprime a favore di un mero ritorno alla teleologia, ma piuttosto a favore di una intesa
come “produttività orientata e cieca” (RC 117, trad. ted. 100) che lasci riconoscere nelle sue forze rigenerative e regolative un “eccesso del possibile rispetto all’attuale” (ivi, p.171, trad. ted. p. 124).
9
Cfr. PP 245, 247; trad. ted. p.249, 251. Il ritmo gioca naturalmente un ruolo importante anche
nella trattazione dei fenomeni della vita. Cfr. su questo tema: B. Waldenfels, Sinnesschwellen,
(1999), cap. 3: “Vom Rhytmus der Sinne”.
10
Semi della ragione. Lezioni alla Sorbona 1949-1952. Dal francese traduzione di A. Kapust,
Muenchen 1994, pp.161ss.
11
Ibid. Cfr. su questo punto Waldenfels, 1998, 80 e ss.
12
Ibid. p.34. In un altro passo (p.71) si dice: “l’entrata nell’età adulta non significa infatti solo il passaggio dalla ignoranza alla conoscenza, ma parimenti il passaggio da uno stadio polimorfico, contenente tutte le possibilità, ad un linguaggio più articolato, più determinato, ma anche più povero.”
13
Cfr. Hua I, §§ 18, 37. Giustamente Merleau-Ponty connota in senso particolarmente kantiano alcuni testi di Husserl (PP 320, trad. ted. 322). Merleau-Ponty certamente era a conoscenza
precocemente della revisione dello schema dell’apprensione nella teoria del tempo di Husserl (ivi,
p.178; trad. ted. p. 183).
14
Cfr. PP 320, trad. ted. Il concetto platonico di synopsis si trova anche in Kant, anche se in
lui la synopsis rimane legata ad una sintesi (KrV, A 97).
15
Con “tracce” si intende qui tradizionalmente azioni reali, qualcosa come tracce del cervello che sono “memorizzate” in qualche luogo. Le cose stanno diversamente quando le tracce sono
intese, come successivamente in Levinas e in Derrida, nel senso di processi temporali e corporei.
Nella Fenomenologia della percezione si trovano espressioni come orme sulla sabbia (400; trad.
ted. p.399); il corpo inteso come “traccia eloquente di una esistenza” (401; trad. ted. 400); e l’espressione “traccia di una coscienza la cui attualità mi si sottrae” (404; trad. ted. p.403).
16
Nelle sue lezioni sul tempo Husserl parla di una “unione degli uguali legati nel passaggio (o
nella coesistenza)” (Hua X, 45), di un “passare assoluto” (ivi, p.81) e di cose simili. Questo uso
del linguaggio è costituito nelle Confessioni di Agostino: “…ut id quod expecxat per id quod adtendit transeat in id quo meminerit” (XI, 28).
17
Merleau-Ponty pensa qui ad un mondo che non consiste di sole cose, ma piuttosto di “transizioni pure (pures transitions)”. Con ciò si capisce il suo interesse alla ontologia dell’evento di
Whitehead che gli era divenuta nota grazie allo scritto giovanile di Jean Wahl dal titolo Vers le concret (1932). Merleau-Ponty si riferisce ripetutamente alla caratterizzazione della natura di
Whitehead nel senso di un puro passaggio (passage). Cfr. RC 121, 131; trad. ted. Vorlesungen I,
102, 106; La Nature 162-165; trad. ted. xxxx. L’esempio dell’uccello si trova anche in Husserl; egli
considera il volo dell’uccello “come datità originaria nel punto-ora (Jetztpunkt), come datità piena
nel continuum del passato che termina nell’ora” (Hua X, 69).
18
Le seguenti citazioni si trovano nella importante sezione PP 381-385; trad. ted. 381-385.
19
Cfr. su questo punto Hua III, p.59: “Il dintorno indeterminato è del resto infinito, cioè l’orizzonte nebuloso e non ancora determinabile è necessariamente lì”. La indeterminazione
(Unbestimmheit), che appartiene ad uno dei più importanti motivi di una fenomenologia della
esperienza, intesa come “fenomeno positivo” (PP 12, Trad. ted. 25), possiede anche un aspetto
spazio-temporale che neanche mediante una logica formale dello spazio e del tempo (cfr.
Stegmueller 1975, pp.191-195) può essere chiarito. Nelle sue lezioni sulla natura Merleau-Ponty
mostra come anche la fisica moderna seppellisca una individualizzazione chiara ed assolutamente spazio-temporale. Cfr. la messa in questione di Whitehead di una concezione della natura
in base alla quale ogni essente è fissato chiaramente nella forma di una “simple location” in un
punto spazio-temporale senza partecipare ad altre entità spazio-temporali (La Nature, 153-165,
trad. ted. xxx); cfr. anche la caratterizzazione del determinismo di Eddington come “cristallizazione sulla superficie di una “nebbia” (ivi, 372; in particolare RC 129, Trad ted. Vorlesungen I, p.105).
La molto più in là citata “debolezza interna che ci impedisce di raggiungere ogni volta la compattezza di un individuo assoluto” trova la sua eco nell’esclusione da parte della fisica moderna di un
“individuo assoluto” (RC 129, trad. ted. Vorlesungen I, p.105).
20
Cfr. qui, dal punto di vista medico, le argomentazioni di Herbert Pluegge (1967) che rendono feconda la concezione del corpo di Merleau-Ponty.
DOSSIER MERLEAU-
21
Il carattere traumatico dell’esperienza dell’estraneo e la perciò risultante non ricuperabilità
di un passato primordiale assume in Levinas un peso più rilevante, tuttavia con il pericolo di una
caricatura (Ueberzeichnung).
22
Relativamente al retroscena del dibattito sulla afasia, cui Merleau-Ponty fa riferimento ripetutamente nelle sue prime opere, cfr. Regula Giuliani-Tagmann, 1983.
23
I membri del corpo intesi come gardiens du passé, come fedeli custodi del passato (Proust,
Recherche, I,6; trad. ted. I,14), rappresentano uno slogan molto usato nell’opera di MerleauPonty. Cfr. per la prima volta PP 211; trad. ted. 215; ed ancora VI 297; ted. 308). Accanto a Proust,
anche Valéry è il più importante ispiratore letterario; questo si evince anche nel tentativo di pensare contemporaneamente corpo e tempo. Sul rapporto di Merleau-Ponty con Freud e Lacan, cfr.
le monografie di Birgit Frostholm (1978) e Hans v. Fabeck (1994).
24
PP 398; trad. ted. 397. Questa formulazione che richiama prontamente la différance di
Derrida, non viene recepita nella traduzione tedesca.
25
Cfr. Waldenfels, 1995, cap.4 sulla idea metodica, risalente a Husserl e Fink, di una “fenomenologia della fenomenologia” (cfr. PP 77,419; trad. ted. 88, 418) e sulla sua trasformazione grazie a Merleau-Ponty.
26
Cfr. l’appendice III alla Crisi che Merleau-Ponty conosce subito dopo la sua pubblicazione
nell’anno 1939 e che commenta in una lezione del 1959/1960.
27
Molti passaggi possono essere letti in parte come confronti nascosti, in parte espliciti con
Bergson. Cfr. per esempio PP 319, 474f; trad. ted. 321, 472. Cfr. RC 161-168; trad. ted.
Vorlesungen I, pp.119-122; in particolare le annotazioni a questa lezione recentemente pubblicate da R. Barbara (Merleau-Ponty, 1998). Per quanto riguarda l’insieme del testo della lezione, si
rimanda all’ampio commento allegato da Alexandre Métraux alle Vorlesungen I.
28
Cfr. Heidegger, Kant und die Metaphysik, § 34.
29
Cfr. PP 488, trad. ted. 486; “investissement” è la comune traduzione del termine psicoanalitico “investimento”; nella traduzione tedesca si trova “Belehnung” [letteralmente “occupazione”,
n.d.cur.]. Su Sartre cfr. L’être et le néant, p.194; trad. ted. p.285f.; su Levinas cfr. Totalité et Infini,
p. 57; trad. ted. p.116.
30
Cfr. Essere e tempo, p.328: “Il fenomeno primario della temporalità originaria ed autentica
è il futuro”. Le divergenze oggettive che si presentano sia nella valutazione di Merleau-Ponty della
inautenticità, sia nella valutazione di Levinas delle possibilità del Dasein, non possono essere
sgomberate con correzioni meramente esegetiche. Questo vale anche per De Waelhens che, nel
suo commento, ancora valido, sulla Fenomenologia della percezione, tratta in modo adeguato
questi passaggi (1968, pp.306-308).
31
Cfr. su questo punto la revisione della filosofia della storia ne Les aventures de la dialectique: “ Se la storia non ha una direzione (un sens) come il fiume, ma senso (du sens), se essa non
fornisce alcuna verità, ma piuttosto errori da evitare e così via” (1955, p.41; trad. ted. p.37), allora non si ha bisogno di un altro inizio.
32
Cfr. su questo punto Le visible et l’invisible, pp.244-250, 296-298; trad. ted. pp.245-253,
307-309. Si tratta di annotazioni di lavoro degli anni 1959-1960 nei quali la tematica del tempo
appare in modo pregnante.
33
In francese si dice écart, letteralmente passo laterale nella danza; la parola “écart” ha un
ruolo rilevante anche nella poetica di Valéry.
34
Il narcisismo del corpo o del discorso come “riferimento all’essere mediante gli essenti” (VI
158; trad. ted. 157), come narcisismo fondamentale del vedere (trad. fr. e ted. p.183), che è aperto anche per altri narcisi, significa contemporaneamente un raggiungersi e un sfuggirsi: “il Sé
incerto è allontanamento, disvelamento del nascosto come tale…” (VI 303; trad. ted. 314).Se si fa
un passo ulteriore con Michel Henry e ci si appella ad una pura autoaffezione della vita, ad un
apparire come pura autoapparizione la cui purezza non è intorbidita da “nessun di fuori (Dehors),
da nessuna deviazione (Ecart), da nessuna ek-stasi” (Fenomenologia materiale, 1990, p.7), allora si finisce con un Sé indifferenziato che nella sua pura presenza si condanna esso stesso al
silenzio o si rifugia nel parlare col ventre.
35
Cfr. VI 243-246; trad. ted. 244-247; in part. p.246; trad. ted. p. 247. Sul concetto di tempo e
sviluppo della embriologia cfr. i passaggi corrispondenti delle lezioni sulla natura.
36
Merleau-Ponty si appella in questo contesto a Ch. Péguy: la filosofia della storia, nel “ritmo
dell’evento del mondo” urta contro il problema della percezione (VI 249; trad. ted. 252).
57
In modo più dettagliato su questo punto cfr. B. Waldenfels, Antwortregister, cap.III, p.5.
VI 248; trad. ted. 251 (nella trad. ted. vi è qui un “e” di più).
39
Così si legge nella prefazione programmatica a Signes (1960), p.22.
40
Cfr. su questo punto dettagliatamente La nature, pp.144-165; trad. ted. pp. xxx-xxx; sia nella
disputa commentata da Merleau-Ponty tra Bergson ed Einstein (cfr. anche il saggio su Einstein
Signes, cap.VIII), sia nella sua trattazione sulla concezione della natura di Whitehead la connessione tra spazio e tempo così come la pluralità dei tempi ed il carattere polimorfo dello spazio e
del tempo acquistano un ruolo rilevante.
41
Cfr. sul motivo della verticalità ispirato da G.Bachelard Antwortregister, cap. III, 8.1.
42
Anche queste riflessioni hanno un retroterra filosofico-naturale, allorquando, insieme a
Whitehead, la natura è contrassegnata come “memoria del mondo” (La nature, 163; trad. ted. xxx)
e “il tempo prima del tempo” insieme alla sua propria “architettonica” sono analizzati in profondità
fino alla embriologia e ontogenesi (ivi, p.276f; trad. ted. xxx).
43
Cfr. il riferimento programmatico alla psicoanalisi: VI 293f; trad. ted. 303f. Qui ci vengono
incontro una serie di motivi già menzionati che hanno un aspetto temporale come il movimento
retrogrado del vero, l’assunto di matrici simboliche e il senso “ominoso” di fenomeni sovradeterminati che da lontano ricorda ancora una volta le aporie della dottrina del tempo di Agostino:
“Quoquo modo se itaque habeat arcana praesensio futurorum, videri nisi quod est non potest”
(Conf. XI, 18). Come posso presagire ciò che non è presente in alcun modo e ciò che non aspetto, ma che mi aspetta?
44
Su questo punto cfr. Levinas che, in lode del modo poetico di scrivere di Nietzsche, dice che
esso “precipita il tempo irreversibile in un caos che fa girare vorticosamente (renversant, le temps
irréversible, en tourbillon)”, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p.10, trad. ted. p.36. Certe
tracce in Merleau-Ponty riportano indietro a Hegel. Nel suo saggio Vie et prise de conscience de
la vie dans la philosophie hégélienne d’Iena, da cui Merleau-Ponty prende citazioni in punti precedenti (SC 1175; trad. ted. 185), Jean Hyppolite parla di un “tourbillon vital” che precede un divenire cosciente della vita e del suo sviluppo concettuale (Hyppolite 1955, p.22; cfr. similmente SC
166; trad. ted. 175). Inoltre ci si deve ricordare di Bergson; nello scritto L’evolution créatrice
(Euvres, 1959, p.732; trad. ted. p.273) si dice per esempio: “La materia, sulla parte più grande
della sua superficie e a diversi livelli d’altezza, ha convertito la corrente in un turbinio sul luogo
(tourbillon sur la place)”.
37
38
58
di Chiara Zamboni
Chi è Merleau-Ponty? È la sua prosa poetica, ellittica e impegnata nel pensiero al medesimo tempo. È la sua prosa carnale, sensuale, sinestetica.
L’importanza di Merleau-Ponty è stata per me sin dalla prima lettura legata alla
attenzione che egli dà al corpo, per il legame che ho con quella cultura delle
donne, che ha avuto come fonte la pratica dell’autocoscienza e che ha posto
al centro della riflessione il corpo, come ciò che da un lato resiste ad ogni discorso, e dall’altro è leva di sapere. Ma anche e necessariamente: le parole dei
testi di Merleau-Ponty sono nella mia memoria in risonanza con le parole degli
amici che me l’hanno fatto conoscere.
Segni, Il visibile e l’invisibile e L’occhio e lo spirito –più degli altri suoi scritti– sono diventati un tessuto vivo sempre presente quando mi trovo a pensare l’esperienza. Avviene che un pensiero, pur nei suoi passaggi necessari,
insista poeticamente nelle nostre riflessioni. È allora che è vivo.
Per spiegare l’insistenza poetica del suo pensiero, l’affiorare alla mente di
nodi concettuali quali l’universale laterale, la carne e così via, adopero un’invenzione concettuale di Peirce: il suo modo di intendere il triangolo semiotico.
A prima vista il triangolo semiotico può sembrare una semplice disposizione
schematica dei soggetti in gioco. Se invece lo consideriamo come la chiave
per capire quel che avviene nell’esperienza del leggere, esso mostra la dinamica per la quale alcune pagine di testi amati diventano crocevia fondamentali. Se ci si chiede perché si amino alcuni testi, lo scambio dinamico, che il
triangolo di Peirce mostra, mi sembra lo possa dire al meglio1.
Se io adopero un segno che sta per un oggetto, provoco, in chi mi sta a
sentire, l’effetto di rapportarsi in qualche modo all’oggetto, cui mi sto riferendo.
Questo rapportarsi è di nuovo un segno. In altre parole un segno provoca un
effetto, che si costituisce come una nuova relazione nei confronti dell’oggetto,
cui il segno originario si rapporta. Peirce chiama interprentante l’effetto che il
segno provoca in una persona e che la induce a modificare il suo rapporto con
l’oggetto originario. È un effetto espresso a sua volta in un segno. Non rimane cioè interiore, ma trova in qualche modo forma visibile e riconoscibile2.
Vorrei sottolineare che Peirce sostiene che l’oggetto è attivo in rapporto al
segno3. In altre parole, l’oggetto influenza in qualche modo la modificazione
del segno. Questo è un aspetto che viene generalmente sottovalutato dagli
studiosi di semiotica, eppure esso fa dell’oggetto uno dei tre soggetti attivi del
triangolo semiotico, più enigmatico, certo, più inquietante, forse. Non inquietante –come vedremo– per Merleau-Ponty.
I testi di Merleau-Ponty sono segni, che hanno avuto effetto su di me non
DOSSIER MERLEAU-
MERLEAU-PONTY, LE AMICHE,
L’ONTOLOGIA CARNALE, LA POLITICA E GLI AMICI
59
60
solo per se stessi ma anche per scambi intensi che ho avuto con amiche e
amici e con la realtà. Dire questo significa affermare che affinché un segno
–un testo– faccia effetto, cioè crei legami di senso nuovi, concorrono diverse
condizioni, delle quali una delle più importanti è data dallo scambio vivo con
chi si conosce. È sicuramente una delle più importanti per l’esperienza femminile.
È a partire da ciò che trovo che la concezione di Gadamer sull’ermeneutica, cioè sull’arte di interpretare i segni, risulti appesantita dal vincolo maschile alla tradizione e non sappia perciò dare conto del legame diverso che le
donne hanno con i testi.
Come si sa, Gadamer sostiene in Verità e metodo che è la tradizione a
designare come vincolante un testo4. La tradizione ha l’autorità di mostrare ciò
che è essenziale, differenziandolo da ciò che è secondario. È evidente dalle
parole di Gadamer che gran parte degli uomini –in particolare i filosofi– avvertono la tradizione come fonte di autorità. Alcuni testi indicherebbero l’essenziale di altri testi, in una catena che determina le questioni da indagare. Non è
così per le donne. Certo la tradizione maschile ha effetti precisi, ma effetti più
vincolanti hanno le conversazioni sui libri con donne e uomini che si conoscono, si amano, si stimano5. Sia la tradizione maschile sia le relazioni vive si giocano nell’area di ciò che Peirce chiama interpretante, ma ben diverse appaiono le posizioni.
È conseguente dunque che il primo interesse che ho avuto per i testi di
Merleau-Ponty sia andato al tema del corpo. A quel che Merleau-Ponty dice
soprattutto del corpo visibile e vedente, che tocca ed è toccato. Un corpo tra
corpi non riducibile a corpo oggettivato, ma implicato lateralmente negli altri,
nell’essere. Ho infatti letto i testi di Merleau-Ponty alla fine degli anni ’70, in un
periodo in cui la cultura espressa dal femminismo ha posto come primo passo
di riflessione la centralità del corpo femminile come opaco ad ogni espressione esaustiva e come potenzialità per uno scambio significativo con il mondo.
Non è stata per me importante una tradizione autorevole: il mio interesse per
questo tema è nato dal confrontarmi con altre in rapporto alla propria esperienza di donne.
È da tener conto che vi sono aspetti che differenziano notevolmente
Merleau-Ponty e la cultura femminile riguardo al tema del corpo. Si pensi ad
esempio alla differenza sessuale. In Fenomenologia della percezione egli
parla di sessualità –e in particolare di quella maschile– come qualcosa che
coincide con l’esistenza e dunque non è né una caratteristica biologica né una
costruzione solo culturale, bensì ha un valore metafisico. Nelle opere successive parla sì di corpo, ma scompare la differenza sessuale come situazione
significante della percezione simbolica6. Al contrario la differenza sessuale è
nella cultura delle donne il significante, che costituisce il primo passo di esplorazione della realtà.
Si pensi anche semplicemente ai percorsi diversi compiuti. Merleau-Ponty
è un uomo, di conseguenza la via per la quale egli è arrivato a dare centralità
al corpo ha avuto un orientamento diverso da quello della cultura femminile. È
normale che sia così. Il fatto è che, essendo un filosofo per certi aspetti tradi-
DOSSIER MERLEAU-
zionale, cancella le tracce per le quali è arrivato ad affermarne qualche cosa
di significativo, invece di darne conto come molte donne nella loro ricerca
hanno fatto, mostrando il loro essere implicate nel processo di conoscenza
come qualche cosa che ha una portata teorica e che dunque va segnalato7.
Non sappiamo di Merleau-Ponty quale via sperimentale abbia seguito per arrivare a questa posizione di pensiero sul corpo. Abbiamo solo le fonti principali
con le quali si confronta: Husserl, la psicologia comportamentista e della
Gestalt, e così via, ma niente del suo percorso soggettivo di sperimentazione.
La mia lettura dei testi di Merleau-Ponty è stata dunque solitaria e al medesimo tempo aperta da queste discussioni con altre. Il confronto mette in movimento l’articolazione del pensiero. A volte aiuta la lettura fatta in solitudine a
trovare mondo, mentre altre volte si muove parallelo ad essa.
Molte donne che leggono e si confrontano in solitudine con un testo, che
per una sua e loro via segreta affascina, entrano in una specie di sogno, in una
sorta di rivelazione. Non sanno distinguere bene dove inizi l’ “io” e dove il
testo. Vivono dentro l’immaginario del testo e l’immaginario è del tutto autosufficiente: si alimenta di se stesso. Restare fedeli a quel primo sogno che il
testo ha rappresentato porta lontano, ma solo se se ne può parlare e discutere con altre e altri che avvertano le stesse questioni, altrimenti esso non ha
mondo.
Quando io ho iniziato a leggere Merleau-Ponty il tema del corpo era vincolante perché le mie interlocutrici più importanti si interrogavano su questo a
partire dall’esperienza. Non mi riusciva di rendere loro comprensibile il sogno
solitario, che mi ritornava insistentemente dalla lettura dei testi di MerleauPonty e che riguardava le cose e la loro vita. Così mi sono trovata lucidamente ad affrontare quella che considero la questione più importante quando si
rimanga fedeli al corpo: quale via prenda il pensiero a partire da esso. Ho
accantonato provvisoriamente quel che mi veniva da una lettura solitaria.
Nella riflessione femminile più avvertita la questione pensiero-corpo è connessa al primo legame corporeo e spirituale con la madre, che riviviamo come
un legame sotterraneo nel nostro rapporto con le altre donne e con il mondo8.
Ogni volta che si guadagna pensiero, lo si fa a partire da questo corpo a corpo
affettivo, percettivo, simbolico, senza trascenderlo, ma dal suo interno, patendolo, e con l’aiuto di pratiche che ci diano un orientamento.
In Merleau-Ponty si tratta non tanto di un corpo a corpo con la madre,
quanto direttamente di un intreccio con il mondo e con le cose. Egli si pone la
questione di cosa sia pensiero e idea in tale aprirsi e ritrarsi del corpo al
mondo.
C’è qualche legame nei suoi scritti tra il coinvolgimento con la madre e l’intreccio con il mondo? Si e no. Leggiamo questo passo tratto da L’occhio e lo
spirito: “Quel che si definisce ispirazione, dovrebbe venir preso alla lettera: c’è
realmente inspirazione ed espirazione dell’Essere, respirazione nell’Essere,
azione e passione così poco distinguibili che non si sa più chi vede e chi è
visto, chi dipinge e chi viene dipinto. Diciamo che un uomo nasce nell’istante
in cui ciò che in fondo al corpo materno era solo un visibile virtuale si fa visibile per noi e, insieme, per se stesso. La visione del pittore è una nascita pro-
61
62
lungata”9. Nel legame con il corpo materno c’è un visibile che è virtuale e che
diviene reale, quando nasciamo e la visibilità è vista e la vediamo. C’è solo
allora dischiudersi dell’Essere. La nascita è questo aprirsi del visibile stesso
dove noi siamo al medesimo tempo attivi e passivi10.
Merleau-Ponty fa capire in questo brano che la memoria del legame con la
madre rimane, ma l’Essere si dischiude trascendendo tale legame, che ha rappresentato solo la potenzialità di ciò che poteva fiorire. Sembra qui dunque
che l’attualità del dischiudersi superi definitivamente il potenziale del materno.
La pittura, che mostra l’implicazione del corpo con il mondo, è nascita prolungata. Dal materno e oltre esso. Invece nelle Note di lavoro a Il visibile e l’invisibile egli parla della carne del mondo, che è polpa e al medesimo tempo cerniera ontologica, e la chiama madre11. La madre è messa in evidenza in questo caso come nodo centrale dell’ontologia. Non è superata, ma desoggettivata. È tipico: molti uomini, coinvolti nel materno, desoggetivano la madre,
quando la inseriscono nell’intreccio del pensiero. Lacan, ad esempio, ad un
certo punto della sua riflessione, ne parla come “la cosa”.
Per le donne il legame con quella madre singolare e concreta che abbiamo conosciuto viene rivissuto sempre di nuovo nelle esperienze della vita.
Esso insiste, ritorna, riaffiora. Non è sicuramente solo il potenziale dell’essere, ma rappresenta dell’essere la cifra sempre da interrogare a partire da un’esperienza soggettiva. La madre non viene trasfigurata nel mito impersonale
della natura né desoggettivata, com’è invece nella tradizione di pensiero
maschile.
Sottolineate queste differenze con la cultura femminile, vorrei far vedere
come Merleau-Ponty dica comunque del legame pensiero-corpo qualcosa di
molto interessante.
In Il visibile e l’invisibile egli riprende alcune pagine di La ricerca del tempo
perduto di Marcel Proust12. Swann ascolta in casa Verdurin la piccola sonata
per pianoforte di Vinteuil. Il compositore comunica con la sua suonata una idea
di amore, che ha il senso di una “dolcezza ritratta e timida”. Le cinque note
dicono un significato sensibile e atmosferico al medesimo tempo. Un significato che non sarebbe niente senza la materialità acustica delle note e i loro
rimandi interni. L’idea di amore non si inscrive nel cielo delle essenze universali. Come del resto le cinque note sarebbero solo una manciata di suoni se
non fossero l’altra faccia di una dolcezza ritratta e timida. C’è qui accennato
un materialismo, che è guidato da qualcosa di non rappresentabile ai sensi.
Swann, che ascolta, ne coglie il senso come una specie di iniziazione13.
Così Merleau-Ponty parla di carne, materialità corporea e idea:
“Incontriamo qui il punto più difficile, cioè il legame della carne e dell’idea, del
visibile e dell’ossatura interiore che esso manifesta e nasconde. Nessuno si è
spinto più lontano di Proust nella fissazione dei rapporti del visibile e dell’invisibile, nella descrizione di un’idea che non è il contrario del sensibile, che ne
è il risultato o la profondità”14. Le idee come invisibile del visibile non si incontrano solo nella letteratura, nella musica, in ciò che ci appassiona, ma per
Merleau-Ponty si trovano anche nella ricerca scientifica, che è esplorazione
dell’invisibile.
DOSSIER MERLEAU-
Sono idee incarnate non perché nella carne noi troviamo occasione di pensarle, ma perché sono fodera della carne. Noi abbiamo perciò accesso ad
esse non direttamente, ma per forza di cose attraverso lo scambio che il corpo
ha con il mondo. È per questo che le idee non sono descrivibili direttamente,
né si possono raccontare, ma ci aprono ad un percorso di iniziazione. La parola “iniziazione” indica una posizione di apertura che veniamo a prendere nel
processo d’esperienza. Venendo meno l’idea di una rappresentazione di concetti, il risultato è che l’idea indica una posizione simbolica che ci troviamo a
vivere: “Con la prima visione, il primo contatto, con il primo piacere, c’è iniziazione, e cioè non posizione di un contenuto, ma apertura di una dimensione
che non potrà più essere rinchiusa, instaurazione di un livello in rapporto al
quale, ormai, ogni altra esperienza sarà riferita. L’idea è questo livello, questa
dimensione, e quindi non un invisibile di fatto, come un oggetto nascosto dietro un altro, non un invisibile assoluto, che non avrebbe niente a che fare con
il visibile, ma l’invisibile di questo mondo, quello che lo abita, lo sostiene e lo
rende visibile, la sua possibilità interna e propria, l’Essere di questo essente”15.
L’idea è l’invisibile del visibile non in forma statica ma come apertura di un
percorso. L’idea è sì profondità della esperienza nel suo primo annunciarsi, ma
non ci è data immediatamente. È infatti iniziazione di un percorso, dunque
richiede un lavoro indiretto del linguaggio, che ci impegna. Merleau-Ponty si
riferisce qui al lavorìo langagièr della lingua: il lavoro delle parole tra loro, che
vanno costituendo una trama per l’intenzione muta di significare orientata
verso un senso che non si conosce e che all’improvviso ci circonda16. Come
quando osserviamo chi lavora un tappeto e tesse la trama dalla parte del retro
secondo un disegno che non è dato di vedere, e, improvvisamente, girando il
tappeto ne vediamo chiaramente il disegno, così, lavorando sulle parole orientati da qualcosa che non si conosce, improvvisamente siamo circondati di
senso. Questo lavoro dei segni è necessario proprio perché l’idea è l’invisibile del visibile, che ci orienta come una iniziazione, ma che ha bisogno di un
processo di espressione dipendente da noi. Essa dice senza chiudersi in un
contenuto.
Il pensiero è dunque iniziazione di ogni esperienza ed allo stesso tempo
eccedenza che va guadagnata in un lavorìo che ci impegna sempre di nuovo
a partire dall’innesto che il nostro corpo ha con l’Essere. L’opacità del corpo,
la sua non oggettivazione, è il motivo della opacità del senso, che ci guida, e
che non è rappresentabile, per il fatto che noi siamo nella situazione che
descriviamo.
Prendiamo una figura che Merleau-Ponty introduce nelle Note di lavoro,
propedeutiche alla continuazione di Il visibile e l’invisibile. Mi riferisco alla figura dell’anima. Scrive: “L’anima è un essere di cui non c’è idea, un essere che
noi siamo e che non vediamo”17. Si potrebbe dire che l’anima equivale ad
essere nel mondo come stile di un certo modo di vivere e di agire. Essa non
è altro che nei comportamenti e nelle parole. È in questo senso che c’è un rapporto stretto tra vita quotidiana e opera, di qualsiasi genere essa sia: letteraria, pittorica, filosofica. Non c’è opposizione tra vita quotidiana e opera né la
vita spiega l’opera. Piuttosto accade che nella vita quotidiana lo stile dell’ope-
63
64
ra attragga la vita stessa, per il fatto che la vita è stilizzazione. “Il rapporto del
pittore con la propria vita è dello stesso ordine: il suo stile non è lo stile della
sua vita, ma attrae anche quest’ultima verso l’espressione”18. Ciò che si subisce come scansioni confuse nella vita, nell’opera diviene espressione e dunque orientamento.
A mio modo di vedere la posizione di Merleau-Ponty sul pensiero che è
fedele al corpo opaco è interessante perché parla del pensiero come qualcosa che è già presente nelle esperienze fatte dal corpo e non si aggiunge ad
esse. Ne è il lato invisibile e avvia ad un processo di espressione e pratica di
vita. Le donne si sono poste più volte la questione di che modalità abbia il pensiero legato al corpo. Tutto il lavoro che è stato fatto sul simbolico ha avuto
all’origine questo problema19. La soluzione che ne dà Merleau-Ponty è da
meditare, soprattutto per l’aspetto di processo a cui essa porta.
E tuttavia proprio nella soluzione che dà Merleau-Ponty a questa questione si avverte l’operare segreto della sua differenza maschile. Che sia un
uomo si vede dal fatto che non c’è traccia di angoscia in questa fedeltà al
corpo e al mondo.
Prendiamo ad esempio il fatto che Merleau-Ponty si appoggi su un “io fungente” piuttosto che sull’ “io trascendentale”, che per Husserl risulta invece
fondamentale. Un “io fungente” rischia in ogni momento di essere assorbito
dall’esperienza del mondo nella sua immediatezza. Di finire per essere pura
immediatezza. Tuttavia Merleau-Ponty esclude sempre con fermezza che vi
sia fusionalità con il mondo e con l’essere. Ne è segno il fatto che la percezione è sempre una stilizzazione fatta di pieni e di vuoti, di un ritmo. La percezione accoglie, ma anche taglia ed esclude, senza che la volontà e la consapevolezza abbiano a centrarci. La fusionalità non viene combattuta od ostacolata con pratiche di individuazione soggettiva: Merleau-Ponty la considera
semplicemente impossibile.
In questa individualità sicura sta il segno del suo essere un uomo, che dunque non rischia mai di identificarsi in modo profondo con la madre né di conseguenza con il tutto a cui la madre ci fa accedere con la nascita. Egli rimane
fedele alla madre, con quella fedeltà propria di un uomo che la considera
potenzialità dell’essere, senza nessun timore di essere catturato in una continuità corporea e sociale con lei.
Per le donne la fusionalità è invece un rischio che sembra loro di correre
costantemente sia quando avvertono una continuità felice con la madre, sia
quando sentono di sprofondare in modo angosciante nel legame con lei e la
continuità è troppo forte. Per questo buona parte del pensiero femminile ha
cercato pratiche simboliche che, mantenendo fede al rapporto con la madre,
senza tradirlo, aprissero vie autonome di invenzioni linguistiche e creatività
politica.
Io credo che dipenda da questa sua sicurezza maschile se Merleau-Ponty
arriva a formulare una concezione della soggettività come scarto differenziale nei confronti degli altri e al medesimo tempo piega, “esserne” dell’essere20,
mentre la maggior parte delle riflessioni femminili sulla soggettività ne mettono in evidenza come costitutiva la modalità relazionale. Dove la relazione ha
DOSSIER MERLEAU-
una storia diversa dallo scarto differenziale e porta ad altre forme simboliche.
Questa questione di un pensiero che non trascenda il corpo mi sta a cuore
ed è tuttora aperta, ed è il motivo per il quale, a partire da discussione con altre
donne, ritorno di frequente sui testi di Merleau-Ponty. Ne rimane separato però
un tema ricorrente che mi viene da una lettura come di sogno di alcuni suoi
scritti, e che non ha trovato rispondenza nelle discussione con amiche impegnate nel sapere e nella politica delle donne. Dall’intensità di questi scambi è
rimasto escluso un resto. Qualche cosa è stato messo da parte. Nella mia lettura solitaria dei testi di Merleau-Ponty avevo ricavato un’intuizione, una specie di rivelazione che non so se riguardi me o il testo. Mi sono fatta l’idea che
nei suoi testi si leggesse che le cose annuiscono, ci sorridono quando troviamo parole per loro.
In realtà se noi andiamo a leggere i suoi scritti, Merleau-Ponty non dice mai
alla lettera questo. Al massimo possiamo trovare che in Il linguaggio indiretto
e le voci del silenzio egli afferma che le cose combattono tra loro per attirare
la nostra attenzione e noi compiamo il gesto di esprimerne alcune a svantaggio di altre21.
L’aiuto maggiore per chiarire un’intuizione confusa in un percorso preciso
di pensiero l’ho avuto da amici studiosi di Merleau-Ponty. Ed è stata una
mediazione indispensabile, altrimenti avrei girato attorno a quell’unica povera
intuizione come l’asino attorno al pozzo. Un’intuizione non va giudicata: non è
né positiva né negativa. Va solo valorizzata con fedeltà, affidandosi per questo al pensiero. Se essa insiste, vuol dire che in essa c’è qualcosa che vuole
dirsi. Non si sa chi voglia dirsi, se l’inconscio o il testo di Merleau-Ponty o il
reale stesso. Propendo per un’ipotesi: ciò che in una intuizione di sogno nella
lettura di un testo vuole dirsi è dell’ordine del reale, che ha coinvolto la nostra
soggettività e la soggettività dell’autore o dell’autrice. Credo che sia a questo
livello che trova collocazione quel che diceva Peirce dell’oggetto nel triangolo
semiotico: che esso influenza attivamente il segno. Con le mie parole: il reale
influenza la pratica di significare. Gli studiosi di semiotica in genere sottovalutano questa ambigua affermazione di Peirce perché, per formazione, riportano il gioco dei segni alla produzione storica e umana del linguaggio, l’unica per
loro veramente conoscibile. Se si segue quell’affermazione di Lacan che dice
che il reale è l’impossibile del simbolico, si comprende perché gli studiosi di
semiotica lo escludano dalle loro analisi e perché perciò esso abbia come
luogo suo di espressione quello che non sappiamo chiamare altro che con il
nome di “sogno”. Cioè fuori dalla storia, ai limiti di essa. Fuori dall’umano già
codificato.
Ho parlato dell’aiuto che mi è venuto dalle discussioni con amici studiosi di
Merleau-Ponty. E pongo l’accento sulla parola “amico”, perché l’area dell’interpretante di Peirce funziona là dove c’è passione, scambio vivo, affetto e
stima, altrimenti l’effetto che il segno crea è regolato da logiche di potere di
codici ben radicati nel simbolico dominante.
Ricordo la prima volta che ho sentito un amico parlare del capitolo intitolato L’intreccio e il chiasma de Il visibile e l’invisibile22. Accennava alla deiscenza dell’essere. Un essere che fiorisce aprendosi verso il fuori, per cui è inter-
65
66
no e allo stesso tempo esterno. Ricordo la sensualità delle mani che si aprivano come la corolla di un fiore. Ricordo l’allegria dello sguardo, e credo
dipendesse dal fatto che la meraviglia per l’essere manteneva lo stupore per
la sensualità della cosa singolare, senza mai sacrificarla.
Naturalmente se rileggo alcune pagine di quel capitolo ritrovo l’atmosfera
delle sue parole: “La carne (…) è la deiscenza del vedente in visibile e del visibile in vedente. E, come il mio corpo non vede se non perché fa parte del visibile in cui si schiude, così il senso cui mette capo la disposizione dei suoni si
ripercuote su di essa”23 e “Quando ritrovo il mondo attuale, così com’è, sotto
le mie mani, sotto i miei occhi, contro il mio corpo, io ritrovo molto di più di un
oggetto: un Essere di cui la mia visione fa parte, una visibilità più vecchia delle
mie operazioni o dei miei atti. Ma ciò non significa che ci sia, fra me e questo
Essere fusione, coincidenza: viceversa, ciò si effettua perché una specie di
deiscenza apre in due il mio corpo, e perché fra il corpo guardato e il corpo
guardante, fra il corpo toccato e il corpo toccante c’è ricoprimento o sopravanzamento, cosicché si deve dire che le cose passano in noi nello stesso
modo in cui noi passiamo nelle cose”24. Eppure nel seminario dell’amico c’era
molto di più di questo testo e di queste parole. C’era il suo modo poetico di dire
e lo stile della sua vita. Lo stile non è percepibile direttamente, ma obliquamente nelle parole, nei gesti, nei silenzi.
Gli amici, con la loro lettura di Merleau-Ponty e con il loro stile di vita, mi
hanno permesso di articolare l’importanza della questione ontologica. Le cose
ci guardano quando noi le guardiamo e c’è una reversibilità tra loro e noi per
la deiscenza dell’Essere. Si tratta di una reversibilità carnale, che si trova
espressa in modo radicale in un passo di L’occhio e lo spirito: “Il pittore vive
nella fascinazione. Le sue azioni più proprie –quei gesti, quei segni di cui egli
solo è capace, e che saranno rivelazioni per gli altri, che non hanno le sue
medesime mancanze– gli sembrano emanare dalle cose stesse, come il disegno delle costellazioni –tra lui e il visibile, i ruoli inevitabilmente si invertono.
Ecco perché tanti pittori hanno detto che le cose li guardano”25. L’essere polimorfo fiorisce senza centro perché l’origine è da sempre “deflagrata”. Siamo
presi –le cose e noi– nel presente dal movimento del fiorire dell’essere. Per
questo siamo in un legame strutturale, inevitabile con le cose.
Nella filosofia del Novecento la centralità che è stata data alla questione
dell’essere ha avuto questo comun denominatore: di aggirare lo schema empirista, che è poi quello del senso comune, per il quale si definisce soggetto colui
che conosce l’oggetto nel pensiero e usa la cosa come un semplice strumento, senza nessun altro rapporto con essa. In realtà siamo presi da una
implicazione così profonda con le cose prima di ogni consapevolezza dell’ “io”,
che lo schema empirista risulta inadeguato a darne conto.
Merleau-Ponty è ricorso all’ontologia proprio per dire come noi e le cose
siamo coinvolti nello stesso movimento dell’essere. Tra noi ed esse esiste un
legame carnale e quella reversibilità chiasmatica, che esclude il primato dell’ “io”.
Gli amici dunque, per la loro attenzione alla ontologia, mi hanno aiutato a
trovare parole significative a quella immagine come di sogno che ritornava con
insistenza e per la quale le cose annuirebbero a parole di verità.
DOSSIER MERLEAU-
Tuttavia rimane il compito di pensare il linguaggio, dato che la verità è di
parole. Merleau-Ponty parla del linguaggio come di una dimensione ontologica. Da un lato le parole di senso sono date dal gesto di significare, dall’altra “il
linguaggio è tutto, perché esso non è la voce di nessuno, perché è la voce
stessa delle cose, delle onde e dei boschi”26. Per lui è inevitabile quel che scrive Peirce del segno: le cose, gli oggetti hanno influenza sul segno, sul linguaggio. Soltanto che Peirce si muoveva in un ambito di pensiero non sufficientemente articolato da un punto di vista ontologico e dunque non riusciva a
dire molto di più di questo.
Se tra noi e le cose c’è un legame carnale prima di ogni consapevolezza,
allora il nostro gesto di dire è dipendente anche dalle cose. E se le nostre sono
parole di verità esse rendono conto di tale coinvolgimento con il reale. Il reale
è compresente e attivo.
Come ridire questo alle amiche, a cui dovevo un forte legame con la politica, perché la politica delle donne prendesse in considerazione che il reale è
vivo e influenza il linguaggio, dato che noi siamo in un legame vivo e inconscio con il mondo?
Il dire sì delle cose è il senso di felicità, che ci prende in alcuni momenti,
nei quali viene detto qualcosa di vero. C’è allora sorriso dell’essere. Il mio tentativo è stato di dire che questo è essenziale nella politica delle donne. Come
si sa, ciò su cui la politica delle donne ha molto insistito è l’importanza della
relazione di un io e di un tu nel discorso e nelle pratiche27. Non però una relazione qualsiasi né il modello di relazione nella quale si costruisce la comunicazione corretta delle buone cittadine e dei buoni cittadini, ma un io e un tu in
cui avviene qualcosa che non è riducibile alla buona comunicazione. Avviene
qualche cosa di non omogeneo alla dimensione storica raccontabile. Per
esprimere questo qualcosa è stato adoperato a seconda dei contesti il nome
di Dio o quello di inconscio, ma a me sembra, sulla scorta di Merleau-Ponty,
che sia l’essere a venirvi implicato. È così quando ascoltiamo qualcosa che ci
sorprende e ci sposta dai binari usuali. Allora succede questo: un senso di
allegria ci prende alle parole di verità. L’allegria della mente è segno dell’annuire delle cose, del sorriso dell’essere alle parole dette28.
Per le donne, che sono così attente al corpo, l’ontologia non può essere
che carnale. Il legame con le cose mette in conto il lato inconscio del corpo29.
Come qualche cosa di non dicibile e che fa tessuto in un modo che si sottrae
alle rappresentazioni dell’ “io” e per il quale le cose sono materialmente insistenti ad esso. Compresenti concretamente e non in una qualche forma di rappresentazione. Per le donne che amano la politica questo è particolarmente
importante: è la scommessa che quel che dicono e fanno, partendo da sé, non
è soggettivistico e pura opinione, ma mostra l’orientamento del mondo.
Ho vinto la scommessa di convincere le amiche che il fiorire dell’essere e
l’intreccio carnale tra noi e le cose ha a che fare con la politica delle donne?
Quel che posso dire è che non si tratta di vincere o di perdere, ma di stare nel
processo a cui questa scommessa impegna.
67
68
1
L’idea di fare riferimento al triangolo semiotico di Peirce per dare conto della passione viva
nei confronti di testi letti mi viene da una conversazione filosofica tenuta con le compagne di
Diotima. Diotima è una comunità di filosofe che si è costituita all’università di Verona nel 1984.
2
Cfr. CH. S. PEIRCE, Collected Papers, vol. 2°, a cura di Charles Hartshorne e Paul Weiss, the
Belknap Press, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1967, 2.303.
3
Cfr. CH. S. PEIRCE, Collected Papers, vol. 1°, a cura di Charles Hartshorne e Paul Weiss, the
Belknap Press, Harvard University Press, Cambridege (Mass.) 1967, 1.284.
4
Cfr. H. G. GADAMER, Verità e metodo, a cura di Gianni Vattimo, Fratelli Fabbri, Milano 1972,
pp. 6-22.
5
Cfr. sul diverso rapporto con la tradizione, l’autorità e i testi tra donne e uomini C. ZAMBONI,
Parole non consumate. Donne e uomini nel linguaggio, Liguori, Napoli 2001, pp. 110-111. È questo il tema attualmente in discussione a Diotima.
6
Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, trad. it. di Andrea Bonomi, Il
Saggiatore, Milano 1980, cap. Il corpo come essere sessuato, pp. 220-243.
7
Sull’essere implicate nel processo di conoscenza da parte femminile si veda AA.VV., Diotima.
La sapienza di partire da sé, Liguori, Napoli 1996.
8
Si veda su questodi L. IRIGARAY, Il corpo a corpo con la madre in Ead., Sessi e genealogie,
trad. it. di Luisa Muraro, La Tartaruga, Milano 1989, pp. 17-32 e L. MURARO, L’ordine simbolico
della madre, Editori Riuniti, Roma 1992.
9
M. MERLEAU-PONTY, L’occhio e lo spirito, Trad. it. di Anna Sordini, SE, Milano 1989, pag. 27.
10
Su Il visibile e l’invisibile analizzato nella prospettiva del legame cancellato, ma riaffiorante con
la madre c’è uno scritto di Luce Irigaray. Si tratta del capitolo Il visibile della carne in L. IRIGARAY, Etica
della differenza sessuale, trad. it. di Luisa Muraro e Antonella Leoni, Feltrinelli, Milano 1985, pp. 117141. Irigaray mostra come la filosofia di Merleau-Ponty sia segnata da un “solipsismo labirintico” per
mancanza di una effettiva relazione con l’altro, e come questo abbia a che fare con il fatto che la sua
filosofia rimane in un rapporto prenatale, incestuoso con il tutto e con la madre, vissuta dall’interno,
senza possibilità di respiro, senza taglio del cordone ombelicale. In qualche modo per ciò il soggetto non viene mai al mondo e non c’è sublimazione della carne. La critica di Irigaray è stata per me
fondamentale. Tuttavia qui ho via via articolato una posizione diversa dalla sua.
11
M. MERLEAU-PONTY, Note di lavoro, in Id., Il visibile e l’invisibile, trad. it. di A. Bonomi, ed. riveduta da M. Carbone, Bompiani, Milano 1993, pag. 278.
12
Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., pp. 176-178.
13
Cfr. M. PROUST, La strada di Swann, trad. it. di Natalia Ginzburg, Einaudi, Torino 1969, pp.
222-229.
14
Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., pag. 164.
15
Ivi, pag. 165.
16
Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio, in Id., Segni, trad. it. di
Giuseppina Alfieri, Il Saggiatore, Milano 1967, pp. 66-72.
17
M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., pag. 261.
18
M. MERLEAU-PONTY, Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio, cit., pag. 92.
19
Un testo tra gli altri che affronta questa questione: Libreria delle donne di Milano, È accaduto non per caso, Sottosopra rosso, Milano gennaio 1996.
20
Sulla soggettività in Merleau-Ponty come “esserne” e piega si legga P. GAMBAZZI, L’occhio e
il suo inconscio, Cortina, Milano 1999.
21
Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio, cit., pp. 74-76.
22
Si tratta di Guido D. Neri, che è stato uno studioso di Merleau-Ponty. Ha tradotto dal francese La struttura del comportamento, ha curato il numero di “aut aut” dedicato a Merleau-Ponty e
uscito nel luglio 1989 con il titolo Merleau-Ponty. Figure della nuova ontologia. Ha tenuto molti
corsi su Merleau-Ponty all’università di Verona.
23
M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., pag. 169.
24
Ivi, pag. 141.
25
M. MERLEAU-PONTY, L’occhio e lo spirito, cit., pag. 26.
26
M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., pag. 170.
27
Un testo considerato classico del femminismo italiano sulla dimensione relazionale nelle
pratiche tra donne è Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere dei diritti, Rosenberg &
Sellier, Torino 1987.
DOSSIER MERLEAU-
28
Cfr. C. ZAMBONI, Die Politik der Frölichkeit, in Diotima und die andere, Die Welt zur Welt bringen, Ulrike Helmer Verlag, Königstein 1999, pp. 187- 188, già in “Via Dogana”, n. 24, dicembre
1995 con il titolo La politica e l’ilarità. Un testo nell’ambito della cultura femminista che prende in
considerazione come centrale il riso, l’ironia gioiosa come alleanza tra il finito e l’infinito è M.
FORCINA, Ironia e saperi femminili, Franco Angeli, Milano 1995.
29
Quando parlo di lato inconscio del corpo faccio riferimento al concetto teorico di immagine
inconscia del corpo, sviluppato da Françoise Dolto. Si veda F. DOLTO, L’immagine inconscia del
corpo, trad. it. di V. Fresco, RED, Como 1996.
69
RIFLESSIONI SULLA PROLIFERAZIONE
DELLE LEGGI
di Gaetano Scatigna Minghetti
…corruptissima re publica plurimae leges.
Tacito, Annales, 27
quannu li liggi sunu assai, ‘un si rispettanu mai
Proverbio siciliano
70
Nell’Europa ormai già quasi integrata, la cui nuova situazione si percepisce
agire in maniera effettiva nella abituale attività di ciascuno –situazione contessuta, come è naturale che sia, di entusiasmi e di premure, di delusioni e di
negligenze–, non può essere più consentito a nessuno di seguitare a conformare l’esistenza di ogni cittadino entro le pastoie di una miriade di leggi che
ne uccidono l’audacia e la fantasia; che ne annullano l’intraprendenza, il
coraggio, il gusto del rischio; elementi, questi, che costituiscono la linfa vitale
delle classi emergenti di ogni epoca: sono dei giocattoli troppo costosi che non
ci si può, ancora a lungo, permettere di mantenere in piedi.
Nell’Europa del futuro, di un futuro che si prospetta imminente, i cittadini italiani sono attesi da sfide, da prove che la mescolanza disordinata delle leggi italiane limita ed arresta, decretandone l’irrefrenabile paralisi ed aprendo pertanto la via ad un colonialismo molto più subdolo, molto più insidioso che, se non
contrastato, porrebbe l’Italia, ipso facto, in uno stato di subornazione che la sua
civiltà giuridica non le consente in alcun modo di rassegnarsi ad accettare.
«…d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano»1.
Il verso che Dante Alighieri fa pronunciare, nel Paradiso, all’imperatore
Giustiniano (483-565) intende ricondurre, con la propria impellente immediatezza, ad un problema la cui urgenza si avverte, anche ai giorni nostri, con quella
identica istanza, già di grande momento al tempo di questo monarca il quale,
resosi perfettamente conto di come fosse ormai molto difficoltoso orientarsi nella
farragine delle leggi, frutto della secolare e doviziosa, sebbene a volte, contraddittoria tradizione giuridica romana, volle che esse fossero finalmente unificate
in un solo codice per conferire loro una funzione organica tale da attribuire all’impero che amministrava un fondamento certo ed incontrovertibile, come base dell’ordine e della convivenza civile sui quali desiderava venisse fondato il principio dell’autorità che egli esercitava in quanto riteneva che anche i propri successori sul trono di Bisanzio dovessero poggiare l’imperium soltanto sulle leggi
e non sulla forza o, soluzione ancora più grave, decisione altrettanto inaccettabile per lui, uomo, per quello che consentivano i luoghi e le stagioni, di moderazione e di trattativa, sulla violenza e sulla sopraffazione: voluntas principis suprema lex esto è il concetto filosofico-giuridico che ne ispirò fondamentalmente la
condotta politica ed amministrativa; beninteso, però, di una volontà ferma e
salda; stabile, dunque! Non volubile né, tantomeno, capricciosa.
NOTE
A tale scopo, Giustiniano commise l’immane, ma, è ragionevole credere,
ugualmente esaltante incarico del riordino, ad una commissione di esperti,
coordinata dal giurista Triboniano, che, postasi all’opera nel 528, riuscì a portare a termine i lavori dopo un impegno decennale che diede i suoi frutti con
la razionale e definitiva sistemazione di tutte le leggi romane, sia quelle più
antiche che quelle più recenti, formulandole con una espressione semplice e
piana, eliminandone le sovrapposizioni e le stridenti contraddizioni perché
potessero essere interpretate in maniera morfologicamente omogenea e filologicamente indubitabile.
Triboniano ed i suoi giuristi compierono un’opera di finissimo cesello che
denunciava chiaramente tutta una sedimentata cultura giuridica i cui prodromi
prendevano l’abbrivio dalla secolare esperienza di saggia civiltà espletata dai
patres della Roma augusta nell’attitudine innata ad esercitare ed a guidare il
governo dei popoli, anche quando i costumi, le usanze, le tradizioni locali si
rivelavano, e, in effetti, molto spesso lo erano, in contraddizione con i supremi
interessi e le esigenze dei dominatori e della megapotenza che essi rappresentavano. Il Corpus iuris civilis si manifestò come un impegno dagli esiti altamente positivi divenendo ipso facto l’insostituibile sostrato, nelle proprie fermentanti implicanze, fin quasi ai giorni nostri, nonostante alcuni vulnera ad
esso proditoriamente inferti, contro ogni ragionevolezza storica e giuridica,
correlato con l’essenziale lievito culturale dell’esperienza della civiltà latino-cristiana, introiettata fin nelle sue più intime latèbre, delle odierne codificazioni
giuridiche del mondo occidentale.
Ma, tutto ciò non fu sufficiente; non bastò, se, in una per così dire continuità
di azione negativa, posta in essere nel corso dei secoli, durante il predominio
spagnolo in Italia, in particolare nel Mezzogiorno viceregnale e nel Ducato di
Milano, il problema della quasi nulla cogenza delle leggi –dovuta, per quanto
sia possibile argomentare dalle conoscenze storiche e giuridiche finora acquisite, ma che potranno essere suscettibili di indagini maggiormente approfondite ed articolate, a conferma di quanto la critica storica ha già ampiamente
documentato– si presentava con la stessa drammatica impellenza dei tempi
andati, con l’aggravante fornita dal fatto che altresì alcuni elementi del clero,
che doveva ergersi a paladino dei reietti, dei più deboli, secondo i dettami del
Vangelo del Cristo, spesse volte si facevano, anche se in alcuni casi inconsapevolmente, strumento attivo e passivo delle persecuzioni a delle angherie
perpetrate dai prevaricanti nobilotti locali, che si sentivano in diritto –in forza
pure dell’origine spagnola della propria casata, che li rendeva classe egemone, quasi a legibus soluti– di spadroneggiare ad libitum senza temere ripercussioni legali di sorta a causa del proprio comportamento ribaldo.
Di qui l’emanazione ripetuta di leggi e di gride che, non applicate e, tantomeno fatte rispettare nella propria integrità, davano l’adito a che venissero
sempre di più raggirate e disattese perdendo, in questa inflazione parossistica, la forza jugulatoria insita naturaliter in qualsivoglia norma che costituisce
l’ordinamento giuridico di uno Stato. È quanto denuncia il Manzoni nei
«Promessi Sposi», opera che, sebbene ormai lontana dalla sensibilità odierna, rappresenta comunque un documento probatorio, sia pure sotto forma di
71
72
narrazione romanzesca, di un’intera epoca che, negli ambienti romantici e
liberali italiani dell’Ottocento, di cui lo scrittore milanese viene ritenuto, per
unanime consenso della critica, un esponente di spicco, era condannata
senza possibilità di appello, per la endogena carenza di certezza della legge
e per la mancanza di giustizia che rendeva imbelle il governo spagnolo –quanto meno nelle proprie diramazioni periferiche– ed inviso ai suoi stessi sudditi,
denunciandone in modo palmare l’impotenza di fondo.
I decreti emanati dalle autorità spagnole, in pratica, si rivelavano formalmente tremendi nella enunciazione ma dannosi nella sostanza per l’incapacità nell’impedire le prepotenze che mandavano ad effetto i signorotti nelle terre
su cui esercitavano la giurisdizione ancora feudale: è di questo carattere irrazionale che sono espressione queste gride, che marchiano a fuoco un assetto sociale precipuamente fondato sul sopruso e sull’oppressione delle classi
subalterne e degli emarginati che solamente in alcuni esponenti della Chiesa
–come, esemplarmente, sono il cardinale Federigo Borromeo ed il padre
Cristoforo– trovavano i patroni contro le angherie e le vessazioni dei ceti dominanti. La prosa stessa delle gride, dei decreti: tronfia, ampollosa, retorica,
mette a nudo senza scampo l’insulsaggine di tutta intera una classe dirigente
e la mancanza di giustizia insita nella società del tempo, dovuta all’impotenza
dei governanti ed al sistema delle leggi, che non venivano osservate né dall’alto clero né dalla nobiltà che, dello Stato, in quel quadro politico, rappresentavano la struttura portante; anche perché, quelle leggi, più che per ogni ceto
sociale, venivano formulate per procurare, nella pratica di ogni giorno, una
veste legale ai soprusi ed alle sopraffazioni di una precisa categoria di persone i cui privilegi non venivano mai posti in discussione, nemmeno dalle rade
jacqueries che scoppiavano improvvise e virulente ma destinate, per ciò stesso, nel volgere di pochi momenti, ad essere annullate in un bagno di sangue,
spesso per l’assenza di una vera guida che ne avesse potuto preparare adeguatamente sia la genesi che lo svolgimento.
È, però, di un autore vissuto a cavallo dei secoli XVIII e XIX ma, oggi, pressocché sconosciuto, Giuseppe Antelmy, la disamina più lucida e, per certi versi,
più disincantata riguardo al problema della abnorme proliferazione delle leggi
che ai suoi tempi, come pure oggigiorno, attanagliava la quotidianità della vita
impedendo con i fatti ciò che si proponeva di voler agevolare in diritto.
Giuseppe Antelmy «nacque in Terra D’Otranto2 –come scrive Carlo Villani– e
fiorì nella prima metà del XIX secolo. «Scrisse: Sorgenti della vera gloria e del
potere del Sovrano, relative alle felicità dei popoli, 1807, opera che va ricordata
da Amilcare Foscarini nel Saggio d’un Catalogo ecc.3, più volte qui menzionato
(citato, cioè a dire, nelle pagine del grosso volume Scrittori ed artisti…, n.d.s.)»4.
«Da noi già ricordato a p. 55 –aggiunge ancora il Villani– nacque precisamente a Ceglie Messapico il 9 novembre 1762, e morì il 2 dicembre 18515.
Appartenne a diverse accademie scientifiche e letterarie, nazionali, nonché
straniere, e scrisse altra «Opera», oltre quella da noi innanzi indicata, secondo ne assicura l’Arditi nella sua “Corografia fis. e stor. della prov. di terra
d’Otranto”, p. 1396, la quale rimase inedita ed andò poi perduta»7.
L’Antelmy, da avvertito illuminista quale bene a ragione può essere ritenu-
Il rapido itinerario storico-giuridico fino a qui compiuto, pur con i limiti ideologico-dialettici entro i quali si è venuto delineando11, deve porre nettamente in
guardia dal formulare delle ipotesi purchessìa, anche se, in fondo, larvatamente ireniche, in quanto l’uomo e le sue leggi, che ne incarnano e ne attualizzano lo spirito in un preciso momento storico e sociale, sono pur sempre
soggetti ad una coalescenza di fattori, di circostanze, di eventi spesse volte
NOTE
to, si era reso subito e perfettamente conto che uno Stato, per funzionare
seriamente, ha l’estrema necessità di poter contare su di una amministrazione efficiente, su di una giustizia rapida ed equanime8, su norme che possano
essere chiaramente applicate e puntualmente rispettate in quanto esse si propongono come elementi cruciali nella vita di una comunità per favorirne lo sviluppo socio-economico nell’articolazione civile dei rapporti. La nostra legislazione –afferma quasi sgomento l’Antelmy– forma un corpo di leggi immenso,
disordinato, e mostruoso. Le leggi de’ Romani, dei Longobardi, de’ Normanni,
degli Svevi, degli Angioini, e degli Aragonesi sono in grandissimo numero. A
simili leggi si unisce il vasto corpo di quelle, che diconsi Dispacci. Or tutte queste leggi furono fatte in diversi tempi, circostanze, e forme di Governi: furono
dettate a popoli di vario costume, genio, ed educazione. Sono per tal riguardo
discordanti, e contraddittorie. In tale disordine, confusione, e moltitudine di
leggi i nostri dritti e le nostre proprietà sono mal sicuri: le liti si moltiplicano, e
le famiglie si ruinano: la giustizia finalmente è, o vilipesa, o non conosciuta.
L’agricoltura, le arti, ed il commercio sono nell’avvilimento: i nostri costumi
sono rozzi, e le nostre maniere sono poco civili. L’imperfezione –continua
L’Antelmy–, ed il difetto delle nostre innumerevoli leggi sono a buon conto la
prima fatale origine de’ nostri mali, e delle nostre infelici circostanze.
«La saviezza –tenta, l’Antelmy, di augurare prima a se stesso e poi anche
agli altri–, e l’impegno del nostro illuminato Governo ci promettono, che la
nostra legislazione debba correggersi, e debba riformarsi a seconda de’ nostri
veraci interessi. La legislazione, che noi speriamo, ci libererà da’ nostri mali, e
renderà prospero, felice, e tranquillo il nostro paese»9.
Quella dell’Antelmy, a ben vedere, fu soltanto una pietosa illusione, un
voler porre, per così dire, le mani avanti in modo da esorcizzare il suo presente
e, con esso, ovviamente, il futuro. Dal proprio punto di vista, l’atteggiamento e
l’auspicio sono comprensibili, specie se si pone mente agli anni tumultuosi, sia
a livello personale, sia in relazione alle vicende politiche ed ideologiche inerenti gli avvenimenti rivoluzionari e controrivoluzionari del 1799, che egli aveva
vissuto di recente da protagonista10.
Ma, il fatto stesso che ancora oggi se ne stia dibattendo su tutti i mezzi di
comunicazione di massa, senza che si possa riuscire a trovare una soddisfacente risoluzione a questa realtà, può indurre a pensare che, al di là di ogni
pessimistica visione delle circostanze nelle quali ci si muove, forse sia insito
nel sistema imperfetto di democrazia e nella struttura stessa della odierna
società italiana la parossistica espansione del numero delle leggi, nella arresa
convinzione che, probabilmente, contro di essa non ci possa essere, almeno
per ora, alcun rimedio.
73
74
indipendenti dalla sua diretta volontà e trovano la propria eziologia in fenomeni che, per molteplici ragioni, non possono essere correttamente moderati; tali,
però, che ne frenano irrimediabilmente l’esistenza e la credibilità nell’ambito
del consorzio sociale.
Nella nuova Europa, il cui diverso status già si avverte concretamente
operare nella consueta giornata di tutti; giornata consustanziata, come è
ovvio, di attenzioni e di dimenticanze, di esaltazioni e di amarezze, non ci si
può più concedere di continuare ulteriormente a regolare la vita di ogni cittadino con una miriade di leggi che ne calpestano l’audacia e la fantasia, che
ne annullano il coraggio ed il gusto del rischio: sono dei balocchi –per usare
un lemma eterodosso a questo assunto– tanto invasivi che sarebbe oltremodo deleterio continuare a maneggiarli pena l’inattendibilità dell’organizzazione statuale e a danno del cittadino che, a norma degli articoli fondamentali
della Costituzione, deve essere tutelato e difeso ugualmente sia nei suoi diritti come nei suoi doveri.
Nella nuova Europa, sarà bene ribadirlo, i cittadini italiani sono attesi da
prove differenti che non le abituali; da prove che la eterogeneità sregolata,
contraddittoria delle numerose leggi tende a bloccare nelle loro iniziative con
grave nocumento dell’ordine sociale ed economico costituito. Lo stesso effetto procurerebbe, per converso, una carenza endemica di esse qualora si
dovesse addivenire ad una drastica «potatura» dell’odierno «corpus» legislativo, impedendo, contestualmente, una sana crescita sociale e culturale, ma
eccitando caos ed incertezze:
Che val perché ti racconciasse il freno
Justiniano, se la sella è vota?
Sanz’esso fora la vergogna meno12.
È l’equilibrio quello che necessita; il giusto mezzo ciò che serve: non altro!
A questo punto, la scommessa è aperta, la mèta da raggiungere è ormai
stabilita! Sta a ciascuno di noi cercare di vincerla; è compito di tutti, solidarmente, di conseguirla nel solco, però, dalla sfolgorante tradizione storico-giuridica latina ed italiana, che pone il Paese su di un ideale piedistallo la cui predella risulta costituita dalla concretezza positiva dell’antica legislazione romana che costituisce il solido substrato dell’ordinamento giuridico dell’Italia, in
particolare, e del mondo occidentale, più in generale: «La quiete, e la felicità
de’ popoli esigono –specifica ancora l’Antelmy–, che le leggi sieno di poco
numero e chiare. Si deduce dalla storia romana, che lo stato di Roma fu maggiormente florido, quando le leggi erano chiare, e scritte in poche tavole, che
moltiplicate a dismisura, e divenute oscure: lo stesso accadde in Atene e
Sparta allorché le leggi furono chiare e di poco numero»13.
È necessario, pertanto, in un momento storico come quello che la temperie quotidiana induce a vivere –momento interessato dalla cosiddetta globalizzazione e, in sostanza, dalla cancellazione delle preziose identità tradizionali,
storiche, religiose, culturali, sociali delle comunità urbane e nazionali, con l’effetto di creare spontanee e legittime opposizioni al livellamento strisciante ed
alla massificazione subdola–, non annullare la testimonianza umana e cultu-
NOTE
rale di quell’ordinamento per poterla proiettare, pedagogicamente, nella più
ampia dimensione europea al fine di meglio apprezzare in ogni loro variegata
gradualità anche le realtà circoscritte, ricche di vivificanti umori, di cui sarebbe
delittuoso disfarsi come ciarpame, della cui facies, comunque, si conosce ogni
particolare ed ogni sia pur minima, specifica sfumatura.
La sfida, è doveroso rimarcarlo con decisione, risulta ormai chiara!
L’obiettivo da raggiungere, teleologicamente, è l’integrazione nell’Europa del
Terzo Millennio: un’era che si annuncia di già fascinosa ed accattivante sebbene, come è ovvio, d’acchito, sembri piena d’incertezze, carica d’incognite ed
angustiata da conflitti, da squilibri e differenze: «È giunta l’ora di procedere
concretamente e con fermezza ad eliminare queste differenze. L’“Europa dei
cittadini”, ipotizzata anche in sede comunitaria, acquista un suo significato
solo in questa direzione.
«In base a tale consapevolezza diciamo sì ad un mercato unico che significhi anche coesione sociale tra le varie aree della Comunità. Siamo, però,
sempre più convinti che solo la realizzazione dell’Unione Europea possa essere in grado di risolvere alla radice i tanti problemi che assillano il nostro continente. Questa, perciò, dovrà continuare ad essere la nostra prospettiva di lotta
per l’Europa»14. Ma, si può ipotizzare, che debba snodarsi sempre tenendo
presente –come specificato, più volte, in altra parte del saggio– l’impronta
indelebile della civiltà latino– cristiana.
L’Italia è stata chiamata a farne parte a tutto titolo ma, perché possa esercitare la propria funzione pleno jure, dovrà necessariamente porre in essere
dei correttivi in diversi campi della sua vita di nazione matura e civile, sia sul
piano umano che culturale, sia, ancora, su quello giuridico: non soltanto nel
modo in cui esso finora è avvenuto, su quello cioè economico-finanziario,
basato esclusivamente sulla quadratura dei conti, sull’equilibrio del dare e dell’avere, come in sostanza le è stato suggerito di agire fino ad oggi, dando
luogo a quelle sfasature che tutti lamentano, frutto, a propria volta, di questa
visione quasi manichea della realtà in cui si vive con la beffa cocente di averla posta in atto al prezzo di enormi sacrifici, per poi ritrovarsi, al termine dell’itinerario, con un sostanziale nulla di fatto: l’esperienza della moneta unica sta
lì ad ammonire i cittadini in tutta la propria nuda crudezza nonostante i trionfalismi con cui è stata accolta15.
Il cambio di rotta dovrà verificarsi, specialmente per quel che riguarda –sulla
scorta delle considerazioni dell’Antelmy, che in ciò si è rivelato un maestro– la
patologica proliferazione del numero delle leggi sebbene, per la verità, il problema sia antico ed ormai persistente. Questo, comunque, non deve indurre
alla stasi. La passività non deve essere accettata, né tanto meno tollerata, perché il tempo incalza, le prove urgono e non ci si può ancora più attardare nel
continuare a piangersi addosso o, in un moto di malinteso attivismo, a redigere obsoleti cahiers de doléance, impostandoli su di una sorta di anafora bislacca che stucchevolmente ripete: «quello che siamo, quello che eravamo». La
sfida, è opportuno ripeterlo, risulta, a questo punto, aperta! L’obiettivo da raggiungere, per l’Italia, è una integrazione intelligente, seppure il cammino, allo
stato dei fatti, si faccia sempre di più irto e difficoltoso. Però, al momento, costi-
75
tuisce di già una vittoria il discuterne ampiamente e con estrema franchezza.
DANTE, Paradiso, VI, 12.
Per la storia dell’intera Terra d’Otranto, si v., di L. CARDUCCI, Storia del Salento. La Terra
d’Otranto dalle origini ai primi del Cinquecento. Società Religione Economia Cultura, Galatina 1993.
3
A. FOSCARINI, Saggio di un catalogo bibliografico degli scrittori salentini, Lecce 1896, p.8.
4
C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani 1904, p.55.
5
Archivio Chiesa Collegiata – Ceglie Messapica, Registro dei battezzati 1758-1786, a. 1762,
p.48; Ibidem, Registro dei morti 1838-1859, a. 1851, n. 247: «Die secunda decembris 1851
Josephus de D. Cataldo Antelmy magnus in Historia, in Philosophia, ac in Jurisprudentia summus
an. 90 Sacramentis munitus placide in Domino quievit, sepultus in dicta Ecclesia» (cioè, nella
Insigne Collegiata Chiesa di Ceglie Messapica, n.d.s.).
6
G. ARDITI, Corografia fisica e storica della provincia di Terra d’Otranto, Lecce 1879, p.139.
7
C. VILLANI, op. cit., p.119.
8
Cfr., G. SCATIGNA MINGHETTI, La giustizia oggi, in “Studi Salentini”, Lecce, a.44, 1999, vol. LXXVI,
pp.167-170. Il saggio, sebbene con un titolo in realtà banalizzante, tratta, anche attraverso un breve
excursus storico-giuridico, delle scottanti problematiche inerenti, oggigiorno, la questione della giustizia in Italia ed in Europa e del vivace dibattito sviluppatosi intorno ad essa nel mentre, sulla scorta delle analisi condotte a termine dal filosofo brentaniano Oronzo Suma, ne indica la soluzione che,
più ragionevolmente, risulta accettabile nell’odierno lasso di tempo culturale e politico.
9
G. ANTELMY, Sorgenti della vera gloria, e del potere del Governo relative alla felicità de’ popoli, Napoli 1807, tomo II, pp. 147-148. Il titolo del lavoro dell’Antelmy riecheggia, molto da presso,
quasi paradigmaticamente, quello dell’opera del leccese Giuseppe Palmieri, che, come afferma A.
VALLONE, “lo esprime compiutamente, nelle idee e nello stile”: Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli, del 1787. A. VALLONE, Giuseppe Palmieri, ieri e oggi. Un salentino
in mezzo ai Lumi, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», Bari, martedì 28 agosto 1979, p.3. Dove,
con il lemma «felicità», usato dai due Autori, aristotelicamente si deve intendere una certa attività dell’anima esplicata secondo virtù, includendo in essa sia i bisogni dello spirito, cioè interiori,
che quelli esterni, ovverossia del corpo. Afferma, infatti, Aristotele: «Le leggi si pronunciano su
ogni cosa mirando o all’utilità comune a tutti o a quella di chi primeggia per virtù o in altro modo:
sicché con una sola espressione definiamo giuste le cose che procurano o mantengono la felicità o parte di essa alla comunità politica». ARISTOTELE, Ethica Nicomachea, Oxford 1957, V, 1, 1129
b4. Comunque, per un primo, ma intenso, inquadramento del pensiero –e degli autori, anche–
illuministico valga per tutti la lettura di A. VALLONE, Illuminismo salentino, in «La Gazzetta del
Mezzogiorno», Bari 19 agosto 1979, p.3.
10
G. SCATIGNA MINGHETTI, Risorgimento in Terra di Brindisi Liberali e reazionari, Ceglie
Messapico 1984, p.26 e nota 16.
11
Deliberatamente, si è omesso di riportare qui i nomi di quegli studiosi che, a partire dal
Machiavelli dei Discorsi fino a giungere allo stesso G. Palmieri delle Riflessioni, hanno nei loro
saggi preso in esame ex professo la questione delle leggi e di tutto ciò che ad essa concerne, per
due ordini di motivi: per non appesantire ulteriormente l’ordito del presente lavoro ma anche perché il loro pensiero è talmente noto e di facile reperibilità nei manuali e nei prontuari specialistici,
che non si è ravvisata l’urgenza di richiamarlo, ancora una volta, in queste pagine, all’attenzione
del lettore.
12
DANTE, Purgatorio, VI, 88-90.
13
G. ANTELMY, op. cit., t. cit., p.133.
14
F. GIGLIO, Per un’Europa credibile. Impegno politico e progettualità educativa, Roma 1989,
pp. 15-16.
15
Cfr., A. MISSIROLI, Conclusioni. Mezzo secolo di integrazione europea: una storia che continua, in AA. VV., Diventare Europei. Indicazioni di percorso per giovani cittadini, a c. del Centro
Studi di Politica Internazionale – CeSPI, intr. di A. Manzella, Roma 1999, pp. 161-181, partic. le
pp. 177-180.
1
2
76
MASSIMO CACCIARI
E L’ENIGMA DELL’OCCIDENTE
1. Europa: evoluzione di un concetto
Si può filosoficamente definire il nostro continente, tratteggiarne i confini
ideali, le molteplici peculiarità ed al contempo essere certi di aver detto qualcosa di sensato? Probabilmente no, poiché nel corso degli anni il dilemma dell’identità europea è servito solamente a far compilare dai migliori interpreti
della cultura occidentale, infinite proposte interpretative sull’argomento, ma
nessuna delle quali pienamente soddisfacente. L’unica generalizzazione che
sembra aver preso piede storicamente riguarda una intenzionale “contrapposizione” nella quale, l’Europa, mai ben definita o conosciuta geograficamente,
veniva volontariamente contrapposta ad un Oriente differente. Prendeva piede
l’idea di un’Europa che legava intimamente il suo nome alla “necessità” di
essere Occidente. Ma l’Occidente veniva, però, a designare filosoficamente
anche la terra dell’occaso, delle tenebre, del pericolo, dell’agguato ontologico.
L’Occidente, quindi, come tensione verso quel nulla originario da addomesticare grazie all’ausilio del “compromesso dialettico”.
Le considerazioni contemporanee più interessanti del “problema” Europa,
furono quelle poste in essere da pensatori del calibro di Nietzsche, Husserl,
Heidegger, Patočka, Derrida la cui linea di pensiero costeggiò da vicino la
tematica più affascinante della psicoanalisi freudiana (quella che considerava
l’Es come oscuro ma indispensabile substrato dell’esistente). La loro concezione filosofica si incentrava sulla certezza che il nostro continente traesse
sostentamento ontologico proprio dal suo apparato dialettico fittizio che conduceva dritto ad una “menzogna costituente”, ad una mancanza d’essere, ad
una vera e propria metafisica dell’assenza. In Italia, dopo il “dominio” culturale idealista di stampo crociano vicino alla cultura continentale, Massimo
Cacciari, sedotto dalla possibilità di contrapporre ad un pensiero continentale
necessitante un filosofare meridiano più legato alla contingenza d’essere,
dopo aver esaminato la crisi del pensiero negativo mitteleuropeo di fine secolo, si sofferma ad analizzare, in maniera originale, con due suoi lavori, Geofilosofia dell’Europa (1994) e L’arcipelago (1997), quelle che considera essere le declinazioni dell’Occidente. Un’accurata indagine etimologica, oltre che
storica e letteraria accompagna la stesura di questi scritti, laddove Cacciari, si
domanda se quel senso del “tramonto” che la nostra cultura porta con sé sin
nel proprio etimo e fin dalla sua origine, sia destinato ad estinguersi con la
tipologia di un’umanità del sottosuolo di dostoevskijana memoria o possa invece aspirare, ad una inaspettata “risurrezione ontologica” che parta, proprio da
NOTE
di Romualdo Rossetti
77
78
quel diffuso atteggiamento nichilista che sembra, ad una sommaria considerazione del fenomeno, il vero artefice del declino culturale contemporaneo. Ed
è, appunto, nel voler esaudire questa domanda originaria, che ci si accorge
della presenza nella cultura occidentale di un arcano ineliminabile, del cosiddetto enigma dell’Occidente che denota la peculiarità di questo “luogo” culturale sempre in perenne fermento.
L’Europa un continente in perenne contraddizione, una terra oltre la terra,
un concetto oltre il concetto, che non ha saputo o non ha potuto autolimitarsi
nel tempo. Infatti, il proprio caos circoscrivente, dovuto ad una originaria confusione di “limiti differenziali” ha denotato da sempre la peculiarità di questo
luogo. Europa “mondo” proiettato ad Occidente, abitato da gente indomita e
ribelle. Europa, grande fucina di valori ma anche immenso campo di sterminio,
dove le “differenze” si sono molto spesso decomposte al Sole rovente di una
“Verità” presunta ma non sempre suffragata da una scrupolosa analisi sostanziale.
L’Occidente come “dilemma” degno di interrogazione, ma che, proprio per
questo, non ammetterà, per il proprio contenuto problematico, nessuna generalizzazione, nessuna banalizzazione. L’Europa dovrà allora essere considerata come periculum, come esperimento da saggiare, vivere ogni volta in
maniera “differente”. La sua sarà un’entità che sfuggirà ad ogni controllo
semantico. Si è europei a volte, senza però sentirci tali, ma questa “assenza
valoriale” è dovuta probabilmente all’enorme varietà di “Europa” che
l’Occidente si trova a possedere. Ma d’altro canto, il suo spazio vitale si dimostra subito uno spazio non geometrico, non calcolabile, non riconducibile a
delle regole, a dei “confini” siano questi fisici o culturali, così come la caratterizzazione del suo demone dimora nel pólemos armonico della sua dialettica,
della sua fame di dominio. L’Europa, allora, la si può riconoscere in quell’
“Occidente-pontefice” che genera il raffronto ma a volte lo sacrifica. I suoi confini1 hanno posseduto, e posseggono tuttora, la consistenza delle dune del
deserto e come queste si spostano al soffio del vento della storia; ma nonostante questo, le sue “frontiere” sono state poste unicamente per essere varcate, attraversate.
Il suo mito narra della “scaltrezza violenta di Zeus”, degli appetiti sfrenati
e mai sazi degli eroi delle origini, dell’inganno architettato dal dio delle folgori
e del Nomos, quando celato nelle rassicuranti forme di un candito toro, riuscì
a rapire e ad abusare della “splendida” fanciulla, sotto nuove rapaci sembianze, all’ombra di un platano nell’isola di Creta, isola-crocevia dei mari: “Europa,
tragico nome. Viveva in Asia Europa, la figlia di Agenore e Telfassa. Agenore
era venuto dall’Egitto nella terra di Canaan (la stessa via di Mosè!). E qui Zeus
la rapisce sotto forma di toro, travestimento carissimo al padre degli dei, da
sempre immagine nelle civiltà mesopotamiche e nell’area semitico-anatolica
del rombo del tuono che minaccia la tempesta vicina e l’imminente scomparsa della luce. Allora soltanto la fanciulla diviene Europa, quando strappata via
dall’Asia (la cui radice forse è quella di Eos, aurora, dall’accadico asu indicante il sorgere) si fa Europa, esule, straniera, tramontante (arapu, erepu, indicano in accadico il tramonto; nel greco erebos, tenebra, ne ritroviamo forse la
NOTE
radice). Destino tragico: dall’aurora al tramonto. Ma compreso nella medesima figura! Asia è in Europa ed Europa in Asia. Della sorella scomparsa oltre
l’orizzonte Cadmo si muove alla ricerca –e Kadmos è nome sicuramente semitico (quadmu significa il primo, il più antico, la guida). Ma anch’egli, sulle tracce della sorella rapita ‘a occidente’, diviene parte integrante d’Europa: il fondatore di Tebe e lo sposo di Armonia, di colei che non annulla, ma compone i
contrasti, figlia di Ares e Afrodite, la dea di Eraclito. Quali confini è possibile
pensare di imporre a tali ‘genealogie’?”.2 Europa quindi come connubio di un
Egiziano e di una Cananea (di un africano e di una asiatica) che si costituisce
suo malgrado, gioco-forza più ad Occidente, nella grande isola centrale che
domina i mari, il cui animale simbolo, guarda caso, è il toro. Europa, sì offesa
brutalmente ma anche premiata dal destino, perché genitrice del mitico
Minosse, primo talassocrate, e madre venerata del continente di Ponente.
Europa sì come nostalgia, come rimpianto, come perdita di colei che rallegrava i cuori; ma Europa anche come, nuova avventura, nuovo corso, nuovo “inizio” che subentra alla fine.
In un’epoca dove il racconto, la descrizione per essere attendibile doveva,
per forza di cose, attenersi al M ýthos e contrastare il Lógos immemore della
moltitudine, la speculazione filosofica diveniva Hýbris da rigettare. Il principio
fu, dunque, il M ýthos inteso come “vera vox”, come entità affermantesi, ed
Ecateo lo conferma con una chiarezza ingenua che escludeva l’onnipresente
contraddizione. Ma conoscere la propria patria equivaleva, ed equivale soprattutto oggi, a conoscere se stessi. L’Europa come parte del mondo delimitata
da confini ipotizzati; ma che nessuno prima di Erotodo ha saputo stabilire con
chiarezza. Questa terra dell’Occidente che nell’insularità delle proprie Póleis
“decentra-accentra” i propri ambiti di influenza venendo a costituire l’arcipelago primordiale, quel luogo principe nel quale le “differenze” possono consistere senza insistere, possono manifestarsi senza celare nascondimento alcuno.
Non che la violenza, la brutalità, non imperi sovrana, visto che proprio a questa si deve il fermento, l’avvio del progresso occidentale. Proprio nella Hýbris
ellenica che viene dal mare si può scorgere il primo motore della cultura europea. Ma allo stesso tempo si assiste insieme alla nascita della politica, della
gestione della “cosa comune”, la genesi della curiosità, della ricerca, della
scienza, di quella particolare disciplina che condizionerà l’opera umana come
nessun’altra oserebbe fare.
Laddove i Greci arcaici non riuscirono a concepire l’Uno se non in qualità
di indistinto, di passaggio amorfo, di Chaos generante (di provenienza asiatica), si fece varco a viva forza, nella contra-posizione dei distinti, il Lógos disvelante della ricerca filosofica delle cause prime. E fu proprio il Lógos dei
sapienti ad esigere la distinzione. Tutto ciò non fece altro che aumentare il fermento, amplificare lo sgomento.
Al pólemos subentrava la stásis; e la conseguenza di ciò si manifestava nella
nascita della pólis, l’emblema costituente della nazione europea. Ma per esaminare con scrupolo indagatore, questa “invenzione” dell’Occidente, occorre
soffermarsi ad soppesare le cagioni culturali che la originarono, che per
Massimo Cacciari risedettero esclusivamente nella differenza di indole esisten-
79
80
te tra le popolazioni orientali e quelle occidentali. Il filosofo veneziano si rifà, così,
ad Eschilo, precisamente alla tragedia I Persiani nella quale compaiono sotto le
spoglie di un incubo alla regina Atossa i caratteri distintivi che differenziano
l’Europa dall’Asia: “Due donne, entrambe “di statura imponente e di incomparabile bellezza”. Ma vi era stásis (188) tra loro, che Serse, il Gran re, non riusciva
a domare. Ecco egli aggioga le due donne a un carro, come cavalle –ma l’una
accetta le briglie, docile, anzi: “fiera di quei finimenti”, mentre l’altra vi si ribella,
fa a pezzi le bardature, rompe quel giogo, sbalza Serse dal carro. La donna, che
in vesti persiane segue mansueta il suo signore, è l’Asia “ricca di genti… gregge divino”; la donna in vesti doriche è Eleutheria indomabile, la libertà greca,
suddita a nessuno. Ma la tragedia è tale proprio in quanto non le contrappone
affatto immediatamente. Una stásis è la loro, non un pólemos. Qui addirittura la
guerra che per il greco ha finito con l’essere assunta a modello del pólemos,
della guerra contro il barbaro, viene chiamata col nome della ‘guerra interiore’.
Asia ed Europa non soltanto appaiono entrambe belle e divine, ma realmente
“sorelle di sangue, della stessa stirpe”. Abitano terre diverse, ma una ne è l’origine. Questo enigma costituisce il cuore della tragedia”.3
Prende qui piede l’idea di una nazione comune d’Occidente, contraddistinta da uno stato di tensione vitale costante, in aperta opposizione alla peculiarità del modus asiatico dimorante in questo, in quella hýbris primigenia, ostile ad ogni connessione. È l’univocità a questo punto, che dispiega per il nostro
pensatore, il proprio potere illimitato contro ogni differenza, contro ogni alterità di sorta. Il senso dell’illimite unito alla magnificenza asiatica in opposizione
alla frantumazione inconciliabile, esistente al di qua del Bosforo.
Nelle terre d’Occidente invece, all’ “illimite” si contrappone il “limite”, il concetto, il giudizio tutto chiuso in sé, la Krisis generativa, l’opposizione insanabile. Ma tutto ciò anelava ad una condizione armonica essenziale nella quale gli
“opposti” potessero avere asilo con eguale dignità e disprezzo. Ma perché
potesse manifestarsi “tranquillamente” l’opposizione, occorreva stabilire un
Logos comune, nel quale il “limite” potesse coesistere nel suo opposto.
Dunque, fu nella coesistenza logica degli opposti che la curiosità epistemica si fece áskesis, si tramutò in esercizio, in abilità. Questo stato di costante
“inimicizia” presupponeva il ricorso alla parresía, a quel modo di parlar franco
che salvaguardava la speranza armonica, ma l’eleuthería greca, causa fondante della parresía diveniva, a sua volta, il presupposto fondativo della pólis
e del concetto a questa subordinato di nomos.
Eleuthería come inestinguibile connessione logica da cui si dipanava pian
piano la fallacia del mýthos: “ Dopo un tale evento, uno solo sarà il linguaggio
di colui che conosce. Quello discorsivo, del logos. E questo linguaggio dimostra che pólemos genera la molteplicità del distinto, e che proprio nel distinguersi, nella perfezione dell’atto che li distingue, i distinti si connettono. In questo Logos comune troverà la sua vera, salda radice il Nomos della città”.4
Logos, Nomos e Pólemos uniti da una radice esistenziale comune, una
radice che rimandava alla phília per la conoscenza. Il pensiero europeo che
prese le mosse dalle coste dell’Asia ionica si prestò quasi subito a scalzare ciò
che la tradizione mitica presupponeva come inamovibile. Ma proprio il “mina-
NOTE
re” le basi tradizionali della credenza senza rimanere schiacciati dall’enorme
mole della fabula, predispose il pensiero eteronomo all’uso indiscriminato
della hýbris. Abbattere il mýthos col logos equivaleva a contrapporsi allo “straniero”, all’ignoto, all’altro che era fuori e dentro noi stessi, accettando, al contempo, l’altrui peculiarità intesa come comune: “È proprio affermando la mia
differenza con l’altro, la mia singolarità, che io sono con lui –anzi: che io sto,
che stando necessariamente mi oppongo a ciò che mi sta di fronte a sua volta
(stásis), e che in questo confronto, in questa contesa, mi riconosco con lui.
L’altro diviene inseparabile Cum. La mia ‘libertà’ da lui è la mia ‘amicizia’ con
lui. Per poterlo ospitare dovrà essermi hostis”.5
Dunque, l’origine della diversità dell’ “altro” coinvolse la stessa matrice filosofica quando ci si accorse che la duttilità del conoscere derivava, quasi esclusivamente, dalle sue metabolaí, dalla potenza del suo differire. Il passaggio più
importante che la filosofia compì però non riguardò esclusivamente la sua capacità di concepire il “differire”, quanto piuttosto il convincersi che il “differire” stesso potesse permanere comunque come entità incomprensibile a qualsiasi sforzo della ragione. Quindi si fu, gioco-forza, costretti, proprio per la sfuggevolezza
del dato del conoscere, ad annettere all’atteggiamento teoretico di sophía quello eminentemente pratico di philía, visto che solamente in tal maniera si poteva
sperare di fare accesso in quella dimensione ottimale propria dell’Armonia:
“Questo è il lato enigmatico di ogni armonia: quel lato per cui essa non è risolvibile come se si trattasse del problema del medio, del metaxý, ‘pontefice’ tra gli
opposti. Se l’inseparabile mai si disvela in quanto tale, l’armonia perfetta resterà sempre aphanés, e cioè irriducibile alla dimensione dell’ente, di ciò che appare. […] L’armonia non diviene, allora, che il numero in base al quale si articola la
distanza che separa limite e illimite, acuto e grave –null’altro che un elemento,
insomma, della ‘composizione musicale’ (tale è, appunto, il cosmo creato dal
Demiurgo). Ma questo numero risulterà necessariamente altrettanto determinato di quello degli opposti, e dunque ne condividerà la natura”.6
Se perdurava la stásis nella sua irrequieta immobilità della contra-posizione, l’armonia rischiava davvero di perdere la sua potenza nascosta, finendo
con l’essere “entificata”, visto che tra l’altro, quest’ultima, non poteva essere
colta se non sensibilmente. A questo punto in Cacciari prende piede la convinzione che, se l’Europa, con l’idea di Occidente che essa ha partorito, potesse fare costante riferimento alla capacità sua intrinseca di “metabolizzare” il
reale, soltanto allora ci si avvicinerebbe ad una “idea” di sintesi degli opposti,
di armonia sostanziale, ma ciò rimane per lo più un miraggio filosofico, un
“non-luogo” della ragione che si sforza ad insistere nel collocare l’opposizione
in schemi mentali inidonei all’uso, creando il “concetto”, la presunzione di vincolare la corrispondenza. Risulta, perciò, necessario all’Occidente, “dare origine” ad un linguaggio filosofico comune, un “codice semantico” che, però, i
molti non riescono ad intendere, a decifrare, un linguaggio che per sua natura possa liberarsi del “presupposto logico” ri-congetturandolo: “Europa è interrogazione –ma lo statuto dell’interrogazione è paradossale. Essa tende intrinsecamente a revocare in dubbio ogni tradizione, ogni valore tramandato; la
verità è sempre per l’interrogazione il prodotto di una ricerca, mai il presuppo-
81
sto, e dunque il prodotto dello stesso dubbio che sistematicamente sostiene
ogni ricerca. Ma, d’altra parte, nessuna interrogazione di “muoverebbe” se
“qualcosa” non la provocasse. […] Interrogando, è come se noi ricordassimo
una perduta intimità con ciò che ancora ignoriamo: futuro passato. E l’aprirsi
di questo problema –che è il problema del linguaggio d’Europa– conduce alla
decisione: noi possiamo custodire quella perdita, quell’assenza, possiamo
fare del nostro linguaggio il suo segno –oppure, intenderlo come totalizzante
discorso, come piena, babelica presenza. Il linguaggio europeo può “decidere” di fagocitare in sé l’assenza, di “liberarsi” da quel “presupposto” che la “voz
abismatica” ci chiama ad interrogare –oppure, può concepire tutti i propri segni
(poiché segni siamo…) come ad-verba non verba “risolti” nella perfetta aderenza all’oggetto designato, ma “indici” o “immagini” dell’Adveniente che nonè, della sua assenza, del suo attuale silenzio”.7
2. Le metafore dell’Occidente. Guerra, Città, Mare ed Arcipelaghi
82
A questo punto della riflessione non ci resta che analizzare quali siano stati
i “simboli” che hanno permesso al nostro continente di estrinsecarsi nella sua
specificità. Sfogliando le pagine di Geo-filosofia dell’Europa, si intuisce subito
che, per il nostro, questi simboli risiedono soprattutto nei concetti di: “Guerra”,
“Pólis” ed in quello di “Mare” che ne richiama a sua volta un altro, l’“Arcipelago”.
“Guerra” non sempre da intendere come Pólemos, come lotta all’identificazione dell’altro da sé, come opposizione ordinata propria di un nuovo assetto
concettuale, ma “Guerra” anche come Stásis, come lotta intestina tra corrispondenti, come vile antagonismo che si ritorce contro se medesimo, contro
la peculiarità della propria identità sconosciuta, come battaglia aperta alla propria psíche, ai propri demoni. Stásis che testimoniava comunque un’azione,
ma un’azione che contemplava l’identità, dove la dialettica amico-nemico
estingueva ogni carattere esteriore di immediatezza, stásis contemplata, sì,
come “guerra civile” tra le potenze di uno stesso demone, ma anche come
inquietudine che presupponeva e rimandava ad un “ormeggio ontologico”, ad
una saldezza esistenziale di non poco conto: “Stásis è nome d’azione, della
stessa radice di “hístemi”: indica il drizzarsi, ben fermi sul posto, lo stare saldo
ed eretto, che nessun assalto potrebbe smuovere. Ma chi così forte si erge,
così saldamente si solleva, viene di necessità avvertito dagli altri come potenza ostile. Anche i venti si levano (“tôn anémon stásis”), e colpiscono chi ne
ostacola l’irrompere. Non è possibile sollevarsi in tutta la propria forza, senza
sollevarsi contro. […] Nessuna ‘perimetrazione’ di competenze e di dominii,
nessun patto veramente durevole possono bastare ad eliminare lo spettro.
Così come impossibile è eliminare quella stásis nell’anima, che ben conoscono Platone e Aristotele: continuamente un impulso si leva contro l’altro, e tutti
contro il logos, e il logos in se stesso, tra i distinti calcoli cui può dar luogo.
Ogniqualvolta una forza dell’anima giunge ad esprimersi en akmêi, giunge ad
aver forma, si spalanca il baratro della stásis”.8
Ma l’opposizione di fatto fortificava le città, ne sacralizzava i rapporti, le
NOTE
finalità, le strategie ed il politico, in qualità di gestore del potere della pólis
doveva essere per sua natura un “oppositore”, un “guerriero”, un fine stratega
predisposto a misurare attacco e difesa, coraggio e prudenza: “Il nostro guardiano è uomo di guerra e filosofo (VII, 525 b 8; VIII, 543 a 5); ma polemikós lo
è per ragioni ben più essenziali del suo compito di difesa della polis (e difesa,
come s’è visto, anche mediante l’attacco). Polemica dovrà essere la sua natura perché egli possa vincere se stesso fino al punto di possedere tutte le virtù
(VI, 485 a sgg.). Polemikós è il suo logos che convince e insieme e-duca. E
polemikós non potrà neppure essere soltanto nei confronti dei nemici esterni
e delle parti irragionevoli dell’anima, ma anche, di necessità, nei confronti dei
cattivi nella sua stessa pólis –e kakoí sono i più che abitano la pólis, e che
incessantemente tentano di fare della pólis un proprio ‘prodotto’”.9
Quindi, la politica delle origini era concepita come “strategia” e non era un
caso se Minerva, la dea della strategia, fosse anche la dea protettrice della
pólis di Atene, faro democratico dell’intera antichità.
Fu dunque la stásis, la guerra intestina, che minò l’integrità delle póleis
presentandosi come la massima negazione di ogni impegno politico. Tuttavia
il governatore della città doveva detenere quell’acume proprio del sapiente se
aspirava a condurre la cattiveria all’ordine, ed era in grado di farlo soprattutto grazie all’utilizzo mirato della dialettica, di quella disciplina del dialogare che
permetteva di fratturare la catena della bestialità, dando vita alla socialità,
ovvero all’omologazione in vista di uno scopo. Ma proprio quando il “dialettico” col suo filosofare tentava di catturare il logos dell’ente stesso, dava luogo
alla scienza del medesimo principio. Dalla diánoia si generava in questo modo
l’epistéme, che se, a sua volta, veniva presa alla lettera, rischiava di ricondurre il tutto, ancora una volta, in una dimensione esistenziale di disequilibrio in
cui la stásis ri-emergeva sovrana: “Se il filosofo sarà re e saprà convincere al
Principio non ipotetico tutti i cittadini, allora soltanto sarà: quella Sirene, in cui
risuona la stessa radice di harmé (unione), di armonia, di areíon, l’eccellente
–quella Pace che, essendo l’áriston, sarà il fine proprio dei buoni, degli áristoi.
Ma questo Fine trascende i limiti del Politico; esso attiene ai poteri della
Persuasione di cui è capace un discorso affatto meta-politico […]. I guardianifilosofi sono gli eroi della pólis, poiché è per essi che si ‘rappresentano’ aidós
e díke, quei doni divini, senza cui neppure è possibile parlare di pólis”.10
Ma in tal maniera, nasceva il quesito di come potesse venire indicato il criterio della loro paideía, del loro modo di agire per il bene comune, visto che il
vento delle passioni rischiava di travolgere l’opera stessa degli arcónti e degli
“esemplari”.
Conviene a questo punto, ai fini dell’indagine cacciariana, inoltrarsi nell’esaminare il concetto di Hýbris che la guerra civile scatenava. Hýbris equivale,
per il nostro, alla tracotanza, alla violenza oltremisura, al vero opposto di eiréne, considerato il fatto che pólemos si esplicava quasi sempre naturalmente in
un contesto di dichiarata inimicizia, dove l’antagonista era circoscritto da una
serie di “ragionevolezze”, di determinazioni particolari che lo rendevano
“degno” di contrapposizione. Ma la hýbris partorita dalla stásis dei “simili” caricava in sé la massima distruttività e perfidia; tanto da assomigliare a quell’e-
83
84
ruzione vulcanica alla quale seguiva immancabilmente un disastroso sommovimento tellurico di vasta portata.
Detto questo, occorre però chiarire, che tale suddivisione gnoseologica esistente tra i rispettivi concetti di stásis e pólemos non fu sempre presente nelle
narrazioni degli antichi. Nei resoconti tucididei, ad esempio, i due termini esistevano come indefiniti: “Ma il realismo tucidideo non separa in alcun modo,
principialmente, stásis da pólemos. Se consideriamo le due forme di guerra nel
grande complesso dell’opera, esse si presentano indissolubilmente intrecciate.
[…] ma pólemos può generare stásis soltanto perché ha già in sé quella h_bris
che giunge alla sua ‘perfezione’ in quest’ultima. Il più freddo e sobrio discorso
di guerra, il più calcolato, il più lontano da ogni “tólma… alógistos”, irragionevole audacia, sta sempre in ‘tremendo dialogo’ con la violenza devastante, “finché la phýsis degli uomini resterà quella che è” (Tucidide III, 82, 2)”.11
Il resoconto di tutto ciò risiede nel famoso discorso che gli ambasciatori ateniesi rivolsero ai Meli, laddove tale ragionamento detenne l’ambizione di valere universalmente non solo dinanzi agli uomini ma, addirittura, dinanzi all’intero Pántheon divino. La tragicità di tale discorso concernette, per Cacciari, non
tanto la scelta delle parole in esso contenute, quanto piuttosto il ritmo del loro
ammonimento, e fu proprio questa particolare caratterizzazione che lo distinse
anche da qualsivoglia esortazione sofistica. Tale ragionamento verbale non
pretese di riabilitare alcun modus di supremazia politica, ma, peggio ancora,
operò l’universale, creò l’idea di incontrovertibilità logica. Diede forma, in parole povere, all’idea di giustezza inalienabile, di assodato veritiero. Gli Ateniesi
“forti” del loro Logos comune non si scomposero minimamente dinanzi le altrettanto motivate ragioni dei Meli, ma pazientemente le controbatterono generando così un’idea di inviolabilità argomentativa: “I Meli cercano impazientemente,
di persuadere gli ateniesi che essi si muovono ingiustamente, fuori da Dike, e
che tutto il loro argomentare non è, diremmo, che ‘ideologia’ –ma gli ateniesi,
pazientemente, ribattono che dalla loro parte non sta semplicemente la ragione del più forte, ma lo stesso Nomos divino, che, in realtà sono essi ad obbedirvi, mentre i Meli pretenderebbero follemente di ribellarvisi. Sono gli spartani,
semmai, quelli che stimano bello ciò che piace e giusto ciò che giova (V, 105,
4)! Gli Ateniesi seguono, invece, il logos comune a tutti i desti, fondato sulla
necessaria natura delle cose umane e divine. Questo logos afferma, per sempre, che non bisogna opporsi a chi è di gran lunga più forte (V, 101), che è folle
anteporre il suono e la seduzione delle parole alla salvezza dell’unica patria (e
cioè che la parola non può essere scambiata con la cosa), che ciò che è presente e visibile è più saldo e sicuro di ogni speranza o desiderio, che il saggio
non fa conto su t ýche ma sulla propria areté ”.12
La hýbris consisteva, dunque, essenzialmente nella pretesa logica ellenica
di armonizzare la dissimilarietà, di collegare ciò che poteva rimanere distinto,
tant’è vero che il cronista Senofonte attesterà i massacri operati dai suoi conterranei a discapito dei “differenti” loro confinanti. E tali eccidi erano stati perpetuati non seguendo delle passionali vendette, quanto proprio per appagare
quella hýbris primigenia. Una hýbris dettata proprio da quella sorta di “illuminismo” del logos greco.
NOTE
Ma vi fu anche un altro fattore determinante che ha contraddistinto l’idea di
Europa per Massimo Cacciari. Questo fattore lo si può facilmente scorgere in
quell’elemento naturale che ha lambito le sponde frastagliate delle penisole ed
ha circoscritto le isole le une dinanzi alle altre, un elemento amato e odiato,
rispettato e sopraffatto, il “Mare”: “Ma il Mare –che cosa ri-vela questo suo
nome, questo nome, Mare, che il Greco ignorava? Lo ignorava forse proprio
perché proveniente dalla radice– mar che indica il morire, dal sanscrito maru,
che significa l’infecondo deserto? O non ci verrà esso, piuttosto proprio dal
‘fondo’ mediterraneo, pelagico? Mare è l’ebraico mar, è l’accadico marru: è il
sapore salmastro di Thálassa. È l’amaro della sua onda. È l’antico, mediterraneo nome di háls”.13
Europa da intendere, allora, non solamente come complesso di terre
d’Occidente, ma come “terra del mare” comprensiva di un “mare delle terre”.
Il Mediterraneo come “via maestra” da percorrere per conoscere l’enigma
temibile, l’arcano indispensabile da dominare, se si voleva riuscire a risolvere
la propria segregazione culturale: “Inizia qui, tra filosofia e mare, un difficile
rapporto. Da un lato, è proprio la filosofia a mettere in luce quel ‘tremendo’,
quel ‘periculosum maxime’ del mare, che sta a cuore della historía di Tucidide,
ma che già colpiva in Erodoto. Dall’altro, la filosofia non può condividere quella ‘demonizzazione’ della potenza del mare e sul mare che s’incontrerà in
Isocrate, ma che è già esplicita, come s’è visto, nello Pseudo-Senofonte. La
filosofia non può condividere la hýbris della talassocrazia, ma non può non
condividerne la forza sradicante. La filosofia deve ‘salpare’ da ogni dóxa, da
ogni Nomos acquisito solo per forza di tradizione –ma, ad un tempo, e con
tutte le sue energie, contrastare l’equivalenza tra giusto e utile, tra giusto semplice equilibrio di potenza, tra giusto e effettuale”.14
Il mare, considerato oltre la sua fisicità, come “metodo”, come “via”, come
“scelta” migliore, se è vero che ciò che gli Elleni talassocrati ricercavano altro
non fu che il tanto richiesto dominio del metodo, la loro ricerca finiva per essere intesa come autentica téchne nautiké, “strumentario” necessario alla noesis.
Il mare come “via d’incontri”, “via di significati”, “via di linguaggi”. Il mare
che rendeva le póleis vitali. Ed il pericolo potenziale che poteva giungere da
questo, in fin dei conti, valeva bene la pena di essere corso, sia pure con
estrema prudenza: “Dolce appare la sua vicinanza, giorno per giorno, ma salata e amara può risultare in realtà, poiché, attraverso i traffici e gli affari, fa
nascere nei cittadini costumi incostanti, non degni di fede (“éthe palímbola kaì
ápista”, Leggi, IV, 705 a). Essere sul mare, ben forniti di porti, significa accogliere “una disordinata varietà di costumi cattivi” (704 a 8), rafforzare o, addirittura, creare l’ápistos dêmos”.15
Ma a questo punto ci si può allora oggi chiedere, come abbiano fatto le
póleis a sopravvivere a loro stesse? Come si è potuta condividere, dall’interno, la stessa struttura della pólis? La risposta non può essere che quella che
ci rimanda al concetto di armonia, quest’ultima, però, non intesa come il frutto
rigoroso di un processo di pace, anzi sembrerebbe qui più veritiero affermare
il “contrario”, ovvero, il senso della “contesa”, del contrasto.
Solamente con la contesa si poteva riuscire a produrre armonia, ma quella
85
86
che concerneva l’éthos della pólis, non era il semplice prodotto della connessione dialettica degli opposti, semmai era la necessaria relazione di questa
connessione. Fu la guerra la “grande madre” che mise in rapporto gli enti differenti. Fu il conflitto che permise il confronto, il progresso. È un dato di fatto,
oggi, che nella pólis siano esistite le differenze, ma è altrettanto credibile che
queste poterono entrare in relazione grazie ad una connessione armonica.
L’armonia risultava indispensabile per richiamare alla mente la contraddizione
della pólis, considerato il fatto che solamente nella contesa presente in quest’ultima i distinti potevano accostarsi, entrare in rapporto. Fu la differenziazione assoluta ad esprimersi nell’idea di nemico, di diverso, di straniero; solamente in questa maniera poteva prospettarsi una vera comunione d’intenti dei
simili: “Nel Cum, nello Xynón esso è davvero tenuto dalla stessa “kraterà
Anánke” che lo individua. Proprio al fondo della distinzione si rivela la più profonda connessione. Ma nel cuore della distinzione sta anche la possibilità della
separazione”.16
Ma la singolarità si poteva manifestare solo dove veniva ad esistere la
distinzione, la differenza dell’altro, ma l’altro non risultava mai in quiete, non si
dimostrava mai statico bensì in perenne movimento, in perenne divenire. Era
sempre in fuga verso qualche “altrove” e spesso fuggiva anche da sé stesso
ed era sempre in procinto di separarsi, di distinguersi.
E fu a causa di questo dinamismo sfrenato che i nemici si contemplarono,
si osservarono vicendevolmente. Essi ebbero bisogno delle altrui verità, e fu
proprio l’éthos che testimoniò la mancanza della verità, ed in ultima analisi la
nullità della polis. Si assistette, così, ad un naufragio linguistico e di costumi
(che permane ancora oggi) che risultò, però, necessario alla stessa definizione del “dicibile”.
Sentirsi europeo al momento, per Cacciari, equivale a fare esperienza di
quel naufragio culturale, nelle sue forme molteplici e contraddittorie: “È quello
della parola perfettamente definita e limpida nella sua disperazione, che sa
riconoscere come costitutivo del suo dire lo stesso silenzio del naufragio.
L’essenziale non sta nell’evitarlo, nell’esorcizzarlo, ma nel ripeterlo diversamente, sempre in nuovi luoghi, come sempre diverse sono le risposte poiché
sempre diverso è il problema”.17
Così, solo quando la pólis cessava, nei suoi confini venivano a convergere le differenze. Fu allora che si costituì il suo éthos dinamico, ed fu proprio
per questo che le póleis si “aprirono” al mondo. Queste non possedevano
porte, ma, come città-isole, erano provviste solo di “ponti” che si gettavano su
quello stesso mare tanto temuto e venerato nell’antichità. Il mare come ponte,
come collegamento tra terre diverse, il mare come il più indispensabile ed al
tempo stesso pericoloso dei passaggi tracciati dall’uomo nell’arco della sua
storia. Dal mare, come ci ricorda il nostro, non spuntavano né la vite né l’ulivo, ma le isole, l’insieme del mondo conoscibile, che dava loro possibilità di
attecchimento. Il mare non risultava, dunque, astrattamente separato dalla
terra, ma ne generava i contorni e ne permetteva la definizione possibile. Era
come se questi elementi primordiali si richiamassero l’uno l’altro per un’inguaribile nostalgia d’essere. La veracità del mare si svelava laddove la si conce-
NOTE
piva come il “luogo” della relazione, del dialogo, del confronto tra le molteplici
differenze che lo abitavano. La peculiarità fondamentale dell’Europa era determinata proprio dall’insularità delle sue terre, era essa stessa l’archi-pelagos
per eccellenza che decentrava-accentrava i costumi, i confini e le convinzioni:
“E tuttavia, inevitabilmente, insorge sempre di nuovo anche la nostalgia, o la
seduzione del Centro, la volontà di “guarire” la malattia europea riedificandone lo spazio intorno a uno stabile, visibile Asse. L’Arcipelago europeo esiste in
forza di tale duplice pericolo: risolversi in spazio gerarchicamente ordinato
–dissolversi in individualità inospitali, “idiote”, incapaci di ricercarsi e richiamarsi, in parti che nulla hanno più da spartire tra loro. Nell’Arcipelago, invece,
città davvero autonome vivono in perenne navigazione le une versus-contra le
altre, in indispensabile distinzione. Ma quel duplice pericolo ne è costitutivo
comunque dell’essenza. Non v’è cammino nell’arcipelago senza Scilla e
Cariddi, senza rupi Simplegadi. La fine del pericolo non sarebbe che la fine del
póros, del cammino d’Europa, del suo ex-periri, della sua esperienza”.18
3. Il Verbo e l’Agnello:
il cristianesimo come “Veritas indaganda”
Il carattere che ha maggiormente contraddistinto l’Europa, oltre agli altri
già menzionati, è stato indubbiamente quello che ha acconsentito l’attecchimento di un “verbo rivelato”19, vero Skandalon della ragione classicamente
intesa, il quale, da un lato, ha preteso di cancellare le altrui certezze e, dall’altro, si è rigenerato nel corso dei secoli, proprio grazie a quella sua intrinseca contraddizione logico-filosofica. Ma tale presunta “inconciliabilità” razionale
che in questa visione alberga non è classificabile come una sorta di “contraddizione” utilitaristica, anzi la coerenza dottrinaria del cristianesimo è massima,
dogmatica. La “contraddizione” risulta essere prettamente logica poiché sottintende la “possibilità-certezza” dell’impossibile.
Per accogliere il Verbo incarnato, non basta la sola capacità comprensiva
dell’essere, che sostiene, ad esempio, qualsiasi dimostrazione scientifica.
Accettare il Verbo come verità incontrovertibile significa aprirsi all’alterità, al
non-ancora-contraddistinto, all’eccezione che sfugge alle regole, sia pur utili
ad una sua propagazione, allo scandalo dell’Altissimo che si fa servo, del
Signore che si sacrifica, si fa agnello: “L’agnello di Dio (“ó α′µυòς του′ Θεου′”:
ma l’aramaico talja vale sia agnus che puer-servus!) ”20. Il cristianesimo allora
da intendere come quella religione che meglio di altre ha saputo porsi, ed al
contempo, opporsi ad Occidente: “La superiorità della religione cristiana non
sta in un suo pieno ‘possesso’ della Verità, nella Offenbarung, nel rendereaperto il mistero, ma proprio nel saperne, attraverso il Logos, l’inattingibilità. E
ciò deve diventare comune, perché pace si dia: sapere che nessuna rappresentazione della Verità è la Verità, sapere che nessuna onto-teologia può valere come scientia dei, quel sapere, cioè, di Dio, identico al sapere che Dio ha
in sé, Scientia superiore alla stessa scientia beatorum (quest’ultima uguale
87
88
alla visio facialis Dei, e perciò ancora costretta nei limiti della relazione tra soggetto e oggetto)”.21
Avvicinandosi alle tesi del Cusano, Cacciari è convinto che l’Europa, come
l’Asia del resto, sia, per sua natura, quel “luogo” culturale nel quale il Logos
si è interrogato sulla mondanità e l’ultramondanità dell’essere, creando il discorso teologico.
Ed è obbligo formativo soffermarsi, a questo punto, sulla riconsiderazione
filosofica di quella figura biblica, Giobbe, che risulta essenziale per riuscire a
decifrare la persuasione umana di poter colloquiare col divino. Si esamina, in
questo contesto, il cosiddetto “urlo di Giobbe”, il grido di un uomo pio giustamente disperato per le proprie disgrazie, un urlo “che spezza il silenzio e inaugura questa avventura inaudita che è il pensare e il parlare di Dio”.22
L’urlo di Giobbe, lacerando il silenzio di Dio, dava così origine al discorso
teologico, a quell’indispensabile inutilità di circoscrizione del divino. Ma nel
momento stesso in cui questa “pretesa” veniva a crearsi, difettava, peccava,
poiché tentava di costringere Dio al colloquio, ad un rapporto interpersonale
arbitrato dalle sole regole dell’uomo. Nonostante questo, la teologia, tradizionalmente intesa, credette di detenere la vocazione di parlare di Dio, ma anche
quella più tendenziosa, che la vedeva intenta ad interloquire direttamente con
“Lui”. E fu proprio per questo, secondo Cacciari, che con Giobbe, la teologia
autocostituendosi venne meno. L’urlo di Giobbe stabilirebbe tutt’al più un colloquio col “Nulla”, inteso come “silenzio tragico divino”, anche se questo “Nulla”
non va pensato nihilisticamente come “assenza di verbo”, quanto piuttosto
come una specie di “silenzio risonante” che, proprio perché risonante custodisce in sé l’inesprimibile: “Il Dio nascosto è il Dio non condannato alla parola, a
dover rispondere. Se l’idolo non disvela-risponde è la sua fine, poiché esso è
nulla fuori della parola piena. Ma il Dio nascosto è quello che custodisce puro
il possibile, la le- the da cui proviene ogni memoria, il silenzio che è fonte di parola […], che si affida ad un’attesa che nulla attende, nulla richiede”.23
Il “silenzio di Dio” rischiava così di naufragare nel suo “nulla revocante” poiché la parola della “creatura”, proprio perché “subordinata”, era destinata a
non colloquiare con Dio. L’uomo, però, era in grado di poter violare il silenzio
divino soltanto se si dimostrava capace di contrapporsi a Dio stesso, dando
origine in tal maniera ad una propria alternativa. Questa “decisione”, questo
“azzardo” ontologico non liberava, tuttavia, unicamente l’uomo da Dio, ma liberava anche il Creatore dalla sua creatura. E fu proprio a causa di questa “libera scissione” che l’umanità tentò di ri-dialogare con l’ “Altro” che non sentì più
proprio ma che desiderava nuovamente “possedere”. Da questa ricerca di
dominio si originarono nuovamente tutti i presupposti del ritorno, si ri-organizzarono le leggi, si ri-allacciò un’altra volta l’ancestrale legame.
La fede cristiana, per questo motivo, è per il filosofo veneziano: “Sì, certezza, ma certezza di un Annuncio che rimane angosciosamente rivolto
all’Inizio e alla Fine: un Annuncio che non risolve nella sua Parola l’Inizio (ma
la cui parola è nell’Inizio), e che promette salvezza senza poterla anticipare, o
pre-comprendere. È una fede che geme nell’attesa”.24
La Rivelazione cristiana in qualità di Veritas indaganda pose sin da proprio
NOTE
Inizio una serie interminabile di interrogativi concernenti il suo fondamento. Fu
Skandalon, fu sfida estrema alle certezze poste dalla mente. Il suo asse costitutivo poteva essere un “eterno rinnovarsi” che, seppur agendo nel tempo, lo
travalicava naturalmente: “La passione del Figlio può per questo apparire
come drâma di tutte le Età del Mondo: l’istante del loro manifestarsi come
assolutamente distinte e in ciò inseparabili. In essa ‘giocano’: la nostalgia del
Passato eterno di ogni sofferenza, l’immediato abbattersi della sofferenza sul
servo, come ordine cosmico, segno di Ananke; la catarsi tragica del dolore (tra
il Pais-doûlos veterotestamentario e il Figlio sta anche l’Eroe); l’agonia stessa
del Figlio, che consiste nel perfetto donarsi al fuoco della distinzione; il Futuro
eterno che questo donarsi eternamente spera e crede e ama. Nel Figlio, ambitus omnium, queste dimensioni si manifestano e configgono, non pervengono
ad alcuna rassicurante pace –poiché la loro Quies costituisce appunto quell’eterno Futuro– ma a distinguersi assolutamente, e a non essere così che in
forza della loro distinzione. Il carattere aionico di ciascuna si compie nell’Aión
della loro stessa relazione”.25
Tale fede, per questo, ha bisogno non solo di una sequela inesauribile di
quesiti, ma anche di altrettante enigmatiche risposte. Ha avuto sì il “potere” di
dare fondamento, di istituire un’assemblea di comuni, ma ha anche ricevuto la
capacità di riconvertirsi alla domanda principale, a quel quesito che testimonia
l’Esistente. Ma per far ciò ha dovuto servirsi di un logos comune, anche se
“diverso”, un logos che ha forgiato nel corso dei secoli lo “Spirito
dell’Occidente”, sia pur nelle onnipresenti contraddizioni che ne hanno denotato la peculiarità.
Un logos che ha preannunciato sin dal suo esordio una ri-conversione radicale degli intenti: “La mente può giungere alla contemplazione
dell’Incondizionato e lì sussistere in pace; la conversione cristiana, invece,
appare autentica soltanto nel suo rinnovarsi incessante, nel tempo. È come se
essa non eliminasse il dubbio, ma, all’opposto, se ne alimentasse.
Presupposto del nostro discorso è, insomma, che pensare la Cristianità significa comprendere il senso del suo essere-in-questione, e cioè, anzitutto,
affrontare quelle domande che, producendosi dalla sua stessa storia, pretendono, ad un tempo, di costituirne il giudizio, la “crisi”, il compimento. Solo di
fronte alla sfida che esse rappresentano, sarà possibile chiedersi quale “riconversione” della Cristianità al cristianesimo sia oggi ancora pensabile”.26
Il cristianesimo, stando a queste attestazioni, può essere considerato come
la sola religione che ha tratto, e trae ancor oggi la sua linfa vitale, proprio da
quel “dubbio” che sembrava cingerla costantemente d’assedio.
E così, in un contesto nuovo e diverso, dove l’incomprensibile si fa lettera,
discorso, testimonianza, si assiste all’abbandono dell’Ineffabile nella sua possibilità di essere uomo e la Kenosi del divino si concretizza nello spasimo dell’agonia del Dio sofferente sul Golgota27, nella miseria del Creatore che si dona
per amore alla particolarità dei suoi carnefici sotto “mentite spoglie” di creatura. E a cosa può mai essere servita l’invocazione del Figlio “Elì, Elì, lemá
sabactani? ”se non a testimoniare la riduzione di Dio allo stato profano? Alla
cosiddetta secolarizzazione dell’ultramondano?
89
90
La disperazione del Figlio sulla croce apriva un baratro nella storia dell’uomo, un baratro dentro il quale sprofondavano le certezze della ragione ellenisticamente intesa: “Nelle potentissime urla di Cristo irrompe l’incommensurabile dolore per l’abbandono: il Padre lascia che il Figlio diventi storicamente
suo Figlio, liberandolo dalla sua amorevole protezione. Cosicché, Dio si fa
uomo e si storicizza incarnandosi nella creatura. Ma è un uomo, il Dio fattosi
saeculum, che pare non comprendere il senso estremo di tale abbandono. Un
uomo che avverte l’angoscia filiale e che la esprime ricolmando di gemiti inimmaginabili la lontananza che si è spalancata tra la croce e il Padre, tra la storia e l’eterno. Solo e agonizzante, deriso e umiliato, sacrificato e annientato,
Cristo fa così esperienza del nulla”.28
Il “Nulla”, in questo contesto, tornava così, trionfalmente, a farsi carico dell’esistenza, pareva sovrastare il Figlio che nudo, deriso, percosso pendeva
annientato dalla croce. La meraviglia dimorava precisamente nella sottrazione
del Padre dal Figlio nel momento cruciale del trapasso, laddove, nella solitudine kenotica del Cristo, l’umanità cercava di far ritorno nuovamente al Padre.
Fu questo lo Skandalon che investì la rappresentazione primigenia del Dio
morente.
Ma la “morte di Dio” poteva testimoniare anche dell’altro, era in grado di
attestare, come sostenne poi Nietzsche, la putrefazione di un’idea, di un
costrutto dialettico tutto occidentale, ma al contempo poteva anche documentare la possibilità di una nuova rifondazione del discorso teologico: “Il cristianesimo fa del ‘Dio è morto’ il cardine di una nuova teo-logia, di una nuova
affermazione del soprasensibile –come atterrito di fronte all’immagine della
sua stessa audacia (l’idea di dio messo a morte dall’uomo!), strappa di nuovo
all’uomo la parola, ne ipostatizza di nuovo il logos. Non per questo il ‘Dio è
morto’ viene dimenticato, ma esso sembra compiersi nel destino che conduce
all’‘ultimo uomo’, al mercato, dove la ricerca di dio non è che dei folli e non
suscita che riso, oppure nelle rassegnate, consolatorie, abitudinarie forme di
una morale: sono queste le due facce della ‘eutanasia del cristianesimo’”.29
Tuttavia, per rimanere criticamente saldi nell’alveo problematico della
Cristianità, è opportuno soffermarsi ad esaminare con scrupolo investigativo la
frase-oltraggio “Dio è morto” che sembrò, e sembra tuttora, essere tanto in
auge nella cultura e nel pensiero dell’ ultimo Occidente. Un’espressione che i
più hanno denunciato come fuorviante e tendenziosa, un’affermazione che
avrebbe il potere di trascinare l’umanità nel caos di un nihilismo teso a sminuire e a vanificare la religiosità e la sacralità morale dell’uomo contemporaneo. Ma accusare Nietzsche od altri di “deicidio” intellettuale, non farebbe altro
che condannare la stessa Cristianità, la stessa Occidentalità a subire una
“verità” estranea, che non le è mai appartenuta pienamente: “La sentenza ‘Dio
è morto’, non esprime la constatazione di un fatto, ma l’attualità di un pensiero che ne pone la trasformabilità –non indica un assoluto, su cui nulla di nuovo
l’uomo potrebbe, ma, anzi, la completa disponibilità per l’uomo della totalità
degli enti. ‘Dio è morto’ significa: Dio è divenuto Spirito, Geist, principio della
contraddizione che supera ogni astratta identità e che in tale processo sussiste come la verità delle differenze. […] Divenuto Spirito, Dio è conosciuto; nel
NOTE
discorso che pone la sostanza come processo, nella identità di concetto e
tempo, la fede si invera definitivamente. E la filosofia si fa teo-sofia (ben più
che teo-logia; in quest’ultima, infatti, non potrà mancare la consapevolezza
dolorosa della differenza insuperabile tra il suo logos e il Logos che, nella sua
stessa ricerca, testimonia)”.30
Ciò che più affascina, a questo punto dell’indagine cacciariana, è il considerare come un’affermazione particolare, come quella nietzscheana possa, in
questo contesto, rimandare a tutt’altro, all’“antagonista” per eccellenza, ad
Hegel appunto, a quella mente filosofica più irruente ed “europea” che
l’Occidente abbia mai generato.
I due (Nietzsche ed Hegel), tradizionalmente considerati dalla storiografia
filosofica come “contrari”, “discordanti” perfettamente, in questo contesto, si
possono accomunare, grazie proprio a quel loro limpido e distinguibile
Pólemos, che non fa altro che avvalorare le asserzioni del Cacciari, soprattutto quando questi insiste nell’affermare la “nobiltà d’intenti dei opposti” e la
“subdola quiete degli identici” che la cultura occidentale ha cercato ipocritamente di sbandierare al mondo intero come moralmente conveniente.
Così, l’attestazione cacciariana della trasfigurazione di Dio nel Geist non fa
altro che rimandare all’intera opera hegeliana che, con le sue insidie dialettiche, rischiava di “intrappolare” la stessa logica cristiana nelle molteplici traslazioni che la sua metafora poteva fornire, tant’è vero che per Hegel la stessa
assolutezza del cristianesimo si dimostrava inconfutabile proprio per il fatto
che si rendeva “Parabola”, “Discorso”, “Evento”. Ma l’opera di Hegel, secondo
il nostro, può condurre, se esaminata approfonditamente nell’ambito di una
dichiarata miscredenza, nella quale si può assistere ad una transvalutazione
ontologica delle stesse figure della tradizione, proprio quando Hegel prospetta il progetto di un’età del Figlio, in cui l’eletto possa superare la “signoria” del
Padre tramite il ricorso costante al Logos: “Non basta affermare che il regno è
in noi, cresce in noi, s’incarna nelle contraddizioni della nostra storia “salvandole” dalla occasionalità e dalla comprensione intellettuale astratta, per eliminare ogni esteriorità, ogni Signoria dell’al di là. Da qui inizia soltanto il balzo
che Hegel, implicitamente, compie nella miscredenza! Il dogma dell’incarnazione, il Logos cristiano superano sì la figura del Signore come incomprensibile prepotenza nei confronti della potenza del nostro spirito, “trasformandolo”
nel Padre che com-patisce e lascia a noi di essere suoi perfetti eredi –ma mai,
per l’intrinseca logica del discorso hegeliano, potrebbero permettere il pieno
superamento della figura del Servo. Il Servo rimane tale anche se com-patito
e liberato; il Servo è confermato nella sua condizione allorché è fatto erede.
Il Servo rimane necessariamente servo finché non si libera da sé. Egli è
costretto perciò a rifiutare il dono della kenosi divina”.31
Cosicché, fino a quando è mantenuta qualsivoglia “subordinazione” dinanzi al dono del Padre, il “Regno” non può dirsi dell’uomo, poiché quest’ultimo
non può definirsi integralmente libero dall’ autorità celeste. Si manifesta addirittura, in proposito, la possibilità di un rovesciamento dottrinario, se è vero che
in questa prospettiva risulterebbe addirittura auspicabile il ricorso ad una
“sorta di trasgressione fideistica”, ad una vera e propria negazione logica, ad
91
92
un rifiuto preordinante l’Annuncio: “L’‘eletto’, anzi, deve trasgredire il comandamento semplicemente imposto, per affermarsi, prima, degno di ereditare il
Regno e, poi, di riprodurlo da sé. La dialettica del ‘peccato’ è essenziale per
dar vita a questo processo, per eliminare nel Padre ogni tratto di signoria e
dominio. Ma il compimento di tale processo rimane indispensabile nell’ambito
del giudaismo, mentre costituisce, per una teosofia di stampo hegeliano, la
quintessenza dell’Annuncio. […] Nessun’opera in sé potrebbe avere valore, se
non si manifestasse come soppressione dell’essere servile e dunque del
Signore che la ha imposta. Nessun’opera ci ‘libera’, se i suoi tempi e le sue
forme ci vengono dettati; se essa è chiamata a rispettare condizioni e limiti che
non derivano dalla sua stessa volontà, dalla sua immanente ragione, essa
allontanerà, non realizzerà il Regno”.32
Ma il cristianesimo in veste di Veritas indaganda, verità che custodisce gelosamente nella sua essenza più profonda la necessità dell’indagine, è assolutamente inconcepibile al di fuori dell’idea di Occidente, tanto che i due termini
Europa e Cristianità risultano essere, in tutto e per tutto, equipollenti. Tuttavia,
se è vero che il cristianesimo si è posto, e si pone tuttora, nella continuità temporale dell’opera dell’uomo, risulta altrettanto indubitabile, il fatto che questo
particolarissimo fenomeno religioso si sia fatto carico delle innumerevoli imperfezioni, delle svariate contraddizioni logiche e morali, delle tante debolezze dell’umanità, al fine di testimoniare la presenza reale del Figlio nella storia.
Così, affinché si possa attendere serenamente il ritorno del Regno tanto
auspicato, occorrerebbe essere in grado di rintracciare la necessità perduta
della relazione con l’Altro, anche di là da qualsiasi modello di rapporto logicoconciliativo, soprattutto quando si è consapevoli del fatto che la contraddizione
permane e si rinforza proprio nella dialettica cristiana, quando afferma che il
Regno, la Gerusalemme Celeste è degli infimi, dei reietti, degli ultimi, dei disperati. Tanto da non far risultare difficile scorgere nelle “beatitudini” la possibilità
concreta della riconversione, della sovversione, della debolezza congenita di
ogni regola etica dell’uomo. E chi meglio del povero conosce ed apprezza le
“ricchezze” del creato, chi meglio del reietto, del “diverso” riesce ad abbandonarsi all’Assoluto, donando altruisticamente la sua particolarità, la sua essenzialità: “Il povero, il vero nudo, esprime il perfetto abbandono, e lo patisce in
tutto sé stesso (se non lo patisse sarebbe “il contemplante”, estraneo al mondo,
e non il suo sale), e tuttavia nulla chiede, nulla pretende, da nessuna “offerta”
dipende. Non lotta per il riconoscimento, non cerca di imporre la sua volontà.
Non accoglie altro dono che quello di potersi donare. Ma il dono è perfetto, perfettamente fine a se stesso, quando è rivolto all’assente, all’invisibile, a colui
che ci ha abbandonato o che è nell’impossibilità di riconoscerci”.33
Il povero, quindi, si manifesta come eschaton, poiché si dona gratuitamente all’assente che sente presente: “Il povero si afferma, esiste compiutamente, al culmine della lacerazione; fonda la communitas come comunione con
l’Altro, e il dono che di sé egli fa è l’alimento della comunione”.34
Il Cum risulta affermabile tra chi non è mai stato congiunto, laddove potrà
non determinarsi in identità e così valere in eterno. Ma, una volta stabilito questo, permane nell’uomo europeo l’enigma logico riguardante l’avvento del
NOTE
“Regno”, visto che la dialettica della tradizione mal si è prestata a concepire
l’inconcepibile. Malgrado questo, l’uomo occidentale con la sua ragione, con i
suoi “poco plastici” schemi mentali ricerca, si interroga, ipotizza, discute,
annienta; ed il frutto della sua indagine si “ri-vela”, “gioca” con la stupida arroganza specifica della creatura, si “ri-cripta” in quel “Nulla partoriente” che per
sua natura rimanda logicamente al divino. Ed è proprio questa la maxima
culpa della modernità, che si evidenzia nella solerzia di intendere altro se non
il “necessario”, il “possibile”, ciò che la lingua può pronunciare e la mente
assolvere. La vera colpa della speculazione occidentale risiede nella difficoltà
logica di “tollerare” la concreta possibilità dell’impossibile: “ Solo un Logos che
custodisca tutte le distanze tra parola e ascolto, ascolto e silenzio, parola e
giudizio, e tra tutte le dimensioni della parola –che sia “salvezza” di ogni contra-dizione, che non pretenda di risolverle in giudizio: solo un tale Logos può
significare l’evento del Regno. […] Non vi è qui alcuna contraddizione, se
riusciamo a pensare il compimento come in sé tragico. La Parola è stata pronunciata e si è incarnata nella figura di un vero nudo, di un perfetto povero; il
tempo, dunque, è pieno. E nello stesso tempo si mostra l’im-possibilità del
compimento. Si badi: non il suo “non-ancora”, ma la sua radicale impossibilità. Il compimento è, ad un tempo, realissimo (questa Parola, questa figura in
carne ed ossa che la rivela) e im-possibile. Nel compimento si dà l’infinita
distanza tra l’evento della Parola che lo manifesta e qualsiasi misura di umana
possibilità. Ma l’im-possibile di cui qui si parla non è astrattamente la negazione della possibilità, bensì il suo eschaton”.35
L’im-possibile, in fin dei conti, può essere ciò che rappresenta più adeguatamente, al contempo, il medesimo e l’altro da sé, la regola e l’eccezione, la
correttezza ed il paradosso. È, in poche parole, il compimento che si “mostra”,
il fine al quale tende ogni parola, ogni silenzio. Esso risulta essere impronunciabile ma “pretende” la menzione e la preghiera attende specificamente questo fine. È la contraddizione delle direzioni, la “croce” che testimonia l’inconciliabilità assoluta di due direzione in essa intersecabili.
La speranza cristiana del “ritorno dalla morte” testimonia l’ultimo atto di un
dramma logico non ancora del tutto consumato ma che segna costantemente
il cammino dell’uomo: “Finché la morte non è ‘messa a morte’ nel Pleroma
della Vita intradivina (che in sé la comprende e da sé la manifesta), l’uomo può
ancora concepirla autonomamente, anzi, come ultima potenza. Questa convinzione (questo esser vinto dalla morte) spiega la potenza del sacrificio; l’uomo non può liberarsene se non vedendo in verità il Logos che muore, proprio
il Logos che è Dio; ma questo atto non dipende in nessun modo dal suo esserne convinto; esso permane misteriosa grazia: hierós. Certo egli deve riconoscerlo attraverso la fede, e soltanto così sarà salvo, ma questa fede, così
come questa salvezza, rimangono in toto appese alla Croce del Figlio, alla
morte di Dio. Occorre questo sacrificio di sé, da parte di Dio, per poter pensare salvezza. […] Il Figlio non è, dunque, semplicemente testimone della Verità
e perciò vittima del sacrificio, ma è la Vita divina che si dona, che realmente e
sanguinosamente si sacrifica, e in questo senso non può concepirsi sacrificio
ulteriore. Con la colpa di questo sacrificio, l’uomo ne consuma la potenza, ne
93
94
tocca il confine invalicabile; il non poter essere ancor più peccatore ‘tocca’ il
poterlo non essere più”.36
Il cristianesimo però, (ed in questo dimora la sua grandezza) non si risolve unicamente nell’assolutezza della sua teoresi, bensì reclama di scendere
nelle piazze che reputa sacre tanto quanto i tabernacoli. Il cristiano, così, intimamente preso dall’Annuncio di Dio, è costretto a schierarsi da una parte proprio dalla missione storica del Figlio. È costretto a seguirne l’esempio, è impegnato civilmente a schierarsi per la difesa di un decalogo di valori sempre
attuali, sempre presenti: “La verità è che, piaccia o no, il cristiano non potrà
mai essere un impolitico. Lo può un filosofo (a fatica), lo può un ateo, lo può
un buddista –non un cristiano. […] La fede stessa nell’incarnazione del Logos,
io credo, costringe ad essa. Fare politica è una dimensione immanente all’idea
stessa di Kenosi. Non si possono imitare le sofferenze del Figlio, se non anche
impegnandosi politicamente. C’è qualcosa di più “politico” della retorica di
Paolo? Polemica (anche e soprattutto con Pietro!), invettiva, trucchi da avvocato… Tra i labores del cristiano vi è quello politico –e per lui, io credo, sia il
più improbus…”.37
La Cristianità si pone, quindi, fin dalle proprie origini come scelta politica.
Ed è proprio per questo che è importante soffermarsi ad esaminare il concetto di “comunità” che da questa deriva seppur nella gestazione e nel parto di
fenomeni sociali apertamente contraddittori alla vocazione iniziale. Il fenomeno più importante di questa contraddizione in termini dell’Occidente risiede in
quella “invenzione” politica che ha permesso l’avanzamento dell’individuo contemporaneo. Un’invenzione questa che trova la sua forza, proprio da quella
“incompatibilità” originaria di senso, comune nel nostro continente.
Cacciari, sulle orme indicate da Tocqueville sostiene che questa “innovazione concettuale” ha avuto modo di rendersi manifesta, grazie alla genesi di
una nuova “specie” di umanità che si è imposta prepotentemente, in piena
contraddizione con le intenzioni della propria cultura, sulla scena europea
degli ultimi tempi, pur rimanendo saldamente legata all’antico esempio citato
da Eschilo nelle sue opere: “Si tratta dell’homo democraticus. Intollerante di
ogni dipendenza, dogmaticamente certo della “naturale bontà” dei propri
appetiti (come la scienza economica gli certifica), egli è però anche, in uno,
costantemente bisognoso di protezione, incapace di vera solitudine, pronto
perciò, non appena i suoi “diritti” gli appaiono minacciati, a trasformarsi in
massa. La sua pretesa di integrale “libertà”, che significa volontà di porre il
proprio particolare interesse immediatamente come l’universale, conduce
necessariamente all’organizzazione di tali interessi, alla “palude delle consorterie”, che affermano legittimo soltanto quel potere che immediatamente li rappresenta e che conducono perciò alla distruzione dell’idea stessa di rappresentanza”.38
Un ritratto questo, certamente poco edificante, specie se contrapposto
all’esempio del Figlio che ogni cristiano dovrebbe seguire, ma che rispecchia
la realtà sociale dell’Occidente. Questo homo democraticus, splendido esempio di persona interessata unicamente al proprio tornaconto, recrimina fin da
subito libertà, autonomia, anche se quando gli eventi si rendono pericolosi per
NOTE
il suo modo di essere, muta pelle e tacitamente reclama con la stessa foga
“protezione”, “difesa”, “tutela”.
L’individuo contemporaneo occidentale, così, non permane mai statico
nella sua individualità ma la rinnega quando gli necessità alcunché, tramutandosi in “massa”, ri-appellandosi al valore della comunità che aveva abiurato in
favore della sua individualità, sebbene gli sfugga qualcosa in questo richiamo:
“ Perché comunità si dia è necessario, infatti, che essa si formi tra autentici
distinti, tra lo straniero, il pellegrino, recante in sé proprie leggi e propri costumi, e colui che lo ospita, e che insieme riconosce di essere sempre, intrinsecamente, potenzialmente hostis a sua volta. Il cum non avrebbe ragione di
sussistere tra “identici”; non rappresenta alcun problema degno di interrogazione l’essere-insieme di individui dominati dalla stessa “imbecille passione”
per il proprio interesse. Non si dà in questo caso comunità, ma mera coabitazione. Il cum è autentico problema, o “scandalo” per il pensiero, soltanto quando indica la comunità con il distante, con il perfettamente distinto. Il termine
comunità appartiene alla “categoria” della distanza”.39
L’homo democraticus mal sopporta l’idea della distanza, ma, paradossalmente e incoerentemente, viene ad eliminare quella della prossimità. Il “prossimo” è da lui definito come colui che differisce, come ciò che si può concepire come avente una distinta particolarità, diversa dalla propria. Nonostante
questo, l’uomo occidentale riesce a porre in essere una sorta di “coabitazione”, di “comunità”, ma quasi sempre su fragili fondamenta etiche: “Può produrre comunità, invece soltanto uno “sguardo” che custodisca l’altro nella sua
distinzione, un’attenzione che lo comprenda proprio sulla base del riconoscimento della sua distanza. L’intelligenza del prossimo non consiste nell’afferrarlo, nel catturarlo, nel cercare di “identificarlo” a noi, ma nell’ospitarlo come
il perfettamente distinto”.40
Egli è nato per interagire politicamente con i suoi simili, ma rimane schiacciato dall’utilitarismo sfrenato delle sue “scoperte” che gli elargiscono tutt’al più
il miraggio di un’autonomia che non potrà mai detenere, perché mal sopporterebbe e lo costringono ad un inquieto soliloquio. La sua opera politica si trasforma in breve in una “occidentalizzazione forzata” del globo irrispettosa delle
altrui peculiarità:“Irresistibile è l’ascesa dello homo democraticus perché essa
è prodotto (fisiologico, appunto) dello spirito europeo, o piuttosto, si direbbe,
di quella eterogenesi dei fini che ne ha sempre caratterizzato il divenire”41 Tale
azione di tracotanza politica rischia, però, di trascinare non solamente le dissomiglianze in un contesto di conformità imposta, ma osa trascinare l’occidentale medio in una dimensione annoiata in cui le caratteristiche personali
non hanno più motivo di frapporsi, nel bene o nel male, alla fenomenologia
dell’esistente. Ma, quel che è peggio, si consente al trionfo di un’oblio eticoontologico che rischia di intaccare la comunicatività dell’homo sapiens:
“Poiché comunicare è sempre necessariamente un fra-intendersi. Il pericolo
dell’equivoco, così come male-inteso, è immanente nel comunicare. Eliminare
la comunicazione e ridurre tutto lo spazio del comprendere e interpretare alla
pura combinazione delle informazioni è la vera, profonda filosofia attuale della
Rete. Che ha già ora immense conseguenze nella vita quotidiana. Dalla perte
95
96
della mera informazione stanno tutti coloro che sostengono che culture, tradizioni, religioni non sono che chiacchiere, o al più “poesia” buona per ornamenti, musei, gite del week-end. Dall’altra parte stanno coloro, invece, che
ritengono indispensabile qualsiasi comunità svuotata del “rischio”, della comunicazione, che abbia smarrito ogni rapporto con la forza simbolica del suo linguaggio naturale”.42
Salta agli occhi, in tale contesto, l’enorme distanza che si frappone tra la
socialità contemporanea e le sue “forme” ed il concetto di societas cristiana
delle origini, così come si evidenzia il tipico immobilismo dell’uomo europeo
che è rimasto simile nel carattere, alla preziosa testimonianza posta in essere
dalla tragedia I Persiani.
Il cristianesimo qui però, non rischia di perdere valore, ma attesta, invece,
la propria capacità di recuperare alle sue valentie anche questo strano individuo che è l’uomo occidentale, e per far ciò non frena la fame di sapere di quest’ultimo, come qualcuno ha sostenuto, creando il dogma, ma le dona il fascino dell’impossibile che nessun’altra visione religiosa prima era riuscita ad
infondere.
La novità del cristianesimo risiede, allora, esclusivamente nell’occidentalizzazione della sua Parabola, in quell’aggiustamento ontologico, posto in essere da Saul di Tarso e dai Padri della Chiesa, che risultava tanto inviso a
Nietzsche ed ai suoi fruitori. Il cristianesimo sarà allora da recepire come quella Veritas indaganda che monda il dannato grazie proprio alla ambiguità logica dei suoi fondamenti che, se da un lato la, approssima alle miserie dell’uomo, dall’altro la mantiene ferma nell’incontrovertibilità “temporale” della sua
onnipresente testimonianza storica. Siffatta fede non è riuscita a mondarsi
dalla presenza ontologica del “dubbio” –ed in questo dimora la sua attualità e
la sua vicinanza all’uomo– che la ha sempre scortata nel corso dei secoli,
dove nella sua rinuncia apologetica delle origini, la si vide impegnata, fin da
subito a difendersi dalle minacce che essa stessa partoriva. I suoi avversari
più temibili non dimoravano nel pagus delle gentes, ma, nelle prime tumultuose synago-gae dei simili. L’eresia si generò dal seno cristiano più fecondo e fu
il frutto della formidabile tensione che la compose. Lo skandalon più alto che
questa fede pose, non si esplicò, come già accennato, nell’“Ut quid dereliquisti me? ” del Figlio agonizzante, bensì con la volontà di cercare di “correggere” la propria contraddittoria natura –ironia della sorte– attraverso l’umana propensione al “conoscere” ed al “giustificare”.
4. Considerazioni conclusive
Pertanto, il soffermarsi ad esaminare con scrupolo filologico il “luogo del
crepuscolo”, che l’Occidente ha filosoficamente rappresentato nel corso della
sua storia, non ci esonera dal ribadire, ancora una volta, che il suo enigma
altro non rappresenta, se non da un lato il desiderio intellettuale di fare a meno
di qualsiasi ricomposizione sintetica della dialettica, ma dall’altro l’impossibilità filosofica di sfuggire a tale condanna. Cosicché, la drammatica consapevo-
NOTE
lezza della propria finitezza ontologica, non fa altro che amplificare quel
trĕmendum, quel senso del tragico, che accompagna ogni stato d’emergenza
culturale, che rischia, sotto questa nuova prospettiva, di ritorcersi contro la sua
stessa peculiarità originaria annientando ogni presunta consapevolezza d’essere. Cosicché, la crisi valoriale dei nostri tempi, che la nostra ragione te
cnico-scientifica ha scatenato, non riproduce affatto un episodio cronologico
determinato –la storia dell’umanità è costellata da continue “crisi d’identità” e
da continui “superamenti” delle stesse– quanto, piuttosto, quella “lotta demitizzante” volta a combattere la presunta sacralità della medesima cultura
dell’Occidente. D’altro canto sarebbe filosoficamente inopportuno additare
tutta la responsabilità del declino etico della nostra cultura al nichilismo e alla
costante presenza del dubbio. A questo proposito come afferma Cacciari bisognerebbe avere il coraggio di differenziare la stessa natura dell’ atteggiamento nichilista occidentale, poiché: se il “nichilismo” lo si intuisce unicamente
come una sorta di relativismo assoluto, come un pensiero debole, prende
piede naturalmente l’ordinaria convinzione che la nostra civiltà sia ormai agonizzante, deficiente di valori e di idee degne di essere vissute o divulgate. Ma
se, al contrario, lo si intende come quella riflessione con la quale “del niente si
fa niente”, si intuisce fin da subito che si ha a che fare con un pensiero ultraforte, con quel complesso “virile” della nostra metafisica che ha sostenuto e
sostiene tutt’ora ontologicamente tutto il progetto tecnico-scientifico del mondo
contemporaneo: “Il nichilismo non è una corrente di pensiero ma un ganglio
vitale della nostra metafisica, e non è propriamente un fattore tranquillizzante,
anzi nella sua ricerca dell’impossibile (la potenza che la volontà vuole è in sé
il superamento di una impossibilità) esso destabilizza e porta al limite ogni
esperienza e ogni possibilità positiva. E tuttavia il nichilismo è uno dei perni del
nostro genoma spirituale, che dobbiamo riconoscere e, solo in questa accettazione, tentare di superare”.43
Un pensiero “ultraforte” oggi, è quello che non si rende vassallo delle
mode, della politica o dell’economia “appianando” la sua natura, ma all’opposto, si palesa come tale solamente quando dimostra di essere capace di districare i numerosi nodi di Gordio che la realtà pone continuamente in essere.
Quindi il nichilismo dell’Occidente andrà considerato non più alla stregua di
una pericolosa patologia da eliminare, quanto piuttosto come un vero e proprio phármakon, di certo letale eticamente se elargito scorrettamente, ma
ontologicamente salutare se la sua posologia ci spinge a conoscere il lato più
nascosto della nostra natura.
Il destino della nostra cultura sembra così essere, quello di un’ eterno oscillare dinanzi al rifiuto o all’accettazione del procedimento metafisico, laddove
l’ambiguità della sua natura originaria rimanda sempre ad un confronto serrato riguardo alle domande “chi siamo?” e “dove siamo?”. La ricerca delle origini ontologiche ci spinge verso il baratro profondo del “nulla cosmico” dal quale
siamo affiorati. Abiurare tale “luogo” non comporterà altro che abiurare la parte
più profonda e autentica della nostra anima.
97
98
NOTE
1
Si consiglia la lettura del piccolo lavoro di M. CACCIARI, Nomi di luogo: confine, comparso
sulla rivista “aut aut” 299-300, 2000.
2
M. CACCIARI, Il linguaggio d’Europa, “MicroMega” 1/2001, pp. 172-173. Inoltre si consiglia la
consultazione della voce “Europa” sul volume di R. GRAVES, I Miti Greci, Milano, Longanesi 1989,
e la attenta lettura dei lavori di G. SEMERANO come: Le origini della cultura europea, (opera pubblicata in quattro volumi da Leo Olschki), e L’infinito: un equivoco millenario. Le civiltà del vicino
Oriente e le origini del pensiero greco, (saggio pubblicato dalla casa editrice Bruno Mondadori),
che hanno segnato una vera e propria rivoluzione etimologico-linguistica per quel che concerne i
contributi della lingua accadica nella costituzione della protostoria del bacino del Mediterraneo a
discapito di quella tesi filologica vigente tutt’oggi nei migliori ambienti accademici, che si ostina a
considerare come unico collante culturale comune all’Europa delle origini, le migrazioni linguistiche indoeuropee provenienti dall’Asia continentale transcaucasica.
3
M. CACCIARI, Geo-filosofia dell’Europa, Milano, Adelphi, 1994, pp.18-19.
4
Ivi, p. 22.
5
Ivi, p. 25.
6
Ivi, p. 26.
7
M. CACCIARI, Il linguaggio d’Europa, cit., pp.170-171.
8
M. CACCIARI, Dell’Inizio, Milano, Adelphi, 1990, p. 587.
9
M. CACCIARI, Geo-filosofia dell’Europa, cit., p. 33.
10
Ivi, p. 37.
11
Ivi, p. 43.
12
Ivi, p. 44.
13
M. CACCIARI, L’arcipelago, Milano, Adelphi, 1997, cit., pp. 14-15.
14
M. CACCIARI, Geo-filosofia dell’Europa, cit., p. 55.
15
Ivi, p. 57.
16
Ivi, p. 147.
17
M. CACCIARI, Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, Milano, Adelphi,
1980, p.49.
18
M. CACCIARI, L’Arcipelago, cit., pp. 21-22
19
Tralascio volontariamente di esaminare gli enormi contributi culturali che l’Occidente ha ereditato dalle civiltà ebraica ed islamica.
20
M. CACCIARI, Dell’Inizio, cit. p. 547.
21
M. CACCIARI, Geo-filosofia dell’Europa, cit., pp.151-152.
22
M. CACCIARI, Giobbe nella cultura contemporanea, in M. CIAMPA Domande a Giobbe. Interviste
sul problema del Male, Roma, Città Nuova, 1989, p.65.
23
M. CACCIARI, Icone della Legge, Milano, Adelphi, 1986, p. 144.
24
M. CACCIARI, Primo monologo filosofico. Colloquium salutis, in B. FORTE, Trinità per atei,
Milano, Raffaello Cortina, 1996, p. 149.
25
M. CACCIARI, Dell’Inizio, cit., pp. 549-550.
26
M. CACCIARI, Europa o Cristianità, “MicroMega”, 2/2000, p. 65.
27
È importante ricordare, in proposito, la testimonianza offertaci dalla tradizione cristianocopta dell’Alto Nilo, derivata da alcuni passi dei Vangeli Apocrifi, i quali designavano il punto
esatto su cui fu piantata la croce del martirio come il luogo dove era stato sepolto il “cranio” di
Adamo, che testimoniava come le sofferenze del Figlio “perfetto” si dipartissero dalla tomba del
primo figlio “imperfetto” del Dio impronunciabile, di colui il quale diede origine all’umanità ed alla
sua miseria.
28
G. CANTARANO, Immagini del nulla. La filosofia italiana contemporanea, Milano, Bruno Mondadori,
1998, p. 383.
29
M. CACCIARI, Il Gesù di Nietzsche, “MicroMega”, 5/2000, p. 195.
30
M. CACCIARI, Europa o Cristianità, cit., p. 66.
31
Ivi, p. 68.
32
Ivi, p. 69.
33
Ivi, p. 72.
34
Ibidem.
35
Ivi, pp. 73-74.
36
M. CACCIARI, Dell’Inizio, cit., pp. 562-563.
99
37
M. CACCIARI, card. A. SILVESTRINI, Dialogo sul dovere civile dei cristiani, in “La primavera di
MicroMega”, - 3, 2001, p. 12.
38
M. CACCIARI, L’invenzione dell’individuo, “Micro Mega”, 1996, pp. 121-122
39
Ibidem.
40
Ivi, p. 125.
41
M. CACCIARI, L’arcipelago, cit., p.120.
42
M. CACCIARI, Duemilauno. Politica e futuro. Colloquio con Gianfranco Bettin, Milano,
Feltrinelli, 2001, p. 15.
43
R. CRISTIN, Lingua e identità. L’eidos Europa, in “aut-aut”, settembre-dicembre 2000, La
Nuova Italia, p.118.
100
L’11 SETTEMBRE.
UNA POSSIBILE LETTURA,
SEGUENDO HANNAH ARENDT
Vorrei invitarvi a partecipare con me ad una finzione scenica: immaginiamo
di essere stati convocati in un Consiglio della città di New York, di cui io sarei
il sindaco. L’ordine del giorno di tale convocazione riguarda i provvedimenti
difensivi che dovremo prendere in seguito al terribile attacco dell’11 settembre
al World Trade Center. Per l’importanza delle decisioni che prenderemo, è
necessaria la partecipazione di ognuno di noi; ogni intervento dovrà tenere
conto delle opinioni altrui e dovrà essere espresso in maniera sintetica. Da
parte mia, i miei interventi saranno ispirati al famoso testo di Hannah Arendt,
Le origini del totalitarismo.
Va detto che, in primo luogo, tale proposta di lavoro assembleare ricalca
con fedeltà l’idea arendtiana della partecipazione politica dei cittadini alla vita
democratica del paese. Partiamo innanzitutto dal fatto che, ad una ricognizione sociologica, la città di New York risulta essere una città multietnica che
ospita, ed ha sempre ospitato, persone provenienti da tutto il mondo senza
che esse abbiano alcun problema con gli uffici addetti all’immigrazione.
In quanto sindaco, avrei riflettuto a lungo sulle teorie contenute in Le origini del totalitarismo, cercando di rintracciare in esso elementi che meglio mi
potessero far comprendere la profonda crisi che tutti noi stiamo vivendo. Il
primo elemento che, a mio avviso, appare importante per la nostra discussione è quello circoscrivibile al significato storico che Arendt attribuisce al concetto di nazione. Secondo la filosofa tedesca, l’idea di nazione è stata alterata con l’avvento del totalitarismo, il quale si è proposto nel Novecento come
una nuova forma di governo distinta da quelle tradizionali, come l’oligarchia, la
tirannia e la democrazia. La teorizzazione politica di Hannah Arendt ha mirato
ad individuare i mutamenti etici e morali nelle diverse epoche storiche, individuando in essi i tratti distintivi del vecchio e del nuovo.
La natura dell’uomo ha la tendenza, nei momenti di crisi, di trovare nelle
esperienze del passato tratti riconoscibili che la memoria richiama a sé, nel
tentativo di trovare una soluzione alle problematiche che l’uomo vive.
L’utilizzazione di tale analogia storica è stato il primo atto compiuto da Bush e
dall’intero Congresso, subito dopo l’11 settembre. Così, Pearl Harbour è ritornato alla memoria degli americani come simbolo di un attacco alla pacifica esistenza della nazione americana: da qui l’assimilazione dell’atto terroristico ad
un atto di guerra. Ma la successiva riflessione di noi tutti ha fatto emergere
come questo ingiustificabile atto terroristico sia stato, prima di tutto, un attacco contro i valori rappresentati dall’intero Occidente. Consequenziale è stata,
quindi, la condanna verso tutti quegli Stati che con il fenomeno terroristico presentano una connivenza. In seguito all’11 settembre, gli equilibri mondiali sono
NOTE
di Elisabeth Young-Bruehl*
101
102
sorprendentemente mutati: schieramenti, fino a pochi decenni fa inimmaginabili, hanno dato vita ad intese politiche fra U.S.A., Cina e Russia contro il terrorismo.
L’attacco alle Twin Tower ha fatto sì che tutti ci risvegliassimo da un torpore delle menti, costringendoci ad interrogarci sul “perché” di tale gesto, tentando di comprendere, per la prima volta, le ragioni degli altri. L’attacco ha
fatto emergere, infatti, delle verità finora nascoste, quelle, cioè, di una dissidenza all’interno dello stesso territorio americano. Ma avevamo veramente
bisogno di un attacco così terribile per riflettere sulla nostra sicurezza?
Esiste nell’uomo contemporaneo una radicale insicurezza derivante dalla
perdita di punti di riferimento forti: di valori, di idee, di progetti. Con lo schiantarsi delle due torri, questa realtà si è presentata agli occhi di tutti: tutti siamo
potenziali vittime di un nemico-ombra. Ecco perché l’idea di una guerra, così
come finora l’abbiamo conosciuta, è improponibile in uno scenario come quello attuale. La II guerra mondiale è stata una guerra di liberazione dal totalitarismo e la morte di milioni di civili era giustificata da questo. Oggi il conflitto
contro la rete terroristica deve avere, invece, un assetto mirato, “chirurgico”,
poiché i terroristi sono presenti ovunque. È per questo motivo che l’amministrazione americana ha smesso di parlare di guerra convenzionale, sostituendola con una definizione di più ampio respiro morale: “libertà duratura”. Del
resto, questo terrorismo antioccidentale, che ha in Osama Bin Laden il suo
leader, si presenta come un’entità sovranazionale che trova protezione in molti
stati del Medio Oriente e non solo.
Se per Hannah Arendt il totalitarismo era legato all’espansione imperialista
di uno Stato fondato su di una ideologia forte, l’attuale terrorismo, pur privo di
uno Stato-Nazione in cui riconoscersi, possiede un’ideologia religiosa in grado
di costituirsi come chiave di lettura del passato e del presente. Ponendosi
come uno strumento di interpretazione della realtà, questo integralismo cieco
si è manifestato in ogni aspetto della vita quotidiana: dal rapporto fra i sessi
alle analisi storiche.
Hannah Arendt ha chiarito come il totalitarismo possa non autoconclamarsi, ma restare cristallizzato all’interno di un regime democratico. Ciò significa
che all’interno di una democrazia esistono quegli elementi di matrice totalitaristica che minacciano la civiltà pluralista.
L’amministrazione Bush, prima dell’11 settembre, era impegnata in un tipo
di politica rivolta agli affari interni, lasciando inalterato il suo potere imperialistico: è stato proprio quest’ultimo ad essere concepito da Bin Laden come il
nemico da combattere, poiché esso incarnava lo spirito di una “crociata” cattolico-ebraica in grado di violentare i paesi musulmani.
A mio avviso, sia l’ideologia musulmana che l’imperialismo, sono due elementi sovranazionali tesi alla totalitarizzazione del mondo. Ma perché un’ideologia attecchisca, è necessaria, secondo Arendt, una specifica figura: quella dell’uomo banale. È mediante quest’ultimo, infatti, che è possibile, sia per i
talebani che per gli imperialisti americani, trovare una sempre più ampia rete
di espansione. Proprio per il suo essere banale, ovvero per non possedere
delle qualità di partecipazione alla vita politica, quest’uomo aderisce acritica-
* Intervento tenuto al Convegno internazionale: Hannah Arendt / Reiner Schürmann Memorial
Symposia in Political Philosophy. “Hannah Arendt’s The Origins of Totalitarianism – Fifty Years
Later”, New York 11-12-13 October 2001. Registrato e tradotto da Christina Belogia.
RECENSIONI
mente ad una particolare visione del mondo senza comprendere le motivazioni reali che muovono sia le attività terroristiche che l’imperialismo. Proprio per
la complessità di tutti i motivi finora espressi, è necessaria da parte nostra una
riflessione più attenta alle reazioni belliche dopo l’attacco dell’11 settembre.
103
M. GIULIANI, Cristianesimo e Shoà, Morcelliana, Brescia 2000, pp. 160.
104
Diciannove secoli di antigiudaismo cristiano sono culminati nella Shoà,
“distruzione”, “catastrofe”, nella quale sei milioni di ebrei sono stati sterminati
nel cuore dell’Europa cristiana (protestante e cattolica) dai nazisti. “Se non vi
fosse stato il bimillenario ‘insegnamento del disprezzo’ cristiano verso gli ebrei
‘carnali e deicidi’ i nazisti avrebbero tentato e parzialmente realizzato il loro
progetto di estirpamento del popolo ebraico dal mondo? L’antigiudaismo cristiano ha pavimentato l’impresa” (p. 108). L’antigiudaismo religioso è “un’indiscussa condizione” dell’antisemitismo razziale e culturale (Ibid.). Sotto la spinta della secolarizzazione, “l’antigiudaismo religioso del lontano passato si è
trasformato divenendo ora antisemitismo biologico-razziale, ora avversione
economico-politica, cioè antisionismo” (p. 19). E così “l’avversione religiosa di
un tempo è divenuta la più ‘scientifica’ giustificazione della politica della razza
pura” (Ibid.). Duemila anni di conflitto antigiudaico dovuti a motivi religiosi, teologici sono, dunque, culminati nella Shoà.
Ma perché tanto odio da parte dei cristiani contro gli ebrei? Qual è la matrice della conflittualità teologica tra ebrei e cristiani?” Esiste un parallelo, –scrive Giuliani– oserei anzi dire una sovrapposizione di tipo ermeneutico-soteriologico tra Israele e il Cristo dei cristiani” (pp. 105-106). “Quel parallelo, quella
sovrapposizione tra Israele e Gesù costituisce la matrice della conflittualità
teologica tra popolo ebraico e chiesa” (p. 106).
La questione intriga. A chi spetta la missione salvifica, il compito messianico: ad Israele, il “popolo eletto”, cioè a coloro che –secondo il racconto degli
Atti degli apostoli– “credettero in Gesù come messia” e perciò convocati a
svolgere la stessa opera salvifica di Cristo? Da una parte c’è Israele, il “popolo eletto” da Dio a una speciale missione nel mondo, a un compito messianico per eccellenza, m ne è rivelativa l’alleanza sinaitica; dall’altra c’è Cristo,
l’Agnus Dei, quindi, la chiesa come ecclesia, comunità di convocati a svolgere la stessa opera di redenzione nel mondo attraverso la fede in quello stesso
Gesù “che Dio ha costituito Cristo” (At. 2,36). Per gli ebrei, Cristo non è il messia, perciò lo hanno crocifisso. Per i cristiani, Cristo è filius Dei. Gli ebrei, dunque, sono deicidi.
L’accusa di deicida abbassa l’ebreo al livello più basso della condizione
umana. Ciò ha costituito, fin dalle origini della storia cristiana, la base per la
demonizzazione dell’ebreo qua talis. Questa verità cristiana cova sotto le teorie pseudoscientifiche della mitologia nazista. Di qui l’antigiudaismo cristiano,
che, grazie alla secolarizzazione, è culminato nell’antisemitismo biologico-razziale e nella Shoà. Di qui il bimillenario insegnamento di disprezzo cristiano
verso gli ebrei carnali e deicidi, che ha favorito il progetto nazista di estirpamento del popolo ebraico dal mondo.
Il popolo ebraico non è stato annientato, è sopravvissuto alla Shoà: “dopo
la Shoà è diventato impossibile negarlo, e continuare come se nulla fosse successo” (p. 21). La Shoà, dunque, è “nuova rivelazione dell’esistenza di Israele
acccanto alla chiesa” e “solleva nella chiesa l’istanza nuova della relatività
soteriologica, dei limiti cioè della propria pretesa di salvezza sul mondo,
RECENSIONI
ponendo così un limite teologico alla redenzione di Cristo” (p. 110). La Shoà,
quindi, “è un problema cristologico perché riapre al cuore della teologia cristiana il problema della redenzione, facendo riscoprire ai cristiani il peccato
originario della loro ermeneutica sostituzionista e la sostanziale relatività soteriologica del simbolo cristiano per antonomasia: la croce di Cristo “(p. 115).
La Shoà mette in discussione l’assolutizzazione del senso salvifico del
sacrificio di Cristo e il suo elitismo sostituzionista; mette in dubbio la salvezza
del mondo operata da Cristo, sovrapposto e sostituito a Israele, che cioè
Cristo sia veramente Redemptor mundi, e insinua un’istanza di relatività soteriologica nella cristologia tradizionale della chiesa. Mette in crisi l’esclusività
soteriologica della croce di Cristo, dal momento che proprio la croce è stata
per gli ebrei simbolo di intolleranza, di condanna, di oppressione e di odio. In
nome di essa i crociati hanno combattuto gli ebrei. La croce era brandita dai
giudici dell’Inquisizione e dagli aguzzini dei pogroms. Per gli ebrei esiste un
parallelo tra la croce e la svastica. Allora: si può includere Auschwitz nella
croce di Cristo? “Il dubbio che la croce di Cristo sia rimedio per tutti i mali e
per tutti i peccati, tranne quelli compiuti in nome della croce stessa, fa tremare l’intero edificio della redenzione cristiana […]; incrina la serafica certezza
dell’universalità e della compiutezza della soteriologia” (p. 114). La redenzione “ridiventa dramma […]. Ridiventa il biblico Chaoskampf, dove Dio è ancora in lotta contro il male e dove nessun redentore può dire ‘tutto è compiuto’”
(p. 115). Auschwitz: “stella del’irredenzione” (p. 116). L’implicazione più urgente e radicale della Shoà per la teologia cristiana è ripensare il ruolo d’Israele
nell’economia cristiana della salvezza. La Shoà pone le chiese e le teologie
cristiane di fronte alla realtà storico-teologica di Israele come popolo di un’alleanza mai revocata, l’alleanza sinaitica è eterna, e di fronte al proprio peccato: “il peccato di non-credere che le promesse di Dio sono irrevocabili e di
negare l’uni-genitura di Israele. In una parola, il peccato di antigiudaismo” (p.
31). Un peccato, dunque, verso Dio e verso Israele, nella forma della dottrina
sosituzionista, in virtù della quale la chiesa sostituisce Israele nel piano di salvezza, della sostituzione teologica, cioè, di Israele con un altro “popolo eletto”,
la chiesa. La sovrapposizione cristiana di Cristo a Israele è il nodo teologico
che è alla base del conflitto ebaico-cristiano. La Shoà riscopre l’irrevocabilità
delle promesse di Dio e la permanenza del valore teologico di Israele nella storia della salvezza. “Infatti se Israele venisse meno, cadrebbero le promesse
fatte ad Abramo e alla sua discendenza per sempre” (p. 23). E ancora: “il principale attributo del Dio biblico, cioè la sua credibilità, verrebbe meno a sua
volta” (Ibid.).
Di qui il compito di ripensare la teologia e segnatamente la cristologia e
l’ecclesiologia, di rivedere tutto il secolare atteggiamento cristiano verso il
popolo d’Israele.
Ai fini di un dialogo cristiano-ebraico significa cogliere le implicazioni teologiche che quel dialogo, meglio quel mancato dialogo che furono diciannove
secoli di antigiudaismo, comporta. “Cristo, dopo Auschwitz, va ripensato fuori
dalle categorie dell’idolatria e rimesso nelle coordinate teo-logiche del Dio di
Israele e dell’alleanza di Israele con Dio” (p. 75). In Cristo Dio non ha abolito
105
106
l’alleanza con Israele, ma l’ha rafforzata. Occorre, dunque, un revisionismo
teologico che ha al suo centro la riscoperta della presenza d’Israele nel
mondo, il popolo di Dio eletto, chiamato prima dai gentili e per i gentili, cioè
prima dei cristiani e per i cristiani, un revisionismo che sottolinea la priorità cronologica di Israele, ma soprattutto teologica. Il peccato originale del cristianesimo nascente è l’aver occultato l’origine ebraica, l’hebraica veritas, della
cosiddetta nuova alleanza; l’alleanza tra Dio e Israele confermata e rinnovata
in Cristo. La rivelazione di Dio in Cristo non è negazione della rivelazione di
Dio a Israele. Ciò comporta “un lavoro su di sé come scavo nelle proprie origini storiche, de-costruzione psicologica del processo formativo della propria
identità, ri-costruzione della propria specificità –la cristologia– alla luce della
‘relatività soteriologica’ implicata nell’accettazione della storia di Israele come
luogo nel quale avviene –viene cioè all’esistenza storica e teologica– e si realizza la veritas christiana” (p. 143).
Le due religioni, che per secoli sono vissute l’una contro l’altra, “oggi hanno
davanti a sé la possibilità di essere l’una accanto all’altra non nella forma della
loro reciproca negazione, ma nella forma del mutuo riconoscimento” (p. 147).
D’altra parte, “Dio ha creato il mondo, non le religioni. E neppure le chiese e
le sinagoghe” (pp. 147-148). Tuttavia “solo attraverso il lavoro su di sé e l’accettazione di un conflitto riscattato dalla sua negatività –di cui Shoà, sigillo di
una ferita antica, è emblema– la positiva verità su di sé di cristianesimo e giudaismo può venire a parola, nella forma di benedizione per il mondo” (p. 148).
“Rovesciare un grande errore, per svelare una grande verità. Questo, e solo
questo, significa il dovere, per le chiese, di fare ancora memoria della Shoà,
dando un contenuto storico alla parola teshuvà (conversione) (Ibid.)
Pietro Birtolo
M. DANESI, Lingua, metafora, concetto. Vico e la linguistica cognitiva, pres. di
A. Ponzio, Edizioni dal Sud, Modugno 2001, pp.136.
Tratto caratterizzante di una parte cospicua degli studi riguardanti, direttamente o indirettamente, la filosofia vichiana continua a dimostrarsi la tendenza allo spostamento, alla comparazione, al dialogo. Sottratto al ruolo di isolato nel suo tempo, a torto o a ragione assegnatogli da studiosi di primo piano,
Vico è riconvocato quale guida per audaci scorribande lungo il tempo grande
del pensiero, attraverso i più disparati campi disciplinari. Risultato più evidente di queste tendenze è stata, negli scorsi decenni, oltre la proliferazione di
contributi monografici di difforme impianto e qualità, una abbondante produzione di volumi collettanei, ricchi ed eterogenei (fra tutti, si ricordino quelli
meritoriamente promossi da Tagliacozzo).
Anche la monografia di Marcel Danesi si uniforma a questa tipologia di
approccio, la cui proficuità va commisurata, più che al rigore filologico della
comparazione, agli apporti specifici di una impostazione latamente definibile
dialogica. In questo caso, l’opera vichiana è accostata alla linguistica cogniti-
RECENSIONI
va, alla quale Danesi ha dedicato diversi studi specifici (tra i più recenti va in
particolare segnalato The Forms of Meaning, pubblicato con Thomas Sebeok
–Mouton De Gruyter, 2000–). L’intento è di illuminare, recuperando idee o
intuizioni di Vico, alcuni dei concetti fondamentali di questo filone della linguistica contemporanea, indicando anche, sulla base degli interrogativi che è
possibile porre a partire dalla rilettura della Scienza nuova, quali possano
essere gli sviluppi futuri della ricerca. È chiaro che, confidando nell’efficacia di
talune omologie, il testo di Danesi è impostato in modo tale che a trarre giovamento dall’operazione debba essere soprattutto la linguistica cognitiva. Il
pensiero vichiano, pur illuminato retrospettivamente da questa, nel testo di
Danesi è in qualche modo, nelle linee interpretative fondamentali, dato per
acquisito. In altri termini, è possibile dire che Vico, più che oggetto di questo
libro, ne sia un personaggio, una sorta di Virgilio, carattere poetico plasmato
dallo studioso per guidare il lettore nei meandri della teoria linguistica.
L’intenzione dell’autore è resa perspicua dalla struttura stessa del libro, nel
quale i capitoli sui principi fondamentali della linguistica cognitiva sono incorniciati da una introduzione ed una conclusione che illustrano l’originalità dei
possibili apporti vichiani. Della linguistica cognitiva sono trattati, con notevole
chiarezza espositiva, i nuclei teorici fondamentali, con l’intento strategicamente rilevante di farne un paradigma alternativo alla linguistica generativa. La linguistica cognitiva, intesa come “scienza che si occupa del nesso che collega
esperienza del mondo, concetti e linguaggio” (39), è collocata a valle di una
tradizione di studi che ha ritenuto indispensabile aprirsi all’analisi del linguaggio figurato, piuttosto che farsi vincolare esclusivamente all’idea di grammaticalità. Fare della metafora il meccanismo fondamentale di costituzione del
nostro sistema concettuale-cognitivo significherebbe porsi in alternativa radicale rispetto alla linguistica chomskiana, dal cui orizzonte sono stati invece
programmaticamente allontanati i fenomeni figurali, ridotti a secondarie deviazioni dalla norma grammaticale incarnata nella competenza.
Alle antiche idee, di ascendenza aristotelica, secondo cui i concetti sarebbero rigidamente distinti in astratti e concreti (“principio dell’autonomia dei concetti”) e quindi organizzati in un sistema tipologico (“principio dell’organizzazione gerarchica”), Danesi oppone i principi inversi di “una continuità eziologica tra i due domini di pensiero” e di “un’interconnessione noetica tra i vari concetti che la nostra mente produce” (39). Il principio di continuità si basa sull’idea che la metafora costituisca una “capacità conoscitiva innata, la quale permette di trasformare le esperienze ‘vissute’ in schemi di pensieri astratti” (48).
Il principio di interconnessione si fonda invece sull’idea che del tutto omologhi
siano i processi intellettivi coinvolti nella produzione di concetti concreti e
astratti (50).
Le parti più efficaci del testo sono probabilmente quelle dedicate a ciò che
Danesi, in linea con Sebeok, denomina “metaforma”. In contrasto con l’idea
che la metafora si realizzi tramite un procedimento induttivo basato sulla comparazione o sostituzione (se A e B sono simili sotto qualche rispetto, possono
esserlo sotto altri), l’autore sostiene che sarebbe più corretto assumere che
sia la metafora a produrre le comparazioni o analogie (51-52). Questo pro-
107
108
cesso sarebbe reso possibile dalle “metafore concettuali” o “metaforme”,
schemi derivati dall’esperienza che fungono da matrici generative di metafore
specifiche. Ad esempio, dall’esperienza vissuta è derivabile lo schema della
verticalità, basato sulla polarità “sù/giù”, che offre la base immaginativa per
generare concetti astratti come “[felicità = sù] / [tristezza = giù]” e da questi
frasi come “mi sento sù/giù”, “la notizia lo ha sollevato”, ecc. (48 –su questo
terreno, il modello esplicativo di Danesi richiederebbe ulteriore discussione,
alla luce delle non infondate critiche di fallacia naturalistica mosse alla celebre
teoria, per molti versi affine, di Lakoff e Johnson).
È soprattutto in relazione a questa ipotesi che è richiamata la Scienza
nuova, opera nella quale l’analisi dei processi metaforici è inserita in una teoria complessiva della origine e formazione del linguaggio e delle lingue. La
capacità di “immaginare … fenomeni astratti” nei termini concreti dell’esperienza vissuta avrebbe secondo Danesi una delle migliori spiegazioni possibili proprio nella logica poetica vichiana (definita con un eccesso di semplificazione “una facoltà”). In particolare, utile sarebbe il riferimento, per quel che
concerne la “generazione dei sistemi logico-simbolici”, alle “tre fasi filogenetiche / ontogenetiche” individuate da Vico. Nell’interpretazione di Danesi, la
prima fase è quella in cui mediante la fantasia si modella “il mondo fisico e
affettivo in termini poetici, e cioè in termini di senso” (125); la seconda “consiste in una metaforizzazione dei referenti astratti”, operata per mezzo l’ingegno;
la terza nella “formazione e utilizzo di un simbolismo astratto e razionale” (124
–non è chiarissimo se Danesi associ questa terza fase alla memoria; ciò
avvallerebbe una corrispondenza facoltà-età dell’uomo che si discosta sensibilmente dal discorso vichiano, nel quale arduo sarebbe intravedere una concezione della memoria come facoltà del simbolismo astratto e razionale).
Questo modello triadico, come le altre suggestioni vichiane, è comunque
assunto non per essere eretto a dogma, bensì per avviarci ad un percorso,
ancora irto di difficoltà, lungo il quale almeno tre questioni fondamentali devono
essere affrontate: come avvenga il passaggio da domini concettuali a codici verbali; se la conoscenza delle cose astratte sia sempre metaforica; quali e quante siano, nel procedere coordinato di esperienza linguaggio e concetti, le fasi
ontogenetiche e filogenetiche. Il riferimento a Vico, in altri termini, renderebbe
accessibile non tanto un modello scientifico quanto una “visione” o permetterebbe addirittura di imporre una “svolta … nelle scienze del linguaggio” (26).
Dal punto di vista della ricostruzione storica (e anche della “creazione dei
precursori”, per usare usare un’espressione ricorrente in situazioni analoghe),
la scelta di porre sotto l’egida vichiana un progetto di svolta acquista un senso
polemico in relazione al richiamo opposto, in Chomsky, al modello cartesiano.
Certo, per dare fondamento a tale ricostruzione sarebbe necessario, come
osserva nella prefazione anche Augusto Ponzio (17-18), il dispiegamento di
argomentazioni storiche e teoriche più ampie di quelle addotte nello spazio limitato dell’agile libro di Danesi. In questo, le riflessioni di Vico sulla metafora e
sulle modificazioni della mente, nella Scienza nuova organicamente connesse
alle idee di topica, senso comune, nazione, sono riproposte, per così dire, in
vitro. Ma evidentemente le scelte dello studioso, come chiarito sin dalla pre-
Donato Mansueto
J. BENTHAM, Deontologia, a cura di S. Cremaschi, La Nuova Italia-Rcs Scuola
spa, Firenze, 2000.
Lavorare sul testo è un compito difficile e tuttavia irrinunciabile nello studio
della filosofia. Confrontarsi direttamente con il testo è il modo migliore per
apprendere ma presuppone la conoscenza approfondita del linguaggio filosofico o, piuttosto, dei linguaggi filosofici, nonché la padronanza di un ventaglio
di nozioni-chiave sull’epoca, il clima culturale, il contesto sociale e politico di
una certa opera.
È allora di notevole interesse la collana Leggere i Classici della casa editrice La Nuova Italia, diretta da Sergio Cremaschi, che ha appunto l’obbiettivo
di facilitare ed incentivare la lettura del testo filosofico. Lo stesso Cremaschi
ha curato l’opera di etica che Jeremy Bentham non riuscì a completare prima
della sua scomparsa: Deontologia (neologismo benthamiano, dal greco dèon,
il doveroso e logos, il discorso). Perché la scelta di Cremaschi cade proprio su
questa particolare espressione del pensiero di Bentham? Certamente perché
la Deontologia costituisce la presentazione più esaustiva e sistematica dell’utilitarismo, una teoria etica conosciuta e discussa tutt’oggi dai filosofi inglesi e
americani, ma non abbastanza apprezzata in Italia.
Tradotta per la prima volta in italiano, la Deontologia, viene proposta al lettore corredata di un notevole apparato storiografico e teoretico, che la rende
non solo accessibile a tutti, ma anche particolarmente adatta ad un approfondimento critico delle tematiche in essa sviluppate così come si evince dalle
varie sezioni del volume. La terza sezione, Contesto, ad esempio, fornisce una
biografia essenziale che consente di legare concettualmente quest’opera
all’insieme degli interessi politici benthamiani. La quarta, Cotesto, prosegue
con un’antologia di passi scelti fra gli esponenti principali della tradizione utilitaristica e si conclude con l’analisi delle teorie dei più noti critici contemporanei dell’utilitarismo, fra i quali ricordiamo J. Rawls, T. Nagel, K. O. Apel, J.
Habermas, J. Mackie e B. Williams. Questa sezione è corredata, inoltre, da un
Lessico che facilita la comprensione dei concetti-chiave contenuti nel testo
accompagnato da alcuni suggerimenti bibliografici e da un indice analitico dei
concetti e dei nomi. La quinta, Guida alla lettura e all’interpretazione, offre
spunti di riflessione sul testo ed è un notevole sussidio didattico per il docente che può trovare precisi quesiti da porre all’attenzione dei propri studenti.
Non potendo ripercorrere in dettaglio le singole parti del volume, mi limiterò a presentarne alcuni aspetti salienti. La sezione iniziale, ad esempio, intitolata Prima del testo, introduce la personalità eclettica e, per molti versi, “scomoda” di questo filosofo che intraprese encomiabili battaglie sociali e politiche
RECENSIONI
messa (21-23), vanno in questo caso rapportate all’economia di un’operazione,
propositiva e polemica al contempo, cui necessitano l’accostamento rapido, la
sintesi, lo spostamento di prospettiva –una economia metaforica, appunto.
109
110
così come si fece portavoce di idee a dir poco discutibili. Da una parte, infatti,
si adoperò affinché venissero varate riforme tese a migliorare la condizione dei
più disagiati e delle minoranze come l’estensione del “principio di tolleranza” a
tutti i credi religiosi o l’abolizione della tratta degli schiavi e della pena di morte.
Dall’altra, però, si dichiarò favorevole a pratiche generalmente condannate
dall’opinione pubblica come il suicidio o l’infanticidio. Inoltre, Bentham ed i suoi
seguaci divennero tristemente famosi per l’introduzione di nuove “Poor Laws”,
leggi che, nell’intenzione, avrebbero dovuto spronare i poveri a migliorare la
propria condizione senza rivolgersi all’assistenza pubblica, ma che si rivelarono un vero e proprio fallimento. Di qui l’ira dei benpensanti del suo tempo e
l’ombra sinistra che tutt’ora avvolge la sua persona.
Questa prima sezione introduce anche al pensiero filosofico di Bentham. In
particolare, Cremaschi si concentra sul il principio di utilità, ossia il principio
che prescrive “la massima felicità nel maggior numero” e la teoria etica che da
esso si sviluppa contenuta nella Deontologia. La traduzione italiana offerta da
Cremaschi si rifà dall’edizione critica di Amnon Goldworth, del 1983. Il volume
contenuto nei Collected Works of Jeremy Bentham, è più breve di quello pubblicato da J. Browing del 1834, poiché mancano due capitoli, “Le virtù di
Hume” e “False Virtù”. Browing, infatti, temendo che il lavoro di Bentham
potesse oltraggiare la fede cristiana, omise volutamente dei passi e presentò
una parafrasi del testo originale contenuto nei manoscritti redatti fra il 1814 e
il 1831, piuttosto che una fedele ricostruzione. L’edizione di Goldworth, invece, riproduce il testo alla lettera scegliendo i passi più recenti dell’opera, rielaborati più volte da Bentham stesso. Il titolo originale dell’opera era
Deontologia, o la morale semplificata: che mostra come attraverso l’intero
corso della vita di ogni persona il dovere coincide con l’interesse giustamente
inteso, la Felicità con la Virtù, la Prudenza nei confronti altrui così come nei
propri confronti con la benevolenza effettiva.
La formulazione di questo titolo tradisce immediatamente l’intenzione costitutiva dell’opera: armonizzare e giustificare il legame concettuale fra i due
corni della teoria utilitarista, vale a dire trovare un punto di raccordo fra il principio dell’interesse personale e quello dell’interesse collettivo e quindi riconciliare la felicità con la virtù. A questo proposito, Cremaschi sottolinea come
spesso l’utilitarismo di Bentham sia stato erroneamente assimilato ad altre
dottrine basate sull’edonismo o l’egoismo psicologico. Tale confusione è stata
certamente alimentata dagli stessi utilitaristi, sia Bentham che J. S. Mill, i quali,
facendo ricorso alla consueta mossa retorica di attribuire nobili origini alla propria dottrina per accrescerne l’autorevolezza, riconobbero in Epicuro la loro
fonte di massima ispirazione.
In realtà, l’etica benthamiana più che conformarsi ad un modello ideale,
nasce dal progetto di riforma intellettuale e morale propedeutico ad una riforma
sociale in Inghilterra e nel mondo. A tal scopo, egli ritenne necessario fondare
la morale non sull’autorità della chiesa, ma sulla sola ragione, intesa come
facoltà universalmente legislatrice, così come, in maniera diversa, avevano
fatto Rousseau, Diderot, Hume e Kant. Nel concepire una morale autonoma
Bentham fa affidamento al principio di utilità, che richiama l’idea di calcolo delle
RECENSIONI
conseguenze presente nel dibattito teologico dei secoli precedenti. Con diverse caratteristiche, il principio di utilità evoca, infatti, la formula “la massima felicità divisa nel maggior numero”, presente nei Delitti e delle pene di Cesare
Beccaria, ma ricorda anche l’idea di Adrien Helvetius per cui l’uomo virtuoso è
colui il cui interesse collima con l’interesse generale. Inoltre, l’etica benthamiana subisce l’influenza della visione di William Paley, per il quale il bene e il male
morali consistono nella quantità totale di felicità, ossia il piacere fisico. Se nella
teoria di Paley è, però, Dio a stabilire le leggi da rispettare, dopo un calcolo
accurato delle loro conseguenze, in quella di Bentham, invece, il compito è affidato all’uomo stesso nel momento in cui deve decidere come comportarsi. La
scelta moralmente giusta è, allora, quella da cui seguono conseguenze
“buone”, ossia, la massima felicità derivata dal risultato e dalle conseguenze
delle nostre azioni: “utilità designa il rapporto fra un’azione o una classe di azioni e le sue conseguenze sia sull’agente sia sugli altri individui in termini di felicità. Il principio prescrive “la massima felicità” risultante dalle conseguenze
delle azioni, come criterio per determinare l’azione giusta (p.6)”. Il principio di
utilità, inoltre, è analitico e quindi non necessità di nessuna giustificazione ma
è di per sé evidente come l’imperativo categorico di Kant.
Sebbene il principio non necessiti di alcuna giustificazione, tuttavia, nella
sua applicazione pratica deve far ricorso ad una teoria psicologica, che specifichi il modo in cui si debba effettuare il calcolo della felicità. Bentham, infatti,
pone nel piacere e nel dolore la fonte di tutte le motivazioni umane. Si agisce
per evitare il dolore e perseguire il piacere: “la natura ha posto il genere umano
sotto la sovranità di due padroni, il dolore e il piacere […]. Essi ci governano in
tutto ciò che facciamo, che diciamo, che pensiamo (J. Bentham, An
Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789, trad it.,
Introduzione ai principi della morale e della legislazione, a cura di E. Lecaldano,
Utet, Torino, 1998, cap. I, p. 89)”. Piacere e dolore non solo sono posti alla base
di una teoria psicologica della motivazione nell’azione, ma sono anche considerati il fondamento dell’unica teoria etica che possa spingere l’uomo ad agire
in modo coerente. Come è possibile, però, conciliare la teoria psicologica con
quella etica, ossia l’egoismo psicologico con il principio di utilità? Bentham suggerisce di far convivere artificialmente l’interesse personale con quello generale tramite provvedimenti legislativi, per quanto concerne il diritto e tramite sanzioni dettate dal giudizio dell’opinione pubblica, per quanto riguarda l’etica privata. La conseguenza naturale del principio di utilità, tuttavia, dovrebbe essere
quella di andare a coincidere nei lunghi tempi con l’atteggiamento della “benevolenza”: “Crea tutta la felicità che sei in grado di creare: elimina tutta l’infelicità che sei in grado di eliminare […] E per ogni granello di gioia che seminerai
nel petto di un altro, tu troverai un raccolto nel tuo petto, mentre ogni dispiacere che tu toglierai dai pensieri e sentimenti di un’altra creatura sarà sostituito da
meravigliosa pace e gioia nel santuario della tua anima (brano autografo di
Bentham dall’album dei ricordi di Maria Lewin Bowring, 22 giugno 1830 in
Bentham Manuscript, University College London, box 174, fol. 80)”.
La benevolenza o “simpatia” avrebbe, da un lato, la funzione di ricucire lo
iato fra interesse personale e generale; dall’altro, dovrebbe servire a risolvere
111
112
una delle più spinose questioni delle teorie utilitariste: evitare che in base al
principio di utilità venga giustificata una situazione in cui la felicità della maggioranza gravi sul malessere di una minoranza. Il criterio dell’utile, infatti, nella
misura in cui prescrive il raggiungimento della somma totale di felicità e benessere, potrebbe arrivare a giustificare l’oppressione di una minoranza, se questo
fosse necessario per accrescere il benessere della maggioranza.
L’introduzione negli ultimi scritti benthamiani del “principio di sicurezza”, però,
sembra far fronte a questo paradosso della teoria utilitarista, poiché consiste
nell’affermazione per cui ogni azione volta a massimizzare la felicità di qualcuno non può comportare la diminuzione della felicità che qualcun altro già possiede.
Ciononostante, la tesi utilitarista benthamiana continuò a non convincere
l’opinione pubblica britannica. Fra i più acerrimi nemici dell’utilitarismo,
Cremaschi ricorda Charles Dickens, la cui critica richiama sia i motivi romantici del rifiuto per il mondo della tecnica, dei fatti e della scienza, sia quelli di
ispirazione religiosa, in base ai quali l’utilitarismo è accusato di non considerare in alcun modo l’amore cristiano verso il prossimo. Alessandro Manzoni,
d’altro canto, denunciò l’impossibilità di giustificare dal punto di vista utilitarista l’idea di una felicità generale. L’utilità generale, è un criterio che non può
fondarsi nel principio dell’egoismo psicologico, ma che si basa sulle leggi fondamentali del cristianesimo: ama il prossimo tuo come te stesso; non fare agli
altri ciò che non vorresti sia fatto a te; ecc. Pertanto, affinché l’utilità non sia
pura e semplice ricerca del piacere personale, essa, per il Manzoni, deve
acquisire valore morale da qualcosa di anteriore e infinitamente superiore ad
essa, il cristianesimo, appunto, che solo è in grado di fornire il principio, la
causa e il criterio della moralità. Infine, ricordiamo la famosa definizione di
“genio della stupidità borghese” che Marx diede a Bentham quale portavoce di
un pensiero che, persa ogni spinta progressista e riformatrice, aveva finito per
esser espressione degli interessi della classe politicamente dominante.
L’utilitarismo subì nei secoli sostanziali modifiche anche per rispondere alle
numerose critiche rivoltegli. Cremaschi ricorda John Stuart Mill, ad esempio,
che fu il primo ad attuare una revisione del benthamismo. Egli distinse qualitativamente i piaceri in piaceri dell’“intelletto”, dei “sentimenti” e dell’“immaginazione” e attribuì alle “regole” la funzione, che Bentham aveva riservato al
principio di utilità, di guidare il comportamento. Il principio di utilità, in Mill, deve
essere applicato solo nei casi di conflitto fra regole. Di particolare interesse è
poi la pagina dedicata ad Henry Sidwick, che ha innestato una forma di “intuizionismo” sulla struttura dell’utilitarismo, facendo appello al senso comune che
adotta una sorta di intuizionismo “dogmatico”, in quanto ritiene intuitivamente
valide le regole generali socialmente riconosciute, ma ricorre inconsapevolmente al calcolo delle conseguenze nei casi di conflitto morale.
Infine, l’accenno alla “teoria della scelta razionale” o “teoria della decisione” ci permette di fare alcune riflessioni prendendo spunto dagli studi effettuati
in proposito da Jhon Harsanyi, il quale ha mostrato come certi principi dell’utilitarismo possano entrare a far parte di una teoria generale del comportamento etico e sociale, ma soprattutto come l’utilitarismo di Bentham e Mill possa
RECENSIONI
essere derivato, quale conseguenza necessaria, dai postulati di razionalità e
coerenza alla base della moderna teoria della decisione. Tale teoria, sviluppatasi fra gli anni ’50 e ’60 del Novecento, non fa nessun riferimento aconsiderazioni di carattere morale, puntando piuttosto alla definizione dell’aspetto
razionale della scelta e della sua coerenza rispetto alle credenze e desideri
della persona che la compie. Prendendo in prestito un esempio di Hume, in
base a tale teoria potrebbe essere perfettamente giustificabile il fatto che qualcuno preferisca distruggere il mondo piuttosto che provocarsi una lieve escoriazione su un dito.
La teoria della decisione ebbe, fra i suoi ispiratori, F. Ramsey il quale nel
saggio Truth and Probabilità del 1950 tentò di dimostrare che, se la struttura
delle scelte di un individuo, rispetto ad un insieme illimitato di alternative, soddisfacesse determinate condizioni di razionalità e coerenza, allora questa persona opererebbe in modo da massimizzare l’utile previsto. Un individuo razionale, allora, agirebbe assegnando valori ai risultati di certi corsi d’azione alternativi, valori determinati in base al grado di desiderabilità e probabilità (soggettiva) dei risultati stessi. L’agente, infine, sceglierebbe l’alternativa che a suo
avviso possiede il più alto risultato (o valore) “atteso calcolato” (crf. D. Davidson
Essays on Actions and Events, Oxford University Press, New York, 1980, trad
it., Azioni ed Eventi, a cura di E. Picardi, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 317).
La teoria di Ramsey fu in seguito riscoperta indipendentemente da J. von
Neumann e O. Morgensten considerati i pionieri della moderna teoria della
decisone di cui si occupa anche E. Eelles. Questi fa notare che il modello alla
base della decisione razionale prescrive come un corso d’azione meriti di
essere intrapreso solo se “rende probabili delle buone conseguenze” e se fa
si ché una persona razionale, portando a termine quel corso d’azione, abbia il
maggior grado di probabilità di realizzare “le migliori conseguenze, dove la
bontà e la probabilità delle conseguenze sono valutazioni soggettive dell’agente (E. Eelles, Rational Decision and Causality, Cambridge University
Press, Cambridge, 1987, p.4)”. In altri termini, la decisione razionale deve
essere intesa come un processo teso a massimizzare l’utile atteso, tenendo
conto del grado di desiderabilità e di probabilità soggettiva dei vari risultati
delle azioni, sottoposti a comparazione e a processo di deliberazione. La decisione in quanto scaturente da una precedente deliberazione, dunque, è una
funzione di preesistenti gradi di credenza e desiderio. La decisione non
essendo autonoma rispetto a questi fattori richiama, per altro, le teorie dell’azione di D. Hume e J. S. Mill che vedono nei desideri (o volizioni) e nelle credenze la causa dell’azione. Le stesse attuali teorie causali dell’azione (D.
Davidson, ad esempio), mantengono questo schema di spiegazione del comportamento razionale e intenzionale.
D’altro canto, anche le moderne teorie cognitive della motivazione, sono
basate sull’assunzione che il comportamento umano è controllato dalla scelta
razionale: un’agente che deve decidere fra due possibili attività, dovrebbe compiere quella più attraente. Il comportamento, cioè, viene spiegato in termini di
“valutazione cognitiva” (cognitive evaluation) di conseguenze previste. In alcune circostanze, per esempio, il processo tramite cui un individuo viene motiva-
113
to ad eseguire un’azione è detto encentive escalation: focalizzando l’attenzione sulle conseguenze positive di un’azione e su successivi imput esterni, un
individuo è stimolato ad agire fino al punto di non poterne più fare a meno.
Non possiamo esimerci dal dire che una tale visione delle motivazioni e
delle scelte umane porta con sé inevitabili difficoltà. Ad esempio, l’analisi di
molto casi ha mostrato come, in accordo ad un “principio di motivazione inerziale”, una persona in una data situazione può agire non perché suppone che
il risultato dell’azione abbia il valore più alto previsto e quindi l’azione sia preferibile rispetto ad altre alternative, ma perché l’agente ha acquisito nel tempo
una tendenza a compiere quel tipo d’azione, divenuta dominante rispetto ad
altre tendenze. Una conseguenza di questo principio è che, sebbene un’attenta valutazione di possibili e alternativi corsi d’azione favorisca un’azione differente, in realtà si finisce per compiere l’azione meno preferita ma più volte
sollecitata da fattori esterni. Dunque, massimizzare l’utile previsto non è sempre il criterio che guida le nostre azioni, poiché l’agire umano difficilmente può
essere irretito in simili formule generalizzanti. Sebbene costituiscano un primo
strumento interpretativo del comportamento intenzionale, esse mancano,
infatti, di tener in conto di questa complessità della psicologia umana e del linguaggio intensionale in cui essa si esprime.
Jlenia Quartarone
114
G. STEINER, La nostalgia dell’assoluto, Milano, B. Mondadori, 2001, pp. 107.
Filologo, linguista, critico letterario di fama mondiale, Steiner è nato in
Francia nel 1929, si è formato in America ed ha operato soprattutto in Europa
quale docente di Letteratura inglese e Letterature comparate presso le
Università di Cambridge e Ginevra ed autore di numerosi libri –saggio oltre
che di due romanzi e racconti. Ora ha riunito in questa breve opera i testi di
cinque conferenze tenute nel 1994 per la radio canadese. Gli argomenti sono
di carattere storico, sociale, filosofico, esistenziale e riguardano la condizione
dell’uomo nel mondo occidentale, i suoi problemi, le sue aspirazioni, il suo
destino. Ogni indagine è sostenuta da citazioni significative di testi antichi e
moderni, dalla loro interpretazione e comparazione sicché dalla particolarità
del caso in esame si perviene ogni volta alla generalità di una teoria. È questo un procedimento proprio dello Steiner e col tempo gli ha fatto superare i
confini della critica letteraria e lo ha rivelato un attento e profondo conoscitore
della storia dell’uomo dalle origini ai tempi moderni, un osservatore acuto dei
suoi costumi, sentimenti, pensieri, azioni e della loro evoluzione. Tutto ciò che
è stato dell’uomo, lingua, cultura, arte, scienza, religione, tutta la sua vita, passata e presente, è ora di Steiner e rappresenta lo sconfinato terreno dal quale
egli muove per ognuna delle sue elaborazioni.
Stavolta, in queste cinque conferenze, intende documentare e provare
quanto storici e sociologi da tempo sostengono e cioè che nel mondo occidentale si è assistito ad una progressiva crisi della teologia, delle chiese, dei siste-
RECENSIONI
mi religiosi, in particolare di quello cristiano, e della funzione di verità e centralità da essi svolta nella vita del singolo e della collettività dalla fine della storia
greca e romana in poi. Circa i tempi d’origine del fenomeno alcuni studiosi li
fanno risalire al momento della diffusione del razionalismo rinascimentale, altri
a quello delle concezioni laiche proprie dell’Illuminismo, altri ancora al periodo
del darwinismo, della rivoluzione industriale quando in nome dell’immanenza si
rifiutò ogni trascendenza. Si discute, quindi, sui tempi ma si è unanimi nel riconoscere l’esistenza del problema e lo Steiner vi aggiunge che tale riduzione e
quasi scomparsa della componente religiosa della vita aveva creato dei vuoti
profondi nello spirito individuale e sociale poiché lo aveva privato di un riferimento sicuro, di un elemento catalizzatore, totalizzante e lo aveva reso nostalgico di esso. Era rimasta intatta, cioè, la tensione verso quanto di unico, di
assoluto la verità religiosa aveva rappresentato e la situazione era sfociata,
negli ultimi centocinquant’anni, nella formulazione di alcune dottrine che, pur
non religiose, avevano mirato a sostituirsi alla vecchia religione, alla sua capacità di attirare e finalizzare le speranze di tutti, di proiettarle in una dimensione
ideale prospettata come correttiva di quella reale, liberata dai problemi di questa. “Mitologie” vengono definite dallo Steiner tali dottrine perché così gli sembra di rendere la loro qualità di religione laica. Il comunismo di Marx, la psicoanalisi di Freud, l’antropologia di Lévi-Strauss sono state le tre grandi “mitologie”
che hanno cercato, tra XIX e XX secolo, di colmare il vuoto provocato dalla crisi
della religione, di prendere il posto di questa. Come una religione, infatti,
anch’esse si sono mostrate fondate da un maestro, fissate in testi canonici,
seguite da discepoli e col tempo sono state messe in discussione da dissidenti, come una religione hanno sviluppato linguaggi, simboli, rituali propri ed aspirato ad essere uniche, totali, assolute, a valere per l’umanità intera, per le sue
condizioni presenti e future, per i suoi destini. Ed ancora seguendo il modello
religioso i loro iniziatori si sono e sono stati ritenuti degli spiriti illuminati, dei
messia, dei profeti, dei portatori e diffusori di verità: Marx s’identificò con
Prometeo, Freud con Mosè; come loro avrebbero procurato uno il fuoco, la luce
della verità, l’altro le leggi del vivere. In effetti Marx elaborò un programma storico, politico, filosofico che avrebbe dovuto condurre ad “un mondo senza classi, senza oppressione economica, senza povertà e senza guerra”; Freud operò,
nella vita e negli scritti, affinché l’uomo risolvesse l’eterno problema del conflitto tra istinto e razionalità, tra pulsioni interiori e condizionamenti esterni, controllasse le repressioni provenienti dal sociale, chiarisse ogni interiorità pur
inconscia e giungesse a sentirsi libero; Lévi-Strauss comprese, nel suo pensiero, le posizioni di Marx (società) e Freud (coscienza) e si avviò verso una
totalità più estesa della loro, verso quella “scienza dell’uomo” che sarebbe stata
la sua antropologia ed avrebbe rivelato la graduale soppressione, verificatasi
nella storia, della condizione naturale dell’uomo in nome di quella culturale,
della sua vita libera a contatto con gli altri elementi ed aspetti della natura in
nome di quella voluta e regolata dal progresso. Questa, secondo lo studioso,
avrebbe annullato completamente quella e si potrebbe già prevedere un’apocalisse finale da attribuire alla volontà di potenza insita nell’uomo progredito e
al correlato bisogno di distruggere quanto del progresso non fa parte.
115
116
Nessuna di tali teorie riuscì nell’intento perseguito di tradursi in un valore
universale, incondizionato, definitivo, in una verità assoluta e tutte sono finite
tra interminabili contestazioni e irreparabili danni, tutte hanno mostrato i limiti
propri di ogni progetto di carattere soggettivo oltre che quelli della dipendenza
da determinati tempi e ambienti della vita e della storia. Come la religione che
avrebbero voluto sostituire anch’esse sono andate in crisi, come i suoi valori
astratti anche i loro valori concreti sono finiti. È successo anche perché nel
contempo inarrestabili divenivano le conquiste della scienza e della tecnica.
Queste suscitavano un’attenzione ed un interesse sempre maggiori, assumevano un posto centrale nell’opinione pubblica, annullavano ogni altra fede o
credenza o aspirazione grazie agli innumerevoli ed evidenti vantaggi che offrivano, lasciavano intravedere destini di inesauribile benessere per il singolo e
la comunità, si trasformavano in un nuovo credo, un nuovo culto, una nuova
vita, assurgevano a quel livello di valore assoluto così intensamente e vanamente perseguito da Marx, Freud, Lévi-Strauss nei loro lavori.
Anche la scienza, tuttavia, finiva col fallire nei suoi immensi ed accattivanti
programmi, giungeva con l’assumere l’aspetto di una minaccia fino a trasformarsi, nei giorni nostri, in un vero e proprio pericolo se si pensa a quanto da
essa provocato in ambito individuale (malattie fisiche e psichiche) e sociale
(inquinamento diffuso, continue sciagure nei trasporti privati e pubblici, presenza di armi ad altissimo potenziale distruttivo, rivalità e tensioni tra gli stati del
mondo, minaccia di guerre nucleari). Deludevano, quindi, la scienza e la sua
ragione oggettiva come aveva fatto quella soggettiva delle suddette dottrine ed
ora le conseguenze erano più gravi perché la fiducia era stata maggiore.
Si esauriva così una serie di progetti mossi dal proposito di chiarire, correggere, cambiare, migliorare quanto della vita era ancora rimasto affidato al caso,
di eliminare, superare ciò che d’illogico, irrazionale era ancora in essa. Si piombava in uno stato di confusione, di smarrimento ché nessuna delle ragioni perseguite si era mostrata capace di realizzare quanto sperato. Tutte avevano
mancato se nel mondo occidentale c’era inflazione, sovrappopolazione, disoccupazione, fame, odio politico, se anche l’antico principio della superiorità della
civiltà, della cultura, dei sistemi politici d’Occidente veniva meno e si pensava
ormai, isolatamente o in gruppo, a misteriosi e invisibili aiuti esterni, a culture
lontane e diverse dalla propria. L’astrologia, l’occultismo, l’orientalismo sono,
infatti, oggi fenomeni molto diffusi presso la popolazione occidentale del mondo
e diffusa è pure l’editoria che ne fa i propri temi e che conta su strati di pubblico sempre più larghi. È il segno che l’Occidente sta attraversando una grave ed
estesa crisi di sfiducia in seguito al sistematico insuccesso di ogni operazione
tesa ad interpretare e realizzare quel senso di assoluto una volta proprio della
religione ma è anche la prova che si aspira ancora a colmare il vuoto di verità,
di centralità da questa lasciato. Che si stia credendo di farlo ricorrendo al misterioso, all’esotico, all’irrazionale, a quanto, cioè, per anni si era cercato di debellare, conferma in modo inequivocabile che il bisogno di un riferimento, di una
verità che lo superi è connaturato all’uomo e non smetterà di esserlo qualunque sia la sua condizione di vita e di pensiero.
Per l’A. gli scritti di Henry More sono una testimonianza dei fortissimi legami che sussistono, alle soglie della modernità, fra teologia, filosofia e scienza.
La nozione di spirit of nature, che è al centro dell’attenzione in questo saggio,
in particolare è connessa non solo con la filosofia della natura di More, ma
anche con la sua metafisica e con la sua teologia. Si comprende pertanto
come l’A. trovi discutibile la convinzione (alla base di taluni contributi recenti)
ce sia possibile “isolare” alcuni aspetti del quadro complessivo della filosofia
di More. In particolare, critica la monografia di A. Rupert Hall, che ha come filo
conduttore la componente ‘scientifica’ del pensiero di More, ed esclude programmaticamente altre componenti, nonché la recente traduzione inglese
dell’Enchirion Metaphysicum curata da Alexander Jacob, il quale ha modificato la successione dei capitoli pubblicando separatamente i capitoli “ccientifici”
e quelli “metafisici”. L’A. osserva giustamente che non è possibile ‘isolare’ le
dottrine ‘scientifiche’ di More dal contesto generale del suo pensiero, “che è
anche e contemporaneamente una metafisica e una teologia” (p. 10).
Fra i contributi più importanti del Bondì c’è la ricostruzione accurata delle fonti
della nozione di spirit of nature: il Bondì mette in rilievo in particolare i temi dell’antica sapienza e della filosofia perenne (come gli altri platonici di Cambridge
More conosceva il De perenni philosophia di Agostino Steuco), testi specifici di
Platone, Plotino, Aristotele e autori appartenenti alla tradizione aristotelica (in
particolare è esaminato Jakob Schegk e si fa riferimento alla discussione delle
sue tesi da parte di Daniel Sennert), nonché influssi stoici. Una caratteristica
importante di questa monografia è inoltre l’insistenza, contro alcune diffuse interpretazioni critiche, del ruolo della qabbalah (in particolare cfr. pp. 89-130).
L’A. giunge a significative conclusioni critiche sul tema controverso del rapporto fra spirito della natura e anima mundi, mostrando come More conservi la
nozione di anima mundi, caratterizzandola però “in un modo molto diverso
rispetto alla tradizione” (p. 92). Il Bondì osserva che non basta cogliere la distinzione tra spirito della natura e anima del mondo se, allo stesso tempo, “non si
precisa che la nozione di anima mundi subisce, da parte di More, una ridescrizione che lo allontana molto dalla tradizione platonica e neoplatonica… Il dato
essenziale è che lo spirito della natura, chiamato a volte vicarious power of
God, a volte inferior soul of the world, tende a coincidere con l’inferiore anima
di Dio” (p. 116). Infine il Bondì rileva una certa ambivalenza in More, mostrando come da un lato egli sottolinei la differenza ontologica dello spirito della natura da Dio, “insistendo sulla sua natura di sostanza creata e sulla sua funzione
strumentale” (pp. 121-122), dall’altro ricorra frequentemente a un linguaggio di
tipo emanazionistico “per caratterizzare lo spirito della natura, e il suo rapporto
con Dio” (p. 125). “Anche gli scritti cabbalistici di More –che contrariamente a
quanto in genere si pensa, sono fondamentali per capire il modo nel quale
viene concepito lo spirito della natura– documentano l’esistenza di una certa
ambivalenza” (p. 69), spesso non rilevata dagli studiosi di More.
RECENSIONI
Antonio Stanca
R. BONDÌ, L’onnipresenza di Dio. Saggio su Henry More, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2001, pp. 218.
117
118
Un’ambivalenza dello stesso genere si riscontra anche in altri aspetti del
pensiero di More, in particolare riguardo al tema dell’entusiasmo: da un lato
c’è la critica radicale dell’entusiasmo come “la piena ma falsa convinzione di
essere ispirati” (p. 62), dall’altro c’è la distinzione netta fra un entusiasmo ‘volgare’ e ‘fanatico’ e un entusiasmo ‘pio’ (p. 63), un’idea diffusa fra i platonici di
Cambridge e presente anche in Shaftesbury.
L’A. mette in luce la presenza di influssi ermetici in diversi aspetti del pensiero religioso di More: nel suo discorso sulla ‘divina sagacia’ e sulla stretta
connessione fra ‘chiarezza della conoscenza’ e ‘purezza della vita’, tra vera
conoscenza e virtù morale o ‘vera santità’, nel rapporto che stabilisce fra la
ragione che è in Dio e quella che è nell’uomo, ma soprattutto nella concezione dell’uomo come ‘animale divino’ (pp. 85-86).
Di grande interesse è il rapporto che l’A. stabilisce fra More e Descartes,
Boyle e Newton. “L’atteggiamento critico di Henry More nei confronti della
cosmogonia di Cartesio –osserva Bondì– ha a che fare con le insufficienze del
meccanicismo, non con le immagini della scienza. Ciò che More rileva non è l’illegittimità e l’irrilevanza, per la filosofia naturale, di indagare la formazione dell’universo. Su questo non c’è alcun contrasto con Cartesio. Ciò che More rileva
–sin dall’inizio del suo percorso intellettuale anche se con accenti diversi da
quelli che caratterizzeranno in seguito la sua posizione– è che il meccanicismo
cartesiano non riesce a spiegare esaustivamente la realtà” (pp. 134-135). Come
si ricava da questa stessa citazione, l’A. è ben consapevole che il rapporto di
More con Descartes non può essere descritto nei termini di un rifiuto da parte di
More della “filosofia sperimentale”, che in realtà è sempre accettata e difesa da
More, ma piuttosto nei termini di un diverso modello interpretativo della stessa
visione scientifica. “More fu molto attratto dal lavoro di Boyle e confidò nella possibilità di utilizzarlo per il proprio programma” (p. 145). Nel modello di scienza di
More “il ricorso alle sostanze incorporee aveva pieno diritto di cittadinanza” (p.
147). Il dissenso non escludeva convergenze su altre tematiche, come ad esempio la concezione della natura come tempio di Dio e del filosofo naturale o dello
scienziato come “prete”. Per quanto riguarda Newton, il rapporto con More è
stato più volte suggerito in studi recenti. Il Bondì offre in questo senso un contributo di grande interesse, mostrando “come le idee di More abbiano frequentemente modellato l’atteggiamento newtoniano verso Cartesio” (p. 150). In particolare, l’A. richiama l’attenzione sul possibile influsso dello spirito della natura di
More sulla concezione newtoniana dello ‘spirito elettrico’ (p. 157).
Le due appendici che sono poste a conclusione del volume sono di notevole interesse. La prima è una ricca rassegna degli studi critici sul concetto di
spirito della natura in More. La seconda mette in luce l’influsso di More sul
grande poeta irlandese William Butler eats, un influsso noto a taluni storici
della letteratura ma generalmente ignorato dagli studiosi di More e dei
Cambridge Platonists. L’ampia conoscenza dei testi di More consente all’A. di
mostrare quanto vasto e profondo sia tale influsso. “nell’opera di Yeats…l’idea
di spirit of nature di anima mundi, di spiritus mundi, si salda con l’idea di una
great memory, intesa come una memoria universale, una sorta di junghiano
inconscio collettivo” (p. 180).
Albino Babolin
RECENSIONI
Dal punto di vista della metodologia storica, l’opera del Bondì è ineccepibile: l’A. conosce perfettamente la letteratura critica su More e l’usa e la discute diffusamente; il riferimento alle fonti primarie è costante, così come quello
al contesto intellettuale. Si tratta in definitiva di un contributo importante alla
conoscenza di uno dei pensatori più significativi del Seicento inglese, esaminato principalmente sotto il profilo della filosofia della natura, ma sempre in
rapporto a tutti i diversi aspetti della sua personalità filosofica.
L. LATTANZI, L’estetica musicale dell’Illuminismo tedesco, Centro Internazionale
Studi di Estetica, Palermo 2000, pp. 89.
L’attenzione dell’A. è concentrata sull’estetica musicale dei due protagonisti
dell’Illuminismo tedesco: Lessing e Mendelssiohn. Caduta la pregiudiziale del
principio d’imitazione, che Lessing e Mendelssohn ritengono elemento comune
delle arti solo come presupposto della teoria dell’illusione estetica, “resta la difficoltà di inquadrare la musica in un sistema che riconduce l’unità delle arti alla
natura raffigurativa, in senso lato pittorica, di ogni linguaggio artistico” (p. 12).
Mendelssohn non nasconde la sua difficoltà nei confronti dei progressi della
musica strumentale, avvicinandosi alla posizione degli enciclopedisti. Tuttavia,
le riserve di Mendelssohn hanno solo in parte a che fare con il canone classicista, e dipendono piuttosto “dalla concezione ebraica della musica e del suo
legame con la poesia, che esclude in principio il problema dell’autonomia estetica della musica” (p. 16). Proprio il genere di emozione suscitato dalla musica
induce Mendelsshon a riformulare la teoria dell’illusione estetica.
A proposito di Lessing, l’A. osserva che il riconoscimento delle potenzialità
e dei limiti di ogni arte non contraddice affatto, in Lessing, la definitiva riduzione del melodramma all’evento drammatico, ma “ne costituisce piuttosto il presupposto” (p. 51). La Drammaturgia di Lessing rivendica per il melodramma
come per la tragedia una libera creatività, che non si lascia costringere dalle
regole convenzionali, ma stabilisce nuove norme “nel momento stesso della
creazione, regole valide nel particolare contesto in cui sorgono” (p. 52).
Il saggio prende in esame un contesto intellettuale molo ampio, all’interno
del Settecento tedesco ed europeo, esaminando il rapporto fra matematica e
retorica, la semiotica musicale e la teoria dell’illusione, il confronto fra musica
antica e moderna, poesia e musica nel contesto della scuola liederistica berlinese, la musica e le “arti miste”, la riforma del melodramma, la danza e l’azione pantomimica, la riforma del balletto.
Il volumetto presenta quindi un quadro analitico delle tendenze fondamentali
dell’estetica musicale dell’Illuminismo, e specialmente dell’Illuminismo tedesco.
Un consistente apparato di note contribuisce all’identificazione di una
bibliografia essenziale sull’argomento trattato e offre una significativa base
erudita per la prosecuzione degli studi nello stesso campo.
119
Albino Babolin
G. MASI, L’idea barocca. Lezioni sul pensiero del Seicento, Clueb, Bologna
2000, pp. 295.
120
L’intento dell’A. è di ripercorrere, attraverso una definizione ‘teoretica’ del concetto di ‘barocco’, le linee di sviluppo della filosofia secentesca che possono riferirsi a tale definizione e all’atmosfera culturale del Barocco. Il Barocco è l’espressione di “un conflitto perenne, di un perenne dilemma, tra vecchio e nuovo, spirito di indipendenza e conformismo, libertà e necessità” (p. 18). Nel campo filosofico questa tensione si esprime nel continuo conflitto “fra la ricerca del nuovo e la
sua sistemazione logica in concetti, ossia come tensione fra tendenza metodica
e spirito di sistema “ (p. 18). Il Barocco è delineato dall’A. nella sua prospettiva
culturale, religiosa e filosofica. Dal punto di vista filosofico, la filosofia di Leibniz
sembra all’A. tradurre meglio “la natura policentrica del Barocco, la sua tendenza conciliativa e compromissoria, il suo fondamentale ottimismo”, la sua intuizione della “continuità della realtà”, il “dinamismo” (p. 121). Dal punto di vista religioso la filosofia di Leibniz è collocata a metà strada fra due tendenze, una di ispirazione neo-platonica e a carattere panteistico che culmina in Spinoza, e una
scolastico-aristotelica di carattere trasccendentalistico, di cui fanno parte
Campanella e Cartesio, il quale “riprende gli antichi schemi della dimostrazione
dell’esistenza di Dio riproponendola peraltro in funzione del problema del metodo (p. 124). Secondo l’A., invece, l’intento di Leibniz, insieme scientifico-filosofico
e religioso, è di conciliare, in base a uno stesso presupposto metafisico, Dio e
mondo, immanenza e trascendenza. Un’altra tendenza viene indicata in quella
mistica, di stampo cristiano, nella versione razionalistica di Malebranche e in
quella sentimentalistica di Pascal, mentre materialistica è la posizione di Hobbes.
Il volume contiene anche trattazioni specifiche di diversi autori e argomenti:
campanella e Galilei, Bacone e Hobbes, Cartesio e l’anticartesianesimo in
Francia, Spinoza e Leibniz. È interessante in questo contesto un giudizio sul platonismo di Cambridge: “la scuola di Cambridge con suo antideerminismo, anticonformismo, col suo spirito di tolleranza, bene esprime la resistenza attiva dello
spirito libero del Barocco alla temperie assolutistica e conformistica dell’epoca
ponendosi come correttivo alla filosofia hobbesiana e come anticipazione
dell’Illuminismo” (p. 208). Riguardo al pensiero religioso di Descartes, l’A. osserva che per Cartesio, come per S. Tommaso, la coincidenza del Dio razionale col
Dio cristiano si può desumere dagli attributi che Cartesio gli dà. “Cartesio si
muove su una linea di pensiero ortodossa: il suo Dio è come quello della Bibbia
e del Cristianesimo: un Dio trascendente e creatore” (p. 225). Il dualismo cartesiano corrisponde alla tensione che definisce il Barocco. “Se c’è un carattere
della mentalità cartesiana che più vale ad apparentarla al barocco, è proprio
l’ambiguità che si rivela nella stessa torsione del suo pensiero: perpetumente in
bilico fra autonomia e ortodossia, fra soggettivismo e oggettivismo, fra conformismo e originalità. Se l’originalità del suo pensiero si rivela soprattutto nell’aver
posto alla ribalta il soggetto, il suo conformismo si rivela, oltre che nella morale,
nell’aver fatto di Dio il deus ex machina di tutto l’apparato scientifico-metafisico
che dà luogo al ‘sistema’” (p. 232). Il pensiero di Pascal viene contrapposto a
RECENSIONI
quello di Descartes come una forma di empirismo fideistico.
Alla fine l’A. chiarisce che per lui il Barocco non è soltanto un fenomeno
storico ma una categoria dello spirito, è un fenomeno globale che investe lo
spirito dell’uomo in tutti i suoi aspetti. Il pensiero che lo caratterizza vibra di
contrasti, ma detesta il disordine, “mentre anela ad uscirne in forma sia metodica che sistematica, esprimenti un bisogno di ordine sia in campo scientifico
che filosofico” (p. 292).
Il volume è corredato di bibliografie alla fine di ogni sezione e di una conclusiva bibliografia generale.
Albino Babolin
AA.VV., Genealogia dell’umano. Saggi in onore di Aldo Masullo, a cura di G.
Cantillo e F. C. Papparo, I e II volume, Guida, Napoli 2000, pp. 812.
L’espressione ‘genealogia dell’umano’ sta a indicare, per i curatori di questa Festschrift, la linea principale della ricerca teoretica di Aldo Masullo, che si
può ricondurre alla tematica hegeliana del salto dalla vita soggettiva immediata dell’organismo alla soggettività che si fa coscienza nell’esistenza umana.
Nel pensiero di Masullo la genealogia si fa etica della dignità della persona e
della comunicazione, perché “quanto più il soggetto si afferma nel proprio infinito valore personale rifiutando di perdersi nell’indistinzione della massa, tanto
più si scopre fondato su una originaria comunità e chiamato ad agire in vista
della comunità” (p. 10). I numerosi saggi che costituiscono i due tomi di questa opera mettono in evidenza, sotto l’aspetto storico e teoretico, diversi aspetti di questa problematica. G. Cantillo si propone di mostrare alcune tracce di
un possibile percorso ‘oltre il trascendentale’ (in senso stretto), verso la storia
“passando attraverso un allargamento di senso del trascendentale (p. 15).
Bianca Maria d’Ippolito esamina il confronto di Masullo con la fenomenologia
secondo le due direttive principali dello “statuto del vissuto nella sua precipua
designazione intenzionale” e dell’uso della fenomenologia come “plesso di
concetti operativi” capaci di “rivelare le dimensioni nascoste dell’esperienza, il
pensiero implicito” (p. 75). Rossella Bonito Oliva, soffermandosi sul problema
del corpo in Hegel, richiama in definitiva l’attenzione sull’antropologia hegeliana. Marco Ivaldo sviluppa il suo saggio sulla base dell’ipotesi, secondo cui “la
monadologia di Leibniz rappresenta una premessa fondamentale del sistema
di Fichte” (p. 265). Francesco Donadio risale dal dibattito recente suscitato da
Apel e Habermas sull’etica della comunicazione e del dialogo all’idea di comunità di Royce. Giuseppe Ferraro sottolinea come Masullo abbia perseguito
“una sorta di continuo sbilanciamento dello storicismo ritrovandosi dentro e
fuori di esso, vicino al nichilismo attivo (p. 455). Fulvio Tessitore, mettendo
l’accento sull’ermeneutica hegeliana “che non ha bisogno della filologia” (p.
467) e sugli echi hegeliani nelle affermazioni crociane contro la storia filologica, parla di una “disgiunzione teorica tra due storicismi”, la cui diversità si
gioca appunto “intorno all’idea di filologia come scienza storica” (p. 472).
121
Giuseppe Cacciatore parla di “storicismo etico”, mostrando, sulla scia di
Piovani, come solo una concezione aperta e pluralistica della storia sia in
grado di favorire la comprensione dell’alterità e soprattutto il pieno riconoscimento etico “della presenza delle altre persone, delle altre coscienze morali,
dei bisogni, dei beni e dei valori oggettivi degli altri” (p. 498). Giuseppe Lissa
si sofferma sul pensiero di Michel Henry, chiedendosi se non si debba, al di là
di Heidegger e dell’ontologia, recuperare lo slancio della fenomenologia e rinnovarlo. La riflessione di Henry, appunto, “si svolge sul filo di questo confronto e porta, nei suoi risultati, alla proclamazione della subordinazione dell’ontologia alla fenomenologia” (p. 506). Il saggio di Domenico Jervolino è dedicato
al confronto fra marxismo critico e fenomenologia ermeneutica.
Abbiamo posto l’accento soltanto su alcuni dei saggi compresi in questi due
tomi. Come avviene spesso in volumi di questo tipo i contributi sono piuttosto
eterogenei, anche se è sempre visibile il richiamo ad alcuni temi di fondo, in particolare alla riflessione sullo storicismo, anche alla luce degli sviluppi del pensiero contemporaneo nella direzione della fenomenologia e dell’ermeneutica. Ed è
costante il riferimento all’insegnamento di Masullo. Si potrebbero comunque
delineare percorsi di lettura diversi. In generale i contributi sono di notevole
spessore teoretico, con precisi riferimenti anche al dibattito storiografico.
Albino Babolin
122
A. ARDOVINO, Il sensibile e il razionale. Schiller e la mediazione estetica, Centro
internazionale Studi di Estetica, Palermo 2001, pp. 73.
Il saggio offre un’analisi strutturale delle Lettere sull’educazione estetica
(1795) di Schiller. In particolare viene prestata attenzione all’impianto fondativo che in esse viene a più riprese delineato “per giustificare in termini filosofici l’esigenza di una mediazione estetica tra sfera sensibile e sfera razionale,
prima di ogni concreta esecuzione della mediazione stessa nel progetto di
un’educazione estetica dell’uomo” (p. 7). L’impianto fondativo, metafisico,
naturalmente acquista per Schiller un senso e una funzione nella misura in cui
è in grado di offrire “un solido terreno alla giustificazione ontologica di alcune
tesi centrali circa il ruolo e la natura dell’estetico in quanto tale” (p. 9).
L’A. presenta anzitutto lo sfondo storico-culturale in cui l’opera di Schiller si
radica; quindi sviluppa una breve ricognizione della successione organica
delle ventisette Lettere; in particolare mette in luce lo stacco netto, la “cesura
trascendentale” (p. 24) tra le prime dieci lettere e le seguenti. L’esigenza di
fondazione appare qui in modo del tutto trasparente, così come il platonismo
di fondo “che la sottende”. Il riferimento a Kant è costante. L’intero percorso
delle Lettere, secondo l’A., “può essere letto come un tentativo di radicalizzazione dello ‘schematismo della riflessione’ (sussunzione di facoltà prima ancora che sussunzione di delle fonti conoscitive cui esse si riferiscono) che Kant
ha messo a tema nella Critica della facoltà di giudizio” (p. 41). Più in generale viene alla luce una perfetta corrispondenza estetico-analogica tra storia e
Albino Babolin
B. CALLIERI, L. FARANDA, Medusa allo specchio. Maschere tra antropologia e
psicopatologia, Roma, EUR, 2001, pp. 106
“L’occhio è potentissimo e trae questa sua potenza dalla luce. L’occhio non
si stanca mai di vedere l’oggetto… Si è ribellato e ha vinto la volontà…
L’occhio fa da sé… Se lo immagina l’occhio? Sì, è l’occhio che guarda se stesso, l’occhio si specchia nella luce. Non vedo l’occhio, ma in sostanza so
cos’è…”. È lo psichiatra e psicopatologo Bruno Callieri a riportare le parole di
un suo paziente in una pagina mirabile del volume da poco pubblicato con
l’antropologa Laura Faranda Medusa allo specchio. Maschere tra antropologia
e psicopatologia. Poco più tardi, Callieri riprende così la sua analisi: “la personalizzazione di un occhio può essere letta anche come recupero apotropaico e apofanico, se non addirittura fenomenico di una maschera”.
Questo gesto ermeneutico, che lega istantaneamente l’occhio alla maschera, lo psicopatologico all’antropologico, la follia alla fenomenologia dell’esperienza circoscrive forse il significato dell’intero volume, che alterna rapidi,
intensi ritratti psicopatologici a saggi di riflessione antropologico-culturale.
All’intersezione tra le due discipline, l’ambizione di Bruno Callieri e Laura
Faranda è infatti quella di esibire la maschera assoluta, di individuare cioè il
RECENSIONI
struttura soggettivo-trascendentale, filosoficamente inevitabile: “Come il singolo individuo trascorre dal sensibile al razionale in ogni sua esperienza, così
è lecito ipotizzare che un’educazione estetica dell’umanità possa operare a
livello storico e politico ciò che già da sempre, a un livello schiettamente trascendentale, accade nel compaginarsi dell’esperienza in generale” (p. 55).
Uno dei saggi centrali dell’estetica schilleriana, quello Su poesia ingenua e
sentimentale, conferma, per l’A., nei suoi effetti l’esito metafisico ultimo dell’impianto fondativo. In esso, l’individuazione di una dimensione riflessiva della
poesia moderna non è altro che un ‘farsi innanzi’ del ‘soggetto in quanto soggetto’. La dimensione della Dichtung finisce per delinearsi in un continuo stato
di tensione e di irriducibilità rispetto a una mediazione puramente filosofica,
che può solo far capo alla “ostensione di un fondamento”. Ma sensibile e razionale, per Schiller, si conciliano autenticamente solo nell’arte. “ Proprio in quanto indicazione –osserva l’A.–, l’ostensione del fondamento non è ancora propriamente l’esecuzione, storica ed esistenziale, della mediazione… Schiller ha
cercato di fondare metafisicamente la possibilità, per l’uomo, di essere una
totalità e di esistere integralmente: ma l’attestazione di questa possibilità cade
ormai fuori dell’indagine” (p. 61).
È evidente che il pregio del libro consiste esattamente nel fatto che affronta le tematiche estetiche di Schiller alla luce del suo tentativo di fondazione di
una mediazione estetica fra il sensibile e il razionale e del rapporto fra riflessione estetica e tradizione metafisica moderna.
123
124
tratto essenziale, l’eidos di quel fenomeno universalmente umano e infinitamente vario che è la maschera. Medusa allo specchio è, così, un esperimento che porta a compimento con audacia, a trent’anni di distanza, il progetto
rimasto incompiuto di un libro che già avrebbe dovuto coniugare psicopatologia e antropologia, esperienza clinica e sapere etnografico: un libro cui lo stesso Callieri aveva iniziato a lavorare con Ernesto de Martino, e di cui è a tutt’oggi possibile consultare, tra le carte di quest’ultimo, una traccia che ne
descrive a grandi linee l’articolazione tematica.
Che cosa dunque è comune all’occhio, nell’esperienza radicalmente metafisica in cui la schizofrenia sprofonda il paziente descritto da Callieri, e alla
maschera, alla maschera descritta da Lévi-Strauss in celebri pagine, ad esempio, alla maschera cui la Grecia ha affidato il segreto della tragedia, alla
maschera cui il carnevale, la festa, il rito hanno affidato e ancora affidano in
Europa l’alchimia del tempo dell’eccezione, del passaggio, del transito, dell’impermanenza, dell’irruzione del nuovo o del disordine o dell’altro? Come
l’occhio e la maschera giocano, l’uno insieme all’altra, l’uno come l’altra, nel
dare forma e significato all’esperienza, e cosa fa sì che l’occhio nel delirio
divenga maschera e che la maschera intrattenga con l’occhio un rapporto
segreto e ineludibile?
Qualcosa di inapparente, di ovvio, di essenziale viene alla luce a partire da
questi margini del nostro mondo, della nostra esperienza, del nostro pensarci e
viverci come soggetti che sono il campo della psicopatologia e quello dell’antropologia culturale, quello del delirio e quello del mito. Questa essenziale
ovvietà è, in una parola, il fenomeno della soglia. L’occhio e la maschera sono,
ciascuno a suo modo, soglie, e ciò che nel delirio e nel mito è, se non saputo,
quanto meno messo sulla scena, esibito, attraversato nell’ombra, è esattamente questo indicibile sapere della soglia. Ogni maschera è una soglia, cioè
qualcosa che dispone anzitutto –se se ne volesse tentare una elementare fenomenologia– un al di qua e un al di là rispetto a sé. Un al di qua, un al di là ed
una tensione, un’intentio, un’istanza di significato che si tende e si distende tra
al di qua e al di là. Al di qua della maschera qualcuno, non visto, vede. Al di là
di essa qualcuno, visto ma incapace di vedere, abita nella distanza dall’invisibile, nel luogo che il suo essere esposto alla visione gli assegna. L’intero gioco
della maschera coincide con questa oscillazione tra invisibile e visibile, o, più
precisamente, tra ciò che si può vedere, ciò che effettivamente si vede, ciò che
non si può e non si deve vedere. Una complessa serie di interdetti impedisce
infatti ai non iniziati, nelle culture cui Lévi-Strauss ha dedicato, nella Via delle
maschere, pagine indimenticabili che Medusa allo specchio richiama ripetutamente, di conoscere o tentare di scoprire l’identità degli anziani che, celandosi
dietro la maschera, officiano il rito. Ma divieti ancora più terribili circondano,
durante e dopo il rito, l’accesso alla maschera stessa, e sanzioni durissime colpiscono chi abbia ad avvicinarsi ad esse, non autorizzato, a maneggiarle, a
impadronirsene. Più profondamente è dunque la maschera ad essere invisibile, e non semplicemente il volto di chi la porta. Il volto mascherato è solo
momentaneamente non visto, figura transitoria, caduca dell’invisibile; invisibile
in assoluto è la maschera, la soglia della visione, il suo luogo inaugurale. Non
RECENSIONI
ad altro alludono il vuoto delle orbite buie che intaccano la superficie colorata
delle maschere che osserviamo quietamente allineate nei nostri musei, l’enorme pupilla che ne sfonda la consistenza altrimenti impenetrabile, opaca.
Invisibile è la maschera, così come invisibile è la luce: si vede attraverso la
luce, ma la luce stessa, il sole è semplicemente accecante. Ed invisibile è l’occhio: attraverso l’occhio io vedo, ma l’occhio, notava già Wittgenstein, l’occhio
non lo vedo mai. Non lo vedo mai se non allo specchio. Ma lo vedo allora come
l’occhio di un altro, come un occhio che è visto, non come quell’occhio vede,
dunque come un occhio su cui Medusa, cui Callieri e Faranda intitolano elegantemente il libro, ha già posato il suo sguardo mortale. L’occhio coincide così
con la luce e con la venuta del mondo alla visibilità, e in questo senso non è
che ombra e ritrarsi o sottrarsi dal visibile. È forse questo ciò che il paziente di
Callieri enigmaticamente intuisce e disperatamente trasmette a chi –come
avviene in queste pagine– sappia cogliere filosoficamente il turbamento della
psicopatologia: l’occhio che “ha vinto la volontà” e che “fa da sé”, l’occhio
“potentissimo”, che trae questa potenza “dalla luce” e che “si specchia nella
luce”, l’occhio che “guarda se stesso”. Ma innumerevoli altri sono i luoghi in cui
al di qua e al di là, corpo e mondo si intrecciano, io e altro si sfiorano, si stagliano, si delineano nella loro oscillazione reciproca. È una soglia, mostra
Callieri moltiplicando gli esempi tratti da una vastissima esperienza clinica,
anche la superficie indecidibile dell’epidermide, che è già mondo ma anche e
ancora corpo, che è già corpo ma anche e ancora mondo. È una soglia la
bocca, che, mostra Laura Faranda in pagine finissime, domina la fisionomia
delle maschere greche e africane, trafitte dal vuoto di un urlo ininterrotto. Sono
soglie l’orecchio, la vagina, l’ano; ogni transito di quel corpo che la fenomenologia chiama corpo proprio e che la psicopatologia o l’antropologia mostra, in
queste pagine, nella sua più antica, forse insuperabile improprietà.
Improprietà più antica, perché quella che emerge nei deliri di chi si senta la
pelle pullulare di animali molteplici e inesauribili (delirio dermatozoico), di chi
veda il proprio spazio abitato da creature animate e incontrollabili (delirio zooptico), di che senta il proprio corpo abitato dal corpo estraneo di un animale selvaggio (delirio zoopatico) sembra essere l’esperienza di un corpo ancora indeciso, o nuovamente indeciso, mio e insieme non mio, familiare ed estraneo,
fidato e ingovernabile, arcaico e mai dismesso. Ciascuna di queste esperienze getta, sulla natura di ciò che abbiamo chiamato soglia, una luce tutt’altro
che priva di una propria vertiginosa intelligenza delle cose. Salvo che, insiste
a più riprese Callieri, questa intelligenza risulta, nell’esperienza psicopatologica, deformante. Il tratto più essenziale della soglia, quello dell’oscillazione
inafferrabile del dentro e del fuori, dell’avvolgimento interminabile dell’al di qua
e dell’al di là, finisce infatti con l’essere travisato, cancellato. Non più luogo di
un transito rispetto al quale l’esperienza accede istantaneamente, per poi ricadere, altrettanto istantaneamente, al di qua o al di là di essa. Non più battito
vitale, ritmo, vibrazione, bilanciarsi di sistole e diastole. Questo è ciò che
avviene nella festa, quando l’eccesso dilaga, e subito anche dilegua. Come gli
antropologi insegnano, in un rito la maschera compare e scompare, inaugura
e sigilla il circolo della perdita di sé e del ritorno a sé, della morte e della rige-
125
nerazione, della discesa nel caos e della riemersione ad un nuovo ordine. Ma
una maschera che non possa più essere strappata dal volto che la porta, un’esperienza interminabilmente stanziata intra festum, un corpo incapace di
transitare attraverso la propria soglia costitutiva e di ricaderne al di qua –come
corpo costituito, Husserl avrebbe detto, come corpo vivente ma anche sempre
parzialmente oggettivato, come corpo proprio sempre screziato di improprietà– questa maschera, quest’esperienza, questo corpo sono ormai radicalmente inabitabili e inospitali. “Chi volesse portare la maschera costantemente”, ha scritto Karoly Kereny in un suo straordinario saggio su Uomo e
maschera, “sarebbe un moro o un mostro”.
Forse la psicopatologia, l’antropologia, la filosofia non sono che il tentativo
di dire questa soglia primordiale, questo epicentro mostruoso ed elementare
dell’esperienza senza esserne assorbiti come avviene nel rito, o travolti come
accade nel delirio. Ciò che esse vedono e sanno è situato sempre ante festum
o post festum, alla soglia della soglia, un passo al di qua o al di là. Nessuno
stupore che il festum della maschera e del delirio, la loro esplosione senza
nome, la loro oscillazione ingovernabile sia il magnete segreto che ne attrae e
ne orienta ogni volta da capo l’ago.
Federico Leoni
126
C. ZAMBONI, Parole non consumate. Donne e uomini nel linguaggio, Napoli,
Liguori, 2001, pp.157.
Un gesto indispensabile per districare una matassa di filo e trovarne il bandolo, era quello di scuoterla leggermente, di scompigliarla per poi individuare,
tra i fili che ricadevano più morbidi e distanziati, quello che essendo all’inizio,
si poteva prendere e avvoltolare in gomitolo. Lo abbiamo visto fare dalle
nostre madri, probabilmente, qualcuna di noi, tra quelle che amano i rilassanti lavori manuali ai ferri o ad ago, lo ha fatto tante volte con sveltezza e certezza. Sì, perché le donne sanno che per rimettere in ordine, per ritrovare
senso, direzione, o semplicemente pulizia, bisogna creare squilibrio. Di questo creare squilibrio e dunque senso e pensiero, ci narra Chiara Zamboni in
Parole non consumate. Donne e uomini nel linguaggio.
Ho premesso un esempio, tratto dalla mia esperienza, per parlare dell’ultima pubblicazione di una filosofa del linguaggio, ormai nota, e che, in questo volume, con la sua personale maturità e scioltezza nel riflettere e nel dire,
ci apre un modo chiaro ed efficace per ripensare e comprendere la questione
della differenza sessuale.
Gli esempi sono cari a Chiara Zamboni; lo sono perché ci fanno fare un tragitto nel quale impariamo percorrendolo. “In questo senso – afferma - si tratta
di una filosofia pratica” (p.117). Gli esempi dicono cosa le donne e gli uomini
fanno nel lavoro, nella vita associata, nella politica. L’autrice utilizza tanti
esempi in questo suo lavoro, esempi che parlano di vita quotidiana, di insegnamento e rapporti con studentesse, di ricerca politica e rapporti con altre
RECENSIONI
donne, esempi che riportano riflessioni di filosofe e di filosofi; li utilizza perché
gli esempi sono testimonianza, mostrano il processo vivente nel quale siamo
implicate. Ma, immediatamente, ella aggiunge: eppure la sola testimonianza
senza pensiero non è sufficiente.
Entriamo così nel senso della sua ricerca che ha ormai raggiunto il pieno
sviluppo. È nel linguaggio, infatti, che Zamboni coglie i segni che aprono al
movimento dell’essere, a quel movimento, in cui i sentimenti, vissuti in un contesto, essendo anche in rapporto a delle parole, diventano e-mozioni, ossia
vive energie trasformatrici. Ciò le interessa particolarmente, perché è consapevole che la rivoluzione della viva energia trasformatrice del mondo è già il
primo atto politico. Primo nel senso di più importante e ben diverso da quello
di una politica, che molte donne seguono per dare rappresentanza alle donne
nel linguaggio, nelle istituzioni e nel lavoro.
Perché, sostiene l’autrice, non è solo quel che si dice, ma come lo si dice
e in rapporto a quale contesto, ciò che mostra che cosa ci sta orientando.
“L’anima è nei comportamenti, nei gesti e nelle parole” (p.125). Le inclinazioni
dell’anima sono, cioè, segni che si possono cogliere facendo attenzione al
rapporto che chi parla ha con il linguaggio, con l’altro a cui si rivolge, con il
mondo e con se stesso. Sono segni tra gli altri segni, perché i sentimenti dell’anima sono nelle azioni, nei modi, e nella lingua: in un certo modo di parlare
e di stare in rapporto alle parole degli altri.
Valenza politica di un dare testimonianza, che è dare parole alla presenza
pura. Facendo attenzione, però, perché le parole senza pensiero risultano
banali. Diventano parole consumate, di quella chiarezza banale che riconferma tutti i luoghi comuni e tutti gli stereotipi. Parole di soddisfazione narcisistica, parole statiche e separate dall’essere. Come persino quelle delle quali
molte studentesse sentono l’esigenza, per essere rappresentate nel linguaggio, come se le parole fossero uno specchio della loro esistenza. “Vogliono trovare nello specchio della grammatica il genere femminile espresso accanto a
quello maschile, ’avvocata’ oltre che avvocato ad esempio, per ritrovare un
luogo per se stesse nella società” (p.118). Zamboni ci avverte, invece, che la
trasformazione della lingua è significativa solo se è simbolica, se cioè la trasformazione della lingua e della realtà vanno di pari passo.
Nel linguaggio, come anche in politica, una piatta simmetria con gli uomini
non porta a una modificazione nella vita delle donne. Una volta rappresentate, tutto si acquieta e non c’è quello squilibrio che porta a una trasformazione
vitale. Il parallelismo statico, a cominciare dai generi grammaticali, non modifica nulla. “Il che non significa che sia sbagliato adoperarli e pretenderli
–aggiunge Chiara Zamboni- anzi, ma la vitalità di ciò dipende da quanto tale
richiesta mette in movimento sé in rapporto agli altri, ai codici, agli elementi
emergenti della società in cui si vive”.
Impariamo così, da un testo di filosofia del linguaggio, che la politica del
simbolico, agita dalla differenza sessuale è quella che mostra l’importanza del
legame tra segno e reale, e non affida la trasformazione del mondo soltanto al
linguaggio, o ai diritti, o alle rappresentanze. È quella che scuote tutta la
matassa per districare i fili e ritrovare il bandolo.
127
128
La differenza sessuale, infatti, non ha bisogno di andare incontro al narcisismo femminile e di appagarlo con un’immagine di sé nel campo del linguaggio, del religioso, del filosofico, del politico, sanando la ferita narcisistica e lasciando sostanzialmente le cose così come stanno; la differenza sessuale si mostra: ha solo bisogno di essere praticata, ha solo bisogno di questa testimonianza, che, come abbiamo detto, è anzitutto linguaggio, segno e
verità di una presenza pura. Zamboni vede la differenza sessuale come un
movimento, che dà nuovo significato alla realtà, senza formalizzarsi né cristallizzarsi in nuovi contenuti sociali; differenza avvertita soprattutto da alcune donne, ma non dagli uomini, che hanno dato una descrizione statica dei
rapporti tra i sessi, spartendo qualità maschili e femminili e richiudendo noi
e loro in un universo sigillato” (p.108).
Invece, l’universo non è sigillato: c’è, anzi, un’apertura tra noi e il mondo,
fatta di reciproca appartenenza. Quando “sentiamo” una verità, la nostra
soggettività si muove insieme al mondo e alle parole: “per questo c’è una
qualità ontologica nella verità che gustiamo nelle parole” (p.100). Allora soggettività e ontologia si muovono insieme, non perché il soggetto costruisce
il mondo e l’essere e vi si identifica, ma perché partecipa del mondo, delle
sue resistenze e modificazioni nell’apertura di verità che sperimenta. Nelle
parole, con le parole. Quelle parole semplici e concrete della lingua materna, ben diverse dai linguaggi specialistici rigidi e ingessati, diventano allora
parole non consumate, perché orientano come un motore segreto, perché
sottraendosi a ogni mestiere, non impongono sensi e comunicazioni, ma si
aprono e ci aprono al mondo, che è amicizia, desiderio, intelligenza, ricerca
di senso. Insomma, verità, che si può percepire, sentire, ma non declinare e
dire come se fosse un contenuto. Proprio come la differenza sessuale.
Marisa Forcina
UMBERTO CERRONI
Le radici culturali dell’Europa
Nell’età della globalizzazione e della tecnologia avanzata l’eredità umanistica e laica della
classicità conferisce all’Europa una centralità universale.
Le civiltà che qui si sono incontrate e scontrate consentono di fornire basi non fragili ai
moderni processi di integrazione etnica, sociale, politica. Un territorio che ha tratto sviluppo dalle differenze e differenze dallo sviluppo, mantenendo una centralità culturale e
intellettuale che lo rende campo ideale per la sperimentazione di pacifiche convivenze politiche, in un delicato equilibrio fra pluralismo e desiderio di universalità.
SAGGI
pp. 120 t 9,29
STEFANO CRISTANTE
Azzardo e conflitto
Indagini sull’opinione pubblica nell’era della comunicazione globale
pp. 208 t 12,91
Cos'è l'opinione pubblica? Come si spiegano le sue persistenti oscillazioni? Come influisce e come viene influenzata dai decisori e dai media?
Azzardo e conflitto costruisce un percorso di ricerca che, a partire dalla definizione del
misterioso oggetto sociale "opinione pubblica", possa stimolare un'indagine in profondità
degli eventi contemporanei con gli strumenti della sociologia e della mediologia.
I temi contenuti in questo libro –dal sexgate alla guerra del Kosovo, passando per una revisione del concetto di potere alla luce delle trasformazioni post-industriali– esplorano le
nuove possibilità di una visione politica dell'immaginario collettivo.
COSIMO CASILLI - NICOLA DE LISO
economia globalizzazione umanesimo
pp.192 t 13,00
Il passaggio verso la globalizzazione del sistema produttivo, del mercato e dei modelli ha
dietro movimenti immensi e interessi potenti, e determina squilibri drammatici. Tempo ci
vorrà per darne un giudizio storico, quello che è importante ora è capirne i meccanismi per
partecipare il più consapevolmente possibile allo sforzo necessario per governarli, affinché
gli squilibri si riducano e le opportunità il più possibile – e per il maggior numero di persone possibile – si colgano. Capirli per agire positivamente e valorizzare la qualità accanto al
costo, la particolarità accanto alla generalità, il locale accanto al globale.
È la ragione di questo libro, che offre strumenti per comprendere e avanza proposte per agire.
Stampa: Tiemme - Manduria
nel gennaio 2002
per conto di Piero Manni s.r.l.
129
130