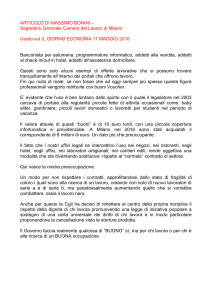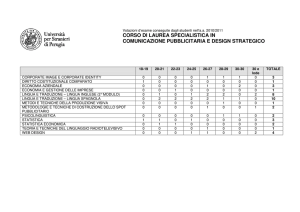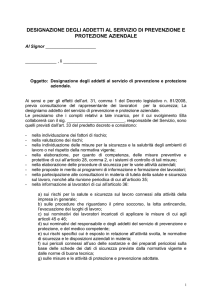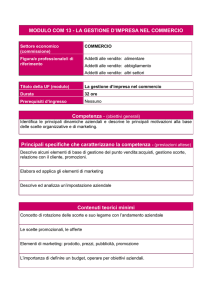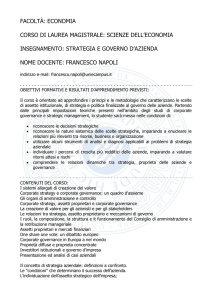Rapporto Corporate
EFIGE
Aprile 2011
Undicesima indagine
sulle imprese
manifatturiere italiane
022011
A cura di
Andrea Brasili, Responsabile editoriale
[email protected]
Luigia Mirella Campagna
[email protected]
Elena d’Alfonso
[email protected]
Silvia Giannangeli
[email protected]
Attilio Pasetto
[email protected]
Antonio Riti
[email protected]
UniCredit Corporate Analysis
La ricerca che ha condotto a questi risultati è stata finanziata dal Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea (FP7/2007-2013)
attraverso l'accordo n. 225551. Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile visitare il sito www.efige.org
La raccolta dei dati è stata effettuata dalla società GfK Eurisko.
Premessa
a cura di Roberto Nicastro
Senza catastrofismi, senza drammi, non si può non osservare che, lungo tutte le fasi di un intero ciclo
economico durato approssimativamente un decennio (dal 2002 al 2011), caratterizzato dalla più dura
recessione globale dal dopoguerra ad oggi, l’economia italiana ha continuato a mostrare un ritmo di
crescita più lento degli altri paesi, una capacità competitiva, nel complesso, calante.
Intendiamoci, questa è un’affermazione difficilmente controvertibile ma per quanto evidente, non è per
niente semplice, non produce conseguenze automatiche. Nei dibattiti sui media negli anni passati il
nick name di “sick man of Europe” è stato utilizzato per diversi paesi, per esempio per la Germania a
partire dagli anni ’90 e nei primi anni del 2000; nel 2005 l’epiteto di “malato” d’Europa, l’Economist
l’ha assegnato all’Italia. Potrebbe sembrare che diagnosticare una malattia significhi abbastanza
automaticamente suggerire una cura, ma non è così in questo caso. Intanto, si può dibattere di chi sia il
ruolo di trovare diagnosi e cura, ma è abbastanza chiaro che non è di una banca. Tuttavia, ci sono due
motivi per cui diviene di interesse anche per una banca interrogarsi su questi temi.
Il primo è quasi una conseguenza involontaria, un prodotto correlato di un’altra attività: la banca ha una
relazione individuale con il proprio cliente-impresa, ne vorrebbe conoscere al meglio le caratteristiche
per comprenderne potenzialità e rischi, per poterla consigliare se ne è partner, per poterla supportare
nell’operatività, se le viene richiesto.
Il secondo motivo è che l’ampiezza del ritardo accumulato negli ultimi anni pone la questione in modo
così intenso che una banca, che è un’impresa tra le altre imprese, con dimensione più che nazionale
non può non essere interessata a capire come può evolvere uno dei suoi mercati di riferimento.
Di fatto, bisogna tenere presente che per un paese inserito in un’area monetaria e con vincoli comuni
di politica fiscale l’eventuale problema di cui si cerca una soluzione non può essere di regolazione
macroeconomica: è, quasi di necessità, microfondato come dicono gli economisti, cioè non può che
trovarsi nelle caratteristiche, nelle pieghe dell’operare delle imprese.
Inevitabile dunque che nello sforzo, che ci è richiesto, di capire le necessità individuali emerga, qualche
volta, uno sguardo d’insieme, un punto di vista più ampio che può dare informazioni rilevanti.
La conoscenza dell’impresa e delle sue necessità è il motivo fondante di questo progetto che nasce
dalla lunga tradizione dell’indagine sulle imprese manifatturiere (è l’undicesima edizione, la prima risale
al 1982) e si proietta verso un futuro internazionale. L’indagine attuale è stata svolta in sette paesi
europei e consente di comparare le imprese lungo una dimensione finora inesplorata, ovvero su dati
“individuali”. L’indagine consente quindi uno sguardo d’insieme che è necessario quando si parla di
comportamenti singoli, altrimenti si resta abbagliati dal particolare: non stiamo parlando né dell’impresa
che apparentemente dal nulla, giunge nel suo settore a dominare il mercato e a conquistarne di nuovi, né
di quella che invece non ha saputo rendere stabile il suo successo e ha perso progressivamente terreno.
Stiamo parlando di un sistema economico che è un aggregato di entrambi i tipi di impresa e che, per dirla
tutta, sembra sia al momento caratterizzato da una certa prevalenza del secondo gruppo rispetto al primo.
Torniamo alla diagnosi, cercando nelle risposte delle imprese indicazioni su quali fattori possano
essere sottesi alle difficoltà che si leggono in aggregato. In un mondo ormai globalizzato è inevitabile
partire dalla relazione delle imprese con l’estero: è noto che le imprese italiane siano molto attive
come esportatrici, ma la globalizzazione implica sforzi anche in altre direzioni. È necessario infatti
Rapporto Corporate I
1
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
che il sistema produttivo sia in grado di comprare e non solo di vendere: l’immagine dell’economia
tedesca come “bazaar economy” coniata anch’essa all’inizio degli anni 2000 per sottolineare il rischio
di sostituire completamente la manifattura domestica con produzione estere, è diventato ora sinonimo
della capacità di approvvigionarsi in maniera efficiente di input intermedi. Su questo terreno, la
catena di fornitura delle imprese italiane sembra ancora troppo semplificata, in prevalenza basata su
acquisti di materie prime dall’estero. Ancora, l’attività verso il resto del mondo è comunque focalizzata
prevalentemente verso l’Europa. Per quanto emerge dall’indagine, si potrebbe coniare la definizione di
“globalizzazione incompiuta” per le imprese italiane. L’incompiutezza deriva non solo dal limitato raggio
d’azione ma anche dalla prassi con cui è realizzata. In riferimento agli investimenti diretti esteri prevale
infatti una modalità che potremmo definire di “internazionalizzazione leggera” - attuata in prevalenza
tramite accordi commerciali - oppure con la preminente finalità di delocalizzare - per ragioni di costo fasi dell’attività produttiva. Pochi interventi sono volti ad aprire la strada a nuovi mercati o ad acquisire
il pieno controllo di un input intermedio importante o di una capacità produttiva specifica.
D’altro canto affinché si realizzi una presenza all’estero più “pesante”e su mercati sia in acquisto
che in vendita più lontani, è ineludibile affrontare la questione della dimensione d’impresa. È noto
che la dimensione media del settore manifatturiero italiano è notevolmente inferiore ad esempio a
quella tedesca (9 addetti contro 35.8) e che il ruolo giocato dalle imprese italiane medie e grandi è
ridotto. Il problema non risiede nella piccola dimensione di per sé ma nel fatto che l’accesso pieno
alla globalizzazione sia difficile per un’impresa piccola. È però complicato capire perché le imprese
italiane non crescano abbastanza. A questo proposito, l’indagine offre indicazioni che fanno riferimento
a vincoli esterni ed interni. In primo luogo le imprese indicano esplicitamente come ostacoli che si
frappongono alla crescita dimensionale le rigidità di natura burocratico-normativa, confermando che il
contesto istituzionale non favorisce la crescita. Esistono però una serie di indicazioni che si traggono
indirettamente attraverso la lettura complessiva dei dati e che fanno riferimento a fattori interni alle
imprese: alcune loro caratteristiche infatti sembrano essere in tensione con l’idea della crescita
dimensionale. Non è la questione della proprietà familiare (diffusa anche in altri paesi e soprattutto in
Germania) ma della sua coesistenza con un modello organizzativo molto accentrato, con poca delega ai
manager e con una prevalenza di manager comunque legati alla famiglia proprietaria. Questa tensione
si manifesta per esempio nel fatto che l’introduzione di innovazioni, che anche se non codificata pure
è frequente nelle imprese italiane, è associata con più difficoltà a mutamenti di natura organizzativa,
che probabilmente ne renderebbero più redditizi gli effetti. Specchio dello stesso fenomeno è lo scarso
utilizzo di strumenti e investimenti in ICT sofisticati di supporto all’organizzazione.
Globalizzazione e dimensione sono dunque due temi importanti ma non completamente esaustivi. Esiste
infatti anche un tema di posizionamento all’interno della filiera produttiva su scala globale, che sempre
più assume un respiro internazionale: se l’obiettivo verso cui le imprese italiane debbano tendere non
può essere per tutte quello di divenire il punto di riferimento, terminale o centrale, della filiera, resta
fondamentale essere partecipi di questa filiera pur non guidandola. Però per le imprese di un paese ad
alto reddito questo vuol dire affermarsi nel ruolo di fornitore di eccellenza; per svolgere questo ruolo
l’impresa deve trasformare fattori di produzione di qualità in output di prim’ordine. Anche su questo
l’indagine fornisce indicazioni non del tutto positive. Per esempio la presenza di lavoratori stranieri è
quasi sempre connessa a produzioni di livello qualitativo basso, come se si rinunciasse all’utilizzo di un
2
I Rapporto Corporate Efige
fattore produttivo potenzialmente prezioso, apportatore di competenze, come può essere un manager
o un tecnico non italiano, beneficiando dell’accresciuta mobilità favorita dall’Unione Europea e dalla
moneta unica. Non solo, nella “auto-valutazione” della qualità dei loro prodotti le imprese italiane
sembrano un po’ più timide delle altre.
Non si fraintenda, lo sguardo di insieme non restituisce un’immagine pessimistica per due ragioni:
la prima è che mette in luce attitudini importanti, sia verso i mercati esteri che verso l’innovazione,
pur evidenziando il bisogno di crescere in complessità. La seconda ragione è che contiene esplicite
linee d’azione. Che indicazione se ne trae per la banca? Non pretendiamo di (anzi di fronte a certi
dibattiti verrebbe da dire pretendiamo di non) essere noi a risolvere questi problemi, ma questi come
detto sono microfondati, sono problemi individuali, e allora la banca si proporrà di operare per favorire
l’intrapresa di certi mutamenti organizzativi, di spingere alla crescita dimensionale o alla scelta di
internazionalizzare in modo differente la propria attività qualora ce ne siano le condizioni, qualora
la competizione lo richieda. Certo è che in un mercato finanziario basato principalmente sul credito
bancario e che lamenta la limitata presenza di operatori specializzati nell’offerta di capitale di rischio
per la crescita di impresa (tutta la filiera che va dal venture capital al private equity e infine al mercato
azionario) sarebbe auspicabile costruire una relazione banca-impresa più intensa di quella che, come
confermato dall’indagine, ha caratterizzato l’ultimo decennio nel nostro Paese. E per questa via, magari,
le imprese del primo tipo, quelle di successo, diventeranno un po’ di più di quelle del secondo.
Rapporto Corporate Efige I
3
4
I Rapporto Corporate Efige
INDICE
SEZIONE 1 - LE IMPRESE ITALIANE NEL CONTESTO CONGIUNTURALE
5
Le imprese italiane nel contesto congiunturale
6
SEZIONE 2 - INDAGINE SULLE IMPRESE MANIFATTURIERE ITALIANE
13
Corporate governance, gestione dell’impresa e forme di aggregazione
Le imprese familiari
14
Occupazione, qualità del capitale umano, formazione
Management femminile e management familiare
22
Investimenti, innovazione tecnologica e R&S
Innovazione e trasformazione organizzativa
delle imprese italiane ed europee
30
Internazionalizzazione commerciale e produttiva delle imprese italiane
38
Concorrenza e mercati
La percezione della qualità del prodotto nelle scelte delle imprese italiane
48
Finanziamento dell’impresa e ruolo della banca
Gli strumenti derivati come copertura e i rischi delle attività internazionali
54
SEZIONE 3 - APPROFONDIMENTI
63
Crisi e innovazione: il ruolo delle strategie per il finanziamento della R&S
64
La forza lavoro straniera in Italia: alcune evidenze a livello d’impresa
70
L’impatto della crisi sulle esportazioni italiane nel 2009.
Caratteristiche d’impresa e strategie di esportazione
76
L’effetto della crisi sulle imprese di grandi dimensioni
82
APPENDICE
89
Aspetti metodologici
89
Rapporto Corporate Efige I
5
LE IMPRESE
ITALIANE
NEL CONTESTO
CONGIUNTURALE
Rapporto Corporate
Le imprese italiane nel contesto congiunturale
LE IMPRESE ITALIANE
NEL CONTESTO
CONGIUNTURALE
a cura di Andrea Brasili
La fase congiunturale globale
pare essere a due velocità: come
sottolinea il FMI, sembra ci una
parte del mondo che corre e una
che gradualmente ricomincia a
camminare In questo contesto, e
cercando di descrivere la situazione
delle imprese italiane manifatturiere,
i dati suggeriscono che dopo il
brusco calo del 2009 e il graduale
recupero registrato nella gran parte
del 2010 sembra aver perso un
po’ di slancio nelle ultime rilevazioni.
Queste poche pagine hanno il ruolo di cercare
di fornire il quadro di riferimento, dal punto
di vista congiunturale, del tessuto delle
imprese manifatturiere italiane visto da dati
più aggiornati e, in genere, più aggregati di
quelli di cui si discute nel seguito di questo
lavoro. Per tracciare questo quadro è utile fare
riferimento alle parole del FMI che descrive la
situazione attuale come una fase di recupero
a due velocità con una parte del mondo che
corre e una che gradualmente ricomincia a
camminare. Questo si riflette direttamente nei
numeri della crescita: il Pil dei paesi sviluppati
è cresciuto del 2,5%1 nel 2010 ed è previsto
crescere allo stesso ritmo nel 2011, e quello
dei paesi emergenti o ad alto tasso di sviluppo
che in entrambi gli anni dovrebbero avere
un ritmo di crescita del 6,5%. Pur essendo
un quadro di ripresa e crescita tutt’altro che
esente da rischi (al di là di quelli imponderabili
o non di stretta matrice economica di cui
abbiamo avuto esempi recentissimi), ce ne
sono sostanzialmente due ben evidenti: da un
lato, quelli legati ai timori sull’equilibrio fiscale
di alcuni paesi, dall’altro, quelli connessi alle
dinamiche dei prezzi delle materie prime, che
sembrano evolvere in relazione alla crescita
espressa dal mondo che corre e quindi non
essere compatibili con il graduale recupero dei
paesi sviluppati.
In questo contesto, è noto che l’economia
italiana ha registrato una robusta caduta
dalla quale è uscita più lentamente rispetto
8
I Rapporto Corporate Efige
agli altri paesi dell’area euro. Il Pil è
aumentato dell’1,3% in termini reali nel
2010 (dopo il calo del 5,2% nel 2009), con
una crescita dei consumi privati di appena
lo 0,6%: le difficoltà del mercato del lavoro,
che non ha ancora registrato in maniera
convincente un’inversione di tendenza
dopo la crisi, rendono debolissima la
domanda per consumi; il 2011 si è aperto
con un calo delle vendite al dettaglio dello
0,3% m/m e dell’1,2% a/a.
In questo contesto, e cercando di descrivere la
situazione delle imprese, il punto di partenza
è dato dalla dinamica della produzione
manifatturiera, che dopo il brusco calo del
2009 e il graduale recupero registrato nella
gran parte del 2010 sembra aver perso
un po’ di slancio nelle ultime rilevazioni. Il
confronto internazionale con i paesi vicini
fornisce un’indicazione non particolarmente
rassicurante, rendendo evidente il diverso
ritmo non solo nella fase storica che ha
preceduto la crisi, ma anche nella fase
espansiva che l’ha seguita, soprattutto rispetto
alla Germania. Quest’ultima ha registrato un
incremento tra il punto di minimo di marzo
2009 (aprile per la Germania, maggio per
l’Austria) e il livello dell’indice di produzione
di gennaio 2011 del 23,9%. Per l’Italia il
recupero è stato del 9,8%, ma soprattutto i
dati degli ultimi mesi evidenziano una chiara
perdita di ritmo, come se la spinta della fase di
ripresa fosse già esaurita: il livello dell’indice a
gennaio 2011 è lo stesso di maggio 2010.
L’apertura al confronto internazionale
sui dati di produzione non può che
richiamarne un altro, quello sugli indicatori
di fiducia delle imprese manifatturiere,
che, a partire dalle rilevazioni nazionali,
viene armonizzato dalla Commissione
Europea e rende disponibili i dati con
dovizia di particolari. Anche in questo caso
il punto di minimo durante la crisi è quasi
simultaneo ed è stato toccato nell’aprile
del 2009. In termini di comparazione con
i livelli pre-crisi, le imprese tedesche sono
più fiduciose oggi di quanto lo fossero
all’apice del ciclo precedente e cioè nel
periodo tra fine 2006 e la prima metà
del 2007, le imprese francesi hanno da
poco superato i loro massimi del ciclo
precedente, mentre per l’Italia, e ancora
di più per la Spagna, questi livelli sono
ancora distanti.
Un’altra caratteristica che val la pena di
notare guardando a questi dati è che la
sensazione di dispersione che il grafico
consegna è assolutamente veritiera: la
distanza a marzo 2011 tra il livello più basso
(la Spagna nei dati in questo caso) e quello
più alto (la Germania) ci sono 25 punti, il
massimo dal 1991 ad oggi. Anche se non è
l’oggetto di questo studio, la questione della
convergenza nella dinamica delle economie
dell’unione monetaria è tema importante,
non eludibile nei dibattiti e nelle scelte di
politica economica.
Le altre informazioni contenute
nelle indagini di fiducia delle
imprese manifatturiere
Ci sono altre informazioni rilevanti
nelle indagini sulla fiducia, di solito
relativamente poco enfatizzate, ma
importanti per avere indicazioni sulla
dinamica delle imprese. Queste
informazioni sono contenute nelle
domande a frequenza trimestrale poste
alle imprese. La prima riguarda la capacità
utilizzata, che fornisce informazioni
rilevanti su quale sia la potenziale
pressione ad investire per le imprese, o
L’indice della produzione manifatturiera (%)
Italia
Eurozone
Germania
Spagna
Francia
120
110
100
90
80
Gen-05
Set-05
Mag-06
Gen-07
Set-07
Mag-08
Gen-09
Set-09
Mag-10
Gen-11
Fonte: Eurostat
La fiducia delle imprese manifatturiere (%)
Italia
Eurozone
Germania
Spagna
Francia
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Gen-05
Set-05
Mag-06
Gen-07
Set-07
Mag-08
Gen-09
Set-09
Mag-10
Gen-11
Fonte: Commissione europea
se, viceversa, un utilizzo non pieno della
capacità già installata suggerisca cautela.
Si deve tenere presente che anche
questo indicatore è risultato delle risposte
delle imprese ad una domanda e quindi
“contiene” una componente di valutazione
idiosincratica, tant’è che le valutazioni
delle imprese dei diversi paesi raramente
si incrociano. Può essere utile allora,
più che dire che il livello di utilizzo della
capacità delle imprese italiane è più basso
di quello delle imprese degli altri paesi,
valutare lo scostamento del livello attuale
dalla media di lungo periodo: da questo
punto di vista, le imprese tedesche sono
le uniche (tra i quattro paesi considerati)
per le quali il livello attuale dell’utilizzo
della capacità è superiore alla media
2000-2007, mentre, tra gli altri paesi,
le imprese italiane sono le meglio
posizionate, situandosi al 5,4% di distanza,
contro il 6,8% delle francesi e l’8,1%
delle spagnole. Non sembra quindi che,
sebbene vi sia un margine ancora ampio
di capacità inutilizzata essa sia più grave
o preoccupante che negli altri paesi, e
non dovrebbe costituire di per sè un freno
particolare alle scelte di investimento.
Rapporto Corporate Efige I
9
Rapporto Corporate
L’altro indicatore importante è la
percezione delle imprese del proprio
posizionamento competitivo nel
mercato di riferimento, distinguendo tra
il mercato domestico, l’Unione Europea
e i mercati extra unione: alle imprese
è richiesto di rispondere se la propria
posizione competitiva sia migliorata, sia
rimasta stabile o sia peggiorata. Anche
in questo caso, tenendo presente il
livello pre-crisi, sembra che le imprese
italiane abbiano recuperato posizioni
sui mercati “lontani”, mentre continua
a permanere un gap competitivo sia
sul mercato domestico che su quello
dell’Unione, tra l’altro con la conferma
di un nuovo peggioramento negli ultimi
mesi (che somiglia al plateau che si
nota nei dati di produzione).
I profitti dai dati di
contabilità nazionale
Ma in concreto come evolve la dinamica
della profittabilità delle imprese? I
dati di bilancio sono informativi in tal
senso ma con molto ritardo. Dai dati
di contabilità nazionale si può ottenere
un’idea grezza di profittabilità lorda (per
macrosettore di attività), sottraendo al
valore aggiunto il costo del lavoro. Il
grafico evidenzia la variazione a/a di
questa misura di profitto operativo lordo.
I risultati relativi al settore manifatturiero
italiano mostrano un recupero del 10,9%
nel 2010, dopo il calo del 20,6% nel
2009. Guardando al profilo trimestrale
però, i dati confermano il rallentamento
registrato nella seconda metà del
2010, con il tendenziale che nel quarto
trimestre torna appena sotto lo zero.
Il paragone a livello internazionale
suggerisce che, da un lato, vi è una
differenza notevole con la Germania: la
serie storica del margine operativo lordo
per questo paese, rappresentata nel
grafico sulla scala di destra, a fine 2010
è ancora largamente in territorio positivo
(+44% a/a), pur tenendo presente che
anche l’escursione negativa del 2009
Le imprese italiane nel contesto congiunturale
La capacità utilizzata (%)
Italia
Eurozone
Germania
95
90
85
80
75
70
65
60
2000-Q1
2001-Q4
2003-Q3
2005-Q2
2007-Q1
2008-Q4
2010-Q3
Fonte: Commissione europea
La posizione competitiva nei diversi mercati (%)
Domestico
EU
Extra EU
10
5
0
-5
-10
-15
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q2
2005
Q1
2005
Q4
2006
Q3
2007
Q2
2008
Q1
2008
Q4
2009
Q3
2010
Q2
2011
-Q1
Fonte: Commissione europea
Margine operativo lordo per la manifattura (%)
Italia
Francia
Spagna
Germania, sc. Destra
30
80
20
60
10
40
0
20
-10
0
-20
-20
-30
-40
-40
-60
-50
2000
Q01
Fonte: Eurostat
10 I Rapporto Corporate Efige
Spagna
Francia
2001
Q3
2003
Q1
2004
Q3
2006
Q1
2007
Q3
2009
Q01
2010
Q03
-80
è stata più ampia. Vi è un po’ di differenza
anche con gli altri due paesi: le imprese
spagnole, con pur un progresso nell’intero
2010 del 6,2%, hanno chiuso l’anno in
crescendo (+10,1% nel quarto trimestre),
quelle francesi invece presentano un profilo
più debole, anche se anch’esso in lieve
miglioramento a fine 2010.
Livello della produzione e utile lordo per le piccole e medie imprese (%)
Variazione utile lordo
Livello della produzione
40
30
20
10
0
I profitti delle piccole
e medie imprese
A questa prima indicazione sui differenziali
del ritmo della ripresa all'interno dell'unione
monetaria se ne associano altre due, invece
di natura microfondata sulla dinamica delle
piccole imprese da un lato e delle grandi
dall'altro. Sulle piccole ci rifacciamo all’indagine
congiunturale che UniCredit conduce insieme
a Confapi. Riportiamo qui l’indice di diffusione
(che esprime il saldo tra le imprese che vedono
una variabile in diminuzione e quelle che
la segnalano in aumento), relativo al livello
della produzione e alla variazione dell’utile
lordo. Come si evince dal grafico, c’è un
miglioramento graduale anche se le imprese
confermano anche in questa indagine la
difficoltà di raggiungere i livelli pre-crisi e la
sensazione (l’ultimo dato è una aspettativa per
il semestre in corso) di aver rallentato il ritmo.
Anche dal punto di vista dei profitti, si evince
sul dato di fine 2010 un certo rallentamento, e
il saldo di diffusione resta in negativo, indicando
quindi che c’è una maggioranza di imprese che
segnala un peggioramento.
Non stupisce troppo questa pressione sui
margini di profitto, soprattutto tenendo
presente quanto detto in apertura: a fronte
di una domanda debole (soprattutto quella
domestica, ancora fondamentale per le
piccole imprese), è impossibile trasferire
sui prezzi di listino le pressioni provenienti
dalle commodities e quindi dai costi. Il
grafico mostra l'incidenza delle variazioni
nei prezzi di listino e nei costi di produzione,
chiaramente spostata a destra (verso gli
aumenti dei costi, ed era già così nel primo
semestre del 2010).
-10
-20
-30
-40
-50
-60
II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem
2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011
Fonte: indagine UniCredit Confapi - I semestre 2011
I margini per le piccole e medie imprese (%)
Variazioni prezzi di listino
Variazioni costi produzione
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
< -20 tra -20 tra -9
e -10
e -5
tra -4
e -2
tra -2
e0
0
tra 0
e2
tra 2
e4
tra 5
e9
tra 10
e 20
>20
Fonte: indagine UniCredit Confapi - I semestre 2011
Ci sono altre due caratteristiche che ci
preme sottolineare a partire da questa
indagine: la prima è che le imprese (quelle
che esportano) suggeriscono come la
domanda finale proveniente da mercati
lontani (extra Unione) continua ad essere
ben più dinamica del totale, meno vivace ma
positiva quella proveniente da mercati esteri
più vicini (l’Unione Europea), stagnante quella
derivante dal territorio nazionale. L’altra
informazione rilevante riguarda la situazione
congiunturale delle imprese per dimensione:
l’andamento della situazione corrente e della
profittabilità migliorano al crescere della
dimensione aziendale. Riguardo al livello
della produzione, mentre i saldi di opinione
delle imprese al di sotto dei dieci addetti
rimangono in territorio negativo, oltre i dieci
addetti i giudizi appaiono via via sempre più
positivi. Dal lato dell’utile lordo, il saldo resta
in territorio negativo per tutte le dimensioni,
ma c’è un chiaro miglioramento al crescere
della dimensione. Le micro imprese scontano
evidentemente la loro oggettiva difficoltà ad
andare oltre il mercato nazionale, mentre le
imprese di maggiore dimensione riescono
ad avvalersi delle migliori opportunità offerte
dalla domanda internazionale.
Rapporto Corporate Efige I 11
Rapporto Corporate
Le evidenze descritte a partire
dall’indagine UniCredit-Confapi
riguardano prevalentemente imprese
piccole e medie.
I profitti delle imprese
quotate
Sulle grandi imprese si può trarre
qualche indicazione aggregando le
risultanze delle trimestrali o semestrali
delle imprese quotate. Senza pretesa
di rappresentatività, abbiamo
selezionato da Bloomberg una lista di
imprese quotate2 ascrivibili al settore
manifatturiero per alcuni dei paesi
europei, di cui si è finora discusso,
calcolando per essi la dinamica
di due differenti indicatori di profitto
(il net profit ratio e il ROE). Per entrambi
la storia pre-crisi è abbastanza
variegata: si nota comunque un livello
di profittabilità elevato delle imprese
spagnole (associabile all’evidenza di un
tasso di crescita per l’economia iberica
sistematicamente più alto di quello degli
altri paesi qui presentati fino al 2007),
un’accelerazione nelle performance delle
imprese tedesche e una dinamica più
contenuta ma generalmente sincrona
(con la parziale eccezione del periodo
2007-2008) con quella degli altri due
paesi per le imprese italiane e francesi.
Poi, almeno per le grandi imprese e
contrariamente alle indicazioni relative
alla fiducia viste prima, la fase di crisi e
l’uscita da essa mostrano co-movimenti
estremamente vicini.
Tutto questo fino alle ultime date, in cui,
come già visto per la produzione e per
la fiducia, la performance delle imprese
italiane diviene meno brillante.
Le imprese italiane nel contesto congiunturale
Livello della produzione e utile lordo per classe di addetti (%)
Livello della produzione
Variazione Utile Lordo sc.destra
60
0
50
-5
40
-10
30
20
-15
10
-20
0
-25
-10
-20
1-5
6-9
10-20
21-49
50-99
-30
100-249
Fonte: indagine UniCredit Confapi - I semestre 2011
Le imprese manifatturiere quotate: il rapporto tra profitti netti e vendite (%)
Italia
Francia
Spagna
Germania
Dic-09
Mar-11
Italia
Francia
Spagna
Germania
Dic-09
Mar-11
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Set-03
Dic-04
Mar-06
Giu-07
Set-08
Fonte: nostre elaborazioni su dati Bloomberg
Le imprese manifatturiere quotate: il Return On Equity (%)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Set-03
Dic-04
Fonte: nostre elaborazioni su dati Bloomberg
12 I Rapporto Corporate Efige
Mar-06
Giu-07
Set-08
Conclusioni
Quale quadro emerge da queste indicazioni
tra il micro e il macroeconomico, focalizzate
sulle performances delle imprese italiane?
Cominciamo dalle evidenze positive: la
capacità utilizzata è risalita significativamente
e un ampio rimbalzo è visibile anche negli
altri dati utilizzati. Però la produzione
manifatturiera, e in modo molto simile
anche l’indicatore di fiducia e le misure
di profitto, mostrano una dinamica meno
brillante di quella degli altri paesi e un po’
di stanchezza nella fase di recupero, come
se dopo lo shock del 2009 si fosse generato
uno scalino non del tutto recuperabile.
Sintetizzando con uno slogan l’impressione
che se ne trae, è che alle imprese italiane
manchi un guizzo, un qualcosa, lo sprint
finale, il colpo di reni del velocista in vista
del traguardo o del saltatore quando è in
prossimità dell’ostacolo. Il grafico relativo alla
percezione della posizione competitiva delle
imprese, per quanto sia il più “aleatorio” dei
dati presentati, essendo basato su sensazioni
e quindi il più lontano dagli hard data è però
importante. Le imprese italiane percepiscono
un buon posizionamento sul mercato
“lontano” - al di fuori dell’Unione Europea ma questo potrebbe facilmente essere legato
non tanto a una maggiore competitività – e
quindi a un aumento delle quote di mercato delle nostre imprese su questi paesi, ma alla
domanda crescente dei paesi “emergenti”.
Quando si passa a considerare l’operatività
delle imprese all’interno dei confini
dell’Unione Europea, infatti, si incontrano più
difficoltà per la concorrenza di imprese che
provengono da altrove, probabilmente proprio
da quel mondo “lontano” che mostra tassi di
crescita a noi oramai sconosciuti.
Questo è un classico problema che ha
un riscontro macroeconomico, ma che è
determinato a livello di impresa e riflette
proprio la mancanza di una capacità che
altrove sembra essere stata ritrovata: cosa
manca davvero è però difficile dirlo, il
tentativo non può che passare per un’analisi
microfondata, analisi a cui sono dedicate le
pagine che seguono.
Dall’update del World Economic Outlook January 2011. Quindi
prima del tragico terremoto in Giappone e prima di quella che i
media definiscono la Primavera Araba, cioè le tensioni politico
sociali che interessano la vasta zona dal nord Africa al Medio
Oriente.
2
Le imprese considerate sono tutte le quotate nel mercato
azionario principale del paese escluse le imprese finanziarie,
quelle di servizi e quelle di energy. In totale sono state censite
per il calcolo degli indicatori 130 imprese italiane, 200
tedesche, 400 circa francesi e 50 spagnole, le cui risultanze
riportate nelle trimestrali o semestrali sono state aggregate
come se si trattasse di un’unica impresa.
1
Rapporto Corporate Efige I 13
XI INDAGINE
SULLE IMPRESE
MANIFATTURIERE
ITALIANE
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
CORPORATE GOVERNANCE,
GESTIONE DELL’IMPRESA E
FORME DI AGGREGAZIONE
a cura di Luigia Mirella Campagna
La concentrazione della proprietà
si conferma elevata nelle imprese
italiane. I soci di maggioranza sono
per lo più persone fisiche; seguono
società finanziarie di gruppo e
imprese manifatturiere; la proprietà
è poco diffusa tra banche, investitori
istituzionali ed enti pubblici. Rilevante
il ruolo delle imprese familiari.
Permane una forte identità tra
soggetto controllante e colui che
prende decisioni strategiche. I gruppi
sono rari tra le piccole e medie
imprese.
Il grado di concentrazione della proprietà si conferma elevato nelle imprese italiane.
Nel 2008 la dimensione media delle quote sociali detenute dai primi tre azionisti superava
il 92%. Il confronto con i grandi paesi dell’Unione Europea inclusi nell’indagine indica che
la concentrazione della proprietà non è un fenomeno solamente italiano: la quota cumulata
media dei primi tre soggetti risulta essere anche più alta in Germania (97,4%), Francia
(95%) e Regno Unito (93,8%). Questa conclusione risulta rafforzata se si guarda alla
dimensione media della quota detenuta dal primo azionista (57,4%), nettamente più bassa
di quella in Germania (76,7), Francia (71,4%) e Regno Unito (65,5%).
In media, l’azionista principale possiede comunque una quota di capitale che gli consente
di avere il controllo di diritto della società. Tale quota tende ad aumentare all’aumentare
della dimensione aziendale. Tale correlazione, non del tutto intuitiva, trova spiegazione
nel fatto che al crescere della dimensione aziendale diventano più diffuse le strutture di
gruppo, spesso utilizzate come strumenti di esercizio del controllo. In questi casi, la società
controllante, cioè l’azionista principale, detiene in genere una quota di capitale sociale
elevata e spesso pari al 100%. Circa la nazionalità dei soggetti proprietari, emerge in Italia
una maggiore impermeabilità al capitale estero rispetto ai principali paesi osservati.
I soci di maggioranza sono per lo più persone fisiche (82,9%); seguono, a notevole
distanza, società finanziarie di gruppo e altre imprese manifatturiere; la proprietà risulta
invece scarsamente diffusa tra banche, investitori istituzionali ed enti pubblici. Questo
modello si pone in posizione intermedia tra quello tedesco, più accentrato sulle persone
fisiche (84,3%) e quello francese, dove l’incidenza delle persone fisiche è più bassa (68%)
e lascia spazio maggiore ad altri soggetti proprietari. Si conferma importante il ruolo delle
imprese familiari, definite come imprese controllate direttamente o indirettamente da un
individuo o da una famiglia. Infine trova riscontro la forte identità tra soggetto controllante
e soggetto che prende le decisioni più importanti.
In Italia, sono mediamente meno del 15% le imprese che appartengono ad un gruppo, ma
la percentuale sale significativamente tra le imprese grandi. Analogo discorso per i legami
di affiliazione tra imprese. Rare le operazioni di acquisizione e scorporo.
16 I Rapporto Corporate Efige
Concentrazione della proprietà
La proprietà delle imprese italiane si
conferma concentrata. Guardando alla
dimensione media delle quote detenute dagli
azionisti principali, si osserva che nel 2008 la
quota cumulata dei primi tre soggetti supera
il 92%. In maniera complementare, lo stesso
fenomeno è evidenziato dalla scarsissima
presenza di imprese a proprietà diffusa:
infatti, soltanto nell’1,9% delle imprese
intervistate la quota di proprietà del primo
azionista è inferiore al 10%.
Quote medie cumulate del capitale sociale detenute dai primi tre azionisti (%)
Italia
Grandi imprese
100
96,9
95,0
93,8
92,4
90,7
80
60
40
20
Il confronto con gli altri grandi paesi europei
inclusi nell’indagine indica però che l’elevata
concentrazione della proprietà non è un
fenomeno soltanto italiano: al contrario, la
quota media dei primi tre soggetti risulta più
alta in Germania (96,9%), Francia (95%) ed
anche Regno Unito (93,8%). Solo in Spagna
emerge un grado medio di concentrazione
lievemente inferiore (90,6%). Il quadro non
cambia anche quando si guarda alle quote
medie cumulate ponderate per la dimensione
aziendale. In generale, tali quote risultano
sempre più alte nelle imprese tedesche e
francesi rispetto a quelle italiane, qualunque
sia la classe dimensionale di appartenenza
dell’impresa. D’altra parte, Italia, Germania
e Francia risultano simili proprio sotto il
profilo della scarsa variabilità delle quote
cumulate medie dei primi tre azionisti tra
le diverse classi dimensionali osservate. In
Spagna e Regno Unito, invece, è emersa
una correlazione negativa tra tali quote e la
dimensione aziendale: nel primo paese, essa
passa dal 91,5% nelle imprese più piccole
(10-19 addetti) all’86,4% nelle grandi (oltre
250 addetti); nel secondo paese, le stesse
percentuali scendono dal 95,8% al 90,6%.
Il tema della concentrazione della proprietà
può essere approfondito guardando con
maggiore dettaglio alle singole quote di
proprietà. In Italia, la dimensione della quota
di proprietà detenuta dal primo azionista è
pari in media al 57,4%, nettamente inferiore
a quella detenuta in Germania (76,9%),
Francia (71,4%), Regno Unito (65,2%) e
0
Germania
Francia
Regno Unito
Italia
Spagna
Quota media del capitale sociale detenuta dal primo azionista (%)
Italia
Grandi imprese
100
80
76,7
71,4
65,5
60
57,8
57,4
40
20
0
Germania
Francia
prossima solo a quella della Spagna (58,7%).
I risultati dell’indagine confermano così il
basso grado di separazione tra proprietà
e controllo che caratterizza in media le
nostre imprese: l’azionista principale, infatti,
possiede in media una quota di capitale
sociale che gli permette di avere il controllo
di diritto sulla società. Tale quota tende ad
aumentare all’aumentare della dimensione
aziendale, confermando la correlazione
diretta tra grado di concentrazione della
proprietà e dimensione dell’impresa. Tale
correlazione, non del tutto intuitiva, trova
spiegazione nel fatto che al crescere
della dimensione aziendale diventano più
Regno Unito
Italia
Spagna
diffuse - come vedremo in seguito - le
strutture di gruppo, spesso utilizzate come
strumenti di esercizio del controllo. In
questi casi, la società controllante, cioè
l’azionista principale, detiene in genere una
quota di capitale sociale elevata e spesso
pari al 100%. Il confronto internazionale
restituisce un quadro simile anche per gli
altri grandi paesi dell’Unione Europea, con
la sola eccezione della Germania, dove non
emerge alcuna correlazione diretta con la
dimensione e le quote medie detenute dal
primo azionista rimangono pressappoco della
stessa entità in ciascuna delle quattro classi
dimensionali osservate.
Rapporto Corporate Efige I 17
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Imprese dove il primo azionista detiene il controllo diretto (% sul totale)
Italia
Germania
Francia
Regno Unito
Spagna
capitale sociale relativamente più bassa
rispetto a quella dei suoi “colleghi” europei e
che non supera il 60%, lasciando uno spazio
ampio per accordi, coalizioni, patti con altri
soggetti proprietari.
100
Assetti proprietari e controllo
80
60
40
20
0
10-19 addetti
20-49
50-249
oltre 250
Tipologia del primo azionista (% di imprese sul totale)
Altro
Enti pubblici
Investitori istituz.
Banca, assic.
Holding
Impresa manif.
Individuo/i
100
80
60
40
20
0
10-19 addetti
20-49
La correlazione positiva tra grado di
concentrazione della proprietà e dimensione
aziendale emerge con chiarezza anche
quando si guarda al numero delle imprese
il cui primo azionista detiene il controllo
diretto dell’impresa, cioè possiede una quota
di capitale sociale superiore al 50%: la
percentuale di tali imprese sul totale si attesta
al 44% fra le imprese con 10-19 addetti,
mentre raggiunge il 76% tra le imprese con
oltre 250 addetti. Il confronto internazionale
conferma l’esistenza della medesima relazione
in tutti i grandi paesi ad esclusione della
Germania; segnala, inoltre, che la percentuale
di imprese italiane il cui primo azionista
18 I Rapporto Corporate Efige
50-249
oltre 250
detiene una quota maggioritaria del capitale
sociale è più bassa rispetto a quella degli
altri paesi in ciascuna classe dimensionale;
la differenza tende ad attenuarsi solo nella
classe con oltre 250 addetti.
In conclusione, la concentrazione della
proprietà nelle imprese italiane si conferma
elevata, non differenziandosi, in questo,
da un modello di proprietà che risulta
peraltro prevalente in Europa. La peculiarità
che invece emerge dal confronto con gli
altri grandi paesi europei è che il socio
di maggioranza, soprattutto tra le piccole
imprese, detiene in media una quota di
Nel controllo di un’impresa può essere
importante, oltre alla distribuzione della sua
proprietà tra un numero più o meno ampio
di soggetti, anche la tipologia del soggetto
proprietario. Una proprietà concentrata
potrebbe infatti esercitare un controllo
effettivo più stringente se fosse nelle mani di
una o più persone fisiche, per esempio una
famiglia, ovvero nelle mani di altri soggetti,
per esempio banche o altre imprese.
L’indagine consente di analizzare le principali
caratteristiche dell’assetto proprietario
guardando ancora una volta alle quote di
proprietà. In merito alla tipologia dei soggetti
proprietari, i risultati dell’indagine rilevano,
come atteso, che nella grande maggioranza
dei casi i soci di maggioranza sono persone
fisiche (82,9%); seguono, nell’ordine, holding
(7,4%) e altre imprese manifatturiere (6%).
La proprietà è invece poco diffusa tra banche
(0,1%), altri investitori non di gruppo (0,3%)
ed enti pubblici (0,1%). Nel complesso,
questi dati - la netta prevalenza delle persone
fisiche da un lato, e la scarsa presenza degli
intermediari bancari e finanziari dall’altro evidenziano il carattere non anonimo della
proprietà delle imprese italiane. I risultati,
tuttavia, variano significativamente quando
si prende in considerazione la dimensione
aziendale: la percentuale di imprese che
indicano un individuo o un gruppo di individui
come principale soggetto che detiene una
quota di capitale sociale è pari all’86,7%
nelle piccole imprese (10-49 addetti),
diminuisce al 63,4% nelle medie imprese
(50-249) e scende fino al 26,8% nelle grandi
(oltre 250 addetti). La riduzione di peso
delle persone fisiche si realizza a vantaggio
soprattutto delle finanziarie di gruppo, che
arrivano ad essere indicate come principale
azionista da oltre il 56% delle grandi
imprese.
Il confronto internazionale non segnala
differenze significative nel peso relativo
dei diversi soggetti proprietari. Il modello
prevalente rimane quello di una proprietà
fondata sulle persone fisiche - individuo
o gruppi di individui: in Germania, in
particolare, l’incidenza di questo soggetto
proprietario è mediamente molto elevata
(84,3%) e tende a rimanere alta anche
tra le grandi imprese (64,5%, contro una
media dei sette paesi osservati pari al
44,1%), pur mantenendo la caratteristica
della correlazione inversa con la dimensione
aziendale. Un modello più vicino alla “rete”
emerge invece in Francia dove, tra i principali
azionisti, compaiono in misura più diffusa
rispetto a quanto accade in Italia e negli
altri grandi paesi europei osservati, le altre
imprese manifatturiere (18%) e le holding
(11%); il modello a “rete”, in particolare,
sembra funzionare tra le grandi imprese,
dove in oltre il 28% dei casi (più di una
volta su quattro) la quota di maggioranza è
detenuta da un’altra impresa manifatturiera;
tra le medie imprese, la stessa percentuale
scende al 22,3%, ma rimane comunque
sensibilmente superiore alla media del
campione (12,8%).
È interessante osservare che nei casi in
cui il socio di maggioranza non è una
persona fisica, ma è invece un’altra impresa
manifatturiera o una holding, l’impresa
italiana si differenzia molto meno sotto il
profilo proprietario rispetto alle “consorelle”
dei principali paesi europei: in questo caso,
infatti - diversamente da quanto avviene
nel caso delle persone fisiche - il socio di
maggioranza detiene una quota media di
capitale sociale molto ampia e di entità
simile a quella degli altri paesi europei (pari
al 73% nel caso di “altre imprese” e ad
oltre l’85% nel caso delle “holding”, con
differenze peraltro minime tra le diverse
classi dimensionali).
Per quanto riguarda, infine, la nazionalità
del primo azionista, l’Italia si conferma un
paese poco permeabile al capitale straniero.
In media, meno del 4% delle imprese
dichiara di avere un socio di maggioranza di
nazionalità estera, anche se la percentuale
aumenta in misura sensibile al crescere
della dimensione aziendale: in media, nelle
imprese con oltre 250 addetti, la percentuale
di imprese con un socio di maggioranza
straniero sale al 23,7%, contro appena
l’1,6% nelle imprese più piccole (10-19
addetti); la stessa percentuale si attesta
sopra il 12% nell’impresa media.
La frequenza tende inoltre ad aumentare tra
le imprese il cui proprietario è una holding
(28,5%) o un’altra impresa manifatturiera
(14,4%), mentre è sostanzialmente nulla la
presenza di imprese estere di proprietà di
persone fisiche (0,7%).
Tra i sette paesi considerati, l’Italia risulta
essere il paese con la minore presenza di
imprese estere. Anche in Germania si rileva
una presenza lievemente maggiore (6%
circa), anche se le medie calcolate per classe
dimensionale correggono parzialmente
il quadro: la maggiore diffusione sembra
infatti riguardare solo le piccole imprese,
mentre l’incidenza delle imprese estere
nelle ultime due classi dimensionali risulta
più bassa di quella italiana (meno del 10%
tra le imprese medie; 18,6% tra le grandi).
Nei restanti paesi, invece, le imprese estere
sono più frequenti: incidenze relativamente
alte emergono non soltanto, come atteso,
nei due paesi più piccoli (Ungheria e Austria),
ma anche nel Regno Unito e in Francia
(rispettivamente 14,2% e 10,2%), dove
diventano peraltro rilevanti tra le grandi
imprese (rispettivamente 44,5% e 41,3).
Si conferma importante il ruolo delle imprese
familiari, definite come imprese controllate
direttamente o indirettamente da un individuo
o da una famiglia. Com’è noto, infatti, la
proprietà non costituisce l’unico mezzo di
controllo di un’azienda: accanto ad essa
possono esistere altre forme di controllo,
che si originano sia da strumenti di natura
contrattuale (accordi di voto, patti parasociali)
sia semplicemente da rapporti di natura
informale (legami di parentela o di fiducia,
ecc.). L’indagine prevedeva dunque una
domanda finalizzata a cogliere il numero
di imprese familiari, definite come sopra.
I risultati confermano l’ampissima diffusione
di questa tipologia di impresa. Oltre il 75%
delle imprese italiane ha dichiarato infatti
di essere controllato da individui o famiglie,
con percentuali che raggiungono l’80%
nel segmento delle imprese più piccole
(10-19 addetti). Trova conferma infatti la
netta correlazione inversa tra diffusione del
modello familiare di impresa e dimensione
aziendale: tra le grandi imprese, la
percentuale delle family business scende a
poco meno del 47%.
Non si tratta di un’anomalia italiana, come
si è portati a pensare quando si parla di
capitalismo familiare nel nostro paese.
L’impresa familiare, al contrario, è il modello
di governance prevalente in tutti i paesi
osservati: in ciascuno di essi, la percentuale
di imprese familiari supera sempre - e
spesso di molto - il 50%. Il peso risulta molto
elevato in Germania (83,5%), Austria (82,4%)
Spagna (76,5%) e perfino Regno Unito
(64,1%); è relativamente più basso in Francia
(57,6%) e Ungheria (55%).
La sua rilevanza è in parte ridimensionata
solo tra le grandi imprese, come si è già
visto per l’Italia: guardando infatti alle
percentuali medie di imprese familiari per
classi dimensionali, si osserva ovunque che
esse scendono al di sotto del 50% nelle
imprese con oltre 250 addetti, con le uniche
eccezioni della Germania e dell’Austria, dove
rimangono invece su valori ampiamente
superiori al 60%. L’indagine rende possibile
un’analisi dettagliata dell’assetto proprietario
e organizzativo dell’azienda familiare:
il riquadro contenuto in questo capitolo
ne traccia un rapido profilo.
Organizzazione
Le informazioni relative all’organizzazione
non attenuano l’idea di un modello
d’impresa fortemente centrato sulla figura
dell’imprenditore. Nell’85% dei casi, è
Rapporto Corporate Efige I 19
Rapporto Corporate
l’amministratore delegato (o capo azienda)
a prendere le decisioni strategiche che
riguardano tutte le aree di business in cui
è impegnata l’azienda. Solo nel restante
15% dei casi, l’impresa sceglie un modello
di organizzazione decentralizzato, dove
il management è delegato a prendere
decisioni autonome in alcune aree di
business. La percentuale delle imprese che
adottano un modello centralizzato tende
ovviamente a ridursi man mano che le
imprese crescono in termini di dimensione,
assumendo strutture più complesse
(poco meno del 70% tra le imprese con
oltre 500 addetti). La scelta di questo
modello organizzativo è inoltre influenzata
dalla natura del soggetto proprietario:
la frequenza più alta si osserva, come
atteso, quando il socio di maggioranza è
una persona fisica (87% dei casi), mentre
tende ad attenuarsi quando il principale
azionista è una holding (70,6%) o un’altra
impresa manifatturiera (78,8%) o quando
si tratta, significativamente, di un’azionista
con nazionalità estera (68,7%).
Il confronto internazionale restituisce infatti
un quadro delle imprese italiane sotto
il profilo organizzativo piuttosto diverso
da quello degli altri paesi e paragonabile
solo all’Ungheria e, in minor misura, alla
Francia.
Negli altri paesi prevale in media il modello
centralizzato, ma non in misura così netta
come in Italia. La media semplice tende
infatti a differenziarsi in misura maggiore
al variare della dimensione aziendale
e, soprattutto, dei soggetti proprietari.
In particolare, in Germania e nel Regno
Unito - dove sono emersi assetti proprietari
molto concentrati e fortemente fondati sulla
persona fisica (quindi molto simili a quello
italiano) - i risultati dell’indagine evidenziano
con chiarezza che il modello organizzativo
basato sulla decentralizzazione delle
decisioni viene comunque adottato con
frequenza largamente maggiore. Nelle
imprese medie e grandi, ad esempio, la
percentuale di imprese che dichiara che le
20 I Rapporto Corporate Efige
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Imprese con modello organizzativo centralizzato (%)
Italia
Media 7 paesi
100
80
60
40
20
0
10-19
addetti
20-49
50-249
oltre
250
Individuo/i Impresa
manif
Holding
Estere
Imprese che appartengono ad un gruppo (%)
Italia
Grandi imprese
100
80
60
40
20
0
Germania
Italia
Spagna
decisioni strategiche sono prese in parte
dai propri manager è prossima - e supera
in alcuni casi (grandi imprese tedesche) il 50%. Diventa invece il modello prevalente,
per ciascuna classe dimensionale
osservata, nei casi in cui il soggetto
proprietario è una holding o un’altra
impresa manifatturiera.
Gruppi
In media, sono meno del 15% le imprese
italiane che appartengono ad un gruppo.
La percentuale, tuttavia, varia
significativamente al variare della dimensione
Ungheria
Austria
Regno Unito
Francia
aziendale, data la forte correlazione positiva
esistente tra le due variabili. Tra le piccole
imprese, meno del 10% appartengono ad
un gruppo; tra le grandi imprese, invece,
la percentuale sale ad oltre il 79%.
La maggiore incidenza della forma gruppo
tra le grandi imprese si spiega, oltre che
come risposta organizzativa ad aree di
business più ampie, anche come strumento
di controllo diretto e indiretto delle imprese
appartenenti al gruppo da parte dell’impresa
capogruppo. Una struttura piramidale
consente infatti la separazione tra controllo
e diritti di voto. Guardando alla posizione
gerarchica delle singole imprese nella
compagine del gruppo, non è un caso che
le aziende capogruppo siano poco meno del
7% tra le imprese più piccole (dove invece
abbondano, in maniera complementare,
le controllate: quasi l’80%), mentre
raggiungano una quota prossima al 25%
tra le grandi imprese (dove le controllate si
riducono invece a circa il 40%).
L’analisi delle quote medie di proprietà,
d’altra parte, rafforza l’idea del gruppo
utilizzato come mezzo di controllo di
un’azienda. Qui, la dimensione media
della quota di capitale sociale detenuta
dal primo azionista raggiunge il 74,1%,
decisamente più alto rispetto al 57,4%
rilevato per l’intero campione Italia.
Guardando, infine, alla tipologia dei soggetti
che compongono i soci di maggioranza, i
risultati dell’indagine rilevano che nel mondo
dei gruppi la persona fisica perde il suo
ruolo prevalente di soggetto proprietario a
favore delle società finanziarie di gruppo.
Le holding rappresentano infatti oltre il
39% dei soggetti designati come azionisti
principali, mentre gli individui o i gruppi di
individui ne rappresentano solo il 28,2%;
seguono le altre imprese manifatturiere,
con una quota ampiamente superiore al
25%, mentre rimangono trascurabili gli altri
soggetti (banche, investitori istituzionali, enti
pubblici).
Il confronto internazionale fa emergere,
ancora una volta, una somiglianza con la
Germania. In entrambi i paesi, ed anche
in Spagna, i gruppi di imprese non sono
particolarmente diffusi. A questo modello,
sembra contrapporsene un altro - diffuso
soprattutto in Francia e, in minor misura, nel
Regno Unito - che si caratterizza per una
preferenza più convinta verso i gruppi.
Acquisizioni e Spin-off
Le operazioni di acquisizioni e spin-offs
riguardano un piccolo numero di imprese.
Nel triennio 2007-2009, solo il 7,1% delle
imprese manifatturiere con oltre 10 addetti
ha acquisito o incorporato altre società, per
lo più italiane (6%). Sotto questo profilo, le
nostre imprese appaiono meno dinamiche
delle imprese tedesche (10,3%), francesi
(8,3%) e, soprattutto, inglesi (13,5%).
Come atteso, esiste una relazione diretta
molto forte con la dimensione: oltre il
32% delle grandi imprese ha effettuato
acquisizioni, contro il 6,3% delle piccole
imprese. In generale, come si è detto, si
preferisce acquisire imprese nazionali
rispetto a quelle estere; ciò è vero per tutti
i paesi osservati, anche se Germania e
Regno Unito risultano essere i paesi con un
interesse relativamente più elevato verso
l’estero.
contratti di affiliazione - si scopre però
che la disparità rispetto agli altri paesi
dipende soprattutto dallo scarso uso che le
piccole imprese fanno di questo strumento.
Viceversa, l’incidenza dei legami di
affiliazione tra le medie e le grandi imprese pari rispettivamente al 33,5%
e al 59,2% - risulta in linea con quella
degli altri paesi più grandi. Rispetto alla
nazionalità delle imprese affiliate, in media
le imprese nazionali risultano nettamente
superiori a quelle estere, ma il rapporto si
inverte quando si guarda alle imprese medie
e grandi.
Nello stesso periodo, hanno dichiarato di
essere state acquisite o incorporate solo
il 2,7% delle imprese. Anche qui, le più
coinvolte sono le imprese grandi, con una
percentuale di poco superiore al 9%. Le
operazioni sono state condotte da imprese
prevalentemente italiane; guardando alle
grandi imprese, il 6,6% delle acquisizioni
è stato effettuato da aziende nazionali, il
restante 2,5% da imprese estere.
Più significativa è la quota di imprese
che hanno legami di affiliazione con altre
imprese (13%), anche se il confronto
internazionale restituisce comunque una
situazione in cui la diffusione di questo tipo
di contratto risulta inferiore rispetto a quella
in essere nei principali paesi concorrenti
(Francia e Germania), dove quasi un quinto
delle imprese dichiara di avere tali legami.
Guardando alla dimensione aziendale - che
impatta significativamente sull’uso dei
Rapporto Corporate Efige I 21
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Le imprese familiari
a cura di
di Luigia
LuigiaMirella
MirellaCampagna
Campagnae eAttilio
AttilioPasetto
Pasetto
In questo
In
questoriquadro
riquadro
analizziamo
analizziamo
più dettagliatamente
più
dettagliatamente
le
imprese familiari le
italiane,
imprese
definite
familiari
come italiane,
imprese
definite come
controllate
direttamente
imprese ocontrollate
indirettamente
direttamente
da un
o
indirettamente
individuo
o da una
dafamiglia.
un individuo o da una famiglia.
L’analisi intende cogliere le peculiarità di questa forma di
impresa rispetto alle imprese non familiari in merito alla
proprietà e agli aspetti gestionali/organizzativi.
Relativamente al primo aspetto e guardando alla
distribuzione del capitale sociale tra i primi tre azionisti,
non si colgono differenze significative rispetto alle imprese
non familiari: la concentrazione della proprietà risulta solo
lievemente più elevata, come emerge dall’osservazione
della quota cumulata media dei primi tre azionisti (93,4%
contro 92,4% delle aziende non familiari); non emergono
inoltre differenze di rilievo tra le diverse classi dimensionali.
La quota media di capitale in mano al primo azionista
supera ampiamente il 50%, assicurandogli così il
controllo diretto dell’azienda; essa risulta solo lievemente
più elevata (57,8%) rispetto a quella delle imprese
non familiari (57,4%) e aumenta - come quest’ultima all’aumentare della dimensione aziendale. È interessante
però osservare che quando si guarda alle quote medie
per classi dimensionali, esse risultano moderatamente
più ampie nelle imprese piccole (10-49 addetti), mentre
la situazione si capovolge nelle imprese medie e grandi,
dove le quote del socio di maggioranza risultano inferiori a
quelle delle aziende non familiari (di circa tre e cinque punti
percentuali, rispettivamente).
La spiegazione di questa differenza va ricercata con ogni
probabilità nella diversa tipologia dei soggetti proprietari.
Nell’impresa familiare prevalgono le persone fisiche,
che risultano essere soci di maggioranza in oltre il 90%
dei casi; la centralità del soggetto imprenditore si mantiene
elevata in tutte le classi dimensionali, comprese quelle
delle medie e grandi imprese, diversamente da quanto si
rileva nelle imprese non familiari (nelle aziende con oltre
250 addetti, ad esempio, le persone fisiche rappresentano
oltre il 40% dei soci di maggioranza, mentre raggiungono
appena il 27% circa nelle imprese non familiari). Questa
caratteristica - la prevalenza delle persone fisiche sulle
22 I Rapporto Corporate Efige
altre tipologie di proprietari - impatta sulla scelta degli
strumenti di controllo: in generale, l’imprenditore tende
ad avere un controllo diretto sulla propria azienda e a
basarsi in misura relativamente maggiore su rapporti di
natura informale (legami di parentela o di fiducia, ecc.),
mentre gli altri soggetti proprietari - imprese, società
finanziarie o altri investitori - utilizzano soprattutto
strumenti formali. A conferma di ciò, non sembra casuale
che tra le imprese familiari è meno diffuso il gruppo,
qualora questo possa essere utilizzato come strumento
di controllo e non solo organizzativo. In media, infatti,
fanno ricorso al gruppo solo il 9,8% delle imprese familiari,
contro il 14,3% dell’intero campione; la percentuale sale al
crescere della dimensione aziendale, ma in ciascuna classe
dimensionale si mantiene comunque inferiore a quella
dell’intero campione (nelle grandi imprese raggiunge il 71%
contro oltre il 79% dell’intero campione).
Relativamente agli altri soggetti proprietari, si osserva come nelle aziende non familiari - che le holding sono più
diffuse rispetto alle altre imprese manifatturiere: in media,
esse rappresentano il 4,3% dei soci di maggioranza,
contro il 3,7% delle seconde. Il loro peso aumenta
sensibilmente tra le grandi imprese, dove l’incidenza
raggiunge il 48,7% del totale. Le holding rappresentano
dunque l’assetto proprietario più diffuso anche tra le grandi
imprese familiari.
Il confronto internazionale non rileva differenze
significative nell’assetto proprietario. La quota
cumulata media dei primi tre azionisti nei sette paesi
europei osservati risulta peraltro più alta di quella italiana,
indicando che il grado di concentrazione della proprietà è
elevato ovunque. Analoghe considerazioni valgono per la
quota media del primo azionista.
In merito al modello gestionale/organizzativo, si osserva,
come atteso, che nelle imprese familiari l’amministratore
delegato (o capo azienda) è un componente della
famiglia medesima nel 95% dei casi. Tale quota,
negativamente correlata con la dimensione aziendale,
scende solo all’81% nella grande impresa, dove comunque
trovano uno spazio maggiore i manager selezionati
all’interno dell’azienda (11,3%) rispetto a quelli assunti
dall’esterno (7,8%). Questo modello gestionale,
fortemente centrato sulla figura dell’imprenditore
familiare, è largamente condiviso nell’impresa
familiare tedesca e austriaca, mentre negli altri paesi
europei considerati nell’indagine, il modello risulta
relativamente più aperto al management non familiare,
soprattutto tra le grandi imprese. Analizzando, in
particolare, questa classe dimensionale, si osserva infatti
che nel Regno Unito l’amministratore delegato è un
componente della famiglia solo nel 27% dei casi, in Francia
nel 48,5% dei casi e in Spagna nel 66%. Nella grandi
imprese britanniche, peraltro, i manager esterni prevalgono
ampiamente su quelli interni, mentre il contrario accade
negli altri due paesi.
Tutto questo tende a ripercuotersi sul modello
organizzativo. Nelle imprese familiari italiane le decisioni
strategiche sono fortemente accentrate nelle mani del
capo azienda (88,2% dei casi); emerge una correlazione
negativa con la dimensione aziendale, ma l’impatto sul
grado di accentramento risulta tutto sommato contenuto
(si passa dal 90,3% delle aziende con 10-19 addetti al
79% delle grandi imprese). Il confronto internazionale
segnala invece che su questo punto le imprese familiari
europee si differenziano in misura significativa da
quelle italiane e il divario tende ad aumentare con
la dimensione: nella grande impresa, infatti, il modello
organizzativo prevalente nella media dei 7 paesi rimane
quello centralizzato, ma in generale la diffusione del
modello organizzativo opposto - cioè quello dove il
management è chiamato a prendere decisioni strategiche
in alcune aree di business - è molto ampia. In Germania dove, come in Italia, abbiamo visto prevalere la figura del
familiare come capo azienda - in media una impresa su
quattro sceglie di adottare un modello decentralizzato; tale
percentuale sale al 55,3% tra le grandi imprese.
Modello organizzativo decentralizzato per paesi
(% sul totale delle imprese familiari)
Italia
Grandi imprese
70
60
50
40
30
20
10
Regno
Unito
Spagna
Austria Germania Francia Ungheria
Italia
In conclusione, le principali differenze tra imprese familiari
e non familiari che emergono dall’indagine riguardano,
a livello di proprietà, il più forte ruolo della persona
fisica rispetto agli altri soggetti proprietari e, a livello
organizzativo, la preferenza per un modello fortemente
accentrato delle decisioni strategiche, associato ad un
management dove è rilevante la presenza dei componenti
della famiglia. Il confronto internazionale rivela che il
primo aspetto è comune anche alle imprese familiari
degli altri grandi paesi europei osservati, mentre l’assetto
organizzativo è una peculiarità delle aziende italiane.
Va inoltre sottolineato come nelle imprese familiari non
solo l’amministratore delegato tenda ad essere un membro
della famiglia proprietaria/controllante, ma che anche
nella composizione del management la quota dei familiari
dirigenti è più elevata: essa si attesta al 6,1% del totale
degli addetti nell’impresa familiare, contro il 4,8% del totale
imprese del campione. A livello europeo, le stesse quote
sono pari, rispettivamente, al 5% e al 3,8%.
La percentuale dei familiari dirigenti tende però a diminuire
al crescere della dimensione aziendale, passando
dall’11,6% nelle imprese più piccole allo 0,6% nelle grandi.
Rapporto Corporate Efige I 23
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
OCCUPAZIONE, QUALITA’
DEL CAPITALE UMANO,
FORMAZIONE
a cura di Attilio Pasetto
La qualità del capitale umano rimane
piuttosto bassa, come dimostrano
la quota elevata di operai comuni,
il basso numero di laureati e la
modesta partecipazione ai corsi
di formazione. Nel management
prevalgono i dirigenti provenienti
dalla famiglia controllante con un’età
generalmente più avanzata rispetto
alla media europea. Grazie agli
ammortizzatori sociali la crisi non
ha penalizzato i lavoratori italiani in
misura maggiore rispetto agli altri
paesi europei.
24 I Rapporto Corporate Efige
L’indagine conferma molte caratteristiche ben note della struttura occupazionale delle
imprese italiane. Innanzitutto, il peso della piccola impresa e la dimensione media inferiore
agli altri paesi europei. In secondo luogo, il ruolo della famiglia proprietaria nella gestione,
oltre che nel controllo, dell’impresa. Dalla ripartizione per mansioni emerge come il peso
degli operai, e in particolare degli operai non qualificati, sia più alto della media europea.
A questa suddivisione per mansioni corrisponde una coerente ripartizione del personale
per titolo di studio, in cui la quota dei laureati nelle imprese italiane risulta più bassa della
media europea. Inoltre, tra le modalità d’impiego degli addetti, la percentuale di occupati
che svolge attività di ricerca e sviluppo appare piuttosto modesta. La non eccelsa qualità
del capitale umano è confermata dall’impiego di forza lavoro straniera, che si presume in
gran parte low skilled, in misura superiore alla media europea, soprattutto nelle piccole
imprese, nel Nord Est e nei settori tradizionali e di scala. Risulta invece meno rilevante il
ricorso al lavoro a tempo determinato e part-time.
L’indagine è ricca di molte indicazioni relative al management aziendale. I manager delle
nostre imprese hanno mediamente un’età più avanzata rispetto ai loro colleghi europei
e sono quasi tutti italiani, con scarse esperienze lavorative all’estero. L’imprenditoria
femminile appare però più diffusa, soprattutto nella piccola dimensione, a ulteriore
conferma - probabilmente - dell’importanza del capitalismo familiare nel nostro paese.
Le difficoltà ad innalzare la qualità del capitale umano si spiegano anche con la modesta
attenzione dedicata alla formazione del personale. Il gap italiano con l’Europa è evidente
in tutte le classi dimensionali, soprattutto nelle grandi e nelle medie imprese, da cui ci si
aspetterebbe invece uno sforzo maggiore per il miglioramento degli skill professionali.
Le domande sugli effetti della crisi mettono indirettamente in evidenza il buon
funzionamento degli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, che ha saputo
attutire i contraccolpi occupazionali un po’ meglio rispetto ad altri paesi. Nello stesso tempo
però emerge l’immagine di un sistema industriale “ingessato”, in cui le imprese in grado di
andare controcorrente, assumendo in tempo di crisi, sono poche.
La composizione della forza lavoro
per classi di addetti evidenzia il forte
ruolo della piccola impresa nel sistema
manifatturiero italiano, con un peso degli
occupati nelle imprese da 10 a 49 addetti
che sfiora il 50% contro il 28,2% della
media dei sette paesi considerati. La
quota degli addetti delle medie imprese
(50-249) appare perfettamente in linea
con la media dei sette (25,2%), mentre
il ruolo delle grandi imprese (oltre 249
addetti) è decisamente inferiore alla
media (25% contro 46,6%). Sono queste
caratteristiche ben note del sistema
industriale italiano, che l’indagine Efige
conferma in pieno. Tra i paesi considerati
la Spagna è quella che si avvicina di più
all’Italia come struttura occupazionale,
con un’incidenza delle piccole imprese del
40%, mentre all’estremo opposto troviamo
il Regno Unito (15,4%), dove predomina
decisamente la grande impresa (65,6%).
Abbastanza simili tra loro sono Francia
e Germania, con un peso delle piccole
imprese di circa il 23%; la principale
differenza fra le due nazioni è che in
Francia il ruolo della grande impresa è più
rilevante (53,7% contro 47,8%).
Per dimensione media le imprese italiane
compaiono all’ultimo posto tra i sette
paesi considerati, con 42,4 addetti contro
i 67,2 del totale del campione. Anche qui
è la Spagna il paese che si avvicina di più
all’Italia, mentre il Regno Unito presenta
il valore maggiore (110,5) e Francia e
Germania mostrano una dimensione media
molto simile attorno ai 77 addetti. Da
notare però che nella piccola dimensione
il numero medio degli addetti delle nostre
imprese è leggermente più alto rispetto
alle altre nazioni, specie nella fascia
minore (10-19 addetti).
Peculiarità tipiche della struttura
occupazionale italiana emergono anche
dalla ripartizione per mansione degli
addetti. Innanzitutto, nel management,
in cui i dirigenti non familiari assumono
Ripartizione per mansione degli addetti (%)
Operai comuni
Operai qualificati
Impiegati
Management non familiare
Management familiare
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Media
7 Paesi
Regno Unito
Media
7 Paesi
Percentuale dei laureati sugli occupati (%)
12
10
8
6
4
2
0
Francia
Germania
Italia
un ruolo decisamente meno rilevante
(3% contro il 6,2% della media dei sette
paesi considerati), mentre il management
familiare presenta un’incidenza maggiore
(4,8% contro 3,8%). Non si può però
non notare che complessivamente il
peso del management all’interno delle
imprese italiane è meno rilevante rispetto
alla media dei sette paesi considerati
(7,8% contro 10%), mentre la quota degli
impiegati, con il 25,5%, è in linea con
la media europea. Per quanto riguarda
invece gli operai, complessivamente il
peso che essi assumono nella struttura
occupazionale delle imprese italiane è più
Spagna
alto della media europea (66,7% contro
64,8%). Al contrario di Germania (62,9%)
e Francia (56,2%) che si attestano su
valori inferiori.
Qui è possibile cogliere un’altra importante
differenza: la quota degli operai qualificati
è la più bassa tra i sette paesi (32,2%
contro 39,6%) e quella degli operai
comuni e apprendisti la più alta (34,5%
contro 25,2%). Questi ultimi assumono un
peso ancora superiore nel Mezzogiorno
(38,3%) e nel Centro (35,4%). In Germania
il peso degli operai qualificati supera il
43% e quello degli operai comuni scende
al di sotto del 20%.
Rapporto Corporate Efige I 25
Rapporto Corporate
A questa ripartizione per mansioni - che
vede nelle imprese italiane un maggior
ruolo dei colletti blu rispetto ad altri paesi
- corrisponde una coerente ripartizione del
personale per titolo di studio. La quota dei
laureati nelle imprese italiane risulta infatti
più bassa della media europea (6,4%
contro 8,8%). Le differenze maggiori si
colgono nelle piccole imprese, con più di
due punti di differenza; man mano che si
sale nella dimensione il gap si riduce fino
ad arrivare ad un perfetto allineamento
nelle grandi imprese con una quota del
13%. Anche in questo caso la Germania
presenta un’incidenza più alta rispetto
a quella dei suoi principali concorrenti,
sfiorando l’11%, seguita dalla Spagna con
il 10,4%.
Ciò che accomuna questi due paesi è
anche la maggiore omogeneità per classi
di addetti, con una quota di laureati nelle
piccole imprese non lontana rispetto alle
grandi.
Tra le modalità d’impiego degli addetti,
la percentuale di occupati che nel 2008
hanno svolto attività di ricerca e sviluppo è
al di sotto della media (6,7% contro 8,1%)
ed inferiore rispetto a tutti i sette paesi
considerati tranne l’Ungheria (3%). La
Germania è il paese che da questo punto
di vista viene al primo posto (11,2%),
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
mentre i valori di Austria, Francia, Spagna
e Gran Bretagna appaiono molto simili
(attorno al 7% o poco più). Merita però
di essere sottolineato che il gap italiano
emerge in tutte le classi dimensionali, con
una importante eccezione rappresentata
dalle medie imprese, che presentano
un dato superiore alla media (7,2%
contro 6%). Un valore tra l’altro vicino
a quello tedesco (7,6%) e più alto degli
altri paesi. Tra le aree geografiche, la
percentuale di addetti alla ricerca scende
in misura proporzionale al grado di
industrializzazione, passando dal 7,5%
del Nord Ovest al 4,1% del Mezzogiorno.
Tra i settori, valori sopra la media si
riscontrano negli strumenti medicali,
nella farmaceutica, nella chimica, nella
meccanica, negli apparecchi elettrici, nei
trasporti e nel tessile.
Un tema importante toccato dall’indagine
riguarda il personale straniero, proveniente
sia da altri paesi UE sia da paesi non UE,
nelle imprese. La percentuale media della
forza lavoro straniera sugli occupati si
attesta nelle imprese italiane all’8,1%,
una quota più alta della media dei sette
paesi considerati (7,3%) e inferiore
soltanto a quelle dell’Austria (11,8%)
e della Germania (9,5%). Valori più
bassi presentano il Regno Unito (6,8%),
Occupati coinvolti nella R&S (%)
12
10
8
6
4
2
0
Austria
Francia
26 I Rapporto Corporate Efige
Germania
Ungheria
Italia
Spagna
Regno Unito
la Spagna (6%), la Francia (4,1%) e
l’Ungheria (0,7%). Dalla nostra rilevazione
emerge inoltre che in Italia i lavoratori
stranieri sono maggiormente presenti
nelle piccole imprese, nel Nord Est e nei
settori tradizionali e di scala. Questi aspetti
vengono affrontati più dettagliatamente in
uno specifico approfondimento.
Venendo alle forme di flessibilità, il
questionario focalizza l’attenzione su due
aspetti: i contratti a tempo determinato e i
contratti part-time.
La percentuale media di forza lavoro
impiegata con contratti a termine nelle
imprese italiane è del 7,2% contro una
media dei sette paesi considerati del
21,4%, dato quest’ultimo che però è
fortemente influenzato da quello della
Spagna e del Regno Unito, che presentano
– soprattutto la prima – valori molto
elevati. Limitando il confronto a Francia e
Germania, il dato dell’Italia è superiore a
quello della Germania (4,7%), ma inferiore
a quello della Francia (12%). Sia per la
Germania che per l’Italia la percentuale
tende ad aumentare al crescere della
dimensione aziendale. In Italia si passa dal
5,5% delle imprese più piccole al 13,8%
delle grandi. I valori aumentano passando
dal Nord Ovest (5,1%) al Mezzogiorno
(10,8%).
Relativamente al part-time, la quota in
Italia è la più bassa (3,3% contro una
media dei sette paesi considerati del 6%),
con un’incidenza crescente all’aumentare
della dimensione. Nelle grandi imprese
si sfiora il 6% contro il 3% delle piccole.
La principale differenza con gli altri
paesi consiste nella maggior diffusione
del fenomeno nelle piccole imprese. In
Germania ad esempio l’incidenza del
part-time tocca l’8,4% nella fascia 10-19
addetti e l’8% nelle grandi imprese.
Tornando alle caratteristiche del
management, nel questionario sono
contenute alcune domande relative al
management straniero e all’età, al genere
e alle esperienze lavorative all’estero
dell’amministratore delegato.
Nel nostro paese l’incidenza del
management straniero sullo staff
manageriale complessivo appare ancora
modesta, pari ad appena lo 0,7% contro
una media dei sette paesi del 2,8%.
Questo dato è fortemente influenzato dalle
piccole e medie imprese, mentre nelle
grandi si arriva al 3% contro una media
dei sette paesi del 5,4%. In Germania
l’incidenza media è del 4,4% (con il 7,6%
nelle grandi imprese) e in Francia è del
5,3% (con il 5% nelle grandi imprese).
Età media dell’amministratore delegato (%)
fino a 44 anni
Nelle imprese industriali italiane si ha una
maggiore presenza delle donne nel ruolo di
amministratore delegato, con quasi l’11%
contro l’8,6% della media dei sette paesi e
il 7,8% della Germania. Soltanto l’Ungheria
ha una quota maggiore di management
rosa (11,5%). Ciò può dipendere dal forte
ruolo del capitalismo familiare nella realtà
italiana. In tutti i paesi tranne l’Austria
la quota di manager femminili decresce
all’aumentare delle dimensioni aziendali.
Il fenomeno risulta particolarmente
accentuato in Italia, in cui la presenza delle
oltre 64 anni
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Francia
In generale emerge che l’età media
dell’amministratore delegato (o del capo
azienda) è più elevata nelle imprese
italiane rispetto alla media dei sette paesi.
In Italia il 52% degli a.d. ha più di 54
anni contro il 41,2% della media degli
altri paesi e il 37,2% della Germania. Ma
soprattutto il 21,7% ha più di 64 anni
contro il 12% della media dei sette paesi e
il 9% della Germania. Al contrario, la quota
degli a.d. al di sotto dei 45 anni è il 19,3%
contro il 23,6% dei sette Paesi e il 23,8%
della Germania. Nella fascia compresa tra i
45 e i 54 anni la quota dell’Italia è appena
il 28,7% contro il 34,9% della media dei
sette paesi e il 38,4% della Germania. A
livello territoriale, il Mezzogiorno e il Nord
Est sono le aree in cui il management è
relativamente più giovane.
da 45 a 64 anni
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Media 7 Paesi
Spagna
Regno Unito
Amministratore delegato femminile (%)
14
12
10
8
6
4
2
0
Austria
Francia
Germania
Ungheria
donne nel ruolo di amministratore delegato
si abbassa all’1,9% nelle grandi imprese,
contro una media generale del 3,4%.
Come prevedibile, i manager e dirigenti
italiani che hanno lavorato almeno un
anno all’estero non sono molti, appena
l’11,4% contro una media dei sette paesi
del 19,4%. L’Italia figura all’ultimo posto
di questa graduatoria, in cui Austria
(33,1%) e Germania (26,6%) occupano
le prime posizioni. Grandissime differenze
esistono tra piccole e grandi imprese: si
passa infatti dall’8% della fascia 11-20
addetti al 62,3% della fascia con oltre
Italia
249 addetti. Si deve sottolineare come
le distanze con le imprese europee siano
particolarmente forti nelle due fasce
intermedie, ossia da 20 a 49 addetti e
50-249 addetti, con rispettivamente 7,1 e
10,2 punti percentuali. Invece, nelle grandi
imprese la quota italiana è più alta della
media dei sette paesi, che si attesta al
59,1%. In questo caso l’Italia batte anche
la Germania (61,1%) ed appare inferiore
soltanto ad Austria (68,2%) e Spagna
(68,8%).
Dolenti note per le imprese italiane
vengono dalla partecipazione dei lavoratori
Rapporto Corporate Efige I 27
Rapporto Corporate
a corsi di formazione. La percentuale
media della forza lavoro che ha partecipato
nel 2008 a corsi di formazione si ferma
per le imprese italiane all’11,9% contro
il 21% della media dei sette paesi. Ciò
appare coerente con quanto rilevato
dall’Isfol, che sottolinea come solo
un’impresa su quattro preveda corsi di
formazione per i propri dipendenti.1
La partecipazione ai corsi di formazione
aumenta al crescere della dimensione
(si passa infatti dal 10,3% delle imprese
più piccole al 24,1% delle grandi), ma
il gap italiano è evidente in tutte le
classi dimensionali, soprattutto nelle
grandi e nelle medie imprese, da cui
ci si aspetterebbe invece uno sforzo
maggiore per il miglioramento degli skill
professionali. La stessa cosa può dirsi a
livello settoriale, dove comunque i comparti
in cui sono più diffusi i corsi di formazione
sono la farmaceutica, l’alimentare, la
chimica, i mezzi di trasporto, i minerali non
metalliferi, gli strumenti medicali e ottici.
Tra i sette paesi i valori più elevati sono
quelli della Spagna (28,6%), seguita dal
Regno Unito (25,5%) e dalla Germania
(24,7%). I corsi tenuti all’esterno
dell’impresa prevalgono leggermente
rispetto a quelli interni. Ciò vale sia per
l’Italia che per la media dei sette paesi,
anche se in qualche caso (Francia, Spagna
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
e Regno Unito) avviene il contrario.
Gli effetti della crisi si sono fatti
pesantemente sentire sull’occupazione,
comportando in quasi il 42% delle imprese
italiane una riduzione della forza lavoro,
percentuale in linea con la media dei sette
paesi. Circa il 9% delle imprese segnala
comunque un aumento nel 2008 degli
occupati, valore in questo caso inferiore
di quattro punti percentuali rispetto alla
media dei sette paesi. Sia per l’Italia che
per il totale del campione il numero di
imprese che hanno diminuito l’occupazione
aumenta al crescere della dimensione.
In media la riduzione della forza lavoro
è stata per le imprese italiane del
15,6%, valore inferiore di oltre un punto
percentuale rispetto alla media dei sette
paesi. Anche la percentuale di aumento,
pari al 10,4%, è più bassa rispetto alla
media dei sette paesi (11,6%).
Non sembra quindi che la crisi abbia
penalizzato in misura maggiore i
lavoratori italiani rispetto a quelli degli
altri paesi, almeno per quanto riguarda
l’industria. Sotto questo punto di vista
gli ammortizzatori sociali, come la
cassa integrazione, hanno dimostrato di
funzionare, tamponando, quanto meno nel
breve periodo, gli effetti della recessione.
Nello stesso tempo però è più frequente
trovare all’estero imprese che pure in
Percentuale media della forza lavoro che ha partecipato a un corso di
formazione (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
Francia
Germania
28 I Rapporto Corporate Efige
Italia
Spagna
Regno Unito Media 7 Paesi
tempi di crisi hanno assunto e in maniera
anche più consistente.
Nella maggior parte dei casi la diminuzione
dell’occupazione è considerata dalle
imprese come definitiva, sia per l’Italia che
per il campione nel suo complesso.
Ad essere colpiti sono stati soprattutto
gli operai, specie in Italia. Infatti a ridurre
i colletti blu è stato il 36% delle imprese
italiane contro il 27% del campione nel
suo complesso. Per i colletti bianchi invece
le percentuali che si riscontrano per l’Italia
sono più basse rispetto alla media dei
sette paesi, pari rispettivamente a 4,3%
contro 12,3% per gli impiegati e a 0,1%
contro 1% per i quadri e dirigenti.
Nei casi in cui è avvenuto un aumento
della forza lavoro, la quota di imprese che
lo considera temporaneo si posiziona in
Italia al 3,5% contro il 2,5% del totale
del campione, mentre la percentuale di
imprese che lo ritiene definitivo risulta
pari al 3,5% contro il 10,5% del totale
del campione, a conferma di quanto
sottolineato sopra. Le assunzioni hanno
riguardato in misura maggiore i colletti blu
rispetto a quelli bianchi, ma con uno scarto
maggiore tra i primi e i secondi nel caso
italiano rispetto al totale del campione.
1
Rapporto Isfol 2009, p. 18.
Rapporto Corporate Efige I 29
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Management femminile e
management familiare
a cura di Elena d’Alfonso
Imprese familiari e amministratore delegato: differenze
tra classi dimensionali (%)
10-19
>250
50-249
20-49
60
50
I dati analizzati lungo la sezione identificano
come l’Italia il paese con una maggiore presenza
di donne al vertice delle imprese manifatturiere.
Come si è visto, nelle imprese industriali
italiane la presenza delle donne nel ruolo di
amministratore delegato rappresenta l’11% contro
l’8,6% della media dei sette Paesi e il 7,8% della
Germania.
Facilmente questo si lega alla struttura proprietaria delle
imprese italiane che è tipicamente familiare: come si è
visto altrove in questo lavoro, infatti, oltre il 75% delle
imprese italiane ha dichiarato infatti di essere controllato
da individui o famiglie.
In generale, guardando a livello internazionale, è più
facile che le donne che assumono posizioni di dirigenza
siano al vertice di imprese familiari: in effetti la media
tra paesi indica che circa l’82% delle donne manager
sono a capo di un’azienda familiare. L’Italia non si
distanzia molto da queste, mostrando una percentuale
di poco più alta, pari all’84% circa. Molto probabilmente
l’effetto si lega alla maggiore facilità che le donne siano
al vertice qualora ereditino la guida dell’azienda o
facciano comunque parte della famiglia proprietaria; in
effetti, nella stragrande maggioranza dei casi, le donne a
capo di un’azienda familiare sono membri della famiglia
40
30
20
10
0
AD donna impresa
familiare membro
della famiglia
AD uomo impresa
familiare membro
della famiglia
AD donna impresa
familiare esterno
alla famiglia
AD uomo impresa
familiare esterno
alla famiglia
proprietaria, mentre sono pochi i casi di manager donne
scelte esternamente alla famiglia.
In Italia, in particolare, le imprese familiari scelgono
una donna praticamente solo se fa parte della
famiglia; questa regola vale infatti nel 97% dei casi.
Se questa evidenza vale anche a livello cross country,
tuttavia, è interessante notare che in quasi tutti gli altri
paesi non è indifferente la quota di donne esterne alla
famiglia al vertice di questo tipo di imprese: ad esempio
nel totale il 4,7% delle imprese familiari sceglie manager
donne esterni oppure cresciuti all’interno dell’impresa,
ma non appartenenti alla famiglia, contro l’1,1% delle
imprese italiane.
La differenza più alta si registra in particolare sulle donne
AD che non fanno parte necessariamente della famiglia,
ma sono cresciute all’interno dell’azienda; quota che
arriva al 7,5% nel Regno Unito e che come media del
Amministratore delegato donna: criteri di scelta all’interno delle imprese familiari (%)
MEMBRO
DELLA
FAMIGLIA
MANAGER
PRESO AL
DI FUORI
DELL'AZIENDA
MANAGER
CRESCIUTO
ALL'INTERNO
DELL'AZIENDA
Austria
91,8
2,3
6,0
Francia
94,8
0,7
4,5
Germania
93,6
1,2
5,2
Ungheria
93,7
0,0
6,3
Italia
98,9
0,8
0,3
Spagna
92,5
2,2
5,4
Regno Unito
91,3
1,2
7,5
Totale
95,3
1,1
3,6
30 I Rapporto Corporate Efige
totale campionario si aggira intorno al 3,6%. Questo
livello medio è però influenzato proprio dall’Italia, che
ne riduce il livello, poiché qui le donne scelte all’interno
dell’azienda familiare come amministratore delegato
scendono allo 0,3%.
ricambio generazionale più che a una maggiore
apertura dei vertici aziendali alle donne. Anche
all’interno delle imprese familiari, in ogni caso, al
crescere della dimensione diminuiscono drasticamente
le donne amministratore, in particolare quando vengono
scelte al di fuori della famiglia.
In generale si può dire pertanto che è più facile trovare
donne che operano in posizione dirigenziale se le
imprese che dirigono sono familiari e, in particolare,
se esse appartengono alla famiglia. Questo implica
fondamentalmente che sia in atto un ricambio
generazionale all’interno delle imprese familiari, che
favorisce la possibilità di una dirigenza femminile.
In effetti guardando all’età dell’amministratore delegato,
si nota che le donne sono mediamente più giovani
degli uomini: la totalità del campione mostra che il 36%
delle donne amministratore delegato sono al di sotto
dei 44 anni, mentre gli uomini al di sotto dei 44 anni
rappresentano il 22,5% della totalità degli amministratori
delegati. In Italia questa differenza è ancora più evidente,
visto che gli uomini sotto i 44 anni rappresentano il 18%
circa, contro il 30,7% delle donne.
Questo ricambio sembra però funzionare
prevalentemente sulle imprese piccole; anche le imprese
familiari, che sembrano essere più propense delle altre
ad esprimere amministratore delegato donna non lo
fanno sulle dimensioni maggiori, soprattutto se scelgono
di assumere al di fuori della famiglia.
Di nuovo questa evidenza, che è presente anche a livello
internazionale, è particolarmente lampante sulle imprese
italiane, dove le donne membri della famiglia nel ruolo
di amministratore delegato nelle imprese grandi (con
un numero di addetti superiore a 250) sono lo 0,2% del
totale delle imprese a gestione femminile, mentre per gli
uomini questa sale allo 0,9%. È interessante poi notare
che non ci sono nel nostro Paese casi di donne a capo di
un’impresa di grandi dimensioni qualora l’amministratore
sia scelto all’esterno dell’azienda. Viceversa è più
probabile che per le grandi dimensioni, quando viene
scelto esternamente, l’amministratore sia uomo.
In conclusione i dati mostrano che qualcosa sta
cambiando, le imprese al femminile iniziano ad
essere una quota non trascurabile della totalità.
Probabilmente però questo è imputabile al
Rapporto Corporate Efige I 31
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
INVESTIMENTI, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E R&S
a cura di Silvia Giannangeli
Le imprese italiane mostrano di
possedere una buona dotazione
di ICT di base, ma investono
relativamente meno della media
dei paesi considerati in nuove
infrastrutture, macchinari ed impianti
durante il triennio 2007-2009.
Più vivace appare invece
l’investimento in innovazione e
in R&S, sebbene supportato da
strategie di finanziamento più
sbilanciate verso strumenti di debito
tradizionale e più indifferenziate
rispetto agli obiettivi finali
dell’investimento.
Le infrastrutture tecnologiche di base hanno raggiunto ormai nel tessuto industriale italiano,
così come negli altri paesi considerati, una diffusione ampissima. Meno diffuso in Italia
risulta essere invece l’utilizzo avanzato dell’ICT. Sotto il profilo degli investimenti in impianti,
macchinari ed ICT nel triennio 2007-2009, le imprese italiane risultano essere meno
attive rispetto alle altre imprese del campione (sia in termini di numero che di intensità sul
fatturato). La minore propensione all’investimento dell’Italia non appare tuttavia associarsi
ad una più forte reazione delle imprese italiane alla crisi del 2009: il 28% di queste ultime
dichiara infatti di aver ridotto nel 2009 i propri piani di investimento in beni materiali, contro
il 33,1% nel campione complessivo.
Sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, l’Italia registra, al contrario, un’attività
complessivamente al di sopra della media dei sette paesi considerati. Un’ampia parte delle
imprese è coinvolta in innovazioni di prodotto e processo, sebbene la complementarietà fra
queste ultime e cambiamenti di tipo organizzativo siano meno evidenti nel nostro Paese. In
aggiunta, le imprese italiane risultano in larghissima misura impegnate in attività di R&S,
confermando di privilegiare l’utilizzo di strutture interne (R&S in-house), ma dimostrando di
essere più propense del campione complessivo verso l’outsourcing dei servizi di ricerca e
sviluppo. Ancora poco valorizzata appare invece la ricerca universitaria: sono molto poche,
anche nel confronto internazionale, le imprese italiane che si avvalgono degli atenei in
qualità di fornitori di servizi di ricerca.
Sul fronte dei finanziamenti, l’autofinanziamento si conferma essere in tutti i paesi
considerati la modalità preferita dalle imprese per gli investimenti in macchinari, impianti ed
ICT. In Italia, tuttavia, esso copre una quota della spesa per investimenti minore rispetto alla
media del campione. Peculiarità italiana è invece il consistente utilizzo di strumenti quali il
leasing ed il factoring. Poche, in Italia come negli altri paesi, le imprese che dedicano alle
spese in R&S una strategia di finanziamento specifica. Quelle che in Italia lo fanno, inoltre,
sembrano utilizzare un menu di strumenti finanziari “ridotto” rispetto alle imprese degli altri
paesi, Francia, Germania ed Austria in testa.
32 I Rapporto Corporate Efige
Dotazione tecnologica e
investimenti in impianti,
macchinari ed ICT
Come già emerso dalle rilevazioni Istat
sull’uso delle ICT nelle imprese, la diffusione
nel tessuto industriale italiano delle
tecnologie informatiche di base è ormai
molto ampia: più dell’82,4% delle imprese
possiede infatti una connessione Internet a
banda larga. L’adozione è maggiore fra le
imprese di grandi dimensioni (la possiede il
93,1% nelle imprese con più di 250 addetti)
ma resta al di sopra dell’80% anche nelle
PMI. Il confronto internazionale, tuttavia,
mostra un modesto divario fra l’Italia e la
media dei paesi inclusi nell’indagine, che
riguarda sia le grandi imprese che le PMI (la
diffusione media nei sette paesi osservati è
pari a 89,2%).
A frenare l’ulteriore diffusione della banda
larga fra le imprese italiane non risulta
essere il costo della connessione (indicato
solo dal 7,3% delle imprese quale fattore
di ostacolo all’adozione) quanto piuttosto
la percezione da parte delle imprese che
la banda larga non sia necessaria alla loro
attività (fattore indicato dal 34,4% delle
imprese che non hanno la banda larga) e,
a conferma che il digital divide è ancora
un tema da affrontare nel nostro Paese, la
mancanza di copertura del territorio (indicata
dal 23,1%).
Ancora poco diffuse rispetto alle imprese
degli altri paesi europei considerati sono
invece le tecnologie ICT più complesse, come
ad esempio i sistemi informativi finalizzati al
commercio elettronico, adottati soltanto dal
13,9% delle imprese italiane, contro il 33,1%
delle imprese austriache, il 28,5% delle
tedesche e più del 50% delle imprese del
Regno Unito.
Nel triennio 2007-2009 la percentuale
di imprese italiane che ha effettuato
investimenti in impianti, macchinari ed
ICT è stata pari all’80,5%, collocandosi
decisamente al di sotto della media dei
sette paesi considerati (pari a 87,8%).
Nel ranking internazionale, la Germania,
Imprese che hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari ed ICT
nel triennio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Austria
Francia
Germania
Ungheria
Italia
Spagna
Regno
Unito
Media 7
Paesi
Spesa per investimento in impianti, macchinari ed ICT nel triennio (% su fatturato)
Italia
Media 7 Paesi
massimo
minimo
20
15
10
5
0
10-19 addetti
20-49 addetti
50-249 addetti
l’Austria e la Spagna si collocano ai
primi posti, con una quota di imprese
impegnate in attività di investimento pari,
rispettivamente, a 97,1%, 94,7% e 91,4%.
Anche in termini di quota sul fatturato, gli
investimenti delle imprese italiane risultano
inferiori al campione complessivo (9%
contro 10,5%).1 Questa tendenza riguarda
soprattutto le imprese più piccole: la
distanza fra le imprese italiane e la media
del campione complessivo è pari a circa
due punti percentuali nella classe al di
sotto dei 20 addetti, e si riduce al crescere
della dimensione fino a raggiungere i pochi
>250 addetti
Totale
decimi di punto nella classe dimensionale
con più di 250 addetti.
La minore propensione delle imprese
italiane ad investire non appare tuttavia
collegata ad una più acuta reazione alla
crisi. Meno di un terzo delle imprese
italiane (il 27,8%) dichiara di aver ridotto
nel 2009 i propri piani di investimento
in beni materiali, contro una il 33% nel
campione complessivo. Fra i paesi che
sembrano aver sofferto di più della crisi,
spiccano la Spagna (dove le imprese a
dover ripianificare i propri investimenti
sono state il 47,3%), la Francia (42,8%), e
l’Ungheria (35,4%).
Rapporto Corporate Efige I 33
Rapporto Corporate
Innovazione e R&S
Sotto il profilo dell’innovazione, le imprese
italiane risultano più attive rispetto alla
media del campione complessivo: il
66,4% delle imprese italiane ha introdotto
innovazioni o di prodotto o di processo nel
triennio 2007-2009, contro una media del
64,3% (percentuali più alte si registrano
solo in Austria e Spagna).2 L’integrazione
fra prodotto e processo è la tipologia più
diffusa di innovazione, introdotta dal 66,4%
delle imprese italiane (un dato di poco
superiore alla media del campione, pari al
64,4%). Il 22,6% degli innovatori italiani si
è concentrato esclusivamente sui prodotti
mentre il 18,6% ha introdotto soltanto
innovazioni di processo (contro una media
nel campione complessivo, rispettivamente,
del 21,7% e del 15,9%). Lo sviluppo
combinato di innovazione di prodotto e
processo è più frequente nelle imprese di
dimensione superiore: all’aumentare della
dimensione si riduce, corrispondentemente,
la quota di innovatori che adottano
esclusivamente innovazioni di processo.
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Imprese che hanno introdotto innovazioni nel triennio per tipologia (%)
solo prodotto
solo processo
prodotto e processo
Media 7 Paesi
Italia
>250 addetti
50-249 addetti
20-49 addetti
10-19 addetti
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fatturato realizzato dalla vendita di prodotti innovativi nel triennio (%)
Italia
Media 7 Paesi
massimo
minimo
40
35
30
25
Fra gli innovatori, il 28,7% ha introdotto
anche cambiamenti di tipo organizzativo: un
dato al di sotto della media del campione
(31,7%). Una maggiore complementarietà
fra le scelte di innovazione di prodotto
o processo ed organizzative si osserva,
ad esempio, nelle imprese austriache o
tedesche, dove la quota di imprese che
combina questi diversi tipi di cambiamento
sale, rispettivamente, al 50,2% ed al 41,1%.
Le imprese italiane che hanno introdotto
innovazioni di prodotto nel corso del triennio
realizzano una quota di fatturato legata alla
vendita di tali prodotti mediamente superiore
rispetto al campione complessivo (24%
contro 21,3%). La distinzione per classi
dimensionali evidenzia come le piccole
imprese (al di sotto dei 50 addetti) così
come le grandi (al di sopra dei 250) tendano
a “concentrare” maggiormente il proprio
giro d’affari sui prodotti innovativi. Inoltre, in
circa un terzo dei casi (il 33,4%) il prodotto
innovativo introdotto dalle imprese italiane
34 I Rapporto Corporate Efige
20
15
10
5
0
10-19 addetti
20-49 addetti
50-249 addetti
risulta essere nuovo anche per il mercato (la
media dei sette paesi considerati è pari al
30,7%).
Le imprese italiane mostrano un utilizzo
degli strumenti di protezione dei diritti di
proprietà intellettuale in linea con la media
delle imprese complessivamente intervistate.
Il 22,2% delle imprese italiane ha dichiarato
di aver protetto le proprie innovazioni con
brevetto, disegno industriale, marchio, o
copyright (la media del campione è pari
al 22,5%). La forma di protezione più
utilizzata risulta essere il brevetto, di cui il
12,6% delle imprese italiane ha inoltrato
>250 addetti
Totale
domanda nel triennio 2007-2009, seguito
dal marchio (utilizzato dal 12,5% delle
imprese). Scarso appare invece l’utilizzo del
disegno industriale e del copyright. Mentre
quest’ultimo, per sua natura idoneo a
proteggere le opere d’ingegno “immateriali”,
è ragionevolmente poco utilizzato da
imprese manifatturiere, il distacco registrato
nell’utilizzo del disegno industriale fra
le imprese italiane (3%) ed il campione
complessivo (7%) è ragguardevole. La
distanza appare ancora più evidente
confrontando l’Italia con la Germania, dove
l’11,5% delle imprese ha inoltrato richiesta
per un disegno industriale nel triennio.
Poche, infine, in Italia e all’estero, sono
le imprese che hanno ceduto brevetti nel
triennio di riferimento: l’1,8% in Italia, contro
il 2% nel campione complessivo. Il paese
in cui le imprese hanno ceduto più brevetti
è l’Austria, con il 3,6% delle imprese
interessate dal fenomeno.
Guardando alla tipologia di ricerca svolta,
in Italia il 75,2% delle imprese che svolge
R&S si avvale esclusivamente di strutture
interne (in-house), il 9,1% l’acquista
interamente da strutture esterne, mentre
il 15,7% combina R&S in-house ed
esterna3. Rispetto alla media del campione
complessivo, in Italia è più elevata la quota
di imprese che fa outsourcing completo
delle attività di ricerca e sviluppo (il 9,1%
contro il 7,6%). Le imprese di dimensione
superiore (nella classe al di sopra dei 250
addetti) dimostrano di essere più propense
ad integrare l’attività svolta al proprio interno
con servizi di ricerca e sviluppo acquistati
all’esterno. Fra le imprese appartenenti a
gruppi industriali, che in Italia rappresentano
quasi il 15% del campione, l’11,4% acquista
R&S da altre imprese all’interno del proprio
gruppo.
Nel triennio 2007-2009 il 52,8% delle
imprese italiane ha svolto attività di
ricerca e sviluppo (R&S), una percentuale
al di sopra della media dei sette paesi
considerati, pari al 46,2%. Solo le imprese
austriache mostrano una maggiore
partecipazione alle attività di R&S, con il
49,2%. In Italia e negli altri paesi la quota
di imprese coinvolte in attività di R&S
aumenta al crescere della dimensione
aziendale. Anche in termini di intensità di
R&S, le imprese italiane si collocano al
di sopra della media del campione, con
una quota di spese in R&S pari al 7,5%
del fatturato. Meglio delle imprese italiane
soltanto quelle tedesche, in cui la spesa in
R&S è stata pari al 7,9% del fatturato (7,3%
nel campione complessivo). A differenziare
l’Italia dalla Germania risulta in particolar
modo l’intensità di R&S delle imprese di
maggiore dimensione: nelle imprese con più
di 250 addetti, in Germania si è investito in
R&S circa l’8% del fatturato, contro il 5,1%
dell’Italia.
Anche in termini di quota sulla spesa, la
ricerca svolta all’interno dell’impresa è
preponderante (assorbe il 62,7% della spesa
in ricerca in Italia ed il 66,6% in media).
Fra le imprese maggiormente “concentrate”
sulle attività svolte in-house spiccano le
tedesche, in cui la ricerca interna assorbe
quasi il 72% della spesa totale, il valore
in assoluto più elevato del campione.
Fra i fornitori esterni di servizi legati alla
ricerca, le imprese italiane prediligono quelli
Imprese che hanno svolto attività di ricerca nel triennio per tipologia (%)
solo R&S esterna
solo R&S interna
R&S interna ed esterna
Media 7 Paesi
Italia
>250 addetti
50-249 addetti
localizzati nel paese di origine: ad essi va
il 30,1% della spesa dedicata alla R&S
esterna (23,8% nel campione complessivo).
Fra i fornitori preferiti dalle imprese italiane
non c’è l’università. In Italia l’utilizzo in
ambito industriale della ricerca svolta
all’interno del sistema universitario è infatti
il più basso fra i paesi considerati: solo
il 22,3% della R&S esterna è acquistato
dagli atenei, contro una media nei sette
paesi considerati pari al 29,4%. All’estremo
opposto dell’Italia, si collocano l’Ungheria
e l’Austria, in cui, rispettivamente, il 57,6%
ed il 51,4%, della ricerca che non si svolge
internamente è acquistato dal sistema
universitario.
Il fattore di ostacolo all’innovazione
riportato con più frequenza dalle imprese
italiane è la mancanza di strumenti
finanziari adeguati (indicato dal 47,6%
delle imprese intervistate). Un significativo
fattore di ostacolo all’innovazione risulta
anche essere la percezione di un rischio
economico eccessivo, indicato dal 39,4%
delle imprese italiane, e la mancanza di
personale qualificato (indicata dal 16,6%).
In generale, nell’ordinamento dei fattori di
ostacolo all’innovazione, non emergono
differenze sostanziali fra le risposte fornite
dalle imprese italiane e quelle degli altri
paesi considerati.
Infine, guardando alla reazione alla crisi, la
percentuale di imprese italiane che hanno
posticipato gli investimenti in innovazioni di
prodotto e di processo durante il 2009 è pari
al 35,6%, contro una media del campione
complessivo del 34,5%. Come già osservato
per gli investimenti in macchinari, impianti
ed ICT, fra le imprese che risultano aver
posticipato con più frequenza si trovano
quelle spagnole (il cui 50,2% dichiara di
aver rinviato le proprie attività innovative).
20-49 addetti
10-19 addetti
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Rapporto Corporate Efige I 35
Rapporto Corporate
Il finanziamento degli
investimenti in beni materiali
ed in R&S
La fonte di finanziamento per le attività
di investimento in macchinari, impianti
ed ICT preferita dalle imprese italiane si
conferma essere l’autofinanziamento.
La quota di investimenti autofinanziati
dalle imprese italiane è pari al 49,5%, un
valore più basso rispetto alla media dei
sette paesi considerati (pari a 53,6%),
più elevato soltanto della Spagna (in
cui l’autofinanziamento copre il 39,6%
degli investimenti). Al più basso ricorso
all’autofinanziamento si associa in Italia un
utilizzo superiore alla media degli strumenti
di debito, fra cui i prestiti bancari ed il
leasing e factoring. I prestiti bancari coprono
in Italia il 23% degli investimenti (contro
una media del campione complessivo di
24%), meno di quanto registrato in Spagna
(31,3%) e Francia (32,5%), e non molto di
più rispetto alla Germania (22,7%). Il leasing
ed il factoring hanno un peso considerevole
nel finanziare gli investimenti del nostro
sistema industriale: queste forme coprono
infatti il 24,3% degli investimenti materiali in
Italia, il valore più alto fra i paesi considerati,
in cui tale percentuale si attesta intorno al
15% in media.
La finanza infragruppo è praticamente
assente in Italia: essa finanzia lo 0,5% degli
investimenti del triennio. Al contrario, ai
trasferimenti infragruppo è legato il 5,5%
degli investimenti delle imprese austriache
ed il 4,6% delle tedesche (2,8% la media
nei sette paesi considerati).4 Anche il
contributo della finanza pubblica, cui si deve
il finanziamento dell’1,6% degli investimenti
delle imprese italiane, è inferiore rispetto
agli altri paesi europei, con l’eccezione
del Regno Unito e della Francia (1,5%).
L’apporto di finanza da venture capital è
infine scarso in tutti i paesi considerati.
La media della quota di investimenti
finanziati attraverso questa fonte si attesta
infatti attorno allo 0,5% nel campione
complessivo. Nelle imprese italiane tale
quota raggiunge il livello minimo dello 0,1%.
36 I Rapporto Corporate Efige
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Le fonti di finanziamento degli investimenti in impianti, macchinari ed ICT
nel triennio (%)
Autofinanziamento
Finanza infragruppo
Finanziamento pubblico
Leasing e Factoring
Venture Capital e Private Equity
Prestiti bancari
Altre fonti
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Austria
Francia
Germania
A livello dimensionale, sono soprattutto
le PMI a finanziarsi attraverso il ricorso al
debito bancario e al leasing e factoring:
la quota di investimenti legata a questi
strumenti si riduce all’aumentare della
dimensione aziendale, mentre cresce la
quota di investimenti autofinanziata, e
quella basata sulla finanza infragruppo.
Nelle imprese con più di 250 addetti la
quota di autofinanziamento supera in Italia
il 64%, a fronte di una media del campione
complessivo pari al 60,7%. L’incidenza
della finanza infragruppo, benché maggiore
rispetto alle imprese più piccole, rimane
Ungheria
Italia
Regno Unito
Totale
nelle imprese al di sopra dei 250 addetti
decisamente inferiore della media dei sette
paesi considerati (3,9% contro il 13%).
Poche, infine, le imprese italiane che nel
2009 hanno beneficiato di agevolazioni
fiscali per gli investimenti: il 17,4%, contro il
19,8% nel campione complessivo.
Analizzando le scelte di finanziamento
degli investimenti in R&S, la maggior
parte delle imprese italiane (il 68,3%)
dichiara di non adottare una strategia di
finanziamento specifica, ma di adottare
invece gli stessi strumenti utilizzati per
Le fonti di finanziamento della R&S svolta nel triennio (%)
Autofinanziamento
Finanziamento pubblico
Finanza infragruppo
Leasing e Factoring
Venture Capital e Private Equity
Prestiti bancari
Altre fonti
100
80
60
40
20
0
Austria
Francia
Germania
Ungheria
Italia
Regno Unito
finanziare la spesa per investimenti in
beni materiali. Nell’ambito dei paesi
considerati, la Francia (39%) registra
una percentuale decisamente inferiore
rispetto alla media (66,4%), mostrando
una maggiore propensione da parte
delle imprese ad applicare strategie di
finanziamento differenziate a seconda
dell’obiettivo degli investimenti. Nelle
imprese che adottano una strategia
di finanziamento della R&S ad hoc,
l’autofinanziamento continua a giocare la
parte del leone in tutti i paesi considerati5.
In Italia l’autofinanziamento copre l’86,4%
della spesa in R&S, contro l’83,8% nel
campione complessivo. L’importanza dei
prestiti bancari si riduce al 5,3% in media
nei sette paesi considerati, ma in Italia è
più elevata (6,6%). Il ruolo della finanza
pubblica, al contrario, è più rilevante nel
finanziamento della R&S rispetto agli
investimenti in beni materiali, coprendo in
media il 5% della spesa. In Italia, tuttavia,
la quota di spese in ricerca finanziate
grazie al ricorso alla finanza pubblica
è la più bassa del campione (3,9%) ad
esclusione dell’Ungheria. Infine, è scarso
in Italia l’utilizzo della finanza infragruppo
e di venture capital, che coprono,
rispettivamente, lo 0,5% ed lo 0,1% della
spesa in R&S, nettamente al di sotto della
media del campione complessivo, pari al
2,2% e 0,3%.
Infine, il 17,3% delle imprese italiane ha
beneficiato di agevolazioni fiscali per la
ricerca e lo sviluppo, contro una media
nei sette paesi considerati pari al 14,2%.
Il paese in cui è più elevato il numero di
imprese beneficiarie di incentivi fiscali è
l’Austria, con il 20,5% delle imprese.
In generale, dunque, le imprese italiane che
dedicano alle spese in R&S una strategia di
finanziamento specifica, sembrano utilizzare
un menu di strumenti finanziari “ridotto”
rispetto alle imprese degli altri paesi, e
soprattutto rispetto alla Francia, la Germania
e l’Austria.
Un moderato tasso di investimento si evidenzia per il
nostro Paese anche a livello aggregato. I dati di gross fixed
capital formation dai conti trimestrali nazionali pubblicati da
Eurostat confermano ad esempio che, fra i paesi considerati
nell’Indagine, l’Italia registra il minor tasso di crescita degli
investimenti nel quadriennio 2004-2008: +0,4%, contro
il 4% della Germania, il 2,9% della Francia ed il 3,2%
nell’Area Euro.
2
In questo ambito, i risultati dell’indagine EU-EFIGE/BruegelUniCredit differiscono sostanzialmente da quanto emerge
dalla 6th Community Innovation Survey (CIS), che fotografa
l’innovazione nelle imprese dei paesi della UE27 nel triennio
2006-2008. Una delle discrepanze più evidenti è la posizione
relativa nella propensione ad innovare delle imprese spagnole
e tedesche, che appare essere, rispettivamente, sovra- e
sotto-stimata dalla nostra indagine, rispetto a quanto
riportato nella CIS. Per quanto attiene alle imprese italiane,
l’indagine tende a sovrastimare moderatamente l’incidenza
delle imprese che hanno introdotto innovazioni nell’universo
di riferimento, congiuntamente ad altri aspetti dell’attività
innovativa delle imprese (fra cui, ad esempio, la quota di
fatturato realizzata dalla vendita di prodotti innovativi e
l’utilizzo di IPR).
3
La R&S è definita esterna allorché svolta da strutture
“esterne” all’impresa che l’acquista, indipendentemente dal
fatto che siano altre imprese appartenenti allo stesso gruppo
industriale, oppure società o enti al di fuori di eventuali gruppi
di appartenenza.
4
Il dato medio è calcolato utilizzando come base il totale delle
imprese intervistate. Guardando al sottoinsieme delle imprese
appartenenti a gruppi industriali, la finanza infragruppo risulta
coprire il 2,6% degli investimenti delle imprese italiane, molto
al di sotto di quanto accade nelle imprese appartenenti a
gruppi nel complesso del campione (11,9%).
5
I dati sul finanziamento della R&S in Spagna non sono
affidabili a causa dell’elevato numero di missing values, e
pertanto non sono commentati.
1
Rapporto Corporate Efige I 37
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Innovazione e trasformazione
organizzativa delle imprese
italiane ed europee
a cura di Silvia Giannangeli
Sotto il profilo dell’innovazione, le imprese italiane risultano
più attive rispetto alla media del campione complessivo. In
aggiunta, esse risultano in larghissima misura impegnate
in attività di R&S. Tale quadro non corrisponde, tuttavia,
con quanto emerge da fonti informative diverse fra cui, in
primo luogo, la sesta Community Innovation Survey (CIS)
che, guardando alle attività di innovazione e ricerca svolte
dalle imprese europee nel triennio 2006-2008, denuncia un
certo grado di arretramento delle imprese italiane rispetto a
quelle degli altri paesi europei considerati nell’indagine
EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit.
Per avere un’idea più precisa sulle caratteristiche dei
processi di innovazione intrapresi nel triennio dalle imprese
del nostro Paese, è utile tuttavia combinare alcune
informazioni provenienti da diverse domande dell’indagine.
In particolare, guardando alle imprese che nel triennio
dichiarano di avere introdotto innovazioni, sia di prodotto
che di processo, quelle italiane risultano meno propense
del campione complessivo ad associare innovazioni
tecnologiche e non-tecnologiche, come ad esempio
quelle di tipo organizzativo. Cambiamenti organizzativi
complementari alle innovazioni tecnologiche sono stati
introdotti dal 43,2% delle imprese italiane innovative, una
quota molto inferiore rispetto alla media dei sette paesi
considerati (49,3%).
Allo stesso modo, le imprese italiane sembrano più
restie a strutturare attività di ricerca in-house con
Caratteristiche delle imprese della manifattura che
hanno introdotto innovazioni nel triennio (%)
Italia
Media 7 paesi
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Innovazioni
organizzative
38 I Rapporto Corporate Efige
Occupati
in R&S
Utilizzo di
protezione degli IPR
addetti dedicati: solo il 64,7% del campione italiano di
imprese innovative dichiara di avere addetti coinvolti in
attività di R&S, mentre la quota sale a 71% nel campione
complessivo1.
Al contrario, le imprese italiane non sembrano caratterizzarsi
per un ricorso alla proprietà intellettuale inferiore a quanto
registrato in media negli altri paesi: il 29,5% degli innovatori
italiani fa uso di almeno uno strumento di protezione della
proprietà intellettuale (brevetto, marchio, copyright o disegno
industriale). Si tratta di una percentuale non dissimile da
quanto registrato nel campione complessivo, dove il 30,8%
delle imprese innovative fa uso di IPR.
Dietro alla diffusa spinta innovativa delle imprese italiane,
si cela dunque una “strategia dell’innovazione”
potenzialmente meno incisiva, in quanto meno basata
su cambiamenti strutturali delle imprese. L’investimento in
alcune attività immateriali, quali appunto l’organizzazione
e le competenze incorporate nel capitale umano
dell’azienda, è meno forte fra chi si dichiara “innovatore”
in Italia rispetto a quanto accade, ad esempio, in
Germania, dove ben il 66% delle imprese innovative
introduce anche cambiamenti organizzativi, ed il 79%
dedica risorse umane alle attività di ricerca e sviluppo.
Si tratta di un “effetto paese” o ha piuttosto a che fare
con fattori legati alla composizione settoriale del
paese? Forse quest’ultima è la risposta più giusta.
È interessante notare infatti che nei settori industriali
high-tech2, il divario fra le imprese innovative italiane ed
il resto del campione sia pressoché scomparso sia sotto
il profilo delle innovazioni organizzative che sotto quello
degli addetti dedicati alla R&S. Nei settori basati sulla
conoscenza, quindi, la disparità fra l’Italia e gli altri paesi
europei considerati nell’indagine si riduce.
Caratteristiche delle imprese high-tech che hanno
introdotto innovazioni nel triennio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Italia
Media 7 paesi
Innovazioni
organizzative
Occupati
in R&S
Utilizzo di
protezione degli IPR
Come discusso nel capitolo precedente, la percentuale di occupati che nel 2008 hanno svolto
attività di R&S nel campione totale formato da innovatori e non innovatori è in Italia al di sotto
della media del campione complessivo (6,7% contro 8,1%) ed inferiore rispetto a tutti i sette
paesi considerati tranne l’Ungheria.
2
Per la classificazione dei settori industriali riconducibili all’high-tech in base alla classificazione
NACE rev. 1.1 si veda OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009, p. 32.
1
Rapporto Corporate Efige I 39
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
COMMERCIALE E PRODUTTIVA
DELLE IMPRESE ITALIANE
a cura di Luigia Mirella Campagna e Attilio Pasetto
Si confermano elevati sia il numero
delle imprese esportatrici sia la quota
di fatturato esportato. Come numero
di mercati di destinazione l’Italia
si colloca dietro Germania e Gran
Bretagna, alla pari con la Francia e
davanti alla Spagna.
L’internazionalizzazione produttiva
delle nostre imprese avviene più
tramite gli accordi con partners locali
che non attraverso gli investimenti
esteri diretti. Con gli IDE le imprese
privilegiano strategie di insediamento
stabile sui mercati di vendita,
mentre puntando sugli accordi la
strategia è orientata prevalentemente
all’outsourcing.
40 I Rapporto Corporate Efige
Il numero delle imprese esportatrici italiane (margine estensivo) appare più elevato
rispetto ai paesi considerati nell’indagine. Anche il margine intensivo (quota di fatturato
derivante dall’export) è relativamente alto, ma la differenza è meno forte. Sia il margine
estensivo sia quello intensivo variano significativamente al variare della dimensione
aziendale, data la forte correlazione positiva esistente tra propensione ad esportare
e dimensione: le grandi imprese, potendo affrontare meglio gli elevati costi fissi, si
rivolgono con più facilità ai mercati esteri. Le imprese italiane raggiungono in media 11
mercati, collocandosi - insieme alla Francia - in una posizione intermedia tra paesi che
differenziano maggiormente i mercati di sbocco (Germania, Regno Unito e Austria) e paesi
che esportano verso un minor numero di paesi (Spagna e Ungheria). L’indagine conferma
inoltre la tendenza delle imprese italiane ad andare all’estero da sole, in quanto molto
scarso è il ricorso agli incentivi. Ciò pone un problema di policy.
La percentuale di imprese italiane che acquistano servizi e beni intermedi dai mercati
esteri è più bassa della media dei sette paesi considerati. Tra i servizi acquistati
dall’estero, i più rilevanti sono i trasporti e servizi assicurativi, i servizi ICT, i servizi
finanziari, la R&S e i servizi di ingegneria. Per quanto riguarda i beni intermedi, le imprese
italiane acquistano materie prime in percentuale maggiore rispetto alla media, mentre sui
componenti troviamo percentuali inferiori.
Il grado di internazionalizzazione produttiva delle nostre imprese è inferiore alla media dei
sette paesi quanto a investimenti esteri diretti (IDE), ma superiore alla media quanto ad
accordi tecnico-produttivi e contratti stipulati con imprese locali. Questo risultato appare
coerente con la minore dimensione media delle imprese italiane, che preferiscono un
modello di internazionalizzazione leggera. Dal confronto fra IDE e accordi si nota che,
mentre gli IDE sono destinati soprattutto a servire, attraverso la vendita dei prodotti,
i mercati o del paese in cui sono effettuati o di paesi terzi, gli accordi obbediscono
principalmente a una logica di delocalizzazione. Attraverso gli accordi si producono infatti
beni, che sono importati nel paese di origine o per essere impiegati nella produzione o per
essere rivenduti come prodotti finiti.
Le tematiche dell’internazionalizzazione
sono affrontate nell’indagine in maniera
molto estesa ed approfondita. La sezione del
questionario che le analizza è suddivisa in
tre parti: la prima contiene domande relative
alle esportazioni; la seconda si occupa di
acquisti all’estero di materie prime, beni
intermedi e servizi; la terza indaga il tema
della realizzazione di attività produttive
all’estero. L’obiettivo è di riuscire ad avere
una visione ampia e completa del grado di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi
dei sette paesi considerati nella survey. Qui
di seguito l’analisi dei principali risultati delle
tre parti.
LE ESPORTAZIONI
Imprese esportatrici
Le imprese manifatturiere che vendono
all’estero rappresentavano nel 2008 oltre
i due terzi del totale delle imprese con
oltre 10 addetti (67%). In questo insieme
sono comprese tutte le imprese attive sui
mercati esteri, incluse quelle che producono
in Italia ma vendono all’estero tramite un
intermediario (4,9%) e quelle che producono
in paesi terzi per vendere successivamente
all’estero (2,9%).
Le imprese esportatrici in senso stretto, cioè
quelle che vendono direttamente sui mercati
esteri merci prodotte in territorio nazionale,
costituiscono il gruppo più numeroso. Nel
2008 si attestavano al 63,5% del totale.
Questa percentuale (margine estensivo),
indiscutibilmente elevata esprime con
evidenza la forte vocazione all’export
dell’industria manifatturiera italiana.
proporzionale alla dimensione aziendale:
essa risulta cioè più intensa tra le imprese
più piccole. Questa osservazione può trovare
una spiegazione nel processo di profonda
ristrutturazione che ha interessato il sistema
produttivo italiano nell’ultimo decennio, che
- come è stato evidenziato da molti lavori
- ha portato all’esclusione tra le imprese
esportatrici di quelle meno efficienti,
soprattutto in alcune delle produzioni tipiche
del made in Italy, anche in conseguenza
dalla pressione competitiva esercitata dai
paesi emergenti.
La diminuzione delle imprese esportatrici
non è un fenomeno solo italiano, ma ha
interessato tutti i paesi oggetto dell’indagine.
L’indagine indica anzi che l’Italia – insieme
al Regno Unito - è il paese dove il numero
delle imprese esportatrici è calato meno che
altrove: il fenomeno, infatti, ha riguardato
più del 17% delle imprese tedesche e una
percentuale intorno all’11% in Francia e
Spagna. Va precisato però che la flessione
si è realizzata per la maggior parte a danno
di un particolare gruppo di imprese, per
le quali la vendita sui mercati esteri non
rappresentava una scelta strategica di
rilievo: tra le imprese che esportavano prima
del 2008, infatti, in ogni paese c’era una
percentuale intorno al 25-30% che lo faceva
in maniera saltuaria e non regolare.
Il margine estensivo varia significativamente
al variare della dimensione aziendale,
trovando riscontro la forte correlazione
positiva esistente tra propensione ad
esportare e dimensione. Guardando al
numero degli addetti, le imprese esportatrici
rappresentano il 55,5% del totale delle
imprese più piccole (10-19 addetti), contro
una media dei sette paesi osservati pari al
41,9%; la percentuale sale ad oltre l’87%
tra le grandi imprese (69,7% la media
dei sette paesi). La stessa informazione
si ottiene guardando al fatturato: tra le
imprese con un fatturato inferiore ad un
milione di euro, le imprese esportatrici sono
in media meno del 30%; raddoppiano ed
anzi superano i due terzi del totale nello
strato di imprese che dichiarano un fatturato
compreso tra 2 e 10 milioni di euro, mentre
raggiungono il 90% tra le imprese con un
fatturato superiore ai 250 milioni.
La dimensione aziendale impatta anche
sull’intensità dell’attività di esportazione,
misurata dalla quota di fatturato derivante
dall’export sul fatturato complessivo
(margine intensivo). Anche questa
percentuale tende a salire man mano
che aumenta la dimensione, sebbene le
differenze tra le diverse classi dimensionali
siano meno pronunciate rispetto a quelle
osservate per il margine estensivo: nella
Imprese esportatrici per dimensione aziendale (% sul totale imprese)
prima del 2008
2008
differenza (sn)
10
90
8
75
La differenza positiva tra il numero
delle imprese che esportavano prima
del 2008 e il numero delle imprese che
hanno esportato nel 2008 indica che
negli ultimi anni le imprese esportatrici
sono diminuite, confermando la tendenza
alla flessione emersa fin dall’inizio del
decennio. La diminuzione, pari in media a
6,8 punti percentuali, risulta inversamente
60
6
45
4
30
2
15
0
0
10-19 addetti
20-49
50-249
>250
Rapporto Corporate Efige I 41
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
interno; le grandi, all’opposto, tendono ad
avere comportamenti più omogenei.
Imprese esportatrici - Margine estensivo e intensivo per dimensione (%)
mg estensivo
mg intensivo
90
75
60
45
30
15
0
10-19 addetti
20-49
50-249
>250
Imprese esportatrici - Margine estensivo ed intensivo per paese (%)
mg estensivo
mg intensivo
70
60
50
40
30
20
10
0
Germania
Francia
Spagna
Ungheria
Austria
Regno Unito
Il confronto internazionale consente di
cogliere alcuni aspetti peculiari del nostro
sistema di esportazione1. Il numero delle
imprese esportatrici italiane, misurato in
termini di margine estensivo, è il più elevato
tra i sette paesi osservati. Ciò è spiegato
dalla enorme frammentazione produttiva che
caratterizza il nostro sistema produttivo, fatto
soprattutto di micro imprese: basti pensare
che in Italia le imprese manifatturiere con
oltre 10 addetti – l’aggregato di riferimento
del nostro campione, che viene utilizzato
come denominatore nel margine estensivo
– rappresentano meno del 20% delle
imprese attive; lo stesso aggregato sfiora in
Germania il 40%.
Per quanto riguarda il margine intensivo,
anch’esso elevato in termini relativi,
si osserva che le differenze rispetto ai
principali paesi sono tuttavia meno ampie
di quanto si è osservato per il margine
estensivo. Ciò segnala che in Italia vi sono
un gran numero di imprese che vendono
all’estero, ma l’intensità delle esportazioni
varia sensibilmente tra loro: accanto ad
imprese molto impegnate nell’attività di
export, ve ne sono evidentemente altre che
esportano solo piccole quantità della loro
produzione.
Italia
Strategie di esportazione
classe più piccola (10-19 addetti), la
percentuale si attesta poco al di sopra del
30% (26,9% la media dei sette paesi),
mentre tra le grandi imprese, la stessa
percentuale raggiunge il 52,6% (43,1%).
In conclusione, i dati disponibili mostrano
con chiarezza che, per riuscire ad esportare,
bisogna essere più grandi: le imprese
grandi, potendo affrontare con maggiore
facilità gli elevati costi fissi, si rivolgono con
più facilità ai mercati esteri. Nel valutare
l’informazione, bisogna tener conto che la
grande dimensione è associata in genere
ad altre caratteristiche aziendali, quali:
42 I Rapporto Corporate Efige
maggiore intensità di capitale e lavoro
qualificato, maggiore spesa in innovazione,
ricerca e sviluppo e, in generale, più elevata
produttività. Non è un caso, quindi, che la
deviazione standard associata al valore
medio del margine intensivo delle imprese
esportatrici decresca al crescere della loro
dimensione: questo indica che la variabilità
dei comportamenti verso i mercati esteri è
maggiore tra le imprese più piccole, dove
è più facile che si mescolino imprese con
caratteristiche molto diverse tra loro, tra le
quali è possibile trovare indifferentemente
imprese con elevata propensione all’export
ed imprese che vendono solo sul mercato
La strategia di internazionalizzazione
commerciale di un’impresa può variare
fortemente in relazione ad alcuni parametri
che ne identificano il livello di sofisticazione.
In particolare, essa si qualifica per il numero
dei mercati di destinazione raggiunti
dall’impresa e la loro prossimità al mercato
domestico, per le quote di esportazioni
collocate su ciascun mercato, per il numero
delle linee di prodotto esportate.
La diversificazione verso un numero elevato
di mercati di sbocco segnala un certo
grado di dinamicità delle imprese in quanto,
oltre a differenziare il rischio svincolando i
risultati aziendali dagli andamenti di pochi
partner commerciali, è indice di successo
competitivo e permette anche di ottenere
vantaggi di scala relativi alla produzione,
distribuzione e commercializzazione del
prodotto. Le imprese italiane raggiungono in
media 11 mercati, collocandosi – insieme
alla Francia - in una posizione intermedia
tra paesi che risultano differenziare in
misura maggiore i mercati di sbocco
(Germania, Regno Unito e Austria) e paesi
che risultano invece legati ad un minor
numero di mercati (Spagna e Ungheria).
Su questa variabile, la dimensione impatta
moltissimo, coerentemente con l’ipotesi
che ogni mercato estero comporta costi
fissi aggiuntivi. La polarizzazione su un
numero relativamente limitato di mercati di
sbocco delle esportazioni resta quindi una
caratteristica delle imprese di dimensioni
minori: le piccole imprese mostrano in
media 10 mercati di sbocco, le grandi ne
raggiungono in media 29.
Relativamente alle aree di destinazione,
quasi il 90% delle imprese esporta una
parte della propria produzione nei paesi
UE-15, mentre i restanti paesi UE ne
attraggono poco più del 40%. Il secondo
mercato di sbocco per le nostre esportazioni
è rappresentato dai paesi europei non-UE,
specialmente Russia e Turchia, dove quasi
il 50% delle imprese vende una parte delle
proprie merci. Gli altri mercati di riferimento
per le nostre imprese sono, nell’ordine, Stati
Uniti e Canada, paesi emergenti dell’Est
Asiatico, America Latina, Cina e India,
accogliendo essi una percentuale di imprese
esportatrici che va dal 30,5% nella prima
area al 17,7% nell’ultima. Le quote medie
di export – ottenute uguagliando a 100 le
esportazioni totali - riflettono il diverso grado
di “presenza” sui mercati: la quota maggiore
(58,2%) viene collocata nei paesi UE-15;
seguono a notevole distanza i paesi europei
non-UE (11,2%), chiudono i mercati cinesi e
indiani, dove la quota di esportazioni rimane
molto bassa (2,8%) e inferiore a quella del
campione complessivo (3,1%).
Mercati di destinazione delle esportazioni (%)
quota media export
n. di imprese (%)
100
80
60
58,2
40
20
11,2
9,2
6,3
Altri
paesi UE
USA e
Canada
5,1
4,4
2,9
2,8
0
Paesi
UE15
Europa
non-UE
Dal confronto internazionale emerge una
sostanziale somiglianza con i paesi europei
più grandi, con qualche differenza legata
probabilmente alla prossimità geografica
dei mercati di sbocco. L’Italia, ad esempio,
è il paese con una presenza nei mercati
UE-15 relativamente più bassa rispetto
ai grandi paesi concorrenti (in Germania,
il 93% delle imprese colloca in questa
area una quota media pari al 60,8%;
in Francia, le stesse percentuali sono,
rispettivamente, 92,5% e 61,2%; in Spagna
92,6% e 70,2%); questa “minor presenza”
nei paesi UE-15 è compensata però da
una attività relativamente maggiore nelle
“altre Aree” (specialmente Africa), dove il
24,2% delle imprese colloca una quota
media di esportazioni pari al 5,1%. Per
quanto riguarda le economie emergenti
a crescita più rapida, le imprese italiane
sono relativamente attive nei paesi
asiatici (esclusa Cina e India, dove invece
accusano un ritardo rispetto ai principali
concorrenti europei) e in America Latina.
E’ interessante osservare che la quota di
imprese esportatrici sui mercati più lontani
è tendenzialmente inferiore a quella rilevata
in Germania, Francia e Regno Unito; non si
osserva invece la stessa cosa per le quote
medie di export. Sembrerebbe quindi che
un minor numero di imprese collochi quote
simili, o in qualche caso anche superiori, a
Altre
aree
Altri paesi Centro e
Cina
asiatici Sud America e India
quelle dei paesi concorrenti; osservazione,
questa, che rimanda alla dimensione
aziendale, mediamente maggiore per le
imprese italiane che vanno sui mercati esteri
più lontani.
Incentivi e credito alle
esportazioni
Malgrado i vantaggi, andare all’estero
costituisce ancora un passo non facile per la
maggior parte delle imprese, soprattutto di
piccola e media dimensione. I problemi più
comuni sono spesso legati semplicemente
alla mancanza dei contatti che potrebbero
informarle sull’esistenza di adeguate
opportunità di affari, possibili soci o
potenziali aperture sui mercati esteri. A parte
questi ostacoli di natura informativa, spesso
segnalati dalle nostre aziende, vi sono poi
ostacoli legati alla capacità dell’impresa
di migliorare l’accesso all’innovazione
e all’alta tecnologia. Infine, un altro
ostacolo significativo è rappresentato
dall’investimento finanziario necessario
per lanciarsi nell’arena internazionale. Il
questionario prevede tre domande finalizzate
a cogliere l’esistenza o meno di strumenti
mirati a superare l’ostacolo finanziario
all’internazionalizzazione.
Poiché una parte significativa degli
attuali programmi pubblici di sostegno
Rapporto Corporate Efige I 43
Rapporto Corporate
all’internazionalizzazione si concentrano
sulla promozione delle esportazioni mediante
strumenti come benefici fiscali, crediti
alle esportazioni, assicurazioni sul credito
alle esportazioni, si è chiesto alle imprese
se hanno beneficiato di incentivi fiscali
o finanziari all’esportazione. Il 97% delle
imprese ha risposto negativamente alla
domanda e solo il 3% affermativamente.
I risultati dell’indagine hanno peraltro
confermato lo svantaggio delle piccole
imprese nell’accesso ai programmi di
sostegno: la percentuale di coloro che hanno
beneficiato di incentivi all’esportazione
scende all’1,4% tra le imprese più piccole
(10-19 addetti), mentre la stessa percentuale
sale al 6,2% fra le imprese grandi (oltre 250
addetti). La scarsa diffusione degli incentivi
tra le PMI può essere collegata qualche volta
alla mancanza di conoscenza dei programmi
di sostegno da parte delle stesse imprese e
alla confusione creata dall’esistenza di troppi
regimi di sostegno che si sovrappongono e
che disorientano le imprese. Qualunque sia la
ragione specifica, però, sarebbe auspicabile
un impegno maggiore del legislatore su
una più capillare diffusione degli incentivi
all’internazionalizzazione.
Il confronto internazionale consente di
cogliere qualche differenza tra i grandi
paesi. In generale, i programmi di sostegno
all’internazionalizzazione sembrano
riguardare ovunque piccole quote di imprese,
ad eccezione della Spagna, dove si osserva
una percentuale relativamente alta di
imprese che usufruisce di incentivi pubblici
(13%), soprattutto tra le medie e le grandi
imprese (circa 20% e 24%, rispettivamente).
E’ interessante però notare che la Francia
risulta relativamente più attiva nel sostegno
alle PMI rispetto a quanto lo sia per le
grandi imprese: guardando alle risposte,
emerge infatti che usufruisce di incentivi
all’esportazione il 6,5% delle piccole imprese
e il 9% delle grandi, contro appena il 4,2%
delle grandi. Analogo discorso vale per il
Regno Unito, sebbene su numeri molto più
piccoli.
44 I Rapporto Corporate Efige
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Relativamente al credito alle esportazioni,
dall’indagine emerge che un numero
relativamente alto di imprese italiane ne
usufruisce (18%, contro una media del
campione complessivo del 10,4%). Anche
qui si osserva una correlazione diretta con la
dimensione aziendale: in media, le imprese
medie e grandi utilizzano più frequentemente
questo strumento di finanziamento (22%
circa, contro il 15% circa delle piccole).
I principali paesi concorrenti ne fanno invece
un uso molto più limitato (Germania 4,4% Francia 4,3%- Regno Unito 5,6%).
Diversi ma in senso opposto sono invece i
comportamenti rispetto alla sottoscrizione
di un’assicurazione sul credito per le
esportazioni o comunque per il commercio.
Le imprese italiane, pur utilizzando in misura
maggiore questa modalità di finanziamento
rispetto alle imprese concorrenti di altri
paesi, sottoscrivono assicurazioni sul
credito in misura minore rispetto agli altri. In
media, solo il 19% delle nostre imprese ha
dichiarato di aver beneficiato o sottoscritto
una polizza assicurativa su questa tipologia
di credito, contro il 40,4% della Germania,
il 34% del Regno Unito e oltre il 32% di
Francia e Spagna. Si conferma così la bassa
“sensibilità” delle nostre imprese ad una
gestione dinamica del rischio collegato
ai crediti commerciali e alle esportazioni,
spiegata forse da una scarsa conoscenza
della materia e, in generale, da una scarsa
cultura assicurativa.
ACQUISTI DI SERVIZI E BENI
INTERMEDI PER LA PRODUZIONE
In questa parte si intende misurare il grado
di internazionalizzazione delle imprese
in termini di importazioni, analizzando le
operazioni di acquisto di beni (materie prime
e semilavorati) e servizi dall’estero. Come
per le esportazioni, anche per le importazioni
questo aspetto dell’internazionalizzazione
si può vedere come margine estensivo
(quota delle imprese che fanno acquisti
sui mercati esteri sul totale delle imprese)
e come margine intensivo (incidenza della
quota estera sugli acquisti totali di beni e
servizi). Il questionario consente di analizzare
l’incidenza del margine estensivo in
riferimento sia al momento della rilevazione
sia prima del 2008, l’anno di scoppio
della crisi. Per il margine intensivo occorre
invece fare riferimento al momento della
rilevazione.
Acquisto di servizi
Il 65,4% delle imprese italiane nel 2008
ha acquistato servizi per la produzione
nazionale sul mercato interno, una
percentuale superiore rispetto alla media dei
sette Paesi considerati (59,8%). Soltanto la
Francia presenta, con il 70,8%, una quota
più alta.
Invece la percentuale di imprese italiane
che ha acquistato servizi dai mercati
esteri (7,1%) è più bassa della media
dei sette paesi considerati (8,2%).
Unicamente Spagna (5,7%) e Regno Unito
(6,1%) presentano valori inferiori. Queste
percentuali aumentano al crescere della
dimensione d’impresa. Soprattutto la quota
di servizi acquistati dall’estero subisce un
forte aumento, passando dal 3,8% delle
piccole imprese (contro il 4,7% della media
dei sette paesi) al 38% delle grandi (contro
il 30,2% della media dei sette paesi). Ma
vi è anche una percentuale rilevante di
imprese che non ha acquistato servizi né
dall’interno né dall’estero (34%), un valore
comunque inferiore rispetto alla media
europea (39,4%). Qui la quota decresce
all’aumentare della dimensione.
L’incidenza in termini di fatturato degli
acquisti di servizi è in linea, con l’11%,
con la media generale. Ma mentre la quota
delle piccole imprese è leggermente più
bassa della media generale, l’incidenza nelle
medie (13,4% contro 11,1%) e nelle grandi
imprese (13,5% contro 12,6%) è maggiore.
Il principale riferimento per le imprese
italiane rimane comunque il mercato interno,
se è vero che la quota media sui servizi
totali dei servizi acquistati all’estero è più
bassa per l’Italia (15,4%) rispetto alla media
dei sette paesi considerati (19,4%), e questo
si verifica per tutte le classi dimensionali.
Per depurare questi dati dagli effetti della
crisi, è stato chiesto agli intervistati di
indicare i loro comportamenti prima del
2008. Le imprese che hanno dichiarato di
acquistare servizi regolarmente è risultata
pari al 6,6%; a questa percentuale va
aggiunto un 14% di imprese che acquistava
saltuariamente. La quota maggiore (79,4%)
non acquistava mai servizi dall’estero.
Sommando le prime due componenti
si arriva a una percentuale del 20,6%,
superiore al 7,1% che ha dichiarato di
aver acquistato servizi nel 2008. La quota
italiana, in media, è perfettamente allineata
a quella europea (20,5%), ma va segnalato
che nella media del campione è più alta
la quota che acquistava regolarmente
(8,4%) e più bassa quella che acquistava
saltuariamente (12,1%).
Diversità emergono inoltre a livello
d’impresa. Infatti, nelle piccole e medie
imprese il dato italiano è al di sotto di
qualche punto percentuale a quello
europeo, mentre nelle grandi imprese è al
di sopra di oltre dieci p.p. (63,4% contro
53,2%).
Quota dei servizi acquistati dall’estero sui servizi totali acquistati (%)
30
25
20
15
10
5
0
Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Media 7 Paesi
Modalità di acquisto dei servizi acquistati dall’estero prima del 2008 (%)
Regolarmente
Qualche volta
Sommatoria delle due modalità
30
25
20
15
10
5
0
Tra i paesi da cui sono acquistati i servizi
prevale nettamente per le imprese italiane
l’Europa dei 15 (89,6% contro l’83,2%
della media dei sette paesi), mentre
relativamente all’incidenza delle altre aree
la quota dell’Italia è generalmente più bassa
rispetto alla media dei sette paesi.
Tra i servizi acquistati dall’estero, i più
rilevanti appaiono i trasporti e servizi
assicurativi sia per l’Italia (79,3%) che per
la media dei sette paesi (72,9%), seguiti
dalle comunicazioni e servizi IT (13,5%
contro 21,4%), dai servizi finanziari (6,8%
contro 10,2%), dalla R&S e servizi di
ingegneria (15% contro 21,9%) e dagli
altri servizi (35,5% contro 36,7%). Come
Francia
Germania
Italia
si vede, si hanno percentuali più alte per
l’Italia riguardo ai trasporti e più basse per
gli altri tipi di servizi.
Acquisto di beni intermedi
componenti o semilavorati per
la produzione
Considerazioni analoghe valgono per gli
acquisti di beni intermedi. Anche qui, sul
totale, le imprese italiane che acquistano
dall’interno è superiore rispetto alla media
dei sette paesi (83,2% contro 69,4%),
mentre il contrario avviene per gli acquisti
dall’estero (32,4% contro 36,3%). Per
questi ultimi l’unica importante eccezione
Spagna
Regno Unito
Media 7 Paesi
è rappresentata dalle grandi imprese (70%
contro 63,1%).
Nel 2008 i beni intermedi acquistati hanno
rappresentato nelle nostre imprese il 32% del
fatturato, una quota stabile per tutte le classi
dimensionali, tranne che per le grandi imprese
in cui si arriva al 37,3%. Sono valori un po’
superiori rispetto alla media dei sette paesi,
che si colloca attorno al 30% con differenze
minime tra le classi dimensionali.
La quota dei beni intermedi provenienti
dall’estero sul totale dei beni intermedi
acquistati non differisce molto per l’Italia
Rapporto Corporate Efige I 45
Rapporto Corporate
(26,2%) rispetto alla media dei sette paesi
(27,2%). Anche in questo caso le grandi
imprese hanno una quota maggiore
(32,5% contro 30,7%).
Analogamente a quanto fatto per i servizi,
anche qui si è chiesto alle imprese il loro
comportamento in materia di acquisti di prodotti
intermedi prima del 2008.
Il 22,4% delle imprese ha dichiarato di aver
acquistato beni intermedi regolarmente e un
altro 19,4% ha dichiarato di aver acquistato
saltuariamente. Come per i servizi, nella media
del campione la quota delle imprese che ha
acquistato regolarmente appare leggermente
più alta (25,5%) e invece la quota di chi
ha acquistato solo qualche volta più bassa
(17,8%). Sommando le due componenti si
hanno quote abbastanza simili (41,8% per
l’Italia contro il 43,3% della media dei sette
paesi). Anche qui troviamo percentuali più
alte di quelle relative agli acquisti dall’estero
per il solo 2008. E anche in questo caso le
quote, sommate assieme, di chi ha acquistato
regolarmente e saltuariamente sono più alte per
le grandi imprese italiane rispetto alla media
dei sette paesi (82,5% contro 72,1%), mentre
il contrario vale – con differenze però molto
minori – nelle altre classi dimensionali.
Per quanto riguarda i paesi di provenienza dei
beni acquistati, si verifica una situazione un po’
diversa rispetto ai servizi, in quanto la quota
dell’Europa dei 15, pur essendo la più rilevante,
assume un peso leggermente inferiore rispetto
alla media dei sette paesi (78 contro 81%),
mentre il contrario si verifica per le altre aree
geografiche.
Le imprese italiane acquistano materie prime
in percentuale maggiore rispetto alla media
dei sette paesi (79 contro 74%), mentre sui
componenti generici/standardizzati (23 contro
41%) e sui componenti specifici/personalizzati
(24 contro 37,7%) si riscontrano percentuali
inferiori. Questa caratteristica si ripete in tutte le
classi dimensionali.
Questa parte si conclude con una domanda
sugli effetti della crisi, che in un certo
46 I Rapporto Corporate Efige
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Quota dei beni intermedi acquistati dall’estero sui beni intermedi totali
acquistati (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Media 7 Paesi
Modalità di acquisto dei beni intermedi prima del 2008 (%)
Regolarmente
Qualche volta
Sommatoria delle due modalità
60
50
40
30
20
10
0
Francia
Germania
Italia
modo integra le due domande relative ai
comportamenti prima del 2008. La domanda
riguarda la quota di imprese che hanno ridotto
il volume degli acquisti dall’estero e l’entità
della riduzione. La quota delle imprese italiane
risulta superiore al totale del campione
(il 53,4% delle imprese che importano contro
il 38,6% della media dei sette paesi), mentre
la riduzione media dei beni acquistati è stata
del 31,4%, valore molto prossimo alla media
generale del 30%. Sia a livello dell’Italia che
degli altri paesi l’incidenza della riduzione si
riduce all’aumentare della dimensione. Per il
nostro paese si passa dal 34% delle imprese
più piccole al 26,9% delle grandi.
Spagna
Regno Unito
Media 7 Paesi
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
La terza parte della sezione è dedicata alle
forme più evolute di internazionalizzazione,
ossia allo svolgimento all’estero dell’attività
produttiva. In estrema sintesi, emerge
che il grado di internazionalizzazione
produttiva delle imprese italiane è inferiore
alla media dei sette paesi considerati
quanto a investimenti esteri diretti (IDE),
ma superiore alla media quanto ad accordi
tecnico-produttivi e contratti stipulati con
imprese locali. Questo risultato appare
coerente con la minore dimensione media
delle nostre imprese, che preferiscono
un modello di internazionalizzazione
leggera, in cui accanto alle esportazioni
recitano un ruolo più importante gli accordi
rispetto agli IDE. D’altra parte, il modello di
internazionalizzazione delle grandi imprese
non si discosta molto da quello delle grandi
imprese europee in cui gli IDE assumono
una dimensione rilevante.
Cominciando ad analizzare più nel dettaglio
gli IDE, la percentuale di imprese italiane
che attualmente realizza parte dell’attività
produttiva all’estero in questa forma si
posiziona al 2,5%, contro una media dei
sette paesi considerati del 4%. La quota di
imprese che detengono IDE sale a crescere
della dimensione, passando dallo 0,6%
delle aziende più piccole al 6,2% delle
medie fino al 25,9% delle imprese con
oltre 250 addetti. La distanza rispetto alla
media dei sette paesi considerati passa
dagli 0,5 p.p. delle aziende minori ai 2,3
punti delle medie per scendere a soli 0,7
p.p. nelle grandi imprese. Si direbbe quindi
che sono le medie imprese quelle che si
differenziano maggiormente sotto questo
punto di vista con l’Europa. Se facciamo
il confronto con le imprese tedesche, in
quest’ultime riscontriamo valori superiori
alla media per tutte le classi dimensionali,
con un totale complessivo del 5,8%, il
più alto fra i sette paesi considerati, se si
esclude l’Austria (7,2%).
Il quadro cambia se si fa riferimento agli
accordi e ai contratti tecnico-produttivi.
La media complessiva delle imprese italiane
si posiziona al 4,1%, contro il 3,8% dei
sette paesi. Qui l’Italia supera la Germania
(3,6%), mentre viene sopravanzata dalla
Francia (5,8%), che a sua volta presenta
una quota di IDE (3,9%) leggermente al
di sotto del totale generale. Anche negli
accordi le percentuali di imprese che li
hanno effettuati aumenta al crescere della
dimensione aziendale, in quanto si passa
dal 3,2% delle aziende minori al 7,1% delle
medie e all’8,6% delle grandi. Come si
può notare, nel passaggio dalle medie alle
Imprese che svolgono parte della produzione all’estero (%)
IDE
Accordi con imprese locali
7
6
5
4
3
2
1
0
Francia
Germania
Italia
grandi non c’è quello “scatto” visto negli
IDE. Interessante è anche seguire lo scarto
con la media dei sette paesi considerati: si
va dagli 0,4 punti percentuali delle imprese
più piccole agli 1,7 punti delle medie
imprese ai soli 0,1 punti percentuali delle
grandi. Si può concludere che, nel caso
italiano, gli accordi rappresentano la forma
di internazionalizzazione produttiva più
adatta alle piccole e medie imprese, mentre
gli IDE lo sono per le grandi.
Osservando la quota del fatturato
proveniente sia dagli IDE che dagli accordi
(margine intensivo), possiamo constatare
come le imprese italiane non siano molto
lontane dalle imprese europee. La quota
media di fatturato realizzata nel 2008
attraverso gli IDE si posiziona per le
imprese italiane al 26,5% del fatturato
totale, contro il 28,4% della media dei sette
paesi considerati, il 27,4% della Germania
e il 25,2% della Francia. Per quasi tutti
i paesi l’incidenza del fatturato prodotto
all’estero appare inversamente correlata
alla dimensione aziendale. L’Italia non fa
eccezione, per cui si passa da un’incidenza
del 38,4% delle aziende minori al 24,4%
delle medie fino al 20% delle grandi
imprese.
La quota del fatturato realizzata attraverso
gli accordi appare più alta sia per il
Spagna
Regno Unito
Media 7 Paesi
campione in generale (30,6%) che per
le imprese italiane (29%). Fa eccezione
la Germania, che presenta una quota di
fatturato proveniente dagli accordi del
25%, non la Francia che arriva al 30,6%.
Anche in questo caso l’incidenza del
fatturato tende a diminuire al crescere
della dimensione, raggiungendo i valori più
elevati nelle piccole imprese. Per l’Italia
in particolare si raggiunge un picco del
32,5% nella fascia da 20 a 49 addetti per
scendere al 21,8% nelle medie imprese e
al 17,5% nelle grandi.
La quota maggiore del fatturato prodotto
all’estero sotto forma di IDE viene realizzato
sia per l’Italia che per i sette paesi
considerati (tranne l’Ungheria) nell’Europa
dei 15. L’Italia però presenta una quota più
bassa (28,7%) della media dei sette Paesi
(35,9%) e della Germania (39,3%), mentre
mostra quote più elevate della media in
quasi tutte le altre aree geografiche, tra cui
in particolare Cina e India (18,9% contro
15,7%).
Decisamente più in linea con la media dei
sette paesi la distribuzione per Paese delle
quote di fatturato provenienti dagli accordi
e contratti, con i Paesi UE dei 15 al primo
posto (33,8%), seguiti da Cina e India
(23,6%) e dagli altri Paesi UE (19,1%).
Rapporto Corporate Efige I 47
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Quota del fatturato realizzata attraverso IDE e contratti (%)
IDE
contratti
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Media 7 Paesi
Destinazione della produzione effettuata all’estero dalle imprese italiane
(% sulle imprese che hanno investito o concluso accordi)
IDE
Accordi
70
60
50
40
30
20
10
di internazionalizzazione più orientato
all’outsourcing, a differenza del modello
seguito dalla maggior parte delle imprese
tedesche.
Tra i principali tipi di attività svolte all’estero,
la produzione di prodotti finiti viene
nettamente al primo posto, con percentuali
per l’Italia del 68,3% negli IDE e di oltre il
75% negli accordi, contro rispettivamente
il 73,8% e il 74,9% della media dei sette
paesi considerati. Al secondo posto viene
la produzione di semilavorati e componenti,
con circa il 46% per gli IDE e il 61% per gli
accordi, valori sostanzialmente in linea con
la media dei sette paesi considerati.
Si nota invece una certa differenza riguardo
la ricerca e sviluppo, l’ingegneristica e la
progettazione e, più in generale, gli altri
servizi, con percentuali per l’Italia più
basse rispetto alla media dei sette paesi.
Negli IDE la percentuale relativa alla R&S
e all’engineering si ferma al 10,6% contro
il 15,7% della media dei sette paesi
considerati. Sempre negli IDE per gli altri
servizi la quota dell’Italia è pari all’8,3%
contro l’11,8% della media dei sette paesi.
Valori più bassi si notano negli accordi, ma
sempre con percentuali inferiori rispetto alla
media generale.
0
venduta
nel paese estero
di produzione
importata
nel paese
di origine per essere
impiegata nella
produzione
Particolarmente interessante è l’analisi
della destinazione della produzione
effettuata all’estero. Qui emerge un quadro
composito ma anche netto allo stesso
tempo. Dal confronto fra IDE e accordi si
nota che, mentre gli IDE sono destinati
soprattutto a servire, attraverso la vendita
dei prodotti, i mercati o del paese in cui
sono effettuati o di paesi terzi, gli accordi
obbediscono principalmente a una logica
di delocalizzazione. Essi rispondono allo
scopo di produrre beni che sono importati
nel paese di origine o per essere impiegati
48 I Rapporto Corporate Efige
importata
e venduta nel
paese
di origine
importata
per essere
riesportata
in paesi terzi
venduta
direttamente
in un
paese terzo
nella produzione o per essere venduti sia
nel paese di origine sia - attraverso la
riesportazione - in paesi terzi.
Questa distinzione, che vale sia per l’Italia
sia per gli altri paesi, tra cui la Germania,
trova riscontro in letteratura2, in cui si
sottolinea come IDE e accordi corrispondano
a strategie alternative, più complesse e
volte all’insediamento stabile per i primi e
principalmente finalizzate all’outsourcing
per le seconde. Il maggior ricorso da parte
delle imprese italiane agli accordi rispetto
agli IDE indica il prevalere di un modello
Per quanto riguarda gli effetti della crisi,
la percentuale di imprese italiane che
hanno subito una riduzione del fatturato
proveniente dagli IDE per la contrazione
dell’attività produttiva supera il 50%,
contro il 37% del totale del campione.
Valori sopra la media si riscontrano anche
per Austria, Francia e Regno Unito, mentre
il dato della Germania è allineato al totale
generale. La crisi ha comportato nel
4,7% dei casi la cessazione dell’attività
all’estero, un valore comunque inferiore
alla media dei sette paesi considerati
(5,9%).
Anche gli accordi hanno risentito degli
effetti della crisi, con il 50,2% di imprese
che hanno subito una contrazione del
fatturato, contro il 44,3% della media dei
sette paesi considerati.
Ultimo tema affrontato in questa sezione
della survey è quello dell’assistenza
da parte di enti pubblici e privati per
l’internazionalizzazione delle attività
all’estero. L’Italia, come previsto, si
colloca con l’1,1% di imprese esportatrici
che hanno ricevuto assistenza al di
sotto sia della media generale (1,3%)
sia di paesi come la Germania (1,8%)
e la Spagna (2,2%). Sono le piccole
imprese le più penalizzate, mentre nelle
medie e nelle grandi imprese si hanno
percentuali superiori alla media. Vale la
pena di rilevare che le imprese estere
ottengono assistenza da enti esteri, oltre
che nazionali, mentre le imprese italiane
non utilizzano quasi per niente questo
importante canale.
L’Italia nel 2008 ha contribuito per l’8,0% alle esportazioni
intraUE-27. I contributi degli altri paesi sono stati: Germania
22,9%; Francia 9,8%; Regno Unito 6,6%; Spagna 4,9%; Austria
3,3%; Ungheria 2,1%. Per quanto riguarda le esportazioni extra
UE-27, l’Italia ha contribuito per l’11,6%. I contributi degli altri
paesi sono stati: Germania 27,5%; Francia 11,6%; Regno Unito
10,3%; Spagna 4,4%; Austria 2,6%; Ungheria 1,2% (Eurostat).
2
Vedi in particolare AA.VV. The global operations of European
firms, Progetto Efige, versione preliminare, 18 giugno 2010.
1
Rapporto Corporate Efige I 49
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
CONCORRENZA E MERCATI
a cura di Andrea Brasili
L’approccio delle imprese italiane al
mercato evidenzia alcune specificità
del tessuto produttivo italiano: poco
ruolo di committenza per il settore
pubblico elevato di imprese estere
senza che a questo corrisponda una
percezione della concorrenza che sia
globale. L’altro punto da sottolineare
è quello della percezione della
qualità: non c’è particolare evidenza
di una fitta presenza di medie e
piccole imprese qualitativamente alla
frontiera; chiamate a valutare su una
scala da 1 a 100 il proprio prodotto
dove a 100 c’è il meglio disponibile
sul mercato le imprese italiane si
descrivono in media a 80 contro
l’87,1 del campione complessivo.
Come si relazionano le imprese italiane con il loro mercato di riferimento? Da questa
sezione emergono alcuni segnali contraddittori su cui val la pena di riflettere, certo
si tratta di indicazioni più qualitative di quanto lo siano quelle provenienti dalle altre
sezioni qui molto si fonda sulle percezioni delle imprese più che su risposte dicotomiche
di caratteristiche che hanno o non hanno.
Le imprese italiane producono su commessa più di quanto avvenga all’estero, e tra i
committenti figurano più spesso che nel campione complessivo ed in linea con quanto
evidenziato in relazione alle esportazioni, imprese estere (e tra i committenti vengono
segnalati meno che altrove i consumatori e la pubblica amministrazione).
Nel contempo però i produttori italiani considerano loro concorrenti imprese localizzate
relativamente vicino.
C’è una certa percezione della problematica della scala dimensionale ma non in
maniera dirompente, e in special modo concentrata tra le grandi imprese (che si
percepiscono evidentemente troppo piccole rispetto ai competitors).
Permane invece in maniera molto più spiccata che altrove la percezione che vi siano
ostacoli alla crescita legati a questioni burocratico-regolamentari o di rigidità del
mercato del lavoro.
Aggiunte a queste vengono segnalate la debolezza della domanda e le difficoltà di
accesso al credito; queste ultime sono ovviamente sensibili alle dimensioni d’impresa,
cioè le imprese più piccole manifestano difficoltà maggiori, in particolare per le imprese
con fatturato inferiore ai 2 mln di Euro.
C’è da dire però che l’aumentare delle difficoltà al ridursi della dimensione d’azienda
è più marcato nel resto del campione, rispetto a quanto avvenga in Italia. In termini
di posizionamento qualitativo, le imprese italiane si valutano un po’ più distanti dalla
best practice di quanto facciano le altre imprese intervistate, e in modo maggiormente
dipendente dalla dimensione (le grandi sono più simili alle imprese grandi di altri paesi).
50 I Rapporto Corporate Efige
Il mercato di riferimento
quota di prodotto su commessa, in modo
molto più marcato di quanto avvenga per gli
altri paesi, e quindi contribuisce a spiegare
anche il differenziale tra imprese italiane
ed europee. Da dove provengono queste
commesse?
Per il 5,8% il cliente è un’impresa
appartenente allo stesso gruppo, per il
44,6% gli ordini provengono da imprese
della stessa regione, per il 72,1% da
imprese italiane in genere, per il 46,8% da
imprese straniere (è il 69,5% nel caso delle
imprese più grandi); solo l’8% vende alla PA
e il 24,5% vende anche al dettaglio (cioè
direttamente al consumatore finale).
Questa sezione dell’indagine è dedicata
all’analisi del mercato di riferimento
dell’impresa e delle modalità con cui
l’impresa si relaziona con la domanda,
nonché all’esame dei suoi clienti, dei suoi
concorrenti e del suo posizionamento
competitivo.
Le imprese italiane intervistate affermano
di produrre su commessa l’82,7% del loro
fatturato1, un valore più elevato di quello
del totale delle imprese (non dissimile però
da quanto dichiarato dalle imprese francesi
e ungheresi che si attestano sugli stessi
valori). Questa caratteristica si relaziona in
senso inverso alla dimensione d’impresa,
cioè più piccola l’impresa più elevata la
Anche in relazione alla tipologia di clientela
c’è una ovvia relazione con la dimensione.
Imprese che producono su commessa (%)
10 - 19
ADDETTI
20 - 49
ADDETTI
Italia
84,3
82,9
79,4
61,6
82,7
Media 7 paesi
71,6
70,7
66,8
59,7
70,7
ITALIA
50 - 249 OLTRE 250
ADDETTI ADDETTI
TOTALE
Principali tipologie dei clienti per cui l’impresa lavora su commessa (%)
10 - 19
ADDETTI
20 - 49
ADDETTI
50 - 249 OLTRE 250
ADDETTI ADDETTI
TOTALE
Intra gruppo
Altre imprese nella stessa
regione
Altre imprese nel resto del paese
3,4
5,5
12,0
28,8
5,8
48,0
44,8
34,9
20,9
44,6
68,9
74,0
75,5
61,8
72,1
Altre imprese straniere
37,6
49,3
63,7
69,5
46,8
8,0
7,6
9,0
8,5
7,9
25,9
23,4
24,9
25,9
24,5
10 - 19
ADDETTI
20 - 49
ADDETTI
50 - 249 OLTRE 250
ADDETTI ADDETTI
TOTALE
5,3
9,6
18,9
29,6
10,4
54,8
53,0
45,4
45,8
52,1
Amministrazione pubblica
Clienti privati
MEDIA 7 PAESI
Intra gruppo
Altre imprese nella stessa
regione
Altre imprese nel resto del
paese
Altre imprese straniere
61,9
67,9
69,6
67,2
66,1
30,9
41,5
54,3
61,8
40,7
Amministrazione pubblica
16,4
15,5
15,4
18,5
15,9
Clienti privati
40,5
33,5
26,2
21,6
34,3
Però è interessante sottolineare che sembra
esserci una chiara soglia sopra i 50 addetti
in relazione all’ampiezza del mercato di
riferimento. Infatti all’incirca il 65% delle
imprese sopra questa dimensione ha come
committenti imprese straniere, mentre
questo avviene solo per il 46,8% del
totale delle imprese italiane. Misurando la
dimensione con la classe di fatturato, si può
notare come la soglia alla quale si assiste
ad un balzo netto sia sui 10 milioni, anche
se già oltre i 2 milioni di fatturato il ruolo di
committenti esteri diviene rilevante (oltre
metà delle imprese lo segnala).
Il ruolo di committente svolto da imprese
estere è meno spiccato per le imprese
del campione europeo, che nel contempo
sembrano avere una clientela molto più
locale (la voce “altre imprese della stessa
regione” è indicata dal 52,1% contro il
44,6% delle imprese italiane) anche per le
imprese di grandi dimensioni (commesse
provenienti da altre imprese dell’area
sono indicate dal 45,8% delle grandi
imprese europee, ma solo dal 20,9% delle
italiane). Un’altra caratteristica che emerge
dal campione europeo è che il ruolo delle
commesse pubbliche è molto più rilevante.
La dimensione d’impresa gioca un
ruolo rilevante anche in riferimento alla
localizzazione dei principali concorrenti.
L’89,4% delle imprese italiane vede il proprio
principale concorrente posizionato all’interno
dei confini nazionali (è l’86,2% per il totale del
campione, la risposta multipla era consentita).
Il principale concorrente è percepito fuori dal
Paese e fuori dall’Europa dal 30,7% delle
imprese del campione, ma solo dal 28,7%
delle piccole imprese e dal 45,2% delle
grandi (il dato per il campione complessivo è
molto simile). Va sottolineato che, nonostante
la maggiore presenza internazionale (come
evidenziato nella sezione precedente, le
imprese italiane considerano loro concorrenti
imprese localizzate relativamente vicino.
Ci sono nel questionario due domande relative
alla percezione dell’impresa in relazione al
Rapporto Corporate Efige I 51
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Localizzazione dei principali concorrenti delle imprese (%)
NEL TUO
PAESE
IN ALTRI
PAESI EU
IN ALTRI
PAESI
EUROPEI
NON EU
Italia
89,5
31,8
9,3
Media 7 paesi
86,2
36,5
13,0
proprio posizionamento competitivo: la prima
riguarda la scala dimensionale dell’impresa,
la seconda la qualità del prodotto. In
riferimento alla dimensione “competitiva”
le imprese italiane che percepiscono la
propria scala produttiva come inadeguata
in relazione a quella dei competitors sono
relativamente poche: il 12% circa. Sono un
po’ più numerose nelle categorie estreme,
tra le imprese più piccole (12,8%) e quelle
più grandi (13%). Nel campione complessivo
invece, pur essendo simile la quota totale
(12,6%), essa è chiaramente decrescente con
la dimensione: tra le imprese con più di 250
addetti solo l’8,9% ritiene di avere una scala
dimensionale troppo piccola confrontata ai
competitors (le grandi imprese italiane sono in
media più piccole che nel resto del campione:
in termini di addetti, la media di quelle che
hanno più di 250 addetti è di 674,6 contro
800 per il totale del campione).
La seconda riguarda invece il posizionamento
competitivo dal punto di vista qualitativo:
posto pari a 100 lo standard qualitativo
più elevato disponibile sul mercato per il
prodotto principale dell’azienda, alle imprese
è richiesto di indicare il livello del proprio
prodotto.
La media delle risposte per le imprese italiane
si assesta a quota 80, contro l’87,1 dell’intero
campione. Alla tematica della qualità è
dedicato il box che segue.
ALTRI PAESI
ASIATICI
(ESCLUSO
CINA E INDIA)
USA E
CANADA
CENTRO
E SUD
AMERICA
ALTRE
AREE
22,1
6,2
6,3
2,8
1,9
20,8
8,8
10,4
4,3
4,2
CINA E
INDIA
Non c’è uno spiccato carattere dimensionale
invece nelle indicazioni dei fattori che limitano
o vincolano la crescita dell’impresa, fatta
eccezione in modo abbastanza ovvio per i
vincoli di natura finanziaria, che “mordono”
più le imprese di dimensioni inferiori (questo
vincolo è indicato dal 33,1% delle imprese fino
a 19 addetti, e dal 22,7% di quelle oltre i 250).
Incrociando la domanda con la dimensione in
termini di fatturato c’è evidenza di difficoltà di
accesso al credito soprattutto per le imprese
delle prime due classi dimensionali (fino a due
milioni di fatturato) e poi via via a diminuire.
Comunque l’accesso alle risorse finanziarie
non costituisce l’elemento di maggiore
difficoltà segnalato dalle imprese: in questa
fase è di gran lunga superato dalla debolezza
della domanda (55,3% contro 31,5% su
tutto il campione), ed è avvicinato dai vincoli
di natura burocratico-legislativa (26,2%) o
di regolamentazione del mercato del lavoro
(27,1%).
Guardando al resto del campione si nota
come la “forma” del vincolo finanziario
alla crescita sia più ripido in relazione alla
dimensione, colpendo di più le imprese più
piccole (si nota in particolare escludendo
le imprese italiane dal set complessivo).
In aggiunta questa dei vincoli finanziari
è la domanda più “gettonata” a livello
complessivo, al pari della mancanza di
domanda (ed escludendo la categoria
residuale “altri”). Molto meno citati sono
i vincoli dovuti alla regolamentazione del
mercato del lavoro e alla burocrazia in
genere.
I criteri di fissazione dei prezzi
Per quanto riguarda le politiche di pricing
attuate dalle imprese nel mercato domestico,
il confronto internazionale è particolarmente
suggestivo. In generale suggerisce tre differenti
approcci: le economie piccole e aperte in cui
prevale la percezione dell’esistenza di un prezzo
di mercato al quale l’impresa deve adeguarsi
(Austria e Ungheria), i grandi paesi dell’Europa
continentale (Germania, Francia e Regno Unito),
in cui sostanzialmente si equivale il numero
di imprese che afferma di fissare il prezzo
come margine sui costi totali e quelle che
invece percepiscono il prezzo come fissato dal
mercato, e i paesi mediterranei
(Italia e Spagna) in cui la maggior parte fissa
il prezzo come margine sui costi totali. Per
l’Italia questa percentuale è pari al 43,1% (il
36,2% fa riferimento al prezzo di mercato).
Al crescere della dimensione d’impresa però
queste caratteristiche tendono a sfumarsi e
sembra prevalere la pressione competitiva
“globale” (per le imprese italiane sopra i 250
addetti il 33,8% fissa il prezzo come mark up
sul totale costi e il 46,3% lo ritiene fissato dal
mercato).
Vincoli alla crescita (%)
VINCOLI
FINANZIARI
RIGIDITÀ
MERCATO DEL
LAVORO
RESTRIZIONI
BUROCRATICHE
O LEGISLATIVE
MANCANZA
DI RISORSE
MANAGERIALI O
ORGANIZZATIVE
MANCANZA
DI DOMANDA
ALTRO
NESSUN
VINCOLO
Italia
31,5
27,1
26,2
13,7
55,3
11,2
6,9
Media 7 paesi
31,9
17,6
19,1
10,9
39,3
30,1
9,0
ADDETTI
52 I Rapporto Corporate Efige
Vincoli alla crescita (%)
MANCANZA
DI RISORSE
RESTRIZIONI
MANAGERIALI
BUROCRATICHE
O
O LEGISLATIVE ORGANIZZATIVE
VINCOLI
FINANZIARI
RIGIDITÀ
MERCATO
DEL LAVORO
10 - 19 addetti
33,1
28,5
27,3
20 - 49 addetti
31,2
27,5
50 - 249 addetti
28,8
oltre 250 addetti
22,7
ITALIA
TOTALE
CAMPIONE
ESCLUSA ITALIA
MANCANZA
DI DOMANDA
ALTRO
NESSUN
VINCOLO
12,7
58,3
10,5
5,9
25,7
13,9
55,6
11,8
7,3
20,6
24,3
15,4
60,1
10,7
7,1
26,5
28,0
13,0
53,3
14,5
15,1
MANCANZA
DI RISORSE
RESTRIZIONI
MANAGERIALI
BUROCRATICHE
O
O LEGISLATIVE ORGANIZZATIVE
MANCANZA
DI DOMANDA
ALTRO
NESSUN
VINCOLO
VINCOLI
FINANZIARI
RIGIDITÀ
MERCATO
DEL LAVORO
10 - 19 addetti
36,4
15,0
17,8
10,6
34,7
37,2
9,0
20 - 49 addetti
32,2
12,8
15,5
10,3
31,1
39,2
11,0
50 - 249 addetti
26,7
10,4
13,0
7,2
33,1
42,7
9,2
oltre 250 addetti
23,9
13,7
15,3
6,4
32,7
37,7
12,1
L’impatto sui margini stessi della crisi è stato
nel senso di una riduzione per il 53,5% dei
rispondenti, di stabilità per il 35,4% e di crescita
per l’11,1%, percentuali sostanzialmente
identiche a quelle del totale del campione.
Nel definire l’ampiezza dei margini stessi conta
l’elasticità della domanda al prezzo (53,4%)
e il margine medio praticato nel settore
(32,7%), meno le condizioni macroeconomiche
complessive (14%), anche in questo caso con
risposte analoghe a quelle complessive.
Oltre la metà (il 52,9%) delle imprese che
vendono all’estero afferma di praticare un
prezzo unico (al netto dei costi di trasporto)
per tutti i paesi di destinazione; questa quota
però è molto legata alla dimensione aziendale
e le imprese più grandi sembrano più capaci
di discriminare il prezzo di vendita (sopra i 250
addetti solo il 42,3% delle imprese afferma di
vendere ovunque allo stesso prezzo).
Per la metà che differenzia il prezzo, a livello di
campione complessivo, i motivi sono molteplici,
ma ricevono segnalazioni più frequenti quelli
legati alla differenziazione per qualità o alla
presenza di tariffe o differenti regimi fiscali.
Una quota molto limitata (il 4,2%) di imprese
fissa i propri prezzi di listino in una valuta
differente dall’euro, quota che ovviamente è
legata alla dimensione d’impresa e quindi al
presidiare molti mercati; per le imprese sopra
i 250 addetti infatti la quota è pari al 17,6%.
In questo senso è naturale che solo poche
imprese facciano regolare uso di strumenti di
protezione dal rischio di cambio (solo il 12.4%
dei rispondenti nel complesso, ma ovviamente
metà delle imprese di grandi dimensioni).
Questa quota è, nel totale del campione, pari
al 15,8%; andando a guardare i singoli paesi
si nota il 20% per Germania e Austria e il 22%
per l’Ungheria.
Principale criterio di fissazione dei prezzi (%)
I prezzi sono fissati come margine
del costo totale
I prezzi sono fissati come margine
del costo variabile
I prezzi sono fissati dal mercato
I prezzi sono regolati
Altro
1
AUSTRIA
FRANCIA
GERMANIA
UNGHERIA
ITALIA
SPAGNA
REGNO
UNITO
26,4
40,4
35,3
22,1
43,1
55,9
36,0
14,8
14,5
16,4
10,7
13,1
10,9
22,0
45,1
5,0
6,2
41,2
1,8
2,1
38,8
5,0
3,3
56,3
0,6
10,3
36,2
3,6
4,0
27,2
2,9
3,1
32,2
2,6
3,2
L’84,6% delle imprese italiane intervistate produce su commessa per almeno il 75% del proprio fatturato. La moda del valore indicato è chiaramente il 100% (sono 1954 su 3020 a indicare questo valore,
cioè il 65%); nel resto del campione la produzione su commessa riveste un ruolo meno ampio: la quota corrispondente (>=75%) è del 74,7% e il valore pari al 100% è indicato dal 52,3% delle imprese.
Rapporto Corporate Efige I 53
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
La percezione della qualità del
prodotto nelle scelte delle imprese
italiane
a cura di Andrea Brasili
Come detto, la prima impressione è che le
imprese italiane abbiano una percezione di
maggiore distanza dalla frontiera della best
practice di quella delle imprese degli altri paesi.
Val la pena di analizzare più da vicino questo
aspetto.
La prima curiosità è valutare se vi siano differenziali
in termini dimensionali. Utilizzando come variabile
dimensionale gli occupati non si notano differenze
sostanziali, mentre, guardando al fatturato, si nota
che su alcune categorie medie la distanza è molto ampia,
per esempio (come mostra il grafico) per la categoria
tra i 10 e i 15 milioni di fatturato.
Un esame più attento della distribuzione delle risposte
conferma questa impressione: le grandi imprese tendono,
più delle altre, ad indicare un valore elevato. Viene scelto
un valore uguale o maggiore di 90 per il 58% delle imprese
con più di 250 addetti, a fronte del 45% delle imprese di
piccola dimensione1; sul campione europeo, le distanze
sono meno ampie: un valore maggiore o uguale a 90 viene
indicato dal 69% delle imprese, con le piccole al 66% e le
grandi al 75%.
La forma complessiva della distribuzione2 delle risposte
in termini di livelli di qualità fornisce un altro punto di vista
sul tema, mostrando una presenza chiaramente meno
fitta su livelli prossimi a 100 per le imprese italiane e una
maggiore densità su livelli bassi (non si direbbe dunque che
c’è semplicemente una differente percezione di quale sia il
livello “normale”, l’intera distribuzione è spostata a sinistra).
Ci sono altre domande in questa sezione del
questionario che afferiscono alla qualità: alle imprese
è richiesto anche di definire quali siano i driver di
competitività più rilevanti per il prossimo futuro. Al di là
del peso molto maggiore della voce residuale “altro” per il
campione complessivo si nota una più forte attenzione delle
imprese italiane alla competitività di costo, indicata dalla
maggior parte delle imprese italiane.
54 I Rapporto Corporate Efige
Posizionamento “qualitativo” per classi di fatturato (%)
Italia
Media 7 paesi
Posto a 100 il livello qualitativo del miglior prodotto
disponibile sul mercato, dove si posiziona il vostro?
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
totale campione
1-2 mln
10-15 mln
più di 250 mln
Distribuzione delle risposte in termini di livelli di qualità (%)
Italia
Totale campione (esclusa Italia)
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
50,0
55,6
61,1
66,7
72,2
77,8
83,3
88,9
94,4 100,0
Fattori di competitività più importanti (%)
Italia
Media 7 paesi
70
60
50
40
30
20
10
0
Ridurre
Migliorare
Ampliare Accrescere Ampliare
costi
la qualità
la gamma
la
la rete
di
del prodotto prodotti riconoscibilità distributiva
produzione
del marchio
Espandere
i servizi
post-vendita
Altro
Anche in questo caso è utile chiedersi se vi siano specificità
dimensionali: focalizzando l’attenzione solo sulla scelta
“migliorare la qualità del prodotto” si nota come essa sia,
in Italia, crescente al crescere della dimensione, mentre nel
resto del campione la relazione è (quasi) inversa (ma con
un’escursione molto limitata, intorno al 2% contro il 7%
nelle risposte delle italiane).
Andamento del miglioramento della qualità del prodotto
in relazione alla dimensione (%)
Driver di competitività:
migliorare la qualità
64
Italia
Media 7 paesi (sc. dx)
ulteriori analisi, suggeriscono che l’idea, accreditata dai
case studies, dell’impresa medio-piccola che, pur nella sua
nicchia, opera alla frontiera della tecnologia e della qualità
non sembrerebbe suffragata dai dati.
49
61
48
58
47
55
46
52
45
10-19
20 - 49
50 - 249
> 250
Infine, c’è una domanda che è rivolta ad indagare i
comportamenti delle imprese in termini di pricing che è
di interesse per il tema in questione. Qui si chiede se le
imprese pratichino prezzi differenziati rispetto alla qualità
del prodotto in differenti mercati di sbocco: le imprese
italiane in genere rispondono affermativamente con molta
più frequenza di quelle del campione nel suo insieme;
andando a scomporre per “percezione qualitativa” si nota
come le imprese del campione che si situano sulla frontiera3
tendono a differenziare poco (5,2%), mentre è più ampia la
quota di quelle che si situano più distanti dalla frontiera ad
offrire prodotti (e prezzi) differenziati per qualità (13,9%).
Per le imprese italiane vale il contrario, lasciando
l’impressione che anche per le imprese capaci di proporre
prodotti di livello qualitativo elevato vi sia una quota di
attività esposta alla competizione sui costi/prezzi.
Prezzo differente per differenziazione qualitativa
MEDIA 7 PAESI
ITALIA
8,3
23,2
PC>99
5,23
26,7
PC<80
13,88
21,95
Tutte le risposte
PC = percezione qualità
In generale sembra che l’approccio strategico, in relazione al
perseguimento della qualità, da parte delle imprese italiane
sia differente da quello del campione complessivo. Queste
indicazioni, assolutamente preliminare e da sottoporre ad
Per l’intero campione italiano il dato è del 46,4%. Guardando alle classi di fatturato si trova un
gradino netto sopra i 15 milioni di fatturato. Infatti, se il fatturato è sotto quella soglia il valore
indicato in termini di propria prossimità alla frontiera è maggiore o uguale a 90 per il 46% delle
imprese; lo stesso balza a 52% per imprese con più di 15 milioni di fatturato.
2
Ottenuta tramite una stima di densità non parametrica.
3
In tabella sono presentate le frequenze delle risposte complessive, quelle delle imprese che
affermano che il loro prodotto è pari al meglio che si può trovare sul mercato (PC>99) e quelle
il cui prodotto, fatto 100 il prodotto disponibile migliore è sotto quota 80 (PC<80).
1
Rapporto Corporate Efige I 55
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
FINANZIAMENTO
DELL’IMPRESA E RUOLO
DELLA BANCA
a cura di Elena d’Alfonso
Le imprese italiane utilizzano molto
debito esterno, principalmente
basato su debito bancario.
Ciononostante il rapporto con la
banca principale non è più stretto in
Italia che altrove: al contrario, rispetto
agli altri paesi su cui sono state
effettuate le interviste, le imprese
italiane hanno in media rapporti con
un maggior numero di banche e
una quota di debito con la banca
principale più basso.
Questa sezione mira a valutare quali sono le caratteristiche finanziarie delle imprese,
al di là di ciò che emerge dall’esclusivo utilizzo dei dati di bilancio. Il questionario si occupa
quindi di capire le attitudini delle imprese rispetto al finanziamento esterno, sia in termini
di strumenti che nel rapporto con le banche.
Dai dati emerge che larga parte delle imprese italiane utilizza finanziamento esterno,
principalmente basato su debito bancario, che rappresenta la maggior parte delle passività
delle imprese, mentre tutti gli altri strumenti, complementari al finanziamento bancario,
sono poco, se non del tutto, utilizzati.
Anche a livello europeo la banca rimane il principale finanziatore delle passività, ma in
generale sembra che la struttura finanziaria sia più articolata nell’utilizzo degli strumenti e
meno sbilanciata verso il breve termine. Le differenze si attenuano però sulle imprese più
grandi, che sembrano essere meno distanti dalle loro controparti europee.
Il fatto che le imprese italiane poggino prevalentemente sul debito bancario non significa,
tuttavia che il rapporto con la banca principale sia particolarmente stretto;
al contrario, rispetto agli altri paesi su cui sono state effettuate le interviste, le imprese
italiane hanno in media rapporti con un maggior numero di banche e una quota di debito
con la banca principale più basso.
In generale, sono poche le imprese del nostro campione che si considerano
finanziariamente razionate, indicazione che delinea un rapporto con la banca di
riferimento che non pone problemi di accesso al credito, ma che, tuttavia, potrebbe essere
efficacemente potenziato.
Probabilmente, avendo poche fonti di altro tipo, le imprese saziano la sete di credito
attingendo da più istituti bancari: in effetti, i luoghi alternativi di raccolta di risorse
finanziarie, come il mercato dei capitali, sembrano essere utilizzati da una quota
estremamente piccola di imprese, e molte poche manifestano l’intenzione di entrare in
borsa nel prossimo periodo.
56 I Rapporto Corporate Efige
Il finanziamento delle imprese
italiane
Le imprese italiane rivelano di avere
una maggiore propensione a utilizzare
finanziamento esterno, rispetto all’utilizzo
esclusivo di autofinanziamento: nel 58%
dei casi, infatti, le imprese tra il 2008 e il
2009 hanno utilizzato risorse esterne, una
percentuale ben al di sopra di quella europea
(42,3%) e, tra i Paesi, inferiore solo alla
Spagna (64,5%).
Struttura delle passività delle imprese (%)
Italia
Media 7 paesi
60
50
40
30
20
10
Le passività si compongono prevalentemente
di debito nei confronti delle banche, in linea
con la media europea (sempre valutata come
media dei sette paesi inclusi nel campione),
tuttavia, come il grafico mette bene in luce,
le imprese italiane sono tendenzialmente più
esposte a breve nei confronti delle banche
rispetto agli altri paesi (il breve rappresenta
per le imprese italiane il 39,9% del debito
versus il 34,3% delle imprese europee).
Il medio lungo è comunque la componente
più importante delle passività (ne rappresenta
il 47,6%), mentre le emissioni di obbligazioni
sono una quota quasi irrilevante del debito:
quelle a breve e a lungo ne rappresentano
insieme l’1,1%, ben al di sotto della media
dei sette Paesi, in cui queste due voci
insieme rappresentano in media il 3,3% del
debito.
Non ci sono grandi differenze tra classi
dimensionali nella struttura del debito: in
generale anche per le imprese di maggiore
dimensione il debito bancario rimane
comunque la voce prevalente delle passività.
0
Debito bancario
a breve
Debito bancario
a Medio Lungo
Obbligazioni
a breve
termine
Tuttavia, la classe di imprese grandi (con
un numero di addetti superiore a 250) si
distanzia in qualche modo dalle altre per
un più largo utilizzo del debito a lungo nei
confronti della banca (52,8%) e per un
maggior ricorso all’emissioni di obbligazioni,
sempre a lungo termine (3,42%).
Nel corso del 2009 l’utilizzo di finanziamento
esterno è aumentato per il 41,5% delle
imprese intervistate. Tra queste, quelle
italiane sembrano avere aumentato
il finanziamento esterno poco meno
degli altri paesi europei (il 40,3% ha
incrementato il finanziamento esterno), e
in maniera differenziata a seconda della
dimensione: sono le imprese medio-grandi
(50-249 addetti), infatti, quelle che più
delle altre hanno incrementato il ricorso a
finanziamento esterno (44%).
Obbligazioni
a Medio
Lungo termine
Altro
L’aumento di finanziamento esterno era
dovuto alle necessità di liquidità per il 58,9%
delle imprese italiane: gli effetti della crisi
hanno pesato principalmente sul cash flow –
anche da legarsi ai tempi di pagamento che
si sono ulteriormente dilatati durante la fase
più dura della crisi. Tale necessità colpisce
principalmente le piccole imprese (10-19),
che segnalano il cash flow come obiettivo del
finanziamento nel 67% dei casi.
A livello europeo l’Italia è seconda solo alla
Spagna (67,8%) per numero di imprese
che hanno segnalato le esigenze di cassa
come ragione principale del ricorso al
finanziamento esterno, mentre per tutte le
altre nazioni questa motivazione è stata sì
importante, ma non necessariamente la
prioritaria.
Un altro obiettivo rilevante del finanziamento
esterno è risultato essere l’aumento della
Struttura delle passività delle imprese italiane per dimensione (%)
DEBITO
BANCARIO A
BREVE
DEBITO
BANCARIO A
MEDIO LUNGO
OBBLIGAZIONI A
BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONI
A MEDIO LUNGO
TERMINE
ALTRO
10-19
40,2
47,0
0,3
0,9
11,6
20-49
39,8
47,9
0,3
0,6
11,4
50-249
40,1
47,2
0,6
1,1
11,0
250 e oltre
36,4
52,8
0,0
3,4
7,3
Totale
39,9
47,6
0,3
0,8
11,4
ADDETTI
Rapporto Corporate Efige I 57
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Numero di imprese che aumentano il finanziamento esterno (%)
ITALIA
MEDIA 7 PAESI
10-19
37,7
38,9
20-49
41,2
43,0
50-249
44,0
43,7
250 e oltre
39,4
40,4
Totale
40,3
41,8
ADDETTI
Strumenti utilizzati per il finanziamento (%)
Italia
Media 7 paesi
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Debito
bancario a
medio lungo
Debito
bancario a
breve
Leasing or
Factoring
produzione attraverso investimenti fissi,
segnalato dal 22% delle imprese italiane,
dato inferiore alla media dei sette paesi
(24,2%), e crescente al crescere della
dimensione.
Infine, un numero non indifferente di
imprese (10,36%), superiore a tutti gli altri
paesi europei coinvolti nell’indagine, ha
utilizzato le risorse esterne per ristrutturare
la propria situazione finanziaria, segnalando
che, almeno in parte, la crisi potrebbe
essere stato un fattore di stimolo a
riequilibrare la propria situazione finanziaria.
Tale ristrutturazione viene fatta in un numero
di imprese crescente al crescere della
dimensione.
In generale, per aumentare il ricorso al
finanziamento esterno durante il 2009 le
imprese hanno utilizzato, nella maggior parte
dei casi, credito a medio-lungo termine
da parte delle banche (79,5%), seguito
58 I Rapporto Corporate Efige
Capitale
proprio
Finanziamenti
pubblici
Incentivi
fiscali
dal credito a breve (49,6%) e dal leasing
o factoring (30,5%). L’allargamento della
compagine o delle quote societarie attraverso
nuovi contributi in termine di capitale è stato
scelto dal 12% circa delle imprese: è da
notare che a livello europeo questa possibilità
è stata utilizzata da una quota di imprese
maggiore (16,4%), in particolare in Francia
(29,6%) e Germania (33,7%).
All’interno di questo quadro il ranking degli
strumenti finanziari utilizzati dalle imprese
italiane si differenzia solo marginalmente da
quanto si nota sull’intero database: tuttavia
nel complesso appare un utilizzo meno
variegato degli strumenti a disposizione
delle imprese. In effetti, il debito bancario e
strumenti come leasing e factoring sono stati
utilizzati da una quota di imprese addirittura
maggiore di quanto si vede sulla totalità del
database, mentre equity, venture capital e
emissione di obbligazioni, sono poco o per
nulla utilizzate.
Altri strumenti
finanziari
Venture
Capital
Obbligazioni
Alcune differenze di maggior rilievo si
riscontrano, tuttavia, al crescere della
dimensione, in particolare sulle imprese
grandi, in cui la struttura finanziaria sembra
essere più complessa, con un utilizzo più
vario degli strumenti finanziari a disposizione.
Per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti
derivati, delle imprese rispondenti,
solo il 6,6% delle imprese li utilizzano,
contro l’8,3% medio internazionale.
Tendenzialmente sono le imprese di
maggiore dimensione, con una complessità
pertanto più elevata, a farne un uso
maggiore: addirittura il 40% (nella totalità
delle imprese è il 33,2%) delle imprese con
un numero di addetti superiore a 250 ha
infatti sottoscritto un derivato, contro il 3,7%
delle imprese di tra 10 e 19, il 6,1% di quelle
tra 20 e 49 e il 12,5% di quelle tra 50 e 249.
Utilizzo degli strumenti finanziari (%)
10-19
20-49
50-249
250 E OLTRE
TOTALE
Debito bancario a medio lungo
78,4
81,6
83,6
81,8
80,8
Debito bancario a breve
51,0
51,0
50,4
40,7
50,8
Leasing o Factoring
24,4
34,6
25,2
31,1
29,9
Capitale proprio
9,7
11,6
15,3
16,5
11,5
Finanziamenti pubblici
3,1
5,1
5,5
7,9
4,6
Incentivi fiscali
1,8
3,8
8,8
2,0
3,8
Altri strumenti finanziari
3,4
2,1
4,4
2,8
2,9
Venture Capital
0,4
0,2
0,0
8,9
0,4
Obbligazioni
0,0
0,3
0,0
2,7
0,2
Rapporto con la banca principale
90
Quota di debito con la banca principale (%)
Nel complesso, ci sembra di potere
concludere che in termini di varietà
di strumenti utilizzati e di strategie di
finanziamento le imprese italiane sono
un po’ meno elaborate delle loro simili
europee. La distanza sembra attenuarsi
solo per dimensioni molto grandi,
ma il finanziamento esterno, anche
indipendentemente dalla dimensione,
poggia per larga parte sul debito bancario.
In questo quadro è particolarmente rilevante
continuare il monitoraggio, utilizzando le
indicazioni dell’indagine, relativamente al
rapporto banca e impresa. Come prima
cosa guardiamo, pertanto alle variabili
fondamentali per identificare le principali
caratteristiche del rapporto con le banche:
innanzitutto multiaffidamento e quota di
debito con la banca principale.
Le imprese italiane per il finanziamento della
loro attività si appoggiano ad un numero
di banche in genere maggiore rispetto alle
REGNO UNITO
80
70
AUSTRIA
UNGHERIA
60
GERMANIA
FRANCIA
SPAGNA
50
ITALIA
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
Numero di banche
loro controparti estere: sono 4 in media le
banche di riferimento, un numero che resta
in linea con le ultime tornate dell’indagine,
da quando cioè, la struttura del mercato
finanziario si è stabilizzato dopo il periodo
delle grandi fusioni. A livello europeo, invece,
la media ruota intorno alle 3 banche per
impresa, e l’Italia è preceduta solo dalla
Tipologia dell’attività e scelta della banca (%)
Italia
ATTIVITÀ
DOMESTICA
ATTIVITÀ
ESTERA
Banche locali
68,7
42,7
Banche nazionali
83,6
80,75
3,3
10,78
Banche locali
64,0
33,6
Banche nazionali
68,1
55,7
5,3
9,7
Banche internazionali
Media 7 paesi
Banche internazionali
Rapporto Corporate Efige I 59
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Fattori alla base della scelta della banca principale (%)
AUSTRIA
Servizi competitivi
FRANCIA GERMANIA
UNGHERIA
ITALIA
SPAGNA
REGNO
UNITO
MEDIA 7
PAESI
27,4
69,1
5,7
19,9
69,9
74,8
52,9
42,2
Servizi tramite internet
0,0
42,8
0,6
1,2
18,8
33,7
5,5
14,4
Trasparenza
9,2
71,8
1,7
14,4
50,0
35,4
6,6
26,5
Collocazione
19,8
74,2
6,6
10,3
37,4
42,2
14,1
26,7
Rete internazionale
3,1
41,3
0,6
0,7
14,7
16,6
2,8
10,4
Consulenza
5,2
46,1
1,4
1,1
20,2
19,5
4,4
13,2
Durata della relazione
22,8
80,1
6,1
17,2
61,3
64,7
40,2
38,6
Flessibilità
15,3
47,2
2,1
15,0
42,3
28,1
13,6
21,9
5,3
17,0
0,9
2,3
6,6
11,5
6,4
5,8
44,1
21,6
9,1
35,7
3,4
11,2
55,0
13,2
Gruppo Bancario
Altro
Spagna (4, 3 banche per impresa). Tutti gli
altri paesi stanno in una media di rapporti
tra 1,7 (per le imprese del Regno Unito) e
2,5 (Francia e Germania).
Come in passato, il numero di banche a cui
l’impresa si appoggia cresce al crescere
della dimensione: nelle imprese con meno
di 20 addetti le relazioni con la banca sono
in media 3,25, nelle imprese con un numero
di addetti tra 20 e 49 sono 4, quelle con un
numero di addetti tra 50 e 249 sono 5,9 e
per le imprese con un numero di dipendenti
superiore a 250 sono 7,4.
La quota del debito nei confronti della
banca principale è poco meno della metà,
il 46,1%: livello significativo, ma inferiore
alla media del campione (58,3%), in cui si
passa dal 55,7% della Spagna al 78,6%
del Regno Unito. In tutti i paesi la quota
diminuisce al crescere della dimensione,
segnalando un rapporto meno intenso con la
banca principale per le imprese più grandi,
probabilmente anche a causa delle differenti
e più complesse operazioni che devono
compiere. Nel caso italiano, le imprese con
un numero di addetti tra 10 e 19 ha una
quota di debito nei confronti della banca
principale di 49,5%, per le imprese tra 20
e 49 la quota è di 45,5%, per quelle tra 50
e 249 di 40,3% e, infine per le imprese con
più di 250 addetti la quota si riduce a 38,2%.
60 I Rapporto Corporate Efige
In effetti, incrociando le informazioni relative
a queste due variabili - il numero di banche
con cui le imprese hanno relazioni e la quota
di debito nei confronti della banca principale
- si può dare una complessiva valutazione
dell’intensità del rapporto: dal grafico si
nota che le imprese spagnole ed italiane si
distanziano dalle altre per avere, in media un
numero di banche superiore agli altri paesi e
un livello di intensità del debito con la banca
principale inferiore.
Il numero degli anni di rapporto nei confronti
della banca principale è, invece, solo di poco
al di sotto della media europea, sono 16,1
contro il 16,6 totale, cosa che evidenzia che
la stabilità del rapporto è un elemento di
scelta importante nei confronti della banca.
Ma non è l’unico.
Innanzitutto la tipologia di banca scelta si
differenzia a seconda dell’attività che si deve
finanziare; non è indifferente la struttura
della banca rispetto al tipo di servizio che
deve dare. Vi è una domanda, in particolare,
che mette in luce questo aspetto; si chiede
alle imprese se utilizzano banche locali,
nazionali o internazionali, e per quale tipo di
attività.
Risulta che le imprese prediligono in
generale la banca nazionale alle altre, e
che comunque utilizzino tendenzialmente
di più le banche estere per le attività estere
e viceversa le banche locali siano utilizzate
molto poco per le attività all’estero.
In particolare, nel caso si facciano attività
all’estero, la percentuale di imprese che
usano banche straniere arriva al 10% (dal
3,3% di utilizzo di banche straniere per
attività sul territorio nazionale). Da un certo
punto di vista il dato evidenzia anche la
percezione da parte delle imprese di una
certa segmentazione del mercato finanziario.
Nel confronto con gli altri paesi quello che
salta più all’occhio è il tasso di risposte:
tendenzialmente in tutte le categorie le
percentuali per l’Italia sono più alte che
quelle estere, probabilmente per via del
multiaffidamento di cui si diceva prima.
Al di là della tipologia dell’attività vi sono poi
alcune caratteristiche principali sulla base
delle quali le imprese scelgono la banca
principale: i primi quattro segnalati dalle
imprese sono la competitività dei servizi
(69,9%), la durata della relazione (61,3), la
trasparenza (49,9%) e la flessibilità (42,3%).
Per quanto riguarda l’accesso al credito, il
59,9% delle imprese ha segnalato di non
avere avuto necessità di maggior credito
nel 2009, valore in linea con la media che
si riscontra nei sette paesi (60,4%). Tra le
imprese intervistate sono, in particolare, le
medio grandi (tra 50 e 249), a non avere
esigenze di natura finanziaria insoddisfatte,
Incentivi finanziari e fiscali per classe dimensionale (%)
ADDETTI
ITALIA
INCENTIVI
FINANZIARI
INCENTIVI
FISCALI
MEDIA 7 PAESI
INCENTIVI
INCENTIVI
FINANZIARI
FISCALI
10-19
10,6
14,5
14,0
11,8
20-49
14,4
23,4
17,6
16,8
50-249
19,4
34,8
22,2
21,2
250 e oltre
28,8
46,4
20,9
24,6
Totale
13,8
21,8
17,3
16,1
il 65% circa, infatti, non ha manifestato
l’esigenza di aumentare il credito. Del 40%
circa di imprese che desideravano maggiore
credito, il 48% lo ha ottenuto, il 20,6%, pur
avendo desiderato maggior credito, non
ne ha fatto richiesta, il 30,5 % è, infine,
vincolato, in quanto pur richiedendolo non
gli è stato concesso. Tra queste ultime, si
definisce strettamente vincolato chi, pur
essendo disposto a pagare un tasso più alto
nell’ottenere credito, non è stato comunque
soddisfatto: fanno parte di questa categoria
il 48% delle precedenti.
Sulla totalità di imprese italiane rispondenti
a queste domande, possiamo dire che il
29,8% è vincolato e il 6,3% è razionato
in senso stretto, un po’ più del campione
complessivo dove queste proporzioni sono
rispettivamente il 23,1% e il 5,1%.
Tra quelli che hanno ottenuto credito, il
costo, nel corso del 2009, è aumentato
per il 45,5% delle imprese rispondenti,
valore poco più alto della media dei sette
paesi (45%): sono le imprese di piccole e
medie dimensioni ad avere sperimentato
maggiormente l’incremento del costo (45,8%
e 45,1% rispettivamente le classi 10- 19 e
20-49), mentre le più grandi hanno quote del
43,6% e del 40,9% (rispettivamente le classi
50-249 addetti e oltre 250).
Come garanzia a fronte del credito, per la
maggior parte, le imprese italiane dichiarano
di fornire alla banca dati di bilancio (94%)
e collateral (46%), di natura personale nel
65,3% dei casi o su asset di impresa nel
65,1% dei casi.
Al di là del debito bancario, come si è visto,
non vengono utilizzate molte altre forme di
finanziamento. E anche andare sul mercato
dei capitali sembra ben poco perseguito
dalle imprese del nostro paese. Infatti, per
quanto riguarda la quotazione, le imprese
italiane sono sempre ben al di sotto delle
loro controparti europee, solo lo 0,5 % degli
intervistati sono quotati, contro l’1,6% della
totalità delle interviste: tale quota è più alta,
infatti, in ognuno dei paesi considerati, dallo
0,87% dell’Ungheria al massimo di 5,7%
del Regno Unito, mentre Francia e Germania
hanno una percentuale pari rispettivamente
all’1,9% e all’1,4%.
Nei prossimi tre anni, si quoterà poi con
certezza lo 0,06% delle imprese, mentre
un altro 0,8% prende in considerazione la
possibilità: anche sommandoli, ci possiamo
aspettare un aumento delle imprese quotate
nell’ordine dello 0,86% contro l’1,1% del
campione generale.
del 17,5% della media del campione. Gli
incentivi fiscali, invece, vengono assegnati
al 21,8% delle imprese, contro il 16,1% del
totale delle imprese intervistate: di questa
tipologia di incentivi, il 3,5% viene attribuito
a livello europeo e il 96,4% a livello
nazionale.
Entrambe le categorie di incentivi tendono
comunque ad essere più diffuse al crescere
del numero di dipendenti, sottolineando
come anche in questo caso la dimensione
renda le imprese maggiormente in grado
di accedere anche alle risorse messe a
disposizione dal pubblico.
In termini di incentivi, che possono
essere considerati una diversa fonte di
finanziamento, l’indagine suddivide tra
incentivi finanziari e incentivi fiscali: le
imprese italiane sembrano essere più
propense a utilizzare i primi rispetto ai
secondi, dato in controtendenza almeno
parziale con quanto emerge a livello
europeo. Gli incentivi finanziari vengono
ricevuti dal 13% delle imprese, ben al di
sotto del 17% del campione. Fatto 100
il valore totale degli incentivi finanziari,
quelli nazionali pesano per l’87,7% e quelli
europei per il 12,2%, valore ben al di sotto
Rapporto Corporate Efige I 61
Rapporto Corporate
XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane
Gli strumenti derivati come
copertura e i rischi delle attività
internazionali
a cura di Elena d’Alfonso e Silvia Giannangeli
L’indagine Efige-UniCredit, ci dà modo di avere,
direttamente da parte delle imprese, alcune
informazioni anche sulle strategie in termini di
copertura dei rischi, cosa che ci pare essere
di particolare rilevanza in una fase in cui le
esportazioni sembrano essere il vero traino
della ripresa.
Al di là delle forme assicurative (in molti casi fornite
da agenzie pubbliche come la SACE), tra gli strumenti
finanziari che permettono la copertura dei rischi i principali
sono i derivati, che hanno tra i loro obiettivi proprio quello
di fare hedging. Iniziamo allora con il guardare quali sono le
imprese che dichiarano di farne uso e quali caratteristiche
le accomunano.
In Italia, delle 1860 imprese che rispondono, solo 145, il
7,8%, hanno utilizzato strumenti derivati; non sembrano
quindi essere strumenti che utilizzati comunemente. Su
queste imprese sembrano poi pesare più gli effetti firm
specific, non ultimo la dimensione di impresa, che quelli
legati al settore. Non vi è, ad esempio, una concentrazione in
alcuni settori in particolare, ma la distribuzione tra branche è
piuttosto diffusa, fatto salvo una certa sovrarappresentazione
del settore alimentare e della chimica.
L’utilizzo di strumenti derivati sembra essere invece
legato a caratteristiche individuali e scelte strategiche
delle singole imprese: quelle che li usano sono, infatti,
sensibilmente più grandi, con 257 addetti in media
contro i 65,5 del campione complessivo. Ma non
sono solo più grandi e generalmente più complesse:
spesso, ad esempio, sono organizzate in gruppi (nel
38,6% dei casi versus il 17,5 del totale nazionale) ed
internazionalizzate. La maggior parte delle imprese che
hanno derivati, infatti, ha scambi con l’estero: il 90%
esporta, percentuale che sale al 95,8% considerando
anche quelle che importano.
Queste sono infatti per definizione esposte al rischio
di apprezzamento o deprezzamento dell’euro rispetto
alle valute estere su cui sono basate le loro transazioni.
Le fluttuazioni del cambio possono incidere, anche
62 I Rapporto Corporate Efige
significativamente, sui margini di operatività delle aziende,
sia riducendo i ricavi dalle vendite sia aumentando i costi
produttivi a causa di variazioni del prezzo del portafoglio
ordini.
I dati suggeriscono però che gli strumenti derivati
solo in parte vengono utilizzati come strumento di
copertura del rischio di cambio, e sono, per altra
parte, da legare alle più articolate esigenze di
finanziamento delle aziende più grandi e complesse.
Di fatto, il 40% delle imprese che usano derivati dichiara
anche di adottare strategie per coprirsi dal rischio di
cambio. Allo stesso tempo, tuttavia, il 45% dichiara di
non essere interessato ad adottare alcuna copertura di
questo tipo, oppure di non affrontare alcun rischio poiché
gli scambi avvengono nella propria valuta.
Il mercato finanziario e assicurativo offre però molteplici
strumenti per la protezione contro il rischio cambio. In
generale, tali strumenti di protezione dovrebbero essere
più appetibili per le imprese maggiormente impegnate
in attività con l’estero: dall’indagine emerge che, a
livello internazionale (media IT, FR, DE e SP), il 7,4%
delle imprese in cui meno del 10% del fatturato è legato
all’export utilizza strumenti per la copertura del rischio
cambio; tale percentuale sale al 15,5% nelle imprese
in cui l’export conta fra il 10 ed il 50% del fatturato, e
raggiunge il 27,1% nelle imprese in cui più della metà
del fatturato è legata alle esportazioni. Distinguendo
tra paesi si notano alcune differenze interessanti. Se,
infatti, ovunque la propensione ad utilizzare strumenti
Percentuale di imprese che utilizzano forme di
protezione contro il rischio di cambio, distinte per
intensità di export (% di export sul fatturato totale)
35
Italia
Germania
Francia
Spagna
Media
30
26,0
25
20
15,5
15
10,5
10
5
0
7,4
3,5
<10
10-50
>50
27,1
di copertura cresce al crescere della quota export, tale
propensione appare strutturalmente più bassa per le
imprese italiane in generale, ed in particolare in quelle
in cui la quota export è minore. La distanza fra l’Italia
e gli altri paesi considerati nel confronto internazionale
è chiara soprattutto nel gruppo dei micro-esportatori
(imprese che esportano meno del 10% del fatturato):
in Italia soltanto il 3,5% in questo gruppo dichiara di
proteggersi contro il rischio di cambio, a fronte del 5,3%
in Germania, il 10,2% in Spagna e quasi l’11% in Francia.
Fra le imprese che vendono i propri prodotti e servizi fuori
dai confini nazionali, il 55% importa fattori produttivi dai
mercati esteri. Come è da attendersi, fra gli importatori, la
propensione ad attivare strategie di copertura del rischio è
maggiore rispetto a quelle che non acquistano dall’estero
(19% contro 11%): questo conferma che scegliere di
coprirsi rispetto al rischio cambio può anche essere dettato
dall’esigenza di proteggere la liquidità contro avverse
rivalutazioni dei propri ordinativi.
L’export dell’Italia, più di quello di altri paesi europei,
si fa attraverso una frammentata e numerosa schiera
di micro-esportatori. È ragionevole che, quando la
quota di export su fatturato è bassa, le imprese siamo
meno motivate a proteggersi contro i rischi legati alle
fluttuazioni del valore dell’euro verso le valute estere.
L’analisi svolta mostra come nel nostro paese esista,
tuttavia, un potenziale disallineamento fra esposizione ai
rischi e copertura. Un elemento chiave sembra essere,
invece, quello dimensionale: l’utilizzo di strumenti
finanziari pensati come copertura da rischi, non solo di
cambio, è più frequente nelle imprese più grandi, dove
la maggiore complessità organizzativo-produttiva si
traduce in strategie, anche finanziarie, più articolate.
Date le caratteristiche dell’export italiano, è importante
che passi importanti vengano compiuti nella direzione di
estendere l’utilizzo degli strumenti finanziari più adeguati
a proteggere la redditività delle imprese che, ancorché
di piccole dimensioni, dimostrano di avere le capacità di
raggiungere i mercati più lontani.
Rapporto Corporate Efige I 63
APPROFONDIMENTI
Rapporto Corporate
Approfondimenti
CRISI E INNOVAZIONE:
IL RUOLO DELLE STRATEGIE PER
IL FINANZIAMENTO DELLA R&S
a cura di Elena d’Alfonso e Silvia Giannangeli
La risposta delle imprese alla
recente crisi economica sotto il
profilo della spesa per l'innovazione
può dipendere dalle caratteristiche
strutturali e delle strategie delle
imprese in tema di ricerca e di
finanziamento. Le scelte su come
finanziare la spesa in R&S e sulla
composizione fra ricerca in-house
e ricerca esterna risultano infatti
moderare l'impatto della crisi
sull'innovazione delle imprese, ed in
particolare sulla decisione di ridurre
le spese dedicate all'innovazione
tecnologica durante il 2009.
66 I Rapporto Corporate Efige
Il ritardo nella crescita della maggior
parte dei paesi europei è stato al centro
del dibattito economico dell’ultimo
decennio. Gli economisti hanno
identificato nella lenta crescita della
produttività e nella scarsa attività
innovativa delle imprese europee uno dei
fattori principali di questo rallentamento.
La perdita di competitività delle imprese
italiane in termini di produttività è stata
peggiore di quanto registrato nelle altre
grandi economie e lo scarto dell’Italia
in termini di innovazione rispetto a
queste realtà è significativo. I policy
makers hanno intrapreso azioni rivolte
al superamento del gap, introducendo
strategie – anche a livello europeo
(la Lisbon Strategy) per incoraggiare
l’innovazione all’interno delle imprese.
Nonostante questo impegno, l’attività
innovativa in Europa rimane debole:
i dati disponibili più recenti confermano
che, nonostante le differenze a livello
internazionale siano di non trascurabile
entità, esiste un gap significativo fra le
imprese europee e quelle degli Stati Uniti
nella spesa in R&S. Nel 2008 la spesa del
settore privato in ricerca e sviluppo è stata
pari allo 0,65% del PIL in Italia, contro
l’1,32% della Francia, l’1,86% della
Germania, e il 2,01% degli Stati Uniti.
La profonda recessione che ha seguito
la crisi bancaria del 2007 ha posto nuovi
interrogativi e rinnovato l’interesse degli
economisti e dei policy makers per il
“ritardo europeo”. La maggior parte dei
governi europei ha affermato con fermezza
l’importanza dell’innovazione e della
ricerca quali motori della crescita dei
paesi all’indomani della crisi e ha assunto
l’impegno ad attuare misure in grado di
sostenere queste attività. Non è, tuttavia,
ancora chiaro quale sia stato l’effetto
della recessione sull’attività innovativa
già in corso.
Nell’aprile del 2009, un’analisi esplorativa
della Commissione europea stimava che il
22% delle imprese europee avesse ridotto
la propria spesa in R&S a causa della crisi
(24% in Italia). Guardando alle imprese
più focalizzate sull’innovazione, questa
percentuale scendeva al 9% (Commissione
europea, 2009). Tale differenza suggerisce
che la risposta delle imprese alla crisi
in termini di investimento in innovazione
possa differire anche significativamente
fra imprese e dipendere, in ultima analisi,
dalle caratteristiche specifiche delle
imprese stesse.
In particolare il lavoro sviluppa e indaga
l’ipotesi che le condizioni finanziarie generali
possano esercitare un effetto negativo
sull’innovazione, che agisce attraverso le
scelte delle imprese in termini di R&S.
La riduzione degli investimenti in
innovazione in risposta alla restrizione
del credito e alla debolezza della domanda
indotte dalla crisi può infatti differire anche
considerevolmente a livello di impresa e
dipendere, tra gli altri fattori, dalla struttura
della “funzione di innovazione” (Crépon,
Duguet e Mairesse, 1998; Hall, Lotti e
Mairesse, 2008) delle imprese.
Le decisioni da parte delle imprese su
come finanziare le proprie attività di ricerca
e sviluppo e sul fatto di svolgere tali
attività in-house, o piuttosto di acquistarle
da strutture esterne sono considerate
importanti fattori in grado di “moderare”
il potenziale impatto della crisi sull’attività
innovativa delle imprese, misurato
attraverso la decisione da parte delle
imprese di posticipare a causa della crisi
attività innovative già programmate.
Guarderemo pertanto a questo tema
verificando innanzitutto l’impatto della crisi
sulla scelta di posporre l’investimento in
innovazione e legandolo alla modalità con cui
si è investito nel corso del triennio in ricerca e
sviluppo.
Mostreremo poi come la scelta di produrre
ricerca interna o esterna sia legata anche alla
natura del finanziamento alla ricerca.
La composizione della R&S
e la probabilità di ridurre la
spesa in innovazione
La crisi economica e finanziaria può
aver avuto un impatto sull’innovazione
attraverso canali diversi: in primo luogo,
un peggioramento generale del credito
può aver accresciuto i vincoli finanziari
agli investimenti in ricerca. In secondo
luogo, la scarsa liquidità dovuta alla
debolezza della domanda ha ridotto la
redditività delle imprese e quindi la loro
capacità di autofinanziamento. Benché
tali problemi abbiano investito tutte le
imprese impegnate in attività innovative, le
reazioni di queste ultime possono differire
anche significativamente. Infatti, ridurre
l’investimento in R&S può risultare meno
costoso per le imprese che si avvalgono
di strutture di ricerca esterne: per queste
imprese la dismissione di progetti innovativi
comporta di fatto l’interruzione di un rapporto
di committenza.
La nostra ipotesi è quindi che l’input mix
scelto dalle imprese per innovare sia un
fattore importante nel determinare la decisione
di dismettere la ricerca e l’innovazione stessa
durante la crisi. In particolare, le imprese per
cui il ricorso R&S esterna è maggiore sono
potenzialmente più inclini a distogliere risorse
dagli investimenti in innovazione e ricerca
quando le condizioni economiche diventano
particolarmente difficili.
In aggiunta, la crisi finanziaria può aver
colpito di più le imprese più vincolate
dal punto di vista del credito. La crisi è
nata infatti nell’ambito delle banche, e ha
determinato da subito un rapido irrigidimento
delle condizioni del credito. Le indagini sul
credito a livello europeo condotte dalla Banca
Centrale Europea hanno registrato un brusco
peggioramento già nel tardo 2008, e le
condizioni si sono mantenute difficili per tutto
il 2009.
Sia per ragioni di “facilità di dismissione” che
di maggiori vincoli finanziari a causa della
crisi, è quindi ipotizzabile che le imprese
che acquistano servizi di ricerca da strutture
esterne siano più propense a dismettere
progetti in corso rispetto alle imprese che
svolgono tutta la ricerca al loro interno.
Per sottoporre a verifica empirica tale ipotesi,
utilizziamo un campione di 9.013 imprese
manifatturiere localizzate in Italia, Francia
e Germania e stimiamo la relazione tra la
scelta di dismettere progetti innovativi in
seguito alla crisi e le strategie in termini
di produzione della ricerca attraverso il
seguente modello probit:
Stima del modello probit [1]
VARIABILE INDEPENDENTE: POSTINNOV
extRD
(I)
(II)
0,001*
0,001
DUextRD
0,150***
0,043
finconstr
0,459***
0,450***
0,053
0,052
0,495***
0,492***
0,033
0,033
0,013***
0,013***
0,002
0,002
0,073**
0,103***
0,036
0,083
- 0,027
- 0,020
0,036
0,036
Pseudo R2
0,045
0,046
LR chi2
504,7***
518,75***
reducton
RD
ITA
FRA
Note: le dummy di settore (Nace 2 digit level) sono state incluse nel modello, ma non sono mostrate nella tabella. I risultati sono
disponibili su richiesta da parte degli autori.
* significatività dei coefficienti al 10%.
** significatività dei coefficienti al 5%.
*** significatività dei coefficienti all’1%. I numeri in corsivo rappresentano gli standard errors.
Rapporto Corporate Efige I 67
Rapporto Corporate
PostInnovit è un indicatore che assume valore
1 se l’impresa i dichiara di avere posticipato,
e quindi ridotto, la spesa per l’innovazione
durante il 2009.
Il set di variabili esplicative wit include,
alternativamente, la quota di ricerca
commissionata al di fuori dell’impresa sulla
spesa totale in R&S (extRDit, modello i) e
un indicatore binario che assume valore
1 quando l’impresa ha acquistato ricerca
da strutture esterne (DUextRD, modello ii).
Sono poi state inserite alcune variabili che
catturano la presenza di vincoli finanziari
stringenti (finconstr2), una dummy che
indica perdita di fatturato durante il 2009
e l’intensità dell’attività di ricerca (misurata
dalla quota di spesa complessiva in R&S sul
fatturato nel triennio 2007-2009), oltre che
le dummy per paese e settore.
I risultati della stima confermano che la
scelta di ridurre l’innovazione è una reazione
a vincoli di natura finanziaria e alla riduzione
del fatturato durante il 2009, entrambi
positivamente e significativamente correlati
con PostInnov.
La scelta di fare outsourcing, totale o
parziale, delle attività di ricerca risulta, infine,
essere associata in modo significativo alla
decisione di ridurre l’impegno in innovazione
nel corso del 2009. La quota di R&S
investita al di fuori dell’impresa risulta essere
positivamente correlata con la decisione di
posticipare l’innovazione (modello i), anche
se l’impatto, misurato dal coefficiente della
variabile extRD è piuttosto basso. Al contrario
la dummy DUextRD non solo è correlata
positivamente con PostInnov, ma l’effetto
marginale è rilevante.
La scelta di esternalizzare l’attività di
R&S è dunque una variabile chiave
nell’identificare quelle imprese che hanno
reagito “peggio” in termini di spesa per
l’innovazione, alla crisi economica del 2009.
L’interpretazione di questa evidenza non è,
tuttavia, ovvia. Da un lato, infatti, si potrebbe
ipotizzare che le attività “esternalizzate”
68 I Rapporto Corporate Efige
Approfondimenti
risultino più facilmente dismettibili, anche
temporaneamente, in quanto meno legate al
core business dell’azienda e meno mirate ad
acquisire conoscenze e tecnologie “firmspecific” di quelle, ad esempio, conseguibili
attraverso la sola attività di ricerca in-house.
Dall’altro lato non è da sottovalutare il fatto
che avvalersi di R&S esterna può permettere
alle imprese di essere più flessibili sul
versante dei costi a fronte di shock esterni,
fornendo quindi un grado di libertà alle
imprese potenzialmente utili nelle fasi
cicliche negative.
Scelte di finanziamento e
composizione della ricerca
Se l’avvalersi di R&S esterna sembra dunque
essere un importante volano in grado di
favorire l’aggiustamento dei costi in risposta
alla crisi, è interessante indagare se questa
sia una scelta “non vincolata” delle imprese
o se invece l’input mix derivi da altri fattori
strutturali, primo fra tutti la strategia di
finanziamento dell’innovazione.
Un’ampia letteratura teorica ed empirica ha
documentato che finanziare l’innovazione
è più difficile che finanziare gli investimenti
ordinari. Come mostrato chiaramente da
Hall (2002) e Hall e Lerner (2009), uno
dei problemi principali per un investitore o
finanziatore esterno all’impresa innovatrice
riguarda l’incertezza sul rendimento
dell’investimento in innovazione. La
presenza di asimmetrie informative e di
problemi di azzardo morale fra l’impresa e
i suoi finanziatori può rendere difficile per
questi ultimi un’appropriata valutazione
dei rischi e il monitoraggio sui risultati
dell’investimento. Queste difficoltà possono
tradursi in un maggior costo a carico delle
imprese per la finanza esterna, rispetto al
costo dell’autofinanziamento, e in ultima
analisi possono vincolare l’investimento in
innovazione.
L’asimmetria informativa e i costi di
monitoraggio sono più alti quando l’attività
di ricerca è svolta interamente in-house,
poiché in questo caso sia gli obiettivi che le
fasi di realizzazione dei progetti innovativi
sono meno chiari ai finanziatori esterni,
i limiti fra l’attività ordinaria dell’impresa
e l’innovazione finanziata sono più labili
e l’incertezza sui risultati è superiore. Al
contrario, quando la ricerca è svolta da
strutture esterne all’impresa, l’obiettivo
finale del progetto e le fasi di realizzazione
sono stabilite più chiaramente ex ante, cioè
al momento della commessa. In aggiunta,
sia i costi che l’orizzonte temporale di
realizzazione del progetto devono essere
in questo caso esplicitati chiaramente nel
contratto di outsourcing verso i fornitori
della ricerca. È quindi probabile che i
finanziatori esterni considerino meno
“rischioso” il finanziamento di progetti nella
cui realizzazione siano coinvolti, almeno
parzialmente, strutture esterne all’impresa.
Dal punto di vista dell’impresa innovatrice,
inoltre, alcuni strumenti finanziari possono
risultare potenzialmente più idonei a
rispondere alle esigenze finanziarie legate
agli investimenti in ricerca esterna, piuttosto
che in-house. Una caratteristica importante
degli strumenti finanziari è, ad esempio,
l’orizzonte temporale di riferimento.
Per poter svolgere ricerca al proprio interno,
ad esempio, un’impresa deve costituire una
struttura dedicata, e assumere personale
qualificato. Si tratta quindi di un progetto
di medio-lungo termine con riflessi
sull’intera organizzazione e sulle modalità
di gestione dell’azienda. In questo tipo di
progetti l’incertezza sui rendimenti futuri
è tipicamente elevata, anche in ragione
del fatto che la conoscenza generata è
spesso non separabile dal capitale umano
che l’ha prodotta, cioè dai dipendenti
che in ogni momento potrebbero lasciare
l’impresa. In questo caso si potrebbero
privilegiare fonti finanziarie interne, per
non incorrere in costose rinegoziazioni con
i finanziatori esterni in caso si allunghino i
tempi di realizzazione dei progetti di ricerca.
Al contrario, i progetti in cui parte della
ricerca risulti acquistata al’esterno, sono
potenzialmente associati a orizzonti temporali
più certi: in questo caso il finanziamento
esterno, come ad esempio il prestito
bancario, potrebbe soddisfare le esigenze
dell’impresa innovatrice.
In sintesi, esiste più di una ragione per
ipotizzare che la strategia finanziaria delle
imprese, ovvero la scelta degli strumenti
attraverso cui coprire il fabbisogno
finanziario degli investimenti in ricerca, sia
profondamente legata al tipo di R&S attuata
dall’impresa.
La compagine dei finanziatori esterni non
è tuttavia formata esclusivamente da attori
mossi da incentivi privati. Un’altra importante
fonte di finanziamento per le spese in
ricerca è costituita dal supporto pubblico.
Benché sia parte della ampia categoria
degli strumenti di “finanziamento esterno”
della ricerca, il finanziamento pubblico
differisce profondamente dal prestito
bancario sotto molti aspetti. Ai fini della
nostra analisi basta evidenziare che anche
l’uso del finanziamento pubblico potrebbe
essere legato alla decisone delle imprese
di svolgere in-house la ricerca o acquistarla
all’esterno. Infatti, l’eventuale specificità
del piano di ammortamento e la più lunga
scadenza temporale dei prestiti agevolati
potrebbero rendere questi ultimi strumenti
idonei a coprire le spese di progetti di ricerca
interni e di lungo periodo. D’altro canto,
se il contributo pubblico fosse veicolato da
contributi a fondo perduto3 o, in generale,
misure una tantum, esso potrebbe tradursi in
un aumento del ricorso a ricerca esterna, più
facilmente dismettibile a esaurimento delle
risorse.
Per valutare il ruolo degli strumenti finanziari
sugli investimenti in R&S, stimiamo un
modello à la Heckman (Heckman, 1979),
in cui viene tenuta in considerazione
la selezione, espressa implicitamente,
di allocare all’esterno almeno parte di
un’attività così importante come quella
di ricerca. In altre parole, la decisione di
allocare esternamente la ricerca viene vista
come “concettualmente separata” dalla
decisione di quanto investire in essa. L’effetto
di selezione, incluso nella procedura di stima,
viene qui introdotto separatamente per
facilitare la comprensione del modello.
Seguendo Piga e Vivarelli (2004) stimiamo la
scelta di usare ricerca esterna come segue:
DUextRDit = 1 se DUextRDit*=xitα + εit>c [2]
0 se DUextRDit*=xitα + εit≤c
Dove DUextRDit è una variabile che assume
valore 1 se l’impresa i dichiara di avere
utilizzato strutture esterne di ricerca nel periodo
osservato, DUextRDit* è una variabile latente4,
xit rappresenta un set di variabili esplicative e εit
rappresenta il termine di errore.
Le variabili esplicative includono la quota di
spesa in R&S finanziata attraverso debito
bancario nel periodo 2007-2009 (BANK)
e la quota finanziata invece attraverso
sovvenzione pubblica (PUBLIC).
Le altre variabili esplicative includono poi
l’intensità di R&S (RD), il fatto di avere
dato in outsourcing (OUTSOURCING)
altre parti della produzione, l’utilizzo di
strumenti di protezione alla proprietà
intellettuale (PROT), l’appartenenza a un
gruppo (GROUP). Si controlla, infine, per
la dimensione d’impresa (SIZE), misurata
come logaritmo del numero totale di
occupati nel 2008, e per gli effetti paese,
specificati attraverso dummy.
supporto pubblico e include l’intensità di R&S
(introdotta in forma quadratica) e una dummy
che indica se l’impresa è capogruppo come
variabile esplicativa aggiuntiva (HEAD).
Infine l’analisi controlla per il settore
di attività, definito sulla base della
classificazione OECD in settori high-tech
(HTECH), medium high-tech (MHTECH),
medium low-tech (MLTECH) e low-tech
(LTECH)5. Le variabili non significative
sono state quindi eliminate dall’analisi e i
risultati inclusi nella tab. 3 mostrano solo
la specificazione finale del modello. In
particolare, gli strumenti finanziari (BANK e
PUBLIC) non risultano significativi nella stima
della [2] e sono, pertanto, stati eliminati
dall’equazione di regressione della quota di
R&S esterna.
Una volta che le imprese decidono di
acquisire la ricerca da strutture esterne,
viene deciso l’ammontare della spesa da
investire in essa. Questa fase della scelta è
dunque modellata come segue:
extRDit = extRDit*=zitβ + eit se DUextRDit=1 [3]
0 se DUextRDit=0
La stima econometrica dell’equazione [2]
considera, in prima battuta, tra le variabili
esplicative, zit la quota di spesa in R&S
finanziata attraverso il credito bancario o il
Rapporto Corporate Efige I 69
Rapporto Corporate
Approfondimenti
Risultati della stima del modello di selezione di Heckman [2]-[3]
VARIABILE INDIPENDENTE: EXTRD
(I)
(II)
GROUP
SIZE
RD
OUTSOURCING
PROT
BANK
BANK*GER
0,288
0,058
-0,008
0,021
0,000
0,001
0,241
0,054
0,324
0,045
0,000
0,001
***
***
***
BANK*FRA
BANK*ITA
PUBLIC
PUBLIC*ITA
0,005
0,002
***
-1,213
***
0,585
3,521
0,527
33,812
17,803
135,250
6,630
24,310
2,420
***
***
0,291
0,058
0,003
0,022
0,000
0,001
0,231
0,055
0,308
0,047
***
-0,005
0,002
-0,001
0,001
0,004
0,001
0,005
0,002
***
PUBLIC*FRA
PUBLIC*GER
constant
/athrho
/lnsigma
rho
sigma
lambda
Wald
LR test of indep. eqns. (rho = 0)
test bankita=bankger=bankfra
test pubita=pubfra=pubger
VARIABILE INDEPENDENTE: DUEXTRD
RD
RDsqr
SIZE
HEAD
FRA
ITA
MHTECH
MLTECH
LTECH
constant
(I)
-0,927
0,215
0,008
0,003
-3,233
1,012
-10,088
4,711
13,405
2,723
18,017
2,643
-2,900
3,484
9,600
3,484
5,998
3,537
28,757
11,985
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
*
**
-1,239
0,091
0,468
3,481
0,437
32,503
14,189
155,780
4,640
(II)
-0,929
0,215
0,008
0,003
-3,395
1,004
-10,720
4,694
13,684
2,752
19,354
2,683
-2,813
3,489
9,667
3,488
5,933
3,537
33,752
12,043
(III)
0,285
0,058
-0,008
0,021
0,000
0,001
0,241
0,054
0,324
0,044
0,000
0,001
***
0,008
0,003
0,002
0,003
0,004
0,003
*** -1,212
0,090
*** 0,623
*** 3,534
0,553
34,263
18,944
135,330
7,860
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
*
***
(III)
-0,926
0,215
0,008
0,003
-3,145
1,014
-9,892
4,709
13,286
2,730
18,174
2,647
-2,840
3,483
9,599
3,482
6,053
3,536
26,799
11,729
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
Note: nella stima della [1] sono state incluse dummy di settore al livello NACE 2 digit. Il paese base considerato è la Germania.
Il settore base della [2] è high-tech (HTECH). Anche nel modello [2] sono state incluse dummy di settore NACE 2 digit, ma non sono
state mostrate nell’analisi. I risultati sono disponibili su richiesta agli autori.
* significatività dei coefficienti al 10%.
** significatività dei coefficienti al 5%.
*** significatività dei coefficienti all’1%. I numeri in corsivo rappresentano gli standard errors.
70 I Rapporto Corporate Efige
*
**
I risultati mostrano come nel complesso la
scelta su come finanziare la spesa in R&S
non sia neutrale rispetto alla decisione
dell’impresa di commissionare esternamente
parte dell’attività di ricerca, evidenziando
anche una certa eterogeneità tra paesi.
Al contrario, le strategie finanziarie non
significativo sembrano rilevanti nello spiegare
l’ammontare investito in ricerca esterna in
nessuno dei paesi considerati6.
Focalizzando l’attenzione sulla scelta di
comprare esternamente la ricerca, l’evidenza
suggerisce che l’outsourcing è correlato
positivamente con il finanziamento pubblico.
In ogni caso, le stime mostrano che questo
risultato è vero in Italia, ma non in Germania
e Francia. Analogamente, una specificità
italiana appare anche nella relazione
positiva riscontrata tra la quantità di spesa
in R&S finanziata dalle banche e l’uso di
ricerca esterna. Infatti mentre in Francia,
non emerge alcuna correlazione tra la
quota finanziata dalle banche e la scelta di
comprare la ricerca all’esterno, in Germania
tale relazione è negativa7.
Come ipotizzato, far parte di un gruppo
aumenta la propensione delle imprese ad
acquistare ricerca esterna. Analogamente,
il fatto che l’impresa dia in outsourcing parte
dell’attività la rende più propensa a utilizzare
la stessa modalità anche nel caso della
ricerca.
È interessante notare poi che l’intensità di
R&S e la dimensione d’impresa non sono
significative nello spiegare la decisione di
outsourcing, mentre lo sono nella scelta della
quantità di spesa da allocare all’esterno.
Contrariamente alle aspettative, l’uso di
strumenti di protezione della proprietà
intellettuale aumenta la propensione
ad acquistare R&S all’esterno.
Anche se sarebbe necessario un ulteriore
approfondimento su questo aspetto, tale
risultato sembra suggerire la presenza
di effetti di complementarietà tra attività
di ricerca interna e esterna. Infatti, un
più alto livello di protezione può essere
considerato come prerequisito necessario
per beneficiare di ricerca esterna in settori
con alti spillover tecnologici, al fine di
garantire l’appropriabilità dei risultati finali.
Una spiegazione alternativa è, invece, che
l’utilizzo di strumenti per la difesa della
proprietà intellettuale sia appannaggio delle
imprese che abitualmente fanno ricerca
e la comprano: in questo caso il risultato
della correlazione positiva può essere
semplicemente un effetto di sorting.
Come discusso, la quota di credito bancario
e di finanziamento pubblico alla ricerca,
non contribuisce a spiegare l’ammontare
di ricerca esterna effettivamente acquistato
dall’impresa. Al contrario, la variabile che
sembra essere determinante a tal riguardo è
la quota totale di fatturato investito in ricerca
e sviluppo: la relazione però non è lineare.
Il fatto che il coefficiente a RD sia negativo
e quello a RDsqr positivo suggerisce che
per bassi livelli di spesa in ricerca prevalga
un effetto sostituzione: in questo caso
un aumento della quantità di fatturato da
investire in ricerca diminuisce la quantità
investita esternamente, fino a un punto di
minimo oltre il quale la relazione cambia.
Per livelli superiori di intensità della ricerca,
infatti, la relazione positiva suggerisce che
predomini un effetto di complementarietà tra
le due tipologie di ricerca.
Ma per l’Italia in particolare, questo tipo di
effetto potrebbe risultare in qualche modo
“rafforzato” dalla correlazione positiva e
significativa tra il finanziamento esterno, in
particolare debito bancario, e l’acquisto della
ricerca al di fuori dell’impresa. Questo può
dunque innescare un effetto moltiplicativo
in caso di condizioni finanziarie agevoli
difficili, contribuendo pertanto ad amplificare
gli aggiustamenti dell’investimento in
innovazione a fronte della crisi.
Le specificità a livello di paese sono
probabilmente l’effetto di una pluralità di
fattori, sia istituzionali che culturali, tra cui le
prevalenti caratteristiche del rapporto bancaimpresa e la struttura del sistema finanziario.
In particolare, la mancanza di correlazione
individuata in Francia e la relazione negativa
riscontrata invece in Germania suggeriscono
una considerevole eterogeneità sia nella
domanda che nell’offerta di strumenti
finanziari per l’innovazione a livello europeo.
Riferimenti bibliografici
Commissione Europea, 2009. Innobarometer
2009. Brussels, DG Enterprise and Industry.
Crépon B., Duguet E., Mairesse J. 1998.
Research and development, innovation
and productivity: an econometric analysis at the
firm level. Economics of Innovation
and New Technology, 7 (2): 115-158.
Hall B.H. 2002. The financing of research and
development. Oxford Review of Economic Policy,
18 (1): 35-51.
Hall B.H., Lotti F., Mairesse J. 2008. Innovation
and productivity in SMEs: empirical evidence for
Italy. NBER Working Paper 14202.
Hall B.H., Lerner J. 2009. The financing of R&D
and innovation. NBER Working Paper 15325.
Heckman J. 1979. Sample selection bias as a
specification error. Econometrica, 47 (1): 153-161.
OECD, 2009. OECD Science, Technology and
Industry Scoreboard 2009, OECD Publishing. doi:
10.1787/sti_scoreboard-2009-en
Piga C.A., Vivarelli M. 2004. Internal and external
R&D: a sample selection approach. Oxford
Bulletin of Economics and Statistics, 66 (4):
457-482.
Conclusione
L’esercizio empirico svolto suggerisce
che la scelta di posporre l’innovazione a
seguito degli effetti della crisi può essere
il risultato non solo delle cattive condizioni
economiche in generale, ma anche di
un effetto indiretto dato dalle scelte delle
imprese in termini di composizione della
ricerca e finanziamento all’innovazione. Le
imprese che fanno outsourcing di ricerca,
infatti, secondo il nostro approccio, sono le
più propense a rimandare l’innovazione: è
più semplice interrompere un accordo di
fornitura esterna che affrontare i costi di
chiusura di una struttura di ricerca interna e
di dismissione del personale e dei macchinari
in essa impiegati. Questa ipotesi è, in effetti,
confermata dalle analisi in tutti i paesi
oggetto di osservazione.
Dati Eurostat.
Finconstr è un indicatore che assume valore 1 quando l’impresa
dichiari di essere stata finanziariamente vincolata durante il
2009.
3
Nella banca dati a disposizione non à possibile distinguere la
forma tecnica attraverso cui il finanziamento pubblico è erogato
alle imprese beneficiarie.
4
Si dice latente una variabile inosservabile stimabile attraverso
una serie di variabili manifeste.
5
OECD, 2009.
6
Alcuni caveat sono necessari: la variabile indipendente e le
esplicative nella [1]-[2] sono osservate contestualmente.
Quindi, in questo contesto, noi non stimiamo tanto la causalità
della relazione, bensì la presenza di correlazione tra variabili.
7
Il likelihood ratio test rigetta l’ipotesi di uguaglianza dei
coefficienti della variabile BANK nei tre paesi.
1
2
Rapporto Corporate Efige I 71
Rapporto Corporate
Approfondimenti
LA FORZA LAVORO STRANIERA
IN ITALIA: ALCUNE EVIDENZE A
LIVELLO D’IMPRESA
a cura di Attilio Pasetto e Antonio Riti
Dall’analisi empirica emerge che
la presenza di lavoratori stranieri
in Italia è più forte nel Nord Est,
nei settori di scala e nella piccola
dimensione nonchè nelle imprese
prevalentemente rivolte al mercato
interno. Si riscontra inoltre una
correlazione inversa tra quota di
personale straniero e quota di
laureati. Ciò conferma la prevalenza
in Italia di forza lavoro straniera low
skilled in misura probabilmente
superiore rispetto ad altri paesi
europei.
Abbiamo visto nel commentare i risultati
relativi all’occupazione (sezione B del
questionario) che la quota della forza lavoro
straniera sugli occupati si attesta nelle
imprese italiane (8,1%) a un livello più alto
della media dei sette paesi considerati
(7,3%) e inferiore soltanto a quelli
dell’Austria e della Germania.
Intendiamo approfondire ora come
la presenza di lavoratori stranieri si
distribuisca nel nostro paese a livello
geografico, settoriale e dimensionale.
Prenderemo poi in considerazione il
rapporto esistente tra quota di lavoratori
stranieri, da un lato, ed esportazioni
e internazionalizzazione produttiva,
dall’altro. Questi aspetti saranno esaminati
dapprima attraverso una analisi descrittiva
e successivamente attraverso alcune
verifiche econometriche.
Dati e analisi descrittiva
Il Nord Est è l’area del nostro paese in cui
è più forte la presenza di lavoratori stranieri
in rapporto agli occupati, con l’11,7% della
forza lavoro, seguita dal Nord Ovest (8,1%)
e dal Centro (6,5%), mentre la quota del
Mezzogiorno è molto più bassa (2,2%),
forse anche a causa di una presumibile
componente di lavoro nero1. La maggior
incidenza di lavoratori stranieri nel Nord
72 I Rapporto Corporate Efige
Est - confermata peraltro da altre fonti2
- è ampia e riscontrabile in tutte le classi
dimensionali. Soltanto nelle grandi imprese
si attenua il divario tra il Nord Est e le altre
macroaree, mentre la quota del Centro
sopravanza quella del Nord Ovest.
L’incidenza dei lavoratori stranieri varia da
settore a settore, raggiungendo i valori più
alti nell’alimentare, nel legno, nella gomma
e plastica, nei minerali non metallici, nella
metallurgia e nei prodotti in metallo. Sono
tutti settori tradizionali o a economie di scala,
in cui la quota dei laureati, sempre secondo
i dati Efige, è inferiore alla media, indicatore
questo che segnala la maggior presenza
di personale low skilled. Al contrario, la
presenza di lavoratori stranieri è bassa nella
carta, nella chimica, nella farmaceutica,
nei macchinari, negli apparecchi elettrici e
negli strumenti di precisione, settori in cui la
quota dei laureati è al di sopra della media.
La tabella qui riportata mostra che queste
evidenze settoriali si ripropongono con una
certa regolarità in quasi tutti i paesi.
Come evidenziato dalla prima tabella,
nelle imprese italiane l’incidenza degli
stranieri appare inversamente correlata
alla dimensione: si scende infatti dall’8,3%
della fascia 10-19 addetti al 6,5%
delle grandi imprese . Un andamento
opposto mostra la quota dei laureati, che
aumenta al crescere della dimensione,
passando dal 6% delle piccole imprese
al 13% delle grandi. Ciò appare coerente
con la prevalenza nella forza lavoro
straniera impiegata dalle imprese italiane
di personale low skilled. Nelle grandi
imprese si ha la concomitante presenza
di più laureati e meno stranieri in rapporto
agli occupati, mentre il contrario avviene
nelle piccole imprese3. In media nei sette
paesi considerati nella survey troviamo una
quota minore di lavoratori stranieri e una
percentuale maggiore di laureati. Del resto,
i dati Eurostat mostrano che gli immigrati
residenti in Italia sono generalmente meno
istruiti rispetto agli immigrati presenti negli
altri paesi UE-15. Il 48% della popolazione
straniera di età compresa tra i 25 e i 55
anni residente nel nostro Paese tra il 2005
e il 2007 possedeva un titolo di studio
corrispondente al massimo alla scuola
dell’obbligo, contro il 19,3% del Regno
Unito, il 27,5% della Germania, il 31%
dell’Austria, il 37,7% della Spagna e il
42,5% della Francia. All’opposto, la quota
di stranieri laureati residenti in Italia era pari
nello stesso periodo al 14% contro il 56,4%
del Regno Unito, il 41,1% della Germania, il
28,5% dell’Austria, il 30,2% della Spagna,
il 27,6% della Francia4.
L’indagine consente di analizzare anche il
rapporto esistente tra personale straniero e
apertura internazionale delle imprese.
La Banca d’Italia rileva come la presenza di
lavoratori extracomunitari sia più elevata,
oltre che nelle imprese più piccole e a più
bassa produttività, anche in quelle meno
aperte al commercio internazionale5.
L’analisi condotta da Bettin, Lo Turco e
Maggioni sui dati 2001-2003 della nona
indagine sulle imprese manifatturiere
Quota media di lavoratori stranieri sugli occupati per addetti e area geografica (%)
NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
MEZZOGIORNO
TOTALE
10-19 addetti
8,6
12,3
6,4
2,3
8,3
20-49 addetti
8,1
11,2
7,1
2,2
8,1
50-249 addetti
7,2
12,4
4,0
1,8
7,7
oltre 249 addetti
6,1
8,5
6,4
2,0
6,5
Totale
8,1
11,7
6,5
2,2
8,1
Percentuale media dei lavoratori stranieri sugli occupati per settore e paese (%)
AUSTRIA
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA
REGNO
UNITO
MEDIA 7
PAESI
Alimentari
14,3
4,9
9,6
8,3
9,6
18,7
9,0
Tessile
15,3
4,2
9,5
6,0
3,3
9,6
6,1
1,9
9,1
6,1
3,3
15,3
5,6
Pelli e cuoio
Legno
12,2
3,1
10,6
11,5
8,9
7,0
8,9
Carta
10,0
3,7
7,2
4,6
3,5
5,5
5,1
6,0
3,5
8,6
7,3
4,1
6,4
6,1
4,1
7,9
3,0
3,6
16,5
5,9
Chimica
Farmaceutica
Gomma e plastica
15,7
4,5
13,6
12,4
7,4
8,2
9,9
Minerali non metallici
12,8
4,4
9,4
9,8
7,4
5,1
7,9
Metallurgia
19,2
8,7
14,7
16,9
6,2
5,3
11,8
Prodotti in metallo tranne macchinari
16,1
5
11,5
10,6
6,1
4,6
8,6
Macchinari e impianti
6,5
3,7
8,7
5,7
4,6
3,9
6,0
Apparecchi elettrici
8,7
3,2
6,9
4,3
3,8
5,8
5,0
12,6
1,9
6,2
2,9
3,9
4,0
5,0
4,8
3,7
15,3
6,6
4,3
3,0
6,9
11,8
4,1
9,5
8,1
6,0
6,8
7,3
Strumenti di precisione
Mezzi di trasporto
Media settori
Rapporto Corporate Efige I 73
Rapporto Corporate
conferma che la quota di lavoro straniero è
più alta nelle imprese che non esportano.
I risultati di una regressione probit
avvalorano la significatività della relazione
negativa tra percentuale di occupati stranieri
ed imprese esportatrici6.
Altri studi, come quello di Barba Navaretti,
Bertola e Sembenelli (2008) 7, sottolineano
come, almeno a livello italiano, esista una
relazione di tipo inverso tra impiego di forza
lavoro straniera e internazionalizzazione.
In altre parole, le imprese che
internazionalizzano parte della produzione
tenderebbero ad impiegare quote molto più
basse di personale scarsamente qualificato
e di immigrati.
I dati dell’undicesima indagine in effetti
confermano che per l’Italia la percentuale
media della forza lavoro straniera è più
alta nelle imprese che non esportano
rispetto a quelle che esportano (8,6%
contro 7,8%). Ciò si riscontra in tutte le
classi dimensionali. Analoga la posizione
della Spagna, dell’Austria e della Francia.
La stessa relazione non vale invece per la
Germania e per il Regno Unito.
Considerazioni molto simili valgono per
le imprese che internazionalizzano. La
quota di lavoratori stranieri impiegata
sia nelle imprese che hanno effettuato
investimenti esteri diretti (5,3%) sia nelle
imprese che hanno concluso accordi di
produzione all’estero (4,6%) risulta per
l’Italia ampiamente al di sotto della media
nazionale (8,1%). Anche la Spagna si
comporta come l’Italia. Non così Austria,
Regno Unito e Francia, in cui la quota
Approfondimenti
Quota media di lavoratori stranieri e laureati sugli occupati per classe
di addetti (%)
Stranieri
Laureati
14
12
10
8
6
4
2
0
10-19
20-49
50-249
di lavoratori stranieri nelle imprese che
producono all’estero nell’una o nell’altra
forma è sempre più alta. Nelle imprese
tedesche invece la quota di lavoro
straniero è più alta della media nazionale
per gli IDE, ma non per gli accordi. Se
però consideriamo congiuntamente IDE e
accordi, la quota di lavoratori stranieri nelle
imprese tedesche appare più alta della
media nazionale.
Verifica empirica
Vediamo ora se quanto emerso dalla
statistica descrittiva può essere
confermato dall’analisi di regressione,
effettuando alcune stime condotte su
1.755 casi di imprese italiane, che
hanno dichiarato di occupare personale
straniero.
oltre 249
Media Italia
Media 7
Paesi
Abbiamo cercato di spiegare la presenza
della forza lavoro straniera in Italia
(quota_fw) in funzione della localizzazione
dell’impresa, della componente
dimensionale, della quota di laureati
sul totale della forza lavoro, del fatto
che l’impresa sia esportatrice, della
realizzazione di IDE o accordi produttivi,
dei settori merceologici di appartenenza.
Dopo aver valutato singolarmente la
significatività di ciascuna delle variabili
elencate, si è proceduto ad un approccio
di tipo incrementale, aggiungendo
progressivamente alla relazione iniziale quota_fw=∂+βiarea - una variabile alla
volta fino ad ottenere la relazione completa
rappresentata da
Percentuale media della forza lavoro straniera sugli occupati per tipo di impresa e Paese
AUSTRIA
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA
REGNO
UNITO
MEDIA 7
PAESI
esportatrici
11,2
4,0
10,3
7,8
5,7
7,0
7,3
non esportatrici
12,5
4,3
9,0
8,6
6,3
6,4
7,3
internazionalizzate
15,8
4,2
11,7
5,1
4,7
9,3
8,0
di cui con IDE
16,6
4,3
13,5
5,3
5,2
8,6
9,3
di cui con Accordi
14,9
4,5
8,8
4,6
3,9
9,6
6,5
Tutte le imprese
11,8
4,1
9,5
8,1
6,0
6,8
7,3
IMPRESE
74 I Rapporto Corporate Efige
quota_fw=∂+βiarea+βiaddetti+βiquota_
laureati+βiexport+βiIDE+βisettore.
All’aumentare delle variabili all’interno
della relazione, i coefficienti delle variabili
sono rimasti statisticamente significativi
ed è cresciuta la bontà di adattamento
della relazione specificata all’ipotesi
teorica sottostante; abbiamo considerato
inoltre anche i test di robustezza per
valutare se la presenza di qualche valore
estremo potesse distorcere i risultati della
regressione. Qui di seguito viene riportata
la specificazione finale.
La regressione lineare utilizzata prevede
tre variabili categoriali, rappresentate
rispettivamente da tre variabili politomiche
- quattro macroaree (Nord Ovest, Nord
Est, Centro, Sud), quattro classi di addetti
(10-19, 20-49, 50-249, oltre 249) e 18
settori merceologici - due variabili binarie,
export e IDE, che assumono i valori uno
o zero, e una variabile continua costituita
dalla quota di laureati sul totale della forza
lavoro.
A livello di macroarea i coefficienti
esprimono il divario che esiste con il
Nord Est, l’area dove sono maggiormente
presenti i lavoratori stranieri: come si
può osservare, gli scostamenti in termini
di quota media di lavoratori stranieri
aumentano passando dal Nord Ovest al
Centro e al Sud.
A livello dimensionale, la regressione,
i cui coefficienti sono tutti significativi,
conferma che sono le imprese di
minor dimensione quelle che occupano
mediamente una quota maggiore di
Analisi di regressione
QUOTA_FW
COEF.
STD. ERR.
T
P>T
Nord Ovest
-3,149
0,691
-4,56
0,000
Centro
-4,827
0,892
-5,41
0,000
Sud
-9,376
1,289
-7,27
0,000
Addetti 21-49
-4,015
0,708
-5,67
0,000
Addetti 50-249
-5,347
0,945
-5,66
0,000
Addetti oltre 249
-7,962
1,346
-5,91
0,000
Quota laureati
-0,041
0,008
5,17
0,000
export
-2,188
0,672
-3,25
0,001
IDE
-2,860
1,162
-2,46
0,014
0,461
1,462
0,32
0,753
Tessile
-1,612
1,407
-1,15
0,252
Pelli e cuoio
-1,776
1,848
-0,96
0,337
Legno
1,695
1,919
0,88
0,377
Carta
-3,035
1,732
-1,75
0,080
Coke
-1,570
6,318
-0,25
0,804
Chimica
-0,964
1,962
-0,49
0,623
Gomma-plastica
4,350
1,530
2,84
0,005
Min. non metallici
3,465
1,626
2,13
0,033
Metallurgia
7,689
1,900
4,05
0,000
Macchine
-3,494
1,319
-2,65
0,008
Apparecch. Elettriche
-4,537
1,600
-2,84
0,005
Mezzi trasporto
-1,496
2,561
-0,58
0,559
Prodotti metallici
2,255
1,192
1,89
0,059
Strumenti precisione
-8,064
2,482
-3,25
0,001
Farmaceutica
-6,272
3,509
-1,79
0,074
costante
20,809
1,248
16,68
0,000
Alimentari
N.osservazioni:1755
R =13,1
2
Rapporto Corporate Efige I 75
Rapporto Corporate
occupati stranieri. I coefficienti della
regressione esprimono il divario che esiste
con la prima classe di addetti (10-19):
lo scostamento maggiore si ha per la
classe dimensionale più grande, mentre
differenze minori si hanno per le classi
intermedie.
Per quanto riguarda la quota di laureati,
la presenza nelle imprese di laureati si
dimostra essere correlata negativamente
alla quota di lavoratori stranieri.
All’incremento dell’1% di laureati
corrisponde una diminuzione dello 0,04%
della quota di lavoratori stranieri.
La relazione che considera l’effetto
esportazione evidenzia una legame inverso
tra la capacità dell’impresa di competere
sui mercati esteri e al contempo occupare
la forza lavoro straniera: il coefficiente della
regressione esprime il fatto che la quota di
lavoro straniero di un’impresa esportatrice
dovrebbe risultare mediamente inferiore
del 2,2% rispetto ad un impresa che opera
nell’ambito del mercato domestico. Merita
inoltre di essere ricordato - sebbene non
ne riportiamo l’esercizio statistico - che la
significatività di questo legame si rafforza,
se si prendono in considerazione le
imprese che esportano anche nei mercati
extra-UE, suggerendo in qualche modo
una maggiore complessità nella relazione
con l’estero, mentre si indebolisce, se si
considerano le imprese che esportano
soltanto verso i mercati dell’Unione
europea.
Considerando l’internazionalizzazione
produttiva, la variabile IDE rappresenta
globalmente sia gli investimenti esteri
diretti sia gli accordi produttivi con
partners stranieri. Anche in questo caso
la statistica descrittiva riceve piena
conferma. Il coefficiente della variabile
IDE è significativo e negativo, e mostra
che un’impresa internazionalizzata ha
mediamente una quota di lavoratori
stranieri inferiore del 2,9% rispetto ad un
impresa non internazionalizzata.
76 I Rapporto Corporate Efige
Approfondimenti
L’introduzione di una dummy settoriale ci
consente infine di valutare la significatività
delle relazioni esistenti tra i settori
considerati e la quota di lavoratori
stranieri. Nei settori evidenziati in grassetto
i risultati appaiono significativi. Possiamo
osservare come ci sia un legame positivo
con la quota di lavoratori stranieri, a
un elevato livello di significatività, nella
gomma e plastica, nei minerali non
metallici e nella metallurgia, confermando
i risultati dell’analisi descrittiva. Si osserva
invece un legame negativo nelle macchine,
nelle apparecchiature elettriche e negli
strumenti di precisione. Anche queste
evidenze sono in linea con la statistica
descrittiva. Non appare invece significativa
la relazione tra forza lavoro straniera e
settori tradizionali, che emerge dalle tavole
di base.
Conclusioni
Le verifiche empiriche qui condotte
attestano come in Italia la forza lavoro
straniera sia maggiormente presente
- oltre che nel Nord Est, nei settori di
scala e nella piccola dimensione – anche
nelle imprese prevalentemente rivolte al
mercato interno, ossia che non esportano
e che non internazionalizzano parte della
produzione.
Emerge inoltre una correlazione inversa
tra quota di personale straniero e quota
di laureati sul totale degli occupati
nell’impresa. Sulla base di ulteriori
regressioni, anche se qui non riportate,
risulta che questo legame di tipo inverso
appare significativo, tra i principali
paesi dell’indagine, oltre all’Italia, solo
per la Germania. Per Francia e Spagna
il coefficiente è negativo, ma non
significativo, mentre per il Regno Unito
è positivo e non significativo. Abbiamo
così la conferma della prevalenza in Italia
di forza lavoro straniera low skilled in
misura probabilmente superiore rispetto
ad altri paesi europei. Da una parte,
le imprese tendono principalmente ad
impiegare i lavoratori stranieri in mansioni
scarsamente qualificate, che gli italiani
non sono disposti a fare; dall’altra parte,
il capitale umano straniero più qualificato
tende a privilegiare altre destinazioni, in
cui riesce a trovare maggiori opportunità
in termini sia retributivi sia professionali8.
Ciò significa che una nazione come l’Italia
corre il rischio di chiudersi all’apporto di
energie fresche e dinamiche in grado di
innalzare il livello qualitativo del capitale
umano complessivo del Paese, con la
conseguenza di avvitarsi sempre più in
una spirale negativa. Dalla quale si può
uscire soltanto puntando a una maggiore
qualificazione degli occupati attraverso
adeguati percorsi formativi sia nella scuola
che nel mondo del lavoro.
Su questo punto vedi Venturini A., L’effetto dell’immigrazione
sui mercati del lavoro dei Paesi di destinazione, Economia
Italiana, n. 3, 2004, pp. 645-666.
2
Si vedano in particolare:
- l’indagine Confindustria sul mercato del lavoro nel 2009
(p.6), pubblicata il 23/7/2010;
- il già citato contributo di Venturini A. (2004).
3
La maggior presenza di lavoratori stranieri nelle piccole imprese
è confermata da Confindustria nello studio sopra citato (p.6)
e da Banca d’Italia (2009) in L’immigrazione nelle regioni
italiane, p. 66, approfondimento contenuto nella pubblicazione
“L’economia delle regioni italiane nel 2008”.
4
Questi dati, di fonte Eurostat, sono tratti dalla Relazione 2008
della Banca d’Italia (pp. 125-126).
5
Vedi il già citato approfondimento contenuto in “L’economia
delle regioni italiane nell’anno 2008”.
6
Bettin G., Lo Turco A. e Maggioni D., A firm level perspective
on migration, presentato al workshop “I cambiamenti della
manifattura italiana visti attraverso l’indagine UniCredit”,
organizzato da UniCredit, Centro Studi Luca d’Agliano,
Università di Milano, Milano, 8/3/2010.
7
Barba Navaretti G., Bertola G. e Sembenelli, Offshoring and
Immigrant Employment: Firm-level Theory and Evidence”,
2008, CEPR Discussion Papers 6743.
8
Visco I., Invecchiamento della popolazione, immigrazione,
crescita economica, 49ma Riunione Scientifica Annuale
della Società Italiana degli Economisti, Università di Perugia,
25/10/2008.
1
Rapporto Corporate Efige I 77
Rapporto Corporate
Approfondimenti
L’IMPATTO DELLA CRISI
SULLE ESPORTAZIONI
ITALIANE NEL 2009.
CARATTERISTICHE D’IMPRESA
E STRATEGIE DI ESPORTAZIONE
a cura di Luigia Mirella Campagna e Antonio Riti
La caduta del commercio estero
nel 2009 ha avuto un forte impatto
negativo sull’interscambio dell’Italia.
L’esercizio statistico svolto rileva
che il sistema manifatturiero
italiano è più esposto alla crisi
rispetto a quello tedesco e coglie
qualche peculiarità. Un ruolo
dominante nella caduta delle nostre
esportazioni spetta al modello di
specializzazione, mentre le strategie
di esportazione e le caratteristiche
aziendali pesano rispettivamente il
25% e il 15% circa.
78 I Rapporto Corporate Efige
Le tensioni sui mercati internazionali,
aggravatesi dalla metà del 2008, hanno
prodotto una serie di effetti a catena che
si sono ben presto trasmessi agli scambi
internazionali, diminuiti nel 2009 del 12,2%
rispetto all’anno precedente. Nello stesso
periodo, l’economia italiana ha attraversato
la più profonda recessione dal dopoguerra,
che l’ha sospinta indietro verso livelli di PIL
del passato, più di quanto sia accaduto in altri
paesi europei.
In Italia, la crisi si è propagata in primo luogo
attraverso il canale esterno e ha colpito
soprattutto le esportazioni. La drastica caduta
della domanda mondiale ha determinato
però situazioni disomogenee tra le diverse
unità produttive, con imprese che hanno
visto ridursi in misura significativa le proprie
vendite all’estero, altre che ne hanno sofferto
meno, altre che non ne hanno sofferto
affatto ma, al contrario, ne hanno tratto
beneficio. I risultati dell’indagine colgono
questa disomogeneità e, pur confermando il
quadro descritto dalla contabilità nazionale,
contribuiscono a gettare luce sui fattori che
hanno comportato maggiori o minori disagi
per le imprese nella risposta alla crisi.
In primo luogo, i dati segnalano che il 55%
delle imprese intervistate ha dichiarato di aver
sofferto una flessione delle esportazioni nel
corso del 2009 rispetto all’anno precedente;
il 31% circa non ha accusato variazioni di
rilievo; il restante 13,5% ha registrato invece
un aumento. Si conferma però che l’industria
manifatturiera italiana ha sofferto più di quella
della maggior parte dei paesi osservati e, in
particolare, più di quella tedesca: in Germania,
infatti, sono state meno della metà le imprese
che hanno sperimentato una riduzione delle
esportazioni (43,5%), a fronte di una buona
percentuale che non ha subito variazioni
rilevanti (37,6%) e di quasi un quinto che le ha
aumentate (18,9%).
Sotto il profilo settoriale, trova riscontro
il dato che le imprese più penalizzate
sono state quelle che producono beni
di investimento (impianti e macchinari,
macchine elettriche, mezzi di trasporto per
uso industriale) e intermedi (elettronica,
chimica, gomma e plastica, metalli di base),
dove la percentuale di imprese che hanno
riportato cali delle esportazioni ha superato
in molti casi il 60%. Viceversa, hanno
sofferto meno le imprese che producono
beni di consumo non durevoli, potendo
contare comunque su una domanda a
carattere anticiclico: nella farmaceutica,
le imprese che hanno registrato una
diminuzione delle esportazioni sono state
meno di un quarto; nel settore alimentare,
non hanno superato il 30%.
Si osservano relazioni interessanti con la
dimensione aziendale: in Italia, sono state
colpite con più frequenza le imprese grandi
(63,8%), mentre l’incidenza scende a poco più
della metà tra le imprese più piccole (52,3%).
Questa relazione diretta tra variazione negativa
delle esportazioni e dimensione aziendale non
si ritrova in tutti i paesi osservati: ad esempio
non emerge in Germania e Spagna. Essa
però si inverte quando si guarda all’entità
della flessione: a fronte di una caduta media
delle esportazioni di circa il 30%, le grandi
imprese hanno registrato cali più contenuti
(24%), mentre le maggiori flessioni (32,9%)
sono state riportate dalle imprese più piccole.
Quest’ultima relazione, contrariamente alla
prima, trova riscontro in ciascuno dei sette
paesi osservati.
Il legame con la dimensione non è dunque
univoco e rinvia, in linea con la letteratura più
recente sulle determinanti delle esportazioni,
ad una serie di altre caratteristiche aziendali,
quali l’età, la qualità del capitale umano,
l’intensità dell’investimento materiale, la
capacità di innovare, la qualità del prodotto,
l’organizzazione. Questi elementi, non
sempre associati al numero degli addetti
e al volume del fatturato, possono infatti
avere un ruolo importante e autonomo nello
spiegare la strategia di internazionalizzazione
scelta dall’impresa e, soprattutto, la sua
performance all’export.
L’analisi descrittiva supporta l’idea che
le caratteristiche dell’impresa hanno
Riduzione delle esportazioni nel 2009 (%)
% imprese
riduzione media
80
60
40
52.1
33.0
60.8
58.7
54.4
29.7
27.5
23.8
20
0
10-19 addetti
20-49
50-249
effettivamente giocato un ruolo nella
risposta alla crisi. I valori medi assunti da
alcune di queste variabili sono riportati
nella tabella seguente, dove le imprese
sono state raggruppate in tre gruppi, definiti
sulla base del tipo di variazione subita dalle
vendite all’estero nel corso del 2009 diminuzione, aumento, nessuna variazione.
Come atteso, si osservano caratteristiche
“migliori” nel secondo e terzo gruppo di
imprese.
In generale, le imprese che hanno retto
meglio l’impatto della crisi sono più
giovani, dispongono di una forza lavoro
più qualificata e hanno una più elevata
250 e oltre
intensità di investimento. Meno chiaro è il
ruolo giocato dall’innovazione di prodotto e
dalla qualità del prodotto; un’osservazione
analoga può essere fatta con riferimento
al modello organizzativo, sia sotto il profilo
dell’appartenenza ad un gruppo sia sotto
quello del grado di accentramento delle
decisioni strategiche.
La relativa opacità del ruolo giocato dalle
caratteristiche d’impresa nelle variazioni
dell’export è coerente con l’idea che sia stata
la drastica caduta della domanda mondiale
il canale principale attraverso il quale si è
manifestata la crisi. Da ciò deriva che un
importante elemento di discriminazione tra
Variazioni delle esportazioni e caratteristiche dell’impresa
Esportazioni nel 2009
diminuite
aumentate
invariate
età
30,4
28,2
28,9
appartenenza ad un gruppo
53,9
14,4
31,8
organizzazione accentrata
(% imprese)
83,2
76,7
84,7
6,8
8,2
7,7
quota laureati su forza lavoro
investimenti/fatturato
9,5
11,7
11,2
innovazione di prodotto
(% imprese)
58,2
64,8
54,3
qualità di prodotto (indice)
79,6
79,0
80,8
Rapporto Corporate Efige I 79
Rapporto Corporate
le imprese è stato senz’altro il loro grado di
dipendenza dalla domanda estera: la crisi
dovrebbe aver colpito più severamente le
imprese maggiormente esposte sui mercati
internazionali, mentre le meno esposte
avrebbero dovuto risultare meno vulnerabili.
Va aggiunto che la caduta della domanda
non si è realizzata nella stessa misura e nello
stesso tempo in tutte le aree geografiche. In
questo senso, è utile guardare alle strategie
di esportazione delle imprese nella loro
complessità, in termini cioè di quota del
fatturato esportato, numero dei mercati di
sbocco e loro distanza.
Sono state quindi individuate delle misure
di “intensità” sia per la quota di fatturato
esportato, o margine intensivo, sia per il
numero dei mercati di sbocco. Per il primo,
sono state fissate tre soglie, che consentono
di misurare il grado di esposizione delle
imprese alla domanda estera: basso (margine
intensivo inferiore al 25%), medio (2550%), alto (superiore al 50%). Per i secondi,
invece, si sono individuate quattro classi, che
esprimono altrettanti livelli di complessità della
presenza all’estero: basso (l’impresa serve
fino a 3 mercati esteri), medio-basso (4-6),
medio-alto (7-15), alto (oltre 15). Infine, per
osservare la distanza geografica dei mercati
esteri, si è guardato alla distribuzione delle
quote medie del fatturato estero nei singoli
mercati di destinazione. Nella tabella seguente
riportiamo i risultati emersi per i tre gruppi di
imprese prima definiti.
Si osserva una evidente correlazione diretta
tra quota del fatturato estero e contrazione
delle esportazioni: come atteso, il calo delle
esportazioni diventa tanto più diffuso quanto
più aumenta la propensione alle esportazioni.
Medesima relazione con il numero dei mercati
di sbocco: le imprese che esportano un
numero elevato di linee di prodotto soffrono di
più. Per quanto riguarda i mercati di sbocco, si
osserva infine che le imprese più colpite sono
quelle presenti con quote maggiori sui mercati
UE-15 e con quote relativamente basse di
export sui mercati più lontani.
80 I Rapporto Corporate Efige
Approfondimenti
Variazioni delle esportazioni e strategie di vendita all’estero
Esportazioni nel 2009
diminuite
aumentate
invariate
% di imprese
export/fatturato (fino al 25%)
47,8
14,0
38,3
export/fatturato (26%-50%)
60,4
14,7
24,9
export/fatturato (oltre 50%)
62,3
11,7
26,0
n° prodotti esportati (0-3)
33,6
15,3
51,0
n° prodotti esportati (4-6)
45,6
14,8
39,6
n° prodotti esportati (7-15)
52,0
13,4
34,6
n° prodotti esportati (oltre 15)
60,4
13,0
26,6
quote medie di export per mercati di sbocco
Paesi UE-15
59,0
55,3
57,7
Altri paesi UE
8,6
10,2
9,6
32,4
34,4
32,6
10,7
10,7
11,0
Cina India
3,4
2,4
2,4
Altra Asia
3,9
5,7
4,9
USA Canada
6,8
5,7
6,0
Altra America
3,1
3,4
2,9
Altro
4,6
6,5
5,4
Paesi extra-UE, di cui:
Europa non UE
Le evidenze fin qui descritte rappresentano
però semplici correlazioni e non ci aiutano
a capire l’importanza relativa che i diversi
fattori hanno svolto nel determinare una
variazione delle esportazioni. Per fare ciò
è necessario fare un passo aggiuntivo e
cercare di capire quali tra i suddetti elementi
sia effettivamente dominante nello spiegare
gli effetti della crisi sulle imprese esportatrici.
Per fare ciò, ricorriamo ad un’analisi di
regressione, che illustriamo nella sezione
successiva. Vi sono due domande cui
vorremmo tentare di offrire una risposta. La
prima è: rispetto ad altri sistemi produttivi,
il sistema manifatturiero italiano è più
esposto alla crisi attuale? La seconda è:
in che misura il settore di appartenenza,
le caratteristiche dell’impresa, le strategie
di internazionalizzazione impattano sulla
diminuzione delle esportazioni che le nostre
imprese sopportano a seguito di una caduta
della domanda mondiale?
Verifica empirica
In questa sezione ci proponiamo di
valutare l’importanza relativa che i vari
fattori fin qui menzionati hanno avuto
sulla flessione delle esportazioni nei sette
paesi osservati nel corso del 2009 rispetto
all’anno precedente.
Per fare questo, utilizziamo un modello
di linear probability model1 (LPM), che
consente di valutare il contributo di ogni
variabile alla spiegazione della varianza
della variabile dipendente. La nostra
variabile dipendente è espressa tramite
una variabile dummy, che assume valore
1 quando l’impresa ha registrato una
riduzione delle esportazioni e valore 0
quando l’impresa non ha subito alcuna
variazione delle esportazioni o le ha
addirittura aumentate.
Il modello può essere espresso nel modo
seguente:
Y = β0 +β1X1+β2X2+....+βkXk+ε
dove i coefficienti βk rappresentano la
probabilità di ottenere Y=1 al variare delle
variabili indipendenti Xk. Seguendo un
approccio incrementale, i risultati della
regressione sono riportati nella tabella 1.
In una prima specificazione del modello,
introduciamo solamente le dummies
paese. Rispetto alla Germania, il nostro
paese di controllo, tutti i paesi osservati
risultano più vulnerabili sui mercati esteri.
In particolare, la Francia e l’Ungheria
mostrano la probabilità più alta di riportare
una diminuzione delle esportazioni (16.7%
e 16,5%, rispettivamente); seguono
l’Italia (11,6%) e la Spagna (10,9%).
Per quanto riguarda il Regno Unito e
l’Austria, il segno risulta positivo, ma il
valore non è statisticamente significativo.
In questa specificazione del modello, l’R2
– il parametro che esprime la capacità
delle variabili indipendenti di spiegare il
fenomeno osservato - è molto contenuto,
pari all’1,6%. Le dummies paese, quindi,
spiegano soltanto in piccola parte la
diminuzione delle esportazioni registrata
nel 2009.
Successivamente, abbiamo inserito nel
modello altre variabili, cominciando dalle
dummies settoriali: i settori sono stati
definiti sulla base della classificazione
ATECO 2002-NACE rev. 1.1 a due digit.
Il potere esplicativo della regressione
migliora sensibilmente, passando
dall’1,6% al 4,2%. La specializzazione
settoriale spiega dunque in misura non
trascurabile la probabilità di contrazione
delle esportazioni. In particolare, si osserva
che in Italia e Francia uno sfavorevole
assetto settoriale impatta sulla probabilità
di registrare cadute delle esportazioni,
diminuendo l’impatto dell’effetto paese.
I risultati sono interessanti anche per
un’analisi a livello settoriale. Utilizzando
il settore alimentare come variabile di
controllo, si è ottenuta per ciascun settore
una misura della probabilità di registrare
contrazioni del fatturato estero. Come
atteso, i settori che producono beni di
investimento e beni intermedi sono più
vulnerabili ad una caduta della domanda
estera, con coefficienti che superano
sempre il 20% e in alcuni casi si attestano
intorno al 30%. Ugualmente alta è risultata
la probabilità di caduta delle vendite
all’estero in alcuni settori tradizionali (pelli
e cuoio, legno e prodotti in legno).
Minore probabilità di caduta è emersa
invece nell’industria della carta e nel
settore della chimica e farmaceutica.
A questo punto, abbiamo inserito alcune
variabili relative alle caratteristiche
aziendali: dimensione, età, quota dei
laureati sul totale della forza lavoro,
intensità degli investimenti materiali,
innovazione di prodotto, organizzazione.
A parte l’innovazione che, pur mostrando
l’atteso segno negativo, non risulta
statisticamente significativa, le altre
variabili aggiungono tutte qualcosa alla
spiegazione della varianza della variabile
dipendente. In particolare, benché nella
tabella 1 non siano riportati, è interessante
citare i risultati della regressione quando
si è inserita la dimensione, espressa
tramite il logaritmo degli addetti: l’R2
è migliorato solo di poco (4,4%) ma, al
di là della frazione di varianza spiegata,
l’inserimento ha esercitato un impatto
non trascurabile solamente sulle dummies
paese di Italia e Spagna, cogliendo
evidentemente l’effetto della loro struttura
produttiva, fortemente sbilanciata verso
le imprese piccole (il coefficiente paese
dell’Italia è aumentato di oltre un punto
percentuale). Per quanto riguarda le altre
variabili, si è osservato che l’intensità
dell’investimento, molto bassa in Italia
soprattutto se confrontata con quella
tedesca, impatta molto negativamente
sulla probabilità di caduta delle
esportazioni. L’effetto negativo derivante
dagli scarsi investimenti è assorbito quasi
interamente dal modello organizzativo
accentrato, largamente diffuso in Italia.
Considerando le caratteristiche aziendali
nel loro complesso, comunque, l’R2 sale
al 5%.
Un miglioramento significativo – l’R2
raggiunge il 6,9% - lo otteniamo
aggiungendo le variabili di strategia: quota
di fatturato estero, numero dei mercati
di sbocco, distanza (espressa con una
variabile dummy che assume valore 1
quando le imprese sono presenti sui
mercati extra-UE), qualità del prodotto. In
particolare, è il grado di esposizione sui
mercati esteri che contribuisce per oltre
un punto percentuale al miglioramento
della regressione, mentre l’altra variabile
importante si rivela essere il numero dei
mercati di sbocco, che contribuiscono
per lo 0,7% al miglioramento. Guardando
nuovamente alle dummies paese, è
interessante notare come in questa ultima
specificazione del modello, l’effetto paese
in Italia si sia ridotto molto (all’8,1%),
assorbito dalla componente “strategica”.
In conclusione, dato un R2 uguale a 6,5%
e scomponendo questo valore per singole
componenti, si può approssimativamente
dire che la porzione maggiore della
varianza totale della variabile dipendente
- definita in termini di numero di imprese
che hanno accusato flessioni delle vendite
all’estero rispetto all’anno precedente - è
spiegata dalla composizione settoriale
(il 37,7% circa). Seguono la strategia di
internazionalizzazione (27,5%), l’effetto
paese (23,2%) e le caratteristiche
dell’impresa (11,6%).
Infine, abbiamo applicato la medesima
regressione alle sole imprese esportatrici
italiane, per indagare quale sia stato nel
nostro paese il peso relativo delle tre
componenti esaminate: composizione
settoriale, caratteristiche aziendali e
strategie di internazionalizzazione.
I risultati sono illustrati nella tabella 2.
Rapporto Corporate Efige I 81
Rapporto Corporate
Conclusioni
La caduta del commercio estero nel
2009 ha avuto un forte impatto negativo
sull’interscambio dell’Italia. L’esercizio
statistico svolto ci ha consentito di
rilevare che il sistema manifatturiero
italiano è risultato più esposto alla crisi
rispetto al sistema produttivo tedesco e
di cogliere qualche eterogeneità rispetto
agli altri paesi osservati. L’indagine dei
punti di debolezza del nostro sistema
produttivo suscita particolare interesse
perché, prima della crisi, erano emerse
molte evidenze che segnalavano che il
processo di selezione competitiva imposto
dal nuovo paradigma tecnologico e
dalla crescente integrazione dei mercati
globali stava generando anche in Italia
un miglioramento del tessuto produttivo,
rivelando una significativa capacità di
reazione delle imprese.
In primo luogo, tra le ragioni del declino delle
esportazioni italiane, un ruolo dominante
spetta al nostro modello di specializzazione,
evidentemente orientato verso settori la
cui domanda globale è caduta in misura
maggiore rispetto ad altri settori ovvero verso
prodotti caratterizzati da una bassa elasticità
rispetto al reddito. La regressione condotta
solo sulle imprese italiane ci segnala infatti
che l’effetto-settori pesa per quasi il 60%
sulla diminuzione delle esportazioni registrata
dalle nostre imprese.
L’altra questione che merita una riflessione
è quella sulla dimensione aziendale,
spesso indicata come uno degli elementi
strutturali più importanti del nostro
sistema produttivo per spiegare il ritardo
di crescita dell’economia italiana e i
problemi di competitività delle nostre
imprese: l’eccessiva frammentazione
produttiva impedirebbe cioè alle imprese di
raggiungere quelle soglie minime necessarie
a sostenere i costi e i rischi delle innovazioni
e a competere sui mercati internazionali.
Rovesciando la tendenza degli anni più
recenti, invece, la caduta delle esportazioni
82 I Rapporto Corporate Efige
Approfondimenti
italiane nel 2009 ha colpito soprattutto le
grandi imprese: le evidenze hanno segnalato,
infatti, una precisa correlazione inversa tra
dinamica delle esportazioni e dimensioni
aziendali. Al fenomeno ha contribuito
certamente un effetto di composizione,
dovuto alla maggiore presenza relativa di
grandi imprese nei settori in cui la caduta
delle esportazioni è stata più forte, ma esso
si è manifestato nettamente anche all’interno
della maggior parte dei settori.
È normale quindi chiedersi perché ciò
sia avvenuto, se si sia trattato di un fatto
eccezionale o meno, se è opportuno tornare
a ragionare sulla relazione tra dimensioni
aziendali e competitività internazionale
delle imprese. L’esercizio statistico svolto
consente una prima riflessione.
La variabile dimensionale, che in una prima
specificazione del modello è significativa
e con segno positivo, perde significatività
quando si implementa il modello con
variabili che descrivono le modalità con
cui le imprese sono presenti sui mercati
internazionali. Pur tenendo conto che
il risultato è certamente influenzato
dalla correlazione positiva esistente tra
dimensione aziendale e complessità
delle attività internazionali, non può non
colpire il risultato che le strategie di
internazionalizzazione - espresse in termini
di quota di fatturato esportato, numero e
distanza dei mercati di sbocco – pesano
per oltre il 25% nello spiegare la caduta
delle esportazioni delle imprese italiane,
contro il 15% delle caratteristiche aziendali.
Una spiegazione di ciò può essere cercata
nell’effetto “contagio”. La caduta della
domanda mondiale si è propagata a mercati
diversi in tempi diversi: la combinazione di
un’ampia propensione all’export e di una
elevata differenziazione dei mercati e dei
prodotti - che normalmente rappresenta
una efficace strategia di diversificazione del
rischio - ha tutt’altro che funzionato nella
crisi globale del 2008-2009. Verificando
per la dimensione, ciò è vero anche per le
piccole e medie imprese: la caduta delle
esportazioni è stata tanto più diffusa quanto
più le aziende avevano perseguito strategie
di internazionalizzazione complesse.
L’argomento andrebbe ovviamente
approfondito prendendo in considerazione
sia l’entità della contrazione di fatturato
estero sia la capacità di reazione alla crisi.
Poiché la crisi ha colpito in misura diversa
le diverse aree economiche, è molto
probabile infatti che la differenziazione
dei mercati abbia comunque contribuito
a contenere le perdite; le prime evidenze,
inoltre, sembrano indicare che la reazione
alla crisi sia stata tanto più tempestiva
quanto più le imprese hanno adottato
modelli di funzionamento complessi.
Tornando alla questione dimensionale,
il peso attribuito alle strategie complesse
di esportazione attenua senz’altro
l’importanza della dimensione nel
discorso complessivo sulla caduta delle
esportazioni, ma non lo annulla del tutto.
Rimangono infatti le evidenze che, a
parità di condizioni, le grandi imprese
sembrano spesso aver sofferto in misura
maggiore rispetto alle piccole. In questo
senso è utile guardare ai dati disponibili
sulle caratteristiche strutturali delle
imprese, aggiornati al 2007. Tali dati
confermano che esiste un gap - in termini
di dimensione, produttività, intensità di
capitale e lavoro qualificato - tra imprese
esportatrici e imprese non esportatrici,
a favore delle prime; tale gap tende
tuttavia a decrescere rapidamente al
crescere della dimensione aziendale, fino a
rovesciarsi per le imprese grandi, con oltre
250 addetti. In questa classe, le imprese
esportatrici si confermano più grandi delle
imprese non esportatrici, ma risultano
peggiori in termini di valore aggiunto e
investimenti per addetto2. Questi dati
suggeriscono che la dimensione di per
sé non è da sola sufficiente a rendere
“robusta” un’azienda ma che, al contrario,
è necessario associare alla dimensione
scelte strategiche complesse.
regressione
A
0,167
regressione
B
0,145
regressione
C
0,144
regressione
D
0,143
-0,019
0,019
0,019
0,020
n.s.
0,165
n.s.
0,166
n.s.
0,185
n.s.
0,167
quota laureati
0,035
0,035
0,035
0,037
Italia
0,116
0,109
0,105
0,082
0,018
0,018
0,018
0,019
Inv/fatturato
organizzazione accentrata
Exp/Fatt (26-50%)
n.s.
n.s.
0,063
Spagna
0,111
0,121
0,135
0,134
0,019
0,019
0,020
0,030
Exp/Fatt (oltre 50%)
0,073
n.s.
n.s.
n.s.
0,014
n.s.
n.s.
n prodotti (4-6)
0,096
n prodotti (7-15)
0,104
n prodotti (oltre 15)
0,142
Francia
Austria
Ungheria
UK
laddetti
Regressione ITALIA
laddetti
età
ns
0,001
0,001
-0,002 (10%)
0,001
0,030
0,032
0,032
0,005
età
quota laureati
Inv/fatturato
0,001
0,001
0,000
0,000
-0,002
-0,002
0,000
0,000
-0,002
organiz accentrata
-0,001
0,000
0,001
0,055
0,046
0,014
0,016
Exp/Fatt (26-50%)
0,033
0,039
mercati extra-UE
0,000
qualità del prodotto
costante
Exp/Fatt (oltre 50%)
0,111
n prodotti (4-6)
0,051
n prodotti (7-15)
0,082
n prodotti (oltre 15)
0,097
0,017
0,018
n.s.
0,212
0,075
0,063
0,016
-0,001
Osservazioni
R2
1686
7,4
Note:
i coefficienti sono significativi all'1%, salvo diversamente specificato;
la seconda riga riporta lo standard error
0,018
0,021
mercati extra-UE
-0,001
qualità del prodotto
-0,001
0,000
0,000
costante
Osservazioni
R2
0,436
0,245
0,181
0,290
0,014
0,024
0,034
0,053
7785
1,60
7785
3,91
6580
4,70
6300
6,40
Note:
i coefficienti sono significativi all'1%, salvo diversamente specificato;
la seconda riga riporta lo standard error
Regressioni:
A= dummy paese;
B=dummy paesi + dummy settori
C=dummy paesi + dummy settori + caratteristiche impresa
D=dummy paesi+ dummy settori + caratteristiche impresa + strategie di esportazione
La stima con un modello OLS di una variabile binaria presenta
la prerogativa di individuare facilmente il contributo di ciascuna
variabile sulla variabile dipendente, ma dall’altro lato presenta
anche alcuni problemi di natura statistica. La possibilità che
la previsione possa a volte risultare esterna all’intervallo
compreso 0-1, indica che la probabilità non può essere
espressa mediante una relazione lineare per tutti i possibili
valori della variabile indipendente, un’altra caratteristica di
questa metodologia è costituita dal fatto che potrebbe venir
meno potrebbe venire meno l’ipotesi di omoschedasticità delle
varianze degli errori.
2
Vedi anche Rapporto ICE 2009-2010.
1
Rapporto Corporate Efige I 83
Rapporto Corporate
Approfondimenti
L’EFFETTO DELLA CRISI
SULLE IMPRESE DI GRANDI
DIMENSIONI
a cura di Elena d’Alfonso e Silvia Giannangeli
La riduzione del fatturato subita
dalle imprese è stata molto diffusa
sia fra le grandi imprese che fra
le PMI. Nonostante il duro colpo
inferto dalla crisi attraverso il
canale dell'export, le imprese
più grandi hanno sperimentato
riduzioni più contenute sia dal
lato dell'occupazione che degli
investimenti. Il processo di
aggiustamento è diffuso e non
sempre, però, dipende dalla crisi.
Una parte delle grandi imprese ha
di fatto continuato a perseguire
obiettivi di lungo periodo con
investimenti mirati a consolidare
la propria posizione in un mercato
profondamente mutato.
84 I Rapporto Corporate Efige
L’ultimo triennio, in riferimento al quale
sono state effettuate le interviste contenute
nella indagine qui presentata, è stato
segnato, com’è ben noto, dalla più profonda
crisi economica dal dopoguerra ad oggi.
Nell’indagine sono state incluse alcune
domande volte a misurare l’impatto della
crisi e le immediate reazioni delle imprese
nel fare fronte al brusco peggioramento della
situazione economica mondiale. Se infatti le
analisi a livello macroeconomico sono state
numerose, anche e soprattutto grazie alla
quantità di dati disponibili, poche sono state le
considerazioni che si sono potute fare a livello
micro: in questo approfondimento guarderemo
dunque a questa parte della storia.
La discussione dei risultati ha evidenziato
l’impatto della crisi sui diversi aspetti
dell’attività delle imprese italiane,
confrontandole con quanto avvenuto negli
altri paesi considerati nell’indagine.
In questo approfondimento adotteremo un
punto di vista diverso e ci concentreremo
su quanto avvenuto nel tessuto “large
corporate”.
La vista sulle grandi imprese ci permette, infatti,
di verificare quali sono stati i cambiamenti
prodotti dalla crisi su una parte importante
del sistema manifatturiero che, come emerge
dall’indagine, è anche quella che ha operato
negli scorsi anni strategie più elaborate in
termini di rapporto con i mercati esteri e che
potrebbero pertanto scontare in maniera
diversa dalle altre una crisi che è stata a tutti
gli effetti globale. L’obiettivo dell’analisi è di
valutare se le imprese di grandi dimensioni, per
loro natura più attive sui mercati esteri, abbiano
subito una caduta del fatturato più intensa a
causa del brusco calo delle esportazioni e quali
reazioni esse abbiano messo in atto a fronte
di un’eventuale diminuzione dell’operatività. In
particolare, è interessante valutare quali siano
state le decisioni in termini di impiego dei fattori
produttivi, sia forza lavoro che investimenti in
capitale materiale ed immateriale. In questo
contesto, valuteremo se il supporto pubblico
abbia influenzato le decisioni di taglio alla
spesa delle imprese. Mentre il colpo della crisi
è stato forte, infatti, non tutte le grandi imprese
sembrano aver reagito in modo “difensivo”,
adottando cioè strategie di taglio alla spesa e
riduzione degli investimenti. C’è, al contrario,
chi ha continuato ad investire nonostante tutto.
Indagheremo in particolare queste imprese
guardando alla relazione banca-impresa che
le caratterizza, e cercando di rispondere alla
domanda se ad una migliore risposta alla crisi
corrisponda anche una più intensa relazione
con la banca, in grado di supportare nel
contesto di una profonda crisi economica e
condizioni del credito difficili.
Analizziamo quindi il database Efige,
concentrando l’attenzione sulle imprese con
un fatturato superiore a 50 milioni di euro nel
2008. Nel complesso 914 imprese su 14911
intervistate, superano questa soglia,
di cui 184 italiane.
L’impatto della crisi sulle grandi
imprese
Guardiamo innanzitutto alle indicazioni
che danno le imprese sulla situazione dei
loro risultati nel corso del 2009: la crisi
ha colpito in maniera diffusa la grande
maggioranza del campione, e vi è poca
differenza tra imprese di grande dimensione
- che hanno sperimentato cadute di fatturato
nel 69,1% dei casi - e la totalità delle
interviste - in cui ci sono state perdite per il
69,7% delle imprese.
Percentuale di imprese che hanno subito perdite di fatturato nel 2009 (%)
Grandi imprese
Campione complessivo
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Spagna
Italia
Francia
Germania Regno Unito
Anche la modalità con cui le grandi imprese
operano sui mercati esteri è sensibilmente
diversa dalle altre: il business estero conta
infatti molto, in media il 42,4% del fatturato è
legato alle esportazioni, un livello che supera di
oltre 10 punti percentuali quello del campione
totale. Ma non solo: le imprese di grandi
dimensioni esportano in più paesi - addirittura
25 in media contro gli 11 del campione
complessivo - e mediamente raggiungono
mercati di sbocco più lontani; sono cioè meno
concentrate nell’Europa a 15 e optano per
destinazioni meno facilmente raggiungibili.
È molto probabile pertanto che il calo
diffuso del turnover sia legato in buona
parte a un calo nelle esportazioni delle
Austria
Ungheria
Totale
imprese. In effetti anche per quanto
riguarda le esportazioni il calo sembra
essere generalizzato alla maggioranza del
campione: il 52% delle grandi imprese
segnala di aver perso fatturato da export,
anche se - come per il calo di fatturato l’intensità della perdita è meno marcata
per le grandi, che segnalano in media di
avere subito un calo del fatturato da export
pari al 22,3% contro il calo dell’intero
campione che è stato indicato pari al 28,3%.
Il dettaglio per paese della diffusione e
dell’intensità media delle perdite evidenzia
che sono l’Italia e la Francia a soffrire di più,
mentre il commercio estero è andato meglio
in Germania e Regno Unito.
Numero di imprese che hanno ridotto le esportazioni e entità della riduzione
27
Intensità della riduzione (% del fatturato)
L’Italia ha mostrato una situazione poco
diversa dal resto delle realtà europee; le
perdite sono state ancora più diffuse - il
72,6% delle imprese ha sperimentato cali di
fatturato - con una situazione solo di poco
migliore nel caso delle grandi.
Le grandi imprese appartenenti al campione
non riportano dunque una situazione
molto migliore di quanto si vede a livello
complessivo. Ciononostante, dal lato dell’entità
del calo, le cose sembrano essere andate un
po’ diversamente: il numero di grandi imprese
che ha perso più del 30% del proprio fatturato
è pari al 19,4%, mentre la quota sale a 24,9%
nel campione complessivo.
Anche per le grandi ci sono state dunque
perdite diffuse; esse sono però riuscite a
“arginare i danni”, e quindi a limitare la caduta
del fatturato. Questo indica una maggiore
solidità delle imprese di grandi dimensioni.
Nel corso del 2008, il primo canale
attraverso cui la crisi ha avuto diffusione
è stato il commercio internazionale che
ha subito un rapido tracollo - di circa il
20% - tra l’agosto e il gennaio dell’anno
successivo. Le imprese internazionali, e le
esportatrici in particolare, sono state dunque
quelle colpite più duramente, almeno in una
prima fase. Al di sopra di una certa soglia
dimensionale la larghissima maggioranza
delle imprese è presente su mercati esteri;
nel nostro campione le imprese con oltre
50 milioni di fatturato sono esportatrici
nell’86% dei casi (contro il 67% nell’intero
campione), quota che sale ad oltre il 90%
(92,6%) in Italia.
25
ITALIA
23
21
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
AUSTRIA
19
REGNO UNITO
17
15
40
45
50
55
60
Numero di imprese che hanno ridotto l’export (%)
Rapporto Corporate Efige I 85
Rapporto Corporate
Per verificare il peso relativo delle variabili
fino a qui commentate tenendo conto anche
della specializzazione settoriale, abbiamo
stimato tre modelli probit.
Ridi=β0+β1Grandii + γ1Austria +
...+γ6Regno Unito + ω1Settore2+
+ω9Settore10 + εi
dove Rid rappresenta, nelle tre varianti
stimate e riportate in tabella, una variabile
dicotomica che assume valore 1 se
l’impresa ha sperimentato un perdita del
fatturato nel 2009 nel primo caso, una
perdita superiore al 10% nel secondo
caso, una perdita invece del fatturato da
esportazioni nel terzo caso; Grandi è un
indicatore che assume valore 1 quando
l’impresa i supera la soglia dimensionale
dei 50 milioni di fatturato. Le altre variabili
incluse sono dicotomiche e catturano gli
effetti fissi legati al paese e al settore
industriale di appartenenza.
La prima colonna della tabella stima la
probabilità di essere incorsi in una perdita
del fatturato nel corso del 2009: come
visto anche dalle semplici descrittive
tale probabilità è positivamente e
significativamente correlata all’essere
esportatori, caratteristica che impatta in
Approfondimenti
maniera ancora più elevata sulla probabilità
di un calo del fatturato, come si nota dalla
seconda colonna della tabella. Le grandi
imprese, mostrano inoltre di avere sofferto
più delle altre, anche se le imprese con un
fatturato superiore a 50 milioni aumenta
solo di poco la probabilità di perdite e
diventa del tutto non significativa quando si
guarda alle perdite superiori al 10%, indicato
nella seconda colonna. Nell’ultima colonna
viene infine valutato in termini probabilistici
il calo delle esportazioni: anche in questo
caso le imprese di dimensioni maggiori sono
quelle che hanno una più alta probabilità di
sperimentare cali nell’export. La regressione
mostra inoltre che il coefficiente associato
all’essere grandi imprese raddoppia rispetto
all’effetto che aveva sulla probabilità di
sperimentare perdite di fatturato, risultato
che conferma nuovamente il peso che
hanno avuto le perdite nelle esportazioni
sulle imprese di maggiori dimensioni.
Una evidenza comune a tutti e tre gli esercizi
è che, anche tenendo conto degli effetti
settoriali attraverso l’utilizzo di dummy, gli
effetti paese rimangono sempre significativi:
posta la Germania come benchmark, i dati
evidenziano che sia in termini di fatturato
che di esportazioni le imprese di questo
paese hanno sofferto meno delle altre.
In particolare, una volta depurati i risultati
dagli effetti di settore, sono Spagna e
Ungheria a segnalare le maggiori perdite
nell’export. Questo suggerisce che in
Italia, dove si erano notate grosse perdite
a livello complessivo, parte del crollo nelle
esportazioni sia legato alla composizione
settoriale delle imprese manifatturiere.
In generale sembra comunque che per le
grandi imprese le difficoltà siano legate
in maniera rilevante alla loro esposizione
all’estero e che, oltre alle specificità
settoriali, ci siano delle differenze a livello di
paese che potrebbero essere guidate dagli
interventi pubblici messi in atti dal governo
per fronteggiare la crisi economica.
L’indagine include alcune domande
specifiche relative al supporto pubblico, che
abbiamo utilizzato per vedere se il supporto
pubblico - introdotto massicciamente da
gran parte dei paesi durante il 2009 - abbia
sortito gli effetti benefici per le imprese e
contribuisca dunque a spiegare eventuali
differenze nella reazione alla crisi delle
imprese localizzate in paesi differenti.
Anche in questo caso abbiamo stimato una
probit1 che evidenzia come le grandi imprese
siano quelle che con più probabilità riescono
Stime dei modelli probit
PROBABILITÀ DI AVERE
SPERIMENTATO UN CALO DI
FATTURATO
IMPATTO SU:
PROBABILITÀ DI AVERE
SPERIMENTATO UN CALO DI
FATTURATO SUPERIORE AL 10%
Esportatori
+ 4.2%
+ 6.5%
Grandi Imprese
+ 2.7%
n.s.
+ 5.6%
Austria
=
=
=
Francia
+ 4.9%
+ 13.8%
+ 16.1%
Ungheria
+ 11.6%
+ 19.8%
+ 17.2%
Italia
+ 10.3%
+ 14.9%
+ 12.2%
Spagna
+ 18.5%
+ 26.9%
+ 13.0%
+ 2.8%
+ 6.3%
=
Regno Unito
PROBABILITÀ DI AVERE
SPERIMENTATO UN CALO DEL
FATTURATO DA ESPORTAZIONE
Nota: L’analisi include variabili dicotomiche per 10 settori industriali, i cui coefficienti stimati non sono riportati in tabella per brevità. La tabella riporta gli effetti marginali espressi in punti percentuali, anziché
i coefficienti stimati dalla procedura econometrica (OLS nel caso la variabile sia espressa in termini percentuali, probit nel caso in cui sia dicotomica). ns: non significativo; =: effetto marginale quasi nullo,
benché statisticamente significativo.
86 I Rapporto Corporate Efige
ad accedere agli incentivi, ma come atteso,
la maggior parte della differenza viene colta
dalle dummy di paese che individuano la
Germania come il paese dove le imprese
accedono a meno incentivi, seguiti
dall’Ungheria e dall’Italia. Sono viceversa
Spagna ed Austria i paesi in cui un maggior
numero di imprese intervistate dichiara di
avere ricevuto supporto pubblico.
Come si mostrerà nella prossima sezione,
però, gli incentivi non sembrano avere avuto
un ruolo decisivo nell’impatto della crisi sui
profitti delle imprese, probabilmente anche
per via del ritardo che è naturale ci sia tra
introduzione delle misure di sostegno e
effettivo risultato sui dati di impresa.
I cambiamenti strategici nelle
grandi imprese all’indomani
della crisi
La capacità delle imprese sembra essere,
dunque, quella di adattarsi velocemente alla
situazione riorganizzando il proprio input mix.
In questo paragrafo verificheremo come le
grandi imprese hanno deciso di riorganizzare
il capitale - materiale e immateriale - e
la forza lavoro e verificheremo quanto
su questo hanno pesato gli strumenti di
supporto pubblico.
Partiamo dall’occupazione: una delle
risposte immediate alla crisi, messe in atto
dalle grandi imprese italiane ed europee,
è stata una considerevole riduzione del
numero degli occupati. Le riduzioni della
forza lavoro hanno infatti interessato un
ampissimo numero di imprese: fra queste vi
sono anche imprese che non risultano aver
subito perdite di fatturato a causa della crisi.
Il processo di riorganizzazione è quindi molto
diffuso e talvolta prescinde dall’impatto
della crisi. Il calo dell’occupazione registrato
nelle grandi imprese appare tuttavia più
contenuto: rispetto al campione nel suo
complesso, le imprese di grandi dimensioni,
sebbene severamente colpite dalla crisi,
mostrano una maggior tenuta sotto il
profilo della forza lavoro, con un calo
dell’occupazione mediamente inferiore
(13,5% versus 16,5%) e un maggiore
ricorso a riduzioni di carattere temporaneo
(26% versus 21%). È da sottolineare, inoltre,
che la ristrutturazione della forza lavoro può
talvolta non essere una risposta alla caduta
del fatturato: il 19,5% delle grandi imprese
riduce i propri livelli occupazionali anche se
non ha sofferto di alcuna perdita legata alla
crisi.
Le grandi imprese italiane, in particolare,
sono state meno interessate dalla riduzione
dei livelli occupazionali, sia in termini di
diffusione che di intensità: il 45,9% delle
grandi imprese del nostro Paese ha infatti
ridotto l’occupazione, contro una media
del 48,1% nei sette paesi considerati.
Anche l’entità della riduzione è stata in
Italia inferiore alla media (12,3%, il livello
minimo fra i paesi, contro il 13,5% nel
campione complessivo). La riduzione
dell’occupazione ha natura permanente
nella grande maggioranza dei casi: tuttavia,
il 26% delle grandi imprese nei sette paesi
considerati dichiara di ridurre il numero dei
propri addetti in modo solo temporaneo.
A tale proposito, è da sottolineare come la
scelta fra riduzioni temporanee e permanenti
possa essere determinata, oltre che dalla
natura delle esigenze delle imprese,
anche dai diversi sistemi di welfare e
protezione sociale in essere nei vari paesi.
Interessante notare come, ad esempio, in
Italia e Germania, dove è agevole ricorrere
a strumenti di riduzione solo temporanei,
come la Cassa Integrazione Guadagni e
il kurtzarbeit programme, le riduzioni di
natura temporanea sono più frequenti
(rispettivamente il 34,8% e 32,1%), mentre
in Spagna tale percentuale si riduce a
17,6% ed in Francia a 13,3%.
Le grandi imprese rispondono alla crisi
economica non solo riducendo la loro
forza lavoro, ma anche ridimensionando
gli investimenti, sia in attività materiali
(macchinari, impianti e ICT) che immateriali,
come la ricerca e sviluppo.
Nel complesso, le imprese di grandi
dimensioni mostrano nel corso del 2009
una maggiore stabilità, evidenziando
una minore contrazione della spesa in
investimento in beni capitali in termini di
entità, ma di nuovo non di diffusione.
Nel 2009 la riduzione dell’investimento in
macchinari, impianti ed ICT delle grandi
imprese ha interessato infatti una quota
elevata di grandi imprese (43,9% contro
39,1% nel campione complessivo). In
termini di entità della contrazione, tuttavia,
le imprese di grandi dimensioni risultano
ridurre la spesa per investimento in media
dell’8,1% (contro una media del campione
Le variazioni della forza lavoro delle grandi imprese nel 2009 (%)
Reduction
Equal
Increase
70
60
50
40
30
20
10
0
AUT
FRA
GER
HUN
ITA
SPA
UK
Total
Rapporto Corporate Efige I 87
Rapporto Corporate
complessivo pari a 10,5%). Le differenze
fra i sette paesi considerati nell’analisi non
sono tuttavia trascurabili, soprattutto per
quanto riguarda la diffusione delle decisioni
di contrarre gli investimenti: in Italia ed in
Germania la percentuale di grandi imprese
che riduce i propri investimenti in capitale
fisico è fra le più basse (rispettivamente, il
37,2% ed il 36,7%), mentre tocca i livelli
più alti fra le grandi francesi e spagnole
(56,6% e 60,1%). Al contrario, l’entità della
contrazione appare simile fra paesi, ed è
pari a 7,3% nelle grandi imprese italiane.
La quota di imprese al di sopra di 50
milioni di fatturato interessata nel 2009
da riduzioni della spesa per investimento
in innovazione appare complessivamente
inferiore a quanto registrato sugli
investimenti in beni materiali. In aggiunta,
le grandi imprese risultano essere meno
toccata dai tagli all’innovazione: solo il 30%
decide di posticipare progetti innovativi,
mentre tale quota sale a 35% nel campione
complessivo. Nel contesto dei sette paesi
considerati, le italiane mostrano una
maggiore tenuta rispetto alla media anche
sotto il profilo dell’innovazione, che è stata
ridotta dal 27,7% delle imprese di grandi
dimensioni.
I risultati discussi finora sembrano dunque
suggerire che, nonostante il colpo inferto
dalla crisi nel biennio 2008-2009 all’attività,
soprattutto estera, delle grandi imprese,
queste hanno mostrato una capacità di
tenuta superiore alle imprese più piccole.
Non solo, infatti, il taglio della spesa in
investimenti fissi è stato minore, ma
anche l’attività innovativa sembra aver
subito di meno il colpo della crisi. Questa
complessivamente maggiore stabilità negli
investimenti può essere legata a costi di
aggiustamento potenzialmente elevati nel
caso di investimenti su ampia scala. D’altro
canto, essa potrebbe essere il risultato
di una effettiva capacità delle imprese
più grandi di continuare ad investire per
costruire o consolidare la propria posizione
88 I Rapporto Corporate Efige
Approfondimenti
Grandi imprese che riducono gli investimenti in capitale fisico
e innovazione nel 2009 (%)
Innovazione
Macchinari, Impianti ed ICT
70
60
50
40
30
20
10
0
Austria
Francia
Germania
Ungheria
sul mercato. Investire in macchinari ed
ICT, così come in attività innovative è, di
fatto, parte integrante del core business
di queste aziende (in Italia, ad esempio, il
91,9% e l’80,8% delle grandi imprese fa
investimenti in beni capitali e innovazione
nel triennio 2007-2009 contro una media
nazionale rispettivamente di 80,5% e
52,8%) ed è quindi possibile che, anche
di fronte ad una crisi molto profonda, le
regole della competizione internazionale a
cui queste imprese sono esposte “domandi”
un maggiore committment sulle attività di
investimento.
Sia le variazioni introdotte nella forza lavoro
che negli investimenti presentano tuttavia
sostanziali differenze fra paesi. A che cosa
sono dovute? Oltre alle specificità nazionali,
tipicamente riassunte negli “effetti paese”,
è possibile che esistano altri fattori in gioco.
Fra di essi, oltre alla riduzione di fatturato
sofferta a causa della crisi, vi è ovviamente
il settore industriale in cui l’impresa opera.
Un altro fattore potenzialmente in grado di
moderare l’impatto della crisi sulla riduzione
dell’occupazione o degli investimenti è
l’utilizzo degli strumenti di supporto messi
in campo dalle istituzioni pubbliche. Per
valutare se le grandi imprese siano più
inclini ad adottare strategie di taglio alla
spesa (sia sotto forma di riduzioni del
Italia
Spagna
Regno Unito
Totale
personale che di taglio agli investimenti
materiali o immateriali), controllando per
eventuali effetti paese, per la composizione
settoriale, per la perdita di fatturato subita
e per l’utilizzo di strumenti di supporto
pubblico, stimiamo il seguente modello:
Ridi=β0+β1Grandii + β2Perditai + β3Pubblicoi
+ γ1Austria + L +γ6Regno Unito +
ω1Settore2 + L +ω9Settore10 + εi
dove Rid rappresenta in ognuna delle
specifiche una tipologia di taglio alla spesa
diverso: nei primi due casi (le cui stime
sono riportate nelle prime due colonne in
tabella), analizziamo la riduzione in termini
percentuali dell’occupazione e della spesa
in macchinari ed ICT, mentre nel terzo caso
guardiamo ad un indicatore dicotomico
che assume valore 1 quando l’impresa i
decide di ridurre l’innovazione nel 2009
(terza colonna in tabella); Grandi è un
indicatore che assume valore 1 quando
l’impresa i supera la soglia dimensionale
dei 50 milioni di fatturato; Perdita è una
variabile dicotomica che indica se l’impresa
i ha subito una riduzione di fatturato nel
2009; Pubblico è una dummy che indica
se l’impresa ha ricevuto supporto pubblico.
Le altre variabili incluse sono dicotomiche e
catturano gli effetti fissi legati al paese e al
settore industriale di appartenenza. Per la
Stime dei modelli probit
RIDUZIONE
DELL'OCCUPAZIONE (%)
IMPATTO SU:
RIDUZIONE DELLA SPESA IN
MACCHINARI E ICT (%)
DECISIONE DI RIDURRE
L'INNOVAZIONE ( 0/1)
-3%
-3%
-4%
Perdita del fatturato
4%
+5%
+19%
Supporto pubblico
ns
ns
ns
Grandi imprese
Prestiti bancari/spesa in macchinari e ICT
+4%
Prestiti bancari/spesa in R&S
=
Austria
+2%
=
=
Francia
=
+4%
+4%
Italia
+1%
=
+16%
Spagna
+5%
=
+6%
Ungheria
+9%
+11%
+20%
Regno Unito
+2%
=
+7%
Nota: L’analisi include variabili dicotomiche per 10 settori industriali, i cui coefficienti stimati non sono riportati in tabella per brevità. La tabella riporta gli effetti marginali espressi in punti percentuali, anziché
i coefficienti stimati dalla procedura econometrica (OLS nel caso la variabile sia espressa in termini percentuali, probit nel caso in cui sia dicotomica). Ns: non significativo; =: effetto marginale quasi nullo,
benché statisticamente significativo.
lettura dei risultati della stima, è necessario
ricordare che la Germania è assunta come
paese di riferimento e gli effetti paese
rappresentano quindi la differenza nella
decisione di ridurre un certo tipo di spesa
rispetto alla media delle imprese tedesche.
Nelle specifiche in cui la variabile dipendente
è la riduzione della spesa in macchinari ed
ICT oppure l’innovazione, il modello include
anche una ulteriore variabile (non riportata
nell’equazione sopra) che mira a catturare
la dipendenza dal credito bancario, e che è
data dalla quota di spesa coperta con prestiti
bancari nel 2007-2009. Chiaramente,
l’ipotesi di lavoro più ovvia era in questo
caso l’esistenza di una relazione positiva fra
la dipendenza dal credito e le decisioni di
ridurre gli investimenti, dato l’impatto che
la crisi ha avuto da subito sulle condizioni di
accesso al credito per le imprese.
La tabella riporta i risultati della stima,
effettuata sull’intero campione delle 14911
imprese dell’indagine. I risultati confermano
che le imprese di grandi dimensioni sono
interessate da riduzioni minori nella forza
lavoro e nella spesa per investimenti in
beni materiali. Allo stesso modo, sono
meno propense a posticipare progetti
innovativi nel corso del 2009. L’aver subito
una perdita di fatturato risulta essere, non
sorprendentemente, un forte driver delle
decisioni di disinvestimento di qualsiasi
tipo. In linea con quanto evidenziato in
precedenza, inoltre, emerge chiaramente
come le imprese italiane si comportino in
modo abbastanza simile rispetto alle tedesche
sotto il profilo della riduzione dell’occupazione
e del disinvestimento in macchinari ed ICT
(a differenziarle maggiormente, semmai, è
la dinamica pregressa degli investimenti nel
triennio 2007-2009, assai più debole nelle
imprese italiane). Una peggiore performance
rispetto alla Germania si osserva invece nella
riduzione dell’innovazione, più diffusa fra le
imprese italiane, al netto degli effetti settoriali.
In aggiunta, è da sottolineare che, come già
accennato più sopra in questo lavoro, nessun
beneficio sembra associato all’aver usufruito
di qualche forma di supporto pubblico.
Interessante appare, inoltre, la pressoché
inesistente relazione fra la dipendenza
degli investimenti dal credito bancario e le
decisioni di disinvestimento.
La relazione delle imprese con le banche
resta tuttavia una questione di interesse
primario: in particolare, è interessante
analizzare il legame fra le strategie
“difensive”, ovvero di taglio alla spesa,
messe in atto dalle imprese e l’intensità della
loro relazione con la banca di riferimento.
La relazione banca-impresa
e le strategie delle imprese
all’indomani della crisi
L’analisi sviluppata sinora ha mostrato che
né la riduzione della spesa per investimenti
in beni materiali, né in innovazione sono
state determinate dall’utilizzo del credito
bancario da parte delle imprese nel triennio
precedente alla crisi. Questo non risponde,
tuttavia, alla domanda se l’intensità della
relazione banca-impresa contribuisca a
determinare il tipo di reazione delle grandi
imprese alla crisi. Di fatto, l’importanza
dei prestiti bancari nel coprire la spesa in
investimento fotografa la capacità delle
imprese ad accedere al mercato del credito,
più che qualificare il tipo di relazione stabilito
con la banca principale. L’ipotesi di lavoro
è, invece, che un più stretto legame con
una banca di riferimento possa aiutare
le imprese, soprattutto in tempo di crisi
Rapporto Corporate Efige I 89
Rapporto Corporate
a continuare ad investire, grazie ad una
maggiore condivisione degli obiettivi di
medio-lungo periodo con i propri finanziatori
principali ed una potenziale maggiore
capacità da parte di questi di valutare le
opportunità ed il potenziale di crescita e
profittabilità oltre la crisi (De Mitri et al.,
2010)2.
È quindi necessario, in primo luogo, definire
una misura dell’“intensità” della relazione
banca-impresa, considerando tre indicatori
di intensità: il numero di banche utilizzate;
la quota di indebitamento con la banca
principale; la quota di investimenti finanziati
con prestiti bancari. In secondo luogo,
categorizziamo il tipo di strategie messe
in atto dalle imprese in base ad una scala
da 0 a 3, dove 0 indica che le imprese non
hanno implementato nessuna reazione
di tipo “difensivo”, mentre valori da 1 a
3 misurano il grado con cui l’impresa ha
perseguito strategie di taglio alla spesa. Le
strategie prese in considerazione sono: i)
una taglio agli investimenti in macchinari
ed ICT; ii) una riduzione dell’innovazione; iii)
una riduzione del numero di prodotti offerti.
La figura mostra come variano gli indicatori
di intensità della relazione banca-impresa
nei vari gruppi distinti in base alla scala
appena definita. Poiché l’obiettivo dell’analisi
è guardare al comportamento delle grandi
imprese significativamente colpite dalla crisi,
ci concentriamo su quelle che dichiarano
una perdita del fatturato superiore al 10%
nel 2009.
Approfondimenti
delle imprese, di fatto, questo può essere
indice di una buona strategia finanziaria e
capacità di ottenere finanziamento esterno.
Da non escludere, inoltre, la maggiore
capacità contrattuale delle imprese di
grandi dimensioni che potrebbe riflettersi
nella possibilità di selezionare fra un
numero elevato di potenziali finanziatori
ottenendo credito a condizioni vantaggiose.
D’altro canto, è da sottolineare come, in
un contesto di aumentata rischiosità, una
prospettiva di più lungo termine possa
“domandare” una più stretta relazione fra la
banca e l’impresa. Grazie ad una maggiore
comprensione delle esigenze finanziarie di
un’azienda, la banca è in grado di offrire
un più appropriato portafoglio di servizi e
strumenti finanziari. Dal punto di vista degli
intermediari creditizi, inoltre, una più stretta
relazione con le imprese potrebbe costituire
una base appropriate per sviluppare appieno
il potenziale di crescita dell’offerta, sia
attraverso strategie di cross-selling che
attraverso un migliore controllo dei rischi.
Tirando le somme di quanto fino a qui
visto, ci sembra di potere delineare per
le grandi imprese un quadro di moderato
ottimismo: a fronte di diffuse perdite
trainate principalmente dal calo del
commercio mondiale, queste imprese hanno
sperimentato riduzioni più contenute sia dal
lato dell’occupazione che degli investimenti.
Un dato positivo sembra senz’altro essere
la diffusione dell’aggiustamento. Non
tutto è però legato alla crisi: c’è chi riduce
l’occupazione anche se non ha ridotto il
fatturato e chi, nonostante severe perdite,
continua ad investire. Sembra quindi che
la crisi abbia innescato un processo di
trasformazione, ma che parte delle imprese
abbia comunque continuato a perseguire
obiettivi di lungo periodo con investimenti
mirati a consolidare la propria posizione
in un mercato profondamente mutato.
Le imprese, che continuano ad investire
nonostante la crisi, mostrano di avere ampio
credito dal mercato bancario, senza tuttavia
legarsi ad un’unica banca di riferimento.
Questo apre una riflessione valida
soprattutto per l’Italia che è fra i paesi in cui
il rapporto fra l’impresa e la banca è tra i più
“diluiti”, come mostrano i dati dell’indagine
presentati nel capitolo precedente.
La relazione banca-impresa e la reazione delle grandi imprese alla crisi (%)
Numero di banche utilizzate
Quota di investimenti finanziata con prestiti bancari (%)
25
Quota di indebitamento verso la banca principale (%)
71
20
20
18
90 I Rapporto Corporate Efige
45
50
44
10
6
5
5
5
70
60
16
15
I dati confermano che le imprese che
reagiscono meglio alla crisi (raggruppate
nella classe 0) hanno ampio accesso al
mercato del credito, perché attraverso
di esso finanziano una più elevate quota
della spesa in investimento. Tuttavia,
esse non sembrano avere una relazione
particolarmente intensa con una “banca
principale”, ma sono anzi caratterizzate
da una minore quota di indebitamento
verso di essa e da un maggiore numero
di banche utilizzate. Dal punto di vista
80
40
36
30
5
20
2
10
0
0
3
2
1
0
P er brevità di esposizione la tabella con i risultati non è riportata
nel testo ed è disponibile su richiesta.
2
De Mitri, S., Gobbi, G., Sette, E., 2010, “Relationship lending
in a financial turmoil”, Banca d’Italia, Tema di discussione n.
772, Settembre.
1
APPENDICE
ASPETTI METODOLOGICI
Questo rapporto utilizza la banca dati sulle
imprese manifatturiere relativa al progetto
Efige (European Firms in a Global Economy),
un progetto di ricerca internazionale,
sotto l’egida della Commissione Europea,
coordinato da Bruegel di Bruxelles, cui
partecipa UniCredit, insieme ad altri sei
partners: Universidad Carlos III di Madrid,
CEPR (Londra), The Institute of Economics of
Hungarian Academy of Sciences (Budapest),
Institute for Applied Economic Research
(Tubinga), Centro Studi Luca d’Agliano
(Milano), Centre d’Etudes Prospectives
et d’Informations Internationales (Parigi).
L’obiettivo del progetto è di disporre di una
base dati comune a sette paesi europei
(Austria, Francia, Germania, Italia, Ungheria,
Spagna, Regno Unito), allo scopo di poter
effettuare studi comparati sulla competitività
delle imprese di tali paesi e di ricavarne
proposte di politica economica.
I dati sono stati raccolti da GFK Eurisko
attraverso i sistemi CATI (Computer Assisted
Telephone Interview) e CAWI (Computer
Assisted Web Interview). Il campione è
costituito da 14.911 imprese, di cui 3.019
per l’Italia, 482 per l’Austria, 2.973 per la
Francia, 488 per l’Ungheria, 2.832 per la
Spagna, 2.142 per il Regno Unito.
Il disegno campionario adottato ha
seguito una stratificazione per settore
e per dimensione d’impresa, tenendo
conto delle principali aree geografiche
di ciascun paese. Al riguardo sono state
considerate quattro classi dimensionali:
10-19 addetti; 20-49; 50-249; oltre
249 addetti.
I settori considerati (Revisione Nace 1.1)
sono i seguenti:
DA
Alimentari e Tabacco
DB + DE
Tessile, prodotti tessili + Carta, Stampa, Editoria
DC + DI + DL
Pelli + Altri minerali non metallici + Apparecchi
elettrici ed ottici
DD
Legno e prodotti in legno
DF
Coke e prodotti petroliferi raffinati
DG
Chimica, prodotti chimici e fibre sintetiche
DH
Gomma e plastica
DJ
Metalli di base e prodotti in metallo
DK
Macchinari e attrezzature
DM
Mezzi di trasporto
DN
Altri settori non classificati
Alle imprese intervistate è stato
somministrato un questionario composto
da sei sezioni: Struttura dell’impresa; Forza
Lavoro; Investimenti, Innovazione tecnologica
e Ricerca e Sviluppo; Internazionalizzazione;
Finanza; Mercato e Prezzi. Ogni sezione
contiene alcune domande sulla crisi. Il periodo
preso in esame è il triennio 2007-2009, il che
consente - per l’Italia - di stabilire la continuità
con le precedenti indagini dell’Osservatorio
sulle piccole e medie imprese.
Qui di seguito si riporta il piano di
campionamento relativo all’Italia.
Italia - Piano di campionamento
DIMENSIONE
TRA 10 E 49 ADDETTI
NACE REV 1.1
DA
DB+DE
DC+DI+DL
DD
DF+DG
DH
DJ
DK
DM
DN
TOTALE
TRA 50 E 249 ADDETTI
OLTRE 249 ADDETTI
TOTALE
CAMPIONE
POPOLAZIONE
CAMPIONE
POPOLAZIONE
CAMPIONE
POPOLAZIONE
CAMPIONE
POPOLAZIONE
196
402
452
83
67
133
571
295
53
193
2.445
6.680
13.259
13.939
3.329
1.650
3.663
18.679
8.211
1.775
5.907
77.092
35
57
80
4
35
24
95
60
13
26
429
773
1.481
1.859
212
536
612
1.876
1.599
435
679
10.062
7
22
22
1
14
12
20
25
14
8
145
122
200
248
15
150
71
168
242
137
55
1.408
238
481
554
88
116
169
686
380
80
227
3.019
7.575
14.940
16.046
3.556
2.336
4.346
20.723
10.052
2.347
6.641
88.562
Rapporto Corporate Efige I 91
Rapporto Corporate
NOTES
92 I Rapporto Corporate Efige
Il Rapporto Corporate è pubblicato come allegato a Scenari Economici: Autorizzazione n. 143 rilasciata il 29 Febbraio 1992 dal Tribunale di Milano.
La presente pubblicazione (in seguito Documento) è opera di UniCredit SpA, è impegnata in numerose attività finanziarie aventi ad oggetto strumenti finanziari collegati alle variabili descritte nel Documento.
In particolare UniCredit SpA, possono prendere posizione o agire come market maker sugli stessi strumenti finanziari. Il Documento ha finalità puramente informative e non rappresenta né un’offerta né una
sollecitazione ad effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Il Documento è destinato ad essere distribuito via posta, elettronica o ordinaria, e non può essere ridistribuito, riprodotto
o pubblicato in alcuna delle sue parti. Le informazioni, le opinioni, le valutazioni e le previsioni contenute nel Documento sono state ottenute o derivano da fonti che UniCredit SpA ritiene attendibili, ma che non
costituiscono in alcun modo una forma di garanzia, sia implicita sia esplicita. Pertanto UniCredit SpA non si ritiene responsabile della loro accuratezza o della loro completezza.
www.mercurioitaly.it