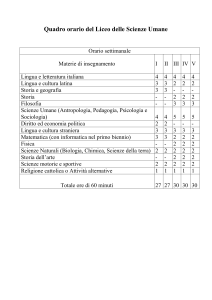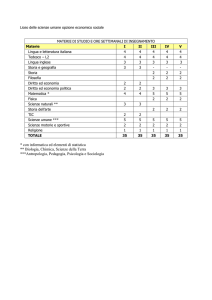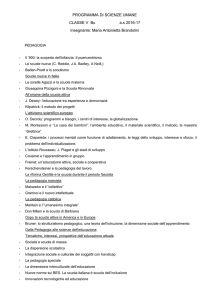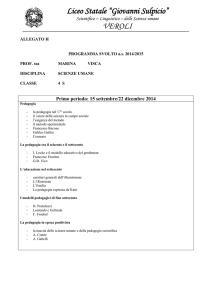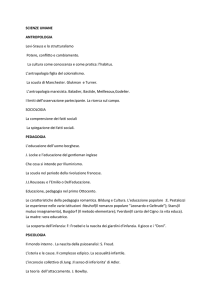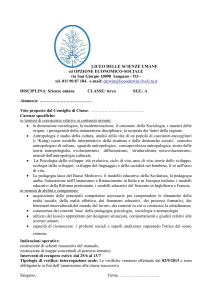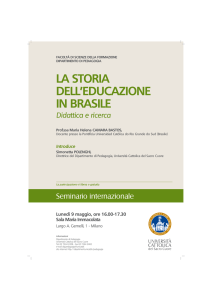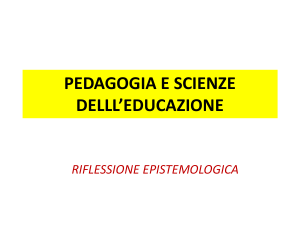BRECHT
Me-ti, il libro delle svolte
Del dubbio
Do, scolaro di Me-ti, sosteneva la tesi che bisogna dubitare di
tutto quel che non si vede con i propri occhi.
Egli fu rimproverato per questo punto di vista negativo e
abbandonò insoddisfatto la casa.
Dopo breve tempo tornò indietro e disse sulla soglia: "Devo
correggermi. Bisogna dubitare anche di ciò che si vede con i
propri occhi".
Essendogli stato chiesto che cosa ponesse un limite ai dubbi,
Do disse:
Il desiderio di agire
1
"La defuturizzazione come caduta
di progettualità derivante da
− dipendenza protratta dalla famiglia,
− difficoltà ad immaginare un percorso di
inserimento nel lavoro
− difficoltà a realizzare relazioni affettive"
2
Pedagogia
"Qualsiasi attività svolta da una persona con lo scopo
di sviluppare effettivi apprendimenti in un’altra
persona”
Raynal F., Rieunier A., Pédagogie: dictionnaire des concepts clés.
ESF Ed,Paris,1997)
3
Differenza
"E' ciò che
− distingue,
− fa diversi,
− discrimina cose e soprattutto persone.
Ci sono ovviamente delle differenze di tipo
...biologico, come quello sessuale...; ma ci sono
anche e soprattutto differenze economiche,
culturali e politiche, ecc.
L'utilizzazione positiva della differenza, così,
rappresenta oggi uno degli obiettivi
pedagogici...di
maggiore
importanza
e
significatività "
(Bertolini P., Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione.
Zanichelli, Bologna, 1996)
4
pedagogia
ed
antropologia culturale
pedagogia delle differenze
"Ogni uomo che interagisca
con un altro uomo si pone in un rapporto
pedagogico
d'insegnamento-apprendimento;
ed ogni rapporto ha significato perché c'è
sempre una antropologia che agisce da
significante (p.48)
La nostra epoca ...
sembra votata ad esplorare
le differenze (p.263)
5
Nella società occidentale contemporanea
...(sono) evidenti
due tensioni opposte
- da un Iato una tendenza a rendere
universali
valori,
linguaggi,
beni,
significati;
- dall'altro una tendenza
specificare, separare."
a riservare,
(Callari Galli M.,Antropologia culturale e processi educativi. La Nuova
Italia,Scandicci (FI), 1993)
6
La pedagogia delle differenze si occupa di
ciò che,
Ieri, rimaneva invisibile:
- il bambino,
- Ia donna,
- il disabile,
- Ia persona stigmatizzata.
l'oggetto di studio della pedagogia delle
differenze sono le situazioni di svantaggio
sociale, oppure di vulnerabilità sociale.
7
Obiettivi formativi del corso
1. rinforzare la capacità di lettura dei fenomeni
derivanti dalle "differenze"
2. individuare strategie pedagogiche che
fanno un uso costruttivo delle differenze,
3. accrescere le proprie conoscenze sulle
ricadute sociali della dimensione di genere,
4. concatenare i concetti di disagio con quelli
della pedagogia delle differenze
8
4 moduli
1. Identità e differenze
2. Costruzione sociale del femminile e del
maschile
3. Disagio, dimensione di genere e rapporti
educativi
4. La pedagogia delle differenze può "fare la
differenza"?
Possiamo delineare delle buone pratiche
per la promozione del benessere
apprenditivo del/della preadoloescente?
9
I concetti base del corso
In più dei concetti di differenza e di
pedagogia altri termini puntellano le nostre
riflessioni
- la conoscenza,
- sistema sociale
- la rappresentazione sociale,
- la decostruzione,
- l'identità o più precisamente le identità
plurime
10
La conoscenza
L'idea di una reaItà in sé, consistente e
separata dal processo conoscitivo,
è stata messa fra parentesi
la conoscenza non è più pensata come
adeguazione al dato ma come costruzione ...
intersoggettiva di significati
Questa svolta metodologica riporta un
indice di questionabilità alle conoscenze già
acquisite e date per scontate
Maria Armezzani, Esperienza e significato nelle scienze psicologiche, Laterza,
Roma/Bari, 2002
11
sistema sociale
(Secondo Luhmann)
"il sistema sociale non viene visto come un
insieme di individui
ma
come un insieme di azioni.
L'agire è la cellula dell'organismo sistema
sociale, non l'individuo".
(Bisio c., Costruzione della realtà e formazione, FrancoAngeli, Milan, 1998,p.24)
12
Rappresentazione sociale
Le rappresentazioni sociali sono "teorie
ingenue, proprie del senso comune, che
esprimono
- sistemi di valori,
- convinzioni
- e norme di comportamento
dotati
della duplice funzione
di organizzare la percezione del mondo
e
di servire da codice condiviso per la
comunicazione sociale e gli scambi
interpersonali"
(Polmonari A., Atteggiamenti e rappresentazioni sociali, in Trenti R. ,Gli
atteggiamenti sociali: teoria e ricerca, Bollati Boringhieri, Torino, 1991)
"Le
rappresentazioni
sociali
sono
rappresentazioni che un gruppo, più o meno
esteso, condivide circa un oggetto, una
13
persona, un evento, un'idea.
Hanno una funzione di mediazione tra ciò
che è il livello individuale nel rappresentare
il mondo ed il livello collettivo.
Esse si formano quando un gruppo deve
attribuire un significato ad una cosa ignota,
e ciò avviene facendo ricorso a ciò che è
familiare -(si parla di) ancoraggio - e
raffigurabile
(processo
denominato)
oggettivazione"
(Bisio C. Costruzione della realtà e formazione, FrancoAngeli, Milan, 1998,p.26)
14
Decostruzione
(Derrida)
designa un atteggiamento
culturale "post-moderno".
La decostruzione rappresenta uno
strumento critico di smontaggio
di termini "alti e gerarchici"
(che ordinano gli altri termini)
consolidati nel tempo
attraverso un processo
di relativizzazione,
storicizzazione
e contestualizzazione.
15
La decostruzione conviviale
intesa come
sospensione e/o relativizzazione del
pregiudizio,
dialogo
e
ricerca
fondati su un comune non sapere iniziale
e sulla molteplicità delle strade possibili
da percorre insieme.
.La decostruzione può introdurci verso
nuovi fondamenti conviviali di solidarietà,
attraverso i quali, nell'umiltà del molteplice,
imparare ad esistere.
("La sfida della mondialità e della interculturalità. Contadini M., Bevilacqua G..
Elledici,2001)
16
Identità
Con questo termine si intende definire
l'autorappresentazione e la percezione di sé
come
un
soggetto
unitario,
con
caratteristiche e qualità
.stabili,
.permanenti
.e diverse da quelle altrui
Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione. P.Bertolini. Zanichelli,
Bologna, 1996)
17
(Tuttavia oggi negli ambiti delle scienze umane)
l'identità
(ha perso)
il suo valore di essenza,
(è diventato)
più un punto di riferimento che una realtà ...
l'identità non è ...data,
è ...soprattutto
un processo, una meta
da accertare
e da acquistare,
(non è)
mai
un valore statico e scontato.
(Antropologia culturale e processi educativi. La Nuova Italia,Scandicci (A),
1993)
18
L'identità
non è data una volta per sempre,
ma si costruisce e si trasforma
durante tutto l'arco della vita.
Si parla oggi di identità plurima,
non più di identità singola.
Il meccanismo sottostante al modellamento continuo delle
identità deriva dal senso di "appartenenza"
19