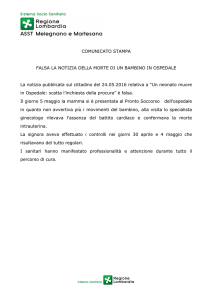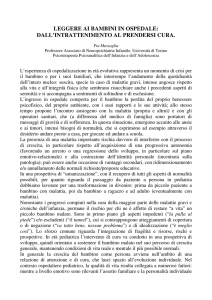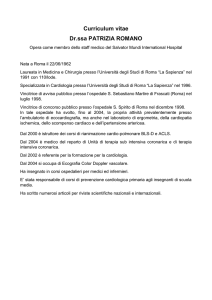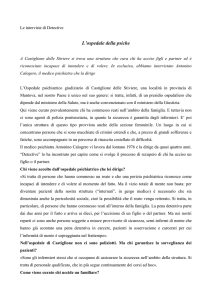L’architettura dell’ospedale psichiatrico come sintomo dell’evoluzione recente della città. Da: Architettura e psichiatria. L’ospedale: spazio di cura , spazio urbano. Atti del ciclo di colloqui Tumulto e silenzi della psichiatria tenuto presso il Centro Thomas More (convento domenicano de la Tourette) Ed. La ferme du Vinatier Parigi 2001 Jean –Paul Dollé Filosofo, professore alla Scuola di Architettura dei Parigi La Villette (traduzione dal francese, Giuseppina Scavuzzo) Se mi interesso di città in quanto filosofo, indipendentemente dalla mia funzione di professore dentro una scuola di architettura, è perché penso che la questione della città sia una questione strategica in questo momento, e che, da un certo punto di vista, è la questione fondamentale: il vivere insieme. D’altra parte, la psichiatria non mi è totalmente estranea, poiché come un gran numero di persone della mia generazione sono stato estremamente interessato – la parola è debole – appassionato di psicanalisi, dell’insegnamento di Lacan, e poi per tutto ciò che intorno alla fine degli anni sessanta – inizio degli anni settanta, si è chiamato movimento antipsichiatrico. Questo per inquadrare, come si diceva allora, “da dove parlo”. Vorrei provare a vedere qui come ci sia una specie di tensione e di articolazione sintomatica , sintomatologica, di collegamento, tra ciò che si fa in un ospedale psichiatrico – ma ugualmente ciò che si spera accada o al contrario ciò di cui si ha paura, ciò che si esclude, ciò che si allontana -­‐ e dall’altro lato ciò che si fa – o si vuole fare o non si fa – in quella che chiamiamo “la città”. Ciò che vorrei esaminare sono le relazioni estremamente appassionate, appassionanti, arricchenti, conflittuali, solidali tra l’uno e l’altro. L’ospedale psichiatrico si concepisce, si articola e si proietta in rapporto al suo intorno che è la città, nel XX sec. –mi atterrò a questo periodo per non dovermi rifare alla storia in generale e passerò in rassegna molto velocemente il XIX sec. Perché credo che tutto ciò che Foucault ha detto sull’internamento è molto noto. Dunque come c’era e come c’è oggi un’interazione tra i due poli, e come ciò che accade nell’uno è segno, senso, o fa da barriera all’altro. Si può dire, per andare veloci e secondo il mio punto di vista, che ci sia una perpetua dialettica circolare. Per esempio dal momento che l’ospedale psichiatrico pensa di trovare la sua verità, il suo compimento, il suo senso, nell’uscita del malato, in un primo tempo gli operatori dell’ospedale si posizionano in rapporto a questo, e tutti i loro sforzi consistono nel far sì che coloro che essi trattano, di cui si prendono cura, si persuadano che non ci sia altra destinazione e finalità che uscire dall’ospedale. Dunque si può dire che, riprendendo le parole di Hegel nella Fenomenologia dello spirito, che il momento del manicomio trova la sua verità in ciò che non è, e che non ha altra vocazione che precisamente di alienarsi in un suo altro e questo altro è il fuori, beninteso, e dunque la socialità, rappresentata da chi vive nella città. In questo senso la storia della psichiatria non tende che finire con l’internamento. Tutto lo sforzo della psichiatria consisterà nel negare se stessa, nell’aprire ciò che ha internato. L’apertura consiste nell’abbattere dei muri alti. L’ospedale psichiatrico, situato all’interno della città o nella sua periferia più vicina, punta ad abolire questa separazione radicale tra dentro e fuori. Vivere bene dentro l’ospedale non si può concepire che se giustamente questo dentro non è vissuto e organizzato per un fuori futuro. Là c’è tutto il movimento riformatore della psichiatria, che prende l’avvio in Francia e in Europa, integrandosi in un movimento generale, in particolare dopo la 2° Guerra Mondiale , dopo la Resistenza. Perché in questa Europa occupata, internata, un certo numero di psichiatri ha compreso che ciò di cui si occupavano (i malati, i folli internati) erano da un certo punto di vista il punto più avanzato, la verità di questa “società del controllo” – per usare un concetto di Foucault-­‐ che aveva mostrato la sua faccia più mostruosa, più odiosa, ma anche finalmente più chiara, la meno ipocrita, in questo fenomeno mostruoso del totalitarismo dei campi di concentramento, per cui dentro questo processo di esclusione generalizzata, la distruzione e l’annientamento di un certo numero di persone “ di troppo”, che non aveva diritto di esistere in quanto tale nel delirio nazista, c’era un posto specifico riservato ai malati mentali. I malati mentali, come gli ebrei e gli zingari, erano “di troppo”, andavano eliminati. A partire da lì un certo numero di psichiatri si rende conto che, infatti, la psichiatria e l’ospedale non potevano pensarsi fuori da ciò che la guerra ha rivelato, in tutta la sua fredda e mostruosa verità, che sottintendeva il fatto che nel cuore della società liberale, democratica, repubblicana, c’era un luogo in cui c’era una popolazione “di troppo”, e che bisognasse ripensare dunque questa situazione in una prospettiva generale democratica. È tutto il movimento, dopo il ‘45, verso una rifondazione della definizione di malato mentale e soprattutto del fatto che può dire qualcosa sullo stato generale della società, che è il sintomo della salute della società. La salute mentale non riguarda solo i malati e chi li ha in cura, perché la malattia mentale è l’indice dello stato della società e della sua salute democratica. Da cui il fatto, ancora una volta, che da un certo punto di vista, c’è un doppio movimento, che da una parte considera che l’atto di guarigione consista giustamente nel reintegrare, nel riinserire il malato mentale, il folle, nel consesso della città, e che d’altra parte questa reintegrazione allo stesso tempo ha per conseguenza che la società deve pensarsi e pensare il suo orizzonte di sviluppo in modo tale da poter integrare i malati mentali. Non è semplicemente il fatto che il dentro nega se stesso abolendo i muri alti, a volte materializzati architettonicamente ma a volte ugualmente in senso metaforico –bisogna che strutturalmente la società, la stessa società democratica, includa nel suo modo di esistere e nel suo modo di aggiornarsi il fatto che abbia prodotto questo luogo di relegazione , di internamento e di silenzio. L’internamento riguarda questa popolazione che a parte, “di troppo”, rispetto alla normalità che definisce o definirebbe un contratto sociale democratico, repubblicano. Per uscire da questo internamento bisogna ammettere che la società stessa produce l’internamento: non solo negli ospedali psichiatrici né nei luoghi più manifesti di internamento, cioè la prigione, ma anche in altri luoghi che, benché la loro vocazione non sia esplicitamente manifesta, funzionano in questa logica di internamento. Si sa che questa dialettica è stata posta negli anni ‘60 nella famosa triade teorizzata da qualcuno il cui nome oggi è forse sconosciuto, Althusser. Egli aveva teorizzato questa struttura di internamento e di dominazione sotto il concetto che era fiorito all’epoca: “i dispositivi ideologici dello Stato” tra cui i principali erano la scuola, l’ospedale psichiatrico e la prigione. Questa teoria, questa affermazione era in risonanza con il movimento detto dell’antipsichiatria e con tutti i fermenti degli anni ’60 in questi luoghi, e che si erano manifestati in modo spettacolare nel “Maggio 1968”. Questo primo movimento, questa logica, consiste nel dire che guarire il malato mentale è guarire la psichiatria. La psichiatria si guarisce negando se stessa e aprendosi, abolendosi nel movimento sociale. È un po’ riduttivo, ma potremmo sintetizzare in questa parola d’ordine del Maggio 1968: “il potere è nella strada”. La strada , cioè la spontaneità della socialità che si da le proprie regole e il suo movimento, che può risolvere queste disfunzioni della società di cui la malattia mentale è la punta dell’iceberg. La malattia mentale è il punto culminante della malattia sociale. Il sociale è malato, la società mortifera, è malsana; questa si mostra in modo mostruoso nella guerra e nei movimenti totalitari nazisti e stalinisti, le due grandi ideologie totalitarie del XX sec. “C’è del marcio in Danimarca” e questo marcio va affrontato alla radice, che non può che essere la rifondazione del potere politico. L’ospedale psichiatrico è l’indice di un mostro, della ragione, la ragione dell’internamento, beninteso. Ma la ragione ha prodotto i suoi mostri , e non solamente “il sonno della “, come diceva Goya, è la ragione stessa che genera i suoi propri mostri. Dunque è da lì che si deve riprendere. Questo movimento ha una portata molto importante, perché aprendo le porte e abolendo gli alti muri, è tutto l’insieme del “vivere insieme” che è sotto tiro. L ‘ospedale psichiatrico è l’analizzatore, come dice chi si occupa di “istituzioni”. Questo analizzatore analizza l’insieme della società. Questo movimento presuppone che c’era e c’è una città, un’urbanità, una società, un contratto sociale; contratto sociale evidentemente alienato, deviato, pervertito, ma in tutti i casi c’è: è un orizzonte. Città: evidentemente luogo di lotta, di discriminazione, di esclusione, di relegazione, compresa l’apartheid, ma c’è la città e soprattutto c’è il desiderio di città. C’è un desideri frustrato. C’è il fatto che si vuole essenzialmente vivere insieme ma si è impediti a farlo, si è rinchiusi. È il segno di un’oppressione, di un’alienazione. Il movimento di uscita dall’ospedale è correlato, anticipa il fatto che sia necessario passare il ponte, come diceva Brassens, rompere gli alti muri per trovare qualcosa che non chiede che spiragli. Dietro il movimento antipsichiatrico c’è un movimento politico e sociale (…) un desiderio di libertà. Mi sembra che da un certo punto di vista ora siamo dall’altra parte della bilancia. Se si poteva dire negli anni ‘60/’70 che era la strada che a guarire e che la strada era l’aperto, il fuori, ebbene sembra che ora siamo in una situazione quasi inversa: è ormai la strada che è patogena e bisogna guarire la strada. La crisi dell’urbanità, della città, della sua centralità, fa sì che serva un rifugio e, in qualche modo, la politica ha bisogno di un asilo, un rifugio. Il vivere insieme, malato, chiede che ci si prenda cura di lui. È così che riappare il tema del “prendersi cura di”. Paradossalmente la politica si è dissolta come categoria, perché ora la politica si abolisce se stessa e non si da, nella migliore delle ipotesi, come obiettivo che la gestione, e allora il sociale come categoria è anch’esso abolito nella psicologia. Ciò che conta oggi, ciò che viene richiesto, ciò che è posto come realizzazione del sociale, è che l’individuo sia lui stesso la propria prestazione, che si integri nella misura in cui dà dimostrazione continua di realizzarsi; che regoli sempre la propria condotta perché il suo posto nella società, consiste che egli si faccia carico della propria vita. Gli è richiesto di essere creativo, di inventarsi e reinventarsi, di essere perpetuamente “performante”, avendo come conseguenza ovviamente che sia sempre sano di spirito e di corpo, in buona salute1. 1 Confronta quanto Basaglia scrive sulla psicologia delle risorse umane, nota del traduttore. Tutto accade come se non ci fosse più il sociale ma piuttosto un generale spingere al sostegno psicologico. In questa condizione, qualsiasi idea di socializzazione è lontana. Quello che esiste è un insieme di individui performanti. Esiste l’antica concezione di una città fondata su un contratto sociale e politico consistente nel fatto che ogni uomo acceda alla sua propria umanità proprio in quanto essere politico. Come dice Hannah Arendt, il zoon politikos – l’essere umano in quanto politico2 -­‐ non può accedere alla sua umanità che creando il mondo come un mondo comune. C’è un rapporto con il mondo se c’è un progetto di un mondo comune; e c’è la possibilità di vivere la propria umanità in questa condivisione in rapporto a un mondo comune. Quello che Aristotele chiama la vita dei zoon politikon. A questa prospettiva si è sostituita ora l’agglomerato di monadi, di individui, di cui diciamo che non hanno altro orizzonte che il proprio interesse -­‐ l’homo economicus essendo per definizione un individuo solitario che calcola, che abita la terra, il mondo e sé, calcolando il proprio interesse. Conseguentemente non ha passione perché la passione è irrazionale, e dunque ognuno si aggrega dentro una specie di ambiente che si autoregola per la logica implicita dell’interesse. È il vasto mercato delle “monadi” di interessi. Sartre ne ha magnificamente parlato nello scritto che non si cita spesso oggi, Les Séquestrés d’Altona. C’è un monologo in cui il personaggio principale in una specie di delirio ripete 1+1 = 1, 1+1 = 1. In questo momento siamo nel 1+1 = 1 indefinitamente. Nella razionalità dell’interesse non c’è posto per il 2, non c’è che la potenza infinita dell’1. Evidentemente questo genera un qualche disturbo e della sofferenza, che non trova espressione nella città perché la città si è dissolta in un agglomerato e questo sia mentalmente, che ora, anche materialmente nella sua concezione: la produzione che noi chiamiamo metropolizzazione in cui tutto funziona per reti. La “metropolizzazione” non ha bisogno di articolare la centralità, la cittadinanza. La “città” si riduce ora “al centro storico museo”, come immagine che può ancora procurare una qualche piacere estetico, e che si presenta come l’immagine della città -­‐ salvo che la città non è un’immagine. Oggi, nella realtà, la città si caratterizza per la sua dissoluzione nella metropolizzazione e in una “politica d’immagine” dei centri storici museo. Si può costatare che come in certi periodi storici la socialità è sospesa, in riserva, non si implementa, Al contrario è relegata, non è messa alla prova. E io mi domando se in queste condizioni la vecchia vocazione, l’utilizzo della bella parola “asilo”-­‐ diritto d’asilo -­‐ non riprenda un senso interessante. E finalmente si può pensare che ciò che si gioca nell’ospedale e ciò che ancora si gioca nell’ospedale psichiatrico non sia un vero progetto di prendersi cura dell’umano -­‐ non per forza guarirlo. Non è qualcosa che può essere proposto come asilo provvisorio in questo mondo in cui non ci si prende più cura di? E io mi domando se gli architetti non dovrebbero apprendere qualcosa da questa categoria del “prendersi cura di”. Invece di attenersi e di conformarsi a una pianificazione del territorio, non sarebbe bene e utile di sostituire, per qualche tempo, non la pianificazione ma “l’accudimento”; non ci sarà più tanto bisogno di pianificare la terra ma di accudirla. Mi sembra che, da questo punto di vista, la funzione asilare avrebbe molto da dirci. Ciò che intendeva Lyonnais Philibert 2 essere politico' come partecipe della sfera pubblica, n.d.t. Delorme, grande architetto e grande teorico dell’architettura, quando diceva che: “l’architettura ha come scopo di alleviare la malinconia”, non guarirla per forza ma alleviarla. Non bisognerebbe prendere questa affermazione sul serio? Io mi domando se oggi non si tratti di alleviare l’angoscia urbana, e se il luogo dell’”asilo”, l’ospedale nella città, non sia assolutamente necessario e non occupi questa funzione che Nietzche reclamava nelle grandi città. C’è bisogno di un “deserto”, come diceva, cioè un luogo dove ci si ritira dal mondo e dalla “frenesia” della pianificazione, per ricaricarsi, mettersi in sosta, ricostituire le riserve, per affrontare e costruire un mondo comune. .