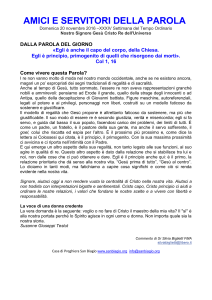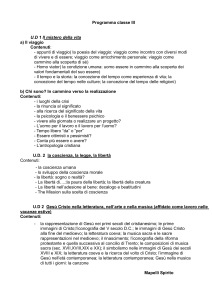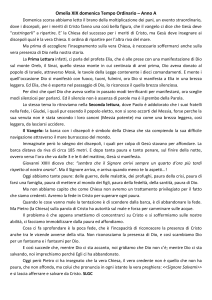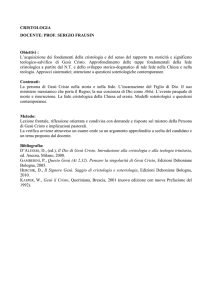SYMBOLON:
DISCHIUDERE IL
CREDO
di Stefano Biavaschi
L’Antico Symbolon della Fede Cristiana
Simbolo degli Apostoli
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen
Credo niceno-costantinopolitano
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
Unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della sostanza del Padre;
per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria
per giudicare i vivi e i morti
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen
Il Credo
Quando nasce il nostro credo? Possiamo dire
che nasce con la rivelazione stessa di Gesù.
L’incontro col Figlio di Dio faceva cadere
l’uomo in ginocchio e gli metteva sulle labbra
la prima semplicissima formula di fede: “Io
credo”. I peccatori, i discepoli, i miracolati,
esprimevano la loro fede con una sola parola,
un solo verbo, perché il Verbo era già davanti
a loro, e non era necessario pertanto elencare
ad essi tutti i contenuti della fede: avevano
visto e credevano, si sentivano amati e
avevano fiducia, un solo sguardo di Gesù e
già lo seguivano.
In questi testimoni nacque però
immediatamente la necessità di annunciare
tale incontro perché anche altri potessero
viverlo, come narrano le bellissime parole
degli apostoli: “Ciò che noi abbiamo udito,
ciò che noi abbiamo veduto con i nostri
occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò
che le nostre mani hanno toccato, ossia il
Verbo della vita, noi lo annunziamo anche a
voi, perché anche voi siate in comunione con
noi”. Dalla predicazione degli apostoli nasce
così l’annuncio del Kerigma, il primo nucleo
della formula di fede: Cristo è venuto, ci ha
salvato con la sua croce, è morto ed è risorto.
Credere era accettare e vivere questa “buona
notizia”. Attorno a questo lieto annuncio
sorsero fin dall’inizio le professioni di fede;
Paolo scriveva a Timoteo: “Combatti la
buona battaglia della fede, cerca di
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato
chiamato e per la quale hai fatto la tua bella
professione di fede” (1 Tm 6,12). E’ quindi
attestata la presenza di formule attorno alle
quali si coagulò quello che oggi chiamiamo il
Simbolo apostolico: “Io credo in Dio, Padre
onnipotente, creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo suo unico Figlio e nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la
santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen”. Questo antichissimo simbolo rimane
ancora oggi una delle più belle preghiere della
Chiesa. Nella lingua greca la parola symbolon
indicava la metà di un oggetto spezzato (per
esempio un sigillo) che serviva come segno di
riconoscimento quando le due metà venivano
riunite. Era un modo per verificare l’identità
di una persona, così come il simbolo della
fede identificava il credente. Symbolon passò
poi a significare raccolta, sommario. Il
Simbolo degli Apostoli raccoglieva le
principali verità di fede, ne era il riassunto (cfr
CCC 185-197). Accanto a questo Simbolo
apostolico nacque nel quarto secolo il Credo
di Nicea-Costantinopoli. In un certo senso
dobbiamo all’eresia ariana il grande Concilio
di Nicea, che riunì ben 318 padri della chiesa
nell’anno 325, poiché questi si sentirono
interpellati sulla propria fede ed avvertirono la
necessità di mettere nero su bianco gli
autentici contenuti del credo cristiano. Tale
Simbolo fu ancora ripreso e convalidato dai
150 padri durante il primo Concilio di
Costantinopoli nel 381. In quegli anni San
Cirillo di Gerusalemme scrisse: “Il simbolo
della fede non fu composto secondo opinioni
umane, ma consiste nella raccolta dei punti
salienti, scelti da tutta la Scrittura, così da
dare una dottrina completa della fede. E
come il seme della senape racchiude in un
granellino molto rami, così questo compendio
della fede racchiude tutta la conoscenza della
vera pietà contenuta nell’Antico e nel Nuovo
Testamento” (Catecheses Illuminandorum
5,12:PG33,521-524). Ancora oggi questo
Simbolo costituisce la formula che recitiamo
durante la santa Messa. Ed ha anche carattere
universale: non è patrimonio di fede solo per i
cattolici, ma anche per tutti i cristiani
d’Oriente e d’Occidente.
Affrontiamo qui di seguito, uno per uno, i
diversi articoli del Credo.
“Credo in un solo Dio…”
L’antico Simbolo della nostra fede inizia con
quel verbo che abbraccia tutti i contenuti
espressi nei vari punti della formula: io credo.
Ma cosa significa realmente credere? Ogni
buon credente sa bene che “credo in Dio” non
significa semplicemente “ritengo che Dio
c’è”. Nel linguaggio quotidiano usiamo con
disinvoltura tantissime volte questo verbo,
attribuendogli diversi significati: penso,
ritengo possibile, immagino… Ma nel
linguaggio
religioso
questo
vocabolo
s’ingigantisce improvvisamente, diventa
improvvisa assunzione di responsabilità,
scelta di vita, consapevolezza di una realtà. E’
un verbo che contiene mille verbi, che
contiene Dio e l’uomo, che contiene tutta
quanta la mia vita, quella degli altri, il senso
stesso dell’universo. Proverò qui di seguito a
tradurlo con altre espressioni, ben sapendo
che esse rappresentano solo una parte di
questo tesoro che le mani dell’antica
Tradizione ci hanno consegnato.
“Io credo in Te, io mi affido a Te, mi fido di
Te e a Te mi consegno, a Te dono la mia vita,
la mia anima, le mie forze, il mio cuore. Da
Te mi sento amato, protetto, custodito. Tu dai
senso alla mia vita, Tu mi hai fatto scoprire la
direzione da seguire, Tu sei la mia meta. Tu
mi hai rivelato le tue verità, ed io in Te le
credo. Tu mi hai donato la vita, ed io ora vivo.
Io sono rinato, io risorgo, io spero. Ero nelle
tenebre ma ora vedo, Tu sei luce per i miei
passi, le mie scelte, le mie decisioni. Io ti
lascio decidere per me. A Te mi arrendo, a Te
mi consegno. Depongo le armi della mia
malvagità, accetto di essere istruito nel cuore,
ascolto la tua Sapienza, progetto la mia vita
secondo il tuo progetto. In Te ripongo ogni
fiducia, in Te confido, spero, trovo riparo. Mi
metto alla tua sequela, perseguo le tue virtù,
indosso la tua armatura. Ti guardo, ti imito,
voglio assomigliarti e tornare ad essere tua
immagine. Ti riconosco come il Signore, ti
adoro, ti contemplo. Allineo i miei pensieri ai
tuoi, i miei ideali ai tuoi, i miei sentimenti ai
tuoi. Avverto che Tu mi scruti e non mi
nascondo, ti accolgo, ti annuncio. Ti assumo
come centro attorno a cui gravitare e far
gravitare. Ti desidero. Prometto di farti
conoscere, di adoperare le mie parole per
testimoniarti. Tu sei il mio unico punto di
riferimento, su Te fondo ogni certezza. Su Te
imposto le mie relazioni. A Te intendo
condurre chi incontro. Io osservo la tua
bellezza, io ti ammiro, io ti rendo grazie per
tutte le cose. Io rinuncio a tutte le mie
stampelle, i miei idoli, i miei bisogni. Io
m’impegno, assumo la mia responsabilità,
acquisto
consapevolezza.
Sceglierò
attentamente le esperienze, ascolterò coloro
che mi mandi, leggerò i tuoi segni. Per Te
combatto, per Te mi riposo. Io mi prendo
cura, io vigilo, io sorveglio. Io conservo, io
proteggo, io custodisco. Io so, io capisco, io
vedo. Io sento, io avverto, io imparo. Io
conosco, io risveglio i miei talenti, accendo il
mio intelletto. Io affermo, io agisco, io ricevo
da Te il coraggio. Io condivido, io entro in
comunione, io mi dono. Io patisco per gli altri.
Io porto la croce. Io esulto. Io ti includo nella
mia vita, io ti scelgo, ti sposo. Io ti amo. Io
sono”.
Ecco, quando diciamo Io credo, diciamo tutto
questo.
“…Padre onnipotente…”
Non siamo realmente credenti. Altrimenti la
nostra
vita
graviterebbe
attorno
a
quest’affermazione del Credo: Dio c’è, ci ama
come un padre, e può fare tutto. A volte lo
speriamo, ma non lo crediamo veramente. In
realtà finiamo sempre con l’arrangiarci con le
nostre forze. Siamo sempre pervasi dalla
sensazione di non meritare una cosa così
grande. Riteniamo che Dio può tutto, ma non
per noi, perché non ci sentiamo degni, perché
abbiamo sempre alle spalle qualche peccato.
In realtà il peccato è proprio questo: relegare
l’onnipotenza di Dio a mera possibilità.
Eppure il Simbolo della nostra Fede ce lo
annuncia chiaramente: Amore e Potenza sono
in Dio una sola realtà. Se Dio fosse solo
Potenza, ci sarebbe da tremare di paura,
avremmo a che fare con un Dio Terribile. Se
invece fosse solo Amore, ma non potesse
nulla, non ne ricaveremmo alcuna speranza. In
realtà il Credo ci dice: esultate, Dio è
entrambe le cose, Amore e Potenza. Ma noi
facciamo fatica ad associarle: oscilliamo tra il
concepirne una sola o l’altra. E non ci
rendiamo neanche conto di cosa perdiamo. E’
come se nella casa di fianco avessimo un
parente straricco e molto potente, che
volendoci molto bene farebbe qualsiasi cosa
per noi, eppure noi non ci rivolgessimo quasi
mai a lui, preferendo gestire tutto da soli, o al
massimo facendogli ogni tanto qualche
telefonatina ma senza un reale convincimento
di poterne ricevere aiuto. Anche nel rapporto
con gli altri ci limitiamo a dare solo consigli
umani, riducendoci al ruolo dei consiglieri di
Giobbe. Non abbiamo mai il coraggio di dire:
“Non trovi lavoro, ma l’hai chiesto a tuo
Padre? Non trovi la salute, ma l’hai chiesta a
tuo Padre? Non trovi una compagna o un
compagno per la tua vita, ma l’hai chiesto a
tuo Padre?”. Abbiamo paura dei sorrisini
altrui, abbiamo paura di essere guardati come
a chi crede nelle favole. Ma ciò accade perché
non siamo in vera intimità col Padre. Non era
questo però l’atteggiamento di Giobbe che,
nonostante le dure prove, nella sua preghiera
diceva a Dio: “Comprendo che puoi tutto e
che nessuna cosa è impossibile per te” (Gb
42,2). In realtà chi ha fede sperimenta davvero
che Dio esaudisce tutte le preghiere. Anzi,
spesso le esaudisce prima ancora che le
diciamo. Soprattutto se vede che con le nostre
azioni stiamo esaudendo le preghiere degli
altri. Gesù dormiva tranquillamente sulla
barca
durante
la
tempesta.
Sapeva
perfettamente che la Potenza era Amore. Dice
il nostro Catechismo: “Di tutti gli attributi
divini, nel Simbolo si nomina soltanto
l’onnipotenza di Dio: confessarla è di grande
importanza per la nostra vita. Noi crediamo
che tale onnipotenza è universale, perché
Dio, che tutto ha creato, tutto governa e tutto
può; amante, perché Dio è nostro Padre
” (CCC 268). Il nostro Dio è un Dio che si
prende cura di noi. Gesù ne ha fatto il centro
del suo insegnamento col discorso della
montagna (Mt 6, 25-34): il Padre veste i gigli
dei campi, il Padre nutre gli uccelli del cielo,
il Padre ci nutre e ci disseta. Potenza e
Amore. Ed anche la preghiera da lui insegnata
c'invita a rivolgerci a Dio come ad un Padre
onnipotente, ad un Padre che è nostro.
Il Catechismo Romano aggiunge: “La ferma
persuasione dell’onnipotenza divina vale più
di ogni altra cosa a corroborare in noi il
doveroso sentimento della fede e della
speranza. La nostra ragione, conquistata
dall’idea della divina onnipotenza, assentirà,
senza più dubitare, a qualunque cosa sia
necessario credere, per quanto possa essere
grande e meravigliosa o superiore alle leggi
e all’ordine della natura” (CR 1,2,13).
“…Creatore del cielo e della terra…”
Il Simbolo del Credo richiama e riassume
tutta la Sacra Scrittura. In questo caso il
richiamo col primo versetto della Bibbia è
evidente: “In principio Dio creò il cielo e la
terra” (Gn 1,1). La catechesi sulla creazione è
di fondamentale importanza perché, come
dice il nostro Catechismo, riguarda i
fondamenti stessi della vita umana e cristiana.
L’eterna domanda della filosofia “da dove
veniamo?” trova qui una risposta, rivelata
dalla Scrittura ed accettata col Credo.
Professare questo punto della fede comporta il
riconoscimento delle nostre origini in Dio: il
credente sa di non essere frutto del caso, è
consapevole di essere stato voluto e di
conseguenza di avere un fine. Ed è questa la
cosa che conta di più; la scienza può
senz’altro aiutarci a far luce sul quando e sul
come della creazione, ma sapere che tutto ha
origine da un “Essere trascendente,
intelligente e buono” ci fornisce il senso delle
cose, dell’universo tutto, e della stessa nostra
esistenza (cfr CCC 282ss). La creazione è,
infatti, “scaturita dalla bontà divina” e
partecipa di questa bontà. “E’ possibile
conoscere con certezza l’esistenza di Dio
Creatore attraverso le sue opere, grazie alla
luce della ragione umana, anche se questa
conoscenza spesso è offuscata e sfigurata
dall’errore. Per questo la fede viene a
confermare e a far luce alla ragione nella
retta intelligenza di queste verità” (CCC 286).
La creazione non è frutto del caso né
panteistica emanazione di Dio, ma un fatto
voluto, un dono fatto all’uomo, un’eredità a
lui destinata ed affidata. Il Creatore ha fatto
tutte le cose dal nulla, conferendo ad esse un
ordine e regolandole con sapienza tramite le
leggi di natura: “Tu hai disposto tutto con
misura, calcolo e peso” (Sap 11,20). E’ errato
ritenere che Dio abbia creato anche il male:
“E Dio vide che era cosa buona…cosa molto
buona” (Gn 1,4ss); “Tu ami tutte le cose
esistenti, e nulla disprezzi di quanto hai
creato; se tu avessi odiato qualcosa, non
l’avresti neppure creata” (Sap 11,24). E’
anche errato ritenere, come sostengono le
correnti gnostiche, che la materia sia qualcosa
di negativo, da respingere o superare. La
realtà della creazione è strettamente unita alla
rivelazione dell’Alleanza con Dio, anzi ne
costituisce il primo passo. Essa si rivela con
forza crescente lungo tutta la Sacra Scrittura,
nei patriarchi, nei profeti, nei salmi, fino a
culminare in Gesù Cristo che fa nuove tutte le
cose rimediando al male introdotto dal
peccato. Non abbiamo dunque a che fare,
come vorrebbe il deismo, con un Dio
orologiaio, il quale, una volta fatto l’universo,
lo avrebbe abbandonato a se stesso. Dio non
solo crea, ma conserva e regge tutta quanta la
creazione, la sostiene continuamente con la
sua sapienza ed il suo amore. Alla domanda
“perché Dio ha fatto il mondo?” il Concilio
Vaticano I risponde: “Il mondo è stato creato
per la gloria di Dio” (Denz-Schönm, 3025).
Ma il Signore non operò per accrescere la
propria gloria, bensì, come amava dire San
Bonaventura, “per manifestarla e per
comunicarla”. Dio non aveva bisogno del
cosmo. Infatti, non ha altro motivo di creare
se non il suo amore e la sua bontà (cfr CCC
293). Ma qual è il fine della creazione? Il fine
ultimo della creazione è che Dio “che di tutti
è il Creatore, possa anche essere tutto in tutti,
procurando ad un tempo la sua gloria e la
nostra felicità” (Conc Ecum Vat II, Ad gentes,
2). E il Signore, nel suo disegno, si serve
anche della cooperazione delle sue creature,
dà agli uomini il potere di partecipare
liberamente alla sua Provvidenza, di diventare
“cause intelligenti e libere per completare
l’opera della creazione, perfezionandone
l’armonia, per il loro bene e per il bene del
prossimo” (CCC 307). Spesso siamo
cooperatori inconsapevoli, ma tutti noi
possiamo partecipare deliberatamente al piano
divino con le nostre azioni, le nostre
preghiere, ed in particolare con la procreazione, che prolunga, attraverso di noi ed il
nostro amore, il disegno creativo di Dio. La
creazione, infatti, non è finita, perché Dio
continuamente “chiama all’esistenza le cose
che ancora non esistono” (Rm 4,17).
“…di tutte le cose visibili e invisibili…”
Abbiamo osservato che ogni articolo del
Credo affonda le radici nella Sacra Scrittura.
In questo caso la radice biblica è, molto
probabilmente, un passaggio della lettera di
Paolo ai Colossesi: “…per mezzo di Lui sono
state create tutte le cose, quelle nei cieli e
quelle sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili...” (Col 1,16). Sappiamo bene quali
sono le realtà visibili, ma cosa intende la
Bibbia per quelle invisibili? Non intende solo
tutte le realtà fisiche non percepibili alla vista,
ma anche tutte le realtà spirituali. Con questa
professione di fede si accetta e si crede
l’esistenza dell’anima, sulla quale si fonda
tutta la speranza cristiana; ma si accettano e si
credono anche tutti gli esseri spirituali ed
incorporei, come gli angeli. Il Concilio
Lateranense IV afferma che Dio “fin dal
principio del tempo, creò dal nulla l’uno e
l’altro ordine di creature, quello spirituale e
quello materiale, cioè gli angeli e il mondo
terrestre; e poi l’uomo, quasi partecipe
dell’uno e dell’altro, composto di anima e di
corpo” (Denz.-Schönm, 800).
Purtroppo oggi molta teologia modernista,
nella foga di razionalizzare tutta la
rivelazione, tende a negare o eludere
l’esistenza degli angeli. Tuttavia nella
Scrittura si legge spesso che gli angeli
guidano il popolo di Dio, annunziano nascite
e vocazioni, assistono i profeti, e sono
presenti in tutti i momenti chiave della storia
della salvezza. Anche la vita di Gesù è
frequentemente assistita dalla presenza degli
angeli, come nell’Annunciazione e nel Natale,
nel deserto e nel Getsemani, presso il sepolcro
vuoto o sul monte dell’Ascensione. Ecco
perché il Catechismo della Chiesa Cattolica
stronca decisamente ogni tentativo di
esclusione degli angeli dalla nostra fede:
“L’esistenza
degli
esseri
spirituali,
incorporei, che la Sacra Scrittura chiama
abitualmente angeli, è una verità di fede. La
testimonianza della Scrittura è tanto chiara
quanto l’unanimità della Tradizione” (CCC
328).
“Angelo” significa “inviato”, “messaggero”;
sant’Agostino amava spiegare che “la parola
angelo designa l’incarico, non la natura. Se
si chiede il nome di questa natura si risponde
che è spirito; se si chiede l’ufficio, si risponde
che è angelo: è spirito per quello che è,
mentre per quello che compie è angelo”
(Interpretazione dei Salmi, 103,1,15).
Spesso siamo soggetti alla tentazione di
considerare astratte tutte le realtà non visibili,
mentre queste sono in realtà più concrete di
quelle fisiche, soggette a mutazioni e
decadimento. Le “cose invisibili” formano
anzi la matrice di quelle visibili, prendendo
parte sia alla loro creazione sia alla loro
sussistenza, tanto che San Paolo ebbe a
scrivere: “Per fede sappiamo che i mondi
furono formati dalla Parola di Dio, sì che da
cose non visibili ha preso origine ciò che si
vede” (Eb 11,3). In particolare gli angeli
possiedono un grado di perfezione notevole,
sono immortali, ed hanno il dono di vedere
Dio faccia a faccia per tutta la loro esistenza.
Pur agendo sempre in linea con i disegni del
Signore, sono muniti di volontà, libertà e
personalità (cfr CCC 330). La loro
intelligenza è una mirabile sintesi di luce e di
amore, di iniziativa ed obbedienza, di
conoscenza celeste ed umile servizio. Essi si
prendono cura degli uomini, delle comunità
cristiane, delle nazioni. “Dall’infanzia fino
all’ora della morte la vita umana è
circondata dalla loro protezione e dalla loro
intercessione” (CCC 336). San Basilio di
Cesarea scriveva che “ogni fedele ha al
proprio fianco un angelo come protettore e
pastore, per condurlo alla vita” (Adversus
Eunomium 3,1).
La Bibbia riconosce inoltre diversi ordini di
spiriti celesti, tra cui gli Angeli, gli Arcangeli,
i Principati, le Potestà, le Virtù, le
Dominazioni, i Troni, i Cherubini, ed i
Serafini.
Paolo, Dionigi, Ambrogio e perfino Dante,
tentarono una catalogazione degli angeli, ma
la loro realtà rimane misteriosa alla nostra
conoscenza. Sappiamo però che queste
presenze invisibili partecipano alla storia della
salvezza sia personale sia collettiva, tanto che
la Chiesa, nella sua Liturgia, si unisce sempre
agli angeli ed alla loro preghiera, invocandone
con fiducia l’assistenza.
“…Credo
Cristo…”
in
un
solo
Signore,
Gesù
Finalmente una buona notizia: Dio, quel Dio
che tutte le religioni cercano, che da sempre la
filosofia insegue, che il cuore invano rincorre
senza afferrare, si è fatto uomo!
Dio, quello stesso Dio che ha fatto l’Universo,
quello a cui la mente umana anela senza
interruzione, colui che solo può porre fine alla
nostra ricerca, ci è venuto a trovare!
Quel Dio che conosce le nostre aridità e le
disseta, conosce le nostre lacrime e le asciuga,
conosce il nostro bisogno d’amore e lo colma,
è finalmente venuto fra noi!
Dio! Non una creatura, non un ideale, non un
sogno, ma Dio in persona!
Se la nostra mente non dormisse, appiattita
dalle categorie del mondo, assonnata dalle
consuetudini, balzeremmo di colpo in piedi
solo all’udire questa notizia che il Credo ci
annuncia.
Balzerebbe anzi in piedi tutta quanta la vita,
lasceremmo cadere dalle mani tutti i nostri
beni, correremmo per le strade sconvolti dalla
gioia. Dio è venuto! Dio è qui! Dio è con noi!
E’ davvero qua, visibile agli occhi, in carne ed
ossa, si è perfino reso comprensibile ai nostri
sensi, ha un volto come il nostro, ci parla e
riusciamo a comprenderlo. Nell’udirlo
avvertiamo immediatamente che è Verità,
nell’avvicinarlo scopriamo all’istante che è
amore. Ci fa ardere il cuore nel petto (e
sappiamo quanto ci sia duro farlo ardere, noi
che intimamente abbiamo sempre temuto che
si raggelasse). Ci accende di luce la mente (e
sappiamo quante tenebre la circondavano,
quanta buia solitudine avvinghiava i pensieri).
Come potremmo dire stavolta che ci
sbagliamo? Abbiamo dubitato delle scritture e
dei profeti, abbiamo trovato mille scuse per
scansare la coscienza, ma come dubitare di
Lui mentre ci trapassa con uno sguardo
infilzando l’anima e il cuore? Passato,
presente e futuro della mia vita si riducono ad
un puntino dinanzi a questi occhi. Casa,
lavoro, distrazioni, si riducono ad un nulla
dinanzi a questa statura.
Diciamo la verità: da sempre abbiamo
scrutato nell’altro che ci passava accanto, da
sempre abbiamo gettato uno sguardo nel
cuore del prossimo per vedere se aveva quelle
cose che ci nutrivano.
Anche quando non lo davamo a vedere, da
sempre abbiamo atteso un incontro che fosse
l’Incontro. Qualcosa che desse senso alla
nostra vita e la riempisse.
Abbiamo sempre avuto bisogno e lo abbiamo
nascosto. Ci siamo infinite volte illusi, e poi
duramente risvegliati. Quindi non è facile
ingannarci, non è facile che un altro uomo si
ponga per noi come senso totale della nostra
esistenza.
Se Costui riesce a porsi in quel modo,
qualcosa c’è. Se Costui tocca tutte le corde
del nostro cuore, anche quelle più intime del
nostro intimo, un mistero c’è.
Sappiamo bene che per vizio di natura
preferiremmo un oblio senza responsabilità,
che desidereremmo una vita quieta piuttosto
che essere sentinelle del mondo sotto i dardi
di tutti.
Se Qualcuno riesce a coinvolgerci così, ad
esporci così, è perché qualcosa veramente
avvertiamo, qualcosa che percepiamo come
tutto, qualcosa che dà significato all’intera
esistenza.
Del resto c’è una prova indiscutibile:
allontanarsene è morire. La più grande prova
di Dio è l’esperienza del non-Dio, è
l’esperienza del tradimento. Diciamo, ancora,
la verità: mille volte ci siamo allontanati,
mille volte abbiamo tradito per inezie grandi
come lenticchie, preferendo il gelo del cuore e
dei pensieri, la tenaglia delle seduzioni che ci
disumanizzava fino all’estremo non senso. Vi
è una sola alternativa a tutto questo male di
vivere, e per tutto il mondo non ve ne sono
altre, perché già le abbiamo cercate e lo
sappiamo. Vi è una sola scelta possibile: dire
“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo”.
“…Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli…”
Dio è amore. Ma l’amore richiede un “tu” a
cui donarsi, perché l’amore è relazione con un
“tu”.
Allora Dio, Dio Padre, genera un “tu”, e
questo “tu” è il Figlio. Ma non lo genera nel
tempo, perché Dio è al di fuori del tempo.
Non vi è un “periodo” nel quale Dio Padre era
senza il Figlio. Il Padre genera il Figlio
nell’eternità. Da sempre il Figlio è generato
dal Padre. E il Padre lo ama. Padre perché
questo “tu” lo ha generato lui. Amandolo gli
dona se stesso. In che misura si dona al
Figlio? In misura totale, perché Dio è amore
perfetto, e dunque si dona totalmente al
Figlio. Gli dona tutto il suo essere. Per cui “il
Figlio è tutto ciò che è il Padre” (cfr CCC
253). Ma se il Figlio è tutto ciò che è il Padre,
anch’egli ama come il Padre, ed ama il Padre,
suo “tu”, in modo totale. Quindi anch’egli
dona tutto se stesso al Padre. Il Figlio è
l’Unigenito del Padre, ha in comune col Padre
l’Essere, ma non la Persona, l’io divino. Ha in
comune col Padre tutto il contenuto di
quest’io, cioè l’essere, perché se lo sono
reciprocamente donato, e quindi Lui ed il
Padre sono “una cosa sola” (Gv 10,30), ma è
persona divina distinta dal Padre, il Figlio non
è il Padre, ed il Padre non è il Figlio (cfr CCC
254). Sono distinti tra loro per le loro
relazioni d’origine: “E’ il Padre che genera,
il Figlio che è generato” (Conc. Lat. IV, Denz
804).
Come l’umanità è venuta a conoscere questo
mistero? Tramite la Rivelazione. E’ Dio che
l’ha rivelato. Il Vangelo è il deposito di questa
rivelazione. La prima volta che nel Vangelo
Gesù è annunciato come Figlio di Dio è ancor
prima del suo concepimento: è durante
l’Annunciazione; è l’arcangelo Gabriele che
annunzia la lieta notizia che Gesù sarà
“chiamato Figlio di Dio” (Lc 1,35).
In occasione del battesimo di Gesù, il Padre
confermerà pubblicamente a tutti quanto
annunciato nel segreto del cuore di Maria:
“Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono
compiaciuto” (Lc 3,22). E questa verità, già
anticamente ispirata ad Isaia (Is 42,1ss) la
rivelerà in modo particolare a Pietro,
sospingendolo a dire: “Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). Quello
stesso Pietro che sul monte Tabor fu folgorato
dalla trasfigurazione del Cristo, ed avvolto
dalla nuvola di luce sentì ancora dal Padre
quello che aveva professato, e che già al
Giordano era stato udito: “Questi è il Figlio
mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto. Ascoltatelo” (Mt 17,5).
Gesù nei suoi insegnamenti aveva spesso
accennato alla sua particolare filiazione divina
(Mt 11,27; 21,37, …), ma è all’inizio della
passione che affronta direttamente, una volta
per tutte, la questione: “Tu dunque sei il
Figlio di Dio? Ed egli rispose loro: lo dite voi
stessi, io lo sono” (Lc 22,70). E’
un’affermazione inequivocabile, che chiude
definitivamente la bocca a tutti quanti
ritengono che Gesù non sia o non possa essere
chiamato Figlio di Dio. Se gli anziani
d’Israele, ben esperti nella legge, avessero
inteso l’espressione “figlio di Dio” con la
comune figliolanza di cui tutte le creature
godono nei riguardi del loro Creatore, non
avrebbero nemmeno posto quella domanda.
E’ evidente che in essa s’intende IL Figlio,
l’Unigenito che nel rivolgersi al Padre non ha
mai usato l’espressione “padre nostro”, pur
avendola insegnata; bensì “padre mio”, e
questa distinzione l’ha sottolineata anche da
risorto: “Io salgo al Padre mio e Padre
vostro” (Gv 20,17). Il Simbolo del Credo non
poteva che ereditare queste verità, perché,
come dice Giovanni, occorre credere “nel
nome dell’Unigenito Figlio di Dio” per
salvarsi (Gv 3,18). Dio ci voleva salvi: “Ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
Unigenito” (Gv 3,16). E grazie al nostro
antico Credo possiamo come gli apostoli
proclamare: “Noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di Unigenito dal Padre, pieno di
grazia e di verità” (Gv 1,14).
“…Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da
Dio vero…”
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero: davanti a questo articolo di fede il
Simbolo
del
nostro
antico
Credo
improvvisamente s’impenna come dinanzi ai
vertici di un Mistero. Come è possibile che
Dio generi Dio? E come è possibile,
all’interno di questo, parlare ancora di un solo
Dio? Abbiamo qui la conferma di trovarci
dinanzi alla pura Rivelazione, perché la nostra
mente umana non solo non è in grado
d’intendere questa verità, ma nemmeno di
formularla in un credo se questa non fosse
stata rivelata. Molti teologi hanno provato ad
affacciarsi a questo mistero, per provare a
renderlo almeno un po’ più comprensibile alle
nostre capacità, ma il limitato segmento del
nostro pensiero, quando giunge a queste
parole del Simbolo, si trova dinanzi a
un’iperbole tendente all’infinito che ci chiede
di abbandonare tutte le nostre stampelle, tutti i
nostri normali parametri conoscitivi, tutte le
nostre certezze naturali.
E i 318 antichi Padri del Concilio di Nicea
sono davvero impietosi davanti alle nostre
obiezioni:
non
smussano,
non
ridimensionano, non attutiscono. Anzi, lo
sottolineano tante volte quante le Persone
della Trinità: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero. Eppure parlavano, da un
lato, ai discendenti degli ebrei, rigidamente
monoteisti, dall’altro ai discendenti dei greci,
rigorosamente logici. Nicea, situata in Bitinia
(attuale Turchia), era collocata esattamente a
metà fra queste due diverse culture, ed il
grande Concilio, facendo da ponte fra i due
continenti, sfidò la filosofia dei Greci a
confrontarsi
col
monoteismo
ebraico
attraverso il mistero di Cristo. Il documento
che venne stilato nel 325, e che assemblò le
precedenti formulazioni in un’unica matrice
destinata a divenire il basamento imperituro
della fede cattolica, non esitò a propugnare
con ben 7 articoli la verità della generazione
divina del Cristo; ed il successivo Concilio di
Costantinopoli (anno 381) li riprese nelle ben
note espressioni che ormai conosciamo:
1) Unigenito Figlio di Dio;
2) Nato dal Padre prima di tutti i secoli;
3) Dio da Dio;
4) Luce da Luce;
5) Dio vero da Dio vero;
6) Generato, non creato;
7) Della stessa sostanza del Padre.
Sette proposizioni per dire la stessa cosa,
quasi a voler fugare ogni dubbio, ogni timore
di aver capito male, quasi a voler imprimere
nella ragione il più grande mistero rivelato:
Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è anch’Egli
Dio, e nonostante ciò vi è un solo Dio. Non
importa che non possiamo capirlo: così ci è
stato rivelato.
Gli ariani provarono in qualche modo a
rendere più ragionevole il mistero, a
“umanizzare” maggiormente il Cristo, ed è
grazie al loro errore che i Padri della Chiesa ci
lasciarono
delle
definizioni
così
inequivocabili.
Anche noi oggi, figli dell’illuminismo e del
razionalismo, ci sottraiamo spesso al mistero
della divinità di Cristo, preferendo talvolta
adorare ancora la dea ragione. E’ però un
errore ritenere che la ragione umana possa
essere comprensiva di tutta la realtà. Ciò non
accade nemmeno per certe verità scientifiche.
La fisica quantistica, per esempio, c’insegna
che una particella di luce può essere al tempo
stesso in due posti diversi, pur restando una
sola particella, come dimostrato dal famoso
esperimento delle due fenditure attraversate
contemporaneamente da un solo fotone. Il
mondo della materia, specchio del suo
Creatore, sembra racchiudere anch’esso
l’assioma “luce da luce”, quasi come un segno
di cose più alte, un invito a ricordare che la
nostra mente è poco più che una vertigine. Ma
chi si sente amato dal Mistero, non lo teme.
“…generato, non creato,
sostanza del Padre…”
della
stessa
Il primo Concilio di Nicea del 325 conosceva
bene quegli errori che gli eretici del tempo
avevano messo in circolazione riguardo alla
natura di Cristo, e li elencò al termine del
Simbolo. Ecco gli errori indicati:
- “Vi fu un tempo in cui Egli non esisteva”
- “Prima che nascesse non era”
- “E’ stato creato dal nulla”
- “Il Figlio di Dio è di un’altra sostanza o di
un’altra essenza rispetto al Padre”
- “Il Figlio di Dio è sottomesso al
cambiamento o all’alterazione”
Mentre il Credo proclamava in cosa credere,
con queste righe finali veniva chiarito in cosa
non credere.
La necessità di fare chiarezza veniva dal fatto
che in quegli anni l’eresia ariana stava
mettendo in dubbio la natura divina del Figlio.
E’ un’eresia che nei secoli non si è mai
spenta. Anzi, ricorre ancora oggi: basta
pensare
all’interpretazione
di
Cristo
nell’Islam, ai Testimoni di Geova, ed a tante
forme di esoterismo più o meno cristiano che
negano appunto la natura divina di Gesù.
Cristo viene visto come un santo profeta,
magari anche come inviato da Dio, ma non
Dio egli stesso.
Come facciamo, oggi, a sapere che la verità
indicata dalla Chiesa (e tra l’altro anche dai
protestanti) è quella giusta? Perché è quanto
risulta dalla Sacra Scrittura. Gesù ha
affermato chiaramente, anche dinanzi la
replica scandalizzata dei giudei, “prima che
Abramo nascesse Io sono” (Gv 8,58) e che
quindi “esisteva prima di nascere”. Ha anche
detto senza possibilità di malintesi: “Sono di
lassù…non sono di questo mondo” (Gv 8,23).
Inoltre non ha nascosto la sua origine divina:
“Sono uscito da Dio” (Gv 16,27), e quindi
noi diciamo “generato dal Padre”. La
preghiera di Gesù prima della sua passione
non lascia dubbi: “Ed ora, Padre, glorificami
davanti a te, con quella gloria che avevo
presso di te prima che il mondo fosse” (Gv
17,5). Davanti a tutte affermazioni, come
potevano i padri conciliari accettare la tesi che
Gesù fosse solamente uomo? Ed è anche
legittimo chiamarlo “Figlio di Dio”, sebbene
la nostra mente tenda a sottrarsi ad una
definizione così forte; perché tutto quanto il
Vangelo ci spinge verso questa verità: durante
l’Annunciazione, le parole dell’angelo
chiamano Gesù “figlio dell’Altissimo”,
“Figlio di Dio” (Lc 1,32.35); anche le parole
di Pietro dichiarano questa rivelazione che fa
da base al nostro Credo: “Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). Perfino
durante il processo di Caifa, quando il termine
“Figlio di Dio” costituiva il più pesante capo
d’accusa e sarebbe bastato disconoscerlo per
salvarsi, Gesù non rinnega la sua figliolanza
divina (Mt 26, 62-66). E finanche il
centurione romano, nella sua scarsa
dimestichezza in questioni religiose, davanti
alla croce fece scaturire la sua professione di
fede nel “Figlio di Dio” (Mc 15,39). Gli
evangelisti e gli apostoli non temettero di
annunziare Gesù come “Figlio di Dio” (Mc
1,1 – At 9,20), anche se ciò era a quel tempo
reato passibile di morte. Ma si trattava di una
verità che non poteva essere taciuta, così forte
che perfino “i morti udranno la voce del
Figlio di Dio” (Gv 5,25); e “quelli che
l’hanno ascoltata vivranno”. Quando si cerca
la verità, l’ultima parola spetta a Cristo, che è
Verità. “Ho detto: sono Figlio di Dio” (Gv
10,36). E il nostro Credo non può che fare da
specchio alle verità di Cristo. Egli è il Figlio,
generato al di fuori del tempo. Eterno e
pienamente Dio; come dice Giovanni “il vero
Dio” (1Gv 5,20). Della stessa sostanza del
Padre. E la sostanza di Dio è l’Amore.
“Chi va oltre e non rimane nella dottrina del
Cristo, non possiede Dio. Chi invece rimane
nella dottrina, possiede il Padre e il Figlio”
(2Giov 9).
“…per mezzo di Lui tutte le cose sono state
create…”
Abbiamo osservato che il nostro antico Credo
attinge le sue verità dalla Sacra Scrittura. Ora,
proprio all’inizio del Vangelo di Giovanni, è
affrontato in modo stupendo il mistero del
Verbo, e si legge: “Tutto è stato fatto per
mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato
fatto” (Gv 1,3). Anzi, l’apostolo sente la
necessità, in questo stesso prologo, di ripetere
tale verità una seconda volta: “…e il mondo fu
fatto per mezzo di Lui…” (Gv 1,10). Anche
San Paolo, nella sua lettera ai Colossesi, la
conclama curiosamente due volte: “Per mezzo
di Lui sono state create tutte le cose…Tutte le
cose sono state create per mezzo di lui” (Col
1,16). Due volte nello stesso versetto: sembra
che emerga in entrambi gli apostoli la
necessità di rimarcare vividamente che Cristo
non è creatura, che precede tutta quanta la
creazione, che possiede natura divina. E’ un
punto chiave della professione di Fede, e
viene ripetuto due volte come per dire agli
ascoltatori: guardate che è così, non mi sono
espresso male, è una verità nuova, difficile da
comprendere, ma è questo che c’è stato
rivelato. Del resto conosciamo bene le
resistenze psicologiche dei giudei ad accettare
tale dato, che per la loro cultura meritava la
lapidazione (Gv 8,57-59). Ma Paolo, che da
Fariseo perseguitava i cristiani proprio su
questo argomento, da cristiano convertito non
nascondeva la verità sull’età spirituale di
Gesù: “Egli è prima di tutte le cose, e tutte
sussistono in lui” (Col 1,17). In fondo
potremmo considerare questo gruppo di
versetti della lettera ai Colossesi (da 1,15 a
1,20) come una sorta di Credo paolino che fa
da matrice al Simbolo del Credo di Nicea. Qui
è racchiuso il testo della primitiva professione
di fede. Il Catechismo della Chiesa Cattolica
può perciò con serenità affermare: “Il Nuovo
Testamento rivela che Dio ha creato tutto per
mezzo del Verbo eterno, il Figlio suo diletto”
(CCC 291). Notare l’aggettivo eterno. Del
resto si tratta di una logica conseguenza: se
tutto è stato fatto attraverso il Figlio, anche il
tempo è stato fatto attraverso di lui. Quindi il
Verbo è nell’eternità. Il tempo non è altro che
dimensione appartenente alla materia, come
del resto confermato dalla fisica moderna:
prima della materia il tempo non è! Pertanto
se tutta quanta la creazione, incluso il tempo,
è stata fatta attraverso il Verbo, questi è
eterno. Ed è eterno in quanto Dio. Per diversi
decenni il materialismo ha sostituito Dio con
la materia, conferendo ad essa caratteristiche
divine quali l’eternità. Esso sosteneva, infatti,
che la materia esistesse da sempre, che
l’universo ci fosse sempre stato. La menzogna
però non durò molto perché la scienza scoprì
presto la non-eternità della materia, asserendo
già nella prima metà del ventesimo secolo che
anche l’universo ha avuto un suo preciso
inizio nel tempo, e che perfino lo stesso
scorrere del tempo ha avuto un principio.
Ma ciò che più c’interessa a livello teologico
è la stretta connessione tra l’opera della
creazione
e
quella
redenzione,
cui
quest’articolo del Credo sembra rimandare.
Nel Compendio del Catechismo della Chiesa
Cattolica è presentata questa domanda: “Che
relazione c’è fra l’opera della creazione e
quella della redenzione?”. Ed il Compendio
risponde: “L’opera della creazione culmina
nell’opera ancora più grande della
redenzione. Infatti questa dà inizio alla nuova
creazione, nella quale tutto ritroverà il suo
pieno senso e il suo compimento” (CCCC 65).
I sette giorni della creazione, avvenuta tramite
il Figlio, sono da lui completati con l’ottavo
giorno della Resurrezione, la domenica del
Signore con la quale la Redenzione è
pienamente attuata. Gli antichi battisteri
ottagonali
riprendono
proprio
questa
simbologia: il compimento della creazione
avviene col Battesimo. E la veste bianca che il
catecumeno indossa prima d’immergersi
indica la ricreata vita di grazia, il ritorno allo
stato originario, secondo quanto era nel
disegno iniziale di Dio, ed ora finalmente
realizzato tramite il Figlio. Per mezzo di lui
tutto è stato creato, per mezzo di lui tutto è
stato salvato.
“...Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal Cielo...”
Circa 3200 anni fa un ragazzo spaurito lungo i
pendii di un monte chiese a suo padre: “Dov’è
l’agnello per il sacrificio?” Quel ragazzo, che
fu poi legato sopra un altare, su ceppi di legno
ormai pronti ad ardere, e che vide con terrore
la lama brandita dalla mano paterna alzarsi su
di lui, si chiamava Isacco. Milleduecento anni
dopo (ma questi sono i tempi di Dio) il
Signore risponde alla domanda di Isacco
attraverso le labbra di un uomo sulla riva del
fiume Giordano: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco
colui che toglie i peccati del mondo”. Questa
frase del Battista chiuderà per sempre, ai
cercatori di salvezza, la strada del sacrificio
pasquale degli agnelli, perchè era venuto un
Agnello che era il Figlio di Dio, l’unico in
grado di portare su di sé tutti i peccati del
mondo. In definitiva aveva avuto ragione
Abramo, padre di quel ragazzo, a
rispondergli: “Dio provvederà da sé
all’agnello per il sacrificio”. Non fu una scusa
o una bugia: Dio la trasformò in verità,
assumendo su di sé la dolorosissima richiesta
fatta ad Abramo. E mandò suo Figlio. Per noi.
Per noi uomini. Per la nostra salvezza.
Ecco che qui il Simbolo del nostro Credo
punta il dito sul cuore della missione di Gesù,
sul vero motivo della sua venuta: la nostra
salvezza! Ma cosa vuol dire salvezza? Cosa
significa che Cristo è il Salvatore? Oggi
moltissimi non lo sanno più; l’uomo moderno
spesso ragiona così: sto bene in salute, ho una
famiglia, un lavoro, un certo benessere, da che
cosa debbo essere salvato?
La parola “salvezza” si è talmente svuotata di
significato che quando chiediamo alla gente
comune, ma anche ai cattolici, perchè Gesù è
venuto, spesso le risposte che raccogliamo
sono: “per insegnarci delle cose”, “per portare
pace e amore”, e perfino “per fondare la sua
religione”. Si sta sempre più perdendo di vista
il centro della missione di Gesù, il fatto che
Cristo è venuto in primo luogo a salvarci. La
parola stessa “Gesù” vuol dire “il Dio che
salva”. Da cosa ci salva? ...sentiamo a volte
chiedere. In realtà la domanda giusta è: per
cosa ci salva? Ci salva per riportarci da dove
siamo venuti: nel cuore stesso di Dio. I
filosofi continuano a chiedersi da dove
veniamo, mentre Cristo a questa nostra
origine ci ha già riportato. E non si tratta solo
di scoprire con la mente la nostra provenienza
ontologica: si tratta di restituire le nostre
esistenze a chi realmente appartengono, si
tratta di rimettere i tralci alla vite che li ha
generati; si tratta di restituire al proprio mare
quei pesci che il peccato ha gettato lontano
sulla sabbia o sugli scogli; si tratta di restituire
le scintille al fuoco che li ha generati. Prima
che si spengano. Ogni mio gesto in direzione
contraria mi spegne. Ogni mio passo in altra
direzione è la morte. Ecco da cosa sono
salvato: da me stesso, dalle mie scelte
sbagliate, dal peccato, semplicemente perché
peccando muoio, mi spengo, non respiro,
secco. Sono salvato dalla dannazione eterna,
ma già a partire da quella dannazione terrena a
cui il peccato riduce la mia vita. Sono salvato
dalle tenebre, morali e spirituali. Ma
soprattutto sono salvato per la vera Vita che
in cambio mi viene donata, per la grande gioia
che ne ricevo, per quel paradiso di Amore che
mi attende senza fine dentro la gloria di Dio, e
per tutte quelle anticipazioni regalate quaggiù
dai doni dello Spirito. Anche tra le afflizioni.
Un ladro sta morendo sulla croce. Tutto è
atrocità, sangue, disperazione; quando un altro
uomo in croce come lui lo guarda e gli dice:
“Oggi stesso sarai in Paradiso con me”. Ecco:
questa è la salvezza. Anche se io sono ancora
sulla croce, anche se sto ancora pagando per il
mio peccato, anche se non riesco nemmeno a
vedere quell’uomo che mi parla perchè i miei
occhi sono coperti di sangue, di sudore, di
lacrime, io però sono già salvo. Ho ricevuto
uno sguardo buono, sono stato considerato
(pesato, scrutato, in ogni granello della mia
vita), ed ecco che, poiché quello sguardo è lo
sguardo di un Dio, e quella considerazione è
sostenuta da un Amore infinito, allora sono
fatto salvo. L’abisso non mi ha più, sono di
Dio, sono finalmente mio.
“...E per opera dello Spirito Santo si è
incarnato...”
Caro factum est, scrive l’apostolo Giovanni
all’inizio del suo vangelo: il Verbo si è fatto
carne. Il nostro Credo c’invita qui a ricordare
il mistero dell’Incarnazione, un miracolo
avvenuto “per opera dello Spirito Santo”. Il
fatto che il Figlio di Dio abbia assunto natura
umana è il tratto distintivo della fede cristiana.
E questo Giovanni lo sottolinea chiaramente:
“Da questo potete riconoscere lo spirito di
Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù
Cristo è venuto nella carne, è da Dio” (1Gv
4,2). Le affermazioni del Simbolo del Credo
sono quindi criterio di discernimento per
riconoscere i cristiani. Abbiamo già avuto
occasione di ricordare, che nella lingua greca
la parola symbolon indicava quella metà di un
oggetto spezzato in due che, ricongiunto
all’altra metà, serviva come segno di
riconoscimento di una persona. Allo stesso
modo il Simbolo del Credo verifica l’identità
di un credente. Chi crede che Dio si è fatto
uomo in Gesù è cristiano; chi non lo crede
non è cristiano. L’Incarnazione, infatti, è,
assieme alla Morte e Risurrezione, il centro
della fede cristiana, il fondamento di tutto
quanto il cristianesimo.
Si tratta, certamente, di un Mistero che sfugge
in gran parte alla nostra ragione, ma questo
non c’impedisce di indagare, alla luce della
Scrittura, sul perchè dell’Incarnazione.
San Paolo, riecheggiando i Salmi, scrive:
“Per questo, entrando nel mondo, Cristo
dice: Tu non hai voluto né olocausti né
offerte,
un
corpo
invece mi
hai
preparato...Allora ho detto: Ecco io vengo...
per fare la tua volontà” (Eb 10,5-7); ecco
quindi una prima risposta: Cristo s’incarna
per fare la volontà del Padre. Luca ci
fornisce una seconda risposta: Dio si è
incarnato per adempiere le promesse (Lc
1,55), quelle fatte ad Abramo ed alla sua
discendenza. Giovanni ci fornisce una terza
risposta: il Verbo si è fatto carne per
cancellare i nostri peccati (1Gv 3,5);
l’apostolo scrive infatti che Dio “ha mandato
il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati” (1Gv 4,10). Cristo dunque
viene per riconciliarci con Dio. Al centro
della sua missione vi è la Salvezza:
l’Incarnazione è avvenuta per salvarci. “Il
Padre ha mandato il suo Figlio come
Salvatore del mondo” (1Gv 4,14). Ma
possiamo rispondere anche in altro modo alla
nostra domanda: l’Incarnazione è avvenuta
perchè Dio ci ama; “Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito” (Gv 3,16). Ed è avvenuta anche
perchè noi conoscessimo l’amore di Dio.
L’Incarnazione reca con sé numerosi doni,
perchè tramite essa riceviamo la vita. “Dio
ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo
perchè noi avessimo la vita per lui” (1Gv
4,9). Si tratta di una vita nuova quaggiù, ma si
tratta anche della vita eterna. Dio ci ha
mandato il Figlio “perchè chiunque creda in
lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv
3,16). Un altro dono (o motivo) racchiuso
nell’Incarnazione è l’adozione a figli:
“Quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato
sotto la Legge, per riscattare coloro che
erano sotto la Legge, perchè ricevessimo
l’adozione a Figli” (Gal 4,4-5): il Figlio di
Dio si è fatto uomo affinché l’uomo
divenisse figlio. Sant’Ireneo di Lione (II Sec)
scrisse: “Questo è il motivo per cui il Verbo si
è fatto uomo, e il Figlio di Dio figlio
dell’uomo: perchè l’uomo, entrando in
comunione con il Verbo e ricevendo così la
filiazione divina, diventasse figlio di Dio”
(Adversus Haereses 3,19,1). Il Catechismo
della Chiesa Cattolica, oltre a ricordare tutte
le motivazioni sopra esposte, ci indica
un’altra ragione dell’Incarnazione: il Verbo si
è fatto carne per fornirci un modello di
santità (CCC 459). Si tratta però di un
modello che ci assorbe in sé, trasformandoci a
sua immagine, facendoci partecipe della sua
natura, perché Gesù “pur essendo di natura
divina, non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio” (Fil 2,6). Se il Verbo
s’incarna, dunque, è anche perchè
diventassimo partecipi della natura divina
(2Pt 1,4).
San Gregorio di Nissa (IV secolo) testimonia:
“La nostra natura, malata, richiedeva di
essere
guarita;
decaduta,
d’essere
risollevata; morta, di essere risuscitata.
Avevamo perduto il possesso del bene; era
necessario che ci fosse restituito” (Oratio
Catechetica, 15).
“...nel seno della Vergine Maria...”
Il Verbo di Dio, per opera dello Spirito Santo,
si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Il
disegno di salvezza attuato dal Padre nella
Nuova Alleanza non vede all’opera solo la
persona del Figlio, ma anche quella dello
Spirito Santo. La nostra redenzione è
realizzata dalla mirabile collaborazione delle
tre Persone divine. Lo Spirito Santo è presente
in tutti i misteri della vita di Cristo, opera in
lui e attraverso di lui in ogni momento della
sua missione. Dopo averla preparata ispirando
tutti i profeti fino al Battista, prepara anche
l’incarnazione di Gesù, santificando il nido
del suo concepimento. Forgia dunque Maria
rendendola “tempio dello Spirito Santo”, in
vista del fatto che questa fanciulla di Nazaret,
per disegno del Padre, sarebbe divenuta
tabernacolo del Dio incarnato. E questa
preparazione della culla del Verbo è talmente
accurata da vedere lo Spirito Santo all’opera
già al momento in cui Maria è concepita nel
grembo di sua madre. Viene infatti preservata
e custodita dalla Grazia fin dall’inizio del suo
primo esistere. “La beatissima Vergine
Maria, nel primo istante della sua
concezione, per una grazia ed un privilegio
singolare di Dio onnipotente, in previsione
dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere
umano, è stata preservata intatta da ogni
macchia del peccato originale”: è quanto
scrive Pio IX nella sua bolla Ineffabilis Deus
(DS 2803), con la quale proclama il dogma
dell’Immacolata Concezione. E’ per questo
dono particolare dello Spirito che l’arcangelo
Gabriele, al momento dell’Annunciazione,
saluta Maria come “la piena di Grazia” (Lc
1,28). E il “sì” della Vergine è anch’esso
posato sulle sue labbra dal divino Paraclito:
frutto di una libertà come mai vi era stata
perché già pienamente redenta. Il Signore è
con Te perchè ora sia anche in Te. Tu sei la
benedetta fra tutte le donne. “Eccomi, io sono
la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto” (Lc 1,38). Totale fiducia.
Totale abbandono. Totale donazione di sé.
Annunciazione, incarnazione. E’ benedetto il
frutto del seno tuo Gesù. E’ significativo che
il Simbolo del nostro Credo, proprio
nell’istante in cui affonda nel centro del
Mistero, definendo l’Incarnazione, definisca
anche Maria. E questo piccolo credo mariano,
scintilla di luce visibile all’interno di un
mistero invisibile, è presente sia nel testo
antichissimo di Nicea-Costantinopoli (“per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria”), sia in quello
ancora più antico degli Apostoli (“il quale fu
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine”). Il Simbolo, congiungendo Maria
alla verità dell’incarnazione, diventa qui fonte
della nostra fede mariana. Ci fa capire che
l’Eterno Padre, magnifico nella sua
Misericordia, donandoci il Figlio ci dona
anche la Madre. Maria, la “Tutta Santa”
(Panaghia, come dicevano i Padri Orientali).
Maria, la Madre di Dio (Theotokos, come
dicevano i Padri Greci). Maria, Regina del
cielo e della terra (come dice la Chiesa).
Maria, mediatrice di tutte le grazie, a tal punto
che “qual vuol grazia ed a Te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz’ali” (Paradiso di
Dante, XXXIII, 14-15).
Possiamo dunque anche noi dire: L’anima tua
magnifica il Signore, o Maria, e il nostro
spirito esulta in Dio perché ci hai donato il
Salvatore.
Salve
Regina,
madre
di
misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra.
A te ricorriamo noi, figli del peccato
originale. A te sospiriamo in questa vita di
lacrime. Rivolgi a noi la misericordia di cui
sei stata colmata, regina degli angeli e dei
santi. Mostraci nel nostro esilio Gesù, il frutto
benedetto dell’amore del Padre. Attraverso il
tuo grembo ci è giunta la salvezza. Mettici al
mondo come figli di Dio. Crescici nella fede e
custodiscici col tuo manto. Prega per noi
peccatori, o dolce Vergine Maria.
“...e si è fatto uomo...”
Ecco la novità che il cristianesimo annuncia al
mondo: Dio si è fatto uomo. Si è fatto carne,
si è fatto storia, si è fatto esperienza visibile
per noi, tanto che gli apostoli possono dire:
“Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi
abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani
hanno toccato...”. E’ un avvenimento, un
incontro. L’umanità passa dal “Dio su noi” al
“Dio con noi” (l’Emmanuele). E’ un evento
unico e del tutto singolare. E “non significa
che Gesù Cristo sia in parte Dio e in parte
uomo”, dice il Catechismo, ma che “Egli si è
fatto veramente uomo rimanendo veramente
Dio. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo”
(CCC 464). La Chiesa ha sempre difeso
strenuamente, nel corso dei secoli, questa
verità di fede che emerge dal Vangelo. Il
dogma della duplice natura di Cristo è a
fondamento della fede cristiana, e non solo
cattolica. Cristo possiede sia la natura umana
sia la natura divina. E attenzione: non solo le
possedeva, ma le possiede tuttora. E’ anche
adesso vero Dio e vero uomo. In una sola
Persona. Tutto ciò che la natura umana di
Cristo compiva, era compiuto anche dalla
natura divina. “Tutto, quindi, nell’umanità di
Cristo deve essere attribuito alla persona
divina come al suo soggetto proprio”
(Concilio di Efeso, DS 255). Non vi è stata
unione o confusione di nature, ma le nature,
umana e divina, sussistono entrambe in una
sola persona. Gli antichi concili sono molto
chiari su questo: “Si indica la diversità delle
nature, nella quale si è realizzata l’ineffabile
unità senza confusioni, senza che il Verbo
passasse nella natura della carne, e senza che
la carne si trasformasse nella natura del
verbo” (II°Concilio di Costantinopoli, c.VII).
E aggiunge: “Due sono le nascite del Verbo di
Dio, una prima dei secoli dal Padre, fuori dal
tempo e incorporale, l’altra in questi nostri
ultimi tempi, quando egli è disceso dai cieli,
s’è incarnato nella santa e gloriosa madre di
Dio e sempre vergine Maria, ed è nato da
essa” (ibid, c.II). Due nascite e due nature
quindi, ma in una sola Persona, quella del
Cristo. E la natura divina di Gesù non
impediva alla sua natura umana né di soffrire
né di morire. Anzi, pur essendo vero che Dio
è sempre nella gloria e quindi nella
beatitudine, sia la morte in Croce sia le
sofferenze appartengono alla seconda Persona
della Trinità che ne rimane pienamente il
soggetto (ibid, c.III; CCC 468). Il Verbo di
Dio che opera miracoli è lo stesso Cristo che
ha sofferto. Né la natura divina impediva
l’esistenza, in Cristo, di un’anima umana. La
caratteristica della natura umana è, infatti,
quella di possedere sia il corpo sia l’anima; e
dunque Gesù, veramente uomo, possedeva
un’anima umana, così come possedeva una
volontà ed un’intelligenza umana (CCC 470).
Il Concilio di Calcedonia (anno 451) afferma:
“Seguendo i santi Padri, all’unanimità noi
insegniamo a confessare un solo e medesimo
Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto
nella sua divinità e perfetto nella sua
umanità, vero Dio e vero uomo con anima
razionale e corpo, consostanziale al Padre
per la divinità, e consostanziale a noi per
l’umanità, ‹‹simile in tutto a noi fuorché nel
peccato›› (Eb 4,15)” (Concilio di Calcedonia,
DS 301). La differenza delle due nature non è
per nulla negata dalla loro unione, né avviene
alcun mutamento in ciascuna delle due nature:
“Rimase quel che era e quel che non era
assunse” canta la Liturgia Romana. Occorre
inoltre respingere l’affermazione che Gesù sia
“diventato” il Cristo: “Il Figlio Unigenito del
Padre, essendo concepito come uomo nel
seno della Vergine Maria, è ‹‹Cristo››, cioè
unto dallo Spirito Santo, sin dall’inizio della
sua esistenza umana” (CCC 486); pertanto
tutta la vita di Cristo è Rivelazione del Padre,
e la sua umanità “appare come ‹‹il
sacramento›, cioè il segno e lo strumento
della sua divinità” (CCC 515,516). Né
sarebbe corretto dire che il Verbo abbia
trascorso “un lunghissimo periodo di tempo
senza la natura umana”, perché il Verbo è,
appunto come dissero i Padri, fuori dal tempo.
Le due nascite sono in qualche modo
“contemporanee”, nella stessa misura in cui
Dio è “contemporaneo” a tutte le epoche della
nostra storia, così come il centro immobile di
una ruota è alla stessa distanza da tutti i suoi
punti. E’ proprio per questa sua divina
partecipazione al mistero del tempo che Cristo
è Ricapitolazione di tutte le cose: ha
ricapitolato in se stesso tutta la storia umana,
ed ha ristabilito l’uomo decaduto; ha vissuto
la sua vita non per sé ma per noi. Si è fatto
nostro modello, permettendo che tutto ciò che
Egli ha vissuto, noi potessimo viverlo in lui.
Di più: fa sì che Egli lo viva in noi. In tal
modo ci rende compartecipi della sua divina
natura: “L’Unigenito Figlio di Dio, volendo
che noi fossimo partecipi della sua divinità,
assunse la nostra natura, affinché, fatto
uomo, facesse gli uomini dei” (San Tommaso
d’Aquino).
“Fu crocifisso per noi”
La croce. Centro della nostra fede e fonte
della nostra salvezza. La crocifissione di Gesù
non è stata la semplice esecuzione di una
condanna, conseguenza della volontà di capi
giudei o romani. E nemmeno è stata frutto di
un destino a cui Gesù non avrebbe potuto
sottrarsi con la sua volontà. Gesù sa di andare
incontro alla croce, e la sceglie. Non la sceglie
per amore del dolore, come possiamo bene
capire dal pianto nel Getsemani: la sua
supplica chiede al Padre di allontanare da sé
quel calice. Non ha progettato la croce per se
stesso; ma, posta davanti come unica via di
salvezza per gli uomini, egli la fa sua. Il
progetto del Padre non è la croce in sé, ma la
nostra salvezza. La croce è il volto che la
nostra salvezza assume nella storia. Se un mio
fratello venisse travolto e schiacciato da un
peso che con le sue forze non riesce a
sollevare, non mi sottraggo dal ferirmi le mani
pur di salvarlo: per amore colgo quella piccola
missione pur non avendo avuto, per me, il
progetto di ferirmi; non posso affermare che
ho scelto quelle ferite in se stesse. Ho scelto
invece la salvezza di quel fratello, salvezza
che in tale circostanza passava attraverso
quelle ferite; mi sono fatto carico della sua
situazione e l’ho fatta mia. San Paolo scrive:
“Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Scritture” (1Cor 15,3). La croce ha dunque in
sé questi significati: espiazione, riparazione,
redenzione. Espiazione perché Cristo paga
sulla croce il prezzo di tutti i peccati passati,
presenti e futuri commessi da tutti gli uomini:
“Non vi è, non vi è stato, e non vi sarà alcun
uomo per il quale Cristo non abbia sofferto”
(DS, 624). Tramite la sua natura umana poté
soffrire, tramite quella divina poté farlo
infinitamente. Non riusciremo mai a
comprendere la pienezza della sofferenza di
Gesù, soprattutto nel suo risvolto spirituale.
Possiamo però entrare in comunione con essa
tramite il dono dell’eucaristia, da lui
misticamente istituita durante l’ultima cena, e
da lui perennemente celebrata sugli altari. La
Croce di Gesù è sacrificio, e questo sacrificio
è lo stesso di quello della Messa. La Croce è
anche, come abbiamo detto, riparazione,
perché espiando i nostri peccati, Cristo li
cancella. Fin dal battesimo nel Giordano,
Giovanni il Battista indica Gesù come
l’agnello sacrificale perfetto che paga per i
nostri peccati: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco
colui che toglie i peccati del mondo” (Gv
1,29). A volte qualcuno s’interroga: può
qualcuno saldare il debito (verso Dio) di
qualcun altro? Nell’economia della salvezza
voluta dal Padre, sì. Nelle relazioni terrene
non è così: se entro in una cristalleria piena
d’oggetti preziosi e per sbadataggine ne faccio
cadere alcuni, che a loro volta ne fanno cadere
altri, combinando un disastro a catena, non
posso che aspettarmi di vedermi comparire
davanti il padrone che mi dice: “Adesso non
te ne vai di qui se non paghi tutto fino
all’ultimo centesimo”, e a me, specie se sono
povero in canna, non rimane che la
prospettiva della galera o di rimanere schiavo
di quel padrone per sempre. Solo una cosa
potrebbe salvarmi: che il figlio di quel
padrone, combinazione, fosse il mio più
grande amico, e mi amasse in modo
particolare; e allora, ricco di tutta la sostanza
del padre, potrà dire: “Non ti preoccupare,
padre, pago io per lui”. Chi non sarebbe grato
di un gesto così? Eppure questo è il gesto
compiuto da Gesù verso di noi, per il quale,
spesso, molti non ringraziano nemmeno,
escludendosi da quell’eucaristia che, oltre ad
essere comunione col suo sacrificio, è anche
rendimento di grazie. Abbiamo detto che la
Croce è anche redenzione: cancellando i
nostri peccati Cristo ci salva. Com’è possibile
sostenere che Gesù salva tutti e nello stesso
tempo affermare che non tutti si salvano? Mi
si permetta un’ultima metafora: un gruppo di
minatori rimane imprigionato nelle viscere di
una miniera, nel buio più completo non sanno
nemmeno da che parte scavare; sono destinati
a morire lì. Ma un loro compagno rimasto
all’esterno, accortosi della situazione, si
precipita con badile e piccone contro la roccia
ed i cumuli di terra che occludono la via verso
la salvezza. Lavora in modo tremendo per ore,
affaticandosi molto e facendosi male, ma alla
fine raggiunge il gruppo e dice: “Ecco la luce,
venite fuori, siete salvi”. Quella salvezza non
è forse per tutti? Eppure parte di loro sceglie
di rimanere assurdamente nel buio e nel
freddo, rifiutando la vita, rifiutando cioè di
salvarsi. Solo il gruppo che segue il
coraggioso minatore si avvia verso la luce.
Quel minatore, come si è capito, è Gesù. Quel
manipolo di persone sporche che lo segue,
quella piccola compagnia che da un lato
gioisce e dall’altro, con le lacrime agli occhi,
continua a gridare verso i fratelli rimasti
dentro perché non si rassegna a non vederli
salvati, è la chiesa.
“...sotto Ponzio Pilato”
E’ singolare che l’unico uomo ricordato nel
Credo, l’unico contemporaneo di Gesù il cui
nome è ricordato nella nostra Professione di
Fede, sia una persona che fede non ne ebbe;
un uomo che anzi “se ne lavò le mani”. E
paradossalmente proprio costui ebbe il suo
nome scolpito per sempre nell’eterno Simbolo
dei cristiani. Non Pietro, non Giovanni o un
altro degli apostoli; ma lui, Ponzio Pilato, lui
che non credette, che non seppe riconoscere la
Luce, e che anzi ordinò la morte del Figlio di
Dio quando questo gli comparì dinanzi.
Eppure inchiodando il Cristo, inchiodò per
sempre il proprio nome al mistero della
salvezza. Ordinò la morte di chi gli offriva in
dono la vita, ma uccidendolo, lo vide morire
anche per lui. Pilato rappresenta in fondo
l’umanità tutta; non è più solo il procuratore
romano della Giudea: ciò che egli compie, è
in lui compiuto da tutta l’umanità peccatrice.
Pilato rappresenta anche la storia, la
dimensione del tempo, dentro la quale
s’incarna il mistero della Croce. L’orizzontale
che viene attraversato dalla verticalità di Dio.
Il nome di Pilato inserito nel Credo indica che
l’eternità di Dio c’incontra in un “qui” e in un
“ora” che è quello della nostra vita terrena, e
che ci salva nella concretezza del nostro
tempo. La sua redenzione incontra il nostro
volto, il nostro nome, in modo del tutto
personale ed unico.
Ma Pilato, oltre a rappresentare la nostra
umanità che crocifigge continuamente il
Cristo, rappresenta anche il Male, il male
metafisico che agisce nella storia, che
s’insinua come un serpente nei poteri del
mondo, che spesso appare come un potere
assoluto e incontrastato, ma in realtà agisce
all’interno di un disegno più alto, di cui non si
avvede, scritto da qualcuno che ha vinto il
mondo. Un disegno che schiaccia la testa di
questo serpente e rende il Cristo vittorioso. Se
quello di Pilato è l’unico nome d’uomo che
appare nel Credo, poco più sopra vi è quello
di una Donna: Maria, la Donna sopra il
serpente. Il nome di Pilato è, nel Simbolo,
legato al verbo morire; quello di Maria è
legato al verbo nascere. Il Credo dipinge
davanti ai nostri occhi tutto il quadro della
vita e della morte, il mistero del bene e del
male. Tra il nome di Maria e quello di Pilato
c’è quel “farsi uomo” che racchiude tutto il
mistero. C’è quell’Uomo generato da Lei e
che in Lei schiaccia il serpente. Ecco, questa è
la vera icona del rapporto bene-male. A volte
trattiamo bene e male come se fossero due
realtà complementari con lo stesso peso. Ci
capita perfino di udire: “Senza il bene non ci
sarebbe il male, e senza il male non ci sarebbe
il bene”. Ma questa è la più grande
sciocchezza: come se tra male e bene vi fosse
un rapporto di causa. Dire “senza il bene non
ci sarebbe il male”, insinua l’idea che il male
sia in qualche modo causato dal bene. La fede
cristiana invece c’insegna che il Bene, come
assoluto morale, coincide con Dio, e Dio (che
nella sua perfezione è privo d’ogni
contraddizione) non può essere causa di male.
Il male non è realtà uguale e contrapposta al
bene, ma sua assenza. L’evangelista Giovanni
spiega in modo esemplare che il rapporto
male-bene è come il rapporto tenebre-luce. Le
tenebre non sono altro che assenza di luce, e
non esistono a causa della luce, ma semmai è
vero il contrario: se la luce non c’è, vi è
tenebra. Allo stesso modo è pure falsa
l’opposta affermazione: “senza il male non vi
sarebbe il bene”. Senza il male staremmo
meglio tutti! Non ho bisogno di uno schiaffo
per apprezzare una carezza, o di una
pugnalata per apprezzare la vita, o di un
aborto per apprezzare una nascita. Il male in
realtà è solo serpente schiacciato, poltiglia
inconsistente. Mentre il bene ha carattere
d’infinitudine e d’eternità, il male non può
vantarsi nemmeno del verbo essere, in quanto
la sua vera natura, ci dice il Vangelo, è
assenza; mancanza d’essere. Chi sceglie il
male, perde pure quello che ha, perde se
stesso, la propria vita; sceglie la dannazione
del non-essere. Chi invece cammina sulla via
del Bene, cammina nella totalità, gode già di
tutto l’esistente, non si perde nulla. Non vi è
obbiettivo che non possa essere raggiunto (e
meno dolorosamente) tramite la santificazione
nel Bene.
“Morì e fu sepolto”
Qui il Credo sprofonda nell’abisso della morte
di Dio, si seppellisce con essa. Non la morte
di Dio come la intendeva Nietzsche (Dio che
muore nel cuore dell’uomo), ma anzi la sua
soluzione, una morte che resuscita il cuore
dell’uomo. Non possiamo leggere il mistero
della morte di Gesù separato da quello della
sua Risurrezione. Cristo, morendo, rinasce in
noi. La Croce è l’albero della Vita che
reinnesta in sé gli umani tralci strappati dal
peccato e dalla morte in esso contenuta,
rivitalizzandoli. Con la morte in croce si
esprime il culmine della Passione, parola
bellissima perché è formata da altre due
grandi parole: Amore e Dolore. Patire, nel
linguaggio del Vangelo, vuol dire soffrire con
amore, soffrire per amore. Quando diciamo
“Patì sotto Ponzio Pilato”, diciamo tutto,
perché in quel patì è racchiuso l’intero
mistero della nostra salvezza. E’ un vocabolo
che contiene il colmo del dolore e il colmo
dell’amore. In teologia adoperiamo anche qui
il termine mistero, ad indicare che la nostra
mente non ha la capacità d’immaginare verità
così alte: in questo caso non è nemmeno in
grado d’intuire la misura di questo amore,
così come non è in grado di comprendere
l’infinitudine del dolore. Si pensa tutt’al più al
dolore materiale dei chiodi, ma quel grido
“Dio mio perchè mi hai abbandonato” indica
nello spirito, più che nel corpo, la vera agonia
di Gesù. Sappiamo quanto soffersero i santi
nei deserti spirituali in cui, messi alla prova,
Dio si sottraeva ai loro sguardi interiori; essi
soffrivano in modo indicibile perché si erano
svuotati di tutto per riempirsi di Dio: quando
perciò Dio sembrava sottrarsi da loro
lasciandoli “vuoti”, essi soffrivano come se la
loro stessa anima gli venisse tolta! Se dunque
pensiamo al Cristo, che per la sua particolare
e consustanziale unione col Padre ne era
infinitamente colmo, si capisce che il dolore
di spoliazione interiore fu veramente
immenso, come se si aprisse nella sua anima
squarciata un vuoto infinito! Nonostante
quest’abisso di dolore gli venisse già
prospettato nel Getsemani, Gesù vinse la
paura perché era consumato da un amore
altrettanto infinito, dal desiderio intrattenibile
di salvarci. Nel nostro linguaggio umano
usiamo, infatti, la parola “passione” anche ad
indicare un grande desiderio; in questo caso si
tratta del desiderio ardente di Gesù di patire
per noi: “Sono venuto a portare il fuoco sulla
terra, e come desidero che fosse già
acceso!”(Lc 12,49). Il fuoco che egli
ardentemente desiderava accendere sulla terra,
era il fuoco del suo amore per noi. Voleva che
ardesse nel nostro petto, come sperimentarono
i due discepoli di Emmaus dopo l’incontro col
Risorto: “Non ci ardeva forse il cuore nel
petto, mentre conversava con noi lungo il
cammino?”(Lc 24,32). Ma affinché questo
fosse possibile, era necessario passare
attraverso il battesimo di sangue della morte
in croce: “C’è un battesimo che devo
ricevere, e come sono in ansia finché non sia
compiuto!”(Lc 12,50). Gesù era travolto dalla
passione per noi, dallo struggente desiderio di
patire per averci con sé per sempre, per
stringerci nell’amore per l’eternità. Passione
per la passione. Che grandezza vi è racchiusa
nel cuore di Cristo in croce, grandezza che in
parte ci fu rivelata anche attraverso i mistici,
tra cui S. Margherita Maria Alacoque (16471690), che ebbe delle rivelazioni speciali
riguardo al Sacro Cuore. Anche suor Faustina
Kowalska
(1905-1938)
fu
fulminata
dall’amore che trapassava il Cuore di Cristo e
poi il suo. Se la teologia non dice di questo
amore, essa si riduce a scienza fredda del
Cristo. Ed anche quando si parla delle
stimmate di santi come San Pio da Pietrelcina,
o quando s’illustra la Sacra Sindone, non si
può ridurre tutto al semplice esame scientifico
dei dati, tacendo il mistero di quell’amore
senza il quale ogni ferita perde il suo
significato di salvezza. Occorre sempre
incastonare quei dati, teologici o scientifici
che siano, all’interno della teologia della
Passione, ed alla luce del divino Amore.
Spiegando anche che la passione di Cristo non
rimase eroismo solitario, ma si circondò di
una compagnia; di un “patire con”: è questo il
significato
profondo
della
parola
compassione. Perché noi tutti, sani od infermi,
siamo chiamati ad essere compartecipi di
questa stessa passione (cfr CCC 618). Le
nostre ferite possono in Cristo diventare
finestre attraverso cui irradia la redenzione
della croce. La morte di Gesù c’invita ad
offrire il nostro dolore e la nostra vita
sull’altare del suo sacrificio. E’ questo il
senso dell’offertorio durante la Santa Messa!
Non la monetina lasciata cadere nel cestino,
ma la nostra intera vita lasciata cadere nella
fornace ardente del cuore di Gesù, l’offerta
dei nostri dolori per il disegno di salvezza
delle anime: se questo non viene detto, la
messa si riduce a puro rito. Se nessuno ci
spiega più questo vero senso del Corpo
Mistico, allora sì, Dio è morto, ed ha ragione
Nietzsche. Ma Dio vive perché noi offriamo
le nostre membra a questo corpo, ed
accettiamo di essere crocefissi con Lui,
trapassati dal suo amore ardente, seppelliti
con Lui per poi in lui essere risorti.
“Il terzo giorno è risuscitato”
Vi è un brano del Vangelo di Matteo che
riporta un evento sorprendente avvenuto il
venerdì santo, immediatamente dopo la morte
di Gesù: “Le rocce si spezzarono, i sepolcri si
aprirono, e molti corpi di santi morti
risuscitarono” (Mt 27,51-52). Questi versetti
ci rivelano una cosa molto importante: la
morte di Gesù è già pregna di risurrezione.
Quei risorti sono il segno fisico di un evento
grandioso ed invisibile che sta avvenendo nel
regno dei morti. Il Simbolo degli Apostoli
inserisce, dopo la morte di Cristo, un
annuncio: “Discese agli inferi”. Il forte grido
che Gesù emette sulla croce si trasforma, al
momento della sua morte, in grido di gioia di
tutti i credenti che nell’oltretomba
attendevano la salvezza: la luce del Risorto
divampa nelle tenebre e miliardi di anime
possono, dopo secoli, finalmente vedere la
redenzione; un evento di portata incalcolabile
che traboccò in superficie con quei risorti che,
“usciti dalle tombe, dopo la risurrezione di
Gesù entrarono a Gerusalemme ed apparvero
a molti” (Mt 27,53). Segno fisico di un
maestoso avvenimento metafisico. L’apostolo
Pietro amò ricordare nelle sue lettere la
discesa agli inferi di Gesù: “Messo a morte
nella carne, ma reso vivo nello spirito, andò,
in spirito, ad annunziare la salvezza anche
agli spiriti che attendevano in prigione” (1Pt
3,19; cfr 1Pt 4,6). Se ne parla anche nel
Catechismo della Chiesa Cattolica: “La
discesa agli inferi è il pieno compimento
dell’annunzio evangelico della salvezza”
(CCC 634). E si legge: “Le frequenti
affermazioni del Nuovo Testamento secondo
le quali Gesù è risuscitato dai morti (At 3,15;
Rm 8,11; 1Cor 11,20) presuppongono che,
preliminarmente alla Risurrezione, egli abbia
dimorato nel soggiorno dei morti. E’ il senso
primo che la predicazione apostolica ha dato
alla discesa di Gesù agli inferi: Gesù ha
conosciuto la morte come tutti gli uomini e li
ha raggiunti con la sua anima nella dimora
dei morti. Ma egli vi è disceso come
Salvatore, proclamando la Buona Novella
agli spiriti che vi si trovavano prigionieri”
(CCC 632). Cristo ha infatti “potere sopra la
morte e sopra gli inferi” (Ap 1,18), e come
fase finale della sua missione si riapproprierà
egli stesso del suo corpo “al fine di essere lui
stesso, nella sua Persona, il punto d’incontro
della morte e della vita, arrestando in sé la
decomposizione della natura causata dalla
morte e divenendo lui stesso principio di
riunione per le parti separate” (San Gregorio
di Nissa).
E’ difficile accostarsi ad un mistero così alto
come quello della Risurrezione di Cristo; il
tesoro che essa racchiude è inesauribile. Si
tratta dell’avvenimento su cui si fonda non
solo la fede, ma la nostra stessa vita. E non
bisogna mai stancarsi di ricordare che la
Risurrezione fu un evento sia fisico sia
metafisico. L’errore più comune è ridurla ad
uno solo dei due aspetti. E’ sbagliato sia
considerarla come un fatto di natura solo
spirituale, privo di fisicità e di storicità, e sia
limitarsi all’aspetto storico-fisico. Il centro
della teologia della Risurrezione non è certo il
“sepolcro vuoto”, ma il Cristo Risorto che si
lascia incontrare anche ai nostri sensi, come
raccontano dettagliatamente i testimoni
oculari, che narrano con grande concretezza le
loro esperienze, riportate da tutti e quattro gli
evangelisti con particolare cura. E pertanto chi
vuole occuparsi di teologia non deve cedere
alla tentazione di sminuire il fatto per
adattarlo meglio alla nostra ragione, come
fecero gli apostoli quando, al primo incontro
col Risorto, respingono l’evidenza della sua
fisicità preferendo pensarlo un fantasma (Lc
24,37). Nel Vangelo il Risorto ci tiene a far
riconoscere la sua corporeità, stabilendo con i
testimoni rapporti diretti, a volte attraverso un
contatto fisico (Lc 24,39; Gv 20,27), altre
attraverso la condivisione di un pasto (Lc
24,30.41-43; Gv 21,9.13-15). E’ per questo
che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice:
“Davanti a queste testimonianze è impossibile
interpretare la Risurrezione di Cristo al di
fuori dell’ordine fisico e non riconoscerla
come un avvenimento storico” (CCC 643). E
pertanto la Chiesa considera la Risurrezione
“un avvenimento reale che ha avuto
manifestazioni
storicamente
constatate”
(CCC 639), un “avvenimento storico
constatabile” attraverso i segni (CCC 647). Al
tempo stesso però non possiamo ridurre la
risurrezione di Cristo alla semplice
dimensione fisica. Il Catechismo la definisce
un avvenimento sia storico sia trascendente
(CCC 639), un avvenimento ben diverso dalle
altre resurrezioni umane che leggiamo nel
testo sacro. E’ una risurrezione che risorge
me; che provoca alla mia anima lo stesso
effetto che provocò ai credenti degli inferi;
che spezza le mie rocce interiori e dischiude il
sepolcro in cui m’imprigiona il peccato; che
m’irradia di luce redentiva, e nella gioia
conduce anche me, verso la Città santa,
assieme a tutti i risorti.
“...Secondo le Scritture...”
Quale significato ha l’espressione “secondo le
Scritture” che troviamo all’interno del nostro
Simbolo di fede? Cosa significa dire che Gesù
è morto e risorto secondo le Scritture? A
questa domanda, che introduce una serie
d’importantissime riflessioni teologiche sul
tempo e sul destino, risponde in modo chiaro
il Catechismo della Chiesa Cattolica: “La
Risurrezione di Cristo è compimento delle
promesse dell’Antico Testamento e di Gesù
stesso durante la sua vita terrena.
L’espressione «secondo le scritture» indica
che la Risurrezione di Cristo realizzò queste
predizioni” (CCC 652). Il primo a svelarci che
gli avvenimenti della passione non si sono
svolti per caso è proprio Gesù, con le sue
parole rivolte ai discepoli di Emmaus dopo la
risurrezione: “O stolti e tardi di cuore a
credere a quello che hanno detto i profeti!
Non doveva forse il Cristo patire tutto questo
ed entrare nella sua gloria?” (Lc 24,25-26). E
quel giorno, “cominciando da Mosè e da tutti
i profeti spiegò loro quanto lo riguardava in
tutte le Scritture”. E così facendo “aprì loro
la mente all’intelligenza delle Scritture” (Lc
24,45), cioè diede la chiave interpretativa
della Bibbia affinché questa venisse da quel
momento in poi letta alla luce del grande
disegno salvifico di Dio. Una prova che tale
insegnamento venne subito recepito, e che
l’espressione contenuta nel Credo non è un
arbitrio dei Padri di Nicea-Costantinopoli che
lo forgiarono, è già racchiusa nella prima
Lettera di Paolo ai Corinzi: “Vi ho dunque
trasmesso, anzitutto, quello che ho ricevuto,
che Cristo morì per i nostri peccati secondo
le Scritture, e che fu sepolto, e fu risuscitato il
terzo giorno, secondo le Scritture” (1Cor
15,3-4). Ecco perché il Catechismo, senza
tema di sbagliare, può affermare: “La morte
violenta di Gesù non è stata frutto del caso in
un concorso sfavorevole di circostanze. Essa
appartiene al mistero del disegno di Dio”
(CCC 599). Questo mistero ci viene
comunicato tramite le Sacre Scritture, che in
qualche modo, per volontà di Dio, diventano
forgiatrici della storia degli uomini. Le cose
scritte dagli autori sacri sono ben più di mero
racconto, di semplice memoria di fatti
accaduti, o di pure previsioni. Una volta
scritte esse diventano matrici della nostra
storia. Cristo stesso riconosce autorità alla
Scrittura e sembra sottostare a quanto vi è
scritto: “Era proprio questo che vi dicevo
quando ero ancora con voi: bisogna che si
adempia tutto quanto di me sta scritto nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi” (Lc 24,
44). E aggiunge: “Così sta scritto: il Cristo
doveva patire ed il terzo giorno risuscitare
dai morti” (Lc 24,46). Attenzione però: Cristo
era perfettamente libero di non sottostare alle
Scritture, in quanto Dio è superiore alla Parola
rivelata; ma poiché nella sua libertà ha scelto
di salvarci, egli si è sottomesso al disegno del
Padre. Se si svaluta il concetto di libertà
dinanzi al concetto di destino, si rischia di
scivolare nello stesso errore in cui cadde
Giovanni Calvino (1509-1564, riformatore
protestante), il quale si spinse fino a voler
tentare di fondare teologicamente la teoria
della
predestinazione:
“Definiamo
predestinazione l’eterna disposizione di Dio
mediante la quale egli ha fissato in sé che
cosa deve avvenire di ciascun uomo secondo
la sua volontà; poiché gli uomini non sono
stati creati tutti allo stesso modo, ma per gli
uni è stata predisposta la vita eterna e per gli
altri
l’eterna
dannazione”
(Calvino,
Istituzione della religione cristiana). E’
evidente la mostruosità teologica cui porta la
cieca sopravvalutazione del destino: Dio
creerebbe uomini per l’inferno e uomini per il
paradiso. Le tesi del calvinismo vennero
naturalmente respinte dalla Chiesa, che già
dinanzi a Lutero aveva sostenuto il valore del
libero arbitrio. E’ vero, insegna il Magistero,
che nelle Scritture si parla di “prestabilito
disegno” di Dio (cfr At 3,23), ma “questo
linguaggio biblico non significa che quelli
che hanno consegnato Gesù siano stati solo
esecutori passivi di una vicenda scritta in
precedenza da Dio” (CCC 599). Il profeta
Giona aveva annunciato un destino di
distruzione per Ninive, ma a seguito di un
grande pentimento collettivo l’intiera città si
salvò. Il destino in fondo è come il vento: ha
le sue direzioni, ma tutto dipende da come io
dispongo le vele. Chi sottovaluta l’ampio
margine di movimento che la nostra libertà ci
dona, si sottrae alla responsabilità delle
proprie scelte per vivere come un automa,
come fa chi ricava il destino dalle stelle e dai
relativi oroscopi; o come chi attende con ansia
rivelazioni private per “sapere che cosa Dio
vuole da me”. Disegno di Dio non significa
predestinazione, futuro già scritto. Il disegno
di Dio è scritto nella storia con le matite delle
nostre vite. E di volta in volta è tracciato in
base alle nostre risposte. Molte anime
rimangono ferme per anni domandandosi
quale sia loro strada nella vita, ma la strada è
solo una: crescere nella fede. Quando l’acqua
del fiume sale, la propria barca si disincaglia e
segue da sola il suo destino. E non sono le
mie domande sul futuro a schiudermi la rotta,
ma l’abbandono fiducioso a Dio. Se
continuamente mi sporgo per guardare avanti,
significa che non sto vivendo veramente
l’abbandono. Ma se lo vivo, allora anch’io
seguo quel vento e quel fiume; anch’io
finalmente vivo secondo le Scritture.
“…E’ salito al Cielo…”
L’ascensione è il compimento definitivo della
missione divina di Gesù. Nel vangelo di
Giovanni leggiamo che essa era già stata
annunciata da Gesù alla Maddalena appena
dopo la Risurrezione: “Non sono ancora
salito al Padre; ma va dai miei fratelli e dì
loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro,
Dio mio e Dio vostro” (Gv 20,17). Anche in
Marco ne troviamo un accenno: “Il Signore
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto
in cielo” (Mc 16,19). E’ però l’evangelista
Luca ad essere più ricco di particolari nel
riportare l’evento: “Poi li condusse fuori,
verso Betania e, alzate le mani, li benedì.
Mentre li benediceva, si separò da loro e
veniva portato nel cielo. Essi, dopo averlo
adorato, se ne tornarono a Gerusalemme con
grande gioia” (Lc 24,50-52). E nel libro degli
Atti Luca completa il quadro del racconto
storico: “Dette queste cose, mentre essi lo
stavano guardando, fu levato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi. E poiché essi
stavano con lo sguardo fisso verso il cielo
mentre egli se ne andava, ecco che due
uomini in vesti bianche si presentarono loro
dicendo: «Uomini di Galilea, perché ve ne
state guardando verso il cielo? Questo Gesù
che è stato assunto di mezzo a voi fino al
cielo, ritornerà nello stesso modo in cui lo
avete visto andarsene verso il cielo». Allora
ritornarono a Gerusalemme dal monte
chiamato Oliveto, che si trova vicino
Gerusalemme quanto il cammino di un
sabato” (At 1,9-12).
Sono quindi almeno quattro i passaggi
evangelici che toccano esplicitamente il tema
dell’ascensione. Nonostante ciò, alcuni
biblisti negano all’evento una connotazione
storica, facendo rientrare anche il preciso
racconto lucano all’interno di una narrazione
simbolico-leggendaria. A noi sembra che il
genere letterario adottato da Luca nel narrare
l’Ascensione sia invece quello della
narrazione storica. E questo per tre motivi:
1) Luca, da buon medico, ha una mente
analitica ed una visione logica delle cose, ed
ama narrarle dopo essersi bene informato
(“Ho deciso anch’io di fare ricerche accurate
su ogni circostanza fin dagli inizi e di
scriverne un resoconto ordinato” – Lc 1,3); in
tutti i suoi scritti mostra infatti grande
precisione e dovizia di particolari; non si
lascia mai sfuggire il controllo della penna,
che adopera sempre con grande lucidità,
evitando enfasi o scivolate di fantasia.
2) I diversi brani sull’ascensione non sono in
contrasto fra loro, ma anzi si completano a
vicenda; vengono con cura riportati fatti e
luoghi: “verso Betania”, “ritornarono a
Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto” (il
monte Oliveto è appunto sulla strada verso
Betania).
3) I protagonisti, che davanti al miracolo se ne
restavano ancora col naso all’insù, vengono
dal miracolo stesso invitati a tornare con i
piedi per terra; quest’invito a non guardare più
verso il cielo sembra racchiudere un’implicita
raccomandazione a ritornare alla missione
faticosa di tutti i giorni; non vi è quindi nella
narrazione dei fatti quell’esaltazione tipica dei
racconti leggendari.
Come la Risurrezione, anche l’Ascensione è
evento sia fisico che metafisico. Il Magistero
della Chiesa, infatti, definisce l’avvenimento
“ad un tempo storico e trascendente” (CCC
660). Storico (e non mitologico) ma anche
trascendente, perché il cielo che accoglie il
Risorto non è quello fisico, ma quello
metafisico, il regno dei cieli da cui il Verbo
era venuto ed a cui ritorna nella gloria. Ecco
allora che il cielo fisico, o la nuvola, pur
appartenendo alla reale esperienza degli
apostoli, diventano simbolo di realtà più alte
ed a loro ancora invisibili. Il vero carattere
dell’ascensione è escatologico, e le Scritture
stesse la collegano alla promessa del dono
dello Spirito, alla venuta del Regno, ed alla
Parusia finale del ritorno di Gesù (cfr At 1,114). Dice il Catechismo: “Il Corpo di Cristo è
stato glorificato fin dall’istante della sua
Risurrezione, come provano le proprietà
nuove e soprannaturali di cui ormai gode in
permanenza. Ma durante i quaranta giorni
nei quali egli mangia e beve familiarmente
con i suoi discepoli e li istruisce sul Regno, la
sua gloria resta ancora velata sotto i tratti di
un’umanità ordinaria. L’ultima apparizione
di Gesù termina con l’entrata irreversibile
della sua umanità nella gloria divina
simbolizzata dalla nube e dal cielo ove egli
siede ormai alla destra di Dio” (CCC 659). Il
Figlio, che con l’incarnazione era sceso nella
natura umana, ora, con l’ascensione, la
riconsegna al Padre redenta. “Sono uscito dal
Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il
mondo e vado al Padre” (Gv 16,28). La sua
missione è compiuta, e torna nella gloria
vittorioso e carico di doni per noi. “Ora io vi
dico la verità: è meglio per voi che io parta,
perché se non parto il Paraclito non verrà a
voi. Se invece me ne vado lo manderò a voi”
(Gv 16,7).
“...siede alla destra del Padre...”
Cosa intende il Credo con l’espressione
“siede alla destra del Padre”? Se questo
frammento di sacra Scrittura compare nel
Simbolo, ha evidentemente una sua
importanza. Prendendo in mano il Vangelo si
scopre innanzi tutto che il lato destro è citato
con particolare rilievo: l’occhio destro, la
mano destra (Mt 5,29-30), la guancia destra
(Mt 5,39), le reti che Gesù comanda di gettare
a destra (Gv 21,6). Durante la passione è con
la destra che Gesù deve tenere la canna dello
scherno (Mt 27,29), e nel sepolcro vuoto è
“seduto a destra” il misterioso giovanetto in
vesti bianche che annuncia la risurrezione
(Mc 16,5). E come il pastore divide le pecore
buone da quelle cattive, ponendo quelle buone
sulla destra, e quelle cattive sulla sinistra (Mt
25,33), così anche quando il Figlio dell’uomo
“si siederà sul trono della sua gloria” porrà i
giusti sulla sua destra ed i dannati sulla sua
sinistra (Mt 25,31-46). Nel Vangelo dunque il
lato destro non è solo il lato forte, il lato
regale, ma è anche il lato buono, quello dei
giusti. Alla luce di questo si comincia a
comprendere perché Gesù indichi il suo trono
alla destra del Padre, come quando durante il
processo di Caifa afferma: “D’ora innanzi
vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra
di Dio, e venire sulle nubi del cielo” (Mt
26,64). Naturalmente questa frase bastò
perché il sommo sacerdote si stracciasse le
vesti e accusasse Gesù di bestemmia,
condannandolo a morte. Era una frase che da
una parte richiamava un’antica profezia di
Daniele sul Messia (cfr Dan 7,13), e dall’altra
faceva eco ad un salmo di Davide in cui il
Signore invita alla sua destra un personaggio
cui pure è riconosciuta suprema signoria (Sl
109,1): si trattava di un salmo su cui Gesù si
era già trovato a discutere con gli israeliti, che
facevano assai fatica ad accettare l’idea che
Dio potesse avere un Figlio, che questo Figlio
fosse anch’egli Dio, e che era venuto fra gli
uomini. In questa discussione Gesù li
interrogò chiedendo come fosse possibile che
Davide sotto ispirazione scrivesse “Ha detto
il Signore al mio Signore: siedi alla mia
destra...”. Com’era possibile che Dio si
rivolgesse a Dio? Ma “nessuno era in grado
di rispondergli nulla; e nessuno, da quel
giorno in poi, osò interrogarlo” (Mt 22, 4146). Sarà l’apostolo Pietro a riprendere, dopo
la morte di Gesù, questo difficile discorso:
Davide poté scrivere così perché alla destra
del Padre c’è il Figlio (At 2,32-38). Pietro
aveva infatti riconosciuto per primo la
figliolanza divina di Gesù (Mt 16,13-17).
Un’altra icona di Gesù seduto alla destra del
Padre ce la offre Marco, raccontando
l’ascensione: “Il Signore Gesù, dopo aver
parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette
alla destra di Dio” (Mc 16,19). Questa gloria
fu vista anche dal diacono Stefano: durante
quel suo discorso al sinedrio in cui tutti
vedevano “il suo volto come quello di un
angelo”, Stefano fissò lo sguardo verso l’alto
e “vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla
sua destra”, e disse: “Ecco, io contemplo i
cieli aperti, ed il Figlio dell’uomo che sta alla
destra di Dio” (At 6,15; 7,55-56). Ma com’era
accaduto per Gesù, anche in questo caso
“proruppero in grida altissime turandosi gli
orecchi” e lo misero a morte.
San Giovanni Damasceno, dottore della
Chiesa orientale (650-749), ci regala quanto
segue: “Per destra del Padre intendiamo la
gloria e l’onore della divinità, ove colui che
esisteva come Figlio di Dio, prima di tutti i
secoli come Dio, e consustanziale al Padre,
s’è assiso corporalmente dopo che si è
incarnato e la sua carne è stata glorificata”
(in De Fide Orthodoxa). Anche il nostro
Catechismo ci fornisce lumi su questo punto:
“L’essere assiso alla destra del Padre
significa l’inaugurazione del regno del
Messia, compimento della visione del profeta
Daniele riguardante il Figlio dell’uomo: «a
Lui fu concesso potere, gloria e regno; tutti i
popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo
potere è un potere eterno, che non tramonta
mai, e il suo regno è tale che non sarà mai
distrutto» (Dn 7,14)” (CCC 664). La stupenda
preghiera di Gesù per la sua glorificazione ci
svela il resto: “Padre, è giunta l’ora, glorifica
il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te.
Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni
essere umano, perché egli dia la vita eterna a
tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita
eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho
glorificato sopra la terra, compiendo l’opera
che mi hai dato da fare. E ora, Padre,
glorificami davanti a Te, con quella gloria
che avevo presso di Te prima che il mondo
fosse” (Gv 17,1-5).
“E di nuovo verrà nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti”
Cristo è il Signore, ed il suo regno di grazia ha
avuto inizio con la sua venuta nel mondo. Egli
sta già regnando sulla terra, ma lo fa
attraverso la Chiesa. Non tutte le cose di
questo mondo gli sono però sottomesse,
perché “questo regno è ancora insediato dalle
potenze inique” (CCC 671). Del resto Gesù
aveva avvertito: “Voi avrete tribolazione nel
mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il
mondo!” (Gv 16,33). La fase storica che
stiamo vivendo è quella che San Giovanni
chiama “l’ultima ora” (1Gv 2,18). Dice il
Concilio Vaticano II: “Già dunque è arrivata
a noi l’ultima fase dei tempi, e la
rinnovazione
del
mondo
è
stata
irrevocabilmente fissata e in un certo modo è
realmente anticipata in questo mondo; difatti
la Chiesa già sulla terra è adornata di una
santità vera, anche se imperfetta” (LG 48).
Alla luce della “teologia della speranza”, i
credenti stanno attendendo il ritorno finale e
glorioso di Gesù che conclude la storia: la
Parusia, termine che anticamente indicava la
visita ufficiale di un sovrano in qualche città.
Ma “questo avvento o apparizione di Gesù,
chiamato “parusia” nel Nuovo Testamento,
non viene felicemente tradotto con “ritorno”,
perché si suggerisce così che si tratta di un
evento già avvenuto una prima volta. In
realtà si tratta del compimento di ciò che è
cominciato con l’incarnazione, croce e
risurrezione di Gesù Cristo, del compimento
dell’opera di Gesù Cristo e della definitiva
manifestazione della sua gloria. Si intende
dunque che alla fine sarà manifesto che Gesù
Cristo era ed è fin dal principio alla base e al
centro significativo di ogni realtà e di ogni
storia, l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il
principio e la fine” (Catechismo Cattolico
degli Adulti, Conf. Ep. Tedesca, III,V,2,4).
Questa considerazione degli ultimi tempi (che
prende nome di escatologia, dal greco èskata,
cose ultime), emerge già dalle sacre scritture.
E’ Gesù stesso che annuncia e promette la sua
parusia (cfr il suo lungo discorso escatologico
racchiuso in Mt 24), anche se “non spetta a
voi conoscere i tempi e i momenti che il
Padre ha riservato alla sua scelta” (At 1,7).
Animato dallo Spirito Santo, Pietro dopo la
Pentecoste
annuncia
agli
ebrei
di
Gerusalemme: “Pentitevi dunque, e cambiate
vita, perché siano cancellati i vostri peccati e
così possano giungere i tempi della
consolazione da parte del Signore, ed egli
mandi quello che vi aveva destinato come
Messia, cioè Gesù. Egli dev’essere accolto in
cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte
le cose, come ha detto Dio fin dall’antichità,
per bocca dei suoi santi profeti” (At 13,1921). Per questa ragione “la Chiesa
pellegrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue
istituzioni, che appartengono all’età presente,
porta la figura fugace di questo mondo, e vive
tra le creature, le quali sono in gemito e nel
travaglio del parto sino ad ora, e attendono
la manifestazione dei figli di Dio” (LG 48). La
Parusia è dunque la vera meta di tutta la storia
dell’umanità. Per questo le chiese cristiane
sono rivolte verso oriente, ad indicare
quest’attesa del Cristo, sole che sorge, pur
essendo, noi, già avvolti dalla luce dell’alba.
Il trionfo definitivo sulle tenebre, porterà agli
uomini “nuovi cieli e una nuova terra” (2Pt
3,13). Il regno di Cristo sarà eterno, ma verrà
preceduto dal giorno del Giudizio, come Gesù
annunzia, in linea coi profeti e col Battista.
Non si tratta di un giorno del calendario, ma
della ricapitolazione in Cristo di tutte le cose.
“Allora saranno messi in luce la condotta di
ciascuno e il segreto dei cuori. Allora verrà
condannata l’incredulità colpevole che non
ha tenuto in alcun conto la grazia offerta da
Dio. L’atteggiamento verso il prossimo
rivelerà l’accoglienza o il rifiuto della grazia
e dell’amore divino. Gesù dirà nell’ultimo
giorno: “Ogni volta che avete fatto queste
cose ad uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me”” (CCC 678). In
realtà il giudizio di Dio sta già operando, nella
storia, per promuovere il bene e liberare dal
male. Dice il Catechismo degli Adulti della
CEI: “Il giudizio opera già in questo mondo,
ma va verso un momento supremo: “Tutti
infatti dobbiamo comparire davanti al
tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la
ricompensa delle opere compiute finché era
nel corpo, sia in bene che in male” (2Cor
5,10). E’ il giudizio definitivo, che per le
singole persone avviene al termine della vita
terrena (“giudizio particolare”) e per il
genere umano, nel suo insieme, al termine
della
storia
(“giudizio
universale”)”
(N.1199).
Sebbene
queste
riflessioni
escatologiche ci mettano davanti la reale
possibilità di una nostra eterna condanna, il
nostro timore è confortato dalla teologale
speranza che accompagna le parole
dell’Apocalisse: “Ecco la dimora di Dio con
gli uomini, e dimorerà con loro, ed essi
saranno il suo popolo, ed egli sarà il Diocon-loro. E asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi. Non vi sarà più morte né lutto e grida
di dolore. Sì, le cose di prima sono passate”
(Ap 21,3-4). Per cui il cristiano non deve
temere di dire: Marana-tha, vieni Signore
Gesù (1Cor 16,22).
“...E il suo Regno non avrà fine...”
Il nostro Credo annunzia la venuta di un
Regno divino che non finirà mai. Su cosa si
fonda questa grandiosa speranza escatologica?
Si fonda su numerosissimi passi della sacra
Scrittura. Fin dall’Antico Testamento è
annunciato un Regno di Dio che durerà per
sempre, soprattutto negli scritti dei profeti:
“Egli è il Dio vivente, che dura in eterno; il
suo regno è tale che non sarà mai distrutto, e
il suo dominio non conosce fine” (Dn 6,27).
E’ significativo però che questo Regno venga
già collegato alla venuta del Messia:
“Guardando ancora nelle visioni notturne,
ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno,
simile ad un figlio di uomo; giunse fino al
vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede
potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e
lingue lo servivano; il suo potere è un potere
eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è
tale che non sarà mai distrutto.” (Dn 7,1314). In questa profezia viene messa in luce la
particolare relazione fra il Padre e il Figlio,
che sarà rivelata pienamente al mondo solo
con la venuta di Gesù. E’ Gesù che dà inizio
al Regno di Dio sulla terra, e con la sua
missione salvifica lo consegna vittorioso al
Padre. Potrebbe sorgere la domanda: ma Dio
non era già prima Re dell’universo? Sì, come
creatore e Signore di tutte le cose, Dio godeva
già della signoria su tutto il creato. Tuttavia, a
causa del peccato entrato nel mondo, i cuori
degli uomini si erano oscurati, e poiché la
signoria di Dio governa il mondo attraverso i
cuori degli uomini, la perdita di regalità dei
cuori comporta un oscuramento della regalità
divina. Se però l’uomo torna in Dio, Egli può
regnare attraverso il suo essere e le sue azioni.
Dio, infatti, ha creato il mondo per noi, e
desidera governarlo con noi condividendo la
sua natura divina. Cristo, operando con lo
Spirito la conversione dei cuori, allinea di
nuovo il creato al suo creatore. Per prima cosa
è avvenuto in Lui questo allineamento, grazie
alla realizzazione della sottomissione della
sua natura umana al Padre, alla sua
obbedienza perfetta, alla sua passione e morte
in croce, alla sua Risurrezione. Già in Cristo
si realizza per la prima volta il Regno: il
Padre regna in lui ed attraverso di lui estende
la sua grazia sul mondo e compie miracoli
sulla natura. E’ Gesù stesso che ce lo
annuncia: “Il Regno di Dio è già in mezzo a
voi” (Lc 17,21). Vi sono dunque tre grandi
fasi di realizzazione del Regno: la prima fase
è quella presente nell’Antica Alleanza, in cui
Dio regna attraverso un popolo, quello
d’Israele: “Voi sarete per me un regno di
sacerdoti ed una nazione santa” (Es 19,6). La
seconda fase è quella realizzata nella nuova
Alleanza, in cui Dio regna attraverso il Figlio,
il Kyrios, il Signore, ed attraverso i cuori uniti
a lui, e cioè attraverso la Chiesa: “Ha fatto di
noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e
Padre” (Ap 1,6). I cristiani possono già essere
cittadini del Regno se fin da quaggiù
aderiscono alla Grazia, e contribuiscono
anche a costruirlo operando per la giustizia, la
carità, la promozione umana e la pace.
Infine vi è una terza fase di realizzazione del
Regno, che prende nome di Gerusalemme
celeste, il paradiso eterno promesso a tutti i
santi che saranno rimasti fedeli fino alla fine:
“E io preparo per voi un regno, come il
Padre l'ha preparato per me, perché possiate
mangiare e bere alla mia mensa nel mio
regno, e siederete in trono a giudicare le
dodici tribù di Israele (Lc 22,29-30). Si tratta
del Regno dei cieli, ma il creato non ne è
escluso, perché alla fine dei tempi vi sarà la
redenzione universale di tutte le cose, e con la
cancellazione definitiva del male sarà
ristabilito il dominio dello Spirito su tutte le
cause; si attuerà il ricongiungimento perfetto
tra il mondo terreno e mondo celeste, tra la
materia e lo spirito, tra il fisico ed il
metafisico, tra il naturale ed il soprannaturale.
Ciò che prima era diviso verrà ricongiunto:
sono queste le “nozze dell’Agnello” di cui
parla il libro dell’Apocalisse (Ap 19,7). E
questo matrimonio è realizzato dall’Amore di
Dio: è l’amore che ricongiunge. La sostanza
stessa del Regno è l’amore di Dio; la signoria
che Cristo esercita è una signoria della grazia,
che si manifesta attraverso la luminosità
dell’amore. Per questo possono parteciparvi
solo i cuori che si sono aperti alla grazia e se
ne sono lasciati trasformare. Amare e regnare
diventano in Dio un solo verbo.
“Credo nello Spirito Santo”
A farci conoscere e a donarci lo Spirito Santo
è Gesù. Egli lo chiama Paraclito (Gv
14,16.26; 15,26; 16,7), che letteralmente
vorrebbe dire “Colui che è chiamato vicino”,
e che spesso traduciamo con Consolatore.
Nell’annunciarne la sua venuta lo chiama
anche Spirito di verità. Il termine “Spirito” è
la traduzione dell’ebraico “Ruah”, che
significa soffio, aria, vento; e Gesù utilizza
proprio l’immagine sensibile del vento per
spiegarci, durante il suo dialogo con
Nicodemo, la natura misteriosa e trascendente
dello Spirito di Dio, di cui nessuno può sapere
“da dove viene e dove va” (Gv 3,5-8). In
questa dimensione misteriosa entrano anche,
dice Gesù, “i nati dallo Spirito”. L’ingresso in
questa vita nuova e soprannaturale avviene
col sacramento del Battesimo. Scrive
Sant’Ireneo di Lione (II sec.): “Il Battesimo ci
accorda la grazia della nuova nascita in Dio
Padre, per mezzo del Figlio suo nello Spirito
Santo. Infatti coloro che hanno lo Spirito di
Dio sono condotti al Verbo, ossia al Figlio;
ma il Figlio li presenta al Padre, e il Padre
procura loro l’incorruttibilità. Dunque, senza
lo Spirito, non è possibile vedere il Figlio di
Dio, e, senza il Figlio, nessuno può
avvicinarsi al Padre, perché la conoscenza
del Padre è il Figlio, e la conoscenza del
Figlio di Dio avviene per mezzo dello Spirito
Santo” (Demonstratio Apostolica, 7). Senza il
Battesimo nello Spirito non vi è dunque vita
cristiana. Come dice San Paolo, “Nessuno
può dire “Gesù è il Signore” se non sotto
l’azione dello Spirito Santo” (1Cor 12,3). San
Paolo chiama il divino Paraclito anche Spirito
della promessa (Gal 3,14; Ef 1,13), Spirito di
adozione (Rm 8,15; Gal 4,6), Spirito di Cristo
(Rm 8,9), Spirito del Signore (2Cor 3,17),
Spirito di Dio (Rm 8,9.14; 15,19; 1Cor 6,11;
7,40), mentre a chiamarlo Spirito della gloria
è San Pietro (1Pt 4,14).
Lo Spirito Santo è all’opera con il Padre ed il
Figlio dall’inizio dei tempi fino al
compimento della storia della salvezza. Lo
Spirito è luce che ci rivela le verità di Dio, ma
proprio perché illumina le cose, si nasconde.
Si adombra per fare luce sul Padre e sul
Figlio. Non dice se stesso, è la Persona divina
di cui sappiamo meno sebbene ogni nostra
conoscenza spirituale venga da Lui. “Non lo
conosciamo che nel movimento in cui ci
rivela il Verbo e ci dispone ad accoglierlo
nella fede” (CCC 687). Gesù ci spiega che pur
guidandoci verso “la verità tutta intera”, lo
Spirito Santo “non parlerà da sé, ma quanto
sentirà dirà” (Gv 16,13). E’ l’annientamento
tipico degli umili. Anche l’umiltà è, infatti,
virtù divina; ben visibile attraverso la
trasparenza di Maria, la colma di grazia che si
adombra per mettere in luce il Figlio.
Diversi sono i simboli attraverso cui si
esprime lo Spirito Santo:
1) L’acqua: segno di purificazione e di
rinascita, che nel battezzato zampilla per la
Vita eterna;
2) L’olio: compare nelle unzioni di re e
profeti, fino alla venuta di Cristo, l’Unto di
Dio, che pone, tramite lo Spirito, il sigillo del
sacro crisma sulla fronte di ogni cristiano;
3) Il fuoco: simboleggia l’azione trasformante
dello Spirito Santo, che consuma il male e
rende ardenti nel bene: questa presenza di Dio
in noi si realizza con le “lingue di fuoco” della
Pentecoste (At 2,3);
4) La nube luminosa: dal Sinai alla
Trasfigurazione di Gesù ed alla sua
Ascensione, accompagna le principali
rivelazioni di Dio (Es 24,15-18; 33,9-10;
40,36-38; 1Re 8,10-12; Lc 9,34; At 1,9), così
come accompagna le principali teofanie di
Maria nella storia umana, fino al ritorno
definitivo di Gesù nella nube (Lc 21,27);
5) La colomba: apparve alla fine del diluvio
come segno di un’alleanza che ricomincia, e
pure quando Cristo risalì dall’acqua durante il
Battesimo nel Giordano, all’inizio della sua
missione di salvezza (Mt 3,16); anche la
colomba ricompare in molte teofanie mariane,
perché Maria è columbarium, tabernacolo di
Cristo.
Dove possiamo incontrare oggi lo Spirito
Santo? In moltissimi ambiti della vita di fede
come singoli cristiani o come chiesa: nelle
Scritture, che Egli ha ispirato; nella
Tradizione che ci giunge attraverso i Padri da
Lui illuminati; nel Magistero della chiesa che
Egli assiste; nella Liturgia, in particolare
quella della Santa Messa, che lo Spirito
vivifica con la sua azione invisibile e nella
quale
realizza
la
miracolosa
transustanziazione del pane e del vino; nei
Sacramenti, ove opera con la sua grazia
trasformante; nella preghiera, possibile solo
perché mossa da Lui; nei sacramentali, come
le benedizioni o gli esorcismi; nei diversi
ministeri che edificano la Chiesa; nei carismi,
che sono un suo dono; nello stato di grazia, a
cui ogni cristiano è chiamato, ed a cui anche il
peccatore può tornare tramite il sacramento
della Riconciliazione; nella carità, perché
essa è pura emanazione dello Spirito Santo
che è amore; nell’evangelizzazione, perché
Egli è anche Spirito di Verità; nella
testimonianza di vita con cui si prolunga la
salvezza, perché lo Spirito è spirito di santità.
“...E’ Signore e dà la vita...”
Cosa s’intende quando professiamo che “lo
Spirito Santo è Signore e dà la vita?”. Quale
vita ci viene donata dallo Spirito Santo? Lo
Spirito di Dio ci fa dono sia della vita fisica
sia della vita spirituale. Ci fa dono della vita
fisica perché la creazione è mossa da Lui: Egli
la disegna, la permea, e la sostiene; ne rende
fecondo il grembo e la vivifica. Come dice la
liturgia bizantina “Egli ha potere sulla vita,
perché essendo Dio, custodisce la creazione
nel Padre per mezzo del Figlio”. Fin da
quando “lo Spirito di Dio aleggiava sulle
acque” (Gn 1,2), Egli non ha mai cessato di
dispensare la vita alle diverse creature, agli
esseri umani: “Mandi il tuo Spirito ed essi
sono creati” (104,30). Per questo il nostro
Catechismo può, a giusto titolo, proclamare:
“La Parola di Dio ed il suo Soffio sono
all’origine dell’essere e della vita di ogni
creatura” (CCC 703). Ma così come agisce
dentro l’atto del creare, lo Spirito Santo, dopo
l’ingresso nel mondo del peccato, agisce
anche nel ricreare. Ispirando divinamente i
santi patriarchi ed i profeti, Egli non ha non
ha mai smesso di parlarci ed illuminarci: nelle
Teofanie e nella Legge, nel Regno d’Israele e
nell’esilio, nella lunga attesa messianica, fino
a quando matura la pienezza del tempo, ed
allora lo Spirito del Signore prepara la “piena
di Grazia”, ed in lei realizza il disegno
misericordioso del Padre. Come annunciato
dall’angelo (“Lo Spirito Santo scenderà sopra
di te”), Egli la copre con la sua ombra e la
Vergine concepisce “per opera dello Spirito
Santo” (Lc 1,35). Nel disegno di salvezza,
Maria diventa dunque il roveto ardente della
Teofania definitiva (CCC 724), ed attraverso
di Lei lo Spirito manifesta al mondo il Figlio
di Dio. In Maria Egli inizia a mettere in
comunione gli uomini con Cristo. Infine,
tramite Gesù, Egli scende sui battezzati,
santifica attraverso le sue parole, istituisce
attraverso l’imposizione delle mani, e cancella
i peccati degli uomini. “Tutto il secondo
articolo del Simbolo della fede deve essere
letto in questa luce: l’intera opera di Cristo è
missione congiunta del Figlio e dello Spirito
Santo” (CCC 727). Questi dà vita alla Chiesa,
ed ancora oggi la vivifica perché
continuamente ci viene fatto dono “dello
Spirito Santo che era stato promesso... in
attesa della completa redenzione di coloro
che Dio si è acquistato” (Ef 1,13-14). Lo
Spirito di Dio ci conferisce, quindi, anche la
vita spirituale. Gesù è la vite e noi ne siamo i
tralci: questo significa che siamo vivificati
dalla stessa linfa vitale della vite, e questa vita
che scorre in essa ed anche in noi è lo Spirito
Santo. Egli ci vivifica, perfezionando la nostra
natura, liberandola dal male e purificandola;
ci arricchisce con le virtù teologali e cardinali,
ci conferisce doni e carismi particolari, ci
abilita alla dimensione soprannaturale
dell’esistenza umana. Nella Bibbia, dal roveto
ardente alla Pentecoste, lo Spirito di Dio
sembra amare l’immagine del fuoco. Perché il
fuoco? Perché brucia, trasforma, consuma.
Ma soprattutto perché il fuoco è da sempre
sinonimo di due cose: la luce ed il calore.
L’azione dello Spirito, infatti, investe sempre
entrambe le realtà dell’uomo: la mente ed il
cuore. La luce è sinonimo di verità (luce della
mente): la verità che Dio ci comunica. Ma non
si tratta mai di una verità fredda, puramente
conoscitiva, ma di una verità che passa
attraverso il cuore, che scalda, che s’identifica
con l’Amore. “Dio è Amore”, scrive S.
Giovanni (1Gv 4,8.16), e l’Amore è il primo
dono, quello che contiene tutti gli altri.
Quest’amore, Dio “l’ha riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato donato” (Rm 5,5). Lo Spirito Santo, che
fa il suo ingresso definitivo nella storia della
Chiesa con la Pentecoste, e nella nostra storia
personale
col
Sacramento
della
Confermazione, è “primizia” della nostra
eredità celeste. “Dio stesso ci conferma,
insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito
l’unzione, e ci ha dato il sigillo e la caparra
dello Spirito Santo nei nostri cuori” (2Cor
1,21-22). Questo Spirito, che soccorre la
nostra debolezza e prega attraverso di noi con
“gemiti inesprimibili” (Rm 8,26), ci rende a
nostra volta strumento di salvezza delle
anime, continuando ancora oggi la sua
missione nel mondo attraverso di noi, affinché
i tralci staccati che toccano il nostro tralcio
diventino anch’essi vite e si salvino.
“...Procede dal Padre e dal Figlio...”
Lo Spirito Santo è Dio. Questa Terza Persona
della Santissima Trinità non ha, dunque, come
del resto anche il Figlio, un inizio nel tempo;
ma è da sempre. Dal Padre procede l’amore
verso il Figlio, e dal Figlio procede l’amore
verso il Padre: è l’amore che unisce le Divine
Persone del Padre e del Figlio. Poiché Dio
ama in modo perfetto, questo Amore è
perfetto. Ma cosa vi è di perfetto se non Dio?
Dunque questo Amore è Dio, quello che noi
chiamiamo Spirito Santo, Terza Persona della
Trinità che è un solo Dio. Questa eccelsa
verità che i Padri ci tramandano, emerge
direttamente dalla Sacra Scrittura, e sostanzia
il secondo articolo del nostro antico Credo.
L’unico elemento che non ritroviamo nel testo
originario del Simbolo, è il cosiddetto
“filioque” (“e dal Figlio”). Leggiamo infatti
così: “ex patre [filioque] procedentem”. Tale
aggiunta, che Roma ammise nella versione
liturgica latina nel 1014, fu in particolare
contestata dalla Chiesa Ortodossa, anche se
essa non fu certo l’unica causa del Grande
Scisma d’Oriente avvenuto nel 1054. Ma
come avvenne esattamente la storia di questo
inserimento? La sequenza è questa:
l’antichissimo Simbolo degli Apostoli
riportava solo l’espressione “Credo nello
Spirito Santo”. Nel 325 il Simbolo di Nicea
proclamava pertanto: “Crediamo nello Spirito
Santo”. Successivamente, il primo Concilio di
Costantinopoli, nel 381, aggiunse “ex Patre
procedentem”: un’aggiunta più che lecita
perché desunta direttamente dal Vangelo (Gv
15,26). Nel quinto secolo già circolavano,
però, professioni di fede che definivano lo
Spirito Santo “procedente dal Padre e dal
Figlio”,
come
l’autorevole
Simbolo
Atanasiano, chiamato così perché attribuito a
Sant’Atanasio
(295-373),
arcivescovo
d’Alessandria d’Egitto. Anche antichi Padri
quali San Basilio vescovo e dottore della
Chiesa (330-379), o San Gregorio Nazianzeno
vescovo di Costantinopoli (329-390) si erano
aperti alla teologia del filioque. Infine, nel
447, papa San Leone I, sulla base di queste
antiche tradizioni, non solo latine ma anche
alessandrine, affermò dogmaticamente il
filioque (cfr CCC 247). Ed anche i successivi
concili (Toledo nel 589; Aquileia nel 796;
Aquisgrana nell’809) confessarono la teologia
del filioque. E’ pertanto comprensibile il
perché Roma abbia finito per accoglierlo nella
liturgia latina nel 1014. Da allora, esso si
diffuse in tutto l’Occidente, e fu accettato sia
dai Latini sia dai Greci nei concili ecumenici
di Lione (1274) e di Firenze (1439). Tuttavia,
nel corso dei secoli furono innumerevoli le
dispute su questo argomento, specie tra
teologi cattolici ed ortodossi. Perché? Quale
concezione dello Spirito Santo vi è dietro il
filioque? La risposta la leggiamo negli atti del
Concilio di Firenze del 1439: “Lo Spirito
Santo ha la sua essenza e il suo essere
sussistente ad un tempo dal Padre e dal
Figlio e [...] procede eternamente dall'uno e
dall'altro come da un solo principio e per una
sola spirazione [...]. E poiché tutto quello che
è del Padre, lo stesso Padre lo ha donato al
suo unico Figlio generandolo, ad eccezione
del suo essere Padre, anche questo procedere
dello Spirito Santo a partire dal Figlio, lo
riceve dall'eternità dal suo Padre che ha
generato il Figlio stesso” (Denz.-Schönm.,
1300-1301). Gli ortodossi usano il termine
greco ekporeuomenon, che noi traduciamo
con procedentem: il primo significa che lo
Spirito Santo “trae la sua origine” dal Padre, il
secondo è invece un termine più comune che
non vuole significare altro che la
comunicazione della divinità consostanziale
del Padre sia allo Spirito Santo sia al Figlio
(o, come dicono gli stessi ortodossi, “allo
Spirito Santo attraverso il Figlio”). Ecco
perché in latino è possibile estendere il
procedentem anche al Figlio. Si tratta allora
solo di una questione linguistica? Di fatto,
quando la chiesa cattolica celebra il rito latino
nella lingua greca, l’espressione “e dal figlio”
non compare. “Dai tempi del Concilio
Vaticano II si svolge un proficuo dialogo
ecumenico, che sembra aver portato alla
conclusione che la formula “Filioque” non
costituisce un ostacolo essenziale al dialogo
stesso e ai suoi sviluppi” (Giovanni Paolo II,
Udienza Generale del 7 novembre 1990). Ai
fini di operare la riunificazione completa coi
fratelli di rito bizantino, il Pontificio
Consiglio per la Promozione dell'Unità dei
Cristiani, a poche settimane di distanza dal
celebre incontro di Giovanni Paolo II col
Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I,
avvenuto il 29 giugno 1995, ha presentato
sull’Osservatore Romano del 13 settembre
1995 una lunga trattazione sulla questione,
ove compare una nota molto forte: “La chiesa
cattolica riconosce il valore conciliare ed
ecumenico, normativo e irrevocabile, quale
espressione dell'unica fede comune della
chiesa e di tutti i cristiani, del simbolo
professato in greco dal II concilio ecumenico
a Costantinopoli nel 381.” In pratica viene
ricostruita l’unità dei cristiani attorno al
Simbolo niceno-costantinopolitano. Questo
naturalmente non ha impedito al “filioque” di
abitare ancora nella liturgia (per lo meno di
rito romano e di rito ambrosiano), così come
abitano le tante altre formule più o meno
antiche delle professioni di fede (CCC 192).
Molto serenamente, il Catechismo della
Chiesa Cattolica, è giunto infatti a dichiarare
una compatibilità fra le due formule: “Questa
legittima complementarità, se non viene
inasprita, non scalfisce l'identità della fede
nella realtà del medesimo mistero confessato”
(CCC 248).
Con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato
Le tre Persone divine vivono nella gloria. Non
solo la gloria che scaturisce dalla natura
trinitaria, ma anche quella riflessa dalle
creature.
Scrive
l’apostolo
Giovanni
nell’Apocalisse: “Ogni volta che quei viventi
rendono gloria, onore e ringraziamento a
Colui che siede sul trono, e che vive nei secoli
dei secoli, i ventiquattro vegliardi si
prostrano dinanzi a Colui che siede sul trono
per adorare Colui che vive nei secoli dei
secoli; lanciano le loro corone dinanzi al
trono dicendo: «Tu sei degno, Signore nostro
e nostro Dio, di ricevere la gloria, l’onore e
la potenza, perché sei tu che hai creato
l’universo, ed è per tuo volere che l’universo,
che non esisteva, fu creato»” (Ap 4,9-11).
A noi umani non è facile comprendere
correttamente il termine “gloria”, perché sulla
Terra questa parola s’intreccia con la
superbia, con la brama di potere, con la stessa
“vanagloria”. La gloria terrena è qualcosa di
vuoto, un’illusione; di essa l’antico Qoelet
direbbe: “Tutto è vanità” (Qo 1,2). Ma in
Cielo questa logica è completamente
capovolta dall’ineffabile amore di Dio che
pervade tutto ed irradia ogni creatura. Dio è
certamente il Kyrios, il Signore assoluto di
tutto, ma la sua signoria è una signoria
d’amore: Egli regna amando, ed il suo regno è
l’amore stesso in cui sono immersi i viventi,
la sua luce di grazia che penetra sottilmente
ogni essere conferendogli la somiglianza
celeste, quella trasparenza e limpidezza che
orienta ogni moto dello spirito unicamente al
bene ed al puro servizio. E’ sì una
sottomissione, ma una sottomissione angelica,
in cui il riconoscimento di Dio come l’unico
Signore è gioia piena, intima comprensione
del senso di tutto alla luce della giustizia
divina, che è pienamente compartecipata,
consostanziale al proprio sentire. La gloria di
Dio è per noi paradiso. Se la s’intuisse un solo
istante, milioni di comportamenti abituali
sarebbero stravolti; l’intera vita sbalzerebbe
verso l’alto, e la nostra esistenza terrena
verrebbe vissuta in modo totalmente diverso,
perché diverrebbe irresistibile il desiderio di
assomigliare a tutto questo, di attuare già
quaggiù, nella misura del possibile, questa
signoria celeste, che i vangeli ci hanno
annunciato come in mezzo a noi, col nome di
“Regno di Dio” (Lc 17,21).
Cosa intende dunque il Simbolo del Credo
con glorificare? Che significa rendere gloria?
Se Dio è già nella gloria, come possono le
creature, nella loro povertà, dare gloria a
Dio? Significa rendere a Dio ciò che è di Dio,
restituirgli quella somiglianza che ci ha
donato. E c’è un solo modo per restituirla:
viverla. Il mondo rende continuamente gloria
ai suoi idoli, rende gloria al suo Cesare che
impera ancora oggi. Ma Gesù, col noto
esempio della moneta, ci indica che, pur
rispettando i compiti che il mondo ci assegna,
dobbiamo nella nostra vita voltarci verso Dio
e rendere gloria solo a lui (Mt 22,21); perché
noi assomigliamo a ciò verso cui rivolgiamo
la gloria. Ecco perché ci è assai conveniente
rendere gloria a Dio. Quella domanda che
Gesù rivolge al popolo, “Di chi è questa
immagine?”, non viene fatta, in realtà,
indicando la moneta del tributo, ma la nostra
anima. E’ puntando il dito alla nostra anima
che Gesù ci chiede: “Di chi è questa
immagine?”. Di chi portiamo l’impronta? Di
chi siamo “immagine e somiglianza” (Gn
1,26)? Dobbiamo quindi restituire a Dio ciò
che è di Dio. Tutto nel creato rende gloria a
Dio. Anche un fiore che sboccia. Anche una
stella che brilla rende gloria a Dio. E l’uomo?
Come può rendere gloria a Dio? Cosa ha da
dare a Dio se non ciò che da Dio riceve?
L’uomo rende gloria a Dio quando gli
restituisce la sua stessa luce. In fondo è come
se tutti custodissimo dentro uno specchio.
Spesso questo specchio è coperto di polvere, è
sporco, non riflette alcuna luce, tanto che a
volte non lo vediamo nemmeno. Ma se viene
restituito alla sua funzione, se viene lucidato e
ripulito, se viene di nuovo “orientato verso il
sole”, verso Dio, ecco che anche noi rendiamo
gloria a Dio. Restituendogli la sua luce.
Diventando altri soli. Diventando anche noi
stelle che brillano. E portando così la sua
immagine. Rendendo gloria siamo in realtà
glorificati noi. Allora la moneta della nostra
vita è restituita a lui. Ed anche le nostre
corone sono lanciate ai suoi piedi. Perché se è
amando che si regna, regnando si dona.
“Ha parlato per mezzo dei profeti”
Il Dio della Bibbia è un Dio che parla. La sua
comunicazione, però, non è mai astratta
trasmissione di conoscenze o di voleri.
Quando Dio rivela, innanzitutto si rivela, cioè
comunica se stesso, e nel comunicarsi dona se
stesso. Dire che Dio ha parlato per mezzo dei
profeti significa dire che Dio ha salvato per
mezzo dei profeti. E dentro questo modo di
operare, i profeti non sono mai stati trattati
come un semplice mezzo. Essi erano amati
quanto e più dei destinatari del messaggio che
attraverso loro scorreva. Ed anche quando la
loro missione li poneva a dura prova,
sottomettendo perfino ogni orgoglio, Dio alla
fine si chinava su di loro coprendoli col
conforto della sua ombra, così come fece
amorevolmente ombra a Giona nello
sconforto del deserto. E’ poi vero che ai
profeti non è dato di sedersi a riposare in
quella ombra, ed anche Giona vide seccare la
sua pianta di ricino, ma questo proprio perché
egli crescesse maggiormente, proprio perché
la vita del profeta non è mai un mezzo, ma
sempre anch’essa fine (Gio 3-4). Anzi, la vita
dei profeti diventa spesso ai nostri occhi un
vero modello, uno stile di vita, un esempio di
condotta, o meglio un esempio di come porsi
rispetto alle cose, di come metterci all’ascolto,
di come entrare a nostra volta nel flusso
ininterrotto delle comunicazioni di Dio. Senza
i profeti, davvero alle nostre spalle ci sarebbe
solo il deserto, il piatto scorrere del tempo
privo di un senso. Con gioia leggiamo
pertanto, anche a millenni di distanza, Isaia e
Geremia, Baruc ed Ezechiele, Daniele ed
Osea, Gioele ed Amos, Abdia e Giona,
Michea e Naum, Abacuc e Sofonia, Aggeo e
Zaccaria, Malachia e tanti altri che pure
possiamo chiamare profeti perché hanno
vissuto e parlato nel solco della parola di Dio.
Profeti che, nella loro libertà, questo solco
hanno talvolta lasciato; profeti che hanno
corretto profeti, come Natan. Ma tutti
protagonisti di un mistero che entra nel tempo
e nella storia degli uomini. Un mistero che
chiamavano JHWH, Elohim, El, El Shaddai,
El Olam, El Haj, El Elion, Kodesh Israel,
Elohe Hashamajim, il Signore Sebaoth,
l’Unico, dai nomi infiniti. La brezza leggera,
il vento impetuoso. Il fuoco ardente nel
roveto. Fino al giorno in cui questo fuoco
venne finalmente acceso per non essere più
eccezionale
teofania,
ma
permanente
quotidianità. “Sono venuto a portare il fuoco
sulla terra, e come vorrei che fosse già
acceso!” (Lc 12,49). E gli apostoli lo videro
questo fuoco. Era un fuoco acceso sulla riva
del mare come sempre ne venivano accesi per
asciugarsi, per cucinare e nutrirsi. Ma stavolta
preparato e acceso da un Risorto (Gv 21). Un
fuoco che li scaldava dentro, come sulla
strada di Emmaus (Lc 24,32), un fuoco che
come “vento gagliardo” aveva fatto irruzione
nella loro vita posandosi su di loro (At 2,1-4).
Era lo Spirito Santo. Il medesimo Spirito che
aveva parlato per mezzo dei profeti. E che ora
ardeva non in un roveto, ma nella stessa
Parola fatta carne. E di conseguenza ardeva e
parlava attraverso coloro che in Lui vivevano
e vivono. Da Cristo è disceso un “popolo di
profeti”, ed ogni cristiano ha, a suo modo, il
dono della profezia, cioè di parlare in suo
nome, di essere sale e luce. Certo occorre la
“vigilanza del cuore”, occorre “essere
sentinelle”, occorre prestare udito al richiamo
di Dio ad Ezechiele e farlo nostro: “Figlio
dell’uomo, ti ho posto come sentinella per la
casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia
bocca una parola, tu dovrai avvertirli da
parte mia” (Ez 3,16-17). Troppe volte,
dinanzi amici, parenti, colleghi di lavoro, il
cristiano si rifugia nella finta amarezza del
“Tanto non mi ascolterebbero!”. Se non
ascoltano non si salvano, viene detto ad
Ezechiele, ma se non parli non ti salvi
nemmeno tu! (Ez 3,18.20). Dire “Ha parlato
per mezzo dei profeti”, dirlo durante il Credo,
cioè pregando, significa dire: riconosco che lo
Spirito parla e si esprime per mezzo di me,
che dentro questo popolo di profeti, che è la
Chiesa, mi viene consegnata una speciale
responsabilità:
quella
innanzitutto
di
ascoltare, rendendomi idoneo all’ascolto di
Dio, e, come immediata conseguenza, quella
di annunciare, vigilando sulle ferite dell’altro,
accendendo il fuoco che lo scalda,
“rimanendo svegli durante la passione”, come
una sentinella, come una pianta di ricino che
fa la sua ombra.
“Credo la Chiesa...”
Un bambino scappa di casa perché non ne può
più di sua madre. In un primo tempo si gode
tutta la sua libertà, vuole “sentirsi adulto”, e
quindi va dove vuole e fa ogni cosa che gli
passa per la testa; si diverte a compiere tutto
ciò che prima gli appariva proibito. Col
gruzzoletto che gli è rimasto in tasca si
compra ogni genere di cose che desidera,
mangia e beve tutto ciò che gli pare, si rotola
completamente vestito nel fango, si arrampica
per luoghi impervi e pericolosi. Ma dopo un
po’ di tempo il bambino comincia a sentire un
grande vuoto, si accorge che le sue giornate
sono tutte uguali, che la sua vita non va in
alcuna direzione. Non sopporta più i suoi
vestiti sporchi e sudati, ed inoltre, finito il suo
gruzzolo, comincia a fare i conti con la fame e
con la sete. Le ferite che si è procurato
arrampicandosi cominciano a fare infezione, e
sente la febbre salirgli su per tutto il corpo.
Lentamente riprende allora la strada di casa,
pur aspettandosi le sfuriate di sua madre.
Costei invece, appena rivede il figlio, piange
di gioia, lo abbraccia, lo porta in casa, lo lava,
gli cura le ferite, gli cambia i vestiti, lo nutre e
lo disseta.
Questo piccolo racconto, per certi versi molto
simile a quello del figliol prodigo, fotografa
gran parte dell’umanità attuale, che spesso
rivendica capricciosamente una libertà fine a
se stessa, e rifiuta la chiesa come madre. Vi
sono cose, indispensabili alla nostra salvezza,
che non possiamo procurarci da soli.
Inizialmente quel “gruzzolo rimasto in tasca”
ci dà come un senso di onnipotenza. Il tralcio
staccato dalla vite, non ne conserva forse, per
qualche giorno, ancora un po’ di linfa? Presto
però ci si accorge che la vita viene meno, che
l’anima si dissecca, che l’ubriacatura di libertà
lascia in realtà, col tempo, una grande sete;
una sete che può essere appagata solo
dall’“acqua che scaturisce dalla roccia”,
quella che sgorga dal costato di Cristo, che
colma i fonti battesimali di tutto il mondo. Ci
si accorge che solo presso questa Madre la
nostra fame si sazia col pane che nutre
davvero, quello che si diffonde da tutti gli
altari come cibo di vita eterna. Ci si accorge
che solo presso i suoi confessionali possiamo
venire lavati dal male commesso, curati nelle
più profonde ferite dell’anima, rivestiti di
abiti nuovi nella luce del ritrovato stato di
grazia. Ed è così che si diventa davvero adulti.
E’ in questa Madre che a nostra volta si
diventa madri, si genera e si salva con lei. Dai
bassifondi di Calcutta alle periferie delle
grandi città, non c’è angolo di mondo che non
sia abbracciato dalla salvezza della Chiesa.
Eppure, dicono alcuni, “Cristo sì, chiesa no”.
Come se avessero in cantina la macchina del
tempo per ritornare nella Palestina di 2000
anni fa ed incontrare là il Cristo, come se
potessero sedersi ancora nel cenacolo fra
Giuda e Gesù e prendere lì l’eucaristia, come
se potessero travestirsi da mendicanti ciechi
alle porte di Gerusalemme per sentirsi dire,
anch’essi, “va’, ti sono rimessi i tuoi
peccati!”. La Chiesa non è cosa “altra”,
rispetto al Cristo, ma è bensì il modo con cui
Cristo mi salva oggi, nel mio tempo e nella
mia storia. Quando Gesù parla della Chiesa
dice “Me”: chi tocca voi tocca Me, chi
perseguita voi perseguita Me. E quando Saulo
ordinava stragi contro la chiesa, facendo
versare il sangue di molti cristiani, Cristo
Risorto sulla via di Damasco lo rimprovera
così: “Saulo, Saulo, perché Mi perseguiti?”
(At 9,4). Un richiamo che dovrebbe far
rabbrividire tutti coloro che, oggi infervorati
dalla stessa febbre di Saulo, attaccano e
devastano la Chiesa. Ma nessun attacco, né
accusa, né diffamazione potrebbero staccare i
cristiani dalla Chiesa (come Satana vorrebbe
per aver buon gioco), poiché essi la amano
come proprie membra. Di più, sanno scorgere
in essa le membra del Cristo, ed ogni attacco
alla Chiesa lo avvertono come colpo di
flagello alle membra del Cristo, alle proprie
membra. Essi non possono fare a meno di
amarne i ministri, di amare intensissimamente
il Papa, di amare tutti i propri Pastori e
sacerdoti. E li amano anche quando ne vedono
i difetti. Nessun laicista potrà mai capire
questo, perché tutto avviene per vie
soprannaturali
ed
invisibili,
per
incorporazione mistica al Corpo di Gesù. E’ la
punta della lancia del cherubino, è la
trasverberazione al nostro costato, è
l’incarnata partecipazione al mistero di
salvezza.
Noi amiamo la Chiesa, e, dopo Cristo, non vi
è nulla che amiamo di più. Essa è Cristo che
cammina nella storia, che coi suoi piedi
possenti estirpa arbusti e rovi, che con le sue
mani piagate ci redime, con le sue spalle
possenti ci sostiene: noi tutti indegni dal
primo all’ultimo, noi tutti con passione così
amati.
“...Una, santa, cattolica e apostolica...”
Perché il nostro antico Credo definisce la
Chiesa una? Perché ha come origine Dio che
è uno, e inoltre perché Gesù volle fondare una
sola Chiesa. Si legge nel Compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica che la
Chiesa ha “come fondatore e capo Gesù
Cristo, che ristabilisce l’unità di tutti i popoli
in un solo corpo” (CCCC 161). La Chiesa
dunque non solo è una, ma grazie allo Spirito
che la anima è anche unificante. Si può dire
che è unificante proprio in quanto una, ossia
proprio in quanto attinge, tramite Cristo,
direttamente all’unità di Dio. Oltre a questo,
oltre cioè ad essere una ed unificante, la
Chiesa è anche unica. “Essa ha una sola fede,
una sola vita sacramentale, un’unica
successione apostolica, una comune speranza
e la stessa carità” (CCCC 161). Grazie a
quest’unica fede, “l’unica Chiesa di Cristo,
come società costituita e organizzata nel
mondo, sussiste (subsistit in) nella Chiesa
Cattolica, governata dal successore di Pietro
e dai Vescovi in comunione con lui. Solo per
mezzo di essa si può ottenere la pienezza dei
mezzi di salvezza, poiché il Signore ha
affidato tutti i beni della Nuova Alleanza al
solo collegio apostolico, il cui capo è Pietro”
(CCCC 162). Talvolta è stata fraintesa
quest’espressione “subsistit in”, peraltro già
presente nel Concilio Vaticano II (LG 8,2);
qualcuno si è chiesto: perché invece di dire
“sussiste nella” non si è semplicemente detto
“è”? Non viene sminuita la piena identità tra
la Chiesa Cattolica e l’unica Chiesa di Cristo?
Proprio di recente, il 29 giugno 2007, una
nota della Congregazione per la Dottrina della
Fede ha precisato che in realtà l’uso di questa
espressione “indica la piena identità della
Chiesa di Cristo con la Chiesa Cattolica”
(Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti
circa la dottrina sulla Chiesa, 3). Quanto alle
Chiese e Comunità separate, “quantunque
crediamo che abbiano delle carenze, nel
mistero della salvezza non sono affatto
spoglie di significato e di peso. Poiché lo
Spirito di Cristo non ricusa servirsi di esse
come strumenti di salvezza, il cui valore
deriva dalla stessa pienezza della grazia e
della verità, che è stata affidata alla Chiesa
cattolica” (Unitatis Redintegratio 3,4).
Naturalmente occorre distinguere fra chiese
che hanno conservato intatti i sacramenti
(come quelle ortodosse), e chiese prive della
successione
apostolica
(come
quelle
protestanti). Le prime “pur non essendo in
perfetta comunione con la Chiesa Cattolica,
restano unite ad essa per mezzo di strettissimi
vincoli, quali la successione apostolica e la
valida eucaristia”, le seconde, prive per loro
stessa scelta del sacerdozio ordinato, “non
sono Chiese in senso proprio; tuttavia i
battezzati in queste comunità sono dal
Battesimo incorporati a Cristo e, perciò, sono
in una certa comunione, sebbene imperfetta,
con la Chiesa” (Dominus Jesus 17). La
Chiesa di Cristo non è quindi la somma
differenziata di tutte le chiese e le comunità
cristiane, accidentalmente separatesi, ma è già
visibile per intero nella Chiesa Cattolica
“nella quale soltanto sono rimasti e
rimarranno tutti gli elementi da Cristo stesso
istituiti” (Unitatis Redintegratio 3). In essa si
trova “la pienezza dei mezzi di salvezza”
(CCCC 165), e per questo la chiamiamo
anche santa, in quanto è la santità di Dio che
l’ha fondata, ed è lo Spirito Santo che la abita
e la vivifica (CCCC 165). Tramite questa
stessa santità i cristiani possono perseguire la
propria santificazione. Il Credo chiama anche
la Chiesa cattolica, che significa universale
perché “è inviata in missione a tutti i popoli
di ogni tempo e a qualsiasi cultura
appartengano” annunziando la totalità e
l’integrità della fede (CCCC 166). Nella
Nuova Alleanza, destinatario della salvezza
non è solo un popolo, bensì l’universalità
delle genti. Il messaggio della Chiesa, che è
poi il messaggio di salvezza di Gesù, può
essere rettamente assimilato da qualsiasi
cultura e mentalità, e nessuno è escluso dalla
totalità dei benefici portati e custoditi dalla
Chiesa; perché katholikòs in greco non indica
solo una somma, una pluralità di destinatari,
ma, per ogni destinatario, la totalità della sua
persona, in tutte le variabili delle sue
espressioni. Infine il nostro antico Simbolo
della fede chiama la Chiesa apostolica: questo
non significa solamente che, per la sua
origine, discende dagli apostoli o che è
costruita sul loro fondamento; ma anche che
la sua attuale struttura è apostolica, “in
quanto istruita, santificata e governata, fino
al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie ai
loro successori, i Vescovi, in comunione col
successore di Pietro” (CCCC 174). Pertanto
anche l’intiero insegnamento della Chiesa “è
quello stesso degli Apostoli”. Sant’Ireneo da
Lione (130-202), nel suo scritto Adversus
Haereses, dopo aver evidenziato il valore
della successione apostolica, tanto da
enumerare i successori di Pietro fino al suo
tempo, e dopo aver messo in risalto il primato
della Chiesa di Roma “nella quale per tutti gli
uomini sempre è stata conservata la
Tradizione che viene dagli Apostoli”, scrive:
“Tali essendo dunque le prove, non si deve
cercare presso altri la Verità, che è facile
prendere dalla Chiesa, poiché gli apostoli
ammassarono in lei, come in un ricco tesoro,
nella maniera più piena, tutto ciò che
riguarda la Verità, affinché chiunque vuole
prenda da lei la bevanda della Vita”.
“Professo un solo Battesimo per il perdono
dei peccati...”
“La Terra era informe e deserta, e le tenebre
ricoprivano l’abisso, e lo Spirito di Dio
aleggiava sulle acque” (Gn 1,2). Fin
dall’inizio la colomba dello Spirito cercava la
propria immagine nell’acqua che aveva
creato. Così “Dio disse: Facciamo l’uomo a
nostra immagine, a nostra somiglianza” (Gn
1,26), e in Eden fu posto l’uomo, fra quattro
corsi d’acqua generati nel deserto perché Dio
ne aveva fatto scaturire un fiume (Gn 2,4-10).
E come in uno specchio d’acqua, nell’uomo si
riflettevano gli attributi di Dio. Ma, tra questi,
anche quello della libertà, che comportava
anche la libertà di sceglierlo come Padre. In
verità, Dio era già “padre naturale” dell’uomo,
ma nel suo amore non voleva che questa
condizione
non
venisse
scelta
con
consapevolezza, fatta propria come risposta a
questo amore. Tale figliolanza non solo era un
Suo diritto, ma era anche l’unica scelta
ragionevole per l’uomo, se nella stessa Luce
voleva vivere. Assenza di Dio poteva
significare solamente assenza di Luce, e
quindi tenebra. E poiché Dio è Bene perfetto e
senza macchia, e non ama le mescolanze,
“separò la luce dalle tenebre” (Gn 1,5). Ma
“le tenebre ricoprivano l’abisso” (Gn 1,2), e
pertanto scegliere le tenebre anziché la Luce,
avrebbe
certamente
comportato
la
disperazione dell’abisso, la lontananza senza
limiti. E così fu; una distanza incolmabile, che
comportò non solo la perdita della figliolanza
con Dio e della Sua immagine, ma anche una
discendenza di peccato, perché chi nasce dalle
tenebre vive nelle tenebre. Affinché questa
discendenza si purificasse, nei giorni di Noè
venne completamente immersa nell’acqua:
“poche persone, otto in tutto, furono salvate.
Figura, questa, del battesimo” (1Pt 3,20-21).
Salvate dall’annunzio di una colomba,
uscirono dalle acque, e dalla loro discendenza
fu generato Abramo, che attraversò l’acqua
del Giordano (Gn 32,11), ove “era un luogo
irrigato da ogni parte” (Gn 13,10). Abramo
seppe accettare il sacrificio del proprio figlio
per riacquistare la paternità di Dio, e i suoi
figli, numerosi come le stelle cielo,
costellarono
la
storia.
Attraversarono
anch’essi di nuovo le acque, sotto la guida di
Mosè. “Sia il firmamento in mezzo alle acque,
per separare le acque dalle acque” (Gn 1,6).
E così, attraverso il Mar Rosso, si diressero
verso la Terra Promessa, immagine dell’Eden
perduto, dissetandosi dall’acqua che sgorgava
dalla roccia nel deserto (Es 17,1-7). Fino ai
giorni in cui, in quella stessa terra, il sacrificio
che era stato trattenuto in Abramo, non fu
trattenuto in Cristo, come se il Padre avesse
detto: “Sarò Io a sacrificare mio figlio”.
Anche Gesù, dopo aver attraversato il deserto,
attraversò le acque del Giordano, e dinanzi al
Battista ricevette la colomba dello Spirito.
“Splendono d’argento le ali della colomba, le
sue piume di riflessi d’oro” (Sl 67,14).
Giovanni aveva battezzato con acqua,
invitando alla penitenza: era una preghiera
penitenziale, non un sacramento, preparava il
cuore dell’uomo, ma non toglieva i peccati.
Gesù invece “passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente” (Sl 83,7). Tanto
che il Battista poté dire: “Ecco l’Agnello di
Dio, ecco colui che toglie il peccato dal
mondo! Ecco colui del quale io dissi: Dopo di
me viene un uomo che mi è passato avanti,
perché era prima di me. Io non lo conoscevo,
ma sono venuto a battezzare con acqua
perché egli fosse fatto conoscere a Israele. ...
Ho visto lo Spirito Santo scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non
lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a
battezzare con acqua mi aveva detto: L’uomo
sul quale vedrai scendere e rimanere lo
Spirito è colui che battezza in Spirito Santo”
(Gv 1,29-33). Questo stesso battesimo, ora
sacramento, Gesù lo consegnò alla sua chiesa:
“Andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome del Padre,
del Figlio, e dello Spirito Santo” (Mt 28,19).
Da allora, Egli ancora toglie i peccati dal
mondo, ma lo fa tramite la sua Chiesa, roccia
da cui sgorga l’acqua nel deserto. “Chi ha
sete venga a Me e beva, chi crede in Me;
come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva
sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,37-38). Il
santo Battesimo non venne mai interrotto,
perché chi non ne attraversa le acque non può
salvarsi: “In verità ti dico, se uno non nasce
da acqua e da Spirito, non può entrare nel
regno di Dio (Gv 3,5). E poiché questo
sacramento proviene da Dio che è uno, anche
il battesimo è uno solo. “Le acque che sono
sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo”
(Gn 1,9). In esso siamo strappati dalle tenebre
e restituiti alla luce. Tramite questo sacro
segno il cristiano è invitato a far proprio
l’invito del profeta Isaia: “Alzati, rivestiti di
luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, le
tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta
avvolge le nazioni; ma su di te risplende il
Signore, la sua gloria appare su di te” (Is
60,1-2). Grazie a questa immersione, il
cristiano non solo riceve la vera vita, ma la
trasmette agli altri: “Chi beve dell’acqua che
Io gli darò, non avrà mai più sete, anzi,
l’acqua che Io gli darò diventerà in lui
sorgente di acqua che zampilla per la vita
eterna” (Gv 4,14). Ecco perché, come il
profeta, il credente grida al suo prossimo: “O
voi tutti assetati venite all’acqua!” (Is 55,1).
Egli sa che dall’acqua del costato di Cristo,
come da una roccia, sgorga di nuovo la vita
che si riproduce, e perciò annuncia il miracolo
operato dallo Spirito affinché di nuovo “le
acque brulichino di esseri viventi” (Gn 1,20).
“Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà”
“Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io
faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete.
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di
voi la carne, su di voi stenderò la pelle e
infonderò in voi lo spirito e rivivrete: saprete
che io sono il Signore” (Ez 37,5-6). La
profezia di Ezechiele (598 a.C.), passando
attraverso la risurrezione di Cristo, diventerà
promessa escatologica per tutti i credenti. Sarà
proprio il Figlio di Dio, infatti, a identificarsi
con la risurrezione stessa: “Io sono la
risurrezione e la vita” (Gv 11,25).
Risurrezione, vita: le due realtà “aspettate” dal
nostro
Credo.
Dicendo
“aspetto
la
risurrezione”, diciamo, infatti, lo stesso che
“aspetto Cristo”. E dicendo “aspetto la vita”,
diciamo
ancora
“aspetto
Cristo”.
L’antichissimo Simbolo degli Apostoli,
rispetto a quello di Nicea-Costantinopoli,
sottolinea ancora di più la fisicità della nostra
futura
risurrezione,
chiamandola
“risurrezione della carne”. Scrive il profeta
Ezechiele: “Riconoscerete che io sono il
Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi
resusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio”
(Ez 37,13). E, quasi a voler fugare ogni
perplessità, Dio conclude: “L’ho detto e lo
farò” (Ez 37,14).
Allo stesso modo, il Simbolo degli Apostoli,
sottolinea però anche la dimensione spirituale
di questa risurrezione, affermando che la vita
del “mondo che verrà”, e da noi nel Credo
attesa, non è la vita di questo mondo, ma è “la
vita eterna”. Perché “chi crede in me, anche
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me,
non morrà in eterno” (Gv 11,25-26).
L’apostolo Giovanni vide, in visione, la
realizzazione di questa promessa, e così la
descrive nel libro dell’Apocalisse: “Vidi poi
un grande trono bianco e Colui che sedeva su
di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi
la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé.
Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti
al trono. Furono aperti i libri, e fu aperto
anche un altro libro, quello della vita. I morti
vennero giudicati in base a quanto scritto in
quei libri ciascuno secondo le sue opere. Il
mare restituì i morti che esso custodiva, e la
morte e gli Inferi resero i morti da loro
custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo
le sue opere” (Ap 20,11-13). Successivamente
l’apostolo descrive anche, dopo la scomparsa
del cielo e della terra, la venuta del “mondo
che verrà”: “Vidi poi un nuovo cielo e una
nuova terra, perché il cielo e la terra di
prima erano scomparsi e il mare non c’era
più. Vidi anche la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo
sposo” (Ap 21,1-3). Ecco la “dimora di Dio
con gli uomini”, ove “non vi sarà più notte, e
non avranno più bisogno di luce di lampada,
né di luce di sole, perché il Signore Dio li
illuminerà” (Ap 22,5). Si legge nel
Catechismo degli Adulti della C.E.I.: “Con la
letteratura sapienziale e apocalittica la
speranza si estende anche ai morti: i giusti
continuano a vivere nell’amicizia di Dio e
nell’ultimo giorno risorgeranno con il corpo
a nuova vita, mentre crollerà il vecchio
mondo e dalle sue rovine ne germoglierà uno
più bello. Intanto bisogna essere fedeli e
perseveranti” (CdA 1173). L’attesa della
realizzazione di questa stupenda promessa
non deve vederci inattivi ed inoperosi, perché
“ciò che è dono della Provvidenza è anche
frutto della libera cooperazione dell’uomo.
Gli uomini contribuiscono a preparare il
futuro e a disegnarne la figura” (CdA 1179).
Quest’insegnamento era già stato messo in
luce dal Concilio Vaticano II: “Ignoriamo il
tempo in cui saranno portati a compimento la
terra e l’umanità, e non sappiamo il modo
con cui sarà trasformato l’universo...
Tuttavia l’attesa di una terra nuova non deve
indebolire, ma piuttosto stimolare la
sollecitudine nel lavoro relativo alla terra
presente, dove cresce quel corpo dell’umanità
nuova, che già riesce a offrire una certa
prefigurazione che adombra il mondo nuovo”
(Gaudium et Spes 39). La profezia del libro
dell’Apocalisse che annuncia: “Tergerà ogni
lacrima dai loro occhi” (Ap 21,4), può già
cominciare a compiersi fin da ora con i nostri
gesti di amore e di carità, verso i fratelli che
vanno custoditi come sentinelle, perché, se si
risvegliano nella fede, si affiancheranno a noi
e ci supereranno. Profeta non è, infatti, solo
colui che vede il futuro, ma anche colui che ce
lo fa vedere, che lo incarna, lo vive, lo
anticipa, facendo suo il richiamo udito da
Ezechiele: “Profetizza allo spirito, profetizza
figlio dell’uomo e annunzia allo spirito: Dice
il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti
e soffia su questi morti, perché rivivano” (Ez
37,9).
“Amen”
Amen: così sia, cosi è, così credo. Il nostro
antico Simbolo della Fede termina, come del
resto anche la Bibbia, con la parola ebraica
Amen, la cui radice si rifà alla stessa radice
della parola credere. L’Amen finale della
nostra Professione di Fede richiama quindi la
stessa parola con cui inizia: Credo. Credere
significa dire Amen alle promesse di Dio,
fidarsi totalmente di Lui, essergli solidale e
fedele (CCC 1064). Gesù Cristo stesso è
l’Amen, come scrive l’apostolo Giovanni nel
libro dell’Apocalisse: “Così parla l’Amen, il
Testimone fedele e verace, il Principio della
creazione di Dio” (Ap 3,14). L’Amen ci
rimanda quindi al principio della creazione,
per riconoscere le nostre radici e ripercorrerne
la storia della salvezza. Oltre alla nostra
fiducia in Dio, l’Amen esprime anche la sua
fiducia in noi, la sua fedeltà, la speranza che
quanto promesso si realizzi. La virtù cristiana
della speranza non è un semplice desiderare o
auspicarsi, ma attesa certa. Quando Maria
riceve l’annuncio dell’Incarnazione, ella non
vive la speranza come semplice desiderio di
una probabilità, ma attende, sa. Allo stesso
modo il cristiano, col suo Amen, attende in
modo certo che tutto si compia, perché già
“tutto è compiuto” (Gv 19,30). Fecondato dal
Credo anch’egli attende, e, portando in
grembo Cristo, sa che Egli viene. Tutta la
Chiesa, anzi tutta la creazione, Lo ha in
gestazione, vivendo continuamente le doglie
del parto (Rm 8,22). Il Dio dell’Amen non
manca alla parola data. Questo lo crediamo e
lo speriamo. “Spe salvi facti sumus”, nella
speranza siamo stati salvati, scrive San Paolo
(Rm 8,24). “Speranza, di fatto, è una parola
centrale della fede biblica, al punto che in
diversi passi le parole ‘fede’ e ‘speranza’
sembrano interscambiabili” (Enciclica Spe
Salvi, 2). E questa speranza noi cristiani la
esprimiamo col nostro Amen a Cristo. Scrive
San Paolo ai Corinzi: “Tutte le promesse di
Dio in lui sono diventate ‘sì’, Per questo
sempre attraverso di lui sale il nostro ‘Amen’
per la sua gloria” (2Co 1,20). Il momento
liturgico in cui facciamo nostre queste
promesse, e ci impegniamo a realizzarle anche
con la nostra vita, è il Credo, il nostro Amen a
Dio. “La vita cristiana di ogni giorno sarà
allora l’Amen all’«Io credo» della
professione
di
fede”
(CCC
1064).
Riconoscendosi nei contenuti del Credo, il
cristiano ne assume la forma, incarna la
missione di Cristo nella sua storia.
Sant’Agostino (354-430), la cui vita è
attraversata proprio dal Concilio di
Costantinopoli del 381 che regala alla
cristianità la formula definitiva e completa del
Simbolo della Fede, scrive nei suoi Sermoni:
“Il Simbolo sia per te come uno specchio.
Guardati in esso, per vedere se tu credi tutto
quello che dichiari di credere e rallegrati
ogni giorno per la tua fede” (Sermones,
58,11,13). E se davvero il cristiano, col suo
Amen, dice questo sì a Dio, allora tutta la sua
vita proclama: “Grazie Signore per avermi
pensato fin dagli inizi, per aver creato
l’Universo, e, in esso, gli uomini a immagine
di te; grazie per il tuo piano di salvezza che
fin dal giorno della prima caduta ci ha
mostrato i segni della tua misericordia; grazie
per i patriarchi ed i profeti da Te inviati, per il
dono delle Scritture che nei secoli ci hanno
illuminato e guidato; grazie per la Tua venuta
sulla Terra, per le parole di luce e di vita con
cui ci hai ammaestrati, per come ci hai amati e
fatti tuoi discepoli; grazie per la Tua opera di
redenzione che hai attuato attraverso la Croce
e la tua Risurrezione; grazie per l’immenso
dono della Chiesa, in cui hai riposto ogni
tesoro di salvezza; grazie per la saggezza
donata ai suoi Padri, per mezzo dei quali lo
Spirito Santo ha continuato a parlarci; grazie
per il mistero di sapienza custodito nella
Tradizione, che attraverso il Magistero giunge
fino a me; grazie per il dono di tutti i santi e
sante che nei secoli hanno riflesso la tua
immagine ed il tuo volto; grazie per il dono
della vita, naturale e spirituale, per i miei
talenti innati e per tutti i carismi dello Spirito;
grazie per il dono soprannaturale dei tuoi
Sacramenti, nei quali hai racchiuso, coi tuoi
meriti, la Grazia santificante; grazie per
avermi reso compartecipe al tuo disegno di
salvezza, perché tu ami attraverso di me,
annunci attraverso di me, salvi attraverso di
me; nella speranza della vita eterna. Amen”.
ooo§§§ooo