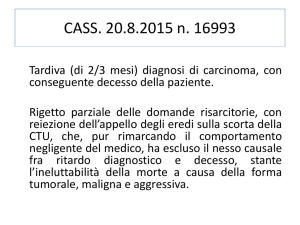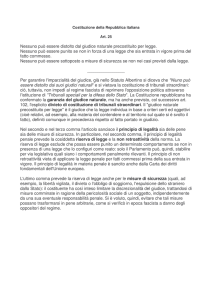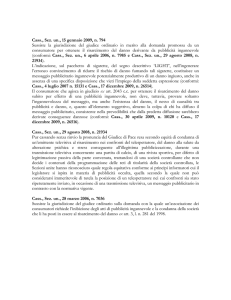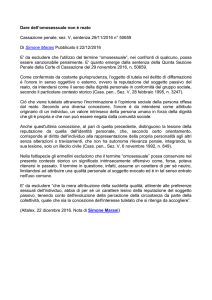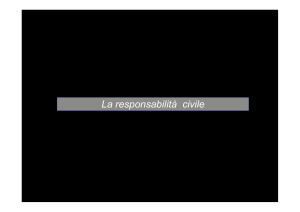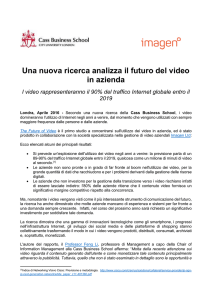Dispensa di diritto civile 9
A cura del cons. Francesco Caringella
1
Contratto, autonomia ed equilibrio.
2
Indice
1. LE NUOVE FRONTIERE DELL’AUTONOMIA NEGOZIALE
1.1 E’ AMMISSIBILE LA DONAZIONE DI COSE ALTRUI: Corte di
Cassazione, sez. II, ordinanza del 23 maggio 2014, n. 11545
1.2 È VALIDA LA CLAUSOLA DISEREDATIVA: Corte di Cassazione, sentenza
del 25 maggio 2012, n. 8352
1.3 GLI ACCORDI IN VISTA DELLO SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO: Corte di Cassazione, sentenza del 21 dicembre 2012, n. 23713
2. LE NUOVE FRONTIERE DEL SINDACATO SULL’AUTONOMIA
NEGOZIALE:
2.1 Corte Costituzionale, sentenza del 21 ottobre 2013, n. 248;
2.2 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 13 settembre 2005, n. 18128
3. LE NUOVE FRONTIERE DEL PRINCIPIO CAUSALE:
3.1 Corte di Cassazione, sentenza dell’8 maggio 2006, n, 10490;
3.2 Corte di Cassazione, sentenza del 24 luglio 2007, n. 16315;
3.3 Corte di Cassazione, sentenza del 20 dicembre 2007, n. 26958
3
Selezione giurisprudenziale
1. LE NUOVE FRONTIERE DELL’AUTONOMIA NEGOZIALE
1.1 E’ AMMISSIBILE LA DONAZIONE DI COSE ALTRUI: Corte di
Cassazione, sez. II, ordinanza del 23 maggio 2014, n. 11545
Con ordinanza del 23 maggio 2014 n. 11545, la Suprema Corte di Cassazione, ha rimesso al Primo
Presidente due questioni ritenute di massima di particolare importanza.
La prima pone il quesito attinente alla possibilità che il divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771
cod.civ. possa essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante sia titolare in comunione
ordinaria.
La seconda, invece, concerne la equiparabilità quoad effecta della categoria dei ‘beni futuri’ di cui all’art. 771
citato con quella di ‘beni altrui’.
(omissis)
Con il terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 769 e 771 c.c. in combinato disposto con l'art. 1103 c.c.,
oltre ad illegittimità per difetto di motivazione ed errata valutazione dei presupposti di fatto per non avere i
giudici di merito riconosciuto che C.F. poteva validamente donare al nipote la quota di proprietà di cui era
esclusivo titolare con riferimento all'immobile di via (OMISSIS), essendo tale bene nella sua piena disponibilità,
potendo essere le argomentazioni del Tribunale riferite semmai alla residua quota di 1/12 pervenuta al donante
per successione ereditaria dal fratello C.P. A conclusione del mezzo viene posto il seguente quesito di diritto:
"Dica la Suprema Corte di Cassazione se il divieto di cui all'art. 771 c.c. può essere legittimamente
esteso anche ai beni di cui il donante è titolare in comunione ordinaria con i propri fratelli".
Con il quarto motivo è lamentata la violazione ed erronea applicazione degli artt. 771 e 769 c.c. in combinato
disposto con gli artt. 1103 e 757 c.c., nonchè carenza assoluta di motivazione, per avere ritenuto i giudici di
merito "beni altrui", fino al momento della divisione, anche i beni in comproprietà ordinaria, ciò in aperto
contrasto con i principi che regolano l'istituto della comproprietà e dell'art. 1103 c.c. che sancisce il principio
della piena disponibilità dei beni in comproprietà nei limiti della quota di titolarità del disponente. Ad avviso dei
ricorrenti eguali considerazioni varrebbero anche per la cd. quota ereditaria. Viene, infine, criticata la conclusione
del giudice di merito circa l'irrilevanza della qualificazione della fattispecie quale condizione sospensiva, ritenendo
che la divisione dei beni ereditari, seppure avvenga dopo il decesso di uno dei coeredi, non cancella i diritti
nascenti sui beni ereditari. Il motivo culmina nel seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte di
Cassazione se l'art. 771 c.c. può essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la
categoria dei "beni futuri" con quella dei "beni altrui".
4
La questione risolta dalla Corte di appello attiene alla proprietà della quota del fabbricato comune (sito in
(OMISSIS)) appartenente a C.F., di cui egli era titolare, in parte, in proprio, per averlo costruito in comune con i
fratelli C.P. e C.G., ed in parte per eredità pervenutagli dal fratello C.P., premorto, e da questi donata - a titolo di
nuda proprietà, riservando a sè l'usufrutto - al nipote C.N., individuando nell'atto pubblico la quota del bene
rimasto sempre in comunione con riferimento ai due appartamenti posti al secondo piano dell'edificio, da sempre
occupati dal donante (come del resto dagli altri due originari comproprietari per le rispettive quote).
A fronte di siffatta situazione - nell'ambito del giudizio di scioglimento dei compendi ereditari - i giudici di
merito hanno accertato la nullità dell'atto di donazione con riferimento agli artt. 769 e 771 c.c.,
sull'assunto che la donazione può avere ad oggetto esclusivamente beni facenti parte del patrimonio
del donante al momento del compimento dell'atto di liberalità, tali non potendosi ritenere quelli di cui
egli era comproprietario prò indiviso.
Invero l'art. 769 c.c. definisce la donazione come il "contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte
arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto" ed il nostro codice -segnando il mutamento
rispetto al regime precedente - ha assoggettato la donazione al principio consensualistico (salvo il caso di
donazione manuale: art. 783 c.c.), il quale comporta che tutti i contratti diretti a promuovere uno spostamento
patrimoniale sono contratti con efficacia reale, cioè idonei a produrre il trasferimento, o immediatamente o in
quanto integrati da un fatto o atto successivo.
Ciò nonostante, svalutando il mutamento degli indici normativi del codice del 1942, si è ritenuta di attualità la
regola dello spoglio, tratto caratterizzante della donazione con effetti reali immediati, il quale implica il
requisito dell'appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto, ossia, come
precisa l'inciso della citata disposizione, l'arricchimento realizzato mediante disposizione di un "suo
diritto" (così Cass. 5 maggio 2009 n. 10356; più di recente Cass. 23 maggio 2013 n. 12782).
Nella medesima direzione si è mossa la - peraltro scarsa - giurisprudenza in materia, nel dichiarare la nullità di
ogni donazione di bene altrui. Così Cass. 20 dicembre 1985 n. 6544, che ha affermato l'invalidità di un bene altrui
facendo leva sull'accezione soggettiva della futurista di cui all'art. 771 c.c.
La interpretazione analogica dell'art. 771 c.c. ricorre anche in Cass. 18 dicembre 1996 n. 11311, che ha dichiarato
la nullità della donazione da parte della pubblica amministrazione di un'area che la stessa si impegnava ad
espropriare. Al predetto indirizzo si sono contrapposte le opinioni espresse da molta parte della dottrina,
valorizzando una lettura dell'art. 769 c.c. che tenga conto della sua seconda parte, laddove consente
l'arricchimento della parte donataria "assumendo verso la stessa un'obbligazione". In tale solco logico
sembra collocarsi Cass. 5 febbraio 2001 n. 1596, che ha considerato separatamente la disposizione di beni futuri
da quella di beni altrui, statuendo che la donazione di cosa altrui non deve reputarsi nulla, bensì
semplicemente inefficace - data la lettura e la natura eccezionale dell'art. 771 c.c. - da cui si è fatto
discendere la sua idoneità a valere quale titolo per l'usucapione immobiliare abbreviata. In sintesi, con la
citata sentenza questa Corte ebbe modo di precisare che anche la donazione di cosa altrui - inefficace, ma valida vantava l'idoneità traslativa pretesa dalla norma, anche se a rigore sembra opportuna una lettura restrittiva del
precedente, emergendo non la validità di qualsiasi donazione di cosa altrui, ma soltanto di quella concepita dalle
parti come donazione di cosa propria del donante, l'unica suscettibile di concorrere all'usucapione.
5
Il problema di non poco conto che si intreccia con i diversi argomenti posti a fondamento delle differenti
soluzioni attiene alla più generale questione della ratio della disposizione di cui all'art. 771 c.c.: se intende
propriamente evitare un eccessivo depauperamento del donante, come parrebbe delinearsi nelle ultime pronunce,
ovvero non consentire di derivare ex lege l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo al donatario
quanto l'acquisto della proprietà non sia effetto immediato del consenso legittimamente manifestato dalle parti,
che alluderebbe ad un difetto (eventualmente temporaneo) di legittimazione a disporre, come sembra valutato
dalla pronuncia del 2001.
E' evidente l'interesse alla soluzione della problematica, trattandosi di affermazione di principio per la
definizione dei confini del divieto di donazione, giacchè in fattispecie come quella in esame, in cui in origine
vi sia una comunione ordinaria dell'intero stabile, del quale sia stato concordato il godimento da parte di ciascuno
dei comunisti - in via esclusiva - di singoli appartamenti, pur vero che poteva formare oggetto di donazione solo
la quota della comunione e non il singolo bene, non essendo il donante titolare esclusivo del bene in suo
(esclusivo) possesso, tuttavia non può non essere significativa la considerazione che la legittimazione a disporre è
da ritenere un elemento esterno alla struttura della fattispecie contrattuale, che determina l'inefficacia traslativa
che la legge imputa al consenso legittimamente manifestato tra le parti. Di qui la rilevanza anche nel
microcosmo delle donazioni laddove il bene può essere ritenuto solo eventualmente altrui, circostanza
che dunque può assumere un'incidenza sul negozio dispositivo o in termini di inefficacia (tesi parimenti
censurata dai ricorrenti in quanto ricompresa nella più complessiva doglianza della ritenuta nullità) ovvero di
nullità per quanto sopra esposto.
Il carattere di questione di particolare importanza fa ravvisare al collegio l'opportunità della trasmissione degli atti
al Primo Presidente affinchè valuti l'eventualità di rimettere la causa alle Sezioni Unite ove condivida l'esigenza di
una risposta nomofilattica al più alto livello sulla questione.
P.Q.M.
La Corte, rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
1.2 È VALIDA LA CLAUSOLA DISEREDATIVA: Corte di Cassazione, sentenza
del 25 maggio 2012, n. 8352
È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla
propria successione alcuni dei successibili.
La clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione
di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il
testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima
ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio.
6
(omissis)
2.1. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 588 cod. civ., nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La censura si riferisce alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la clausola di
diseredazione contenuta nel testamento della signora I..S. sarebbe invalida, perché la scheda testamentaria non
conteneva anche disposizioni positive. I ricorrenti rilevano che mediante la clausola di diseredazione il testatore
provvede a regolare i rapporti patrimoniali per il tempo successivo alla propria morte, favorendo, fra i successibili
legittimi, quelli non esclusi con la diseredazione. Quest'ultima, pertanto, mirando, mediante l'esclusione di uno o
più successibili legittimi, ad ampliare il beneficio degli altri, sarebbe di per sé una disposizione - implicitamente positiva. In ogni caso, osservano i ricorrenti, l'art. 587 cod. civ., nel definire il testamento come l'atto con il quale
taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, non
escluderebbe affatto che la libertà di disporre delle proprie sostanze riconosciuta al testatore, possa manifestarsi
anche in un 'non volere disporre' di esse in favore di uno o più soggetti determinati. La decisione relativa alla
mancata attribuzione equivarrebbe, quindi, non già all'assenza di una idonea manifestazione di volontà, bensì alla
manifestazione di una ben precisa volontà. Il giudizio di invalidità della clausola di mera diseredazione
postulerebbe quindi che alla espressione 'dispone', contenuta nell'art. 587 cod. civ., si assegni il significato di
'attribuisce'; ma, rilevano i ricorrenti, le due espressioni hanno invece significati diversi, collocandosi in un
rapporto di genere a specie, nel senso che “è atto di disposizione dei propri beni, infatti, tanto l'attribuzione di
essi, quanto la dichiarazione di non volerli attribuire a determinati soggetti”.
In sostanza, sostengono i ricorrenti, l'art. 588 cod. civ., da un lato, non esaurisce le ipotesi in cui il legislatore
prevede e disciplina l'attività dispositiva; dall'altro, non esclude che altre disposizioni - quali quelle non attributive
- siano tutelate dall'ordinamento, purché, nel realizzare la funzione testamentaria di produrre effetti successori,
non contrastino con l'ordine pubblico; contrasto che deve escludersi nel caso in cui siano rispettati i diritti dei
legittimari.
A conclusione del motivo, i ricorrenti, oltre a specificare il vizio di motivazione denunciato, formulano il
seguente quesito di diritto: “dica l'Ecc.ma Corte se incorre in violazione degli artt. 587 e 588 cod. civ. il
Giudice del merito che qualifichi come invalida la clausola mediante la quale il testatore stabilisca di
escludere dalla successione uno o più successibili legittimi”.
3. Con l'unico motivo del proprio ricorso, il ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 457, 467 e 468 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda
volta a sentir dichiarare il suo diritto a succedere ad E.G. per rappresentazione.
A conclusione del motivo, il ricorrente incidentale propone i seguenti quesiti di diritto: “se sono da condividere e
da applicare alla fattispecie de quo i seguenti principi, affermati dalla S.C.: 1) La diseredazione al pari
dell'indegnità a succedere, non esclude la operatività della rappresentazione in favore dei discendenti del
rappresentato. La diseredazione ha effetti solo nei confronti del soggetto nei cui confronti è effettuata, e
pertanto, non esclude che il discendente legittimo di chi sia stato diseredato dal testatore possa succedere a
quest'ultimo per rappresentazione (Cass. civ., sez. II, 23.11.1982, n. 6339). 2). La diseredazione, al pari
7
dell'indegnità a succedere, non esclude l'operatività della rappresentazione a favore dei discendenti del diseredato
(Cass. civ., sez. II 14.12.1996, n. 11195)”.
4. Il Collegio ritiene che il secondo motivo del ricorso principale, ancorché prospettato dai ricorrenti come
subordinato al rigetto del primo, debba essere esaminato in via prioritaria, non solo per ragioni di ordine logico,
ma perché dal suo accoglimento, a differenza di quanto potrebbe verificarsi con l'accoglimento del primo
motivo, discende la possibilità di definizione del giudizio nel merito. (omissis)
Al contrario, l'accoglimento del secondo motivo, inerendo ad un vizio di violazione di legge, potrebbe dare
luogo, sussistendone in concreto i presupposti, ad una decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod.
proc. civ..
In questo senso, e cioè nel senso che deve prioritariamente esaminarsi la censura che coinvolge l'accertamento di
quale sia la portata delle disposizioni legislative rilevanti in materia rispetto alle censure che coinvolgono
l'interpretazione della clausola testamentaria, si è del resto già espressa Cass. n. 1458 del 1967, che costituisce il
precedente di questa Corte al quale si è ispirata la decisione impugnata.
4.1. Il controricorrente e ricorrente incidentale ha eccepito, ma solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la
inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale per inidoneità del quesito di diritto.
L'eccezione è infondata, atteso che il quesito, nei termini testuali prima riportati, è formulato in modo tale che,
ove allo stesso sia data risposta positiva, la controversia può essere decisa in senso favorevole alla tesi dei
ricorrenti principali.
5. Il motivo è fondato.
5.1. La Corte d'appello si è riferita alla risalente giurisprudenza di questa Corte, la quale, segnatamente nella
sentenza n. 1458 del 1967, ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 587,
primo comma, cod. civ., il testatore può validamente escludere dall'eredità, in modo implicito o
esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però, che la scheda testamentaria
contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nelle
forme dell'istituzione di erede o del legato. È quindi nullo il testamento con il quale, senza altre
disposizioni, si escluda il detto erede, diseredandolo. Peraltro, qualora dall'interpretazione della scheda
testamentaria risulti che il de cuius, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare un
successibile, abbia implicitamente inteso attribuire, nel contempo, le proprie sostanze ad altri soggetti,
il testamento deve essere ritenuto valido, contenendo una vera e propria valida disposizione positiva dei
beni ereditari, la quale è sufficiente ad attribuire efficacia anche alla disposizione negativa della
diseredazione... “.
In motivazione, la Corte, che ha esaminato una clausola testamentaria meramente negativa (“Nelle mie piene
facoltà mentali e in perfetta salute, dichiaro, qualora io dovessi mancare, di escludere dalla mia eredità e cioè da
quello che io posseggo, le mie due nipoti A. e G.... figlie del mio defunto fratello P...., per il loro indegno
comportamento verso di me ed i miei fratelli”), è partita dalla tesi tradizionale dell'invalidità della clausola di
diseredazione ma, anziché pervenire ad una dichiarazione di nullità, come avrebbe dovuto coerentemente fare,
data la portata meramente diseredativa della richiamata disposizione, e quindi dichiarare aperta la successione
legittima, ha ritenuto di poter ricavare, per via interpretativa, una volontà, implicita, del testatore di disporre col
8
testamento stesso a favore dei successibili ex lege diversi dalle nipoti escluse; ha pertanto, coerentemente
affermato l'apertura della successione testamentaria.
In particolare, la Corte, pur ritenendo che il testamento abbia carattere necessariamente attributivo, ha
ammesso tuttavia la validità della clausola non solo quando questa si accompagni a disposizioni
attributive espresse, ma anche quando esaurisca il contenuto del testamento, purché sia possibile
ricavare in sede ermeneutica “sia in modo diretto ed esplicito, sia in modo indiretto ed implicito la
inequivocabile volontà del testatore, oltre che di diseredare un determinato successibile, di attribuire le
proprie sostanze ad un determinato altro”.
Successivamente, nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato il principio per cui “la volontà di
diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione
di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di
volontà o dal tenore complessivo dell'atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta
autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito
ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di
diseredazione, l'effettivo contenuto della volontà di istituzione. Pertanto, ove il giudice del merito
nell'interpretazione dello scritto ritenga inesistente una tale volontà, correttamente lo stesso non
ammette la prova diretta al fine di dimostrare la volontà del de cuius di disporre dei propri beni a favore
di alcuni soggetti, in quanto con tale prova si mira non già ad identificare la volontà testamentaria
contenuta, esplicitamente o implicitamente, nella scheda, ma alla creazione di una siffatta volontà”
(Cass. n. 6339 del 1982; Cass. n. 5895 del 1994).
5.2. La soluzione accolta dai precedenti di questa Corte non è condivisa dal Collegio, in quanto contiene in sé
una sostanziale contraddizione. Da un lato, infatti, si predica la assoluta invalidità di una clausola meramente
negativa, ove la stessa non sia accompagnata ad altre che contengano disposizioni attributive, ancorché tali da
non esaurire l'intero asse e-reditario; dall'altro se ne riconosce la validità anche nel caso in cui costituisca l'unica
disposizione contenuta in una scheda testamentaria, a condizione però che sia possibile ricavare sia in modo
diretto ed esplicito, sia in modo indiretto ed implicito la inequivocabile volontà del testatore, oltre che di
diseredare un determinato successibile, di attribuire le proprie sostanze ad un determinato altro.
Un simile argomentare vanifica, in realtà, la affermazione di principio dalla quale sembra muovere la sentenza del
1967, della tendenziale invalidità della clausola di diseredazione, la quale è invece valida ed efficace allorquando
dalla stessa sia possibile desumere una istituzione in favore di soggetti non contemplati ma comunque
implicitamente individuabili, una volta esclusi dalla successione quelli invece espressamente menzionati nella
clausola di diseredazione.
5.3. Dalla lettura della richiamata sentenza del 1967 emerge che l'argomento dirimente per escludere la
ammissibilità nel nostro ordinamento di una clausola testamentaria di contenuto esclusivamente negativo, quale,
appunto, la clausola di diseredazione che manifesti la volontà del testatore di escludere un successibile, senza che
sia possibile individuare una volontà positiva, sia pure implicita, di chiamare altri alla sua successione, è quello
desunto dal contenuto e dalla portata degli artt. 587 e 588 cod. civ..
9
La lettura delle citate disposizioni offerte nei precedenti di questa Corte deve essere rivista e superata alla luce
delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 587, primo comma, cod. civ., il negozio di ultima volontà ha la funzione di consentire al
testatore di disporre di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Con
una tale definizione, il legislatore sembra accogliere la natura essenzialmente patrimoniale dell'atto di
ultima volontà. Le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale (art. 587, secondo comma, cod. civ.),
che la legge permette siano contenute in un atto privo di disposizioni di carattere patrimoniale purché abbia la
forma del testamento, condividono, invece, con il negozio di ultima volontà solo il tratto formale, ma non quello
sostanziale, legittimando di conseguenza l'applicazione di un diverso regime (si pensi all'irrevocabilità, che è
generalmente incompatibile con il contenuto tipico del testamento).
Peraltro, dal rilievo che la disposizione testamentaria tipica abbia contenuto patrimoniale, non discende
la conseguenza che il testamento, per essere tale, debba avere necessariamente una funzione
attributiva. L'articolato sistema delineato dal legislatore permette che il fenomeno devolutivo dei beni e
l'individuazione degli eredi e dei legatari possano trovare indistintamente fondamento sia nella legge che nella
volontà del testatore. Nel nostro ordinamento, la possibilità di un'attribuzione di beni per testamento, che genera
un fenomeno vocativo legale, convive con quella, inversa, di un'istituzione per testamento di eredi, che genera la
devoluzione legale dell'asse (o di una sua quota). Una simile convivenza, poi, non può che essere confermata
dall'art. 457 cod. civ., che riconosce farsi luogo alla successione legittima, quando manca in tutto o in parte quella
testamentaria, smentendosi dunque una gerarchia di valore tra le due forme del regolamento successorio, e
dovendosi invece ricondurre il concorso tra le due vocazioni ad un rapporto di reciproca integrazione.
5.4. I richiamati precedenti hanno inteso riconoscere l'ammissibilità di una volontà di diseredazione ove in essa si
ravvisi o una disposizione principale attributiva, esplicitamente o implicitamente presupposta, della quale la
volontà del testatore è una modalità di esecuzione (Cass. n. 1458 del 1967), o un'implicita istituzione di tutti gli
altri successibili non diseredati, volontà che non si presume ma va provata (Cass. n. 6339 del 1982; Cass. n. 5895
del 1994). Quest'ultimo orientamento ammette la clausola di diseredazione solo se fondata
sull'equivalenza tra l'esclusione e l'istituzione implicita di altri.
Tuttavia, se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo in tutto o in parte i
successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con un'espressa e apposita dichiarazione, limitarsi
ad escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni. Invero, escludere
equivale non all'assenza di un'idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di
volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della
dichiarazione stessa, che è negativa.
Per diseredare non è quindi necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni, né - sulla scorta
dell'espediente che escludere è istituire - alla prova di un'implicita istituzione.
In sostanza, la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore,
costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto
tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la
successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio. Il
10
'disporre' di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ., può dunque includere, non solo una volontà attributiva e
una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva. Altre volte, d'altronde, il
nostro legislatore ha concepito disposizioni di contenuto certamente patrimoniale, che non implicano
attribuzioni in senso tecnico e che possono genericamente farsi rientrare nella nozione di 'atto dispositivo' del
proprio patrimonio ex art. 587, primo comma, cod. civ., avendo utilizzato il termine 'disposizione' nel senso
riferito in questa sede (in materia di dispensa da collazione, di assegno divisionale semplice, di onere
testamentario, di ripartizione dei debiti ereditari, di disposizione contraria alla costituzione di servitù per
destinazione del padre di famiglia, di disposizione a favore dell'anima e di divieti testamentari di divisione).
Le varie ipotesi in cui l'attività dispositiva possa manifestarsi sono tutelate dall'ordinamento purché non
contrastino con il limite dell'ordine pubblico: ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se
non 'attributiva' e anche se non prevista nominatim dalla legge, può dunque costituire un valido
contenuto del negozio testamentario, solo se rispondente al requisito di liceità e meritevolezza di tutela,
e se rispettosa dei diritti dei legittimari.
L'ammissibilità della clausola diseredativa, quale autonoma disposizione negativa, appare, infine, in linea con
l'ampio riconoscimento alla libertà e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore, che in altri ambiti del
diritto successorio ha ammesso un'efficacia negativa del negozio testamentario : nell'ambito del contenuto
patrimoniale del testamento, non solo il testatore può ben gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma
può escludere il legittimario dalla quota disponibile, sia mediante l'istituzione nella sola quota di legittima, sia
mediante il legato sostitutivo previsto dall'art. 551 cod. civ.; il testatore può inoltre modificare le norme che la
legge pone alla delazione successiva, escludendo l'operatività del diritto di rappresentazione a favore dei pro-pri
congiunti con la previsione di più sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un'esclusione diretta.
5.5. In conclusione, deve in proposito, e in risposta al quesito di diritto formulato dai ricorrenti principali a
conclusione del secondo motivo di ricorso, affermarsi il seguente principio di diritto: “È valida la clausola del
testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione
alcuni dei successibili”.
1.3 GLI ACCORDI IN VISTA DELLO SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO: Corte di Cassazione, sentenza del 21 dicembre 2012, n. 23713
L’accordo con cui, prima del matrimonio, il futuro coniuge si impegna a ritrasferire all’altro la proprietà di
un immobile “in caso di fallimento di matrimonio” ed a titolo di corrispettivo per le spese sostenute per la
ristrutturazione di altro locale adibito a residenza familiare, non configura un’ipotesi di accordo prematrimoniale nullo per illiceità della causa, ma una “datio in solutum”, in cui l’impegno negoziale assunto è
collegato “alle spese affrontate”, e il fallimento del matrimonio non rappresenta la causa genetica
dell’accordo, ma è degradato a mero evento condizionale.
11
In linea generale, gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale e in
vista del futuro divorzio, sono nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di
indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio.
(omissis)
Come è noto, in Italia, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del
matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità
della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di
divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, in quanto
trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del sistema normativo, ormai orientato a
riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche
successivi alla crisi coniugale. E’ assai singolare che invece siano stati ritenuti validi accordi in vista di una
dichiarazione di nullità del matrimonio, perché sarebbero correlati ad un procedimento dalle forti connotazioni
inquisitorie, volto ad accertare l’esistenza o meno di una causa di invalidità del matrimonio, fuori da ogni potere
negoziale di disposizione degli status: tra le altre, Cass. n. 248 del 1993).
Giurisprudenza più recente di questa Corte ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé
contrari all’ordine pubblico; più specificamente il principio dell’indisponibilità preventiva dell’assegno di
divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l’azione di nullità (relativa)
sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n.
5302/2006).
Va peraltro precisato che la sentenza impugnata, sorretta da motivazione ampia, articolata e non illogica, ha
fornito un preciso inquadramento della scrittura privata in esame. Si tratta, all’evidenza, di valutazione di merito,
in suscettibile di controllo in questa sede, ove immune da errori di diritto.
L’impegno negoziale della P., una sorta di datio in solutum, viene collegato alle spese affrontate dall’O. per la
sistemazione di altro immobile adibito a casa coniugale, e il fallimento del matrimonio non viene considerato
come causa genetica dell’accordo, ma è degradato a mero ‘‘evento condizionale’’. Prosegue la Corte di
merito precisando che, ove causa genetica fosse il matrimonio (e il suo fallimento), l’impegno predetto, una sorta
di sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi anche in ordine all’assunzione di
iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo coniugale, sarebbe sicuramente nullo. Ma indice di tale ipotesi
potrebbe essere soltanto una notevole sproporzione delle prestazioni, al contrario non provata.
L’argomentazione è censurata dalla ricorrente, ma, al contrario, la Corte territoriale ha fatto buon uso delle regole
di ermeneutica contrattuale, in particolare con riferimento all’art. 1353 c.c., per cui le clausole del contratto si
interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Si tratterebbe in definitiva - si può aggiungere - di un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia
negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione
consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo
rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque
12
un accordo (rectius: un vero e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro
proporzionali, secondo l’inquadramento effettuato dal giudice a quo.
Come si è detto, una motivazione adeguata e non illogica, e immune da errori di diritto.
Come è noto, ai sensi dell’art. 1197 c.c. il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella
dovuta, salvo che il creditore vi consenta; l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Nella specie, il trasferimento di immobile può sicuramente costituire adempimento, con l’accordo del creditore,
rispetto all’obbligo di restituzione delle somme spese per la sistemazione di altro immobile, adibito a casa
coniugale.
La condizione, nella specie sospensiva (il ‘‘fallimento’’ del matrimonio) non può essere meramente potestativa ai
sensi dell’art. 1355 c.c., e cioè dipendere dalla mera volontà di uno dei contraenti (ciò che, nella specie, non
potrebbe verificarsi, considerando, evidentemente, le parti tale ‘‘fallimento’’, come fattore oggettivo,
indipendentemente da eventuali responsabilità addebitabili all’uno o all’altro coniuge).
La condizione neppure può porsi in contrasto con norme imperative, l’ordine pubblico, il buon costume (in tal
caso renderebbe nullo il contrasto, ai sensi dell’art. 1354 c.c.). Dunque nulla sarebbe una condizione contraria
all’art. 160 c.c., sopra indicato. E tuttavia, nella specie, essa appare pienamente conforme a tale disposizione, ove
si consideri che in costanza di matrimonio (e prima della crisi familiare) opera tra i coniugi il dovere reciproco di
contribuzione di cui all’art. 143 c.c.; il linguaggio comune spiega il significato ad esso attribuito dal legislatore, è la
parte che ciascuno conferisce, con cui si concorre, si coopera ad una spesa, al raggiungimento di un fine. Con la
contribuzione, si realizza dunque il soddisfacimento reciproco dei bisogni materiali e spirituali di ciascun coniuge,
con i mezzi derivati dalle sostanze e dalle capacità di ognuno di essi.
Può sicuramente ipotizzarsi che, nell’ambito di una stretta solidarietà tra i coniugi, i rapporti di dare ed evere
patrimoniale subiscano, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una ‘‘sospensione’’ appunto, che cesserà con il
‘‘fallimento’’ del matrimonio, o con il venir meno, provvisoriamente con la separazione, e definitivamente con il
divorzio, dei doveri o diritti coniugali.
Condizione lecita, dunque, nella specie, di un contratto atipico, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi,
sicuramente diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c. Vanno
pertanto rigettati i due motivi, in quanto infondati e, conclusivamente, il ricorso stesso.
2. LE NUOVE FRONTIERE DEL SINDACATO SULL’AUTONOMIA
NEGOZIALE:
2.1 Corte Costituzionale, ordinanza del 21 ottobre 2013, n. 248;
(omissis)
Ritenuto che − in un giudizio civile promosso per ottenere la restituzione di somma che gli attori assumevano
versata come anticipo (in misura di circa un terzo del pattuito) per l’acquisto di un immobile, che non aveva poi
13
potuto, però, aver luogo per la mancata erogazione, ad essi, di un mutuo bancario destinato a coprire il residuo
prezzo − l’adito Tribunale ordinario di Tivoli, premesso che nel preliminare di vendita, l’importo corrisposto dai
promissari acquirenti, era stato testualmente qualificato come “caparra confirmatoria”, ha sollevato d’ufficio, con
l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1385, secondo comma, del
codice civile, «nella parte in cui non dispone che – nelle ipotesi in cui la parte che ha dato la caparra è
inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra e nella ipotesi in cui, se
inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio
della caparra – il giudice possa equamente ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire, in
ipotesi di manifesta sproporzione o ove […] sussistano giustificati motivi»;
che, ad avviso del rimettente, si prospetta, nella specie, una esigenza di bilanciata tutela del diritto della parte non
inadempiente (cioè del venditore), a percepire la caparra, e dell’opposto interesse di quella inadempiente (cioè del
promissario acquirente) a non perdere un capitale notevole, ed eccessivo nella sua quantificazione, a fronte di un
(proprio) inadempimento che, «seppur colposo, certamente non è stato voluto e rispetto al quale si è adoperato
in ogni modo per trovare una soluzione»;
che, però, l’automatismo della disciplina recata dalla disposizione denunciata non lascerebbe spazio al giudice per
alcun rimedio ripristinatorio dell’equità oggettiva e del complessivo equilibrio contrattuale; dal che il dubbio,
appunto, della sua “irragionevolezza”;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità della questione, per omessa espressa indicazione dei
parametri costituzionali violati; e, in subordine, per la sua non fondatezza.
Considerato che, dal contesto dell’ordinanza di rimessione, è chiaramente individuabile, nell’articolo 3, secondo
comma, della Costituzione, il parametro rispetto al quale il giudice a quo sollecita la verifica di costituzionalità
della disciplina della caparra confirmatoria, per sospetta sua «intrinseca incoerenza […] rispetto alla complessiva
finalità perseguita dal legislatore», per cui non risulta fondata l’eccezione di inammissibilità come sopra formulata
dall’Avvocatura;
che la questione in esame è, però, comunque, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, in punto
sia di non manifesta infondatezza che di rilevanza;
che, infatti, per il primo profilo, nel presupporre un oggettivo ed insuperabile automatismo tra l’inadempimento
del tradens e la ritenzione della caparra confirmatoria da parte dell’accipiens (e, specularmente, tra
l’inadempimento dell’accipiens e il diritto della controparte ad esigerne il doppio), il rimettente omette di
considerare che ciò che viene in rilievo, anche nel contesto della disciplina del recesso recata dall’articolo 1385
del codice civile, è comunque un inadempimento «gravemente colpevole, […] cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e
art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1456 c.c.)», come ben posto in evidenza nella sentenza delle
Sezioni unite della Corte di cassazione n. 533 del 2009;
che, in punto poi di rilevanza, il Tribunale rimettente, per un verso, trascura di indagare compiutamente la reale
portata dei patti conclusi dalle parti contrattuali, così da poter esprimere un necessario coerente giudizio di
corrispondenza del nomen iuris rispetto all’effettiva funzione della caparra confirmatoria; per altro verso, non
tiene conto dei possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che
14
rifletta (come, nella specie, egli prospetta) un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente
sbilanciato in danno di una parte. E ciò in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità (totale o parziale) ex
articolo 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’articolo 2 Cost., (per il profilo
dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato
contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «funzionalizzando così il rapporto
obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse
proprio dell’obbligato» (Corte di cassazione n. 10511 del 1999; ma già n. 3775 del 1994 e, in prosieguo, a sezioni
unite, n. 18128 del 2005 e n. 20106 del 2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1385,
secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all’articolo 3, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l’ordinanza in epigrafe.
2.2 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 13 settembre 2005, n. 18128
Il potere del giudice di ridurre la penale possa essere esercitato d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla
penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale e stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la mancata previsione da
parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si
traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.
(omissis)
5. Con il primo motivo del ricorso si denuncia: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. Difetto di motivazione. Il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Si deduce l'erroneità dell'assunto del Tribunale in ordine alla ritenuta non riducibilità d'ufficio della penale e si
richiama a sostegno della censura la sentenza n. 10511/1999 di questa Corte.
6. La censura pone il problema se il potere di ridurre la penale, conferito al giudice dall'art. 1384 c.c.,
possa essere esercitato d'ufficio ovvero se sia necessaria la domanda o la eccezione della parte tenuta al
pagamento.
6.1. Il dato normativo, come detto, è costituito dall'art. 1384 c.c. secondo cui «La penale può essere diminuita
equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento».
6.2. Fin dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata
concorde nell'affermare che il potere del giudice di ridurre la penale non può essere esercitato d'ufficio, pur
15
manifestando nell'ambito di questo orIentamento, notevoli oscillazioni in ordine al modo ed ai tempi in cui le
parti avrebbero dovuto esercitare il loro riconosciuto dovere di sollecitare la pronuncia del giudice, giungendo, in
taluni casi, ma con affermazione poi superata dalla successiva prevalente giurisprudenza, a ritenere che la
richiesta di riduzione della penale dovesse ritenersi implicita nell'affermazione di nulla dovere a tale titolo.
Tale orientamento è stato, tuttavia, posto in discussione dalla sentenza n. 10511/1999 di questa Corte, la
quale ha, invece, ritenuto che la penale possa essere ridotta dal giudice anche d'ufficio.
Questo nuovo orientamento non ha però trovato seguito nella successiva giurisprudenza della Corte, che (fatta
eccezione per la sentenza n. 8188/2003 che ad esso si è adeguata) ha ribadito l'orientamento tradizionale, con le
sentenze n. 5324/2003, n. 8813/2003, n. 5691/2002, n. 14172/2000.
6.3. Queste sezioni unite, chiamate a risolvere il richiamato contrasto, ritengono di dover confermare il
principio affermato dalla sentenza n. 10511/1999, cui si è adeguata la sentenza n. 8188/2003.
6.4. Non vi è dubbio che la svolta operata dalla sentenza n. 10511/1999 è stata influenzata da due concorrenti
elementi.
Il primo relativo al riscontro nella giurisprudenza, che fino ad allora aveva negato il potere del giudice di ridurre
d'ufficio la penale, di taluni cedimenti, individuati nel fatto che, in alcune delle pronunzie, l'ossequio al principio
tradizionale appariva solo formale, poiché si giungeva talvolta a ritenere la domanda di riduzione implicita
nell'assunto della parte di nulla dovere a titolo di penale ovvero l'eccezione relativa proponibile in appello.
Il secondo fondato sull'osservazione che l'esegesi tradizionale non appariva più adeguata alla luce di una rilettura
degli istituti codicistici in senso conformativo ai precetti superiori della Costituzione, individuati nel dovere di
solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), nell'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle
pretese creditorie (Corte cost. n. 19/1994), da valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di
correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.).
6.5. Quanto al primo elemento sopra ricordato, non v'è dubbio che le variegate posizioni assunte dalla
giurisprudenza, in ordine ai tempi ed ai modi in cui la richiesta di riduzione della penale debba avvenire ed alle
ragioni per le quali la stessa possa essere richiesta, denotano quanto meno una debolezza dei fondamenti giuridici
sui quali si basa la tesi della non riducibilità d'ufficio della penale, nonché una implicita contraddittorietà,
individuabile specie in quelle pronunce le quali affermano che la norma dell'art 1384 c.c. - che attribuisce al
giudice il potere di diminuire equamente la penale - non ha la funzione di proteggere il contraente
economicamente più debole dallo strapotere del più forte, bensì mira alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio
contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano
derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente (v. Cass. 6 aprile 1978, n. 1574), ovvero ritengono che la
riduzione della penale, per effetto di parziale adempimento dell'obbligazione, a norma dell'art. 1384 c.c., non
integra un diritto del debitore, ma è rimessa all'equa valutazione del giudice, in relazione all'interesse dei creditore
al tempestivo ed integrale adempimento (v. Cass. 7 luglio 1981, n. 4425).
6.6. Quanto al secondo elemento non può che condividersi la necessità di una lettura della norma di cui
all'art. 1384 c.c. che meglio rispecchi l'esigenza di tutela di un interesse oggettivo dell'ordinamento alla
luce dei principi costituzionali richiamati.
16
6.7. Naturalmente una lettura di questo tipo, consentita dal fatto che l'art. 1384 c.c. non contiene alcun
riferimento ad un'iniziativa della parte rivolta a sollecitare l'esercizio del potere di riduzione da parte del giudice,
non può prescindere dalla necessità di sottoporre a vaglio le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza che
ritiene necessaria quella iniziativa e di verificare nel contempo se sussistano altre ragioni, che consentano quella
lettura della norma adeguata ai principi costituzionali posti bene in luce dalla sentenza n. 10511/1999.
6.8. Gli argomenti addotti dalla giurisprudenza che nega il potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale sono
principalmente tre.
6.8.1. Il primo argomento si fonda sul principio generale, al quale l'art. 1384 c.c. non derogherebbe, secondo cui
il giudice non può pronunciare se non nei limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti.
Senonché questo argomento non appare decisivo e sembra fondarsi sull'assunto della esistenza di un fatto che è,
invece, da dimostrare.
Occorre partire dal testo dell'art. 112 c.p.c., secondo cui «Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non
oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle
parti».
Ora, il giudice che riduca l'ammontare della penale, al cui pagamento il creditore ha chiesto che il
debitore sia condannato, non viola in alcun modo la prima proposizione del richiamato art. 112 c.p.c.,
atteso che il limite postogli dalla norma è, in linea generale, che egli non può condannare il debitore ad
una somma superiore a quella richiesta, mentre può condannarlo al pagamento di una somma inferiore.
Ma l'art. 112 c.p.c. dispone anche che il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere
proposte soltanto dalle parti.
La norma lascia intendere che vi sono, oltre alle eccezioni proponibili soltanto dalle parti, anche eccezioni che
non lo sono e, in quanto tali, rilevabili d'ufficio.
Se così è, allora, il problema della riducibilità della penale non è risolto dall'art. 112 c.p.c., ma dalla
risposta al quesito se la riduzione della penale sia oggetto di una eccezione che può essere proposta
soltanto dalla parte.
Nel codice civile sono espressamente individuate varie ipotesi di eccezioni proponibili soltanto dalla parte; in via
esemplificativa: art. 1242, primo comma. c.c. - eccezione di compensazione; art. 1442, comma quarto, c.c. eccezione di annullabilità del contratto, quando è prescritta l'azione; art. 1449, secondo comma, c.c. - eccezione
di rescindibilità del contratto, quando l'azione è prescritta; art. 1460, primo comma, c.c. - eccezione di
inadempimento; art. 1495, terzo comma, c.c. - eccezione di garanzia, nella vendita, anche se è prescritta l'azione;
art. 1667, terzo comma, c.c. - eccezione di garanzia, nell'appalto - anche se l'azione è prescritta; art. 1944,
secondo comma, c.c. - eccezione di escussione da parte del fideiussore; art. 1947, primo comma, c.c. - beneficio
della divisione nella fideiussione; art. 2938 c.c. - eccezione di prescrizione; art. 2969 c.c. - eccezione di decadenza,
«salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause
d'improponibilità dell'azione».
17
L'art. 1384 c.c., al contrario delle ipotesi sopra indicate, non fa alcuna menzione della necessità della
eccezione della parte o, quantomeno, della necessità che il giudice debba essere sollecitato ad
esercitare il potere di riduzione della penale conferitogli dalla legge.
Il silenzio della norma sul punto non depone certamente a favore della tesi secondo cui la riduzione della penale
debba essere chiesta dalla parte, ma fa propendere, se mai, a favore della tesi contraria, specie se si guardi ad
altre previsioni del codice civile nelle quali l'intervento del giudice è visto in funzione correttiva della
volontà manifestata dalle parti (v. Cass. sez. un. 17 maggio 1996, n. 4570, che espressamente parla di
«funzione correttiva» del giudice, non solo nell'ipotesi della riduzione della penale manifestamente eccessiva (art.
1384 c.c.), ma anche nei casi di riduzione dell'indennità dovuta per la risoluzione della vendita con riserva di
proprietà (art. 1526 c.c.) e di riduzione della posta di giuoco eccessiva (art. 1934 c.c.).
6.8.2. Il secondo argomento addotto è che la riduzione della penale fissata dalle parti è prevista dalla legge come
istituto a tutela degli specifici interessi del debitore, al quale quindi deve essere rimessa, nell'esercizio della difesa
dei propri diritti, ogni iniziativa al riguardo ed ogni consequenziale valutazione della eccessività della penale
ovvero della sua sopravvenuta onerosità, in relazione alla parte di esecuzione che il contratto ha avuto.
Anche questo argomento si fonda su un dato non dimostrato e cioè che l'istituto della riduzione della penale sia
predisposto nell'interesse della parte debitrice.
Intanto una affermazione di questo tipo appare contraddetta dall'osservazione che la penale «può» ma non
«deve» essere ridotta dal giudice, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; dal
che si desume che non esiste un diritto del debitore alla riduzione della penale e che il criterio che il giudice deve
utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva ha natura oggettiva, atteso che non è previsto che il giudice
debba tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che sul suo patrimonio la
penale può avere, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, mentre il riferimento all'interesse
del creditore ha la sola funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia
manifestamente eccessiva o meno.
Ne discende che, pur sostanziandosi la riduzione della penale in un provvedimento che rende in concreto meno
onerosa la posizione del debitore e che deve essere adottato tenuto conto dell'interesse che il creditore aveva
all'adempimento, il potere di riduzione appare attribuito al giudice non per la tutela dell'interesse della parte
tenuta al pagamento della penale, ma, piuttosto, a tutela di un interesse che lo trascende.
Del resto il nostro ordinamento conosce altri casi in cui l'intervento equitativo del giudice pur risolvendosi in
favore di una delle parti in contesa non è tuttavia predisposto specificamente per la tutela di un suo interesse.
Si pensi all'ipotesi in cui una delle parti abbia chiesto il risarcimento del danno in forma specifica; il giudice, in
questo caso, anche se l'esecuzione specifica sia possibile, ha tuttavia il potere di disporre che il risarcimento
avvenga per equivalente «se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore»
(art. 2058 c.c.).
È un potere che il giudice può esercitare pacificamente d'ufficio avuta presente l'obiettiva difficoltà che
il debitore può incontrare nell'eseguire la prestazione risarcitoria; la difficoltà, appunto perché obiettiva,
non riguarda però la situazione economica del debitore, ma piuttosto l'esecuzione stessa della prestazione, ad
esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità. L'onerosità per il debitore viene
18
cioè in rilievo come metro di giudizio perché il giudice possa effettuare la sua valutazione e non come interesse
tutelato dalla norma.
Si pensi ancora al potere attribuito al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa se lo stesso non può
essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.), pacificamente esercitatile indipendentemente dalla
richiesta delle parti.
Già, quindi, dall'esame critico della giurisprudenza maggioritaria, emergono elementi per affermare che il potere
di riduzione della penale è concesso dalla legge al giudice per fini che prescindono dalla tutela
dell'interesse della parte, che al pagamento della penale sia tenuta per effetto del suo inadempimento o
ritardato adempimento.
6.8.3. Il terzo argomento addotto dalla giurisprudenza prevalente è che il giudice, nell'esercizio dei poteri
equitativi diretti alla determinazione dell'oggetto dell'obbligazione della clausola, non dispone di altri parametri di
giudizio che di quelli dati dai contrapposti interessi delle parti al fine esclusivo di verificare se l'equilibrio
raggiunto dalle parti stesse, nelle preventiva determinazione delle conseguenze dell'inadempimento, sia equo o sia
rimasto tale.
Ma anche questo argomento non appare decisivo ove si consideri che la mancata allegazione (o la impossibilità
di riscontri negli atti acquisiti) della eccessività della penale incide sul piano fattuale dell'accertamento
della sussistenza delle condizioni per la riduzione della penale medesima, ma non sull'esercizio
officioso del potere del giudice.
In proposito è sufficiente ricordare ciò che accade in tema di nullità del contratto, che il giudice può dichiarare
d'ufficio purché risultino dagli atti i presupposti della nullità medesima (Cass. n. 4062/1987), senza che per
l'accertamento della nullità occorrano indagini di fatto per le quali manchino gli elementi necessari (Cass. n.
1768/1986, 4955/1985, 985/1981), e più di recente Cass. n. 1552/2004, secondo cui «La rilevabilità d'ufficio
della nullità di un contratto prevista dall'art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia obbligato ad un
accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare "ex actis" ossia dal materiale probatorio
legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi dei giudice limitati al rilievo della nullità e non
intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa», nonché da ultimo Cass., sez. un., 4
novembre 2004, n. 21095.
6.8.4. Sembra, quindi, che nessuno dei tre argomenti prospettati dalla giurisprudenza maggioritaria sia decisivo
per la soluzione del quesito oggetto del contrasto, mentre, come in parte anticipato, vi sono argomenti che
appaiono sufficientemente probanti a sostegno della tesi fin qui minoritaria, i quali assumono una valenza
decisiva alla luce dei principi costituzionali posti in luce dalla sentenza n. 10511/1999.
6.9. Poiché nella discussione sull'esistenza del potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale è stato spesso
introdotto il tema dell'autonomia contrattuale è bene prendere le mosse proprio da tale punto.
L'art. 1322 c.c. - la cui rubrica è appunto intitolata all'autonomia contrattuale - attribuisce alle parti:
a) il potere di determinare il contenuto del contratto;
b) il potere di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare.
Nel primo caso l'autonomia delle parti deve svolgersi «nei limiti imposti dalla legge», nel secondo caso la libertà è
limitata per il fatto che il contratto deve essere diretto «a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
19
l'ordinamento giuridico».
La legge, quindi, nel riconoscere l'autonomia contrattuale delle parti, afferma che essa ha comunque
dei limiti.
L'osservanza del rispetto di tali limiti è demandato al giudice, che non può riconoscere il diritto fatto
valere, se esso si fonda su un contratto il cui contenuto non sia conforme alla legge ovvero sia diretto a
realizzare interessi che non appaiono meritevoli secondo l'ordinamento giuridico.
L'intervento del giudice in tali casi è indubbiamente esercizio di un potere officioso attribuito dalla legge.
Se nel nostro ordinamento non fosse stato previsto e disciplinato l'istituto della clausola penale e, tuttavia, le parti
avessero introdotto in un contratto una clausola con tale funzione, il giudice, chiamato a pronunciarsi in ordine
ad una domanda di condanna del debitore al pagamento della penale pattuita per effetto dell'inadempimento,
avrebbe dovuto formulare, d'ufficio, un giudizio sulla validità della clausola; giudizio che avrebbe potuto avere
esito negativo, ove fosse stato ravvisato un contrasto dell'accordo con principi fondamentali dell'ordinamento, ad
esempio per il fatto che la penale doveva essere pagata anche se il danno non sussisteva.
In questo caso vi sarebbe stato un controllo d'ufficio sulla tutelabilità dell'accordo delle parti e, ove il
controllo si fosse concluso negativamente, la tutela non sarebbe stata accordata.
Nel nostro diritto positivo questo controllo non è necessario perché l'istituto è riconosciuto e disciplinato dalla
legge (artt. 1382 e segg. c.c.).
Nel disciplinare l'istituto la legge ha ampliato il campo normalmente riservato all'autonomia delle parti,
prevedendo per esse la possibilità di predeterminare, in tutto o in parte, l'ammontare del risarcimento del danno
dovuto dal debitore inadempiente (se si vuole privilegiare l'aspetto risarcitorio della clausola), ovvero di esonerare
il creditore di fornire la prova del danno subito, di costituire un vincolo sollecitatorio a carico del debitore, di
porre a carico di quest'ultimo una sanzione per l'inadempimento (se se ne vuole privilegiare l'aspetto
sanzionatorio), e ciò in deroga alla disciplina positiva in materia, ad esempio, di onere della prova, di
determinazione del risarcimento del danno, della possibilità di istituire sanzioni private.
Tuttavia, la legge, nel momento in cui ha ampliato l'autonomia delle parti, in un campo normalmente
riservato alla disciplina positiva, ha riservato al giudice un potere di controllo sul modo in cui le parti
hanno fatto uso di questa autonomia.
Così operando, la legge ha in sostanza spostato l'intervento giudiziale, diretto al controllo della conformità
del manifestarsi dell'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa è consentita, dalla fase formativa
dell'accordo - che ha ritenuto comunque valido, quale che fosse l'ammontare della penale - alla sua fase
attuativa, mediante l'attribuzione al giudice del potere di controllare che la penale non fosse
originariamente manifestamente eccessiva e non lo fosse successivamente divenuta per effetto del
parziale adempimento.
Un potere di tal fatta appare concesso in funzione correttiva della volontà delle parti per ricondurre
l'accordo ad equità.
Vi sono casi in cui la correzione della volontà delle parti avviene automaticamente, per effetto di una
disposizione di legge che ne limita l'autonomia e che sostituisce alla volontà delle parti quella della legge (in tali
casi l'accordo delle parti, che non rispecchia il contenuto tipico previsto dalla legge, non viene dichiarato nullo
20
ma viene modificato mediante la sostituzione della parte non conforme); ve ne sono altri, in cui una inserzione
automatica della disciplina legislativa, in sostituzione di quella pattizia, non è possibile perché non può essere
determinata in anticipo la prestazione dovuta da una delle parti, che quindi non può essere automaticamente
inserita nel contratto; in tali casi la misura della prestazione è rimessa al giudice, per evitare che le parti utilizzino
uno strumento legale per ottenere uno scopo che l'ordinamento non consente ovvero non ritiene meritevole di
tutela, come è reso evidente, proprio in tema di clausola penale, dal fatto che il potere di riduzione è concesso al
giudice solo con riferimento ad una penale che non solo sia eccessiva, ma che lo sia «manifestamente», ovvero ad
una penale non più giustificabile nella sua originaria determinazione, per effetto del parziale adempimento
dell'obbligazione.
In tale senso inteso, il potere di controllo appare attribuito al giudice non nell'interesse della parte ma
nell'interesse dell'ordinamento, per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali
la tutela delle posizioni soggettive delle parti appare meritevole di tutela, anche se ciò non toglie che
l'interesse della parte venga alla fine tutelato, ma solo come aspetto riflesso della funzione primaria cui
assolve la norma.
Può essere affermato allora che il potere concesso al giudice di ridurre la penale si pone come un limite
all'autonomia delle parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale, limite non prefissato ma
individuato dal giudice di volta in volta, e ricorrendo le condizioni previste dalla norma, con riferimento
al principio di equità.
Se così non fosse, apparirebbe quanto meno singolare ritenere, sicuramente con riferimento all'ipotesi di penale
manifestamente eccessiva, in presenza di una clausola valida (si ricordi che è valida la clausola ancorché
manifestamente eccessiva), che l'esercizio del potere del giudice di riduzione della penale debba essere
condizionato alla richiesta della parte, quasi che, a questa, fosse riconosciuto uno jus poenitendi, e, quindi la
facoltà di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione liberamente assunta (quella appunto del pagamento di una
penale che fin dall'origine si manifestava come eccessiva).
Se si considera che il potere di riduzione della penale può essere esercitato solo in presenza di una clausola che
sia valida (e quindi esente da vizi che ne determino la nullità o l'annullabilità) più coerente appare allora
qualificare detto potere come officioso nel senso sopra specificato, di riconduzione dell'accordo, frutto della
volontà liberamente manifestata dalle parti, nei limiti in cui esso appare meritevole di ricevere tutela
dall'ordinamento.
Non è privo di significato il fatto che la giurisprudenza, pur affermando la tesi della necessità della domanda o
eccezione della parte al fine di sollecitare il potere di riduzione affidato al giudice, non ha potuto tuttavia non
riconoscere (come del resto la quasi unanime dottrina) la natura inderogabile della disposizione di cui all'art. 1384
c.c., attributiva al giudice del potere di ridurre la penale, riconoscendo che essa è posta principalmente a
salvaguardia dell'interesse generale, per impedire sconfinamenti oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale
(v. in tal senso Cass. 4 febbraio 1960, n. 163 e successivamente, in modo conforme circa la natura inderogabile
della norma, Cass., sez. un., 5 dicembre 1977, n. 5261; Cass. 7 agosto 1992, n. 9366; Cass. 29 marzo 1996, n.
2909; Cass. 5 novembre 2002, n. 15497 - queste ultime tre in motivazione), in tale modo riconoscendo l'esistenza
dei presupposti per un intervento officioso dei giudice, non tanto per la tutela di interessi individuali, ma
21
piuttosto per una funzione correttiva di riequilibrio contrattuale (se si vuole privilegiare la tesi della natura
risarcitoria della penale) ovvero di adeguatezza della sanzione (se si vuole privilegiare la tesi della funzione
sanzionatoria).
Aspetto quest'ultimo particolarmente sottolineato da Cass. 24 aprile 1980, n. 2749, secondo cui il potere
conferito al giudice dall'art. 1384 c.c. di ridurre la penale manifestamente eccessiva è fondato sulla necessità di
correggere il potere di autonomia privata riducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante
l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti,
valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva incidenza di esso
sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale.
Pare, quindi, a queste sezioni unite, che la lettura della norma interessata, svolta nel quadro dei principi generali
dell'ordinamento e dei principi costituzionali posti in luce dalla sentenza n. 10511/1999, consenta di giungere alla
conclusione che il potere del giudice di ridurre la penale possa essere esercitato d'ufficio, e ciò sia con
riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione
avvenga perché l'obbligazione principale e stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la
mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di
parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola
parte rimasta inadempiuta.
7. È questa lettura della norma che porta ad affermare il principio che «il potere di diminuire equamente la
penale, attribuito dall'art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d'ufficio».
3. LE NUOVE FRONTIERE DEL PRINCIPIO CAUSALE:
3.1 Corte di Cassazione, sentenza dell’8 maggio 2006, n, 10490;
La definizione di causa fornita dal codice civile è quella di funzione economico-sociale del negozio riconosciuta
rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata. Tuttavia si discorre da tempo di una
fattispecie causale "concreta quale sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del
modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale e non anche della
volontà delle parti. “Causa, dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta,
funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto,
seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla
cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso
compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale”.
Pertanto, sarebbe nullo il contratto ( ancorchè tipico) nel caso si verifichi la mancanza di causa in concreto (…nel
caso che ci occupa, sia proprio il difetto di causa a viziare irrimediabilmente di nullità il contratto di consulenza,
intesa per causa lo scambio di quella ben identificata attività consulenziale, già simmetricamente e specularmene
svolta in adempimento dei propri doveri di amministratore, con il compenso preteso dal N.)
22
(omissis)
Con il quinto motivo viene contestato il vizio di violazione ed errata applicazione dell'art. 1418 c.c.. per essere
stata predicata la fattispecie della nullità "sopravvenuta" - in alternativa, la violazione e falsa applicazione dell'art.
112 c.p.c., ed omessa motivazione in relazione alla preesistenza delle cariche amministrative in capo al ricorrente.
Osserva, in particolare, il ricorrente che, a suo avviso, l'espressione adottata dal giudice milanese ("mancanza di
giustificazione concreta del contratto") andava piuttosto intesa nel senso che, a mancare (ovvero a risultare
impossibile), fosse in realtà l'oggetto del contratto.
Il motivo è destituito di giuridico fondamento.
Tanto il primo quanto il secondo giudice hanno, difatti, rettamente predicato la nullità della doppia vicenda
negoziale collegata sotto il profilo dei difetto causale (così il tribunale milanese), ovvero della mancanza di
giustificazione concreta del contratto consequenziale alla luce della sostanziale identità delle
prestazioni svolte dal N. una volta nella qualità di amministratore della società, l'altra in quella di
consulente esterno ad essa (così la Corte d'appello).
L'affermazione, corretta in punto di diritto, necessita, peraltro, di alcune puntualizzazioni, avendo la parte
ricorrente invocato, nella specie, una diversa eziogenesi della nullità negoziale - conseguente, a suo dire, ad una
pretesa "impossibilità dell'oggetto" -, atteso che, a suo dire, il tradizionale concetto di causa intesa come "schema
economico-giuridico" posto in essere dalle parti non consentiva di affermare che il negozio stipulato tra le parti
ne fosse privo, corrispondendo esso allo schema tipico delineato dall'art. 2222 c.c..
Va preliminarmente escluso che la nullità della convenzione negoziale in parola derivi dalla pretesa impossibilità
dell'oggetto del contratto, così come opinato dal ricorrente.
E' noto come la dottrina manualistica sia solita distinguere, quanto all'oggetto della prestazione dedotta in
obbligazione, tra impossibilità fisica e giuridica, definendo fisica la impossibilità derivante da
prestazione impossibilis in rerum natura (quale la traditio di una cosa distrutta), giuridica quella che, pur
non consistendo di per sè in un illecito (ciò che distingue la prestazione ad oggetto impossibile da quella ad
oggetto illecito, come la vendita di banconote contraffatte), è purtuttavia inattuabile in conseguenza di un
divieto normativo (quale quello di edificazione violando le distanze legali).
E' palese come, nel caso di specie, non ricorra nessuna delle così descritte fattispecie di impossibilità, trattandosi
di prestazione (attività di consulenza) possibile tanto nella sua fisicità che sotto il profilo della conformità a
norme di diritto, di talchè l'assunto difensivo risulta, in parte qua, infondato.
Merita ulteriore considerazione, invece, la questione, del pari sollevata dal ricorrente, della causa del negozio
giuridico stipulato tra le parti.
E' innegabile che, intesa nel comune significato di "funzione economico sociale" del contratto - secondo un
approccio ermeneutico, peraltro, di tipo "astratto" -, il negozio oggetto della presente controversia non possa
legittimamente dirsi "privo di causa", corrispondendo esso, addirittura, ad uno schema legale tipico, quello
disegnato dall'art. 2222 c.c..
23
Ma, a giudizio di questo collegio, la nozione di causa così delineata non corrisponde, nella specie (così come in
via di principio generale) a quella che, dopo attenta riflessione della più recente dottrina, deve ritenersi concetto
correttamente predicabile con riferimento al profilo oggettivo della struttura contrattuale.
E' opinione corrente quella secondo cui la prima elaborazione del concetto di causa (sostanzialmente estranea
all'esperienza romana come elemento costitutivo del negozio, che doveva corrispondere essenzialmente a
"modelli" formali) sia stata il frutto della riflessione dei giuristi d'oltralpe che, tra il 1625 ed il 1699, distinguendo
per la prima volta sul piano dogmatico i contratti commutativi dalle donazioni, individueranno nell'obbligazione
di una parte verso l'altra il fondamento della teoria causale (e di qui, l'origine storica della perdurante difficoltà a
superare la dicotomia contratto di scambio-liberalità donativa). Gli stessi rapporti tra la causa e gli altri elementi
del contratto, apparentemente indiscussi nei relativi connotati di alterità, paiono, nel progressivo dipanarsi del
concetto di causa negotii, talvolta sfumare in zone di confine più opache (si pensi alla relazione causa/volontà nei
negozi di liberalità; a quella causa/forma ed all'avvicinamento delle due categorie concettuali verificabile nei
negozi astratti; a quella causa/oggetto, con le possibili confusioni a seconda della nozione che, di entrambe le
categorie giuridiche, ci si risolva di volta in volta ad adottare, oggetto del contratto essendo tanto la
rappresentazione ideale di una res dedotta in obbligazione, quanto la res stessa, causa risultando la funzione dello
scambio in relazione proprio a quell'oggetto).
Tutte le possibili definizioni di causa succedutesi nel tempo (che un celebre civilista degli anni '40 non esita a
definire "oggetto molto vago e misterioso") hanno visto la dottrina italiana in permanente disaccordo (mentre
negli altri paesi il dibattito è da tempo sopito), discorrendosi, di volta in volta, di scopo della parte o motivo
ultimo (la c.d. teoria soggettiva, ormai adottata dalla moderna dottrina francese, che parla di causa come But); di
teoria della controprestazione o teoria oggettiva classica (che sovrappone, del tutto incondivisibilmente, il
concetto di causa del contratto con quello di causa/fonte dell'obbligazione); di funzione giuridica ovvero di
funzione tipica (rispettivamente intese in guisa di sintesi degli effetti giuridici essenziali del contratto, ovvero di
identificazione del tipo negoziale - che consente ad alcuni autori di predicare la sostanziale validità del negozio
simulato sostenendone la presenza di una causa, intesa come "tipo" negoziale astratto, sia pur fittizio, quale una
donazione, una compravendita, ecc. -); di funzione economico-sociale, infine, cara alla c.d. teoria oggettiva,
formalmente accolta dal codice del 42, del tutto svincolata dagli scopi delle parti all'esito di un processo di
astrazione da essi (per tacere delle teorie anticausalistiche, di derivazione tedesca, con identificazione della causa
nell'oggetto o nel contenuto - Inhalt - del contratto, non indicando il codice tedesco la causa tra gli elementi
costitutivi del contratto).
La definizione del codice è, in definitiva, quella di funzione economico-sociale del negozio riconosciuta rilevante
dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata (così, testualmente, la relazione del ministro
guardasigilli); ma è noto che, da parte della più attenta dottrina, e di una assai sporadica e minoritaria
giurisprudenza (Cass. Sez. 1^, 7 maggio 1998, n. 4612, in tema di Sale & lease back) Sez. 1^, 6 agosto 1997, n.
7266, in tema di patto di non concorrenza; Sez. 2^, 15 maggio 1996, n. 4503, in tema di rendita vitalizia), si
discorre da tempo di una fattispecie causale "concreta", e si elabori una ermeneutica del concetto di
causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del
contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata
24
critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d'altro, non spiega come un
contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi
reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e
dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti.
Causa, dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta,
funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo
stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio
che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso
che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a
suo modo unica) convenzione negoziale.
Così rottamente intesa la nozione di causa del negozio, appare allora evidente come, nel caso che ci occupa, sia
proprio il difetto di causa a viziare irrimediabilmente di nullità il contratto di consulenza, intesa per causa lo
scambio di quella ben identificata attività consulenziale, già simmetricamente e specularmene svolta in
adempimento dei propri doveri di amministratore, con il compenso preteso dal N..
3.2 Corte di Cassazione, sentenza del 24 luglio 2007, n. 16315;
Nell’impossibilità di utilizzazione della prestazione, essa è in astratto ancora eseguibile ma viene meno la possibilità
che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto. Essa implica il venir meno
dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore .
L'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir
dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che dell'obbligazione costituisce la fonte per irrealizzabilità della
relativa causa concreta.
L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente
prevista, costituisce - analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione - (autonoma) causa di estinzione
dell'obbligazione.
Nella vicenda che ne occupa, secondo quanto accertato dai Giudici di merito l'epidemia di dengue emorragico in atto
nell'isola di Cuba ha invero indubbiamente determinato nell'acquirente del "pacchetto turistico" tutto compreso de
quo il venir meno dell'interesse pratico che la relativa complessa prestazione era, nella sua unitaria considerazione,
nel caso funzionalmente volta a soddisfare.
Tale impossibilità dell’esecuzione della prestazione complessa del contratto di viaggio “tutto compreso” è da valutarsi
avuto riguardo allo "scopo turistico" che il medesimo è funzionalizzato a soddisfare che "si sostanziava non nella
semplice messa a disposizione di un pacchetto turistico ma nella necessità di assicurare che quella vacanza sarebbe
stata poi fruita in condizioni di ordinaria tranquillità, secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio".
25
Con il 1^ motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.,
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole essere stata nel caso erroneamente ritenuta integrata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della
prestazione, tale viceversa non essendo la "prestazione dedotta in contratto" (nella specie il viaggio ed il
soggiorno nella destinazione pattuita), in difetto di "prova alcuna dell'esistenza di provvedimenti di interdizione o
di restrizione ai flussi turistici per la destinazione prescelta, ovvero dell'oggettiva impossibilità di raggiungere e
soggiornare nella città di Santiago de Cuba".
Lamenta che si sono a tale stregua privilegiate piuttosto le "finalità ulteriori" in base alle quali l'acquirente del
"pacchetto turistico" si è nel caso indotto ad esercitare il "recesso" dal contratto, indebitamente assegnandosi
rilievo a mere "soggettive valutazioni circa l'opportunità e la convenienza di effettuare il viaggio (non volendo
egli esporsi neppure a rischi modesti)", anzichè all'"effettiva impossibilità di fruire dei servizi offerti
dall'organizzazione in conformità del contratto".
Si duole che non si sia tenuto conto come già "dalla comunicazione in data 17.7.1997 dell'Ambasciata di Cuba a
Roma (doc. 2 del fascicolo di primo grado)", e quindi in epoca precedente all'esercizio del recesso", la situazione
sanitaria risultava essere "totalmente sotto controllo, e ricondotta in condizioni di normalità", essendosi altresì
trascurato di considerare che "il dengue emorragico è malattia endemica nell'isola di Cuba, mai debellata. Non a
caso il Ministero degli Esteri italiano non ha mai diramato alcuna comunicazione intesa a vietare, o anche solo a
sconsigliare, i viaggi verso Cuba e verso la città di Santiago de Cuba".
(omissis)
Va quindi sotto altro profilo sottolineato come risulti dai Giudici di merito accertato, e del resto emergente anche
dagli odierni scritti difensivi delle parti (v. pag. 2 del ricorso della Y. s.a.s., in atti), che nel caso l'agenzia di viaggi
X. ha "prenotato" per conto del cliente V. un "pacchetto turistico comprensivo di volo e soggiorno per due
persone a Santiago De Cuba nel periodo 6-19 agosto 1997".
Negozio che il giudice dell'appello ha ricondotto al contratto di "viaggio tutto compreso", caratterizzato da
una "complessiva prestazione cui era tenuta la X. ... che si sostanziava non nella semplice messa a disposizione di
un pacchetto turistico ma nella necessità di assicurare che quella vacanza sarebbe stata poi fruita in condizioni di
ordinaria tranquillità, secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio".
A tale stregua, attesa l'accertata sussistenza di una epidemia di dengue emorragico nell'isola di Cuba, nel
confermare "in diritto" la "decisione del Giudice di Pace, che aveva "ritenuto (art. 1463 c.c.) essere divenuta
impossibile la complessiva prestazione cui era tenuta la X.", traendone "la duplice conseguenza" che la medesima
"doveva essere ritenuta liberata da quella prestazione e ..., al tempo stesso, non poteva pretendere alcuna
controprestazione dalla Aternum", il Giudice dell'appello ha considerato come invero "più proprio" il
"riferimento all'art. 1464 c.c. (in luogo dell'art. 1463 c.c.)", atteso che la prestazione della X. era divenuta solo
parzialmente impossibile, nel senso che quella poteva, sì, assicurare lo svolgimento del soggiorno, ma non anche
adeguati standard di sicurezza sanitaria: in questo caso, quindi, l'altro contraente aveva facoltà di scegliere tra la
riduzione del prezzo ed il recesso dal contratto (così come è poi in concreto accaduto), se non avesse avuto
interesse a quella prestazione monca".
26
Ha al riguardo sottolineato il tribunale che "il V. si recava a Cuba per un viaggio di piacere", sicchè l'accertata
sussistenza di un "focolaio endemico non ... ancora completamente debellato" non consentiva invero al predetto
di poter compiutamente godere della prestazione dovutagli, residuando "il pericolo di contrarre la malattia,
specialmente in considerazione del fatto che essa, propagandosi con la puntura d'insetti, da un canto non
consente alcuna efficace e tranquillizzante forma di difesa e, dall'altro, può in breve tempo propagarsi anche in
zone che erano rimaste fino a quel momento immuni".
A tale stregua, il Giudice dell'appello ha ritenuto in effetti giustificata la "scelta" del medesimo di "non volersi
esporre neppure ad un rischio di modesta entità".
Orbene, va anzitutto posto in rilievo come risulti corretta la qualificazione operata dal giudice dell'appello
della vicenda posta nella specie in essere dalle parti in termini di contratto viaggio vacanza "tutto
compreso" (cd. "pacchetto turistico" o package) previsto dal D.Lgs. n. 111 del 1995, ed ora trasfuso nel
D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 82 e segg. (cd. Codice del Consumo).
Ipotesi che va invero distinta dal contratto di organizzazione (art. 5 e segg.) o di intermediazione (art. 17 e segg.)
di viaggio (CCV) di cui alla Conv. Bruxelles del 23/4/1970 (resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084), in
base al quale un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di
base (trasporto, albergo, ecc.) per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno.
Rispetto a quest'ultimo, in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati, e vengono in rilievo diversi
tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione (cfr. Cass., 17/7/2001, n. 9691;
Cass., 6/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (v. Cass., 6/11/1996, n.
9643; Cass., 26/6/1964, n. 1706) ovvero - in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo
di trasporto dei clienti - del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi (v. Cass., 23/4/1997, n. 3504;
Cass., 6/1/1982, n. 7; Cass., 28/5/1977, n. 2202), ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai
(differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o di package) si caratterizza sia
sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità.
Il "pacchetto turistico", che può essere dall'organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore (D.Lgs. n.
111 del 1995, art. 3,comma 2, ora trasfuso nel D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 83, comma 2, - Codice del consumo -),
risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da
servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.)
costituenti parte significativa del "pacchetto turistico", con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per
un periodo di tempo comportante almeno una notte (D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 2 e segg., ora trasfuso nell'art.
84 del Codice del Consumo).
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la
finalità che la stessa è volta a realizzare.
Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già
singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al
riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della "finalità turistica" che la
prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a
soddisfare.
27
I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal
cd. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in
condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - di relax, svago, ricreativi,
ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere"
assicurato dalla vacanza, che il turista- consumatore in particolare persegue nell'indursi alla
stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso".
Diversamente da quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, la suddetta "finalità turistica" (o "scopo di
piacere") non costituisce pertanto un irrilevante motivo del contratto de quo.
La "finalità turistica" non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna
dell'acquirente il package costituendo l'impulso psichico che lo spingono alla stipulazione del
contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che
lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta (cfr. Cass.,
25/5/2007, n. 12235; Cass., 8/5/2006, n. 10490).
Causa concreta che, da un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l'essenzialità di tutte le
attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere
psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a
realizzare. Da altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto.
La causa concreta viene a rivestire, come non si è mancato di osservare in dottrina, decisiva rilevanza altresì
in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono
sullo svolgimento del rapporto, quali ad es. l'impossibilità o l'aggravio della prestazione,
l'inadempimento, ecc..
Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto
meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - essi
depongano per l'impossibilità della relativa realizzazione.
In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto
obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.).
E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse
creditorio
comporta
la
irrealizzabilità
della
causa
concreta
del
medesimo,
assumendo
conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.
Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo
sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della
prestazione.
Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente
sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta.
Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o di package) la sopravvenuta
impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o
rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori
28
per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po' dal coniuge o
dalla ci cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi.
Come è stato posto in rilievo in dottrina, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione costituisce
figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile.
La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed
oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496;
Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass., 8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018;
Cass., 29/10/1962, n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione
del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e art. 1256 c.c., comma 1 (v. Cass., 28/1/1995,
n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir
meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della
controparte (cd. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del
contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass.,
14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894).
L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente
nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà luogo ad una corrispondente
riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al
mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta
del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140).
Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a
sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di
per sè l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore.
Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno
della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel
caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse
creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala
l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al
venditore di effettuare la consegna prevista).
Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si
estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della
prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir dell'interesse creditorio, e di
conseguenza il contratto che dell'obbligazione costituisce la fonte per irrealizzabilità della relativa
causa concreta.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta
impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt.
1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037).
Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con
quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione
29
della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce
- analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione - (autonoma) causa di estinzione
dell'obbligazione.
Nella vicenda che ne occupa, secondo quanto accertato dai Giudici di merito l'epidemia di dengue emorragico in
atto nell'isola di Cuba ha invero indubbiamente determinato nell'acquirente del "pacchetto turistico" tutto
compreso de quo il venir meno dell'interesse pratico che la relativa complessa prestazione era, nella sua unitaria
considerazione, nel caso funzionalmente volta a soddisfare.
Premesso che (anche) l'impossibilità della esecuzione della prestazione complessa del contratto di viaggio
vacanza "tutto compreso" o package è da valutarsi avuto riguardo allo "scopo turistico" che il medesimo è
funzionalizzato a soddisfare, va sottolineato come nell'impugnata sentenza risulti in effetti posto in rilievo che il
contratto de quo "si sostanziava non nella semplice messa a disposizione di un pacchetto turistico ma nella
necessità di assicurare che quella vacanza sarebbe stata poi fruita in condizioni di ordinaria tranquillità, secondo i
canoni di valutazione propri di un turista medio".
Il Giudice dell'appello, nell'escludere la ricorrenza nel caso dell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di
esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c., viceversa ravvisata dal Giudice di prime cure, ha ritenuto
nella specie configurabile un'ipotesi di impossibilità parziale ex art. 1464 c.c., della prestazione, in presenza di
prestazione ravvisata effettuabile pur se "monca", stante l'accertata mancanza degli "adeguati standard di
sicurezza sanitaria".
Orbene, anche la parziale impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art. 1464 c.c., appare invero nel
caso non correttamente evocata.
L'epidemia di dengue emorragico costituisce infatti evento determinante non già il deterioramento o la riduzione
della prestazione (v. Cass., 17/7/1987, n. 6299) bensì il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria
del luogo di esecuzione della prestazione turistica.
Nella situazione nel caso determinatasi, certamente non deponente per la normalità delle condizioni igienicosanitarie dell'Isola di Cuba, l'esecuzione della prestazione turistica è venuta a risultare infatti comunque inidonea
al soddisfacimento dell'interesse del V. al godimento della vacanza "tutto compreso" nei suoi molteplici aspetti di
relax, svago, culturali, ecc., pienamente godibili solamente in presenza delle imprescindibili condizioni di
sicurezza sanitaria, secondo i normali standard del luogo di destinazione prescelto, come dai Giudici del merito
correttamente posto in rilievo nel sottolineare che l'accertata sussistenza di "focolaio endemico non ... ancora
completamente debellato" non rispondeva alla "necessità di assicurare che quella vacanza sarebbe stata poi fruita
in condizioni di ordinaria tranquillità, secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio".
Tale mancanza ha nella specie inciso, in termini di relativo venir meno, sull'interesse creditorio del suindicato
acquirente del "pacchetto turistico", con conseguente sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del
contratto de quo dal medesimo stipulato.
Alla stregua di quanto sopra esposto va allora affermato che è piuttosto la sopravvenuta impossibilità (non
ascrivibile alle parti) di utilizzazione della prestazione in argomento da parte del V. a venire nel caso
propriamente in rilievo.
30
Nell'adeguatamente valorizzare l'interesse creditorio e la causa concreta del contratto di package anche sotto il
profilo della sorte del rapporto obbligatorio e della vicenda contrattuale, tale figura non privilegia invero la
"impossibilità del raggiungimento delle soggettive finalità ulteriori del creditore", e pertanto i motivi, attribuendo
decisivo rilievo al suo "sopravvenuto sgradimento" per "la destinazione prescelta per il viaggio", ma consente di
valorizzare gli specifici ed essenziali interessi perseguiti mediante la stipulazione di tale tipo di contratto, che ne
integrano la causa concreta.
Inconfigurabili soluzioni estreme come quella prevista all'art. 1463 c.c., la figura della sopravvenuta impossibilità
di utilizzazione della prestazione si rivela istituto dotato di flessibilità, là dove consente di pervenire, nel coerente
contemperamento delle diverse esigenze, a soluzioni differenti in presenza di situazioni diverse, senza che le parti
incorrano in responsabilità.
Lo "scopo turistico" consente infatti di spiegare come la relativa persistenza giustifichi l'esecuzione del
contratto in favore del turista che intenda usufruirne, anche a costo di correre il rischio di contrarre il
morbo, senza esporre il tour operator alle conseguenze dell'inadempimento in cui incorrerebbe laddove
intendesse non darvi più attuazione. E al contempo permette al turista che come nella specie quel
rischio non voglia viceversa correre di non avvalersi della prestazione senza essere comunque tenuto
alla corresponsione del corrispettivo.
Emerge con tutta evidenza a tale stregua come, quand'anche obiettivamente eseguibili il trasporto ed il soggiorno
nella loro autonoma e separata considerazione, la complessa prestazione del contratto di viaggio vacanza "tutto
compreso" in questione risulta nel caso divenuta per il V. inutilizzabile, stante la non disponibilità del medesimo
ad usufruirne anche a rischio della contrazione del morbo. Rischio che, diversamente da quanto sembra invero in
qualche modo adombrare l'odierno ricorrente laddove si duole che "il recesso del viaggiatore era stato dettato
esclusivamente da sue soggettive valutazioni circa l'opportunità e la convenienza di effettuare il viaggio (non
volendo egli esporsi neppure a rischi modesti...."), certamente al medesimo non può invero, quand'anche - in
ipotesi - minimo, "imporsi" di correre.
Essendo la prestazione de qua divenuta inidonea a soddisfare l'interesse creditorio, l'estinzione dello stipulato
contratto in argomento per irrealizzabilità della causa concreta comporta, va infine sottolineato, l'esonero delle
parti dalle rispettive obbligazioni.
Il debitore non è pertanto più tenuto ad eseguirla, ed il creditore non ha l'onere di accettarla.
Non vi è pertanto luogo nel caso alla corresponsione dell'indennità per il recesso di cui alla evocata disciplina in
tema di contratto di viaggio (C.C.V.).
Va, d'altro canto, posto al riguardo in rilievo che il principio di buona fede oggettiva o correttezza (quale
generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi
contrattuali, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale,
specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonchè volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti
dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti
anche solo colposamente ingenerati nei terzi) impone invero al creditore di avvisare il debitore dell'inutilità
della prestazione, essendo in difetto tenuto al risarcimento dei danni (cfr. Cass., 27/10/2006, n. 23273;
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
31
Una siffatta domanda, anche riguardandosi alla stregua del suindicato profilo la lamentata tardività della
"disdetta", non risulta peraltro dall'odierna ricorrente formulata.
(omissis)
3.3 Corte di Cassazione, sentenza del 20 dicembre 2007, n. 26958
L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non
disciplinata in modo espresso, costituisce - analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione autonoma causa di estinzione dell'obbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare
l'interesse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per
sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta l'esonero delle parti dalle rispettive
obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha l'onere di accettarla.
(omissis)
La prima e preliminare questione di diritto sottoposta all'esame di questo collegio è, dunque, quella
dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione con riferimento al soggetto legittimato a rilevarla ed
invocarla. Va in premessa ricordato come comunemente vengano individuati, in dottrina, tre diverse ipotesi di
impossibilità, la prima consistente nel perimento della cosa (al quale è parificato il suo smarrimento), la seconda
integrante il caso della sua incommerciabilità, la terza. (che postula, come noto, più complesse valutazioni
fattuali) predicabile nei casi di obbligazioni di fare, con particolare riguardo a fattispecie di impedimenti di
carattere personale: in tali ipotesi, al fine della liberazione del debitore, viene comunemente sottolineato il
necessario carattere di assolutezza e di obiettività della impossibilità stessa, concetto che, come sovente
evidenziato ancora in dottrina, pare certamente applicabile (salvo poi valutare le cause della stessa impossibilità)
ai casi di perdita delle facoltà fisiche necessarie per l'adempimento. A tali requisiti, si suole poi aggiungere,
alternativamente, quelli dell'infungibilità della prestazione divenuta impossibile e della riconducibilità del concetto
di impossibilità alla prestazione e non alla persona del debitore. Un primo dato appare dunque certo, quello, cioè,
per il quale ha carattere sicuramente liberatorio l'impossibilità fisica materiale, e per questo assoluta, del debitore.
L'analisi si sposta, così, sul piano degli effetti dell'impossibilità sopravvenuta: mentre la non imputabilità ad
alcuna delle due parti è senz' altro idonea ad attivare il meccanismo previsto dalla norma ex art. 1463 c.c., e
mentre, pacificamente, di questa disposizione viene esclusa la applicabilità in caso di impossibilità imputabile al
debitore, fortemente controversa risulta la conseguenza della impossibilità imputabile al creditore: la dottrina è, in
proposito, divisa tra chi ritiene che i relativi effetti sarebbero del pari disciplinati dalla norma in parola, e chi, al
contrario, ne opina la riconducibilità all'art. 1453, in quanto prodotti dall'inadempimento del creditore agli
obblighi di cooperazione con il debitore nell'adempimento della prestazione di quest'ultimo.
Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, anche in dottrina, oltre che nella risalente giurisprudenza di
questa corte di cui a Cass. 23.8.1949 n. 2394 (pubblicata in una nota rivista giuridica l'anno successivo a quello
del suo deposito), si ritiene configurabile l'ipotesi di impossibilità tanto unilaterale (ossia legata ad una sola delle
32
contrapposte obbligazioni), quanto di entrambe le prestazioni dedotte in contratto. Non erra il ricorrente nel
sottolineare che il modus operandi del rimedio risolutorio non sia lo stesso per tutte le fattispecie previste dal
codice, considerando che, nel caso di risoluzione per inadempimento, l'azione è rimessa alla facoltà dell'altro
contraente (il non inadempiente), mentre, nel caso di impossibilità sopravvenuta, l'effetto risolutorio opera in
modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile: ma è
altrettanto innegabile che (il dato è testuale nella norma di cui all'art. 1463 c.c.), nel caso in cui sia riscontrata
l'impossibilità assoluta di effettuare la propria prestazione, la parte liberata non può chiedere la
controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla
ripetizione dell'indebito. Ciò comporta, quale definitivo approdo dell'esegesi del testo normativo, che la
risoluzione de qua possa legittimamente essere invocata da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione
rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile (in tali sensi, in passato, Cass.
18.9.1956 n. 3222): non avrebbe altrimenti senso prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla
premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione (prestazione della quale, dunque, non avrebbe
più senso discutere in termini di possibilità/impossibilità) può del tutto legittimamente richiedere alla controparte
la restituzione a seguito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa. Non è pertanto
meritevole di accoglimento la doglianza contenuta nel motivo di ricorso in esame nella parte in cui vorrebbe
allocare presso il solo obbligato alla prestazione impossibile l'interesse ad agire in giudizio (inconferente, dunque,
è il richiamo all'art. 100 c.p.c.) per la propria liberazione: lo stesso interesse conserva, specularmente, la parte che,
eseguita la propria prestazione - ipso facto possibile proprio perchè (come nella specie)... già eseguita - ne
richieda poi la restituzione a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione di controparte. Nella
specie, la prestazione del cliente (pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo del soggiorno in
albergo), possibile e già eseguita, non va incontro ad alcuna mutazione, nè genetica nè funzionale, a seguito della
morte sopravvenuta alla stipula del contratto (nonchè all'adempimento della propria obbligazione): la morte,
difatti (come correttamente rileva, in proposito, il ricorrente), non è causa di impossibilità della prestazione del
defunto (che l'ha già eseguita), bensì ragione di non fruibilità, da parte sua, della controprestazione offerta
dall'albergatore. L'analisi si sposta, allora, sugli aspetti contenutistici di quest'ultima obbligazione. Sostiene, difatti,
il ricorrente, a fronte della (invero non esaustiva) ricostruzione operata in diritto dal Giudice di merito - il quale
discorre di impossibilità della prestazione dell'albergatore senza ulteriori specificazioni al riguardo - che tale
prestazione non sarebbe mai stata nè mai sarebbe divenuta tecnicamente "impossibile" a causa della morte del
cliente, pena una inammissibile confusione concettuale tra prestazione, da un canto, e fruizione (da parte del
creditore) della prestazione, che, nella specie, consisterebbe (trovandovi al tempo stesso il suo insuperabile limite
contenutistico - esecutivo) nel "mettere a disposizione la struttura alberghiera secondo quanto contrattualmente
concordato".
L'argomentazione non può essere condivisa.
E' innegabile che, così articolata in parte qua la tesi difensiva, il discorso sia destinato ad orbitare,
preliminarmente, sul piano del sinallagma contrattuale, id est della causa negoziale intesa nel suo aspetto
funzionale. Questa corte ha già avuto recentemente modo di affermare il principio secondo cui un concetto
"di funzione astratta" di causa non può più ritenersi soddisfacente criterio di ermeneutica contrattuale,
33
dovendosene più correttamente procedere, di converso, ad una ricostruzione in termini di "causa
concreta". (Cass. n. 10490 del 2006, che adotta tale criterio ricostruttivo dell'elemento causale del negozio con
riferimento, peraltro, ad una vicenda nella quale il difetto di causa, emergeva sul piano non funzionale ma
genetico, integrando conseguentemente una ipotesi di nullità contrattuale). Il concetto di causa concreta non può,
peraltro, non attenere altresì all'aspetto funzionale del predetto essentiale negotii. Alla stregua del concetto di
"causa negoziale concreta" va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della
prestazione (id est, della sua esecuzione, tale da costituire un impedimento assoluto ed oggettivo a carattere
definitivo) integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto
che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c., e art. 1256 c.c., comma 1, in ragione del venir meno
della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della
controparte (Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 548; Cass.,
14/10/1970, n. 2018), ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della
prestazione da parte del creditore. Tale principio di diritto risulta di recente affermato da questa stessa corte
con la sentenza n. 16315 del 2007 (la fattispecie concreta di cui quel collegio ha avuto modo di occuparsi
riguardava una vicenda relativa ad un soggiorno turistico all'estero dove una epidemia di dengue emorragica
aveva indotto il contraente ad invocare la risoluzione del contratto di package). Nella motivazione della sentenza
(che afferma principi di diritto dai quali questo giudice non ha motivi per discostarsi) si rileva, in limine, come,
nella specie, non fosse in realtà predicabile l'esistenza di un vero impedimento preclusivo dell'esecuzione
dell'obbligazione, precisandosi, peraltro, che il soggiorno o il servizio alberghiero "assumono, al riguardo, rilievo
non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo
prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità turistica che la prestazione complessa in
cui si sostanziano quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare. Tale finalità non costituisce,
pertanto, un irrilevante motivo del contratto de quo, e non si sostanzia in specifici interessi che rimangono nella
sfera volitiva interna del creditore della prestazione alberghiera costituendo il semplice impulso psichico interiore
che lo spinge alla stipulazione del contratto, ma viene (anche implicitamente) ad obbiettivarsi in tale tipo di
contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, così connotandone la sua causa
sul piano concreto" (in argomento, adde Cass. 12235/07 oltre alla già citata Cass. 10490/06). Il concetto di causa
concreta appare, così, funzionale, da un canto, a qualificare il "tipo" contrattuale - determinando l'essenzialità di
tutte le attività e servizi strumentali alla realizzazione della finalità turistica (e cioè il benessere psico - fisico che il
pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare) -; dall'altro, assume
rilievo quale criterio di adeguamento del rapporto negoziale, considerato nella suo aspetto dinamico-effettuale.
Di talchè la causa (come non si è mancato di osservare da parte della più attenta dottrina) finisce per assumere
rilievo non meno decisivo in ordine alla sorte della vicenda contrattuale (oltre che con riferimento alla fattispecie
negoziale considerata nel suo aspetto genetico), in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo
sviluppo del rapporto (inadempimento, impossibilità, aggravio della prestazione, ecc.), eventi negativamente
incidenti sull'interesse creditorio (nella specie, turistico), obbiettivato in seno all'elemento causale del contratto, e
tali da farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete
del caso - si accerti l'impossibilità, della relativa realizzazione. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione
34
della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della
prestazione (in argomento, funditus, cfr. Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., (cfr.
ancora Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037 e la già citata Cass. 24/07/2007 n. 16315), ma,
nella specie, soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effetti. Il venire oggettivamente
meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare
l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174
c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto
interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo
conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione. Il venir meno dell'interesse
creditorio (e della causa del contratto che ne costituisce la fonte) può essere, dunque, legittimamente
determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si
presenti come non imputabile al creditore, nonchè oggettivamente incidente sull'interesse che risulta
(anche implicitamente) obbiettivato nel contratto: una impossibilità tale da vanificare o rendere
irrealizzabile la “finalità turistica” (laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il
turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici;
l'esigenza di un distacco dall'ambiente di lavoro; la necessità di riprendersi da un periodo di stress; la ricerca di
avventure post-matrimoniali ecc.) in cui si sostanziano, viceversa, i motivi impulsivi sottesi alla stipula del
contratto da parte del creditore della prestazione di soggiorno alberghiero. Così, pur essendo la
prestazione in astratto ancora eseguibile, deve ritenersi che il venir meno della possibilità che essa realizzi lo
scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo “scopo di vacanza” in cui si sostanzia la
“finalità turistica”), implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla
sfera giuridico - economico di quest'ultimo. Superando le perplessità in passato avvertite, in argomento, da questa
stessa Corte (Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in consonanza con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, va
pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se
normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce - analogamente all'impossibilità di
esecuzione della prestazione - autonoma causa di estinzione dell'obbligazione: essendo la prestazione
divenuta inidonea a soddisfare l'interesse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto
obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta
comporta l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il
creditore non ha l'onere di accettarla. Ad ulteriore conforto di tale conclusione va ricordato, ancora,
l'orientamento recentemente espresso da questa stessa corte, a sezioni unite, in ordine alla necessità di un più
penetrante controllo dell'autonomia privata da parte del Giudice in sede di tutela della parte ^debole" di un
rapporto contrattuale, orientamento puntualmente espresso nella sentenza n. 18128 del 2 005, con la quale le
sezioni unite hanno sottolineato - in tema di rilevabilità d'ufficio della clausola penale - che “l'esegesi tradizionale
della norma ex art. 1384 c.c., non appare più adeguata alla luce di una ri-lettura degli istituti costituzionali in
senso conformativo ai precetti superiori della Carta fondamentale - individuati nel dovere di solidarietà nei
rapporti intersoggettivi, ex art. 2 Cost., e nell'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese
creditorie -, integrati con i generali canoni di ermeneutica contrattuale quali quelli della buona fede oggettiva e
35
della correttezza di cui agli artt. 1175, 1337, 1359, 1375 c.c.". La pronuncia evoca, del tutto condivisibilmente,
quanto più volte affermato dalla stessa Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 19 del 1994, ha a sua volta
sottolineato come "con riferimento a rapporti obbligatori disciplinati da norme inerenti all'ordinamento generale
dello Stato" vada riconosciuta "l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite superiore alle
pretese creditorie", principio a sua volta consacrato dal giudice delle leggi nella precedente sentenza n. 149 del
1992, ove si afferma che "l'interesse del creditore all'adempimento degli obblighi dedotti in obbligazione deve
essere inquadrato nell'ambito della gerarchia dei valori comportata dalle norme, di rango costituzionale e
ordinario, che regolano la materia in considerazione: e quando, in relazione a un determinato adempimento,
l'interesse del creditore entra in conflitto con un interesse del debitore tutelato dall'ordinamento giuridico o,
addirittura, dalla Costituzione, come valore preminente o, comunque, superiore a quello sotteso alla pretesa
creditoria, allora l'inadempimento, nella misura e nei limiti in cui sia necessariamente collegato all'interesse di
valore preminente, risulta giuridicamente giustificato". Mette ancora conto di analizzare l'aspetto, evidenziato dal
ricorrente nel sub-motivo 2, della limitazione al solo cliente deceduto di tale situazione oggettiva di impossibilità
della controprestazione da parte del soggetto che, avendo già ricevuto la prestazione in denaro, è tenuto alla
restituzione "secondo le norme relative all'indebito".
(omissis)
36