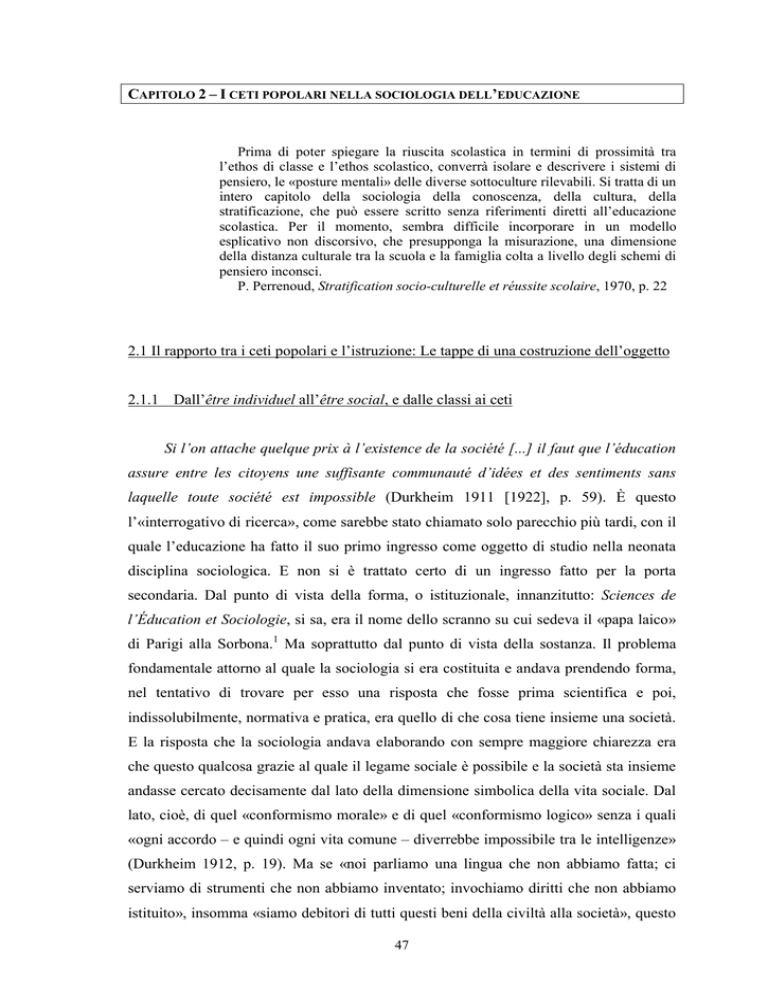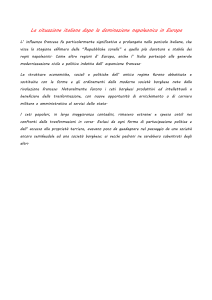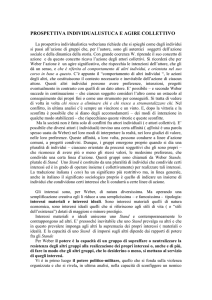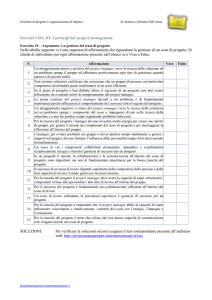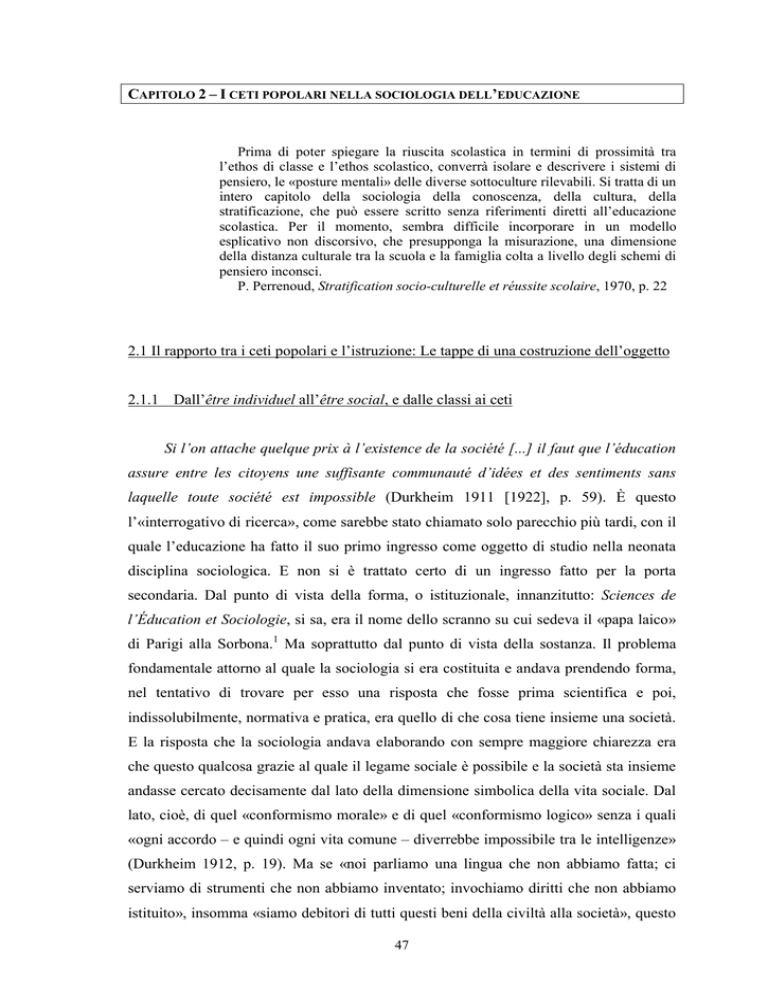
CAPITOLO 2 – I CETI POPOLARI NELLA SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
Prima di poter spiegare la riuscita scolastica in termini di prossimità tra
l’ethos di classe e l’ethos scolastico, converrà isolare e descrivere i sistemi di
pensiero, le «posture mentali» delle diverse sottoculture rilevabili. Si tratta di un
intero capitolo della sociologia della conoscenza, della cultura, della
stratificazione, che può essere scritto senza riferimenti diretti all’educazione
scolastica. Per il momento, sembra difficile incorporare in un modello
esplicativo non discorsivo, che presupponga la misurazione, una dimensione
della distanza culturale tra la scuola e la famiglia colta a livello degli schemi di
pensiero inconsci.
P. Perrenoud, Stratification socio-culturelle et réussite scolaire, 1970, p. 22
2.1 Il rapporto tra i ceti popolari e l’istruzione: Le tappe di una costruzione dell’oggetto
2.1.1 Dall’être individuel all’être social, e dalle classi ai ceti
Si l’on attache quelque prix à l’existence de la société [...] il faut que l’éducation
assure entre les citoyens une suffisante communauté d’idées et des sentiments sans
laquelle toute société est impossible (Durkheim 1911 [1922], p. 59). È questo
l’«interrogativo di ricerca», come sarebbe stato chiamato solo parecchio più tardi, con il
quale l’educazione ha fatto il suo primo ingresso come oggetto di studio nella neonata
disciplina sociologica. E non si è trattato certo di un ingresso fatto per la porta
secondaria. Dal punto di vista della forma, o istituzionale, innanzitutto: Sciences de
l’Éducation et Sociologie, si sa, era il nome dello scranno su cui sedeva il «papa laico»
di Parigi alla Sorbona.1 Ma soprattutto dal punto di vista della sostanza. Il problema
fondamentale attorno al quale la sociologia si era costituita e andava prendendo forma,
nel tentativo di trovare per esso una risposta che fosse prima scientifica e poi,
indissolubilmente, normativa e pratica, era quello di che cosa tiene insieme una società.
E la risposta che la sociologia andava elaborando con sempre maggiore chiarezza era
che questo qualcosa grazie al quale il legame sociale è possibile e la società sta insieme
andasse cercato decisamente dal lato della dimensione simbolica della vita sociale. Dal
lato, cioè, di quel «conformismo morale» e di quel «conformismo logico» senza i quali
«ogni accordo – e quindi ogni vita comune – diverrebbe impossibile tra le intelligenze»
(Durkheim 1912, p. 19). Ma se «noi parliamo una lingua che non abbiamo fatta; ci
serviamo di strumenti che non abbiamo inventato; invochiamo diritti che non abbiamo
istituito», insomma «siamo debitori di tutti questi beni della civiltà alla società», questo
47
accade perché «a ogni generazione viene trasmesso un tesoro di conoscenze che essa
non ha raccolto da sola» (ivi, p. 226). In altri termini, se l’esistenza della società
dipende da quella di una «comunità di idee e di sentimenti» tra i suoi membri,
quest’ultima a sua volta può essere prodotta solo da «una socializzazione metodica delle
giovani generazioni» (ivi, pp. 60 e 51).
Una cultura condivisa è ciò che rende possibile una società, e l’educazione è ciò
che rende possibile tra i suoi membri l’esistenza e il perpetuarsi della condivisione
culturale – nelle parole di Durkheim «il mezzo attraverso il quale [la società] prepara
nel cuore dei suoi figli le condizioni essenziali per la propria esistenza» (Durkheim
1911 [1922], p. 51). Cultura ed educazione non entrano dunque come oggetti tra altri, o
specificazioni disciplinari, della sociologia: vi entrano come le due dimensioni
fondamentali e imprescindibili della risposta al quesito per risolvere il quale la
sociologia stessa era nata. Il che equivale a dire, con un linguaggio più suggestivo ma
ugualmente «ben fondato», che la sociologia fa in realtà la sua prima comparsa nella
forma di una sociologia che è ad un tempo e in modo indistinguibile della cultura e
dell’educazione. Dove cultura ed educazione non vanno intesi nell’accezione ristretta
che hanno assunto quando, più tardi, sono diventati uno dopo l’altro settori di ricerca
più o meno istituzionalmente autonomi della sociologia. La sociologia culturale di
Durkheim non è infatti una sociologia delle istituzioni specializzate nella produzione
simbolica almeno quanto la sua sociologia dell’educazione non è – o non è solo – una
sociologia di una di queste istituzioni specializzate, il campo dell’istruzione formale. È
infatti l’attività di produzione simbolica diffusa, o più esattamente i processi di
costruzione e di uso di significati condivisi, che stanno a cuore a Durkheim, e i
meccanismi attraverso i quali la società trasmette questi significati condivisi ai suoi
membri. La sua sociologia culturale è allora in primo luogo una sociologia della
conoscenza2, e la sua sociologia dell’educazione una sociologia della trasmissione di
questa conoscenza, ovvero non solo una sociologia della scolarizzazione ma una
sociologia dei processi di socializzazione.3
Ma, come ben osserva Jean-Louis Derouet, «la storia della sociologia
dell’educazione [...] è discontinua», e «dopo un primo periodo, molto brillante,
all’epoca di Durkheim», essa «è rimasta senza posterità. La sociologia dell’educazione è
scomparsa dopo la prima guerra mondiale.4 Essa è “rinata” dopo la seconda guerra
mondiale.» E non solo è rinata dapprima altrove, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti,
ma soprattutto, e anche quando più tardi è tornata a rivivere in Francia, «questo
48
rinascimento ha riposato su delle basi sensibilmente diverse da quelle del periodo
durkheimiano». (Derouet 2000, p. 200). In particolare è cambiata, e in modo definitivo,
quella che potremmo definire la ragione d’essere primaria della sociologia
dell’educazione. Benché infatti, dal dopoguerra ai giorni nostri, la disciplina abbia
conosciuto una sempre maggiore «diversificazione degli oggetti, dei riferimenti
epistemologici e dei metodi» (ivi, p. 206) di ricerca – tanto da indurre alcuni ad evocare
oggi il rischio di una vera e propria «esplosione» (ibidem) dell’eterogeneità di approcci
che ne minaccerebbe la sopravvivenza stessa – il tema cruciale che ha motivato la
“rinascita” della sociologia dell’educazione e il suo sviluppo nei decenni successivi è
stato uno solo, come una sola era stata la preoccupazione che ne aveva determinato la
prima nascita. Allora, lo abbiamo visto, questa preoccupazione era quella della
costruzione del legame sociale attraverso l’integrazione dei membri in una cultura
comune. Compito della sociologia dell’educazione era portare alla luce, descrivere e
quindi prescrivere i meccanismi più efficaci per «costituire questo essere [sociale] in
ciascuno di noi» (Durkheim 1911 [1922], p. 51).
Nel dopoguerra, «questo compito si è evoluto. L’integrazione è certamente
rimasta una missione essenziale ma la società ha ritenuto che la scuola “sapesse fare”5 e
la questione è uscita dall’arena del dibattito.» (Derouet 2000, p. 200). Per farvi entrare
un nuovo problema che non ha ancora smesso di tenere banco: quello della cosiddetta
uguaglianza delle possibilità di accesso al e di riuscita nel sistema dell’istruzione. La
nuova missione – che non si può dire (ancora?) onorata – assegnata alla disciplina è
diventata allora ovviamente quella di identificare e prescrivere le condizioni per tale
uguaglianza. O meglio, poiché il terreno di riflessione teorica e di indagine empirica nel
quale da allora le condizioni dell’uguaglianza davanti all’istruzione sono state esplorate
è stato quello in cui tale condizioni palesemente mancavano, identificare le cause delle
disuguaglianze di accesso al sistema istruzione e poi, con la massificazione di questo
accesso, sempre più le cause delle disuguaglianze di riuscita nel sistema stesso. È stato
naturalmente allora, con la comparsa del nuovo problema, che gli strati inferiori della
società hanno fatto il loro ingresso da protagonisti nella sociologia dell’educazione.
Andando ad occuparvi, nella loro qualità di svantaggiati per eccellenza dal sistema
dell’istruzione, quel posto privilegiato che il punto di vista di Durkheim non aveva
potuto accordare loro.6
E questo ingresso lo hanno fatto prima soprattutto in qualità di classi, e solo più
tardi come ceti. Perché, come osserva Jean Floud a proposito della sociologia
49
dell’educazione britannica – che fu la prima a «rinascere» e lo fece inoltre con una
solidissima tradizione di studi sulla mobilità sociale,
fino al 1945, grosso modo, il problema della classe sociale
nell’istruzione era visto, dagli scienziati sociali come dai politici, in
primo luogo come una barriera alla possibilità. Il problema era un
problema istituzionale: come assicurare uguaglianza di accesso per i
bambini con capacità simili, a prescindere dalle loro origini sociali,
alle istituzioni di istruzione secondaria e superiore fatti per, e ancora
usati prevalentemente da, i figli delle classi sociali superiori. Nella
misura in cui si riteneva che la classe sociale influenzasse la
prestazione educativa, il problema era concepito come un problema
materiale: in che modo mitigare gli handicap della povertà, della
malnutrizione e del sovraffollamento usando la scuola come un ente di
servizio sociale – distribuendo latte e pasti gratuiti ai bambini che ne
avevano bisogno e sviluppando i servizi di medicina scolastica.
(Floud 1961 [1968], pp. 138-139)
Tanto le disuguaglianze di rendimento all’interno del sistema di istruzione quanto
quelle, allora molto più visibili, di accesso al sistema stesso (il cosiddetto «spreco di
talenti» o «spreco di capacità»), erano dunque imputate a differenze nelle condizioni
materiali delle classi sociali: alla mancanza di disponibilità economiche nel caso
dell’accesso, agli effetti della povertà economica sulle condizioni quotidiane di vita nel
caso del rendimento. Sulla plausibilità di questa seconda spiegazione, Banks osserva
peraltro che «ci sono pochi dubbi che prima della seconda guerra mondiale le
condizioni economiche nelle quali si svolgeva la vita della classe operaia incitavano
poco a guardare altrove per trovare le ragioni del suo scarso rendimento scolastico»
(Banks 1971, p. 65).
Nei primi due decenni del dopoguerra, in particolare in Gran Bretagna ma anche
nei principali Paesi dell’Europa continentale e negli Stati Uniti, la crescita economica
unita a sforzi senza precedenti compiuti dagli Stati in direzione di una ridistribuzione
della ricchezza prodotta – il cosiddetto periodo d’oro dello stato sociale – ridussero
notevolmente entrambi gli ostacoli. Da un lato, migliorarono le condizioni materiali di
vita della classe operaia, e le situazioni di povertà tali da compromettere la salute fisica
e lo sviluppo organico stesso dei bambini non costituirono più la norma negli strati
inferiori. Dall’altro, in molti Paesi furono poste le basi istituzionali – riforme dei cicli di
istruzione e potenziamento degli aiuti economici (per una panoramica, cfr. il capitolo 3
di Banks 1971) – per favorire una democratizzazione dell’accesso all’istruzione
secondaria e superiore. In quegli stessi anni e in quegli stessi Paesi, tuttavia, un numero
50
crescente di risultati di indagini statistiche, molte della quali commissionate dai governi,
si accordava nel rilevare la persistenza generalizzata e anzi l’ottimo stato di salute delle
disuguaglianze di fronte all’istruzione.7 Fu per l’accumularsi di questi risultati
convergenti e preoccupanti che, come nota Floud,
nel periodo del dopoguerra il continuo tentativo di democratizzare
l’istruzione secondaria e superiore in condizioni inconsuete di piena
occupazione e di benessere diffuso ci mise di fronte alla necessità di
riformulare il problema in modo più sottile e ritenere che la classe
sociale avesse un’influenza profonda sulla educabilità dei bambini.
(Floud 1961 [1968], p. 139)
Nelle parole di Banks:
Il peso crescente delle prove della persistenza di disuguaglianze di
classe sociale nel percorso di istruzione, a dispetto della
democratizzazione delle possibilità di accesso al sistema stesso, ha
reso inevitabile la messa in relazione stretta di studi dell’ambiente
familiare con considerazioni relative alle classi sociali. La consistente
tendenza dei figli degli operai o dei lavoratori manuali a riuscire meno
bene a scuola, e a lasciare la scuola prima dei figli dei lavoratori non
manuali anche quando avevano le stesse capacità, esigeva una
spiegazione, e sembrava ragionevole cercare quella spiegazione nelle
esperienze e nelle attitudini della famiglia operaia.
(Banks 1971, pp. 61-62)
È precisamente con questa «riformulazione» del problema, come la chiama Floud,
che gli strati popolari entrano finalmente nella sociologia dell’educazione anche come
ceti, cioè con la loro cultura al seguito, dopo che per un periodo vi avevano soggiornato
solo o prevalentemente come classi, portandosi dietro unicamente le loro nude
«possibilità di vita» materiali. In altri termini, come scrive Jean-Claude Forquin, nei
risultati di queste indagini statistiche «si trova in insieme di suggerimenti, di
orientamenti molto fortemente convergenti [...]: le fondamenta di ciò che si potrebbe
definire, globalmente, un modello “culturalista” di spiegazione delle disuguaglianze di
fronte all’istruzione» (Forquin 1979a, p. 98). Fondamenta, o riformulazione, che
tuttavia vanno intese qui in un senso più logico che strettamente cronologico. O, quanto
meno, vanno intese in un senso cronologico solo se ci riferisce alle riflessioni sul
rapporto dei ceti popolari con la sfera dell’istruzione e dell’educazione che sono state
condotte nell’ambito della sociologia dell’educazione istituzionalmente definita – che è
appunto quella a cui Floud e Forquin si richiamano. Perché, come vedremo meglio tra
51
poco, soprattutto negli Stati Uniti, in settori disciplinari confinanti quali la sociologia
della famiglia e soprattutto la psicologia sociale (e, in misura minore, la psicologia dello
sviluppo), il rapporto tra la cultura dei ceti popolari, l’educazione e l’istruzione era stato
esplorato fin dagli anni Trenta, vale a dire ben prima degli effetti di riorientamento
teorico prodotti dai risultati delle prime grandi indagini statistiche.
2.1.2 Dalla misurazione di una lontananza alla comprensione di una esperienza
L’obiettivo di questo capitolo è quello di ripercorrere le grandi tappe della storia
della presenza della cultura dei ceti popolari nelle ricerche che, dagli anni TrentaQuaranta del Novecento fino ad oggi, si sono occupate di analizzare il rapporto tra
questa cultura e la sfera dell’educazione e dell’istruzione. E che sono state motivate,
pressoché nella totalità dei casi, dall’intento di esplorare – direttamente o indirettamente
– il nesso esistente tra le disuguaglianze di origine sociale e le disuguaglianze di fronte
all’istruzione. Cioè, in termini generalissimi, identificare «che cos’è che, in funzione
dell’età del bambino, nella socializzazione e nell’educazione familiare, in modo diretto
o indiretto, favorisce la riuscita e l’integrazione scolastica o, al contrario, è suscettibile
di causare dei problemi di adattamento» (Bergonnier-Dupuy 2005, p. 6). La rassegna
sarà mirata alla ricostruzione di una progressione logica prima che all’esaustività o al
rispetto stretto di una progressione cronologica. Soprattutto, essa trascenderà spesso i
confini della sociologia dell’educazione per toccare quei territori disciplinari limitrofi
che nel corso dei decenni hanno contribuito in forme più o meno importanti
all’accumulazione del sapere scientifico su questo argomento: dalla psicologia sociale, a
quella dello sviluppo, e più recentemente a quella cognitiva, alla sociologia della
famiglia, alla sociolinguistica, fino a quelle che in Francia chiamano – distinguendole
dalla sociologia dell’educazione – le sciences de l’éducation, e, in tempi recenti,
l’antropologia dell’educazione e l’antropologia urbana.
Accumulazione, appunto, e non cumulatività, è infatti il termine più adatto per
descrivere lo stato della conoscenza scientifica sull’argomento, e il modo peculiare in
cui esso ha preso forma. Perché su quello che chiameremo sinteticamente il tema delle
spiegazioni culturaliste delle disuguaglianze educative, la mole delle ricerche condotte e
dei dati raccolti è pari soltanto alla frammentazione dei risultati ai quali queste ricerche
e questi dati hanno condotto. Frammentazione non tanto nel senso che queste tessere di
puzzle che sono i risultati delle diverse ricerche risultano difficilmente incastrabili –
52
ovvero compatibili – tra loro, quanto piuttosto nel senso che, per quanto il numero dei
«pezzi» sia sempre andato aumentando senza sosta, sono pure sempre mancante alcune
tessere di giuntura necessarie per collegare tra loro le altre e completare il puzzle. Le
ragioni di questa mancanza sono composite. Esse non sembrano tuttavia imputabili alla
frammentazione disciplinare – e quindi dei riferimenti epistemologici, teorici e
metodologici – che pure ha sempre caratterizzato questo ambito di ricerca. Anzi, come
vedremo tra poco, a fronte di questa diversificazione di appartenenze, la prospettiva
analitica con la quale per lungo tempo si è guardato al problema è stata fin troppo
omogenea. Piuttosto, in primo luogo la complessità intrinseca dell’oggetto di ricerca
stesso non sembra essere senza responsabilità nel faticoso avanzamento della
conoscenza scientifica su di esso. Una complessità al limite dell’ingestibile che è
peraltro evocata molto spesso dai commentatori più sensibili che si sforzano di rendere
almeno in parte ragione del fatto che «non si può certo dire che l’attenzione che negli
ultimi anni i sociologi hanno prestato a questo problema ci abbia portati molto lontano
nella strada verso una soluzione» (Banks 1971, p. 62):
Abbiamo molti studi del rapporto tra origine di classe e riuscita nel
sistema di istruzione, e molti aspetti diversi di quell’origine sono stati
suggeriti come fattori causali nella correlazione tra famiglia e scuola,
ma fino ad ora sappiamo molto poco sul modo preciso nel quale questi
diversi fattori si combinano nel deprimere la prestazione intellettuale.
[...] Forse la ragione più importante dei problemi di questa area di
studio è l’enorme complessità del concetto di ambiente o origine
familiare. Non solo ci sono molti aspetti diversi della vita familiare
che si rivelano importanti, ma questi ultimi sono anche
frequentemente difficili da operazionalizzare in modo adeguato. Oltre
a ciò, si può dimostrare che questi fattori non operano in maniera
indipendente, ma sono strettamente collegati tra loro e possono
benissimo avere un effetto cumulativo. In queste condizioni è quasi
impossibile identificare il modo preciso in cui un particolare ambiente
familiare opera per produrre il successo o il fallimento scolastico.
(ibidem, sottolineatura mia)8
Anche a distanza di oltre trent’anni, risulta tuttora molto difficile non concordare
con Banks su quest’ultima considerazione. Alla quale aggiungerei che la vera meta
impossibile non sembra forse tanto raggiungere la precisione del nesso tra aspetti
circoscritti dell’adattamento scolastico e singoli tratti culturali dell’ambiente familiare,
quanto piuttosto unire questa precisione alla completezza di una visione che sia nello
stesso tempo d’insieme e fine della relazione tra le due macro variabili dell’origine
familiare e della riuscita nel sistema di istruzione. E infatti non è un caso che, come
53
vedremo, la storia di più di quarant’anni di ricerche culturaliste sulle disuguaglianze
educative – cioè il periodo che va grosso modo dagli anni Quaranta agli anni Ottanta del
Novecento – sia proprio la storia di una polarizzazione tra precisione e completezza.
Tra, da un lato, «il crudo empirismo che ha prevalso così frequentemente» (Banks
1971, p. 97), al quale la crudezza ateorica non ha tuttavia impedito di portare qualche
volta alla luce correlazioni inequivocabili tra singole dimensioni dell’ambiente familiare
e singole dimensioni del percorso di istruzione, che sono entrate a far parte del (poco)
sapere acquisito di questo ambito di ricerca. E, dall’altro, tentativi di costruire modelli
teorici culturalisti elaborati e di ampio respiro (dei quali i due più importanti furono
certamente quelli di Bernstein e soprattutto di Bourdieu) che ambissero a mettere
contemporaneamente in relazione causale tra loro più dimensioni diverse delle due
macro variabili. E ambissero, quindi, in tal modo, alla completezza nella spiegazione
del loro nesso. Sacrificando – o più esattamente, semplificando – però, e di molto, «il
dettaglio dei processi di mediazione» (Perrenoud 1970, p. 12) e le variabili intermedie
in azione in questi meccanismi. Fino a lasciare questi processi e questi meccanismi
intermedi delle «scatole nere» inesplorate, oppure tracciare del loro funzionamento dei
ritratti «scheletrici» (Lahire 1999a, pp. 124 e 131) e in quanto tali irreali. Perché se, nel
polo della precisione, l’empirismo è stato consumato «crudo», cioè poco o per nulla
aggraziato da una «cottura» teorica, nel polo della completezza esso ha avuto invece la
tendenza, se non a scomparire dalla tavola dei ricercatori, a venire consumato talmente
«cotto» da essere privato di qualsiasi «apporto nutritivo» autonomo che gli permettesse
di fare qualcosa di più che semplicemente confermare il modello teorico.9
Polarizzati per quanto riguarda il rapporto tra teoria ed empiria, e quello tra
ricerca della precisione e ricerca della completezza, gli studi delle covariazioni tra
singole dimensioni dell’adattamento scolastico e singoli tratti culturali dell’ambiente
familiare da un lato e i modelli complessi elaborati per rendere conto della relazione
complessiva tra le due macro variabili dall’altro hanno tuttavia presentato per più di
quarant’anni una singolare convergenza. Una forte tendenza all’uniformità che ha
attraversato i confini disciplinari ed ha riguardato segnatamente la prospettiva analitica
generale. Da quando il problema delle disuguaglianze sociali di fronte all’istruzione è
stato riformulato come un problema eminentemente culturale, di differenze culturali, la
preoccupazione centrale e unanime dei ricercatori è stata infatti per molto tempo quella
di produrre una misurazione di queste differenze:
54
Una gran parte della sociologia dell’educazione adotta questa
prospettiva in modo più o meno esplicito, consacrandosi a misurare
gli scarti [...] nati dall’incontro tra la socializzazione familiare e la
socializzazione scolastica. Il bambino è all’incrocio di queste due
socializzazioni e il successo scolastico degli uni dipende dalla
prossimità delle due culture, scolastica e familiare, laddove il
fallimento scolastico degli altri si spiega con la distanza di queste
culture e con il dominio sociale della seconda sulla prima. Così, il
successo o il fallimento, essenziali nell’esperienza scolastica, sono
interpretati in termini di scarti di socializzazione.
(Dubet e Martuccelli 1996, p. 52, sottolineatura mia)
Misurare, nelle parole di Dubet e Martuccelli, uno scarto di socializzazione,
significa evidentemente quantificare una distanza o una lontananza, calcolare ciò che
manca per arrivare da un punto a un altro. Significa quindi, in primo luogo, dirigere
l’attenzione dell’analisi molto più sui due modi di socializzazione considerati in sé che
sulle forme e sugli effetti (reciproci) del loro contatto. Ed esporsi al rischio di scivolare
continuamente da un significato analitico ad uno concreto della nozione di separatezza
tra le due culture – facendo cioè di essa un assunto di partenza anziché un risultato
eventuale dell’analisi. In secondo luogo, significa prendere uno di questi due modi di
socializzazione come il limite di riferimento e guardare all’altro soprattutto in termini di
assenza, mancanza, difetto. Guardarlo, cioè, per censirvi la presenza o l’assenza di
singoli tratti culturali presenti nel primo molto più che per portarne alla luce una
coerenza simbolica propria – sforzandosi quindi di contestualizzare e comprendere
queste presenze e queste assenze all’interno di un sistema significante complessivo (e
non solo, con spiegazioni di tipo funzionalistico, in termini di razionalizzazione o
adattamento alle risorse o alle condizioni di vita). Nelle parole di Jean-Claude
Combessie, «per le classi inferiori, il solo principio unificatore proposto è la differenza
delle loro aspirazioni e dei loro comportamenti rispetto a quelli della classe media», ma
così facendo questi «contributi allo studio delle differenze tra le culture di classe non
hanno potuto essere formulati che facendo astrazione delle differenze culturali tra le
classi sociali» (Combessie 1969, pp. 16 e 17; cfr. su questo anche Holden e Edwards
1989).
La tendenza a fare della separatezza culturale il punto di partenza anziché quello
di arrivo dell’analisi, e quella a fare astrazione del fatto che «ogni gruppo sociale» tende
«a organizzare la propria esperienza in universo coerente», ovvero «anche dominata una
cultura funziona ancora come una cultura» (Grignon e Passeron 1989, p. 21), hanno
caratterizzato la grande maggioranza degli studi culturalisti delle disuguaglianze
55
educative prodotti tanto nel campo dell’educazione familiare quanto in quello dei
rapporti con il sistema di istruzione fino agli anni Ottanta. Fino a quando, cioè, il
generale cambio di paradigma verificatosi nelle scienze sociali in quel decennio, con la
salita in auge delle teorie dell’azione e dell’attore e degli approcci interpretativi, ha
investito progressivamente anche l’ambito di ricerca del rapporto tra culture di ceto e
disuguaglianze educative (su questo passaggio nel campo della ricerca educativa, cfr.,
tra i molti altri, Mehan 1992; Van Zanten e Anderson-Levitt 1992; Sirota 1993; DuruBellat e Van Zanten 1999; Derouet 2000; Van Haecht 2006).
Il «ritorno dell’attore» e della questione dell’attribuzione del senso dell’azione,
unito a un rinnovamento metodologico in direzione qualitativa e soprattutto etnografica,
ha permesso di guardare al problema della differenza culturale tra l’universo delle
famiglie dei ceti popolari e l’universo educativo in un modo diverso che come a un
problema di misurazione – dall’esterno – di una distanza. L’etnografia dell’educazione
ha in particolare iniziato ad uscire dal contesto dell’interazione in ambito scolastico, che
fino ad allora tanto la New Sociology of Education inglese quanto l’antropologia
dell’educazione statunitense le avevano riservato (cfr. Delamont e Atkinson 1980; Van
Zanten e Anderson-Levitt 1992), e a diffondersi allo studio della socializzazione
familiare e soprattutto allo studio dei rapporti tra scuola, famiglie e comunità di
quartiere – un oggetto di analisi, quest’ultimo, in gran parte nuovo prodotto proprio dal
rinnovamento degli anni Ottanta (cfr. tra gli altri Epstein e Sanders 2000). Molto
banalmente, questo ha reso possibile produrre descrizioni fini, prima che misurazioni,
delle differenze culturali all’origine delle disuguaglianze educative. L’approccio
analitico di tipo interpretativo ha poi soprattutto fatto sì che quelle descrizioni di
universi culturali e dei loro rapporti venissero condotte, per così, dire, il più possibile
nei loro stessi termini. Ha cioè, da un lato, imposto un deciso cambio di direzione alla
tendenza alla decontestualizzazione dei tratti culturali popolari che aveva prevalso nella
ricerca culturalista sulle disuguaglianze educative dei decenni precedenti. Prendendo
finalmente sul serio, quindi, quella notazione programmatica, riportata in apertura di
questo capitolo, con la quale nel 1970 Philippe Perrenoud faceva un bilancio dello stato
dell’arte del campo, affermando che «prima di poter spiegare la riuscita scolastica in
termini di prossimità tra l’ethos di classe e l’ethos scolastico, converrà isolare e
descrivere i sistemi di pensiero, le “posture mentali” delle diverse sottoculture
rilevabili» (Perrenoud 1970, p. 22) all’interno delle quali, solo, i diversi rapporti con
l’ethos – e in generale, il mondo – scolastico assumono tutto il loro senso. Dall’altro
56
lato, e soprattutto, la prospettiva interpretativa ha permesso di integrare nell’analisi delle
differenze tra le culture familiari di ceto e la cultura scolastica, per dirla con un
linguaggio poco scientifico, il vissuto degli attori, ovvero, in termini più ortodossi, il
senso soggettivo della loro azione. Il modo, cioè, in cui tanto gli alunni quanto le loro
famiglie danno senso alle proprie pratiche, rappresentazioni e valori, e soprattutto a
quelli, spesso divergenti, dell’universo simbolico scolastico, e, quindi, alla propria
esperienza a contatto con o all’interno di questo universo.
La finezza di analisi resa possibile dall’uso del metodo etnografico, lo sforzo di
comprensione contestuale delle differenze culturali rilevate nei termini dell’universo
simbolico, o sistema significante, da cui provengono e in cui assumono il loro senso,
l’attenzione all’interpretazione che l’attore dà della propria esperienza. Sono questi gli
elementi di discontinuità principali che si possono rilevare tra i primi quarant’anni di
studi culturalisti delle disuguaglianze educative e le nuove direzioni di ricerca che
questo campo ha imboccato con sempre maggiore decisione da poco più di due decenni.
Discontinuità che hanno riguardato prima e in modo diretto le prospettive di analisi e i
metodi di indagine, ma che, attraverso i nuovi modi di vedere ed esplorare l’oggetto di
ricerca, hanno coinvolto anche gli interrogativi che a questo oggetto sono stati rivolti,
per trasformare, infine, l’oggetto stesso. Per molto tempo, lo abbiamo visto, questo
oggetto è stato una lontananza. O più esattamente, una differenza che l’obiettivo
fotografico del ricercatore, all’altezza e nel punto in cui era collocato, mostrava
inequivocabilmente sotto le sembianze di una distanza. E che come una distanza veniva
interrogato: ci si chiedeva a quanto ammontasse lo scarto; eventualmente, ci si chiedeva
poi se questo scarto si potesse spiegare, funzionalmente, con un’altra distanza che aveva
a che fare con «le possibilità di vita», o con quelle che Bourdieu chiama la «condizione
di classe e [la] posizione di classe» (Bourdieu 1966). Una delle conseguenze più
importanti ed immediate dell’aumento dello zoom dell’obiettivo, e forse anche della
sostituzione del vetrino con uno meno opaco, prodotti dalla nuova prospettiva di analisi
è stato proprio quello di problematizzare l’immagine di lontananza che per tanti anni
questo obiettivo aveva offerto al ricercatore. Mettendo in discussione in particolare
l’idea di separatezza, ovvero impermeabilità, tra i due universi culturali che questa
immagine portava con sé. E che, con uno scivolamento semantico ulteriore, aveva preso
spesso la forma di una idea di non implicazione ad un tempo mentale e pratica degli
alunni e delle famiglie di ceto popolare nell’universo scolastico – da quella che è stata
57
spesso chiamata la «dimissione genitoriale» delle seconde alla «smobilitazione»
scolastica (Sirota 1988, p. 118) dei primi.
Problematizzare quell’assunto di lontananza tra il mondo delle famiglie popolari e
il mondo dell’istruzione così consolidato nelle ricerche classiche non significa mettere
in discussione il fatto che il problema delle disuguaglianze di fronte all’istruzione vada
cercato in una discrepanza culturale, in una tensione, o in una incompatibilità tra modi
di socializzazione. Significa, piuttosto, invitare a distinguere analiticamente la questione
dall’esistenza di una differenza, o anche di una incompatibilità, tra due culture, da
quella del grado di chiusura dei confini simbolici tra le due. E suggerire, quindi, che le
due questioni debbano – ma, prima ancora, che possano – essere esplorate
distintamente. Come ho anticipato nel capitolo precedente (cfr. sopra il paragrafo 1.2),
questa distinzione analitica è tanto più necessaria quando si esplori, come in questo
caso, un caso di contatto culturale obbligato e pervasivo come è quello dei ceti popolari
con la sfera simbolica delle rappresentazioni, delle pratiche e dei valori «legittimi»
relativi all’educazione e dell’istruzione. Il carattere inevitabile di questo rapporto non
era stato mai preso sul serio ed esplorato nelle sue conseguenze dall’obiettivo lontano
del ricercatore del periodo classico, che di tale rapporto restituiva piuttosto i vuoti e le
assenze – ciò che rapporto, appunto, non era. Allo sguardo ravvicinato della nuova
prospettiva interpretativa ed etnografica, l’inevitabilità del contatto – piuttosto che il
distacco – culturale si impone invece come il punto di partenza dell’analisi. E la
descrizione dei modi di composizione che gli attori costruiscono tra i due universi
simbolici e le rispettive logiche di azione – piuttosto che la misura dello «scarto» tra
questi due mondi – come il suo oggetto privilegiato.
Un oggetto, e uno sguardo ravvicinato, che, come abbiamo visto sopra, è anche
quello di questa ricerca. La quale, per la prospettiva analitica scelta e i metodi di ricerca
adottati si colloca certamente tra le nuove direzioni di studio culturalista sulle
disuguaglianze educative sorte dalla svolta interpretativa degli anni Ottanta. Una
«svolta» rispetto ad una tradizione imponente che, tanto per le nuove direzioni di studio
quanto a maggior ragione per la presente ricerca, non ha fatto tuttavia certatamente solo
da riferimento negativo, come le riflessioni condotte finora possono avere erroneamente
suggerito. In primo luogo, e in generale, infatti, se è vero che, come ho sostenuto, la
gabbia analitica nella quale gran parte di questa tradizione è stata costretta ha costituito
per molto tempo un ostacolo sulla via della comprensione dei rapporti tra i ceti popolari
e l’universo educativo, è altrettanto vero che è a questa tradizione che dobbiamo
58
quell’«accumulazione» di – pochi o tanti – saperi che ci permette di parlare oggi della
ricerca culturalista sulle disuguaglianze educative come di un campo di studio. In
secondo luogo, accanto alle discontinuità nei riferimenti epistemologici, teorici e
metodologici che, come abbiamo visto, hanno contraddistinto il passaggio dai primi
quarant’anni agli ultimi due decenni, è possibile individuare delle linee di continuità – o
meglio, di evoluzione nella continuità – per quanto riguarda gli ambiti o i filoni di
ricerca specifici del campo. Per questo, prima di dedicare (nella sezione 2.3) alla svolta
degli ultimi vent’anni uno sguardo più ravvicinato, nella prossima sezione (2.2)
verranno ripercorse le tappe logico-cronologiche più importanti del processo di
costruzione del campo che ha avuto luogo nel periodo classico. Per preparare questo
viaggio tra i due stati del campo, la mappa delle prospettive analitiche che è stata
sommariamente tracciata sopra verrà integrata, nelle ultime pagine di questa sezione, da
una, altrettanto sommaria, mappa tematica degli ambiti di ricerca e delle loro
evoluzioni.
2.1.3 Gli ambiti di ricerca tra continuità e discontinuità: Una mappa possibile
Prima di procedere a tracciare questa mappa tematica, sincronica e diacronica, del
campo di studio culturalista delle disuguaglianze educative, occorre tuttavia una
precisazione. Nelle pagine precedenti tale campo è stato molto genericamente descritto
in questo modo: l’insieme multidisciplinare di analisi teoriche ed empiriche del nesso
tra le disuguaglianze di origine sociale e le disuguaglianze di accesso a e di riuscita nel
sistema di istruzione accomunate dall’idea che tale nesso vada spiegato nei termini di
una differenza culturale. Nei termini, cioè, di una differenza tra la cultura scolastica e le
culture di ceto – intese entrambe nell’accezione antropologica di universi di significati e
di pratiche costitutivi di un modo di vita – e i relativi modi di socializzazione. Si può
aggiungere anche, in una maniera altrettanto vaga e imprecisa, che i vari ambiti di
ricerca che è possibile isolare all’interno di questo campo si distinguono proprio per la
particolare porzione della differenza culturale alla quale prestano attenzione (quale
differenza culturale produce disuguaglianza) e/o per i modi in cui ne illustrano il
funzionamento (come la differenza culturale produce disuguaglianza).
In ogni caso, dei due termini della differenza, il modo di socializzazione
scolastico e il modo di socializzazione familiare, è stato prevalentemente quest’ultimo
ad occupare le analisi dei ricercatori. E questo sia quando i due termini apparivano ai
loro occhi soprattutto come le due estremità separate di una distanza, sia quando hanno
59
iniziato ad essere visti in primo luogo come due posizioni costrette a trovare una forma
di accomodamento. Nel primo caso, se la disuguaglianza di fronte all’istruzione era
prodotta da una differenza culturale, la radice del problema andava cercata dal lato dalla
cultura familiare di origine e della sua incapacità ad armonizzarsi con la cultura
scolastica. Nel secondo caso, sono state le forme dell’accomodamento della cultura di
provenienza dell’allievo e della sua famiglia alla cultura e al mondo scolastico, più che
quelle – pure esistenti – che andavano nella direzione contraria, ad occupare
l’attenzione dei ricercatori.
In entrambi i periodi, c’è stata tuttavia una parte più o meno minoritaria del
campo dell’analisi culturalista delle disuguaglianze educative che ha puntato il suo
obiettivo sull’altro polo della differenza, la cultura e il modo di socializzazione
scolastico. E questo non tanto per portare semplicemente alla luce il modo in cui la
cultura che gli allievi dei ceti popolari «si portano da casa» funzioni – o piuttosto non
funzioni – concretamente a scuola. Quest’ultimo, infatti è ancora un punto di vista che,
pur estendendo utilmente l’angolo della visuale, resta comunque analiticamente centrato
sulla cultura familiare di origine, ritenendo che «la riproduzione delle disuguaglianze da
parte della scuola deriva soltanto dalla applicazione di un egualitarismo formale»
(Forquin 1982b, p. 59). Gli studi culturalisti delle disuguaglianze educative che hanno
puntato l’obiettivo sul mondo dell’istruzione lo hanno fatto piuttosto con l’obiettivo di
portare alla luce le responsabilità autonome della scuola nella genesi di queste
disuguaglianze – responsabilità che in questa prospettiva vanno evidentemente oltre il
semplice fatto di «far le parti uguali tra disuguali», come avrebbe detto Don Milani. In
altri termini, queste ricerche si sono occupate di portare alla luce i modi nei quali le
disuguaglianze non solo funzionano, non solo si palesano o si manifestano, ma si
fabbricano al seno della scuola.
Questo lavoro, lo abbiamo visto, si occupa invece delle forme dell’esperienza
della scolarizzazione dal punto di vista delle famiglie che la vivono. Del rapporto delle
famiglie dei ceti popolari con la scuola colto guardando e dando voce alle prime. In
questo senso, esso rientra nella corrente maggioritaria di attenzione per ciò che accade a
casa e nella famiglia piuttosto che per ciò che accade a scuola. Alla voce della scuola su
ciò che accade a scuola, ovvero allo sguardo portato dagli insegnanti su queste famiglie
e sui loro figli, è stato riservato un posto, ma al solo scopo di poter meglio interpretare e
comprendere l’esperienza soggettiva delle famiglie integrandola con informazioni su
quella che potremmo chiamare la loro esperienza oggettiva del contatto con l’universo
60
scolastico. In altri termini, questa ricerca non si occupa, almeno non in modo diretto, del
modo in cui le disuguaglianze di fronte alla scuola si fabbricano a scuola, e in
particolare non si occupa della responsabilità autonoma della scuola in questa
fabbricazione. Le ricerche del campo di studi culturalisti delle disuguaglianze educative
che hanno puntato l’obiettivo sul mondo dell’istruzione per portare alla luce queste
responsabilità non costituiscono dunque il riferimento principale di questo lavoro. Per
questo, esse non troveranno posto nella mappa e nel successivo percorso attraverso
questa mappa che verranno proposti nelle pagine che seguono.10 Che esploreranno,
invece, come annunciato, il territorio della letteratura sulle culture di ceto.
Le pratiche e i valori educativi familiari, i valori e le aspirazioni relativi alla
riuscita scolastica e sociale, gli stili cognitivi e linguistici sono i tre grandi ambiti delle
culture di ceto che sono stati esplorati nei primi quarant’anni di studi culturalisti sulle
disuguaglianze educative. Disseminato tra l’area di studio degli stili di educazione
familiare e quella degli stili cognitivi e linguistici si può identificare un quarto ambito di
ricerca relativo alle rappresentazioni educative implicite dei genitori, o, come pure sono
state chiamate – soprattutto in ambito psicologico – alle loro etnoteorie o teorie
implicite dello sviluppo intellettuale e sociale del bambino. Tanto in quest’ultimo
settore di ricerca quanto in quello delle pratiche educative e degli stili cognitivi e
linguistici, in questi decenni l’interesse dei ricercatori ha privilegiato nettamente lo
studio delle famiglie con figli in età prescolare.
Una delle direzioni di sviluppo recenti degli studi culturalisti sulle disuguaglianze
educative riguarda proprio un generale spostamento in avanti delle fasce d’età in cui si
sono concentrate le analisi degli stili educativi familiari, che sono diventate sempre di
più quelle scolari e adolescenziali. Questo ha condotte naturalmente le ricerche
sull’educazione familiare ad integrare sempre più al loro interno la presa in conto delle
modalità di «accompagnamento genitoriale alla scolarità» (Bergonnier-Dupuy 2005, p.
6). In modo pressoché indipendente da questa evoluzione del filone di studio classico
dell’educazione familiare, il rapporto quotidiano delle famiglie con l’esperienza della
scolarizzazione dei figli è emerso come l’oggetto di analisi di un filone in larga misura
nuovo affermatosi contestualmente alla prospettiva interpretativa ed etnografica e ad
essa ispirato. Come vedremo meglio sotto, alla nascita di questo nuovo ambito di ricerca
hanno concorso ragioni interne legate appunto all’evoluzione dei metodi e delle
prospettive di analisi dello studio culturalista delle disuguaglianze educative non meno
di ragioni esterne legate alle trasformazioni dei sistemi di istruzione. In particolare, da
61
un lato, la generale «apertura» della scuola alla «collaborazione» o «partnership» con le
famiglie e le comunità locali, che a partire dagli anni Settanta è diventata la parola
d’ordine delle riforme dei sistemi di istruzione avviate in molti Paesi (cfr. su questo
tema l’intera sezione dedicata della bibliografia). Dall’altro, l’applicazione ancora
potenziata di questo principio di coinvolgimento delle famiglie e delle comunità alle
politiche educative riservate alle scuole delle zone urbane «sensibili». E non è un caso
infatti che questo settore di ricerca abbia prodotto per lo più studi di caso dei rapporti tra
scuola, famiglia e comunità locale in quartieri popolari urbani e/o abitati da minoranze
etniche.11
Mi pare infine che sia possibile isolare ancora una terza, seppure meno definita,
direzione di evoluzione maggiore che i temi di indagine del periodo classico hanno
imboccato negli ultimi due decenni. Questa direzione può essere considerata uno
sviluppo – o più esattamente, un arricchimento, che si colloca accanto alla vecchia
impostazione – di quello che potremmo definire il filone cognitivista12 classico relativo
tanto agli stili cognitivi e linguistici familiari quanto alle rappresentazioni educative
implicite dei genitori. Quest’ultimo filone, come è stato anticipato e come vedremo
meglio tra poco, si è occupato prevalentemente delle forme dell’interazione didattica in
senso lato – cioè concepita o meno come tale dagli attori: dagli scambi verbali e da
«come le madri insegnano ai loro bambini» (Pourtois 1979) in situazioni quotidiane, al
gioco, a vere e proprie attività parascolari come la lettura e la sollecitazione linguistica e
intellettiva deliberata – che ha luogo tra genitori e bambini soprattutto in età prescolare.
Direttamente o indirettamente, l’esplorazione di queste modalità interazione era
finalizzata a studiarne le conseguenze sullo sviluppo cognitivo e linguistico e sul
successivo adattamento scolastico del bambino. Un terzo momento logico dell’analisi,
che poteva integrare gli altri due o più spesso costituire un oggetto di ricerca autonomo,
era l’esplorazione delle teorie implicite di questo sviluppo che in qualche modo stavano
dietro all’azione dei genitori.
In altri termini, il filone cognitivista classico si occupava di come i genitori di
bambini per lo più non ancora scolarizzati (o ancora alla scuola dell’infanzia)
concepissero – e mettessero in pratica le loro concezioni di – «il mestiere di bambino»
(Chamboredon e Prévot 1973) e «il mestiere di genitore di bambino», o, per riprendere
le parole di una delle prime ricerche sull’argomento, delle loro «concezioni di “una
brava madre” e di “un bravo bambino”» (Duvall 1946). Recentemente, anche questo
campo di indagine, come quello dell’educazione familiare, si è evoluto nella direzione
62
di una presa in conto di fasce di età più avanzate e quindi dell’esperienza della
scolarizzazione. E accanto allo studio dell’interazione prescolare tra genitori e figli, a
dire il vero un dominio attualmente quasi completamente monopolizzato dalla
psicologia dello sviluppo,13 si sta sviluppando – questa volta soprattutto nell’ambito
della sociologia, dell’antropologia e delle scienze dell’educazione14 – un’altra direzione
di ricerca centrata in modo diretto sul rapporto epistemologico con i saperi e
l’apprendimento scolastico. Da un lato, gli studi delle situazioni prescolari non si
occupano tanto di come questo rapporto venga forgiato in generale dagli stili
interazionali e linguistici della prima educazione familiare, quanto, più precisamente,
delle forme del rapporto domestico con la parola scritta che facilitano o ostacolano
l’apprendimento della lettura e della scrittura. Dall’altro, gli studi delle fasce di età più
avanzate, e scolarizzate, si occupano di come questo rapporto con i saperi e
l’apprendimento scolastico, una volta costituitosi, funzioni concretamente nel corso
della scolarità. In primo luogo, su come esso funziona nell’esperienza scolastica
quotidiana degli studenti stessi. In secondo luogo, su come questo rapporto funziona nei
genitori, i quali, specie nei primi anni di scolarizzazione dei figli, nella loro attività
quotidiana di accompagnamento alla scolarità mettono continuamente in pratica una
serie di concezioni implicite relative al «mestiere di studente» e al «mestiere di genitore
di studente». Molto spesso, analisi più o meno fini del rapporto epistemologico
familiare con i saperi e l’apprendimento scolastico si trovano integrate negli studi di
caso del rapporto quotidiano delle famiglie dei ceti popolari e/o delle minoranze etniche
con l’esperienza della scolarizzazione dei figli – vale a dire nella seconda direzione di
ricerca nuova a cui si è accennato sopra. Nello stesso tempo, queste analisi costituiscono
l’oggetto anche di un corpus parallelo di ricerche più specializzate circoscritte
all’esplorazione di questo solo aspetto del rapporto tra le famiglie e la scuola.
Quella che è stata appena tracciata è una mappatura, scheletrica e generalissima,
dei territori da cui principalmente provengono a volte gli stimoli a volte i veri e propri
indirizzamenti che hanno nutrito questo lavoro, e al cui interno ci muoveremo, quindi,
in questo capitolo. Letta congiuntamente alle osservazioni sul cambio di prospettiva
analitica fatte sopra, dovrebbe costituire in particolare un disegno della struttura
essenziale del campo degli studi culturalisti delle disuguaglianze educative in due
momenti successivi della sua storia. Che metta in risalto, soprattutto, le continuità e le
discontinuità essenziali tra le due istantanee. Detto questo, vanno aggiunte
immediatamente una serie di avvertenze, o istruzioni per l’uso. La prima è che la
63
mappatura proposta è il frutto di selezioni e raggruppamenti altamente idiosincratici.
Per riprendere il titolo di questo paragrafo, è una delle tante possibili. E questo non solo
perché, come è stato detto, trascura deliberatamente una intera porzione del campo
occupata dalle analisi delle responsabilità scolastiche nella genesi delle disuguaglianze
educative per concentrarsi sui soli studi delle culture di ceto. Ma perché, e in modo più
essenziale, nel ricostruire il campo degli studi culturalisti delle disuguaglianze educative
centrati sulle culture di ceto l’idiosincrasia è una necessità inevitabile prima ancora che
una scelta deliberata. Le radici multidisciplinari, la forte disomogeneità della qualità,
rilevanza e visibilità della produzione, e la difficile cumulatività dei risultati, lo abbiamo
visto, concorrono tutte a quella immagine di frammentarietà estrema che, quasi come in
una inversione retorica, finisce per costituire il marchio distintivo di questo settore.
Quando non ha ostacolato addirittura la percezione dell’unità del suo oggetto di studio e
quindi della sua esistenza stessa come campo di ricerca, questa frammentarietà ha
certamente contribuito ad impedire la costruzione di un canone condiviso e
riconoscibile che andasse oltre un elenco ridotto all’osso di nomi della levatura di
Bourdieu e Bernstein. Una mancanza cronica di accordo sui confini interni ed esterni
del campo della quale, del resto, ci si può rendere conto molto facilmente consultando
un qualsiasi campione – casualmente costruito – di manuali, storie, rassegne, e
soprattutto antologie, storiche o contemporanee, di sociologia dell’educazione. Dove,
appunto, Bourdieu e Bernstein costituiscono forse le uniche «invarianti» sempre
presenti di un panorama continuamente mutevole.
La seconda istruzione per l’uso della mappa del campo del rapporto tra le culture
di ceto e la sfera dell’istruzione qui proposta è che la classificazione dei vari ambiti di
ricerca è una distinzione analitica molto più che lo specchio della divisione concreta
del lavoro dei ricercatori. In altre parole, i grandi temi di studio che sono stati isolati,
tanto per il periodo classico quanto per quello recente, si trovano spesso a coesistere non
solo negli stessi ricercatori e nelle stesse ricerche, ma anche, come tasselli logici, nelle
stesse analisi e nelle stesse spiegazioni teoriche. E il motivo ovvio di ciò è che, pure
analiticamente distinguibili, è fin troppo evidente come i temi individuati riguardino
dimensioni di una cultura che sono tra loro strettissimamente interconnesse – e proprio
sulle cui connessioni si sono infatti concentrate le analisi migliori. È questo soprattutto
il caso, come vedremo, del rapporto tra il tema dei valori educativi e delle teorie
genitoriali implicite dello sviluppo e dell’educazione. Ma anche certamente del rapporto
64
di entrambi con le pratiche educative. O del rapporto tra i valori educativi e i valori
della riuscita sociale. E così via.
Infine, ed è questa la terza avvertenza all’uso della mappa che è stata disegnata e
del percorso che seguirà tra breve, solo una parte delle analisi teoriche ed empiriche che
verranno toccate da questo percorso affronta in modo diretto la questione delle
disuguaglianze di fronte all’istruzione. O, più esattamente, mette in relazione diretta le
dimensioni delle culture familiari di ceto esplorate con la riuscita nel sistema
dell’istruzione (nelle ricerche del periodo classico più vecchie, in particolare statunitensi
e in particolare provenienti dal territorio della psicologia sociale, non è affatto
infrequente che tale indicatore sia sostituito dal quoziente di intelligenza). Questo è vero
soprattutto per la grande area di studio delle pratiche e dei valori dell’educazione
familiare. A proposito della quale è anzi possibile affermare che le riflessioni più
elaborate e interessanti provengano proprio da quelle ricerche che si sono sforzate di
illuminare il nesso tra particolari stili educativi e particolari appartenenze di ceto
piuttosto che da quelle che si sono concentrate sul legame tra i primi e la riuscita
scolastica. Poiché l’educazione familiare è anche una delle prime dimensioni delle
culture di ceto in assoluto ad aver ricevuto l’attenzione dei ricercatori, è proprio da
questo ambito di ricerca che inizieremo il percorso attraverso quella che sopra ho
definito la storia della presenza della cultura dei ceti popolari negli studi sulle
disuguaglianze educative.
2.2 Lo sguardo «oggettivistico» classico: Educazione familiare, valori e aspirazioni, stili
cognitivi e linguistici
2.2.1 Le pratiche, le concezioni e i valori dell’educazione familiare
Se, come ho sottolineato più volte, il campo di studio culturalista delle
disuguaglianze educative si distingue per la sua eterogeneità e frammentarietà, al suo
interno è senza alcun dubbio l’ambito di ricerca sul rapporto tra culture di ceto e modi
di educazione familiare quello nel quale tali caratteri sono presenti al massimo grado.
Al di là del pluralismo disciplinare costitutivo di questo settore, in esso è stata
soprattutto una frammentazione tematica spesso irrelata alle appartenenze disciplinari
unita a una prevalenza netta di approcci fortemente empiristi sui tentativi di
sistematizzazione teorica ad avere reso particolarmente difficile la cumulatività di saperi
65
nella completezza di una visione d’insieme. Le pratiche di puericultura della primissima
infanzia e le pratiche propriamente educative dell’infanzia e dell’adolescenza; le
concezioni genitoriali del fine dell’educazione familiare e dell’ideale di bambino; il
rapporto tra la concezione che i genitori hanno del proprio ruolo e i modi in cui la
mettono in pratica; il rapporto tra i valori educativi e gli orientamenti di valore più
generali, e il rapporto di entrambi con le condizioni materiali di vita di vita della
famiglia e la posizione professionale dei genitori; infine, il rapporto tra gli stili educativi
familiari e lo sviluppo dell’orientamento alla riuscita scolastica e sociale. Senza alcuna
pretesa di esaustività, sono questi alcuni dei temi forti che – isolatamente o più spesso in
collegamento tra loro – hanno caratterizzato i primi quarant’anni di riflessioni sul
legame tra le culture di ceto e i modi di educazione familiare.
A rischio di semplificare brutalmente, potremmo dire che l’avvio di questo
quarantennio è stato segnato dall’acquisizione quasi immediata di alcuni risultati
empirici forti che hanno delimitato le direzioni entro le quale si è svolta gran parte della
ricerca degli anni successivi. Queste acquisizioni hanno riguardato in particolare la
sociologia e la psicologia statunitensi degli anni Quaranta, nelle quali lo studio del
rapporto tra ceto ed educazione familiare era stato inaugurato. E lo era stato soprattutto
con due temi di indagine. Quello che allora suscitava i dibattiti più vivaci riguardava
l’analisi del rapporto tra appartenenza di ceto e grado di severità delle pratiche
educative materne, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla puericultura
della primissima infanzia (e dunque a pratiche quali allattamento, svezzamento,
manipolazione del neonato, educazione sfinteriale). L’altro, a metà tra lo studio dei
valori educativi e delle concezioni educative implicite, riguardava la variabilità tra i ceti
dell’immagine del bambino e del genitore ideali, ovvero dei tratti infantili ritenuti
desiderabili e delle concezioni del ruolo genitoriale, in particolare del ruolo materno. La
questione delle pratiche educative e quella dei valori e delle rappresentazioni educative
si erano quindi presentate inizialmente in gran parte separate all’attenzione dei
ricercatori.
La prima questione era soprattutto dibattuta perché per più di un decennio l’unico
dato forte acquisito delle ricerche è stato che queste ricerche presentavano dei risultati
contraddittori (per una sintesi, cfr. Bronfenbrenner 1958 e Sewell 1961). In breve, gli
studi condotti fino a tutta la prima metà degli anni Quaranta (cfr. per esempio Ericson
1946 ma soprattutto il più noto, l’«inchiesta di Chicago» di Davis e Havighurst 1946) si
accordavano nel rilevare una maggiore costrittività dello stile educativo delle madri del
66
ceto medio rispetto a quello delle madri del ceto popolare. Questo risultato venne
ribaltato dalle ricerche condotte negli anni successivi (cfr. in particolare l’«inchiesta di
Boston» di Maccoby e Gibbs 1954).15 Scoppiò così, nel corso degli anni Cinquanta, una
vivace polemica sull’interpretazione di questa contraddizione, con gli autori delle prime
ricerche che sostenevano la non comparabilità dei dati (cfr. il ritorno sui dati fatto da
Havighurst e Davis 1955), e i sostenitori dei risultati successivi che mettevano in dubbio
la correttezza dell’interpretazione dei dati delle prime ricerche (cfr. in particolare Sears,
Maccoby e Levin 1957). Questa polemica stimolò naturalmente anche la produzione di
altre indagini che sembrarono tutte confermare il risultato più recente, vale a dire la
maggiore severità dello stile educativo del ceto popolare rispetto a quello del ceto medio
(cfr. tra gli altri Sturm White 1957; Littman, Moore e Pierce-Jones 1957).
Nel 1958, Urie Bronfenbrenner pubblicò una celebre rassegna di questa messe di
studi nella quale rianalizzò molti dei dati cercando di renderli maggiormente
comparabili e soprattutto propose finalmente una interpretazione della contraddizione
dei risultati che mise fine alla polemica. In breve, Bronfenbrenner concluse che
l’insieme dei dati metteva in luce una tendenza generale e di lungo periodo all’aumento
della permissività delle pratiche educative, e che questa tendenza era coerente con
l’evoluzione dei saperi e delle norme «legittime» in materia di tecniche di puericultura e
di pratiche educative (cfr. su questa evoluzione anche Haber 1962; Leslie e Johnsen
1963; e soprattutto Baumrind 1966).16 I risultati contraddittori sulla maggiore o minore
presenza di questa tendenza al permissivismo nei diversi ceti erano spiegati, secondo
Bronfenbrenner, dalla rapidità ineguale della diffusione delle nuove norme educative
«legittime» lungo la scala sociale (per una analisi analoga cfr. la ricerca di Boltanski
1969; sul tema della esposizione differenziale ai saperi di puericultura «legittimi» cfr.
per esempio anche Boek, Sussman e Yankauer 1958; Newson e Newson 1963).17 I
genitori di ceto medio avrebbero cioè adottato per primi le nuove tecniche, più
permissive, laddove nello stesso tempo i genitori di ceto popolare, condividendo gli
stessi valori educativi del ceto medio e proprio allo scopo di realizzarli, avrebbero avuto
la tendenza ad adottare le tecniche diffuse nel ceto medio nel periodo precedente. Nelle
belle parole di Bronfenbrenner:
Nella moderna classe operaia, forse c’è una maggiore libertà di
espressione emotiva, ma non c’è incertezza o indecisione per quanto
riguarda la meta da raggiungere nell’educazione dei figli.
Costantemente, negli ultimi venticinque anni, i genitori della classe
operaia hanno insistito su quelle che generalmente sono considerate
67
virtù della classe media: ordine, conformismo e auto-controllo. I loro
metodi non sono forse così efficaci come quelli dei genitori di classe
media, e sono forse più disperati. Forse questa stessa disperazione, a
cui si aggiunge una esposizione precoce a comportamenti impulsivi e
aggressivi, porta i genitori della classe operaia a perseguire mete
nuove con tecniche vecchie. Essi accettano i livelli di aspirazioni della
classe media, ma non hanno ancora interiorizzato sufficientemente i
meccanismi di risposta che rendono realizzabili questi livelli per loro e
per i loro figli. Devono ancora imparare ad aspettare, a spiegare, e a
dare e a rifiutare il proprio affetto come un premio o una ricompensa.
(Bronfenbrenner 1958, tr. it. pp. 45-46, sottolineatura mia)18
L’interesse di questa analisi di Bronfenbrenner trascende di molto la sua portata
contestuale di interpretazione definitiva dei primi vent’anni di ricerche sulle pratiche di
educazione familiare. Esso risiede soprattutto nel fatto di essere stata una delle prime
riflessioni sul tema ad avere focalizzato l’attenzione sulla complessità delle dinamiche
del rapporto tra le pratiche educative familiari da un lato, e i valori e le rappresentazioni
educative implicite dall’altro. Portando alla luce, riguardo ai ceti medi, un caso di
mutamento nelle pratiche educative avvenuto senza un corrispondente mutamento nei
valori educativi, e, per i ceti popolari, una mancanza di sincronizzazione temporale della
trasformazione di valori e pratiche, Bronfenbrenner ha in particolare messo in
discussione l’assunto di corrispondenza tra pratiche e valori – o meglio, di
identificazione tra certe pratiche e certi valori – che informa spesso allo stato implicito
molta della letteratura sull’educazione familiare dell’epoca (e non solo). E porta questa
letteratura a «usare il comportamento materno in un’area dell’allevamento dei bambini
per indicare l’orientamento materno generale» e alla «generalizzazione dalle pratiche di
cura dei neonati all’educazione dei bambini in generale e ai tratti di personalità
desiderabili nei bambini» (Leslie e Johnsen 1963, p. 919). Insomma, ad interpretare le
pratiche educative come l’espressione pura e semplice di valori e trascurare in questo
modo di considerare quella che gli stessi Leslie e Johnsen definiscono parsonsianamente
la possibilità di una «incoerenza tra la concezione e l’esecuzione del proprio ruolo»
(ibidem) da parte dei genitori. O, il che è lo stesso, la possibilità che pratiche educative
diverse in gruppi sociali diversi non siano l’espressione di orientamenti di valore
differenti, ma siano tecniche diverse – magari più o meno efficaci – al servizio degli
stessi valori. Come vedremo anche in questa ricerca, questa cautela analitica si rivela
essenziale proprio nell’analisi delle pratiche di socializzazione delle famiglie dei ceti
popolari, specie di quelle legate direttamente alla scolarità. Queste pratiche, spesso
pedagogicamente «eterodosse», inefficaci o controproducenti dal punto di vista
68
dell’adattamento e dalla riuscita scolastica, possono certo riflettere una diversità nel
valore attribuito all’istruzione (quindi, nel grado di interesse e investimento per la
scolarità dei figli), ma possono anche essere semplicemente il prodotto di una diversità
nella familiarità con l’universo simbolico scolastico e i suoi saperi (nelle modalità,
diversamente efficaci, di tale investimento).19
Il tema dei valori educativi e delle concezioni del genitore e del bambino ideali è
il secondo oggetto di indagine con il quale negli Stati Uniti degli anni Quaranta è stato
inaugurato lo studio del rapporto tra culture di ceto ed educazione familiare. Come
anticipato, la tendenza iniziale fu quella di esplorarlo in modo indipendente dall’analisi
delle pratiche, e solo in un secondo momento i due temi iniziarono ad essere messi
sistematicamente in relazione (cfr. Leslie e Johnsen 1963). In questo ambito, fin dalle
prime ricerche emerse un dato forte che, in forme più o meno elaborate, nei quattro
decenni a venire sarebbe stato riconfermato pressoché all’unanimità dalle indagini
successive (non ultimo, nella forma probabilmente più elaborata per eccellenza, dalle
ricerche di Bernstein), diventando, almeno per il periodo classico, uno dei (pochi)
risultati acquisiti di questo ambito di ricerca.
Una delle primissime formulazioni di questo dato è quella offerta da Evelyn
Duvall nel 1946, in un articolo seminale dedicato alle variazioni tra i ceti nelle
«concezioni della genitorialità» delle madri (Duvall 1946). Sulla base delle risposte
aperte date da un campione di madri alle due domande su «le cinque cose che fa una
brava madre» e «le cinque cose che fa un bravo bambino», Duvall identifica due
concezioni – e aspettative – di ruolo di madre e bambino distinte e soprattutto
inegualmente diffuse tra i ceti: quella che ella definisce «la concezione tradizionale»
prevalente tra le madri di ceto popolare e «la concezione evolutiva» delle madri di ceto
medio. Così, se il bravo bambino dei ceti popolari è quello che soprattutto «si mantiene
pulito e ordinato», «obbedisce e rispetta gli adulti», ed «ha un buon carattere, è onesto,
affidabile, educato, gentile, cortese», insomma «fa piacere ai grandi», il bravo bambino
dei ceti medi è quello che cresce «felice e contento» ed «emotivamente equilibrato»,
«ha fiducia nei suoi genitori», «è avido di imparare», «mostra iniziativa», «esprime se
stesso» e «cresce come persona» (ivi, pp. 195-196). La madre ideale, nel primo caso,
«tiene in ordine la casa» e «accudisce il bambino fisicamente», «stabilisce abitudini
regolari» e lo «abitua alla regolarità», «mantiene la disciplina» e «rende il bambino
buono», cioè gli «insegna l’obbedienza» e lo «istruisce sulla morale». Nel secondo caso,
ella soprattutto gli «insegna ad avere fiducia in se stesso» e ne «incoraggia
69
l’indipendenza», «è attenta al suo benessere emotivo», «lo aiuta a svilupparsi
socialmente», «provvede alla sua crescita intellettuale» e «lo guida con comprensione
tenendo conto delle sue opinioni» (ivi, p. 195). In breve, nel modello tradizionale di
Duvall «i ruoli sono concepiti in modo rigido», laddove il modello evolutivo «è
caratterizzato da aspettative riguardo alla madre e al bambino in termini di crescita e
sviluppo piuttosto che in termini di conformità a comportamenti specifici (le concezioni
di ruolo sono dinamiche e flessibili)» (Duvall 1946, p. 195):20
[Le rappresentazioni] evolutive sono caratterizzate da concetti come il
rispetto per la persona (sia essa un bambino o un adulto), una
immagine piacevole dell’interazione personale, l’orgoglio per la
crescita e lo sviluppo, e una modalità di guida del bambino che è
permissiva e volta a stimolarne lo sviluppo, nel senso che è opposta ai
tentativi più tradizionali di «rendere» i bambini conformi al modello
di bambino pulito e ordinato, obbediente e rispettoso, educato e
socialmente accettabile.
(ivi, p. 203)
Si potrebbe a questo punto obiettare certamente a ragione che ci sono solidi indizi
per sospettare sull’appropriatezza metodologica del percorso che ha condotto Duvall a
questi risultati, e che i risultati stessi vadano quindi accolti con riserva. Abbiamo visto
infatti che i tratti caratteristici dei due modelli di ruolo sono stati ricavati attraverso la
codifica di risposte a domande aperte che sollecitavano giudizi normativi molto astratti
su «una brava madre» in generale e «un bravo bambino» altrettanto in generale. Quindi,
attraverso due operazioni di raccolta e trattamento dei dati – la sollecitazione libera
nell’intervistato di giudizi astratti e la codifica successiva delle risposte – non certo
ottimali quando si abbia a che fare, come in questo caso, con intervistati di ceto basso (e
a maggior ragione quando questi ultimi siano confrontati con una parte del campione di
ceto più elevato). Se l’opportunità di indagare gli orientamenti di valore in un modo così
diretto è già di per sé discutibile quale che sia l’estrazione sociale dei soggetti studiati,
come ben ci ricorda Bernstein, «il più grande svantaggio dell’uso di un public language
è precisamente una difficoltà nella generalizzazione formale» (Bernstein 1961, p. 305):
ovvero, l’astrazione ha molta poca cittadinanza nelle abitudini tanto di comunicazione
quanto di pensiero dei ceti inferiori. Ed è quindi forse da imputare anche a questo – più
o almeno oltre che a diversità così marcate nelle «concezioni della genitorialità» – il
fatto che la parola libera delle madri di ceto popolare abbia evocato soprattutto
immagini concrete come la pulizia, la regolarità, la cortesia, l’obbedienza, o concetti
70
astratti di uso altamente convenzionale come la moralità. Anziché riferirsi a cose come
il benessere emotivo, la fiducia in se stesso o la capacità di iniziativa, per non parlare
del concetto di espressione di sé e di quello di crescita della personalità individuale.
Certo bisognerebbe poter avere accesso ai testi delle interviste e alle procedure di
codifica (per vedere, per esempio, in quale misura questa codifica sia stata una vera e
propria traduzione, e quanto fedele, di elementi simbolici da un sistema significante a
un altro)21, ma il dubbio resta. Il motivo per il quale ai risultati della ricerca di Duvall è
stato comunque dedicato qui questo spazio risiede, come già accennato, nella loro
qualità di campione rappresentativo – e prototipico. Questi risultati, lo abbiamo visto,
identificano l’essenza della differenza tra i valori e le rappresentazioni educative dei
genitori di ceto popolare e medio nell’opposizione tra, rispettivamente, la
valorizzazione delle proprietà del conformismo e la valorizzazione delle proprietà
dell’autodirezione. In forme diverse, pressoché tutte le indagini successive sul tema
condotte nel periodo classico concorderanno nell’indicare proprio in questa polarità di
fondo il nocciolo della divergenza tra i due sistemi di valori e concezioni educative.22 E
di questa polarità si sforzeranno in particolare di identificare, in due linee di indagine in
gran parte distinte, le cause e gli effetti.
Una prima direzione di ricerca importante ha infatti focalizzato l’attenzione
soprattutto sul nesso di causalità che lega il sistema di valori e concezioni educative
proprie di un ceto alle condizioni di vita che i membri di quel ceto sperimentano in virtù
della loro posizione nella struttura sociale – e, segnatamente, che lega la valorizzazione
delle proprietà del conformismo alle condizioni di vita dei ceti popolari. Come
vedremo, è stato per lo più con spiegazioni di natura funzionalistica che questo nesso è
stato illuminato. Banalmente, e in termini molto generali, si è teso a sostenere che
l’esperienza dei membri del ceto medio e quella dei membri del ceto popolare fossero
caratterizzate da due tipi ben distinti di strutture delle relazioni sociali – tanto, per
alcune ricerche (come quelle di Bernstein), nei rapporti interni al ceto, quanto, per altre
ricerche (come quelle di Kohn e McKinley), nei rapporti che i membri di questi ceti
sperimentavano con il resto della società. E che le proprietà dell’individuo e le finalità
dell’educazione familiare valorizzate nei due ceti fossero semplicemente quelle che si
rivelavano maggiormente adatte, ovvero funzionali, alla forma delle relazioni sociali
che i loro membri sarebbero stati soprattutto chiamati a sperimentare. Una seconda
direzione di ricerca ha invece esplorato soprattutto ciò che stava a valle dei questa
diversità nei valori e nelle rappresentazioni educative tra i ceti: la loro espressione nelle
71
pratiche educative e/o i loro effetti nel profilo di personalità che concorrevano a
formare nei bambini. Per indagare poi il grado di coerenza di questo profilo di
personalità con quello richiesto nelle istituzioni di istruzione formale, sotto l’angolo
delle proprietà «intellettuali» (lo sviluppo intellettuale e gli stili cognitivi e linguistici)
come sotto quello delle proprietà «morali» (tra le quali in particolare il grado di
autoregolazione e il grado di interiorizzazione del «bisogno di riuscita»).
Un posto di primissimo piano tra quanti nel periodo classico si sono occupati
dello studio dei valori educativi di ceto spetta senza alcun dubbio a Melvin Kohn (per
una sintesi efficace delle sue tesi principali, cfr. in particolare Kohn 1963; cfr. anche
Kohn 1959a, 1959b, 1969; Kohn e Carroll 1960; Pearlin e Kohn 1966; Kohn e Schooler
1969). L’importante riflessione che Kohn ha dedicato «ai valori o agli scopi che i
genitori hanno per i loro figli» (Kohn 1969, p. 12) nel corso degli anni Sessanta e
Settanta include entrambe le direzioni di ricerca delineate sopra, il nesso tra la posizione
nella struttura sociale e i valori educativi, e quello tra questi ultimi e le pratiche
educative, come sottolinea lo stesso Kohn che riassume così il suo programma di
ricerca:
Nella mia prospettiva di sociologo io pensavo che i principali effetti
causati dalla struttura sociale sul comportamento avessero luogo
attraverso i valori: cioè che la classe sociale influirebbe sui valori dei
genitori e che i valori di questi, a loro volta, influirebbero
significativamente sul comportamento dei genitori nei confronti dei
figli.
(ivi, p. 13)
In termini estremamente sintetici, la prima tappa logica di questo programma è
l’identificazione di quello che secondo Kohn costituisce l’elemento mediatore tra la
posizione di classe e i modi di socializzazione familiare – o, nelle sue parole, «il ponte
tra la struttura sociale e il comportamento» (Kohn 1963, p. 471). Sotto l’influenza di
Kluckohohn, Kohn li definisce «concezioni di ciò che è desiderabile – cioè, valori»
(ibidem; cfr. anche 1959a, pp. 338-339), ma, come già nel caso della ricerca di Duvall, a
me pare che ciò a cui egli si riferisce sia in realtà a un insieme di valori, assunti
educativi impliciti e attese di ruolo. Un insieme in cui, in altri termini, la dimensione
propriamente normativa e la dimensione cognitiva spesso sono difficilmente
distinguibili.23 Come anticipato, la diversità nei «valori parentali» connessa
all’appartenenza di ceto che Kohn identifica è in tutto analoga a quella che seppure in
72
forma più rozza aveva già messo in luce Duvall. Come osserva peraltro lo stesso Kohn,
il quale scrive:
La nostra ricerca, condotta nel 1956-57, fornisce i dati più
direttamente paragonabili a quelli di Duvall. Anche noi abbiamo
rilevato che i genitori di classe operaia valorizzano l’obbedienza,
l’ordine e la pulizia molto di più di quanto facciano i genitori di classe
media, e che i genitori di classe media a loro volta valorizzano la
curiosità, la felicità, il rispetto e – soprattutto – l’autocontrollo molto
più dei genitori di classe operaia. Abbiamo rilevato inoltre che le
scelte di valori si raggruppano in modo omogeneo per le due classi: il
centro dei valori dei genitori di classe operaia è la conformità alle
prescrizioni esterne, quello dei genitori di classe media è
l’autodirezione. Per i genitori di classe operaia, è l’atto manifesto che
è importante: il bambino non deve trasgredire le regole imposte
dall’esterno; per i genitori di classe media, ad essere importanti sono
le motivazioni e i sentimenti del bambino: il bambino deve dominare
se stesso.
(Kohn 1963, p. 475) 24
Conformità e autodirezione (o, in una precedente formulazione, rispettabilità e
interiorizzazione delle norme di condotta: cfr. Kohn 1959a) sono dunque, anche per
Kohn, il «centro dei valori» educativi – o, come direbbe in termini più cognitivi
Bourdieu, la «formula generatrice» – dei modi di socializzazione del ceto popolare e del
ceto medio. Riguardo alla maniera in cui questa formula, appunto, «genera» i modi di
socializzazione, ovvero questi sistemi di valori si manifestano nelle pratiche educative,
Kohn ha inizialmente focalizzato la sua attenzione soprattutto sulle forme di esercizio
dell’autorità familiare (cfr. Kohn 1959b). Non per interessarsi semplicemente, come le
ricerche di cui si è occupato Bronfenbrenner che abbiamo discusso sopra, alle tecniche
di disciplina più utilizzate dai genitori delle due classi, ma in primo luogo per portare
alla luce i tipi di comportamenti del bambino che sollecitano nei genitori il ricorso a
pratiche di disciplina: «la questione cruciale non è quale metodo di disciplina i genitori
preferiscano, ma quando e perché usano un metodo di disciplina piuttosto che un altro»
(Kohn 1963, p. 478). La conclusione alla quale Kohn giunge a questo proposito è in
particolare che
le condizioni nelle quali [i genitori] puniscono i loro figli fisicamente,
o si astengono dal farlo, appaiono essere piuttosto diverse per le due
classi sociali. I genitori di classe operaia hanno maggiori probabilità di
reagire sulla base delle conseguenze immediate delle azioni dei
73
bambini, i genitori di classe media sulla base della loro interpretazione
dell’intenzione che il bambino aveva nell’agire.
(Kohn 1959b, p. 364)
E, soprattutto, per Kohn queste «reazioni dei genitori di entrambe le classi ai
comportamenti indesiderati dei figli sono completamente appropriate per i loro valori»
(ivi, p. 365):
Per i genitori di classe operaia, l’«importante ma problematico» ruota
attorno a qualità che assicurino la rispettabilità; per i genitori di classe
media, attorno alle norme di condotta interiorizzate. Nel primo caso, il
comportamento desiderabile consiste essenzialmente nel non violare
le prescrizioni; nel secondo, esso consiste nell’agire in accordo ai
dettami dei propri principi. Qui l’atto diventa meno importante
dell’intenzione dell’attore. [...] Dire che i genitori di classe operaia
sono particolarmente reattivi alle conseguenze e particolarmente
indifferenti all’intenzione equivale a dire che i loro sforzi sono diretti
ad ammonire atti disobbedienti, sconvenienti. Dire che i genitori di
classe media si preoccupano maggiormente dell’intenzione equivale a
dire che i loro sforzi sono diretti ad incoraggiare i bambini a
sviluppare norme di condotta interiorizzate e ad agire sulla base di
queste norme piuttosto che sulla base di regole imposte dall’esterno.
(Kohn 1959b, pp. 364-365)
La parte più ambiziosa e originale della riflessione di Kohn è però il terzo
momento logico del suo programma di ricerca: identificare attraverso quale meccanismo
l’appartenenza a una classe sociale influisca sulla formazione dei valori educativi
genitoriali. Come è piuttosto noto, Kohn ritiene che questo meccanismo vada cercato
soprattutto nelle diverse condizioni professionali dei membri delle due classi, e in
particolare nel diverso grado di autodirezione professionale richiesto dai lavori tipici del
ceto medio e del ceto popolare (cfr. Leonard, Pearlin e Kohn 1966; Kohn e Schooler
1969; Kohn 1966a). Se, scrive infatti Kohn, «con ogni probabilità il rapporto tra classe
sociale e valori parentali deriva dall’intero complesso delle condizioni di vita
caratteristiche delle varie classi sociali», «la nostra ipotesi è che le più importanti di
queste molte condizioni siano le condizioni professionali che nel lavoro stimolano o
inibiscono l’esercizio dell’autodirezione» (Kohn 1969, p. 146), cioè «l’uso, nell’ambito
del lavoro, dell’iniziativa, del pensiero, e dell’indipendenza di giudizio» (ivi, p. 144). In
particolare,
le occupazioni di classe media richiedono un più grande grado di
autodirezione; le occupazioni di classe operaia, in larga misura,
74
richiedono che si seguano delle regole esplicite stabilite da una
qualche autorità. Ovviamente, queste differenze corrispondono a
quelle che abbiamo trovato tra le due classi sociali nelle caratteristiche
dei figli che sono valorizzate dai genitori.
(Kohn 1963, p. 476)25
Constatare l’esistenza di questa «corrispondenza» e ipotizzare che essa sia il prodotto di
un rapporto di causalità tra le condizioni professionali e i valori educativi, aggiunge
infine Kohn,
non equivale ad assumere che i genitori insegnino consapevolmente ai
propri figli a soddisfare le future richieste professionali; può essere
semplicemente che le loro esperienze occupazionali abbiano
influenzato in maniera significativa le concezioni genitoriali di quello
che è un comportamento desiderabile, sul lavoro o lontano dal lavoro,
per gli adulti o per i bambini.
(ibidem)26
2.2.2 Gli stili cognitivi e linguistici dell’educazione familiare
Prendendo le mosse da un interesse per l’analisi dei valori educativi familiari di
ceto, considerati l’elemento di mediazione essenziale tra la posizione sociale e i modi di
socializzazione familiare, la riflessione di Kohn arriva così a costruire una catena
causale complessa. Una catena di imputazione che va dalle condizioni professionali ai
valori educativi dei genitori, e da questi ultimi alle loro pratiche di educazione.
Soprattutto, una catena nella quale, alla fine, l’influenza della condizione sociale (qui
esemplificata dalla condizione professionale) sui modi di socializzazione familiare
sembra passare attraverso modi diversi di percepire la realtà più – o prima – che da
modi diversi di valutare questa realtà. O, in altri termini, da qualcosa di molto simile ad
una diversità di stili di percezione, o stili cognitivi, più o prima che da semplici
orientamenti di valore. Ma, se questa interpretazione è esatta – cioè se, come Kohn
sembra infine suggerire pur senza esplicitarlo, le condizioni di esistenza agiscono prima
e in modo diretto a livello cognitivo – allora altri tipi di nessi logici tra i tre elementi
delle condizioni di esistenza, dei valori educativi e delle pratiche educative oltre a
quello ipotizzato da Kohn appaiono essere ugualmente plausibili. In primo luogo,
potrebbe darsi che valori e pratiche non siano in un rapporto di determinazione tra loro
ma dipendano entrambi da un causa comune, i modi di percezione della realtà prodotti
dalle condizioni di esistenza, appunto. Potrebbe anche darsi che il rapporto di
75
determinazione tra valori e pratiche esista ma nella direzione di causalità inversa
rispetto a quella ipotizzata da Kohn: che cioè i modi di sperimentare la realtà prodotti
dalle condizioni di esistenza si traducano in maniera diretta in pratiche di educazione, e
queste ultime influenzino l’elaborazione dei valori educativi e l’adesione ad essi.
Ovvero, «ci si potrebbe altrettanto bene immaginare i valori relativi all’educazione
come delle razionalizzazioni delle pratiche educative imposti dalle condizioni di
esistenza della cellula familiare» (Lautrey 1980, p. 154).
Vedremo ora come entrambe queste ipotesi alternative siano state esplorate e
proposte da altri due ricercatori che, proprio come Kohn, negli anni Sessanta e Settanta
si sono occupati dei rapporti tra condizioni di ceto, valori e pratiche educative, sebbene
da una prospettiva più esplicitamente attenta alla dimensione cognitiva di questi nessi:
Jacques Lautrey e Basil Bernstein. A differenza di Kohn che non si è mai interessato
agli effetti dei valori e delle pratiche educative di ceto sui profili di personalità – o
meglio, sulle disposizioni sociali – dei bambini e tanto meno agli effetti di questi ultimi
sull’adattamento scolastico, per Lautrey e Bernstein questi effetti sono al centro dei loro
interrogativi di ricerca. Classicamente, il punto di partenza della riflessione di Lautrey è
«chiedersi quale mediazione intervenga tra lo status socioeconomico dei genitori e
l’intelligenza dei loro bambini» (Lautrey 1980, p. 18), ovvero il proposito di individuare
il meccanismo che è all’origine della correlazione molto spesso osservata tra la riuscita
dei bambini nei test di intelligenza e le loro origini di ceto. Meno classicamente, è
piuttosto l’intento di rendere ragione delle «discrepanze tra potenziale e riuscita
effettiva dei bambini di classe operaia» (Bernstein 1958a, p. 159), cioè tra la loro
riuscita scolastica e il loro quoziente di intelligenza misurato da test non verbali, a
costituire lo stimolo iniziale del lavoro di Bernstein. Va aggiunto tuttavia che in questa
sede, e in relazione alla presente ricerca, l’interesse maggiore delle riflessioni di Lautrey
e Bernstein non risiede tanto nei legami che i due studiosi hanno tracciato tra le
subculture di ceto, la personalità e l’adattamento scolastico dei bambini, quanto sulle
loro analisi dei nessi tra i valori e le pratiche educative di tali subculture e le condizioni
di esistenza che le producono.
76
2.2.2.1 Strutturazione della vita familiare e stili educativi
La riflessione di Lautrey parte dall’«ipotesi che le condizioni di vita e di lavoro
legate allo status socioeconomico dei genitori determinino in una certa misura le loro
pratiche educative e che, a loro volta, queste ultime influenzino lo sviluppo intellettuale
del bambino» (Lautrey 1980, p. 18). In altri termini, è sul versante delle pratiche di
educazione che, secondo Lautrey, vanno cercate le variabili intermedie e i meccanismi
della correlazione tra l’origine di ceto familiare e lo sviluppo dell’intelligenza. Il
«quadro teorico di partenza, suscettibile di fondare una definizione delle pratiche
educative e di essere fonte di ipotesi relative ai loro effetti sullo sviluppo cognitivo»
(ivi, p. 19) gli viene suggerito in particolare dalla teoria dello sviluppo cognitivo
infantile di Piaget e dalla sua nozione di adattamento all’ambiente. È infatti nelle forme
di organizzazione dell’ambiente familiare che Lautrey identifica l’aspetto del «sistema
educativo familiare» (ivi, p. 160) passibile di condizionare lo sviluppo intellettivo del
bambino. La strutturazione dell’ambiente familiare, come egli la definisce, può essere
descritta come il modo in cui sono legati tra loro gli avvenimenti della vita quotidiana
della famiglia, quindi la forma generale dell’organizzazione della vita familiare che è
indipendente dai contenuti culturali sui quali questa organizzazione porta. È sulla base
di combinazioni differenti di stimoli (o perturbazioni) e regolarità (o equilibrio)
ambientali, entrambi indispensabili allo sviluppo cognitivo, che Lautrey distingue tre
tipi di strutturazione possibili dell’ambiente familiare.
La strutturazione rigida caratterizza un ambiente in cui le regolarità prevalgono
sugli stimoli: l’equilibrio tende cioè a non essere turbato da perturbazioni e gli
avvenimenti familiari tendono ad essere rigidamente programmati con scarse eccezioni.
Nelle parole di Lautrey, «la relazione che lega un avvenimento B a un avvenimento A in
questo tipo di ambiente è una relazione semplice, che non è modulata da alcun
avvenimento esterno alla relazione considerata» (ivi, p. 66). La strutturazione debole
caratterizza al contrario un ambiente familiare a prevalenza di stimoli, che è fonte di
perturbazioni ma non offre le condizioni per il riequilibrio: in questo caso gli
avvenimenti familiari tendono ad essere per lo più imprevisti. Infine, la strutturazione
flessibile è quella di un ambiente che è fonte perturbazioni ma offre al soggetto anche le
condizioni per il riequilibrio: gli avvenimenti familiari non sono né rigidamente
programmati né imprevedibili, ma la loro occorrenza dipende da altri elementi
prevedibili del contesto. Per tornare all’esempio precedente, la regola «se A allora B» è
77
resa più complessa dal corollario che B potrebbe non prodursi se oltre all’avvenimento
A si verificasse contemporaneamente anche l’avvenimento C. Se il primo stile di
strutturazione non propone sufficienti stimoli e il secondo non permette l’assimilazione
cognitiva degli stimoli che propone, quest’ultimo tipo di organizzazione della vita
familiare è quello che offre le condizioni ideali per lo sviluppo intellettivo del bambino,
in quanto gli propone stimoli sempre nuovi e nello stesso tempo gli offre la possibilità
di assimilarli, vale a dire di utilizzarli come basi di nuove costruzioni cognitive.
Studiando la diffusione delle tre forme di organizzazione in un campione di
famiglie appartenenti a classi sociali diverse,27 Lautrey rileva che, mentre la
strutturazione debole è nel complesso diffusa marginalmente e la sua occorrenza si
verifica per lo più nelle due estremità opposte della scala sociale, «passando dagli strati
agiati agli strati popolari, le forme flessibili di strutturazione cedono progressivamente il
posto alle forme rigide» (ivi, pp. 123-124). In altri termini, la strutturazione rigida
appare essere la forma di organizzazione dell’ambiente familiare tipica delle famiglie di
ceto popolare, laddove nelle famiglie di ceto medio sembra prevalere uno stile di
strutturazione flessibile maggiormente favorevole allo sviluppo intellettivo dei bambini.
Se la constatazione di questa associazione tra tipi di strutturazione e livello
socioculturale della famiglia costituisce il nocciolo della risposta all’interrogativo di
ricerca principale di Lautrey, spiegare il legame tra intelligenza e origine di ceto, la
parte più interessante della sua riflessione riguarda tuttavia l’interpretazione
dell’associazione stessa. Del perché, cioè, una certa appartenenza di ceto predisponga a
una certa forma di organizzazione della vita familiare.
L’esplorazione di questo legame lo conduce in primo luogo a «considerare
eventuali determinazioni ideologiche del tipo di strutturazione» (ivi, p. 135) dal lato dei
valori educativi. E cercarle con uno strumento di rilevazione in tutto analogo a quello
già utilizzato da Duvall e Kohn: sollecitare i genitori studiati a enumerare le «qualità
[più importanti] che si può desiderare di trovare in un bambino» e «i principi di
educazione [...] che vi sembrano i più importanti» (ivi, p. 144). Del tutto analoghi a
quelli già messi in luce da Duvall e Kohn sono soprattutto pure gli orientamenti di
valore educativi che Lautrey rileva nei diversi ceti. Sul versante della scelta dei tratti
desiderabili di un bambino, infatti, per il campione di famiglie francesi degli anni
Settanta studiato da Lautrey, come già per le famiglie americane degli anni Quaranta e
Cinquanta di Duvall e Kohn,
78
le qualità più «importanti e problematiche» nei ceti popolari sono la
buona educazione, la pulizia, il lavorare bene a scuola, e l’obbedienza.
Queste qualità sono poco scelte dalle famiglie di status sociale alto, a
vantaggio del rispetto degli altri, dello spirito critico, della curiosità, e
della perseveranza. [...] Le qualità più frequentemente invocate nei
ceti popolari mettono nell’insieme l’accento sulla sottomissione, la
conformità a una norma. [...] Al contrario, le qualità che diventano le
più frequenti quando aumenta lo status sociale mettono l’accento sulle
determinazioni individuali, l’iniziativa, l’originalità.28
(ivi, p. 149)
In modo simile, per quanto riguarda la scelta diretta dei principi di educazione,
i principi più scelti quando il livello socioculturale diminuisce hanno
in comune il fatto di mettere l’accento sul controllo esterno del
comportamento del bambino: «ricompensarlo ogni volta che agisce
bene e punirlo quando agisce male», «sorvegliare il più possibile ciò
che fa», e «preservarlo dalle cattive frequentazioni». Al contrario, i
principi che vengono scelti sempre di più man mano che lo status
sociale aumenta caratterizzano delle forme di controllo del
comportamento meno immediate, che lasciano più posto all’iniziativa
del bambino e alle sue caratteristiche personali: «inquadrarlo con
flessibilità», «dare l’esempio», e «adattare i propri principi in funzione
di ciascun bambino».
(ivi, pp. 149-150)
La distribuzione tra i ceti delle pratiche costitutive degli stili di strutturazione
della vita familiare da un lato e degli orientamenti di valore educativi dall’altro
mostrano quindi una evidente coerenza funzionale:29
L’esistenza di regole rigide non è in effetti affatto compatibile, dal
punto di vista funzionale, con la valorizzazione di qualità come lo
spirito critico, e conduce più verosimilmente a valorizzare
l’obbedienza. Reciprocamente, un sistema di valori che mette
l’accento sull’iniziativa conduce probabilmente a ridurre il numero
delle regole di comportamento specifiche a una situazione particolare.
(ivi, pp. 163-164)
Una coerenza che, tuttavia, nulla dice sul rapporto di determinazione che le due variabili
delle pratiche di strutturazione e dei valori educativi possono intrattenere tra loro e/o
con la condizione sociale di ceto – e soprattutto su quale dimensione di quest’ultima sia
quella pertinente. Kohn, lo abbiamo visto, identifica questa dimensione nella condizione
professionale, e traccia una catena causale che va da quest’ultima ai valori e dai valori
alle pratiche. Ma, osserva Lautrey, «gli argomenti avanzati» da Kohn «per dimostrare la
verosimiglianza di una determinazione dei valori da parte delle condizioni di lavoro» –
79
e che abbiamo visto nelle pagine precedenti – «possono essere ripresi in una forma
quasi identica per mostrare, questa volta, l’influenza delle condizioni di vita familiari»
(ivi, p. 153):
l’obbedienza è senza dubbio una qualità importante e problematica
quando delle forti necessità [materiali] rendono le regole della vita
familiare intangibili. La pulizia, l’ordine, la cura costituiscono
soprattutto un problema quando lo spazio è ristretto, e sono tanto più
importanti quanto meno i genitori dispongono di mezzi finanziari
sufficienti per sostituire ciò che è stato perso, sporcato o rovinato.
(ibidem)
«Allo schema di imputazione causale suggerito da Kohn», aggiunge allora Lautrey, «se
ne potrebbe dunque opporre un altro: condizioni della vita familiare → pratiche
educative → valori» (ibidem).
Seppure mitigata da molte cautele che ne sottolineano il carattere ipotetico ed
empiricamente non verificato, è precisamente quest’ultima la strada interpretativa
suggerita da Lautrey. In primo luogo, è nelle condizioni dell’esistenza quotidiana della
famiglia imposte dal grado di disponibilità di risorse associato alla posizione nella
struttura sociale che Lautrey individua l’elemento di mediazione tra l’appartenenza di
ceto e la strutturazione dell’ambiente familiare. In secondo luogo, egli ipotizza questa
mediazione come un legame funzionale: il tipo di organizzazione della vita quotidiana
del bambino all’interno della famiglia non sarebbe cioè che il risultato dell’adattamento
delle regole di funzionamento della famiglia stessa e della struttura delle interazioni tra i
suoi membri alle sue condizioni materiali di esistenza – fatte di disponibilità di risorse
economiche, di spazio e di tempo.30 In altri termini, per Lautrey «il tipo di strutturazione
sembra essere la risultante delle regolazioni attraverso le quali la famiglia adatta il suo
funzionamento alle sue condizioni di vita [...] all’interno del margine di iniziativa che
lascia il sistema economico e sociale» (ivi, pp. 142-143). La possibilità di scelta tra
alternative diverse che caratterizza la strutturazione flessibile presuppone una certa
disponibilità di risorse che renda effettivamente possibile questa varietà di scelta. In
modo analogo, la riduzione delle alternative propria della strutturazione rigida è
certamente funzionale a condizioni di vita dominate da una scarsità di risorse che rende
comunque minime le possibilità di scelta. Così, nelle parole di Lautrey, «se le famiglie
dei ceti popolari scelgono più spesso l’occorrenza di tipo rigido», questo accade perché
«la società limita in numerosi domini l’“universo dei possibili” delle famiglie delle
classi popolari», ed è proprio questa diminuzione delle possibilità a fare sì che «la
80
relazione che associa due avvenimenti è qui più difficilmente modificabile, perché essa
è più spesso l’espressione di una impossibilità o di una necessità assoluta» (ivi, pp. 140142). Perché questa relazione tra avvenimenti possa «cambiare forma, attenuarsi, o
scomparire», insomma possa diventare flessibile, è necessario che scompaia ugualmente
quella «necessità imperiosa» che «restringe in anticipo la molteplicità di possibilità»
(ivi, p. 142).31 Infine, se le pratiche educative costitutive dello stile di strutturazione
dell’ambiente familiare sono prodotte dalle e funzionalmente legate alle condizioni
materiali di esistenza quotidiana della famiglia, una relazione analoga ma inversa di
determinazione funzionale è, secondo Lautrey, quella che lega queste stesse pratiche ai
valori educativi, che «ci si potrebbe immaginare [...] come delle razionalizzazioni delle
pratiche educative imposte dalle condizioni di esistenza della cellula familiare» (ivi, p.
154).
2.2.2.2 Codici sociolinguistici e modi di socializzazione familiare
Nel modello dei modi di socializzazione familiare di ceto proposto da Lautrey, la
strutturazione dell’ambiente familiare costituisce dunque l’elemento mediatore «nella
catena causale che collega una struttura sociale all’orientamento cognitivo dei suoi
membri» (ivi, p. 161), e questa catena prosegue con le pratiche e finisce con i valori
educativi familiari. Il rapporto tra la struttura delle relazioni sociali di ceto, gli
orientamenti cognitivi e i modi di socializzazione familiare è pure al centro della
riflessione di Basil Bernstein. La cui stretta affinità con il lavoro di Lautrey non si ferma
alla scelta del tema di indagine e agli interrogativi di ricerca di partenza ma riguarda
anche, in modo più sostanziale, una parte delle conclusioni alle quali i due autori
giungono, e segnatamente la forte congruenza dei ritratti degli stili di socializzazione di
ceto che emergono dalle loro analisi. Punti di partenza simili che portano a conclusioni
simili, dunque, ma che lo fanno attraverso modelli causali in parte differenti. Non solo,
come è noto, nel modello di Bernstein sono le forme di comunicazione verbale, e non le
forme di strutturazione dell’ambiente familiare, a mediare tra la struttura delle relazioni
sociali tipica di un ceto e l’orientamento cognitivo e il comportamento sociale dei suoi
membri. Soprattutto, la catena di causalità lineare e unidirezionale delineata da Lautrey
è sostituita da un modello causale assai più complesso e circolare, il cui principale punto
di forza sta proprio nell’aver sottolineato l’influenza reciproca tra i suoi elementi – e in
particolare tra, da un lato, la struttura delle relazioni sociali e, dall’altro, tutte le sue
81
espressioni simboliche nei modi di socializzazione, siano esse gli orientamenti cognitivi
e linguistici, le pratiche o i valori educativi.
Bernstein, lo abbiamo visto, in modo simile a Lautrey parte dal problema della
«correlazione tra subcultura o classe e riuscita scolastica» (Bernstein 1958a, p. 159). E
come ogni altro teorico culturalista delle disuguaglianze educative la spiega con
l’incontro tra due modi di socializzazione più o meno compatibili, quello della scuola e
quello delle famiglie. In termini estremamente sintetici, la ben nota tesi generale di
Bernstein è che all’origine dell’affinità del modo di socializzazione delle famiglie di
ceto medio e dell’incompatibilità del modo di socializzazione delle famiglie di ceto
popolare con il mondo scolastico sia una diversità radicale nella struttura delle relazioni
sociali che strutturano i due ceti. Le due diverse forme di relazione sociale producono
orientamenti o «stili cognitivi» (Lawton 1968, p. 14), o modi percezione della realtà, o
ancora «modi di espressione cognitiva» (Bernstein 1958a, p. 160) differenti, i quali sono
simbolizzati da forme di comunicazione verbale, o tipi di uso linguistico, o codici
sociolinguistici anch’essi diversi. A loro volta, «differenti forme di uso del linguaggio
[…] creano per i parlanti differenti ordini di rilevanza e di relazione» (Bernstein 1971,
p. 237) nell’espressione e ancor prima nella percezione e nell’esperienza della realtà,
cioè fanno sì che «la loro percezione è di un ordine qualitativamente differente»
(Bernstein 1958a, p. 160). Questo li predispone all’instaurazione di differenti tipi di
relazioni sociali, e in particolare alla riproduzione di quella forma di relazione
caratteristica del contesto sociale che ha prodotto il loro codice sociolinguistico, e li
rende impreparati ad affrontare contesti caratterizzati da forme di relazione sociale
diverse. «Così, il bambino di classe media e il bambino di classe operaia sono orientati
verso ordini di apprendimento differenti come risultato delle implicazioni delle loro
forme di uso del linguaggio» (Bernstein 1961, p. 308), ma mentre le disposizioni
cognitive del primo coincidono con quelle presupposte dalla forma delle relazioni
sociali e dalla struttura della comunicazione verbale usate a scuola, quelle del secondo
sono incompatibili con esse. Questo spiega, secondo Bernstein, la predisposizione del
primo e la «resistenza» tanto cognitiva quanto motivazionale del secondo
all’apprendimento nei contesti di istruzione formale: «viene suggerito», scrive Bernstein
in quella che è probabilmente la prima formulazione della sua teoria, «che quanto più
bassi sono i ceti sociali tanto maggiore è la resistenza all’istruzione formale e
all’apprendimento e che questa è una funzione della struttura sociale dei ceti stessi»
(Bernstein 1958a, p. 160).
82
Come già nel caso di Lautrey, questa conclusione maggiore relativa al rapporto tra
disposizioni sociali e cognitive e adattamento scolastico non esaurisce tutta la rilevanza
delle tesi di Bernstein. Almeno altrettanto interessante in questa sede è infatti l’analisi
che egli traccia di ciò che sta a monte di questo rapporto: il modello di relazione tra le
differenti strutture dei rapporti sociali proprie del ceto medio e del ceto popolare e le
loro «implicazioni», oltre che comunicative e linguistiche, «logiche, sociali e
psicologiche» (Bernstein 1959, p. 318) sulle disposizioni degli attori. In primo luogo, è
in termini molto vicini a quelli di una differenza tra una forma meccanica ed una forma
organica di solidarietà sociale che Bernstein descrive le strutture delle relazioni sociali
caratteristiche dei due ceti: tra, nel ceto popolare, relazioni sociali basate su una forte
identificazione, e indifferenziazione, tra individuo e gruppo, su ruoli comunalizzati, e,
nel ceto medio, relazioni sociali basate sulla differenza, quindi sulla differenziazione e
sulla individualizzazione, ovvero su ruoli individualizzati (Bernstein 1971, pp. 241242). Questa polarità concettuale molto generale tra tendenza all’unione – o
indifferenziazione, o identificazione, o fusione – e tendenza alla separazione – o
differenziazione, o individualizzazione – costituisce, come direbbe Bourdieu, la
«matrice generativa» di tutte le manifestazioni di queste due diverse forme di ordine
sociale nell’ordine simbolico dei modi di pensiero e di comunicazione.
Dei due diversi modi di comunicazione verbale ai quali tali strutture di relazioni
sociali danno luogo, innanzitutto. Modi di comunicazione che, prima di chiamare
definitivamente dei codici sociolinguistici, Bernstein aveva inizialmente definito
linguaggi, chiamando linguaggio formale ciò che avrebbe in seguito ribattezzato un
codice elaborato e linguaggio pubblico quello che sarebbe diventato il codice ristretto
dei ceti popolari. Ora, se la sostituzione dell’appellativo di «linguaggio» con quello di
«codice sociolinguistico» è andata nella direzione di un avanzamento e di una
chiarificazione teorica,32 al contrario a me pare che la coppia di qualificativi originari
fosse molto più precisa nel cogliere l’essenza della differenza tra le due forme di uso del
linguaggio. E che lo fosse specialmente il «pubblico» riferito all’uso linguistico dei ceti
popolari. Perché l’essenza della differenza non risiede tanto semplicemente nel diverso
grado – ristretto ed elaborato, appunto – di complessità, varietà e ricchezza sintattica e
lessicale. Che pure distingue le due forme linguistiche, dal momento che il tratto più
visibile del codice ristretto è proprio l’uso di una gamma ridotta di alternative sintattiche
e lessicali, quindi un’alta ripetitività e prevedibilità del lessico e dell’organizzazione
sintattica del discorso (per una rassegna dettagliata delle caratteristiche del codice
83
ristretto cfr. in particolare Bernstein 1959). Il nocciolo della differenza tra i due codici
risiede piuttosto nel fatto che, al contrario del codice elaborato, il codice ristretto «è
principalmente un mezzo per produrre qualificazioni sociali [quindi, pubbliche,
appunto] e non individuali», ovvero è «una forma linguistica che massimizza i mezzi di
produzione di simboli sociali piuttosto che individuali» in quanto «la [sua] struttura [...]
inibisce l’espressione verbale di quelle esperienze di differenza che isolerebbero
l’individuo dal suo gruppo» (Bernstein 1959, pp. 315-316). Tutto ciò può essere
espresso anche dicendo che nei due contesti sociali la forma della comunicazione
verbale è diversa perché dal linguaggio ci si aspetta che esso adempia a funzioni
differenti: simbolizzare e riaffermare l’inclusione e l’identità tra i parlanti in un caso,
simbolizzare e costruire la differenziazione delle loro identità personali nell’altro.
A livello formale, questo significa che «l’uso del linguaggio della classe media è
ricco di qualificativi personali, individuali» (Bernstein 1958a, p. 164) e in tal modo
permette al parlante a «verbalizzare la sua relazione discreta con l’ambiente» (Bernstein
1959, p. 316), vale a dire di esprimere verbalmente la sua esperienza singolare, tanto
cognitiva quanto affettiva, di questa relazione. Al contrario, nei ceti popolari «il
linguaggio non è un mezzo per verbalizzare in modo relativamente preciso l’esperienza
di separatezza e differenza» (ibidem) tra i parlanti e tra l’individuo e il gruppo. A livello
formale, a questo concorrono per esempio «un uso limitato e rigido degli aggettivi e
degli avverbi» che limita drasticamente «le qualificazioni individuali degli oggetti (i
nomi) e le modificazioni individuali dei processi (gli avverbi)», oltre a «un uso
frequente dei pronomi impersonali come soggetti delle frasi» che «implica
l’oggettivazione dell’esperienza che viene verbalizzata» (ivi, pp. 313-314), ovvero, la
sua spersonalizzazione. «Questo non significa che i parlanti di questo linguaggio
interagiscano in un modo del tutto uniforme», ma significa che la produzione di
qualificazioni individuali, e in particolare l’espressione della dimensione affettiva
dell’esperienza individuale, non passa attraverso la mediazione verbale ma «è realizzata
con un mezzo che offre una immediatezza di comunicazione, cioè attraverso il
simbolismo espressivo» (ivi, p. 316).
Che il codice ristretto sia un linguaggio «pubblico» fatto per esprimere
l’esperienza comune del gruppo o, il che è lo stesso, l’esperienza di identificazione del
parlante con l’interlocutore e nel gruppo, porta con sé anche un’altra importante
caratteristica formale. Non solo, come abbiamo visto, la selezione stessa degli elementi
lessicali rende arduo verbalizzare la discriminazione cognitiva e affettiva. Ma l’esigenza
84
stessa di esplicitazione ed elaborazione dei significati vi è drasticamente ridotta dal
solido sfondo di assunti comuni esistente tra i parlanti – e dal fatto che la funzione
principale della comunicazione è proprio quella di riconfermare questa comunione
simbolica e attraverso di essa simbolizzare e rafforzare la comunione sociale. Questo fa
sì che il codice ristretto sia «un linguaggio di significati impliciti» (ivi, p. 315). O, come
Bernstein lo definì in una formulazione successiva e più elaborata di questo concetto, un
linguaggio che esprime ordini di significato particolaristici, cioè «quei significati in cui
principi e operazioni sono relativamente impliciti da un punto di vista linguistico»
(Bernstein 1971, p. 239) e soprattutto la cui comprensione è fortemente dipendente dal
contesto che li ha generati: «dove il sistema semantico è particolaristico, gran parte del
significato è trasmesso attraverso il contesto e può essere ristretto a quelli che
condividono una simile storia contestuale» (ibidem). Laddove la condizione – e nello
stesso tempo l’esigenza – di discriminazione, differenziazione, individualizzazione di
parlanti che vivono in un contesto di ruoli individualizzati li orienta piuttosto a dare
meno per scontato e ad elaborare ed esplicitare meglio i significati verbali. In una
parola, li orienta verso ordini di significato universalistici «in cui principi e operazioni
sono resi linguisticamente espliciti [...] e i significati sono meno legati a un dato
contesto» e in quanto tali «per principio accessibili a tutti» (ibidem).
L’elaborazione ed esplicitazione dei significati verbali ha in particolare a che fare
con l’articolazione logica del discorso, cioè con la differenziazione più o meno fine
degli oggetti e soprattutto con il modo più o meno complesso di stabilire tra essi
relazioni logiche.33 La povertà della struttura sintattica, la tendenza a «enfatizzare le
cose piuttosto che i processi» (Bernstein 1959, p. 313) espressa nell’uso di un gamma
molto limitata di costruzioni e tempi verbali, l’uso «semplice e ripetitivo» (ivi, p. 311) e
spesso inappropriato di una gamma altrettanto limitata di congiunzioni, il ricorso
frequente ad affermazioni categoriche in cui «la ragione è confusa con la conclusione»
(ivi, p. 314): queste sono alcune delle caratteristiche formali del codice ristretto che,
secondo Bernstein, ostacolano l’elaborazione e l’espressione di costruzioni logiche
complesse, e predispongono alla descrizione piuttosto che all’analisi, o, come egli
scrive, a «una sensibilità al contenuto piuttosto che alla struttura degli oggetti, [...] ai
confini di un oggetto piuttosto che alla matrice delle relazioni e delle interrelazioni che
esso intrattiene con altri oggetti» (Bernstein 1958a, p. 160).
Una sensibilità che prima di essere comunicativa è percettiva e cognitiva. E che ci
conduce quindi dai modi di comunicazione verbale a quelle che, come abbiamo visto,
85
Bernstein definisce le loro «implicazioni logiche, sociali e psicologiche» sullo stile
cognitivo e il comportamento sociale, con particolare riferimento agli stili di
socializzazione familiare. Abbiamo anche visto come, nel modello di Bernstein, il
termine di «implicazione» non vada in realtà inteso ad indicare una catena di causalità
lineare che va dalla struttura sociale agli usi del linguaggio e da questi ultimi ai modi di
pensiero e di azione degli attori. Piuttosto, in tale modello, modo di comunicazione, stile
cognitivo (quindi, modo di classificazione della realtà e di organizzazione
dell’esperienza) e comportamento sociale sono concepiti come tre diversi «sistemi
simbolici [...] allo stesso tempo realizzazioni e regolatori della struttura delle relazioni
sociali» (Bernstein 1971, p. 234). Come cioè tre forme di espressione nell’ordine
simbolico di un ordine sociale che le ha prodotte ma che esse contribuiscono in modo
determinante a riprodurre. Da un lato, quindi, gli usi del linguaggio e i modi di pensiero
e azione dei membri di un ceto sono legati alla struttura sociale da una relazione di
causalità bidirezionale. Dall’altro, essi sono a loro volta in un rapporto di
determinazione circolare tra loro: «spazi simbolici omologhi», come direbbe Bourdieu,
prodotti da una causa comune, essi «risuonano» e si rafforzano l’uno con l’altro. Così,
sono naturalmente gli stili cognitivi e i modi di comportamento sociale costitutivi delle
subculture di ceto ad orientare gli usi del linguaggio che abbiamo visto sopra. Ma questi
ultimi costituiscono nello stesso tempo il veicolo principale della trasmissione
intergenerazionale, attraverso la socializzazione familiare, di quei modi di pensiero e di
azione. «Quando il bambino impara il suo linguaggio», scrive Bernstein,
egli imparerà anche la sua struttura sociale; e quest’ultima diventerà il
substrato della sua esperienza più intima attraverso l’effetto
dell’elaborazione linguistica. Il ruolo principale del linguaggio, da
questo punto di vista, è quello di sensibilizzare progressivamente il
bambino alle richieste future che gli verranno fatte, modificando la
sua esperienza e stabilizzando le sue percezioni.
(Bernstein 1961, p. 309)
E, come avviene per i codici sociolinguistici, anche nel caso degli orientamenti cognitivi
e dei modi di socializzazione l’essenza della differenza tra la cultura del ceto medio e
quella dei ceto popolare è nella diversa tendenza alla differenziazione vs.
indifferenziazione sociale e cognitiva.
Una diversità che comincia, nella prima interazione tra genitori e bambini, con
l’esperienza più o meno intensa che i bambini dei due ceti fanno della individuazione
emotiva e cognitiva del proprio sé dal proprio ambiente e dalle persone che lo
86
popolano.34 E prosegue poi con un’esperienza pure di intensità ineguale della
discriminazione degli altri oggetti dell’ambiente oltre al proprio sé e soprattutto della
messa in relazione di tali oggetti tra loro – in una parola, con un’esperienza più o meno
ricca della classificazione simbolica. Sul versante delle implicazioni propriamente
cognitive, in modo molto simile a Lautrey, Bernstein rileva come questa diversità di
esperienze nella prima socializzazione si traduca in una diversa abilità nel
concettualizzare relazioni logiche complesse, e segnatamente in una capacità di analisi,
astrazione e generalizzazione più o meno sviluppata – e quindi ovviamente anche più o
meno favorevole all’apprendimento nei contesti di istruzione formale:
Maggiore è la differenziazione dell’esperienza del bambino, maggiore
è la sua abilità nel differenziare e nel concettualizzare gli oggetti del
suo ambiente. Questo, naturalmente, fa parte del processo di
socializzazione di ogni bambino, ma è il modo di stabilire relazioni
che è di importanza decisiva, perché il modo determina i livelli di
concettualizzazione possibili. [...] Il bambino della classe media è
predisposto a ordinare relazioni simboliche e, quel che è più
importante, a imporre ordine e vedere relazioni nuove.
(Bernstein 1961, 296)
Con una interpretazione originale, Bernstein identifica inoltre in questa stessa
difficoltà cognitiva a stabilire relazioni logiche complesse dei membri dei ceti popolari
anche l’origine di quell’orientamento al presente che numerosissime ricerche precedenti
e successive al lavoro di Bernstein si sono accordate nell’identificare come una
disposizione sociale distintiva della subcultura dei ceti popolari.35 Opponendola a
quell’orientamento al futuro – definito anche attitudine alla gratificazione differita (cfr.
Schneider e Lysgaard 1953, Straus 1962) – che è stato altrettanto unanimemente
considerato una delle chiavi più importanti dell’orientamento al successo scolastico e
alla mobilità sociale dei ceti medi (soprattutto, anche se non certo esclusivamente, dal
filone di ricerca di ispirazione parsonsiana sulla distribuzione sociale dei «valori del
successo»: cfr. sopra il paragrafo 1.2.1.1.1 del capitolo 1).36 Il grado di abilità nello
stabilire relazioni logiche complesse tra gli oggetti dell’ambiente influenza infatti
secondo Bernstein anche la capacità di concettualizzare collegamenti tra i mezzi e i fini
dell’azione, e questo tanto più quanto più importante è la distanza temporale che separa
queste due componenti dell’agire. Così, nei ceti medi c’è una «consapevolezza
dell’importanza tra mezzi e fini di lungo periodo» unita ad una «abilità ad adottare
misure appropriate per attuare il raggiungimento di obiettivi distanti attraverso una
87
appropriata catena mezzi-fini» (Bernstein 1958a, p. 161). E, quel che è soprattutto
rilevante qui, questo orientamento cognitivo influenza in modo determinante la
concezione familiare dello sviluppo infantile. Non solo nelle famiglie di ceto medio c’è
una «scrupolosa osservazione del bambino da parte dei genitori» che fa sì che «le più
piccole fasi dello sviluppo e l’emergere di nuovi tratti comportamentali siano oggetto di
attenzione e commento» (Bernstein 1961, p. 295). Ma, più in generale,
il bambino della classe media e di livelli sociali assimilabili è
socializzato all’interno di una struttura formalmente articolata. Le
decisioni presenti che riguardano il bambino che sta crescendo sono
guidate dalla loro efficacia nel raggiungere obiettivi lontani. [...] Il
futuro è concepito in rapporto diretto con la vita educativa ed motiva
del bambino. Di conseguenza, il bambino cresce in una struttura
razionale ordinata, in cui la sua esperienza totale è organizzata fin
dalla tenerissima età.
(ivi, p. 292)
Questa attitudine che potremmo definire lungimirante verso il futuro del bambino
è fondata su una concezione molto più generale del futuro individuale come il limite di
un processo di cui l’individuo stesso è in grado di controllare l’andamento e l’esito.
Dunque, come una condizione futura che è in qualche modo il prodotto della propria
responsabilità individuale – e quindi del grado di impegno, sforzo, capacità, merito
profusi. In quanto tale, si oppone alla concezione fatalistica del futuro,37 e in particolare
del «raggiungimento del successo, come qualcosa che dipende da condizioni sulle quali
l’individuo non detiene il controllo» (Katz 1964, p. 147) – e in cui «“la fortuna” e/o “la
raccomandazione” sono importanti quanto il duro lavoro» (ibidem).38 Una concezione
fatalistica, quest’ultima, che la letteratura sulle culture di ceto associa classicamente – e
pressoché universalmente – ai ceti popolari (cfr. tra gli altri Katz 1964; e, sul fatalismo
dei ceti popolari italiani, Strodtbeck 1958 e naturalmente Banfield 1958).39 Così come
fa anche Bernstein, tentando in più di renderne conto con la prospettiva temporale
ridotta tipica dello stile cognitivo dei ceti popolari, dove
il carattere specifico di obiettivi a lungo termine tende ad essere
sostituito da concezioni più generali del futuro, in cui la fortuna, un
amico o un parente giocano un parte più importante del calcolo
rigoroso di connessioni. Così, le attività presenti, o quasi presenti,
hanno un valore più grande della relazione che l’attività presente ha
con il raggiungimento di un obiettivo lontano. Il sistema di aspettative,
o l’estensione temporale dell’anticipazione, è ridotto, e questo crea un
insieme differente di preferenze, obiettivi e insoddisfazioni. Questo
88
ambiente limita la percezione dello sviluppo del bambino. Le
gratificazioni presenti o le deprivazioni presenti diventano
gratificazioni assolute o deprivazioni assolute, perché non esiste un
continuum temporale sviluppato lungo il quale l’attività presente
possa essere collocata. Rispetto alle classi medie, la posticipazione del
piacere del presente per una gratificazione del futuro è considerata
difficile.
(Bernstein 1961, p. 297)
L’orientamento temporale può essere dunque considerato una conseguenza
sull’ethos generale ed educativo del ceto medio e del ceto popolare del loro
orientamento cognitivo. Qui la dimensione pertinente dello stile cognitivo è, come
abbiamo visto, la maggiore o minore tendenza a discriminare gli oggetti dell’ambiente e
a vedere relazioni tra essi – o, come dice Bernstein, la sensibilità alla struttura piuttosto
che al contenuto degli oggetti. La diversa tendenza a individualizzare il proprio sé
rispetto all’ambiente e al gruppo e a concettualizzare e verbalizzare in modo più o meno
preciso l’esperienza personale del proprio rapporto con essi è invece all’origine di altri,
forse ancora più rilevanti, aspetti dell’ethos e dello stile educativo dei due ceti. Aspetti
che peraltro sono stati già variamente messi in luce da tutte le ricerche di cui ci siamo
occupati nelle pagine precedenti di questa sezione, ma dei quali ancora una volta
Bernstein offre una interpretazione originale radicata espressamente in cause di ordine
cognitivo – e ancora prima nella struttura delle relazioni sociali. Questi aspetti hanno a
che fare, dal lato delle pratiche educative, con le differenze tra i ceti nei modi di
esercizio dell’autorità genitoriale e nel ricorso alle varie tecniche di disciplina e, dal lato
degli orientamenti di valore educativi, con la diversa valorizzazione della conformità e
dell’autodirezione. Il ritratto delle differenze tra i due ceti che Bernstein traccia riguardo
a queste dimensioni è in tutto analogo a quello che abbiamo visto emergere sopra dai
lavori degli altri ricercatori. Così, anche per Bernstein le preferenze dei genitori di ceto
medio vanno all’esercizio della disciplina attraverso il ragionamento e l’induzione del
senso di colpa e ai valori educativi dell’autodirezione, mentre quelle dei genitori di ceto
popolare vanno piuttosto all’esercizio di quella che Weber chiamerebbe una autorità
tradizionale – che cioè si appella all’autorità del ruolo piuttosto che alla razionalità degli
argomenti –, alle punizioni corporali e ai valori educativi della conformità alle regole
esterne.
Ed è nel fatto che, come abbiamo visto, nell’ordine simbolico del ceto popolare
«l’intenzione soggettiva non è verbalmente esplicita o [cognitivamente] elaborata»
(Bernstein 1961, p. 297), laddove tutto nell’ordine simbolico del ceto medio è orientato
89
a favorire lo sviluppo della sensibilità cognitiva ed espressiva per l’intenzione
dell’attore, che secondo Bernstein vanno ricercate le radici di queste differenze negli
stili educativi. E, ancor prima, nelle disposizioni psicologiche che accompagnano il
comportamento sociale degli attori. Perché «una sensibilità rafforzata per la propria
intenzione e per quella degli altri facilita lo sviluppo di una bassa soglia del senso di
colpa, aumenta il numero di referenti che condizionano una relazione sociale, e apre la
strada al controllo del comportamento attraverso l’induzione del senso di colpa»
(Bernstein 1961, p. 301). Così, «il controllo razionale e la manipolazione del senso di
colpa indotto sarà un importante strumento disponibile per la madre di classe media per
disciplinare il bambino» (ivi, p. 295). Al contrario, «l’uso del linguaggio pubblico, che
minimizza l’espressione verbale e l’elaborazione dell’intenzione soggettiva, alza la
soglia del senso di colpa» (ibidem), e in tal modo rende obiettivamente meno efficace
usare quest’ultimo a fini disciplinari. Tanto che non solo a casa, osserva Bernstein, ma
anche
a scuola la punizione di coloro che sono stati socializzati all’uso di un
linguaggio pubblico tenderà ad essere frequentemente corporale, sia
nelle minacce sia nell’esecuzione diretta, perché è difficile suscitare
un senso di colpa o vergogna nel ragazzo o un senso di
coinvolgimento personale nell’atto. Tra il cattivo comportamento e la
punizione viene stabilito un rapporto meccanico.
(ivi, p. 313)
In altri termini, «l’impersonalità protegge o isola il parlante dalla responsabilità, dal
coinvolgimento personale e dal senso di colpa per ciò che ha detto o ha fatto» (ivi, p.
301). Un’attitudine questa, che può sicuramente essere considerata una variante di
quella tendenza fatalistica a vedere il proprio destino futuro come relativamente irrelato
rispetto alla propria responsabilità individuale che abbiamo visto a proposito
dell’orientamento temporale. Sia che, infatti, questo destino per l’attore sia stato
avverso, sia che, a maggior ragione, l’attore abbia compiuto un cattivo comportamento,
in entrambi i casi il locus della causalità (cfr. Fontaine 1994) verrà percepito come
esterno anziché esterno all’attore, cioè quest’ultimo «ha maggiori probabilità di
biasimare l’ambiente piuttosto che se stesso, e questo rafforza lo sviluppo del
meccanismo di rimozione e negazione» (ivi, p. 302) della responsabilità.
Che «i sensi di colpa tendono ad essere separati dalla nozione di errore» (ivi, p.
301) significa anche che la modalità di regolazione esterna del comportamento prevale
sull’autoregolazione, ovvero, per dirla con il linguaggio usato in precedenza, che la
90
conformità passiva alle regole fissate dall’esterno ha la meglio sull’autodirezione.
Perché il fatto che l’attore abbia consapevolezza dell’errore compiuto – quindi, si
conformi alla distinzione che il proprio gruppo fa tra il «bene» e il «male» – ma non
provi per tale errore un senso di colpa equivale a dire «il comportamento è subordinato
alla vergogna piuttosto che al senso di colpa» e «la vergogna indica la percezione di una
diminuzione del rispetto accordato alla condotta da parte del gruppo» (1961, p. 313).
Infine, oltre al ricorso a tecniche differenti di disciplina dei bambini, la diversa
efficacia che, nei due ceti, l’espressione verbale ha nel condizionare e controllare il
comportamento implica più in generale una sensibilità degli attori a tipi differenti di
relazioni sociali di autorità, e questo tanto all’interno quanto all’esterno dei rapporti
familiari. In breve, gli attori socializzati all’uso di un codice elaborato tenderanno ad
essere sensibili a – e a riprodurre – rapporti di dominio la cui legittimità poggia in primo
luogo sulla forza logica degli argomenti con i quali tale legittimità è rivendicata.
Ovvero, «la relazione con l’autorità è mediata dalla razionalità» (ivi, p. 299) e dunque
prima ancora dal linguaggio verbale attraverso il quale tale razionalità può essere
veicolata. Al contrario, tra quanti sono stati socializzati all’uso di un codice ristretto la
pretesa di legittimità del rapporto di autorità passerà raramente per la logica
argomentativa e per l’espressione verbale tout court. Perché il suo fondamento
«risiederà nella forma della relazione sociale che è presente non verbalmente » (ivi, p.
299), cioè sui ruoli sociali occupati dagli individui, o, nei termini di Bernstein, sulle loro
«qualità posizionali».
Così, nei rapporti tra genitori e figli, nei ceti medi l’autorità dei primi sui secondi
tende a poggiare prevalentemente sul ragionamento e sulla persuasione con argomenti
logici, laddove nei ceti popolari «le ragioni per il cambiamento di comportamento
richiesto [ai figli da parte dei genitori] sono fornite raramente o solo accennate»
(ibidem) perché la vera ragione e il vero fondamento della richiesta risiedono
nell’autorità statutaria del ruolo di potere genitoriale («devi fare questo perché te lo dico
io che sono tuo padre»). Se, dunque, nei due casi, le ragioni dei genitori sono
considerate complementi più o meno indispensabili delle richieste che essi rivolgono ai
figli, la stessa importanza differenziale hanno le ragioni dei figli. In primo luogo nelle
situazioni specificamente disciplinari, dove questo spiega, secondo Benstein, la diversa
sensibilità già rilevata da Kohn alle intenzioni vs. alle conseguenze dell’atto sanzionato
da parte dei genitori di ceto medio e di ceto popolare:
91
Kohn ha indirizzato la sua attenzione al fatto che i genitori di classe
media hanno maggiori probabilità di reagire in base alla loro
interpretazione dell’intento che il bambino aveva nell’agire in un certo
modo, mentre i genitori di classe operaia hanno più probabilità di
reagire in base alle conseguenze immediate. [...] Semplicemente, nelle
famiglie di classe operaia si discute poco degli atti che richiedono
misure disciplinari, c’è una ridotta investigazione verbale
dell’intenzione.
(ivi, p. 313)
2.2.3 Il sistema educativo familiare e i fattori «morali» della riuscita scolastica
Il problema di partenza di Bernstein, lo abbiamo visto, era quello classico di
rendere conto della correlazione tra appartenenza subculturale di ceto e riuscita
scolastica. Abbiamo pure visto che per indagarlo egli ha scelto di imboccare la strada
della dimensione più prettamente cognitiva di questo rapporto, quella degli stili di
percezione, di pensiero e di uso del linguaggio. Ma che tuttavia la risposta al problema
che emerge infine dalla sua indagine eccede di molto i confini di questa dimensione.
L’incompatibilità che Bernstein disegna tra il bagaglio di socializzazione che il bambino
dei ceti popolari si porta a scuola e quello che la scuola si aspetta da lui non è infatti
limitata a quella che, seguendo la nota distinzione di Parsons, chiameremo «la
componente cognitiva o tecnica» (Parsons 1959, p. 440), ovvero il fattore intellettuale,
della riuscita scolastica. Non è cioè limitata, rimanendo nello specifico delle tesi di
Bernstein, alla ridotta capacità di manipolazione simbolica, tanto nell’area della sintassi
e del lessico del linguaggio quanto in quello del pensiero astratto – che, peraltro, già da
sola sarebbe molto più che sufficiente a rendere conto di quella che certe volte Bernstein
arriva a definire l’«ineducabilità» nel sistema di istruzione formale dei bambini dei ceti
popolari.
Questa incompatibilità si estende anche all’altra faccia dell’adattamento
scolastico, quella che Parsons definisce «la componente morale o “sociale”» (ibidem) e
che potremmo chiamare anche il suo fattore comportamentale e motivazionale.40 A
cominciare dalla motivazione all’apprendimento per la riuscita scolastica e sociale,
che, come abbiamo visto, ha molto a che fare con l’attitudine verso il tempo, con
l’orientamento temporale culturalmente condizionato. Perché la scuola è l’istituzione
sociale che probabilmente più di ogni altra incarna l’orientamento al futuro, in quanto in
essa «ogni elemento del presente è finemente collegato a un futuro distante» (Bernstein
1961, p. 296): «a scuola un’attività o una serie di attività sono significative in relazione
92
a un obiettivo distante e il presente ha estensioni critiche nel tempo e nello spazio»
(Bernstein 1958, p. 172), e soprattutto da quelle estensioni nel futuro prende molta parte
del suo significato. Un significato, dunque, che nel caso degli studenti dei ceti popolari
può essere severamente limitato dall’altrettanto «limitato sistema di aspettative, o
estensione temporale dell’anticipazione» (ivi, p. 297) che è inscritto nell’orientamento
al presente caratteristico della loro attitudine verso il tempo. «Il bambino di classe
operaia», scrive Bernstein, «è interessato soprattutto al presente, e la sua struttura
sociale, a differenza del bambino di classe media, gli offre un incentivo o un sostegno
scarsi per rendere i metodi e gli obiettivi della scuola personalmente significativi»
(Bernstein 1958, p. 172).
Un secondo fattore «morale» dell’adattamento scolastico che nel modello di
Bernstein appare culturalmente condizionato dall’appartenenza di ceto è la sensibilità
all’autorità dell’insegnante, al modello di autorità che incarna e al modo in cui la
esercita. Una autorità impersonale e simbolicamente mediata dalla parola, e
segnatamente dalla parola razionale, assai lontana da quella alla quale i bambini dei ceti
popolari hanno imparato ad essere sensibili e a rispondere all’interno delle proprie
famiglie. Dove, come abbiamo visto, l’espressione dell’autorità dei genitori passa
raramente per la mediazione linguistica, e altrettanto diretto è l’esercizio della
disciplina.
La sensibilità al modello scolastico di relazione di autorità è strettamente collegata
a un terzo fattore comportamentale della riuscita scolastica. Che nel linguaggio della
moderna pedagogia «attiva» e in particolare nel vocabolario professionale attuale del
mondo dell’istruzione soprattutto primaria è molto in voga definire autonomia (cfr.
Lahire 1995 e 2001b; sul rapporto delle famiglie di ceto popolare con i metodi della
pedagogia attiva alla scuola materna, cfr. Bernstein 1975 e Chamboredon e Prévot
1973). In questa prospettiva un alunno autonomo è un alunno che è in grado di autoimporsi una disciplina, di dominarsi e governarsi da solo senza il bisogno del controllo e
dell’intervento costante di un’autorità esterna. E questo tanto nella condotta quanto nel
lavoro scolastico. Da un lato, l’alunno autonomo ha cioè interiorizzato le regole di
comportamento della vita in comune a scuola. Dall’altro, è altrettanto autodiretto nelle
attività di apprendimento, il che significa che sa portare a termine il lavoro scolastico da
solo e nei tempi richiesti, è attivo e curioso, ha spirito di iniziativa, e, in breve, è
internamente motivato all’apprendimento. In altri termini, possiede, questa volta nella
loro variante scolastica, tutto quell’insieme di proprietà che Kohn definiva
93
dell’autodirezione e che, dalle prime ricerche statunitensi del dopoguerra fino a quelle
di Bernstein, abbiamo visto essere costantemente preferite e stimolate nelle famiglie del
ceto medio. E opposte a quelle preferite e soprattutto favorite dal modo di
socializzazione delle famiglie popolari. Dove la conformità al gruppo e la passività
hanno la meglio sullo spirito di iniziativa individuale e sull’espressione di sé, la
regolazione esterna del comportamento sull’interiorizzazione delle regole, la disciplina
eteroimposta su quella autoimposta, e, in generale, il lavoro e la vita sotto costrizioni
sulle limitazioni liberamente consentite dei progetti personali – o, come direbbe
Bourdieu, l’ascetismo «di necessità» su quello «di libertà».
Un’abitudine e una disposizione molto generale alla sottomissione alla necessità
non deliberata, quindi, che probabilmente non è senza relazione con quello che viene
spesso descritto, soprattutto nella letteratura «soggettivistica» più recente, come il
rapporto soggettivo strumentale che famiglie e studenti dei ceti popolari intratterrebbero
con il lavoro e i saperi scolastici (cfr., tra i molti altri, Léger e Tripier 1986; Thin 1998;
Charlot, Bautier e Rochex 2000; Charlot 2001; Périer 2005). Su questo rapporto, che a
mio avviso si potrebbe con almeno altrettanta efficacia chiamare pragmatico o
materialistico, torneremo più diffusamente nel Capitolo 5. Per il momento è sufficiente
dire che esso consiste, in generale, nel fatto che «il senso della scolarizzazione per le
famiglie popolari risiede nelle possibilità sociali che essa genera e delle quali porta la
promessa, siano esse degli sbocchi professionali o dei saperi che permettono di
“cavarsela” nella vita quotidiana» e che dunque per queste famiglie «ciascuna attività
pedagogica si deve inscrivere direttamente nella prospettiva dell’efficacia sociale»
(Thin 1998, p. 161).41 Soprattutto, in quest’ottica, «il lavoro scolastico fa parte degli
obblighi spiacevoli [della vita] allo stesso titolo del lavoro salariato», e proprio come il
lavoro degli adulti «la scolarizzazione è presentata come una costrizione necessaria»
(ivi, pp. 166-167). Il che conduce sia le famiglie sia gli studenti ad avere difficoltà ad
entrare nella logica scolastica dell’esercizio «gratuito», o, come direbbe ancora una
volta Bourdieu, dell’«interesse disinteressato» per l’apprendimento, astraendo cioè
questo apprendimento e i suoi contenuti dai loro usi pragmatici – siano essi immediati,
come i loro collegamenti con la vita quotidiana,42 o meno immediati, come la loro utilità
in termini di formazione professionale e dunque sbocco lavorativo. E questo spiega
almeno in parte perché anche quel fattore comportamentale e motivazione della riuscita
scolastica che ha a che fare con il desiderio e il piacere di apprendere, il gusto per il
sapere, la curiosità intellettuale, l’interesse autentico per le attività scolastiche – nonché
94
con la disposizione a generalizzare l’attitudine all’apprendimento e all’appropriazione
culturale oltre la scuola – vari anch’esso sovente insieme all’appartenenza di ceto, nelle
stesse direzioni ma in maniera relativamente indipendente dagli altri fattori «morali»
considerati sopra.
Nel modello di Bernstein, la curiosità intellettuale e l’entusiasmo per
l’apprendimento, la volontà e la motivazione alla riuscita, l’autodisciplina nel lavoro e
nella condotta, l’accettazione e il rispetto dell’autorità dell’insegnante sono dunque
proprietà cruciali dell’adattamento scolastico che, non meno delle qualità intellettuali
legate allo sviluppo cognitivo e linguistico, appaiono culturalmente condizionate
dall’appartenenza di ceto. Lo spazio considerevole che a tale modello è stato riservato
nelle pagine precedenti non risiede tanto nella natura peculiare della spiegazione – di
natura sociolinguistica – che Bernstein offre della correlazione tra appartenenza di ceto
e disuguaglianze educative. Al di là dei numerosi rilievi critici dei quali questa tesi è
stata fatta oggetto, la ricerca che viene presentata in queste pagine non si è infatti
occupata di indagare la dimensione degli usi linguistici delle culture di ceto, e in questo
senso il lavoro di Bernstein non costituisce il suo riferimento teorico principale.
L’interesse di questo lavoro in questa sede risiede piuttosto nel fatto che nella teoria di
Bernstein un insieme piuttosto composito di fattori, sia intellettuali sia «morali»,
dell’adattamento scolastico viene considerato insieme e messo globalmente in relazione
con le culture familiari di ceto. E questo rende tale teoria il modello di spiegazione
culturalista delle disuguaglianze educative del periodo classico (e non solo) che
probabilmente più di ogni altro ha tentato di conciliare la completezza della spiegazione
con il dettaglio dei meccanismi di mediazione all’opera tra l’ambiente familiare e il
percorso di istruzione. O meglio, con il dettaglio delle variabili intermedie o «variabili
prossimali» nelle quali le due macro-variabili o «variabili distali» possono essere
scorporate.
Naturalmente l’insieme delle «variabili prossimali» identificate da Bernstein tanto
nel caso della cultura e della socializzazione familiare di ceto quanto in quello dei fattori
dell’adattamento scolastico non esaurisce affatto, né probabilmente approssima
lontanamente, l’enorme complessità delle due «variabili distali». Nondimeno,
l’inventario che egli traccia dei fattori «morali» della riuscita scolastica e delle «cause»
corrispondenti dal lato dell’educazione familiare costituisce un campionario molto
fedele – una sorta di bignami – dei temi e dei risultati delle ricerche che a questo
argomento sono state dedicate in tutto il periodo classico. Dagli anni Quaranta agli anni
95
Settanta del Novecento è stata prodotta una quantità impressionante di riflessioni
teoriche e ricerche empiriche sul rapporto tra i fattori comportamentali e motivazionali
dell’adattamento scolastico e l’appartenenza di ceto prodotte. Questi lavori,
disomogenei per l’appartenenza disciplinare (riguardo alla quale la psicologia in tutte le
sue varianti è comunque decisamente soprarappresentata rispetto alla sociologia) e per
lo spessore analitico e teorico, presentano invece una singolare convergenza in merito
alle variabili «dipendenti» considerate dal lato dei fattori dell’adattamento scolastico e
soprattutto alle variabili «indipendenti» che considerate dal lato dell’educazione
familiare.
L’autoregolazione, ovvero l’interiorizzazione delle regole di condotta,43 è uno dei
fattori comportamentali dell’adattamento scolastico che tra i primi (cfr. per esempio
Baldwin 1948) e in modo più consolidato hanno attirato l’attenzione dei ricercatori (per
una rassegna, cfr. Grolnick e Ryan 1989), ed anche uno di quelli sulle cui cause
sociologiche le interpretazioni appaiono essere maggiormente convergenti (cfr., Elder
1963; Rosen 1964; Baumrind 1966; Baumrind e Black 1967; Baumrind 1968).
L’interrogativo di ricerca in questo caso, come negli altri, è naturalmente quali siano le
proprietà degli stili educativi familiari che favoriscono o ostacolano questa
interiorizzazione, e se e come la distribuzione di queste proprietà vari tra i ceti. Kohn, lo
abbiamo visto, sottolineava l’importanza dei modi di esercizio della disciplina familiare,
delle cause che la provocano e delle tecniche sulle quali si basa. Bernstein vi ha
aggiunto l’importanza dell’uso del linguaggio nelle situazioni di disciplina e più in
generale nei modi di esercizio dell’autorità genitoriale. In termini sostanzialmente
simili, è questa anche la risposta sulla quale converge la maggior parte delle ricerche.
Non sorprendentemente, quello che sembra favorire maggiormente l’interiorizzazione
delle regole è infatti uno stile educativo familiare né permissivo né autoritario ma
«democratico» o, nella nota definizione di Diana Baumrind, «autorevole». Che cioè
coniughi in sé le due dimensioni fondamentali del sostegno e del controllo e, in
particolare, riassuma tutto quell’insieme di proprietà che abbiamo visto caratterizzare
soprattutto la socializzazione delle famiglie di ceto medio: in cui lo strumento principale
del controllo genitoriale sono la parola, il ragionamento e la disciplina fondata sulla
privazione dell’affetto, le regole vengono spiegate e all’occorrenza sono flessibili, e al
bambino vengono lasciate una certa autonomia e potere decisionale.44
L’educazione all’autonomia e la responsabilizzazione precoce attraverso un alto
livello di aspettative genitoriali, insieme al controllo «moderato» sono stati
96
tradizionalmente identificati anche come i tratti dello stile educativo familiare cruciali
per lo sviluppo del fattore «morale» dell’adattamento scolastico più studiato per
eccellenza, l’orientamento alla riuscita. Nelle sue almeno tre varianti del bisogno
psicologico di riuscita (il bisogno di riuscita, o movente della riuscita, o motivazione
alla riuscita), dei valori della riuscita, e delle aspirazioni scolastiche e professionali, lo
studio dell’orientamento alla riuscita è un filo rosso – e molto spesso – che attraversa
tutto il periodo classico di analisi culturalista delle disuguaglianze educative. E che
soprattutto accomuna in riflessioni e dibattiti nella sostanza assai simili filoni di ricerca
apparentemente lontanissimi come la tradizione psicosociologica di ispirazione
parsonsiana di studio dei valori degli Stati Uniti degli anni Cinquanta e Sessanta e la
querelle tra teoria della riproduzione e individualismo metodologico sull’interpretazione
delle disuguaglianze di fronte all’istruzione che ha dominato la scena sociologica
francese degli anni Settanta. A differenza di ciò che accade per altri fattori «morali»
dell’adattamento scolastico quale l’autoregolazione, non si può inoltre certo affermare
che la mole di studi sul rapporto tra ceto e orientamento alla riuscita abbia dato origine
ad una interpretazione condivisa di questo rapporto e delle variabili intermedie in gioco.
L’accordo maggiore riguarda probabilmente proprio le ricerche classiche
statunitensi più vecchie sulla dimensione maggiormente psicologica di questo
orientamento (per una rassegna cfr. Spenner e Featherman 1978): quello che nel 1953
David McClelland aveva chiamato il movente della riuscita (achievement motive) o il
bisogno di riuscita (need for achievement) e nel 1956 Bernard Rosen ribattezza la
motivazione alla riuscita (achievement motivation) distinguendolo dall’orientamento ai
valori della riuscita (achievement value orientation). Il primo è un generico «impeto ad
eccellere [...] [che] non delinea le aree nelle quali tale eccellenza dovrebbe o potrebbe
realizzarsi» (Rosen 1956, p. 206), e dunque precede la definizione dei fini e dei mezzi ai
quali indirizzare l’azione. Il secondo «fornisce una definizione dei fini», «prepara
l’individuo a trasformare il motivo in azione» e fa sì che «la motivazione alla riuscita
possa essere tradotta in quei tipi di azione che conducono alla riuscita culturalmente
definita (e quindi operare come un fattore di mobilità sociale)» (ibidem). In quanto tale,
in questo filone di ricerca l’orientamento ai valori della riuscita è solitamente rilevato
attraverso scale di atteggiamento costituite da affermazioni generali esprimenti
orientamenti di valore, laddove metodi proiettivi (come la costruzione di storie a partire
da immagini) sono piuttosto impiegati per cogliere il «bisogno subconscio di riuscita»
97
(Kahl 1965, p. 669; per una riflessione sui metodi utilizzati per le «misurazioni
dell’orientamento alla riuscita» cfr. in particolare Kahl 1965).
Poiché non solo i valori della riuscita ma anche il bisogno psicologico di riuscita
pare variare con l’appartenenza di ceto, Rosen avanza l’ipotesi che
gli orientamenti di valore, poiché tendono ad essere ad un livello
concettuale, vengono probabilmente acquisiti in quello stadio
dell’educazione infantile in cui è possibile una comunicazione verbale
di natura abbastanza complessa. La motivazione alla riuscita, al
contrario, ha probabilmente le sue origini in certi tipi di interazione
genitore-bambino che si verificano prima nella vita del bambino e
probabilmente sono emozionali e non verbalizzati.
(ivi, p. 210)
In particolare «molti studi empirici», scriveva già nel 1956,
hanno mostrato che la motivazione alla riuscita ha maggiori
probabilità di essere alta quando il bambino è esortato a conseguire
risultati, è ricompensato per il loro ottenimento, e per il
raggiungimento di indipendenza e padronanza, una padronanza che
dopo essere stata acquisita è accompagnata da poche restrizioni.
(ibidem)
Insomma, le pratiche educative familiari favorevoli allo sviluppo della motivazione
interna ad eccellere sembrano coincidere con quelle che conducono all’autoregolazione,
ed essere ancora una volta coerenti con lo stile educativo «democratico» o «autorevole»
maggiormente diffuso tra le famiglie di ceto medio. È questa la conclusione alla quale
giungono pressoché all’unanimità le analisi del legame tra modi di socializzazione
familiare, appartenenza di ceto e sviluppo dell’achievement motivation che soprattutto
nel decennio a partire dalla metà degli anni Cinquanta sono state prodotte in questa
tradizione di ricerca (tra le quali vale ancora la pena di ricordare Monroe Drews e
Teahan 1957; Strodtbeck 1958; Winterbottom 1958; Rosen e D’Andrade 1959;
Crandall, Preston e Rabson 1960; Scanzoni 1967; Straus 1962; Elder 1965).45
2.2.3.1 I «valori del successo» e le aspirazioni educative e professionali
Decisamente più interessanti in questo contesto e per il presente lavoro appaiono
le riflessioni che, più che delle conseguenze psicologiche degli stili di educazione e
interazione familiare di ceto sullo sviluppo dell’impulso ad eccellere, si sono occupate
98
del rapporto tra appartenenza di ceto e aspirazioni educative e alla mobilità sociale. Un
tema, quest’ultimo, che se è stato al cuore degli interessi di ricerca della tradizione
funzionalistica statunitense (cfr. sopra il paragrafo 1.2.1.1.1 del capitolo 1) come e assai
più dello studio psicologico dell’achievement motivation, a differenza di quest’ultimo
non si può dire certo che sia rimasto sostanzialmente confinato a questa tradizione. In
termini cronologici, e con una periodizzazione quanto mai rozza dei quarant’anni di
analisi culturalista delle disuguaglianze educative che ho definito sopra il periodo
classico, è infatti possibile identificare oltre all’età d’oro parsonsiana – all’incirca
dall’inizio degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta – almeno altri due
momenti importanti per l’analisi delle aspirazioni sociali. Il primo è in realtà un
«momento» piuttosto esteso nel tempo che ha anticipato ed è sopravvissuto all’era
funzionalista statunitense, si è sovrapposto ad essa e ne è stato influenzato: si tratta della
tradizione di studio della mobilità sociale che per lungo tempo ha monopolizzato la
sociologia dell’educazione britannica – che, come abbiamo visto nelle pagine
introduttive di questo capitolo, ha preso l’avvio proprio dal problema dello «spreco di
talenti» prodotto dalle disuguaglianze di accesso all’istruzione.
Una questione in tutto analoga a quella che, più tardi e in tutt’altro contesto
scientifico, avrebbe opposto nel campo sociologico francese dei primi anni Settanta la
teoria della riproduzione di Bourdieu e la teoria della mobilità sociale di Boudon. I
quali, in modo non dissimile dai loro colleghi americani e britannici di trent’anni prima,
erano impegnati a rendere ragione di alcuni «fatti imbarazzanti» (Boudon 1973, p. 23)
che stavano emergendo dal bilancio di circa quindici anni di ciò che allora veniva
chiamata ottimisticamente – e senza le virgolette – «democratizzazione» dell’accesso
all’istruzione in Francia.46 Questi fatti mostravano che, in termini essenziali, di tale
«apertura democratica» delle istituzioni scolastiche erano stati i ceti che erano già
clienti di più o meno vecchia data di tali istituzioni, anziché i veri «nuovi clienti» dei
ceti popolari, ad approfittare maggiormente. Da un lato, perché «l’evoluzione della
struttura delle probabilità di scolarizzazione caratteristiche delle diverse classi [...] ha
subito una semplice traslazione verso l’alto e non una vera trasformazione» (Bourdieu
1979, p. 180). Dall’altro, e soprattutto, perché questo prolungamento generalizzato della
scolarizzazione ha avuto luogo per i diversi ceti in filiere di istruzione dal valore
scolastico e sociale profondamente diversificato – e gerarchizzato. Cosicché la
«democratizzazione» dell’istruzione conosciuta dai ceti popolari sembrava avere in
realtà tutte le sembianze di una sostituzione dell’esclusione precoce dal sistema
99
dell’epoca precedente con una «eliminazione differita» (Oeuvrard 1979) attraverso la
(auto)relegazione in filiere svalutate.
Negli Stati Uniti certamente la massificazione dell’istruzione secondaria aveva
avuto luogo qualche decennio prima, se è vero che «nel 1958», come ricorda Martin
Trow, «la popolazione della scuola media superiore comprendeva quasi il 90 per cento
del relativo gruppo di età» (Trow 1961, p. 180). E con essa erano pure apparsi prima
agli occhi dei ricercatori «fatti imbarazzanti» simili a quelli che avrebbero occupato la
riflessione di Bourdieu e Boudon, nella forma segnatamente di una correlazione
sistematica tra l’appartenenza di ceto degli studenti e il loro orientamento o meno verso
il college e le relative carriere professionali. Non era tuttavia tanto una preoccupazione
legata alla «spartizione dei benefici» (Darras 1966) tra gli strati sociali, come nel
dibattito francese, quella che negli anni Cinquanta animava gli studiosi della mobilità
sociale negli Stati Uniti. Questa preoccupazione sarebbe arrivata anche lì più tardi, con
il Coleman Report del 1966, e il problema più urgente allora non avrebbe avuto a che
fare l’accesso al sistema dell’istruzione, cioè con le differenze di ceto nelle scelte di
orientamento scolastico e professionale, ma, prima e in modo più essenziale, con le
differenze di riuscita nel sistema stesso, e anzi con la mancanza di «uguaglianza delle
opportunità educative», come recitava il titolo del rapporto, ai livelli iniziali del
percorso di istruzione.
Come accennato già nel capitolo precedente, ciò che invece le lenti dei ricercatori
statunitensi e in parte anche britannici dagli anni Quaranta a buona parte degli anni
Sessanta permettevano di leggere nelle differenze tra i ceti nelle scelte dei percorsi
scolastici e professionali erano prima di tutto differenze di ambizione, aspirazioni,
gerarchie di valori, obiettivi. Ed era questo ciò che soprattutto interessava ed
eventualmente preoccupava. E attorno a cui ruotavano pressoché tutti gli interrogativi di
ricerca. Il funzionalismo parsonsiano aveva dettato la matrice più generale di questi
interrogativi. Se la condivisione di valori comuni era la garanzia della sopravvivenza e
del buon funzionamento di una società, il compito primo di qualsiasi scienza della
società era naturalmente quello di tastare il polso al legame sociale attraverso una
«misurazione» di tale condivisione: fino a che punto arrivavano i common values? E
dove cominciavano i class differential values (Han 1969)? Tra i primi, come osservava
in quegli stessi anni con lucidità Robert Merton, ovvero tra le «mete, scopi, interessi che
sono definiti culturalmente, e si presentano come obiettivi legittimi per tutti i membri
della società [...] la cultura americana contemporanea sembra approssimarsi al tipo
100
limite di cultura nella quale viene data grande importanza a certe mete di successo»
tanto che in essa «continuo» è «l’incitamento ad avere un’alta ambizione» (Merton
1968, pp. 299, 305 e 309, sottolineatura mia). Non sorprende quindi che il valore,
l’obiettivo, o nelle parole di Merton, la «meta culturale» integrativa per eccellenza, e
dunque anche la cartina al tornasole per «misurare» l’integrazione degli individui nella
società americana, venisse allora considerato «la distribuzione dei “valori del successo”
fra le diverse classi sociali» (ivi, p. 363). O, nella definizione di Rosen, l’orientamento
alla riuscita. Meno ovvio e più discutibile è il fatto che, con quella che lo stesso Merton
ci ricorda essere una operazione di conflazione di elementi culturali analiticamente
distinti, nella maggior parte di queste ricerche l’aspirazione degli individui alla meta del
successo venisse «misurata» attraverso la loro aspirazione ai «modi accettabili secondo i
quali tali mete possono venir raggiunte» (ivi, p. 300). E tra questi mezzi
istituzionalizzati il primo posto era occupato dalle aspirazioni educative e, attraverso
esse, professionali. Cosicché in molte analisi implicitamente la misura dell’aspirazione
al «successo professionale» raggiunto attraverso un brillante percorso di istruzione
finiva per simbolizzare la misura dell’ambizione tout court.
Va subito aggiunto, tuttavia, che l’inclinazione maggioritaria (anche se non
esclusiva, come vedremo) della letteratura classica sui valori a un certo semplicismo
«etnocentrismo di classe» (Combessie 1969) è più un peccato originale di qualsiasi
sguardo «oggettivistico» portato sull’azione sociale e sulle sue logiche che un limite
specifico di questa tradizione di ricerca. Che in quanto tale non giustifica certamente
l’oblio pressoché completo nel quale dalla fine degli anni Sessanta questa letteratura è
caduta nel campo sociologico, e in particolare nel dibattito per fortuna mai sopito sulle
logiche dell’agire – o, se si vuole, sulle forme di influenza della cultura sull’azione
(Swidler 1986). E non lo giustifica perché gran parte dei temi e delle alternative
analitiche che oggi sono accreditate e si affrontano in questo dibattito sono le stesse che
gli psicologi sociali parsonsiani di mezzo secolo fa consideravano e soppesavano nelle
loro ricerche sulle differenze di ceto nelle aspirazioni e nei «valori della riuscita».
La più semplice e popolare di queste alternative, e anche quella che ha finito per
essere ritenuta la più rappresentativa di questa tradizione di ricerca, era naturalmente
che «questi dati possono essere interpretati come una prova di differenze di classe nella
valutazione della desiderabilità degli obiettivi dominanti del successo» (Caro 1966, p.
492). Ovvero, alla domanda se «la tradizione americana dell’aspirazione al successo è
condivisa dalle classi inferiori [...] un gruppo di analisti ritiene che non lo sia» (Empey
101
1956, p. 703). Come anticipato nel capitolo precedente, è solitamente attribuita ad
Herbert Hyman e al suo celebre saggio del 1953 su «i sistemi di valori delle diverse
classi» una delle formulazioni più chiare ed autorevoli di questa interpretazione della
«mancanza di mobilità» degli «individui degli strati inferiori» nella società americana
(Hyman 1953, p. 267). La posizione di Hyman è, in breve, che «un sistema di credenze
e di valori all’interno delle classi inferiori [...] implica minor importanza della meta
tradizionale del successo [...] [e] minor interesse per il raggiungimento di obiettivi che a
loro volta faciliterebbero il successo» (ibidem). Nei termini di Merton, la gerarchia dei
valori e preferenze della cultura dei ceti popolari si differenzia in modo essenziale da
quella della cultura dominante nella società perché in essa né il fine del successo né i
mezzi legittimi per raggiungerlo occupano le prime posizioni.
Già lo stesso Hyman mitigava la portata «etnocentrica» di questa interpretazione
ammettendo che «questi dati potrebbero tuttavia essere interpretati in modo diverso», e
segnatamente con l’ipotesi che, anziché essere assente, «il valore del successo sia
presente nelle classi inferiori in forme alternative» (ivi, p. 277). Per esempio, che esso
sia diretto a forme alternative di successo professionale. Nella prima prospettiva, il fatto
che «le classi inferiori sono meno inclini ad aspirare alle libere professioni o a
professioni dirigenziali [...] ha supportato l’idea che esse non desiderino “avere
successo”» (Empey 1956, p. 704) e quindi non abbiano ambizioni e non condividano i
«valori del successo» tout court. In questa seconda ipotesi, le differenze tra i ceti nella
gerarchia del prestigio attribuito alle professioni – un tema di indagine classico di
questo filone di ricerca – sono invece interpretate piuttosto come una espressione del
fatto che «le classi inferiori non definiscono la riuscita soltanto in termini di lavoro
libero professionale o dirigenziale, ma anche un lavoro qualificato o la proprietà di un
piccolo commercio rappresentano un progresso» (ibidem). E che questo per esempio
accada perché diverse sono le proprietà del lavoro, o le ragioni della soddisfazione
professionale, che sono valorizzate nei diversi ceti, come numerose analisi del periodo
classico e non solo si sono accordate nel rilevare (tra le prime cfr. per esempio Centers
1948; Lipset e Bendix 1952; Lyman 1955; Inkeles 1960; Katz 1964; ma anche
Goldthorpe et alii 1968). Accordandosi anche nell’identificare tradizionalmente, e a
grandi linee, l’essenza di questa differenza nell’opposizione tra la preferenza accordata
alla sicurezza del lavoro, nella forma della stabilità professionale e delle condizioni
economiche, nei ceti inferiori, e la valorizzazione dell’interesse e della soddisfazione
intrinseca delle mansioni professionali, delle possibilità di carriera (e, quindi, anche in
102
un certo senso del rischio) e del prestigio sociale della professione dal lato dei ceti medi
e superiori.
L’idea dell’esistenza di significati differenziali del successo nei diversi ceti – o,
nelle parole di Merton, l’idea che «i simboli del successo [...] sono diversi per ciascuna
classe» (Merton 1968, p. 324) – rappresenta in realtà solo una variante dell’ipotesi di
una differenza originaria tra i ceti negli orientamenti di valore, sebbene si tratti di una
variante che va decisamente nella direzione di un allontanamento dall’«etnocentrismo di
classe» «oggettivistico» e di un avvicinamento ad una prospettiva di analisi
«soggettivistica» di analisi delle culture di ceto. Ma l’adesione di un individuo o dei
membri di un ceto a una gerarchia di prestigio occupazionale e più in generale a mete
del successo «eterodosse» dal punto di vista della cultura dominante può essere anche il
risultato di quello che Merton chiama un «adattamento alle contraddizioni della struttura
sociale e della struttura culturale» (ivi, p. 331). Tra cioè «le aspirazioni che vengono
prescritte culturalmente» (ivi, p. 303) a tutti i membri della società e le opportunità
strutturali della loro realizzazione alle quali invece non tutti hanno uguale accesso.
Molto più della tesi dell’alterità valoriale originaria della cultura popolare, nella sua
forma forte dell’ipotesi di assenza dei «valori del successo» e nella sua forma debole
dell’ipotesi di definizioni alternative del successo, la tesi che potremmo chiamare della
«condivisione valoriale adattata» ha goduto di una fortuna vasta e costante nello studio
della mobilità sociale e delle disuguaglianze di fronte all’istruzione. E, come nel caso
della tesi dell’alterità originaria, anche le occorrenze della tesi della «condivisione
adattata» possono essere ricondotte a due versioni essenziali, una debole e una forte.
Ciò che le differenzia, in questo caso, è il grado più o meno profondo di
«interiorizzazione» delle limitazioni strutturali che esse presuppongono per l’attore, e
quindi il grado di lucidità, o meglio di riflessività dell’azione, che gli accordano nel
processo di adattamento delle aspirazioni alle condizioni strutturali per la loro
realizzazione. Nella versione debole l’«interiorizzazione» è poco profonda e la
riflessività è elevata, così come elevata è la capacità dell’attore di discriminare tra le
proprie aspirazioni da un lato, e le forme e le ragioni del loro adattamento alle
possibilità. Desideri impossibili e possibilità indesiderate restano cioè ben distinti nella
percezione dell’attore: così, mentre «egli può condividere gli ideali dominanti nella
società su quali siano gli obiettivi maggiormente desiderabili, [...] per ragioni pratiche
[che egli stesso sa essere tali] può dirigere il suo comportamento verso un obiettivo più
modesto» (Caro e Pihlblad 1965, p. 466), senza che questo obiettivo «pratico» giunga
103
tuttavia a sostituire quello «ideale» nella sua scala di preferenze. Nella versione forte,
questa scissione tra aspirazioni e aspettative si ricompone, e desideri impossibili e
possibilità indesiderate si fondono in rassicuranti possibilità che sono anche desideri: le
aspettative si trasformano infatti in nuove aspirazioni modificando gli stessi
orientamenti di valore, e la consapevolezza dell’attore delle limitazioni strutturali che
pesano sulle sue scelte diminuisce.47 La versione forte ipotizza cioè l’esistenza a livello
della cultura di un gruppo sociale di qualcosa di molto simile al meccanismo
psicologico individuale di riduzione della dissonanza (cfr. su questo paragone Caro
1966). Qualcosa che è tanto pernicioso per la mobilità sociale dell’individuo (e del
sistema) almeno quanto è provvidenziale per il suo benessere esistenziale (e, direbbe
qualche funzionalista poco lungimirante, per la buona salute dell’ordine sociale).
Perché, in ogni momento, modellando i suoi desideri sulle sue possibilità, lo sottrae alla
dolorosa consapevolezza di volere ciò che non può e di potere ciò che non vuole per sé
e per i propri figli.
In una versione, nell’altra o in entrambe, come ipotesi privilegiata o come una
delle ipotesi scartate, la tesi della «condivisione valoriale adattata» compare in una larga
parte della letteratura statunitense classica sui valori e sulle aspirazioni di riuscita (cfr.
tra gli altri Empey 1956; Stephenson 1957; Weiner e Murray 1963; Caro e Pihlblad
1965; Rehberg, Schaefer e Sinclair 1970). Hyman, per esempio – che, come abbiamo
visto, privilegia infine la versione forte della tesi dell’alterità valoriale, cioè dell’assenza
dei valori del successo nei ceti inferiori – prende in considerazione anche l’idea che
«una persona di classe inferiore aspira in realtà a un livello elevato di successo, ma si
adatta alla sua condizione di inferiori possibilità di riuscita [...] [con] una specie di
riassestamento degli obiettivi», per giudicarla tuttavia improbabile. In quegli stessi anni
e in quello stesso ambito, altri ricercatori le accordano invece un maggiore credito. Una
occorrenza della tesi della «condivisione valoriale adattata» nella sua versione forte mi
pare per esempio quella che, per restare nell’ambito delle ricerche statunitensi classiche
sui valori, è stata elaborata da Hyman Rodman nella sua ipotesi dello «stiramento dei
valori» dei ceti bassi (the lower-class value stretch) (Rodman 1963; sulla quale cfr.
anche Caro 1966; Della Fave e Klobus 1976). Lo «stiramento dei valori» è secondo
Rodman precisamente uno dei «meccanismi sociali che minimizzano la tensione che la
persona di classe bassa potenzialmente sperimenta» (Rodman 1963, p. 209) nella
situazione delineata da Merton: quando cioè la condivisione degli stessi orientamenti di
valore dominanti nel resto della società si scontra con condizioni materiali di esistenza
104
che rendono molto difficile per tale individuo poter mettere in pratica questi valori ed
agire in accordo con essi. In tale situazione, sostiene Rodman,
la persona di classe bassa, senza abbandonare i valori generali della
società, [...] senza abbandonare la valorizzazione del successo, nella
forma di un alto reddito o di una elevata riuscita scolastica e
professionale, stira i valori in modo che anche livelli più bassi di
successo diventino desiderabili. [Per esempio] senza abbandonare i
valori del matrimonio e della filiazione legittima, stira questi valori in
modo che anche una unione non legale e figli legalmente illegittimi
siano desiderabili.
(ibidem, sottolineatura mia)
«Il risultato», aggiunge ancora Rodman,
è che, in molte aree, i membri della classe bassa hanno una gamma più
ampia di valori rispetto agli altri membri della società. Essi
condividono i valori generali della società con i membri delle altre
classi, ma in più hanno stirato questi valori, o hanno sviluppato valori
alternativi, che li aiutano ad adattarsi alla loro condizione deprivata.
[...] Il prodotto è un sistema di valori stirato con un basso livello di
obbligo verso tutti i valori della gamma, compresi quelli dominanti, di
classe media.
(ibidem)
«Questa», conclude Rodman, «è quella che ipotizzo sia la trasformazione più
importante dei valori [dominanti] che si verifica nella classe bassa, piuttosto che una
trasformazione nella quale i valori di classe media vengono abbandonati o ci si fa beffe
di loro» (ibidem). Una trasformazione, cioè, nella quale «la volpe di classe bassa» non
«rinuncia», da «ribelle» come è nella favola, «al gusto dominante per i grappoli dolci»,
ma piuttosto, da brava volpe «adattiva», «si fa venire un gusto per i grappoli acerbi»
(ibidem). Così, «le risorse culturali, in un certo senso, vanno a compensare la sua
mancanza di risorse sociali ed economiche» (ivi, p. 214).
Qualche anno prima, nel suo noto studio pionieristico dei valori e delle aspirazioni
degli operai dell’industria automobilistica, Ely Chinoy (1952) non aveva sostenuto
niente di sostanzialmente differente. A partire dall’interrogativo di ricerca. Gli operai
dell’industria automobilistica studiati da Chinoy sperimentavano infatti una condizione
professionale caratterizzata da una assenza di prospettive realistiche di avanzamento
professionale, fosse esso di carriera o di semplice trattamento economico. E ciò che
Chinoy si chiedeva era allora se e in che modo queste persone potessero conciliare la
105
propria situazione personale, «le realtà della propria esperienza» priva di opportunità,
con «la tradizione di opportunità» della cultura americana, vale a dire con «le
esortazioni [...] a perseguire obiettivi ambiziosi» che nel sistema culturale americano
scaturivano dall’idea forte che «chiunque dotato di capacità e determinazione potesse,
grazie ai propri sforzi, “avere successo nel mondo”» (Chinoy 1952, p. 454). La risposta
di Chinoy è che «questi uomini non hanno rinunciato ai valori del successo della società
americana», ma li hanno resi compatibili con la – e dotati di senso nella – propria
personale esperienza «ridefinendo il significato di avanzamento in termini più vicini alla
realtà della propria esperienza» (ivi, p. 458). In primo luogo, proiettando le speranze di
successo sul futuro scolastico e professionale dei figli: «anche se gli uomini possono
nutrire poche speranze sul loro avanzamento personale nel presente, hanno ancora la
possibilità di conservare la propria identificazione con la tradizione di opportunità
concentrando le loro aspirazioni sul futuro dei propri figli, una pratica fortemente
incoraggiata dalla cultura» (ivi, p. 459).48 In secondo, e soprattutto, non potendo
identificare, in modo «ortodosso», i propri valori del successo con le proprie prospettive
di avanzamento professionale, questi uomini danno di questi valori un’interpretazione
«eterodossa»: «essi spostano la propria attenzione sulla sicurezza da un lato e
sull’acquisizione di proprietà materiali dall’altro, identificando entrambi con l’“avere
successo”» (ivi, p. 458, sottolineatura mia). La sicurezza di avere dei risparmi da parte e
di accedere con essi ai beni di consumo, «con uno spostamento, nel contesto [simbolico]
dell’avanzamento, dalla sfera occupazionale a quella del consumo»: «se uno è in grado
di pagare le bollette e le rate della casa, della macchina o di un nuovo frigorifero, e
riesce ancora a mettere da parte una piccola somma, allora sta avanzando» (ivi, p. 459).
Ridefinendo l’«avere successo» «nei propri termini», conclude Chinoy, «questi
lavoratori dell’industria automobilistica hanno in larga misura mantenuto la forma ma
perso la sostanza della tradizione americana delle opportunità» (ibidem). Ciò che più
interessa qui è in primo luogo che, mentre hanno chiaramente «importato» nel proprio
sistema simbolico un elemento della cultura dominante, nel compiere questa operazione
essi hanno altrettanto chiaramente ridefinito questo tratto culturale conferendogli un
significato «eterodosso» rispetto a quello «legittimo». In secondo, questa ridefinizione
simbolica è servita a «riadattare», proprio come un vestito che era stato di altri,
l’obiettivo imposto dalla cultura ai mezzi che la struttura sociale metteva a loro a
disposizione per perseguirlo. Ora, con un deciso cambio di aria scientifica, a me pare
che il meccanismo di adattamento – o «bilanciamento» – delle aspirazioni di alle
106
aspettative di mobilità sociale descritto da Rodman, Chinoy e i loro colleghi sia nella
sostanza identico alla tesi sulla quale Bourdieu ha imperniato gran parte della sua
spiegazione dei limiti della «democratizzazione» dell’istruzione secondaria e superiore
nella Francia degli anni Sessanta. Questi limiti, lo abbiamo visto, avevano a che fare
tanto con la correlazione tra appartenenza di ceto e riuscita nel sistema di istruzione
quanto, prima ancora e soprattutto, con disuguaglianze nell’accesso al sistema stesso.
Che nella Francia di allora, nel periodo tra l’estensione dell’obbligo scolastico a 14 anni
e poi a 16 anni (nel 1936 e nel 1959) e l’istituzione di una vera scuola media inferiore
unica (nel 1975), significavano in particolare scelte di orientamento scolastico alla fine
del ciclo elementare correlate molto più all’appartenenza di ceto che alla riuscita
scolastica (cfr. Bourdieu 1966).49 Le quali a loro volta stavano a significare, prima
ancora che un destino di esclusione, una chiara attitudine di autoesclusione delle
famiglie dei ceti popolari dal sistema educativo.
Un’autoesclusione, o un’attitudine di rinuncia anticipata che, come è assai noto,
Bourdieu interpreta proprio come una anticipazione di quel destino di esclusione che
con molta probabilità avrebbe comunque atteso quanti dai ceti popolari avessero voluto
avventurarsi nelle maglie più strette di quel sistema (cfr. sopra il paragrafo 1.2.1.2 del
capitolo 1). Se per il ricercatore questa probabilità di insuccesso all’interno del sistema
di istruzione è chiaramente attestata dalle statistiche, per le famiglie e gli studenti dei
ceti popolari essa è testimoniata in modo non meno vivido dalla loro esperienza di vita
presente e passata tra i propri simili, dall’ «influenza dell’ambiente familiare e di tutto
l’ambiente sociale» nei quali l’eccezionalità di certi percorsi formativi e professionali e
il fallimento scolastico generalizzato costituiscono in ogni momento dei potenti moniti
«che tendono a scoraggiare delle ambizioni percepite come smisurate» (ivi, p. 333). E lo
fanno così perfettamente e completamente che nemmeno il rimpianto accompagna negli
attori questa rinuncia all’irrealizzabile. Perché quest’ultima è così ben «interiorizzata»
che l’aspirazione (percepita come) irraggiungibile cessa per ciò stesso di essere
desiderabile e le aspettative si trasformano in nuove aspirazioni, o, nel linguaggio di
Bourdieu, le «probabilità oggettive» diventano «speranze soggettive». E gli attori
popolare, quelle «persone modeste che non hanno mai amato altro che ciò che hanno»
(Bourdieu, ... ), «scelgono» il proprio destino sociale proprio come l’onesta volpe
adattiva di Rodman, cugina di quella meno onesta e più famosa di Esopo, si convinceva
infine in buona fede di non avere mai desiderato altro che l’uva acerba che pendeva dai
rami più bassi del pergolato (cfr. anche Elster 1983). Nell’uno come nell’altro caso, essi
107
«prendono la realtà per i loro desideri», e mentre «le scelte che compiono sembrano loro
obbedire all’ispirazione irriducibile del gusto o della vocazione» le loro «aspirazioni ed
esigenze sono definite nella loro forma e nel loro contenuto dalle condizioni oggettive
che escludono la possibilità del desiderio dell’impossibile» (ivi, p. 331 e 332).50
Ora, è piuttosto evidente che il significato di questa spiegazione delle differenze
di ceto nelle aspirazioni educative cambia parecchio a seconda che si ipotizzi che sia
proprio «la realtà» o piuttosto la «percezione della realtà» che gli attori prendono per i
propri desideri. Perché la prima ipotesi non è altro che il nocciolo di tutte le teorie
razionalistiche delle «decisioni scolastiche individuali» a partire da quella di Raymond
Boudon (1979). Per le quali gli studenti e le loro famiglie «vedono bene» quali sono,
per sé – cioè in relazione alla loro particolare dotazione di risorse legata alla posizione
sociale – i costi, i benefici e i rischi «oggettivi» delle varie tappe e percorsi del cursus
scolastico. E dunque scelgono o scartano queste tappe e questi percorsi in funzione della
particolare combinazione di costi, rischi e benefici che presentano per loro, cioè del loro
grado di utilità, che diventa anche la misura delle loro aspirazioni. Nelle parole di
Boudon, nella fissazione dei propri obiettivi di istruzione gli individui «obbediscono a
un processo di decisione razionale i cui parametri sono funzioni della posizione sociale»
(Boudon 1973, tr. it. p. 66). Che, va aggiunto, pur se nel linguaggio, sconosciuto ai
razionalisti, degli orientamenti di valore e delle ambizioni, è anche la sostanza di quanto
avevano già sostenuto quegli studiosi classici delle aspirazioni e dei valori di riuscita
che avevano posto soprattutto l’accento sulla necessità di distinguere tra la misura
assoluta e la misura relativa di queste proprietà. E utilizzare, quindi, un modello
cosiddetto «a scala a pioli» (ladder model of mobility) dell’ambizione alla mobilità
sociale (Turner 1964) , dove ciò che conta non è l’altezza assoluta nella struttura sociale
della meta – educativa e professionale – alla quale si aspira ma il numero di scalini che
la collegano al punto dal quale si parte per raggiungerla. Appunto per non dover
concludere che, poiché non aspiravano a raggiungere i vertici della struttura
occupazionale, gli studenti dei ceti inferiori non avessero ambizioni e non
condividessero i «valori della riuscita» al cuore della cultura americana. Così, per
esempio, già nel 1956 Empey deplorava il fatto che nelle ricerche dell’epoca sulle
aspirazioni professionali troppo spesso
sulla gerarchia delle professioni è stata imposta una definizione
monolitica del successo professionale, e le aspirazioni delle persone di
classe inferiore sono state confrontate con quelle delle persone di
108
classe superiore. Quasi senza eccezione, le aspirazioni occupazionali
assolute delle classi superiori sono state trovate «più alte» nella
struttura economica di quelle della classe inferiore.
(Empey 1956, p. 703)
Laddove, a suo avviso, una analisi in termini di ambizione relativa avrebbe rilevato che
«gli studenti di classe inferiore erano significativamente più inclini di quelli di quelli di
classe superiore a desiderare un lavoro che nella comunità avesse un rango sociale
superiore a quello che aveva il loro padre, [...] a considerare importante avere un reddito
superiore al suo, e a ritenere insoddisfacente per se stessi il suo lavoro» (ivi, p. 707).
Offrendo così «uno scarso sostegno all’idea che gli studenti di classe inferiore hanno
limitato le proprie aspirazioni al loro orizzonte di classe presente» (ibidem).
Soprattutto nell’ottica di una teoria del rapporto tra appartenenza di ceto e
mobilità sociale, la portata della tesi dell’adattamento della aspirazioni educative e
professionali alla «realtà» della propria condizione sociale diventa molto diversa se si
ipotizza che la percezione da parte dell’attore di tale «realtà» possa essere in qualche
modo distorta. Con questa ipotesi si esce naturalmente all’istante da ogni teoria
dell’attore razionale, il cui fondamento è per definizione che l’attore non si sbagli nel
compiere la valutazione delle condizioni della sua azione. Sebbene «distorta» non sia in
questo caso la parola più giusta, è invece proprio attorno al problema della natura della
percezione che l’attore ha delle sue «possibilità oggettive» che ruota l’aspetto più
radicale della tesi di Bourdieu. Che non afferma semplicemente che le famiglie di ceto
popolare non hanno aspirazioni educative elevate per i propri figli perché, lungimiranti,
hanno già calcolato che con i mezzi economici e culturali di cui dispongono non
riuscirebbero a realizzarle e quindi imbarcarsi nell’impresa non varrebbe la pena.
Perché, se così fosse, non direbbe niente di diverso da Boudon. Bourdieu sostiene
piuttosto che, nel compiere tale valutazione, le famiglie dei ceti popolari confondono, se
così si può dire, livelli di analisi distinti, prendendo come il proprio destino individuale
quello che è statisticamente il destino collettivo del proprio ceto. E, anticipandolo
attraverso condotte di disinvestimento nel sistema di istruzione, concorrono attivamente
a fare sì che anche il proprio caso individuale finisca per andare a cadere proprio
nell’occorrenza statisticamente più frequente per il proprio gruppo di ceto. O, nelle
parole di Bourdieu, si fanno «inconsapevolmente complici del processo che tende a
realizzare il probabile» (Bourdieu 1974, p. 74) attraverso quell’effetto di profezia che si
autoavvera che egli ribattezza di causalità del probabile:
109
La probabilità oggettiva di accedere a un certo ordine di insegnamento
che è attaccata a una classe costituisce più che una espressione della
rappresentazione disuguale delle differenti classi nell’ordine di
insegnamento considerato, semplice artificio matematico che
permetterebbe soltanto di valutare in maniera più precisa o più
eloquente l’ordine di grandezza delle disuguaglianze; essa è una
costruzione teorica che fornisce uno dei principi più potenti di
spiegazione di queste disuguaglianze: la speranza soggettiva che
conduce un soggetto ad escludersi dipende direttamente dalle
condizioni che determinano le probabilità oggettive di riuscita proprie
alla sua categoria, così che essa fa parte dei meccanismi che
contribuiscono alla realizzazione delle probabilità oggettive.
(Bourdieu e Passeron 1970, p. 190, sottolineatura mia)
Una confusione di «scala», va osservato infine, che non è affatto dissimile da
quella che in Learning to Labour (1977) ipotizzava anche Paul Willis nel rendere conto
del disinvestimento scolastico dei giovani di classe operaia nell’Inghilterra degli anni
Settanta. Come è assai noto, in una etnografia che è probabilmente il classico per
eccellenza della teoria della resistenza della cultura popolare applicata al rapporto tra i
ceti popolari e l’istruzione, Willis documenta l’ultimo anno di permanenza a scuola di
un gruppo di adolescenti inglesi di famiglia operaia, la loro forte avversione per la
scuola e per i valori tipici del ceto medio che essa incarna – docilità, impegno,
competizione, meritocrazia, riuscita, valorizzazione del lavoro intellettuale, e le loro
«scelte» di abbandonarla alla fine del ciclo di istruzione obbligatoria preferendole lavori
manuali non qualificati. È altrettanto noto come l’obiettivo principale di Willis in questo
lavoro sia quello mettere in luce l’uso attivo che questi adolescenti fanno della cultura
operaia – fatta di anti-autoritarismo, maschilismo e valorizzazione del lavoro manuale –
per produrre strategie di difesa della propria identità e resistenza alla cultura scolastica.
Dove Willis – anti-legittimista, volontarista, e anzi in tempi recenti sempre più vicino al
relativismo radicale populista nella sua concezione della cultura popolare (cfr. in
particolare Willis 1990; si veda sopra la nota 32 del primo capitolo) – si avvicina suo
malgrado alla sostanza delle tesi bourdieuiana è nella interpretazione finale che offre di
questa manifestazione del disinvestimento scolastico popolare. Che dall’umile
evitamento preventivo del «fare gli studi non è roba per gente come noi» delle famiglie
«modeste» di Bourdieu è diversa nella forma, più spettacolare, ma identica nelle
conseguenze per gli individui e la società.
Queste conseguenze consistono infatti in entrambi i casi in una «collaborazione o
persino complicità» (Bourdieu 1974, p. 28) attiva quanto fatale dei membri dei ceti
popolari nella realizzazione individuale del proprio destino sociale di ceto. E per
110
entrambi i sociologi all’origine di tale «complicità» vi sarebbe una sorta di mancata
discriminazione, e dunque una identificazione, tra il destino collettivo del gruppo e il
destino individuale dei suoi singoli membri. O, in altri termini, la mancanza di una
ricerca della salvezza individuale da questo destino collettivo.51 Che per Bourdieu, lo
abbiamo visto, è una incapacità: l’effetto persuasivo della percezione del destino
collettivo, delle «possibilità oggettive», è tale che impedisce all’attore anche
semplicemente di considerare la possibilità di potervi sfuggire. L’idea che l’attore sia
«ingannato» da una sorta di percezione doxica della realtà è invece quanto di più
lontano possa esserci dalla posizione di Willis. Per il quale l’identificazione degli
studenti di ceto popolare tra il proprio destino individuale e il destino collettivo del loro
ceto è in primo luogo una scelta. E soprattutto è una scelta che deriva – anziché da una
percezione distorta – da una comprensione profonda della funzione di riproduzione
della struttura delle disuguaglianze sociali svolta dal sistema educativo attraverso il velo
dell’ideologia meritocratica e individualistica:
La controcultura scolastica coglie perfettamente quella che potrebbe
essere definita la differenza tra le logiche individuali e collettive e la
natura della loro confusione ideologica nell’istruzione moderna.
L’essenza della penetrazione culturale relativa alla scuola – che è
realizzata in modo inconscio all’interno dell’ambiente cultuale nelle
sue pratiche e nei suoi oggetti ma che determina nondimeno una
prospettiva intrinsecamente collettiva – è che la logica degli interessi
di classe o di gruppo è diversa dalla logica degli interessi individuali.
[...] Il conformismo può avere senso per l’individuo, ma per la classe
non paga affatto. [...] Il singolo individuo può essere convinto
dell’apparente riassunto che il sistema educativo fa di ciò che si pensa
accada nella società – l’avanzamento attraverso lo sforzo di tutti
coloro che si impegnano –, ma la controcultura scolastica «sa» molto
meglio dello Stato e delle sue agenzie che cosa aspettarsi –
l’esclusione della massa da parte dell’élite attraverso uno falso ricorso
al merito. La controcultura scolastica e altre forme di cultura operaia
contengono elementi di profonda critica all’ideologia dominante
dell’individualismo nella nostra società.
(Willis 1977, p. 128-129)
Ora, se si astrae a sua volta questa tesi di Willis da tutto il suo pesante velo
ideologico utopistico, si può ritenere che le pratiche di resistenza scolastica che egli
documenta non siano dovute ad una acuta quanto improbabile capacità di analisi critica
del sociale ma semplicemente all’effetto dell’incontro, nel contesto scolastico, tra due
culture incompatibili (cfr. Giglioli e Ravaioli 2004). Ad un fenomeno dunque non
dissimile da quello che aveva messo in luce già Bernstein nella sua descrizione delle
111
frustrazioni, e delle reazioni alle frustrazioni, che attendono il bambino di ceto popolare
tra le mura della scuola. Suggerendo pure, questa volta nel linguaggio dell’analisi
sociologica, che uno tra i più potenti motivi di frustrazione fosse proprio l’incontro tra
la logica orientata all’individualizzazione e all’individuo che impronta tanto i saperi e il
linguaggio quanto l’ethos scolastico e la logica comunitaria della lealtà e della
sottomissione dell’individuo al gruppo – o, nelle parole di Bernstein, la sensibilità a
relazioni sociali basate su una forma di solidarietà meccanica – che il bambino di ceto
popolare porta con sé a scuola.
Poiché non era interessato specificamente al tema delle aspirazioni educative,
Bernstein non ha aggiunto tuttavia una osservazione sulla quale molte analisi soprattutto
recenti dell’esperienza scolastica popolare concordano (cfr. Terrail 1984 e 1990;
Rochex 1995; Beaud e Pialoux 1999; Beaud 2002; Poullaouec 2004; Périer 2005). E
cioè che questa logica comunitaria, mentre costituiva un potente ostacolo sulla via del
percorso scolastico e rendeva frustrante il contatto quotidiano con la scuola, nello stesso
tempo preservava assai efficacemente lo studente di ceto popolare e la sua famiglia
dalla frustrazione, dal disorientamento e dall’insicurezza derivanti dall’esclusione,
deliberata o subita, dal sistema dell’istruzione – e soprattutto dalla prospettiva, pericolo,
o minaccia di tale esclusione. Il ruolo «isolante» anche dai rischi di destabilizzazione
esistenziale giocato dalla logica comunitaria della cultura popolare è ben sintetizzato da
Jean-Pierre Terrail, che scrive:
L’esperienza operaia, lungi dall’incitare all’auto-affermazione del
soggetto individuale, insegna al contrario che quest’ultimo non vale
che per il fatto di far parte di una collettività: che si tratti della vita di
fabbrica nella quale si sa che importanza abbia la cooperazione; della
vita extra-lavorativa in cui le solidarietà della famiglia, del quartiere,
della classe, si rivelano un giorno o l’altro un bisogno vitale; che si
tratti in generale dei rischi di isolamento, di fallimento, di repressione
insiti nei tentativi di fuga, di riuscita individuale. L’opposizione così
presente nella cultura operaia dal «loro» al «noi» si accompagna
logicamente ad una forte tendenza alla sottomissione dell’«io» al
«noi»: cosa che la frequenza rispettiva dell’«io» e del «si» nei racconti
di vita raccolti in ambienti piccolo borghesi (o borghesi) e operai
mette bene in evidenza.
(Terrail 1984, pp. 432-433; sottolineatura mia)
In questa sorta di effetto profilattico sul benessere esistenziale individuale, la
forza dei legami comunitari di ceto era indubbiamente aiutata da un sistema di
istruzione nel suo stato «pre-democratizzato», nel quale cioè il modo di selezione era
112
precoce e netto, e la fissazione dei destini scolastici e, attraverso di essi, sociali
avveniva presto e subito in modo non ambiguo. E, almeno nell’esperienza e
nell’universo simbolico dei ceti popolari, il proseguimento degli studi, la riuscita
scolastica e la garanzia di riuscita sociale attraverso il titolo di studio erano tre elementi
indissolubilmente legati tra in modo altrettanto univoco: dei quali cioè si poteva avere la
ragionevole certezza che il primo non si sarebbe verificato senza il secondo, e
soprattutto tutti e due avrebbero dato origine al terzo. Come il non proseguimento che
poteva seguire un’esperienza di fallimento scolastico – sempre comunque di durata
assai breve e più o meno prevedibile in partenza – era associato altrettanto linearmente
ad una prospettiva di riproduzione delimitata dall’orizzonte del proprio gruppo di ceto,
nella forma della propria famiglia e della propria comunità.
Con la «democratizzazione», si potrebbe dire che le famiglie dei ceti popolari
hanno perso molti dei punti di riferimento simbolici che servivano loro da orientamento
nel sistema dell’istruzione senza essere ancora riuscite a sostituirli con altri che siano
altrettanto efficaci a preservarli, come i vecchi, da un senso di precarietà esistenziale e
sociale. In primo luogo, il prolungamento della scolarizzazione di massa si è
accompagnato, proprio per far fronte al mutamento nella quantità e nella qualità della
domanda di scolarizzazione (cfr. Oeuvrard 1979), a una progressiva ramificazione e
opacizzazione della gerarchia di prestigio dei percorsi educativi, ovvero alla
moltiplicazione di filiere dai valori scolastici e sociali tanto profondamente diseguali
quanto potenzialmente opachi agli occhi meno esperti delle famiglie popolari. Così, nel
momento stesso in cui il proseguimento degli studi dopo la scuola media inferiore ha
iniziato ad essere percepito come un orizzonte possibile, se non ragionevole, anche dalle
famiglie dei ceti popolari, la capacità di padroneggiare questo orizzonte ha iniziato
sempre più a sfuggire loro, non lasciandogli spesso altra possibilità che quella di
navigarvi a vista. In secondo luogo, e inevitabilmente, i due elementi simbolici
rappresentati dal concetto di proseguimento degli studi e da quello di riuscita scolastica,
prima
saldamente
associati
nella
rappresentazione
popolare
dell’universo
dell’istruzione, si sono irreversibilmente dissociati. E al loro posto ha preso sempre
maggiore forma una categoria simbolica in gran parte nuova per i ceti popolari, che loro
malgrado ha assunto sempre maggiore importanza nella loro esperienza oggettiva del
mondo scolastico, ma che nondimeno stenta ancora molto a trovare una collocazione
nella loro esperienza soggettiva, cioè nel loro universo di senso: si tratta di quello che si
113
potrebbe chiamare il concetto di «permanenza prolungata nel sistema di istruzione in
situazione di fallimento scolastico cronico».
Infine, last but not least, come effetto della «democratizzazione» del sistema
dell’istruzione il concetto di riuscita scolastica ha subito una seconda, più grave,
dissociazione: il progressivo indebolimento del suo rapporto con l’inserzione
professionale e con la riuscita sociale che quest’ultima poteva garantire. L’inflazione dei
titoli di studio, che in Europa ha cominciato a produrre i suoi effetti a partire dagli anni
Settanta, ha cioè a poco a poco corroso le connessioni simboliche (e non solo) piuttosto
chiare ed univoche che nello stato precedente del sistema legavano «il titolo e il posto»
(Bourdieu e Boltanski 1975) e lo status sociale associato a quest’ultimo. Se si è trattato
indubbiamente di un fenomeno strutturale generale che in forme diverse ha toccato tutti
gli strati sociali, nondimeno la sua portata destabilizzatrice è stata moltiplicata, nei ceti
popolari, dal fatto che è loro letteralmente mancato, molto più che negli altri ceti, «il
tempo di capire» (Bourdieu 1979, p. 157) ciò che stava accadendo, in quanto il
mutamento delle regole del gioco della concorrenza nel campo dell’istruzione è coinciso
per loro con il primo ingresso da neofiti in quell’universo. Già nel 1984, Terrail
riassumeva assai efficacemente il disorientamento scolastico52 che la massificazione
dell’accesso al sistema dell’istruzione degli anni Sessanta e Settanta aveva prodotto nei
ceti popolari:
Dal lato delle famiglie rimaste per lungo tempo estranee alla scuola
[...], la fine degli anni Settanta si caratterizza per una presa di
coscienza da parte della massa della posta in gioco scolastica senza
tuttavia che le capacità reali di appropriarsene (mentre queste famiglie
sono anzi quelle toccate nel modo più brutale dalla crisi) siano molto
migliorate. Il malessere qui è importante e la responsabilità del
fallimento di massa è largamente attribuito alla scuola e agli
insegnanti. [...] In sintesi, nel momento in cui le famiglie operaie
investono fortemente nella scuola, è il senso stesso di questo
investimento che tende a sottrarsi, come il senso della scuola tende a
sottrarsi per i loro figli.
(Terrail 1984, p. 436, sottolineatura mia)
Cercare di cogliere e comprendere questo senso, quello della pratica quotidiana
nel rapporto con la scuola e quello, più sfuggente, di ciò che da questa pratica ci si
attende infine, è dunque essenziale. Forse ancora più che per altre aree di studio del
periodo «classico» del rapporto dei ceti popolari con l’universo dell’educazione e
dell’istruzione, le conclusioni delle analisi classiche sulle aspirazioni, aspettative e
114
scelte dei percorsi di istruzione necessitano di essere integrate. Da un lato, con una
considerazione dei cambiamenti strutturali profondi degli ultimi trent’anni: le
trasformazioni del panorama simbolico dell’universo di istruzione, e quella che
potremmo chiamare la «privatizzazione» dei destini individuali nel mondo dei ceti
popolari seguita, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, alla dissoluzione delle
solidarietà
comunitarie
e
professionali
–
o,
nelle
parole
di
Terrail,
l’«individualizzazione operaia» (Terrail 1990). Dall’altro, appunto, con una presa in
conto molto seria del «punto di vista dell’attore» sulla propria esperienza e sul senso
della propria azione. Insomma, con quello sguardo «soggettivistico» con il quale la
sociologia dell’educazione degli ultimi vent’anni ha guardato con sempre maggiore
attenzione ai ceti popolari.
2.3 Il nuovo sguardo «soggettivistico»: Famiglia e scuola al quotidiano, senso
dell’esperienza scolastica, rapporti con il sapere e rapporti tra saperi
Sul fatto che gli anni Ottanta abbiano costituito per la ricerca in sociologia
dell’educazione un momento di profonda rottura con il passato il consenso è pressoché
unanime tra gli studiosi. Come c’è accordo nel ritenere che a questa rottura abbiano
concorso un rinnovamento – anche generazionale – interno alla sociologia
dell’educazione non meno che un generale cambio di paradigma verificatosi in quel
periodo nelle scienze sociali e, sul versante esterno, trasformazioni delle politiche
educative, dei sistemi di istruzione, e dei dibattiti sociali sulla scuola e sulle sue
funzioni. In altri termini, nel periodo considerato non è cambiato solo il modo il modo
di guardare all’oggetto, ma, in modo indipendente da questo sguardo, sono cambiate
anche le sembianze dell’oggetto stesso. La caduta in disgrazia degli strutturalismi e dei
funzionalismi, la perdita di attrattiva per il «macro», e il «ritorno dell’attore» e
dell’interesse per il simbolico, con la salita in auge delle teorie dell’azione e degli
approcci interpretativi, hanno costituito, come è assai noto, la cifra del generale cambio
di aria scientifica nelle scienze sociali. Anche limitandosi all’Italia e ai Paesi
tradizionalmente di riferimento per la ricerca in sociologia dell’educazione, e cioè Stati
Uniti, Francia e Gran Bretagna, identificare in modo analogo un filo rosso nelle
trasformazioni che nello stesso periodo ha conosciuto quello che potremmo definire il
rapporto tra il sistema educativo e il sistema sociale è molto più complesso. Perché
storicamente molto diverse sono, per questi Paesi, le forme di tale rapporto, e diversi
115
sono stati anche i tempi delle loro trasformazioni, soprattutto tra gli Stati Uniti e
l’Europa. Nondimeno, pare possibile tratteggiare qualche direzione di evoluzione molto
generale.
2.3.1 Il nuovo panorama storico dello sguardo «soggettivistico»: L’apertura della
«forma scolastica»
La
principale
è
costituita
naturalmente
dalle
conseguenze
della
«democratizzazione» dell’accesso all’istruzione, o meglio del prolungamento di massa
della permanenza nel sistema, che in Europa è seguito alle riforme degli anni Sessanta e
Settanta. L’inflazione dei titoli di studio sul mercato del lavoro e la ridefinizione delle
filiere e delle regole del gioco del modo di selezione scolastico – dalla selezione
precoce e netta alla selezione differita attraverso la relegazione in percorsi svalutati –
sono state, come abbiamo appena visto, alcune di queste conseguenze. Ma il mutamento
quantitativo e qualitativo del pubblico del sistema dell’istruzione ha portato con sé, con
un effetto a catena, anche altre evoluzioni, nei dibattiti e nelle politiche educative. Ha
posto in particolare, ad ogni livello del percorso di istruzione mano a mano che la
«democratizzazione» lo investiva, il problema dell’adeguatezza della relativa «forma
scolastica» (Vincent 1994) ai suoi nuovi pubblici: nella distinzione di Bernstein, del tipo
di saperi trasmessi, o del programma, in primo luogo; poi del modo della loro
trasmissione, o della pedagogia; infine, del modo di valutazione (cfr. Bernstein 1975a).
E questa messa in prospettiva della legittimità della forma scolastica ha spesso aperto la
strada alle sue riforme. Che, tutte, sono andate nella direzione di una apertura delle
istituzioni scolastiche al mondo esterno.
Sul versante dei modelli pedagogici ed educativi (e dunque dei criteri di
valutazione), questo ha significato in primo luogo un’apertura all’allievo attraverso
l’adozione di una pedagogia «attiva» – o «dell’autonomia» (Lahire 2001), o «implicita»
(Bernstein 1975) – centrata su una concezione del ruolo dell’educando come quello di
un partner autonomo, responsabile e attivo dell’educatore nel processo di
apprendimento.53 Jean-Pierre Terrail qualifica molto efficamente l’essenza di questa
trasformazione pedagogica in direzione di ciò che egli definisce l’«avvento del
puerocentrismo» (Terrail 2002, p. 221) come un passaggio da un ideale di relazione
educativa come adattamento dell’allievo al sapere e all’insegnante a un modello nel
quale sono gli altri due termini della relazione a dovere adeguarsi al primo:
116
le pedagogie tradizionali ritengono che l’azione scolastica sia
strutturata essenzialmente dall’asse maestro-sapere: come se la
prestazione di un maestro qualificato fosse l’elemento primordiale, se
non addirittura sufficiente, della trasmissione dei saperi. [...]
L’innovazione introdotta dalle pedagogie dell’«educazione nuova»
che si impongono negli anni Sessanta [...] consiste dal fatto che queste
pedagogie si emancipano dalla tradizione che vuole che la
trasmissione dei saperi sia in primo luogo affare del maestro,
facendone un affare dell’allievo e della sua attività. In questo modo
esse spostano l’esigenza di adattamento che è al principio stesso
dell’azione pedagogica: nella loro prospettiva, insegnare significa
adattarsi all’attività dell’allievo, primo motore di un processo che non
si caratterizza più ora come trasmissione ma come appropriazione di
saperi. L’azione scolastica non procede più dalla definizione
preliminare del sapere da trasmettere, e dall’intronizzazione del
maestro come direttore d’orchestra della trasmissione. Parte dal
bambino, dalle sue motivazioni, dalle sue risorse. Lo pone al centro
della scuola («puerocentrismo»), vede nella sua attività la dinamica
che deve strutturare l’azione pedagogica, e concepisce l’intervento del
maestro come sostegno periferico di questa attività, grazie alla quale si
ritiene che i saperi «si auto-costruiscano».
(ivi, pp. 221-222)
Un’apertura all’allievo e al suo universo culturale di provenienza è stata anche la
direzione nella quale sono andate le riforme dei contenuti dei programmi e dei saperi
trasmessi, che hanno finito per indebolire il tradizionale legittimismo della cultura
scolastica e favorire una sua apertura al relativismo e alla presa in conto della differenza
culturale (cfr. Chartier 2003).54 È in particolare accaduto molto spesso che il principio
di una «eguale dignità di tutti i gusti» e di tutti le competenze culturali, nonché di
conseguenza della «molteplicità dei criteri di eccellenza» (Dubet e Duru-Bellat 2004, p.
112) sia stato invocato e messo in pratica come una possibile soluzione al problema
delle disuguaglianze di fronte all’istruzione. E abbia trovato uno dei suoi terreni di
applicazione privilegiato nelle cosiddette pedagogie della differenza largamente
adottate nei contesti di istruzione in cui si concentrano i segmenti più deboli della
popolazione scolastica, a cominciare dalle scuole dell’obbligo dei quartieri più popolari
o/e abitati da minoranze etniche. Se il «principio di giustizia» scolastica che sottostà a
questa visione è evidentemente quello del «rispetto della differenza», che esclude come
non etico qualsiasi tentativo di imporre una gerarchia di legittimità e di valore unica,
come osservano chiaramente Dubet e Duru-Bellat con una considerazione che può
sembrare assai ovvia ma che è troppo spesso trascurata (quasi come fosse politically
incorrect):
117
questa visione, per quanto sia generosa, può allontanare da qualsiasi
figura di giustizia condivisa. Sarebbe come calibrare le formazioni sui
gusti manifestati dagli allievi in un certo momento. Certi avranno
allora il gusto per gli studi umanistici, altri quello per cose più
concrete: non c’è bisogno di essere un grande sociologo per prevedere
che i primi verranno da famiglie più istruite di quelle dei secondi. Se è
possibile, in maniera astratta, decretare l’uguale dignità di tutti i gusti
e la molteplicità dei criteri di eccellenza, resta che, alla fine, tutte le
filiere sono gerarchizzate per il fatto che sfociano su degli
orientamenti professionali disuguali. [...] Questi gusti derivano dalle
socializzazioni familiari [...]. Ora, la vocazione di una scuola giusta è
quella di aprire l’orizzonte degli allievi e di sviluppare i gusti e le
conoscenze di una cultura percepita come universale e liberatrice [e
non necessariamente assecondare i gusti e le conoscenze preesistenti].
[...] In una certa misura, l’adattamento dei formatori ai formati è
inevitabile, ma di fatto esso costituisce un vettore privilegiato di
disuguaglianza: così, negli istituti scolastici popolari le attese degli
insegnanti si fanno meno esigenti.
(ibidem)
Una terza apertura, questa volta interna, è stata quella dei confini tra le discipline e i
saperi trasmessi, ovvero quella tendenza dei moderni sistemi di istruzione alla
destrutturazione interna del curriculum scolastico che già Bernstein aveva identificato
definendola un passaggio da codici seriali a codici integrati (1975a).55 Infine, quella
che è forse più rilevante qui è stata l’apertura della gestione della scuola ad attori
esterni. In primo luogo, l’apertura della gestione in senso proprio, amministrativa e
didattica, del sistema di istruzione alla politica e alle comunità locali che è avvenuta in
certe esperienze nazionali di decentralizzazione educativa territoriale.
Ma soprattutto l’apertura alla gestione in senso lato delle istituzioni di istruzione a
quello che nel vocabolario della letteratura pedagogica e didattica viene spesso definito
l’«extrascuola», ovvero un «sistema formativo integrato». Un esempio importante di
questa apertura all’extrascuola è certamente quella che è stata a ragione chiamata la
«medicalizzazione del fallimento scolastico» (Pinell e Zafiropoulos 1978), la quale è
consistita in particolare in una «psicologizzazione» delle difficoltà di adattamento
scolastico e si è tradotta praticamente in una implicazione sempre più stretta di figure di
psicologi ed educatori specializzati nella vita delle scuole (e in particolare delle scuole
dei quartieri «sensibili»). Come lo è la collaborazione con gli enti locali e
l’associazionismo per l’organizzazione di attività parascolastiche, dalle attività più
qualificanti e di arricchimento del curriculum delle scuole dei ceti medi alle attività di
sostegno e doposcuola delle scuole dei quartieri popolari.
118
L’irruzione più rilevante dell’«extrascuola» nella vita scolastica che si è verificata
negli ultimi trent’anni ha riguardato però senza dubbio l’ingresso dei genitori negli
organi di governo degli istituti (che per esempio nel caso dell’Italia è stato sancito da
una legge del 1974), e, più in generale, la progressiva apertura della scuola alle
famiglie (cfr. tra i molti altri Montandon 1994a; Beattie 1985).56 Con l’affermazione
sempre maggiore di quel concetto che nel vocabolario delle politiche educative
anglofono prende il nome di partnership, in quello francofono di partenariat, e in
quello italiano di cooperazione tra la scuola e le famiglie. E che non esprime
semplicemente l’idea di un coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica (sotto
forma, per esempio, di flussi di informazione e comunicazione tra l’universo della
famiglia e quello della scuola), o anche quella di una loro partecipazione ai processi
decisionali della scuola, ma, più fondamentalmente, sottintende l’idea di una
condivisione del lavoro educativo tra la scuola e le famiglie. Una condivisione della
quale nei concetti bandiera di «apertura» e «collaborazione» è posta in primo piano
soprattutto la sua dimensione di diritto: l’idea cioè che alla voce dei genitori siano
finalmente conferiti dei poteri – di indirizzo, decisione, controllo, eventualmente di veto
– nell’universo scolastico. Ma nella nozione di condivisione del lavoro educativo tra la
scuola e la famiglia è racchiusa anche un’altra potente dimensione di senso: l’idea di
una condivisione di doveri, e quindi di una corresponsabilità delle famiglie stesse
nell’esito dell’impresa educativa svolta dalla scuola e dagli insegnanti. Un’idea che,
nella pratica del funzionamento delle istituzioni scolastiche, specie di istruzione
obbligatoria, degli ultimi tre decenni, è entrata sempre più a far parte dell’universo dei
presupposti dati per scontati della cultura professionale degli insegnanti, e come tale è
stata sempre più incorporata nell’organizzazione del loro lavoro didattico ed
educativo.57 Nella quale è inscritto non solo un certo tipo di allievo per il quale e sul
quale quel lavoro didattico è pianificato, ma sempre più è inscritto anche un certo di
tipo di ruolo genitoriale senza il quale quegli obiettivi didattici ed educativi non possono
essere raggiunti.
Si potrebbe obiettare che in una certa misura lo sia sempre stato anche in epoca
precedente all’apertura della scuola, che tradizionalmente il soddisfacimento di queste
esigenze di cooperazione genitoriale nel lavoro educativo della scuola sia stato una
esclusiva delle famiglie di ceto medio e alto, e che proprio questa tradizione
socialmente situata di implicazione familiare diretta nella scolarità sia una delle ragioni
del legame tra appartenenza di ceto e successo scolastico. Se tutto questo è certamente
119
vero, e cioè se è vero che, anche quando la scuola era «chiusa», per certi ceti lo era
comunque meno che per altri, è altrettanto indubbio che anche – e soprattutto – per i ceti
medi e alti negli ultimi trent’anni le porte di questa istituzione si siano
considerevolmente (ulteriormente) dischiuse. Ma quello che è soprattutto interessante
notare qui sono, si potrebbe dire, la diversa visibilità e le nuove funzioni che al ruolo
genitoriale attivo inscritto negli obiettivi didattici ed educativi della scuola sono stati
attribuiti in questi decenni:
Il senso delle raccomandazioni relative alla cooperazione tra famiglia
e scuola si è modificato. Se negli anni Sessanta si chiedeva ai genitori
di fornire un incoraggiamento agli apprendimenti scolastici dei loro
figli, se negli anni Settanta si parlava vagamente di una
complementarità reciproca tra la famiglia e la scuola, negli anni
Ottanta si raccomanda agli insegnanti di stabilire una collaborazione
stretta con le famiglie allo scopo di inquadrare meglio i bambini nel
loro ambiente e di suscitare il coinvolgimento dei genitori nelle
questioni della scuola e nelle attività scolastiche dei loro figli.
(Montandon 1994a, p. 33)
In particolare, da quando gli effetti delle politiche di «democratizzazione» hanno
portato alla ribalta in modo drammatico il problema della riuscita differenziale dei
membri dei diversi ceti all’interno del sistema dell’istruzione (laddove fino ad allora il
problema percepito come più urgente era stato quello del loro accesso differenziale al
sistema stesso), l’implicazione dei genitori nella scolarità dei figli ha iniziato ad essere
sempre più percepita dagli addetti ai lavori (dai policy makers agli insegnanti) come la
chiave di volta per affrontarlo e risolverlo.58 Ora, in parte questa percezione derivava
effettivamente dalla ricezione nel dibattito pubblico e nelle culture professionali della
scuola di un sapere scientifico. Perché parecchi lavori scientifici – a partire dalle
ricerche pionieristiche inglesi di Elizabeth Fraser (1959) e J.W.B. Douglas (1964) –
avevano posto il coinvolgimento pratico ed emotivo dei genitori nell’accompagnamento
alla scolarità dei figli al primissimo posto, davanti anche al capitale culturale ed
economico della famiglia, tra i fattori della riuscita scolastica. Ma certamente un
numero assai più importante di lavori, come abbiamo visto, aveva invece puntato
soprattutto il dito sulle differenze e disparità culturali tra i ceti, o aveva collegato a
queste differenze e disparità i diversi gradi e forme di implicazione dei genitori dei vari
ceti nella scolarità dei figli. Assumere ottimisticamente che una panacea del malessere
scolastico dei ceti popolari andasse cercata nell’instaurazione di una «cooperazione» tra
120
le famiglia popolari e la scuola è equivalso invece spesso proprio a sottovalutare o
quanto meno a fraintendere la natura di queste differenze e disparità culturali.59
Questo ottimismo è stato soprattutto evidente nelle politiche educative
specificamente rivolte alle popolazioni scolastiche più «a rischio» che soprattutto a
partire dagli anni Ottanta sono state realizzate in vari Paesi. E il cui prototipo è il
celebre e tuttora esistente programma di compensazione Head Start, creato negli Stati
Uniti del 1965 nell’ambito della cosiddetta War on Poverty allo scopo di preparare a un
buon inserimento scolastico i bambini di famiglie disagiate di età prescolare – ovvero
«avvantaggiare», appunto, gli svantaggiati in vista dell’inizio della competizione
scolastica. Se l’obiettivo finale dell’Head Start era naturalmente quello di educare i
bambini sviluppando in essi disposizioni all’apprendimento e all’adattamento sociale
scolastico, il suo obiettivo strumentale in vista di questo fine era coinvolgere il più
possibile i genitori negli interventi e nelle attività proposte ai bambini:
[Negli Stati Uniti] il tema del coinvolgimento dei genitori [nella
scolarità] assunse risalto negli anni Sessanta con la realizzazione dei
programmi federali Head Start, Follow Through, e Title I per i
bambini di età prescolare e dei primi anni di scuola elementare [...].
Questi programmi sancirono per legge il coinvolgimento dei genitori
a basso reddito nella preparazione dei loro figli piccoli a entrare con
successo a scuola.
(Epstein e Sanders 2000, p. 285, sottolineatura mia)
L’obiettivo dell’implicazione dei genitori nella scolarità è stato il perno attorno al quale
hanno ruotato pressoché tutte le politiche di compensazione educativa che si sono
succedute da allora (cfr. Pourtois e Desmet 1991; Durning 1995). La cui essenza
comune può anzi essere identificata, più in generale, in una sorta di accentuazione,
ovvero in una esasperazione, di tutte quelle forme di «apertura» della «forma
scolastica» che, come abbiamo visto, hanno caratterizzato l’evoluzione dei sistemi di
istruzione negli ultimi trent’anni. Dunque dalla destrutturazione del curriculum alla
valorizzazione in esso del bagaglio di competenze culturali che gli allievi ricevono dal
proprio contesto sociale di provenienza, fino all’apertura forte delle istituzioni
scolastiche alle comunità locali in cui sorgono, spesso anche nella prospettiva di elevare
culturalmente e socialmente tali comunità facendo della scuola il punto di riferimento
del territorio (per uno studio di caso di un simile progetto, cfr. per esempio Van Zanten,
Payet e Roulleau-Berger 1994; Van Zanten 2001).
121
Così è stato in primo luogo negli Stati Uniti, con la proliferazione dei programmi
che un tempo venivano chiamati «di compensazione» e oggi non a caso si preferisce di
gran lunga definire «di cooperazione tra famiglia, scuola e comunità» rivolti alle
minoranze etniche e linguistiche (sui quali cfr. Chavkin (ed.) 1993; Epstein e Sanders
2000; per studi di caso dell’applicazione di tali programmi cfr. Delgado-Gaitan 1991;
White, Taylor e Moss 1992). Così è stato, in Europa, per la politica delle Zones
d’Education Prioritaires (ZEP) inaugurata in Francia nel 1982 (sulla quale nella
sociologia dell’educazione francese esiste ormai una letteratura vastissima, che in parte
riporto nella sezione dedicata della bibliografia: per un panoramica sulla politica e sulla
ricerca relativa alle ZEP si possono vedere utilmente Isambert-Jamati 1990; Liensol e
Oeuvrard 1992; Bouveau e Rochex 1997; Glasman 2003; Kherroubi e Rochex 2002 e
2004; e i lavori di Agnès Van-Zanten)60. Quella delle ZEP può essere descritta, più che
come una politica di compensazione rivolta agli elementi deboli della popolazione
scolastica, come una politica rivolta al potenziamento delle capacità educative generali
di intere aree territoriali socio-economicamente depresse (dalle periferie delle grandi
città alle zone rurali). In quanto tale, essa si fonda sull’idea di mobilitazione, nelle
responsabilità educative, dell’intera comunità locale, e dunque anche sulla massima
apertura all’esterno delle istituzioni scolastiche del territorio: «nei quartieri in difficoltà,
la politica detta delle zone di educazione prioritarie (ZEP) ha condotto, a partire dal
1982, a moltiplicare le relazioni di cooperazione con degli attori nuovi (comuni,
assistenti sociali, associazioni del quartiere... )» (Durning 1995). Una filosofia simile,
anche nel nome, è infine quella che ha ispirato in Gran Bretagna la recente instaurazione
delle Education Action Zones (EAZs) nel 1998 (sulle quali cfr. Evans e Fuller 1999;
Gamarnikow e Green 1999; Jones 2000; Reid e Brain 2003).
In questa velocissima panoramica di quelli che mi sembrano i principali elementi
di novità nel rapporto tra scuola e società degli ultimi trent’anni, vale ancora la pena di
aggiungere un’ultima osservazione. Di rilevare un’ultima «apertura», che in questo caso
è l’apertura di una questione, di un dibattito, che resta tuttora quanto mai aperto: la
questione della missione – o delle finalità, o delle funzioni – del sistema educativo.
Anche qui si potrebbe certamente obiettare che su a che cosa debba servire l’istruzione
scolastica sono state condotte aspre dispute fin quasi dalla prima comparsa di questa
istituzione, e che Durkheim nella sua storia de L’évolution pédagogique en France
(1938) ce ne ha offerto uno spaccato esemplare per l’istruzione superiore francese. La
questione «aperta» su questo tema negli ultimi trent’anni può essere considerata in un
122
certo senso una occorrenza storicamente situata di questa disputa perenne, e in questo
caso il contesto storico nel quale essa si colloca, e soprattutto che l’ha generata, è ancora
una volta quello della «democratizzazione». In seguito alla quale, come ben sintetizza
Jean-Louis Derouet riferendosi al caso francese – ma le sue osservazioni sono valide per
tutti i Paesi che hanno conosciuto una evoluzione analoga –, «la società [...] si trova
attualmente tra due modelli di riferimento, che assegnano dei ruoli diversi alla scuola»:
Il vecchio modello è stato concepito a partire dagli anni Trenta e
corrisponde ad una tradizione social-democratica. La società è vista
come una nebulosa in cui dei gruppi – che corrispondono più o meno
alle categorie professionali [...] – intrattengono rapporti complessi e
instabili: conflitti, negoziazioni, compromessi, alleanze, ecc. In questa
prospettiva, il ruolo dello Stato è di regolare la dinamica di queste
negoziazioni, di vigilare affinché il rapporto tra i forti e i deboli non
sia troppo disuguale [...]. La scuola gioca sicuramente un ruolo
importante nell’adempimento di questa funzione. Per ciò che essa fa:
un pilotaggio della ripartizione delle posizioni sociali attraverso il
diploma, e per ciò che essa lascia sperare: l’uguaglianza delle
possibilità. Questo modello si sfalda senza venire completamente
abbandonato, ma deve affrontare almeno altri due concorrenti. Il
riferimento al mercato resta minoritario. [...] In compenso emerge
fortemente un altro modello che sostituisce, nella missione della
scuola, la lotta contro l’esclusione alla lotta per l’uguaglianza.
L’opposizione principale non è tra i dominanti e i dominati, ma tra
coloro che sono dentro al gioco sociale – quale che sia la loro
posizione – e coloro che ne sono esclusi. Il che riformula i doveri
dello Stato, e quelli della scuola.
(Derouet 2000, p. 206, sottolineatura mia)
Il primo modello è evidentemente quello che potremmo definire della
«democratizzazione meritocratica», o meglio della «selezione democratica delle élites»,
che, come abbiamo visto nelle prime pagine di questo capitolo (cfr. il paragrafo 2.1.1),
venne realizzato nell’Europa post-bellica e vi restò dominante per qualche decennio fino
alla seconda ondata di «democratizzazione», quella «quantitativa» (Prost 1986). Il
problema, allora, lo abbiamo visto, era quello dello «spreco di talenti» dei ceti inferiori,
e le misure adottate nei vari Paesi andavano tutte nella direzione di abbattere le barriere
istituzionali ed economiche che impedivano ai figli del popolo più «capaci e meritevoli»
di «raggiungere i gradi più alti degli studi» – come recita l’articolo 34 della nostra
costituzione repubblicana che è di quello spirito del tempo è espressione. «I doveri della
scuola», per riprendere le parole di Derouet, in questo modello erano quindi in qualche
modo quelli di individuare e selezionare per lo Stato le destinazioni migliori – cioè gli
123
investimenti potenzialmente più redditizi per la società – disseminate in tutto il corpo
sociale verso le quali lo Stato stesso avrebbe dovuto indirizzare la sua ridistribuzione
delle risorse tra i ceti. Le politiche di compensazione classiche, finalizzate a mettere
tutti in grado di partecipare a armi pari alla competizione meritocratica, devono essere
considerate una variante di questo stesso modello, ovvero «una modalità di
aggiustamento dei margini del principio di uguaglianza delle possibilità» (Dubet e
Duru-Bellat 2004, p. 109) attraverso l’integrazione, o la mitigazione, o il
perfezionamento, di quest’ultimo principio di giustizia fondato sul merito individuale
con un principio di giustizia distributiva.
Un altro criterio, o principio, radicalmente diverso, di giustizia scolastica è invece
sotteso al modello delle funzioni del sistema educativo che in seguito alla
massificazione dell’accesso è venuto ad affiancare il modello meritocratico. Seguendo
ancora Dubet e Duru-Bellat (2004), potremmo chiamarlo il principio del minimo
garantito di saperi e competenze, o il principio dell’uguaglianza dei risultati, secondo il
quale la missione più importante del sistema di istruzione è quella di garantire a tutti un
certo livello minimo comune di saperi e competenze. Il che non è affatto lontano dal
compito che gli assegnava Durkheim: fare dell’être individuel un être social, assicurare
«tra i cittadini una sufficiente comunità di idee e di sentimenti» (Durkheim 1911 [1922],
p. ), farsi custode e garante del legame sociale. In una parola, in questo modello, prima
di selezionare, la scuola deve socializzare: socializzare nell’accezione durkheimiana di
integrare socialmente, far diventare un membro utile della società, come avrebbe detto
lo stesso Durkheim, ovvero mettere in grado di esercitare una cittadinanza consapevole,
costruire la cittadinanza, come si preferisce piuttosto dire oggi.
Se è vero che «in linea di principio i due riferimenti non sono incompatibili»,
perché «l’integrazione di un massimo di giovani nel funzionamento sociale “normale”
non è in contraddizione con una ridistribuzione delle posizioni all’interno di questo
funzionamento» (Derouet 2000, pp. 206-207), cioè analiticamente l’obiettivo della
socializzazione non è in contraddizione con quello della selezione meritocratica, nella
politica e nella prassi educativa è assai difficile tenerli insieme. A cominciare,
evidentemente, dalla costruzione dei programmi di insegnamento e dalla definizione dei
tipi e dei livelli di competenze su cui si basano i criteri di valutazione. Dove è
inevitabile che la ricerca di un minimo comune di conoscenze e la ricerca di un
curriculum che permetta ha chi ne ha la capacità di raggiungere l’eccellenza «si
parassitano [...] mutualmente» (ibidem):
124
In una logica meritocratica, che permetta a ciascuno di raggiungere
l’eccellenza alla quale ha teoricamente diritto, [i programmi] sono
definiti da questa eccellenza, vale a dire dalle attese dei cicli ulteriori
e, quindi, gli allievi più deboli rimangono indietro. Questa
disuguaglianza appare normale, e un esercizio riuscito da tutti sarà
giudicato troppo facile. [...] [La] concezione della giustizia nella quale
è l’uguaglianza dei risultati [...] che viene messa al primo posto
implica un cambiamento di prospettiva: i programmi della
scolarizzazione comune e obbligatoria devono essere definiti a partire
dalle esigenze garantite a tutti, anche se gli allievi migliori sono in
grado di fare molto di più.
(ibidem)
Più
fondamentalmente
ancora,
e
in
modo
relativamente
indipendente
dall’influenza sui programmi di insegnamento, queste due concezioni della missione del
sistema scolastico si traducono in concezioni molto diverse di quello che dovrebbe
essere il prodotto compiuto della realizzazione del compito educativo della scuola. Il
che significa che si traducono in definizioni molto diverse della riuscita. Che nel
modello meritocratico coincide evidentemente con il successo accademico nel senso
tradizionale: con l’eccellenza dei risultati in termini di voti, concorsi superati, filiere
prestigiose alle quali si è guadagnato l’accesso. Laddove il significato della riuscita del
modello della socializzazione si può dire che sia qualcosa di molto vicino al «riuscire
bene nella vita» del linguaggio dei ceti popolari. Nel quale per esprimere sinteticamente
il bilancio di una esistenza si usa sovente dire che una persona «ha fatto una bella
riuscita», o «gli ha fatto una bella riuscita» se si sta parlando di qualcuno con un figlio
adulto che «è venuto su bene». Un modo di dire che in questo contesto non è usato
quasi mai per riferirsi al livello di istruzione o allo status professionale raggiunto, o
almeno non solo a questi, ma è una sorta di giudizio morale globale sul «prodotto
umano» finito. Il metro di misura in questo caso è quello dell’ethos popolare, e in
particolare dell’ethos educativo popolare. Nel quale un figlio «riuscito bene» è in primo
luogo, come dappertutto, un figlio che non ha deviato verso il basso della traiettoria
tipica del suo ceto. Solo che mentre negli altri ceti questa deviazione ha a che fare di
solito con traguardi di istruzione o professionali poco soddisfacenti, sotto l’ultimo
gradino della scala di status della società non ci sono altri gradini, ma c’è l’esclusione
sociale nel sottoproletariato. La «cattiva riuscita» dell’esperienza e dell’immaginario dei
ceti popolari non coincide quindi solo con una devianza dalla traiettoria tipica del ceto,
ma con la devianza sociale nel suo significato convenzionale: la disoccupazione o la
125
mancanza di «voglia di lavorare» (che è l’opposto dell’essere «un lavoratore»
dell’iconografia delle «belle riuscite» popolari), le «cattive compagnie», le gravidanze
adolescenziali, le dipendenze, la delinquenza. E dunque la «bella riuscita» è a sua volta
prima di tutto, per riprendere le parole di Derouet riportate sopra, una «integrazione [...]
nel funzionamento sociale “normale”» – nella quale cioè ha relativamente poca
importanza quale sia il gruppo di status della società in cui si viene «integrati» ma ne ha
molta il fatto che tale gruppo sia percepito come interno alla società stessa.
Ora, come l’«apertura» della forma scolastica che ha segnato gli anni della «postdemocratizzazione» – nelle sue varie dimensioni di apertura della forma pedagogica
all’allievo, apertura al relativismo culturale, apertura dei confini tra le discipline e i
saperi, apertura della scuola agli attori esterni e alle famiglie – ha avuto la tendenza a
trovare le sue espressioni più radicali nella politica e nella prassi educativa delle scuole
maggiormente frequentate dai membri dei ceti popolari, così è stato anche per la
concezione delle finalità del sistema di istruzione in termini di socializzazione e
uguaglianza dei risultati. Ci si potrebbe interrogare molto a lungo – e ritengo che nelle
sedi istituzionali e soprattutto scientifiche idonee non lo sia mai stato fatto abbastanza61
– sul servizio che in questo modo si sia offerto e si stia offrendo agli attori più deboli e
bisognosi del sistema di istruzione. Se cioè, molto banalmente, la scuola che prende
forma dal percorrere con decisione queste vie sia proprio quella che alle famiglie e agli
studenti dei ceti popolari porta i vantaggi maggiori, o quanto meno gli svantaggi minori.
Al «disorientamento scolastico» provocato nei ceti popolari dal fatto che
l’aumento della facilità di accesso ai titoli scolastici sia coinciso con il loro
deprezzamento sul mercato del lavoro e dello status sociale ho già accennato sopra. Ci
si potrebbe poi chiedere fino a che punto l’applicazione dell’idea di collaborazione tra
scuola e famiglia si riveli vantaggiosa per questi attori – ed è significativo che
nell’ultimo decennio, in una prospettiva di bilancio di trent’anni di apertura della scuola
alle famiglie, questa problematizzazione stia affiorando con sempre maggiore frequenza
nelle riflessioni critiche dei ricercatori che si occupano del rapporto con la scuola nei
ceti popolari (si veda sopra la nota 57. Cfr., tra gli altri, Wyness 1995; Montandon 1996;
Glasman 1998; Payet 1998; Stoer e Cortesão 1999; Crozier 1999; Deslandes 1999;
Heywood-Everett 1999; Martin e Vincent 1999; Stanley e Wyness 1999; Mozère 2000;
Carvalho 2001; Checchi 2003; Périer 2005). Oppure ci si potrebbe chiedere fino a che
punto lo sia l’inclusione e la valorizzazione, all’interno del curriculum scolastico, della
«differenza» culturale» della quale questi attori sono spesso portatori rispetto alla
126
cultura legittima tradizionale. Perché è vero, per non fare che un esempio quanto mai
banale e di «buon senso», che in una scuola media inferiore di una periferia disagiata un
corso integrativo o una animazione socioculturale parascolastica sulla musica rap o sulle
cucine del mondo risulterà per gli allievi e le loro famiglie (molte delle quali magari
immigrate) molto più gratificante, in termini di autostima, di un corso propedeutico di
latino o di un corso di potenziamento delle lingue straniere come quelli che si
organizzano nelle scuole medie dei quartieri «bene». Ma resta comunque il fatto che le
filiere dell’istruzione secondaria sono gerarchizzate in termini di rendimento formativo,
professionale e sociale. E che le monete che regolano l’accesso alle filiere più redditizie
sono ancora saperi come il latino o le conoscenze linguistiche, mentre la conoscenza
delle sottoculture giovanili o quella della gastronomia etnica non vi hanno alcun
mercato. In terzo luogo, ci si potrebbe interrogare su quali siano i reali vantaggi – e
quali gli svantaggi – che gli allievi e le famiglie dei ceti popolari ricavano dalla
«psicologizzazione» delle difficoltà scolastiche, con l’ingresso massiccio di questa
prospettiva nella cultura professionale degli insegnanti, e la facilità sempre maggiore
con la quale le scuole orientano verso terapie di natura psicologica le famiglie degli
alunni con problemi di apprendimento o di disciplina. O, infine, ci si potrebbe chiedere
quale servizio rendano ai ceti popolari le pedagogie «attive» fondate su un ideale di
«autonomia» del bambino e dell’allievo che può essere molto lontano da quello che
sottende le pratiche educative delle famiglie popolari e la loro concezione dei processi
di apprendimento.
Il lavoro che viene presentato in queste pagine ha cercato di offrire alcune risposte
a queste domande. Come lo hanno fatto, prima di esso, le ricerche che più lo hanno
ispirato: le analisi del rapporto tra i ceti popolari e l’istruzione che, a partire dagli anni
Ottanta, hanno accompagnato con una trasformazione del proprio sguardo i
cambiamenti in corso nel mondo dell’istruzione. Come già accennato, nella
trasformazione dello sguardo scientifico hanno certamente avuto un ruolo determinante
fattori «interni»: la generale evoluzione «soggettivistica» dello spirito del tempo
sociologico, e, nella sociologia dell’educazione, l’esaurimento, anche generazionale,
dell’egemonia dei grandi paradigmi conflittualisti e della riproduzione, e l’apertura ai
paradigmi quantitativi, costruttivisti e microsociologici. Tra i nuovi oggetti di ricerca
degli ultimi due decenni che sono più debitori di questa evoluzione interna della
sociologia dell’educazione vi sono in particolare tutti quei temi di ricerca sul locale
scaturiti da ciò che viene spesso definita l’apertura della scatola nera del sistema
127
dell’istruzione. E quindi lo studio del curriculum, delle pratiche pedagogiche, di
valutazione e di orientamento; dell’interazione in classe; del funzionamento degli istituti
scolastici e delle culture professionali degli insegnanti; dei rapporti tra gli istituti e il
territorio locale (cfr. tra gli altri Derouet, Van Zanten e Sirota 1987a e 1987b; DuruBellat e Van-Zanten 1999; Van Haecht 2006). Anticipata in parte, nel periodo
«classico», dalla New Sociology of Education inglese, a partire dagli anni Ottanta questa
«apertura della scatola nera» è uscita dai confini di tale tradizione di ricerca ed è diventa
una delle tendenze dominanti della sociologia dell’educazione.
Se su questa prima tendenza hanno pesato soprattutto i cambiamenti interni del
campo scientifico, sulla seconda tendenza maggiore di evoluzione degli oggetti di
ricerca degli ultimi decenni hanno pesato in modo determinante anche le trasformazioni
esterne del campo dell’istruzione. Questa secondo orientamento, che è quello nel quale
più si situa la presente ricerca, potrebbe essere descritto, in termini generalissimi, come
una attenzione per i modi, i processi e i confronti tra socializzazioni analizzati ponendo
al centro la questione del senso soggettivo dell’azione. Quindi, come è stato da più parti
sottolineato (cfr. Perrenoud 1988; Derouet e Derouet-Besson 2005; Van Haecht 2005,
2006), come una sorta di «ritorno alle origini» durkheimiane della sociologia
dell’educazione (cfr. sopra il paragrafo 2.1), seppure integrato con quello sguardo
«soggettivistico» che nella sociologia durkheimiana non aveva cittadinanza. «Da una
ventina d’anni», ha osservato recentemente Anne Van Haecht, «viene posto il problema
delle condizioni e delle modalità di una rifondazione della sociologia dell’educazione
all’interno della sociologia generale», e per alcuni il nuovo tratto unificatore della
disciplina «non potrebbe essere che quello di una sociologia delle rappresentazioni che
gli attori si fanno delle proprie azioni analizzate in termini di socializzazione» (Van
Haecht 2005, p. 24). Ora, è evidente come la ragione d’essere di una sociologia
dell’educazione incentrata sullo studio della diversità delle definizioni della situazione
scolastica che deriva dalla diversità dei modi di socializzazione risieda in larga misura
in una precisa caratteristica dell’oggetto che poco ha a che fare con le evoluzioni del
campo scientifico. Questa prospettiva deve infatti gran parte della sua rilevanza attuale,
oltre che al cambiamento di paradigma scientifico che l’ha resa possibile, al fatto che il
pubblico del sistema educativo è diventato socialmente e culturalmente eterogeneo, e
soprattutto la massificazione dell’accesso ha spazzato via quella affinità elettiva, quella
corrispondenza, quella «omologia» culturale – nel senso antropologico molto prima che
in quello umanistico di «cultura» – che nello stato precedente esisteva tra la domanda e
128
l’offerta di scolarizzazione. E che in Les Héritiers (1964) faceva per esempio dire a
Bourdieu, con una osservazione riferita all’istruzione superiore ma in larga misura
valida anche per quella secondaria, che «l’Università predica sempre a dei convertiti»
perché «dato che la sua funzione ultima è quella di ottenere l’adesione ai valori della
cultura, essa non ha veramente bisogno di costringere o di sanzionare» (Bourdieu e
Passeron 1964, p. 70) dal momento che la sua clientela già si definisce per il loro
possesso.
Così, uno dei nuovi oggetti di ricerca è stato la messa a nudo delle caratteristiche e
dei presupposti del modo di socializzazione scolastico: di ciò in cui, ai vari livelli della
carriera di istruzione, consistono «il mestiere di alunno» (Sirota 1993) o «il mestiere di
studente» (Coulon 1997) – delle loro aspettative di ruolo, avrebbe detto Parsons – e dei
percorsi con il quale vi si entra (cfr. per esempio Sirota 1988 per la scuola elementare;
Coulon 1997 per l’università). Ma un’attenzione assai maggiore è stata riservata, in
un’ottica di confronto tra socializzazioni, ai modi «eterodossi» in cui gli studenti stessi
interpretano e mettono in pratica le aspettative inscritte nel proprio ruolo istituzionale:
per usare un linguaggio ricorrente in questa letteratura, all’esplorazione con metodi
etnografici e biografici del senso che essi conferiscono alla loro esperienza scolastica
mentre la vivono (cfr. tra gli altri Dubet, Cousin e Guillemet 1991; Charlot, Bautier e
Rochex 1992; Rochex 1995; Dubet e Martuccelli 1996; Bautier e Rochex 1998; Charlot
2001; Jellab 2001; Beaud 2002). Focalizzato sulla comprensione delle logiche di azione
degli studenti nel loro rapporto con le istituzioni di istruzione, questo secondo approccio
di analisi ha avuto prevedibilmente come contesti di ricerca privilegiati i cicli di
insegnamento secondario e superiore (ma, per un’eccezione relativa alla scuola
elementare, cfr. Perrenoud 1994; cfr. anche Dubet e Martuccelli 1996, i quali si
occupano di tutti i livelli dell’istruzione). Nello studio dei primi cicli della
scolarizzazione, dall’istruzione prescolare alla scuola media inferiore, la questione del
senso dell’esperienza scolastica si è decisamente trasferita sulle famiglie. E l’oggetto di
analisi sono diventate allora le forme nelle quali le esigenze del modo di socializzazione
scolastico entrano materialmente e soprattutto simbolicamente nelle loro vite: come
vengono interpretate, quale senso viene dato loro, quali sono le logiche di azione che
regolano il contato con esse.
129
NOTE AL CAPITOLO SECONDO
1
A dire il vero a quel nome si era arrivati più che altro per il verificarsi di circostanze istituzionali e
opportunità di carriera che poco avevano a che fare con considerazioni di opportunità scientifica:
semplicemente, si era liberata nel 1902 la cattedra Sciences de l’Éducation di Ferdinand Buisson, e
Durkheim, che veniva dal suo posto di professore di Science Sociale et Pédagogie a Bordeaux, l’anno
seguente ottenne di far aggiungere in coda et Sociologie (cfr. Lukes 1973).
2
Ovvero, per dirla con Jeffrey Alexander, quella di Durkeheim è una concezione forte dello studio
sociologico della cultura (cfr. tra gli altri Alexander 1989). Una delle caratterizzazioni più comprensive e
attualmente più accettate delle direzioni che lo studio sociologico della cultura ha preso negli ultimi
trent’anni circa è infatti quella che, proprio sulla scorta di Alexander, distingue questo settore tra un filone
di sociologia della cultura, caratterizzato da una concezione «debole» dell’oggetto, e un filone di
sociologia culturale, caratterizzato invece da una concezione «forte». Secondo la concezione «debole», lo
studio sociologico della cultura è lo studio di quelle istituzioni alle quali all’interno della società è
specificamente ed espressamente riservato il compito della produzione simbolica. Esse coincidono
abbastanza bene con ciò che Parsons colloca nel quadrante della Latenza del suo schema AGIL: la
religione, il diritto, la sfera dell’arte, dell’industria culturale di massa, dei mass media, della scienza sono
alcune di queste istituzioni. Secondo la concezione «forte», l’oggetto dello studio sociologico della
cultura sono invece, in termini generalissimi, i processi di costruzione e di uso di significati condivisi (che
approcci teorici diversi hanno di volta in volta identificato nelle strutture e categorie fondamentali del
pensiero, in valori e norme, in sistemi complessi di idee quali le ideologie, o in una intera
Weltanschauung) che hanno luogo all’interno di una struttura di relazioni sociali e possono manifestarsi –
e quindi essere studiati – in qualsiasi tipo di «fatto sociale» (quali pratiche, eventi, istituzioni, artefatti).
Con il suo Strong Program in Cultural Sociology (sul quale cfr. tra gli altri Alexander e Smith 2003)
Jeffrey Alexander è appunto uno dei principali esponenti contemporanei di questa seconda prospettiva, ed
è anche colui al quale si deve l’introduzione dell’espressione di sociologia culturale per designarla.
Questa espressione costituisce un richiamo esplicito all’espressione sociologia religiosa con la quale
all’inizio di Les Formes élémetaires de la vie religiosa (1912) Durkheim identifica l’oggetto del suo libro.
Per Durkheim quel neologismo doveva stare ad indicare che egli non era interessato ai sistemi religiosi
istituzionalizzati in quanto tali, come gli storici o gli etnografi delle religioni, ma a «comprendere la
natura religiosa dell’uomo», «un aspetto essenziale e permanente dell’umanità». Per Alexander, esso
significa che l’oggetto della sociologia culturale non è limitato alla cultura intesa come l’insieme dei
prodotti delle sfere istituzionali specificamente riservate alla produzione simbolica (sociologia della
cultura) ma comprende l’intera dimensione simbolica della vita sociale. In altri termini, come per
Durkheim tutta la vita umana ha una dimensione di «vita religiosa» in quanto vita sociale, così secondo la
prospettiva analitica della sociologia culturale ogni azione sociale ha una dimensione simbolica.
3
Sull’accezione convenzionale ristretta di educazione adottata nella sociologia post-durkheimiana – dove,
alla maniera anglofona, il termine «educazione» è usato correntamente nel significato ristretto di
«istruzione» (e non in quello più ampio di «formazione» o «trasmissione culturale») – Marie Duru-Bellat
e Agnès Van Zanten osservano giustamente:
L’espressione «sociologie de l’éducation», usata correntemente dai sociologi di
lingua francese, è di fatto la traduzione letterale di «sociology of education», mentre
la maggior parte dei lavori condotti in questo campo riguardano le istituzioni di
istruzione, soprattutto quelle che dispensano i gradi iniziali di formazione. La
formazione permanente e, più in generale, le forme non scolastiche di
apprendimento e di insegnamento restano meno studiate, malgrado l’interesse
recente per nuovi oggetti, quali l’alternanza, che abbozzano quella che sarebbe una
sociologia della formazione. Una vera sociologia dell’educazione comprenderebbe,
se si prendesse alla lettera il termine «educazione», un campo estremamente vasto,
perché i meccanismi attraverso i quali una società trasmette ai suoi membri i saperi,
saper fare e saper essere che considera necessari alla sua riproduzione sono di una
varietà infinita. Sarebbe di fatto una sociologia della socializzazione, che si
interesserebbe a tutti gli ambienti di vita del bambino, se non addirittura dell’adulto,
e non soltanto alla scuola.
(Duru-Bellat e Van Zanten 1999, p. 7)
130
4
Seguendo d’altra parte le sorti della sociologia durkheimiana.
5
Salvo poi ricredersi di questa convinzione in modo sempre più preoccupato negli ultimi anni. Nei quali
sia, massicciamente, nell’arena del dibattito pubblico sia qua e là anche in quella del dibattito sociologico,
la questione della tenuta del legame sociale e del ruolo della scuola in essa è tornata d’attualità e la sua
risposta appare sempre meno scontata. Cfr. per esempio Martuccelli 2000, Dubet e Duru-Bellat 2004.
6
E non lo aveva fatto perché, ancora troppo preso dalla questione, che riteneva non scontata, di garantire
tra tutti gli «esseri sociali» «le similitudini essenziali che reclama la vita collettiva» (Durkheim 1911
[1922], p. 50), non si era interessato altrettanto a quella parte di educazione che avrebbe dovuto
«diversificarsi e specializzarsi», perché se «la società non può vivere senza che esista tra i suoi membri
una sufficiente omogeneità [...], d’altro canto, senza una certa diversità, ogni cooperazione sarebbe
impossibile» (ibidem). Aveva però sempre avuto ben presente ciò che questa parte di educazione
specializzata avrebbe dovuto soprattutto garantire ai nuovi membri della società: «che nessun ostacolo, di
qualsiasi natura, impedisca loro di occupare nei quadri sociali il posto rispondente alle loro facoltà [...] in
modo da permettere alle ineguaglianze sociali di esprimere esattamente le ineguaglianze naturali»
(Durkheim 1893, p. 368), perché «se l’istituzione delle classi o delle caste dà origine talvolta a dolorosi
dissensi invece di produrre la solidarietà, ciò accade perché la distribuzione delle funzioni sociali sulla
quale essa riposa non corrisponde, o meglio non corrisponde più, alla distribuzione dei talenti naturali»
(ivi, p. 366). Durkheim aveva chiamato «divisione coercitiva del lavoro» questa stortura. Decenni più
tardi, commentando i dati sulle disuguaglianze di accesso all’istruzione a parità di riuscita scolastica (o
intelligenza), i sociologi funzionalisti dell’educazione degli anni Cinquanta e Sessanta l’avrebbero
definita «sprechi» della «riserva di talento» presente nelle classi inferiori. Né Durkheim né – in modo
molto meno giustificabile – quelli che sono solitamente considerati i suoi epigoni degli anni Cinquanta e
Sessanta, nell’auspicare la realizzazione di una perfetta corrispondenza tra le «disuguaglianze sociali» e le
«disuguaglianze naturali», si sono tuttavia occupati della peculiare struttura mostrata da queste ultime.
Cioè del fatto che il confronto tra la «distribuzione naturale delle capacità» (Durkheim 1893, p. 368), o
dei livelli di rendimento scolastico, da un lato, e le posizioni di status dall’altro, sembravano suggerire
con molta insistenza che, per dirla con Don Milani, «Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei
poveri» (Scuola di Barbiana 1967, p. 60).
7
Per la Gran Bretagna, e limitatamente alle indagini ufficiali (sulle quali cfr. Katz 1965), vale la pena di
citare i rapporti Early Leaving (1954) sulle disuguaglianze di accesso all’istruzione secondaria, Crowther
(1959) e Newsom (1963) sull’istruzione secondaria, e soprattutto il rapporto Plowden (1967) sul rapporto
tra rendimento e origine sociale nell’istruzione elementare. Tra le altre ricerche britanniche di questo
periodo, si possono ricordare Floud, Halsey e Martin 1956 e Fraser 1959. Negli Stati Uniti l’indagine
statistica più nota sulle disuguaglianze di fronte all’istruzione è un po’ successiva. Si tratta del Coleman
Report del 1967. Il Coleman Report è noto soprattutto per aver messo in luce l’influenza sul rendimento
scolastico del cosiddetto effetto di composizione sociale della classe scolastica, e segnatamente il fatto che
il rendimento degli alunni delle minoranze etniche fosse positivamente correlato, ceteris paribus, alla
proporzione di alunni bianchi presente nella loro classe. Questa conclusione del rapporto è stata in
particolare all’origine della politica del bussing, il tentativo di desegregazione delle scuole dei ghetti
condotto attraverso il «mescolamento» con gli alunni di altri quartieri, cioè il trasporto di alcuni alunni
dei ghetti nelle scuole di altri quartieri e viceversa. Quanto alla Francia, vale la pena di ricordare
l’inchiesta longitudinale dell’I.N.E.D. (Institut National d’Études Démographiques) 1962-1972 (sulla
quale cfr. Forquin 1979).
8
In termini simili, ma forse più propositivi, Phlippe Perrenoud osserva:
Abbiamo certamente il punto di partenza [...]: le disuguaglianze di cultura, di
istruzione, di intelligenza, dei genitori; e il punto di arrivo: le disuguaglianze di
riuscita scolastica davanti a un insegnamento formalmente uguale. Ma il dettaglio
dei processi di mediazione ci sfugge. L’immensa difficoltà di misura delle variabili
intermedie permette di comprendere le ragioni di questa lacuna, non di ignorarla.
Bisogna riconoscere ugualmente che i sociologi non possono proseguire il lavoro da
soli: le variabili intermedie sono di competenza di una psicologia dell’intelligenza e
dell’apprendimento che si ponesse in una prospettiva sociologica e comparativa, e di
una psicologia sociale centrata sulle interazioni cognitive e linguistiche all’interno
del gruppo familiare. Questa collaborazione interdisciplinare è altamente
desiderabile.
(Perrenoud 1970, p. 12)
131
9
Per quanto riguarda in particolare il modello culturalista elaborato da Bourdieu, questo tipo di critica è
stata sviluppata nel modo più ampio ed elaborato da Bernard Lahire (cfr. in particolare Lahire 1998,
1999a, 1999b; Ravaioli 2005). Lahire ha più volte sottolineato come la teoria bourdieuiana dell’habitus
sia «una teoria della riproduzione “piena”, ma una teoria della conoscenza e dei modi di socializzazione
“vuota”», la quale
evoca retoricamente l’«interiorizzazione dell’esteriorità» o l’«incorporazione delle
strutture oggettive» senza mai dare loro veramente corpo attraverso una descrizione
etnografica (o storiografica) e l’analisi teorica. [...] A forza di insistere sul «ciò si
riproduce», si è finito per trascurare il «che cosa si riproduce» e il «come, in quali
modi, ciò si riproduce».
(Lahire 1999a, p. 131)
Sulla base di questa critica, a partire dalla metà degli anni Novanta Lahire ha iniziato ad elaborare una
revisione della teoria bourdieuiana dell’azione con il nome di sociologia psicologica. In termini
estremamente sintetici, il programma di ricerca di Lahire è nato dalla constatazione che molti degli
strumenti concettuali della sociologia bourdieuiana, nati per lo studio di unità di analisi di tipo aggregato
quali i gruppi sociali, si rivelano poco adatti per studiare l’individuo socializzato in quanto tale. Non solo
nella sociologia di Bourdieu si trova un interesse pressoché esclusivo per il sociale nella sua forma
aggregata, ma vi si trova anche l’idea che i concetti e i metodi che sono adatti allo studio del sociale nella
sua forma aggregata lo siano anche per cogliere quello che Lahire definisce il «sociale individualizzato».
«L’epistemologia molto poco weberiana di Pierre Bourdieu», scrive Lahire, «fa sì che egli non sia molto
sensibile alla questione delle variazioni di scala nella produzione delle conoscenze sociologiche» (Lahire
1999a, p. 123). Questo è vero soprattutto per il concetto di habitus, del cui meccanismo di funzionamento
a livello individuale la sociologia bourdieuiana offre una comprensione ben ridotta sia per quanto
riguarda la sua costituzione, il processo di socializzazione (ovvero la trasmissione culturale), sia per
quanto riguarda le sue modalità di attualizzazione in situazioni concrete.
10
Va però aggiunto che si tratta di una scelta di compromesso in cui considerazioni di economia si
sposano con più presentabili ragioni di pertinenza contestuale. Non si tratta certo invece di una scelta
motivata da considerazioni di rilevanza in senso assoluto. Perché, benché probabilmente minoritario per
quantità rispetto all’insieme delle analisi sul rapporto tra istruzione e culture di ceto, il corpus di
letteratura sulle responsabilità autonome del sistema di istruzione nella genesi delle disuguaglianze
educative minoritario non lo è sicuramente anche per rilevanza. Esso comprende diversi filoni di ricerca
che si possono considerare in gran parte distinti tra loro. Tra i principali c’è certamente l’analisi dei
programmi, dei metodi pedagogici e dei criteri di valutazione che ha contraddistinto l’approccio della
cosiddetta sociologia del curriculum di Basil Bernstein e del primo periodo della New Sociology of
Education inglese (ed è simboleggiato dalla celebre raccolta Knowledge and Control uscita a cura di
Michael Young nel 1971). Ciò che ha contraddistinto questo approccio, allora assai innovativo, allo
studio delle responsabilità autonome della scuola nelle disuguaglianze di fronte all’istruzione è stato in
particolare il fatto di interrogandosi per la prima volta sulle pretese di legittimità che le istituzioni
educative avanzano circa i saperi che trasmettono (il curriculum) e i modi di trasmissione di questi saperi
(la pedagogia e le forme di interazione tra insegnanti e alunni). Mettendo quindi questi saperi e questi
modi di trasmissione in prospettiva, relativizzandoli, ovvero, per dirla con Bourdieu, portando alla luce la
loro natura di «arbitrario culturale dominante». L’interesse, di natura macrosociologica e di ispirazione
marxista, per il rapporto tra i gruppi di potere all’interno della società e la sua politica del sapere
scolastico costituisce un filone in parte distintito che è simboleggiato da approcci come quello di Bowles
e Gintis (Schooling in Capitalist America, 1976) e Baudelot e Establet (L’école capitaliste en France,
1971). A metà tra quest’ultimo approccio macro e una sociologia del curriculum e dei criteri di
valutazione può essere considerata la prospettiva della Réproduction (1970) di Pierre Bourdieu. Un filone
ancora diverso è quello dello studio dell’interazione in classe di ispirazione etnomedotologica (sul quale
cfr. Fele e Paletti 2003), che ha dominato la seconda fase della New Sociology of Education inglese e nel
quale si possono far rientrare anche i lavori ispirati alla teoria dell’etichettamento, a cominciare
dall’analisi dell’«effetto Pigmalione» condotta da Rosenthal e Jacobson (Pygmalion in the Classroom,
1968), ma anche la ormai classica ricerca nella quale Ray Rist ha documentato come il ceto di
appartenenza degli alunni inizi a influenzare il comportamento degli insegnanti fin dalla scuola materna
(«Student Social Class and Teacher Expectations: The Self-Fulfilling Prophecy in Ghetto Education»,
1970) (per una rassegna, cfr. Trouillaud e Sarrazin 2003). Un ultimo filone che vale la pena ricordare qui
è quello dello studio del cosiddetto effetto istituto, e in particolare degli effetti indipendenti del fattore
segregazione vs. mescolanza sociale delle scuole sul rendimento scolastico dei loro alunni, un tema che è
132
stato posto per la prima volta con forza all’attenzione del dibattito sulle disuguaglianze di fronte
all’istruzione dal già citato Coleman Report del 1967 (cfr. sopra la nota 7) (cfr. Bressoux 1994).
11
Si potrebbe obiettare che quella dell’etnografia dell’educazione della classe operaia urbana e delle
minoranze etniche è una tradizione che preesiste alla svolta interpretativa degli anni Ottanta ed è radicata
in particolare, da un lato, per quel che riguarda la classe operaia urbana, nella sociologia britannica (tanto
nella New Sociology of Education quanto, ancora prima, nella tradizione britannica degli studi di
comunità), e, dall’altro, per quel che riguarda la scolarizzazione delle minoranze etniche,
nell’antropologia dell’educazione statunitense (cfr. per un confronto tra l’etnografia dell’educazione
inglese e americana Delamont e Atkinson 1980; sull’antropologia dell’educazione negli Stati Uniti la
rassegna di Van Zanten e Anderson-Levitt 1992). Le ricerche prodotte nell’ambito di queste due
tradizioni erano tuttavia per lo più focalizzate sull’esperienza scolastica degli alunni stessi e, in secondo
luogo, sulle interazioni che avevano luogo all’interno delle mura scolastiche (anche se non
sull’interazione in classe: cfr. per esempio Willis 1979). In altre parole, tranne eccezioni (come per
esempio fu, nella tradizione degli studi inglesi di comunità, la ricerca pionieristica di Jackson e Marsden
1962), in queste ricerche il modo in cui la scuola entrava nell’esperienza quotidiana delle famiglie e la
voce dei genitori trovavano poco posto. L’avere spostato l’attenzione sul modo in cui l’esperienza della
scolarizzazione è vissuta dalle e nelle famiglie costituisce quindi l’elemento di differenziazione principale
tra la «vecchia» etnografia dell’educazione inglese e americana e la «nuova», che, come vedremo, si è
sviluppata soprattutto in ambito statunitense e francofono.
12
In quanto segue userò come etichetta di comodo l’espressione filone cognitivista per indicare, per il
periodo classico, l’insieme delle ricerche sugli stili cognitivi e linguistici dell’interazione tra genitori e
figli e delle ricerche sulle rappresentazioni educative implicite dei genitori, e, per il periodo recente,
anche una parte delle ricerche sul rapporto epistemologico di studenti e genitori con i saperi scolastici.
13
Per avere una idea dello stato attuale di questo campo di ricerca si può per esempio consultare
utilmente la rivista Child Development, in cui proprio l’interazione didattica prescolare tra genitori e
bambini e le sue conseguenze sullo sviluppo cognitivo e l’adattamento scolastico costituisce uno degli
argomenti più frequenti degli articoli pubblicati. Il tema delle teorie educative implicite è pure un ambito
di indagine attuale della psicologia dello sviluppo (cfr. per esempio Mugny e Carugati 1989 sulle
concezioni dell’intelligenza; Vandenplas-Holper 1987; Goodnow e Collins 1990), e particolarmente della
cosiddetta psicologia dello sviluppo interculturale, che si occupa appunto di come le concezioni del
bambino e del suo sviluppo varino tra le varie culture etniche e nazionali (cfr. Harkness e Super (eds.)
1996; Harkness, Raeff e Super (eds.) 2000; Sigel (ed.) 1985). Si vedano per esempio su questo tema le
attività dei membri dell’ARIC (Association pour la recherche interculturelle) dell’Università di Friburgo,
delle quali ci si può fare un’idea in Bril, Dasen, Sabatier e Krewer (eds.) 1999; Sabatier e Dasen (eds.)
2001. Ma, come vedremo, quello delle teorie educative implicite è un oggetto di ricerca che continua ad
essere frequentato anche in ambito sociologico, seppure non da solo e per lo più nel contesto dello studio
culturalista delle disuguaglianze educative. Un interesse per questo argomento è presente
tradizionalmente anche nella letteratura sociologica di impostazione femminista, dove il focus dell’analisi
è in primo luogo sulle concezioni femminili del ruolo materno. Cfr. per esempio i recenti studi di Mahrer
Kaplan 1992 e Ribbens 1994 sulle madri di ceto medio.
14
Ma anche, in forme più specialistiche, nella sociolinguistica. A questo proposito vale senz’altro la pena
di citare il lavoro più recente di William Labov, i cui interessi di ricerca negli ultimi anni si sono
concentrati sempre più sullo studio dell’apprendimento della lettura, con particolare riferimento alle
difficoltà e agli «errori» di lettura specifici di bambini e adulti dei ceti popolari e/o delle minoranze
etniche. Un tema, quest’ultimo, che peraltro era già presente in Language in the Inner City (1972).
15
Anche dati relativi al contesto francese di questo stesso periodo (anni Cinquanta) si accordano nel a
maggiore severità delle pratiche educative del ceto popolare rispetto a quelle del ceto medio: cfr. in
particolare Lobrot 1962.
16
La bibbia del Dottor Spock, The Common Sense Book of Baby and Child Care, era uscita per la prima
volta nel 1946, e prima ancora, come osserva Diana Baumrind,
il punto di vista psicoanalitico secondo il quale la gratificazione completa nel
bambino delle sue necessità legate al succhiare, all’espellere e all’esplorazione
genitale è essenziale per una personalità adulta solida e sana aveva fornito una
giustificazione per un allattamento prolungato a richiesta, uno svezzamento graduale
133
e tardivo, una educazione sfinterica tardiva e tollerante. [...] L’introduzione vigorosa
nella filosofia educativa di attitudini permissive e bambino-centriche è iniziata
almeno quarant’anni fa [a metà degli anni Venti] [...] come in parte un risultato della
teoria psicoanalitica dello sviluppo sessuale.
(Baumrind 1966, p. 808)
Così,
Nei tardi anni Quaranta e negli anni Cinquanta la casa o la scuola ideale era
organizzata attorno all’accettazione illimitata dei bisogni di gratificazione del
momento del bambino, piuttosto che attorno alla preparazione per la vita adulta. Al
bambino doveva essere assicurata la massima libertà di scelta ed espressione in
entrambi i contesti.
(ibidem)
Sull’influenza delle teorie psicoanalitiche dello sviluppo della personalità infantile sulle
raccomandazioni relative alle tecniche di puericultura negli anni Quaranta, cfr. anche Sewell
1952.
17
Come osserva anche Haber,
[Negli Stati Uniti dei primi anni Cinquanta] erano in circolazione due modelli di
raccomandazioni e pratiche [sull’educazione dei bambini]. Il primo, l’approccio
rigido, della disciplina, era di moda negli anni Trenta e nel decennio precedente. Il
secondo, l’approccio permissivo, dell’autocontrollo, era sostenuto negli anni
Quaranta e in quelli immediatamente successivi. [...] Una delle fonti del
cambiamento [...] è l’influenza sulle raccomandazioni relative alla cura dei bambini
delle nuove ricerche sullo sviluppo infantile. [...] Le pratiche di cura delle madri di
ceto medio mostravano una stretta affinità con le principali raccomandazioni degli
esperti. [...] I dati sulle tendenze storiche e sul divario temporale tra
raccomandazioni e pratiche suggeriscono la conclusione provvisoria che
l’esposizione a un modello di raccomandazioni relative alla cura dei bambini
influenza le pratiche di cura in modo particolare nelle famiglie di ceto medio.
(Haber 1962, pp. 684-685)
18
Non si possono non citare anche le parole con quali Bronfenbrenner chiude il suo saggio: «negli ultimi
anni», egli scrive, «ci sono state [...] delle indicazioni che la divergenza tra le classi sociali si sta
restringendo: ed è questo il problema di studio per il futuro» (Bronfenbrenner 1958, tr. it. p. 47,
sottolineatura mia). È infatti veramente difficile trovare nella letteratura sul tema dell’educazione
familiare di cinquant’anni fa riflessioni altrettanto profetiche. I risultati di questa ricerca mettono
chiaramente in luce il fatto che, in materia di permissivismo educativo, non solo questa divergenza tra i
ceti medi e i ceti popolari si è ristretta fino a scomparire, ma è riapparsa questa volta nella direzione
opposta.
19
Scrive Jean-Claude Forquin:
Il fatto che […] si manifestino delle differenze nei comportamenti quotidiani dei
genitori nei confronti della scolarità dei propri figli (aiutarli o non aiutarli nei
compiti, fare o non fare loro recitare la lezione, andare o non andare a parlare con gli
insegnanti, ecc.), questo significa che le attitudini profonde verso l’istruzione
divergono, che gli uni accordano alla scuola più valore degli altri? Non ci sono altre
interpretazioni possibili di queste differenze: diseguaglianze di competenze
«pedagogiche», di disponibilità temporale, di familiarità con il mondo scolastico e i
suoi «rituali»?
(Forquin 1982b, p. 59)
20
Non si può non notare la singolare affinità tra questa osservazione di Duvall sul grado di apertura dei
ruoli familiari nei diversi ceti e la riflessione – pure molto più raffinata ed elaborata – che a questo stesso
tema avrebbe dedicato qualche anno più tardi Basil Bernstein, elaborando la distinzione tra famiglie
posizionali (con confini tra i ruoli rigidi) prevalenti nei ceti popolari e famiglie orientate verso l’individuo
134
(con confini tra i ruoli flessibili) prevalenti nei ceti medi (cfr. tra gli altri Bernstein 1971). Su Bernstein, si
veda sotto, il paragrafo 2.2.2.2.
21
In questo limite metodologico Duvall è un esempio dello sguardo «oggettivistico» del periodo classico.
22
Nel 1963, riferendosi ai quasi vent’anni che erano allora trascorsi dalla ricerca di Duvall, Kohn
osservava a questo proposito:
I pochi risultati significativi di studi successivi [a quello di Duvall] sono interamente
coerenti con questo punto essenziale, specialmente nelle ripetute indicazioni del
fatto che i genitori di classe operaia enfatizzano molto di più l’obbedienza agli ordini
dei genitori dei genitori di classe media.
(Kohn 1963, p. 475)
Per una conferma di questi risultati relativa al contesto britannico, si può vedere per esempio il noto
studio della psicoanalista Josphine Klein sulle subculture di ceto inglesi (Klein 1965). Per quanto riguarda
il contesto francese, si possono vedere in particolare Perron 1971 e Lautrey 1980. Infine, per un confronto
trasnazionale sul rapporto tra appartenenza di ceto e valori educativi genitoriali si può vedere utilmente
Inkeles 1960, dove sono riportati e commentati i risultati di una indagine condotta sul tema dall’istituto di
ricerca privato INRA (International Research Associates) nel 1958 in 11 Paesi (Austria, Gran Bretagna,
Danimarca, Germania, Italia, Olanda, Norvegia e Svezia per l’Europa, e inoltre Australia, Brasile e
Giappone).
23
Su questo legame inestricabile tra dimensione normativa e dimensione cognitiva, Leslie e Johnsen
osservano giustamente che «il concetto di comportamento infantile accettabile [...] riflette un sistema di
valori che include l’“adulto ideale” come pure i fini dell’educazione familiare» (Leslie e Johnsen 1963, p.
927) – i quali a loro volta, va aggiunto, sono strettamente legati alla concezione antropologica del
bambino e del percorso che lo fa diventare un adulto.
24
La ricerca alla quale Kohn si riferisce è la prima che egli ha condotto sull’argomento. I suoi risultati
sono discussi in Kohn 1959a:
Le madri di classe operaia è più probabile che valorizzino l’obbedienza;
desidererebbero che i propri figli reagissero con prontezza all’autorità dei genitori.
Le madri di classe media è più probabile che valorizzino sia il rispetto sia
l’autocontrollo; desidererebbero che i propri figli sviluppassero un controllo interno
e una apertura amichevole agli altri. Inoltre, le madri di classe media è più probabile
che considerino la curiosità come la prima virtù. Al contrario, le madri di classe
operaia enfatizzano l’ordine e la pulizia, valorizzando il bambino che ha desiderio di
esplorare ed è ricco di immaginazione in misura relativamente minore del bambino
che è presentabile. [...] I valori [dei padri] sono simili a quelli della madri.
(Kohn 1959a, p. 340)
25
«Ci sono almeno tre rispetti», scrive in particolare Kohn
in cui le occupazioni di classe media differiscono tipicamente dalle occupazioni di
classe operaia, oltre e più delle loro ovvie differenze di status relative alla sicurezza,
alla stabilità e al reddito, e al prestigio sociale generale. Una è che le occupazioni di
classe media hanno a che fare di più con la manipolazione dei rapporti
interpersonali, delle idee e dei simboli, mentre le occupazioni di classe operaia
hanno a che fare di più con la manipolazione delle cose. La seconda è che le
occupazioni di classe media sono più soggette all’autodirezione, mentre le
occupazioni di classe operaia sono più soggette alla standardizzazione e alla
supervisione diretta. La terza è che lo svolgimento delle occupazioni di classe media
è maggiormente dipendente dalle proprie azioni, mentre nelle occupazioni di classe
operaia è più dipendente dall’azione collettiva.
(Kohn 1963, pp. 475-476)
26
Vale la pena di ricordare qui il debito che verso questa ipotesi di corrispondenza tra condizione
professionale e valori educativi formulata da Kohn hanno, tra gli altri, le tesi critiche radicali sostenute da
Samuel Bowles ed Herbert Gintis nel loro celebre Schooling in Capitalist America (1976). Anche Donald
135
McKinley (1964) ha messo in relazione i modi di socializzazione familiare dei bambini con la condizione
professionale dei genitori. A differenza di Kohn, McKinley si è interessato tuttavia agli effetti di questa
condizione sulle pratiche educative, e agli effetti di queste ultime sull’achievement motivation dei figli. In
termini essenziali, la tesi di McKinley è che l’atteggiamento punitivo e di rifiuto verso i figli,
l’aggressività e lo scarso coinvolgimento educativo diffusi tra i padri dei ceti operai urbani vadano
interpretati come un effetto delle frustrazioni legate all’inferiorità del loro status professionale. Ovvero,
come una sorta di dislocazione dell’aggressività dalla struttura dei rapporti di potere sociale in cui tale
aggressività viene generata alla struttura dei rapporti familiari nei quali, soltanto, essa trova sfogo.
McKinley si accorda poi con numerose altre ricerche nel rilevare che questo atteggiamento paterno di
aggressività e rifiuto ha conseguenze negative sull’autostima e quindi sull’achievement motivation dei
figli.
27
Nel questionario a risposte chiuse e nel protocollo di intervista semi-strutturata (riportati integralmente
nell’Appendice di Lautrey 1980) con i quali Lautrey ha raccolto i dati della sua indagine presso un
campione di famiglie, gli stili di strutturazione sono stati operazionalizzati attraverso domande relative
allo svolgimento di una normale giornata del bambino. I temi trattati sono stati in particolare
l’organizzazione del tempo (la regolarità degli orari quotidiani) e dello spazio (il posto degli oggetti in
casa e gli spostamenti del bambino dentro e fuori casa), la regolazione della vita fisica (i pasti, la pulizia,
la sessualità, il sonno, le situazioni di pericolo fisico) e sociale (le regole di buona educazione e le attività
di svago) del bambino. Quindi, come sottolinea Lautrey, «le domande non riguardavano mai delle
opinioni, delle attitudini o dei fatti generali, ma erano sempre relative a dei comportamenti precisi, a dei
fatti concreti. [...] Le situazioni evocate erano tutte centrate sugli aspetti più quotidiani della vita
familiare» (Lautrey 1980, p. 90). Così, per esempio, nell’intervista a domande chiuse, nella domanda
relativa a «i tragitti da scuola a casa alla sera», le opzioni nelle quali erano operazionalizzati i tre stili di
strutturazione erano le seguenti: per la strutturazione rigida, «avete fissato un’ora di ritorno molto precisa
e la rispetta in modo puntale»; per la strutturazione debole, «gli capita spesso di attardarsi per la strada
(sia perché lo lasciate libero sia perché non tiene conto del vostro divieto)». La domanda su «i giochi a
casa» proponeva invece queste scelte di risposta: per la strutturazione rigida, «gioca esclusivamente nei
luoghi che avete stabilito per quello (ad esempio, la sua camera, il corridoio, o una qualunque altra
stanza)»; per la strutturazione debole, «gioca ovunque nell’appartamento»; per la strutturazione morbida,
«gli capita spesso di giocare fuori dai luoghi che avete stabilito per quello. Accettate, a certe condizioni
(per esempio, che faccia dei giochi calmi o che disegni)» (cfr., per tutto il questionario, ivi, pp. 94-96).
28
Commentando le singole qualità del bambino scelte dai genitori dei diversi ceti Lautrey scrive:
[Per i ceti popolari] è chiaramente il caso dell’obbedienza, ma ci sembra che sia
anche il caso della buona educazione che, così come veniva definita dai genitori nel
corso dell’intervista, assomigliava spesso a un segno esteriore della sottomissione
agli adulti. La pulizia ha acquisito un significato vicino [...]. La qualità di bravo
scolaro [...] anch’essa presuppone la conformità al modello scolastico. In breve, a
prima vista, ciò che è importante e problematico nell’educazione dei bambini dei
ceti popolari sembra essere la sottomissione ad un’autorità esterna, la conformità a
un modello. [Per i medio-alti] è chiaramente il caso dello spirito critico e della
curiosità che incitano ad accordare maggiore credito alle proprie inclinazioni che a
un modello imposto. L’importanza accordata al rispetto degli altri ci sembra
coerente con questo orientamento, segnatamente in virtù del suo corollario che è il
rispetto da parte degli altri delle proprie convinzioni e dei propri modi di vedere.
Anche la perseveranza è una qualità che permette all’individuo di perseguire un
compito di propria iniziativa, senza costrizioni esterne.
(Lautrey 1980, pp. 149-159)
29
Questa coerenza include anche, aggiunge Lautrey, «le conclusioni degli studi americani e francesi più
recenti» (ivi, p. 169) sulla severità degli stili educativi di ceto e sulle forme di esercizio dell’autorità
familiare. Sebbene, infatti, «a prima vista ci sono poche sovrapposizioni tra i fatti ai quali rinviano questi
concetti [di severità, modi di autorità e tecniche di disciplina] e quelli che permettono di identificare la
forme delle regole e abitudini che organizzano la vita familiare» (ibidem),
queste due categorie di fatti non sono tuttavia senza rapporto, nella misura in cui
l’attitudine autoritaria e la severità appaiono come dei mezzi per mantenere una
forme di strutturazione rigida. Quando delle costrizioni imperiose conducono i
genitori a stabilire delle regole o abitudini intangibili, questi ultimi sono più spesso
136
condotti, per mantenerle, ad avvalersi del proprio potere e a sanzionare duramente. È
dunque verosimilmente perché sono legati in modo funzionale che il tipo di
strutturazione rigida e i comportamenti di autorità e di severità intrattengono con la
classe sociale una relazione dello stesso tipo. In maniera analoga, l’attitudine
democratica, istituendo una forma di condivisione del potere con il bambino, non
può apparire che quando è possibile soddisfare spesso i desideri che esprime, vale a
dire quando è possibile modulare le regole in funzione delle circostanze. In altri
termini, la varietà delle possibilità che è alla base delle forme flessibili di
strutturazione dell’ambiente familiare è una condizione necessaria all’instaurazione
di relazioni democratiche tra genitori e figli.
(ivi, pp. 169-170)
30
Lautrey sottolinea come questa influenza della disponibilità di risorse familiari sulle interazioni tra
genitori e figli si estenda al di là dei domini di attività effettivamente condizionati dalle possibilità
materiali per dare vita a uno stile di interazione più generale. In altri termini, non tutte le scelte della
rigidità nelle regole di comportamento compiute dalle famiglie di ceto popolare che mostravano uno stile
globale di strutturazione rigida «apparivano direttamente determinate dalle condizioni di vita», ma alcune
«regolarità [...] sfuggivano probabilmente ad una determinazione diretta da parte delle condizioni di vita,
almeno di quelle legate alla condizione sociale»:
Se le famiglie dei ceti popolari scelgono più spesso l’occorrenza di tipo rigido,
compreso in quelle situazioni, ciò accade forse perché, dettando il comportamento in
una quantità di situazioni, le condizioni di vita determinano uno stile di interazione
con il bambino, un’attitudine che si estende all’insieme delle situazioni, comprese
quelle che non dipendono direttamente da esse.
(ivi, p. 140)
A questo proposito mi pare interessante notare che, nel suo ritratto dell’habitus popolare, Bourdieu
interpreta il rapporto con l’alimentazione della cultura popolare in termini in qualche modo opposti a
quelli di Lautrey. Questo rapporto, il franc-manger popolare, come Bourdieu lo chiama e lo descrive, si
contraddistingue infatti per un rifiuto delle costrizioni, tanto di natura estetica (quindi, di attenzione alla
forma della presentazione e alla ritualità del pasto) quanto legate alle preoccupazioni salutistiche e
dietetiche tipiche di un’«etica della sobrietà». In quanto tale, scrive Bourdieu, «l’arte di bere e di
mangiare resta forse uno dei soli terreni sui quali le classi popolari si oppongono esplicitamente all’arte di
vivere legittima» (Bourdieu 1979, p. 200). Ed è interessante che Bourdieu interpreti questo rifiuto dei
limiti nella sfera dell’alimentazione come una sorta di reazione di rivincita dei membri dei ceti popolari
alle pesanti costrizioni che condizionano tutte le altre sfere della loro vita:
La radice comune di tutte queste «licenze» che ci si accorda [nella sfera
dell’alimentazione] è forse la sensazione che uno non si può mettere a imporsi, come
se non bastasse, dei controlli, delle costrizioni e delle limitazioni deliberate – e
questo proprio nel campo dell’alimentazione, bisogno primario e rivincita – e
proprio all’interno della vita domestica, solo asilo di libertà, quando da tutte le parti
e per tutto il resto del tempo è sottoposto alla necessità.
(ivi, p. 218)
31
A proposito della presenza rilevata in una parte minoritaria di famiglie dei ceti popolari di forme di
strutturazione debole, che come abbiamo visto risultano diffuse ai due margini opposti della scala sociale,
Lautrey sottolinea come per lo più le condizioni materiali di esistenza di queste famiglie fossero
caratterizzato da una precarietà estrema e il loro profilo socioeconomico fosse quindi in realtà molto
vicino a quello del sottoproletariato:
Si trattava chiaramente di famiglie che avevano perso ogni speranza, e forse ogni
desiderio, di integrarsi nella società. A partire dal momento in cui non cerca più di
mantenersi – e soprattutto di mantenere il bambino – nella norma, non le è più
necessario organizzarsi in maniera rigida all’interno del margine che le è lasciato tra
l’ospedale e il commissariato.
(Lautrey 1980, p. 142)
32
Un chiarimento, cioè, del fatto che è alla saussuriana parole e non alla langue – e quindi non a un
linguaggio ma a un uso socialmente specifico di esso – che ci si riferisce quando si parla, come fa
137
Bernstein, di una «forma linguistica [che] è considerata come una conseguenza della relazione sociale, o,
più in generale, [...] una qualità della struttura sociale» (Bernstein 1971, p. 237). «Il linguaggio», arriverà
a chiarire Bernstein nel 1971, «è un insieme di regole alle quali tutti i codici sociolinguistici devono
conformarsi, ma quali codici sociolinguistici siano realizzati dipende dalla cultura che agisce attraverso i
rapporti sociali in contesti specifici» (ibidem).
33
Scrive Bernstein:
In un linguaggio formale il significato è logicamente esplicito e finemente
differenziato, mentre in un linguaggio pubblico il significato è implicito e
rozzamente differenziato. Per «differenziato» si intende non semplicemente
l’estensione degli oggetti che sono elaborati o significanti ma l’ordine logico
dell’elaborazione o del significato. Cioè, la matrice di relazioni che suscitano.
(Bernstein 1959, p. 316)
34
Questa diversità di esperienze ha origine segnatamente, secondo Bernstein, nel modo differente in cui
nelle famiglie di ceto popolare e di ceto medio si stabilisce la prima relazione – affettiva – tra la madre e
il bambino. Mentre nelle seconde l’affettività passa principalmente attraverso la simbolizzazione verbale
e questo fa sì che il rapporto tra il bambino e la madre sia fin dall’inizio una relazione simbolicamente
mediata, nelle prime il linguaggio non è il principale veicolo di trasmissione dell’affettività, che tende ad
essere espressa piuttosto attraverso il ricorso a simboli espressivi. Questo fa sì che nei ceti popolari «la
relazione del bambino con la madre è di una natura diretta, immediata» (Bernstein 1961, p. 297):
[Nei ceti medi] la prima relazione linguistica tra madre e bambino è essenzialmente
una relazione che massimizza la differenziazione e la discriminazione cognitiva e
affettiva, piuttosto che l’inclusività affettiva e l’identità. [...] Uno degli obiettivi
della famiglia di classe media è produrre bambini orientati a certi valori ma
individualmente differenziati tra loro. Il bambino è nato in un ambiente che lo
considera e reagisce a lui come a un individuo con i propri diritti, cioè, ha uno status
sociale specifico. [...] Nella classe operaia inferiore la relazione linguistica tra madre
e bambino è di un ordine diverso. È essenzialmente un forma verbale in cui,
inizialmente, i qualificativi personali vengono fatti attraverso un simbolismo
espressivo, cioè non verbalmente. [...] È una forma verbale che massimizza
l’esperienza diretta dell’affettività inclusiva piuttosto che la differenziazione
emotiva e cognitiva verbalmente condizionata.
(ivi, pp. 294-297)
35
Quella che potremmo definire, in un linguaggio poco ortodosso, l’«imprevidenza del povero» è uno dei
temi in assoluto più ricorrenti della letteratura sulla cultura dei ceti popolari, e non solo di quella che ha
esplorato in particolare il rapporto di questa cultura con il mondo dell’istruzione e la mobilità sociale. Di
quest’ultima va certamente ricordato il filone di ricerca classico di ispirazione parsonsiana sui cosiddetti
«valori del successo» e sulla loro distribuzione sociale (cfr. sopra il paragrafo 1.2.1.1.1 del capitolo 1). È
stato proprio in questo ambito che è stata coniata tra l’altro la definizione di attitudine alla gratificazione
differita per indicare l’antitesi borghese e piccolo borghese dell’«imprevidenza» popolare. Ma, per citare
davvero a caso, l’orientamento al presente è anche uno dei tratti distintivi degli adolescenti americani di
classe operai degli anni Quaranta studiati da Hollingshead in Elmtown’s Youth (1949), dei loro quasi
coetanei inglesi (e soprattutto le relative famiglie) ritratti da Hoggart in The Uses of Literacy (1957) dei
discendenti di questa classe operaia inglese studiati da Paul Willis in Learing to Labour (1977), fino ai
ceti popolari questa volta francesi degli anni Sessanta evocati da Bourdieu in La Distinction (1979), dei
quali Bourdieu stesso scrive:
Il gusto «modesto» [della piccola borghesia] che sacrifica gli appetiti e i piaceri
immediati ai desideri e alle soddisfazioni a venire si oppone al materialismo
spontaneo delle classi popolari che rifiutano di entrare nella contabilità benthamiana
dei piaceri e delle pene, dei profitti e dei costi. [...] Si comprende meglio come il
materialismo pratico che si manifesta soprattutto nel rapporto con il cibo sia una
delle componenti più fondamentali dell’ethos, ovvero dell’etica popolare: la
presenza al presente, che si afferma nel desiderio di approfittare dei buoni momenti
e di prendere il tempo come viene, [...] [in una] sorta di immanentismo temporale.
(Bourdieu 1979, pp. 201 e 203)
138
Anche se poi lo stesso Bourdieu aggiunge che nei ceti popolari «è ancora una sorta di calcolo economico
che scoraggia di sottomettere l’esistenza al calcolo economico» (ivi, p. 203), cioè l’imprevidenza
popolare ha una sua razionalità perché le
due disposizioni verso l’avvenire [...] sono esse stesse in un rapporto di causalità
circolare con due avvenire oggettivi: contro l’antropologia immaginaria della
scienza economica che non si è mai tirata indietro di fronte alla formulazione di
leggi universali della «preferenza temporale», bisogna ricordare che la propensione a
subordinare i desideri presenti ai desideri futuri dipende dalla misura in cui questo
sacrificio è «ragionevole», vale a dire dalle possibilità che si hanno di ottenere in
ogni caso delle soddisfazioni future superiori alle soddisfazioni sacrificate. [...]
L’edonismo che conduce a prendersi giorno per giorno le rare soddisfazioni («i
buoni momenti») del presente immediato è la sola filosofia concepibile per coloro
che, come si dice, non hanno avvenire e che hanno in ogni caso poco da aspettarsi
dall’avvenire.
(ibidem)
36
Va ricordato che l’orientamento temporale figura anche tra i cinque orientamenti culturali fondamentali
già identificati da Florence Kluckhohn (cfr. Kluckhohn 1950; Kluckhohn e Strodtbeck 1961). O, più
esattamente, e parsonsianamente, come uno dei cinque problemi umani universali che tutti gli individui e
tutte le società si trovano a dover affrontare. Ciascuno di questi problemi prevede un numero limitato di
soluzioni, e queste diverse soluzioni, proprio come le pattern variables di Parsons, definiscono i principi
di orientamento culturale fondamentali degli individui e delle società. Che in Variations in Value
Orientations (1961) Kluckhohn e Strodtbeck definiranno orientamenti di valore, intendendo con essi
tanto i valori consci quanto l’ethos incoscio («un’astrazione dal comportamento di individui in quanto
attori in situazioni», Kluckhohn 1950, p. 383), vale a dire principi di orientamento che possono «operare
sia a un livello manifesto sia a un livello latente, poiché il grado di consapevolezza che gli individui
hanno degli orientamenti di valore che influenzano il loro comportamento varierà da completamente
implicito a completamente esplicito» (Banks 1971, p. 75). Così, le risposte al problema di «qual è la
dimensione temporale significativa, o qual è la direzione nel tempo del processo di azione» (Kluckhohn
1950, p. 378) possono essere un’enfasi sul passato, sul presente o sul futuro: «una società orientata al
presente sottolinea il merito del vivere nel presente con un’enfasi sulle gratificazioni immediate; una
società orientata al futuro sprona l’individuo a credere che la pianificazione e i scarifici presenti siano
utili, o siano un obbligo morale, per garantirsi guadagni futuri» (Rosen 1956, p. 208). Un secondo
problema è «quali sono le predisposizioni innate degli uomini» (ibidem), ovvero la concezione della
natura umana, che può essere vista come malvagia, buona o come una mescolanza di bontà e cattiveria. Il
terzo problema è «qual è la relazione dell’uomo con la natura» (ibidem), e nella concezione del rapporto
tra l’uomo e la natura l’uomo può essere visto come soggiogato dalla natura, come padrone, o infine
come in un rapporto di armonia con essa. È quest’ultimo un problema che si riferisce ad una dimensione
dell’ethos molto vicina a quella relativa alla concezione della responsabilità individuale nel proprio
destino e del locus, interno o esterno, della causalità. Tant’è vero che, nell’utilizzo che fa del modello di
Kluckhohn per lo studio della sindrome della riuscita (achievement syndrome), Bernard Rosen definisce
questo orientamento culturale anche come orientamento all’attivismo vs. alla passività, e lo descrive
come
la misura in cui una società o un sottogruppo incoraggia l’individuo a credere nella
possibilità di manipolare l’ambiente fisico e sociale a proprio vantaggio. In una
società orientata all’attivismo l’individuo è incoraggiato a credere che è sia possibile
sia necessario per lui migliorare il suo status, mentre un orientamento alla passività
favorisce l’accettazione dell’idea che gli sforzi individuali per raggiungere la
mobilità siano relativamente inutili.
(Rosen 1956, p. 207)
Il quarto problema è «qual è il tipo di personalità che è maggiormente valorizzato» (ibidem), che
Kluckhohn e Strodtbeck hanno riformulato in seguito come il problema della concezione del significato
dell’agire. In questo caso, le risposte possibili sono un’enfasi posta sull’essere, sull’essere in divenire, o
sul fare (o sul risultato). Infine, il quinto problema ha a che fare con «qual è la modalità dominante di
relazione dell’uomo con gli altri uomini» (ibidem), ovvero con «l’orientamento che esprime in termini
generalissimi [...] il carattere della solidarietà sociale» (ivi, p. 381). L’orientamento relazionale può
essere «lineare», «collaterale» o «individualistico»: il primo caratterizza una struttura di relazioni che
enfatizza il legame temporale («che deriva sia da fattori biologici sia dal fatto che gli essei umani hanno
139
una tradizione culturale che viene trasmessa nel tempo», ibidem) e gerarchico tra i membri della società;
il secondo una struttura di relazioni che enfatizza il legame di consanguineità; il terzo relazioni che
enfatizzano «l’autonomia individuale» (ibidem) e dunque l’indipendenza. Sempre nella riformulazione di
Rosen, questa dimensione è definita come orientamento familista vs. individualista (Rosen 1956, p. 208):
«in una società orientata al familismo l’individuo non è sollecitato, o forse non gli viene permesso, a
raggiungere l’indipendenza dai legami familiari. Una società orientata all’individualismo non si aspetta
che l’individuo mantenga il genere di legami affettivi che impediranno la sua mobilità» (ibidem). La
prima formulazione di questo schema nell’articolo del 1950 è stata fatta da Florence Kluckhohn proprio
con l’obiettivo di elaborare uno strumento per lo studio culturalista della stratificazione sociale. Sulla base
della tesi che in ogni società in un momento dato del tempo una delle possibili risposte a ciascuno dei
problemi rappresenterà l’orientamento culturale dominante, mentre gli altri saranno «orientamenti
culturali alternativi»: «più precisamente, le società hanno un profilo dominante di orientamenti culturali
identificabile e altrettanto identificabili profili sostituti» (ivi, p. 376). E i gruppi tra i quali la società è
stratificata vanno studiati «per il loro grado di aderenza agli orientamenti dominanti, o al contrario per il
loro spostamento su valori e schemi di comportamento che esprimono orientamenti alternativi» (ivi, p.
383). Nella società statunitense di allora, aggiunge poi Kluckhohn,
il profilo della [...] core culture americana può essere delineato come una enfasi
sugli orientamenti seguenti: orientamento relazionale individualistico; orientamento
al risultato, in cui il giudizio sul valore di una persona è basato principalmente sui
suoi risultati, sulla sua produttività; l’uomo conto la natura, o orientamento alla
padronanza razionale; e la definizione della natura umana come malvagia ma
perfettibile.
(ivi, pp. 382-383)
Analogamente, nella sua applicazione del modello di Kluckhohn allo studio della sindrome della riuscita
Rosen osserva che «le risposte che indicano una prospettiva attivista [nella concezione del rapporto tra
l’uomo e l’ambiente], rivolta al futuro, individualistica [...] sono considerate quelle che riflettono i valori
che più probabilmente facilitano la riuscita e la mobilità sociale», e aggiunge che «la classe media è
caratterizzata da una proporzione più ampia di persone con valori orientati alla riuscita rispetto agli strati
sociali inferiori» (Rosen 1956, p. 208). Un ritratto per molti versi simile a quello che della classe media fa
Parsons con l’aiuto delle sue cinque pattern variables: «la sua immagine della cultura della classe
media», osserva Kahl, «enfatizza l’universalismo, la specificità, la neutralità affettiva, l’orientamento al
sé, e l’acquisizione» (Kahl 1965, p. 671), laddove al contrario caratteristiche dell’ethos popolare sono il
particolarismo, il sentimento di obbligazione diffusa, il coinvolgimento affettivo, l’orientamento al
gruppo e la valutazione dello status sulla base di criteri ascrittivi.
37
Sulla quale si veda anche, in una prospettiva antropologica, le belle pagine che il giovane Bourdieu ha
dedicato alla concezione del tempo dei contadini e dei sottoproletari algerini (Bourdieu, Darbel, Rivet e
Seibel 1963; Bourdieu 1977).
38
Come vedremo meglio in seguito, nello specifico del rapporto soggettivo che i genitori intrattengono
con il futuro dei propri figli, la concezione tipica del ceto medio del futuro individuale come qualcosa su
cui l’individuo ha controllo assume la forma di una idea forte e ottimistica di educabilità del bambino. In
primo luogo, cioè, dell’idea che il fine dell’educazione familiare (e dunque il ruolo dei genitori) consista
nel plasmare la personalità del bambino favorendone lo sviluppo nella direzione ritenuta desiderabile – e,
quindi, prima ancora, dell’idea che questo condizionamento sia effettivamente possibile, cioè che il
bambino sia un essere radicalmente educabile. In secondo luogo, di una fiducia nelle proprie capacità di
genitori di orientare nella direzione desiderata la crescita dei propri figli. Al contrario, nel dominio delle
concezioni educative genitoriali la rappresentazione fatalistica del futuro individuale come qualcosa sul
quale l’individuo ha scarso controllo assume la forma di una concezione molto diversa del ruolo
genitoriale. Che si potrebbe certamente definire «ridotta» se la si leggesse, con una operazione di
«etnocentrismo di classe» (Combessie 1969), prendendo come riferimento la prima. Perché, in questa
seconda concezione, ciò che spetta al genitore è soprattutto assecondare e assistere «il compiersi della
crescita naturale» dei propri figli, come la definisce Annette Lareau (Lareau 2003). La crescita «naturale»
è in particolare quella che è inscritta nella personalità del bambino, che in quest’ottica è concepita come
largamente innata e in quanto tale immodificabile. Il bambino è cioè visto come un essere scarsamente
educabile, se per educabilità si intenda, come sopra, l’insieme delle azioni educative finalizzate ad
orientare il suo sviluppo in una direzione deliberatamente scelta. E soprattutto i suoi genitori devono
ringraziare soprattutto – o prendersela con – il destino per il figlio che gli è capitato in sorte e la «buona»
o la «cattiva riuscita» che quest’ultimo ha fatto.
140
39
Come osserva Bernard Rosen,
Mentre è probabilmente vero che l’idea secondo la quale il successo è desiderabile e
possibile è diffusa nella nostra società, i valori che la implementano – quelli che
incoraggiano il comportamento che facilita la riuscita – sono stati a lungo associati
più alla cultura della classe media che a quella della classe inferiore. È più probabile
che ai bambini di classe media venga insegnato non solo a credere nel successo, ma
anche ad essere disposti a fare quei passi che rendono la riuscita possibile; in breve,
ad abbracciare il sistema di valori della riuscita che affermano che data la buona
volontà di lavorare duro, pianificare e fare gli opportuni sacrifici, un individuo
dovrebbe essere in grado di manipolare il proprio ambiente in modo da garantirsi
alla fine il successo.
(Rosen 1956, p. 211)
In termini analoghi, Joseph Kahl osserva che «in generale il fine del “successo” è diffuso attraverso la
gerarchia di classe, ma il contenuto specifico di questo fine e i mezzi con i quali può essere raggiunto
variano in modo significativo» (Kahl 1965, p. 678). Sui significati differenziali del successo nei diversi
ceti, si veda in particolare Katz 1964.
40
Una distinzione analoga è anche quella che fa Philippe Perrenoud tra i due grandi modelli di
spiegazione culturalista delle disuguaglianze di fronte all’istruzione in termini di modi di socializzazione
familiare di ceto, modelli che egli definisce della spiegazione attraverso l’eredità culturale e della
spiegazione attraverso l’orientamento culturale (Perrenoud 1970):
La spiegazione attraverso l’eredità culturale può situarsi:
- a livello delle strutture logico-sintattiche inconsce, che tendono a delle forme di
equilibrio invarianti, ma differenti a seconda dell’ambiente per il ritmo di sviluppo e
il grado di perfezione, legati segnatamente agli strumenti linguistici disponibili;
- a livello delle abitudini mentali e degli schemi di pensiero per l’essenziale
inconsci, posti, a seconda degli ambienti, a una distanza variabile dagli schemi e
dall’ethos istituiti dalla scuola;
- a livello dei contenuti culturali specifici, delle conoscenze extrascolastiche, della
familiarità con le opere e gli standard estetici.
[...]
La spiegazione attraverso l’orientamento culturale [...] [può situarsi] a tre livelli:
- il livello della personalità, in particolare sotto l’angolo del need for achievement o
achievement motive, tradotto imperfettamente come motivazione alla realizzazione o
alla riuscita;
-il livello dell’ethos, considerato questa volta nei suoi aspetti «prescrittivi» o
«normativi», in quanto sistema implicito di valori inconsci, «luogo geometrico»
delle attitudini e dei comportamenti specifici;
- il livello dei valori, attitudini e rappresentazioni manifeste della famiglia e del
bambino a proposito del sapere, della scuola, dei criteri e delle vie della riuscita
sociale.
(Perrenoud 1970, pp. 23-24)
41
Come vedremo meglio nel Capitolo 5, questo rapporto strumentale con la scuola si manifesta,
soprattutto riguardo all’istruzione infantile primaria e prescolare, con la tendenza spesso rilevata delle
famiglie popolari a tracciare «una forte cesura tra gioco e lavoro» e mettere tutto ciò che riguarda la
scuola elementare dal lato del secondo, e percepire invece «più che in ogni altra [classe sociale] la scuola
materna [...] unicamente come un luogo dove i bambini si divertono» (Thin 1998, p. 166) anziché
apprendere (cfr. di nuovo Bernstein 1975b e Chamboredon e Prévot 1973; cfr. anche Bernstein 1967 sulle
differenze tra i ceti nelle concezioni degli usi – didattici o meno – dei giocattoli). I genitori di ceto
popolare hanno cioè difficoltà a comprendere ed apprezzare la dissimulazione del lavoro di
apprendimento e l’educazione diffusa che caratterizzano i nuovi metodi pedagogici, la cosiddetta
«pedagogia implicita» (Bernstein 1975b), in opposizione alla «pedagogia esplicita» o tradizionale. Contro
questa «pedagogia del gioco» il cui obiettivo è la trasmissione impercettibile di disposizioni durevoli
all’apprendimento e all’investimento scolastico, i genitori dei ceti popolari tendono a opporre l’immagine
di una separazione netta tra il «divertimento» e il «lavoro» e a identificare senza riserve tutto ciò che
riguarda la scuola dal lato di quest’ultimo.
141
42
In una ricerca molto interessante Bernard Lahire ha analizzato proprio in questi termini le difficoltà di
apprendimento della scrittura dei bambini dei ceti popolari: cfr. Lahire 1990 e 1993a.
43
Che, come abbiamo visto, ha molto a che fare anche con la concezione del locus della causalità e della
responsabilità delle proprie azioni, il quale può essere visto dall’attore come soprattutto interno o
soprattutto esterno a sé. Sulla concezione dei bambini del locus della causalità in relazione alle proprie
prestazioni scolastiche e sul suo rapporto con lo stile educativo familiare, cfr. in particolare Katkovsky,
Crandall e Good 1967.
44
Nella ricerca psicologica del periodo classico sul rapporto tra stile educativo familiare e sviluppo di
quelli che qui abbiamo chiamato i fattori «morali» della riuscita scolastica ma che in tale letteratura sono
definiti piuttosto i tratti (pro)sociali o antisociali della «personalità» del bambino e dell’adolescente, si è
venuta a creare presto una sostanziale convergenza tra gli studiosi sulle dimensioni di analisi rilevanti
dello stile educativo familiare, e in larga misura anche sui «effetti» sui bambini e sugli adolescenti (cfr.
Darling e Steinberg 1993). Queste dimensioni corrispondono nella sostanza alla dicotomia tra dimensione
espressiva e dimensione strumentale che già Parsons aveva identificato come centrale nell’analisi della
socializzazione familiare (Parsons e Bales 1955). Come osserva anche Melvin Kohn, in questa letteratura
sulle modalità di rapporto tra genitori e figli e sui loro effetti, quelle che vengono costantemente
identificate come «le due principali dimensioni della relazione tra genitori e figli» sono «il sostegno e la
coercizione» (Kohn 1963, p. 478) (per una riflessione simile cfr. anche Straus 1964). Così, se il
behaviorista John Watson nel suo all’epoca popolare Psychological Care of Infant and Child (1928)
enfatizzava soprattutto l’importanza del controllo rispetto all’affettività genitoriale, qualche anno più tardi
Percival Symonds in The Psychology of Parent-Child Relationships (1939) individuava le principali
dimensioni di analisi dell’educazione familiare nella sicurezza emotiva (distinguendo tra rifiuto vs.
accettazione del bambino) e nell’equilibrio di potere tra genitori e figli (distinguendo tra genitori
sottomessi vs. dominanti), e concludeva che il miglior «adattamento sociale» del bambino si verifica in
un modello di relazioni familiari in cui il bambino è «accettato» e nello stesso tempo i suoi genitori sono
«dominanti», quindi, in altri termini, quando il sostegno emotivo si coniuga con il controllo genitoriale. In
modo simile, Alfred Baldwin (1948 e 1955) individuava nell’unione di democrazia e controllo (un modo
di educazione che in Baldwin 1948 egli chiama «democrazia attiva», e distingue dalla «democrazia
inattiva» dell’educazione lassista) lo stile educativo ottimale per lo sviluppo di un «sano adattamento»
scolastico del bambino. Per questo autore,
la democrazia è caratterizzata da un alto livello di contatto verbale tra genitore e
bambino, che prende la forma di consultazione nelle decisioni, spiegazione delle
ragioni delle regole familiari, e spiegazione verbale in risposta alla curiosità del
bambino. Questo flusso di comunicazione verbale si accompagna ad una mancanza
di arbitrarietà nelle decisioni e a una generale permissività oltre a contenimento
riguardo all’emotività [la cosiddetta democrazia fredda]. Il secondo fattore, il
controllo, è correlato al primo. Sottolinea l’esistenza di restrizioni del
comportamento che sono trasmesse in modo chiaro al bambino [...]. Un’altra
caratteristica del controllo è una mancanza di frizione sulle decisioni disciplinari.
(Baldwin 1948, p. 129)
La stessa discriminazione tra dimensione del controllo e dimensione dell’affettività si trova in Patterns of
Child Rearing (1957) di Robert Sears e Eleanor Maccoby (e altri). Qui gli autori identificano in
particolare nella prima dimensione, permissivismo vs. severità, lo strumento analitico principale per
classificare il comportamento materno, ovvero «il tratto principale che influenzava le pratiche educative
delle madri» (Sears, Maccoby et alii 1957, p. 472). La seconda dimensione, che essi definiscono calore
vs. freddezza è considerato invece il fattore educativo più significativo nell’influenzare lo sviluppo del
comportamento del bambino. Il «modello circomplesso» dello stile educativo materno elaborato da Earl
Schaefer (1959), probabilmente il più noto tra quelli citati finora, individua allo stesso modo la griglia
analitica del comportamento materno nelle due dimensioni che egli defnisce dell’amore vs. ostilità (cioè,
accettazione vs. rifiuto del bambino) e dell’autonomia vs. controllo (soprattutto psicologico): così, a
grandi linee, il quadrante «ostilità e autonomia» descriverà un comportamento materno di sostanziale
negligenza e indifferenza verso il figlio; il quadrante «ostilità e controllo» uno stile educativo autoritario
ed esigente; il quadrante «amore e controllo» un comportamento materno iperprotettivo e possessivo;
infine, il quadrante «amore e autonomia» uno stile educativo «democratico» maggiormente favorevole a
un buon sviluppo psicologico e sociale del bambino. Vale la pena di ricordare ancora la griglia analitica
tridimensionale del comportamento genitoriale proposta da Wesley Becker nel 1964, in cui accanto alle
142
dimensioni classiche del calore vs. ostilità e restrittività vs. permissivismo compare anche quella distacco
calmo vs. coinvolgimento emotivo ansioso. Sulla bese di queste tre dimensioni, coniugando un approccio
dimensionale ad un approccio tipologico allo studio dello stile educativo familiare, Becker distingue otto
tipologie genitoriali: democratica (calore + permissivismo + distacco emotivo), indulgente (calore +
permissivismo + coinvolgimento emotivo), iperprotettiva (calore + restrittività + coinvolgimento
emotivo), organizzata efficace (calore + restrittività + distacco emotivo), del controllo rigido (ostilità +
restrittività + distacco emotivo), autoritaria (ostilità + restrittività + coinvolgimento emotivo), negligente
(ostilità + permissivismo + distacco emotivo), nevrotica ansiosa (ostilità + permissivismo +
coinvolgimento emotivo).
45
Tra queste analisi riveste certamente un interesse particolare una ricerca condotta Fred Strodtbeck
(1958) fortemente ispirata alla contemporanea etnografia di Edward Banfield sul «familismo amorale»
della cultura meridionale italiana. In essa i posti del ceto medio e del ceto popolare vengono presi dalle
differenti culture di provenienza di gruppi di origine immigrata: Strodtbeck è infatti interessato a rendere
conto della diversa valorizzazione dell’istruzione e riuscita nel sistema di istruzione statunitense dei
discendenti degli immigrati ebrei provenienti dall’Europa orientale e degli immigrati provenienti
dall’Italia meridionale (cfr. anche Rosen 1959 per un analisi analoga delle variazioni della «sindrome
dell’achievement» in diversi gruppi etnici e religiosi). E lo fa sostenendo che questa differenza vada
cercata tanto nella diversità degli ethos delle culture di origine delle famiglie quanto in strutture dei
rapporti familiari diversamente favorevoli allo sviluppo della motivazione alla riuscita. Il ritratto
suggestivo che Strodtbeck traccia dei due ethos è in particolare il prodotto di una sorta di collazione
originale tra le cinque pattern variables di Parsons e l’analogo modello degli orientamenti culturali
fondamentali elaborato di Florence Kluckhohn (si veda su entrambi sopra la nota 36): la concezione
interna o esterna del locus della causalità e della responsabilità nel rapporto tra l’uomo e il suo ambiente,
la concezione della pefettibilità o meno della natura umana, l’orientamento relazionale familista e
particolarista o individualista e universalista, la concezione diffusa o specifica delle relazioni di potere,
l’orientamento temporale al presente o al futuro sono le dimensioni lungo le quali Strodtbeck classifica e
confronta i due sistemi culturali. Rilevando, nel caso dei portatori della cultura ebraica, una
configurazione di tratti «che riflettono i valori che più probabilmente facilitano la riuscita e la mobilità
sociale» (Rosen 1956, p. 208) e sono descritti tanto da Kluckhohn quanto da Parsons come propri del ceto
medio: un’idea di padronanza e responsabilità per il proprio destino individuale e di perfettibilità della
natura umana, un orientamento al futuro, un orientamento relazionale individualista e universalista, una
concezione specifica dei rapporti di potere. E rilevando al contrario una configurazione formata dai tratti
a questi complementari nel caso dei discendenti degli immigrati italiani: un’idea pessimistica e fatalistica
sulle capacità dell’uomo di migliorarsi e controllare il proprio destino, un orientamento temporale al
presente, un orientamento relazionale particolarista e familista, una concezione diffusa delle relazioni di
potere. Se questi diversi orientamenti culturali generali agirebbero, secondo Strodtbeck, sulla diversità
delle aspirazioni educative delle famiglie dei due gruppi culturali, i diversi livelli di motivazione alla
riuscita dei loro figli sarebbero invece soprattutto influenzati dalla diversità delle strutture dei rapporti
familiari in esse prevalenti. In particolare egli avanza l’ipotesi dell’esistenza di una correlazione
inversamente proporzionale tra sviluppo dell’achievement motivation e rapporti di potere familiari
fortemente sbilanciati a favore della figura paterna tanto nella relazione padre-figlio quanto in quella
padre-madre: «una mancanza di potere all’interno della famiglia potrebbe condurlo [il figlio] ad inferire
che egli non potrà mai controllare il proprio destino in nessun altro luogo e che farebbe meglio a restare
vicino ai suoi genitori. [...] Il potere del padre [...] tende a indurre il figlio a credere più nel “fato” e meno
nella possibilità di lasciare la casa» (Strodtbeck 1958, pp. 343-344). In breve, conclude Strodtbeck, «un
basso potere decisionale all’interno della famiglia [...] produce una generalizzazione di questa
inadeguatezza a questioni esterne alla famiglia» (ivi, p. 345). Il rapporto tra la struttura dei rapporti di
potere familiari tra i coniugi e tra genitori e figli e lo sviluppo dell’achievement motivation nei figli è stato
indagato negli stessi anni anche da Murray Straus (cfr. per esempio Straus 1962; Straus 1964).
46
Un concetto che oggi, assimilata bene la lezione della sociologia dell’educazione degli anni Settanta, i
sociologi o mettono rigorosamente tra parentesi o preferiscono sostituire con il più prudente
«massificazione», per interrogarsi magari proprio sui rapporti tra «massificazione» e
«democratizzazione» (per una riflessione attuale sul concetto di «democratizzazione» dell’istruzione, cfr.
per esempio Merle 2000; Duru-Bellat e Merle 2000; Garcia e Poupeau 2003; Dubet e Duru-Bellat 2004).
Per un riflessione ante-litteram sul significato del «concetto di uguaglianza di opportunità educative», si
veda il celebre articolo di James Coleman (1968).
47
Vale forse la pena di osservare che questa categorizzazione di massima delle tipologie di spiegazioni
che nelle scienze sociali sono state offerte del rapporto tra scelte dei percorsi educativi e appartenenza di
143
ceto non segue affatto la classificazione che di questo stesso ambito è stata offerta da Diego Gambetta
(1987). Da una prospettiva di individualismo razionale, Gambetta ritiene infatti che la concezione
dell’adattamento riflessivo alle possibilità e quella dell’adattamento non riflessivo, che qui vengono
considerate semplicemente due versioni, forte e debole, di una stessa tesi di fondo, rappresentino invece
due concezioni irriducibili dell’attore e della sua azione. Nei noti termini di Gambetta, nella prima
versione gli attori sarebbero visti come «sottoposti ad effetti traenti che li attirano verso una determinata
meta», nella seconda essi sarebbero visti come «spinti da effetti propulsivi» (Gambetta 1987, tr. it. p. 29).
48
Una «identificazione», se così vogliamo chiamarla, che tuttavia presenta un limite assai caratteristico
dell’attitudine dei genitori di ceto popolare verso il futuro dei propri figli. Che non riguarda solo la sfera
delle aspirazioni alla riuscita, e che soprattutto, come vedremo dai risultati del lavoro che viene qui
presentato, non riguarda solo i genitori americani degli anni Quaranta. Questo limite consiste nella
tendenza a collocare la responsabilità della «riuscita» dei propri figli – della loro riuscita scolastica e
professionale ma anche della loro riuscita sociale in senso lato, quindi della direzione presa al bivio tra un
«bravo bambino» e un «cattivo bambino» e, più tardi, tra un’esistenza «onesta» e una «cattiva strada» –
su questi ultimi molto più che su stessi. Una attitudine che certamente può essere, come sostiene Chinoy,
una reazione difensiva anticipata alla disillusione futura alla quale, «con i loro redditi limitati e con la loro
mancanza di conoscenza» e la possibilità di «garantire [ai figli] un aiuto finanziario o una guida per la
carriera lavorativa ridotti» (ibidem), questi padri hanno alte probabilità di essere esposti. Ma, più in
generale, è un’attitudine che altrettanto certamente non è senza relazione con quell’orientamento culturale
fatalistico, quell’idea di scarso controllo sul proprio ambiente e sul proprio destino che, come abbiamo
visto nella pagine precedenti, molte ricerche hanno identificato come uno dei tratti distintivi dell’ethos dei
ceti popolari.
49
Se infatti in Francia l’innalzamento dell’età della scolarizzazione obbligatoria a 14 anni risale al 1936
(e nel 1959 questa soglia venne ulteriormente elevata a 16 anni), si dovette attendere il 1975, con la
riforma Haby, per l’isitutuzione di una vera scuola media inferiore unica. In Italia, come è noto,
l’estensione dell’obbligo scolastico a 14 anni venne istituito da Gentile addirittura nel 1923, ma nei fatti
rimase lettera morta fino all’istituzione della scuola media inferiore unica nel 1962.
50
Termini vicinissimi a quelli di Bourdieu sono usati nel contesto statunitense anche da Francis Caro e
Terence Pihlblad:
Si può ritenere che le aspirazioni dichiarate e le aspettative non siano indipendenti.
Un impegno serio rivolto a un obiettivo professionale che è percepito come
irraggiungibile può essere la fonte di un considerevole frustrazione personale. La
teoria del bilanciamento suggerisce che si tenterà di ridurre la preoccupante
discrepanza. Un adolescente che pensi al suo futuro professionale potrebbe ridurre lo
squilibrio tra ciò che desidera e ciò che pensa di poter ottenere riducendo le sue
aspirazioni. Questo processo di bilanciamento delle preferenze e delle anticipazioni
può essere culturale come individuale. Un bambino che cresce in un ambiente di
classe inferiore può essere scoraggiato da genitori e insegnanti dal nutrire obiettivi
professionali che si ritengono irraggiungibili. Incoraggiando lo sviluppo di obiettivi
professionali modesti, gli adulti «responsabili» tentano di preservare la persona
giovane da eventuali delusioni professionali. Si cerca di abbassare le aspirazioni in
modo che corrispondano a quelle che si ritengono essere delle aspettative realistiche.
Si può sostenere che non esistano differenze fondamentali nella valutazione della
struttura occupazionale. Le differenze osservate tra le classi nelle aspirazioni
professionali possono essere attribuite piuttosto al «freno delle aspettative».
(Caro e Pihlblad 1965, pp. 469-470)
51
Del tema del rapporto tra l’identità di ceto e la percezione del proprio destino individuale nella cultura
popolare, e in particolare sull’indebolimento della prima e sull’«individualizzazione» della seconda a
partire dagli anni Ottanta, si è occupato soprattutto Jean-Pierre Terrail (cfr. Terrail 1990).
52
Questa espressione è stata introdotta nel 1981 dal sociologo Jean Manuel De Queiroz nella sua tesi di
dottorato, intitolata appunto La désorientation scolaire. Sur le rapport social de familles popolaires
urbaines à la scolarisation (Université de Paris VIII, direttore di tesi Paul de Gaudemar). Da allora nella
sociologia francofona è divenuta un classico per riassumere gli effetti della massificazione dell’accesso
all’istruzione nei ceti popolari, e in particolare per indicare quella che qui ho definito la perdita di punti di
riferimento simbolici nel rapporto dei membri di questi ceti con l’universo dell’istruzione.
144
53
Nel modello pedagogico «dell’autonomia»,
si presuppone che l’allievo sia attivo (o, in ogni caso, deve essere posto in una
situazione attiva), deve fare domande, interrogarsi, andare a cercare un complemento
d’informazione in un libro, un dizionario, un manuale, ecc., e l’insegnante deve
basarsi sulle sue capacità, sulle sue conoscenze, sulle sua intelligenza, sulla sua
comprensione, sul suo giudizio. L’allievo deve «prendere in carico la sua attività
intellettuale».
(Lahire 2001b, p. 153)
Questa concezione pedagogica si oppone naturalmente alla pedagogia direttiva, o «esplicita»,
tradizionale, nella quale all’educando è riservato un ruolo passivo. Ma non si identifica nemmeno nella
pedagogia cosiddetta «del risveglio»:
Il bambino concepito in questo modello pedagogico non è necessariamente il
bambino sbocciato difeso da una certa pedagogia romantica e libertaria, che si
opponeva anch’essa a tutti i formalismi aridi, a tutti i tradizionalismi, alla direttività,
all’oppressione del bambino da parte dei maestri e al soffocamento della sua
creatività e della sua immaginazione attraverso l’inculcamento di saperi. Il bambino
non è concepito a partire dal suo possibile sboccio ma come un essere intelligente,
capace di costruire i suoi saperi e di essere un cittadino responsabile.
(ibidem)
54
Il dibattito e le politiche educative statunitensi relative a quello che viene chiamato il curriculum
multiculturale rappresentano probabilmente la manifestazione più estrema di questa tendenza. In tale
dibattito,
da un parte della controversia stanno i difensori delle grandi opere e dei tradizionali
«valori occidentali»; dall’altra sta un’alleanza di minoranze, donne, teorici letterari e
filosofi postmoderni che vorrebbero ri-definire quei riferimenti standard e, talvolta,
anche la struttura delle identificazioni e dei valori che ritengono vi sia sottesa.
(Brint 1998, p. 102)
Un’alleanza le cui posizioni hanno molto influito sulle trasformazioni del sistema di istruzione
statunitense degli ultimi trent’anni, che sono andate fortemente nella direzione di una
istituzionalizzazione del multiculturalismo nelle politiche e nella pratica educativa:
se [...] la parola «multiculturalismo» non veniva quasi pronunciata nei discorsi
pubblici all’inizio degli anni Ottanta, [...] entro la fine degli anni Ottanta molti stati
americani (a cominciare dalla California nel 1987) hanno aggiunto fra i principiguida per la formulazione dei curricoli l’obbligo di adottare punti di vista
«multiculturali e imparziali nei confronti del genere» [Rosenfelt 1994].
(idibem)
55
La tendenza verso queste due «aperture», la valorizzazione delle competenze culturali e dei saperi che
l’allievo porta con sé a scuola e l’integrazione dei saperi e delle discipline, è per esempio assai evidente
nella riforma dell’assetto della scuola media inferiore italiana portata avanti con vari provvedimenti
legislativi nel corso degli anni Settanta (in particolare con le due leggi 348 e 517 del 1977) allo scopo
principale di completare quella «democratizzazione» iniziata nell’anno scolastico 1962-63 con
l’instaurazione della scuola media unica.
56
Per una visione d’insieme delle politiche di apertura di vari Paesi europei ed extraeuropei, si può vedere
utilmente il rapporto 1997 dell’OECD Parents as Partners in Schooling. Su Francia, Italia, Germania e
Inghilterra cfr. Beattie 1985; sul Portogallo cfr. Stoer e Cortesão 1999; sul Québec cfr. Vatz Laaroussi
1996; sulla Scozia cfr. Martin, Tett e Kay 1999; sulla Gran Bretagna cfr. Heywood-Everett 1999.
57
Sul tema dell’ideologia e delle pratiche dell’apertura della scuola alle famiglie si ormai accumulato
nella sociologia anglofona e francofona degli ultimi anni un certo numero di lavori che per lo più
contengono riflessioni critiche assai interessanti (a questi lavori è riservata un’intera sezione apposita
della bibliografia, alla quale si rimanda). Una parte di questi lavori – che nella bibliografia è stata in gran
145
parte trascurata – è costituita da letteratura normativa e prescrittiva sulle «buone pratiche» per favorire e
incrementare l’avvicinamento dei genitori al mondo scolastico, soprattutto nelle scuole popolari o tra i
genitori delle minoranze etniche (tra i rappresentati più autorevoli e prolifici di questa prospettiva c’è
Joyce Epstein, direttore del Center on School, Family, and Community Partnerships della Johns Hopkins
University; cfr. in questa prospettiva anche Chavkin (ed.) 1993; Delgado-Gaitan 1991; Martin, Tett e Kay
1999). Ma la parte più interessante della letteratura recente sul tema dell’apertura della scuola alle
famiglie riguarda piuttosto analisi e bilanci critici del modo in cui questa idea di cooperazione è stata
applicata nelle politiche educative dei governi e delle singole scuole negli ultimi tre decenni. Queste
analisi si concentrano per lo più su due aspetti. Il primo è la messa in luce del fatto che al concetto
bandiera di collaborazione scuola-famiglia sono stati associati, nella pratica delle sue applicazioni
concrete, prospettive molto diverse sul rapporto tra la scuola e le famiglie (cfr. Glasman 1998; Payet
1998; Crozier 1999; Deslandes 1999; Heywood-Everett 1999; Martin e Vincent 1999; Stanley e Wyness
1999), e soprattutto nel caso delle scuole popolari l’idea sottostante prevalente è stata quello di una
educazione, o anche di una acculturazione, delle famiglie, anziché quella di una effettiva condivisione del
lavoro educativo con esse (cfr. Wyness 1995; Montandon 1996; Mozère 2000). Si suggerisce che questa
prospettiva sottostante di scuola come «polizia delle famiglie» da un lato contrasti decisamente con
l’essenza del moderno concetto di collaborazione e dall’altro non sia senza responsabilità nello scarso
successo generale di queste iniziative tra i genitori dei ceti popolari. Il secondo tema ricorrente in questa
letteratura riguarda proprio nello specifico gli effetti dell’apertura della scuola alle famiglie nel caso dei
ceti popolari. Da un lato si analizzano le ragioni dello scarso successo di queste politiche con i genitori
dei ceti popolari (cfr. in particolare Périer 2005). Dall’altro, e soprattutto, si problematizza l’idea stessa
che una simile politica di apertura e il concetto di corresponsabilità educativa che ne è alla base sia
veramente profittevole per gli studenti dei ceti popolari, come l’ideologia della cooperazione scuolafamiglia sembra dare per scontato (cfr. tra gli altri Carvalho 2001; Stoer e Cortesão 1999; in Italia questa
posizione è sostenuta tra gli altri dall’economista Daniele Checchi: cfr. Checchi 2003).
58
Come ben sottolinea Cléopâtre Montandon, con una osservazione che è riferita alle trasformazioni del
panorama scientifico ma valgono anche per l’appropriazione dei saperi scientifici nelle politiche e nelle
cultura professionali del campo dell’istruzione,
dopo le teorie che attribuivano il fallimento scolastico a dei fattori di personalità, di
intelligenza, dopo le teorie che hanno imputato le prestazioni scolastiche dei ragazzi
al loro ambiente familiare, al suo handicap culturale, dopo quelle che hanno cercato
di spiegare le disuguaglianze tra gli alunni con la scuola, la sua organizzazione e le
sue strutture, per esempio con il numero di alunni per classe, con la qualificazione
degli insegnanti, con i programmi o ancora con la logica della riproduzione, vedono
la luce dei nuovi approcci che mettono l’accento sull’importanza delle interazioni tra
la famiglia e la scuola.
(Montandon 1994a, p. 33)
59
Nonché, ovviamente, a spostare in una posizione in qualche modo più comoda l’asse dei doveri e delle
responsabilità scolastiche nelle disuguaglianze di riuscita, mettendo al primo posto tra i compiti della
scuola quello di coinvolgere i genitori nei percorsi e nei destini scolastici dei figli – il che spesso ha
significato praticamente solo spostare su di essi gran parte delle responsabilità dei fallimenti di quei
percorsi e di quei destini.
60
Presso l’INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), il Centre Alain Savary funge da centro di
documentazione nazionale sulle politiche di educazione prioritaria, e oltre a documentazione di carattere
legislativo e didattico raccoglie una preziosa e continuamente aggiornata anagrafe della ricerca scientifica
sul tema della scolarità nei quartieri popolari (cfr. in particolare la Bibliographie générale sur l’éducation
prioritaire on-line sul sito www.inrp/zep).
61
Il nascente dibattito sull’utilità dell’idea di cooperazione tra scuola e famiglie nel caso della
scolarizzazione nei ceti popolari, al quale ho accennato sopra (cfr. la nota 57), è una eccezione molto
apprezzabile.
146