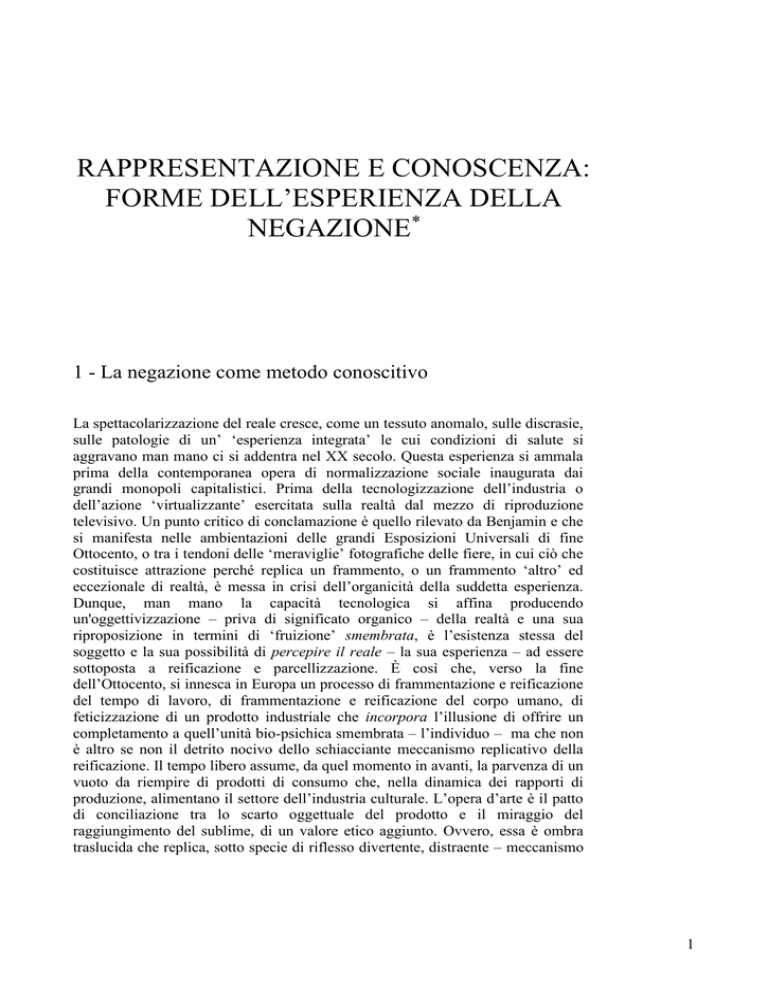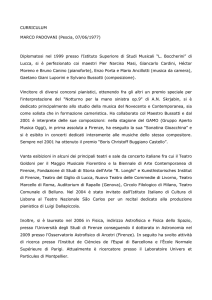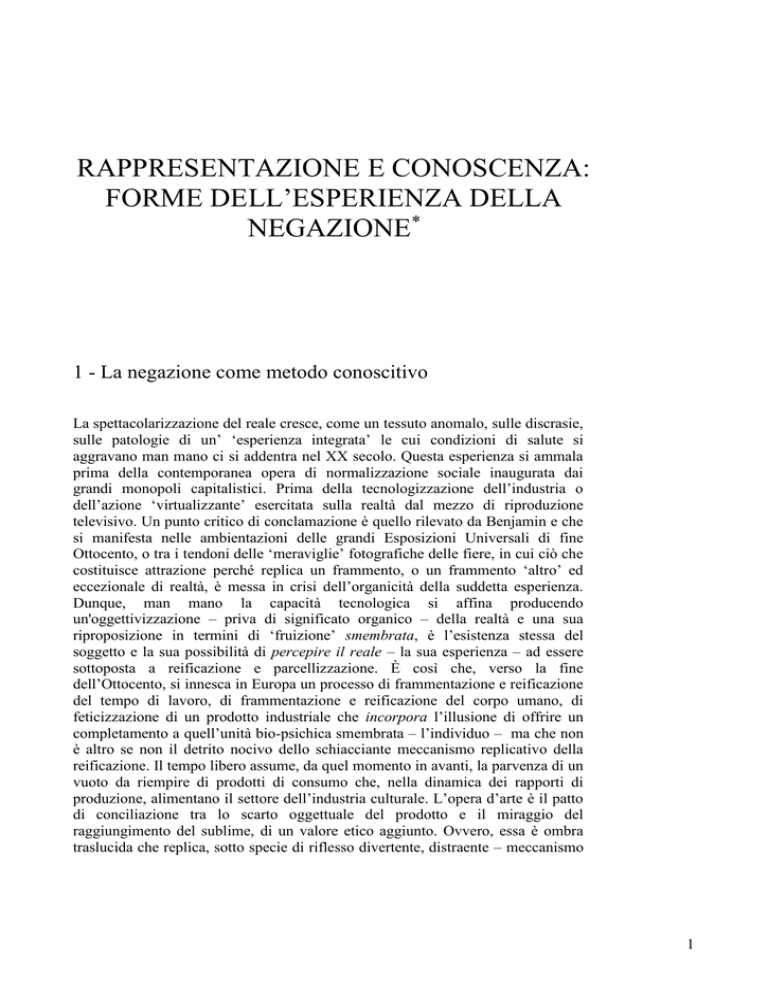
RAPPRESENTAZIONE E CONOSCENZA:
FORME DELL’ESPERIENZA DELLA
NEGAZIONE*
1 - La negazione come metodo conoscitivo
La spettacolarizzazione del reale cresce, come un tessuto anomalo, sulle discrasie,
sulle patologie di un’ ‘esperienza integrata’ le cui condizioni di salute si
aggravano man mano ci si addentra nel XX secolo. Questa esperienza si ammala
prima della contemporanea opera di normalizzazione sociale inaugurata dai
grandi monopoli capitalistici. Prima della tecnologizzazione dell’industria o
dell’azione ‘virtualizzante’ esercitata sulla realtà dal mezzo di riproduzione
televisivo. Un punto critico di conclamazione è quello rilevato da Benjamin e che
si manifesta nelle ambientazioni delle grandi Esposizioni Universali di fine
Ottocento, o tra i tendoni delle ‘meraviglie’ fotografiche delle fiere, in cui ciò che
costituisce attrazione perché replica un frammento, o un frammento ‘altro’ ed
eccezionale di realtà, è messa in crisi dell’organicità della suddetta esperienza.
Dunque, man mano la capacità tecnologica si affina producendo
un'oggettivizzazione – priva di significato organico – della realtà e una sua
riproposizione in termini di ‘fruizione’ smembrata, è l’esistenza stessa del
soggetto e la sua possibilità di percepire il reale – la sua esperienza – ad essere
sottoposta a reificazione e parcellizzazione. È così che, verso la fine
dell’Ottocento, si innesca in Europa un processo di frammentazione e reificazione
del tempo di lavoro, di frammentazione e reificazione del corpo umano, di
feticizzazione di un prodotto industriale che incorpora l’illusione di offrire un
completamento a quell’unità bio-psichica smembrata – l’individuo – ma che non
è altro se non il detrito nocivo dello schiacciante meccanismo replicativo della
reificazione. Il tempo libero assume, da quel momento in avanti, la parvenza di un
vuoto da riempire di prodotti di consumo che, nella dinamica dei rapporti di
produzione, alimentano il settore dell’industria culturale. L’opera d’arte è il patto
di conciliazione tra lo scarto oggettuale del prodotto e il miraggio del
raggiungimento del sublime, di un valore etico aggiunto. Ovvero, essa è ombra
traslucida che replica, sotto specie di riflesso divertente, distraente – meccanismo
1
anestetico di massa, con l’industria cinematografica – la potenza schiacciante del
rapporto di scambio.
I meccanismi di conciliazione delle antinomie sociali, implicati nell’attività dei
mezzi tecnici di ri-produzione culturale, segnalano lo slancio verso
un’apprensione positiva della realtà da parte del soggetto. Il tentativo, cioè, di
appropriarsi di una conoscenza del reale che avalla il sistema di rapporti socioeconomici. Nei primi del Novecento le avanguardie storiche operano
artisticamente per rovesciare l’assunto positivo di questa apprensione. Si formano,
pertanto, delle modalità di penetrazione negativa della realtà valide come formule
di comprensione e percezione critica delle mistificazioni dei rapporti materiali:
La qualificazione della verità come atteggiamento negativo del sapere, che penetra l’oggetto –
quindi cancella l’apparenza del suo essere immediatamente così – suona come un programma
di dialettica negativa quale sapere che «concorda con l’oggetto»: ma stabilire questo sapere
come positività lo fa cadere. Con la formula della «uguaglianza con sè», della pura identità, il
sapere dell’oggetto si rivela come una truffa, perché questo sapere non è affatto più sapere
dell’oggetto […] la dialettica ha il suo contenuto d’esperienza non nel principio bensì nella
resistenza dell’altro contro l’identità[…]1
Se assumiamo la prospettiva della ‘resistenza’ all’uniformazione, vediamo venire
alla luce tratti rilevanti delle operazioni duchampiane sui ready-made o di Samuel
Beckett sul linguaggio verbale. Recuperare l’oggetto, come materiale che non
asserisce la sua presenza reale positivamente ma denuncia ‘l’apparenza del suo
essere’, significa concordare in negativo con l’oggetto. Usare il linguaggio
modulando la mendacità del suo statuto reificato e manifestandolo profondamente
in contraddizione con la sua vocazione esplicativa, significa negarne l’evenienza
attuale, contestare la possiblità che esso entri in ‘identità’ con il reale. La
necessità di stabilire ‘un atteggiamento negativo del sapere’, si profila
contemporaneamente a quella prima elaborazione della crisi – come risposta alla
crisi – che accompagna le emergenze della reificazione del soggetto alla fine
dell’Ottocento. Trasporre in negativo il materiale, significa appropriarsi del
materiale penetrandone l’involucro di apparente conciliazione e innestare, in ciò
che il materiale incorpora del rapporto di produzione che l’ha ‘realizzato’, il quid
della sua negazione.
Non sarebbe corretto considerare tutta l’avanguardia come espressione di
un’estetica negativa, di un’estetica cioè che problematizzi l’uso del materiale per
metterne in luce l’inconciliabilità interna, equivalente alla contraddittorietà del
mezzo di produzione che l’ha generato. Significherebbe cercare di fondare la
realtà dell’apparente per mezzo di un’apparenza priva di fondamento. Sarebbe
una mistificazione, poiché non tutta l’arte cosiddetta d’avanguardia sviluppa il
presupposto necessario ad un uso ‘negativo’ del materiale. È più opportuno
riconoscere la ciclicità di simile risposta all’industrializzazione culturale,
dall’Ottocento al Novecento, nel lavoro sui materiali tecnico-espressivi laddove
esista una non esplicita, non di superficie, negazione estetica delle forme di
esperienza del reale. Ciò che equivale a dire: dove l’opera d’arte non sia
esaltazione illusiva dei mezzi di (ri)produzione e di scambio (suggestione e
condizionamento); dove non sia fuga dal rapporto reificato che intrattiene con la
realtà verso paradisi di conservatorismo; dove non sia in contrasto diretto con i
contenuti di quei rapporti. Dove l’opera d’arte, infine, risulti da un’adozione del
2
materiale che tenga conto che quel materiale è prodotto dai meccanismi di
scambio ed è loro immagine traslata. E risulti da una messa in evidenza
dell’inconciliabilità interna del materiale, lì il potenziale negativo del lavoro
artistico è riconoscibile.
2 - Teatro e atteggiamento negativo dell’arte
Quando l’arte, storicamente, si sia posta in aperta dialettica con la realtà del
sistema costituito – di uno stato di fatto che coinvolge, a partire dai mezzi di
produzione, le possibilità stesse dell’espressione – con quel sistema ha fatto i
conti implicitamente. L’esplicitazione di un atteggiamento antagonistico soffre il
peso di una condanna eseguita a priori. È infatti la conseguenza del vizio di forma
di una manifesta vocazione artistica al dissenso, quella di subire la
funzionalizzazione forzata da parte del sistema economico:
L’utile che gli uomini si ripromettono, nella società antagonistica, dall’opera d’arte, è infatti
proprio, in larga misura, l’esistenza dell’inutile; che però viene liquidato nell’atto in cui viene
sussunto interamente sotto la categoria dell’utilità [corsivo nostro]. L’opera d’arte,
adeguandosi interamente al bisogno, defrauda gli uomini in anticipo di quella liberazione dal
principio di utilità che avrebbe appunto il compito di procurare. 2
La dialettica tra ‘utilità’ e ‘inutilità’, interna alla produzione artistica, permea la
storia delle forme d’arte d’avanguardia. E si può spiegare solo non scendendo ad
icastiche definizioni di ciò che sia utile o inutile artisticamente. Poiché qui utile va
inteso come funzionale ed economicamente propizio – nell’ottica di un’economia
dello scambio – pur traendo origine da un’urgenza culturale di fuga
dall’utilitarismo. Per questa ragione, laddove si intenda penetrare i rapporti tra
utilità-inutilità negli approcci artistici delle avanguardie, il fatto culturale deve
essere considerato sovrapposto a un sostrato economico-produttivo e deve
soggiacere all’insieme degli strumenti adottati, che pure incorporano il fatto
culturale e quello di scambio traslati sul piano dei materiali.
Per certi versi il teatro, in quanto sistema coordinato di strumenti espressivi
eterogenei, raccoglie l’intero spettro dei piani di analisi appena citati. Nel suo
rapporto con qualsivoglia progressista o conservatore atteggiamento critico,
proprio il teatro mette in luce il punto di frattura originario creatosi tra la
mediazione culturale imposta all’evento e l’evenienza spontanea di quest’ultimo,
l’utile e l’inutile e il loro conseguente adattamento a una formula di arte
amministrata:
Parlare di cultura è sempre stato contro la cultura. Il denominatore comune «cultura» contiene
già virtualmente la presa di possesso, l’incasellamento, la classificazione, che assume la
cultura nel regno dell’amministrazione.3
Raccogliendo e dispiegando le serie innumerevoli delle potenzialità espressive dei
materiali (dal corpo, all’incidenza acustico-visiva, alla sollecitazione astrattivoimmaginativa) l’evento teatrale è costantemente sottoposto all’azione della
classificazione culturale. Il gesto del teatro, più di altri ‘gesti’ artistici, è
compromesso con la sua socializzazione immediata, e deve quindi considerarsi
3
immediatamente catalogabile. Esso deve risultare, a priori, funzionale al sistema
di scambio, onde eludere il rischio, esiziale per la produzione, dell’impopolarità.
In quest’ottica, almeno per tutta la prima metà del secolo XX, il rapporto tra
l’elaborazione culturale e il teatro e, proprio a seguito del suo mutamento
ottocentesco in fatto puramente commerciale, tra la critica militante e il teatro, ha
assunto posizioni importanti in accesi dibattiti.
Sfuggire all’ ‘incasellamento’ e alla ‘classificazione’ culturale del gesto coincide
con la liberazione del potenziale culturale eversivo in esso implicito. Per gesto si
intende intenzione espressiva. Ma, appunto, la definizione classificatoria di quella
espressione variabile costringe a normalizzazione l’intenzione che l’ha prodotta.
Quello della tassonomia culturale è quindi un gioco di specchi cavi che
proiettano, a priori, una rappresentazione non spontanea e libera del gesto. Solo
un gesto che non si rifletta in questa rappresentazione, che non vi si specchi,
sfugge come bagliore effimero alla calcificazione culturale e si disperde nel fiume
di una vitalità non concettualizzata. Ciò non toglie che questa dissoluzione,
propizia a una fuga dalle maglie strette, ma non impermeabili, del sistema di
produzione e scambio, sia effimera e recuperabile – prima o dopo – alla
classificazione.
Il ‘nuovo teatro’4 italiano – che ricade, nella sua configurazione originaria,
all’incirca nel panorama sociopolitico dei primi anni Sessanta – si mostra in
rapporto del tutto negativo con le condizioni economico-produttive del periodo.
Sia sul piano espressivo che su quello distributivo e produttivo il fenomeno risulta
inclassificabile. E anche i rapporti che la critica intrattiene, tardivamente, con
quest’ultimo sono contrassegnati da una sostanziale incapacità classificatoria.
Tant’è vero che, finalità primaria dell’accostamento critico al nuovo teatro, è
quella di approntare strumenti di analisi pregnanti per verificare la fondatezza
della diffidenza mostrata verso un fenomeno non qualificabile. Inqualificabile
poiché nega alla radice una forma di scambio, di comunicazione, che, a
quell’altezza cronologica, sembra ormai stabilizzata sugli stilemi funzionali
dell’Accademia. E, infatti, il diniego dei nuovi gruppi prende avvio proprio dal
rifiuto dei moduli espressivi accademici. Di qui viene sviluppandosi la vitalità
nuova di un panorma teatrale i cui nuclei costitutivi incrinano le ferme
convinzioni – e convenzioni – di un sistema produttivo che impiegherà un
decennio, ‘caldo’ come quello degli anni Sessanta, per ridurli a norma. Ma si
tratta di un processo di riduzione che subisce lo scacco di una preliminare
negazione delle sue dinamiche.
3 - Crisi dei meccanismi di produzione e consumo: stabilità e
rapporti con il territorio
4
In Italia la regia si afferma tardi. L’idea registica forte, in Italia, corrisponde in
parte alla riuscita di un progetto che deriva da suggestioni risalenti alla fine
dell’Ottocento: la fondazione di un teatro stabile. Il sistema produttivo italiano,
nella seconda metà del Novecento, vede convivere, tra i generi ‘alti’ di spettacolo,
i residui delle compagnie private – strascico del nomadismo tardo ottocentesco
del grande attore – e una produzione nuova, radicata nel territorio. Quella che nel
progetto di Giorgio Strehler dovrebbe concorrere a educare un nuovo pubblico
cittadino: la produzione stabile. Questo nuovo rapporto con il panorama urbano
determina non solo un comprensibile mutamento distributivo, ma anche un nuovo
modello di concepimento del sistema produttivo. Si afferma la concentrazione
dell’offerta artistica teatrale in un centro ‘stabile’, verso cui dovranno convergere
le più fervide intenzionalità creative, onde conseguire uno sbocco tra le luci del
palcoscenico. Il teatro stabile accentra le dinamiche creative tanto quanto quelle
produttive e distributive.
Sinteticamente, è l’articolazione delle relazioni tra il regista e il suo ensemble
attorico a costituire la novità, in Italia, di un rapporto che coinvolge anche il
pubblico. La centralità del teatro stabile è radicamento nel territorio e quindi
possibilità di raggiungere un’identificazione, un’individuazione sul piano sociale.
Quella del teatro stabile – novità assoluta in un paese come l’Italia in cui norma
privata e nomadismo sono il modello culturalmente e socialmente più conosciuto
– è l’unica formula organizzativa che sembra in grado di sfuggire, anzi
alimentarsi, alla crisi della domanda che imperversa nel teatro di prosa. Gli
interventi del teatro stabile vanno letti, infatti, nell’ottica di una struttura pubblica
accentratrice che aspira a scopi di risanamento e ‘bonifica’ del territorio.
L’alternativa teatrale a tale stato di cose accede, sul finire degli anni Cinquanta,
alla ribalta del sistema commerciale spettacolare. Questa alternativa risponde ai
canoni di uno spontaneismo a sfondo non impresariale ma più che altro
dilettantesco, più vicino alle filodrammatiche che alle compagnie ‘di giro’. Sopra
questo spontaneismo, appoggiato a un’offerta anche culturalmente autonoma che
si avvale dei testi della drammaturgia ‘d’avanguardia’ europea – Beckett, Genet,
Ionesco… – si forma il terreno culturale su cui poggeranno le operazioni dei primi
gruppi del nuovo teatro.
Prendendo in esame la configurazione economica e strutturale dell’offerta
spontanea in generale, ricaviamo l’immagine di una realtà profondamente precaria
che trova nel ricavo della ‘serata’ l’unica fonte di guadagno. Negli anni Sessanta
il teatro di ricerca non è finanziato. Portare ‘in giro’ uno spettacolo necessita o la
sicurezza di un rientro di spese, nel caso ci si allontani dalla sede ‘centrale’ in cui
opera il gruppo, o la limitazione degli interventi a una ristretta zona comunale. È
tuttavia evidente che le possibilità di azione dei piccoli gruppi autonomi sono più
ampie rispetto al macchinoso e pesante movimento degli stabili, che non possono
permettersi di scontentare o contrariare provocatoriamente il pubblico
contribuente. Il motivo per cui i gruppi spontanei necessitano di una sede
operativa è valido sul piano creativo ma anche sul piano economico, come ricerca
di un luogo dove ottenere visibilità, risonanza e rientro sicuro di spese.
I gruppi del nuovo teatro maturano rapporti nuovi ed esclusivi con spazio e
pubblico. Se per l’offerta stabile lo spazio è il luogo riconoscibile in cui ‘educare’
i propri spettatori e, per i gruppi autonomi non impegnati nella ricerca, una
funzione pubblicitaria in cui proporre un prodotto esteticamente valido a un
5
pubblico trattato con i crismi del buon gusto e dell’elegante educazione ‘civilina’,
il nuovo teatro appronta uno spazio in cui vivere il teatro e shoccare5 la ‘platea’.
Lo spazio dei gruppi del nuovo teatro è luogo in cui esperire le possibilità creative
di una drammatizzazione spontanea del reale. Il pubblico può risultare inutile ai
fini dell’esperimento e propizio per l’incasso. Oppure può ricoprire il ruolo di un
tessuto reattivo cui imporre, per la loro messa a punto, formule espressive nuove.
La funzione del pubblico, nella sua veste di destinatario di un messaggio, è
negata. E anche la collocazione topografica dello spazio è negata nella sua
funzione di radicamento nel territorio.
Tra spazi d’azione inediti e rapporti strutturali rinnovati si comprende la distanza,
la sostanziale estraneità, dell’attore del nuovo teatro alla recitazione accademica.
Lo spontaneismo è propiziato da un soggetto attorico che forgia da sé i propri
strumenti di lavoro. L’attore del nuovo teatro non soggiace al processo
normalizzatore, funzionale a creare ‘manodopera’ di qualità per gli stabili, messo
a punto in Accademia. Le qualità recitative sono sviluppate seguendo
un’evoluzione spontanea di metodi e suggestioni, errori e traguardi e non meno
prendendo in considerazione basi tradizionali da riformulare. L’attore del nuovo
teatro è un artista che mette costantemente in discussione gli stilemi precostituiti.
Mezzo adeguato al conseguimento, di volta in volta, di nuove soluzioni espressive
è la formula operativa del laboratorio che in Italia prende piede proprio negli anni
Sessanta. Il lavoro di laboratorio possiede caratteristiche precise. Ovviamente si
tratta di una dimensione sperimentale – di ‘laboratorio’ appunto – nella quale si
organizza la ricerca in senso parascientifico, spesso per tentativi, e premettendo la
possibilità dell’errore, di pervenire cioè a un approdo inospitale come sosta di un
percorso a tappe. La prassi laboratoriale coincide spesso con il lavoro collettivo.
Una dimensione che va dal lavoro di gruppo vero e proprio alla valorizzazione, da
parte di una figura registica o coordinatrice, delle idiosincrasie dei singoli attori.
Questo è l’unico vero radicamento dei gruppi del nuovo teatro: il legame
indissolubile con condizioni formative e operative che ne fanno degli ‘apolidi’.
Nella sua forma pura e non compromessa con il mercato – cioè con la necessità di
approntare soluzioni disponibili all’uso in tempi brevi – il laboratorio è una forma
spontanea di ‘teatralizzazione’ del vissuto. Conforme alle biografie dei diversi
gruppi del nuovo teatro italiano, la forma laboratoriale si esprime in una pratica e
in una sperimentazione condotta attraverso le pieghe riposte della vita quotidiana.
6
4 - Crisi della rappresentazione-rappresentazione della crisi
4.1 - Virtualità dell’esperienza
Elemento connettore tra arte e realtà – nella seconda metà del Novecento, ma a
partire almeno dalla fine dell’Ottocento – è sicuramente la deformazione delle
possibilità esperienziali dell’individuo, direttamente collegata a una:
Distruzione della Erfahrung (esperienza) operata dalla società borghese avanzata, e dalla sua
sostituzione con concetti amministrati e privi di vita. La scomparsa della vera esperienza, che
anche Benjamin aveva sottolineato come una caratteristica della vita moderna […] 6
La sostituzione di un’esperienza di vita con ‘concetti amministrati e privi di vita’,
deriva dalla crisi in cui entrano le unità minime di rappresentazione del reale della
‘vita moderna’. Laddove esista un interesse anestetizzante per il dato materiale,
ogni rappresentazione della realtà non può che permearsi di concessioni
funzionali alla sistematicità utilitaristica. Per l’individuo socialmente integrato le
possibilità residue di esperienza della realtà si esauriscono, in breve,
nell’assunzione del ruolo di agente propulsore di uno scambio economico e di
oggetto del meccanismo produttivo moderno. La stessa facoltà di verbalizzazione
subisce la corruzione e l’inaridimento esercitati dal sistema di scambio:
Ciò che, in una successione stabilita di lettere, trascende, e cioè non si lascia risolvere, nella
pura correlazione all’evento, è bandito come qualcosa di oscuro e come un relitto di
metafisica verbale. Ma in tal modo la parola, che deve limitarsi a designare e non può più
significare nulla, è talmente fissata e attaccata alla cosa da irrigidirsi in una specie di formula.
Ciò colpisce, in ugual modo, la lingua e l’oggetto. Invece di rendere l’oggetto accessibile
all’esperienza, la parola depurata da ogni residuo estraneo lo presenta come il caso particolare
di un momento astratto […]7
L’oggetto subisce un’amputazione ‘materiale’ sul piano della realtà. Non può
ulteriormente permanervi presente, se non nell’ordine dell’univocità che gli è
concessa. In questa prospettiva all’arte non resta che lasciarsi compenetrare da
strumenti corrotti dall’interno. Ogni operazione creativa, condotta con e sui
materiali disponibili, non può che innestarsi nelle guide di espressioni dimidiate,
orientate in partenza verso rappresentazioni conformi al sistema.
È facile comprendere come ogni operazione artistica che agisca con materiali
corrotti, indipendentemente dall’impostazione formale e dall’affabulazione
implicata nella resa del contenuto, si comporti come un meccanismo funzionale e
in connivenza con quella corruzione. Un meccanismo che di per sé lavora con
falsi frammenti di false rappresentazioni, per costruire apparenze illusive di
interpretazioni del reale. Se, dunque, lo scopo dell’esperienza negativa dell’arte
può essere sintetizzato, alla luce del suo rapporto con il sistema ufficiale, come un
‘pensare in contraddizioni in forza della contraddizione esperita nella cosa e
contro di essa’8, il lavoro sopra e dentro il materiale e gli strumenti adottati
7
diventa momento ‘realizzativo’ centrale. Un operare artistico che entri in
dialettica con il sistema dominante – e pare essere questo il presupposto di alcuni
gruppi che convenzionalmente designamo con il termine avanguardia – deve
incidere le ‘escrescenze’ che l’ingranaggio sistemico ha prodotto sul materiale. E,
quindi, deve costituirsi come un operare che sfugga alla rappresentazione distorta
della realtà, imposta dall’artificiosità tecnico-riproduttiva.
Il ruolo che certa arte d’avanguardia ricopre nel Novecento possiede,
essenzialmente, una funzione gnoseologica – vale a dire critica – destinata a
penetrare ed esperire l’incrinatura insanabile che postula un’identità, un’integerità
e uniformità solo virtuali. Intorno ai frantumi dell’apparenza d’identità, che la
‘società dello spettacolo’ distribuisce ai suoi ‘attori sociali’, si dispone l’interesse
del lavoro artistico sperimentale. Prendendo in esame le prime risposte agli effetti
ancora precoci dell’impatto tra arte e tecnica della ri-produzione, nel primo
Novecento, tra le più efficaci si rivelano le operazioni avanguardiste di Dada e
Samuel Beckett. In queste due ‘irregolarità’ dell’arte europea del secolo XX,
l’incrinatura del reale è esperita nelle profondità delle apparenze del linguaggio.
Che sia esso linguaggio verbale o sia il prodotto di una distillazione
dell’immagine, è svelata la sua apparente trasparenza, in realtà rovesciata nella
più esteriore opacità. Nelle succitate operazioni, l’apparenza non resta quindi che
un detrito di rappresentazioni false, pur riuscendo efficace – informando
esasperatamente tutta l’opera – sul piano della sua stessa negazione.
4.2 - Il corpo e il frammento nell’arte del nuovo teatro
Cercando di ridurre ai minimi termini una possibile risposta alla domanda su
quale sia la caratteristica del materiale adottato dal nuovo teatro italiano, ci
imbattiamo in due gruppi di elementi espressivi. Si tratta, in realtà, di sintesi di
segni e strumenti che tuttavia individuano, con una certa precisione, gli interessi
operativi su cui si concentra il lavoro di sperimentazione teatrale negli anni
Sessanta. Da un lato troviamo il corpo. Per corpo intendiamo quanto di materico,
oggettivamente incisivo sul piano spaziale, si presenta in scena. Dall’altro lato, il
frammento, vale a dire lo strumento di destrutturazione del corporeo, ma anche
l’unità modulare di scomposizione e configurazione sincronica del tempo.
Entrambi gli elementi sono quanto di più problematico, tra i materiali, il sistema
di produzione renda disponibile.
L’interesse sviluppato per il corpo deve essere letto, prima di tutto, come
scioglimento dal vincolo di una presunta purezza virtuale del fisiologico, verso la
riappropriazione di una complessità fisica in lotta contro la seduzione di
quella‘virtualizzazione’. Il corpo è principalmente oggetto tra oggetti, non unità
astratta e funzionale alla collocazione sociale, ma struttura spaziale suscettibile di
essere plasmata. Una struttura spaziale che è infinitamente ricca di potenzialità
creative. Prima di tutto essa subisce il modellamento determinato dalla sua
dinamicità, espressa nei termini dell’azione. È ‘con quella pratica artistica che è
stata battezzata genericamente arte di comportamento che i mezzi linguistici tipici
dell’arte vengono sostituiti dal gesto e dall’azione’9. Gesto e azione dilatano e
8
restringono il corpo, lo integrano in altri corpi-oggetto e ne costituiscono le linee
di tensione che modificano lo spazio. Il corpo, i corpi in quanto oggetti della
scena, sono la scena. Il fisiologico e l’inorganico sono costituenti spaziali che
acquistano valore meccanico organico all’interno del sistema di riferimento, e
valore dinamico in rapporto all’azione.
Il rapporto con lo spazio, rinnovato dal punto di vista materiale, e il conseguente
allontanamento da un’insidiosa virtualità, spingono i gruppi del nuovo teatro a
superare ‘i limiti della rappresentazione, pur di riacquistare un rapporto meno
spettrale con la realtà’10. È infatti sul piano di una costante tensione tra le lusinghe
di una rappresentazione illustrativa e il confronto con le costrizioni, i limiti, anche
la fallibilità maldestra del corporeo, che si consuma parte del lavoro sulla
dissociazione spaziale e temporale di Leo e Perla, o sulla composizione scenica
‘d’eccesso’ di Carmelo Bene. Il corpo, non consumato dall’attrito estenuante con
l’ombra della sua spettacolarizzazione, può diventare nucleo generatore del
contingente, dell’imprevisto che apre la struttura programmata all’irruzione
materica del vitale, come negli esperimenti maturi di Carlo Quartucci.
L’estetica del frammento è elaborata dal nuovo teatro come lavoro sulla
distorsione temporale, intervenuta con la parcellizzazione dei rapporti di spazio e
fruizione della modernità. Lo sbriciolamento della continuità materiale è elemento
implicito del montaggio cinematografico. La continuità temporale è compromessa
e mistificata ancorchè descritta solo virtualmente, come illusione percettiva, dal
cinema. I frantumi di un’esistenza diventano, nell’acquiescenza all’imposizione
del frammentario, oggetti sottoposti al controllo sistemico, tessere di
‘amministrazione’ che modificano nell’osservatore la percezione della continuità,
così come rivelano:
[…] quelle scene terribili al cinema quando alcuni anni della vita dell’eroe sono descritti in
una serie di sequenze che durano uno o due minuti, solo per far vedere come era cresciuto o
invecchiato[…]. Questo spezzettare un’esistenza in alcuni momenti banali che possono essere
caraterizzati schematicamente simbolizza la dissoluzione dell’umanità in elementi di
amministrazione.11
Questa affermazione, che può prestare facilmente il fianco a critiche su una certa
miopia retriva del suo autore, nasconde in realtà fondamentali germi di
riflessione. Il frammento, che nel cinema affiora a necessità espressiva ancor
prima che linguistica, è ellissi implicita di ciò che si considera inessenziale. È
quindi sintesi temporale, manifestazione di una totalità virtuale non riscattata da
una nuova definizione della totalità. Solo a livello percettivo, seguendo il tracciato
di un semplice aggiramento sensoriale, destinato a determinare un’abitudine
fruitiva12, questo tempo si annuncia come omogeneo e compiuto.
La ‘serialità’ del tempo, di cui si appropria l’estetica del frammento, manifesta
con maggiore violenza ed evidenza i suoi effetti nel passaggio, intervenuto nei
primi decenni del Novecento, dall’ascolto musicale diretto alla riproduzione
radiofonica, che reifica e atomizza la fruizione. La possibilità di riprodurre musica
su nastri fruibili estesamente, e cioè la massificazione di un ascolto parcellare, è
frammentazione potenziale della continuità di tempo, implicita nella sequenza
musicale. Se la sostanza musicale è suono correlato al tempo, non tanto la perdita
d’aura di una totalità d’opera costituisce il primo effetto della reificazione del
9
frammento musicale, quanto l’affiorare di un’artificiosa ‘atemporalità ripetitiva’13
che riduce a materiale seriale il suono.
Cinema e musica, ovvero immagine in movimento e suono, costituiscono la
sostanza del frammento. Costituiscono cioè gli strumenti principali di
focalizzazione e rovesciamento della mistificazione sistemica. Non è un caso se,
operando sulla tensione tra frammento e continuità – sempre per riportarci
all’esempio del nuovo teatro italiano – negli anni Sessanta l’introduzione delle
proiezioni cinematografiche in scena è finalizzata non tanto alla resa
‘spettacolarizzata’ di un’immagine riprodotta filmicamente, quanto a isolare la
sua qualità oggettiva di frammento illusorio di spazio e frammento reale di tempo
in qualità di ritmo (frammento reale di luce). Così come non è un caso che
l’interesse per il suono non sia indirizzato al raggiungimento di una pretesa
totalità scenico-sonora illusiva, ma a sostanziare, della sua qualità temporale
frammentaria, unità acustiche demistificanti.
Le operazioni di certo nuovo teatro su corpo e frammento tendono a porre in
cortocircuito questi due elementi. Basti pensare a come Leo e Perla sfruttino
l’immagine filmica ingombrante che, proprio per la sua inaccessibile enormità,
diventa invasiva espropriando il corpo del suo peso e della sua solidità materiale.
O, ancora, ci si può soffermare sulla micro-unità sonora che, nelle intenzioni di
Carmelo Bene, dovrebbe divorare i residui di una vitalità corporea lasciata
all’abbandono. Oppure si può constatare come la materialità – è il caso del
primissimo Ricci – possa costituirsi dei detriti di frammenti cinetici da esporre in
suoni e immagini. È evidente che interesse per una riformulazione del fisiologico,
dell’oggettuale, e prelievo del frammento per disporlo sulle maglie di un tessuto
lacerato e ridotto a brandelli, sono testimonianze di operazioni condotte su
materiali-base. Materiali moderni, corrotti in quanto artificiosi, compromessi dalla
sclerosi del sistema produttivo industriale. Ma anche materiali dal cui esercizio
non può prescindere un’operazione di rifiuto dell’idioma ufficiale. Quindi corpo e
frammento sono unità espressive sottoposte a una rigorosa operazione di
riflessione dialettica. E non perché essi siano fatti oggetto di un messaggio
contestatario diretto, ma perché utilizzati in quanto sostanze che incorporano una
contraddizione sociale profonda. E ogni approfondimento non orientato a sanare
quella contraddizione ma a dilatarne l’incrinatura, non può che costituire un
episodio di arte negativa.
In Italia, nel decennio che va dal 1959 al 1967, un certo tipo di nuovo teatro, nato
prima del Convegno di Ivrea e quindi non ancora parte dell’ondata dei successivi
gruppi sperimentali – sorti sui fasti teorici di quel 1967 –, opera in direzione di
una riformulazione negativa delle componenti basilari del teatro. Il corpo, il corpo
nello spazio, la tecnologia, le modalità di fruizione: tutti elementi problematizzati
dalle nuove forme produttive e tutti impliciti nell’articolazione oggettuale e nella
fenomenologia della frammentazione. Tutti elementi sottoposti alla logica
deteriorante della società dello spettacolo. Il corpo è quanto reclama una
sostanzializzazione, che è anche rappresentazione negativa della sua virtuale
ostensione. Il corpo è replicato, smembrato, dilatato e rimpicciolito, sezionato in
parti attrattive da esporre come resti di tessuto industriale. È soprattutto reificato e
privato di quelle potenzialità esperienziali non connesse alla commerciabilità. Lo
spazio è vuoto sospeso, privo di senso, che acquista significato solo se
socializzabile: solo se ottiene collocazione produttiva esso esiste. Lo spazio può
10
esistere solo in quanto dimensione espositiva. La tecnologia è movimento
riproduttivo, asettico e perfettibile, cui è affidato il compito di amalgamare corpo
e frammento all’immagine, in una totalità del tutto virtuale. Anche il rapporto con
il pubblico non può che essere caratterizzato da disorganicità e alienazione,
fruizione separata e virtuale. Nelle contraddizioni interne a questi elementi, il
nuovo teatro si incunea per dilatarne la spaccatura. Una dilatazione che è
negazione (o tensione verso questa negazione) della qualità di fondo della
posizione occupata da quegli stessi elementi, nel sistema ufficiale.
5 – Ripetizione e differenza
Proprio per questo si parla continuamente di idea, novelty e surprise, di ciò che dovrebbe
essere insieme arcinoto e mai esistito. Ritmo e dinamismo sono al servizio di questo scopo.
Nulla deve restare com’era prima, tutto deve continuamente scorrere, essere in moto. Poiché
solo l’universale trionfo del ritmo della produzione e della riproduzione meccanica può
assicurare che nulla muti, e che non appaia mai qualcosa di incongruo.14
Negli anni Sessanta, il problema immanente a una prospettiva di fuga dal ‘ritmo e
dinamismo’ imposto dalla scansione della produzione industriale, è esteticamente
risolvibile problematizzando la ripetizione. Se il sistema ufficiale deve ‘assicurare
che nulla muti’ per offrire al ‘pubblico’ la credibilità di una totalità organica
raggiunta, un lavoro sotterraneo rispetto all’ufficialità non può che assumere e
riversare la sostanza della ripetizione nella fenditura della differenza. Il nuovo
teatro italiano si impegna in un lavoro di disgregazione di alcune unità di
reduplicazione, mettendone in luce le contraddizioni interne. In una prospettiva
sintetica le coordinate che queste unità individuano sono circoscritte al tessuto
spaziale, temporale e materiale-corporeo.
La moltiplicazione delle dinamiche minime di movimento e l’oggettivazione del
fisiologico sono i presupposti di scardinamento della pseudo-positività del corpooggetto. Il corpo – l’oggetto – non è immagine luminosa che sia possibile
contenere nella bidimensionalità asettica dell’offerta pubblicitaria. Tanto meno
frammento funzionale alla produzione. Quella lucidità accattivante o significativa
è unità cinetica fredda, materialmente deperibile. Quel frammento funzionale è
corpo suscettibile di produrre un’espressione autonoma, corpo sfuggente.
L’oggetto, il frammento di corpo, è residuo di una macchina produttiva ma è
residuo autonomo che fatalmente può occupare, con terribile voracità, l’intera
scena. Di qui il frammento abnorme usato nel Gulliver di Ricci o l’accatastamento
asfittico dell’oggetto di trovarobato in Bene. Anche il mezzo tecnico che Leo e
Perla espongono impudicamente in scena è perdita di controllo sull’oggetto.
Correlato del corpo, frantumato e riprodotto, è uno spazio atomizzato, svuotato di
capacità espressive autonome. Lo spazio di scena è un vuoto cui è negata qualsiasi
possibilità autonoma di significazione. Esso, al contrario, riverbera il suo statuto
di vuoto insignificante su ogni oggetto che ne occupi una porzione, che voglia
assumersene le responsabilità significative. La scena non può che esistere come
11
campo di replica del materiale, disponibile ad accogliere tensioni di ogni tipo e ad
acquisire i connotati reduplicati di quelle tensioni.
Maggiore rilievo, ma anche impegno più sostanzioso, richiede il lavoro sul tempo.
Il ritmo corrisponde al coordinamento dei frammenti di materia nei vuoti di
spazio. Ogni elemento materiale, connesso alla virtualità della successione
ritmica, ha due possibilità di riuscita. Può ripetersi in un’esasperante replica che
confermi la serialità del tempo produttivo, o può svincolarsi dalla serialità
annullando il potenziale illusivo del suo statuto di segno-materiale. L’immagine
scandita dal proiettore può divorare il corpo e se stessa riducendosi a impulso
ritmico luminoso. Può incidere l’ombra, in scena, rendendo il mero negativo unico
elemento significante dello spettacolo. Lo stesso vale per il suono. L’audio
riprodotto dal registratore, il suono diretto in asincrono, sono i risultati di un
utilizzo materico della sostanza sonora. La riproduzione o la finzione, connesse al
suono di scena, sono anti-illustrative, anti-illusive. Il suono, nella sua
compromissione con il riproducibile o nella sua costituzione diretta è tempo che
scandisce un’assenza. Assenza di un corpo, assenza di spazio. Tuttavia corpo,
tempo, spazio, nei lavori del nuovo teatro italiano, determinano una peculiare
tensione verso l’organicità presente dell’evento. Un’organicità problematica e
continuamente messa in crisi.
Abbiamo scelto di usare il termine ‘negazione’, che possiede qui valore concettuale e in parte
metodologico, in riferimento da un lato all’estetica negativa adorniana, verso cui dichiariamo
quindi, in questo modo, il nostro debito. Dall’altro lato, l’utilizzo di suddetto termine si è reso
necessario esaminando i documenti teorici e interpretativi prodotti dalla speculazione critica degli
studiosi che hanno cercato di comprendere il nuovo teatro italiano, nei primi anni Settanta (come
si vedrà, argomento del presente testo). Il termine ‘negazione’, infatti, ricorre, con valore
strumentale analitico non trascurabile, sulle pagine della rivista che più di ogni altra si è occupata
del nuovo teatro, ovvero Teatro, diretta da Giuseppe Bartolucci, Edoardo Fadini, Ettore Capriolo.
Potrebbe essere sufficiente, uno tra i tanti casi, il titolo scelto da Bartolucci, Sul nuovo teatro
«negativo» e «utopia», per un suo intervento ‘consuntivo’ che apparve sul numero 3, anno III
1970, di quella rivista. Ma non è tanto il vezzo dell’intestazione saggistica, pur irrefutabile, che ci
forza ad utilizzare il concetto di ‘negazione’. Infatti, esso è infine per noi sufficientemente
giustificato dall’insistenza con cui l’affabulazione di un numero rilevante di contributi, inseriti in
Teatro, ne chiama in causa esplicitamente l’incisività teorica. Intediamo così rendere ragione di
quanto si propone non come una forzatura, né come una mistificazione intellettuale, ma come la
presa d’atto di posizioni teoriche e critiche chiare che, altrettanto chiaramente, hanno influenzato –
e da essi si sono lasciate influenzare – i percorsi creativi degli artisti del nuovo teatro.
1
T.W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1970, pp.143,144.
2
M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell'illuminismo, Einaudi, Torino 1997, p.170.
3
Ivi, p.138.
4
Decidiamo di usare la denominazione ‘nuovo teatro’, che riteniamo preferibile a ‘teatro
sperimentale’, ‘neoavanguardia’, ‘teatro di ricerca’, ‘teatro di alternativa’, ‘teatro indipendente’,
perché essa possiede funzione strumentale, storicamente connotata. Si tratta infatti di una
categoria ‘attributiva’ – utilizzata come strumento per comprendere l’operato di alcuni gruppi
teatrali, attivi tra gli anni Sessanta e i Settanta – forgiata durante il Convegno di Ivrea. Il ‘nuovo
teatro’ è la designazione cui gli organizzatori del Convegno scelsero di far risalire l’intero
apparato concettuale e interpretativo elaborato in quella sede.
5
Sull’importanza dello shock nell’arte moderna, cfr, W. Benjamin, Angelus Novus, in particolare, Baudelaire e Parigi,
Einaudi, Torino 1995.
6
M. Jay, L’immaginazione dialettica, Einaudi, Torino 1979, p. 102.
7
M. Horkheimer, T.W. Adorno, op. cit , p178
*
12
8
T.W. Adorno, op. cit, p. 129.
L. Bonotto, M. Guderzo, R. Melchiori, T. Santi, G.E. Simonetti, a cura di, Crisi della rappresentazione e iconoclastia
delle arti, DeriveApprodi, Roma 1999, p.13.
10
Ivi, p. 38.
11
M. Jay, op. cit, p.329.
12
In merito alle consuetudini maturate nei processi di fruizione dell’opera d’arte, ci sembra non
sarebbe privo di interesse un esame della ‘assuefazione’ al cliché di tanta arte contemporanea, che
prenda le mosse proprio da, Adorno, T.W, Sulla popular music, Armando, Roma 2004. Crediamo
che simile analisi possa gettare una prima luce, ancorchè precoce, sull’uso creativo dei
campionamenti audiovisivi.
13
Ivi, p.300.
14
M. Horkheimer, T.W. Adorno, op. cit, p.142.
9
13