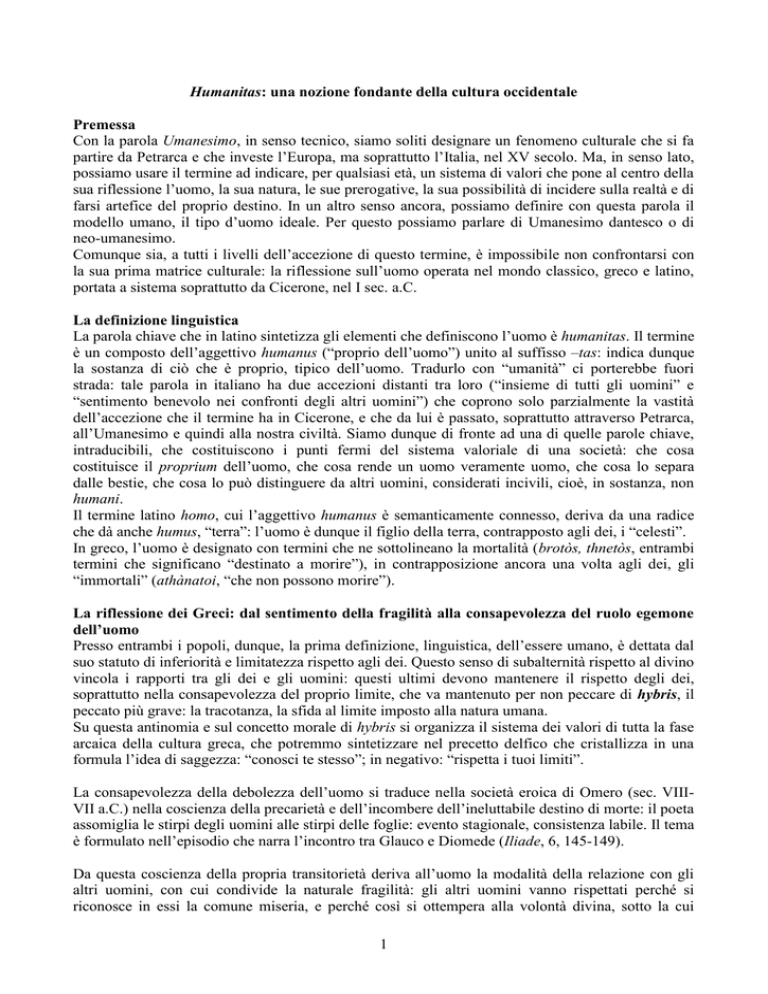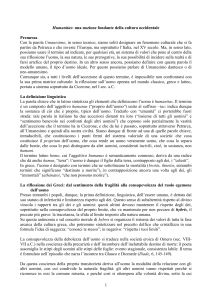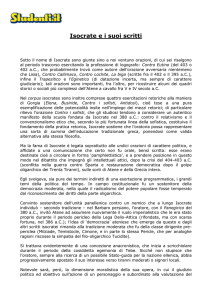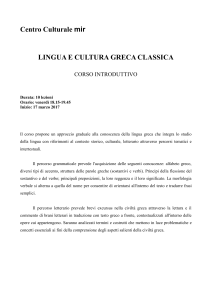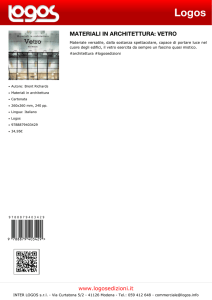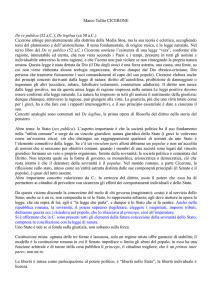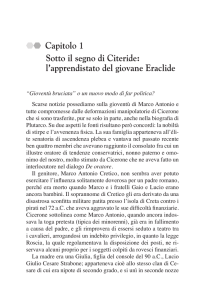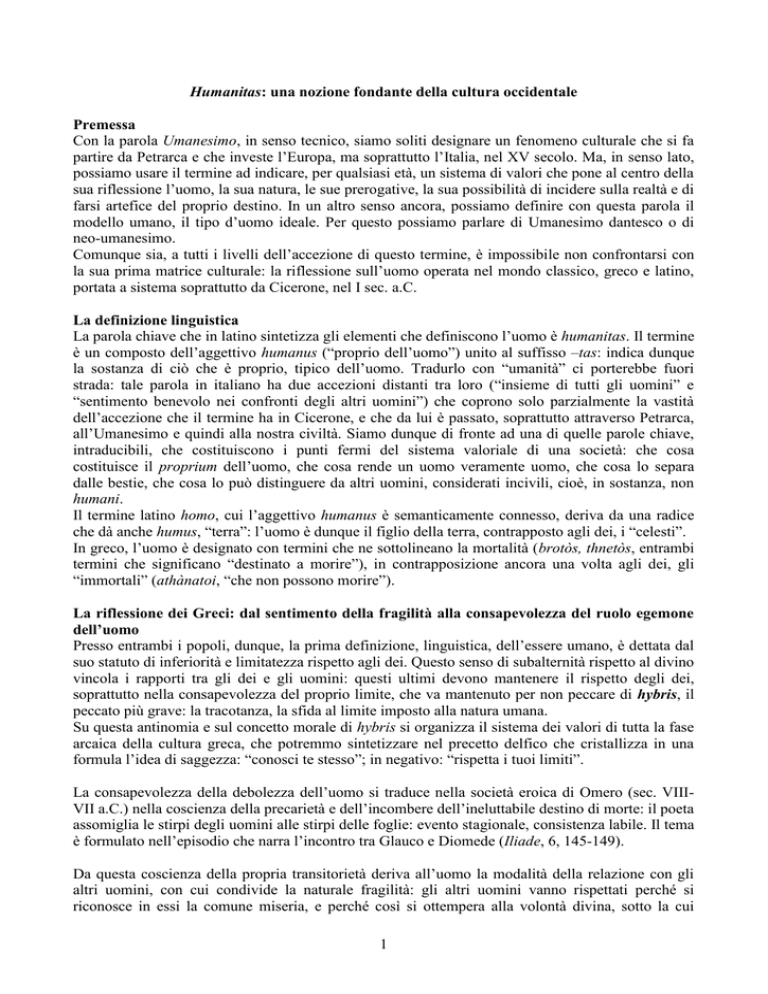
Humanitas: una nozione fondante della cultura occidentale
Premessa
Con la parola Umanesimo, in senso tecnico, siamo soliti designare un fenomeno culturale che si fa
partire da Petrarca e che investe l’Europa, ma soprattutto l’Italia, nel XV secolo. Ma, in senso lato,
possiamo usare il termine ad indicare, per qualsiasi età, un sistema di valori che pone al centro della
sua riflessione l’uomo, la sua natura, le sue prerogative, la sua possibilità di incidere sulla realtà e di
farsi artefice del proprio destino. In un altro senso ancora, possiamo definire con questa parola il
modello umano, il tipo d’uomo ideale. Per questo possiamo parlare di Umanesimo dantesco o di
neo-umanesimo.
Comunque sia, a tutti i livelli dell’accezione di questo termine, è impossibile non confrontarsi con
la sua prima matrice culturale: la riflessione sull’uomo operata nel mondo classico, greco e latino,
portata a sistema soprattutto da Cicerone, nel I sec. a.C.
La definizione linguistica
La parola chiave che in latino sintetizza gli elementi che definiscono l’uomo è humanitas. Il termine
è un composto dell’aggettivo humanus (“proprio dell’uomo”) unito al suffisso –tas: indica dunque
la sostanza di ciò che è proprio, tipico dell’uomo. Tradurlo con “umanità” ci porterebbe fuori
strada: tale parola in italiano ha due accezioni distanti tra loro (“insieme di tutti gli uomini” e
“sentimento benevolo nei confronti degli altri uomini”) che coprono solo parzialmente la vastità
dell’accezione che il termine ha in Cicerone, e che da lui è passato, soprattutto attraverso Petrarca,
all’Umanesimo e quindi alla nostra civiltà. Siamo dunque di fronte ad una di quelle parole chiave,
intraducibili, che costituiscono i punti fermi del sistema valoriale di una società: che cosa
costituisce il proprium dell’uomo, che cosa rende un uomo veramente uomo, che cosa lo separa
dalle bestie, che cosa lo può distinguere da altri uomini, considerati incivili, cioè, in sostanza, non
humani.
Il termine latino homo, cui l’aggettivo humanus è semanticamente connesso, deriva da una radice
che dà anche humus, “terra”: l’uomo è dunque il figlio della terra, contrapposto agli dei, i “celesti”.
In greco, l’uomo è designato con termini che ne sottolineano la mortalità (brotòs, thnetòs, entrambi
termini che significano “destinato a morire”), in contrapposizione ancora una volta agli dei, gli
“immortali” (athànatoi, “che non possono morire”).
La riflessione dei Greci: dal sentimento della fragilità alla consapevolezza del ruolo egemone
dell’uomo
Presso entrambi i popoli, dunque, la prima definizione, linguistica, dell’essere umano, è dettata dal
suo statuto di inferiorità e limitatezza rispetto agli dei. Questo senso di subalternità rispetto al divino
vincola i rapporti tra gli dei e gli uomini: questi ultimi devono mantenere il rispetto degli dei,
soprattutto nella consapevolezza del proprio limite, che va mantenuto per non peccare di hybris, il
peccato più grave: la tracotanza, la sfida al limite imposto alla natura umana.
Su questa antinomia e sul concetto morale di hybris si organizza il sistema dei valori di tutta la fase
arcaica della cultura greca, che potremmo sintetizzare nel precetto delfico che cristallizza in una
formula l’idea di saggezza: “conosci te stesso”; in negativo: “rispetta i tuoi limiti”.
La consapevolezza della debolezza dell’uomo si traduce nella società eroica di Omero (sec. VIIIVII a.C.) nella coscienza della precarietà e dell’incombere dell’ineluttabile destino di morte: il poeta
assomiglia le stirpi degli uomini alle stirpi delle foglie: evento stagionale, consistenza labile. Il tema
è formulato nell’episodio che narra l’incontro tra Glauco e Diomede (Iliade, 6, 145-149).
Da questa coscienza della propria transitorietà deriva all’uomo la modalità della relazione con gli
altri uomini, con cui condivide la naturale fragilità: gli altri uomini vanno rispettati perché si
riconosce in essi la comune miseria, e perché così si ottempera alla volontà divina, sotto la cui
1
protezione si pongono i deboli. Questa relazione comporta atteggiamenti di tipo aristocratico, una
benevolenza che Omero definisce col termine philophrosyne, letteralmente “amore per la
temperanza”: “questo termine (...) vuol significare che qualcuno tratta cordialmente le persone di
cui non sarebbe obbligato a curarsi in modo speciale” (Snell, La cultura greca).
Va detto comunque che tale atteggiamento è riservato ai membri del gruppo, e ne sono esclusi
coloro che non rispettano il modello etico proposto dal codice eroico, quello della kalokagathia:
ideale etico ed estetico di equilibrio interiore ed esteriore. Significativo al proposito l’esempio di
Tersite nel II libro dell’Iliade: questo soldato è “smodato”, “molte parole sapeva in cuore, ma a
caso”ed é “l’uomo più brutto che venne sotto Ilio”. Per questo, nonostante il discorso che pronuncia
contro Agamennone sia per molti aspetti coincidente con le accuse che al sovrano rivolge Achille,
viene colpito da Ulisse. I compagni lo deridono senza pietà (Il. 2, 265-275).
Occorre attendere il V sec. perché l’uomo si renda consapevole del proprio ruolo egemone rispetto
alle altre creature viventi. La predicazione dei Sofisti laicizza la prospettiva sull’uomo, che, secondo
Protagora, diviene il criterio per il giudizio sulla realtà (fr. 1 D.K.):
Di tutte le cose misura è l’uomo: di quelle che esistono in quanto esistono e di quelle che non
esistono in quanto non esistono .
L’uomo è in grado di sottomettere la natura e di migliorare le proprie condizioni di vita; sfuggendo
alla legge che vuole le bestie sottoposte esclusivamente all’istinto, è capace di ricorrere alla propria
ragione, il logos, per piegare le circostanze alla propria volontà.
Anche Sofocle propone attraverso i suoi eroi un modello di umanità ideale, in cui le prerogative
umane risaltano nel tragico conflitto con un destino di morte. Ma l’orizzonte è segnato dalla
presenza ineluttabile del limite imposto dalla natura all’uomo. Paradigmatico a questo proposito il
celebre coro del primo stasimo dell’Antigone, perché alla esaltante celebrazione delle risorse umane
segue la tragica consapevolezza della inevitabilità della morte (vv. 332s. e 368-375):
Molte sono le cose che suscitano meraviglia
ma nessuna suscita più meraviglia dell’uomo (...).
E imparò per sé la parola, e il pensiero veloce come il vento
e le leggi del vivere civile
e a fuggire i colpi dei geli inospitali
e le piogge rovinose,
l’uomo ricco di risorse: non c’è nulla
nel futuro che lo trovi privo di mezzi.
Solo dalla morte
non si procurerà scampo.
La necessità della morte è ricordata come limite invalicabile; se l’uomo è in grado di trovare
comunque un passaggio percorribile di fronte alle difficoltà (è questo il senso etimologico del
termine pantoporos, che abbiamo tradotto “ricco di risorse”), non deve tuttavia scordare il proprio
limite. Tale consapevolezza salvaguarda l’uomo dal peccato più grave, che resta, in linea con la
meditazione arcaica, la hybris.
L’ “umanità” di Euripide
Nel teatro di Euripide troviamo che ai personaggi del conflitto tragico viene riservata la possibilità
di esprimere le proprie ragioni, senza essere preliminarmente giudicati in base a criteri sociali, o
razziali, o di appartenenza di genere. Non a caso spesso le protagoniste delle sue tragedie sono
donne. Medea, ad esempio, è un personaggio abnorme: la donna, una straniera proveniente dalla
2
Colchide, è stata abbandonata dal marito Giasone, per amore del quale aveva tradito la patria,
perduto la famiglia, ucciso il padre e il fratello; per vendicarsi di lui, che la lascia priva di tutto,
decide di compiere un’azione immane e abominevole: uccide infatti i figli nati dalla loro unione.
Pure, alle sue ragioni viene lasciato lo spazio dell’intera tragedia, ed essa suscita la nostra pietà:
riconosciamo, con Snell, che ella “ha per sé soltanto il diritto umano universale”.
La strenua analisi intellettuale e il rigore critico (strumenti che gli derivano dalla Sofistica) con cui
il poeta indaga il rapporto dell’uomo col proprio destino, lo fanno giungere alla conclusione che è
impossibile negare nella realtà “la categoria dominante: il compromesso, o assunzione parziale dei
dati contrastanti”, come scrive Guido Paduano (Il nostro Euripide, l’umano). Cioè: c’è un’istanza di
verità in ogni uomo, come in ogni uomo esistono una debolezza e una negatività ineludibili.
Filantropia universale?
La riflessione euripidea ci riporta alla questione, accennata a proposito dell’epica omerica, del
limite entro cui si esercita la benevolenza reciproca; Euripide si fa portavoce di un’istanza che verrà
teoreticamente fondata nel secolo successivo dalla speculazione degli Stoici: egli riconosce e
testimonia la sostanziale unità del genere umano, attribuendo pari dignità ad ogni individuo,
indipendentemente dalle condizioni in cui egli è nato. Per questo risultava alla sua epoca
scandaloso, visto che l’indagine sulle prerogative dell’uomo nell’etica antica si impernia su una
discriminazione che la coscienza dei moderni percepisce come un limite profondissimo: il diritto
naturale, la legge della benevolenza reciproca, e le sue derivate istituzionali, leggi e garanzie,
valgono solo per determinate categorie umane. Come sappiamo, per secoli l’esercizio di questa
legge non è valso nei confronti delle donne, degli stranieri e degli schiavi. Una citazione valga per
tutte: racconta Diogene Laerzio che Talete fosse solito dire che ringraziava il destino di tre cose: di
essere nato uomo e non animale, maschio e non femmina, greco e non barbaro (Diog. Laerz.1, 33).
Isocrate e il concetto di paideia
Nel IV sec. la concezione di “ciò che pertiene all’uomo” si arricchisce di un elemento, già presente
nella predicazione sofistica: ciò che distingue l’uomo dalle bestie è il suo logos, cioè la sua capacità
di pensare, e di sapere esprimere i propri pensieri con la parola (ancora logos).
E’ Isocrate, il più famoso retore ateniese della sua epoca, che, in una polemica con il
contemporaneo Platone, attribuirà alla maestria nel dominio del linguaggio il più alto traguardo
dell’umanità:
Atene ha onorato l’arte del parlare (tutti ne provano desiderio, e tutti invidiano chi la possiede),
ben sapendo che questo solo, fra tutti gli animali, è per natura nostra particolare prerogativa e che
perciò, se siamo superiori in questo, ci distinguiamo da tutti gli altri. (Panegirico, 48)
La funzione della parola è strettamente connessa al reperimento e alla trasmissione dei valori etici
fondanti la comunità umana:
E’ la parola che ci ha fornito tutto ciò che abbiamo escogitato. Essa infatti ha stabilito ciò che è
giusto e ciò che è ingiusto, ciò che è bello e ciò che è turpe, e se queste cose non fossero state
stabilite, noi non saremmo in grado di vivere insieme. Attraverso la parola disprezziamo i malvagi
e lodiamo i buoni. Attraverso la parola educhiamo gli ignoranti e onoriamo i sapienti:
consideriamo infatti giustamente il saper parlare come si deve il massimo segno di saggezza, e un
discorso veritiero e lecito e giusto è lo specchio di un’anima buona e affidabile. (Antidosis, 254255)
I fondamenti etici, senza i quali la parola diventa uno strumento ingannevole e pericoloso (Isocrate
scrive un’orazione Contro i Sofisti), sono quelli ancorati alla tradizione ateniese, di matrice
soloniana, improntata al senso della misura, alla saggezza e alla giustizia:
3
Scoprirete che la mancanza di moderazione e la tracotanza (hybris) sono causa di mali, mentre la
saggezza (sofrosyne) è causa di beni. (Aeropagitico, 119)
Fondamentale pertanto per la costituzione di un buon cittadino è una propensione naturale, dal
momento che la virtù, secondo Isocrate, non è insegnabile. Ma la buona disposizione può essere
fortificata e giungere a maturazione grazie a una cultura appropriata, ottenuta attraverso un percorso
educativo (in greco paideia) che prevede come summa del sapere l’abilità oratoria: non vano
tecnicismo, ma salda unione tra sistema di valori, solida cultura e arte retorica.
Dunque “imparare a ben parlare significava nello stesso tempo imparare a ben pensare, e anche a
ben vivere. (..) Paideia designa contemporaneamente educazione e cultura” (H.I.Marrou, Storia
dell’educazione nell’antichità). Si tratta pertanto di un’ “un’oratoria che (...) vuole porsi quale
disciplina principe in un ideale curriculum umanistico che possa assorbire ogni altro aspetto del
sapere; ed è una concezione della retorica, questa, destinata a dominare pressoché senza contrasti
per tutta la latinità e per buona parte del Medioevo” (F. Condello, in Enciclopedia dell’antico,
Einaudi).
L’ellenismo e l’affermazione della dimensione privata su quella politica
Con la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) si dà solitamente avvio a quel periodo della storia
greca che va sotto il nome di ellenismo: infranto il sogno di una monarchia universale, l’alternativa
non fu il ritorno al sistema delle poleis, che avevano mostrato tutta la loro debolezza all’avvento
della supremazia macedone, ma la costituzione di stati monarchici. Con il tramonto della polis
tramonta anche un aspetto fondamentale connesso all’idea di uomo, quello politico: essere cioè
uomo nell’orizzonte di una dimensione civica, essere uomo in quanto cittadino. L’avvento della
monarchia di tipo ellenistico, abolendo di fatto qualsiasi potere decisionale al di fuori di quello del
sovrano, sottrae all’uomo questa dimensione di partecipazione e di responsabilità civica. Le risorse
dell’uomo, come le sue paure, vengono ora gestite nella sfera del privato. Come è stato detto da più
parti, l’uomo, da cittadino che era, diventa individuo.
Il concetto di philanthropia nel quadro della cosmpopolis stoica
Il passaggio dalla prevalenza della dimensione politica alla riduzione individualistica dell’uomo che
si realizza nella sfera del privato è testimoniato da un parallelo mutamento che investe la
speculazione filosofica: nelle filosofie ellenistiche (dall’epicureismo, allo stoicismo, alla filosofia
dei cinici o degli scettici) è la dimensione etica che prevale su tutto il resto.
In particolare, allo stoicismo, che sarà la più diffusa delle filosofie ellenistiche a Roma, si deve
l’attribuzione di una base teoretica al concetto, già discusso, di filantropia universale. Secondo gli
Stoici, il mondo è governato da un logos divino, che è ordine e provvidenza del mondo. Le anime
individuali partecipano di questa natura razionale, sono parte di essa. Ne deriva che tutti gli uomini,
in quanto parte consustanziale della ratio divina, hanno pari dignità:
Ne consegue che per natura il favore degli uomini nei confronti degli uomini sia comune, e che
necessariamente l’uomo non appare estraneo all’uomo per questo: perché è un uomo. (Cic. de fin.,
3, 62)
Anche la schiavitù, se pure viene accettata come fenomeno storico, accidentale e contingente, viene
respinta a livello teorico, contrastando la famosa affermazione di Aristotele secondo la quale gli
schiavi sono tali per natura. Citiamo un passo di uno scrittore cristiano, Lattanzio, che riferisce
questo concetto stoico:
Se la natura dell’uomo è capace di sapienza, necessariamente sia gli operai che i contadini che le
donne e in buona sostanza tutti quelli che hanno forma umana, debbono essere educati ad essere
sapienti; così si forma un popolo di sapienti di ogni lingua e condizione e sesso ed età (SVFIII,
253).
4
Se tutti gli uomini, partecipi della stessa prerogativa di razionalità, hanno pari dignità, al concetto di
differenziazione degli uomini in base all’appartenenza ad una specifica categoria o a una specifica
comunità si sostituisce un’idea di mondo cosmopolita, in cui tutti gli esseri razionali, uomini e dei,
abitano:Tutto questo mondo deve essere considerato una sola città comune agli uomini e agli dei
(Cic. de leg., 1, 7 23)
Non solo dunque, a livello di relazioni orizzontali, si estingue la differenziazione tra categorie
privilegiate e categorie discriminate di uomini, ma anche, a livello verticale, si annulla la percezione
di quella distanza tra gli uomini e gli dei, che aveva costituito inizialmente la base per la definizione
stessa dell’essere umano.
Il ruolo chiave di Cicerone nella divulgazione della nozione di humanitas
Cicerone, nel I sec. a.C., introdurrà a Roma in modo sistematico gli elementi fondamentali della
cultura greca, fino ad allora guardata con sospetto più o meno esibito e più o meno sincero.
Il progetto culturale, ambiziosissimo, si scontrava però con la diffidenza che la classe dirigente a
Roma nutriva per la grecità, che veniva considerata, nell’ottica di un pragmatismo e di un
tradizionalismo sostanzialmente acritico, troppo intellettualistica e individualistica (non
dimentichiamo che il contatto stringente tra le due culture avviene in epoca ellenistica).
Esso prevedeva la rielaborazione dei due assi fondamentali dello sviluppo della paideia greca: la
filosofia e la retorica.
Eclettico in campo filosofico, Cicerone eleggerà tuttavia il sistema stoico delle virtù cardinali a
fondamento etico della società civile da lui idealmente disegnata. Tale sistema verrà arricchito dalla
intransigente tradizione di valori romana, legata al mos maiorum e decisamente orientata verso un
esercizio pubblico della saggezza e verso una dimensione civica dell’individuo.
Seguace di Isocrate, egli attribuirà sempre all’eloquenza il sommo gradino del sapere, considerando,
come il suo maestro, che nell’arte della parola consista il proprium dell’uomo, e che l’esercizio di
tale arte, mai disgiunto dai fondamenti etici riconosciuti dal gruppo sociale, non si riduca ad un
sapere tecnicistico, ma debba comprendere una cultura enciclopedica e una solida base morale (e
che pertanto comprenda, nel suo massimo grado di perfezione, anche la filosofia).
5