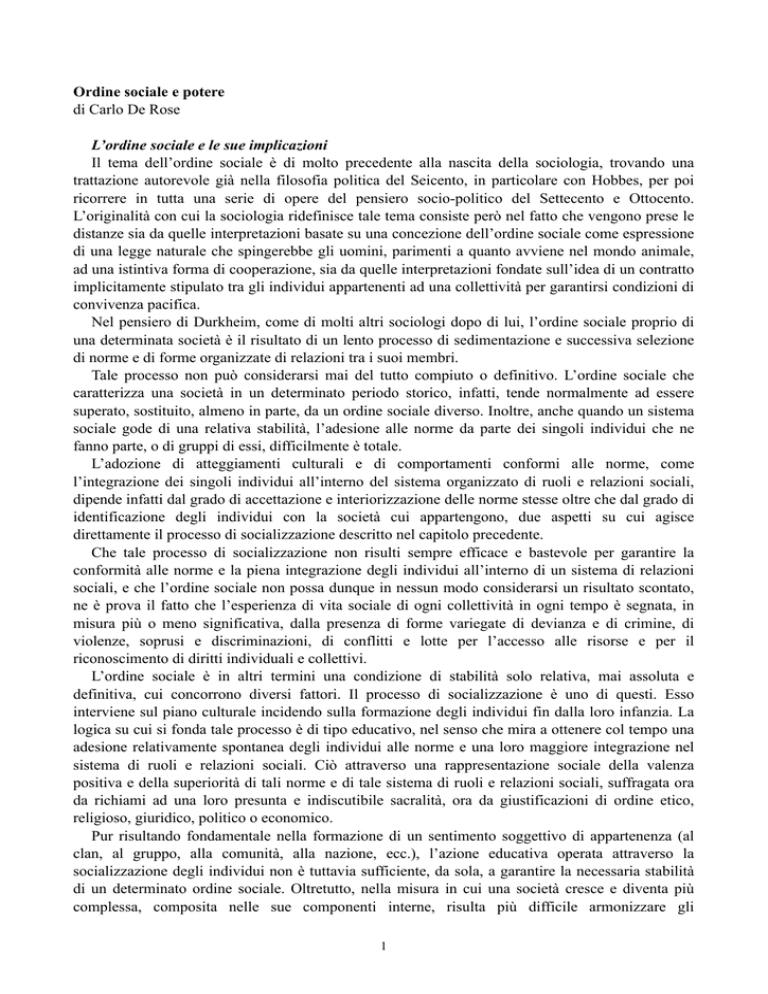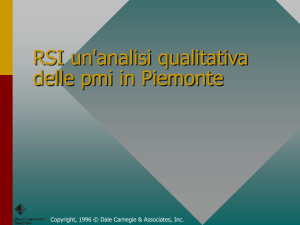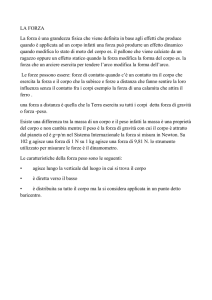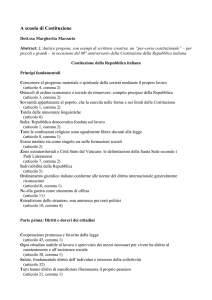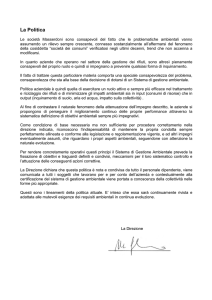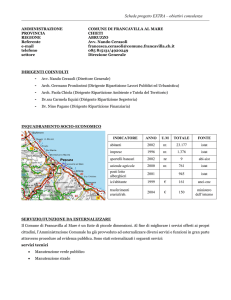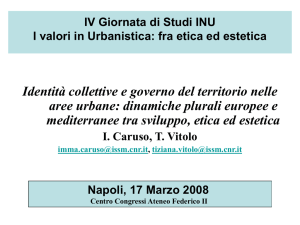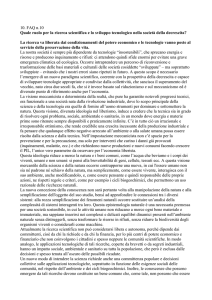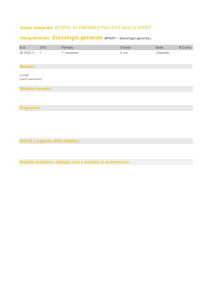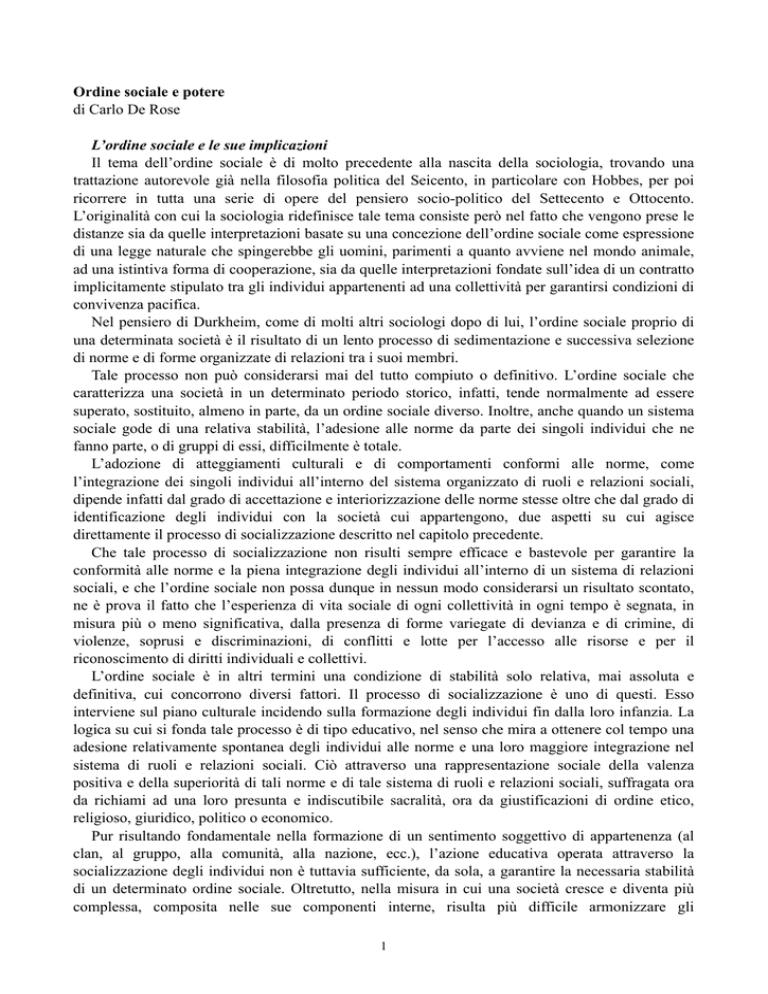
Ordine sociale e potere
di Carlo De Rose
L’ordine sociale e le sue implicazioni
Il tema dell’ordine sociale è di molto precedente alla nascita della sociologia, trovando una
trattazione autorevole già nella filosofia politica del Seicento, in particolare con Hobbes, per poi
ricorrere in tutta una serie di opere del pensiero socio-politico del Settecento e Ottocento.
L’originalità con cui la sociologia ridefinisce tale tema consiste però nel fatto che vengono prese le
distanze sia da quelle interpretazioni basate su una concezione dell’ordine sociale come espressione
di una legge naturale che spingerebbe gli uomini, parimenti a quanto avviene nel mondo animale,
ad una istintiva forma di cooperazione, sia da quelle interpretazioni fondate sull’idea di un contratto
implicitamente stipulato tra gli individui appartenenti ad una collettività per garantirsi condizioni di
convivenza pacifica.
Nel pensiero di Durkheim, come di molti altri sociologi dopo di lui, l’ordine sociale proprio di
una determinata società è il risultato di un lento processo di sedimentazione e successiva selezione
di norme e di forme organizzate di relazioni tra i suoi membri.
Tale processo non può considerarsi mai del tutto compiuto o definitivo. L’ordine sociale che
caratterizza una società in un determinato periodo storico, infatti, tende normalmente ad essere
superato, sostituito, almeno in parte, da un ordine sociale diverso. Inoltre, anche quando un sistema
sociale gode di una relativa stabilità, l’adesione alle norme da parte dei singoli individui che ne
fanno parte, o di gruppi di essi, difficilmente è totale.
L’adozione di atteggiamenti culturali e di comportamenti conformi alle norme, come
l’integrazione dei singoli individui all’interno del sistema organizzato di ruoli e relazioni sociali,
dipende infatti dal grado di accettazione e interiorizzazione delle norme stesse oltre che dal grado di
identificazione degli individui con la società cui appartengono, due aspetti su cui agisce
direttamente il processo di socializzazione descritto nel capitolo precedente.
Che tale processo di socializzazione non risulti sempre efficace e bastevole per garantire la
conformità alle norme e la piena integrazione degli individui all’interno di un sistema di relazioni
sociali, e che l’ordine sociale non possa dunque in nessun modo considerarsi un risultato scontato,
ne è prova il fatto che l’esperienza di vita sociale di ogni collettività in ogni tempo è segnata, in
misura più o meno significativa, dalla presenza di forme variegate di devianza e di crimine, di
violenze, soprusi e discriminazioni, di conflitti e lotte per l’accesso alle risorse e per il
riconoscimento di diritti individuali e collettivi.
L’ordine sociale è in altri termini una condizione di stabilità solo relativa, mai assoluta e
definitiva, cui concorrono diversi fattori. Il processo di socializzazione è uno di questi. Esso
interviene sul piano culturale incidendo sulla formazione degli individui fin dalla loro infanzia. La
logica su cui si fonda tale processo è di tipo educativo, nel senso che mira a ottenere col tempo una
adesione relativamente spontanea degli individui alle norme e una loro maggiore integrazione nel
sistema di ruoli e relazioni sociali. Ciò attraverso una rappresentazione sociale della valenza
positiva e della superiorità di tali norme e di tale sistema di ruoli e relazioni sociali, suffragata ora
da richiami ad una loro presunta e indiscutibile sacralità, ora da giustificazioni di ordine etico,
religioso, giuridico, politico o economico.
Pur risultando fondamentale nella formazione di un sentimento soggettivo di appartenenza (al
clan, al gruppo, alla comunità, alla nazione, ecc.), l’azione educativa operata attraverso la
socializzazione degli individui non è tuttavia sufficiente, da sola, a garantire la necessaria stabilità
di un determinato ordine sociale. Oltretutto, nella misura in cui una società cresce e diventa più
complessa, composita nelle sue componenti interne, risulta più difficile armonizzare gli
1
orientamenti valoriali, ideologici, politici, religiosi, oltre che gli interessi economici, dei singoli
individui o dei gruppi di individui che ne fanno parte. In questi casi il sistema di norme, ruoli e
relazioni sociali esistente non riesce a rappresentare pienamente la società nella sua complessità,
risultando piuttosto espressione di quelle componenti del tessuto sociale che, per ragioni diverse,
vengono ad occupare una posizione dominante.
Muovendo da queste considerazioni, Durkheim per primo richiama l’attenzione su un secondo
fattore che interviene nel salvaguardare l’ordine sociale: il sistema di sanzioni. Nella misura in cui
l’azione educativa affidata alle agenzie di socializzazione non sortisce gli effetti desiderati, o anche
prescindendo dall’esistenza ed efficacia di un’azione educativa, la società può sempre ricorrere ad
un’azione di tipo sanzionatorio per indurre i singoli individui ad adottare comportamenti e
atteggiamenti conformi al sistema di norme e funzionali al tipo di organizzazione di ruoli e relazioni
sociali in essere nella società medesima.
Tale azione sanzionatoria può assumere forme diverse, che vanno dalla riprovazione sociale
espressa attraverso atteggiamenti di disapprovazione, indignazione, ostracismo ed emarginazione,
alla punizione vera e propria, fino alla repressione. Può penalizzare gli individui sul piano morale o
nella loro immagine pubblica compromettendo la possibilità di una loro integrazione o il
mantenimento di un determinato ruolo sociale. Può tradursi in una privazione di qualche diritto o
nella perdita dei privilegi derivanti dal proprio status. Può infine colpire gli individui nella loro
libertà e integrità fisica.
Benché distinguibili sul piano analitico ed in rapporto alla logica su cui rispettivamente si
fondono, l’azione educativa e l’azione sanzionatoria sono comunque interconnesse, rappresentando
modalità complementari di esercizio del controllo sociale sugli individui. Controllo sociale che,
ritornando alla questione iniziale da cui si è partiti, rappresenta evidentemente una imprescindibile
implicazione nel mantenimento di una qualsiasi sorta di ordine sociale, anche in quelle società
apparentemente più coese. A prescindere dai meccanismi e dalle modalità concrete con cui la
società esercita tale controllo sugli individui, ciò che però qui ci preme sottolineare è la funzione ad
esso associata.
Durkheim, similmente a quanto fa Comte prima di lui, si sofferma principalmente sulla funzione
positiva che i meccanismi del controllo sociale svolgono nel determinare una maggiore integrazione
e cooperazione tra gli individui e nell’evitare, o perlomeno contenere, gli effetti perturbativi
derivanti da uno stato di anomia, cioè di assenza di regole e di valori condivisi tra i membri di una
collettività.
In parziale continuità con Durkheim, anche Parsons concepisce il controllo sociale come un
“sostegno” all’equilibrio del sistema sociale, dal momento che determina un’azione preventiva sui
comportamenti devianti, orientando i membri della società a riconoscere e discernere ciò che non si
deve fare perché dannoso per la collettività cui appartengono. In questa prospettiva interpretativa, il
controllo sociale si scompone cioè in una duplice funzione: persuasiva e dissuasiva. Serve a
persuadere i membri di una collettività ad adottare atteggiamenti e comportamenti conformi alle
norme e ai valori prevalenti nella collettività medesima. Serve al contempo a dissuadere i membri di
una collettività dal mettere in atto comportamenti devianti (azione preventiva) o a dissuadere coloro
i quali hanno già posto in essere comportamenti devianti dal metterli nuovamente in atto (azione
rieducativa o repressiva).
Secondo altri autori, il controllo sociale presenta una sostanziale ambivalenza di funzioni.
Accanto a quelle appena ricordate ce ne sono altre latenti che derivano dallo stesso assetto dei
rapporti sociali e dalla posizione che singoli gruppi o categorie occupano all’interno della società.
In questa seconda prospettiva interpretativa, il controllo sociale viene considerato non solo in
2
rapporto all’imperativo funzionale cui assolve di salvaguardare l’ordine sociale, ma anche per gli
effetti di limitazione, condizionamento e manipolazione che produce sui membri di una collettività.
Detto in altri termini, il controllo sociale presuppone comunque un esercizio di potere che può
anche essere asservito ad una volontà di dominio di una parte della società su un’altra. In questo
caso, sia nelle sue finalità persuasive perseguite attraverso l’azione educativa dei processi di
socializzazione, sia nelle sue finalità dissuasive perseguite attraverso il sistema di sanzioni, il
controllo sociale non risponderebbe tanto alla difesa di un ordine sociale condiviso che è
espressione degli interessi superiori della collettività, quanto alla riproduzione di una struttura
gerarchica dei rapporti sociali.
Accogliendo questa seconda interpretazione più problematica del controllo sociale quale
meccanismo ambivalente di regolazione dei comportamenti e delle relazioni sociali tra gli individui,
ci si deve a questo punto chiedere su quali sfere della vita sociale degli individui esso interviene e
su quali altre condizioni esso fonda la sua efficacia. La questione non è secondaria se si considera
che il controllo sociale, anche quando non è palesemente finalizzato a garantire forme di dominio di
una parte della società sull’altra, implica comunque delle imposizioni che possono risultare in
contrasto con le idee, gli orientamenti culturali, gli interessi, i bisogni, le aspirazioni dei singoli
individui o di gruppi di essi.
Per rispondere compiutamente a tale interrogativo occorre tornare sul concetto di ordine sociale
e chiarire che con esso non ci si riferisce ad un ordine astratto o universale, anche quando esso è
rappresentato ideologicamente come tale. Esso è piuttosto il risultato di un processo continuo di
sedimentazione e selezione di norme e forme di relazioni che attengono alle diverse sfere della vita
sociale degli individui: quella culturale, quella economica e quella politica.
Alla sfera culturale è riconducibile quel sottoinsieme di norme e forme di relazioni sociali che
trova origine e giustificazione in un sistema di principi, valori, credenze, costumi, modelli di
comportamento, pratiche collettive. Alla sfera economica è invece riconducibile quel sottoinsieme
di norme e forme di relazioni sociali che rispecchia i modi di organizzazione della produzione e
della circolazione dei beni, oltre che il controllo delle risorse materiali, e dei vantaggi che da esso
derivano. A quella politica, infine, è riconducibile quel sottoinsieme di norme e di forme di relazioni
che è espressione, e al contempo fonte di legittimazione, del sistema di governo della collettività.
Tale tripartizione, qui riassunta in termini elementari, rappresenta ovviamente una
semplificazione descrittiva. Ma ai fini della nostra argomentazione ci aiuta ad introdurre e meglio
esplicitare alcuni corollari delle considerazioni sviluppate fino a questo punto.
Il primo corollario riguarda la presunta armonia dell’ordine sociale. In una situazione ideale,
cioè, le norme e le forme delle relazioni che concorrono a identificare un determinato ordine sociale
dovrebbero essere tra loro coerenti.
Nelle società concrete, tuttavia, tale coerenza non è sempre garantita. Quella che può essere una
norma o un principio di riferimento nella sfera culturale, ad esempio, può contraddire una norma o
un principio della sfera economica. Inoltre, può anche darsi che all’interno di una stessa sfera si
sovrappongano norme e principi diversi, tra loro contraddittori, situazione questa che può tradursi in
una varietà di comportamenti, atteggiamenti e orientamenti individuali tra loro non pienamente
compatibili e, dunque, potenzialmente pericolosi per lo stesso ordine sociale.
Il secondo corollario riguarda il tipo di emanazione dell’ordine sociale. Anche qui muoviamo da
un assunto di tipo ideale affermando che in via di principio l’ordine sociale dovrebbe essere una
emanazione della collettività nel suo insieme. Più spesso accade invece che l’ordine sociale assunto
come riferimento, e legittimato come tale, sia in effetti espressione di una componente sociale
dominante, e ciò a prescindere se tale componente dominante corrisponda o meno ad una estesa
maggioranza degli individui che costituiscono la collettività in questione.
3
Il terzo e ultimo corollario riguarda infine il processo che porta al costituirsi e progressivo
mutarsi di un ordine sociale. Tale processo avviene secondo due differenti logiche. Una di tipo
cumulativo, per cui si può affermare che l’ordine sociale di una collettività è il frutto di una lenta
sedimentazione di norme e forme di relazioni sociali che avviene nel tempo e che dunque in esso vi
è traccia della stessa storia di questa collettività. Una di tipo selettivo, dal momento che l’ordine
sociale è al contempo espressione di una continua selezione tra possibili norme e forme di relazioni
sociali tra loro alternative.
Queste due logiche non sono di per sé in contraddizione, ma nelle società concrete si ritrovano
non di rado dei disallineamenti tra ciò che l’ordine sociale eredita dal passato, o potremmo dire
dalla tradizione, e ciò che è il prodotto delle trasformazioni recenti determinatesi nella società.
Simili disallineamenti, ad esempio, si producono nella sfera culturale per effetto
dell’interiorizzazione, da parte di una generazione, di principi, valori, credenze, costumi, modelli di
comportamento, pratiche collettive che difficilmente si abbandonano perché su di essi si fonda la
stessa identità di quella generazione. Da questa resistenza al cambiamento deriva quindi un ulteriore
elemento di incertezza o potenziale debolezza dell’ordine sociale, riconoscibile nel fatto che si
producono diversi orientamenti, ovvero disorientamenti, culturali tra una generazione e l’altra.
Se è vero che sull’ordine sociale e sulla sua stabilità ricadono le contraddizioni appena ricordate,
c’è anche da dire però che gli effetti di tali contraddizioni vengono in parte annullati grazie a due
specifici meccanismi di auto-compensazione e di riproduzione di ogni sistema sociale.
Il primo di questi consiste nella capacità del sistema sociale stesso di accettare e sopportare una
certa quantità di comportamenti e atteggiamenti individuali e collettivi dissonanti con l’ordine
sociale esistente. Tale capacità può variare da società a società, e da epoca a epoca; normalmente
risulta essere direttamente proporzionale al grado di pluralismo e complessità del sistema sociale in
questione. L’accettazione di simili dissonanze, oltretutto, è anche una condizione per l’espressione
ed il riconoscimento di comportamenti e atteggiamenti positivamente innovativi.
Il secondo meccanismo consiste in una sorta di inconsapevole reificazione dell’ordine sociale
che deriva dal fatto che la più parte dei membri della società in questione si comporta esattamente
come se quell’ordine fosse effettivamente esistente e vincolante. Questo atteggiamento
interpretativo della realtà – che si produce e alimenta attraverso le interazioni intersoggettive
quotidiane tra gli individui, e che a sua volta si traduce in una rappresentazione collettiva della
realtà medesima – è descritto da due teorici contemporanei: Peter L. Berger e Thomas Luckmann
(1966). Essi, muovendosi su quel filone di pensiero della sociologia fenomenologica riconducibile
all’opera del sociologo e filosofo austriaco Alfred Schutz (1899-1959), mettono in evidenza la
tendenza culturale presente in tutte le società ad assolutizzare gli ordini convenzionali fino a
concepirli come “naturali”, e ad assumerli come dati per scontati.
Allorché l’azione persuasiva dei processi di socializzazione unitamente ai meccanismi ora
descritti non risultano sufficienti a contenere le spinte che si producono all’interno di una
collettività, e talvolta anche dall’esterno di essa, la riaffermazione e difesa di un determinato ordine
sociale viene affidata ai sistemi di sanzione che agiscono sul piano della dissuasione. A tal riguardo
c’è da sottolineare che l’efficacia di tale controllo presuppone, come già accennato, l’esercizio di un
potere, o per lo meno la possibilità di una sua attivazione. Detto in altri termini, ogni ordine sociale
ha già in sé un richiamo implicito all’esercizio del potere; richiamo che non è solo simbolico, dal
momento che nell’esperienza collettiva si traduce anche in concrete modalità d’azione, in specifici
ruoli e istituzioni, in mezzi e risorse in gioco.
4
Sulla natura del potere
Avendo identificato il potere come una dimensione costitutiva dell’ordine sociale, occorre a
questo punto soffermarsi sul significato specifico che assegniamo a questo termine. Ciò precisando
fin da subito che più che operare una chiarificazione lessicale, qui si tratta di circoscriverlo
concettualmente in rapporto ai fenomeni di interesse delle scienze sociali ed in particolare della
sociologia. Tale compito non è del tutto semplice, anche perché nelle stesse scienze sociali non
esiste una definizione universalmente riconosciuta di potere, come dimostra il fatto che termini
quali influenza, dominio, autorità, supremazia, leadership, vengono talvolta utilizzati come
sinonimi di potere pur se essi attengono più propriamente a particolari forme di esso o tutt’al più
alle sue implicazioni e ai suoi presupposti. La prospettiva di analisi e le questioni da cui muove
specificamente la sociologia sono d’altronde diverse da quelle proprie di altre discipline, tra cui, ad
esempio, la scienza politica, benché proprio sul tema del potere tra queste due discipline vi sia una
sostanziale contiguità di interessi per i fenomeni ad esso associati.
Per altro verso la difficoltà ad operare una delimitazione concettuale deriva anche dal fatto che il
termine potere nel linguaggio comune è utilizzato indistintamente per riferirsi a fenomeni diversi.
Ad esso si fa infatti abitualmente ricorso ora per qualificare una qualche capacità (individuale o
collettiva) di fare qualcosa; ora per riferirsi ad una forma di rapporti sociali caratterizzati
gerarchicamente in funzione del controllo di una qualche risorsa (materiale o immateriale); o ancora
per richiamare l’attenzione sul carattere di presunta superiorità e di forza riconosciuto ad istituzioni,
valori, principi, come avviene allorché si ricorre ad espressioni del tipo: il “potere della legge”, il
“potere dei media”il “potere delle idee”, il “potere della fede”, il “potere dell’amore”.
Focalizzando l’attenzione su quello che è l’uso prevalente del concetto nelle teorie sociali e
politiche contemporanee, si può comunque affermare che con il termine potere ci si riferisce
generalmente alla capacità di un soggetto di intraprendere azioni e assumere decisioni che,
all’interno di un determinato contesto sociale, risultano vincolanti o condizionanti per altri
soggetti, ovvero alla capacità di controllare risorse che rivestono un significato ed un valore
socialmente rilevante. Tale capacità normalmente è esercitata (o è esercitabile) in ragione di un
ruolo, di una posizione o di una carica e presuppone, e al contempo produce, forme asimmetriche
di relazione tra i soggetti coinvolti.
Questa definizione si caratterizza per un elevato livello di astrazione ed offre il vantaggio, nella
sua formulazione generale, di inglobare altre definizioni più specifiche senza privilegiarne
univocamente alcuna. Tuttavia, per qualificare il potere in rapporto alle forme concrete che assume,
ai suoi fondamenti e agli ambiti in cui viene esercitato, occorre preliminarmente integrare questa
definizione con una serie di specificazioni.
Intanto c’è da osservare che, nella definizione proposta, il potere non viene inteso come una
generica capacità soggettiva, ma come la capacità di intervenire sulla realtà in modo socialmente
rilevante. Affermando ciò occorre immediatamente precisare che la rilevanza sociale cui si fa
riferimento non dipende tanto dalla validità e utilità delle azioni intraprese o delle decisioni assunte
da chi ha potere. Non dipende neanche dalle qualità personali di chi detiene il potere, benché tali
qualità possono risultare determinanti per l’assunzione ed il mantenimento del potere stesso. Un
soggetto che pure ha grandi doti e intraprende azioni di grande valore può di fatto non possedere
alcun potere. La rilevanza sociale dell’azione di potere consiste piuttosto nel controllo che produce
sull’ambiente esterno, ovvero negli effetti vincolanti e condizionanti che produce sui soggetti che
ne sono direttamente destinatari o che da tale azione sono comunque coinvolti.
Il fatto di qualificare il potere in questi termini presuppone un assunto teorico che è bene
esplicitare e problematizzare: il potere è tale solo se produce effetti di questo genere, o perlomeno
solo se può, all’occorrenza, produrre effetti di questo genere. Tale assunto presenta due implicazioni
5
che riguardano rispettivamente la dimensione attiva del potere e l’intenzionalità degli effetti che
esso produce. Se è vero che il potere è definito come una capacità del soggetto, è anche vero che
tale capacità è riconoscibile e resa effettiva soltanto attraverso l’azione. In altri termini non esiste
potere senza esercizio di esso. Affermare che il potere produce affetti è dunque una conseguenza del
carattere costitutivamente attivo del potere. Ciò però non significa che l’esercizio del potere
produca sempre cambiamenti, e ancor meno che esso produca sempre miglioramenti o progressi.
L’esercizio del potere, infatti, può anche essere finalizzato all’assoluta conservazione di situazioni
esistenti, comportando talvolta anche forme di contrapposizione, se non proprio di repressione, nei
confronti di quei soggetti che invece propongono o tentano di introdurre dei cambiamenti. Il
mantenimento dello status quo, pur presentandosi come una situazione di staticità, è cioè da
considerarsi comunque come un possibile effetto dell’esercizio del potere.
Che generi cambiamenti o li impedisca, il potere, nell’accezione che qui assegniamo al termine,
può considerarsi tale soltanto se associato ad una qualche dimensione intenzionale. Il filosofo
Bertand Russel (1872-1970), estremizzando tale concezione, arriva a definire il potere come
“produzione intenzionale di effetti”. Nei suoi termini, cioè, il potere è pienamente tale solo se
consente, a chi lo detiene e lo esercita, di ottenere gli effetti intenzionalmente prefigurati. Se gli
effetti dell’esercizio del potere non sono intenzionali, o divergono dalle intenzioni di chi lo detiene,
o se addirittura gli si rivolgono contro, allora ci si ritrova in una situazione di incompiutezza del
potere, o potremmo dire di impotenza, in quanto viene a mancare la capacità di controllarne le
conseguenze. Tuttavia, nelle concrete manifestazioni che possiamo desumere dall’esperienza di
qualsiasi collettività, gli effetti dell’esercizio del potere si collocano quasi sempre in una situazione
intermedia tra la completa efficacia (produzione esclusiva di effetti intenzionalmente prefigurati) e
la totale inefficacia (generazione di soli effetti non intenzionali). Inoltre, succede che agli effetti
intenzionali delle azioni e delle decisioni poste in essere da chi detiene il potere si sovrappongano
non di rado effetti non intenzionali che nella fase di determinazione delle stesse azioni e decisioni
non risultano neanche prevedibili.
Sulla determinazione degli effetti dell’esercizio del potere intervengono del resto molteplici
fattori, raramente controllabili nelle loro reciproche interazioni. Il prodursi degli effetti
intenzionalmente prefigurati da chi detiene il potere può di fatto essere subordinato al verificarsi di
altre condizioni o essere favorito da talune circostanze e ostacolato da altre. Considerando poi che
l’esercizio del potere da parte di un soggetto si traduce normalmente in una serie di singole azioni e
decisioni che si distribuiscono in un arco di tempo, la questione relativa alla intenzionalità degli
effetti che produce va ulteriormente problematizzata tenendo conto che ci sono conseguenze
riconducibili ai singoli atti e conseguenze riconducibili ad un insieme di atti, come ci sono
conseguenze che attengono al momento in cui gli atti si producono (conseguenze immediate) e
conseguenze che derivano dalla successione di più atti nel tempo e dal variare delle circostanze
attinenti al contesto (conseguenze di medio e lungo periodo).
C’è inoltre da considerare la questione, per niente marginale dal punto di vista teorico, relativa al
punto di osservazione rispetto al quale avviene la valutazione degli effetti prodotti dall’esercizio del
potere. Si intuisce infatti che tali effetti possono essere interpretati diversamente da chi esercita il
potere, da chi lo subisce o da chi lo analizza dall’esterno, e la valutazione di questi stessi soggetti
può modificarsi nel tempo e in relazione alle circostanze in cui essa viene operata o alle
informazioni di cui a quel momento si dispone.
I diversi livelli di problematizzazione appena introdotti meriterebbero ulteriori approfondimenti,
ma ai fini della nostra trattazione ci preme soprattutto evidenziare il carattere sostanzialmente
situazionale del potere che da queste problematizzazioni si può desumere. Se è vero, come
segnalano anche Peter Morris (1987) e Steven Lukes (1996), che taluni soggetti possono essere
6
dotati di una capacità di estendere e diversificare il campo entro cui riescono ad esercitare con
successo il proprio potere, è anche vero che il potere non si manifesta mai come una capacità del
tutto “trascendente il contesto”. Il potere, anzi, si costituisce e riproduce come tale sempre
all’interno di un determinato contesto sociale, il che significa anche che non è mai assoluto e
universale. Nella storia dell’umanità certamente è possibile rintracciare innumerevoli esempi di
personaggi o istituzioni che sono stati rappresentati e considerati come dotati di un potere assoluto e
universale, non di rado anche di origine divina. Ma ad un’analisi attenta non si può non riconoscere
che si tratta sempre di poteri situati (in un periodo, in un luogo, in un sistema sociale e culturale).
Il carattere situazionale del potere discende d’altra parte dal fatto che esso si manifesta e si
esercita attraverso delle relazioni sociali. Il potere cioè non può considerarsi semplicemente come
una capacità di cui si ha possesso e che all’occorrenza viene utilizzata al pari di un qualsiasi altro
bene o risorsa, idea questa riconoscibile negli scritti di Machiavelli e di Hobbes sulla natura del
potere. Secondo Crespi (2006), questa concezione sostanzialistica è il riflesso delle teorie
teocratiche del potere affermatisi nel Medioevo. Essa viene progressivamente superata da una
concezione del potere di tipo relazionale che nel pensiero politico e sociale occidentale si afferma
con la nascita degli Stati nazionali e con lo sviluppo dell’individualismo liberale.
La dimensione relazionale del potere è determinata in primo luogo dal fatto che le azioni e le
decisioni di chi detiene ed esercita il potere producono effetti vincolanti o condizionanti su altri
soggetti. L’esercizio del potere presuppone infatti un rapporto tra almeno due soggetti, o potremmo
dire due attori sociali: uno che detiene ed esercita il potere, l’altro che, direttamente o
indirettamente, è destinatario dell’azione del potere, ovvero che lo subisce, dovendo eventualmente
subordinare le proprie azioni, le proprie scelte e l’espressione delle proprie idee ai vincoli e ai
condizionamenti posti in essere da chi esercita potere. Il tipo di rapporto che si stabilisce tra questi
due soggetti, tuttavia, non è soltanto conseguente all’esercizio del potere, ma ne è anche in certa
misura fondamento. Con ciò si vuol dire che il potere si costituisce e si riproduce anche grazie alle
dinamiche dei rapporti sociali che si stabiliscono all’interno di un contesto e che fanno sì che un
soggetto assuma una posizione di potere e la mantenga nel tempo, eventualmente anche a
prescindere dalle sue inclinazioni e capacità ad assumere tale posizione.
La dimensione relazionale è infine costituiva del potere per il fatto che esso implica pur sempre
un reciproco riconoscimento tra chi lo detiene e chi lo subisce, ossia tra due soggetti assunti non in
ragione della loro personale identità (cioè come persone), ma in ragione del ruolo che rivestono,
della posizione che occupano, delle cariche che ricoprono in quanto attori sociali. Tale
riconoscimento prescinde dall’approvazione e condivisione che può esprimere chi è sottoposto
all’esercizio di un potere nei confronti di chi questo potere lo detiene e lo esercita. Anche
l’eventuale contrapposizione o conflitto presuppone dopotutto un reciproco riconoscimento –
sebbene circoscritto all’interno di un determinato contesto sociale – in assenza del quale la stessa
azione di potere perde di efficacia e significatività.
Affermare che il potere ha sempre una implicazione relazionale non equivale però a dire che esso
si esercita solo sulle persone attraverso qualche forma di comando. Come ricorda Raimondo
Strassoldo (1987), il potere si esercita anche sulle cose. Più precisamente possiamo affermare che
l’esercizio del potere si traduce ora in azioni e decisioni che vincolano o condizionano direttamente
i comportamenti, gli orientamenti e le possibilità di scelta e di espressione di altri soggetti, ora in
forme indirette di controllo che possono essere esercitate su quelle risorse (materiali e immateriali)
che rivestono un particolare rilievo all’interno di un contesto sociale, ovvero sui processi da cui
dipende l’accesso a tali risorse, la loro distribuzione e allocazione.
7
Le forme del potere
Chiarita la natura del potere, si tratta ora di chiedersi quali forme assume, ossia in che modi esso
può essere esercitato. A tal proposito una prima fondamentale distinzione su cui convergono tanto i
sociologi che gli scienziati politici è quella tra potere consensuale e potere coercitivo.
Un potere può considerarsi consensuale allorché il suo esercizio produce un diffuso consenso tra
coloro i quali sono ad esso sottoposti. Come meglio precisiamo più avanti, tale consenso può
fondarsi su diverse motivazioni, ma ciò che qui ci interessa sottolineare e che esso presuppone sia
una formale legittimazione dei soggetti che il potere lo detengono e lo esercitano, sia una
sostanziale accettazione delle sue implicazioni. Per contro, un potere può considerarsi coercitivo
quando chi lo esercita persegue l’obbedienza e la conformità ricorrendo prevalentemente alla
minaccia o all’uso di sanzioni negative, non potendo contare né sulla sua piena legittimazione, né
sulla prevalente accettazione delle sue azioni e delle sue decisioni da parte dei soggetti ad esso
sottoposti.
La distinzione appena proposta va considerata nel suo carattere tipologico. Ciò significa che
potere consensuale e potere coercitivo sono due tipi di potere che identifichiamo sul piano
concettuale per favorire la descrizione e l’interpretazione di situazioni concrete. Come per ogni altra
tipologia che introdurremo d’ora innanzi, è cioè necessario tener conto che la distinzione tra un tipo
ed un altro nella realtà difficilmente è così netta. Di fatto, il potere consensuale raramente si
configura come un potere che gode di un consenso assoluto e generalizzato, circostanza questa che
a ben vedere svuoterebbe anche di significato l’esistenza e la necessità dell’esercizio di un potere.
Come è anche vero che difficilmente un potere si fonda esclusivamente sul ricorso alla coercizione,
all’intimidazione o alla violenza, circostanza questa che, quando pur si produce, può essere descritta
ricorrendo all’uso di altri concetti, quali quelli di dominio e sopraffazione o, sul piano politico, di
regime.
Nella generalità dei casi, quindi, utilizziamo l’espressione potere consensuale per indicare un
tipo di potere che produce una situazione di accettazione tale da non mettere mai realmente in
discussione né la legittimità del ruolo di chi detiene ed esercita il potere, né la necessità ed il dovere
di conformarsi alle sue prescrizioni. Tale accettazione non equivale però a dire che tutti i soggetti
sottoposti al potere condividano pienamente le azioni, le decisioni, i valori espressi da chi detiene
ed esercita il potere. Non vuol neanche dire che l’operato di chi detiene il potere non sia oggetto di
critiche, di contestazioni o di qualche forma di opposizione.
L’accettazione del potere, valutabile in rapporto sia al singolo individuo che all’insieme degli
individui ad esso sottoposti, è piuttosto espressione della consapevolezza che lo stesso potere
esistente è in quel momento il solo riconoscibile, fosse anche perché non esiste, o non si intravede,
un’effettiva alternativa ad esso. Di potere coercitivo parliamo invece per indicare quelle situazioni
in cui chi detiene il potere ricorre prevalentemente a forme di sanzione per contenere le espressioni
di dissenso non potendo contare né su una sufficiente legittimazione del proprio ruolo, né su una
diffusa approvazione per il proprio operato. Chi è sottoposto al potere in questo caso riconosce
l’esistenza di alternative ad esso ed auspica un suo effettivo superamento o ribaltamento.
La linea di demarcazione tra potere consensuale e potere coercitivo non è comunque sempre così
netta e riconoscibile, sia perché dipende dall’effettiva consapevolezza che del potere hanno coloro i
quali ad esso sono sottoposti, sia perché il ricorso ad azioni di tipo coercitivo può anche soltanto
essere minacciato o temuto, ma non prodursi effettivamente. E’ per questo motivo che nel
descrivere le forme di potere si ricorre a due ulteriori distinzioni, quella tra potere visibile e potere
nascosto, e quella tra potere effettivo e potere potenziale (cfr. Stoppino, 1974).
Un potere può definirsi visibile quando è esercitato in modo esplicito, ossia quando è invocato e
dichiarato da chi lo esercita e al contempo è riconosciuto come tale da chi ad esso è sottoposto. Al
8
contrario, un potere può definirsi nascosto quando chi lo detiene e lo esercita tende a celare la
propria posizione, ovvero quando i sottoposti sono effettivamente inconsapevoli dell’azione di
potere che subiscono. Chi esercita visibilmente il proprio potere, sia esso un soggetto individuale o
collettivo, promuove se stesso adottando una strategia di distinzione anche perché fa affidamento
sul riconoscimento delle proprie qualità (capacità, valori, obiettivi e progetti perseguiti, approcci
adottati), della propria forza e del controllo che ha sulle risorse socialmente significative proprio per
consolidare la propria posizione di potere. Chi invece esercita il potere in modo nascosto ricorre
generalmente ad una qualche forma indiretta e non dichiarata di controllo: «1) sulle conoscenze,
sulle informazioni, sulle credenze e i valori di chi obbedisce; 2) sugli impulsi psicologici inconsci e
sulle emozioni più profonde del soggetto subordinato; 3) sulla situazione ambientale, sul contesto in
cui l’attore che subisce il potere è collocato ed entro cui sceglie strategie e comportamenti.» (Sola,
2005: 72).
Un potere può d’altra parte definirsi effettivo (o anche attuale) se produce conseguenze su coloro
i quali sono sottoposti ad esso, ossia se realmente determina la loro condotta o condiziona i loro
orientamenti (valoriali, ideologici, politici, ecc.). Si parla invece di potere potenziale (o anche
latente) per riferirsi alla possibilità che un soggetto ha – in virtù di proprie attitudini oppure in virtù
della carica che ricopre, del ruolo che riveste o delle risorse di cui dispone – di determinare la
condotta o condizionare gli orientamenti di altri soggetti. Senza entrare nel merito della questione
relativa a chi valuta il potere come effettivo o solo potenziale, o in rapporto a chi il potere si
manifesta in una delle forme distinte, qui c’è da richiamare comunque l’attenzione sulla
ambivalenza dei due caratteri di effettività e potenzialità. Infatti, ogni potere effettivo, ossia ogni
potere il cui esercizio produce effetti riconoscibili, presuppone anche una dimensione potenziale.
Come è anche vero che ogni potere potenziale, nel momento in cui è riconosciuto come tale dai
possibili destinatari della sua azione, produce anch’esso un effetto attuale (fosse anche soltanto il
timore, il rispetto, la deferenza).
Le modalità di esercizio del potere
La capacità (effettiva o potenziale) di determinare la condotta o di condizionare l’orientamento
altrui ottenendo un agire conforme a delle prescrizioni – conformità che possiamo anche esprimere
come obbedienza, osservanza, rispetto, accettazione – implica normalmente una combinazione di
mezzi e risorse che chi detiene il potere deve poter attivare. A tal proposito Etzioni (1968) introduce
una tripartizione sulle modalità di conquista ed esercizio del potere a seconda del prevalere: a) della
forza e della coercizione; b) della induzione; c) della persuasione o della manipolazione.
A proposito della prima modalità qui occorre precisare che le azioni poste in essere per ottenere
obbedienza possono configurarsi come sanzionatorie o repressive. Abbiamo già visto che il ricorso
alle sanzioni contraddistingue il potere coercitivo, perché induce i sottoposti a conformarsi alle
prescrizioni di chi detiene ed esercita il potere in virtù del timore delle sanzioni stesse. L’uso della
forza da parte di chi detiene il potere configura invece una situazione di maggiore soggiogamento se
per forza si intende: «qualsiasi azione materiale diretta contro le persone fisiche o le loro proprietà
che, quando riesce, impedisce loro di agire in un determinato modo o le pone nella situazione
desiderata, annullandone le resistenze e, in casi estremi, la stessa esistenza.» (Lukes, 1996, p. 724).
Il potere basato sul ricorso alle sanzioni e quello fondato sull’uso della forza non sempre
vengono distinti. Ciò è anche comprensibile se si pensa che la minaccia o l’applicazione di una
sanzione, soprattutto quando questa va a ledere diritti fondamentali degli individui o le loro
condizioni di dignità e integrazione all’interno della collettività di cui fanno parte, rappresenta pur
sempre un’azione di forza. La distinzione è tuttavia utile perché consente di chiarire il tipo di
rapporto che si stabilisce tra chi detiene il potere e chi ad esso è sottoposto. Nel caso del potere
9
basato sulle sanzioni, infatti, la volontà del soggetto che esercita il potere prevale sulla volontà di
chi ad esso è sottoposto, ma ciò non significa che quest’ultimo perde completamente la possibilità
di scegliere, anche se si riduce il suo spazio di azione. Chi si conforma alle prescrizioni di un potere
di questo genere in realtà adotta una strategia di adattamento della propria condotta ai vincoli
derivanti dalla minaccia delle sanzioni, adeguandosi così alle “regole del gioco” poste in essere da
chi detiene il potere e ritagliandosi dove possibile degli spazi di resistenza.
All’interno di queste regole resta aperta la possibilità di scegliere tra opzioni diverse, come resta
anche aperto il confronto (ed i possibili conflitti) tra chi detiene il potere e chi lo subisce. Nel caso
di un potere fondato sull’uso della forza o della violenza, invece, gli spazi di espressione e di scelta
di coloro i quali sono sottoposti al potere vengono ridotti, talvolta completamente annullati. Il
timore per le conseguenze derivanti dalla non conformità della propria condotta alle prescrizioni di
chi detiene il potere, ovvero il terrore delle violenze, dei soprusi o delle discriminazioni di cui si
può essere vittima, tende inoltre a favorire atteggiamenti di assuefazione e rinuncia tra coloro i quali
a questo genere di potere sono sottoposti, atteggiamenti che possono anche tradursi in apparenti
espressioni di consenso utilizzate ideologicamente dagli stessi detentori del potere per rafforzare la
propria posizione.
Come già intuito da Machiavelli, il ricorso alla coercizione e l’uso della forza rappresentano però
due modalità dispendiose e altamente conflittuali (e dunque anche instabili) di esercizio del potere
riscontrabili per lo più in situazioni di forte accentramento del potere stesso. Se è vero che capi e
condottieri, sovrani e principi, despoti e dittatori insieme ai loro apparati (politici, militari,
polizieschi, ideologici, amministrativi, ecc.) abbiano in ogni tempo e luogo fatto ricorso a tali mezzi
per garantirsi situazioni di controllo indiscusso, è anche vero che l’efficacia e la stabilità del potere
non dipendono necessariamente da essi. Anzi, quanto più chi detiene una posizione di potere è
interessato a consolidarla, tanto più è obbligato a sostituire progressivamente le modalità coercitive
e repressive eventualmente adottate per conquistare tale posizione, con modalità tese a ridurre i
livelli di conflittualità e a vincere le resistenze (anche quelle non espresse) dei sottomessi. Tra le
modalità alternative rientrano quelle indicate da Etzioni, tra cui per l’appunto l’induzione, la
persuasione e la manipolazione.
Con il termine induzione ci si riferisce genericamente ad ogni forma di remunerazione, di
promessa di compenso (allettamento) o di corruzione messa in atto da chi detiene il potere (o aspira
a conquistarlo) per garantirsi il consenso, il sostegno o la complicità dei sottoposti o di una parte di
essi.
Che all’induzione si ricorra per conquistare una nuova posizione di potere (magari destituendo
altri soggetti) o per rafforzare e difendere una posizione già esistente, tale modalità presuppone
sempre quattro differenti condizioni: a) che chi ha il potere (o aspira ad averlo) non riesca
diversamente ad imporre la propria volontà o ad ottenere il necessario riconoscimento in virtù di
qualità personali o in virtù di una legittimazione indiscussa che gli deriva dal ruolo che riveste o
dalla carica che ricopre; b) che il consenso dei sottoposti, ovvero il loro sostegno e la loro
complicità, possano essere contrattati; c) che le azioni intraprese, le decisioni assunte e gli
orientamenti di chi detiene il potere (o aspira ad esso) non risultino palesemente in contrasto con gli
interessi, le aspettative e i valori dei sottoposti su cui l’azione di induzione viene esercitata; d) che
chi detiene il potere (o aspira ad esso) disponga di risorse (materiali o immateriali) socialmente
significative o abbia il controllo sull’accesso ad esse e sulla loro assegnazione/distribuzione.
Se chi ricorre all’induzione cerca di conquistare consenso e sostegno offrendo in cambio un
qualche vantaggio, chi ricorre alla persuasione o alla manipolazione persegue lo stesso obiettivo
attraverso un’azione di convincimento o influenza. Più precisamente, chi fonda il proprio potere
sulla persuasione tende a fornire argomentazioni a sostegno dell’opportunità delle proprie scelte e
10
della validità e superiorità dei propri orientamenti ovvero a giustificare il proprio operato alla luce
degli obiettivi perseguiti e dei risultati ottenuti.
Per contro, chi fonda il proprio potere sulla manipolazione tende ad esercitare in modo occulto
una influenza sulle idee, le valutazioni, le preferenze altrui; ciò al fine di modificare l’orientamento
altrui, strappare un consenso (seppur solo formale e artificiale), ovvero per evitare o contenere il
dissenso e l’opposizione nei suoi confronti. Mentre cioè chi adotta la strategia della persuasione è
interessato ad ottenere una sostanziale e consapevole approvazione da parte di coloro i quali sono
destinatari della propria azione di potere, chi adotta la strategia della manipolazione preferisce
piuttosto disorientarli.
Tale disorientamento è finalizzato a rendere meno valutabili, nelle loro reali implicazioni, le
azioni e le scelte perseguite. Risultato questo che si può ottenere operando un controllo (e se
necessario una censura) sulle informazioni e le conoscenze accessibili ai propri sottoposti, oppure
veicolando informazioni e conoscenze tese a costruire rappresentazioni distorte o ideologiche della
realtà.
Talvolta questa manipolazione viene anche operata facendo leva sui timori, i pregiudizi, le
credenze, i bisogni inconsci dei soggetti subordinati, creando artificiosamente confini (culturali,
politici, di ceto, di razza, religiosi, territoriali, ecc.) o allarmi sociali per pericoli e nemici da cui
difendersi. Strategie simili sono riconoscibili di fatto nell’apparato ideologico di molti regimi, come
anche in quei sistemi di potere fondati su qualche forma di fondamentalismo o di localismo.
Autorità e legittimazione
Tanto le costrizioni operate attraverso il ricorso alle sanzioni o alla forza, quanto le azioni di
convincimento perseguite con l’induzione, la persuasione o la manipolazione, implicano un
investimento di energie e risorse da parte di chi aspira a conquistare potere o a consolidarlo. Non
sempre le energie e le risorse investite a tal fine producono gli effetti attesi.
Il consenso, l’obbedienza, la conformità, il rispetto, l’accettazione rappresentano cioè risultati
per niente scontati, spesso incerti e mai definitivi, soprattutto se perseguiti attraverso azioni di
pressione. Una maggiore stabilità ed un minore dispendio di energie e risorse si ottiene solo nel
caso in cui chi detiene ed esercita il potere (o aspira ad esso) gode di un particolare tipo di
riconoscimento da parte dei sottoposti (attuali o potenziali). Definiamo legittimazione questo tipo di
riconoscimento e parliamo di autorità per qualificare ogni potere che gode di una effettiva
legittimazione.
La legittimazione è da considerarsi come il prodotto di un processo di giustificazione del potere
che porta coloro i quali sono ad esso sottoposti a darsi delle stabili ragioni della loro accettazione,
ovvero a riconoscere ai soggetti che detengono il potere il diritto di esercitarlo, e ad essi stessi
l’obbligo di accettarlo e conformarsi alle sue prescrizioni.
Detto in altri termini, attraverso il processo di giustificazione viene sancita la legittimità del
soggetto (individuale o collettivo) che detiene il potere e dell’eventuale apparato che lo supporta,
ovvero la legittimità dei meccanismi da cui dipende l’attribuzione di un ruolo o di una carica che
autorizza all’esercizio di quel potere.
Tale processo è normalmente di natura sociale, nel senso che le ragioni che giustificano il
riconoscimento di legittimità di un potere e che motivano i singoli individui a conformarsi alle sue
prescrizioni, sono elaborate dalla collettività (il gruppo, la comunità, la nazione, ecc.) cui i singoli
individui appartengono e all’interno della quale il potere può essere esercitato. Ciascun individuo
può anche darsi delle proprie personali ragioni per giustificare l’esercizio del potere da parte di un
determinato soggetto, ma sono le giustificazioni con valenza collettiva, ossia quelle riconosciute
11
come socialmente significative all’interno di una collettività, a fondare realmente la legittimità di un
potere.
Proprio perché il potere fondato sull’autorità presuppone un processo di legittimazione collettiva,
l’accettazione da parte dei sottoposti tende a configurarsi come una disposizione all’obbedienza e
alla conformità che non richiede altre giustificazioni di merito. Ciò significa che alle singole
prescrizioni di chi detiene il potere, ovvero ai suoi comandi, non ci si conforma prevalentemente né
in ragione di una valutazione positiva dei loro contenuti, né in ragione di un qualche vantaggio che
se ne ricava, né ancora per timore delle conseguenze negative che potrebbero derivare dal
disattenderle, ma piuttosto in ragione di un’attribuzione di legittimità che avviene a monte. Ed è
proprio interrogandosi sulla natura di questo genere di disposizione all’obbedienza che Max Weber
(1922) introduce una fondamentale distinzione tra tre tipi di potere legittimo: tradizionale,
carismatico e legale (o razionale).
La legittimità di un potere è di tipo tradizionale allorché poggia sulla credenza nel carattere
sacro delle tradizioni e sul diritto esclusivo di chi esercita il potere in virtù di queste tradizioni. È la
tradizione che stabilisce chi è legittimamente designato a ricoprire un ruolo di potere e tale
designazione trova giustificazione all’interno di una determinata comunità (civile, politica,
territoriale, religiosa) per il fatto che così è sempre stato.
Non si tratta dunque né di un ruolo attribuito e assunto in virtù di particolari capacità personali,
né di una carica assegnata sulla base di un qualche ordinamento vigente e di un procedimento
elettivo. Quando pure si fa riferimento ad una elezione, questa è tutt’al più rappresentata come di
origine divina, il che rafforza ancor di più la legittimazione sociale di chi è designato ad esercitare il
potere e l’indipendenza della sua autorità dal volere e dall’approvazione di coloro i quali sono ad
esso sottomessi.
Un potere legittimo è invece di tipo carismatico quando si fonda sulla credenza nel carattere
straordinario, nella forza o nel valore esemplare di chi lo detiene. Un potere di questo genere
secondo Weber discende dal riconoscimento di un carisma, ossia di una qualità personale fuori dal
comune, quale quella attribuita all’eroe, al profeta, al condottiero, al rivoluzionario, al duce. Il
carisma viene talvolta considerato come una qualità innata, altre volte come una qualità sovraumana
di origine divina.
Nell’uno come nell’altro caso esso è sancito da una qualche prova (un atto eroico, il successo di
un’impresa difficile, un miracolo, una profezia, una missione, una rivoluzione) che, soprattutto nei
momenti di crisi o di profonda trasformazione sociale, suscita mobilitazione, entusiasmo, adesione
popolare incondizionata. Su tale prova, e sul riconoscimento delle qualità necessariamente
straordinarie richieste per essa, fondano la propria fiducia, fede, dedizione e obbedienza i seguaci
del capo carismatico.
Infine, un potere può definirsi legale (o razionale) quando poggia sulla credenza nella legalità
del sistema di norme statuite (e vigenti) e nella legittimità delle cariche attribuite e dei relativi poteri
esercitati in virtù di questo sistema di norme. Questo tipo di potere si contraddistingue per il
carattere impersonale delle regole su cui esso si fonda. Ciò significa che: a) chi detiene il potere, nel
mentre dispone e comanda, da parte sua si conforma egli stesso agli ordinamenti sulla base dei quali
determina le sue prescrizioni; b) chi si conforma alle prescrizioni lo fa non perché obbedisce alla
persona che detiene il potere, ma perché si subordina – in quanto membro di una comunità, di uno
stato, di un’associazione – alla legittimità di una carica che è emanazione di un ordinamento
legalmente costituito.
Questa subordinazione non è dunque significativa di una sottomissione di natura personale e
comunque è sempre circoscritta alle sole prescrizioni derivanti dal campo di competenza attribuito a
chi detiene quella carica. Dal punto di vista giuridico, il rapporto tra chi detiene il potere e chi è
12
sottoposto ad esso è perciò un rapporto tra eguali, ossia tra soggetti cui sono riconosciuti gli stessi
diritti fondamentali.
Questi tre tipi di legittimazione si contraddistinguono anche in rapporto agli apparati di potere ad
essi associati. Nel caso della legittimazione di tipo tradizionale, l’apparato amministrativo è
costituito da individui reclutati o in ragione dei legami diretti con chi detiene il potere (il “signore”)
oppure in ragione di vincoli di natura fiduciaria che si stabiliscono con esso. I componenti
dell’apparato amministrativo si rapportano al signore come servitori personali, ovvero come
favoriti, mentre i dominati si considerano suoi sudditi.
Entrambi si attengono al volere del loro signore rappresentando il rapporto con costui come un
rapporto di sudditanza personale. Il signore, da parte sua, nel mentre fa appello alla tradizione
conformandosi ai vincoli che questa pone a lui stesso, al contempo si riserva il diritto di decidere sia
come tale tradizione vada interpretata e garantita, sia quali azioni intraprendere nelle situazioni
concrete.
L’apparato di cui si avvale il potere carismatico è invece costituito da seguaci, discepoli,
individui scelti personalmente per la loro devozione o perché riconosciuti come capaci a loro volta
di testimoniare il carisma del capo e di supportarne la sua missione, il suo progetto, con la
necessaria determinazione e fedeltà. La relazione di potere, pertanto, è in questo caso ancor più
marcatamente personale, non dovendosi neanche inscrivere all’interno di una consuetudine di
norme e di usanze ereditate dal passato, come è invece per le relazioni di potere fondate su una
legittimazione di tipo tradizionale.
Ciò oltretutto spiega perché la legittimazione di cui gode il capo carismatico difficilmente può
trasferirsi ad altri. E Weber a tal proposito fa anche osservare come il potere carismatico riesce a
riprodursi soltanto se i successori che lo ereditano riescono a legittimare la loro autorità in ragione
di un legame diretto con il capo carismatico. Può trattarsi di un legame di consanguineità, oppure di
un mandato assunto in quanto discepolo prediletto, persona di fiducia o erede morale del capo
carismatico.
Alternativamente, la legittimazione può anche riprodursi attraverso la trasformazione del carisma
in pratica quotidiana, ossia attraverso un processo di spersonalizzazione e istituzionalizzazione del
potere e del suo apparato (una chiesa, un partito, una organizzazione, ecc.).
Al potere di tipo legale assunto nella sua forma idealtipica più pura Weber riconduce infine
l’apparato amministrativo burocratico. Questo apparato è costituito da funzionari che sono
selezionati sulla base delle competenze e dei titoli di cui sono in possesso ed in relazione alla
qualificazione richiesta per le mansioni che devono assolvere attraverso procedure (esami) a
carattere razionale e impersonale.
Essi si conformano alle prescrizioni di chi detiene il potere non in ragione di legami personali,
ma in ragione della gerarchia di responsabilità e competenze legalmente istituite e formalizzate
negli ordinamenti vigenti. Essi pertanto adempiono principalmente ai doveri d’ufficio limitando la
propria azione amministrativa alle competenze assegnate al loro ufficio o agli organismi di cui sono
chiamati a far parte.
Nel ruolo che ricoprono, i funzionari amministrano risorse che non gli appartengono e di cui non
dispongono se non in funzione dei compiti loro attribuiti e sulla base di regole esplicite. Per le
mansioni che svolgono essi ricevono generalmente (ed unicamente) un prestabilito stipendio in
denaro, e le loro prestazioni sono dunque da considerarsi soltanto di tipo professionale non
rispondendo ad altri obblighi né di natura personale, né di natura ideologica, se non quelli più
generalmente attribuiti dagli ordinamenti vigenti a qualsiasi altro soggetto appartenente alla stessa
collettività.
13
Riferimenti bibliografici
Arendt H., On Violence, New York, Harcourt Brace & World, 1970 (trad .it. Sulla violenza,
Milano, Mondadori, 1971).
Berger P. L. e Luckmann T., The social construction of reality, London, Doubleday, 1966 (trad.
it. La realtà come costruzione sociale, Bologna, il Mulino, 1969).
Bobbio N., Il problema del potere, Torino, CLUE, 1966.
Boudon (a cura di), Traité de sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1992 (trad. it.
Trattato di sociologia, Bologna, il Mulino, 1992.
Chazel F., “Potere”, in Boudon R. (a cura di) Trattato di sociologia, Bologna, il Mulino, 1992,
pp. 165-196).
Crespi F., “Politica e potere”, in Costabile A., Fantozzi P. e Turi P. (a cura di), Manuale di
sociologia politica, Roma, Carocci editore, 2006, pp. 49-70.
Etzioni A., The active society, New York, The Free Press,1968.
Lasswell H.D. e Kaplan A., Power and society, New Haven, Yale University, 1950, (trad. it.
Potere e società, Milano, Etas Kompass, 1969).
Lukes S., voce “Potere”, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, vol. VI, pp. 722-744.
Morris P., Power. A philosophical analysis, Manchester, 1987.
Rush M., Politics and Society: An Introduction to Political Sociology, Prentice Hall Harvester
Wheatsheaf, 1992 (trad. it. Politica e società, Bologna, il Mulino, 1994).
Russel B., Power: A New Social Analysis, London, Allen & Unwin, 1968 (trad. it. Il potere: una
nuova analisi sociale, Roma-Milano, Bocca, 1954).
Sola G., I paradigmi della scienza politica, Bologna, il Mulino, 2005.
Stoppino M., Le forme del potere, Napoli, Guida, 1974.
Strassoldo R., voce “Potere”, in Nuovo dizionario di Sociologia, Torino, Edizioni San Paolo,
1987, pp. 1536-1551.
Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen, Mohr, 1922 (trad. it. Economia e società,
Milano, Comunità, 1968).
14