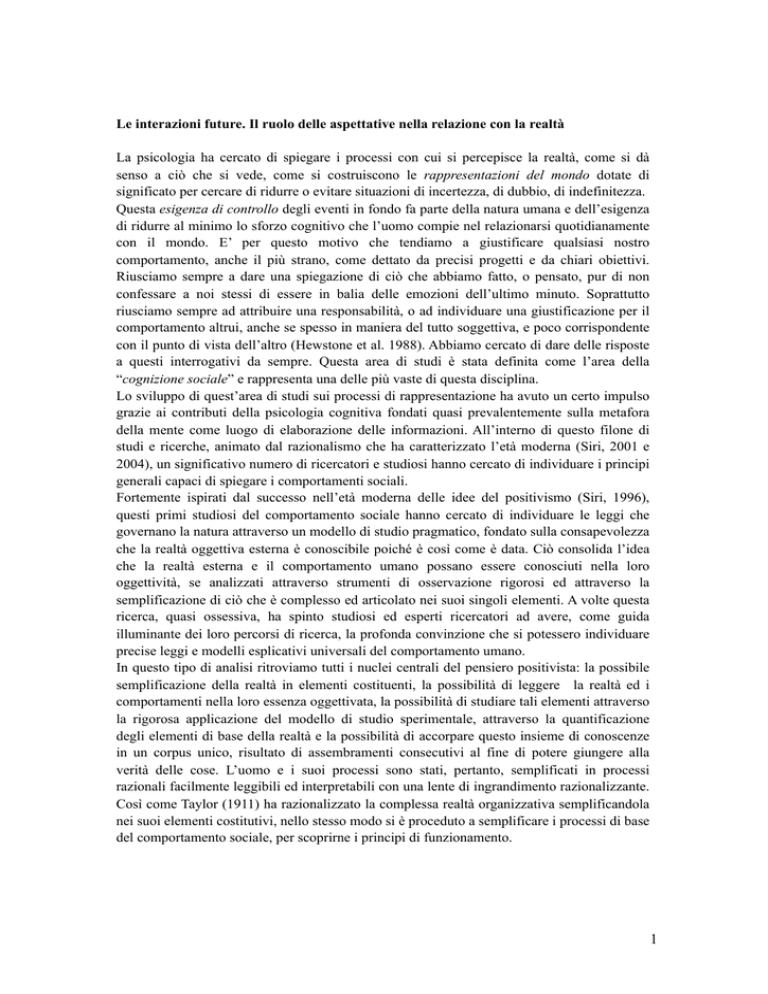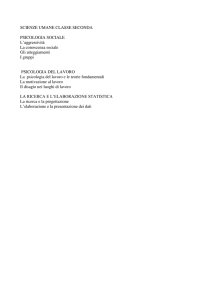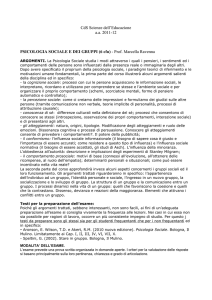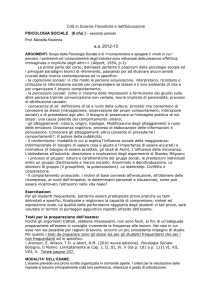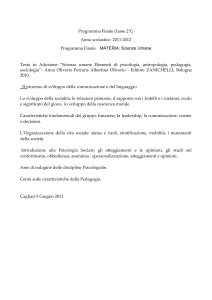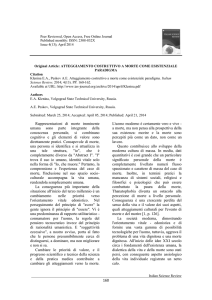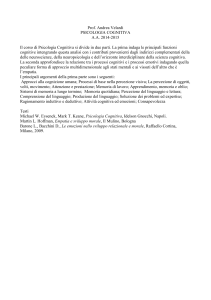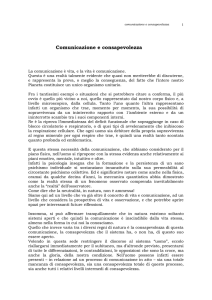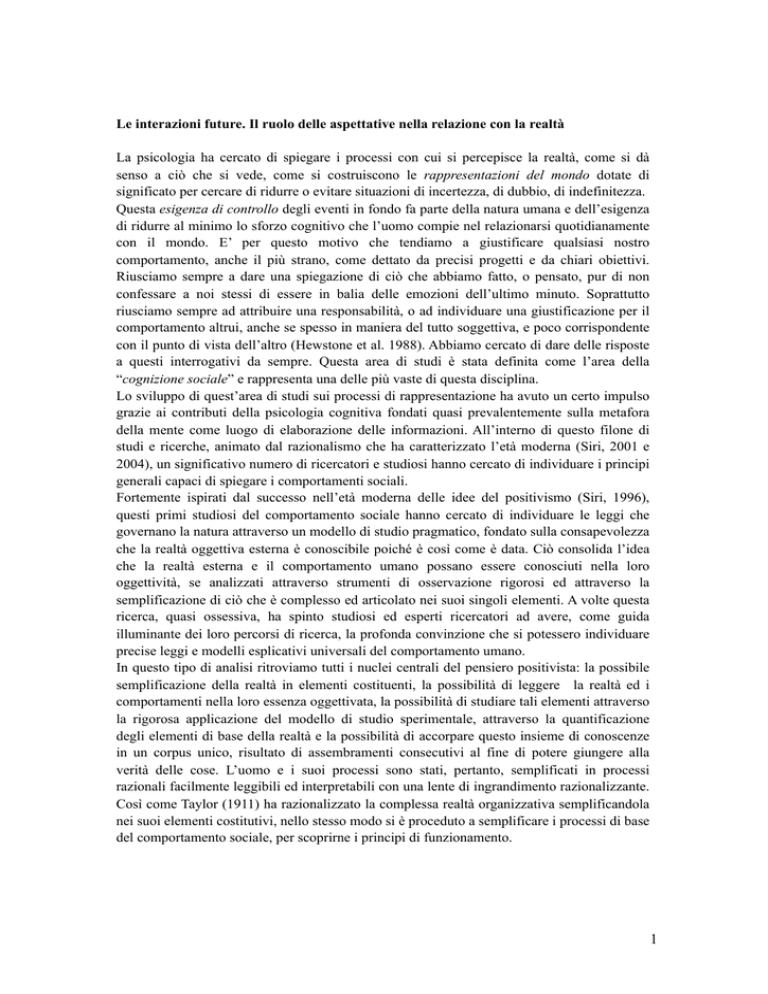
Le interazioni future. Il ruolo delle aspettative nella relazione con la realtà
La psicologia ha cercato di spiegare i processi con cui si percepisce la realtà, come si dà
senso a ciò che si vede, come si costruiscono le rappresentazioni del mondo dotate di
significato per cercare di ridurre o evitare situazioni di incertezza, di dubbio, di indefinitezza.
Questa esigenza di controllo degli eventi in fondo fa parte della natura umana e dell’esigenza
di ridurre al minimo lo sforzo cognitivo che l’uomo compie nel relazionarsi quotidianamente
con il mondo. E’ per questo motivo che tendiamo a giustificare qualsiasi nostro
comportamento, anche il più strano, come dettato da precisi progetti e da chiari obiettivi.
Riusciamo sempre a dare una spiegazione di ciò che abbiamo fatto, o pensato, pur di non
confessare a noi stessi di essere in balia delle emozioni dell’ultimo minuto. Soprattutto
riusciamo sempre ad attribuire una responsabilità, o ad individuare una giustificazione per il
comportamento altrui, anche se spesso in maniera del tutto soggettiva, e poco corrispondente
con il punto di vista dell’altro (Hewstone et al. 1988). Abbiamo cercato di dare delle risposte
a questi interrogativi da sempre. Questa area di studi è stata definita come l’area della
“cognizione sociale” e rappresenta una delle più vaste di questa disciplina.
Lo sviluppo di quest’area di studi sui processi di rappresentazione ha avuto un certo impulso
grazie ai contributi della psicologia cognitiva fondati quasi prevalentemente sulla metafora
della mente come luogo di elaborazione delle informazioni. All’interno di questo filone di
studi e ricerche, animato dal razionalismo che ha caratterizzato l’età moderna (Siri, 2001 e
2004), un significativo numero di ricercatori e studiosi hanno cercato di individuare i principi
generali capaci di spiegare i comportamenti sociali.
Fortemente ispirati dal successo nell’età moderna delle idee del positivismo (Siri, 1996),
questi primi studiosi del comportamento sociale hanno cercato di individuare le leggi che
governano la natura attraverso un modello di studio pragmatico, fondato sulla consapevolezza
che la realtà oggettiva esterna è conoscibile poiché è così come è data. Ciò consolida l’idea
che la realtà esterna e il comportamento umano possano essere conosciuti nella loro
oggettività, se analizzati attraverso strumenti di osservazione rigorosi ed attraverso la
semplificazione di ciò che è complesso ed articolato nei suoi singoli elementi. A volte questa
ricerca, quasi ossessiva, ha spinto studiosi ed esperti ricercatori ad avere, come guida
illuminante dei loro percorsi di ricerca, la profonda convinzione che si potessero individuare
precise leggi e modelli esplicativi universali del comportamento umano.
In questo tipo di analisi ritroviamo tutti i nuclei centrali del pensiero positivista: la possibile
semplificazione della realtà in elementi costituenti, la possibilità di leggere la realtà ed i
comportamenti nella loro essenza oggettivata, la possibilità di studiare tali elementi attraverso
la rigorosa applicazione del modello di studio sperimentale, attraverso la quantificazione
degli elementi di base della realtà e la possibilità di accorpare questo insieme di conoscenze
in un corpus unico, risultato di assembramenti consecutivi al fine di potere giungere alla
verità delle cose. L’uomo e i suoi processi sono stati, pertanto, semplificati in processi
razionali facilmente leggibili ed interpretabili con una lente di ingrandimento razionalizzante.
Così come Taylor (1911) ha razionalizzato la complessa realtà organizzativa semplificandola
nei suoi elementi costitutivi, nello stesso modo si è proceduto a semplificare i processi di base
del comportamento sociale, per scoprirne i principi di funzionamento.
1
Questa ipersemplificazione rischia di promuovere una rappresentazione del comportamento
umano priva di quella dinamicità e di quei processi di influenzamento reciproco che stanno
alla base della complessità del comportamento umano .
Purtroppo l’immagine dell’uomo razionale è diventata una forma di cliché tanto utilizzata da
stimolare numerose ricerche di laboratorio che in alcuni casi hanno rischiato di confermare
tale modello razionalistico più per la specificità del contesto sperimentale che per la capacità
di coglierne la sua specificità.
Questa forma mentis che spesso ritroviamo in molte ricerche sulle interazioni, caratterizza
molti testi di marketing che prendono in prestito diversi concetti della psicologia per
aspiegare i comportamenti sociali, attraverso un minuzioso processo di analisi e di
semplificazione dei processi. Esistono tuttavia evidenze sul fatto che l’individuo non agisce
solo in modo razionale, anche se dice spesso, anche a se stesso, di agire sempre secondo una
logica razionale, o secondo processi cognitivi “freddi”, caratterizzati dalla logica dei costibenifici (Mannetti, 2002). Il modo stesso di reagire alle interazioni sociali testimoniano un
desiderio di gioco, di humor, di esperienza e di esplorazione non esclusivamente correlati con
la dimensione della razionalità, ma carichi di effetti di desiderio e di significazione assai
lontani dalla logica razionalistica. Sempre più spesso la complessità, la circolarità, la
pluriappartenenza, la multiculturalità irrompono con forza destrutturante nel nostro
quotidiano, minando le certezze acquisite. La percezione degli altri, per esempio, anche nella
sua articolata e meravigliosa funzione, non sembra rispondere alle medesime leggi universali
individuate dagli studi di laboratorio di psicologia cognitiva.
Il senso e il significato che diamo alle cose guidano, a volte inaspettatamente, il nostro modo
di percepire la realtà e gli altri. Una realtà che non sembra più data una volta per tutte, bensì
costruita di volta in volta dai processi di socializzazione, di simbolizzazione e dai significati
che noi stessi gli attribuiamo.
Un significato profondamente influenzato dal contesto culturale di riferimento. Così una
frase, un’azione, un comportamento assume un significato diverso in funzione dei codici
culturali che utilizziamo per interpretarli.
Lo sanno bene coloro che hanno il compito di valutare e giudicare le modalità educative dei
bambini di altre etnie. In alcuni contesti, infatti, l’uso di un comportamento “violento” nei
confronti del proprio figlio, anche se è in ogni caso deprecabile, non è segno di inadeguata
genitorialità. Questi comportamenti possono rientrare nelle più condivise modalità educative
di una particolare comunità. Sempre più spesso giudici, medici, insegnanti e operatori del
territorio devono fare i conti con queste profonde differenziazioni, cercando di leggere
correttamente ciò che una società sempre più multiculturale, o meglio multietnica, offre.
Queste considerazioni richiedono, tuttavia, un approfondimento di tipo sociologico, etico e
giuridico che trascende il nostro obiettivo.
Di certo, ritornando ai temi della psicologia delle interazioni, in questo processo il contesto
sociale e culturale ha un ruolo determinante nella costruzione di senso. Già Lewin nel 1935
studiando il rapporto tra processi psicologici e contesto sociale scriveva che “gli esperimenti
sulla memoria e sulla pressione esercitata dal gruppo sull’individuo dimostrano che qual che
esiste come realtà per una persona è determinato in buona misura da ciò che socialmente
viene accettato come tale. Questo vale anche per la fisica: per un abitante di un’isola
dell’Oceano Pacifico, il mondo può essere piatto; per l’europeo esso è rotondo”.
2
La realtà quindi non è assoluta, ma la sua percezione può variare secondo il gruppo cui ogni
individuo appartiene. Secondo Lewin (1935) le forse ambientali (appunto la realtà) hanno un
ruolo di grande rilievo nello sviluppo dell’individuo e nella determinazione del suo
comportamento, ma ciò che è importante è la profonda relazione “causale circolare fra le une
e le altre”.
L’ambiente esperito dall’individuo è visto potenzialmente diverso da persona a persona, come
per la stessa persona in momenti diversi. Viene così riconosciuto il ruolo attivo dell’individuo
nei processi di conoscenza e l’influenza del processo di significazione individuale nella
spiegazione della realtà , a sua volta culturalmente caratterizzato.
Bruner nel 1957 sosteneva che l’esperienza percettiva si verifica attraverso un processo
mediante il quale la cosa o la persona percepita “è collocata in un posto e acquista il suo
significato da una classe di percetti con i quali è raggruppata” attraverso un processo
pressoché inconsapevole (Mannetti, 2002). Ecco quindi che gli individui diventano artefici
del loro ambiente sociale e del contesto in cui vivono e percepiscono. Come scriveva Bruner
(1992) “non è l’eredità biologica dell’uomo a guidare e plasmare la sua azione e la sua
esperienza, ad avere la funzione di causa universale; piuttosto, questa eredità impone dei
limiti all’azione, limiti i cui effetti non sono immutabili. Le culture, invece, mettono in moto
dei <<meccanismi-pròtesi>> che ci rendono possibile trascendere i <<puri e semplici>>
limiti biologici; per esempio i limiti di capacità della memoria o quelli dello spettro visivo e
uditivo. Si presuppone che sia la cultura e non la biologia a plasmare la vita e la mente
dell’uomo, a dare significato all’azione inserendo gli stati intenzionali profondi in un sistema
interpretativo.
La cultura può farlo imponendo i modelli che fanno parte dei suoi sistemi simbolici: il
linguaggio e le modalità del discorso, la forma della spiegazione logica e di quella narrativa e
i modelli, infine, della vita sociale con i relativi aspetti di reciproca interdipendenza”.
Questa tesi ci spinge a considerare il comportamento del consumatore non solo determinato
dai suoi bisogni e dalla sua dimensione biologica, ma a comprendere il suo comportamento e
i processi funzionali che lo influenzano (percezione, memoria, apprendimento e decisione)
strettamente influenzati dal contesto sociale e culturale in cui si muove. Questo è
maggiormente più evidente se pensiamo al modello di cultura del consumo a verso cui
andiamo. Una volta svincolato dalla dimensione del bisogno e dell’esclusiva esigenza
biologica i comportamenti sociali, così come quelli di consumo sono atti che esprimono un
modello di cultura condiviso.
Solo negli ultimi anni si è assistito nella psicologia ad una maggiore attenzione alla
dimensione narrativa e simbolica per la comprensione dei comportamenti sociali (Mazzara,
2008). Ecco, quindi, che lo stesso oggetto o comportamento assume un significato diverso nel
tempo e nello spazio tanto da rendere ancora più insicura e difficile l’opera di chi intende
predire o spiegare i comportamenti umani e sociali. D’altra parte è anche comprensibile come
mai ci sia un netto rifiuto di tale aleatorietà. La soggettività dei significati rende, infatti, arduo
il lavoro di chi deve interpretare e soprattutto predire.
In realtà sembra che tutta la filosofia intrinseca a molte teorie scientifiche moderne (tra cui
anche il marketing e alcune psicologie) stia cambiando. Nonostante le critiche mosse al modo
di studiare l’umo ancora troppo focalizzate sull’immagine dell’uomo “econmico” (Fabris,
2009; Siri, 2004), di fatto si sta diffondendo sempre di più una concezione umanistica,
3
culturale e sistemica per studiare l’interazione sociale. Una concezione capace di tener conto
sempre più spesso del contesto culturale e sociale e del processo di influenzamento reciproco
uomo-ambiente.
In questo caso l’individuo deve essere considerato come un sistema complesso in stretta
interrelazione con un sistema ancora più ampio del sociale. Entrambi analizzabili attraverso
una modalità di studio di tipo olistico. Così studiare la l’interazione sociale senza fare
riferimento ai filtri individuali che la società contribuisce a diffondere, o senza prendere in
considerazione l’influenza che l’attribuzione di significato ha nei processi di percezione della
realtà, risulta insufficiente per comprendere le interazioni.
La realtà viene percepita come vorremmo che fosse, non come oggettivamente si presenta. Di
là dalla rappresentazione razionalizzante, quando ci confrontiamo con la realtà utilizziamo
sempre dei filtri cognitivi ed affettivi. Quante volte capita letteralmente “di non vedere ciò
che ci può fare soffrire”, oppure quante volte ci ritroviamo a percepire solo quei messaggi e
quei significati coerenti con il nostro punto di vista? Quante volte cercando un oggetto
smarrito usiamo delle vere e proprie mappe, una specie di guida dei posti da osservare perché
ritenuti (chissà perché) luoghi in cui “probabilmente” ritroveremo l’oggetto perduto? E’ come
se fossimo guidati dall’abitudine e dall’esperienza passata, senza renderci conto che gli altri
luoghi possono essere altrettanto probabili posti in cui il nostro oggetto è caduto o è stato
accidentalmente spostato.
A volte utilizziamo lo stesso processo di razionalizzazione per imporre una realtà che di
razionale non ha nulla. Basta soffermarsi solo per un attimo alle pene d’amore per avere un
esempio chiaro e lampante per tutti. Pur di non soffrire siamo capaci di non vedere o di
minimizzare gli errori, le mancanze e le malefatte dell’amato partner (tanto da essere
increduli persino delle numerose testimonianze o consigli dei più cari amici), così come ci
ritroviamo a giustificare i torti subiti da un caro amico, ad ampliare enormemente gli aspetti
positivi di una scelta conflittuale effettuata, a prendere in considerazione solo gli aspetti
vantaggiosi di un acquisto rinnegando o ignorando completamente ciò che contraddice la
nostra idilliaca visione. Ecco quindi che ogni atto di acquisto, ogni azione, ogni messaggio
pubblicitario, va inserito e compreso all’interno di precisi percorsi di senso che ogni
individuo costruisce, analizzati alla luce dei più inconsapevoli filtri cognitivi ed affettivi che
ci permettono di “leggere la realtà e gli eventi”.
L’individuo non è solo un insieme di sensazioni, né un calcolatore che costruisce regole
decisionali sulla base del rapporto costi-benefici, né è semplicemente animato da richiami
accattivanti. Egli è tutto questo, ma all’interno di uno sforzo continuo di ricerca di senso e di
significato, di un progetto esistenziale che investe ogni atto (Siri, 1995).
Il gioco razionale nella spiegazione della realtà: la dissonanza cognitiva
Leon Festinger (1957), allievo di Kurt Lewin, è stato il primo ad occuparsi di alcuni processi
di razionalizzazione e giustificazione dei comportamenti descrivendo gli effetti della
dissonanza cognitiva. Questa si basa sulla premessa che gli atteggiamenti di un individuo
sono tendenzialmente consonanti e che le sue azioni sono di solito coerenti con gli
atteggiamenti. Il principio da cui parte Festinger è che l’individuo è prevalentemente
caratterizzato da coerenza e razionalità. Nel prendere qualsiasi decisione, come ad esempio
4
acquistare un prodotto, l’individuo affronta una situazione di conflitto nella quale deve
soppesare le valutazioni positive e negative nei confronti delle diverse alternative. Subito
dopo la decisione le informazioni sulle caratteristiche positive della possibile scelta che di
fatto è stata scartata e quelle sulle caratteristiche negative della scelta effettuata possono
produrre una situazione di dissonanza il cui grado deriva dall’importanza stessa della
decisione, dal grado di attrazione della scelta rifiutata, dal numero di elementi negativi che
caratterizzano la scelta effettuata. Secondo Festinger la dissonanza è psicologicamente
scomoda o comunque è in grado di creare un certo disagio a causa della tensione che deriva
da una scelta che può essere in contrasto con una valutazione. La dissonanza, intesa come
incoerenza tra processi cognitivi, o come discordanza tra atteggiamento dichiarato e
comportamento agito, provoca una condizione di difficoltà che spinge l’individuo ad adottare
tutte le possibili soluzioni e i filtri per recuperare uno stato di coerenza, di equilibrio e
conseguentemente di “benessere” (Williams, 1981). Lo stato di disagio provocato dalla
dissonanza è, probabilmente, determinato dal fatto che siamo, sempre, stati abituati a
percepirci coerenti con le nostre opinioni, equilibrati nei nostri comportamenti.
A fronte di tale disagio, l’individuo cerca di trovare specifici rimedi: la rivalutazione delle
proprie opinioni; la revoca delle decisioni (il che tuttavia non sempre è possibile e spesso
assai costosa); il cambiamento dei propri atteggiamenti o delle convinzioni (per esempio un
consumatore può avere un atteggiamento sfavorevole nei confronti di una marca, ma l’offerta
di coupon può indurlo a provare la marca in questione); la ricerca di nuove informazioni che
dimostrino che il comportamento agito, in fondo, non è così incoerente o sbagliato come
sembra. Ciò avviene attraverso quelli che vengono definiti i filtri cognitivi. Questi permettono
di raccogliere le informazioni coerenti con le proprie aspettative. L’uso di filtri per la
selezione delle informazioni può dare vita ad una vera e propria forma di percezione
difensiva, intesa come la tendenza a non rilevare la presenza di stimoli ritenuti non graditi o
minacciosi e spiacevoli: di fronte ad una scelta (per esempio l’acquisto di un’automobile) pur
di evitare il disagio provocato dal recepire informazioni contrastanti con la scelta fatta, non
sarà difficile vedere il nostro impavido acquirente confrontarsi entusiasticamente con chi ha
fatto lo stesso acquisto, leggere e ricordare solo le informazioni che convalidano e sostengono
la scelta fatta, rinnegare o screditare tutte quelle informazioni, e\o le loro fonti, che
dimostrano di avere commesso un profondo errore di valutazione nell’acquisto
dell’automobile.
Schemi e aspettative nella costruzione della realtà
Nelle interazioni un ruolo determinante è attribuito alle aspettative. Queste sono in grado di
guidare l’intera azione, oltre che i processi di selezione delle informazioni e di percezione
della realtà. Sappiamo, per esempio che l’attenzione opera in modo tendenzioso, favorendo
l’accesso degli input verso i processi superiori di elaborazione di quei contenuti che
sembrano avere più pertinenza con le attese, con le abitudini, con i bisogni e con gli scopi che
l’organismo sta perseguendo in quel momento. “L’obiettivo che governa il Sistema Io finisce
per rendere necessaria la scorciatoia di pre-giudizi e di ipotesi “rischiose” resi necessari dalla
capacità limitata e dall’urgenza di decidere. L’influenza delle aspettative e questo processo di
influenzamento sui processi percettivi (previsione – controllo – decisione – azione) si rafforza
5
in situazioni complesse ed ansiogene e la forza degli stereotipi e dei pregiudizi si inasprisce
nel momento in cui ci si percepisce in difficoltà, o quando la nostra attivazione fisiologica
(aoursal) supera un certo limite. Con il termine arousal si indica l’intensità dell’attivazione
fisiologica e comportamentale dell’organismo. Secondo la Teoria dell’Arousal (Olivero e
Russo, 2009) quando l’organismo deve effettuare una prestazione occorre una attivazione
come l’aumento della vigilanza e dell’attenzione (attivazione del sistema nervoso centrale), la
preparazione dei muscoli allo sforzo (attivazione del sistema muscolo-scheletrico),
l’attivazione del sistema cardiaco e respiratorio per la produzione delle energie necessarie per
sostenere lo sforzo (sistema vegetativo simpatico) all’azione. Secondo la legge di
Yerkes_Dodson un’attivazione fisiologica moderata favorisce un buon livello di prestazione
percettiva, attentiva, decisionale. Diverse ricerche sul campo infatti dimostrano che se
l’attivazione fisiologica cresce, la prestazione aumenta corrispondentemente. Ciò però
avviene fino ad un certo punto e fino ad una certa attivazione fisiologica (arousal). Oltre un
certo livello la prestazione decresce. E’ possibile rappresentare il rapporto arousal prestazione come una
campana capovolta in cui la
prestazione si riduce con
l ’ a u m e n t a r e
dell’attivazione. Quando
siamo sotto stress o
emotivamente attivati la
nostra memoria ci fa brutti
scherzi così come la nostra
capacità attentiva o di
riflessione. Questo processo
spiega come mai molto
spesso durante un esame
particolarmente ansiogeno
alcuni studenti hanno difficoltà ad interagire con il docente a causa di un’eccessiva emozione
(ansia, paura) che può provocare una riduzione della capacità di esposizione e di richiamo
alla memoria degli argomenti studiati
Il fenomeno ci può spiegare come mai in situazioni particolarmente stressanti si è più
propensi ad utilizzare schemi e stereotipi o perché si è più soggetti alla pressione della
conformità, violando qualsiasi principio di logica “razionale” (Siri, 2002).
Gli schemi, tuttavia, non hanno solo effetti negativi. Aiutano a classificare la realtà ed a dare
senso a ciò che registriamo. Il modo in cui classifichiamo un evento dirige la nostra
attenzione sull’informazione rilevante per quella categoria di eventi. Se si prova a classificare
l’osservazione di un gruppo di persone come “riunione di lavoro” nella quale è presente un
dirigente e i suoi collaboratori probabilmente si sarà più propensi a raccogliere tutte quelle
informazioni che sono coerenti con i temi di lavoro, ignorando o dando meno importanza ad
altre tematiche, ma soprattutto si tenderà ad interpretare buona parte dei messaggi e delle
comunicazioni in maniera del tutto diversa rispetto alla stessa situazione in cui il gruppo di
lavoro viene, invece, codificato come semplice “gruppo di amici”.
6
In questo processo l’uso degli schemi o meglio l’uso di categorie e concetti intesi come
rappresentazioni mentali e strutture di conoscenza più o meno condivisi, è indispensabile per
semplificare la realtà e dare senso all’enorme quantità di stimoli ed informazioni.
Questa classificazione in strutture conoscitive, solitamente automatica, è estremamente utile
in quanto ci consente di trattare oggetti apparentemente diversi allo stesso modo e ci consente
di guidare i nostri comportamenti e il modo di leggere la realtà circostante. Il
raggruppamento, che la concettualizzazione determina, semplifica il mondo e lo rende
controllabile. Questi processi sono estremamente preziosi poiché classificare l’enormità degli
stimoli ambientali in equivalenti e diversi è un primo passo per arrivare all’adattamento. La
riduzione del mondo in unità concettuali aiuta anche la memoria e la chiarezza del pensiero.
La gente ricorda meglio l’informazione organizzata in parti o quella che richiama elementi
noti e conosciuti. Così come i concetti facilitano anche la comunicazione. Le definizioni
verbali associate ai concetti ci permettono di parlare di emozioni, di pensieri , di personalità
ed atteggiamenti. Non è facile comunicare esperienze che non si prestano ad un’immediata
traduzione in unità più semplici. La concettualizzazione in fondo riduce l’ansia. Finché non
sappiamo che cosa accade nel mondo, non possiamo neanche sapere come potremo agire agli
eventi. Infatti un mondo non definibile in base a schemi o concetti di qualche tipo è
potenzialmente pericoloso.
Il ruolo degli schemi nella percezione dei protagonisti dell’interazione
In una società in cui la sfera dell’esperienza sociale ha un ruolo determinante, poiché è quella
in cui si gioca il legame con gli altri, l’accettazione da parte del gruppo, il riconoscimento del
proprio valore e del proprio modo di essere, rappresentano uno degli aspetti più importanti
del processo di interazione sociale. In questo processo di conoscenza la relazione sociale è
alla base della costruzione del Sé. Grazie ad essa si mantiene l’identità personale, il senso del
sé rappresenta la sfera di azione da cui possiamo trarre alimento per la nostra autostima,
essenziale per la sopravvivenza psicologica (Siri, 2001).
In questa relazione, tuttavia, un ruolo determinante è riconosciuto ai processi di preselezione, di pre-giudizio e di deformazione della realtà oggettiva proprio perché aiutano
l’individuo a non mettere in discussione la propria immagine e il proprio Sè. Non è un caso
che “percepiamo” (ed elaboriamo) diversamente le informazioni provenienti da coloro che ci
criticano, ritenendole non valide, inattendibili e false, mentre tendiamo a ritenere indiscutibili
tutte le informazioni che al di là di ogni evidenza tendono a supportare la nostra buona
immagine. Anche gli adulatori vengono percepiti diversamente. In un contesto sociale
complesso si manifesta uno dei “difetti” maggiori del sistema dell’Io: quanto più lavora sotto
stress tanto più esso tende ad irrigidire gli schemi e i pregiudizi che governano il suo operare,
nel tentativo di garantirsi una rappresentazione rassicurante di sé e delle cose. L’abuso delle
categorie può, infatti, costituire un limite alle nostre esperienze e oscurare sottili differenze (a
volte anche differenze macroscopiche, si pensi per esempio all’effetto omologante dei
pregiudizi e degli stereotipi) che intercorrono tra un pezzo e un altro della realtà.
Gli stessi concetti ci possono spingere a richiamare la nostra attenzione su certe
caratteristiche facendocene ignorare altre. Uno degli esempi di cecità sociale è quello che
7
porta a vedere la gente che appartiene ad una categoria come totalmente differente da quella
che appartiene ad altre.
Questo fenomeno è particolarmente delicato se ci riferiamo a particolari rapporti
interpersonali come quelli che richiedono un forte investimento personale e una particolare
motivazione all’ascolto come per esempio nelle situazioni di sostegno psicologico e sociale o
nel campo educativo. Chi si occupa di counseling, per esempio, dovrebbe essere
particolarmente formato a riconoscere e gestire i propri schemi cognitivi e i propri pre-giudizi
poiché questi possono semplificare troppo la realtà e influenzare negativamente la relazione
di aiuto su cui si dovrebbe basare il lavoro del consulente.
Uno dei più noti esperimenti in merito a questo processo di categorizzazione sociale è stato
realizzato da Salomon Asch (1946), il quale ha dimostrato come una lista di aggettivi e di
elementi che descrivono una persona è possibile avere un idea comune e condivisa della
caratteristiche di personalità della persona stessa. Asch ha somministrato ad un gruppo di
persone una lista di aggettivi “intelligente, competente, industrioso, caldo, determinato,
pratico e prudente” per avere una descrizione pressoché condivisa da tutti di una persona
generosa, che “crede che certe cose sono giuste, vuole che gli altri capiscano il suo punto di
vista, che è sincero quando discute o vorrebbe che la sua opinione fosse ritenuta giusta”.
Oltre a questa immagine condivisa dalle persone che avevano letto la lista di aggettivi Asch
ha dimostrato l’esistenza di alcuni elementi centrali capaci di modificare radicalmente
(sempre in maniera abbastanza condivisa) l’immagine della persona. Bastava sostituire
l’aggettivo caldo con freddo per avere un’impressione profondamente diversa. Asch
contribuendo significativamente all’applicazione delle teorie gestaltiche in campo sociale ha
voluto dimostrare che l’impressione che ci facciamo degli altri è sempre più della semplice
somma delle parti e che vi sono dei tratti centrali descrittivi che fungono da punti di
ancoraggio nella formazione dell’impressione, rendendola stabile e significativa.
Lasciarsi guidare dalle proprie attese ed aspettative, infatti, determina il rischio di perdere di
vista ciò che veramente colui che chiede aiuto intende portare all’attenzione del consulente.
Ciò ovviamente non vale solo per coloro che si occupano di consulenza psicologica, ma di
tutte le relazioni interpersonali e delle diverse forme di ascolto: dalla consulenza aziendale
alla relazione medico paziente.
Proviamo a riportare un breve esempio pratico tratta dalla mia esperienza di responsabile
della formazione per diversi anni in Telefono Azzurro. Si tratta di un tema trattato in altri
contesti (Russo, 2003 e 2004) che trattiamo brevemente anche in questa parte del testo per
sottolineare l’importanza che assume la consapevolezza dell’effetto delle attese e degli
schemi nella comunicazione e nell’interpretazione della realtà e dei comportamenti altrui.
Ci riferiamo ad esperienze svolte per la formazione dei consulenti telefonici di una delle più
note helpline per l’infanzia e l’adolescenza in Italia, gli operatori telefonici di Telefono
Azzurro. In questo contesto ogni richiesta d’aiuto prende forma all’interno di uno scambio
comunicativo tra un professionista ed un utente. Se è vero che tramite l’interazione/
comunicazione si costruiscono i significati e si dà un senso alla realtà che ci circonda,
(Saccani, 1994), si può affermare che attraverso i discorsi (lo scambio conversazionale) si
producono significativi effetti sulla realtà stessa.
In altri termini, la parola detta assume rilevanza se si presuppone che “dire è fare delle
azioni” (Austin e Searle, 1994).
8
Attraverso il colloquio terapeutico o la consulenza telefonica, gli interlocutori cercano di
riconoscere e ri-costruire una situazione problematica, al fine di riuscire in qualche modo a
mutarla. Nella stessa definizione di “incontro terapeutico” si pone come elemento fondante il
compiersi di una “trasformazione della storia narrata che lasci spazio a nuove esperienze”:
c’è un’attenzione quindi alla narrazione e alle strutture semantiche, alla trasformazione del
modo in cui gli utenti descrivono i loro problemi. Anche il colloquio telefonico crea uno
spazio d’ascolto: offre all’utente/chiamante l’opportunità di verbalizzare il proprio problema,
di riflettere sulla possibilità di apportare delle modificazioni alla situazione attuale, di
ricostruire insieme all’operatore una “nuova storia”, sulla quale ci sia il consenso di entrambi.
Nella relazione tra l’operatore telefonico e l’utente adolescente, ad esempio, emerge con
forza il rapporto tra “dire e fare”.
L’offerta del servizio di consulenza si basa, quindi, sulla corretta interpretazione delle
richieste di aiuto. In base alla lettura della domanda si ottiene una prima definizione
interpretazione della richiesta e la costruzione e di conseguenza la costruzione della relazione
di aiuto. Questo processo come indicato da Schein (1992) prevede una profonda conoscenza
non solo delle problematiche e delle possibili origini multidimensionale del disagio, ma
soprattutto una profonda capacità del consulente di comprendere i propri schemi di
riferimento e il proprio modo di relazionarsi con il disagio e con chi chiede aiuto. Parlare di
domanda e di offerta significa riconoscere due poli, due attori sociali, ognuno dei quali dotato
di senso e di intenzionalità specifiche, di linguaggi e di sensi differenti, di culture e di
riferimenti semantici differenti, di desideri e bisogni. Il consulente deve essere capace di
riconoscere le modalità di interpretazione personali adottate per comprendere la dimensione
relazionale e i vissuti riportati dal chiamante. Nella costruzione della relazione di aiuto uno
dei rischi maggiori potrebbe essere quello di non sapere “valutare e controllare” i propri
vissuti e le modalità interpretative nell’analisi di quanto viene riportato da chi ha richiesto
una forma di aiuto. La complessità della consulenza nella relazione di aiuto nasce infatti dal
fatto che il nostro sistema nervoso è simultaneamente “un sistema di raccolta dati, un sistema
di elaborazione e un sistema manageriale autogeno: ossia osserviamo, reagiamo
emotivamente a quanto osservato, analizziamo, elaboriamo ed esprimiamo giudizi basati sulle
nostre osservazioni con lo scopo di produrre degli eventi, cioè interveniamo” (Schein, 1992).
Ciò significa che l’interpretazione dei dati e dei messaggi del chiamante passano attraverso
la capacità di lettura e attraverso i “filtri” cognitivi ed affettivi del consulente. Per una
consulenza efficace e funzionale è, pertanto, necessario che il consulente sappia utilizzare con
“consapevolezza” le proprie specificità e i propri vissuti e che sappia riconoscere gli schemi
cogniti che più facilmente vengono utilizzati nella valutazione delle situazioni. È necessario
che sappia riconoscere quali sono gli eventuali ostacoli alla comunicazione e gli errori che
possono derivare dai propri vissuti, dalle proprie abitudini e dai filtri cognitivi ed affettivi
(Simon, 1960; Nisbett e Ross, 1980). E’ indicativo il fatto che uno degli errori comunicativi
verso cui può essere facile orientarsi in una relazione di aiuto è di “dare suggerimenti prima
ancora di avere ascoltato a fondo. Abilità che in realtà chiama in causa competenze di ascolto
attivo e richiede un preciso training formativo. La modalità del suggerimento e della
soluzione sottolinea in ogni caso, l’asimmetria della relazione e tende a favorire rapporti di
dipendenza, ostacolando processi di crescita (Di Fabio 2003). SI tratta in fondo della stessa
simmetria che caratterizza i processi di valutazione basati su pregiudizi e stereotipi. Una
9
valutazione guidata dai propri schemi interpretativi senza una oggettiva corrispondenza con
la realtà sociale oggetto di valutazione. Ogni stereotipo è una forma di generalizzazione
rigida riguardanti gruppi sociali dal contenuto illogico ed inesatto. Secondo gli approcci
motivazionali questi meccanismi pregiudiziali derivano da motivazioni autoprotettive e
servono a mantenere un’immagine positiva di se stessi e del proprio gruppo di appartenenza,
come indicato dalla teoria dell’Identità sociale di Tajfel e Turner (1979) o la teoria della
categorizzazione di sé (Turner, 1987). Così dietro l’obiettivo palese di chi presta aiuto si può
nascondere una difesa della propria immagine positiva o l’esigenza di una forma di riscatto
personale, un modo per contenere profondi sensi di colpa e una forma di inadeguatezza, o
addirittura l’esigenza di conquistare o consolidare una posizione di potere. Chi riceve aiuto,
infatti, può adagiarsi su quell’aiuto e abdicare alle sue capacità adattandosi al ruolo di colui
che è aiutato, colludendo perfettamente con il bisogno di riconoscimento del consulente.
Nella relazione di aiuto ai fini di una sua efficacia profonda e di qualità, diventa
fondamentale allora la preparazione dell’operatore.
A questo proposito di parla comunemente di competenza comunicativa e relazionale senza
una chiara indicazione di cosa significhi. Una prima considerazione è che questa competenza
richiede una profonda consapevolezza di sé, dei propri vissuti e motivi, del proprio quadro
valoriale, capacità di decentramento cognitivo, abilità nella costruzione e nell’interpretazione
della relazione (Di Fabio, 1999). Queste abilità permettono di comprendere gli elementi e le
dinamiche che possono determinare gli ostacoli alla comunicazione e causare una non
corretta interpretazione. La relazione dialogica volta ad ottenere la libera espressione
dell’altro è strettamente influenzata da alcuni atteggiamenti che si possono manifestare già
dalle prime fasi della relazione. Si tratta di atteggiamenti,schemi, abitudini che spingono il
consulente a prestare maggiore attenzione durante la costruzione della relazione di aiuto ad
una dimensione piuttosto che ad altre, ad alcune informazioni o parti di esse piuttosto che a
quanto interamente riportato dall’altro, tanto da rischiare di ostacolarne la libera e trasparente
“apertura” (Di Fabio 2003; Mucchielli, 1987). Le dimensioni che possono guidare
l’attenzione e determinare il flusso delle informazioni che vengono prese in considerazione
possono così essere semplificate: la dimensione cognitiva e affettiva, la “centratura” sul
cliente o la centratura su sé stessi. Poiché durante la consulenza il criterio più importante per
decidere cosa analizzare ed utilizzare per una corretta “diagnosi” e come intervenire è da
ricercarsi, da una parte, negli elementi di “evidenza” riportati da colui che ha rischiato un
supporto ed un aiuto, e, dall’altra, nella percezione e l’interpretazione che l’osservatore ha
delle informazioni che è riuscito a raccogliere, anche la “qualità delle relazioni” e il modo di
approcciare il chiamante diviene oggetto di osservazione o almeno elemento di riflessione e
di analisi da parte del consulente. Questo, infatti, potrà essere guidato durante l’analisi dei
vissuti e dei dati da una “predisposizione” ad agire prevalentemente nella dimensione
cognitiva, agendo sugli elementi di razionalità, manifestando atteggiamenti di giudizio degli
elementi senza considerare opportunamente tutte le informazioni che attengono alla
dimensione affettiva che nella relazione di aiuto è in ogni caso sempre presente. Altra
condizione è quella in cui l’attenzione del consulente si inquadra principalmente all’interno
del registro dell’affettività. Sono le emozioni che guidano la diagnosi o comunque assumo un
ruolo determinante le informazioni che hanno una forte valenza affettiva. Il registro delle
emozioni del chiamante e delle emozioni del consulente guidano l’attenzione e strutturano la
10
relazione di aiuto, con una ridotta attivazione dei processi di giudizio e di razionalizzazione.
Ovviamente si tratta di due dimensioni che agiscono non secondo la regola del tutto o nulla,
ma con la prevalenza dell’una sull’altra.
La mancanza di consapevolezza da parte del consulente delle proprie abitudini o
“predisposizioni” rischia di ostacolare la comunicazione o lasciare costruire al consulente una
realtà che è assai lontana da quanto vuole essere riportata dall’altro. Una realtà più coerente
con le proprie aspettative o una realtà che protegge il consulente dalle sue più profonde ansie
e insicurezze (Schein, 1992). Sull’altro versante agisce una predisposizione ad interpretare i
vissuti, a leggere i dati riportati dal chiamante, a costruire una strategia di intervento con una
centratura sul consulente stesso o esclusivamente sul cliente. In quest’ultimo caso il rischio
maggiore è quello di perdere di vista il gli effetti che il chiamante ha sul consulente. Si tratta
in ogni caso di informazioni utili se opportunamente equilibrate con le informazioni tratte a
sua volta da un’analisi centrata sul chiamante. Dalla predisposizione di una dimensione
sull’altra è possibile distinguere diverse tipologie di risposta e di consulenza secondo la
seguente rappresentazione (Di Fabio, 2003).
Dall’interazione delle diverse dimensioni è possibile individuare cinque tipologie di
atteggiamento e conseguentemente diverse modalità di comunicazione del consulente, che
possono risultare da ostacolo ad una relazione di aiuto efficace e funzionale.
-
Atteggiamento interpretativo - dimensione cognitiva, centratura sul consulente:
questo implica l’attenzione a ciò che viene presentato e riportato e che risulta
essenziale per l’ascoltatore e determinante per il giudizio e la razionalizzazione. Ne
risulta una comunicazione in cui non c’è spazio per la vera ed autentica dimensione
dell’altro. Il consulente giudica oggettivamente ciò che viene riportato dall’altro
attraverso le proprie “griglie di riferimento abituali, riportando quanto espresso
11
all’interno una logica di spiegazione causale secondo regole e criteri “razionali” del
consulente. La risposta interpretativa tende spesso a presentare una ricostruzione di
ciò che il consulente ha sentito sulla base di legami causa – effetto relativamente agli
aspetti che hanno attirato la sua attenzione
-
Atteggiamento risolutivo – dimensione cognitiva, centratura sul consulente: in
questo caso vengono proposte al chiamante soluzioni precostituite che in realtà
rispecchiano le logiche del consulente e non il problema del chiamante. Le soluzioni
incalzano senza aspettare di ascoltare (diagnosi) le informazioni e i problemi
riportati. Si indica la strada da perseguire sotto forma di consigli razionali. Uno dei
rischi maggiori è di dare la sensazione al chiamante di volersi “liberare di lui” in
tempi brevi senza che gli sia concessa la possibilità di essere compreso. Inoltre
suggerendo all’altro ciò che deve fare si rischia di alimentare una relazione di
dipendenza, utile alla soddisfazione dei bisogni del consulente ma pericolosa per il
chiamante.
-
Atteggiamento valutativo morale - dimensione affettiva, centratura sul consulente:
in questo caso il consulente si pone in una posizione rigorosa basata sulla valutazione
morale di quanto riportato. Si tratta di una valutazione morale che coinvolge più la
dimensione affettiva ed emotiva del consulente piuttosto che il rispetto di criteri etici
comunemente e razionalmente condivisi. Il consulente filtra quanto riportato dal
chiamante sulla base delle reazioni emotive personali determinate dalle proprie idee
precostituite e dei propri presupposti ideologici. In questa relazione la dimensione
politica, intesa come forma nobile della contrattazione e della negoziazione, lascia lo
spazio alle posizioni rigide ideologiche. La mancanza di rispetto di tali posizioni
ideologiche scuote emotivamente il consulente che rischia di esprimere (anche non
espressamente) un atteggiamento di valutazione, di sentenziosità e di
colpevolizzazione.
-
Atteggiamento di sostegno e consolazione – dimensione affettiva, centratura sul
chiamante. in questo caso il consulente agisce consolando, supportando il chiamante,
rassicurandolo sulla sua situazione, sdrammatizzando gli aspetti per lui preoccupanti.
La risposta di supporto rassicura, consola, sostanziandosi di modalità materne,
rischiando di attivare una profonda passività nel chiamante. In questo caso il
consulente rischia di colludere con il chiamante, inducendo dipendenza soprattutto se
questa forma di interazione viene agita sistematicamente.
-
Atteggiamento investigativo inquisitorio – dimensione cognitiva, centratura sul
chiamante. La voglia indagatrice e la modalità inquisitoria caratterizza questo
atteggiamento, secondo il quale il consulente interroga seguendo i propri criteri logici
e razionali di analisi ma spostando l’attenzione solo su quanto riportato dal
chiamante. Non vi è spazio per l’analisi della dimensione affettiva personale e del
cliente. Né tanto meno si capaci di “contestualizzare” quanto riportato. L’inquisizione
pone l’altro di fronte un interrogatorio martellante con domande precise e puntuali. In
12
questa situazione il chiamante rischia di allontanarsi e di chiudersi difensivamente di
fronte all’eccesso di attenzioni.
Compito del consulente è di essere consapevole delle proprie predisposizioni ed abitudini al
fine di giungere ad un giusto equilibrio per la raccolta delle informazioni prestando
attenzione alle le diverse dimensioni. Alla base di questa forma di equilibrio di attenzione vi
èi un profondo atteggiamento di accettazione dell'altro, la capacità di riconoscere le proprie
predisposizioni al fine di promuovere un’analisi della dimensione cognitiva ed affettiva
senza un’unica centratura su uno dei due poli dell’interazione. La posizione rigida su uno dei
suddetti versanti rischia, infatti, di ostacolare la comunicazione. La relazione di aiuto deve
essere supportata da questi diversi atteggiamenti, senza rigide predisposizioni. Perché ciò
accada il consulente deve essere, da una parte, preparato a riconoscere i propri atteggiamenti
secondo lo schema proposto e dall’altro ad attivare il circolo virtuoso della comprensione e
facilitazione. Questo può essere garantito solo attraverso un processo circolare che prevede la
sospensione del giudizio, l’accettazione cognitiva-emotiva dell’altro, l’ascolto attivo, la
costruzione di una relazione di fiducia e la costruzione di senso e di significato attraverso un
lavoro congiunto tra consulente e chiamante.
Decisione e cognizione sociale
Alla base dei processi cognitivi che abbiamo fino ad ora esaminato vi è la consapevolezza
che in fondo il sistema dell’Io è caratterizzato da processi di semplificazione e di sintesi che
sembrano guidati dal principio di regolarità. E’ questa regolarità che può garantire la
sicurezza di “prevedere” e gestire la complessità del mondo e per contenerne la sua carica
ansiogena.
Per lungo tempo l’implicita assunzione che sottostava alle teorie e agli studi sui processi
decisionali era che il comportamento poteva essere “catturato”, spiegato da un modello
onnicomprensivo o da una “grande teoria”. In questa prospettiva le persone decidono
attentamente, valutando ogni singolo aspetto della situazione e della scelta da effettuare,
arrivando al termine di questo delicato e “consapevole” processo ad una decisione
soddisfacente. Lo schema generale del processo lo descriveva come una sequenza coerente e
consapevole di azioni volte a risolvere una tensione indotta dalla mancata soddisfazione di un
bisogno. Il primo autore che ha introdotto il concetto di problem solving per l’analisi del
comportamento dei consumatori è stato Howard (1963), il quale ha sottolineato l’importanza
del processo di apprendimento che permette al consumatore di agire degli automatismi o
attivare un processi di valutazione delle scelte più controllato e lineare.
Secondo Howard con passare del tempo e con l’esperienza gli individui imparano a
identificare le variabili ambientali capaci di dare maggiore soddisfazione ed a reagire nei
confronti di queste in maniera del tutto automatica. Questo processo, per chi si occupa di
problemi di consumo, implica che ogni singola fase potrebbe essere studiata dall’uomo di
marketing per potere comprendere i singoli passaggi decisionali del consumatore al fine di
adeguare messaggi e prodotti in funzione delle credenze e opinioni del consumatore e dei
suoi processi razionali di scelta. I prodotti potrebbero essere caratterizzati da quei attributi
13
che guidano il processo decisionale, così come il messaggi pubblicitari potrebbero rispettare
le aspettative del consumatore.
Alla base di questo modo di vedere il processo decisionale vi sono alcune considerazioni e
presupposti euristici della società moderna: l’idea che il mercato sia caratterizzato da
alternative e che il consumatore procede in genere a fare una scelta tra queste alternative
secondo un processo logico, direi quasi matematico (anche se automatico perché strettamente
associato a processi di apprendimento in cui il comportamento di consumo è stato associato a
piacevoli o spiacevoli conseguenze); che i criteri di valutazione utilizzati permettano la
previsione delle conseguenze di ogni tipo di consumo (uno di questi criteri può essere la
convenienza economica del prodotto); che il consumatore utilizzi delle regole e delle
valutazioni decisionali logiche per valutare le diverse alternative (semplificando il processo
di consumo in un atto di valutazione di un prodotto do di un servizio solo attraverso una
dimensione quella economica o quella relativa alla soddisfazione oggettiva del bisogno); che
le informazioni usate per le decisioni abbiano una loro precisa origine e fonte (sia che si tratti
di persone esterne sia che si tratti di contenitori interni come la memoria). Questa linearità
coerente con il modello di homo oeconomicus dell’età moderna non comprende la
complessità della realtà umana, anche se soddisfa l’esigenza di controllo e di razionalità di
cui abbiamo parlato.
Come, abbiamo avuto modo di descrivere prima, non tutti i processi decisionali si presentano
secondo questa complessa ed articolata linearità. La valutazione può realizzarsi man mano
che si scoprono nuove alternative, man mano che queste assumono un diverso significato
simbolico ed esperienziale per l’individuo al di là della semplice analisi costi benefici.
In questo processo sembra perdersi e confondersi l’idea di espressione del proprio Sé, non vi
è che il riferimento all’esperienza dell’acquisto in cui ciò che conta è la dimensione oggettiva
della scelta in funzione di obiettivi ben precisi. Non vi è la dimensione del consumo in cui
l’aspetto espressivo e l’esigenza di ricerca di conferme alla propria immagine non sembra
svilupparsi secondo questo modello razionale di valutazione delle alternative. Non tutte le
decisioni procedono secondo questo modello lineare e razionalistico. Non a caso l’enfasi su
modelli onnicomprensivi e razionalistici ha tuttavia riconosciuto una battuta d’arresto
significativa già negli anni Ottanta (Simonson et al. 2001).
Eppure ancora oggi non è difficile trovare teorie e modelli in cui il flusso decisionale viene
descritto secondo un modello razionalistico, figlio dell’era positivistica, ma a volte distante
dalla realtà dei fatti. Con ciò non si vuole svalutare il valore di numerose ricerche sui processi
cognitivi e sulla razionalità dell’individuo, ma si ritiene opportuno segnalarne la debolezza
nella spiegazione dei comportamenti. A volte il processo decisionale viene rappresentato
come un percorso caratterizzato da una parte da un insieme di variabili umane come la
personalità, la motivazione, la percezione, l’apprendimento e dall’altro dalla da processi
razionali caratterizzato dalla valutazione cognitiva delle informazioni, la loro pesatura, la
scelta razionale e così via. Le variabili come personalità e motivazione rischiano di essere
percepite come variabili di disturbo che alterano inspiegabilmente il processo razionale di
scelta. Come è possibile vedere nella figura successiva la personalità, l’apprendimento, la
motivazione sono elementi importanti ma sembrano essere considerati come un insieme
indefinito di variabili che sembrano non coincidere con il flusso più importante dove avviene
la valutazione delle informazioni secondo un processo di tipo cibernetico. La stessa
14
rappresentazione grafica che troviamo in molti testi di marketing sottolinea la presenza di una
distribuzione proporzionata degli elementi da studiare o da considerare.
Il processo decisione qui descritto è coerente con il modello positivistico caratterizzato dalla
possibilità di individuare leggi universali, razionalmente definibili, flussi decisionali
caratterizzati da processi lineari e deterministici. Eppure numerose ricerche hanno dimostrato
che il processo di decisione può avvenire attraverso diverse strategie. Ogni individuo, può,
per esempio, valutare gli sforzi richiesti per una particolare scelta e scegliere la strategia
migliore in funzione del livello di sforzo e di impegno richiesto. Alcune decisioni sono prese
con un basso coinvolgimento emotivo, affettivo, cognitivo. Già nella seconda metà degli anni
Settanta è stato evidenziato che le persone molto spesso non sono affatto consapevoli dei
processi cognitivi che utilizzano nel formulare i propri giudizi e le proprie scelte (Nisbett,
Wilson, 1977).
Il processo decisionale non necessariamente rispetta il modello cibernetico razionale. Di fatto
esistono processi automatici che riportano all’attenzione degli studiosi i processi preconsci, o
la valutazione dei processi inconsapevoli o di processi di influenzamento di valori, emozioni,
desideri sui processi di attenzione e percezione (Postmanm, Bruner, McGinnies, 1948).
Anche il giudizio su di sé non sembra
essere così lineare e logico come
sembra. La percezione del proprio
modo di essere è strettamente legata
alla relazione sociale e influenzata da
questa. Secondo uno dei primi teorici
del comportamento sociale, Mead
(1934) il proprio concetto di sé è il
riflesso delle opinioni comunicati da
altri per noi significativi. La società
offre uno specchio nel quale scopriamo
la nostra immagine o autodefinizione.
Dai risultati di numerose ricerche
risulta che la gente alimenta la propria
autostima riponendo viva fiducia nelle
opinioni di chi giudica favorevolmente piuttosto che a seguito di una precisa e puntuale
analisi delle informazioni su di sé. Gergen già nel 1965 aveva dimostrato come l’autostima di
un gruppo di studentesse universitarie potevano essere influenzate durante un’intervista fatta
da un’attraente laureata in psicologia clinica che chiedeva loro di valutarsi più onestamente
possibile. Ogni studentessa dava un punteggio alla propria persona, al proprio aspetto e alle
proprie qualità sociali. La ricerca ha dimostrato come l’approvazione della psicologa data alle
valutazioni positive delle studentesse produsse invariabilmente un aumento
nell’autoconsiderazione dei soggetti. Oltre alle opinioni di persone significative il confronto
sociale, studiato da Festinger nel 1954, ha un ruolo determinante nei giudizi su di sé. Il
confronto sociale diviene pertanto il principale sistema di discernimento di ciò che è vero e
che è falso nella vita sociale. Ciò fu dimostrato in una delle più note ricerche sul confronto
sociale fatta da Morse e Gergen (1970): in questo esperimento un candidato si presentava per
un intervista; durante l’attesa dell’intervistatore veniva fatto sedere da solo e provvisto di una
15
serie di moduli da compilare tra cui un test standardizzato sull’autostima. Una volta che il
candidato avesse risposto a metà test, un secondo candidato veniva introdotto nella stanza.
Questo era un complice dello sperimentatore e su metà dei soggetti della ricerca doveva fare
colpo indossando un bell’abito, portando con sé una valigetta elegante, con dentro matite ben
temperate, un libro di filosofia e un portadiapositive. Agli altri soggetti della ricerca la stessa
persona si presentava maleodorante, con un vestito malconcio, uno zainetto consunto con
dentro uno squallido romanzetto. I punteggi di autostima mostrarono risultati sorprendenti:
dopo l’entrata a metà della compilazione i punteggi dei candidati cambiava
significativamente. I punteggi della prima parte del test erano superiori dopo l’entrata della
persona ben vestita e inferiori per coloro che avevano avuto il contatto con il tipo malconcio.
Confrontandosi con quest’ultimo i candidati registrarono un aumento della loro autostima e lo
dichiararono inconsapevolmente nella compilazione della seconda parte del test. Questa
ricerca e altre simili hanno voluto indicare che il giudizio di sé può essere fortemente
influenzato dal confronto con gli altri.
L’uso delle scorciatoie: le euristiche
Le euristiche, come dicevamo, sono strategie di pensiero che consentono di formulare
rapidamente un giudizio sulla probabilità che qualche evento si verifichi o sulle
caratteristiche di una persona o di un prodotto. Molti problemi conoscitivi che affrontiamo
nella vita quotidiana sono strutturati in modo da richiedere l’uso del ragionamento
probabilistico. In realtà le ricerche condotte sul modo in cui le persone rispondono a questo
tipo di quesiti indicano chiaramente che in molti casi non vengono usate le leggi
probabilistiche ma vengono utilizzati i processi di stereotipizzazione e la semplificazione..
Una delle principali euristiche è quella della rappresentatività. Secondo questa strategia, o
meglio scorciatoia, persone o prodotti vengono inscritti in una categoria concettuale tramite
un processo di valutazione della similitudine tra le loro caratteristiche principali e quelle
rappresentative della categoria. I giudizi di categorizzazione basati sulla rappresentatività
interessano principalmente l’utilizzo di schemi sociali relativi a prototipi o stereotipi
(Zamperini, Testoni, 2002). Alcune imprese minori spesso cercano di trarre vantaggio da
questa strategia cercando di creare prodotti con nomi o caratteristiche estetiche molto simili a
quelli adottati da marche famose. In questo caso si vuole stimolare il consumatore a credere
che le caratteristiche dei due prodotti siano simili.
Un’altra euristica è quella della disponibilità secondo cui gli individui stimano la frequenza
oggettiva di determinati eventi sulla base della facilità di recuperare di informazioni
disponibili. Ciò significa che un individuo prova realmente a raccogliere le informazioni per
risolvere il quesito e per stimare la probabilità da associare ad un evento, ma nel far ciò si
basa sugli elementi cognitivamente più disponibili. Ecco perché dopo un grave fatto di
cronaca relativo alle vittime di un incidente aereo troviamo una percentuale ampia di persone
disposte a dichiarare che la probabilità di morte per incidente in aereo è tra le più alte,
contrariamente a quanto le statistiche dichiarano inequivocabilmente. L’immediata ed
effettiva disponibilità di informazioni affidabili su fatti ed eventi non corrisponde alla corretta
valutazione delle frequenze degli eventi stessi.
16
In maniera del tutto automatica, poiché guidati da questi processi di semplificazione la
probabilità soggettiva prende il sopravvento su quella oggettiva. Di fronte ad una possibile
scelta di prodotti tutti uguali in termini estetici, di composizione di prezzo, di peso la
possibilità di ricordare con più facilità il nome di un prodotto piuttosto che di un altro spinge
a valutare più positivamente il prodotto di cui si ricorda il nome. Ecco perché le azione
investono ingenti risorse per differenziare i propri prodotti da quelli concorrenti ricorrendo a
miglioramenti nelle performance ma soprattutto investendo nella comunicazione poiché è
senza dubbio importante influenzare la capacità dei consumatori di ricordare il prodotto
dell’azienda. D’altra parte è proprio questa euristica che porta i consumatori a sovrastimare
sistematicamente il valore di certi prodotti e delle marche più note.
L’euristica dell’ancoraggio postula che quando le persone devono esprimere un giudizio in
situazioni di incertezza, spesso riducono tale incertezza assumendo come punto di riferimento
un dato per loro sicuro, come per esempio un’esperienza passata o uno stereotipo. Questo
dato funge da ancoraggio per tutte le altre informazioni che verranno “accomodate” in modo
da rimanere pertinenti al dato iniziale. Ecco che a causa di una valutazione pregiudiziale
verso un prodotto, una marca o una persona sarà assai difficile riuscire ad accettare idee e
informazioni ad essa contrastante.
Le euristiche rispetto al pensiero logico formale sono più rapide, più facili e più semplici tali
da condurre a soluzioni mediamente corrette. Unico problema ovviamente è quel termine
“mediamente”. Si tratta, infatti, sempre di scorciatoie dettate certamente dall’esperienza, dalla
condivisione di credenze, dalla semplificazione che in un contesto assai complesso come la
realtà circostante sono molto utili, ma che rischiano di
condurci ad un’eccessiva
semplificazione e quindi all’errore.
L’aspetto più interessante di questo processo è che nella maggior parte delle volte questo
avviene in maniera del tutto inconsapevole, inintenzionale e automatico (Wilson et al. 1996).
A volte sono proprio gli elementi più irrilevanti che influenzano il comportamento di scelta
dell’individuo (Simonson et al., 1993). La scelta automatica guidata da un sentimento, da
un’emozione, dall’esigenza di soddisfare un intimo bisogno o da un’abitudine non può che
essere giustificata che da argomentazioni spesso lontani da una valutazione incapace di
reggere ad un’analisi razionale ed oggettiva.
I processi automatici sono fuori della sua consapevolezza. Si tratta di processi che si attivano
senza l’intenzione della persona, sfuggono al suo controllo. Al contrario i processi controllati
sarebbero processi meno efficienti (dal punto di vista del dispendio di energia psichica) in
quanto richiedono sforzo e tempo, che possono essere disturbati da fattori personali
(incapacità, fatica cognitiva, scarsa motivazione) e situazionali che vengono applicati
intenzionalmente e consapevolmente dall’individuo che può quindi controllarli (Mannetti,
2003).
Sulla base di questa distinzione alcuni autori hanno provato a individuare processi differenti
che caratterizzano il modo di attribuire significati alle cose e al modo di prendere le decisioni.
Significativi a questo riguardo sembrano le due teorie di Pretty e Cacioppo autori della teoria
della probabilità dell’elaborazione e la teoria di Chaiken sull’elaborazione euristico
sistemica.
Secondo Pretty e Cacioppo il processo decisionale e di persuasione si sviluppa secondo due
possibili vie: quella centrale e quella periferica. La prima prevede un’attenta elaborazione
17
cognitiva delle informazioni e delle alternative secondo il modello razionale e lineare che
abbiamo descritto sopra. Questo processo centrale, che richiede energia e attenzione in genere
viene attivato in funzione anche delle peculiarità della situazione e delle specificità della
persona. Infatti le persone molto motivate ad elaborare attentamente le informazioni della
situazione o il messaggio pubblicitario tenderanno ad attivare il percorso centrale soprattutto
se sono e si percepiscono anche competenti in materia. Ovvero se hanno le competenze
cognitive adeguate per procedere a questo tipo di elaborazione.
La seconda via, quella periferica, è caratterizzata da un minore impegno nell’elaborazione
delle informazioni e della presa di decisione. In questo caso la decisione viene presa in
maniera quasi automatica, secondo abitudini o comunque facilmente determinata da
pregiudizi, da attese, così come da influenze esterne. Non vi è un’attenta riflessione sulle
informazioni e sulle possibili alternative. Quando la motivazione e la capacità cognitiva sono
ridotte è più probabile che venga seguita la via periferica.
Questa distinzione dovrebbe spingere l’uomo di marketing a prestare attenzione al grado di
coinvolgimento e alle competenze del proprio gruppo target perché queste informazioni,
secondo Pretty e Cacioppo (1983) permettono di capire se il messaggio deve essere
strutturato per un’attenta elaborazione delle informazioni o se può solo agire a livello
periferico, puntando così sugli aspetti di persuasione più superficiali come la gradevolezza
della fonte piuttosto che la trattazione del contenuto e la qualità degli argomenti.
Questa teoria ha spinto molti studiosi a valutare il grado di influenzamento nei processi
decisionali di alcune variabili come la qualità degli argomenti, l’esperienza, il prestigio e la
gradevolezza della fonte e il coinvolgimento delle persone (valutato in funzione della
situazione misurando per esempio aspetti oggettivi come l’affaticamento e la distrazione) o
aspetti soggettivi come l’interesse e la motivazione.
Anche secondo Chaiken (1980) ogni individuo nell’attribuzione di un significato ad un
messaggio o a un prodotto può utilizzare due diversi approcci o due diversi processi
cognitivi: un processo centrale che richiede tempo e sforzo per elaborare attentamente la
situazione e le diverse alternative e un processo di elaborazione euristica che utilizza semplici
regole decisionali, apprese durante le esperienze precedenti o determinate dalle influenze
sociali che richiede uno sforzo limitato. L’elaborazione euristica è in altre parole un processo
cognitivo che procede dall’alto verso il basso in quanto utilizza strutture cognitive precedenti,
aspettative e credenze, opinioni e pregiudizi per elaborare le nuove informazioni
L’elaborazione euristica è più circoscritta rispetto alla via periferica di cui hanno parlato
Pretty e Cacioppo (1983) perché la dimensione definita periferica faceva riferimento a tutto
ciò che non era elaborazione attenta e dettagliata delle informazioni secondo un processo
cognitivo e razionale. Tale modello tuttavia prevede che i due processi siano mutuamente
escludenti. Non si può avere congiuntamente un processo periferico e centrale. Invece il
modello di Chaiken prevede la possibilità che i due processi si verifichino
contemporaneamente. In altre parole chi riceve il messaggio può avere la motivazione e la
capacità di seguire un’elaborazione sistematica e allo stesso tempo , se sono disponibili
potrebbe lasciarsi guidare da pregiudizi o da processi euristici (che descriviamo
dettagliatamente più avanti). Il giudizio finale e il conseguente cambiamento
dell’atteggiamento potranno essere influenzati in modo interattivo dalle due modalità di
elaborazione. La scelta di un processo rispetto all’altro è infatti un falso problema poiché il
18
modo di reagire dell’individuo non può essere così semplificato ma va visto sempre in
maniera sinergica, dinamica ed interattiva.
A volte il processo potrà essere di tipo centrale, o prevalentemente di tipo centrale, altre volte
prevalentemente periferico con un influenza forte dei processi euristici. La scelta di un’auto
per esempio sembra essere guidata prevalentemente da un processo sistematico e centrale e di
fatto è così. Ma non vi è alcun dubbio che in questo processi di scelta entrano in gioco
elementi decisionali legati alla nostra esperienza passata, ai nostri desideri, ai significati più o
meno razionali che attribuiamo a quella specifica scelta. E questo è quanto più vero oggi in
cui la scelta di auto della stessa categoria che si assomigliano profondamente è guidata
soprattutto da altre considerazioni piuttosto che dalla semplice valutazione costi benefici.
In realtà i processi decisionali automatici e controllati non possono essere intesi come
disgiunti e mutuamente escludenti.
I processi controllati hanno una parte di automatismi così come gli automatismi hanno
elementi di consapevolezza. La complessità dei processi decisionali non solo deve fare i conti
con la presenza di processi non razionali o comunque non coscienti, ma anche con la
compresenza di processi automatici e processi cognitivi controllati. In genere i processi
automatici sono quelli che vengono attivati più immediatamente, sono quei processi che
forniscono la prima risposta che viene successivamente controllate se necessario modificate,
attraverso uno sforzo cognitivo e un maggiore tempo per l’analisi della situazione o del
prodotto. Tra i fattori capaci di stimolare un processo controllato e di stimolare un maggiore
impegno energetico vi sono alcuni elementi come per esempio la presenza di nuove
informazioni incongruenti con gli schemi posseduti o con le aspettative, l’interesse della
persona per eventuali giudizi esterni o la percezione di dovere rendere conto della scelta fatta
ad altri o a se stessi, tutti fattori che stimolerebbero un certo bisogno di accuratezza, mentre la
dimensione temporale così come la stanchezza e la mancanza di energie o interessi specifici
(appunto il debole coinvolgimento personale verso qualcosa o qualcuno)sarebbero fattori che
ostacolano l’applicazione di processi cognitivi controllati. Questi argomenti e queste teorie
sono state alla base di molte ricerche e di molti dibattiti in questi ultimi anni. E’ bene però
sottolineare, per ricollegarci a quanto abbiamo detto all’inizio del paragrafo, che sia il
modello della probabilità che quello dell’elaborazione euristica sistematica presuppongono
che le persone siano sempre ed esclusivamente motivate a trovare soluzioni razionali o
comunque accurate e che i processi decisionali siano pur sempre caratterizzati da processi
“freddi” e logici. A volte il grado di logicità si riduce poiché ci lasciamo guidare da aspetti
superficiali e da un’analisi semplice della realtà, altre volte il grado di elaborazione è elevato.
Si tratta, comunque, di modelli che considerano esclusivamente la funzione cognitiva degli
atteggiamenti e della scelta di consumo, senza considerare la dimensione affettiva,
emozionale e del desiderio che ha un ruolo determinante nella spiegazione dei processi di
scelta.
Eppure anche nella ricerca delle informazioni, come abbiamo visto più sopra, la dimensione
motivazionale ed affettiva ha un ruolo determinante. L’attenzione su un’area, su un oggetto,
su una persona può essere influenzata dal piacere di avere un contatto giusto con quello
oggetto o con quella persona modificando anche il processo di raccolta di informazioni. Pur
di mantenere inalterata la propria autostima, gli individui vanno alla ricerca di tutte le
informazioni che non possono che dare conferma delle proprie qualità. Anche la scelta di
19
effettuare la ricerca delle informazioni utilizzando la propria banca interiore (la memoria che
è a sua volta strettamente influenzata dalle emozioni) o l’ambiente esterno dipende da
processi affettivi e non è solo da motivi razionali. Se osserviamo i processi di consumo come
quelli relativi all’acquisto di auto ci rendiamo conto che anche in questo campo la raccolta
dettagliata di informazioni non sempre rappresenta un elemento importante e determinante.
Uno studio effettuato tra i consumatori australiani (Solomon, 2002) ha mostrato che più di un
terzo degli acquirenti di una nuova auto fanno sue o poco più di due visite in giro per le
concessionarie prima di acquistare l’auto. Nel caso in cui l’oggetto di acquisto ha un valore
simbolico, legato maggiormente all’espressione di sé, come l’abbigliamento i consumatori
tendono, paradossalmente, ad impegnarsi maggiormente proprio perché il rischio di sbagliare
la modalità più giusta per esprimere se stessi viene vissuto con maggiore preoccupazione.
La ricerca stessa delle informazioni, a volte, non risponde a principi logici e razionali. Ogni
individuo può distinguersi dall’altro anche in funzione dell’impegno e delle energie che
investe per cercare le informazioni in merito ad un prodotto da acquistare. In genere
dovrebbero essere i consumatori che per la prima volta si confrontano con un prodotto a
dovere cercare tutte le informazioni per decidere, così come coloro che si ritengono più
esperti perché conoscono la materia e vogliono sapere di più in merito alle caratteristiche del
prodotto che conoscono. Di fatto alcune ricerche hanno dimostrato che né gli uni, né gli altri
sono i soggetti che maggiormente dedicano la loro attenzione alla ricerca delle informazioni.
Coloro che moderatamente conoscono il prodotto sembrano essere quelli più stimolati ad
intraprendere un percorso di approfondimento e di accurata ricerca delle informazioni.
Sembrerebbe che ci sia una relazione a U capovolta tra la conoscenza e la familiarità del
prodotto e l’impegno e l’energia spesi nella ricerca delle informazioni aggiuntive.
Il ruolo delle emozioni e delle motivazioni nella percezione della realtà
Bruner in un convegno del 1955 in Colorado durante il suo intervento dal titolo Going
beyond the information given (Bruner, 1983, Contarello e Mazzara, 2002) ha voluto
dimostrare che la percezione non è altro che un processo di categorizzazione e di costruzione
soggettiva. Non più solo acquisizione di informazioni attraverso in nostri sensi ma processo
di rielaborazione delle informazioni sensoriali attraverso la guida dettata dai nostri desideri e
dalle nostre emozioni. E per dimostrare questo assunto Bruner si è servito di uno dei più noti
esperimenti che i manuali di psicologia sociale riporta. Tale esperimento intitolato da Bruner
Value and need as organizing factors in perception, consisteva nel chiedere ad un gruppo di
ragazzi di dieci anni di età di giudicare la grandezza di alcune monete. Metà del gruppo
campione dei bambini proveniva da un’area benestante di Boston mentre la restante parte dai
sobborghi e dalle zone più povere della città. I risultati mostrano che questi ultimi tendevano
a sovrastimare la grandezza delle monete rispetto al primo gruppo, soprattutto per le monete
di maggiore valore e ad accentuare le differenze tra le diverse monete, soprattutto quelle che
avevano i valori più estremi, contrastando il principio della tendenza centrale secondo cui un
gruppo di valutatori tendono naturalmente a confluire verso un giudizio di valore medio
indipendentemente dall’oggetto da valutare.
20
L’appartenenza ad un contesto sociale, i bisogni e i desideri hanno influenzato la percezione
della grandezza delle monete indicando chiaramente l’influenza dei processi “caldi” affettivi
e cognitivi nell’elaborare le informazioni. A partire dagli anni Cinquanta e dai risultati di
ricerche su tale ambito Bruner ha approfondito i processi di sviluppo dei bambini per provare
a studiare come questi imparano ad andare oltre l’informazione data. Questi studi hanno
spinto Bruner e altri studiosi a riflettere sull’importanza della relazione sociale e dei vissuti
dei bambini per la crescita e lo sviluppo cognitivo del bambino. Lo stesso Bruner si è
soffermato sul ruolo attivo che hanno gli adulti nello sviluppo del linguaggio e nell’influenza
che ha l’adulto nei processi di acculturazione e di crescita. Questo tema non è certo lontano
dalle problematiche di oggi.
La motivazione sembra, pertanto, avere un ruolo determinante nell’interpretazione della
realtà. Diversi studi hanno infatti sottolineato l’influenza esercitata dalla motivazione
all’accuratezza, per esempio, sui processi cognitivi. La motivazione all’accuratezza o il suo
contrario la motivazione alla chiusura cognitiva determinano la quantità e la qualità
dell’attività cognitiva di un soggetto e del grado di impegno nella ricerca di informazioni più
dettagliate e nell’individuazione di possibili alternative nella scelta di un particolare
comportamento. Se la motivazione all’accuratezza spinge le persone ad adottare strategie più
onerose la motivazione alla chiusura cognitiva spinge all’adozione di strategie semplificatrici
come per esempio l’uso dell’euristiche. Secondo Kruglaski (1996) la motivazione alla
chiusura coincide con l’utilizzo di schemi e stereotipi e con l’impazienza e impulsività nel
formulare giudizio. Si tratta di un modo di reagire al contesto sociale dettato prevalentemente
da una forma di rigidità di pensiero e dalla riluttanza ad accettare punti di vista diversi dal
proprio. La motivazione alla chiusura può essere indotta da caratteristiche del contesto
(situazione id pressione temporale, affaticamento, rumore, noiosità e comunque scarso
interesse al compito) sia essere una caratteristica disposizionale di un individuo (Mannetti,
2003) e determina: la riduzione della ricerca di altre informazioni prima di prendere una
decisione, la formulazione di un numero inferiore di alternative, una maggiore
predisposizione a recepire le prime informazioni e un maggiore affidamento a pregiudizi e
stereotipi.
Le aspettative sono una semplice lettura della realtà o contribuiscono a modificarla?
Abbiamo visto che gli schemi hanno un ruolo determinante per la rappresentazione della
realtà e per guidare il nostro comportamento. Tuttavia in alcuni casi l’uso di questa modalità
semplificata può portare alla formulazione di giudizi, convinzioni e decisioni inadeguate se
non addirittura dannose. Sulla base del processo semplificatore degli schemi nascono i
pregiudizi, ovvero una forma di giudizio che anticipa, e quindi semplifica, l’attribuzione di
senso ad un evento, l’attribuzione di causa ad un comportamento, attribuzione di aspetti
caratteriali alle persone. In questo caso si parla di stereotipo sociale inteso come una forma di
teoria implicita di personalità, condivise all’interno di un gruppo di persone e che riguardano
il proprio gruppo o un altro gruppo.
L’aspetto più importante per la definizione dello stereotipo è che si tratta di una teoria
implicita condivisa da una comunità di individui e che tali teorie implicite si riferiscono ai
21
partecipanti di un intero gruppo. Uno degli autori che ha dato grande impulso alla ricerca
sugli stereotipi è stato Tajfel che le 1969 pubblicò un articolo dal titolo, Aspetti cognitivi del
pregiudizio, in cui affermò che gli stereotipi possono essere concepiti come particolari forme
di categorizzazione che consistono nell’accentuare le somiglianze interne al gruppo e le
differenze fra gruppi. Questi rischi si aggravano se consideriamo che in genere le persone
mostrano nei confronti dei propri schemi mentali un notevole attaccamento. A volte, pur di
non mettere in discussione le proprie e rassicuranti certezze si rischia di considerarle valide
anche di fronte a nuove e chiare informazioni. Per evitare la sgradevole sensazione
determinata dalla dissonanza è possibile riscontare anche una forma di adattamento forzato
dei nuovi stimoli agli schemi preesistenti. Si parla in questo caso di perseveranza degli
schemi. Questa perseveranza rischia di innescare poi un meccanismo perverso definito
profezia che si autoavvera. Secondo tale fenomeno l’adozione di uno schema per interpretare
un fenomeno, un evento o il comportamento di una persona può influenzare tanto il nostro
modo di relazionarci con quella persona o evento da creare i presupposti per la conferma
dello schema o del pregiudizio. Esempio comune di tale fenomeno si ha quando convinti che
le persone di un certo gruppo sono poco socievoli e introverse ci relazioniamo con loro in
maniera poco amichevole, forse intimoriti dal nostro schema e dal pregiudizio. Ma questa
modalità poco accogliente rischia di determinare una relazione perfettamente coerente con lo
schema che abbiamo appena adottato per adeguare il nostro comportamento al presunto modo
di essere dell’altro. Lo schema ci ha fatto perdere di vista il nostro comportamento che è
diventato un vero e proprio stimolo ad un comportamento meno accogliente dell’altro,
determinando la profezia che si autoavvera.
Rosenthal e Jacobson (1968) hanno realizzato una delle più note ricerche sull’influenza degli
schemi e dei pregiudizi. L’esperimento realizzato con il coinvolgimento di insegnanti ha
voluto analizzare il ruolo delle aspettative nei confronti dei propri studenti nell’influenzare e
determinare il comportamento e il rendimento degli studenti stessi. La ricerca rientra tra le
numerose attività di analisi e studio che negli anni Sessanta in America avevano stimolato
l’interesse degli studiosi per cercare di comprendere e gestire il differente modo di relazione
degli insegnanti nei confronti di gruppi etnici diversi. Per studiare questi aspetti i due
ricercatori fecero un esperimento in una scuola di San Francisco somministrando a tutti gli
studenti un questionario di intelligenza. Successivamente agli insegnanti fu comunicato il
livello intellettuale dei rispettivi alunni per verificare se questo “schema”, questa
informazione potesse in qualche modo influenzare il loro modo di relazionarsi con studenti
con livello basso, medio e alto.
Fu comunicato agli insegnanti solo l’insieme degli studenti che avevano ottenuto un
punteggio elevato (livello intellettuale superiore), creando poi un gruppo di controllo di
studenti di cui non gli insegnanti non avevano alcuna informazione dei risultati del test. Di
fatto l’attribuzione di un punteggio superiore alla media fu dato in maniera del tutto casuale.
Dopo otto mesi i due ricercatori somministrarono nuovamente il test per verificare eventuali
miglioramenti. I risultati rilevarono che gli studenti ritenuti più bravi al test effettivamente
ottennero un punteggio significativamente superiore degli studenti del gruppo di controllo.
Effettivamente si registrò un miglioramento elevato. Ulteriori ricerche hanno poi dimostrato
che il raggiungimento di una prestazione decisamente superiore per quei ragazzi nei confronti
dei quali si erano indotte delle aspettativa più elevate furono determinate in parte da
22
comportamenti diversi da parte degli insegnanti nei confronti degli studenti ritenuti più bravi:
gli insegnanti mostravano più attenzione a questi studenti, li stimolavano con compiti più
impegnativi, fornivano loro feedback più frequenti e positivi e offrivano maggiori opportunità
di partecipazione alle attività rispetto al gruppo di controllo. Ecco un chiaro esempio di
profezia che si autoavvera. Le aspettative degli insegnanti avevano determinano un
cambiamento nei loro stessi comportamenti tanto da influenzare le prestazioni reali degli
studenti.
23
La valutazione dell’ambiente e delle persone: l’attribuzione di causa
Il tema dell’attribuzione di causa è di grande interesse per la psicologia sociale poiché fa
riferimento ad un considerevole numero di studi e di ricerche sui processi attraverso il quale
gli individui giustificano i propri comportamenti sociali e i comportamenti altrui. Per la
descrizione di questo processo partiamo dai risultati di un’interessante ricerca condotta da
Duncan nel 1976 sulle percezioni e le spiegazioni della violenza che si verifica fra individui
della stessa razza e membri di razze diverse. Ai soggetti dell’esperimento fu mostrato un
filmato in cui dei soggetti agivano in maniera sempre più aggressiva l’uno verso l’altro
terminando la sequenza con la visione di uno dei partecipanti che dava una spinta ad un altro.
I risultati sorprendenti dimostrarono che quando il protagonista che agiva in maniera violenta
era di colore nero, oltre il 70% dei soggetti scelsero la categoria “comportamento violento”
per descrivere ciò che avevano visto. Quando invece la spinta veniva data dal bianco nei
confronti del nero tale percentuale scendeva drasticamente al 13%. Chiedendo poi di spiegare
il comportamento osservato Duncan si rese conto che l’appartenenza da una razza era
determinante nell’attribuzione di causa dei comportamenti osservati. Quando colui che dava
la spinta era nero i soggetti affermavano che tale comportamento violento era strettamente
legato a fattori disposizionali, ovvero a caratteristiche di personalità, mentre nel caso in cui si
trattava di persona di razza bianca i soggetti nell’attribuzione di causa del comportamento
violento facevano riferimento maggiormente ad aspetti situazionali.
Tali risultati hanno stimolato un’innumerevole quantità di ricerche sull’attribuzione di causa
dimostrando come lo stesso evento può essere letto in maniera assolutamente differente in
funzione della persona che agisce, delle caratteristiche ad essa attribuite, in funzione del
contesto e così via.
I primi studi sull’attribuzione di causa sono stati realizzati da Heider (1958). Costui concepì
l’individuo come uno scienziato ingenuo il cui compito è quello di collegare il
comportamento osservabile con cause non osservabili al fine di potere spiegare i fenomeni
che osserva. Nel pieno rispetto dell’immagine dell’uomo come individuo elaboratore di
informazioni, Heider considerava l’individuo come proteso a raccogliere i dati necessari alla
conoscenza di un certo oggetto e a giungere a conclusioni logiche come si farebbe in un
laboratorio sperimentale. Secondo questo autore il compito principale che deve risolvere un
soggetto osservatore è decidere se una particolare azione è causata da fattori interni e
disposizionali (le sue abilità, la sua personalità, la sua motivazione) o indotta da fattori
esterni o situazionali (la fortuna, le specifiche condizioni in cui si viene a trovare).
L’attribuzione di causa a fattori interni o esterni modifica radicalmente il significato attribuito
ad un’azione e conseguentemente il nostro modo di reagirvi. Si provi a pensare alle nostre
reazioni di fronte ad un comportamento indisponente subito e alle diverse reazioni che
abbiamo avuto nel caso in cui tale azione sia stata attribuita a caratteristiche personali
dell’attore, piuttosto che alla situazione che ha spinto l’attore a comportarsi in una particolare
maniera. La stessa materia giuridica impone la valutazione di un’azione criminale in funzione
dell’influenza situazionale o della preterintenzionalità.
Secondo Heider nell’attribuzione di causa dei comportamenti sembra che vengano
privilegiate le spiegazioni in termini di caratteristiche disposizionali poiché più economiche
(è più facile attribuire le colpe alle persone che analizzare la complessità del sistema, basti
24
pensare a quanto sia facile attribuire all’errore umano un incidente catastrofico in un’azienda
piuttosto che analizzare quanto l’azienda stessa e le sue macchine e le sue contraddizioni
possano realmente spingere l’individuo a commettere un errore). In questo modo la causa di
un evento viene attribuita ad un solo elemento: l’individuo e le sue presunte debolezze.
D’altra parte secondo l’autore la persona sembra essere sempre più saliente rispetto al
contesto in cui si muove, dando luogo ad un effetto percettivo simile a quello di figura
sfondo. Attore e azione formano un’unità causale (Heider, 1958) la quale induce il soggetto
a focalizzare l’attenzione sulla persona, anziché sulla situazione assegnandole così un ruolo a
volte sproporzionato. Nella valutazione di una notizia di cronaca sugli incidenti stradali è
facile attribuire le responsabilità alle caratteristiche di personali, con il rischio di perdere di
vista gli effetti delle condizioni di usura dell’auto, della cattiva progettazione delle strade,
dell’inadeguatezza dei segnali e così via.
D’altra parte l’uso di tratti di personalità per descrivere le persone e dare senso alle loro
azioni caratterizza la cultura occidentale. Essa rappresenta una abitudine abbastanza diffusa e
coerente con la particolare sensibilità che la dimensione individuale ha in questa cultura
individualista rispetto alle culture collettiviste.
Il contributo di Heider (1958) relativo alle variabili disposizionali è stato per la psicologia
sociale di grande valore per avere introdotto per avere dato il via a numerosi altri studi sui
processi di attribuzione. Tra questi vi è il lavoro di Jones e Davis (1965) e il loro modello
dell’inferenza corrispondente. Secondo questi autori il processo attributivo consiste nel
risalire dal comportamento osservato e dai suoi effetti alle eventuali intenzioni dell’attore e
dalle intenzioni alle caratteristiche disposizionali (i tratti di personalità) che le sottendono. Il
processo attributivo si distingue, in questo caso, in due fasi, la prima in cui l’osservatore
prova a riconoscere il carattere intenzionale dell’azione osservata e la seconda più
strettamente legata all’inferenza delle caratteristiche disposizionali dell’attore. Durante la
prima fase per inferire che alcuni degli effetti di un’azione siano intenzionali l’osservatore
deve credere che l’attore conosca le conseguenze della sua azione e che abbia la capacità (per
esempio la forza) di produrre gli effetti osservati. Riconosciute le abilità dell’attore e la sua
consavolezza degli effetti della sua azione il passo successivo è l’accertamento che al
momento dell’azione l’individuo si trovava in condizione di libera scelta (non era sotto
pressione esterna nell’agire una particolare azione). Un’azione compiuta sotto costrizione ( o
prescritte dal ruolo agito in un particolare momento o influenzato da particolari norme) non
può essere attribuita alle caratteristiche di personalità dell’attore.
Il soggetto percepiente inizia questa seconda fase del processo attributivo confrontando le
conseguenze delle azioni scelte con quelle di altre possibili azioni, non attuate. Il principio
che guida il processo inferenziale è quello degli effetti non comuni in base al quale il soggetto
compie un’inferenza corrispondente quando l’azione da lui scelta produce degli effetti
relativamente unici o comuni (Hewstone et al. 1988). Ad esempio, dare una spinta a qualcuno
è un’azione facilmente distinguibile da altre azioni possibili e ciò che la differenzia è il fatto
di arrecare un dolore fisico. Minore è il numero di tali effetti non comuni, tanto più saremo
sicuri della correttezza delle inferenze sulle disposizioni personali.
Un altro contributo di grande interesse per le teorie sull’attribuzione è quello offerto da
Kelley (Kelley, 1973; Kelley e Michela, 1980), autore della teoria della covariazione, il quale
25
inizia il suo lavoro interrogandosi su quale è l’informazione che le persone usano per arrivare
ad un’attribuzione causale.
Secondo Kelley le persone adotterebbero gli stessi processi che uno scienziato utilizza nel
laboratorio per dare spiegazione ai fenomeni. In particolare Kelley afferma che “un certo
effetto viene attribuito a quella condizione che è presente quando l’effetto è presente e
assente quando l’effetto è assente”, ovvero se una condizione si presenta al soggetto
percepente quando ha luogo un certo evento e non si presenta quando l’evento non ha luogo
costui tende a concludere che la condizione causa l’evento. Per fare questo tipo di analisi
l’individuo si serve di tre regole: la regola della specificità, del consenso e della congruenza.
Per una breve descrizione di queste regole proviamo a fare un breve esempio: supponiamo di
dovere decidere se andare in un ristorante a mangiare del buon pesce sulla base delle
informazioni sulla bontà del cibo e del servizio che ha dato il nostro caro amico Luigi. Per
decidere se andare in quel ristorante per noi diventa importante valutare se il giudizio più che
positivo di Luigi sia più attribuibile alla reale qualità del ristorante e alla freschezza del pesce
provato o alle sua eccessiva cortesia e gentilezza nel giudicare i ristoranti. Per potere decidere
partiamo dalle informazioni che abbiamo: Luigi lavora spesso fuori ufficio, e mangia molte
volte al ristorante, se il giudizio positivo di Luigi è stato espresso solo per quel ristorante
(alta specificità), o comunque se Luigi non esprime così facilmente giudizi positivi come
Matteo per esempio; se il suo giudizio è coerente nel tempo (Luigi torna in quel ristorante più
volte e giudica sempre positivamente quel ristorante) (alta congruenza), e se il suo giudizio
coincide con quello del nostro amico Ivan e tanti altri nostri amici (alto consenso), allora
potremmo essere certi che il giudizio dato da Luigi non è attribuibile alla sua personale
predisposizione a giudicare positivamente i ristornanti, ma può essere ragionevolmente
attribuibile ad una causa esterna ben precisa: la bontà del pesce mangiato e la qualità del
servizio di quel ristorante. In genere utilizziamo le regole della specificità, del consenso e
della congruenza per l’attribuzione delle cause dei comportamenti degli altri. Alcuni autori
(Weiner et al. 1979), tuttavia, hanno sollevato qualche perplessità sull’utilizzo di questo
processo inferenziale così preciso e dettagliato nell’attribuzione delle cause. Supponiamo che
dopo avere usato le regole indicate da Kelley concludiamo che un complimento che abbiamo
ottenuto da un amico per un esame sostenuto con successo sia attribuibile più che alla facilità
del nostro amico a fare complimenti, alle nostre reali capacità dimostrate durante l’esame: il
nostro amico si è congratulato con noi e con nessun altro (regola della specificità), molti altri
colleghi si sono congratulati con noi (regola del consenso ed accordo intersoggettivo), la
versione scritta dell’esame ha ottenuto lo stesso successo della versione orale per cui abbiamo
avuto le congratulazioni (regola della congruenza della causa), in questo caso potremmo
veramente essere soddisfatti di noi stessi e credere che il successo ottenuto sia frutto di
“cause interne”? Questa è la domanda che si sono posti Weiner e i suoi collaboratori (1979)
dopo avere applicato il modello di Kelley. Secondo questi autori non è sufficiente avere
stabilito di essere causa dei propri successi poiché occorre, inoltre, decidere se il proprio
successo è frutto di impegno, oppure di specifiche capacità. Se il fallimento viene attribuito a
scarse capacità (fattori disposizionali stabili) si potrà pensare ad un fallimento come a una
situazione immodificabile e duratura, se invece si ritiene che il proprio fallimento o successo
sia dipeso da scarsa applicazione (impegno appunto) probabilmente l’impegno nella prova
successiva sarà maggiore. Weiner e collaboratori sottolineano il ruolo della motivazione
26
come fattore dinamico che si manifesta sotto forma di spinta soggettiva a competere, a
cimentarsi in certi compiti e a perseverare anche di fronte a ostacoli difficili. In questo caso
questa spinta motivazionale è strettamente dipendente: a) dall’attribuzione del “locus of
control” (Rotter, 1966) (il luogo del controllo interno o esterno richiama un principio secondo
cui le persone possono distinguersi per una prevalente attribuzione dei fenomeni a cause
interne o per l’abitudine o la prevalenza ad attribuire ciò che accade a cause esterne); b) dalla
stabilità della causa; c) dalla controllabilità, che attiene al grado in cui la persona crede che la
propria prestazione cada sotto il controllo volontario. Per fare un esempio i fattori causali
abilità e sforzo sono considerati entrambi interni, ma se il primo è ritenuto stabile ed
incontrollabile, il secondo risulta instabile e controllabile. Sul piano psicologico questi tre
elementi possono incidere profondamente sul modo di percepirsi e di percepire gli altri. Il
locus per esempio incide sull’autostima: più sento che gli eventi che mi circondano sono fuori
dal mio controllo più bassa sarà la propria autostima o l’immagine positiva che si ha di sè. La
stabilità agisce sulle aspettative di successo o insuccesso in una prospettiva futura. La
controllabilità, quando, è riferita a fallimenti personali produce emozioni di colpa e vergogna.
Come abbiamo potuto vedere in questi modelli di spiegazione dell’attribuzione di causa, e
soprattutto nel modello dei Kelley, si concepisce la persona tanto razionale da individuare i
processi attraverso cui si dovrebbero compiere le attribuzioni causali accurate.
In pratica, l’evidenza empirica ha mostrato che i soggetti percepienti non seguono la logica
dello scienziato, usando modello formali e dettagliati nell’attribuzione di causa.
Piuttosto fanno attribuzioni in modo rapido, impiegando molto meno informazione e
mostrando evidenti tendenze a servirsi di spiegazioni semplificate. Nei processi attributivi
entrano, infatti, in gioco errori o bias capaci di distorcere i processi che dovrebbero essere, o
che vorremmo che fossero, lineari e logici.
Tra questi bias ricordiamo l’errore fondamentale di attribuzione, già menzionato, in cui si
sopravvalutano le disposizioni e si sottovalutano le influenze situazionali come cause del
comportamento (Ross, 1977); le divergenze attore-osservatore intesa come la tendenza
diffusa che porta gli attori sociali ad attribuire il proprio comportamento a fattori situazionali,
mentre gli osservatori spiegano le stesse azioni nei termini di caratteristiche stabili e
disposizionali (Jones e Nisbett, 1971); il falso consenso che si fonda sul presupposto che le
altre persone si comportano come il soggetto percepente (Ross, Greene e House, 1977); i
giudizi tendenziosi in favore di sé che inducono le persone ad ascrivere il proprio successo a
disposizioni interne, come la capacità personali, e i fallimenti alle caratteristiche della
situazione, come la difficoltà di un compito o di un esame. Quante volte gli studenti
attribuiscono alla difficoltà dell’esame o alle difficoltà relazionali con il proprio docente, gli
insuccessi attribuibili alla mancanza di impegno personale nella preparazione dell’esame
finale di un corso? Quasi tutti siamo abituati ad attribuire il merito per i nostri risultati
positivi ed evitiamo di rimproverarci per quelli negativi al fine di preservare, aumentare e
proteggere la nostra autostima, o presentare un’immagine favorevole agli altri o
semplicemente conservare il controllo sull’ambiente. Ed infine un ultimo bias è relativo a
giudizi tendenziosi in favore del proprio gruppo, secondo il quale i membri di un gruppo di
successo tendono a assumere la responsabilità di prestazione del gruppo in misura superiore
a coloro che si trovano all’interno di un gruppo che ha fallito in un compito (Schlenker e
Miller, 1977).
27
Il ruolo degli atteggiamenti nelle interazioni
Il concetto di atteggiamento ha sempre avuto un ruolo determinante nella psicologia sociale.
L’importanza attribuita a questo concetto ha origine nella convinzione che i comportamenti
umani sono strettamente influenzati dagli atteggiamenti delle persone.
Gli atteggiamenti sociali costituiscono pertanto degli indicatori attraverso i quali è possibile
prevedere le azioni delle persone. Oltre a ciò è opinione diffusa che per modificare un
comportamento di un individuo un punto di partenza consista nel cambiare i suoi
atteggiamenti. Al fine di spingere il consumatore ad acquistare un particolare prodotto la
pubblicità cerca di fare cambiare atteggiamento nei confronti di qual prodotto attraverso la
costruzione di un’immagine positiva del prodotto stesso o attraverso la comunicazione
dell’esperienza che tale prodotto promette al consumatore; per essere rieletto un politico
cerca di suscitare nei suoi elettori atteggiamenti ed opinioni positive su di sé e possibilmente
sui propri programmi (anche se l’attenzione sui programmi sembra cha abbia avuto in questi
ultimi anni un ruolo meno determinante nel “condizionare” i comportamenti degli elettori).
Il concetto di atteggiamento, de resto, è largamente usato anche nei discorsi e nelle
conversazioni quotidiane. Tutti noi facciamo riferimento agli atteggiamenti positivi o negativi
che i nostri amici hanno verso una persona o un evento, verso l’ambiente o verso certe
ideologie o partiti politici.
Il concetto di atteggiamento sembra essere un elemento determinante, per questo è stato
studiato e approfondito per diversi anni. Tuttavia a differenza di altri concetti delle scienze
sociali, questo rischia di essere un concetto astratto, privo di significato o di una definizione
che sia assoluta e corretta. Esaminando i testi a disposizione si possono trovare molte
definizioni degli atteggiamenti. Proviamo a definire cosa intendiamo per atteggiamento? Il
problema che molti studiosi si sono posti è da una parte provare a dare una definizione di un
concetto tanto usato da renderlo quasi come un’entità prototipica di indiscutibile rilevanza,
uno di quei concetti che sembrano vivere di vita propria, e dall’altra provare a individuare il
modo migliore di misurare gli atteggiamenti per potere predire i comportamenti sociali. Di
fatto questa stretta relazione di dipendenza tra atteggiamento e comportamento è stata oggetto
di analisi e di dibattiti non solo metodologici ma anche concettuali.
L’atteggiamento originariamente ha fatto riferimento alla dimensione individuale: è stato
infatti considerato una proprietà dell’individuo, un suo modo di considerare gli oggetti, gli
eventi e le persone con cui entra in relazione. L’atteggiamento infatti indica il grado di
piacevolezza o meno che si prova verso un oggetto. Tuttavia questa definizione incide
significativamente sul modi di vedere l’atteggiamento, poiché sembra sottolineare la
dimensione valutativa che l’individuo fa nel momento in cui esprime un giudizio nei
confronti di un oggetto.
Come vedremo più avanti, provando a definire scientificamente il termine atteggiamento che
questo concetto è tanto complesso da non potersi limitare ad un’espressione di giudizio nei
confronti di un oggetto. Una cosa è certa: il concetto di atteggiamento ha avuto un grande
successo in termini di attenzioni e di ricerche negli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta con
un’accezione prevalentemente individuale. Siamo infatti in un contesto sociale in cui le scelte
individuali di consumo e di investimento assumono un’importanza determinante. Non è un
28
caso che tale macro concetto caratterizzato da una particolare valenza individuale abbia
trovato il suo naturale terreno di sviluppo giusto negli Stati Uniti. “Solo in società
“democratiche” poteva svilupparsi un interesse così profondo per la conoscenza di
atteggiamenti e un’altrettanto curiosità per le modalità in cui essi possono essere modificati,
specie attraverso quei mezzi di comunicazione di massa come la stampa, la radio, il cinema, e
la televisione da cui la società statunitense dipendeva e tuttora dipende per immaginarsi
come efficace comunità ideale e pratica” (Mantovani, 2003).
Lo studio degli atteggiamento e le loro definizione hanno per lungo tempo fatto riferimento a
questa dimensione individuale che tanto ha caratterizzato la società occidentale. Solo al
termine del secolo scorso la stessa definizione di atteggiamento ha lasciato spazio ad una
riflessione più collettivista considerando questo concetto non solo come il risultato di una
valutazione e di una espressione dell’individuo ma il risultato di una più profonda influenza
culturale e sociale. Proviamo ad andare con ordine per analizzare gli aspetti determinanti
relativi agli atteggiamenti: la loro definizione, la loro funzione e il loro rapporto con il
comportamento dell’individuo.
Il termine atteggiamento sociale fu introdotto in psicologia sociale da Thomas e Znaniecki nel
1918 per spiegare la differenza riscontrata nel comportamento dei contadini polacchi emigrati
in America con quello dei loro connazionali rimasti in patria. In quell’occasione Thomas e
Znaniecki definirono l’atteggiamento come quel “processo mentale individuale che determina
le risposte effettive e potenziali di ogni individuo al suo mondo sociale”. In questa
definizione risalta in primo piano la disposizione che l’individuo avrebbe nei confronti di un
oggetto come elemento caratterizzante il concetto di atteggiamento. Un’altra interessante
definizione che sembra calcare le orme di questi autori fu la definizione che ne diede Gordon
Allport (1935) che descrisse l’atteggiamento come “uno stato mentale o neurologico di
prontezza, organizzata per mezzo dell’esperienza, che esercita un’influenza di controllo o
dinamica sulle risposte dell’individuo nei confronti di ogni oggetto o situazione con cui entra
in rapporto”.
A partire da queste definizioni è possibile adottarne una che rispecchia quelle già riportate e
che è stata data da Eagly e Chaiken (1993) secondo la quale “l’atteggiamento è una tendenza
psicologica che viene espressa valutando una particolare entità”. Ciò significa che perché una
persona possa avere un atteggiamento è necessario che essa entri in contatto direttamente o
indirettamente con uno specifico oggetto ed esprima una forma di valutazione nei suoi
confronti che può essere manifesta o nascosta, implicita o esplicita, automatica o
intenzionale. A partire da queste definizioni, ed altre ancora, è possibile individuare nel
concetto di atteggiamento le seguenti caratteristiche fondamentali degli atteggiamenti:
• essi si riferiscono a persone o oggetti che fanno parte dell’ambiente dell’individuo;
• essi formano una parte del modo in cui l’individuo percepisce e reagisce al suo
ambiente ed incidono sui modi con cui attingiamo informazioni dall’ambiente e di
conseguenza influenzano la percezione delle mete che vogliamo raggiungere, in
questo senso hanno un carattere motivazionale;
• gli atteggiamenti vengono appresi e sono relativamente duraturi, il loro mutamento
avviene in genere molto lentamente;
• gli atteggiamenti implicano valutazioni e sentimenti.
29
L’importanza del valore conoscitivo degli atteggiamenti ci viene dimostrata dal ruolo che gli
atteggiamenti hanno nella stessa selezione delle informazioni. Come abbiamo visto nella
prima parte del capitolo il modo di elaborare le informazioni è strettamente legato all’utilizzo
di particolari filtri cognitivi ed emotivi. Per cercare di semplificare la realtà e di difendere
anche il proprio sistema di credenze e di valori le informazioni vengono selezionate, anche
inconsapevolmente. Gli atteggiamenti influenzano infatti sia la ricerca attiva
dell’informazione pertinente per l’atteggiamento, il processo di codifica dell’informazione (i
processi percettivi e di giudizio), il recupero stesso di tale informazione dalla memoria. In
una vecchia ricerca (Gollin, 1954) venne mostrato ad alcune persone un fil nel quale una
donna si comportava in maniera palesemente contraddittoria da una scena all’altra. In alcune
scene si mostrava gentile e generosa, dedita all’assistenza di un aziano malato. In altre
appariva equivoca e “dura”: poteva per esempio apparire come una prostituta in strada.
Chiedendo alle persone di mettere per iscritto una descrizione complessiva del personaggio si
evidenziò che la maggior parte delle persone (il 58%), allo scopo di fornire un’immagine
coerente ignorò diverse scene, se le loro descrizioni erano pressoché positive, tendevano a
tralasciare le immagini in cui appariva una figura discutibile e viceversa. Alcuni autori
ritengono che insieme all’aspirazione ad una coerenza logica e razionale un altro aspetto che
sembra giocare ubn ruolo determinante è l’esigenza di avere sentimenti coerenti ed emozioni
uniche verso una persona o evento. La gente non ama avare sentimenti misti (Anderson,
1978).
Tenendo conto del bisogno di coerenza si dovrebbe concludere che la gente sviluppi
un’immagine coerente di ogni persona conosciuta e che sia portata a trascurare tutte le
successive informazioni contraddittorie. In altre parole ci sarebbe un effetto di primacy
secondo cui la prima informazione ricevuta è quella più importante per la costruzione di
un’impressione. Ma non sempre è così. L’effetto recency, infatti, prevede l’influenza
dell’ultima informazione ricevuta per la costruzione di un’immagine o di un’impressione.
Quale di questi due effetti è il più frequente? Diversi autori hanno provato a dare una riposta.
Buona parte delle prime ricerche indicava nell’effetto primacy l’elemento più importante. Nel
classico esperimento di Asch (1946) sulla costruzione dell’immagine di una persona a partire
da alcuni aggettivi descrittivi. Se quelli positivi venivano posizionati all’inizio della lista le
impressioni iniziali positive avevano un’influenza maggiore tanto da persistere senza che si
tenesse conto delle informazioni negative successive. L’effetto primacy risulta quindi
dominante. Tuttavia questo risultato è stato messo in discussione non appena veniva chiesto
alle persone di prestare più attenzione alle nuove informazioni o quando il tempo che
intercorre dalla prima analisi al suo recupero mnemonico passa un certo periodo di tempo
(Miller e Campbell, 1959). Il coinvolgimento e il tempo sembra che spingano le persone a
lasciarsi influenzare dalle ultime informazioni. I risultati di alcune ricerche (Miller e
Campbell, 1959). dimostrarono che l’informazione più recente influenzava fortemente la
memoria.
La ricerca attiva delle informazioni pertinente all’atteggiamento al fine di garantire il rispetto
del principio della coerenza, è stata particolarmente studiata da Festinger (1957) per la
definizione della teoria della dissonanza cognitiva di cui abbiamo già parlato. Gli effetti
30
prodotti dall’esposizione selettiva delle informazioni sono stati ampiamente documentati da
diversi studiosi tra cui le ricerche di Frey (1986) dove si sottolinea anche le condizioni in cui
le persone non
mostrano gli effetti dell’esposizione selettiva ricercando al contrario
informazioni contrastanti sia perché hanno (o percepiscono di avere) un sistema cognitivo
tanto stabile da consentire loro di integrare informazioni discordanti o di rifiutarle con una
certa capacità di argomentazione e controllo sia perché l’atteggiamento è ancora poco
consolidato al punto che l’individuo può ritenere di modificarlo.
Diverse ricerche hanno dimostrato come in molti casi le persone cerano di ignorare
l’informazione che contrasta il proprio atteggiamento. Non stiamo più considerando il grado
di esposizione e selezione delle informazione, ma la valutazione che ne viene fatta.
Nell’elaborazione delle informazioni, come abbiamo già visto, la ricerca della coerenza
assume un ruolo importante. Il principio della coerenza introdotto da Heider (1946) assume
che tutte le persone si sforzano di organizzare le proprie cognizioni in modo tale da evitare
contraddizioni ed incoerenze. Tale principio mostra l’incapacità del soggetto percepente, nel
formarsi un’impressione, di utilizzare tutte le informazioni di cui dispone.
L’assunzione di base che gli atteggiamenti guidano il processo di valutazione e di
elaborazione delle informazioni cercando di rispettare tale coerenza si ritrova tra le teorie del
giudizio sociale come quella della teoria dell’assimilazione e contrasto descritta da Sherif e
da Hovland (1961). Secondo questi autori l’atteggiamento del soggetto costituisce una sorta
di ancora di giudizio, rispetto alla quale sono confrontati tutti gli altri atteggiamenti possibili.
Si fa l’ipotesi che gli atteggiamenti che si collocano in una posizione relativamente vicina a
quella del soggetto sul continuum attitudinale, saranno percepito come simili ai propri, più di
quanto non sia nella realtà, mentre quelle più distanti verranno rifiutati perché percepiti
maggiormente divergenti di quanto effettivamente non siano. Queste tendenze a distorcere il
processo di percezione e a fornire valutazioni tendenziose è alla base di giudizi stereotipati e
di errori di attribuzione di cui spesso non ci rendiamo conto. Soprattutto in situazioni
particolari come la testimonianza in un processo o nella valutazione dei comportamenti di
gruppi etnici diversi dal nostro questo processi inducono gli individui a commettere gravi
errori di distorsione che sarebbe bene controllare o comunque esserne consapevoli. In pratica
la teoria del giudizio sociale suppone che l’atteggiamento costituisca una sorta di schema di
riferimento on base al quale vengono interpretate le nuove informazioni: una volta che si è
formato un determinato giudizio verso una marca o un gruppo le successive esperienze
vengono interpretate in base ad esso.
31
In questo caso l’atteggiamento inteso prevalentemente nella sua dimensione cognitiva sembra
essere organizzato secondo un vero e proprio continuum in cui possono essere individuate tre
aree di diversa ampiezza in funzione della storia dell’individuo e dell’atteggiamento preso in
considerazione: un’area dell’accettazione che contiene tutte le affermazioni che la persona
accetta o condivide sul quel particolare oggetto o situazione; un’area del rifiuto che contiene
tutte le affermazioni che la persona rifiuta e l’area dell’indifferenza che contiene le
affermazioni nei confronti delle quali la persona è indifferente. Se la nuova informazione
ricade nell’area dell’accettazione o vicina ad essa l’informazione subirà un vero processo di
assimilazione e verrà percepita come più “accettabile” di quanto effettivamente e
oggettivamente non sia. Così le l’affermazione ricade nell’area dle rifiuto la forza di
rinnegare l’accettazione di quella informazione sarà maggiore di quanto effettivamente non
meriti, poiché l’informazione viene percepita maggiormente distante dai propri punti di vista.
Questa distorsione percettiva assume un ruolo importante nella valutazione dei messaggi
finalizzato al cambiamento degli atteggiamenti. Il rischio che il messaggio ricada nell’area
del rifiuto è quello di incrementare una posizione di oppositiva nei confronti dell’oggetto o
prodotto del messaggio promozionale più di quanto effettivamente non sia lecito pensare. In
questo caso se la nuova affermazione è percepita come discrepante dall’atteggiamento
preesistente della persona il messaggio rischia di produrre un cambiamento di atteggiamento
nella direzione opposta a quella sostenuta dal messaggio determinando un vero e proprio
effetto boomerang (Mannetti, 2003). Questa interessante teoria deve però fare in conti con
due elementi importanti: la dimensione affettiva ed emotiva che sembra non essere
pienamente compresa nel modello e il ruolo del coinvolgimento del Sé. Il coinvolgimento del
Sé infatti ha un ruolo determinante nell’ampiezza delle aree per cui atteggiamenti
caratterizzati da un elevato coinvolgimento dell’Io hanno un’area di rifiuto più ampia ed
un’area dell’indifferenza più ridotta; così come il rischio di distorsioni maggiori per quelle
informazioni che ricadono nell’area dell’accettazione quando queste contribuiscono
significativamente a rafforzare l’atteggiamento preesistente ritenuto importante per
l’individuo. Malgrado questa teoria non sia stata supportata da dati significativi, è ritenuta
utile per avere posto l’attenzione a questa dimensione del coinvolgimento e del ruolo che
32
possono avere le influenze sociali e le “appartenenze” nei processi di persuasione e
nell’elaborazione delle informazioni.
Le definizioni di atteggiamento
L’atteggiamento sembra essere una forma di predisposizione, determinata da esperienze
dirette o semplicemente da influenze da parte di altri, verso una classe di stimoli
caratterizzata dalla possibilità di rispondere a questa con una specifica classe di risposte.
Sotto la spinta dello sviluppo della psicologia cognitiva che si affermò negli anni Sessanta il
concetto di atteggiamento venne considerato prevalentemente come costituito dalla
dimensione cognitiva ovvero dalle credenze. In quest’accezione l’atteggiamento sembra
essere una forma di riassunto delle credenze che una persona possiede riguardo ad un certo
oggetto. Il termine credenza designa in questo caso l’informazione che una persona ha a
proposito di altre persone, oggetti e questioni. La centralità delle credenze è alla base del
modello di Fishbein e Ajzen (1975) che spiega in termini cognitivi la formazione delle
valutazioni che ritroviamo negli atteggiamenti. In questo caso l’atteggiamento è la risultante
delle convinzioni personali ovvero la probabilità con cui un individuo si aspetta che una data
informazione sia vera; e i valori che sono determinati da tutto ciò che una società considera
buono o cattivo. Questa relazione è stata espressa dalla teoria aspettativa-valore secondo cui
gli atteggiamenti sono una funzione della somma delle credenze verso un oggetto, dove
ciascuna credenza è considerata come costituita dall’aspettativa in termini di probabilità che
l’oggetto possieda una determinata caratteristica (per esempio che il politico che vogliamo
eleggere sia onesto, competente, e sincero) moltiplicata per il valore che la persona stessa
attribuisce a quelle caratteristiche e in che misura le ritiene positive o negative. Per prevedere
l’atteggiamento è necessario in questo caso moltiplicare ciascuna aspettativa relativa ad una
caratteristica dell’oggetto per il valore ad essa attribuito e sommare questi prodotti (Mannetti,
2002). Come è possibile intuire questo modo di intendere gli atteggiamenti rientrano
perfettamente nella logica razionalistica con cui è stato studiato l’individuo nell’età moderna.
Il modello prevede infatti di potere misurare concretamente il grado di positività o negatività
verso un particolare oggetto secondo un modello tipicamente razionalistico. Vedremo che tale
modo di intendere gli atteggiamenti è alla base di studi e riflessioni che ne sottolineano i
rischi e le limitatezze.
Secondo il modello tripartito di Rosemberg e Hovland (1960) l’atteggiamento è stato studiato
come formato da tre diverse componenti, interagenti tra di loro: la componente cognitiva,
quella affettiva e quella conativa ( comportamentale).
emozione
Stimoli
Atteggiamenti
Risposte del sistema nervoso simpatico,
Dichiarazioni verbali delle emozioni
cognizione
Risposte percettive. Dichiarazioni verbali
di opinioni
comportamento
Azioni manifeste. Dichiarazioni verbali
riguardanti il comportamento
33
La componente cognitiva è costituita dall’insieme di credenze, pensieri, opinioni ed idee nei
confronti di un particolare oggetto. Queste credenze possono avere diversi gradi di positività
o negatività. La componente affettiva comprende i sentimenti e le emozioni che si provano
verso un particolare oggetto. Anche in questi elementi affettivi vi può essere un massimo di
positività o di negatività. Infine la componente comportamentale comprende tutti i
comportamenti espliciti nei confronti dell’oggetto e anche le intenzioni non ancora espressi in
azioni e comportamenti manifesti. Questa descrizione strutturale degli atteggiamenti che
prevede questa distinzione formale in tre componenti, anche se non ha avuto negli ultimi anni
un forte supporto empirico, è stata ritenuta utile per la capacità descrittiva di un concetto assai
complesso come l’atteggiamento. Inoltre è stata ritenutile utile come schema operativo che
spinge a considerare la valutazione dell’atteggiamento attraverso diversi caratteristici
elementi
(Mannetti, 2002). Le ricerche che hanno cercato di verificare la struttura
correlazionale delle componenti dell’atteggiamento hanno, tuttavia, prodotto risultati
contraddittori. Alcuni autori sono giunti alla conclusione che, allo stato attuale, non esistono
evidenze empiriche a supporto della teoria delle tre componenti poiché le analisi fattoriali
adottate in queste ricerche di verifica non hanno prodotto risultati significativi.
La visione multidimensionale proposta sottolineando la compresenza di diversi fattori nella
definizione dell’atteggiamento si differenzia dalla descrizione unidimensionale che vede
l’atteggiamento esclusivamente come sentimento positivo o negativo, generale e durevole nei
confronti di una certa persona, oggetto o argomento (Petty e Cacioppo, 1987). Secondo il
modello unidimensionale il concetto di atteggiamento deve essere distinto da quello di
credenza da un lato e dalle azioni e intenzioni dall’altro. In questo caso il termine
atteggiamento si riferisce alle emozioni connesse con l’oggetto di atteggiamento da
distinguere dalle credenze, dalle intenzioni e dai comportamenti manifesti. Queste quattro
distinzioni concettuali – credenze, atteggiamenti, intenzioni e comportamenti – sono state
racchiuse in un modello teorico che descrive il rapporto tra atteggiamenti e comportamento e
sviluppato da Fishbein e Ajzen (1975).
Il modello dell’azione ragionata di Fishbein e Ajzen rappresenta la concezione più illustre ed
aggiornata dei modelli descrittivi dell’atteggiamento definiti modelli aspettative – valore
secondo cui gli atteggiamenti sono funzione delle credenze, dell’aspettativa in termini di
probabilità che un oggetto, evento o persona possieda una determinata caratteristica
moltiplicata per il valore che la stessa persona attribuisce a quella specifica caratteristica:
Atteggiamento uguale a Somma delle Aspettative moltiplicata per il Valore ad esse attribuito.
Nelle sue prime formulazioni il modello detto anche multi-attributo è risultato
particolarmente utile per “misurare” l’atteggiamento verso un oggetto (un prodotto o una
marca per esempio). Il primo contributo sul questo versante fu dato da Fishbein (1967) che
permise la valutazione dei singoli attributi riconosciuto ad un oggetto o un prodotto
ponderando tale valutazione con l’importanza ad essi attribuiti e la probabilità che l’oggetto
in questione avesse quegli attributi. L’atteggiamento è il risultato dell’intensità della
convinzione che l’oggetto possieda particolari attributi per la valutazione di ogni singolo
attributo.
Per esempio proviamo a calcolare la probabilità che un elettore voti un particolare candidato.
Questa previsione secondo il modello di Fishbein può essere fatta analizzando la valutazione
34
e la stima relativa alla presenza assenza degli attributi di un prodotto e la loro valutazione: per
esempio se volessimo misurare l’atteggiamento verso un nuovo PC, si procede
all’individuazione degli attributi che caratterizzano un Computer; la velocità, il prezzo,
l’assistenza, l’inaffidabilità della macchina; successivamente si procede alla stima di ciascun
attributi in termini di importanza per l’acquirente e in termini di probabilità che quel
particolare prodotto abbia quegli attributi al fine di sommare i prodotti relativi alle singole
aspettative per avere il punteggio dell’atteggiamento complessivo:
• Aspettativa 1 (l’intervistato è sicuro al 90% che il PC sia veloce) x valutazione 1
(valuta la velocità in modo molto positivo su una scala da –10 a + 10 =9)
• Aspettativa 2 (l’intervistato è sicuro al 50% che il PC abbia un prezzo accessibile) x
valutazione 2(valuta il prezzo in modo positivo su una scala da –10 a + 10 =6)
• Aspettativa 3 (l’intervistato è sicuro al 30% che A abbia una buona assistenza) x
valutazione 3(valuta l’assistenza in modo positivo su una scala da –10 a + 10 =4)
Aspettativa 4 (l’intervistato è sicuro al 90% che il PC ha una elevata inaffidabilità
della macchina) x valutazione 4(valuta l’inaffidabilità in modo molto negativa su una
scala da –10 a + 10 = -9).
In questo caso l’atteggiamento verso il PC èquivale alla somma dei prodotti delle singole
aspettative e delle valutazioni. Il modello multi attributo ha il vantaggio di indicare quali
attributi siano importanti per il consumatore nel determinare l’atteggiamento verso l’oggetto
al fine di fornire una base per determinare il posizionamento nel mercato o individuare gli
attributi su cui fare affidamento per una campagna promozionale.
•
Così se volessimo migliorare l’atteggiamento verso il nuovo PC da questo tipo di analisi
potrebbe risultare che le possibili aree di intervento sono:
• progettare specifiche comunicazioni persuasive volte ad aumentare il grado di
sicurezza con la quale si ritiene che il prodotto in questione possieda gli attributi
valutati più positivamente;
• progettare messaggi che contengano informazioni che accrescono la sicurezza delle
aspettative circa attributi positivi, riducendo quella relativa ad attributi ritenuti
negativi;
• promuovere comunicazioni persuasive volte a ridurre il grado di sicurezza con la
quale si ritiene che il prodotto possieda l’unico attributo valutato negativamente;
• progettare messaggi che contengano riferimenti agli attributi ritenuti salienti
(identificati preventivamente)
Tuttavia è bene sottolineare che i problemi che caratterizzano questa tecnica sono relativi, da
una lato, alla possibilità di scegliere tutti gli attributi realmente importanti per i consumatori e
dall’altro al modo in cui gli intervistati interpretarono i criteri di importanza nella tecnica di
misurazione impiegata nella parte valutativa dell’indagine. Un altro aspetto critico è che il
modello presuppone che esista una correlazione positiva tra atteggiamento e comportamento:
se il consumatore valuta positivamente un prodotto allora manifesterà una determinata
intenzione d’acquisto ad essa coerente. In pratica ci si attende che i consumatori acquistino i
prodotti e le marche valutate meglio. Di fatto in questo tipo di analisi il rischio è quello di
35
valutare l’atteggiamento nella sua astrattezza e non il comportamento che è sempre
contestualizzato. In effetti questo modello ci permette di avere una prima valutazione
approssimativa per affrontare il problema del comportamento di acquisto.
Una soluzione per risolvere questo problema è stata proposta da Ajzen e Fishbein (1980). In
questa formulazione gli autori proposero di misurare l’atteggiamento verso il comportamento
(e non la misurazione dell’atteggiamento verso un prodotto, situazione, persona). Viene,
pertanto, valutato l’atteggiamento del consumatore nei confronti di uno specifico
comportamento relativo all’oggetto, analizzando la relazione tra comportamento e le
conseguenze del comportamento, secondo quanto indicato dai principi della psicologia
comportamentale.
Ciò comporta lo spostamento dell’attenzione del ricercatore dalla valutazione delle
caratteristiche dei prodotti e delle situazioni alla valutazione delle conseguenze pratiche dei
comportamenti e al valore attribuito al comportamento in sé. Resta, comunque, il limite di un
modello basato sui resoconti e sulle opinioni degli intervistati, ed ancora un modello che
rischia di proporre un’analisi degli atteggiamenti decontestualizzata ed astratta.
Un ulteriore passo è stato fatto con lo sviluppo della teoria dell’azione ragionata di Fishbein
e Ajzen (1975), nello specifico, focalizza l’attenzione su tre componenti principali:
l’atteggiamento dell’individuo, l’influenza dei gruppi di riferimento e la maggiore o minor
propensione del soggetto a permettere che le influenze esterne incidano sulle proprie scelte.
Queste tre aspetti e la loro valutazione sottolineano la centralità della dimensione razionale e
delle credenze nella formazione delle valutazione che caratterizzano un atteggiamento.
Secondo Fishbein e Ajzen oltre alla valutazione delle credenze relative agli attributi di un
particolare oggetto o evento e alla probabilità percepita che quel particolare evento o oggetto
abbia realmente quegli attributi, per riuscire a valutare il grado di coerenza tra atteggiamento
e comportamento è necessario considerare e valutare la dimensione sociale, l’influenza del
contesto e del gruppo di appartenenza sulle valutazioni del soggetto.
Sapere che un particolare oggetto, persona o evento ha alcuni attributi con una certa
probabilità non permette di valutare quanto importante sia manifestare un comportamento
coerente con tale atteggiamento se non si valuta come questo venga percepito dal gruppo e
dal contesto sociale cui si appartiene. Per esempio la valutazione positiva dei dispositivi di
protezione individuale (i famosi DPI: caschi, lenti protettive, maschere antipolvere, guanti,
ecc.) che la normativa sulla sicurezza sul lavoro 626 del 1994 e del loro grado di utilità per la
salvaguardia della salute non sembra essere un elemento forte nel determinare i
comportamenti di sicurezza e ridurre quelli di rischio. Se nello stesso contesto lavorativo il
comportamento degli altri, le abitudini, le regole sociali condivise non “prevedono” l’utilizzo
dei sistemi di sicurezza come i DPI molto probabilmente gli individui non adotteranno l’sudo
dei dispositivi di protezione se non in caso della presenza di ispettori o capi reparto.
Soprattutto se l’appartenenza al gruppo dio lavoro è ritenuta dall’individuo un aspetto
importante per la propria autostima e per la buona e sana convivenza sociale in quel posto di
lavoro. Questo è un problema particolarmente sentito in quei contesti lavorativi dove la
sicurezza sul lavoro e le regole che essa prevede vengono viste più come un imposizione
normativa o della direzione. Il campo della sicurezza sul posto di lavoro infatti è ritenuto da
molti lavoratori come un’area in cui è possibile, in maniera consapevole o inconsapevole,
agire le conflittualità con la direzione stessa. In altri contesti, l’uso dei dispositivi può essere
36
percepito come un segnale di mancanza di virilità o di inesperienza (quante volte i lavoratori
infortunati sono proprio quelli con maggiore esperienza o coloro che volevano mostrare a sé e
agli altri di essere invulnerabili, o più abili di coloro che suggeriscono di utilizzare i
dispositivi di protezione individuale?). Fishbein e Ajzen hanno introdotto le “norme sociali”
rappresentate dagli altri significativi che suggeriscono quali siano i comportamenti più
corretti e quelli accettati in una particolare situazione e contesto sociale. ecco quindi che
accanto alla valutazione della presenza di particolari attributi e il valore ad essi dato questo
modello integra una nuove complessa dimensione che è quella della motivazione
all’adattamento e che si riferisce alla maggiore o minore propensione dell’individuo ad
adattarsi alle aspettative dei gruppi di riferimento.
Secondo questo modello le singole persone possono, inoltre, essere viste come più o meno
propense o condizionate dalle altrui aspettative, distinguendo in questo caso tra soggetti ad
alta sensibilità normativa (soggetti molto attenti ed influenzati dalle aspettative altrui) e
soggetti a bassa sensibilità normativa (soggetti poco influenzati dalle aspettative altrui).
L’intenzione di agire un particolare comportamento è strettamente influenzato dalla
valutazione soggettiva e dalla dimensione sociale. L’analisi delle intenzione secondo questo
processo permetterebbe una migliore comprensione del comportamento dell’individuo e
garantirebbe, secondo Fishbein e Ajzen (1975), sia una maggiore rilevanza del concetto di
atteggiamento in psicologia sociale che la “razionalità” delle condotte umane (Mantovani,
2003). La Theory of Reasoned Action ha dato prova di certo potere predittivo a condizione
che il comportamento sia sotto il controllo volitivo, cioè rientri nella sfera delle azioni
possibili praticamente e concretamente, azioni nelle quali il soggetto ha margini di
manovra. L’applicabilità del modello sembra valere solo esclusivamente per quei
comportamenti che possono ritenersi ragionevolmente intenzionali. Come tutti sappiamo
bene, però, nella nostra vita quotidiana la maggior parte delle nostre intenzioni sono tanto
immediate da non essere paragonabili ad un processo lento e consapevole né tanto meno
fondato un attenta analisi dei costi e benefici. Molte volte (ma non sempre) di fronte alle
situazioni della vita quotidiana la dimensione emozionale sembra essere quella predominante
nel guidare il nostro comportamento: ci lasciamo trasportare dall’emozione connessa ad un
37
oggetto, prodotto o persona per poi razionalizzare tutto ciò che ci è successo. Il significato
affettivo che hanno le cose per noi è alla base delle nostre azioni, diventando poi la base per
una spiegazione razionale e consapevole di ciò che abbiamo fatto.
Il modello dell’azione ragionata, come dice il termine stesso, era anch’esso figlio del suo
tempo: proponeva un’idea di uomo quasi esclusivamente razionale, caratterizzato da processi
decisionali coscienti e razionali, come la tradizionale visione dell’uomo promossa dai teorici
dello Human Information Processing.
Questo modello infatti non teneva in considerazione che buona parte delle nostre decisione
sono guidate dall’emotività, dagli stati d’animo, dagli umori, anzi questi aspetti sembrano
influenzare in maniera determinante tutto il processo di significazione della realtà circostante,
promuovendone una valutazione ex post da parte dei processi razionali. Almeno per quel che
riguarda alcuni processi decisionali. Questi, a volte, non sono il risultato di processi consci
ma aggiustamenti automatici alle situazioni in cui le persone si trovano (Mantovani, 2003).
A questa critica lo stesso Ajzen nel 1988 rispose inserendo all’interno del suo modello una
terza dimensione capace di influenzare strettamente l’intenzione ad agire un particolare
comportamento: la percezione del controllo. Secondo Ajzen (1988) anche una persona
motivata può non agire se percepisce scarso controllo sui fattori ambientali esterni e sulle sue
capacità di azione. Quando lo sforzo connesso all’acquisto risulta oltre la portata percepita, il
cliente evita di agire seppure tentato dalle promesse di risultato che l’acquisto può produrre.
Ad esempio, posso essere molto tentato da una proposta di partecipare ad un corso di
formazione informatica, ma pensare che “tanto non ce la farò mai ad usare il computer”, mi
spinge a non iniziare l’azione. Questa condizione crea la paradossale situazione della profezia
che si autoavvera, di cui abbiamo già parlato. Per superare le limitazioni della teoria
dell’azione ragionata, Ajzen ha proposto una revisione al primo modello: la Theory of
Planned Behavior), o teoria del comportamento pianificato. Il modello è stato sviluppato
per prevedere i comportamenti nei quali il soggetto non dispone del completo controllo
volitivo, perché qualche barriera interna od esterna influenza l’azione stessa.
La maggiore differenza tra il primo modello e questo del comportamento pianificato è
l’addizione della variabile “controllo comportamentale percepito” ovvero il risultato di
quanto vengono visti difficili i comportamenti, in termini di attuazione pratica (Control
Beliefs) e la percezione del grado di successo che l’individuo sente di avere,sull’attuazione
del comportamento (Perceived Power ).
38
Anche con questa modifica il comportamento umano e il suo rapporto con il concetto di
atteggiamento richiama l’attenzione su un processo di pianificazione razionale e cognitiva
delle azioni dell’individuo. La percezione del controllo della situazione certamente introduce
una maggiore attenzione alla dimensione emotiva, ma di certo non limita la funzione
cognitiva di predisposizione di piani di piani di azione in cui la dimensione della cognizione
aveva sempre un ruolo determinante. Questa concezione dei piani, di fatto, è stata messa in
discussione poiché la quotidianità è spesso caratterizzata da imprevedibilità difficilmente
inquadrabile all’interno di schemi ed algoritmi che non fanno altro che misurare e prevedere
ciò che noi “riteniamo” sia misurabile e prevedibile. Gli stessi programmi dei computer si
rilevarono imprecisi ed inaffidabili soprattutto di fronte alla complessità ed imprevedibilità
della realtà e della quotidianità. Tale sfiducia verso i programmi e gli schemi interpretativi
che la scienza cognitiva aveva prodotto fino agli anni Ottanta ha contribuito
significativamente allo spostamento dell’attenzione degli studiosi sui processi di
significazione che ogni singolo individuo o gruppo adotta per dare senso alla quotidianità e
all’analisi del ruolo adattivo che ha l’azione nei confronti di un ambiente imprevedibile.
(Clancey, 1997; Suchman, 1987; Mantovani, 2003). D’altra parte in società postmoderna
sempre più capace di riconoscere la multidimensionalità dell’identità, di accettare le
incoerenze e le contraddizioni che un mondo complesso comporta, capace di vedere e
prevedere l’ordine nel disordine e il disordine nell’ordine, pensare di potere definire gli
atteggiamenti come elementi stabili nel tempo e nello spazio senza una loro
contestualizzazione e un’analisi del loro valore adattivo (e quindi individualmente cangiante)
rischia di spingerci a studiare l’individuo secondo i principi paradigmatici del positivismo e
secondo un modello di analisi fondato sulla razionalità e sulla prevedibilità certamente
rassicurante, ma limitativo nella sua capacità esplicativa.
39
Riferimenti bibliografici
Adorno, T. W., Frenkler-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford R.N., (1950). The autoritarian
personality Harper & Row: New York (trad. it. La personalità autoritaria, Edizioni di
Comunità, Milano, 1977).
Anderson N.H., (1978). “Cognitive algebra: integration theory applied to social attribution” in L.
Berkowitz (Eds.) Cognitive theories in social psychology. Academic Press: New York.
Allport G., (1935). “Attitude”. In C.M. Murchison, Handbook of social psychology. Clarck University
Press: Worchester.
Ajzen I., (1988). „Nature and Operation attidute“. In Annual Review of Psychology, 52, 27 – 58.
Ajzen I., Fishbein M, (1980). Undestanding attitudes and social behaviors, Englewood Cliffs: Prentice
Hall.
Ash S.E., (1946). „Forming impression of personality“. In Journal of Abnormal and Social Psychology
41, 258 – 290.
Aspinwall L.G., Brunhart S.M., (1996). “Distinguishing optimism from denial: Optimistic beliefs
predict attention to health threat”. In Personality and social psychology Bulletin 22, 993 –
1003.
Benjafield J.G., (1995). Psicologia dei processi cognitivi. Il Mulino: Bologna.
Berkowitz L., Knurek D. (1969). “Label-mediated hostility generation”. In Journal of Personality and
Social Psychology, 13 pp. 200- 206.
Broadbent D., (1958). Perception and communication. Pergamon: London.
Bruner J., (1992). La ricerca del significato. Bollati Boringhieri: Torino
Bruner J., (1983). In search of mind. Essay in autobiogrphy. Harper & Row: New York.
Deutsch J.A., Deutsch D., (1963). “Attention, some theoretical consideration”. In Psychological
Review, 70, pp 80 – 90.
Di Fabio A., (1999). Counseling. Dalla teoria all’applicazione. Giunti: Firenze
Di Fabio A. (2003). Counseling e relazione di aiuto. Giunti: Firenze
Duncan B.L., (1976). “Differential social perception and attribution of intergroup violence: testing the
lower limits of stereotyping of blacks”. Journal of Personality and Social Psychology 34, 590
– 598.
Canestrari R., (1984). Psicologia generale e dello sviluppo. Clueb: Bologna
Carlson N.R., (1987). Psicologia. La scienza del comportamento. Bologna: Zanichelli.
Clancey W.J. (1997). Situated Cognition, Cambridge University Press: Cambridge.
Chapanis A., (1972). New approaches to safety in industry. London: InComTec.
Chapanis A., (1959) Research techniques in Human Engineering. Baltimore: Johns Hopkins Press;
(trad. it. L’ergonomia. Milano: Franco Angeli, 1970).
Codispoti M., (2002). “Indici biologici come sonda dei processi cognitivi”. In A.M. Borghi e T. Inchini
(a cura di) Scienze della Mente. Il Mulino: Bologna.
Contarello A., Mazzara B.M., (2002). Le dimensioni sociali dei processi psicologici. Editori Laterza:
Roma
Corteen R.S., Wood B., (1972). “Autonomic response shock associated words in an unattended
channel”. In Journal of Experimental Psychology, 94 pp. 308 – 313.
Fabris G.P. (2009) Societing. Franco Angeli Milano
Fazio R.H. (1986). “How do attitudes guide behaviors?” In R.M. Sorrentino, E.T. Higgins (eds.)
Handbook of motivation and cognition: fundation of social behavior. Guilford Press: New
York.
Fishbein M. (1967). “Attitude and Prediction of behavior”, in M. Fishein Attitude theory and
measurement, Wiley: New York.
40
Fishbein M., Ajzen I., (1975). “Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and
research”. Reading, Mass: Addison- Wesley.
Frey D. (1986). “Recent research on selective exposure to information”. In L. Berkowitz (ed.)
Advances in experimental social psichology (vo.19) Academic Press: Orlando.
Gabassi P.G., (1995). Psicologia, Lavoro, Organizzazione. Franco Angeli: Milano.
Gergen, K.J., (l982). Toward transformation in social knowledge. New York: Springer-Verlag. Second
edition (1991) London: Sage.
Gergen, K.J., (l994). Reality and relationships, soundings in social construction. Cambridge: Harvard
University Press.
Gergen, K.J. Gergen, M.M., (1988). „Narrative and the self as relationship”. In L. Berkowitz (Ed.)
Advances in experimental social psychology, V. 21, New York: Academic Press, pp. 17-56
Gollin E., (1954). “Forming impressions of personalità” in Journal of Personality, 23, pp. 65 – 77.
Hall E. T., (1968). LA dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le
persone. Bompiani: Milano.
Heider F. (1946). “Attitude and cognitive organizations”. In Journal of Psychology, 21. pp. 519 – 529.
Heider F. (1958). The psychology of interpersonal relation. Wiley: New York. (trad. Itt. Psicologia
delle relazioni interpersonali. IL Mulino: Bologna).
Heinrich H.W., (1959). Industrial accident prevention. A scientific approach. McGraw Hill: New York
Hewstone M., Stroebe W., Codol J.P., Stephenson G. (1988). Introduction to social psicology. A
european perspective. Basil Balckwell: Oxford (Trad. It. Introduzione alla psicologia sociale,
Il Mulino, Bologna, 1991).
Hillyard S.A., Hink R.F., Schwent V.L., Picton T.W. (1973). “Electrical signs of selective attention in
the human brain”. In Science, 182 pp 177 – 180.
Hillyard S.A, Mangun G.R, Woldoroff M.G., Luck S.J., (1995). “Neural system mediating selective
attention”. In The Cognitive Neurosciences, a cura di Gazzaniga, Cambridge, Mass MTI
Press, pp 665 – 681.
Hovland C.I., Janis I.L., Kelley H.H. (1953). Communicationa and persuasion: Psychological studies
of opinion change. Yale University Press: New Haven.
Hui M.K., Dube L., Chebat J.C., (1997). “The impact of music on consumers reactions to waiting for
services”. In Journal of Retailing, 15 May pp 250 – 260.
Husband R.W., Godfrey J., (1934). “An experimental Study of Cigarette Identification”, in Journal of
Application Psychology, 18.
Ip G.W.M., Bond M.H. (1995). “Culture, value and self-concept” in Asia Journal of Psychology, 1, pp.
29 – 35.
Jones E.E., Nisbett R.E., (1971). The actor and the observer. Divergent perceptions of the cause of
bahavior. Silver Burdett General Learning Press: Morristown N.J.
Jones E. E., Davis K.E., (1965). “From acts to dispositions : the attribution process in person
perception”. In L. Berkowitz (Ed.) Advances in experimental Social Psychology, (vol.2
Academc Press: New York.
Katz D., (1967). “The functional approach to the study of attitude”. In M. Fishbein (ed.) Reading in
attititude theory and measurement. Wiley: New York.
Kelley H.H., (1973). “The processes of causal attribution” in American Psychologist, 28, pp 107 – 128.
Kelley H.H., Michela S.L., (1980). “Attribution Theory and research”. In Annual Review of
Psychology, 31, 457 – 502.
La Piere R.T:. (1934). “Attitude vs actions” in Social Forces, 13, pp. 230-237.
Lewin K., (1935). A dynamic theory of personality. McGraw & Hill: New York.
Likert K., (1932). “A technique for the measurement of attitudes”. Archivies of Pyschology, 41, 5 -53.
41
Mayo E. (1945). The social problems of an Industrial Civilization. Harward Business School, Boston
(trad. It. I problemi umani e sociopolitici della civiltà industriale. Utet: Torino, 1969).
Mantovani G., (2003). Manuale di psicologia sociale. Giunti: Firenze
MAzzara B.M. (2008). I discorsi dei media e la psicologia sociale. Carocci Editore: Roma
Mead G.H. (1934). Mind, self and society. University of Chicago Press: Chicago (trad. It. Mente, sè e
società, Giunti Barbera: Firenze, 1972).
Mecacci L., (1999). Psicologia moderna e postmoderna: Editori Laterza:Roma-Bari.
Miller N., Campbell D. (1959). “Recency and primacy in persuasion as a function of timing of
speeches and measurement” in Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 1- 9.
Milliman R.E., (1982). “Using background music to affect the behaviour of supermarket shoppers”. In
Journal of Marketing, 46, Summer pp. 86 – 91.
Moore W.L. Lehmann D.R., (1986). “Time compression, response opportunity and persuasion”. In
Journal of Consumer Research, 13 June pp. 85 – 99.
Mucchielli R., (1987). Apprendere il counseling. Ericson: Trieste.
Nisbett R.E., Ross L. (1980). Human inference: Strategies and shortcomings of social judgments.
Olivero N. Russo V. (2009). Manuale di Psicologia dei Consumi. McGraw-Hill Milano.
Pavlov J.P. (1927). Condizioned reflexes, Oxford University Press: London (trd.it. I riflessi
condizionati, Boringhieri, Torino, 1966).
Prentice – Hall Englewood Cliffs, N.J.
Petersen D., (1996). Human error reduction and safety management. New York: van Nostrnd
Reinhold.
Reason J., (1990). L’errore umano. Milano: il Mulino.
Rogers R.W. Prectice-Dunn S., (1998). “Protection motivation theory”. In D. Gochman (a cura di)
Handobook of health behavior research. Plenum. New York, 113 – 132.
Rosemberg M.J., Hovland C.I., (1960). “Cognitive, affective and behavioral components of attitudes”.
In C. I. Hovland and M. J. Rosemberg, Attitude Organization and Change. Yale University
Press: New Haven.
Ross, L. (1977). “The intuitive psychologist and his shortcomings: distorsion in attribution process” in
L. Berkowitz (Eds.) Advances in experimental social psychology. Academic Press: New York.
Ross L.D., Greene P., House D., (1977)”The false consensus phenomenon: an attributional bias on selperception and social perception processes” Journal of Experimental Social Psychology , 32, 880 –
892.
Russo V. (2003). “La formazione degli operatori telefonici” in Rapporto Nazionale sulla Condisione
dell’Infanzia e dell’Adolescanza. Telefono Azzurro Eurispes, Roma
Russo V. (2004). “il ruolo attivo dell’individuo nella costruzione della realtà” in Massimo Bellotto e
Vincenzo Russo. Psicologia Sociale. McGraw-Hill. Milano.
Rotter J.B. (1966). “Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement” in
L. Berkowitz (eds.) Cognitive theories in social psychology. Academic Press: New York.
Schein E., (1992). Lezioni di consulenza. Raffaello Cortina: Milano
Schlenker B.R., Miller R.S., (1977). “Egocentrism in group: self-serving biases or logical information
processing?” in Journal of Personality and Social Psychology, 35, 755- 764.
Schmitt B., Simonson A., (1997). Marketing aesthetic. The strategy management of brands, identity
and image. The free Press: NY.
Schwarz N. (1999). “Self reports: how the questions shape the answers“ in American Psychologist, 54,
(2), 93 -115.
Schwarz N., Hippler H.J., Deutsch B., Strack F. (1985). “Response categories: effects on behavioral
reports and comparative judgments”in Pubblic Opinion Quaterly, 49, 388-395.
Sherif M., Hovland C.J. (1961). Social judgment. Yale University Press. New Heaven
42
Simon H., (1990) The new science on management decision. Harper & Row: New York
SIRI, G. (2001), La psiche del consumo. Milano: Franco Angeli.
SIRI, G. (2004), La psicolgiia dle consumatore, McGraw-Hill: Milano
SIRI, G. (1996), IO e Sè Utet, Torino
SIRI ,G. (1995). Sogni e Bisogni. Milano: Lupetti.
Spangenberg E. R., Crowley A.E., Henderson P.W. (1996). “Improving in the store environment: do
olfactory cues affect evaluations and behaviors?”. In Journal of Marketing, 60 April pp 67 –
80.
Spearman C., (1927). The ability of man. London: Macmillan.
Staats A.W., Staats C.K. (1958) “Attitudes established by classical conditioning” in Journal of
Abnormal and Social Psychology, 57, pp. 37- 40.
Suchman L. (1987). Thinking about anwers: the application of cognitive process to survey
methodology. Jossy Bas: San Francisco.
Taylor F.W. (1911). The principles of Scientific Management. Harper & Brothers: New York (trad. It.
L’organizzazione scientifica del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1975).
Tajfel H. Turner J.C. (1979). “An integrative theory of intergroup conflict”in G; Austin, S, Worchel
(eds.) The social psichology of intergroup relations. Brooks\Cole: Montenery.
Thomas W.I., Znaniecki F., (1918). The Polish peasant in Europe and America. University of Chicago
Press: Chigago.
Thurstone L.L., (1928). “Attitudes can be measured”. American Journal of Sociology 33, 529-554.
Thurstone L.L., (1931) “The measurement of attitudes”. Journal of abnormal and social psychology,
26, 249-269.
Turner J.C. (1987). Rediscovering the social group: a self-categorization theory. Blackwell: Oxford.
Werner H., (1970). Psicologia comparata dello sviluppo mentale. Giunti Barbera: Firenze
Weiner B., Russell D., Lerman D., (1979). The cognition-emotion process in achievement-related
context”, in Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1211 – 1229.
Williams K.C., (1988). Psicologia per il marketing. Il Mulino: Bologna.
Witte K. (1998). “Fear as motivator fear as inhibitor”. In P.A. Andersen e L.K. Guerro (Eds),
Handbook of communication and emotion, Academic, SanDiego 423 - 450
Woldorff M.G., Hackley S.A. e Hillyard S.A. (1991). “The effects of channel-selective attention on the
mismatch negativity wave elicited by deviant tones”. In Psychophysiology, 2 pp 30 – 42.
Zajonc R.B. (1968). “Attitudinal effects of mere exposure” In Journal of Personality and Social
Psychology, Monograph Supplement, 9 (2), 1-27
Zucher L.A., (1977). The mutable self. Sage: Beverly Hills, CA.
43