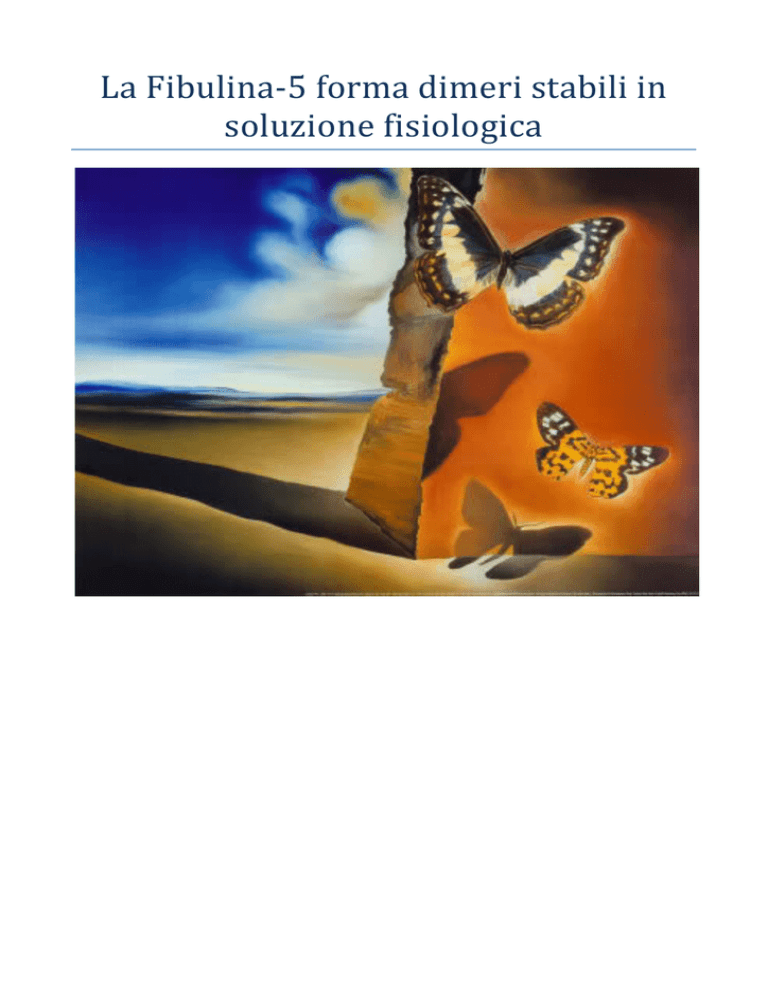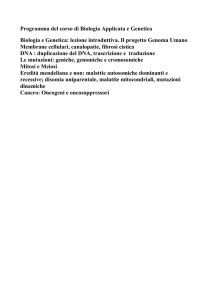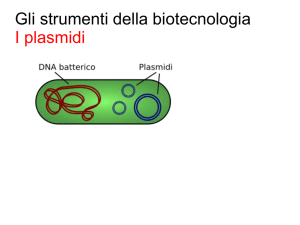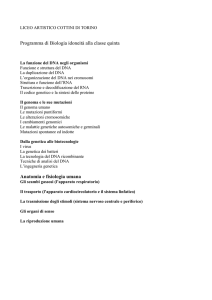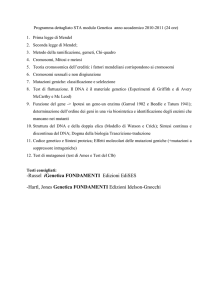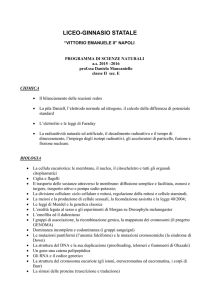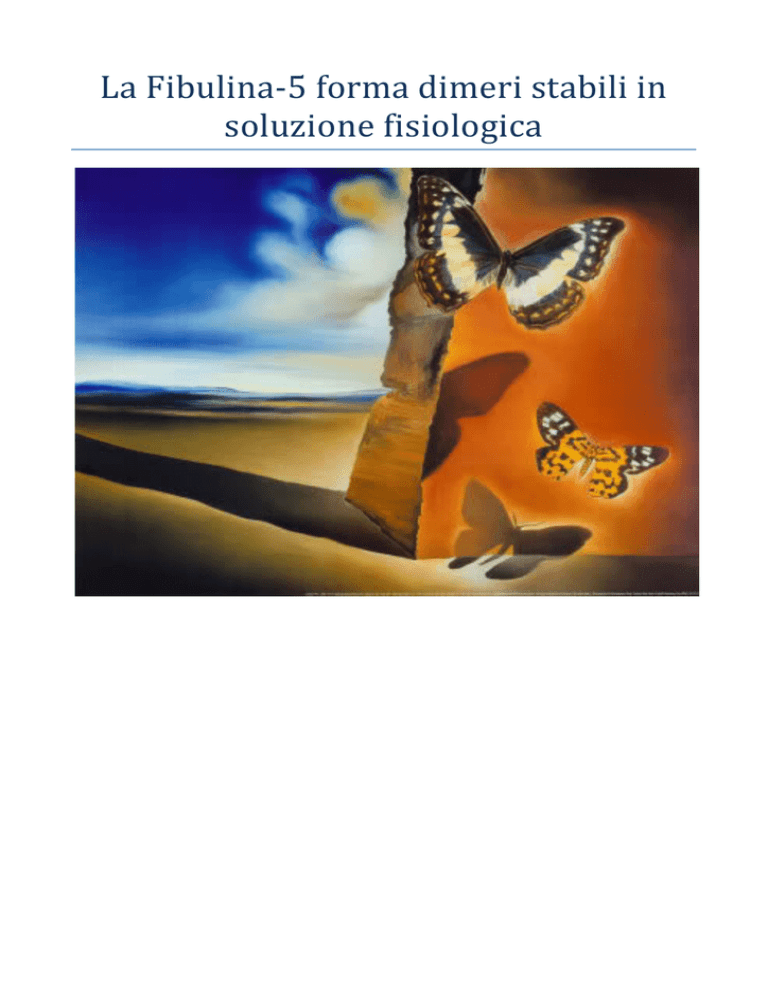
La Fibulina‐5 forma dimeri stabili in soluzione fisiologica PREMESSA Caro lettore L’onore e l’onere della conoscenza impone a noi tutti l’indagare su cosa effettivamente sia la
patologia, su quali siano i meccanismi e su come sia possibile risolvere un problema. Questa nostra
linea guida, ferrea, ci impone un abitus, un modus vivendi, del tutto peculiare, facendo della
conoscenza il nostro cibo, e dello spirito critico la nostra arma.
Con questo mio “logorroico” lavoro ho voluto discutere, semplicemente mettere per iscritto quale
sia il mio modo di vedere le cose e di intendere la ricerca. Forse, ai più, tutto ciò potrà sembrare una
perdita di tempo, un qualcosa di inutile. Ma invito tutti a guardare al di là dell’orizzonte.
Il lavoro da me svolto cerca di sottolineare la necessità di correlare qualunque studio alla pratica,
che molto spesso viene sottovalutata. La domanda che mi pongo frequentemente è: ma a cosa serve
tutto ciò? Perché bisognare conoscere?
Ebbene con questo mio scritto ho cercato di collegare tutte le mie conoscenze e di capirne l’utilità.
Non è tanto l’esame che mi spaventa quanto la mia ignoranza, ogni qualvolta che affronto un
argomento. Nell’iniziare questo lavoro, mi sono reso conto delle numerose pecche della mia
conoscenza. Ho cercato di incanalare questa mia voglia di conoscere e umilmente chiedo scusa se vi
annoierò oppure dirò cose già dette, conosciute.
Il seguente testo si articola in più parti: si inizia con una breve relazione sulla matrice extra
cellulare, inquadrata anche sul piano patologico; segue poi una seconda parte relativa al lavoro; una
terza parte inquadra le metodiche e i risultati ottenuti; infine verranno prese in considerazione
alcune patologie per marcare lo stretto legame tra la patologia e l’eventuale risoluzione di un
problema, sempre pertinenti al contesto. Non mancheranno alcuni richiami a nozioni o cencetti.
Chiedo scusa se saranno presenti dei paragrafi in inglese, ma la mancanza di tempo mi ha impedito
di tradurli.
Forse tutto quello scritto qui potrebbe, domani, già essere completamente smentito oppure no. Forse
il mio è solo un sogno. Tuttavia questo non mi impedirà mai di pensare, di dire o di fare.
Questa è la potenza della conoscenza: il sognare che domani si supererà il confine dell’orizzonte.
Grazie a tutti.
Il vostro
Antonio Romanelli
PARTE I PREMESSA Prima di iniziare la mia discussione, terrei a fare una puntualizzazione.
Le fibuline sono glicoproteine della matrice extracellulare, che interagiscono con i “colossi”
proteici della matrice stessa, come collagene ed elastina. In patologia, si è potuto apprendere come
difetti congeniti od acquisiti possano portare all’instaurarsi di condizioni cliniche dall’esito anche
fatale. Superfluo citare le collagenopatie (sindromi di Ehlers-Danlos, scorbuto) e elastinopatie.
Tuttavia, spesso, si sottovaluta il ruolo di quei piccoli componenti della ECM nel mediare un
corretto assemblaggio di componenti dall’elevato peso molecolare. Ma la loro piccola mole non
rende giustizia a questi infaticabili “operai”. Tuttavia, non mancano casi si gravi patologie indotte
dalla deficienza o totale mancanza di glicoproteine della ECM. Valga per esempio il difetto della
fibrillina I nel ruolo della sindrome di Marfan. Quindi, bisogna sottolineare l’importanza di queste
piccole glicoproteine e comprendere come, alle volte, difetti di queste ultime possano portare ad una
patologia. Nel variegato contesto della ECM queste glicoproteine giocano un ruolo importante,
basilare. Forse non salta subito all’occhio, ma sono proprio queste glicoproteine ad organizzare
nello spazio la fitta rete di GAGs, collagene ed elastina. Con il mio lavoro spero di trasmettere
questo concetto.
Per farla breve, il tutto è una sorta di puzzle, dove alla fine, anche se manca un solo pezzo, il quadro
non sarà mai completo.
CHE COSA E’ LA MATRICE EXTRACELLULARE La ECM è quella parte di “tessuto” che si trova all’esterno della cellula. La ECM è, in particolare,
l’elemento distintivo del tessuto connettivo. È quindi facile capire come, alterazioni delle proteine
della ECM vadano a colpire quei distretti ricchi di tessuto connettivo (pareti delle grandi arterie,
derma, ossa, ecc…). Tra cellula e ECM non vi è un muro, ma un continuo scambio di informazioni
atte a mantenere un equilibrio. Risulterà evidente, allora, l’importanza di comprendere appieno i
meccanismi che presiedono alla sintesi e al funzionamenti dei vari componenti.
MA COME E’ FATTA LA ECM? La ECM è un composito, formata da una componente amorfa e una fibrillare. Per meglio
comprendere la formazione della ECM viene studiato il tessuto connettivo, in quanto è proprio in
tale tessuto che la presenza della ECM è palese. In primis, nella ECM individuiamo due
componenti: una componente amorfa e una fibrillare.
LA COMPONENTE AMORFA La componente amorfa è formata dai proteoglicani. Nei proteoglicani la componente saccaridica è
maggiore di quella proteica. I proteoglicani sono formati da una core-protein unita a GAGs. Alla
core-protein si uniscono i GAGs e più proteoglicani si uniscono ad una mastodontica molecola di
acido ialuronico tramite una link protein. Ricordiamo che l’acido ialuronico è l’unico GAGs non
solfonato. I GAGs conferiscono resistenza alle forze di compressione.
I GAGs sono etero polimeri disaccaridici. L’unità fondamentale è il disaccaride composto da un
amminozucchero e un monosaccaride acido. Il monosaccaride acido è ricco di gruppi carbossilici
e/o solfati, che legano ioni, facendo aumentare la concentrazione di questi ultimi nella ECM.
L’aumento della concentrazione di ioni aumenta il richiamo osmotico di acqua, conferendo turgore
al sistema. Inoltre i proteoglicani, sequestrando il calcio extracellulare giocano un ruolo importante
anche nella contrazione del muscolo miocardico.
Quindi i GAGs sono un po’ come una spugna, trattenendo acqua nella matrice, aspetto molto
importante nel mantenimento di un corretto flusso di metaboliti, nonché di segnali paracrini. È
inutile dire che i più moderni trattamenti di ringiovanimento della cute sono basati sull’iniezione
intradermica di acido ialuronico.
Concludendo, l’intera struttura amorfa raggiunge un peso molecolare davvero incredibile,
superando anche il milione di dalton.
SINTESI DEI GAGS I GAGs, che spesso sono legati a proteine formando proteoglicani, sono sintetizzati nell'apparto del
Golgi dove, in seguito a modifiche post-trascrizionali, le unità disaccaridiche vengono aggiunte ai
core proteici. Fa eccezione però l'acido ialuronico, che non essendo parte di proteoglicani ma
trovandosi libero, viene prodotto da enzimi presenti sulla superficie esterna della membrana
plasmatica direttamente in sede extracellulare.
Per la sintesi di ciascun GAG esistono appropriati enzimi, ed è chiaro che il deficit di uno solo di
tali enzimi potrà portare a patologia.
Alterazioni dei GAGs o mucopolisaccaridi portano a mucolisaccaridosi, un gruppo enorme di
patologie caratterizzate da ritardo mentale e difetti posturali.
LE MUCOPOLISACCARIDOSI Le mucopolisaccaridosi in campo medico, sono un gruppo di malattie metaboliche, dove ognuna di
esse è causata da deficit di enzimi specifici.
I sintomi e i segni clinici presentano disostosi multiple, ritardo di sviluppo, epatosplenomegalia,
deformità a livello scheletrico, bassa statura, dismorfismi facciali, opacità corneale, problemi
cardiaci.
Colpisce prevalentemente i maschi in età infantile, negli USA l'incidenza è di 1 su 25.000 bambini.
Esistono nove diverse tipologie di Mucopolisaccaridosi, ciascuna prende il nome dal medico che
per primo l'ha diagnosticata:
I.
Mucopolisaccaridosi I, che comprende:
o
Mucopolisaccaridosi I H, chiamata anche malattia di Hurler. Caratterizzata da deficit
di α-L-iduronidasi lisosomiale;
o
Mucopolisaccaridosi I S, riclassificazione della Mucopolisaccaridosi V, chiamata
anche malattia di Scheie, la forma più innocua fra le varie tipologie;
o
Mucopolisaccaridosi
I
HS,
chiamata
anche
malattia
di
Hurler-Scheie,
riclassificazione della Mucopolisaccaridosi VIII;
II.
III.
Mucopolisaccaridosi II, chiamata anche sindrome di Hunter;
Mucopolisaccaridosi III, chiamata anche sindrome di Sanfilippo, nelle varianti A, B, C e D.
Ha la caratteristica di coinvolgere il sistema nervoso durante la sua manifestazione;
IV.
Mucopolisaccaridosi IV, chiamata anche malattia di Morquio, nelle varianti A e B. Colpisce
la struttura scheletrica e altri parti del corpo dove si osservano varie anomalie, l'enzima in
questione è il N-acetilgalattosamina-6-solfato;
V.
VI.
Mucopolisaccaridosi V, riclassificata Mucopolisaccaridosi IS;
Mucopolisaccaridosi VI, chiamata anche malattia o sindrome di Maroteaux-Lamy, dove si
mostrano comunemente segni di patologie oculari;
VII.
Mucopolisaccaridosi VII, chiamata anche sindrome di Sly, essa si manifesta a causa di un
deficit di β-glucuronidasi. Di questa forma, fortunatamnte, non si conoscono casi in Italia;
VIII.
IX.
Mucopolisaccaridosi VIII, riclassificata Mucopolisaccaridosi IHS;
Mucopolisaccaridosi IX, chiamata anche deficit di ialuronidasi.
Per una corretta diagnosi occorre effettuare l'esame delle urine, insieme ad una radiografia per
valutare le anomalie dello scheletro ed una corretta anamnesi condotta dal medico. Le
mucopolisaccaridosi possono essere diagnosticate anche prima della nascita prelevando cellule
fetali dalla madre.
Al momento non c’è una cura definitiva. Si è visto qualche risultato su alcuni casi e in alcune forme
con il trapianto di midollo osseo che tuttavia non può essere definito un rimedio definitivo. Si
iniziano a vedere i risultati della ricerca con la terapia di sostituzione enzimatica o ERT (oggi per
l'MPS I, l'MPS VI e per l'MPS II, in un futuro prossimo per la MPS IV). Viene riposta molta fiducia
(i dati sono iniziali) nella somministrazione della genisteina. Si intravede qualche spiraglio nella
ricerca con la terapia enzimatica intratecale (per i pazienti con disturbi neurologici) e nella terapia
genica (MPS II e III). Il trattamento di scelta è la somministrazione di enzimi di cui risultano
deficitari, per riuscire a vivere dignitosamente.
La prognosi muta a seconda della tipologia.
COMPONENTE FIBRILLARE Nella ECM, la componente fibrillare è data dal collagene e dall’elastina.
COLLAGENE Il collagene può essere paragonato alle “funi di acciaio” della ECM, quindi permette di resistere alle
forze di trazione.
Il collagene (o collageno) è la principale proteina del tessuto connettivo negli animali. È la proteina
più abbondante nei mammiferi, rappresentando nell'uomo circa il 6% del peso corporeo.
Il collagene è una struttura rigida, rigidità conferita dalla presenza di idrossilisina e idrossiprolina.
La più stabile disposizione e riarrangiamento del collagene è quella della tripla elica proprio per la
presenza del tripeptide glicina-idrossilisina-idrossiprolina. L'unità strutturale del collagene è
rappresentata dal tropocollagene (o tropocollageno), proteina con una massa molecolare di circa
285 KDa formata da tre catene polipeptidiche con andamento sinistrorso che si associano a formare
una tripla elica destrorsa. Solitamente, per il collagene di tipo I, sono presenti due catene α1 ed una
catena α2. Tutte le unità di tropocollagene hanno la stessa lunghezza, la stessa ripetitività di
amminoacidi: (Gly-X-Y)n, che implica quindi la presenza della glicina ogni tre residui e dove X e Y
sono spesso la idrossilisina e l'idrossiprolina. I filamenti di tropocollagene sono tenuti insieme da
legami idrogeno. Questi legami sono possibili grazie alla presenza di glicine e dalle modifiche posttraduzionali di lisina e prolina. Entrambi questi due amminoacidi subiscono una ossidazione per
aggiunta di un gruppo ossidrile. La prolina è modificata a idrossiprolina dall'enzima Prolina
Idrossilasi, che inserisce il gruppo -OH in corrispondenza del secondo carbonio dell'anello; mentre
la lisina è modificata a idrossilisina dall'enzima Lisina Idrossilasi, che inserisce il gruppo -OH al
posto del gruppo amminico della catena laterale della lisina. Entrambi gli enzimi agiscono in
presenza del co-fattore acido ascorbico e del co-substrato α-chetoglutarato. Queste modifiche sono
necessarie per aumentare la possibilità di formazione dei legami idrogeno e per diminuire
l'ingombro sterico. Le tre unità strutturali assumono una forma simile ad un treccia.
La varie fibre sono legate da legami crociati tra due allisine o tra una lisina e un' allisina. La lisina è
convertita in allisina dall'enzima Lisina Ossidasi, che inserisce al posto del gruppo amminico della
catena laterale della lisina in corrispondenza dell'ultimo carbonio (carbonio δ) un gruppo aldeidico.
Quando avviene il legame crociato si verificherà una condensazione aldolica (sia la lisina che
l'allisina sono due aldeidi).
La biosintesi del collagene avviene ad opera di diversi tipi cellulari a seconda del tessuto (ad
esempio fibroblasti nel tessuto connettivo, osteoblasti nell’osso). Il processo inizia con la
trascrizione del gene o dei geni e la maturazione dell’mRNA. Sono presenti sequenze che
codificano per lunghi peptidi in eccesso rispetto alle molecole di collagene mature, quindi il
collagene nasce come procollagene, prodotto che possiede rispetto al collagene due telomeri, uno
N-terminale e uno C-terminale, che hanno struttura globulare. La traduzione avviene a livello dei
ribosomi a ridosso della parete del RER (reticolo endoplasmatico rugoso) e la catena nascente di
procollagene subisce rimozione del peptide segnale e idrossilazione di specifici residui di prolina e
lisina ad idrossiprolina e idrossilisina (ad opera di idrossilasi, con cofattore essenziale la vitamina
C), con la produzione di catene α di procollagene. Tre di queste catene si avvolgono a formare una
tripla elica, stabilizzata da legami idrogeno tra amminoacidi idrossilati (legami crociati). Questa
elica passa nell'apparato del Golgi dove viene completata la glicosilazione e da qui, attraverso
vescicole di secrezione la molecola viene secreta all’esterno. All’esterno della cellula la molecola
subisce l’azione di alcune procollagenepeptidasi, che tagliano i telomeri trasformando il
procollagene in tropocollagene. Le molecole di tropocollagene si dispongono in file parallele a
formare fibrille. Le fibrille infine possono disporsi in fasci ondulati o paralleli per formare fibre e le
fibre possono formare fasci di fibre.
Esistono numerosissimi tipi di collagene propriamente detto e diverse proteine che hanno struttura
polipeptidica largamente assimilabile al collagene. In letteratura sono stati finora descritti 28 tipi di
collagene.
Tra le patologie del collagene segnaliamo lo scorbuto (patologia acquisita) e le sindromi di EhlersDanlos.
SCORBUTO Lo scorbuto (scòrbuto) è una malattia dovuta a carenza di vitamina C. Questa vitamina è essenziale
per la formazione del collagene e aiuta a mantenere l’integrità del tessuto connettivo, del tessuto
osseo, della dentina dei denti; è indispensabile per la guarigione delle ferite e facilita quella delle
ustioni; facilita l’assorbimento del ferro. Il deficit nei bambini è dovuto a mancanza di supplementi
di vitamina C. Negli adulti è generalmente dovuto ad avversione per alcuni alimenti o a diete
inappropriate. La gravidanza, l’allattamento, l’ipertiroidismo, le malattie infiammatorie acute e
croniche, le operazioni chirurgiche, sono tutte condizioni che aumentano le richieste di vitamina C.
Lo scorbuto infantile compare abitualmente tra il 6° e il 12° mese di vita: il bambino è irritabile,
non ha appetito e non aumenta di peso, le estremità delle ossa lunghe (per esempio, femore) si
rigonfiano, e le gengive sanguinano facilmente: spesso sono presenti febbre, anemia e aumento
della frequenza cardiaca. Negli adulti lo scorbuto rimane latente per 3-12 mesi dopo l’insorgenza
del deficit di vitamina C, e si manifesta con emorragie gengivali e sottoungueali, apatia, irritabilità,
perdita di peso, dolori muscolari e articolari: le vecchie ferite cedono e le nuove stentano a guarire.
Per prevenire l’insorgenza dello scorbuto infantile si dovrebbe somministrare ogni giorno succo di
arancia non bollito, a partire dal primo mese di vita. La terapia dello scorbuto, sia del bambino sia
dell’adulto, si basa sulla somministrazione di vitamina C per via orale. Utili sono anche alimenti
come cavoli, broccoli, spinaci, fragole, limoni, cavolfiori, peperoni, ferro e magnesio.
SINDROME DI EHLERS­DANLOS La sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) raccorpa una serie di patologie ereditarie contraddistinte da
lassità dei legamenti e iperelasticità della cute. Tale sindrome, infatti, colpisce prevalentemente il
tessuto connettivo, con la presenza di un collagene mutato. Tuttavia, ciascun tipo differente ha
caratteristiche specifiche, che coinvolgono altri organi ed apparati. La prima descrizione clinica
dettagliata è attribuita a Tschernogobow nel 1892. Il nome fa riferimento a Edward Ehlers, un
dermatologo danese, e Henry Alexander Danlos, un fisico francese esperto in chimica e disordini
dei tessuti, che per primi stilarono un elenco delle caratteristiche tipiche, e delinearono
accuratamente il fenotipo di questo gruppo di disordini. Sono riconosciuti sei tipi differenti, a
seguito di una revisione operata di recente che esclude alcune delle tipologie precedentemente
incluse nella definizione (come il tipo IX e il tipo XI). Nel 1998 la classificazione proposta da
McKusick nel 1972 è stata rimpiazzata da quella di Villefranche: a sostituzione della numerazione
romana è stata preferita una nomenclatura descrittiva che evidenzia un carattere tipico che
contraddistingue la tipologia a cui fa riferimento. Le forme più comuni sono:
1. Classica (in precedenza riconosciute come tipo I e tipo II, rispettivamente gravis e mitis);
2. Ipermobilità (o tipo III ipermobile);
3. Vascolare (o tipo IV arterioso o ecchimotico);
4. Cifoscoliosi (o VI tipo oculare o scoliotico);
5. Artroclasia (in passato incluso nel tipo VII, come VIIA e VIIB);
6. Dermatosparassi (anch’esso precedentemente incluso nel tipo VII, come VIIC).
Gli altri tipi sono estremamente rari, e non si riscontrano casi riportati in Italia. L’incidenza media
stimata è di un caso su 5000-10000, la quasi totalità dei casi di tipo Ipermobilità o Classico. Per
avere un'idea sono noti, nel mondo, appena una decina di casi accertati di Dermatosparassi.
Per la maggior parte delle tipologie, la sindrome di Ehlers-Danlos è causata da un difetto nella
sintesi di un collagene (un componente della matrice extracellulare) e altre proteine del tessuto
connettivo. Si trasmette per via genetica. Sono stati identificati almeno 29 geni che contribuiscono
alla struttura proteica del collagene, che sono dislocati in 15 dei 24 cromosomi umani e un totale di
più di 19 forme diverse di collagene. Ad eccezione del tipo Cifoscoliosi, che ha carattere
autosomico recessivo, gli altri sono dominanti. L’origine del tipo Ipermobilità rimane tutt'oggi
sconosciuta.
Una corretta diagnosi è determinante, e se possibile, deve essere convalidata quanto prima.
Confermare la diagnosi per l’EDS è una procedura complessa, in alcuni casi non è possibile avere
un riscontro diretto mediante test, come per il tipo “Ipermobilità”, per il quale non esiste alcun
esame specifico. Il metodo di valutazione più efficace rimane forse la storia clinica familiare del
paziente.
Al momento non esistono cure efficaci. Molti medici sconsigliano ai pazienti affetti da EDS di
praticare sport che possano comportare complicanze per tendini e cute. Evitare sollevamenti ripetuti
e trasporto di oggetti pesanti. È necessario avvertire il proprio medico in caso di interventi
chirurgici. Per lacerazioni o ferite con conseguente emorragia, è necessario prestare particolare cura
alle suture e sostituirle quando possibile con l’uso di strisce adesive e colle. Prestare particolare
attenzione nell’analisi dei reperti cardiologici, ed in particolare alla presenza di murmure da
prolasso mitralico. Se c’è prolasso, sono consigliati monitoraggio e controlli periodici, così come
l’assunzione di precauzioni per endocardite batterica subacuta (SBE). I pazienti affetti da tipo
“Vascolare” sono a rischio per aneurisma arterioso e rottura. Potrebbe essere indicato un controllo
non invasivo delle arterie. Recenti studi dimostrano possibile rischio di allargamento dell’aorta
toracica. È bene quindi sottoporsi ad ecocardio frequenti. Alte dosi di acido ascorbico (1-4 g/d)
sono state testate, ma non si hanno sufficienti dati per poter affermare una reale efficacia della
terapia, che tuttavia si è dimostrata utile anche in pazienti che non mostrano carenza di vitamina C.
La consultazione di un oftalmologo può essere necessaria. Talvolta sono presenti miopia,
distaccamento retinico, cheratocono. Allo stesso modo sono consigliate regolari visite da un
dentista. I pazienti affetti da disordini del tessuto connettivo dovrebbero prestare particolare cura
all’igiene dentale. In presenza di periodontite è necessario agire tempestivamente.
ELASTINA L’elastina invece conferisce alla ECM la capacità di poter ritornare alle dimensioni originali.
L'elastina è una proteina costituente il tessuto connettivo che è elastica e permette a molti tessuti
dell'organismo di tornare alla loro forma originaria dopo essere stati sottoposti a forze di stiramento
o di contrazione. L'elastina è un costituente fondamentale della pelle, conferendole la caratteristica
risposta elastica quando il tessuto è sottoposto a tensioni meccaniche. Il locus è Cromosoma 7
q11.1-21.1.
L'elastina è principalmente composta dagli amminoacidi glicina, valina, alanina e prolina.
Strutturalmente è formata da molte molecole di tropoelastina (ad α-elica), idrosolubile e con massa
molecolare di circa 70.000 dalton, legate da legame covalente formatosi in seguito a reazione
catalizzata da lisil ossidasi. Il prodotto finale consiste in un voluminoso composto insolubile con
resistenti legami crociati di lisina.
Desmosina e isodesmosina sono amminoacidi peculiari, entrambe riscontrate nell'elastina.
L'elastina svolge un ruolo importante nelle arterie ed è particolarmente abbondante nei grandi vasi
sanguigni come l'aorta. È anche un costituente strutturale molto importante dei polmoni, dei
legamenti, della pelle, della vescica e della cartilagine.
LISIL OSSIDASI La protein-lisina 6-ossidasi (o lisil ossidasi) è un enzima extracellulare, appartenente alla classe
delle ossidoreduttasi, che catalizza la formazione di aldeidi da residui di lisina in precursori del
collagene e della elastina. Queste aldeidi sono altamente reattive e subiscono reazione chimica
spontanea con altri gruppi aldeidici prodotti dalla lisil ossidasi o con residui immodificati di lisina.
Questo porta alla formazione di legami cross-link nella struttura del collagene e dell'elastina,
essenziali per rendere stabili le fibrille di collagene e per assicurare l'integrità e l'elasticità
dell'elastina.
L'importanza dei legami cross-link dovuti alla lisil ossidasi è stata dimostrata da studi in modelli
animali in cui l'enzima è stato inibito tramite carenza nutrizionale di rame, cofattore essenziale, o
somministrando l'inibitore β-amminopropionitrile (BAPN). La carenza provoca malformazioni
ossee, iperestensibilità della pelle, debolezza dei legamenti e maggior rischio di aneurisma
dell'aorta. Questa condizioni sono correlate con la minore formazione di legami cross-link del
collagene e della elastina.
ULTERIORI COMPONENTI DELLA ECM Nella ECM troviamo tutta una serie di glicoproteine implicate nel corretto assemblaggio e
organizzazione. Tra tutti questi attori minori, il mio studio ha preso in considerazione la fibulina-5.
Tuttavia occorre conoscere la fisiologia di tali proteine per meglio comprenderne l’importanza. Cito
la fibronectina e la laminina, dato il loro ruolo peculiare nella riparazione tissutale.
FIBRONECTINA Famiglia di glicoproteine dimeriche prodotte da molte cellule e tessuti, presenti nel tessuto
connettivo lasso e in quello denso. La particolare composizione amminoacidica permette loro di
legare sia proteine delle membrane plasmatiche delle cellule connettivali (per esempio, le integrine)
sia componenti della matrice extracellulare, come fibre collagene, eparina, eparansolfato.
Una molecola di Fibronectina umana consta di due catene polipeptidiche molto simili (non
identiche) unite da legami disolfuro in sede C-terminale. Ciascuna di queste si compone di una serie
lineare di domini distinti, in modo da fornire ad ogni polipeptide un'architettura modulare. Ognuno
è formato da una catena di circa 30 domini Fn con ripiegamento indipendente: questi sono presenti
in molte altre proteine, quali recettori di membrana o fattori di coagulazione (un'elevata produzione
di fibronectine caratterizza i processi cicatriziali), ma hanno assunto la denominazione Fn in quanto
la Fibronectina è la prima struttura in cui sono stati scoperti. Tali domini tendono a combinarsi in 5
o 6 unità funzionali di dimensioni maggiori.
Ciascuna delle due catene polipeptidiche contiene siti di legame per altri componenti della ECM o
per recettori superficiali di membrana che legano la ECM (come le integrine). L'attività della
Fibronectina si evidenzia in processi dinamici quali quelli di sviluppo embrionale, in cui la
migrazione delle cellule deve seguire percorsi particolari la cui formazione è guidata da proteine
quali, appunto, la Fibronectina. Per esempio, le cellule delle creste neurali si muovono dal sistema
nervoso in sviluppo verso ogni zona dell'embrione attraverso percorsi ricchi di fibrille di
Fibronectina.
LAMININA La Laminina è una famiglia di glicoproteine che consistono di tre diverse catene polipeptidiche
legate da ponti disolfuro. Ne sono stati identificati 15 tipi e le loro molecole assumono la forma di
una croce con tre bracci corti ed uno lungo. Pesa 800 kDa: 400kDa la catena A e 200kDa le catene
B1 e B2 che legano il collagene di tipo IV. La laminina non è sintetizzata da fibroblasti, bensì dalle
cellule epiteliali.
Le laminine influenzano, al pari della fibronectina, la migrazione embrionale, la crescita ed il
differenziamento cellulare, ad esempio mediando lo spostamento delle cellule germinali primordiali
dal sacco vitellino embrionale alle gonadi in via di sviluppo, attraverso il circolo sanguigno. Qui
daranno origine a spermatozoi o uova. L'intero processo, infatti, avviene attraverso superfici
particolarmente ricche, tra le altre proteine, di laminine, in quanto pare che le cellule germinali
primordiali possiedano sulla superficie proteine che legano questo componente della MEC. Le
laminine possono anche legare altre laminine, proteoglicani, collagene e altri componenti della
matrice extracellulare. Studi evidenziano che laminine e molecole di collagene IV vadano a
comporre reti interconnesse nella membrana basale che conferiscono a quest'ultima forza ed
elasticità.
TIRANDO LE SOMME: FUNZIONE DELLA ECM A seconda della sua composizione la ECM può svolgere differenti funzioni come ad esempio quello
di supporto delle cellule e del loro ancoraggio e di divisione tra i diversi tessuti.
L'ancoraggio delle cellule avviene attraverso interazioni tra la ECM e proteine di membrana, dette
glicorecettori, appartenenti alla famiglia delle integrine. Attraverso questi “ponti” molecolari le
variazioni della MEC possono trasmettere stimolazioni meccaniche ed influire sull'organizzazione
del citoscheletro; allo stesso modo il citoscheletro può indurre modificazioni nella ECM. Spesso la
ECM ha un ruolo nel processo di regolazione riconoscimento intercellulare, permettendo il corretto
funzionamento di recettori cellulari come le caderine e le molecole adesive dei neuroni (N-CAM).
PARTE II LA FAMIGLIA DELLE FIBULINE Le fibuline sono una famiglia di proteine composta da 7 membri. La fibulina 1 è una glicoproteina
legante il calcio. Nei vertebrati, la fibulina-1 si ritrova nel sangue e nella matrice extracellulare.
All’interno della matrice extracellulare la fibulina-1 è associata alle membrane basali e alle fibre
elastiche. Inoltre, interagisce con altri componenti della ECM quali fibronectina, proteoglicani,
laminine e tropoelastina. Nel sangue la fibulina-1 è associata al fibrinogeno.
I membri della famiglia delle fibuline sono:
I.
Fibulina-1, il cui gene è FBLN1;
II.
Fibulina-2, FBNL2;
III.
Fibulina-3, FBNL3;
IV.
Fibulina-4, FBNL4;
V.
Fibulina-5, FBNL5;
VI.
VII.
Fibulina-6, FBNL6 o HMCN1 (hemicentin-1);
Fibulina-7, FBNL7.
LA FIBULINA­5 La fibulina-5 è una è una glicoproteine di 52 Kd con dominio calcio-legante simil EGF (cbEGF),
abbondantemente presente nella ECM ed è essenziale nella formazione del tessuto elastico.
Mutazioni missenso per il gene FBNL5 causa disordini delle fibre elastiche, quali cutis laxa e si è
notato un’associazione con la degenerazione maculare legata all’età.
Due monomeri di FBNL5 si associano a formare un dimero con una cavità centrale. Lo studio ha
dimostrato come l’equilibrio dimero/monomero sia influenzato dal NaCl e Ca2+, le cui
concentrazioni sono elevate nei liquidi fisiologici, soprattutto nel liquido extracellulare che
imbibisce la ECM. Tuttavia ancora non si sa quale delle due forme sia quella attiva e il ruolo
preciso della fibulina.
I siti di dimerizzazione coinvolgono i cbEGF e ciò suggerisce un particolare ruolo di tale dominio
nella dimerizzazione. È probabile che la Fibulina-5 funzioni come un dimero durante
l’elastinogenesi o che la dimerizzazione rappresenta un interruttore per limitare le interazioni con la
tropoelastina.
Quindi, le fibuline sono una famiglia di 7 glicoproteine della ECM, associate con le fibre elastiche e
le membrane basali. Sono coinvolte nell’assemblaggio, organizzazione e stabilizzazione dei
complessi macromolecolari. Le fibuline contengono domini cb-EGF e un particolare modulo
proteico, tipico delle fibuline, all’estremità C-terminale (Fc). Le fibuline 3-5 subiscono modifiche
nella regione N-terminale del dominio cbEGF.
Il gene della fibulina-5, FBNL-5, è localizzato sul cromosoma 14 ed è altamente espresso durante la
formazione dell’arterie, mentre nei vasi adulti la sua espressione è nettamente ridotta. Ciò
suggerisce che la fibulina-5 abbia un ruolo particolare nei processi di danno vascolare e
aterosclerosi. L’espressione di fibulina-5 è stata confermata in altri distretti corporei ricchi in fibre
elastiche: aorta, pelle, utero, polmone, cuore, ovaio, colon. L’estensibilità di questi tessuti è dovuta
alla presenza di fibre elastiche, che con l’età diminuiscono, portando ad una perdita finale di
elasticità. La fibulina-5 è essenziale per l’elastinogenesi. Topi Knock-out per il gene FBNL5
mostrano disordini delle fibre elastiche con severe elastinopatie. Mutazioni del gene causano
disordini delle fibre elastiche, come cutis laxa ed è associata con la degenerazione maculare legata
all’età.
È stato dimostrato che la fibulina-5 lega le fibre elastiche ed interagisce con la tropoelastina,
fibrillina-1, lisil ossidasi-1, 2, 4, con la proteina-2 legante il TGFβ, emilina-1, apolipoproteina-a e
superossido dismutasi. Inoltre la presenza di un dominio RGD suggerisce che la fibulina-5
interagisca anche con le integrine.
L’assemblaggio delle fibre elastiche è un complesso processo gerarchico. Un modello propone che
la fibulina-5 interagisca con le fibre elastiche per mezzo della fibrillina-1; la molecola di
tropoelastina si lega alla fibulina-5 e ciò permette di reclutare la lisil ossidasi, che tramite la
formazione di legami crociati, porta alla formazione delle fibre elastiche. Quindi la fibulina-5
incrementa il reclutamento della tropoelastina, aumentando la formazione di fibre elastiche.
Comunque, altri dati suggeriscono che la fibulina-5 rallenti la maturazione delle fibre elastiche. Ciò,
ovviamente, è da mettere in relazione con la doppia natura della fibulina-5 che presenta una forma
monometrica e una dimerica.
La fibulina-5 esiste come corto segmento con un dominio globulare alla fine.
Lo studio ha cercato di chiarire le dinamiche dell’equilibrio della fibulina-5 tra forma monometrica
e dimerica.
PROCEDURE SPERIMENTALI Il lavoro si prefissa di far luce non solo sulla struttura della fibilina-5, ma anche di comprendere il
suo funzionamento nelle soluzioni fisiologiche, quindi di studiare l’idrodinamica di tale proteina,
nonché gli equilibri intercorrenti tra fase monomerica e dimerica, cercando infine di comprenderne i
meccanismi. Alla luce di ciò sono state adottate varie metodiche sperimentali. Dopo l’iniziale
procedura di individuazione e selezione del gene FBNL-5, segue la complessa procedura di analisi
della proteina basata su indagini spettrofotometriche.
LA SPETTROSCOPIA La misura e lo studio di uno spettro è chiamato spettroscopia. In origine uno spettro era la gamma di
colori che si osserva quando della luce bianca viene dispersa per mezzo di un prisma. Con la
scoperta della natura ondulatoria della luce, il termine spettro venne riferito all'intensità della luce in
funzione della lunghezza d'onda o della frequenza.
Oggi il termine spettro è stato generalizzato ulteriormente, ed è riferito a un flusso o un'intensità di
radiazione elettromagnetica o particelle (atomi, molecole o altro) in funzione della loro energia,
lunghezza d'onda, frequenza o massa.
Uno strumento che permette di misurare uno spettro viene chiamato spettrometro, spettrografo o
spettrofotometro. Quest'ultimo termine si riferisce ad uno strumento per la misura dello spettro
elettromagnetico.
È noto che la luce emessa da una sorgente si propaga nello spazio in ogni direzione. Se essa
incontra un corpo “opaco” (in cui le radiazioni non possono propagarsi), si genera un cono d’ombra.
Se la superficie è levigata, i raggi possono subire una riflessione, se non è levigata possono subire
una diffusione. Se invece penetrano in un corpo trasparente ma vengono deviati, allora si ha il
fenomeno della rifrazione, che provoca la scomposizione della luce policromatica in radiazioni di
diverso colore (lunghezza d'onda) che possono essere raccolte su uno schermo dando origine alle
spettro. L’esperimento di scindere la luce nei suoi colori componenti fu effettuato da Newton nel
1666, ponendo le basi della spettroscopia.
Esistono 3 tipi di spettri:
1. Ad emissione continua: studiando la radiazione ottenuta scaldando un corpo nero si otterrà
uno spettro continuo che contiene tutte le onde elettromagnetiche esistenti, poiché in esso
non vi sono interruzioni tra una radiazione e l’altra;
2. Ad emissione a righe o bande: si ottiene usando come sorgente un gas rarefatto (a bassa
densità e pressione) ad elevata temperatura. Lo spettro che ne deriva non è continuo ma a
righe o bande (caratteristiche di specie poliatomiche). Gas con diversa composizione danno
diverso insiemi di righe caratteristiche, per questo motivo esso è utile per identificare la
composizione chimica di un gas;
3. Ad assorbimento: quando la luce emessa da una sorgente, passa per un gas a bassa
pressione. Esso consente di identificare la natura chimica di una sostanza allo stato però
gassoso.
L’analisi spettrale dunque, non solo è utile per analizzare le stelle, ma anche per studiare qualsiasi
altro corpo che assorba e rifletta radiazioni elettromagnetiche.
Per eseguire un'analisi spettrofotometrica si misura l'entità dell'assorbimento di una radiazione
luminosa con un campione posto davanti ad una sorgente di radiazioni. Per interpretare i fenomeni
che avvengono è necessario conoscere le caratteristiche delle sorgenti luminose e la struttura della
materia. L'assorbimento della radiazione provoca un aumento dell'energia interna della sostanza che
assorbe. Ciò implica una eccitazione delle particelle componenti (elettroni, atomi, molecole, ecc.),
che produce fenomeni caratteristici per ogni sostanza. Secondo la meccanica quantistica l'energia
delle particelle costituenti la materia è quantizzata, può cioè assumere solo certi valori discreti. In
condizioni normali una particella si trova nello stato di minima energia. Quando una radiazione
colpisce una particella, se l'energia dei fotoni è uguale alla differenza fra l'energia dello stato
eccitato della particella e quella di uno stato fondamentale, la radiazione viene assorbita e la
particella passa dallo stato fondamentale a quello eccitato. Poiché ad ogni sistema molecolare è
associata una distribuzione caratteristica dei livelli energetici (elettronici, vibrazionali, rotazionali)
l'assorbimento di una data radiazione è una proprietà caratteristica di quel sistema e non di altri. La
meccanica quantistica consente di spiegare perché l'assorbimento di una determinata radiazione è
specifico per ogni sostanza e dà luogo ad un caratteristico spettro di assorbimento. Essa inoltre,
mediante lo sviluppo delle regole di selezione, permette di stabilire quali transizioni siano proibite e
quali invece siano permesse.
Gli spettri di assorbimento rilevano quali frequenze sono state sottratte alla radiazione incidente nel
passaggio attraverso il campione e permettono di misurare l'intensità con cui queste frequenze sono
assorbite.
Le tecniche basate sullo studio delle radiazioni assorbite che trovano maggior applicazione nei
laboratori di analisi sono suddivide in base alle caratteristiche delle radiazioni in:
I.
II.
Spettroscopia ultravioletta/visibile;
Spettroscopia infrarossa;
III.
Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS);
IV.
Spettroscopia di emissione atomica (EAS);
V.
Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare.
Ogni sostanza assorbe a caratteristiche lunghezze d'onda questo consente di individuare un'analita
sulla base del suo spettro di assorbimento, come fosse la sua impronta digitale, cioè di effettuare
un'analisi qualitativa. Il profilo dello spettro di assorbimento dipende da vari parametri, quali, lo
stato di aggregazione della sostanza, la natura del solvente, il pH della soluzione. L'assorbimento ad
una certa lunghezza d'onda dipende dalla natura e dalla concentrazione dell'analita.
UN ESEMPIO: TRANSMITTANZA E ASSORBANZA La transmittanza, in ottica e in spettroscopia, è la frazione di luce incidente ad una data lunghezza
d'onda che attraversa un campione.
dove I0 e I1 sono rispettivamente l'intensità della luce incidente e della luce che emerge dal
campione attraversato.
Generalmente la trasmittanza è espressa come valore percentuale
La trasmittanza è legata all'assorbanza dalla seguente relazione
L'andamento della trasmittanza in funzione della lunghezza d'onda per una data sostanza
rappresenta lo spettro della sostanza stessa.
L'assorbanza (in passato densità ottica, indicata con D) in spettroscopia è definita come il logaritmo
decimale dell'inverso della trasmittanza
dove I0 e I1 sono le intensità della luce incidente e della luce che emerge dal campione attraversato
ad una data lunghezza d'onda.
L'assorbanza è in relazione lineare con la concentrazione di un campione - per concentrazioni
sufficientemente basse - secondo la legge di Lambert-Beer. Attraverso tale relazione, le misure di
assorbanza sono alla base dell'analisi chimica quantitativa per spettrofotometria.
BIOLOGIA MOLECOLARE Una volta ottenuto il DNA codificante per la proteina fibulina-5, questo è stato trattato con enzimi
di restrizione 5’ XhoI (Xanthomonas holcicola) e 3’ NaeI (Naesseria mucosa heidelbergensis). I
segmenti ottenuti sono stati poi amplificati tramite PCR e studiati.
ENZIMI DI RESTRIZIONE Le deossiribonucleasi II (sito-specifiche) (solitamente note con il nome di enzimi di restrizione)
sono una classe di enzimi, appartenente alla classe delle idrolasi, che catalizzano il taglio
endonucleolitico del DNA per dare frammenti specifici a doppia elica con fosfati terminali al 5'.
Questi complessi proteici sono in grado di rompere i legami fosfodiesterici base-base del DNA a
doppio filamento. Il ruolo biologico di questi enzimi è di protezione e salvaguardia della cellula: nei
procarioti questi enzimi sono essenziali per il taglio e la degradazione di filamenti estranei al
genoma (come ad esempio quello derivante da una infezione fagica).
La scoperta degli enzimi di restrizione è dovuta a Werner Arber, microbiologo svizzero, insieme a
Daniel Nathans e Hamilton Smith. Nel 1978 i tre ricevettero il Premio Nobel in medicina per "per la
scoperta degli enzimi di restrizione e la loro applicazione a problemi di genetica molecolare".
Gli enzimi di restrizione sono divisi in tre categorie: le endonucleasi di tipo I, II, III.
Le endonucleasi di tipo I (numero EC 3.1.21.3) e III (numero EC 3.1.21.5) necessitano di ATP
come coenzima per il taglio e possono anche catalizzare reazioni di modificazione del DNA quali la
metilazione (aggiunta di gruppi metilici a basi specifiche). Le reazioni di nucleasi e metilasi sono
associate. Mentre le endunucleasi di tipo I effettuano l'idrolisi del DNA in punti casuali, distanti
anche più di 1000 bp dal sito di riconoscimento, quelle di tipo III riconoscono il sito bersaglio ed
effettuano il taglio vicino a quest'ultimo, circa 24-26 bp dalla sequenza consenso.
Discorso a parte va fatto per le endonucleasi di tipo II, gli enzimi di restrizione propriamente detti,
quelli che si usano in laboratorio per intenderci. Questi enzimi, infatti, non necessitano di ATP per
la loro funzione ed il taglio avviene in corrispondenza di sequenze molto specifiche. Hanno inoltre
attivita nucleasica e metilasica non associate.
Ciascun enzima di classe II possiede una propria sequenza bersaglio (detta anche sequenza
consenso), che riconosce e taglia. Questa sequenza, solitamente di 4-8 paia di basi, è detta sito di
restrizione e permette di tagliare il DNA a livello di quel sito. Si tratta di siti con sequenze
palindromiche: se lette secondo la stessa polarità, sono identiche nei due filamenti (ad es.
5'...GATC...3' è palindromica perché il suo complementare è 3'...CTAG...5', che letta da 5' a 3'
corrisponde a GATC). Una conseguenza di questo fatto è che l'enzima di restrizione è un dimero,
più precisamente un omodimero, perché deve riconoscere la stessa sequenza su entrambi i filamenti.
Alcuni enzimi (detti rari), hanno siti di taglio poco presenti nel genoma (sono quelli con le sequenze
più lunghe). Altri, come EcoRI, BamHI e HindIII, tra i più utilizzati, hanno siti di taglio ben più
frequenti.
Sono possibili due tipi di taglio: il taglio sfalsato ed il taglio orizzontale. L'enzima EcoRI produce
un taglio sfalsato creando due estremità (dette coesive o sticky ends) a singolo filamento al 5'.
L’estremità coesive (cioè "appiccicose") che si sono create, possono appaiarsi con sequenze
complementari.
Il taglio di SmaI non produce estremità coesive, ma estremità "piatte" (blunt ends).
Gli enzimi di restrizione di classe II sono utilizzati in applicazioni di tipo biotecnologico. Ad
esempio, nella tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione di classe II sono
impiegati per il clonaggio molecolare, che consiste nell'introduzione di un gene d'interesse in una
molecola di DNA detta plasmide, in grado di replicarsi in un sistema ospite, spesso batterico, per
produrre grandi quantità del gene o per permetterne l'espressione.
Affinché il gene venga inserito, sia il DNA del gene che del plasmide vengono trattati con lo stesso
enzima di restrizione: al termine della reazione, sia il plasmide che il gene presenteranno delle
estremità terminali simili. In particolare, se l'enzima utilizzato produce un taglio sfalsato, le
estremità coesive prodotte tenderanno ad associarsi in presenza dell'enzima DNA ligasi, che
catalizza la reazione di ligazione.
Un'altra applicazione pratica consiste nell'analisi, ad esempio in medicina forense, degli RFLP
(Restriction fragment length poymorphism, polimorfismi di lunghezza da frammenti di restrizione).
Quando un sito polimorfico, contenente una sequenza consenso per un enzima di restrizione, viene
mutato, è possibile osservare in maniera differenziale l'attività di taglio dell'enzima stesso. Se non si
visualizza nessun taglio, sarà presente alcuna mutazione sul sito specifico dell'enzima. Se, in caso
contrario, il taglio avviene, il sito specifico sarà intatto e non mutato.
PCR La reazione a catena della polimerasi (in inglese: Polymerase Chain Reaction), comunemente nota
con l'acronimo PCR, è una tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione
(amplificazione) di frammenti di acidi nucleici dei quali si conoscano le sequenze nucleotidiche
iniziali e terminali. L'amplificazione mediante PCR consente di ottenere in vitro molto rapidamente
la quantità di materiale genetico necessaria per le successive applicazioni.
Tale metodica fu ideata nel 1983 da Kary B. Mullis il quale ottenne, per questo, il premio Nobel per
la chimica (1993).
La PCR ricostruisce in vitro uno specifico passaggio della riproduzione cellulare: la ricostituzione
(sintesi) di un segmento di DNA "completo" (a doppia elica) a partire da un filamento a singola
elica. Il filamento mancante viene ricostruito a partire da una serie di nucleotidi (i "mattoni"
elementari che costituiscono gli acidi nucleici) che vengono disposti nella corretta sequenza,
complementare a quella del DNA interessato.
Questo processo viene svolto in natura da enzimi chiamati DNA-polimerasi, che sono in grado di
sintetizzare progressivamente un nuovo filamento di DNA nelle seguenti condizioni:
I.
devono essere disponibili i nucleotidi da polimerizzare, sotto forma di desossiribonucleosidi
trifosfati (dNTP);
II.
il DNA deve essere denaturato, ovvero le due eliche che compongono i filamenti devono
essere già separate;
III.
il segmento da ricostruire può essere soltanto prolungato, ovvero non è possibile sintetizzare
un nuovo filamento a partire da zero;
IV.
devono inoltre essere rispettate opportune condizioni di temperatura, pH, ecc.
È possibile quindi ricostruire le condizioni che portano alla formazione dei nuovi segmenti di DNA,
ponendo in soluzione:
I.
II.
III.
una quantità, anche minima, del segmento di DNA che si desidera riprodurre;
una quantità opportuna di nucleotidi liberi per costituire i nuovi filamenti;
opportuni "inneschi", detti primer, costituiti da brevi sequenze di DNA (oligonucleotidi)
complementari agli estremi 5’ e 3’ del segmento da riprodurre;
IV.
altri elementi di supporto (ad es. ioni magnesio), necessari per costituire l'ambiente adatto
alla reazione;
V.
una DNA polimerasi (non è necessario che provenga dallo stesso organismo di cui si deve
replicare il DNA).
Per avviare la reazione della polimerasi (fase di prolungamento del filamento a partire dal primer
5’) è prima necessario provvedere alla separazione dei filamenti del DNA (fase di denaturazione),
quindi alla creazione del legame tra i primer e le regioni loro complementari dei filamenti di DNA
denaturati (fase di annealing). Questo processo risulta però incompatibile con la DNA polimerasi
umana, che viene distrutta alle temperature necessarie alla denaturazione (96-99 °C).
Per ovviare a questo inconveniente si fa ricorso alle polimerasi appartenenti a organismi termofili
che non sono inattivate dalle alte temperature, ad esempio la Taq polimerasi proveniente dal
batterio termofilo Thermus aquaticus. Ciò consente di realizzare più cicli di PCR in sequenza, in
ciascuno dei quali viene duplicato anche il DNA sintetizzato nelle fasi precedenti, ottenendo una
reazione a catena che consente una moltiplicazione estremamente rapida del materiale genetico di
interesse.
La soluzione di DNA da replicare, desossiribonucleotidi trifosfati, ioni magnesio, primer e TAQ
polimerasi viene portata a una temperatura compresa tra 94 e 99 °C. Ci si trova, di conseguenza, in
una situazione in cui la doppia elica del DNA viene completamente scissa ed i due filamenti di cui
essa è composta sono liberi (fase di denaturazione).
Successivamente la temperatura viene abbassata fino a 40-55 °C circa al fine di permettere il
legame dei primer alle regioni loro complementari dei filamenti di DNA denaturati (fase di
annealing).
Infine la temperatura viene alzata fino a 65-72 °C al fine di massimizzare l'azione della TAQ
polimerasi che determina un allungamento dei primer legati, utilizzando come stampo il filamento
singolo di DNA (fase di prolungamento).
Il ciclo descritto viene ripetuto generalmente per circa 30-40 volte. In genere non si superano i 50
cicli in quanto ad un certo punto la quota di DNA ottenuto raggiunge un plateau. Ciò avviene, ad
esempio, per carenza degli oligonucleotidi usati come inneschi o per diminuzione dei dNTP.
Bisogna inoltre considerare che si potrebbe amplificare in maniera eccessiva anche eventuale
materiale genomico contaminante.
La scelta del bersaglio genetico da amplificare tramite PCR dipende da ciò che si è interessati ad
ottenere e per tale motivo si ricorre a differenti strategie come, ad esempio:
− in caso di malattie genetiche o tumorali viene amplificato il gene responsabile di tali stati
patologici (ovviamente il gene in questione deve essere stato già riconosciuto);
− in caso di malattie infettive si possono amplificare geni del microorganismo in questione che
codifichino per funzioni vitali essenziali o per fattori di virulenza.
Il bersaglio da amplificare può anche essere una molecola di RNA (come, ad esempio, nel caso di
alcuni virus) la quale deve essere, come primo passo, sottoposta ad una reazione di retrotrascrizione
(vedi anche RT-PCR).
Per effettuare una PCR si può benissimo utilizzare una piccola quantità di bersaglio in quanto la
sensibilità della reazione è molto alta. Si è visto che una quantità di DNA genomico di 100 ng è
sufficiente per identificare un gene bersaglio che è presente in una singola copia. La presenza d'un
basso quantitativo di bersaglio, comunque, aumenta la probabilità che vengano amplificate
sequenze non specifiche. Una quantità troppo elevata di DNA, al contrario, può diminuire
l'efficienza dell'amplificazione a causa della presenza di troppi elementi contaminanti e può rendere
complessa la valutazione della resa della reazione durante i processi di ottimizzazione dei singoli
parametri per cercare di allestire tutta la PCR. Durante le fasi d'allestimento d'una PCR sarebbe
bene, per evitare le problematiche appena riportate, cercare d'ottimizzare la quantità di DNA
utilizzata (anche se non sempre ciò è possibile) mandando una serie di reazioni d'amplificazione in
cui tutti i parametri siano fissi tranne il quantitativo di DNA che viene impiegato in dosi scalari.
Per poter far ciò, comunque, è necessario poter valutare la quantità di DNA ottenuta durante il
processo di estrazione e ciò può essere ottenuto tramite una lettura spettrofotometrica d'una aliquota
dell'estratto in cui viene misurata l'assorbanza a 260 nm, e tenendo conto del fatto che un valore di
assorbanza di 1 con un cammino di 1 cm corrisponde a 50 μg/ml di DNA a doppia elica ed a 40
μg/ml di DNA a singola elica o di RNA. Effettuando, inoltre, una lettura ad una lunghezza d'onda di
280 nm (picco d'assorbanza delle proteine, principale contaminante degli estratti) ed effettuando il
rapporto tra le rispettive assorbanze a 260 e 280 nm si può ottenere una stima della purezza del
DNA ottenuto (in genere in preparazioni pure di DNA od RNA tale rapporto vale, rispettivamente,
1,8 e 2,0).
La lettura a 230 nm, invece, riflette la presenza di contaminanti quali: fenolo, composti aromatici,
peptidi e carboidrati. Il rapporto tra l'assorbanza a 260 nm e quella a 230 nm permette di
evidenziare la contaminazione da tali agenti (nelle preparazioni pure vale 2,2). Preparazioni in cui i
rapporti sopra indicati si discostano significativamente da quelli delle preparazioni pure sono indice
di contaminazione e ciò fa sì che la stima della concentrazione di DNA ottenuto sia meno accurata.
Altri fattori che possono inficiare l'efficienza dell'amplificazione sono: la presenza di DNA
circolare ed il suo peso molecolare. Effettivamente l'efficienza d'amplificazione è leggermente
inferiore in molecole di DNA circolari o che abbiano un peso molecolare troppo elevato per cui, in
questi casi, è consigliabile utilizzare appositi enzimi di restrizione che permettano, rispettivamente,
di linearizzare il materiale genomico o di ridurlo in frammenti più piccoli.
L'allestimento d'opportuni controlli di qualità permette di valutare la sensibilità e specificità della
metodica, nonché di evidenziare la presenza di falsi positivi o falsi negativi. I controlli da utilizzare
sono:
I.
il controllo positivo;
II.
il controllo negativo.
Il controllo positivo consiste in un campione in cui la sequenza bersaglio è contenuta. Tale controllo
non dovrebbe contenere un numero di copie di sequenza bersaglio troppo alto (in genere tra105 e
106). Ciò al fine di evitare di creare pericolosi aerosol che possano contaminare altri campioni o di
sottostimare eventuali cali di sensibilità della reazione con produzione di falsi negativi.
Il controllo negativo consiste in un campione in cui la sequenza bersaglio manca. Esso serve per
evidenziare eventuali contaminazioni che potrebbero riferirsi sia all'estrazione del materiale
genomico, sia al momento di preparazione della PCR.
La scelta dei primer da utilizzare costituisce un aspetto essenziale per la buona riuscita della PCR.
Essi, infatti, devono potersi ibridare in maniera specifica ed efficiente alla sequenza d'interesse,
tralasciando quelle aspecifiche. La tipologia di primer da usare varia a seconda dello scopo della
PCR.
Nel caso di malattie infettive risulta conveniente ricorrere a primer che siano specie-specifici o che
possano efficacemente distinguere tra ceppi patogeni e non. Per la diagnosi di patologie genetiche si
può ricorrere, invece, a due strategie: primer che siano complementari a regioni adiacenti a quella in
cui si trova la mutazione da individuare oppure primer in cui uno dei due sia complementare alla
sequenza mutata. In quest'ultimo caso si avrà che, in assenza della mutazione, non si avrà alcun
prodotto d'amplificazione. Poiché la complementarietà dei primer rispetto alla sequenze bersaglio
può non essere assoluta si può ricorrere all'uso di primer contenenti alcuni nucleotidi non
complementari (per creare, ad esempio, siti di taglio per enzimi di restrizione) o primer degenerati
(cioè miscele di oligonucleotidi che variano tra loro per la presenza di differenti basi in punti
specifici). Questi ultimi consentono di poter identificare geni di cui sia nota solo la sequenza
proteica o geni omologhi tra diverse specie. Nell'allestimento di una PCR la distanza compresa tra i
due primer è alquanto flessibile e può andare dalle 100 alle 10000 paia di basi (anche se, in realtà,
l'efficienza dell'amplificazione diminuisce quando si superano le 3000 paia di basi). Per cercare di
ovviare a questo problema sono state costruite varianti della DNA polimerasi prive dell'attività
esonucleasica (che va dal 5' al 3'). La lunghezza d'un primer è, in genere, compresa tra le 20 e le 30
paia di basi e non dovrebbe essere inferiore alle 16 (al fine di non pregiudicare la specificità del
processo).
Grazie alle banche dati ed alle pubblicazioni scientifiche stanno diventando sempre più disponibili
le sequenze di DNA o di RNA necessarie per poter disegnare i primer da utilizzare nelle PCR.
Una volta ottenuta la sequenza d'interesse bisogna controllare che nel resto del genoma non vi siano
sequenze omologhe che possano portare alla produzione di falsi positivi e successivamente si può
iniziare a disegnare i primer tenendo presente alcune accortezze:
− il contenuto di GC dovrebbe essere compreso tra il 45 ed il 50%;
− i primer non dovrebbero contenere sequenze tra loro complementari oppure sequenze
ripetute invertite per evitare che si formino aggregati di primer (detti dimeri di primer) o
strutture a forcina.
La concentrazione con cui i primer vengono comunemente usati si aggira attorno ad 1 mM e si
ritiene che un simile quantitativo sia sufficiente per almeno 30 cicli d'amplificazione. Una
concentrazione di primer troppo elevata potrebbe portare all'amplificazione di sequenze non
specifiche, mentre, al contrario, una troppo scarsa presenza di primer rende la PCR inefficace. Per
allestire una PCR, si renderà, quindi, necessaria un'ottimizzazione della concentrazione dei primer,
tramite diluizioni scalari.
La concentrazione di magnesio è senza dubbio il fattore più critico di tutta la PCR. Questo
parametro deve essere fatto oggetto di una attenta procedura d'ottimizzazione in quanto può variare
anche se si utilizzano diversi primer per amplificare una medesima regione di DNA. La presenza di
magnesio condiziona l'attività della polimerasi, l'ibridizzazione dei primer ed aumenta la
temperatura cui il DNA stampo si denatura. Vista la grande importanza del magnesio, bisogna
prestare attenzione a che nella soluzione di reazione non sussista un'eccessiva quantità di agenti
chelanti (es: EDTA) o di gruppi negativamente carichi (es: gruppi fosfato) in quanto entrambi
possono catturare il magnesio presente rendendolo non disponibile. Per allestire una PCR, di
conseguenza, è bene allestire diverse miscele di reazione contenenti quantità progressivamente
scalari di magnesio che varino da un minimo di 0.05 mM ad un massimo di 5 mM (il più delle volte
si utilizza magnesio 1,5 mM).
Generalmente i nucleotidi vengono utilizzati alla concentrazione di 200 μM ciascuno. Un aumento
di questa concentrazione non porta ad un aumento dell'efficienza della reazione in quanto i gruppi
fosfato carichi negativamente possono legarsi al magnesio della miscela rendendolo meno
disponibile. I nucleotidi, in concentrazione superiore ai 200 μM, possono aumentare la percentuale
d'errore della polimerasi od addirittura inibirla qualora presenti in concentrazione millimolare.
Nei primi studi riguardanti la PCR veniva usata un frammento di DNA polimerasi di Escherichia
coli (detto frammento di Klenow) ottenuto tramite digestione enzimatica. Le temperature necessarie
per la denaturazione del DNA, sfortunatamente, disattivavano quest'enzima che doveva, così, essere
reinserito nella provetta dopo ogni fase di denaturazione. La successiva introduzione della Taq
polimerasi, termostabile, permise di risolvere quest'inconveniente piuttosto noioso. La Taq
polimerasi ha consentito di ottenere anche un miglioramento nella specificità della PCR in quanto
ha permesso l'uso di temperature di annealing e di allungamento più elevate rispetto a quelle
possibili con il frammento di Klenow, il che rende la reazione più stringente. Effettivamente la Taq
polimerasi presenta un picco d'attività enzimatica attorno ai 75-80 °C ed inoltre permette di
amplificare frammenti di lunghezza superiore alle 400 Kb (limite del frammento di Klenow), fino
ad un massimo di 10 Kb. La Taq polimerasi, a differenza d'altre polimerasi, presenta un'attività
esonucleasica 5'-3' ma non in direzione 3'-5'. In direzione 3'-5' è consentito alle polimerasi,
compreso il frammento di Klenow, di correggere eventuali errori (proof reading) dovuti ad
un'erronea incorporazione dei nucleotidi. Ciò fa sì che la Taq polimerasi presenti un tasso d'errore
di 2x10−5 nucleotidi, valore che comunque può variare modulando opportunamente alcuni parametri
quali:
− concentrazione dei nucleotidi;
− concentrazione del magnesio;
− temperatura di "melting";
− temperatura di annealing.
Tale tasso d'errore, fortunatamente, risulta ininfluente per le maggior parte delle applicazioni
successive, come, ad esempio, il sequenziamento o l'utilizzo di sonde specifiche. La ricerca,
comunque, si è volta a ricercare altre polimerasi con frequenza d'errore minore e con una più
elevata resistenza alle alte temperature. Ciò ha fatto sì che venissero messe in commercio altri
enzimi come quelli ottenuti per purificazione da Thermococcus litoralis, Pyrococcus furiosus o
Thermotoga maritima. La prima, infatti, associa un'elevata termoresistenza ad una maggior fedeltà
nella sintesi del filamento complementare mentre le altre presentano un'interessante attività di
correzione di bozze. Il frammento di Stoffel è una DNA polimerasi ottenuta eliminando i 289
aminoacidi della porzione N-terminale della Taq polimerasi. Ciò fa sì che l'enzima risultante sia
privo dell'attività esonucleasica 5'-3' e che abbia una maggior resistenza alle alte temperature (ha
infatti un'emivita di circa 20 minuti a 97,5 °C). Una tale caratteristica permette l'utilizzo di
temperature di denaturazione più elevate del solito e facilità nella sintesi di frammenti ricchi in
guanine e citosine che presentano una struttura secondaria alquanto eleborata. Un'altra caratteristica
favorevole consiste nell'avere un'attività ottimale in un intervallo di concentrazione di magnesio
ampio, compreso tra 2 e 10 mM. Ciò può facilitarne l'utilizzo in caso di PCR che vadano ad
amplificare più di un bersaglio (PCR multiplex). La DNA polimerasi, estratta da Thermus
thermophilus e successivamente prodotta per via ricombinante, presenta, oltre all'azione classica,
un'attività di trascrittasi inversa (DNA polimerasi RNA dipendente) che si manifesta in presenza di
cloruro di manganese ad una temperatura di circa 60 °C. La DNA polimerasi DNA dipendente si
attiva con l'aggiunta di cloruro di magnesio che va a chelare il manganese. Tale enzima, inoltre
sembra resistere bene ad eventuali componenti ematici in grado di inibire la Taq polimerasi, per cui
trova applicabilità nel campo della diagnostica di laboratorio in cui sia necessario utilizzare un
bersaglio ad RNA. In commercio si trova anche la AmpliTaq Gold DNA polimerasi che è in grado
di attivarsi gradualmente a seguito d'una esposizione a 95 °C per 10 minuti. Tale attivazione, che
rientra nel concetto delle PCR "hot start", permetta un aumento della sensibilità e specificità della
reazione. Risulta, infine, molto utile nelle PCR multiplex in quanto diminuisce l'aggancio aspecifico
dei primer e la formazione di dimeri. Anche la quantità d'enzima da utilizzare può essere un fattore
limitante l'accuratezza della PCR in quanto se la concentrazione è troppo bassa la resa
dell'amplificato è scarsa mentre se è troppo alta si possono generare dei prodotti aspecifici. Il più
delle volte si utilizza una quantità d'enzima variabile tra 1 e 5 unità per 100 μl. Generalmente i
quantitativi più elevati d'enzima vengono usati per amplificare materiale genetico complesso come
quello genomico.
Nella fase di denaturazione, come affermato precedentemente, deve avvenire la completa
separazione dei due filamenti di DNA. Si tratta di un momento importante in quanto una
denaturazione incompleta può pregiudicare l'efficienza dell'amplificazione. La denaturazione
avviene piuttosto rapidamente ma bisogna assicurarsi che la temperatura raggiunta sia omogenea in
tutta la provetta di reazione. Il più delle volte la temperatura utilizzata è di 94 °C per 30-60 secondi
ma bisogna considerare che vi sono molte variabili che possono richiedere un aggiustamento di tali
valori:
− volume di reazione;
− posizione della provetta all'interno del thermocycler;
− lunghezza e quantità di DNA stampo;
− contenuto in coppie GC (le coppie GC sono più stabili in quanto formano tra loro tre legami
idrogeno per cui ci vuole più energia per romperli; per ogni percento di GC la temperatura di
denaturazione deve aumentare di 0,4 °C);
− la soluzione di reazione e la sua forza ionica (la temperatura di denaturazione, infatti, deve
essere innalzata di 16,6 °C per ogni aumento di 10 volte della concentrazione dei cationi
monovalenti).
È da tenere presente che aumenti eccessivi di temperatura o protratti troppo a lungo possono
diminuire l'attività della DNA polimerasi che a 95 °C ha un tempo di emivita di 40 minuti. Per
evitare simili problematiche, si può ricorrere ad agenti (tipo formammide) che destabilizzano i ponti
idrogeno per cui la temperatura di denaturazione può essere diminuita. Nella fase di annealing, in
cui i primer si appaiano alle sequenze complementari del bersaglio, la temperatura da utilizzare, e la
sua durata, devono essere scelti considerando due aspetti opposti. Una temperatura più elevata,
infatti, aumenta la specificità della reazione ma ne può pregiudicare l'efficienza poiché favorisce la
separazione dei primer dal bersaglio (il valore della temperatura a cui si ha il 50% di transizione tra
stato a doppia ed a singola elica viene detto temperatura di melting o di fusione). Se la temperatura
viene abbassata, le condizioni diventano meno stringenti ma viene favorita la formazione di ibridi, e
quindi di amplificati, aspecifici. Una guida utile nel valutare la temperatura di annealing da adottare
può essere la composizione in coppie GC. Se queste sono poche, allora la temperatura può essere
inferiore ai 55 °C, altrimenti deve essere superiore.
Nella fase di prolungamento la temperatura da adottare è quella cui corrisponde la massima attività
enzimatica (ad esempio con la polimerasi Taq si utilizza una temperatura di 70-72 °C). Il periodo di
tempo in cui tale temperatura viene utilizzata varia a seconda della lunghezza del frammento da
amplificare (per la Taq polimerasi un minuto è sufficiente per frammenti di 2 Kb). In genere,
l'ultimo ciclo della reazione di amplificazione dura più a lungo al fine di poter ottenere prodotti che
siano completi il più possibile. Tale passo risulta estremamente importante in situazioni in cui i
prodotti di reazione debbano avere estremità ben definite, per poterli utilizzare, ad esempio, nel
sequenziamento o nel clonaggio.
Paradossalmente, il più grande problema della PCR deriva proprio dalla sua elevata sensibilità ed
efficienza. In effetti la reazione risulta molto sensibile alla presenza di materiale genetico
contaminante che si può trovare in differenti posti: strumentazione, operatore, ambiente esterno.
Una delle maggiori fonti di contaminazione consiste nell'apertura di provette contenenti materiale
amplificato (contaminazione da carry over) il quale, a seguito dell'apertura del recipiente, può
disperdersi nell'aria sotto forma di aerosol che potrebbe contaminare successive PCR.
Se si considera, in effetti, che in una PCR condotta in un volume di 100 μl si possono trovare fino a
1012 molecole di DNA, ciò significa che in 10 − 7 μl di soluzione si hanno 103 filamenti di DNA, il
che può costituire una pericolosa fonte di contaminanti. Il problema delle contaminazioni è tanto
maggiore quanto la sensibilità della PCR è elevata. Una PCR meno sensibile risulterà, ovviamente,
meno soggetta a contaminazioni ma necessiterà di una maggior presenza del proprio bersaglio per
poterlo amplificare. Un altro aspetto che deve essere considerato è la presenza di materiale
contaminante di origine ambientale o cellulare. Volendo, ad esempio, amplificare materiale
genomico umano, vi sarà la possibilità che lo stesso operatore sia una fonte di contaminazione (per
esempio per perdita di frammenti di cute che si desquamano o per il rilascio di goccioline di saliva).
Avendo a che fare con microorganismi vi può essere la possibilità che essi crescano in vicinanza ai
luoghi in cui la PCR viene preparata. È anche possibile la contaminazione crociata a partire dal
materiale utilizzato come controllo positivo il quale potrebbe andarsi a depositare nelle provette dei
campioni da testare. Esiste, infine un'altra possibilità di contaminazione che si può avere durante le
procedure di rilevazione del prodotto della PCR (ad esempio su gel d'agarosio per la corsa
elettroforetica). In questo caso è possibile che materiale di un campione possa aggiungersi in
piccola quantità ad un altro con la possibilità di un risultato falsato. Di fronte ad un problema così
importante come quello delle contaminazioni (si pensi soprattutto al campo della diagnostica) è
opportuno che vangano intrapresi degli accorgimenti idonei a minimizzare tale rischio.
È assolutamente indispensabile che l'area di preparazione della miscela della reazione sia ben
distinta da quella in cui i campioni vengono inoculati e da quella in cui vengono analizzati. Ciò vale
anche per tutta la strumentazione da utilizzarsi. Il fine di ciò consiste nell'evitare che eventuale
materiale
genomico
possa
contaminare
la
soluzione
mentre
viene
preparata.
Tutti i reagenti della PCR dovrebbero venir suddivisi in aliquote piuttosto piccole in maniera tale da
evitare che una provetta venga aperta e chiusa un numero troppo elevato di volte. In caso di
presenza di materiale contaminante, poi, non sarà necessario buttare tutto quanto il reagente
considerato inquinato ma solo l'aliquota di esso che è stata utilizzata. I reagenti, inoltre, dovrebbero
essere conservati in aree dove non sono presenti prodotti di altre PCR od eventuale DNA estratto.
Le pipette utilizzate nei laboratori costituiscono una delle maggiori fonti di contaminazione in
quanto, durante la fase d'aspirazione d'una soluzione contenente DNA, possono creare degli
aereosol che si vanno a depositare sulla punta e che possono successivamente andare ad inquinare
altri campioni (specie i controlli negativi). Per ovviare a questa problematica è bene utilizzare
puntali dotati di filtro o pipette ad espulsione positiva. Un altro accorgimento utile da usare consiste
nell'utilizzo di pipette differenti per la preparazione della miscela di reazione e per l'inoculo del
DNA.
Tutte queste misure vanno, ovviamente, inserite in un contesto generale di buona pratica
laboratoristica che dovrebbe prevedere, tra l'altro: il cambio frequente dei guanti, la pulizia accurata
di tutte le superfici e strumentazioni e la chiusura di tutte le provette subito dopo il loro utilizzo.
La PCR viene utilizzata in tutte quelle situazioni in cui bisogna amplificare un quantitativo di DNA
fino a livelli utili per analisi successive. I campi di applicazione sono enormi. La tecnica viene
sfruttata, per esempio, in medicina per la diagnostica microbiologica o per l'evidenziazione di
cellule tumorali, in tumori liquidi, quando esse sono troppo poche per essere evidenziate da altre
metodiche (malattia minima residua). Estremamente utile è l'uso della PCR in medicina legale. In
biologia la PCR viene usata per le analisi di paleontologia e di antropologia molecolare ed in
numerosi campi dell'ingegneria genetica. Fondamentale è poi il suo utilizzo per lo studio del
genoma di organismi non coltivabili, quali numerosi batteri e protisti, e per lo studio di popolazioni
in ecologia. Le diverse gradazioni di specificità dei primer integrate alla diversa efficienza con cui
essi si legano all'amplificato a seconda della temperatura garantiscono a questa tecnica una
straordinaria flessibilità per studi a tutti i diversi livelli tassonomici.
SINTESI E PURIFICAZIONE DELLA FIBULINA­5 RICOMBINANTE La proteina ricombinante viene espressa da EBNA 293, cellule transfettate. Per trasfezione si
intende il processo di introduzione di materiale biologico esogeno in cellule eucariotiche e nella
gran parte dei casi di mammifero. È più frequente l'inserimento di materiale genetico, tra cui
solitamente DNA e siRNA, ma, in generale, possono essere trasfettate anche proteine.
Le cellule transfettate con FBNL-5 producono fibulina-5, che viene poi riversata nel materiale
sierico di incubazione delle cellule. I polipeptidi sono stati purificati tramite cromatografia per
affinità con il nichel.
EBNA 293 Si tratta di cellule di rene fetale umano, nelle quali è stato transfettato il gene FBNL-5, complessato
con EBNA-1, un gene del virus Epstein Barr. Il gene EBNA-1 è responsabile della replicazione del
virus. Più precisamente, la sequenza di origine di replicazione di EBNA-1, ori-P, è stata unita al
gene FBNL-5. In questo modo le cellule esprimono costitutivamente il gene e producono la relativa
proteina, che poi viene esocitata all’esterno, nel siero di coltura.
VETTORE Nell'ambito delle biotecnologie ci si riferisce al termine vettore per indicare un segmento di DNA,
solitamente di dimensioni ridotte, che può trasportare sequenze di interesse. Attraverso tecniche di
subclonaggio, infatti, un vettore può fungere da veicolo molecolare per segmenti di DNA che
occorre esprimere (un fine comune è quello di amplificare il segmento) all'interno di una cellula
ospite.
Spesso derivati da plasmidi, piccole molecole di DNA circolare a doppio filamento presenti
naturalmente nei citosol batterici, i vettori contengono solitamente:
1. un'origine di replicazione compatibile con l'organismo ospite, in modo da permettere al
vettore di replicarsi attraverso il replisoma dell'organismo;
2. uno o più marker di selezione, che permette di selezionare dall'esterno le cellule contenenti
il vettore (ad esempio regioni che conferiscono resistenza ad antibiotici e permettono di
selezionare le cellule);
3. una regione detta multi-cloning site (MCS), presso cui è possibile inserire gli specifici
segmenti di interesse attraverso l'utilizzo di enzimi di restrizione.
I vettori legati ai plasmidi permettono l'inserimento di segmenti di dimensioni ristrette (poche
migliaia di paia di basi). Esistono diversi altri tipi di vettore non derivati da plasmidi, in grado di
trasportare regioni di DNA molto più ampie.
MALLS­MULTIANGLE LASER LIGHT SCATTERING MALLS è un sistema di misurazione atto a calcolare l’intensità della luce riflessa da ogni angolo di
una struttura microscopica. Il calcolo si basa sull’intensità della luce misurata e l’efficienza del
rilevatore di notare la più minima variazione. Raccolti tutta una serie di dati, viene proposto un
modello che permette approssimativamente di calcolare l’intensità della luce all’angolo zero.
L’angolo zero è messo poi in correlazione con la massa molare. Nel lavoro la sorgente di luce è un
laser che emette onde di 688 nm. Dal comportamento del raggio in soluzione si è poi riusciti a
determinare la massa della proteina.
DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA FIBULINA 5 Una volta identificata la forma, si è passati a stabilire il peso del monomero e del dimero della
fibulina. Tramite un apposito microscopio e ricorrendo a particolari metodiche, come l’analisi di
Fourier, si è poi potuto ricostruire l’immagine 3D della molecola.
DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA’ IDRODINAMICHE Tramite appositi software, si è riusciti a calcolare la massa, che è di 49,779 Da, il peso specifico
(0,7085 ml/g) e il grado di idratazione (0,3802 g di acqua/ g di proteina). Utilizzando la MALLS si
è ottenuto il peso della fibulina coniugata con la catena di carboidrati, tipica delle proteine che
vengono esocitate fuori dalla cellula. La massa della proteina, “in vivo” è di 51,620 Da,
leggermente superiore al valore ottenuto precedentemente. Inoltre sono state determinate alcuni
parametri che regolano l’equilibrio tra monomero e dimero, inoltre è stato stabilito che la
dimerizzazione è anche calcio-dipendente.
COMMENTI La complessità delle tecniche adottate non deve stupire, in quanto è molto difficile determinare la
struttura di componenti microscopiche. Tuttavia, per quanto riguarda l’analisi strutturale, il
principio è uno solo: per risalire alla struttura basta analizzare le deviazioni di raggi a specifiche
lunghezze d’onda. La banalità di questo metodo non deve indurre ad una semplicistica visione di
tutto il processo. Infatti, bisogna tenere presente che i dati ottenuti da queste analisi sono stati poi
elaborati secondo modelli matematici molto complessi ed affidandosi a software appositi. Infatti,
senza l’aiuto dei computer l’analisi strutturale sarebbe molto difficile. È quindi chiaro che, una
trattazione esauriente delle metodiche adottate sarebbe inutile nonché indaginoso. Tuttavia la cosa
più importante è il concetto, cioè l’aver capito che strutture diverse colpite dalla stessa sorgente
luminosa daranno risultati diversi.
PARTE III RISULTATI Alla luce dei risultati, si discuterà dei grafici ottenuti, presenti nel lavoro.
CD SPECTRA Circular dichroism (CD) is the differential absorption of left- and right-handed circularly polarized
light.
A CD Spectrometer is an instrument that records this phenomenon as a function of wavelength.
Modern instruments, however, can generally also record CD as a function of temperature or
chemical environment, at several wavelengths.
This phenomenon is exhibited in the absorption bands of an optically active molecule. CD can be
used to help determine the structure of macromolecules (including the secondary structure of
proteins and the handedness of DNA).
Linearly polarized light is polarized in a certain direction (that is, the magnitude of its electric field
vector oscillates only in one plane, similar to a sine wave). In circularly polarized light, the electric
field vector has a constant length, but rotates about its propagation direction. Hence it forms a helix
in space while propagating. If this is a left-handed helix, the light is referred to as left circularly
polarized, and vice versa for a right-handed helix.
The electric field of a light beam causes a linear displacement of charge when interacting with a
molecule, whereas the magnetic field of it causes a circulation of charge. These two motions
combined result in a helical displacement when light impinges on a molecule (both field vectors in
the same place are of the same direction, but at different moments of time). Since circularly
polarized light itself is "chiral", it interacts differently with chiral molecules. That is, the two types
of circularly polarized light are absorbed to different extents. In a CD experiment, equal amounts of
left and right circularly polarized light of a selected wavelength are alternately radiated into a
(chiral) sample. One of the two polarizations is absorbed more than the other one, and this
wavelength-dependent difference of absorption is measured, yielding the CD spectrum of the
sample.
Due to the interaction with the molecule, the electric field vector of the light traces out an elliptical
path after passing through the sample.
At a given wavelength,
where ΔA is the difference between absorbance of left circularly polarized (LCP) and right
circularly polarized (RCP) light (this is what is usually measured).
It can also be expressed, by applying Beer's law, as:
where
εL and εR are the molar extinction coefficients for LCP and RCP light, C is the molar concentration,
l is the path length in centimeters (cm).
Then
is the molar circular dichroism. This intrinsic property is what is usually meant by the circular
dichroism of the substance.
In general, this phenomenon will be exhibited in absorption bands of any optically active molecule.
As a consequence, circular dichroism is exhibited by biological molecules, because of their
dextrorotary and levorotary components. Even more important is that a secondary structure will also
impart a distinct CD to its respective molecules. Therefore, the alpha helix of proteins and the
double helix of nucleic acids have CD spectral signatures representative of their structures.
CD is closely related to the optical rotatory dispersion (ORD) technique, and is generally
considered to be more advanced. CD is measured in or near the absorption bands of the molecule of
interest, while ORD can be measured far from these bands. CD's advantage is apparent in the data
analysis. Structural elements are more clearly distinguished since their recorded bands do not
overlap extensively at particular wavelengths as they do in ORD. In principle these two spectral
measurements can be interconverted through an integral transform (Kramers–Kronig_relation), if
all the absorptions are included in the measurements.
The far-UV (ultraviolet) CD spectrum of proteins can reveal important characteristics of their
secondary structure. CD spectra can be readily used to estimate the fraction of a molecule that is in
the alpha-helix conformation, the beta-sheet conformation, the beta-turn conformation, or some
other (e.g. random coil) conformation. These fractional assignments place important constraints on
the possible secondary conformations that the protein can be in. CD cannot, in general, say where
the alpha helices that are detected are located within the molecule or even completely predict how
many there are. Despite this, CD is a valuable tool, especially for showing changes in conformation.
It can, for instance, be used to study how the secondary structure of a molecule changes as a
function of temperature or of the concentration of denaturing agents, e.g. Guanidinium
hydrochloride or urea. In this way it can reveal important thermodynamic information about the
molecule (such as the enthalpy and Gibbs free energy of denaturation) that cannot otherwise be
easily obtained. Anyone attempting to study a protein will find CD a valuable tool for verifying that
the protein is in its native conformation before undertaking extensive and/or expensive experiments
with it. Also, there are a number of other uses for CD spectroscopy in protein chemistry not related
to alpha-helix fraction estimation.
The near-UV CD spectrum (>250 nm) of proteins provides information on the tertiary structure.
The signals obtained in the 250-300 nm region are due to the absorption, dipole orientation and the
nature of the surrounding environment of the phenylalanine, tyrosine, cysteine (or S-S disulfide
bridges) and tryptophan amino acids. Unlike in far-UV CD, the near-UV CD spectrum cannot be
assigned to any particular 3D structure. Rather, near-UV CD spectra provide structural information
on the nature of the prosthetic groups in proteins, e.g., the heme groups in hemoglobin and
cytochrome c.
Visible CD spectroscopy is a very powerful technique to study metal–protein interactions and can
resolve individual d-d electronic transitions as separate bands. CD spectra in the visible light region
are only produced when a metal ion is in a chiral environment, thus, free metal ions in solution are
not detected. This has the advantage of only observing the protein-bound metal, so pH dependence
and stoichiometries are readily obtained. Optical activity in transition metal ion complexes have
been attributed to configurational, conformational and the vicinal effects. Klewpatinond and Viles
(2007) have produced a set of empirical rules for predicting the appearance of visible CD spectra
for Cu2+ and Ni2+ square-planar complexes involving histidine and main-chain coordination.
CD gives less specific structural information than X-ray crystallography and protein NMR
spectroscopy, for example, which both give atomic resolution data. However, CD spectroscopy is a
quick method that does not require large amounts of proteins or extensive data processing. Thus CD
can be used to survey a large number of solvent conditions, varying temperature, pH, salinity, and
the presence of various cofactors.
CD spectroscopy is usually used to study proteins in solution, and thus it complements methods that
study the solid state. This is also a limitation, in that many proteins are embedded in membranes in
their native state, and solutions containing membrane structures are often strongly scattering. CD is
sometimes measured in thin films.
COMMENTO RIQUADRO A Nei liquidi fisiologici vi è un’elevata concentrazione di NaCl e calcio, quindi con questo primo
riquadro si è cercato di capire cosa accade quando la fibulina-5 si ritrova in una soluzione
fisiologica. Tale riquadro mette in relazione il grado di assorbanza con la lunghezza d’onda del
raggio che colpisce la soluzione. Tale relazione è legata alla concentrazione del soluto, alla
temperatura, al pH, ma soprattutto alla struttura della proteina esaminata.
La soluzione di partenza contiene 500 mM di NaCl e successivamente si studiano le variazioni di
assorbanza in vari casi:
I.
II.
III.
Linea rossa: aggiunta di 2 mM EDTA e di EGTA, due sostanze chelanti i cationi;
Linea azzurra: soluzione pura di NaCl;
Linea nera: soluzione pura di NaCl con aggiunta di CaCl2 a 2mM.
Si può notare come i tracciati del caso II e III siano molto simili, al contrario del tracciato I.
Siccome queste variazioni sono da mettere in relazione con variazioni spettroscopiche della
soluzione, molto probabilmente il soluto avrà subito qualche modifica nella forma. Siccome nel
caso I vi erano agenti chelanti, l’artefice di tale variazione sono da ricercare nei cationi dei Sali.
SEC, SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY Size exclusion chromatography (SEC) is a chromatographic method in which molecules in solution
are separated based on their size (more correctly, their hydrodynamic volume). It is usually applied
to large molecules or macromolecular complexes such as proteins and industrial polymers.
Typically, when an aqueous solution is used to transport the sample through the column, the
technique is known as gel filtration chromatography, versus the name gel permeation
chromatography which is used when an organic solvent is used as a mobile phase. SEC is a widely
used Polymer characterization method because of its ability to provide good Mw results for
polymers.
The main application of gel filtration chromatography is the fractionation of proteins and other
water-soluble polymers, while gel permeation chromatography is used to analyze the molecular
weight distribution of organic-soluble polymers. Either technique should not be confused with gel
electrophoresis, where an electric field is used to "pull" or "push" molecules through the gel
depending on their electrical charges.
SEC is a widely used technique for the purification and analysis of synthetic and biological
polymers, such as proteins, polysaccharides and nucleic acids. Biologists and biochemists typically
use a gel medium — usually polyacrylamide, dextran or agarose — and filter under low pressure.
Polymer chemists typically use either a silica or crosslinked polystyrene medium under a higher
pressure. These media are known as the stationary phase.
The advantages of this method include good separation of large molecules from the small molecules
with a minimal volume of eluate, and that various solutions can be applied without interfering with
the filtration process, all while preserving the biological activity of the particles to be separated. The
technique is generally combined with others that further separate molecules by other characteristics,
such as acidity, basicity, charge, and affinity for certain compounds. With size exclusion
chromatography there are short and well defined separation times, narrow bands which leads to
good sensitivity. There is also no sample loss because solutes don't interact with the stationary
phase. Disadvantages are for example that only a limited number of bands can be accommodated
because the time scale of the chromatogram is short and generally there has to be a 10% difference
in molecular mass to have a good resolution.
CROMATOGRAMMA Un cromatogramma, in chimica, è il grafico prodotto da un'analisi cromatografica che correla la
risposta del rivelatore del gascromatografo al tempo, ossia al volume di eluizione (se il flusso
dell'eluente non è costante, il grafico del segnale rispetto al tempo non è uguale a quello che si
ottiene riportandolo in termini di volume).
Consiste in una serie di picchi che rappresentano l'eluizione dei singoli analiti, separati dal processo
cromatografico. Oggi è generato il più delle volte da software dedicati, che raccolgono il segnale
del rivelatore e lo elaborano arrivando eventualmente a produrre anche il risultato dell'analisi
cromatografica in termini di composizione per confronto dei tempi di ritenzione o delle proprietà
degli analiti relativi ai singoli picchi.
Il successo di una separazione cromatografica è giudicato in base alla capacità del sistema di
separare il picco di ogni analita presente nel campione da ogni altro
COMMENTO RIQUADRO B In questo riquadro viene messo in relazione il DRI o differential refractive index (indice
differenziale di rifrazione) e il volume di soluzione preso in esame. Le metodiche adottate qui
servono per dividere le varie forme della proteina e per cercare di capire cosa accada. Le varie linee
rappresentano le varie soluzioni:
I.
Linea gialla: 100 mM di NaCl e aggiunta di 2 mM di EDTA e EGTA. In questo caso si
osservano due picchi a circa 8 e 14 ml;
II.
Linea rossa: 500 mM di NaCl e aggiunta di 2 mM di EDTA e EGTA. In questo caso si
osservano due picchi a circa 8 e 14 ml;
III.
Linea verde: 150 mM di NaCl e aggiunta di 2 mM di CaCl2. In questo caso si notano due
picchi, a 8 e 13 ml;
IV.
Linea nera: 500 mM di NaCl e aggiunta di 2 mM di CaCl2. In questo caso si notano due
picchi, sempre a 8 e 13 ml.
Tale riquadro sottolinea che la presenza di NaCl e CaCl2 modificano l’indice, ovvero modificano la
struttura della proteina (che nel grafico corrisponde ai picchi e alle variazioni di volume ai quali si
presentano i picchi). Infatti, la curva gialla e quella rossa presentano quasi lo stesso andamento,
suggerendo che l’aggiunta l’aumento della concentrazione di NaCl non modifica in modo
sostanziale il DRI, data la presenza dei chelanti. Al contrario, invece, la curva verde e quella nera
presentano un andamento molto diverso dalle due precedenti, suggerendo il ruolo dell’NaCl e del
calcio nel modificare il DRI. Più che altro bisogna notare il tempo, espresso in volumi crescenti di
soluzione, ai quali si trovano i picchi. Tuttavia resta ancora da determinare la natura della modifica
e l’entità. Nel prossimo riquadro verrà studiata la situazione che si verifica nella II e nella IV
soluzione, in quanto in queste due soluzioni vi è una sovrapposizione del primo picco (8 ml) mentre
il secondo picco è spostato. Tale variazione è indice che in queste soluzioni è avvenuto qualcosa ed
è ovvio che, siccome anche la concentrazione di NaCl influenza i risultati, verranno studiate solo
quelle soluzioni con la stessa concentrazione di NaCl.
WESTERN BLOT Il western blot o immunofissazione è una tecnica biochimica che permette di identificare una
determinata proteina in una miscela di proteine, mediante il riconoscimento da parte di anticorpi
specifici; in generale, per facilitare il riconoscimento, la miscela di proteine viene prima separata in
base alle loro dimensioni (o peso molecolare) utilizzando un gel di poliacrilammide (ma esistono
variazioni quali il dot blot o slot blot, in cui la miscela proteica non viene separata in base alle
dimensioni, ma ci si affida alla selettività antigene/anticorpo); successivamente le proteine vengono
trasferite su di un supporto, che comunemente è una membrana di nitrocellulosa, e quindi si procede
al riconoscimento vero e proprio della proteina mediante l'utilizzo di un anticorpo specifico.
Recentemente sono state messe a punto tecniche che permettono il riconoscimento
antigene/anticorpo direttamente nella matrice del gel, evitando quindi il trasferimento su membrana.
Questa tecnica si usa quando il campione corso è composto da una miscela di moltissime proteine
tali che con una colorazione standard (blu coomassie o nitrato di argento) non si riuscirebbe a
distinguerle l'una dall'altra, oppure quando, pur avendo bande ben distinte (discrete), la proteina di
interesse è in quantità troppo basse per essere visualizzata con altre tecniche. Infatti il western
possiede tre passaggi in cui avviene l'amplificazione del segnale, ciò rende visibili anche decimi di
picomole (10-10mol) di proteina.
COMMENTO RIQUADRO C Nel riquadro C si cerca di capire cosa avviene alla massa della proteina nei momenti dei picchi
analizzati nel riquadro B. I picchi qui sono presenti a diversi volumi poiché viene utilizzata un’altra
tecnica. Per poter far ciò i ricercatori hanno effettuato un western blot, determinando le dimensioni.
Vengono prese in esame due soluzioni:
I.
Linea rossa: soluzione a 500 mM di NaCl con aggiunta di 2 mM di EDTA e EGTA. In
questo caso si nota un addensamento preciso della proteina. L’addensamento corrisponde ad
una massa compresa tra i 104-105 Daltons; inoltre da notare il valore del DRI, che si attesta
intorno allo 0,25, sottolineando l’omogeneità della struttura proteica in questa situazione;
II.
Linea nera: soluzione a 500 mM di NaCl e aggiunta di CaCl2. In questo caso è presente
un’area di distribuzione della proteina, con massa compresa tra 105-106 Daltons. In questo
caso, l’”area proteica” presenta un intervallo di DRI compreso tra 0,50-0,75, concludendo
quindi che in questo caso che il campo proteico è meno omogeneo rispetto al precedente.
Inoltre, una parte della curva nera, presenta un andamento simile alla curva rossa, cioè non
tutta la fibulina è dimerizzata. Di conseguenza si raggiunge un equilibrio.
Con questo riquadro, è stata sottolineata la variazione di massa della fibulina-5 a seguito
dell’aggiunta del calcio e di come esista in due forme. Nel primo caso non si è avuta variazione di
massa data la presenza degli agenti chelanti. C’è da dire che anche il sodio, seppure in misura
minore, modifica la conformazione della fibulina-5.
Da questi parametri è stato poi possibile determinare le dimensioni della proteina, prelevandola
dalla rispettiva banda di corsa.
SVEDBERG Lo svedberg (simbolo S) è un'unità di misura del tasso di sedimentazione che non fa parte del
Sistema Internazionale. Uno svedberg, dimensionalmente uguale ad una unità di tempo, è pari a 1013
secondi. L'unità prende il nome dal quello del fisico e chimico svedese Theodor Svedberg,
vincitore del Premio Nobel per la chimica nel 1926 per il suo lavoro sulla chimica dei colloidi e
l'invenzione dell'ultracentrifuga.
Nell'ultracentrifugazione, il tasso di sedimentazione di una particolare macromolecola è calcolato
dividendo la velocità di sedimentazione costante (espressa in m/s) per l'accelerazione applicata
(espressa in m/s2) e moltiplicando poi per 1013. Il coefficiente di sedimentazione è proporzionale
alla massa e al raggio della particella in soluzione.
RIQUADRO D Nell’ultimo riquadro è stato calcolato il coefficiente di sedimentazione delle proteine nelle due
soluzioni osservate nel riquadro C. Inoltre i valori ottenuti sono stati messi in relazione con un
indice di distribuzione della concentrazione, c(s). Passiamo ai risultati:
I.
Linea rossa: soluzione 500 mM di NaCl e 2 mM di EDTA ed EGTA. La proteina in questo
caso presenta un coefficiente di sedimentazione intorno ai 3,6 S. Inoltre l’indice di
distribuzione della concentrazione sottolinea che la proteina, in tale soluzione sia tutta
presente in un’unica forma;
II.
Linea nera: soluzione 500 mM di NaCl e 2 mM di CaCl2. In questo caso il coefficiente di
sedimentazione presenta un picco a 5,3 S, sottolineando una variazione di massa del soluto.
La non omogeneità dell’indice di distribuzione indica l’esistenza di un possibile equilibrio
chimico tra le due forme, equilibrio chimico che verrà indagato successivamente.
Concludendo, alla luce di tali esperimenti, alla componente proteica con coefficiente di
sedimentazione pari a 3,6 S e massa compresa tra 104-105 Daltons e stato assegnata la forma
monometrica della fibulina-5. L’altra componente proteica, con massa il doppio rispetto a quella
della fibulina monometrica e coefficiente di sedimentazione pari a 5,3 S è stato assegnata la forma
di fibulina-5 dimerica. L’ulteriore computo della massa delle due aree proteiche ha poi portato a
conferma di tale ipotesi. Infine, da notare la stretta correlazione tra i suddetti parametri fisici, la
presenza di agenti chelanti, e l’aggiunta di calcio.
Nelle soluzioni prese in esame si formano anche degli oligomeri di fibulina (HOO), che quindi
tendono ad alterare i valori ottenuti. Tuttavia ancora non si sa se in vivo tali oligomeri esistano o
meno.
CONSIDERAZIONI SULL’EQUILIBRIO TERMODINAMICO La figura 2 esamina le variazioni di alcuni parametri termodinamici in funzione della
concentrazione di NaCl e CaCl2. Le due curve sono da riferire alla costante di dissociazione, Kd, e
al rapporto tra massa media della proteina e massa monometrica.
Nel riquadro A possiamo notare come aumentando la concentrazione di NaCl il rapporto tra
AM/MM aumenti (curva blu). Ciò vuol dire che il sale in soluzione favorisce la dimerizzazione
della fibulina-5. Infatti il numeratore, cioè la massa monometrica è costante, di conseguenza,
siccome si formeranno alcuni dimeri di fibulina, aumentando la massa media, il valore del rapporto
aumenta, assestandosi ad un valore di 1,4. Osservando la linea nera, notiamo che la Kd, ovvero la
presenza del sale facilita la formazione del dimero rallentando il ritorno di quest’ultimo nella forma
monometrica, oppure è il sale stesso che complessandosi con il monomero agisce da catalizzatore
per la formazione del dimero. La costante di dissociazione per l’NaCl raggiunge un valore minimo
di circa 10 µM.
Nel riquadro B viene aggiunto CaCl2 ma l’effetto del calcio è molto più potente. Ciò lo si deduce da
due dati molto importanti:
I.
Per concentrazioni molto basse di calcio, se paragonate a quelle dell’NaCl, il rapporto
AM/MM è di circa 1,7, ovvero il calcio favorisce nettamente l’aumento della massa media
del soluto, aumentando la concentrazione del dimero di fibulina;
II.
La Kd è di circa 1 µM, ovvero il calcio favorisce la formazione del dimero dieci volte di più
rispetto all’NaCl. In altri termini, il calcio sposta la reazione verso la dimerizzazione, questo
perché la fibulina-5 presenta un certo numero di siti leganti il calcio.
CONCLUSIONE Molto probabilmente, in soluzioni fisiologiche, la fibulina-5 è presente maggiormente nella forma
dimerica. Tuttavia resta ancora da provare quale delle due forme sia effettivamente implicata
nell’elastinogenesi e in tutta quella serie di processi che pone la fibulina-5 come “pace-maker” della
ECM.
PARTE IV MACULOPATIA DEGENERATIVA Col termine maculopatia si intende qualsiasi malattia che colpisce la macula, la zona della retina
che serve alla visione centrale distinta (consente di riconoscere i volti, di leggere, di guidare...). Al
centro della macula – che si trova a sua volta al centro della retina – c’è la fovea: si tratta di una
depressione retinica dove si trova la foveola, la zona centrale più sottile in cui sono presenti solo i
coni: si tratta dei fotorecettori – ossia di cellule in grado di trasformare i segnali luminosi in impulsi
elettrochimici – responsabili della visione centrale e della percezione dei colori (a differenza dei
bastoncelli, utilizzati per la visione notturna, abbondanti nella periferia retinica).
Il sintomo principale delle maculopatie è una caratteristica perdita della funzione visiva: chi è
affetto da patologia maculare accusa una perdita di visione al centro del campo visivo (scotoma
positivo), da non confondere con la visione di una macchia nera nella zona centrale del campo
visivo (scotoma negativo), come denunciato da pazienti colpiti da neurite ottica. Altro sintomo
comune nelle maculopatie è la distorsione delle immagini (metamorfopsie). Ad esempio, le righe di
congiunzione delle piastrelle non si vedono più diritte. Sintomi di minore frequenza sono le errate
percezioni della dimensione degli oggetti osservati.
Per una corretta diagnosi si usa il cosiddetto test di Amsler, una griglia di linee perpendicolari al cui
centro compare un piccolo disco nero.
Tra le forme più comuni di maculopatia c'è la degenerazione maculare senile (Amd) che può
provocare cecità centrale; è considerata la prima causa di perdita della vista in Occidente (41% dei
non vedenti secondo l'Oms).
In uno studio è stato dimostrato come, l’aumento della produzione di antiossidanti e il decremento
degli enzimi neutralizzanti i radicali liberi, tra i quali la SOD, sono da mettere in correlazione con la
degenerazione maculare senile. Infatti la retina, data la sua funzione, è perennemente esposta a
radiazioni ionizzanti, da qui deriva il ruolo centrale di scavangers ed enzimi neutralizzanti i radicali
liberi in tale distretto corporeo.
SUPEROSSIDODISMUTASI O SOD L'enzima superossido dismutasi (SOD), che appartiene alla classe delle ossidoreduttasi, catalizza la
seguente reazione:
2 O2.- + 2 H+ ⇌ O2 + H2O2
Si tratta quindi di un importante antiossidante in quasi tutte le cellule esposte all'ossigeno. Una delle
estremamente rare eccezioni è costituita dal Lactobacillus plantarum e relativi lactobacilli, che
usano un meccanismo diverso.
La dismutazione catalizzata dalla SOD può essere scritta con le seguenti semi-reazioni:
M(n+1)+ − SOD + O2− → Mn+ − SOD + O2
Mn+ − SOD + O2− + 2H+ → M(n+1)+ − SOD + H2O2.
dove M = Cu (n=1) ; Mn (n=2) ; Fe (n=2) ; Ni (n=2).
In questa reazione lo stato di ossidazione del catione metallico oscilla tra n e n+1.
Esistono molte forme comuni di SOD: sono proteine cofattorate con rame e zinco, o manganese,
ferro, o nichel.
I citosol di praticamente tutte le cellule eucariote contengono enzima SOD con rame e zinco (CuZn-SOD). (Per esempio, Cu-Zn-SOD disponibile in commercio è normalmente purificata dagli
eritrociti bovini: PDB 1SXA, EC 1.15.1.1). L'enzima Cu-Zn è un omodimero di peso molecolare
32,500. Le due subunità sono unite innanzitutto grazie a interazioni idrofobiche ed elettrostatiche. I
legami di rame e zinco sono catene laterali all'istidina.
I mitocondri del fegato dei polli (e quasi tutti gli altri), e molti batteri (come l' E. coli) contengono
una forma con manganese (Mn-SOD). (Per esempio, la Mn-SOD trovata in un mitocondrio umano:
PDB 1N0J, EC 1.15.1.1). I legami degli ioni manganese sono 3 catene laterali all'istidina, una
catena laterale all'aspartato e una molecola d'acqua o legame ossidrile a seconda dello stato di
ossidazione del Mn (rispettivamete II e III). E. coli e molti altri batteri contengono anche una forma
dell'enzima con ferro (Fe-SOD); alcuni batteri contengono Fe-SOD, altri Mn-SOD, e altri entrambi.
(Per l'E. coli Fe-SOD: PDB 1ISA, EC 1.15.1.1). I siti attivi delle superossido dismutasi contenenti
Mn e Fe contengono lo stesso tipo di amminoacidi nelle catene laterali.
Nell'uomo, sono presenti tre forme di superossido dismutasi. La SOD1 si trova nel citoplasma, la
SOD2 nei mitocondri mentre la SOD3 è extracellulare. La prima è un dimero (consiste di due
unità), mentre le altre sono tetrameri (quattro subunità). La SOD1 e la SOD3 contengono rame e
zinco, mentre la SOD2 ha la manganese nel suo centro di reazione. I geni sono collocati nei
cromosomi 21, 6 e 4, rispettivamente (21q22.1, 6q25.3 and 4p15.3-p15.1).
L'anione superossido radicale (O2-) dismuta spontaneamente in O2 e H2O2 abbastanza rapidamente
(~105 M-1 s-1 a pH 7). Ciononostante, il superossido reagisce ancora più rapidamente in presenza di
gruppi come il monossido di azoto, che può formare perossinitrito. Comunque, la SOD ha il più
rapido numero di turnover (velocità di reazione con il suo substrato) di ogni altro enzima conosciuto
(~109 M-1 s-1), essendo la reazione limitata solo dalla frequenza di collisione tra la stessa e il
superossido. Così la SOD catalizza reazioni pericolose del superossido proteggendo la cellula dalla
tossicità del superossido.
Il superossido è uno dei maggiori agenti ossidanti nella cellula e di conseguenza, la SOD ha un
ruolo antiossidante chiave. L'importanza fisiologica delle SOD è visualizzabile dalle gravi patologie
evidenti nei topi modificati geneticamente per mancare di questi enzimi. I topi mancanti della
SOD2 muoiono pochi giorni dopo la nascita, a causa del forte stress ossidativo. Quelli in cui manca
la SOD1 sviluppano una gran varietà di patologie, tra cui il carcinoma epatocellulare,
un'accelerazione della perdita di massa muscolare legata all'età, un'incidenza precoce della cataratta
ed una speranza di vita minore. Quelli che mancano della SOD3 non mostrano nessun difetto
evidente ed hanno una normale aspettativa di vita.
Mutazioni nel primo enzima SOD (SOD1) sono state collegate alla Sclerosi laterale amiotrofica
familiare (ALS, una forma di malattia dei motoneuroni). Gli altri due tipo non sono stati collegati ad
alcuna malattia umana; comunque nel topo l'inattivazione di SOD2 è causa di mortalità prenatale e
l'inattivazione di SOD1 provoca epatocarcinoma. Mutazioni di SOD1 possono causare ALS
familiare tramite un meccanismo che al momento ancora non si conosce, ma che non è dovuto alla
perdita dell'attività enzimatica.
La SOD viene usata nei prodotti cosmetici per ridurre il danno da radicali liberi sulla pelle, per
esempio per ridurre una fibrosi dovuta alle radiazioni in caso di cancro al seno. Gli studi sul suo
impiego cosmetico devono essere comunque giudicati come tentativi, poiché non ci sono stati
controlli adeguati durante lo svolgimento, compresa una mancanza di randomizzazione, del doppio
cieco o del placebo.
DEGENERAZIONE MACULARE SENILE La DMS è una alterazione progressiva della regione centrale del tessuto retinico, la macula,
deputata alla visione centrale, cioè alla distinzione dei dettagli più fini delle immagini ed al
riconoscimento dei colori.
Tale alterazione può provocare una drastica riduzione del campo visivo, ledendo grandemente
l'autonomia della persona. Nei paesi industrializzati la DMS rappresenta la prima causa di cecità
legale.
La malattia è stata individuata alla fine dell'800, ma soltanto negli ultimi decenni il miglioramento
delle tecniche diagnostiche - soprattutto con l'utilizzo della fluoroangiografia - ha permesso di
individuare precocemente i quadri clinici.
Gli sforzi attuali dell'oftalmologia mirano al riconoscimento tempestivo delle lesioni retiniche
iniziali, le cosiddette DRUSEN (dal tedesco Geode). Nella fase iniziale della DMS, infatti, i
pazienti non lamentano sintomi, godono ancora di una buona vista e solo l'esame fluoroangiografico
è in grado di rilevare le lesioni maculari in fase iniziale.
La degenerazione maculare senile può assumere due forme: quella secca o atrofica e quella umida
o essudativa.
La forma secca è certamente la più comune, colpendo circa il 10% della popolazione con più di 60
anni, ha un'evoluzione lenta e non prevedibile nei tempi (la riduzione del visus varia da caso a caso)
ed è caratterizzata da atrofia più o meno estesa dell'epitelio pigmentato e da drusen.
La forma umida, più rara (colpisce circa il 2% della popolazione oltre i 60 anni), ma più grave, ha
un andamento rapido e progressivo ed è caratterizzata da una neovascolarizzazione coroideale che
interessa l'epitelio pigmentato e la neuroretina.
Il progredire dell'età favorisce un peggioramento delle condizioni del neuroepitelio retinico: l'atrofia
geografica rappresenta l'evoluzione finale della degenerazione maculare senile, caratterizzata da
atrofia dell'epitelio pigmentato, danno irreversibile dei fotorecettori e della coriocapillare.
La DMS è una malattia multifattoriale correlata alla predisposizione genetica, all'invecchiamento,
all'esposizione ad ambienti sfavorevoli e allo stile di vita.
Questi fattori, oltre a svolgere un danno diretto sull'organismo, modificano la disponibilità e la
necessità di elementi nutrizionali con funzione strutturale e protettiva.
A prescindere da tutti gli altri fattori sembra che sia proprio l'età, cioè l'invecchiamento
dell'organismo, a creare il substrato sul quale può successivamente instaurarsi il danno della DMS.
Il danno ossidativo fotochimico costituisce un aspetto importante nella patogenesi della DMS.
Il selenio e altri oligoelementi contribuiscono ad assicurare l'efficienza di complessi enzimatici
essenziali nell'ambito delle difese contro lo stress ossidativo. Le vitamine antiossidanti A, C ed E
sono in grado di svolgere un ruolo profilattico nei confronti del danno maculare legato all'età.
I carotenoidi proteggono l'area maculare, mentre gli acidi grassi ω3 sono fondamentali per le foro
funzioni strutturali.
Attualmente non vi sono strategie preventive sicure a causa della scarsa conoscenza dell'eziologia
della malattia; certamente esiste una componente genetica, ma il tipo e il numero dei geni coinvolti
risultano difficili da definire, anche per il fatto che si tratta di una malattia ad insorgenza senile.
Alcuni studiosi hanno rilevato l'importanza del ruolo dei radicali liberi nell'evoluzione della
degenerazione maculare senile, e consigliano quindi, in forma di prevenzione, una terapia
antiossidante a base di vitamine A, C ed E. L'obiettivo è quello di mantenere il pool antiossidante a
livelli adeguati intervenendo sullo stile di vita e ricorrendo, quando necessario, all'integrazione.
L'esposizione all'ambiente esterno, alla luce e a fattori tossici, ma anche i processi fisiologici, come
il metabolismo e l'invecchiamento, innescano numerose reazioni ossidative a livello della retina,
responsabili della sintesi di radicali liberi. La lesività di questi composti è correlata alla loro
capacità di indurre un danno tipo ossidativo a livello delle membrane e dei sistemi enzimatici
cellulari.
Per la formazione di radicali liberi occorrono due principali elementi: una fonte di energia e
l'ossigeno. Per quanto riguarda l'occhio, la via più comune di danno ossidativo è quella fotochimica.
L'energia luminosa, soprattutto quella ultravioletta, può infatti venire assorbita da molecole sensibili
che reagiscono con particolari substrati o con ossigeno molecolare. La luce che raggiunge la macula
è in grado di danneggiare sia l'epitelio pigmentato che i fotorecettori, specialmente i coni che
rispondono alla luce blu. Tra i composti sensibili a tali processi vanno annoverati in primo luogo i
lipidi polinsaturi di membrana e poi i citocromi, gli enzimi flavinici dei mitocondri, la ribofiavina
libera e altri ancora. La protezione nei confronti dei radicali liberi, essenziale per i sistemi cellulari,
è assicurata dall'interazione di sistemi di origine endogena con fattori esogeni di tipo nutrizionale
che agiscono come cofattori enzimatici o come antiossidanti (es. vitamine, carotenoidi).
Nell'ambiente extracellulare, nel citoplasma e nei mitocondri la superossido dismutasi che contiene
zinco e richiede la presenza di selenio come cofattore, elimina l'anione superossido e lo trasforma in
ossigeno e perossido d'idrogeno. Anche la vitamina E è in grado di neutralizzare i radicali liberi, in
particolare il radicale idrossile e l'anione superossido. Localizzata nello strato fosfolipidico della
membrana cellulare, questa vitamina preleva un elettrone dagli acidi grassi polinsaturi ossidati
passando da tocoferolo a tocoferile; in seguito viene "riattivata" dalla vitamina C.
Recentemente è stato scoperto che la somministrazione di vitamine ed oligoelementi ad azione
antiossidante può avere un ruolo di rilievo nella prevenzione di questa patologia. In alcuni studi
pilota sono stati somministrati farmaci ad azione antiangiogenetica come l'interferone, ma i risultati
sono stati contraddittori.
Attualmente la forma secca risulta non trattabile, mentre per quella umida esistono alcuni tipi di
intervento.
I farmaci antiangiogenici sono sostanze farmacologiche che attaccano selettivamente i vasi in
proliferazione senza intaccare il tessuto fisiologico.
La radioterapia, che usata a bassi livelli non dà effetti collaterali, agisce sulle cellule endoteliali
vascolari riducendone la proliferazione e l'evoluzione della malattia.
La terapia fotodinamica. caratterizzata dall'utilizzo contemporaneo di un tipo particolare di Laser in
associazione con una sostanza chimica.
La laserterapia si è dimostrata utile nel ridurre la perdita visiva centrale a lungo termine dovuta ad
alcune forme di neovascolarizzazione. Solo una piccola parte dei pazienti può, però, essere trattata
con il laser (solo quando la membrana è extrafoveale o juxafoveale; in presenza di membrane
sottofoveali, solo se la lesione è molto piccola e circoscritta); inoltre più della metà dei pazienti
sottoposti all'intervento laser presentano recidive entro tre anni.
La rimozione chirurgica della membrana presenta alcuni vantaggi rispetto alla laserterapia in quanto
danneggia meno i tessuti circostanti. Il rischio di recidiva, però, permane, al quale si aggiunge
quello di insorgenza di cataratta e di distacco di retina; il recupero funzionale richiede buone
condizioni della retina circostante.
La riabilitazione visiva dei pazienti con grave calo del visus dovuto a degenerazione maculare
senile è un problema che in molti casi non riceve dall'oculista la giusta attenzione.
Spesso il paziente ha perso la normale visione centrale, per la formazione di una cicatrice centrale
(scotoma centrale), ma non è cieco in senso assoluto, ha cioè una residua capacità visiva periferica:
questa deve essere allenata e rafforzata per salvaguardare al meglio l'autonomia visiva del soggetto.
In tal modo è possibile migliorare anche notevolmente la qualità della vita dell'anziano con
ipovisione. Il programma riabilitativo del paziente ipovedente è complesso ed impegnativo e
comprende l'uso di lenti di ingrandimento, di telescopi galileiani per la visione per lontano, di
videoingranditori. L'utilizzo di filtri colorati, gialli, ambra o grigi può aiutare ad aumentare la
nitidezza delle immagini e la velocità di lettura. Assai importante, nell'affrontare i casi di
minorazione visiva, è l'approccio pluridisciplinare. La collaborazione dell'oculista e dell'ortottista
nel prescrivere ed indicare la correzione ottica deve essere completata dalla consulenza dello
psicologo, professionista in grado di motivare ed incentivare il paziente anziano nell'utilizzo di
ausili ottici.
TERAPIE Dal mondo della ricerca giungono oggi notizie molto confortanti su nuove e rivoluzionarie
possibilità terapeutiche: la terapia fotodinamica con verteporfina potrebbe significare una svolta
nella terapia della degenerazione maculare senile di tipo umido. Si tratta però di un trattamento
complesso che richiede personale altamente specializzato, adeguate strutture di riferimento e
soprattutto costi economici elevati. Scopo della terapia fotodinamica, già ampiamente studiata ed
utilizzata nel campo dell'oncologia per il trattamento dei tumori dermatologici, è quello di
distruggere la membrana neovascolare maculare attraverso l'iniezione endovenosa di una sostanza
farmacologica fotosensitiva che viene attivata mediante trattamento laser.
La Verteporfina, il farmaco fotosensitivo utilizzato nella terapia fotodinamica, svolge una potente
azione citotossica, legata all'induzione di una trombosi intraluminale con conseguente eliminazione
di apporto sanguigno al tessuto patologico. Essa si accumula selettivamente nelle cellule endoteliali
dei neovasi. La sua attivazione avviene con l'applicazione di un raggio laser sulle aree da trattare, di
lunghezza d'onda pari al picco di assorbimento della sostanza stessa. Il raggio laser utilizzato non è
ad azione termica e di conseguenza non provoca danni alla retina sovrastante La verteporfina è oggi
in fase di sperimentazione per occludere selettivamente i neovasi nella degenerazione maculare
senile. La sicurezza, l'efficacia e la selettività di questa terapia sono state dimostrate attraverso studi
sperimentali aventi lo scopo di rilevare la dose ottimale di verteporfina, il tempo di irraggiamento e
la lunghezza d'onda del raggio laser nel bloccare la diffusione della fluorescina e quindi distruggere
i neovasi. I risultati sono stati incoraggianti. Per le potenzialità di successo che racchiude, la terapia
fotodinamica con verteporfina rappresenta certamente un grande passo in avanti nel tentativo di
preservare ed eventualmente potenziare il residuo visivo nei pazienti affetti da degenerazione
maculare senile di tipo umido; tutto ciò in attesa del recupero della funzione visiva (trapianto
dell'epitelio pigmentato), se gli attuali esperimenti condotti su animali potranno avere un'attuazione
clinica.
L'analisi dei risultati ottenuti nel corso degli ultimi due anni della degenerazione maculare senile
con la terapia fotodinamica conferma i promettenti risultati ottenuti durante le fasi sperimentali.
Nella terapia viene utilizzata una sostanza chiamata Verteporfin (Commercialmente Visudyne Ciba Vision). Tale sostanza è un agente fototerapeutico. La sua azione viene ottenuta in due fasi.
Nella prima fase la verteporfin viene somministrata per via endovenosa, con il paziente seduto,
nell'arco di 10 minuti. E' necessario poi attendere altri 5 minuti dopo il termine della iniezione. In
questo periodo la sostanza va ad accumularsi selettivamente, a livello oculare, nei vasi anomali
dell'area affetta da degenerazione. Nella seconda fase viene effettuata la applicazione di un
trattamento laser di lunghezza d'onda di 690 nanometri. Questa luce ha l'intensità di un flash ed è
incapace di determinare lesioni termiche della retina. Lo spot del laser viene applicato sulla zona
interessata per 83 secondi. Durante questo tempo si ottiene l’attivazione della sostanza che
distrugge così soltanto i vasi e i tessuti coinvolti nel processo di neovascolarizzazione coroideale.
CORRELAZIONE TRA SOD­FIBULINA­5­DEGENERAZIONE MACULARE SENILE Alla luce di tutti questi dati, sarebbe molto interessante cercare di capire se la fibulina-5 abbia un
ruolo in questa forma di maculopatia. Infatti un aumento dello stress ossidativo comporta una
risposta infiammatoria, durante la quale la ECM viene modificata e si assiste a neoangiogenesi.
Interessante sarebbe capire come la fibulina-5 intervenga nell’espressione della SOD extracellulare,
oppure se sia la fibulina-5 stessa a mediare la neoangiogenesi, che è poi la causa di cecità.
Attualmente nessun lavoro è stato svolto con l’intenzione di correlare questi tre fattori. Tuttavia,
ritengo che il trittico, SOD-Fibulina-5- maculopatia possa essere interessante nonché, forse, possa
chiarire alcuni processi della angiogenesi tuttora sconosciuti. Per fare un esempio basti immaginare
se sia la stessa fubulina-5 a mediare l’angiogenesi. Come molto spesso accade, in medicina,
qualunque studio presenta effetti trasversali in tutte le discipline. Dimostrare il legame tra tutti
questi fattori potrebbe aprire la strada a campi di ricerca mai percorsi per particolari patologie di
elevata incidenza (non solo maculopatie, ma anche cancro, e fibrosi).
ATEROSCLEROSI L'aterosclerosi è una malattia infiammatoria cronica delle arterie di grande e medio calibro che si
instaura a causa dei fattori di rischio cardiovascolare: fumo, ipercolesterolemia, diabete mellito,
ipertensione, obesità, iperomocisteinemia; si sospetta che possano esservi anche altre cause, in
particolare di natura infettiva e immunologica. Anatomicamente, la lesione caratteristica
dell'aterosclerosi è l'ateroma o placca aterosclerotica, ossia un ispessimento dell'intima (lo strato più
interno delle arterie, che è rivestito dall'endotelio ed è in diretto contatto con il sangue) delle arterie
dovuto principalmente all'accumulo di materiale lipidico (grasso) e a proliferazione del tessuto
connettivo.
Clinicamente l'aterosclerosi può essere asintomatica oppure manifestarsi, di solito dai 40-50 anni in
su, con fenomeni ischemici acuti o cronici, che colpiscono principalmente cuore, encefalo, arti
inferiori e intestino.
Il termine aterosclerosi è stato proposto da Marchand nel 1904 per sottolineare la presenza
dell'ateroma (dal greco athere, che significa "pappa", ad indicare il materiale grasso, poltaceo,
contenuto nelle placche). Le lesioni, che hanno come caratteristica specifica la componente lipidica
più o meno abbondante, si evolvono con il tempo: iniziano nell'infanzia come strie lipidiche (a
carattere reversibile) e tendono a divenire vere e proprie placche aterosclerotiche, che nelle fasi
avanzate possono restringere (stenosi) il lume arterioso oppure ulcerarsi e complicarsi con una
trombosi sovrapposta, che può portare ad una occlusione dell'arteria.
Per arteriosclerosi si intende invece un indurimento (sclerosi) della parete arteriosa che compare
con il progredire dell'età. Questo indurimento arterioso è la conseguenza dell'accumulo di tessuto
connettivale fibroso a scapito della componente elastica.
Gli eventi iniziali nella formazione dell'aterosclerosi (aterogenesi) vanno identificati nel danno
dell'endotelio (danno funzionale o disfunzione endoteliale) e nell'accumulo e successiva
modificazione (aggregazione, ossidazione e/o glicosilazione) delle lipoproteine a bassa densità
(LDL) nell'intima delle arterie, due eventi che si influenzano a vicenda.
L'accumulo delle LDL è dovuto non solo all'aumento della permeabilità dell'endotelio
funzionalmente o anatomicamente danneggiato, ma anche al loro legarsi ai costituenti della matrice
extracellulare dell'intima; legame che aumenta il tempo di residenza in loco delle lipoproteine. Un
fattore importante che causa un aumento della matrice connettivale intimale (ispessimento
dell'intima) è rappresentato dall'attrito della corrente sanguigna sulla superficie vasale (stress
emodinamico), che è particolarmente accentuato in corrispondenza delle ramificazioni e delle
curvature dei vasi, sedi che risultano particolarmente predisposte alla sviluppo delle lesioni
aterosclerotiche.
La disfunzione/attivazione endoteliale, ad opera dei fattori di rischio cardiovascolare, è seguita
dall'adesione e migrazione di monociti e linfociti T nell'intima in risposta all'espressione sulla
superficie endoteliale di molecole adesive (Selettine, VCAM-1, ICAM-1) e ai segnali chemiotattici
(MCP-1) emessi dall'endotelio danneggiato (vedi endotelio: fisiologia dell'endotelio).
I macrofagi fagocitano le lipoproteine infiltrate ed ossidate nell'intima e si trasformano nelle cellule
schiumose, che caratterizzano le strie lipidiche (fatty streaks). La secrezione di citochine e di fattori
di crescita, principalmente di derivazione macrofagica, induce la migrazione delle cellule muscolari
lisce dalla media nell'intima, dove proliferano, si differenziano nel fenotipo “sintetico” e
sintetizzano matrice extracellulare, determinando la trasformazione delle fatty streak nelle lesioni
avanzate. Alla crescita delle lesioni può contribuire l'adesione di piastrine all'intima denudata e il
formarsi di trombi intramurali, conseguenti alla erosione/ulcerazione delle placche aterosclerotiche.
Quindi, nella patogenesi dell'aterosclerosi intervengono l'endotelio, i leucociti, le cellule muscolari
lisce e le piastrine e rivestono un ruolo fondamentale l'infiltrazione lipidica della parete arteriosa e
l'azione meccanica del flusso sanguigno sulle pareti dell'arteria.
Questa teoria unificata dell'aterosclerosi è il frutto di una lunga serie di teorie patogenetiche,
ciascuna delle quali ha di volta in volta posto l'attenzione su l'uno o l'altro dei molteplici fattori
patogenetici, a cominciare dalle teorie della “insudazione” [Virchow (1856), Anitchkov e Chalatov
(1913)] e della “incrostazione” [Rokitansky (1842), Duguid (1946)] fino ad arrivare alle più recenti
teorie della “risposta alla lesione endoteliale” (Ross e Glomset, 1973 e 1986) o della “risposta alla
ritenzione” di K. J. Williams e I. Tabas (1995), nella quale viene attribuita maggiore importanza
come fenomeno iniziale delle lesioni all'intrappolamento delle LDL nell'intima, piuttosto che ad un
iniziale danno endoteliale.
Contrariamente alla prima formulazione dell'ipotesi della “risposta al danno endoteliale” (Ross e
Golmset,1973), oggi è generalmente accettato che l'inizio dell'aterosclerosi non richieda un danno
endoteliale nella forma di desquamazione focale, con denudamento dell'intima e adesione
piastrinica. Piuttosto, un evento precoce dell'aterogenesi è identificato nell'alterazione funzionale
(disfunzione) dell'endotelio da parte delle noxae patogene. La compromissione dell’attività
endocrino-paracrina dell'endotelio è responsabile della disfunzione endoteliale. L'alterazione
funzionale si manifesta con l'espressione di molecole adesive alla superficie cellulare e con la
secrezione di sostanze biologicamente attive (citochine, fattori di crescita, radicali liberi), che sono
responsabili dell'adesione dei leucociti, ma anche di turbe delle proprietà emostatiche dell'endotelio,
della permeabilità alle proteine plasmatiche e del controllo del tono vasale.
Anche se la disfunzione riguarda tutte le funzioni endoteliali, la diagnosi di disfunzione endoteliale
avviene valutando solo alcuni aspetti significativi di essa, come l'entità della vasodilatazione
endotelio-dipendente nelle coronarie o nelle arterie brachiali, utilizzando l'infusione intra-arteriosa
di agonisti ed antagonisti endoteliali come il L.NMMA, inibitore della sintesi di ossido nitrico
(NO), a dosi che non determinano effetti sistemici, oppure misurando la vasodilatazione flussoindotta. Il termine “attivazione endoteliale” designa un tipo di disfunzione endoteliale caratterizzato
dall'acquisizione (per effetto di vari stimoli, citochine in primo luogo) di nuove proprietà funzionali
ed antigeniche riguardanti soprattutto l'interazione con i leucociti (De Caterina: European Heart
Journal 2003, 5 (Suppl. A), A15).
Il ruolo fondamentale nello sviluppo della reazione infiammatoria cronica dell'intima è svolto dalla
ossidazione delle LDL, che restano intrappolate nella matrice extracellulare dello spazio
subendoteliale. L'ossidazione delle LDL è dovuta ad enzimi e metaboliti ossidanti prodotti dalle
cellule della parete arteriosa, soprattutto dai monociti-macrofagi reclutati nell'intima in conseguenza
del danno endoteliale a varia eziologia.
Inizialmente, si ha la perossidazione della componente lipidica delle LDL, che interferisce
scarsamente sull'interazione delle LDL con il recettore ApoB-E (o LDL-R); tali MM-LDL (LDL
minimamente ossidate) sono “cavalli di Troia” (Hajjar: Journal of Biological Chemistry 1997,
272,22975), fisicamente simili alle LDL, ma con un carico di macromolecole bioattive, che viene
introdotto nella cellula con la endocitosi delle MM-LDL.
Nelle fasi successive, si generano prodotti dei lipidi perossidati e prodotti aldeidici (malondialdeide,
MDA; 4-idrossinonenale), che possono modificare covalentemente la componente proteica delle
LDL; queste OX-LDL “sabotatori cellulari” non vengono più riconosciute da LDL-R, ma si legano
agli "scavenger receptors" (SR: SR-A, CD36 e CD68). Poiché gli SR non sono soggetti a
regolazione a feedback-negativo, le OX-LDL non solo introducono nelle cellule che le fagocitano
macromolecole attive, ma in aggiunta causano l'accumulo intracellulare di esteri del colesterolo,
responsabile della trasformazione in cellule schiumose o foam cells, caratteristiche del tessuto
aterosclerotico.
L'interazione con i corrispondenti recettori LDL-R e SR (e la conseguente generazione di
messaggeri intracellulari, in particolare i radicali liberi dell'ossigeno o ROS) e l'introduzione nella
cellula di prodotti ossidati sono la base biochimica dell'azione patogena delle LDL. Le OX-LDL
attivano nelle cellule (endotelio, macrofagi, cellule muscolari lisce), alcuni fattori di trascrizione
(es. NF-kB), che inducono l'espressione di geni che codificano per molecole adesive, citochine e
fattori di crescita e che danno l'avvio alla risposta infiammatoria.
Ad esempio, nell'endotelio, i geni per le molecole adesive ICAM-1, VCAM-1 e E selettina, per il
fattore chemiotattico MCP-1 e per il Fattore Tessutale sono sotto il controllo del fattore di
trascrizione redox-sensibile NF-kB. Kume N. nel 1991 ha suggerito che le cellule endoteliali
assorbono le OX-LDL attraverso una via recettoriale che non coinvolge gli scavenger receptors.
Sawamura, T., N. Kume, e altri nel 1997 hanno identificato il primo recettore delle cellule
endoteliali per le Ox-LDL, che è stato denominato LOX-1 (lectinlike Ox-LDL receptor-1).
Gli studi sperimentali hanno attestato che le LDL ossidate possiedono numerose attività biologiche
sulle cellule della parete arteriosa, inclusa un'azione citotossica diretta e un'azione mitogena su
cellule muscolari lisce, macrofagi, fibroblasti e cellule endoteliali. Nell'endotelio inducono
l'espressione di molecole adesive per i leucociti; stimolano la produzione di sostanze chemiotattiche
(che in parte rimangono legate alla superficie endoteliale e in parte sono liberate nel subendotelio) e
favoriscono la sintesi di fattori di crescita per i monociti/macrofagi e per le cellule muscolari lisce;
stimolano la sintesi di PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1) e di fattore tessutale, promuovendo
la coagulazione; stimolano la produzione di endotelina e inibiscono quella di NO, inibendo la
vasodilatazione endotelio-dipendente. Sui macrofagi esercitano un effetto chemiotattico diretto;
determinano la trasformazione in cellule schiumose; stimolano la produzione di citochine, fattori di
crescita e metalloproteasi. Nelle cellule muscolari lisce inducono la sintesi di MCP-1. Infine le LDL
ossidate attivano le piastrine e ne provocano l'aggregazione.
Macroscopicamente l'aterosclerosi si manifesta fondamentalmente con tre lesioni elementari, che
rappresentano le fasi evolutive della malattia:
− stria lipidica;
− placca fibrosa;
− lesione complicata.
Le strie lipidiche sono strie allungate di 1-2 mm, ma talora raggiungono 1 cm o più, di colore
giallastro e bordi netti, che spiccano sul colore biancastro dell'intima; sono di solito piatte e
presentano una superficie liscia e continua. Si tratta di lesioni reversibili: in presenza dei fattori di
rischio cardiovascolare possono progredire nelle lesioni più avanzate, ma se questi mancano
possono regredire. Infatti le strie lipidiche dell'aorta sono estremamente frequenti anche nelle aree
geografiche dove l'incidenza dell'aterosclerosi avanzata è bassa, e strie lipidiche compaiono
nell'aorta di tutti i bambini che abbiano più di 1 anno, senza differenze razziali, geografiche ed
ambientali; possono essere presenti anche alla nascita. Nello studio di New Orleans (1952-1957)
compiuto da Strong e McGill sulle aorte di 526 soggetti deceduti fra 1 e 40 anni, le strie lipidiche
aumentavano rapidamente di estensione durante la pubertà. Nelle coronarie le strie lipidiche
compaiono verso la pubertà. Nello studio autoptico di Stary (1979-1986) sono state esaminate le
arterie coronarie di 560 soggetti tra 0 e 29 anni. Le strie lipidiche coronariche erano visibili dopo i
10 anni, con una incidenza del 50% nei bambini tra 10 e 15 anni.
La placca fibrosa consiste di un ispessimento circoscritto, sporgente sul piano dell'intima, di
colorito bianco perlaceo o lievemente giallognolo, di dimensioni varie, da qualche millimetro a
diversi cm. La superficie è liscia o alquanto scabra ma continua, la consistenza è dura. Alla sezione,
l'aspetto può essere omogeneo oppure variegato per la presenza di un centro decisamente giallo,
molle o poltaceo, unto e asportabile (la cosiddetta pappa ateromasica), ricoperto verso l'intima da un
rivestimento fibroso, detto cappa, duro e biancastro. Le placche ateromatose hanno nell'uomo una
distribuzione abbastanza costante: in ordine decrescente sono interessate: aorta addominale, fino
alla biforcazione delle arterie iliache, con maggiore gravità intorno agli osti delle diramazioni
maggiori; arterie coronarie, di solito entro i primi 6 cm; arterie poplitee, femorali e aorta toracica, in
particolare intorno agli osti delle arterie intercostali; carotidi interne. Sono invece di solito
risparmiati i vasi delle estremità superiori.
Le placche fibrose possono poi andare incontro ad ulteriori complicazioni (ulcerazione, emorragia,
trombosi, calcificazione), determinando così il terzo e più grave stadio aterosclerotico, le lesioni
complicate.
Le manifestazioni cliniche dell'aterosclerosi compaiono in genere dopo i quaranta-cinquanta anni di
età e sono dovute alla ischemia (riduzione del flusso ematico) nel letto vasale dipendente dall'arteria
lesa. La riduzione del flusso dipende sia dal restringimento del lume arterioso in corrispondenza
delle lesioni aterosclerotiche sia dalla presenza di meccanismi di compenso insufficienti. Il
principale meccanismo di compenso è rappresentato dall'instaurarsi di circoli collaterali, che
consentono al sangue di raggiungere i territori ipoirrorati attraverso i vasi adiacenti.
Le manifestazioni croniche sono conseguenti ad un restringimento stabile dell'arteria colpita, che
rende il flusso ematico fisso, cioè incapace di aumentare quando le condizioni funzionali lo
richiedono, come ad esempio durante gli sforzi fisici. Di conseguenza la sintomatologia, in
particolare il dolore, tende ad essere assente a riposo e a presentarsi in occasione di esercizio fisico
più o meno intenso, a seconda della gravità dell'ostruzione arteriosa e dell'efficienza dei circoli
collaterali. Tipiche sindromi croniche sono: angina pectoris stabile, angina abdominis, claudicatio
intermittens, nella quale il dolore insorge durante la deambulazione e scompare tipicamente dopo
pochi minuti di riposo.
Le manifestazioni acute sono invece il risultato di una improvvisa riduzione del lume arterioso, che
provoca una brusca riduzione del flusso ematico nel territorio dipendente. In genere l'occlusione
arteriosa è causata dalla rottura (fissurazione) di una placca aterosclerotica, con conseguente
trombosi in corrispondenza della ulcerazione. Raramente alla base delle manifestazioni acute vi può
essere uno spasmo vasale, che viene chiamato in causa quando gli esami angiografici non rilevano
alterazioni dei vasi. Sono sindromi ischemiche acute: angina pectoris instabile, infarto miocardico,
infarto intestinale, ictus ischemico.
I fattori responsabili della fissurazione della placca ateromatosa sono molteplici e complessi, ma
due fenomeni sembrano di particolare importanza: l'infiammazione della placca e la presenza di
una'abbondante componente lipidica, che renderebbero la placca meno resistente all'urto della
corrente ematica. Le cellule infiammatorie e soprattutto i macrofagi producono enzimi idrolitici
(metalloproteasi), capaci di lisare il collagene della cappa fibrosa, che diviene cosi meno resistente
agli stress emodinamici.
APOLIPOPROTEINE Le apolipoproteine sono proteine capaci di legare lipidi e sono costituenti delle lipoproteine,
aggregati molecolari deputati al trasporto di colesterolo e trigliceridi attraverso la circolazione ai
vari tessuti e organi. Sono molecole anfipatiche, come i fosfolipidi in cui si immergono nella
formazione delle lipoproteine, porgendo la loro faccia apolare verso l'interno delle stesse e quella
polare verso l'ambiente acquoso esterno.
Le apolipoproteine esistono in cinque diverse classi con relative sottoclassi, differenti per peso
molecolare, associazioni ed eventuale funzione:
− apoA1 che si associa con le lipoproteine ad alta densità (HDL);
− apoA2 che si associa anch'essa con le HDL;
− apoB100, si associa a VLDL e lipoproteine a bassa densità (LDL) ed è riconosciuta dal
recettore per le LDL (LDL-R);
− apoB48, si associa ai chilomicroni e costituisce poco meno della prima metà dell'apoB100 e
per questo motivo manca del tratto proteico riconosciuto da LDL-R;
− apoC1, si associa a VLDL e LDL;
− apoC2, è associata anche ai chilomicromi e attiva lipoproteina lipasi (LPL);
− apoC3, è associata anch'essa a VLDL, LDL e chilomicromi e inibisce la LPL;
− apoD, si associa a HDL ed è detta anche CETP (cholesterol esterificate trasferring protein);
− apoE, associata a chilomicromi, VLDL e LDL e promuove la rimozione delle VLDL e delle
rimanenze dei chilomicroni.
Le apolipoproteine svolgono tre funzioni principali e solo alcune delle loro sottoclassi assolvono a
ciascuna funzione. La prima funzione è quella di contribuire alla struttura delle lipoproteine; la
seconda funzione è di regolare l'attività enzimatica nel metabolismo lipidico; la terza, infine, è di
costituire dei ligandi per i recettori (come la già citata LPL, a livello dell'endotelio o HTL, a livello
del fegato).
Le apolipoproteine presentato a livello della struttura secondaria sia alfa eliche che foglietti beta
anfipatici, questo permette a queste proteine di interagire con il nucleo idrofobo delle lipoproteine e
anche di aggregare tra di loro, eventualmente passando da una lipoproteina ad un'altra, evento
particolarmente importante nel percorso delle VLDL e dei chilomicroni.
RELAZIONE TRA ATEROSCLEROSI E FIBULINA­5 In realtà non esiste una correlazione diretta tra aterosclerosi e fibulina-5. È ovvio il ruolo centrale
delle lipoproteine ossidate nella genesi di placche ateromasiche. Ma in realtà la fibulina-5 media
l’attività della SOD della matrice extracellulare. Infatti alcuni studi hanno messo in evidenza questa
relazione. Quindi in realtà il “giunto” nella genesi dei processi aterosclerotici è ancora una volta un
enzima ad attività antiossidante, la superossido dismutasi. Quindi anche qui troviamo una terna
logica: fibulina-5-SOD-ossidazione delle lipoproteine. È facile capire che forse la SOD, stoppando
la catena di reazioni di formazione di radicali liberi, stoppi anche il livello di ossidazione delle
lipoproteine. Altrettanto facile intuire la relazione diretta tra fibulina-5 e SOD. Si ritiene che la
fibulina-5 stimoli l’attività della SOD. Per quando riguarda le meccaniche di tale processo, il tutto
resta ancora materia di studio.
CUTIS LAXA La cutis laxa è un insieme di malattie del tessuto connettivo per cui la pelle perde elasticità,
mostrando piaghe.
Esistono varie forme di tale patologia, alcune sono benigne mentre ne esiste una in particolare le cui
complicanze cardiache possono risultare mortali.
Fra i sintomi e i segni clinici ritroviamo ritardo dello sviluppo, lassità della pelle, ernie, fino a
complicazioni quali enfisema polmonare e cuore polmonare.
Si distingue dalla sindrome di Ehlers-Danlos in quanto la pelle non mostra la caratteristica fragilità.
Altre patologie da cui occorre distinguerla sono la sindrome di Turner e la neurofibromatosi.
Non esiste un trattamento specifico, si ricorre alla chirurgia plastica per ovviare a deficienze fisiche.
CUTIS LAXA E FIBULINA­5 Una forma ereditaria di cutis laxa è direttamente correlata a mutazione del gene FBNL5. Alla luce
di quanto esposto, è facile capire come ciò possa avvenire. Ulteriori studi vengono condotti, ma,
come in molti altri casi, data la centralità della fibulina-5, questa patologia potrebbe essere solo il
grado più estremo, di un variegato gruppo di patologie. Gli sforzi della ricerca sono tesi a cercare di
capire le meccaniche nonché a cercare altre relazioni patologiche. Tuttavia, ritengo che sia
opportuno trattare brevemente di che cosa sia una mutazione.
MUTAZIONE Per mutazione genetica si intende ogni modificazione stabile nella sequenza nucleotidica di un
genoma o più generalmente di materiale genetico (sia DNA che RNA). Una mutazione modifica
quindi il genotipo di un individuo e può eventualmente modificarne il fenotipo a seconda delle sue
caratteristiche e delle interazioni con l'ambiente.
Le mutazioni sono gli elementi di base grazie ai quali possono svolgersi i processi evolutivi. Le
mutazioni determinano infatti la cosiddetta variabilità genetica, ovvero la condizione per cui gli
organismi differiscono tra loro per uno o più caratteri. Su questa variabilità, tramite la
ricombinazione genetica, opera la selezione naturale, la quale promuove le mutazioni favorevoli a
scapito di quelle sfavorevoli o addirittura letali. Essendo la maggior parte delle mutazioni non
favorevoli, gli organismi hanno sviluppato diversi meccanismi per la riparazione del DNA dai vari
danni che può subire, riducendo in questo modo il tasso di mutazione.
Le mutazioni vengono distinte dai genetisti in base alla loro scala di azione: l'alterazione può
riguardare un singolo gene, porzioni del genoma o l'intero corredo cromosomico.
Se le mutazioni avvengono in una cellula somatica queste, assieme ai relativi effetti, saranno
presenti in tutte le cellule da essa derivate per mitosi; alcune di queste mutazioni possono rendere le
cellule maligne e provocare cancro, e sono responsabili di alcune malformazioni congenite. Se le
mutazioni sono presenti nelle cellule delle linee germinali o nei gameti sono ereditate dalle
generazioni successive e possono eventualmente provocare malattie genetiche ereditarie.
Le mutazioni vengono generalmente classificate in due classi a seconda della loro origine.
Le mutazioni spontanee sono mutazioni provocate da fattori chimici endogeni e da errori nei
processi che si attuano sul materiale genetico; la definizione di mutazione spontanea è di mutazione
che avviene in assenza di agenti mutageni noti. Non sono molto frequenti, ma sono comunque
inevitabili vista la intrinseca imperfezione di ogni meccanismo molecolare. Gli errori possono
essere dovuti a:
− Tautomeria - una base è modificata per lo spostamento di un atomo di idrogeno;
− Deaminazione - reazione che trasforma una base azotata in una diversa; ad esempio provoca
la transizione C → U (che può essere riparata); c'è anche la deaminazione spontanea della 5metilcitosina in T e la deaminazione che determina A → HX (adenina → ipoxantina);
− Depurinazione - idrolisi del legame glicosidico e formazione di un nucleotide privo di base
(di solito G o A);
− Danni ossidativi - dovuti alla formazione spontanea nella cellula di specie con atomi di
ossigeno molto reattive, in grado di attaccare il DNA e causare danni al singolo o al doppio
filamento e danneggiamento delle basi azotate;
− Errori nei processi di replicazione, della ricombinazione e della riparazione del DNA. Ad
esempio può essere dovuta alla DNA polimerasi che aggiunge nucleotidi non corretti; ciò
può generare una trasversione se c'è lo scambio di una purina con una pirimidina o
viceversa; una transizione se c'è lo scambio di una purina con un'altra purina oppure di una
pirimidina con un'altra pirimidina.
Le mutazioni indotte sono invece prodotte dall'azione di particolari agenti fisici o chimici detti
appunto agenti mutageni. È detto mutagenesi il processo che determina una mutazione indotta e
mutagenizzato l'organismo in cui è stata prodotta. Si distinguono i danni per mutazioni indotte in:
− Sostituzione delle basi con molecole con struttura analoga a quelle comunemente presenti
nel DNA ma che formano appaiamenti diversi e quindi errati;
− Aggiunta di gruppi sostituenti alle basi azotate: anche in questo caso generando molecole
con capacità di appaiamento non corrette;
− Danneggiamento delle basi: rompendo legami o aggiungendone di nuovi rispetto alla
condizione normale;
− Inserzione o delezioni di basi.
I mutageni fisici sono soprattutto radiazioni ionizzanti (raggi X, raggi gamma) e non ionizzanti
(raggi UV); gli agenti chimici sono molto numerosi e appartengono a diverse classi di composti.
Oltre che per la natura i mutageni differiscono anche per spettro mutazionale, ovvero per il tipo (o i
tipi) di mutazione che possono provocare. Spesso una stessa conseguenza può essere causata da
mutageni diversi (anche per natura), anche se generalmente i meccanismi con cui essi hanno agito
sono profondamente diversi.
Una importante differenza tra mutageni fisici e chimici è che i primi agiscono indipendentemente
dall'organismo; i mutageni chimici invece possono avere effetti diversi in funzione del sistema
biologico. Mentre una radiazione, infatti, colpisce direttamente il materiale genetico, un composto
chimico può interagire con altre molecole (enzimi, metaboliti, specie reattive...) presenti nella
cellula che ne possono variare le caratteristiche.
Le mutazioni geniche sono le mutazioni che alterano un singolo gene e dunque le più "piccole" che
si possono avere. In quanto tali non sono visibili attraverso analisi al microscopio (tranne alcuni casi
estremi), ma possono essere riscontrate solo tramite analisi genetiche. Le mutazioni geniche portano
alla formazione di nuove forme geniche, ovvero di nuovi alleli, detti appunto alleli mutanti. In
quanto tali questi sono rari nella popolazione e si differenziano dagli alleli più diffusi detti invece
tipi selvatici. Bisogna però far distinzione anche tra alleli mutanti e morfi. I morfi sono infatti due o
più alleli di uno stesso gene con frequenza superiore all'1% (polimorfismo). Alla luce di questo ne
deriva che il concetto di mutazione non è assoluto: un gene potrà subire una mutazione; se l'allele
mutante però troverà le condizioni per diffondersi nella popolazione e superare la frequenza dell'1%
non si parlerà più di mutazione ma di morfo.
Possono essere distinte in due categorie: mutazioni puntiformi e mutazioni per sequenze ripetute. Le
prime sono causate da sostituzioni di basi o da inserzioni o delezioni di coppie di basi (mutazioni
frameshift). La seconda categoria comprende le mutazioni causate sempre da inserzioni o delezioni
ma di sequenze di basi ripetute.
Originariamente il termine mutazioni puntiformi indicava mutazioni che interessano un solo
nucleotide, ma è ormai comune classificarvi anche mutazioni di fino a 50 nucleotidi. Molte
mutazioni puntiformi sono probabilmente senza effetto. Gran parte del DNA in un genoma
eucariotico non codifica per prodotti proteici, ed è incerto se il cambiamento di una singola base
nucleotidica in questa parte silente del DNA possa influire sulla salute di un organismo.
Naturalmente, una singola mutazione puntiforme può invece avere un notevole impatto sul fenotipo,
come accade ad esempio nell'anemia falciforme.
Le sostituzioni di basi determinano uno scambio di un nucleotide con un altro. Sono definite
transizioni qualora vi è un scambio di una purina con altra purina (A ↔ G) o di una pirimidina con
un'altra pirimidina (C ↔ T); oppure transversioni quando lo scambio è di una purina con un a
pirimidina o viceversa (C/T ↔ A/G). In genere le transizioni sono più frequenti delle transversioni.
Quando ci si riferisce a mutazioni di una sequenza che codifica per un determinato prodotto genico
le sostituzioni potranno essere:
− mutazioni sinonime o di sostituzione: quando la mutazione determina un codone diverso ma
che codifica per lo stesso amminoacido (questo è possibile grazie alla ridondanza del nostro
codice genetico ). Non si avrà alcun cambiamento nel prodotto genico;
− mutazioni di senso errato: quando un codone viene sostituito con uno che codifica per un
altro amminoacido. Se quest'ultimo avrà le stesse caratteristiche chimiche (dimensione,
carica...) allora la sostituzione sarà conservativa altrimenti non conservativa. È chiaro che il
secondo caso rende più probabile una variazione nella funzionalità del prodotto;
− mutazioni non senso: quando la mutazione determina la formazione di un codone di stop
all'interno della sequenza. Questo provoca, se il prodotto è una proteina, un'interruzione
precoce della sua sintesi nella traduzione. In generale maggiore sarà il frammento non
tradotto maggiore sarà il rischio di una mutazione svantaggiosa.
Le mutazioni frameshift (dall'inglese, spostamento dell'ordine di lettura) sono dette anche mutazioni
da scivolamento. Sono causate dall'aggiunta (inserzione) o l'eliminazione (delezione) di uno o pochi
nucleotidi. Nel caso di inserzione o delezione di nucleotidi in numero non multiplo di tre, viene
alterato l'ordine di lettura (in inglese frame) di tutti i codoni successivi nell'ordine a quello inserito o
deleto. Scoperte da Crick e Brenner studiando il codice genetico, si tratta di mutazioni quasi sempre
dannose.
Le mutazioni per sequenze ripetute sono analoghe alle mutazioni frameshift, interessano però più di
un nucleotide adiacente; in particolare interessano gruppi nucleotidici che formano una sequenza la
quale si ripete più volte di seguito. La mutazione, che si origina nel corso della replicazione del
DNA, provoca una variazione nel numero di queste sequenze ripetute; il nuovo filamento di DNA
potrà presentarne in eccesso o in difetto. Il fenomeno che causa la mutazione è detto slittamento
della replicazione (replication slippage). Malattie genetiche associate a questo tipo di mutazione
sono la Corea di Huntington e la sindrome dell'X fragile.
Gli effetti delle mutazioni possono essere notevolmente diversi a seconda del tipo di mutazione e
della posizione in cui questa si verifica. Una mutazione può non portare a nessuna conseguenza e
questo quando interessa DNA che non codifica (o meglio sembra non codificare) per nessun
prodotto genico (il cosiddetto junk DNA o DNA spazzatura ) . Se la mutazione va invece ad alterare
le sequenze codificanti, ovvero i geni, si ha una variazione nel tipo o nella quantità del corrispettivo
prodotto genico, che può essere una proteina o RNA funzionale (rRNA, tRNA, snRNA ecc.).
Parliamo in questo caso di mutazione biochimica; se la mutazione biochimica porta a una
variazione visibile del fenotipo si parla di mutazione morfologica.
Inoltre distinguiamo, sempre in relazione agli effetti, in:
− mutazione positiva: porta un vantaggio evolutivo;
− mutazione neutra: non risulta in un depotenziamento della capacità riproduttiva
dell’individuo;
− mutazione disvitale o semiletale: rende più difficoltosa la perpetuazione riproduttiva
dell’individuo (il tipico esempio sono le malattie genetiche che debilitano in qualche modo
l’individuo, rendendolo meno capace di riprodursi, senza però impedirglielo totalmente);
− mutazione subletale: non permette all’individuo di raggiungere l’età riproduttiva;
− mutazione letale: porta alla morte dell'individuo in fase embrionale o fetale.
L'efficacia della mutazione, sia positiva che negativa, dipende poi dal tipo di allele mutato così
creato; questo potrà essere infatti dominante o recessivo. Nei diploidi se è dominante avrà sempre
effetto (sia in un eterozigote che in un omozigote dominante); se è recessivo, essendo
aploinsufficiente, per avere effetto ha bisogno che anche l'altro elemento della coppia genica sia
mutato (individuo omozigote recessivo). Negli aploidi, che sono emizigoti, la mutazione avrà
invece sempre effetto.
Le mutazioni possono essere in alcuni casi pleiotropiche, ovvero possono dar luogo a più effetti: ad
esempio nel topo (Mus musculus), un comune allele mutante e dominante in condizioni di
eterozigosi determina una variazione del colore del mantello; in omozigosi, cioè quando l'allele
mutato è presente in duplice copia, provoca invece la morte dell'animale prima ancora della nascita.
Si può presumere quindi che il gene mutato controlli non solo il colore della pelliccia, ma anche
qualche altro processo biochimico vitale per l'organismo.
A differenza di mutazioni su larga scala, quelle puntiformi possono essere soggette a reversione:
attraverso altre mutazioni le prime possono scomparire o ne può scomparire l'effetto sull'organismo.
Nel primo caso parliamo di reversione in senso stretto: la mutazione revertente può riportare il
codone mutato così com'era originariamente (si parla comunemente di retromutazione); oppure la
mutazione può alterare sempre il codone mutato trasformandolo in uno diverso da quello iniziale,
ma codificante per lo stesso amminoacido (reversione di sito). Nel caso in cui la seconda mutazione
occorra su un codone diverso si parla di soppressione: la soppressione potrà essere interna se il
codone è all'interno del gene mutato o esterna se appartiene ad un altro gene. Un esempio di
soppressione interna è una delezione (o un'inserzione) che annulla l'effetto di una inserzione (o
delezione) nello stesso gene. Il caso più comune di soppressione esterna è invece la mutazione
nell'anticodone di un tRNA che annulla quella avvenuta nel codone complementare.
È stata sviluppata una particolare nomenclatura per specificare il tipo di mutazione e il tipo di base
o amminoacido cambiato.
Sostituzione di un amminoacido - (ad esempio D111E) La prima lettera rappresenta il codice (ad
una lettera) dell'amminoacido originariamente presente; il numero indica la posizione
dell'amminoacido a partire dall'estremità N-terminale; la seconda lettera è il codice
dell'amminoacido sostituito in seguito alla mutazione. Se la seconda lettera è una X vuol dire che un
qualunque amminoacido può sostituire quello iniziale.
Delezione di un amminoacido - (ad esempio ΔF508) Il simbolo greco Δ (delta) indica una
delezione; la lettera rappresenta l'amminoacido deleto; il numero è la posizione, sempre dall'Nterminale, dove si trovava l'amminoacido nella sequenza prima della delezione.
Le mutazioni su larga scala comprendono tutte le mutazioni che alterano il genoma variando la
struttura dei cromosomi (mutazioni cromosomiche) o il numero dei cromosomi (mutazioni
genomiche). Sono definite anche anomalie citogenetiche o anomalie cariotipiche. Queste alterazioni
normalmente sono una conseguenza di un errore durante la divisione cellulare, nella meiosi o nella
mitosi. A differenza delle mutazioni geniche, che sono riscontrabili solo tramite analisi genetica,
queste possono in molti casi essere visibili anche al microscopio, in quanto portano alla formazione
di particolari strutture cromosomiche nella fase di appaiamento.
Si parla di mutazioni cromosomiche o anomalie cromosomiche quando è, appunto, la struttura di
uno o più cromosomi ad essere alterata. Ci possono essere anomalie strutturali di vari tipi:
− Delezione: quando una parte del cromosoma è mancante. Disturbi associati a questa
anomalia sono la sindrome di Wolf-Hirschhorn, che è causata dalla perdita di parte del
braccio corto del cromosoma 4, e la sindrome di Jacobsen, originata dalla delezione della
parte terminale del cromosoma 11;
− Duplicazione: quando una parte del cromosoma è raddoppiata, causando la presenza di
materiale genetico in eccesso. Alcuni disturbi conosciuti sono la sindrome di Bloom e la
sindrome di Rett;
− Traslocazione: quando una regione di un cromosoma viene trasferita in un'altra posizione
dello stesso cromosoma o di un altro; ci sono due tipi principali di traslocazioni: la
traslocazione reciproca e la traslocazione robertsoniana.
− Inversione: quando una regione di un cromosoma inverte il suo orientamento; causando
un'inversione dell'ordine dei geni;
− Anello: quando le due estremità di un cromosoma si appaiano tra loro, formando un anello.
Quest'anomalia può comportare, o meno, perdita di materiale genetico.
Si parla di mutazione genomiche o anomalie cariotipiche quando un organismo presenta dei
cromosomi in più o in meno rispetto al normale. Se sono presenti interi corredi cromosomici in più
o in meno si parla di euploidia aberrante; se invece è solo una parte del corredo in eccesso o in
difetto l'anomalia è chiamata aneuploidia.
Nell'uomo e, in generale, in tutti gli organismi diploidi, che hanno dunque coppie di cromosomi
omologhi, le forme di aneuploidia più frequenti sono la mancanza di un cromosoma da una coppia
(monosomia) o la presenza di un cromosoma in più in una coppia (trisomia) . Più raro è il caso di
perdita di una coppia intera (nullisomia).
Un esempio degli effetti di un'anomalia di questo tipo è la sindrome di Down, chiamata anche
trisomia 21; gli individui affetti da questa sindrome hanno tre copie del cromosoma 21, invece che
due. La sindrome di Turner è invece un esempio di monosomia; gli individui nati con questa
anomalia possiedono un solo cromosoma sessuale, quello femminile X. Tra gli organismi aploidi i
casi più diffusi di aneuploidia consistono nella presenza di un cromosoma soprannumerario
(disomia).
Anche per questa categoria di mutazioni le possibili conseguenze sull'organismo sono variabili. In
generale ci sarà effetto ogni volta che, nella modificazione del cromosoma o del genoma, si altera
anche la sequenza o il numero di uno o più geni. A differenza delle mutazioni geniche in questo
caso gli effetti saranno sempre negativi.
Per tutte le mutazioni cromosomiche è necessaria la rottura del doppio filamento in almeno un
punto per permettere il successivo riarrangiamento: se la rottura avviene all'interno di un gene al
termine del processo la sua sequenza sarà mutata. Ad esempio, in un' inversione, se le fratture sono
avvenute in sequenze codificanti, a seguito del diverso orientamento del frammento reinserito, i
geni alle estremità avranno parte della sequenza giusta e parte proveniente dall'altra estremità del
frammento, quindi sbagliata (i geni interni al frammento invece non saranno mutati ma solo invertiti
nell'ordine). La situazione è analoga per le traslocazioni. Le delezioni e le duplicazioni invece
avranno ulteriori conseguenze, essendo riarrangiamenti che alterano non la disposizione ma la
quantità di materiale genetico. La delezione avrà effetti negativi proporzionali alla dimensione del
frammento deleto. La duplicazione aumenta il numero di copie dei geni contenuti nel frammento
duplicato: anche questo però ha conseguenze dannose perché determina uno squilibrio genico.
In modo analogo nelle mutazioni del cariotipo si ha un aumento o una diminuzione delle dimensioni
del genoma cellulare. L'auploidia aberrante è rara ma comunque letale negli animali (tranne rare
eccezioni), può essere anche determinante invece nelle piante. Recenti studi invece hanno ormai
dimostrato che l'aneuploidia è una delle dirette cause di molti tumori (e non una conseguenza come
si era anche pensato).
Altre mutazioni possono essere indotte da:
− Mutazioni da sistemi di riparazione: paradossalmente mutazioni genetiche possono essere
inserite anche da particolari processi di riparazione del DNA. Può capitare infatti che
determinati danni del DNA non siamo riconosciuti e riparati da nessun macchinario preposto
a questo compito, fino al successivo ciclo di replicazione: se questi danni (come ad esempio
i fotoprodotti indotti dalle radiazioni ultraviolette) bloccano l'azione della DNA polimerasi,
cioè impediscono di replicare il DNA a valle del danno, determinano la perdita di materiale
genetico con conseguenze praticamente sempre letali per la cellula figlia. Si sono allora
sviluppati meccanismi di riparazione cosiddetti SOS, che agiscono in questi casi estremi: le
polimerasi di questo sistema non si bloccano, ma aggiungono lo stesso nucleotidi davanti al
danno; nella gran parte dei casi però l'aggiunta è casuale e quindi con alto rischio di
aggiungere nucleotidi non corretti; quindi di provocare mutazioni. Un altro sistema con
conseguenze analoghe è il sistema di riparazione delle rotture del doppio filamento di DNA
che non sfrutta l'omologia: il cosiddetto NHEJ (non-homologous end joining, giunzione
delle estremità non omologhe). Anche qui per riparare la rottura e evitare di perdere il
frammento privo di centromero nel successivo ciclo meiotico o mitotico il sistema provoca
delezioni delle sequenze adiacenti alla rottura. In entrambi i casi quindi i sistemi evitano un
danno molto grande, ma devono pagare come prezzo l'inserimento di mutazioni anch'esse
potenzialmente dannose;
− Mutazioni condizionali: sono mutazioni che pur presenti hanno un effetto soltanto in
determinate condizioni ambientali. I casi più diffusi, tra gli aploidi, sono le mutazioni
sensibili alla temperatura; che agiscono cioè solo al di sopra (o di sotto) di determinate
soglie di temperatura;
− Mutazioni per trasposizione: sono dovute all'inserimento, all'interno della sequenza
codificante o di regolazione, di elementi trasponibili o trasposoni. Questi determinano
l'inattivazione completa del gene, ma essendo elementi dinamici, possono fuoriuscire dal
gene e ristabilire la sua sequenza corretta.
Il primo a introdurre il termine mutazione nel campo della genetica fu Hugo de Vries, nel 1901, che
lo riferiva però alle brusche variazioni nei caratteri di un organismo; in particolare osservando come
nella progenie di un ceppo della pianta Oenothera lamarckiana si potevano ottenere alcuni individui
inaspettatamente giganti. Il concetto di mutazione così come è inteso oggi, invece, fu usato solo a
partire dal 1927.
In generale si può dire, comunque, che le mutazioni genetiche hanno avuto un ruolo essenziale
ancora prima, fin dagli albori della genetica; già nei celebri lavori del padre della genetica, Gregor
Mendel, infatti, i fenotipi come il colore bianco dei petali o giallo dei semi maturi, usati per
formulare le sue leggi, non erano che dovute a mutazioni inattivanti dei corrispettivi geni.
Il primo "sfruttamento" consapevole delle mutazioni avviene a partire dagli studi, condotti ai primi
del 900 da Thomas Hunt Morgan e il suo cosiddetto fly group, sul moscerino della frutta Drosophila
melanogaster. Morgan e colleghi portarono le prime importanti prove sperimentali della teoria
cromosomica dell'ereditarietà, che ipotizzava per la prima volta una stretta connessione tra geni e
cromosomi. I ricercatori isolarono in una vasta popolazione di insetti un moscerino dagli occhi
bianchi (mentre nel fenotipo selvatico erano rossi). Anche qui il fenotipo particolare era stato
provocato da una mutazione spontanea nel gene per il colore degli occhi. Mutazione che aveva
prodotto una nuova forma allelica; gli incroci tra individui con alleli diversi hanno permesso di
ottenere i risultati sopra detti. Morgan isolò per questi incroci, dopo il caso del moscerino dagli
occhi bianchi, ben 83 ceppi ciascuno con mutazioni su geni diversi. Le mutazioni ebbero poi un
ruolo sempre più crescente da quando furono scoperti i primi agenti mutageni. La maggior parte
degli esperimenti chiave nella storia della genetica fecero uso di mutazioni indotte: nel 1941, nel
loro celebre esperimento che portò al dogma un gene-un enzima, Edward Lawrie Tatum e George
Wells Beadle fecero ad esempio uso di ceppi di Neurospora crassa mutagenizzati tramite raggi X. In
modo analogo Tatum e Joshua Lederberg nel 1946 usarono mutazioni in ceppi di Escherichia coli
per dimostrare l'esistenza del processo di coniugazione batterica.
Un importante capitolo nella storia delle mutazioni nella genetica riguarda la disputa sull'origine
delle mutazioni nei batteri. Intorno agli anni quaranta infatti alcuni batteriologi misero in dubbio
che le mutazioni potessero avvenire nei batteri in modo del tutto spontaneo, come era invece
accettato per gli organismi superiori; essi ritenevano piuttosto che le mutazioni erano indotte dalla
presenza di particolari condizioni ambientali. Ad esempio, i batteri che sopravvivevano in seguito
all'aggiunta di un batteriofago avevano acquisito la resistenza grazie a una mutazione indotta dalla
stessa presenza dei fagi (teoria adattativa). Numerosi altri studiosi invece erano convinti che le
mutazioni si verificassero così come in tutti gli altri organismi, spontaneamente. Quest'ultima teoria
(teoria genetica) fu definitivamente dimostrata da due celebri esperimenti: il cosiddetto test di
fluttuazione (o di Salvador Luria e Max Delbruck), sviluppato nel 1943 e la tecnica della piastratura
delle repliche ideata da Joshua e Esther Lederberg.
Gli studi genetici che fanno uso di mutazioni possono essere distinte in due categorie a secondo
dello scopo dello studio e dei dati che si posseggono: studi di genetica diretta e di genetica indiretta.
Il primo approccio è usato qualora si voglia determinare i geni che in un organismo siamo correlati
a una certa funzione: in questo caso l'organismo viene esposto a mutageni e successivamente il
genetista compie la cosiddetta "caccia al mutante", in cui va a ricercare gli individui i cui sono stati
alterati i fenotipi correlati alla funzione che si sta studiando. A questo punto si determina la
posizione del gene mutato tramite incroci si isola e si analizza in dettaglio: ne si determina la
sequenza nucleotidica e si osserva per quale prodotto genico codifica. Nella genetica diretta quindi
si parte dal fenotipo per vedere da quale genotipo è causato. Il secondo tipo di studio compie invece
il percorso inverso: parte dal genotipo per studiare il fenotipo: si parte in genere da una sequenza di
DNA o RNA nota o addirittura da un prodotto genico (di solito una proteina), si mutagenizzano in
modo selettivo e si vede che effetti fenotipo causano nell'organismo; si parla in questo caso anche di
silenziamento genico .
Molto importanti sono le tecniche che permettono di ottenere mutazioni sito specifiche; mutazioni
cioè indotte in modo selettivo nelle zone di interesse di una sequenza. In questo modo per esempio è
possibile inserire una mutazione in un particolare dominio di una proteina e, saggiando le
conseguenze, determinarne la funzione.
I test di mutagenesi sono procedure in cui cellule, tessuti o interi organismi sono esposti all'azione
di una sostanza chimica, per verificarne e/o quantificarne la mutagenicità; i sistemi biologici in
esame sono quindi studiati, dopo un certo periodo di incubazione, e analizzati per vedere la
presenza di eventuali mutazioni. In generale la capacità mutagena di un agente è direttamente
proporzionale ai mutanti identificati al termine del test. I test routinari sono svolti su batteri,
essendo sistemi più conosciuti e di più facile utilizzo. I test sono però volti a scoprire il danno che
una sostanza può creare all'uomo, il quale ha, ovviamente, molte caratteristiche biologiche diverse
dai procarioti; per questo si procede a modificare geneticamente i batteri usati nei test per mimare
un sistema il più vicino possibile a quello umano, oppure si usano cellule di mammifero
(solitamente di roditori). Tra i test più usati ci sono il test di Ames e il test del micronucleo.
Un esempio di applicazione delle mutazioni in campo biomedico è il test di Ames. Il test, sviluppato
negli anni settanta da Bruce Ames, ha lo scopo di determinare la cancerogenità di una sostanza
studiando la sua capacità di indurre mutazioni; in generale infatti una sostanza mutagena è anche
cancerogena. È solitamente usata una forma mutata del batterio Salmonella typhimurium, ad
esempio un ceppo che non è in grado di crescere in terreno privo di istidina; il ceppo è diviso in due
piastre separate con terreni privi dell'amminoacido: uno di essi sarà esposto alla sostanza da testare
l'altro no. Se la sostanza ha capacità mutagena ci sarà una certa probabilità che induca delle
reversioni della mutazione; annulla cioè l'effetto della prima mutazione con una mutazione,
permettendo di nuovo al batterio di sopravvivere anche in assenza di istidina. Sul ceppo non
mutagenizzato invece non ci sarà nessuna colonia o molto poche (essendo la reversione per
mutazione spontanea molto rara). Più colonie sopravviveranno nel campione mutagenizzato,
maggiore sarà stato il numero di retromutazioni e quindi maggiore è la cancerogenità della sostanza.
ESEMPI DI MUTAZIONE POSITIVA La tolleranza al lattosio, che permette la digeribilità del latte e degli alimenti che lo contengono, è
derivata secondo i genetisti da una mutazione favorevole avvenuta circa 10.000 anni fa (8.000
secondo altre fonti) che colpì gli uomini che abitavano la zona del Caucaso. È un chiaro esempio di
mutazione favorevole che, in quanto tale, si è presto diffusa rapidamente nella popolazione: ad oggi
solo una parte della popolazione umana soffre di intolleranza per questa sostanza. Ulteriori
dimostrazioni derivano dal fatto che popoli che abitarono zone lontane dall'origine della mutazione,
come Asiatici e Africani, e che non vennero in stretto contatto con i caucasici, presentano oggi una
maggiore diffusione dell'intolleranza al lattosio.
Un altro caso che si ritiene essere una mutazione positiva è la delezione di 32 coppie di basi nel
gene umano CCR5 (CCR5-32) che conferisce all'uomo la resistenza all'AIDS negli omozigoti,
mentre ritarda i suoi effetti negli eterozigoti. La mutazione è mediamente più diffusa tra coloro che
hanno discendenza europea; una teoria per spiegare la maggiore diffusione nella popolazione
europea della mutazione CCR-32 la mette in relazione con le forme di resistenza alla peste
bubbonica sviluppate nella metà del quattordicesimo secolo.
ESEMPI DI MUTAZIONE NEGATIVA La fenilchetonuria è una malattia provocata da una mutazione genica che rallenta o blocca la
capacità di trasformare l'amminoacido fenilalanina in tirosina. Questo dunque si accumula
nell'organismo e se in grado di raggiungere il cervello può provocare danni neurologici.
Il daltonismo ha tra le varie cause possibili quelle genetiche, dovute a mutazioni su geni che
codificano per fotorecettori.
L'albinismo è una disfunzione genetica dovuta alla mutazione del gene per la melanina.
L'anemia drepanocitica o anemia falciforme è una malattia del sangue conseguenza di una
mutazione che provoca l'alterazione della struttura e della funzione dei globuli rossi.
Il gatto Manx si è sviluppato a seguito di un'alta frequenza di accoppiamento tra individui della
stessa specie. La mutazione riguarda il gene cosiddetto "M" e provoca oltre all'assenza di coda
anomalie nella struttura scheletrica. Il gene è dominante ma si manifesta con diversa espressività.
Gli individui omozigoti dominanti (M/M) non sopravvivono e muoiono quando sono ancora nello
stato di feto nell'utero materno.
CHELOIDE Il cheloide è una cicatrice esuberante della cute che si estende oltre i limiti della lesione primitiva.
Deve essere distinto dalla cicatrice ipertrofica che invece non si estende mai oltre tali limiti.
Il cheloide è una cicatrice cutanea fibrosa di formazione naturale, che si può formare in soggetti
predisposti a seguito di danneggiamento della cute di vario tipo, come ferite chirurgiche o
traumatiche, foruncoli, applicazione di piercing, ustioni.
Il cheloide è solitamente molto antiestetico, rilevato, a superficie liscia e lucida spesso solcata da
teleangectasie, di colore rosso-violaceo. Solitamente asintomatico, il cheloide può talvolta
provocare lieve prurito locale. Pur non essendo una patologia grave ma prevalentemente un
inestetismo (ad eccezione dei casi in cui determina limitazione funzionale locale per indurimento ed
anelasticità del tessuto), il cheloide è estremamente difficile da trattare.
Dal punto di vista psicologico il cheloide può determinare spiacevoli ripercussioni il continuo
bisogno di giustificazioni, il senso di inadeguatezza, il disagio e a volte la vergogna del portatore.
Con l'asportazione il cheloide tende quasi sempre a recidivare in forma più grave dopo ogni
tentativo di trattamento. Prima di prendere in considerazione l'asportazione chirurgica dunque, è
possibile valutare altre opzioni terapeutiche, come le infiltrazioni cortisoniche intralesionali e la
crioterapia seguita dalla compressione locale.
CHELOIDE E FIBULINA 5 È stato scoperto che la fibulina-5 sia in grado di ottimizzare i processi di riparazione e
cicatrizzazione. Infatti, in vivo, la fibulina-5 media l’elastinogenesi con una restituito ad integrum
della zona lesa. In soggetti colpiti da cheloidi, la fibulina-5 nella ECM è assente. È quindi facile
intuire che l’assenza della fibulina-5 determini una esagerata fibrosi, con residui cicatriziali
deturpanti e alla volte debilitanti. È facile prospettare un utilizzo futuro della fibulina-5 come agente
in grado di prevenire la formazione di cicatrici.
Tuttavia ancora molto resta da chiarire, relativamente alla funzione e alle dinamiche che questa
proteina ha nella elastinogenesi, e non solo.
Concludo, nella speranza che venga fatta ulteriore luce sui fenomeni a capo della elastinogenesi e di
come la fibulina-5 giochi un ruolo importante nella riparazione tissutale.