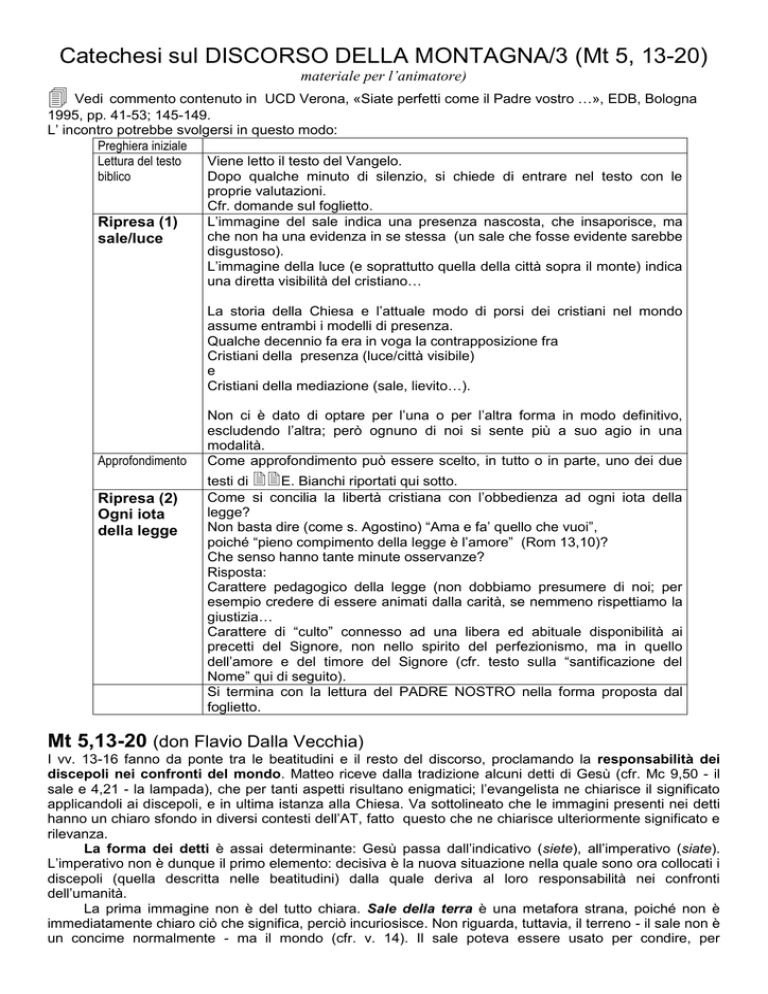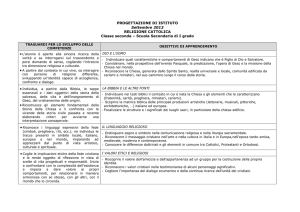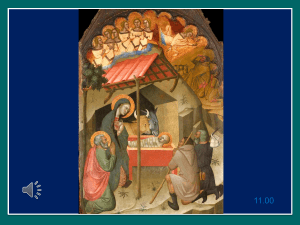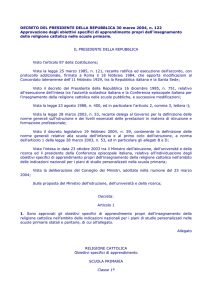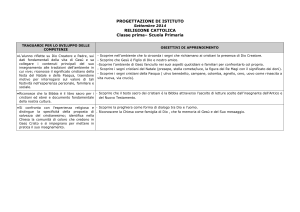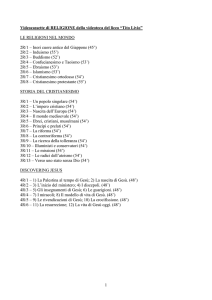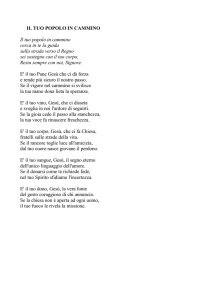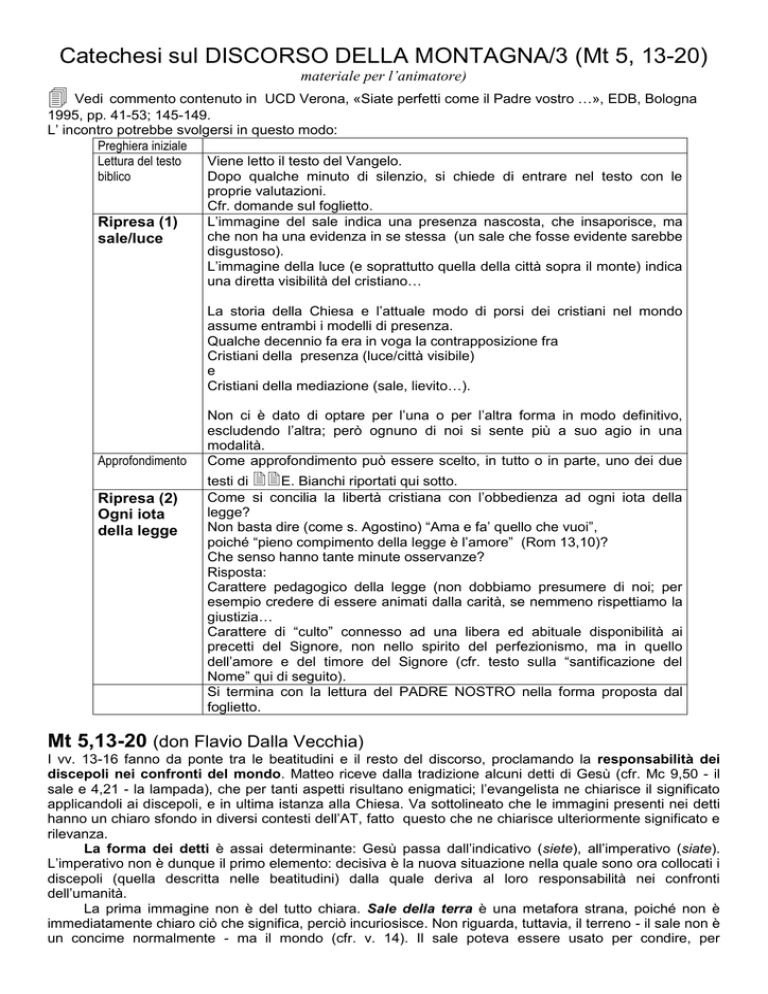
Catechesi sul DISCORSO DELLA MONTAGNA/3 (Mt 5, 13-20)
materiale per l’animatore)
Vedi commento contenuto in
UCD Verona, «Siate perfetti come il Padre vostro …», EDB, Bologna
1995, pp. 41-53; 145-149.
L’ incontro potrebbe svolgersi in questo modo:
Preghiera iniziale
Lettura del testo
Viene letto il testo del Vangelo.
biblico
Dopo qualche minuto di silenzio, si chiede di entrare nel testo con le
proprie valutazioni.
Cfr. domande sul foglietto.
L’immagine del sale indica una presenza nascosta, che insaporisce, ma
Ripresa (1)
che non ha una evidenza in se stessa (un sale che fosse evidente sarebbe
sale/luce
disgustoso).
L’immagine della luce (e soprattutto quella della città sopra il monte) indica
una diretta visibilità del cristiano…
La storia della Chiesa e l’attuale modo di porsi dei cristiani nel mondo
assume entrambi i modelli di presenza.
Qualche decennio fa era in voga la contrapposizione fra
Cristiani della presenza (luce/città visibile)
e
Cristiani della mediazione (sale, lievito…).
Approfondimento
Ripresa (2)
Ogni iota
della legge
Non ci è dato di optare per l’una o per l’altra forma in modo definitivo,
escludendo l’altra; però ognuno di noi si sente più a suo agio in una
modalità.
Come approfondimento può essere scelto, in tutto o in parte, uno dei due
testi di E. Bianchi riportati qui sotto.
Come si concilia la libertà cristiana con l’obbedienza ad ogni iota della
legge?
Non basta dire (come s. Agostino) “Ama e fa’ quello che vuoi”,
poiché “pieno compimento della legge è l’amore” (Rom 13,10)?
Che senso hanno tante minute osservanze?
Risposta:
Carattere pedagogico della legge (non dobbiamo presumere di noi; per
esempio credere di essere animati dalla carità, se nemmeno rispettiamo la
giustizia…
Carattere di “culto” connesso ad una libera ed abituale disponibilità ai
precetti del Signore, non nello spirito del perfezionismo, ma in quello
dell’amore e del timore del Signore (cfr. testo sulla “santificazione del
Nome” qui di seguito).
Si termina con la lettura del PADRE NOSTRO nella forma proposta dal
foglietto.
Mt 5,13-20 (don Flavio Dalla Vecchia)
I vv. 13-16 fanno da ponte tra le beatitudini e il resto del discorso, proclamando la responsabilità dei
discepoli nei confronti del mondo. Matteo riceve dalla tradizione alcuni detti di Gesù (cfr. Mc 9,50 - il
sale e 4,21 - la lampada), che per tanti aspetti risultano enigmatici; l’evangelista ne chiarisce il significato
applicandoli ai discepoli, e in ultima istanza alla Chiesa. Va sottolineato che le immagini presenti nei detti
hanno un chiaro sfondo in diversi contesti dell’AT, fatto questo che ne chiarisce ulteriormente significato e
rilevanza.
La forma dei detti è assai determinante: Gesù passa dall’indicativo (siete), all’imperativo (siate).
L’imperativo non è dunque il primo elemento: decisiva è la nuova situazione nella quale sono ora collocati i
discepoli (quella descritta nelle beatitudini) dalla quale deriva al loro responsabilità nei confronti
dell’umanità.
La prima immagine non è del tutto chiara. Sale della terra è una metafora strana, poiché non è
immediatamente chiaro ciò che significa, perciò incuriosisce. Non riguarda, tuttavia, il terreno - il sale non è
un concime normalmente - ma il mondo (cfr. v. 14). Il sale poteva essere usato per condire, per
conservare, per purificare. La storia della ricezione mostra che varie sono state le linee interpretative: con
sale è stata intesa la saggezza dei discepoli (cf. rito del battesimo), la loro predicazione, la disponibilità al
sacrificio o al cambiamento di vita. La notazione che il sale potrebbe perdere il sapore (più propriamente
diventare sciocco) induce a preferire l’uso del sale per condire; ma il peso cade sull’essere gettato! Il sale
non è sale per se stesso, ma condimento per il cibo; così i discepoli non sono qui per se stessi ma per la
terra. Così dichiara Gb 6,6: Si mangia forse un cibo insipido, senza sale? O che gusto c’è nell'acqua di
malva? Dunque il compito dei discepoli è dare sapore, ma non va trascurata la funzione del sale di
preservare. Si tratta di dare sapore e quindi di dare senso alla vita, ma anche di conservarne i valori
preservandola dal pericolo di deteriorarsi. L’immagine invita inoltre a tener presente che il sale nella realtà
non è qualcosa di separato da ciò a cui dà sapore: dare senso non è dunque creare un mondo alternativo
al presente, ma dare gusto a questo.
L’immagine della luce richiama numerosi riferimenti nell’AT, ma anche nel NT. Dio è luce, ma
anche la legge (cfr. Sap 18,4), il popolo, Gerusalemme, il servo del Signore (cfr. Is 42,6; 49,6), la sapienza
e infine Gesù (cfr. Gv 8,12). Illuminati dalla luce che è Cristo (cfr. Mt 4,16), i discepoli diventano a loro volta
luce per l’umanità. Mentre il sale sembra sparire nell’amalgama dei cibi, la luce richiama l’idea di una
presenza permanente, resta sempre presente, ma come ciò che fa risaltare le cose che illumina. I discepoli
nel vivere la loro identità sono luce, danno gusto e senso all’umanità. Come non si mette la lampada in un
vaso (il moggio è un’unità di misura - 8,75 litri - ma anche un recipiente), così i discepoli, come
Gerusalemme nell’AT, sono una città collocata sul monte. In tal modo la metafora mette al centro la
visibilità. Il v. 16 rappresenta poi la chiave riassuntiva di tutte queste affermazioni, sottolineando che
testimonianza è connaturata all’essere Chiesa: non si può dunque essere discepoli senza essere
missionari. Ciò però che deve risaltare sono le opere buone, cioè lo stile di vita realizzato secondo le
beatitudini (e secondo le successive antitesi), per glorificare il Padre. La vita dei discepoli diventa in tal
modo trasparenza della realtà di Dio, per cui Dio sarà glorificato attraverso la loro umanità. Come il
discepolato significa il compimento dei comandamenti di Gesù, così anche nella predicazione la vita dei
cristiani occupa un posto determinante.
Nei vv. 17-20 incontriamo quattro detti singoli (loghia), l’ultimo dei quali potrebbe valere da titolo o da
ricapitolazione anticipata delle antitesi successive. A dire il vero, i vv.17-19 non sono direttamente collegati
alle antitesi: trattano della validità della legge, non della giustizia dei discepoli; ma collocando questi
versetti all’inizio della sezione principale del discorso, Mt indica chiaramente che essi rivestono per lui
un’importanza fondamentale. Qui è in discussione il rapporto con la legge mosaica (Torah) e perciò con il
giudaismo, anche se l’interpretazione è stata sempre controversa.
Nel v. 17, Mt non pensa al compimento delle profezie della legge e dei profeti; nel contesto il detto si
applica a Gesù che compie gli insegnamenti di legge e profeti. Ma che significano abolire e compiere? Li si
può riferire all’insegnamento di Gesù o alla sua vita: in entrambi i casi risultano comunque ambigui e
ammettono diverse sfumature interpretative. Dal significato dei due verbi è tutt’al più possibile pensare a
un compimento della legge grazie all’obbedienza di Gesù; ma il contesto seguente consente anche di
pensare al suo insegnamento, sebbene in Mt si noti una precedenza data alla prassi. Il verbo compiere ha
in Mt un riferimento esclusivamente cristologico (riferito alla missione di Cristo). Il detto del v.17, introdotto
con sono venuto, è in linea con passi in cui si tratta dell’invito tutto speciale di Gesù a compiere la volontà
del Padre.
In tale chiave di lettura, i vv. 18-19 non fanno che trarre le conseguenze del v. 17. Nei vv.17-19, Mt
ha accolto una tradizione giudeo-cristiana che pretende l’osservanza di tutti i singoli comandamenti ed
esclude una critica concreta ai comandamenti della Torah. Quale differenza vi è allora tra la comunità
matteana e il giudaismo? Per Mt - a partire da Gesù - è in linea di principio chiaro che il comandamento
dell’amore rappresenta il comandamento principale, mentre i comandamenti rituali sono iota e apice, però i
comandamenti rituali sono pur sempre parti della legge che Gesù adempie nella sua totalità.
Nel v. 20 ritorna di nuovo al centro il comportamento umano, esplicitato nelle antitesi. Appunto tale
esplicitazione chiarisce che la maggiore giustizia non pone l’accento sulla quantità, ma soprattutto sulla
qualità (il comandamento dell’amore).
«I detti riguardanti la permanente validità della Torah come interpretata da Gesù (5,17-20) servono a
ribadire l’idea del rapporto organico tra il giudaismo e il cristianesimo matteano. Ci ricordano che almeno
alcuni cristiani della fine del primo secolo dopo Cristo non vedevano nessuna contraddizione nel seguire
sia la Torah che gli insegnamenti di Gesù. Questo fatto dovrebbe servire a prevenire qualsiasi insensato
attacco al “legalismo ebraico” [... Questo comporta] il rispetto per lo sfondo ebraico e per l’ambientazione in
cui questi testi hanno avuto origine» (D.J. Harrington).
Perchè il sale cristiano non perda sapore
(Enzo Bianchi)
La Stampa, 15 giugno 2008
Nel faticoso procedere del dibattito sulla presenza dei cristiani nella società, sulla loro influenza e visibilità
e sulla laicità delle istituzioni si avverte a volte il rischio di un fraintendimento delle rispettive posizioni,
una precomprensione di alcuni termini o l’applicazione al linguaggio dell’altro di schemi mentali che non
gli appartengono. Sono le normali difficoltà di un dialogo che non sia semplice sovrapporsi di due
monologhi, ma perché questo rischio congenito non trasformi il dibattito in un dialogo tra sordi è necessario
l’ascolto di ciò che l’altro dice e di come si definisce, la volontà di capire in profondità anche al di là delle
espressioni usate, lo sguardo capace di abbracciare ambiti e periodi storici più ampi del contingente: l’arte
del dialogo è ben altra cosa della retorica raffinata.
Sono difficoltà di questo tipo che mi paiono affiorare con particolare frequenza quando si riflette sulle
immagini di “Chiesa” presenti nel vissuto e nell’immaginario della realtà italiana e che finiscono troppo
spesso per essere contrapposte. Non mi riferisco tanto alla sbrigativa identificazione che i media
normalmente fanno tra “Chiesa” e “gerarchia” o parti di essa, né intendo affrontare qui il pur importante
argomento del ruolo del “laicato” all’interno della Chiesa cattolica, penso invece a un’ambiguità che
ricompare sovente quando la lettura dell’impatto del cristianesimo nella nostra società evoca le esigenze
radicali del vangelo. Non manca infatti chi, al solo sentirle nominare, le cataloga come pretese elitarie che si
contrapporrebbero a una “buona notizia” alla portata di tutti. Ora, fin dal suo primo apparire storico e dalla
sua rapida diffusione, il messaggio cristiano non è mai stato riservato a un’élite, né intellettuale né
economica. Questo però non significa che non sia possibile una riflessione sulla qualità della testimonianza
resa dai cristiani, sulla loro coerenza con le parole e le azioni di colui che confessano come loro Signore.
Così come dovrebbero esistere dei modi più articolati di quelli desumibili dalle anagrafi parrocchiali per i
battesimi e i matrimoni per “contare” e “pesare” i cristiani e il loro contributo all’edificazione di una casa
comune.
Quando mi accade di proseguire le mie riflessioni sulla “differenza cristiana” che deve essere visibile e
leggibile nell’oggi della storia per non appiattirsi sulla mentalità mondana dominante, avverto reazioni di
chi ritiene che quanti la pensano come me auspichino una Chiesa di puri e duri, una ristretta cerchia di
iniziati che guarda dall’alto in basso la quotidianità della vita nelle parrocchie e nei gruppi ecclesiali o che
ignora la portata di certi eventi di massa, quasi che ci si compiacesse della situazione oggettiva di minoranza
in cui i cristiani si sono venuti a trovare ormai anche in Italia. Ora, non vi è nulla da rallegrarsi nel fatto che
solo un quinto di quanti si dichiarano cattolici ha un legame reale e non sporadico con la comunità cristiana
e la sua vita liturgica, ma non serve nemmeno vantare le cifre più incoraggianti per una lettura approfondita
dell’impatto che il vangelo e la concreta comunità cristiana hanno oggi nella nostra società.
Benedetto XVI non cessa di parlare di “chiamata radicale del vangelo”, di “esigenze radicali della sequela”,
di “coerenza tra vissuto e fede” come caratteri distintivi della comunità cristiana che, anche in condizioni di
minoranza, resta così testimone di Cristo e capace di evangelizzare proprio attraverso la “differenza
cristiana”. Sì, essere “sale della terra”, come Gesù ha definito i suoi discepoli, non significa considerarsi
migliori degli altri, tenersi lontani dalle espressioni più popolari della fede, diffidare del comune sentire di
quanti vivono come meglio possono la coerenza con il proprio battesimo; significa, al contrario, sapersi e
riconoscersi “peccatori come i nostri padri”, bisognosi di concreta e quotidiana misericordia anche da parte
dei propri fratelli nella fede. Ma vuol dire anche non accontentarsi di un cristianesimo “minimo”, richiedere
e favorire scelte coerenti con una vita cristiana il più possibile fedele al messaggio evangelico: quanti di noi
non hanno conosciuto uomini e donne estremamente semplici, con scarsissimi strumenti culturali, eppure
capaci di gesti e scelte quotidiane esemplarmente conformi alla fede professata?
Ben altra cosa – questa straordinaria ordinarietà del vangelo vissuto giorno dopo giorno, con serenità e
serietà – dall’attraente modello di una religione forte, incarnato in minoranze attive ed efficaci, capaci di
assicurare identità e visibilità per il peso specifico che riescono ad assumere. La testimonianza della fede
cristiana deve essere abitata da una esigente dinamica spirituale, da una tensione a caro prezzo verso i
principi evangelici fondamentali: solo così sarà capace anche di scuotere l’assuefazione a stili di vita che,
pur diffusissimi e pertanto considerati “normali”, contraddicono le istanze cristiane più autentiche. Senza
questa vigilanza, senza il discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male per me, per gli altri, per
l’insieme della convivenza, i cristiani corrono il rischio di divenire sale che perde il suo sapore, di
contraddire quel “tra voi non è così” che Gesù rivolse ai suoi discepoli mettendoli in guardia dall’agire
come “coloro che sono ritenuti i capi delle nazioni”.
Percorso esigente, certo, ma non elitario; percorso che rende possibile la complementarietà di due esigenze
fondamentali per il cristiano, oggi come sempre: l’ascolto della volontà di Dio manifestata nella sua Parola e
nella persona di Gesù di Nazaret e, d’altro lato, l’ascolto dei propri fratelli e sorelle in umanità; percorso
non agevole, ma capace di dare e ridare senso alla propria e alle altrui esistenze e, di conseguenza, di
contribuire a una vita in comune qualitativamente più umana.
Il vero cristiano sa comunicare la gioia
da E. Bianchi, La differenza cristiana, Einaudi, Torino 2006.
Nel nostro orizzonte ci sono oggi due fenomeni con cui l'evangelizzazione si trova a fare i conti:
l'indifferentismo della maggior parte degli uomini delle nostre società post-cristiane e il pluralismo religioso,
dovuto soprattutto alle migrazioni di credenti di altre religioni nel nostro continente. Entrambi mettono in
crisi non solo le forme e i modi, ma la stessa plausibilità dell'evangelizzazione: sono fenomeni dolorosi per
la coscienza credente perché non la contestano frontalmente, non la combattono apertamente, ma
affermano, con il loro stesso esserci, che il cristianesimo può essere insignificante e che si può vivere bene
anche senza di esso. L'indifferenza religiosa pone la Chiesa di fronte allo spettro della propria possibile
insignificanza e inutilità, mentre il pluralismo religioso fa intravedere al cristianesimo la possibilità di doversi
considerare una proposta tra le altre, senza titoli di superiorità né, tanto meno, di assolutezza.
L'indifferenza di chi è deluso dalla fine delle ideologie, l'indifferenza di ex credenti frustrati nella loro attesa
di un rinnovamento ecclesiale, l'indifferenza dell'homo technologicus convinto di poter dominare tutto
attraverso la tecnica appare ai cristiani come enigmatica e grande nemica. Eppure, li stimola a porsi
domande salutari: perché il cristianesimo ha cessato di essere interessante agli occhi di molti? E i cristiani,
sono essi stessi davvero «evangelizzati», così da poter essere efficaci «evangelizzatori»? Sanno davvero
esprimere e comunicare la loro peculiarità, la loro «differenza»? Non dimentichiamo che l'indifferenza
cresce man mano che scompare la differenza! Del resto, il cristianesimo è un'offerta, non un'imposizione, e
non pretende di avere il monopolio della felicità, ma afferma di trovarla nella vita secondo Gesù Cristo. Il
fatto che vi siano degli atei, allora, non fa che rafforzare la scelta di libertà che sta alla base di una vita
cristiana. Il problema serio, se mai, è che non siano i cristiani stessi e le chiese a produrre atei con i loro
atteggiamenti disumani e intolleranti, con la pratica dell'autosufficienza e del non ascolto.
Quanto al pluralismo religioso, occorre non essere astratti: non si incontra mai l'islam o una religione, bensì
uomini e donne che appartengono a determinate tradizioni religiose e per i quali questa appartenenza è un
aspetto di un'identità molteplice e non monolitica. In questo «camminare accanto», in questo vivere gli uni
a fianco degli altri, i cristiani non devono imboccare vie apologetiche né assumere atteggiamenti difensivi
o, peggio ancora, aggressivi, ma devono saper creare spazi di vita e di accoglienza in vista
dell'edificazione di una polis non semplicemente multiculturale e multireligiosa ma interculturale e
interreligiosa. Qui più che mai i cristiani sono chiamati a creare spazi comunitari a partire dalla loro capacità di essere uomini e donne di comunione e a rendere le loro chiese autentiche «case e scuole di
comunione» per tutti gli uomini. Il cammino di evangelizzazione richiede conoscenza dell'altro e della sua
fede, capacità «pentecostale» di parlare la lingua dell'altro, di farsi prossimo in senso evangelico di chi si è
fatto vicino a noi fisicamente, mostrando così di credere nell'unico Padre e di riconoscere la fraternità universale. Di fronte all'altro per lingua, etnia, religione, cultura, usi alimentari e medici, prima di evangelizzare
occorre imparare l'alfabeto con cui rivolgersi a lui, manifestando concretamente una vicinanza e una
simpatia «cordiali». Solo in questo modo si potrà «costruire una casa comune per l'umanità nella quale Dio
possa vivere».
Oggi ai cristiani è chiesto di non venir meno al loro compito di annunciare il vangelo, ma questo annuncio
non può essere disgiunto da una buona comunicazione, un comportamento limpido, una pratica cordiale
dell'ascolto, del confronto e dell'alterità. Sì, l'annuncio cristiano non deve avvenire a ogni costo, né
attraverso forme arroganti, né con un'ostentazione di certezze che mortificano o con splendori di verità che
abbagliano. Infatti, come ricordava già Ignazio di Antiochia all'inizio del II secolo: «il cristianesimo è opera
di grandezza, non di persuasione».
Paolo VI ha più volte chiesto alla Chiesa, in vista dell'evangelizzazione, di «farsi dialogo, conversazione, di
guardare con immensa simpatia al mondo perché, se anche il mondo sembra estraneo al cristianesimo, la
Chiesa non può sentirsi estranea al mondo, qualunque sia l'atteggiamento del mondo verso la Chiesa».
Ecco perché occorre innanzitutto che i cristiani siano loro stessi «evangelizzati», discepoli alla sequela del
Signore piuttosto che militanti improvvisati: così sapranno mostrare la «differenza» cristiana. I cristiani non
cerchino visibilità a ogni costo, non rincorrano la sovraesposizione per evangelizzare, non si servano di
strumenti forti di potere ma, custodendo con massima cura, quasi con gelosia, la Parola cristiana, sappiano
innanzi tutto essere testimoni di quel Gesù che ha raccontato Dio agli uomini con la sua vita umana.
Il primo mezzo di evangelizzazione resta la testimonianza quotidiana di una vita autenticamente
cristiana, una vita fedele al Signore, una vita segnata da libertà, gratuità, giustizia, condivisione, pace, una
vita giustificata dalle ragioni della speranza. Questa vita improntata a quella di Gesù potrà suscitare
interrogativi, far nascere domande, così che ai cristiani verrà chiesto di «rendere conto della speranza che
li abita» e della fonte del loro comportamento. Per questo servono uomini e donne che narrino con la loro
esistenza stessa che la vita cristiana è «buona»: quale segno più grande di una vita abitata dalla carità, dal
fare il bene, dall'amore gratuito che giunge ad abbracciare anche il nemico, una vita di servizio tra gli
uomini, soprattutto i più poveri, gli ultimi, le vittime della storia? Teofilo di Antiochia, un vescovo del II
secolo, ai pagani che gli chiedevano «mostrami il tuo Dio», ribaltava la domanda: «mostrami il tuo uomo e
io ti mostrerò il tuo Dio», mostrami la tua umanità e noi cristiani, attraverso la nostra umanità, vi diremo chi
è il nostro Dio. I cristiani del XXI secolo possono dire questo? Sanno mostrare una fede che plasma la loro
vita a imitazione di quella di Gesù, fino a far apparire in essi la differenza cristiana? La loro vita propone
una forma di uomo, un modo umano di vivere che racconti Dio, attraverso Gesù Cristo?
Nella lotta di Gesù contro ciò che è inumano, nella lotta dell'amore, c'è stato spazio anche per un'esistenza
umanamente bella, arricchita dalla gioia dell'amicizia, circondata dall'armonia della creazione e illuminata
da uno sguardo di amore su tutte le realtà più concrete di un'esistenza umana. Perché anche le gioie e le
fatiche che il cristiano incontra ogni giorno diventino eventi di bellezza occorre una vita capace di cogliere
sinfonicamente la propria esistenza assieme a quella degli altri e del creato intero.
Così, la vita del cristiano che vuole annunciare Gesù come «uomo secondo Dio» sarà anche, a imitazione
di quella del suo Signore, una vita felice, beata. Certo, non in senso mondano e banale, ma felice nel
senso vero, profondo, perché la felicità è la risposta alla ricerca di senso. Tale dovrebbe essere la vita
cristiana: liberata dagli idoli alienanti come dalle comprensioni svianti della religione, contrassegnata dalla
speranza e dalla bellezza.
LA SANTIFICAZIONE DEL NOME
I vocaboli del linguaggio cristiano "martire" e
"martirio" risalgono, come è noto, alla parola greca
che indica testimone e testimonianza. Ciò non
accade nell'ebraismo: la parola ‘ed designa il
testimone, non il martire. In ebraico c'è invece una
coppia di espressioni opposte, e correlate anche
concettualmente, qiddush ha-Shem e chillul haShem, che alla lettera significano "santificazione
del Nome [di Dio]" e "profanazione del Nome",
entrambe di origine biblica.
Come si santifica il Nome di Dio? Con la preghiera,
con la condotta, con il martirio; così come si
profana il Nome di Dio con l'immoralità e
"calpestando come la polvere della terra la testa
dei poveri" (Am 2,7).
Questa diversità semantica rispetto al lessico
cristiano ha una sua ragione teologica: il martire
cristiano è colui che muore per testimoniare la sua
fede, il martire ebreo è colui che muore per non
venir meno alla volontà di Dio espressa nei
precetti: "è scritto (Es 20,6): 'Coloro che amano e
osservano i miei comandamenti'. Rabbi Natan
disse: 'Questi sono i figli d'Israele che hanno dato
la loro vita per i precetti'. 'Perché sei condotto alla
decapitazione?'. 'Perché ho circonciso mio figlio
affinché fosse un figlio d'Israele'. 'E perché sei
condotto a essere arso?'. 'Perché ho letto la Torà'.
'E perché sei condotto a essere crocifisso?'.
'Perché ho mangiato pane azzimo'. 'E perché sei
flagellato?'. 'Perché ho portato il lulav [mazzo di
palma, mirto e salice usato nella festa delle
Capanne]. Queste piaghe mi hanno fatto amare dal
Padre mio che è nei cieli"' (Mekhilta', Bachodesh
6).
Di fatto, anche questo tipo di martirio è incluso
nella concezione cristiana: basti pensare ai sette
fratelli Maccabei, alla loro madre Anna (il suo nome
è nelle fonti talmudiche), al vecchio Eleazaro, tutti
personaggi del Il libro dei Maccabei (che si trova
solo nella Bibbia cattolica e ortodossa), morti per
non violare le leggi della kasherut, dei cibi puri e
impuri, che - ironia del canone! - sono tra le leggi
rituali ebraiche più spesso disprezzate dai cristiani.
La coscienza di questi martiri è bene espressa dal
racconto talmudico, leggermente diverso nelle
motivazioni (i sette fratelli rifiutano l'idolatria):
"Quando lo presero [l'ultimo fratello] per ucciderlo,
sua madre disse: 'Datemelo ché lo possa baciare
un momento'. Allora gli disse: 'Figlio mio, va' e di'
ad Abramo vostro padre: Tu hai eretto un altare, io
ho eretto sette altari'. Poi salì sul tetto, si gettò giù
e morì. E una voce celeste disse: 'Madre gioiosa di
figli!' (Sal 113,9)" (bGhittin 57b).
Se all'origine del martirio ebraico sta l'ubbidienza e
all'origine del martirio cristiano la fede, non
bisogna, come appunto mostrano gli esempi citati,
farne due categorie separate. Il tema della
testimonianza gioca un ruolo fondamentale nella
"santificazione del Nome", come appare anche
dalla normativa stabilita in proposito dal sinodo
rabbinico di Lod o Lidda (Il sec. e.v.). Allora,
partendo dal principio che "un uomo deve vivere
per la pratica dei precetti divini, e non morire a
causa di essi" (Tanchuma' 81a), si decretò che "un
uomo può violare tutte le leggi per salvarsi la vita,
tranne queste tre: divieto di idolatria, fornicazioneincesto-adulterio, e omicidio. Ma questa regola vale
soltanto se uno è solo, o sono presenti meno di
dieci uomini [dieci uomini costituiscono già la
comunità, l'ekklesia]. In pubblico, bisogna morire
piuttosto che violare anche il più piccolo precetto"
(jShev’it 35a). Questo, perché non si dia
testimonianza di scandalo, cioè chillui ha-Shem: e
a tale principio si erano attenuti i leggendari fratelli
Maccabei. D'altro lato, nel suo codice rituale, Mosè
Maimonide, prendendo posizione nella disputa
sulla liceità di ricercare il martirio, sostiene che chi
sceglie il martirio nei casi in cui la legge sceglie la
vita, è colpevole (Jad chazaka', Jesode' haTorà
5,1).
La normativa di Lod prende forma nel periodo delle
due guerre giudaiche, periodo nel quale non a caso
l'accezione di qiddush ha-Shem come martirio
prevalse sulle altre due indicate sopra, e nel quale
accanto ai numerosi casi di martirio individuale, tra
cui il celebre martirio di rabbi Aqiva, si
manifestarono anche casi di martirio collettivo in
forma di suicidio di massa, come quello dei 960
difensori di Masada contro i romani nel 73 e.v. Sul
suicidio come qiddush haShem, parecchi racconti
si riferiscono alla prima guerra giudaica, e fra
questi alcuni narrano di navi piene di giovani e
fanciulle, o di notabili di Gerusalemme, mandati da
Vespasiano a Roma per essere destinati ai
bordelli. I prigionieri si annegarono durante il
viaggio, per non commettere chillul ha-Shem.
Allora "lo Spirito santo pianse e disse: 'Per queste
cose io piango' (Lam 1,16)" (Lamentazioni Rabbà
1,45-46).
Si riferisce invece alla seconda guerra giudaica il
racconto del martirio di rabbi Chananjà ben
Teradion. Adriano aveva proibito lo studio della
Torà: Chananjà trasgredì il divieto, e fu condannato
a essere arso avvolto nel rotolo della Torà che
aveva con sé. E perché non morisse subito, gli
misero sul cuore gomitoli di lana bagnata. I
discepoli gli chiesero: "Che cosa vedi?". Rispose: "I
fogli del rotolo bruciano e le lettere volano al cielo".
Allora gli suggerirono di aprire la bocca per morire
più in fretta, ma egli replicò:
"È meglio che Colui che mi diede l'anima se la
riprenda, piuttosto che io violi il precetto di non
nuocere a se stessi". A questo punto il carnefice gli
disse: "Maestro, se tolgo la lana bagnata e aumento il fuoco [per accelerare la morte], mi condurrai nel mondo che verrà?". Chananjà lo promise, il carnefice tolse la lana, aumentò il fuoco e il
maestro morì. Subito il carnefice si gettò nel fuoco,
e una voce celeste proclamò: "Rabbi Chananjà ben
Teradion e il carnefice sono destinati alla vita del
mondo che verrà". Rabbi (Giuda) pianse e disse:
"Alcuni ottengono il mondo che verrà in un'ora, e
alcuni lo guadagnano solo dopo molti anni" (cf.
bAvodà Zarà 17b-18a, tr. it. citata in E.Bianchi, op.
cit., pp. 114-115). È singolare in questa storia di
martirio la somiglianza con il caso del buon ladrone
in croce con Gesù: il martirio irradia intorno a sé
una forza salvifica unica, già prefigurata nel
sacrificio di Isacco, che per l'ebraismo è fonte di
salvezza di generazione in generazione.
Un altro momento forte nella storia bimillenana
del martirio ebraico (nel quale ai persecutori romani
si sostituirono quelli cristiani) è il periodo delle
crociate, specialmente la prima. Le comunità
ebraiche della valle del Reno furono il bersaglio
delle orde caoticamente in marcia verso la Terra
santa. Nel maggio del 1096 le comunità di Spira,
Worms, Magonza, Colonia, Treviri, Metz e anche
Praga furono distrutte: agli ebrei fu lasciata la sola
alternativa del battesimo. La prima che scelse il
martirio fu una donna, a Spira, il 3 maggio.
Seguirono eccidi e suicidi di massa, compiuti come
consapevole qiddush ha-Shem. Nonostante i
tentativi dei vescovi di salvare gli ebrei, i martiri
furono 5000; altri 2500, secondo l'accusa fatta da
Gregorio IX ai crociati, perirono nella e dopo la
terza crociata (1189-92), soprattutto in Inghilterra.
Un'ulteriore stagione di martirio furono i secoli XIVXVI in Spagna; e anche allora il modello fu quello
dei sette fratelli (è da ricordare che l'Inquisizione
interrogava i cuochi dei marrani - gli ebrei
battezzati a forza che osservavano segretamente
l'ebraismo - per scoprire se mangiavano ancora
kasher).
Nel 1648-49 il cosacco Bogdan Chmielnicki considerato oggi l'eroe nazionale dell'Ucraina - con
le sue bande massacrò 100.000 ebrei ucraini e
polacchi e distrusse 300 comunità: una tragedia
che l'ebraismo est-europeo definì la terza
distruzione del tempio, e che fu pianta con un lutto
di tre anni. È per noi difficile discernere in tali eventi
le vittime dai martiri: ma proprio questo ha il suo
significato nella definizione del martirio.
Nel nostro secolo, il martirologio ebraico pareva
ormai consegnato alle cronache e alle lamentazioni
liturgiche del passato. Ma giunse qualcosa
peggiore del martirio, la Shoà (in ebraico,
"catastrofe"): peggiore non solo per il numero (6
milioni di vittime), ma perché alle vittime fu negato
anche il martirio, in quanto fu loro negata ogni
scelta. L'unica, ignara scelta fu quella dei loro
genitori, di averli messi al mondo per la morte. Da
allora, il fumo di Auschwitz ha nascosto a molti il
Nome, che i martiri antichi invece manifestavano e
glorificavano. Perché questo Nome riappaia,
occorre che lo si cerchi non dalla parte di quel Dio
che gradiva gli olocausti (si vede quanto sia
inopportuno e quasi empio il termine Olocausto per
designare la Shoà) ma da quella dei martiri nonmartiri, fra i quali, umiliato e muto, Egli patì la più
grande profanazione della storia. Le parole di Dio a
Giacobbe: "Ecco, io sono con te" (Gen 28,12),
sono per noi, se abbiamo la forza di crederlo, la
testimonianza del coinvolgimento di Dio in questo
martirio.
(De Benedetti, Ciò che tarda avverrà, Qiqajon,
Vercelli 1992, pp. 80-86.)