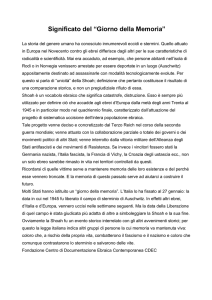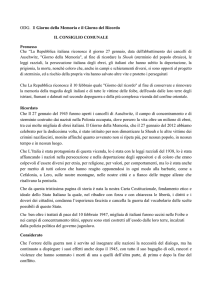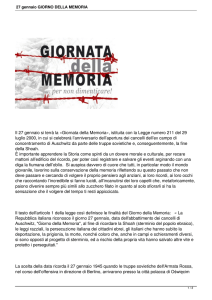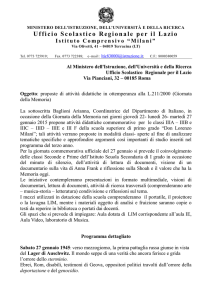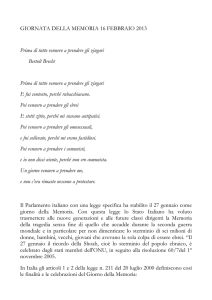Seconda pagina
lunedì 26 gennaio 2004
Speciale
La storia
che ritorna
DA FRANCOFORTE
I.G. Farben: un nome che da
un secolo provoca forti emozioni,
prima di orgoglio per le innovazioni in campo chimico, poi di orrore per il sostegno al regime nazista nella campagna di sterminio, e infine di rabbia per le speculazioni in borsa legate alla sua
eredità patrimoniale.
L’“industria dei colori” venne
costituita alla vigilia della prima
guerra mondiale, si sviluppò sotto il mantello del regime nazista,
e venne messa a nudo dagli Alleati alla fine della seconda guerra mondiale. La sua liquidazione
è stato un processo martoriato,
durato oltre cinquant’anni e conclusosi con una dichiarazione
d’insolvenza. Ai lavoratori coatti
della “I.G. Auschwitz”, rimasti a
mani vuote, rimangono solo i
tragici ricordi e i biglietti da visita di avvocati pronti a far valere i
loro diritti, per lo più morali. Infine sono riemersi /senza troppo
successo, questa volta) anche
quegli avvocati in stile Ed Fagan
che puntano al grande malloppo
non tanto in Germania, quanto
negli Stati Uniti e in Svizzera. La
storia della I.G. Farben sembra
non aver fine, ma soprattutto
non sembra trovar pace.
In Germania l’industria chimica incominciò a svilupparsi
attorno al 1870. Già nel 1900 ben
sei imprese dominavano il mercato mondiale nella produzione
di coloranti sintetici: BASF,
Bayer, Hoechst, Agfa, Cassella e
Kalle. L’aspra concorrenza e gli
alti costi di ricerca portarono a
una svolta del settore chimico tedesco. Nel 1904 i direttori di
Bayer (Leverkusen), BASF - Badische Anilin & Soda Fabrik AG
(Ludwigshafen) e Agfa (Berlino)
decisero di unirsi in una Interessengemeinschaft mit Gewinnausgleich IG, una “comunità d’interessi con perequazione degli utili”. Nel 1907 a questa joint venture
si aggiunsero i concorrenti Hoechst (Francoforte sul Meno), Cassella (Francoforte sul Meno) e
Kalle (Wiesbaden).
Il 9 dicembre 1925 avvenne il
passo decisivo: la fusione nella
I.G. Farben, che diventò il più
grande gruppo industriale del
mondo con l’85% del mercato dei
coloranti. Nel 1929 il gruppo registrò un fatturato di 1,4 bilioni di
Reichsmark, di cui quasi il 60%
in export. Il primo direttore generale della I.G. Farben fu Carl
Bosch, l'uomo che mise a punto il
processo di sintesi dell'ammoniaca, che gli valse il premio Nobel
per la chimica nel 1931.
Furono gli anni dell’orgoglio.
Poi venne l’inarrestabile ascesa
dei nazisti e con essa le prospettive di guadagno in guerra. L’inizio della collaborazione tra i manager del gigantesco cartello monopolistico e il nazionalsocialismo venne siglato nel momento
in cui la direzione della I.G. Farben firmò uno chèque di 400 mila
Reichsmark per il Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (Nsdap), fondo che andò a finanziare la campagna per l'elezione di Adolf Hitler a cancelliere nel 1933. Il ringraziamento del
Führer non si fece attendere. Appena divenuto Kanzler sottoscrisse il cosiddetto “contratto
della benzina” con cui il ministero dell'economia del Terzo Reich
e le industrie I.G. Farben si accordarono per la produzione entro il 1935 di 400 mila tonnellate
di benzina sintetica all'anno fino
al 1944. Lo Stato avrebbe pagato
alla I.G. Farben la differenza fra
il costo di produzione e il prezzo
sul mercato libero della benzina,
impegnandosi a comprare il
combustibile eventualmente invenduto, in modo da assicurare
in ogni modo un profitto, di almeno il 5%, agli azionisti del
gruppo.
In men che non si dica, attraverso intrecci personali e mutua
dipendenza, la I.G. Farben, con
sede a Francoforte sul Meno, divenne il più grande finanziatore
della politica di sterminio. Senza
la I.G. Farben per Hitler non sa-
laRegioneTicino
Nella vicenda del colosso chimico tedesco I.G. Farben,
che produsse il gas Zyklon B utilizzato nei campi di sterminio,
si riflette la storia delle compromissioni dell’industria tedesca
nel più grande crimine del ventesimo secolo
di Resy Canonica
I colori
dello sterminio
I.G. Auschwitz
Dai fasti del Reich allo smembramento
• 1925 Costituzione della Interessengemeinschaft Farbenindustrie Ag (I.G. Farben) con sede a Francoforte sul Meno. Attraverso la fusione di imprese del calibro di
Bayer, BASF, Agfa e Hoechst nasce il maggiore gruppo chimico del mondo con oltre
83 mila dipendenti.
• 1933 “Contratto della benzina” tra I.G.
Farben e regime nazista, che regola l’acquisto pubblico dei prodotti del gruppo.
• 1941 Inizio dei lavori di costruzione della
I.G. Auschwitz per la produzione di caucciù
sintetico e di olio combustibile.
• 1945 Gli Alleati sequestrano tutto il patrimonio della I.G. Farben.
• 1947 Inizio del processo per i crimini di
guerra nazisti a 24 manager della IG Farben.
13 dirigenti vengono condannati a pene detentive tra i 18 mesi e i 6 anni per “schiavizzarebbe stato possibile distruggere
quello che ha distrutto, e senza
Hitler la I.G. Farben non avrebbe
potuto guadagnare quello che ha
guadagnato. Nel 1939 registrò un
fatturato di 821 milioni di Reichsmark, e quattro anni più tardi divennero già 1,7 miliardi. Durante la guerra contò 190 mila dipendenti e un fatturato di quasi tre
miliardi di Reichsmark. Un risultato ottenuto anche mediante
l’impiego di lavoratori coatti.
Dal 1941 il capo delle SS Heinrich Himmler in persona esercitò sempre più pressione per aumentare la produzione di gomma sintetica (detta Buna, nome
derivante dalle sillabe iniziali di
due suoi ingredienti: il butadiene e il sodio, Natrium in tedesco)
nei paesi occupati all’est, lontano
dalle bombe degli Alleati. In Polonia, ad Auschwitz-Monowitz,
venne costruita la fabbrica “I.G.
Auschwitz” con il sangue dei detenuti dei campi di sterminio.
Dei 40 mila internati, due terzi
morirono annientati dal lavoro.
Ma il nome della I.G. Farben
rimane indissolubilmente legato
alla produzione del gas tossico
Zyklon B. Possedendo una parte-
2
zione della popolazione civile nei paesi occupati”.
• 1952 Smembramento della I.G. Farben e
istituzione della “I.G. Farben in liquidazione”. Bayer, BASF e Hoechst riprendono l’attività in modo indipendente.
• 1958 La I.G. Farben i. l. versa alla Jewish
Claims Conference 30 milioni di marchi, con
cui vengono risarciti 8.000 dei 200 mila ex lavoratori coatti.
• 1988 La Corte federale di giustizia respinge il ri-trasferimento alla I.G. Farben i. l. di 4,4
miliardi di marchi di beni all’estero depositati presso l’allora Società di Banca Svizzera.
• 1994 La società di partecipazioni Wcm
(di Karl Ehlerding), con sede a Francoforte
sul Meno, fino ad allora la più grande filiale
della I.G. Farben, aumenta la sua quota di capitale della I.G. Farben i. l. al 75%. Wcm ri-
cipazione del 42,5% della Degesch (Deutsche Gesellschaft für
Schädlingsbekämpfung), fu produttrice, assieme a Degussa, dell’arma letale usata nelle camere
a gas. La I.G. Farben divenne una
vera e propria fabbrica dell’orrore.
Con la disfatta del Terzo Reich
nel 1945 ebbe fine questo orrore,
ma non la storia della I.G. Farben. Gli Alleati ordinarono lo
smantellamento del gruppo per
impedire che si ripetesse un’alleanza tra l’industria chimica e
la politica tedesca. Il Tribunale
di Norimberga decise di far ereditare il 90% del gruppo a Bayer,
Hoechst e BASF e di mettere in
liquidazione il restante 10%.
Ognuna delle tre società tornate
indipendenti e proprietarie di
quasi tutte le fabbriche della Germania occidentale oggi è venti
volte più grande di quanto la I.G.
Farben madre fosse al massimo
del suo sviluppo nel 1944. Nonostante ciò, esse non si sono mai
considerate i successori nei rapporti giuridici della I.G. Farben,
e non hanno mai ritenuto doveroso adempiere a risarcimenti
nel nome della Horrorfabrik (per
balta così la sua posizione facendo della sua
società madre una sua filiale.
• 1999 La I.G. Farben i. l. annuncia l’istituzione di una fondazione, con il cui reddito devono venire risarciti i lavoratori coatti. Invece
del patrimonio previsto di 3 milioni di marchi, vengono raccolti solo 500 mila marchi.
• 2000 Il governo federale e l’economia tedesca creano un fondo per gli indennizzi degli ex lavoratori coatti. La I.G. Farben i. l. non
vi partecipa, facendo valere l’esistenza della
fondazione.
• 2001 Accordo per la vendita di 479 appartamenti del valore di 38,4 milioni di euro in
proprietà della I.G. Farben alla Wcm per 1,5
milioni di euro.
• 2003 La Wcm non effettua il pagamento.
Alla I.G. Farben viene a mancare la liquidità
e dichiara l’insolvenza.
quasi trent'anni dopo la seconda
guerra mondiale i presidenti dei
rispettivi consigli di amministrazione furono ex membri del
partito nazista).
Per quanto riguarda il restante 10% della I.G. Farben in liquidazione, la storia non è meno triste e, anzi, suscita ancora più
rabbia. Secondo una decisione
degli Alleati, la società “I.G. Farben in liquidazione” avrebbe dovuto limitarsi a vendere il patrimonio residuo della I.G. Farben,
versarne il ricavato ai lavoratori
coatti, e poi sciogliersi. Ma la liquidazione durò più a lungo del
periodo di esistenza attiva della
fabbrica stessa. Ai vari amministratori importava non tanto la
liquidazione della ditta, quanto
la propria liquidità. E si tratta di
molti milioni di marchi sottratti
in vari modi: mediante la vendita di immobili sottoprezzo, mediante riparti straordinari ai soci – in tutto tre: 1967, 1986 e 1994 –
e non da ultimo attraverso le speculazioni in borsa favorite dalle
capriole del titolo soprattutto nel
periodo della riunificazione tedesca.
Solo nel 1998, con la nomina
dei liquidatori Otto Bernhardt e
Volker Pollehn, incominciò una
vera e propria liquidazione della
più grande industria tedesca dell’anteguerra. Nel 1999 venne
creata una fondazione, la IG Farben Stiftung, con una filiale negli Stati Uniti, per rivendicare il
risarcimento dei lavoratori coatti. Sinora la fondazione è dotata
solo del capitale iniziale di 500
mila marchi (250 mila euro), ma
spera ancora di poter rimpinguare il fondo riorganizzando il
ri-trasferimento dei beni depositati all’estero… in Svizzera, nell’ex Società di Banca Svizzera,
ora UBS.
Si tratta di una vicenda simile
a tante altre createsi nel periodo
nazista al confine tra la Germania e la Svizzera. Infatti è a Basilea che la I.G. Farben, per questioni fiscali e di sicurezza in generale, costituì la I.G. Chemie
con un capitale proprio di 290 milioni di franchi svizzeri e con una
filiale negli Stati Uniti che dal
1939 si chiamò General Aniline
and Film Corp.
Dopo la guerra, il governo
svizzero congelò beni e attività
delle società tedesche, tra le qua-
li anche la I.G. Chemie, che dal
1945 si chiamò Interhandel AG.
Ma poi, sulla base di una serie di
rapporti stilati dalle autorità elvetiche, la Interhandel venne riabilitata e nel 1959 si fuse con la
SBS. In seguito, dopo anni di colloqui, venne raggiunto un accordo secondo cui l’amministrazione Usa nel 1964 concesse alla Interhandel, e quindi alla SBS, una
quota (515 milioni di franchi
svizzeri) derivante dal realizzo
della liquidazione della General
Aniline and Film Corp.
Queste sono le operazioni che
alimentano le discussioni attorno all’affaire I.G. Farben: la Interhandel e la General Aniline
and Film Corp. erano da considerarsi ormai società svizzere, o
erano invece da considerarsi ancora appendici della tedesca I.G.
Farben?
Da una parte l’UBS respinge
ogni dubbio in questo senso affermando che la Interhandel era
indipendente dalla I.G. Farben
già dal 1940, facendo riferimento
anche ai risultati della Commissione indipendente d’esperti
Svizzera - seconda guerra mondiale (Commissione Bergier)
presentati nell’estate 2001. Dall’altra parte gli azionisti della
I.G. Farben in liquidazione portano avanti i propri argomenti.
Già venti anni fa, l’associazione
degli azionisti aveva tentato il
rimpatrio dei beni, un’azione che
si concluse con un fallimento alla Corte federale di giustizia nel
1988.
Ora a dar man forte agli azionisti è saltato fuori di nuovo
Edward Fagan, l’avvocato americano divenuto famoso con la denuncia collettiva per recuperare
i fondi ebraici “dormienti” nei
forzieri svizzeri. Fagan e gli azionisti, guidati da Rüdiger Beuttenmüller, affermano di poter sostenere la propria causa con nuove prove scovate in documenti
degli archivi della DDR, dell’Unione Sovietica e anche della
Svizzera che dimostrerebbero la
malafede della SBS.
In una conferenza stampa a
Zurigo lo scorso 29 dicembre, Ed
Fagan ha annunciato di aver
consegnato un ultimatum al patron dell’UBS Peter Wuffli, chiedendogli di aprire dei negoziati
per raggiungere un accordo amichevole sul dossier I.G. Farben
entro il 9 gennaio… Termine scaduto e perciò Fagan continuerà
la sua crociata davanti al tribunale del distretto sud di New
York. Questa volta in palio ci sono 2,2 miliardi di dollari.
A prescindere dall’esito della
vertenza, anche in questo caso
ad approfittare non saranno le
vittime della persecuzione nazista. A loro non è rimasto che dimostrare la rabbia cresciuta negli anni.
Come il 10 novembre scorso
quando alla pretura di Francoforte la “I.G. Farben in liquidazione” ha chiesto l’avvio della
procedura d’insolvenza. Uno degli ex lavoratori coatti presenti
alla dimostrazione ha ammesso
di potersi consolare pensando al
destino della ex centrale della
I.G. Farben a Francoforte: un edificio lungo 250 metri e alto sette
piani dell’architetto Hans Poelzig. Finito di costruire nel 1930 –
con il nome di I.G. Farben Haus –
ospitò gli uffici del gruppo industriale. Alla fine della guerra – ribattezzato I.G. Farben Building –
divenne il quartier generale dell’esercito Usa in Europa guidato
dal generale Dwight D. Eisenhower. Qui vennero applicate
le decisioni prese a Washington
sulla riorganizzazione della Germania del dopoguerra. Nel 1995
il quartier generale venne trasferito ad Heidelberg, lasciando così lo stabilimento alla città di
Francoforte che decise di trasformarlo in un campus universitario. Dal 2001 vi studiano i giovani
della Johann Wolfgang Goethe
Universität e non viene più chiamato con il nome dell’ex proprietario, bensì con il nome dell’architetto.
L’inchiesta
lunedì 28 gennaio 2008
Speciale
Operazione
pulizia
di Stefano Guerra
Davide Martinoni
e Diego Moles
Foto Ti-Press
laRegioneTicino
2
Il Piano di Magadino...
Ex discariche, depositi, aziende attive fuori zona edificabile sono solo
alcuni dei segni tangibili del degrado paesaggistico del Piano di
Magadino, un comprensorio che negli ultimi 40 anni ha vissuto un
rapido e disordinato sviluppo. Ma queste situazioni abusive sono anche
il frutto della negligenza e del lassismo dei Comuni (e, in minor misura,
del Cantone) in ambito edilizio e pianificatorio. C’è voluto il rogo
di Riazzino perché il Dipartimento del territorio decidesse di fare un po’
di pulizia richiamando gli enti locali alle loro responsabilità
Trasformato da palude a territorio
agricolo con l’arginatura del fiume
e la bonifica, il Piano si estende
su una superficie di 4 mila ettari
(1’600 circa sono “verdi”), con 16
Comuni e oltre 29 mila abitanti
Il Piano passato al setaccio:
Una ditta di compostaggio, un’azienda di commercio legnami, un’ex discarica, diversi depositi e un oliveto
Sono una quindicina gli abusi
edilizi di gravità medio-elevata
sul Piano di Magadino. È quanto
emerge dalle segnalazioni di una
dozzina di Comuni sollecitati
poco meno di un anno fa dal Dipartimento del territorio (Dt) a
voler trasmettere a Bellinzona
un elenco di opere, impianti, depositi e attività non autorizzati e
di una certa incidenza territoriale (per intenderci: non la piccola
baracca per gli attrezzi su un appezzamento agricolo) situati fuori zona edificabile nei rispettivi
comprensori.
la Morobbia a Giubiasco. Il 20
febbraio 2007 il capo del dipartimento Marco Borradori ha scritto a 12 Comuni del Piano (Giubiasco, Camorino, Sant’Antonino,
Cadenazzo, Gudo e Sementina
per il Bellinzonese; Contone, Magadino, Locarno, Tenero, Gordola, e Cugnasco per il Locarnese)
chiedendo loro di trasmettere all’Ufficio delle domande di costruzione (Udc) un elenco degli stabili e delle situazioni abusive di
gravità medio-elevata. Dieci Comuni hanno risposto sin qui. Alcuni (pochi) per dire che non
hanno nulla da segnalare. Dalle
indicazioni di chi si è già fatto
vivo emerge una situazione «non
così catastrofica come si potrebbe
credere», osservano all’Udc. Ma
andiamo a vedere.
Tutto cominciò a Riazzino
All’indomani dell’incendio di
copertoni verificatosi 14 mesi fa
sul “terreno Tomasetti” a Riazzino, ai piani alti del Territorio ci
si è detti che era davvero giunta
l’ora di richiamare all’ordine i
Comuni, di tentare di fare almeno un po’ di pulizia sul Piano di
Magadino. Sull’onda delle polemiche e dell’inquietudine generate dal rogo di Riazzino, il Dt ha
così intensificato l’attività di vigilanza sul comprensorio che va
dalla foce del Ticino a quella del-
Locarno territorio
‘sensibile’
Un po’ di pulizia nel comprensorio che va dalle Bolle di Magadino alla foce della Morobbia a Giubiasco
“Affaire Compodino” e “terreno Tomasetti” a parte, i casi segnalati dal fronte locarnese del
Piano di Magadino perché non
conformi alla Legge edilizia cantonale o alla Legge federale sulla
pianificazione del territorio sono
emblematici di un certo modo di
“vivere” il territorio. Locarno
ha ricevuto di recente dal Cantone una proposta di incontro (per
altro sollecitato dalla stessa
Città) che presumibilmente avrà
luogo già nella seconda metà di
febbraio e darà modo di valutare
alcune situazioni particolari e
stabilire come procedere.
Uno dei temi in discussione
sarà l’ex discarica Fondeca, un
fondo di circa 4 mila metri quadrati, situato fuori zona edificabile, di fianco al riale Trodo, nella fascia golenale protetta del Ticino. Recentemente i proprietari
hanno provveduto a sgomberare
materiale di diverso tipo, dando
così seguito ad un’ingiunzione
giunta a ottobre da parte della
Città. Negli ultimi anni il sedime
era stato utilizzato come deposito intermedio. Verrà certamente
inventariato fra i siti inquinati.
Sulla sponda sinistra del fiume Ticino, in direzione della
Monda, c’è una seconda situazione “sensibile”: si tratta di un terreno agricolo, di 5-6 mila metri
quadrati, che ha subìto importanti lavori di bonifica, per altro
non completamente autorizzati.
La Compodino trasloca
Trasferimento ‘sostenibile’ in vista per la ditta di compostaggio
Sviluppi straordinari e di grande interesse sono attesi in fondo al tunnel dell’annosa “querelle” in atto fra ente pubblico (Cantone e Città di Locarno), Compodino e privati in merito all’attività di
compostaggio svolta sul Piano di Magadino, in territorio di Locarno.
L’azienda, come noto, opera da anni
in una sorta di limbo pianificatorio.
Questo perché il sedime è adibito a centro di compostaggio, ma essendo situato
in zona agricola non ha potenzialità di
sviluppo edilizio che consentano di apportare tutta una serie di migliorie tecniche utili anche ad eliminare i cattivi
odori – veri o presunti che siano – che
sono la causa delle maggiori recrimina-
‘Poteva essere peggio’
Anche l’Unione contadini ticinesi (Uct) ha fornito a Bellinzona un elenco di situazioni non
autorizzate fuori zona edificabile sul Piano di Magadino. Il segretario Cleto Ferrari non vuole dire né quante né quali né
dove sono. Perché si tratta di
«casi non sempre giuridicamente
chiari». Tra le situazioni segnalate dall’Uct all’Ufficio domande
di costruzione vi sono (ancora)
il “terreno Tomasetti” a Riazzino e un fondo agricolo adiacente
all’A13 in territorio di Locarno
utilizzato dal gruppo Piero Ferrari nell’ambito dello smantellamento del silos e del trasloco
dalle Bolle di Magadino. Ma in
generale, Cleto Ferrari relativizza: «Va tenuto conto del fatto che
la pianificazione del comprensorio è stata lasciata nelle mani dei
14 Comuni del Piano di Magadino, e ognuno ha sempre guardato
all’interno del proprio orticello.
Se poi si considera anche la crescita della popolazione, mi sembra di poter dire che poteva anche
essere peggio. Abbiamo la fortuna che sul Piano di Magadino si
può fare ancora qualcosa: la situazione non è compromessa
come al Pian Scairolo o nella piana di San Martino a Mendrisio».
Il segretario dell’Uct intravede
una possibilità nell’istituzione
di un fondo per sostenere i Comuni in caso di dezonamenti e
al limite anche le aziende situate su terreni agricoli intenzionate a traslocare in zona artigianale. Una mozione in questo senso,
sottoscritta tra gli altri dallo
stesso Ferrari, è pendente al
Consiglio di Stato.
zioni. La Compodino è comunque, notoriamente, il centro di compostaggio del
Locarnese per definizione, visto che
raccoglie e smaltisce annualmente
qualcosa come 8-10 mila tonnellate di
scarti verdi, e i suoi maggiori fornitori
sono proprio i Comuni.
Ebbene, l’intera questione sta subendo una svolta improvvisa e di notevole
importanza: si sta valutando l’ipotesi di
un trasloco della Compodino su un terreno situato a circa tre chilometri di distanza, sul quale l’azienda intende aprire un impianto di compostaggio con valorizzazione del biogas. Il terreno per il
futuro insediamento, già acquisito allo
scopo, è pure situato in zona agricola, in
pieno futuro Parco del Piano di Magadino, ma sembrerebbe decisamente più
adatto ad un azzonamento Ap/Ep rispetto a quello che ospita attualmente il
centro di compostaggio.
Realizzare il progettato impianto con
valorizzazione del biogas aprirebbe uno
scenario del tutto nuovo e sarebbe un
atto concreto di promovimento dell’energia pulita nel Sopraceneri. Il progetto specifico nasce da uno studio di varianti sottoposto al Cantone alcuni mesi
fa e scaturito nella scelta di una variante pianificatoria riguardante appunto il
nuovo terreno. Tramite un impianto di
fermentazione (coperto) il futuro centro
di compostaggio sfrutterebbe il suo bio-
gas – e forse anche dell’altro, grazie a sinergie ancora da pianificare – per produrre energia elettrica pulita da poi
mettere in rete in collaborazione con un
fornitore.
In Svizzera è già attiva una ventina di
stazioni di biogas del genere previsto
sul Piano di Magadino, ma quella che
più si avvicina al progetto locarnese è
della Kompogas, inaugurata nel giugno
del 2007 a Utzenstorf, nella campagna
bernese.
Attualmente è al vaglio del Cantone,
per preavviso, una bozza della necessaria variante pianificatoria. Dopodiché il
dossier andrà sui banchi della commissione Piano regolatore del Consiglio co-
munale cittadino; commissione che dovrà fornire al Legislativo tutti gli elementi utili per decidere se credere o
meno nella promozione dell’energia pulita.
A questo progetto, notasi bene, se ne
allinea un altro per lo sfruttamento
della biomassa, promosso dal Comune
di Losone forse in collaborazione con
la Società elettrica Sopracenerina. Ma
la possibile concorrenza non spaventa
i promotori della “nuova” Compodino:
«Tutte le iniziative del genere sono benvenute. Abbiamo già perso troppo tempo ed è giunto il momento di accelerare
nella promozione delle energie alternative».
Una riga da tirare sull’espansione non autorizzata
Gudo, la Giordani Sa deve fare marcia indietro. I titolari: troppo cari i terreni industriali
Dino e Giuseppe, i fratelli
Giordani, distribuiscono su un
tavolo di legno i piani del ridimensionamento: «Ecco», fa Giuseppe puntando l’indice su una
delle planimetrie. «In pratica si
tratta di tirare una riga qui, tagliando quasi a metà la superficie
che usiamo oggi. La parte del sedime che resta fuori verrebbe ripristinata come terreno agricolo.
Sulla superficie restante invece
abbiamo proposto di togliere un
paio di piccoli châlets [tra cui
quello dove ci troviamo, ndr] e di
costruire un nuovo capannone
dove c’è già la vecchia tettoia: per
gestire meglio il deposito legname
e per poter lavorare a tetto, non
più all’esterno come abbiamo
sempre fatto finora, con sole pioggia neve...». Il progetto (che verrebbe realizzato a tappe con un
investimento di circa 2 milioni di
franchi su una decina d’anni)
non è piaciuto al Cantone. Un
paio di mesi fa i funzionari dell’Ufficio domande di costruzione
(Udc) hanno fatto sapere ai titolari della ditta di Gudo specializzata in commercio legnami e lavori
selvicolturali che va trovata
un’altra soluzione: oggi è impensabile costruire un capannone di
2 mila metri quadrati in un’area
agricola, all’interno del futuro
Parco del Piano di Magadino, e
per di più in piena “fascia cuscinetto” di una zona palustre di importanza nazionale.
Fondata a Giubiasco nel 1960
dal padre di Dino e Giuseppe, la
Giordani Sa (che allora non si
chiamava ancora così e che ora
con una ventina di operai è una
delle maggiori aziende del ramo
forestale in Ticino) si trasferì
agli inizi degli anni ’80 in località
“Ciosse Vecchie” a Gudo. I fratelli Giordani acquistarono due sedimi: uno di 4’846 metri quadrati
con un edificio-abitazione risalente agli anni ’50 e un altro, in
minima parte edificato, di 10’997
metri quadrati. L’area è situata
un centinaio di metri a est del
ponte che immette nello “Stradonino” che collega Gudo e
Sant’Antonino, lungo la strada
che costeggia l’argine insommergibile sulla sponda sinistra del
fiume Ticino. La ditta, con regolari licenze edilizie, costruì subito una tettoia per tenere al riparo
dalle intemperie i macchinari e
per stoccare il legname; successivamente sorsero altre piccole infrastrutture.
Negli ultimi anni la Giordani
Sa si è però estesa progressivamente verso Giubiasco, finendo
con l’occupare l’intera area di oltre 15 mila metri quadrati. Dieci
anni fa la Sezione agricoltura decretò che «quelli non sono fondi
agricoli ai sensi dell’articolo 6 della Legge federale sul diritto fondiario rurale (Ldfr)», dicono Giuseppe e Dino mostrandoci i documenti ufficiali. «Noi abbiamo
sempre fatto tutto alla luce del
sole: e nessuno ci ha mai detto
niente». L’area si trova in ogni
caso in zona Sac (superficie per
La Giordani Sa si è estesa fino a occupare tutto il sedime in zona Sac
l’avvicendamento delle colture).
E l’espansione dell’attività è avvenuta comunque senza la necessaria autorizzazione, sottolineano all’Udc. Sollecitati da Cantone
e Comune, i fratelli Giordani
hanno inoltrato una domanda di
costruzione a posteriori che in
sostanza ratificava la situazione
attuale. Di fronte al preavviso negativo del Dipartimento del territorio e alla decisione di diniego
della licenza edilizia da parte del
Municipio di Gudo giunta alcune settimane fa, i titolari della
ditta hanno incaricato un archi-
tetto di studiare una soluzione
per la riorganizzazione del sedime. Ma il progetto non rientra
nei paletti fissati dal Cantone (ripristino della situazione autorizzata, più un 30 per cento circa di
ampliamento previsto dalla Legge federale sulla pianificazione
del territorio). Perciò è stato bloccato dall’Udc, che non ne vuol sapere di un nuovo capannone di 2
mila metri quadrati in quell’area.
«Si tratta di un abuso grave. Lì
non può più essere costruito nulla.
Punto e basta», spiegano all’Udc.
A questo punto le alternative per
i titolari dell’azienda sono tre:
abbandonare totalmente o parzialmente («lasciando a casa alcuni operai») l’attività “storica”
del commercio della legna da ardere (che richiede superfici relativamente grandi ove depositare
e lasciar stagionare per un anno i
tronchi) nonostante l’accresciuto interesse per la legna quale
fonte di energia (i Giordani riforniscono diversi impianti di riscaldamento innovativi, pubblici
e privati, nella regione); puntare
su un nuovo deposito in zona boschiva («ma avremmo grossi problemi logistici, e poi ogni spostamento costa parecchio»); oppure
trovare un terreno che costa
poco in zona industriale (Giuseppe: «ma i prezzi oscillano tra i 200
e i 400 franchi al metro quadrato:
per noi sarebbe anti-economico»).
Cosa faranno adesso Dino e
Giuseppe Giordani? «Non lo sappiamo», rispondono all’unisono.
Quel che è certo è che torneranno a riunirsi con il Cantone e il
Comune nell’ambito dell’“operazione pulizia” sul Piano di Magadino. Nel frattempo, magari, anche lo stesso Cantone avrà dato
l’esempio sgomberando un deposito temporaneo (ma di fatto ormai abusivo, perché in funzione
da tempo) di materiale verde e legname situato su un terreno che
i fratelli Giordani scorgono in
lontananza guardando fuori dalla finestra del loro ufficio, verso
Sant’Antonino...
L’intervista
mercoledì 27 gennaio 2010
Speciale
La giornata
della memoria
che settimane fa, ha fatto
della memoria un baluardo
dalla cui sommità difendere
la causa della libertà e del diritto. Le memoria può dunque essere una forza dell’azione politica?
L’ultima
parola
Nel suo libro, lei cita Eli
Wiesel che invitava (quasi intimava) al silenzio “noi” che
non facemmo niente per impedire lo sterminio. Di chi è
allora, in termini di patrimonio che si trasmette di generazione in generazione, la memoria della Shoah?
«La prendo alla larga. È stato
tradotto recentemente in italiano il libro Perché l’Olocausto
non fu fermato, il cui autore, lo
storico americano T.S. Hamerow, mostra che – al contrario di
quanto vuole un luogo comune – negli anni ’30, ’40 cosa stesse avvenendo in Europa lo sapevano più o meno tutti. Il fatto è
che decidere di muoversi per interrompere quanto stava avvenendo avrebbe significato per i
diversi governi assumersi diverse responsabilità.
KEYSTONE
Si parla, si crede di ricordare, e perciò di sapere. Ma lo
scrittore Wlodek Goldkorn
ricordava, alcune settimane
fa, che la scritta Arbeit macht
Frei (rubata dall’ingresso di
Auschwitz, e da poco ricollocata) non è il “simbolo della
Shoah”, come è stato scritto
su tutti i giornali, perché si
trova in realtà all’ingresso
del campo di prigionia in cui
furono rinchiusi non solo
ebrei. Lo sterminio è avvenuto non lì, ma a Birkenau, ha
precisato. Parliamo tanto di
Shoah e ne sappiamo ben
poco, insomma?
«No. Non credo che sappiamo
poco. Sappiamo molte cose e forse conosciamo anche lo scenario
complessivo della Shoah, ma ne
abbiamo una memoria di tipo
museale. Voglio dire: di una visita al Louvre ricorderò solo qualcuna delle moltissime opere
d’arte che ho visto. Ciò che non
ho, e sfido chiunque ad avere, è il
segno complessivo del museo.
Dunque dobbiamo distinguere
tra ciò che sappiamo di un evento, ciò che percepiamo come senso di quell’evento, da ciò che è
parte del farsi di quell’evento,
ma che alla fine non è essenziale
per ricostruire il tempo passato.
C’è una bella frase dello storico francese Marc Bloch secondo
cui se voglio ricostruire il passato devo prendere una cosa, una
immagine che mi sta davanti in
quel momento e poi fare scorrere
indietro il rocchetto del film che
mi rappresenta quell’immagine
e allora ne scoprirò l’origine.
Non perché necessariamente la
successione degli eventi dia un
risultato obbligato, ma perché
ogni cosa che si produce è la conseguenza di una scelta tra diverse possibilità. Partire dall’oggi
per trovare il senso di ciò che è
stato, e non viceversa.
Così, la scritta “arbeit macht
frei” è l’oggetto che abbiamo davanti; possiamo non sapere
dov’è, ma sappiamo che cosa ci
evoca, la sua funzione è esattamente quella; ed è, direi, efficace: indica un evento e il posto in
cui è avvenuto».
2
A colloquio con lo storico David Bidussa
autore di ‘Dopo l’ultimo testimone’,
saggio sul ruolo e il significato della testimonianza
nella storiografia, e nella nostra coscienza,
dello sterminio nazista degli ebrei d’Europa
di Erminio Ferrari
E quando non ci sarà più nessuno a testimoniare? Quando le
parole di un sopravvissuto alla
Shoah potranno essere ascoltate
solo attraverso una registrazione? “Dopo l’ultimo testimone”
chi racconterà ancora, mostrando ciò che resta della propria
vita, che cosa è stato lo sterminio
nazista degli ebrei d’Europa?
Dopo l’ultimo testimone (Einaudi) è il titolo del libro che David Bidussa ha pubblicato l’anno
scorso per interrogarsi sulla dolorosa e necessaria problematicità con cui la parola del testimone concorre a scrivere la storia
di quell’evento. Bidussa, storico
sociale e ricercatore presso la
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha posto questa domanda
tanto più urgente mentre si avvicina il giorno in cui non ci sarà
più nessuno (vittima o carnefice) a poter raccontare “ciò che
vide”. Quale sarà allora la memoria di cui oggi si celebra la
giornata?
laRegioneTicino
L’ingresso di Auschwitz
‘Non uscirò vivo’
“Cari genitori
[…] Il campo si trova su una radura. Dal mattino presto
veniamo portati nella foresta a lavorare. I piedi mi sanguinano quando mi tolgo le scarpe. Lavoriamo tutto il
giorno quasi senza mangiare e la notte dormiamo per
terra (ci sono stati tolti anche i cappotti). Ogni notte arrivano soldati ubriachi e ci picchiano con dei bastoni di
legno. Il mio copro è nero per le macchie di sangue rappreso, come un pezzo di legno affumicato. Delle volte ci
tirano un paio di carote crude o barbabietole ed è una
disgrazia: ci picchiamo per acchiappare un pezzetto o
una fogliolina. L’altro ieri sono evasi due ragazzini, allora ci hanno messi in fila e ogni quinto della fila veniva fucilato. Non ero il quinto, ma so che non esco vivo da
qui […]
Chaim”
Il mittente era un figlio di contadini, nato a Sedziszow, in Galizia.
Fu arrestato e portato con migliaia di giovani ebrei nel lager di
Pustkow, anch’esso in Galizia, e lì ucciso in data sconosciuta. La
lettera, conficcata nel filo spinato, fu trovata da un contadino e
consegnata ai genitori (da Le mie ultime parole - Lettere dalla
Shoah, a cura di Zwi Bacharach, ed. Laterza).
La prima, riconosciuta l’impossibilità (o l’incapacità) di fermare la persecuzione degli ebrei
in Europa (negli anni ’30 non era
ancora in corso lo sterminio) poteva essere quella di favorire
l’immigrazione verso il proprio
paese. Hamerow mostra però
che il tasso di disponibilità all’accoglienza delle popolazioni
perseguitate era nelle opinioni
pubbliche, americana, inglese e
francese dell’ordine dello 0,5%,
0,7%. E uno dei motivi per cui
nessun governo si offrì di accogliere i gruppi di cui la Germania voleva “liberarsi”, fu appunto l’indisposizione delle proprie
opinioni pubbliche. Il secondo
motivo è che gli ebrei erano percepiti come una categoria di persone che in qualche modo aveva
lucrato negli anni della crisi economica. Dunque la loro condizione, almeno nella prima fase
della persecuzione, veniva percepita come una sorta di contrappasso. Significativamente, du-
rante la guerra, questo tasso di
problematicità non diminuì, ma
crebbe.
Allora qualcosa di vero c’è nella frase di Wiesel, e bisogna riflettervi. Io penso ad esempio
che quello stato d’animo non è
necessariamente orientato nei
confronti di un solo gruppo, in
questo caso gli ebrei, ma fa parte
del modo di pensare intemporale
dei sistemi politici.
L’altra cosa sorprendente rivelata da Hamerow, per noi almeno, è che il dato di riflessione sull’orrore non avvenne a campi
aperti, quando si ebbe la consapevolezza delle dimensioni dello
sterminio e ci si poteva attendere un atto almeno di resipiscenza. No, secondo Hamerow questo
atto, sondaggi alla mano, non ci
fu almeno fino alla fine degli
anni ’50.
Accanto a questo dato cita altri due casi, sintomatici: in paesi come Canada e Australia, il
tasso di disposizione all’acco-
glienza era ancora più basso dello 0,5%: parliamo di paesi con
una enorme disponibilità di spazio, con una presenza ebraica
sotto lo 0,3%, e che non hanno accolto nessuno».
Morale?
«È necessaria un’analisi di
una situazione e capire come si
originano le reazioni degli individui e delle comunità in condizioni di ansia e di paura. Va compreso che l’una e l’altra non si
vincono affrontandole sul piano
della morale; ma con una sorta
di terapia di informazione, riflessione, lavorando su un dato
gnoseologico, teoretico, culturale. Non con iniezioni di etica,
perché queste possono produrre
reazioni nell’immediato (di senso di colpa, di pudore) destinate
a durare fino al sussulto successivo, ma senza impedire che si ripetano l’errore e la colpa».
Mi sta parlando dell’oggi?
«Sicuro, ma per dire che settant’anni fa le persone non erano
per forza peggiori o più superficiali di noi. Credo piuttosto che
fossero attivi meccanismi culturali ed emozionali con cui vanno
fatti i conti ancora oggi. È la sola
possibilità di produrre risposte
che valgano anche ai nostri giorni in situazioni analoghe».
Nello studio della Shoah si è
passati da una storiografia
“senza testimoni”, a una narrazione che si è avvalsa della
testimonianza e della sua natura dinamica. Il passo successivo sarà la loro integrazione, o una delle due dovrà
cedere il passo? Resterà lo
scarto tra documento e voce
del testimone?
«Non credo che lo scarto sarà
colmato. La testimonianza è una
forma di narrazione in cui è fondamentale l’io. È determinata
cioè da quanto la persona vuole
che sia saputo di sé e ascoltato: e,
specularmente, da quanto il testimone reputa che voglia essere
saputo e detto da parte di chi
ascolta. In una testimonianza
convivono elementi di autocensura e di spostamento del peso
specifico delle parole da un argomento all’altro, a seconda dell’ambiente in cui la testimonianza viene resa.
Il racconto del testimone è un
documento estremamente mobile; mentre quasi sempre si tende
ad assumerlo così com’è. Mi
sembra un errore, dovuto anche
a una sorta di infingardia o di
malinteso rispetto».
La giornata della memoria
chiede a tutti di essere partecipi e di fare tesoro dell’ammonimento che viene dalla
Shoah. Ma come “ricordare”
qualcosa di cui non si ha avuto esperienza?
«Il problema è se il “giorno
della memoria” trova un posto
nel profilo delle storia di un paese, di ciascun paese. Se resta, o
diventa, una data metafisica non
reggerà nel tempo. Se viene trasformata in una “data etica” si
consumerà, sarà vissuta come
un’intrusione che pretende di
dirti come vivere. Sarà intesa
come un dato estraneo alla vita
quotidiana.
Perché rimanga nel proprio
valore e nel proprio significato
occorre che questa data sia
proiettata lungo una storia nazionale, come esito di una vicenda di possibilità e di scelte che
hanno prodotto come risultato lo
sterminio».
Un grande testimone come
Marek Edelman (che lei conobbe bene), eroe del ghetto
di Varsavia, scomparso po-
«La memoria può esserlo a
patto di non essere assunta come
un pacco chiuso. Del passato
devo ricordare che ho fatto delle
scelte, e i criteri che mi hanno
guidato a farle. Devo cercare di
mettere a fuoco i principi che
non ho salvaguardato, i compromessi a cui sono sceso.
La memoria è un esercizio di
riflessione; non la redazione di
un manuale, né un racconto
oleografico, senza asperità. Uno
dei pregi di Edelman è che ha
raccontato tutte le asprezze,
spiegandole quando era necessario. Sapeva, e raccontava, che al
momento della rivolta il primo
avversario era proprio una parte
del ghetto. Non tacque mai che
ribellarsi ai nazisti significava
anche combattere tutta quella
parte di società “ibridata”, compromessa per interesse o per
paura.
Edelman ha insegnato a non
ragionare
in
termini
di
buoni/cattivi, dentro/fuori; ma
a pensare a un conflitto che era
la somma di tanti microconflitti
non meno importanti, tragici,
dal punto di vista del processo di
decisione della piega che avrebbero preso gli eventi.
E, ancora, Edelman aveva
chiarissimo questo meccanismo
quando rifletteva sulla Polonia
degli anni ’80 [quando fu attivo
sostenitore delle lotte di Solidarnosc, ndr], sulla Varsavia del
1943, come sulla Sarajevo del
1992. Continuò a ragionare su
che cosa vuol dire collocarsi in
un luogo, conoscere che cosa vi
si muove e perché; e non solo assumere una visione partigiana
di un conflitto».
La filosofa Hanna Arendt,
da lei citata nel suo libro,
scrisse che solo il racconto e i
concetti che ne scaturiscono
possono sottrarre alla futilità
la vicenda umana. Lei, di suo,
afferma che la memoria della
Shoah ha un valore prescrittivo. Non è un’affermazione da
poco. Ma come raccontare
quando non ci sarà più l’ultimo testimone? Quale sarà il
mezzo espressivo più adeguato per non perdere il patrimonio della sua parola e farne
un elemento di storia?
«Una volta finita la fase narrativa “pura”, dovremo assumere
la Shoah come fatto storico, accertato, indiscutibile, i cui documenti si tratteranno finalmente
non come ipotesi di esistenza di
un evento, che ormai sarà considerato superiore a ogni dubbio.
L’altro elemento su cui lavorare è che quell’evento è stato
testimoniato e raccontato da
tantissime fonti (scritti, fotografie, filmati), e ripreso in seguito e in maniera indiretta da
tantissime persone che vi stettero intorno (né dalla parte delle vittime né dei carnefici).
Questa terza serie di fonti sarà
quella su cui saremo costretti a
misurarci per capire una storia
che comunque non sarà mai del
tutto ricostruita.
È come se ci trovassimo davanti a una serie lunghissima di
fotografie scattate in rapida sequenza: per tante che siano non
restituiranno mai il senso di
continuità che dà un film. Ciò
che manca, e mancherà sempre,
è il pur ridottissimo spazio tra
una immagine e la successiva.
Tutta la documentazione sulla Shoah di cui disponiamo è
come quella serie di foto. Per
riempire gli spazi bisognerà far
lavorare la testa, più che cercare spasmodicamente altri documenti, perché così torneremmo
nella logica della dimostrabilità
della sua esistenza. Dopo l’ultimo testimone direi: basta. Ora
ricostruiamo tutto, basta cercare prove. Rimettiamoci finalmente al lavoro».
L’intervista
martedì 27 gennaio 2009
Speciale
La giornata
della memoria
KEYSTONE
Dove
finisce
la storia
Auschwitz
ne, ad esempio con una Eva
Braun)». O con quell’Hitler così
ben recitato da Bruno Ganz. «Sì,
se si punta alle emozioni primarie
si rischia di assistere a situazioni
che potrebbero anche ripugnare».
La Shoah
e Israele
La burocrazia dello sterminio
tunità e la fondatezza di una formula divenuta comune: “Il dovere
della memoria”. Io credo piuttosto
che la memoria sia una fatica, un
travaglio. Del resto Primo Levi,
che tutti leggiamo come il testimone più alto della Shoah, non ha
smesso di dirlo, fin dalla poesia
posta in esergo di Se questo è un
uomo. Nelle sue parole la memoria è molto più di un precetto, è
piuttosto un problema. E da questo punto di vista, vincolarla a
una data rischia di trasformarla
in un appuntamento e di conseguenza toglierle complessità».
Ad Auschwitz
come al Colosseo
Un rischio che forse si corre
anche come conseguenza di quella sorta di monumentalizzazione
della Shoah. La sua trasformazione in elemento quasi decorativo del paesaggio culturale, la sua
iscrizione in un canone, persino
estetizzante, di bon ton culturale
e politico. La sua ritualizzazione.
Con tutto il bene che si può dire
delle visite delle scuole di (quasi)
tutta Europa ai campi di sterminio, non bisognerebbe chiedersi
se non si finirà di questo passo
per visitare Auschwitz come si
visita il Colosseo?
«Capisco – conviene Luzzatto –
ma non si può dare una risposta
2
Più che un dovere la memoria è un travaglio,
dice lo storico Sergio Luzzatto,
e da sola non basta a comprendere la natura di un evento
come lo sterminio nazista
Per capire bisogna rifarsi alla storia
di Erminio Ferrari
KEYSTONE
Un giorno Adolf Hitler chiese:
ma chi si ricorda più del genocidio degli armeni? Contava sull’oblio che seppellisce anche i crimini più grandi della storia, per
assicurarsi un’impunità postuma. Ma si sbagliava. Il crimine
da lui ordito ha prodotto una memoria colossale, persino più
grande di quanto il ricordo di tutti noi messi assieme possa capacitare; più grande e dolorosa di
quanto siamo in grado di capire.
Per questo, quando la memoria
sanguina, la storia soccorre;
quando tuttavia la memoria domina, la storia soccombe.
E poi: di chi sarà la memoria
che si celebra nella Giornata ad
essa oggi intitolata, data di liberazione del campo di sterminio
nazista di Auschwitz? Esclusiva
delle vittime? Del giovane soldato sovietico – il liberatore – sul
cui volto Primo Levi lesse lo sgomento dell’innocente per “l’altrui colpa”? Del carnefice? Degli
spettatori imbelli di quel crimine
epocale?
E soprattutto: che fare noi,
oggi, di una memoria che siamo
stati sollecitati a sentire come dovere, e che come tutti i doveri potrebbe indurre la tentazione a venire schivati?
«La memoria è un travaglio»,
dice Sergio Luzzatto nel colloquio che pubblichiamo in questa
pagina. Una fatica alla quale non
ci si può sottrarre, ma a cui potrebbe essere rischioso votarsi
incondizionatamente. Docente
di storia moderna all’Università
di Torino e storico della contemporaneità, Luzzatto ha studiato
le persistenze del retaggio fascista nella società italiana, criticando a fondo, con gli strumenti
della storiografia, l’impellenza
revisionista di una parte sempre
più estesa della pubblicistica e
del ceto politico.
Ferdinand Braudel scrisse di
una “storia misura del mondo”;
e non stupisce che a questa “misura” si richiami Luzzatto, quando la memoria – dolore e sangue
pulsante – sembra ancorare un
evento e il suo ricordo alla mera
dimensione sensibile. Anche nel
caso della Shoah, certo. Anche
accettando il rischio di finire per
usare parole che ancora suonano
come empietà alle orecchie di
sensibilità dolenti e esasperate; o
di essere involontario argomento
di polemica politica.
Vediamo. Alla Giornata della
memoria, in Italia, sono state fatte seguire quella “del ricordo”, il
10 febbraio, intitolata alle vittime
delle foibe in quel supplemento
di odio e vendetta che seguì la
fine della seconda Guerra Mondiale alla frontiera italojugoslava; e, più recentemente, la Giornata delle vittime del terrorismo,
il 9 maggio, data dell’uccisione di
Aldo Moro.
Parrebbe soltanto un’inflazione di giornate, ma è quasi trasparente la volontà (più o meno consapevole) di separare le memorie, orientare i ricordi: quello della Shoah per i democratici; quello delle foibe per la destra (istituito non a caso da un governo Berlusconi); quello del terrorismo,
legandolo alla morte di un uomo
e all’atto dei suoi carnefici, le
Brigate Rosse, e dunque orientando unilateralmente il senso
comune del fenomeno: perché allora non scegliere il 12 dicembre
di Piazza Fontana?
La memoria, professor Luzzatto, è destinata a dividere?
«Penso anch’io che vi sia stata,
soprattutto in Italia, un’inflazione inopportuna di date intitolate
alla memoria. Un incremento di
sollecitazioni di questo genere rischia di svalutare ciascuna di
queste “giornate”.
Aggiungerei che da qualche
tempo, pur comprendendo e condividendo le motivazioni che hanno
condotto a istituirla, sono perplesso anche rispetto a quella che a
molti di noi appare la più importante: quella dedicata alla Shoah;
se non altro per l’entità del fenomeno storico che evoca.
Sono cioè dubbioso sull’oppor-
laRegioneTicino
univoca. Sappiamo bene quanto
conti nell’animo umano il processo di identificazione. E non c’è
dubbio che quando si visitano i
luoghi dello sterminio la sensibilità dei ragazzi viene resa più viva
rispetto a quella indotta da testi
letti o immagini viste. Lo stesso
Holocaust Museum di Washington ha assunto questo argomento:
a chi entra nel museo viene assegnata l’identità di una figura di
pari età scomparsa nella Shoah.
Il processo di identificazione è
quindi molto forte e può essere utile nell’avvicinare i ragazzi o le coscienze a un evento come la
Shoah. Tuttavia è un meccanismo che può rivelarsi fuorviante,
quando sulla messa a distanza di
un fenomeno prevale l’avvicinamento, l’immersione nelle situazioni. Una prossimità emotiva che
può favorire l’identificazione con
le vittime, sì, ma anche con gli
spettatori o con i carnefici dello
sterminio».
E qui, si sente, parla lo storico:
«Credo la comprensione di un fenomeno è tanto più profonda
quanto meno è memoria e più è
storia. Siamo sufficientemente
lontani dai fatti per chiedere ai ragazzi di mettere a distanza le cose,
non viverle con sentimenti primari (che, nel caso della finzione cinematografica, producono anche
esiti paradossali di identificazio-
Dall’avvicinamento alla memoria, alla sua paternità, alla
sua “proprietà”. A chi appartiene la memoria della Shoah. Recentemente, l’ex ambasciatore
israeliano in Vaticano ha detto in
un’intervista a Repubblica, che il
Vaticano ha tentato in anni recenti di “cristianizzare” la
Shoah. Al di là della polemica
contingente (in risposta al biasimo vaticano per l’attacco a Gaza)
la questione – storiografica o morale, fa lo stesso – è grande e non
finisce di dividere. Anche l’ex
presidente del parlamento israeliano Avraham Burg ha parlato
di un “furto” della Shoah, ma
questa volta da parte dello Stato
di Israele ai danni dell’ebraismo,
e più in generale dell’umanità.
«L’affermazione di Burg è
senz’altro pertinente – osserva
Luzzatto – e riguarda le dinamiche profonde della società israeliana. E non da oggi: pensiamo al
processo Eichmann e all’investimento politico e sociologico fatto
sulla Shoah nel presentarsi come
il popolo delle vittime, così da accreditare una politica invece aggressiva e ingiustificabile.
È ben discutibile l’idea che i cristiani abbiano cercato di impossessarsi della Shoah. I passi compiuti da papa Wojtyla non possono essere intesi in questo senso, ma
semmai come assunzione di una
grande responsabilità storica e
ideologica. Non credo cioè che sia
giusto e onesto imputare alla chiesa al tempo stesso indifferenza o,
al contrario, il furto della Shoah.
Pur con tutte le contraddizioni e le
reticenze della gerarchia, mi sembra un’accusa esagerata e incoerente».
L’intervista è stata registrata
prima della revoca della scomunica al vescovo lefebvriano negazionista Williamson, da parte di
papa Ratzinger. Ma non si tratta
della sola Chiesa. Detto diversamente: si può oggi dire che la
Shoah appartiene ormai a tutti;
alla storia delle vittime e dei carnefici; a quella di chi per età e
provenienza non la conobbe?
«Sì, possiamo considerarla
tale: nell’ultimo trentennio c’è stata un’assunzione di responsabilità sempre più capillare. Un
esempio per indicare i risultati di
questo processo: ogni anno all’inizio dei miei corsi all’Università di
Torino propongo agli studenti un
test di cultura storica generale.
Ecco, mi ha colpito il fatto che, in
mezzo a tante risposte di una
ignoranza imbarazzante, se c’è
una cosa ben nota a tutti i ragazzi
è la Shoah. Non la confondono
con altre cose, come avviene per altri temi, e credo che questo sia un
risultato. Anche se, mi rendo ben
conto, il rovescio di questa medaglia è la banalizzazione della
Shoah, a forza di sentirne parlare
o di vederla al cinema. Significativamente, quasi tutti gli storici
concordano sul fatto che fu il telefilm Holocaust, più dei libri di un
Primo Levi, ad attirare l’attenzione di massa sulla Shoah».
Attenzione di massa, parole
per le masse. Ci fu un tempo in
cui il primo ministro israeliano
Menachem Begin definiva il leader palestinese Arafat una specie
di Hitler reincarnato. Oggi alcuni uomini pubblici evocano l’incombente pericolo di un nuovo
sterminio per motivare una politica israeliana di violenza e aggressione. Non è una forma di
pervertimento della storia? E
non fa lo stesso il nobel Saramago quando paragona Gaza ad Auschwitz? Non è anche questa
un’offesa alla storia?
Si bruciano bandiere con la
stella di David assimilata a una
svastica...
Il pervertimento
della storia
Di nuovo soccorre lo storico:
«Non credo sia solo una questione
di banalizzazione: da un lato la
confusione tra memoria e storia fa
sì che il rapporto tra passato e presente esca fatalmente distorto. Se
noi confondiamo la memoria di
alcuni con la vicenda di tutti, allora possono prodursi cortocircuiti
che prescindono dalle situazioni,
facendosi sempre più diffusi e
gravi. D’altra parte, lo stesso impiego strumentale di questi temi
testimonia come le vicende della
Shoah sono ormai diventate simboli. E, si sa, le icone si sottraggono allo specifico di una concretezza storica, cronologica, e investono una contemporaneità più spalmata sui tempi della storia».
Con una precisazione: «Certo,
dobbiamo rimpiangere il fatto che
qualcuno voglia confrontare
Gaza con Auschwitz, anche se almeno una cosa condividono questi due luoghi, quello di essere
chiusi: anche da Gaza i rifugiati
non possono scappare. Ed è una
ironia tragica quella che ci propone il ricordo dell’apertura di un
cancello, e quale cancello, mentre
abbiamo ancora sotto gli occhi
uomini donne bambini e vecchi a
loro volta chiusi dietro confini invalicabili.
Detto questo, è solo con un’approssimazione colpevole che Saramago può paragonare Gaza ad
Auschwitz. Ma, di nuovo, Israele
non può brandire Auschwitz
come un’arma per quarant’anni
dicendo “noi possiamo fare questo
e quello per ciò che ci è successo ad
Auschwitz”, senza mettere in conto che un giorno questi usi strumentali gli si possano ritorcersi
contro».
Abbiamo ricordato il processo
Eichmann. Con tutte le controversie che ha generato, ha pure
avuto il merito di portare in luce
le responsabilità enormi di chi
pure non maneggiò direttamente lo Zyklon B (oltre a quello di
aver ispirato a Hanna Arendt il
fondamentale La banalità del
male). Lei crede che in Europa
sia stato svolto a sufficienza un
lavoro di storia e di memoria per
portare in luce e alla coscienza la
parte di chi non commise, e tuttavia non impedì?
«Sappiamo del cammino percorso dalla Germania. Io posso
aggiungere qualcosa delle sole
realtà che conosco, Francia e Italia. La Francia ha fatto molto,
non solo attraverso i processi Barbie e Touvier. È passata anche attraverso un laborioso travaglio
memoriale e storico, coinciso con il
passaggio dalla presidenza Mitterrand a Chirac. Coincidenza paradossale: il silenzio di Mitterrand contro il mea culpa di Chirac. La Francia, inoltre, ha fatto
sicuramente molto e a tutti i livelli. Penso anche a film e libri, che
hanno contribuito in modo decisivo a rendere storia propria quegli
eventi».
I segnali
contraddittori
«Dell’Italia faticherei a dire lo
stesso. Al di là delle confusioni
strumentali sulla vicenda propria
del fascismo, nello specifico della
Shoah l’Italia ha conosciuto una
situazione particolare: ha avuto
un Primo Levi, divenuto testimone e voce universale della Shoah,
letto da generazioni di studenti;
un viatico importante per una riflessione adeguata attorno all’Olocausto. È stato, diciamo così, un
apprendimento partito dal basso.
Dall’alto, invece, sono giunti segnali diversi e contraddittori: da
una parte si è assistito a un percorso edificante di un personaggio
come Gianfranco Fini (che però
ha stabilito una dubbia distinzione tra leggi razziali e resto della
vicenda politica del fascismo); ma
l’unico processo che abbia avuto
una risonanza paragonabile a
quella del processo contro Touvier,
è stato quello a carico di Erich
Priebke. Si noti: un processo a un
ufficiale tedesco, non a un ufficiale
italiano. E questo non ha risolto il
problema: pur con i meriti di conoscenza attribuibili a quel procedimento, ancora una volta è mancato il processo di presa di coscienza del ruolo che molti italiani
hanno avuto nella macchina dello sterminio.
Di fatto, la “banalità del male”
che tanti paesi hanno riscontrato
in loro cittadini assurti a simbolo
di quel crimine, in Italia faremmo
fatica a trovarla perché sostanzialmente non l’abbiamo ancora
cercata».
Estero
sabato 27 gennaio 2007
Speciale
La giornata
della memoria
KEYSTONE
11
Incontro con Marta Ascoli, deportata a 17 anni
a Auschwitz e poi a Bergen Belsen
Il valore della memoria e le necessità della storia
nel confronto con una sopravvissuta
di Erminio Ferrari
Un treno
per Auschwitz
L’arrivo
KEYSTONE
Trieste – Man mano che gli
uomini morivano, nel vagone
si faceva posto. Da Trieste a
Auschwitz il treno impiegò
quasi una settimana; spesso
era costretto a fermarsi a causa dei bombardamenti, o a deviare dal percorso perché un
tratto di ferrovia era andato
distrutto. I morti venivano
scaricati, i vivi arrivarono ad
Auschwitz e subito dopo molti
di loro erano già morti.
Nel marzo 1944 Marta Ascoli
aveva 17 anni. Le Ss andarono
a prenderla a casa. C’erano
solo lei e la madre, il padre arrivò mentre lasciavano l’appartamento, chiese che cosa
stava accadendo e fu portato
via anche lui.
Li condussero alla Risiera di
San Sabba, alla periferia della
città. Nello stabilimento dismesso erano detenuti partigiani, militari, ebrei (quelli jugoslavi, di ogni età, arrivati
dal campo di Arbe, in Slovenia). A pieno regime la Risiera
fu portata dopo l’8 settembre
1943, quando l’area di Trieste
fu dichiarata Adriatisches Küstenland e amministrata direttamente dal Reich.
Per gli ebrei era un campo di
transito verso i lager dell’Europa centrale, ma molti vi morirono, asfissiati dai gas di scarico di camion chiusi ermeticamente, e poi eliminati nel
forno crematorio edificato nel
cortile della Risiera (l’unico in
esercizio in Italia), che prima
era un essicatoio e poi fu perfezionato secondo l’esperienza
via via maturata nei campi polacchi.
Per tutti gli altri era il campo definitivo. Li si uccideva in
tanti modi. Chi vuole può visitare le celle in cui si praticava
la tortura e vedere ancora
esposta la copia della mazza
che li colpiva alla nuca (l’originale è stata rubata nel 1981). E
farsene un’idea. Tra i tre e i
cinquemila morti, fino alla
fine d’aprile, quando i nazisti
in rotta fecero saltare il crematorio, la cui impronta profilata
sul muro dell’edificio principale, oggi dice forse molto di
più di una retorica presenza.
Dopo una decina di giorni in
Risiera, la madre di Marta,
cattolica, venne rilasciata. Le
lasciò disperazione, un asciugamani e un pettine. Lei e suo
padre, invece, furono caricati
dapprima su un camion e poi
in un vagone blindato stipato
all’inverosimile, da non potersi neppure accucciare. Fu una
Ss italiana a consentirle di salire sul vagone con il padre,
dopo che ne era stata separata.
Il viaggio cominciò dal silos.
Nell’introduzione alla sua
memoria, pubblicata a oltre
cinquant’anni da quel viaggio,
Marta Ascoli si sentì di “dichiarare per chiunque avesse
dei dubbi, che tutto quanto da
me descritto corrisponde a verità”. Verrebbe da chiederle se
una tale precisazione non era
forse superflua, ma solo nel dicembre scorso, mentre a Teheran il presidente iraniano
Mahmud Ahmadinejad inaugurava l’infame convention di
negazionisti, a Trieste un ex
deputato di Alleanza Nazionale dichiarava all’Ansa che la
Risiera non fu un campo di
morte. Non è una domanda da
fare. Lei mostra l’avambraccio
e ricorda, sgradevolmente.
«Ad Auschwitz ci scaricarono dal treno e sulla banchina
vidi mio padre per l’ultima volta». Lui fu mandato subito nella camera a gas, lei trasferita a
Birkenau, dove le venne tatuato il numero 76479.
Marta era giovane e in salute, e si vede che in quel momento nel campo c’era ancora
posto: diversamente la selezione non ci sarebbe stata, e l’intero trasporto sarebbe stato inviato direttamente nelle camere a gas; o sarebbe stata più rigorosa, e un aspetto men che
laRegioneTicino
Un superstite alla Risiera
decente avrebbe condannato a
morte chi gli toccava. E comunque, per la maggior parte,
si sarebbe trattato di una mera
questione di tempo: le selezioni si succedevano. La capoblocco faceva scendere dai tavolati (le coje) e allineare tutte
le detenute, nude davanti agli
ufficiali delle Ss che decidevano chi eliminare. «Io ne ho superate quattro. Sono stata fortunata».
Fortunata, beninteso, è una
parola da spendere con parsimonia; o da lasciare a chi ci è
passato, perché decida se usarla o no. Le parole contavano,
infatti. Forse non più di una
buccia di patata che poteva tenere in vita; ma non meno. C’erano parole da capire, quelle
degli ordini dati in tedesco dalle Ss, o in polacco o ucraino
dalle kapò; e c’erano parole da
scambiare per tenersi in vita.
Per cinque mesi, Marta non
parlò. «Non c’erano italiane nel
mio blocco e la sola lingua straniera che conoscevo era l’inglese». Imparò a riconoscere e a
pronunciare la sua nuova
identità da prigioniera: a scandire Sechsundsiebzig, vier, neunundsiebzig.
Il resto silenzio. Forzato allora e poi mantenuto per più di
mezzo secolo. Un’esperienza
del silenzio comune a molti
scampati al genocidio, che è
difficile indagare nelle motivazioni, tanto sono diverse per
ciascun caso: dall’impossibilità di razionalizzare un trauma che ha smascherato l’insufficienza della ragione; alla
fuga da un incubo ricorrente
che almeno di giorno si vuole
evitare; al timore di non essere
creduti (“Tanto non vi crederanno”, così le Ss irridevano i
prigionieri). Per Marta Ascoli,
il momento di mettere per
iscritto Auschwitz venne nel
1998, nei mesi seguenti la prima operazione al cuore. «Lo
dovevo a mio padre».
E un altro timore: essere sì
creduti, ma non capiti, forse
anche per questo, a lungo,
Marta tenne coperto il numero
tatuato sul braccio. Perché «la
gente
non
comprendeva,
confondeva le cose, non avrebbe
capito di che cosa stavamo parlando».
Una situazione nota anche
questa, una sorta di competizione tra le memorie: quella di
chi ha subito lo spavento di un
bombardamento, quella di chi
ha conosciuto la paura e le ferite della battaglia; di chi è
passato per un campo di concentramento; di chi è uscito
vivo da dove avrebbe dovuto
uscire solo morto. Ciascuno
con la propria ferita, unica
perché unica è la vita.
«Non faccio graduatorie tra
il dolore di ciascuno. Posso solo
dire che la durata media di vita
a Birkenau era di quattro, cinque mesi». E se c’è una differenza tra uno scampato e un
sopravvissuto, forse è di quella
che intende parlare.
Nel dicembre 1944, con l’avvicinarsi dell’Armata Rossa, i
nazisti avevano intensificato
l’eliminazione dei prigionieri,
tenendo in vita solo quelli ancora in grado di lavorare. Marta era tra quelli.
Un lavoro che consisteva,
anche, nello smantellare l’ulti-
mo forno crematorio rimasto
attivo. Gli altri tre erano stati
fatti saltare. I russi, ormai a
Cracovia lasciavano fare.
«Con altre centinaia di prigionieri sono stata messa alla
demolizione del crematorio,
pezzo per pezzo, ordinatamente
perché lo si potesse ricostruire
in territorio tedesco».
Il 31 dicembre 1944 il trasferimento, prigionieri e carcerieri, a Bergen Belsen. «Le settimane passavano e non ci davano quasi più niente, ormai.
Mi sono presa tutte le malattie
possibili, tifo petecchiale compreso. Nessuno più si curava di
noi. E noi non capivamo più da
quanto tempo eravamo lì. Lo
abbiamo saputo soltanto il 15
aprile, quando inglesi e polacchi sono entrati nel campo».
Per tre giorni i militari si occuparono del seppellimento
dei cadaveri disseminati per
tutto il lager (qualcuno ricorderà il filmato girato dai militari e poi montato da Alfred
Hitchcock) e solo “dopo” dei
“vivi”.
«Io, non so con quali forze, mi
sono spostata dal mio blocco,
perché morire non volevo morire in mezzo ai lamenti di chi
anche stava morendo. Così ho
trovato i resti di una rapa e con
un piccolo temperino, impiegandoci un tempo lunghissimo,
l’ho tagliata e mangiata. Penso
che quella rapa mi abbia salvato la vita». Gli altri, stravolti
dalla fame, si erano gettati sulle razioni di latte condensato e
carne in scatola, distribuiti
dagli inglesi. E morirono, tanto il loro fisico non era più in
grado di assimilare. «Vicino a
me è morta una che si chiamava Dora, poi una che si chiamava Stella, e una che si chiamava Mariucci...».
Il ritorno in Italia non fu immediato, né lineare. Disinfezioni, campi di transito, ricerca di notizie («ma ho sempre
evitato di guardare nelle file degli uomini, avevo paura di vedere mio padre nello stesso stato in cui ero io»), qualcuno che
aiuta. Per Marta fu un militare
triestino, reduce da un campo
di prigionia. La prese con sé e
«una mattina che avevo 41 di
febbre siamo saliti su una tradotta russa, non sapendo che
direzione seguiva». E la direzione era il nord, se La tregua
vi dice qualche cosa.
Si trovarono in posti ancora
più lontani e sconosciuti. Nuovi campi e nuove fughe. Dopo
tre mesi, finalmente Trieste.
Trieste che non era il miglior posto per un ritorno.
Troppe contese sulla sua storia, sul suo posto nella storia,
sui morti della sua storia. «Lo
so, ogni volta le foibe. Ogni volta quella contabilità assurda
dei morti: chi ne ha fatti di più.
La conosco questa solfa: va
bene la Shoah, dicono, va bene
la persecuzione degli ebrei, ma i
comunisti hanno anche loro le
loro infamie. Per anni i fascisti
di Trieste si sono riempiti la
bocca con questa storia». La
bocca, i libri, le piazze, i calendari. E la politica. A chi ricorda la Risiera, ricordano la cavità di Basovizza. Come se un
crimine servisse a giustificarne un altro. O se la vendetta
dei titini, mettiamo, basti a ridurre a mero eccesso di zelo la
denuncia del vicino di casa,
che guidò le Ss a picchiare alla
porta della famiglia Ascoli.
Forse perché tanta è la storia e poca la sua elaborazione.
Poche la volontà e la capacità
di renderla un viatico per il futuro. Siamo ancora alla memoria, retaggio del passato. Traumatica, ingannevole, edulcorata, plagiata. E d’altra parte:
come farne a meno?
E sarebbe giusto, poi?
Che differenza passa tra la
memoria tatuata su un avambraccio, 76479, e la storia di
quel numero?
Diciamo, proviamo a rispondere, che la storia è conoscenza e la memoria è esperienza.
Primo Levi arrivò a dire che i
soli autentici testimoni avrebbero potuto essere soltanto i
sommersi, certificando in qualche modo l’impossibilità di arrivare al fondo della questione.
Una avvilita negazione della
ratio, o eventualmente di un
plausibile disegno divino, del
male radicale di Auschwitz.
Per noi, più mestamente, un
ricollocamento nel posto che a
ciascuno spetta, di chi ascolta
e di chi racconta.
Marta Ascoli tornò a Birkenau dopo più di quarant’anni.
«Ho visto che cosa era restato e
che cosa era cambiato. E ho capito che se non l’avessi provato,
quel posto l’avrei inteso soltanto come un episodio della storia». È questa la differenza.
L’approfondimento
venerdì 27 gennaio 2006
Speciale
Il giorno
della memoria
Liliana Segre ricorda le farfalle. E tutto il resto, sicuro, ma
quelle farfalle.
Erano esposte, fissate con
uno spillo nell’addome, in un
corridoio del posto di guardia
di Arzo, dove aspettava di essere ricevuta da un ufficiale svizzero che le negò l’asilo. Era il 7
dicembre 1943. Ad Auschwitz si
ricordò di quel giorno. E ancora oggi, giornata della memoria, benché per lei tutti i giorni
siano quelli della memoria.
«Fu un’esperienza tremenda»,
racconta oggi Liliana Segre ricordando la tredicenne di allora. Un racconto che va lasciato,
per quanto possibile, intatto:
«Quando riuscimmo – io, mio
papà e due vecchi cugini che erano con noi – a passare da quella
cava di sassi dietro Saltrio, in
una giornata di inverno fredda
e piovosa, a noi cittadini borghesi e impreparati a reggere il passo dei contrabbandieri e a vedere
le nostre valigie gettate nel dirupo e disfarsi, quel passaggio parve un’avventura estrema. Ma
appena ci sentimmo in Svizzera,
ci abbracciammo, ridendo e
piangendo, convinti di essere al
sicuro, di non dover più avere
paura.
Immediatamente oltre la cava
c’era un boschetto, da cui spuntarono due sentinelle svizzere, le
quali, senza dire una sola parola, ci presero in consegna e ci accompagnarono fino al comando
di Arzo. Era mattina presto e ricordo la nostra stanchezza, ma
soprattutto di come le donne che
uscivano di casa non si voltassero neppure a guardarci. Non potevamo passare inosservati,
stranieri e accompagnati dalle
guardie; ma eravamo come invisibili.
Al posto di guardia fummo
messi ad aspettare in un corridoio, nel quale erano esposte una
serie di farfalle bellissime. Eravamo allegri e tranquilli, e io
guardavo quelle farfalle fissate
con uno spillo e quello spillo mi
inquietava.
Dopo ore, l’ufficiale ci accolse e
fu una cosa terribile. Disprezzo,
boria e furia di questo ufficiale
ci rivelarono il nostro destino.
Rifiutava di credere che gli ebrei
fossero perseguitati; accusava
mio padre di essere un imbroglione che voleva sottrarsi alla
chiamata alle armi. Ci accusava
di voler metterci al comodo, mentre fuori c’era la guerra.
Ricordo che passai dal riso alla disperazione e mi buttai ai
suoi piedi supplicandolo di tenerci in Svizzera. Mio padre gli
assicurava che poteva lavorare,
e gli mostrò i documenti che provavano che poteva mantenersi
senza gravare sulla Confederazione. Non ci fu niente da fare.
Era seccato, l’ufficiale, non
aveva tempo da perdere con noi.
Non solo ci rimandò indietro, ma
ci fece riaccompagnare dalle sentinelle armate fino alla terra di
nessuno da cui eravamo entrati.
Io corsi verso un cancello che mi
pareva di vedere nella rete di confine, ma appena lo toccai risuonarono le campanelle. E su quella rete fummo arrestati, sotto gli
occhi delle guardie svizzere, compiaciute.
La sera stessa eravamo nella
camera di sicurezza della caserma di Saltrio. La prima tappa
per Auschwitz. Di noi quattro solo io sono tornata a raccontare.
Dei due vecchi cugini, uno è morto di stenti nel campo di concentramento di Fossoli e l’altro si è
suicidato a San Vittore quando
seppe che sarebbe stato deportato
il giorno successivo; mio padre,
che non ho mai più visto dopo
l’arrivo ad Auschwitz, morì nei
primissimi mesi della prigionia.
La sentenza di morte fu emessa dall’ufficiale svizzero di Arzo,
gli esecutori furono gli altri. Non
lo dimentico.
Con tutto ciò io non assegno
colpe collettive nei confronti di
alcuna nazione. Per questo sono
una donna libera e una donna di
pace».
laRegioneTicino
Intervista a Liliana Segre, deportata tredicenne
ad Auschwitz con il padre, dopo essere stata respinta
alla frontiera svizzera.
Con Primo Levi ricorda: ‘Meditate perché questo è stato’
di Erminio Ferrari
Né il giorno
né l’ora
I bambini di Auschwitz
Non è facile e non le fu facile
esserlo, donna di pace e donna
in pace. Anche lei conobbe l’incredulità, il fastidio, il desiderio di oblio, che i reduci dai
campi di sterminio si vedevano
opporre a ogni tentativo di raccontare. Del resto gli stessi nazisti li avevano avvertiti: se mai
uscirete vivi da qui, nessuno vi
crederà.
E per quarant’anni, Liliana
Segre non ha parlato, serbando
quel silenzio in cui si era rinchiusa la vita di moltissimi altri reduci. Quarant’anni di memoria privata prima di diventare testimone pubblica della
Shoa. Perché?
«Quando sono tornata da Auschwitz compivo quindici anni.
Ero giovanissima, ma già molto
vecchia. E nei giorni immediatamente successivi al mio rientro a
Milano, mi sono resa conto che i
parenti ritrovati, le amiche, pure
persone che mi volevano bene,
non sapevano. Non capivano,
non sapevano capire quello di
cui io parlavo. Era come se parlassi una lingua sconosciuta.
Ero un’aliena.
Così, passati i primissimi
giorni, in cui cercavo di raccontare cosa mi era accaduto, mi
sentivo rispondere – se andava
bene, e dai migliori che incontravo, badi bene – che anche loro
avevano patito così tanto. Finivano addirittura per farsi compiangere per avere perso il baule
con i beni della nonna, o per
aver vissuto la paura dei bombardamenti, o dell’essere stati
nascosti. Il racconto corale di allora, seppelliva il racconto della
ragazzina reduce tra i pochi tornati.
Devo dire che nel giro di pochissimi giorni, poche settimane, ho capito che non potevo parlare, che dovevo tacere. Era un
senso di isolamento morale e fisico che mi ha costretto a tacere, se
non in rarissimi casi e con persone molto intime.
Poi la vita ha preso il sopravvento, mi sono sposata e sono diventata madre, cosicché io stessa
ho accantonato questi ricordi,
che bastava tuttavia poco a far
tornare: un fuoco, un cane lupo,
una minima cosa o un odore che
mi ricordassero quel tempo. Avevo allora la forza di respingere il
7
baratro, volevo vivere, amare e
essere amata. Così, con un po’ di
vigliaccheria e di desiderio di
farcela nonostante tutto, e godendo la stagione bella della vita, non ho testimoniato. Una
scelta che oggi posso dire colpevole, egoista.
Finché, col passare degli anni
e le perdite degli affetti; con il
mutare della storia, e osservando i revisionismi che avanzano,
arrivò l’ora di interrogarmi. Fu
in occasione dei miei sessant’anni e della bellissima festa che mi
prepararono i miei familiari. Ricordo che al termine della giornata avvertii un senso di insoddisfazione profondo per non
aver fatto sino ad allora il mio
dovere. Così, nel buio della mia
stanza, decisi che sarei diventata una testimone della Shoa.
Non sapevo come l’avrei fatto,
né con chi. Ma con molta umiltà
mi rivolsi a delle amiche insegnanti, dicendomi a disposizione, e cominciai. Dopo quasi sedici anni, sono più vecchia e mi affatico, ma continuo».
Un raccontare – il suo e di chi
come lei tornò – in mille modi
analizzato, spiegato, ammirato,
sopportato. Atto liberatorio, o
sacrificio ogni volta rinnovato.
Lezione politica, saggio morale,
preghiera, invettiva. È possibile comunicare la Shoa, tradurre con un processo di razionalizzazione, come è il raccontare,
ciò che per molti versi ha sovvertito la ragione, la comunicazione tra gli esseri umani?
«Me lo sono chiesto molte volte. Soprattutto perché prima di
affrontare le platee che oggi mi
ascoltano mi sono chiesta se davvero fossi in grado di farlo, e la
riposta è no. Né io né altri lo sono. Quello che scrisse Primo Levi
è vero: noi non siamo i veri testimoni. I veri testimoni sono coloro che hanno varcato la soglia
estrema e non sono tornati a raccontare. Noi raccontiamo fino a
un certo punto, e loro che potrebbero dire fino a che punto è giunto l’essere umano nell’accanirsi
contro un suo simile colpevole
solo di essere nato, loro non hanno potuto testimoniare.
Io sono una modestissima testimone. Tanto che in realtà io
non racconto quasi nulla dei fatti; ma fin dall’inizio ho privile-
L’estate prima della deportazione
giato i sentimenti, il senso del distacco. La partenza dalla tua casa, quando ancora è una casa, e
fai la valigia, cominciando a distaccarti dalle cose che erano la
tua dimensione quotidiana. Poi
perdi anche quella valigia, e ti
sembra un’enormità, ma non
hai ancora visto nulla; e poi
smarrisci i riferimenti dei luoghi, della famiglia, della lingua.
Io non sapevo neppure dove mi
trovavo, quando ci hanno deportati ad Auschwitz. Perdi i riferimenti temporali. In un campo di
sterminio non si conoscono il
mese, né il giorno, né l’ora.
Non parlo delle selezioni, degli
appelli al gelo, degli scheletri che
camminano, delle camere a gas;
cerco di raccontare chi erano
quelle persone picchiate e affamate, che avevano freddo, sonno,
e non sapevano più dov’erano e
dove sarebbero state. Questo è il
perno della mia testimonianza.
L’abbandono, la perdita di tutto,
persino del proprio corpo, ridotto a una figura piagata, scheletrita, nuda».
Ma se quello fu l’esito, ancora
poco si sa, si spiega, di come avvenne che nessuno sia stato capace di riconoscere l’avanzare
di tanta barbarie. Come fu possibile?
«In quegli anni, il tessuto della comunità ebraica italiana
era composto da persone prevalentemente borghesi e in moltissimi casi fasciste, come la gran
parte della borghesia di allora.
Un’adesione al regime – salvo
pochi intellettuali lungimiranti, ebrei e no – proporzionalmente identica a quella del resto degli italiani.
In casa, mio padre e mio zio
erano stati ufficiali dell’esercito
italiano nella prima guerra
mondiale; si sentivano italiani a
tutti gli effetti. Inoltre, la mia era
una famiglia laica, niente affatto religiosa, e non si parlava di
ebraismo in alcun modo. La separazione cadde come un evento
incomprensibile, inatteso e incompreso. Tanto che fu considerata una situazione provvisoria,
motivata politicamente ma destinata a non avere effetti né a
durare.
Finché si dovette prendere atto
di quanto le cose stessero precipitando. Ma la stessa fuga a cui
tutti si diedero dopo l’8 settembre
non fu riconosciuta (se non da
un ristrettissimo numero di persone) come un esito di quanto si
stava preparando negli anni
precedenti. Ricordo che quando
il padre di Tullia Zevi venne a
salutarci prima della partenza
per l’America, ben prima dell’8
settembre, i miei dissero che il
suo allarme era eccessivo, e che
non bisognava temere.
Non si capì cosa stava accadendo, e forse oggi riesco a comprendere come fu possibile quella mancanza di lucidità. I miei,
ad esempio, erano tutti concentrati sulla malattia terminale di
mio nonno e non si rendevano
conto della gravità di quanto si
andava preparando. Finì che
anche il nonno, ammalato di
Parkinson, fu deportato ad Auschwitz dove giunse vivo, purtroppo per lui».
Si torna sempre a Primo Levi, allo stupore che vide sul volto dei soldati russi giunti nel
campo di Auschwitz. Alla vergogna “l’altrui colpa” letta sul
viso di uno di quei giovani.
Quell’altrui colpa che fece vergognare il soldato russo, ma
non abbastanza l’Europa, noi,
occidentali, civilizzati, cristiani: mi è sempre parsa un’espressione cruciale della riflessione
sulla Shoa. L’Europa ha saputo
riconoscersi in quella colpa?
«Esiste una mole impressionante di letteratura su questo tema. Si passa da un relativismo
impressionante a sensi di colpa
collettivi, attraverso ogni tipo di
riflessione teologica, politica, filosofica, psicologica. In realtà,
penso che solo pochi eletti si siano chiesti “io dov’ero?”.
Ho incontrato poche persone
che lo hanno fatto. Ricordo una
suora, che conobbi da ragazza e
ritrovai da adulta: dopo una
mia testimonianza in una scuola, ha chiesto la parola e mi ha
detto “io ti voglio chiedere scusa,
perché non abbiamo capito”. Ho
incontrato un amico che mi ha
detto di aver visto sparire i compagni di scuola ebrei e di non essersi neppure chiesto come mai,
né dove finissero. Non gli importava, mi ha detto, e per sempre
gli è rimasto un senso di colpa
per non avere fatto la cosa più
semplice.
E spesso la cosa più semplice è
seppellita sotto saggi, arzigogoli
filosofici sulla banalità del male
o del bene: in realtà, credo che alla maggior parte della gente – in
particolare a coloro che per ragioni di educazione o di collocazione sociale non se ne sono mai
occupati – di questo argomento
non importi proprio niente».
Non teme dunque una banalizzazione della memoria, anche attraverso la ritualizzazione delle cerimonie (interviste
comprese)?
«Ogni volta che il 27 gennaio
vengo invitata a rendere la mia
testimonianza, mi dico che sì,
avevamo ragione noi quattro disgraziati rimasti a batterci perché si istituisse il Giorno della
memoria (benché per noi sia
sempre il giorno della memoria),
pensando che in quel giorno si
onorassero i morti. Ma non è
sempre stato così. Per certi versi
è avvenuta un’operazione in cui
i morti contano meno delle ragioni di chi li ricorda. Ma è un
discorso che esula dalla mia testimonianza.
A mio parere, piuttosto, in
questo giorno bisognerebbe ricordare i bambini, i neonati,
quelli che non hanno potuto diventar grandi. Quelli portati via
dalla culla per essere uccisi. Bisognerebbe raccontare la storia
di uno, perché dire sei milioni
non ha più alcun effetto. Bisognerebbe parlare di uno, dargli
un nome, ricordare dove abitava
e quando è partito; e chiedersi,
sessant’anni dopo, chi sarebbe,
cosa farebbe. Vite. Vite interrotte
solo perché erano nate».
Signora Segre, non ha mai
desiderato dimenticare?
«No, il mio è un debito troppo
grande con i martiri miei e con
tutti quelli che non ho conosciuto. E se sono stata risparmiata –
non so perché e non ho risposte
su questo punto – ho il dovere di
dire come Primo Levi: meditate
perché questo è stato».
L’intervista
lunedì 2 marzo 2009
Speciale
2
Incontro con Giancarlo Bastanzetti il cui padre Pietro morì nel
1944 nel campo di concentramento di Mauthausen:
‘Il seme dell’odio, purtroppo, sta di nuovo germinando’
A fine gennaio ha incontrato gli allievi della scuola media di
Bellinzona 1
a cura
di Claudio Rossi
Testimonianze
per non dimenticare
laRegioneTicino
Giancarlo Bastanzetti
marzo 1946, a Milano in Corte
d’Assise era stato condannato a 8
anni e 4 mesi. Anche perché noi
abbiamo rifiutato una possibile,
cosiddetta vendetta, ma non abbiamo avuto giustizia. Nemmeno formale”.
Suo padre, Pietro Bastanzetti, il 17 marzo 1944 viene
arrestato e portato nel carcere di S.Vittore. Qual è stato il
motivo del suo arresto?
“Aver organizzato assieme a
pochi altri, ma con l’adesione di
tutte le maestranze, gli scioperi
del dicembre 1943, del marzo
1944 e il sabotaggio della produzione bellica nella fabbrica milanese dove lavorava”.
Il 5 aprile 1944 viene deportato e l’8 aprile arriva a
Mauthausen, in Austria.
Come erano le condizioni di
vita e quali erano le attività
nel campo?
“Le condizioni di vita erano
tali da prevedere una sopravvivenza di 90 giorni. Il campo era
sostanzialmente un campo di
transito verso qualcuno dei 49
sottocampi, salvo il lavoro da
schiavi nella sottostante grande
cava di granito”.
Il 1° giugno 1944, suo padre ridotto in condizioni pietose dalla fame, dalle percosse, in fin di vita viene lasciato morire. Il 2 giugno 1944 a
42 anni “passava per il camino e andava nel vento di
Mauthausen”. Chi le riferì
questi terribili momenti?
Suo padre ha lasciato delle
lettere, degli oggetti personali?
“Innanzitutto il papà “non
KEYSTONE
Giancarlo Bastanzetti ha settantatrè anni, per tutta la sua
vita non ha fatto altro che ricordare, testimoniare, denunciare
e difendere la memoria di chi
non lo può più fare.
Fa parte del Gruppo della Memoria, che a Saronno svolge
un’intensa attività: incontri, dibattiti, conferenze, formazione
nelle scuole, pellegrinaggi nei
campi di sterminio nazista, per
ricordare undici milioni di persone, di cui sei milioni di ebrei,
sterminate nelle camere a gas e
nei forni crematori durante la
seconda guerra mondiale.
Il 23 gennaio scorso Giancarlo Bastanzetti ha raccontato la
sua storia agli allievi della
Scuola media di Bellinzona 1.
Primo Levi, deportato ad
Auschwitz, rivolgendosi a chi
visita il campo di concentramento scrisse: “Fa’ che il tuo
viaggio non sia stato inutile,
che non sia stata inutile la
nostra morte. (…) fa’ che il
frutto orrendo dell’odio, di
cui hai visto qui le tracce,
non dia un nuovo seme, né
domani, né mai”. Lei pensa
che questo “seme” potrà ancora germinare?
“Io penso, purtroppo, che quel
seme abbia già germinato. Tutti
i giorni episodi di razzismo, antisemitismo, intolleranza, pregiudizio, fascismo e nazismo, reali,
pur sotto forme diverse da quelle
conosciute nel secolo scorso, sono
sotto gli occhi di tutti. Almeno di
chi vuole vedere. È ovvio che sarei felice di sbagliarmi”.
L’eredità
del Male
Verso la fine della guerra, i
Tedeschi si accorsero che la
liberazione era imminente e
distrussero molte tracce degli orrori dei lager. Quindi
l’unica fonte che si ha sono le
testimonianze orali e scritte
di chi è sopravvissuto. Che
ruolo può avere la scuola anche in un futuro lontano, affinché non si dimentichi ciò
che è stato?
“Un ruolo di estrema importanza, essenziale. I giovani
avranno sempre il diritto di sapere, la scuola e le famiglie hanno il dovere di dare una risposta
a questo diritto. Con la speranza
che avendo saputo, non si ricada
nei medesimi errori”.
Mauthausen
viene lasciato morire”, ma viene
assassinato (probabilmente!)
con un’iniezione di benzina o di
fenolo al cuore. Ho avuto le ripetute, dolorose testimonianze di
due suoi compagni di deportazione, due fra i pochissimi sopravvissuti. Si chiamavano Angelo Caserini e Bruno Bagatta e
furono loro a portarlo in infermeria la sera prima del decesso.
Bruno Bagatta, ritrovandomi
dopo vent’anni, piangeva come
un bambino, perché mio padre
resosi conto che era giunto il momento della fine, gli aveva dato
tutto quello che era rimasto da
lasciare in eredità ai figli: due cerini. Due cerini che lui si vergognava di non avermi portato,
perché un giorno li aveva barattati con una fetta di pane, dandoli a un russo che aveva una siga-
retta, ma non i fiammiferi per accenderla. Il papà ha lasciato delle lettere scritte con una matita
copiativa contro il muro del carcere di Bergamo: a sua madre, a
sua moglie, ai suoi figli. Nonostante il tono rassicurante, quelle
lettere sono un autentico testamento di un uomo che prevede di
non tornare da quell’inferno”.
Pietro Bastanzetti era innocente, come lo erano le migliaia di persone deportate.
Lei non ha mai dimenticato?
Se fosse possibile, che cosa
chiederebbe alla giustizia?
“Semplicemente di rimediare
all’infamia della sentenza del
giugno 1946, con la quale la Cassazione a Roma dichiarava innocente quel tale che era andato
ad arrestare mio padre e che nel
Bastanzetti in aula con gli allievi della Scuola media di Bellinzona 1
Quale messaggio sente di
mandare ai giovani?
“Più che un messaggio un augurio, fatto col cuore. Di crescere
come donne e uomini liberi. Essere libero significa, sempre, poter
scegliere. È preferibile aver sbagliato in virtù di una libera scelta, piuttosto che fare una cosa
giusta, perché costretto”.
La strada per Mauthausen
• Gli scioperi generali del marzo 1943 e del 1944
furono il più vasto movimento di massa dei
lavoratori durante la guerra, nei territori occupati dai Tedeschi. La popolazione dei centri urbani era al limite della sopravvivenza,
oltre ai bombardamenti, alla fame e al freddo,
i ceti a reddito fisso vedevano ridursi ogni
giorno la propria possibilità di acquistare addirittura gli stessi generi razionati. Per i lavoratori dipendenti, in particolare gli operai,
c’era lo spettro della disoccupazione dovuto
al rischio che la produzione fosse interrotta
per mancanza di materie prime, di energia,
ecc. I lavoratori chiedevano l’indispensabile
per vivere, di non lavorare per la guerra, di
poter essere liberi nelle loro case, di non esse-
re arrestati, deportati, torturati dai nazifascisti, chiedevano che i loro figli non fossero
arruolati dallo straniero. Si aggiungano le retate e i trasferimenti coatti di manodopera
per il lavoro in Germania. Lo sciopero si estese dal Piemonte e dalla Lombardia al Veneto,
alla Liguria, all’Emilia ed alla Toscana. Due
milioni di persone parteciparono al movimento. I grandi industriali si dimostrarono
solidali con gli occupanti tedeschi. Lo sciopero segnò una dura sconfitta per i fascisti. La
macchina da guerra nazista ricevette un serio colpo, per una settimana la produzione
bellica in tutta l’Italia del Nord venne arrestata. Lo sciopero fu una battaglia vinta contro le forze fasciste-hitleriane.
• Nel campo di sterminio di Mauthausen morirono 122 mila persone: socialisti, omosessuali
e rom tedeschi, polacchi, jugoslavi prigionieri
di guerra sovietici, ebrei, ungheresi, olandesi.
Arrivavano al campo anche interi convogli di
italiani, partigiani, operai provenienti dai
grandi scioperi di Torino, Milano e Genova. I
più numerosi furono quelli di fine marzo e del
giugno 1944. I prigionieri venivano accolti a
randellate, poi costretti a scendere nei sotterranei dove c’erano le docce, in seguito “depilati”, disinfettati. Poi ognuno era costretto a consegnare tutti gli oggetti personali. Mauthausen è stato considerato il massimo livello per
l’annientamento dei prigionieri. Coloro che lavoravano erano costretti a turni di 12 ore, sen-
za cibo, al freddo. Ciò significava la morte per
fatica nel tempo massimo di tre mesi. I malati
e gli inabili finivano subito nelle camere a gas.
• Gli scalini della morte: i deportati dovevano
estrarre le pietre dalla cava, squadrarle, salire
e scendere uno dietro l’altro più volte al giorno, portando a spalla sacchi pieni di massi, i
186 gradini ripidi scavati in una parete della
cava stessa. Spesso i prigionieri perdevano conoscenza cadendo addosso ad altri disperati,
travolgendoli e facendoli cadere nel precipizio.
Le guardie armate di mitragliatrice si divertivano a spingere o a sparare a qualche internato per vedere quanti altri venivano travolti nella caduta.
Il caso
Berlino – Rivive nel cyberspazio la
memoria di centinaia di ex lavoratori
coatti, ridotti in condizioni disumane
dalla Germania nazista negli anni tra
il 1939 e il 1945: le loro testimonianze
si possono vedere e ascoltare oggi su
un portale Internet interamente dedicato a questo capitolo della storia del
paese.
Il portale, dal titolo “Lavoro Coatto
– 1939-1945 – Memoria e Storia”, è stato realizzato grazie a un’iniziativa
del Museo Storico e della Libera Università di Berlino. Si tratta di un
omaggio agli oltre 12 milioni di lavoratori coatti durante il nazionalsocialismo, che offre per la prima volta
KEYSTONE
Rivive sul web la storia dei lavoratori coatti del Terzo Reich
La cava di Mauthausen
i resoconti di quell’epoca direttamente da 590 protagonisti provenienti da 26 paesi.
“Molti sopravvissuti dell’Europa
centrorientale raccontano per la prima volta le sofferenze ed i tempi difficili che molti di loro hanno sofferto dopo
il 1945”, ha spiegato Guenther
Saathoff, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione della
Libera Università di Berlino che ha
realizzato il progetto insieme al Museo Storico della capitale. Con il sostegno all’archivio online, la Fondazione “Ricordo, Responsabilità e Futuro” lavora per tenere viva la memoria di queste vittime del nazionalso-
cialismo e, allo stesso tempo, per rendere accessibili le storie delle loro
vite ai giovani e agli accademici, al
fine di contribuire all’istruzione politica e alla ricerca.
Nel complesso, l’archivio offre 398
interviste audio e 192 video di 590 ex
lavoratori coatti, dei quali 341 uomini
e 249 donne. Cominciato nel 2004, il
progetto è stato realizzato da un team
di 32 ricercatori di istituti internazionali, che hanno raccolto le testimonianze – alcune delle quali lunghe anche quattro ore – su un totale di duemila audio e video cassette. Tutte le
interviste sono accessibili dal sito Internet www.zwangsarbeit-archiv.de.
Seconda pagina
venerdì 28 gennaio 2005
Speciale
A sessant’anni
da Auschwitz
Varsavia – Il fischio straziante di un treno e una fitta
nevicata come in quel giorno
del 27 gennaio del 1945 hanno
accolto ieri i reduci e i grandi
della Terra che sono convenuti
nel gelo del lager di Auschwitz
per ricordare ancora una volta, 60 anni dopo, l’orrore dell’Olocausto. E rendere omaggio ai milioni di morti che il
nazismo ha lasciato sul terreno dei campi di sterminio di
mezza Europa.
«Come ultimi ancora in vita
tra i superstiti di Auschwitz abbiamo il diritto, anzi il dovere,
di avvertirvi e di chiedervi che
la sofferenza dei nostri fratelli
non diventi mai più realtà» ha
affermato ieri Simone Veil, 78
anni, ex prigioniera di Auschwitz con il numero 78651,
ex presidente del Parlamento
europeo, nel corso della solenne cerimonia.
La celebrazione svoltasi sotto la neve, a circa 10 gradi sotto zero, a ridosso di ciò che resta dei quattro forni crematori
del campo di Auschwitz-Birkenau, alla presenza di circa 5
mila superstiti e delle autorità
di 46 paesi – per la Svizzera
era presente il presidente
della Confederazione Samuel
Schmid – si è iniziata nel primo pomeriggio di ieri con il
simbolico fischio di locomotiva ed il rumore di una frenata,
in memoria di quei lunghi treni merci che, piombati, portarono per anni ad Auschwitz
fra il 1940 ed il 1944 oltre 1,3 milioni di persone destinate alla
morte, provenienti dai più diversi paesi d’Europa.
«La mente umana non è in
grado di comprendere l’orrore
che regnava fra questi fili spinati» ha sottolineato il presidente d’Israele Moshe Katsav,
ringraziando l’Armata Rossa e
le altre forze alleate per la liberazione del campo.
Prima di lui Wladyslaw
Bartoszewski, 83 anni, ex prigioniero di Auschwitz ed ex
ministro degli esteri polacco,
ha ricordato come nessun paese del mondo abbia reagito
adeguatamente alle notizie
sulle fabbriche della morte
sorte in territorio polacco sotto occupazione tedesca, che arrivavano da diverse fonti della
resistenza polacca. «In questo
luogo va detto chiaramente che
ogni tentativo di riscrivere la
storia e di mettere nella stessa
fila i boia e le loro vittime è
amorale» ha sottolineato il
presidente russo Vladimir
Putin rivendicando inoltre il
ruolo dell’Urss nel liberare il
laRegioneTicino
2
Toccante cerimonia ieri ad Auschwitz dove i reduci e i grandi della
Terra (assente il presidente americano George Bush) hanno
commemorato le vittime dell’Olocausto. La cerimonia si è iniziata
con il fischio di una locomotiva, in memoria di quei treni che fra il
1940 e il 1944 portarono nel campo di sterminio 1,3 milioni di persone
a cura di Claudio Carrer
Il mondo grida
mai più
Vecchio Continente da Hitler,
a costo di 27 milioni di sovietici caduti. E oltre a Putin tra le
personalità che si sono raccolte ad Auschwitz – grande assente il presidente americano
George W. Bush – hanno partecipato alle celebrazioni Jacques Chirac e la regina d’Olanda, Elie Wiesel e Viktor Yushenko, Moshe Katsav, Dick
Cheney e Jack Straw e molti
altri.
«Perché hanno cancellato il
mio nome e mi hanno dato il
numero, perché hanno bruciato
la mia gente?» ha chiesto una
superstite di Auschwitz venuta da Israele che si era avvicinata al microfono dopo Katsav,
mostrando anche il numero tatuato sulla mano sinistra. Pieno di commozione è stato anche il breve discorso del cardinale Jean-Marie Lustiger venuto ad Auschwitz in rappresentanza del Vaticano. «Il silenzio di questo luogo e delle
sue vittime ci raccomanda di ri-
spettare la dignità anche di un
uomo solo, perché lui è l’uomo»
ha detto Lustiger che ha anche
letto l’accorato messaggio del
Pontefice.
«Il tentativo di eliminare l’intero popolo ebraico si pone come un’ombra sull’intera Europa e il mondo, e non ci può lasciare indifferenti» ha scritto
Giovanni Paolo II.
«Dobbiamo gridare perché
l’orrore del quale Auschwitz è
diventata simbolo non si ripeta
più nella storia della umanità»
ha detto il presidente polacco
Aleksander Kwasniewski.
Simone Veil e Bartoszewski
hanno a quel punto firmato
per primi l’atto di fondazione
del Centro di educazione sull’Olocausto che avrà sede nella
struttura una volta usata dalle
suore carmelitane e che ora fa
parte integrante del Museo del
campo di concentramento.
Subito dopo, al suono dello
sciofar, il corno tradizionale
ebraico, si è iniziata la preghiera ecumenica per i defunti
in ebraico, latino e polacco, seguita dal rito delle candele. Le
fiammelle, contenuto in portacandele di vetro blu, sono state
raccolte dai rappresentanti di
tutti i paesi presenti e deposte
sulle 21 lapidi che ricordano in
diverse lingue le vittime di
questo luogo, che si trovano
tra le rotaie che conducevano
al campo i famigerati vagoni
piombati.
La toccante cerimonia si è
conclusa con il canto El Maale
Rahamim eseguita dal cantore della sinagoga di Fifth
Avenue di New Jork, Joseph
Malovany.
Il monito di Israele
Il presidente Moshe Katsav: attenzione, la Shoah può ripetersi
Gerusalemme – Dopo le dure parole mercoledì del premier Ariel Sharon contro l’indifferenza con la quale il mondo 60 anni fa
assistette allo sterminio degli ebrei europei,
ieri è stato il presidente di Israele a lanciare
un preoccupato avvertimento: attenzione,
ha ammonito Moshe Katsav, l’Olocausto
può ripetersi. Il capo dello stato ebraico, che
ha partecipato in Polonia alla commemora-
zione della liberazione di Auschwitz, ha
messo in guardia il mondo contro un ritorno della barbarie. Katsav ha detto che, anche se oggi gli ebrei non sembrano in pericolo esistenziale, un nuovo Olocausto «può
ripetersi nelle generazioni future». «Non c’è
alcuna certezza che non possa succedere» ha
affermato in un’intervista al quotidiano
israeliano Jerusalem Post. «Le buone vo-
lontà, la democrazia, i valori universali, nulla di tutto ciò ha potuto fermare l’antisemitismo» ha aggiunto. Il presidente israeliano
ha mostrato anche preoccupazione per la
crescita del nuovo antisemitismo in Europa, anche se «non mette in pericolo, ora, l’esistenza del popolo ebraico». Ma Katsav ha ricordato che «l’Olocausto è stato il risultato finale di sviluppi innescati decenni prima».
Dalla ‘selezione’ alle camere a gas
Ecco come funzionava la macchina dello sterminio
Sfruttabile
Vienna – In un punto è fallita la
terribile e perversamente efficace
macchina di sterminio di Auschwitz: anche per i nazisti, che
con cinica precisione tatuavano un
numero sul braccio di ogni nuovo
arrivato, non è stato mai possibile
sapere il numero esatto delle vittime, di uomini, donne, vecchi e
bambini uccisi nelle camere a gas,
fucilati o morti per fame, fatica,
epidemie, freddo oppure in seguito
ad atroci esperimenti medici.
I ricercatori, in base agli elenchi
dei trasporti effettuati nella Germania nazista ed alle testimonianze dei sopravvissuti, ritengono che
siano stati 1,1 milioni di ebrei, 75
mila polacchi, 20 mila zingari Sinti
e Rom, 15 mila prigionieri di guerra sovietici e migliaia di persone di
altre nazionalità arrivate nel lager
alla fine del binario che entrava attraverso il cancello, ammassati in
vagoni per il bestiame.
Ad aprile 1940 il capo delle Ss,
Heinrich Himmler, impartì l’ordine di costruire il campo di Au-
schwitz, e due mesi dopo, a giugno,
fu aperto il campo centrale sull’area di un’ex caserma della monarchia austro-ungarica, nel sud della
Polonia. Originariamente doveva
servire per rinchiudervi gli avversari politici del regime. Dopo la
conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, quando fu decisa la “soluzione finale della questione
ebraica”, si cominciò ad allargare
il campo, con gli edifici di Birkenau (Auschwitz II, dove ieri si sono
svolte le celebrazioni). Alla fine
della seconda guerra mondiale il
complesso abbracciava una superficie di 40 chilometri quadrati, nei
quali c’erano 48 sottocampi, per
ospitare sia i prigionieri sfruttati
per lavori indispensabili all’economia bellica tedesca sia quelli destinati alle camere a gas.
Nel complesso c’erano per esempio una fabbrica della industria
chimica IG-Farben e aziende agricole per le quali era previsto lo
sfruttamento della manodopera
dei prigionieri. Nel più grande di
questi cosiddetti “Lager esterni” a
Monowice (Monowitz), distante sei
km dal campo principale, circa 10
mila prigionieri lavoravano in una
fabbrica Buna-Werke producendo
gomma sintetica e benzina per lo
sforzo bellico.
L’inizio dello sterminio di massa
dei prigionieri avvenne nell’autunno del 1941, con la fucilazione di 12
mila prigionieri di guerra sovietici. Negli stessi mesi cominciarono
le prime uccisioni con il gas mortale “Zyklon B”. Nel giugno del 1942
ebbe inizio nelle camere a gas lo
sterminio degli ebrei deportati dai
paesi occupati dal Terzo Reich.
Nei primi mesi i corpi vennero
gettati in fosse di massa che tuttavia furono riaperte e svuotate nel
novembre 1942. Nell’inverno 194243 vennero costruiti i due grandi
crematori I e II, con forni progettati nei minimi dettagli ai quali furono aggiunti poi due crematori più
piccoli. Lo spietato comandante
del lager, Rudolf Hoess, aveva
stimato una «capacità di cremare
circa 2 mila cadaveri ogni 24 ore».
Tutto cominciava con la famigerata “selezione” sulla rampa di arrivo della ferrovia: appena scesa
dai treni, dove doveva lasciare tutti
i propri bagagli, la gente veniva divisa dai medici delle Ss tra quelli
“sfruttabili per il lavoro” e quelli
destinati alle camere a gas. Lo
sfruttamento non si fermava nemmeno davanti ai cadaveri, ai quali
venivano strappati i denti d’oro
prima di essere cremati, mentre
ancora quando erano vivi gli erano
stati tagliati i capelli usati per imbottiture. Fino al novembre del
1944 i crematori di Auschwitz, rimasero in funzione giorno e notte,
quasi ininterrottamente.
All’avvicinarsi dell’Armata Rossa nell’inverno 1944-45 i nazisti cominciarono a smontare l’impianto
e, per cancellare le tracce dell’orrore, le Ss fecero saltare le camere a
gas e i crematori. Ma nel lager continuarono le esecuzioni, l’ultima
avvenne il 6 gennaio 1945, vittime
ANSA
quattro donne.
Estero
martedì 27 gennaio 2004
Speciale
La giornata
della memoria
Di che cosa abbiamo memoria,
noi che siamo venuti “dopo”? Cosa ricordare della storia che ci ha
preceduti, del secolo più sanguinoso nella storia dell’umanità, se
non le parole, i volti, gli insegnamenti di chi c’era? Fatta eccezione per l’esperienza diretta (sulla
cui elaborazione o rimozione, o
sublimazione, da Freud in qua è
stato scritto di tutto), non possiamo ricordare che per sentito dire. Ne discende che l’esercizio
della memoria è un atto di volontà e di fiducia. Di storia, su un
piano più “scientifico” che politico. Ma alla fine le ragioni dello
stare insieme, che sono poi la politica, sono quelle che prevalgono, così che la memoria – in particolare quella dei luoghi deputati alla sua manifestazione – finisce per adeguarsi o essere suscitata da temperie storiche alterne.
Da ragioni che non sempre sono
le sue.
I Lager, parliamo di questo,
“continuano a condurre una vita
che si connette in termini dinamici alle svolte della storia, ispirando sentimenti variabili, cioè influenzando e subendo i mutamenti ideologici, le viltà, gli sdegni, gli
smemoramenti, i calcoli opportunistici, i travagli delle società e
delle generazioni che si succedono”.
Parole di Bruno Segre, storico
della Shoah (era in età da deportazione quando il fascismo di
Salò decise di coinvolgersi a fondo nella “soluzione finale”, ma
qualcuno guardò giù...) e uomo
di pace, col quale ricordiamo che
il 27 gennaio in Italia è la giornata della memoria.
Analogamente all’alterno culto o disuso della memoria cosiddetta collettiva, quella individuale si alimenta della dialettica
conscio/inconscio. E se della prima conosciamo i meccanismi,
della seconda temiamo le imboscate. Professore, è una compagna affidabile ’sta memoria?
«Direi che la memoria è uno
strumento indispensabile alla sopravvivenza di tutti gli esseri. I vegetali ne hanno una, funzionale
al loro vivere, le piante ricordano
quando mettere le foglie; i miei
gatti hanno una memoria di ferro
per ciò che occorre loro a sopravvivere». E se fossimo in una pagina della scienza potremmo parlare di memoria della specie, di memoria genetica...
«Agli uomini la memoria è indispensabile nella stessa misura –
e potrebbe con ciò essere detto
tutto, ma – il nostro problema è
che se ne possono fare cattivi usi.
Quando la memoria diventa l’imbalsamazione o mitizzazione di
una serie di fatti, se ne fa un pessimo uso. Se invece viene utilizzata
per ricordare il male e progettare
il bene, si fa un uso più propizio».
Tuttavia Tzvetan Todorov, che
a usi e abusi della memoria ha
dedicato pagine importanti, si è
fermato sui rischi insiti in quella
forma di tentazione del bene che
nasce dalla memoria del male.
«Lo so e allora la risposta corretta
alla sua domanda è la problematizzazione degli usi della memoria, più che la memoria in sé».
Gli usi, certo. Anche dedicare
una giornata alla memoria è in
un certo senso farne uso, pedagogico, se non altro. Quindi possiamo chiederci se la giornata della
memoria e i luoghi della memoria sono uno strumento adeguato al mantenimento del suo elemento vitale, fecondo; o ne sono
la museificazione, se non, peggio, la ghettizzazione?
«Vorrei essere preciso. Parlare
di luoghi della memoria implica
la capacità, la necessità di saperli
“leggere”. Questo è un fatto di cultura, di preparazione, che non sono ancora patrimonio di tutti.
«Ho visitato Auschwitz l’anno
scorso, per la prima e unica volta
nella mia vita. Innanzitutto, la
guida ci ha condotti in cima alla
torretta da cui si domina il campo
di Birkenau. Vedere da lassù l’estensione e la collocazione geografica del campo mi ha fatto interrogare sulla lettura dei luoghi: sul
laRegioneTicino
Nella giornata della memoria, le parole di Bruno Segre,
storico della Shoah, riportano ai temi meno occasionali
e più profondi del ricordo e del suo rapporto
con le contingenze storiche e politiche che ne condizionano l’uso.
di Erminio Ferrari
Il ricordo
e la memoria
Auschwitz, il camino fumava
nostro modo di vederli oggi, e su
come chi “allora” viveva lì attorno non sapesse che cosa vi stava
avvenendo».
E questo riguarda la capacità
di interpretare un luogo, pur così
pieno di significati. Mentre il lavoro di trasmissione di questa
capacità è l’altro polo del nostro
discorso. «Infatti. Ho visitato Auschwitz, invitato da due classi di
un liceo di Bergamo, ed è stato un
viaggio straordinario. Due generazioni mi separavano, anagraficamente da quei ragazzi – per
spiegarmi: loro avevano un anno
o due più di quelli che avevo io
quando la mia famiglia è sfuggita
alla deportazione – ed è stata un’esperienza ricchissima poter confrontare le mie percezioni con le loro. Ma soprattutto è stata una rivelazione conoscere il vastissimo
lavoro di preparazione che aveva
preceduto il viaggio. Intendo dire
che, al di là della suggestione dei
luoghi, della capacità maggiore o
minore di “leggerli”, è fondamentale la preparazione ai luoghi, il
lavoro di conoscenza e di studio
che introducano alla visita».
Studio, letture, conoscenza appartengono alla volontà della ragione, alla sua veglia; ma vi sono
autori che sostengono l’inenarrabilità di Auschwitz. «Lo so –
concorda Segre, che queste cose
le ha indagate a fondo –, ma la
penso al contrario. Che cosa sapremmo della Shoah senza le narrazioni? Che cosa conosceremmo
di Auschwitz senza, diciamo, Primo Levi? Al di là del lavoro egregio degli storici, senza le testimonianze non ci resterebbe nulla. È
fondamentale che qualcuno abbia
narrato lo sterminio. E questo ha
a che fare con i rapporti tra memoria e storia. Nel caso della
Shoah, credo che la memoria di
chi l’ha conosciuta sia stata un
elemento di ricostruzione fondamentale, senza il quale anche il lavoro storiografico più accurato
avrebbe avuto uno spessore ben
minore».
Con tutto che lo stesso Primo
Levi arrivò a dire che i soli autentici testimoni furono i “sommersi”, coloro che non uscirono
da quell’esperienza. E a proposito del dovere/limite del dare testimonianza scrivendo, anche
Imre Kertész, Nobel della letteratura e a sua volta sopravvissuto
ai campi, a proposito delle vittime del genocidio fa dire a un proprio personaggio: queste morti
“troverebbero un posto degno tra i
simboli dell’immaginario umano
a una sola condizione: che non fos-
11
Mostar, non dimenticare
sero mai avvenute. Ma siccome
erano avvenute, erano difficili anche da immaginare”.
Allo stesso modo, potremmo
forse dire che la memoria ricorda, ma non spiega. Se nella tragica constatazione di Levi c’era il
senso di impotenza del sopravvissuto a dar conto dell’abisso, il
lavoro dello storico, che pure
avrebbe gli strumenti per organizzare in una ricostruzione coerente ciò che accadde, deve fermarsi ancora prima, sulla soglia
della domanda sul senso di tutto
quel male. Storia e memoria, insomma, si giustificano, si alimentano e si interrogano a vicenda. Ma la memoria, che spesso è memoria del dolore subito –
e quasi mai dei quello inferto –
quanto basta a spiegare, a restituire un senso di tutto ciò?
Anche lo storico si interroga.
«Guardi, spiegare non credo si
possa spiegare la Shoah. Ne abbiamo il compito, sì, ma è inesauribile. Esistono ricostruzioni dettagliate, di grande respiro, storiograficamente superbe; ma una
spiegazione ancora non me la so-
no data. È vero che la memoria
non spiega, ma purtroppo non vi
riesce neanche la storiografia. Ho
letto, studiato, indagato; so che cosa è successo, e come, in quegli anni in Europa, ma faccio fatica a
trovare una spiegazione profonda
di un programma di sterminio di
questa scala».
Forse perché riuscire a spiegare implicherebbe l’accettazione
della disumana facoltà dell’uomo di superare nei fatti la propria capacità di concepire il male. Ma tornerei all’inenarrabilità
della Shoah, che forse si può collegare alla sua unicità, un concetto che divide ancora. Non è così, professore? «Credo che vi sia
un aspetto mistificatorio in tutto
questo discorso sull’unicità della
Shoah. In realtà la storia dell’umanità è colma di stragi orrende.
La Shoah, purtroppo, non è stata
unica. Su scala diversa, le pulizie
etniche nell’ex Jugoslavia hanno
lo stesso marchio d’infamia. E, nel
dettaglio, la morte di un bambino
ebreo, o di Mostar o di Nablus è
sempre una perdita enorme».
Di nuovo, dice Segre, la que-
stione è la problematizzazione
dell’evento: «Direi piuttosto che la
Shoah è il paradigma di come
una civiltà avanzata può produrre una macchina tecnologicamente perfetta per distruggere un popolo. È stata una follia, certo, ma
esplicata con avanzatissimo
know how tecnologico. Anche la
mole di materiali che oggi consentono agli storici di ricostruire lo
sterminio di ebrei, zingari e altri
“Untermenschen” è dovuta al fatto che ne è rimasta una documentazione di tipo industriale. I campi stessi erano fabbriche in cui entrava una materia prima e da cui
usciva il prodotto finito, spesso attraverso il camino. Tutto registrato con tecnologica precisione; pensi solo all’efficienza del sistema di
trasporti messa in atto da Eichmann. Da questo punto di vista la
Shoah è paradigmatica dei tipi di
guasti che la nostra civiltà è in
grado di produrre». E non parla
al passato Segre: «No, purtroppo.
Credo cioè che l’avanzare della
tecnologia farà progredire la possibilità di produrre tragedie ancora più colossali». È il paradosso
tragico della modernità, mi sembra. «Certo. Non parlerei dunque
di unicità ma di paradigmicità».
O di un’esemplare epifania del
male, che non ha insegnato molto, se solo si pensa a che cosa è avvenuto nei decenni successivi.
«Appartengo – risponde Segre – a
una generazione che continua ad
auspicare che la storia sia maestra di vita, ma devo constatare
che no, non lo è affatto. Al contrario, sembra che la storia dia ad
ogni generazione, ad ogni gruppo
umano la possibilità di imparare
da sé a misurarsi con la propria
capacità di produrre il male. Nello stesso tempo, un residuo di cultura illuminista mi impone di
non rinunciare a fare uso della ragione. Il grosso della nostra aggressività origina da qualcosa di
diverso dalla ragione, ma spesso
gli uomini mettono l’intelligenza
al servizio delle proprie pulsioni.
Se fossimo capaci di razionalizzare la carica di aggressività di
cui sono portatrici talune pulsioni,
riusciremmo a trasferire il nostro
comportamento dal piano della
violenza a quello della non-violenza. D’altra parte che cos’è la democrazia se non un sistema che permette agli uomini di vivere il conflitto in modo non violento? Togliere la violenza dal mondo significa
soprattutto usare la ragione invece
ci affidarsi agli impulsi. Questo
non spiega la Shoah, beninteso,
ma è ciò che mi pare di avere appreso nei decenni in cui mi sono occupato di questa tragedia».
Eppure, di nuovo, avanza un
discorso storiografico, politico,
pubblicistico, che ha il tratto dell’alterazione, più che della revisione del passato di cui parliamo. Una specie di deresponsabilizzazione di scelte fatte da individui, motivata dal fatto che “a
giudicare sarà la storia”. Mi sembra un argomentare capzioso. O
no? «Qui risponderò un po’ a
spanne. Ho l’impressione che in
generale la cultura politica europea non abbia fatto i conti con la
Shoah. Non l’hanno fatta gli italiani, la cui cultura politica dominante è autoassolutoria, quasi che
la Shoah non li riguardasse».
Già, Mussolini non ha ucciso
nessuno, Berlusconi dixit. «Ma è
un discorso che sul piano storiografico è stato inaugurato già da
De Felice. Non ha fatto i conti con
la Shoah la cultura dominante
francese, a dispetto dell’antisemitismo e del collaborazionismo di
Vichy. Ma nemmeno gli alleati,
che pure hanno avuto grandi responsabilità di omissione riguardo allo sterminio. Credo – conclude Segre – che i conti più a fondo li
abbia fatti la Germania. È pur vero che sono tedeschi Ernst Nolte e
diversi negazionisti, ma va riconosciuto che in Germania si è lavorato molto affinché le giovani
generazioni sapessero perfettamente cosa è accaduto».
Mentre c’è stata una metà
d’Europa, quella sovietica, che ha
usato la Shoah per giustificare
una contingenza: lo sterminio come espressione massima della
violenza capitalista, a mascheramento della violenza comunista...
«Assolutamente, ma aggiungerei
che questi conti mancati spiegano
molto dell’inerzia con cui l’Europa
segue e interviene nel dramma mediorientale. La tragedia di israeliani e palestinesi non nasce in Medio Oriente, ma in Europa: l’hanno prodotta i tedeschi con la Shoah
e francesi e inglesi con il colonialismo. Diciamolo, infine: tutte le premesse dell’attuale catastrofica situazione mediorientale sono scritte nella storia europea. E tuttavia
non c’è in Europa l’assunzione di
responsabilità che potremmo attenderci, tanto che l’Europa è impotente e inetta davanti al dramma che si consuma laggiù». Bruno
Segre, possiamo dirlo ora, è uno
dei sostenitori più attivi di Neve
Shalom, il villaggio in Israele in
cui da decenni ebrei e palestinesi
convivono in una riuscita esperienza di integrazione. Sa cosa dice quando parla di memoria, sappiamo che cosa intende quando
parla di pace.
Estero
lunedì 27 gennaio 2003
laRegioneTicino
8
Speciale
Il passato
presente
di Erminio Ferrari
Milano – Becky tiene sempre
a portata di mano dei cioccolatini. Un po’ sorridendo, un po’ sul
serio, quei bonbon le ricordano
il soldato che per confermarle
che era finita in Svizzera
estrasse dalle tasche della divisa dei cioccolatini e glieli diede.
Ottobre 1943. «Ero terrorizzata. Mi aveva intimato l’alt in tedesco, e poi aveva un elmetto
uguale a quello dei tedeschi che
ci perseguitavano». E poi aveva
dodici anni.
Becky Behar («sposata Ottolenghi», come precisa sempre)
era l’ultima figlia della sola famiglia ebrea sopravvissuta agli
eccidi del Lago Maggiore del
settembre 1943. La prima strage
di ebrei in Italia: sedici uccisi e
gettati nel lago tra il 22 e il 24
settembre.
Dopo l’infamia delle leggi
razziali; la vergognosa codardia
dei circoli accademici; la tacita
connivenza di una nazione in
mano al duce; la persecuzione
degli ebrei d’Italia era entrata
nella fase più cruenta e spietata, quella della soluzione finale.
Sessant’anni fa, sembra ieri,
per chi come Becky della memoria ha fatto un dovere.
«Noi stavamo a Meina, dove
mio padre possedeva l’Hotel Victoria. Siamo stati presi con altre
famiglie di ebrei che si trovavano nell’albergo. Gente che aveva
case a Meina o erano sfollati, o
clienti. Erano famiglie fuggite
dalla Grecia, ma con passaporto
italiano.
«Quando, dopo l’8 settembre, i
tedeschi sono arrivati in albergo, avevano già una lista dei presenti ebrei, fornita dal comune e
da alcune spie del posto. Ricordo
una signora che si era presentata pochi giorni prima e aveva
chiesto alloggio per qualche
giorno; ci teneva molto a frequentare gli ospiti dell’albergo,
a fare amicizia con noi ragazzi e
a tempestarci di domande. Dopo
pochi giorni questa signora ha
lasciato l’albergo e in breve arrivarono i tedeschi.
«Abbiamo visto i soldati tedeschi scendere dai camion e circondare l’albergo. Uno di loro
prese il mio cagnolino che scorrazzava davanti all’ingresso e lo
gettò nel lago. Per me bambina
fu uno choc.
«Tre militari entrarono poi
nella camera dei genitori, dove
eravamo riuniti mamma, papà e
i quattro figli. Un ufficiale chiese
a mio padre se era lui il proprietario dell’albergo. Alla risposta
affermativa di mio padre, disse:
lei è ebreo e dà ospitalità ad ebrei
nemici della Grande Germania,
quindi si ricordi che da questo
momento niente più le appartiene. Detto questo ci lasciarono in
camera e riunirono tutti gli altri
ebrei dell’albergo. Poi ci condussero tutti all’ultimo piano, i sedici ospiti più noi sei. Eravamo ragazzi, bambini, anziani.
«Il giorno dopo prelevarono
mio padre per portarlo al comando tedesco di Baveno. Ricordo le lacrime di mia madre e le
parole di mio padre: tornerò, abbiate fede.
«A salvarlo, e noi insieme a
lui, fu il console turco che si trovava ospite della nostra villa,
dove si era stabilito dopo i bombardamenti di Milano. Eravamo infatti di nazionalità turca e
la Turchia non era ancora in
guerra. Quella santa persona,
informata dal personale dell’albergo, si precipitò al comando tedesco a Baveno e picchiando i
pugni sul tavolo disse: non potete toccare un cittadino turco, ne
farò un caso diplomatico. I tedeschi, forse sperando ancora che
la Turchia si alleasse con loro,
riportarono mio padre a Meina.
«Restammo ancora qualche
giorno chiusi all’ultimo piano
dell’albergo, finché il console ottenne che la nostra famiglia venisse “liberata” dall’ultimo piano dell’albergo, senza tuttavia
poterlo lasciare.
«Una sera sentimmo dei passi
cadenzati sulle scale. Il mattino
dopo ci dissero che una parte degli ebrei era stata portata ad un
interrogatorio. Poche ore dopo,
un cameriere venne da mio padre e disse che erano stati pescati
I sommersi
Incontro con Becky Behar Ottolenghi scampata all’eccidio
L’Hotel della memoria
Sessant’anni fa sul Lago Maggiore la prima strage di ebrei in Italia
dei cadaveri nel lago, tra Meina
e Arona, e che qualcuno aveva
riconosciuto gli ebrei dell’albergo.
«Riuscii di nascosto dai miei
genitori a uscire dall’albergo, attraverso una porticina che i tedeschi non conoscevano. In bicicletta andai sul posto a vedere e per
primo riconobbi il padre dei
miei amici Fernandez, poi la
madre, mentre altri non riuscii a
riconoscerli perché erano troppo
sfigurati. Tornai in albergo e dopo poche ora salii le scale per trovare il mio amico John,figlio dei
Fernandez. Mi chiese se avevo
saputo che avevano portato via i
suoi e un’altra famiglia, i Torres. Credeva ancora che li avrebbero ricondotti in albergo. Io
avevo già visto i cadaveri dei
suoi genitori e gli dissi sì, di avere fiducia. Non so come fece quella ragazzina…
«Dopo due o tre giorni vennero
a prelevare i ragazzi e i più anziani. John mi salutava dicendo
che ci saremmo rivisti. Il nonno
Fernandez, abbracciandomi mi
ringraziò per il tabacco che talvolta gli procuravo: grazie
Becky, non so se ci rivedremo,
disse. Aveva capito.
«Il giorno dopo, altri cadaveri
galleggiavano sul lago. I tedeschi li uccidevano legando loro
una pietra al collo e li gettavano
nel lago. Solo che nella fretta
non sempre riuscivano a legare
bene la pietra, così che alcuni cadaveri riemersero».
E c’è ancora chi dice che in
Italia non è successo niente.
Quell’Italia che ha fatto del 27
gennaio la Giornata della Memoria. Un bel problema la memoria: ogni giorno ne aggiunge
un po’ al successivo. Strato su
strato fino a essere quel che siamo e ciò che già stiamo divenendo. Ma questa è una memoria eletta a qualcosa di più di un
processo di identificazione: a
virtù civica. E chissà se funziona.
“A chi servono le storie di un
ennesimo ebreo?”, si chiede un
personaggio dell’ultimo romanzo di Chaim Potok. Immaginiamo che servano, giacché sono
anche le nostre. Di noi, (“che vivete sicuri/nelle vostre tiepide
case”) ai quali Primo Levi chiese se “questo” era un uomo.
E infatti c’è Levi in un momento preciso del ricordo di
Becky.
«Non siamo mai stati religiosi, ebrei, sì, ma piuttosto laici.
Mio padre ci aveva insegnato
che esisteva Dio, ma non eravamo praticanti. Non avevamo
mai sentito la nostra presunta
diversità. Non mi sono mai sentita diversa.
«Di esserlo, perché altri avevano deciso che lo fossi, l’ho capito
Levi: è accaduto e può accadere ancora
quando una sera mio padre ci
radunò nel suo studio per dirci
che il giorno dopo non avremmo
più potuto andare a scuola. Fu
un trauma. I miei genitori avevano sempre cercato di tutelarci,
ci tenevano all’oscuro degli avvenimenti europei e italiani. Alle
mie domande, mio padre rispondeva evasivamente.
«Il mattino seguente, mio padre mi accompagnò a salutare
l’insegnante e i compagni. Ricordo ancora le lacrime negli occhi
di questa maestra; ma ricordo
anche che alcuni dei miei più cari compagni, che frequentavano
abitualmente casa nostra, non si
fecero più vivi».
Inizia così la complicità in
uno sterminio? Tra chi insultava gli ebrei per strada e chi li rese invisibili ai propri occhi la
differenza rischia di essere così
labile. Tra chi firmò le leggi razziali e gli accademici che firmarono il formulario in cui si
dichiaravano “non di razza
ebraica”. Tra la ferocia e le mani davanti agli occhi.
«I tedeschi – ricorda Becky –
si comportavano in maniera
sprezzante nei nostri confronti.
Ricordo la faccia di disprezzo
del militare che ci portava da
mangiare. Era giovanissimo. Indottrinato e feroce. Con un gusto
particolare nell’infierire su persone che avvertiva più istruite e
colte di lui».
Ma, Becky lo sa, è pur un’altra la domanda che viene – quasi che la ferocia del giovane militare tedesco abbia una sua
oscena plausibilità (pur se resta
lo sgomento per come una nazione civile come quella tedesca
abbia potuto) nelle dinamiche
di manipolazione delle masse
in circostanze di crisi di valori
e certezze – e cioè: nessuno si è
accorto di quello che si stava
preparando e poi avvenne? È
ben vero che i contadini polacchi “non sapevano” di Auschwitz; i concittadini di
Goethe “non sapevano” di Buchenwald, ma.
«In quei giorni di Meina, non
avevamo contatti con l’esterno,
se non attraverso il personale e i
clienti dell’albergo. Tra questi
c’erano dei giornalisti, inviati a
Meina perché lì c’era la villa
Mondadori; ma non si interessavano più di tanto di quello che
stava succedendo nelle camere
superiori. Alla sera i saloni dell’albergo erano requisiti dai tedeschi per le loro feste, a cui si associavano alcune clienti. Come
se niente fosse.
La gente non ne faceva parola.
Forse non immaginava cosa sarebbe successo, forse non se lo domandava nemmeno. Forse non
voleva saperlo».
Riprendiamo il ricordo.
Scampati all’eccidio, i Behar
dovevano pure mettersi in salvo. E fu di nuovo il console turco (una specie di sconosciuto
Perlasca) la loro salvezza. «Infatti ci avvertì che di lì a pochi
giorni la Turchia sarebbe entrata in guerra e a quel punto lui
non avrebbe più potuto aiutarci.
«Così organizzammo la nostra fuga, in barca. Di notte attraversammo il lago verso la
sponda lombarda, dove ci ospitarono, a gruppi di due, alcuni
amici. Poi alcuni contrabbandieri ci fecero passare in Svizzera, la nostra salvezza. Ci avevano fatto trascorrere l’ultima notte in una stalla, dalle parti di
Abbiate Guazzone e il mattino
presto ci fecero passare la rete,
dalle parti di Ponte Tresa, mi
pare. Io avevo in spalla uno zaino colmo di scatolette di viveri
ed ero tutta infagottata, perché
mia madre aveva una gran paura che morissimo di fame e di
freddo.
«Le istruzioni erano che appena passata la rete, avremmo dovuto metterci a correre per non
essere presi a fucilate dai tedeschi. Io lo feci, ma ero gravata
dallo zaino e caddi. Mi ritrovai
davanti un militare che mi intimò l’alt in tedesco. Ero sola,
non vedevo più gli altri. Quel militare aveva un elmetto come i tedeschi. Ero terrorizzata, piangevo disperata. Lui non riusciva a
spiegarsi, ma per farmi capire
che eravamo in Svizzera, mi allungò dei cioccolatini.
«Fummo riuniti e portati a
Bellinzona da cui ripartimmo
per il campo di Rovio, sfilando
per le vie della città e sentendo su
di noi lo sguardo delle persone
che si affacciavano a vedere “gli
ebrei”. A Rovio abbiamo preso
pidocchi e scabbia, infezioni intestinali, ma insomma eravamo
vivi. Grazie alla Svizzera».
Non che sia facile essere un
“salvato”, di nuovo Levi, come è
scritto in un libro capitale del
Novecento. «No che non lo è. Ci
si chiede perché “loro” no e noi
sì. Mio padre, rientrato dopo la
guerra, si chiuse in un mutismo
totale. Non amava parlarne, anche perché c’era una grande indifferenza attorno a noi. Lo dice
anche Primo Levi: quando tornò
e avvertì l’indisponibilità della
gente ad ascoltare certe cose. Mio
padre lo sperimentava, e taceva».
E per lei Becky, invece, cosa
significa essere una “salvata”?
«Ho vissuto questa condizione
come un incarico, portando la
mia esperienza in giro, parlandone di preferenza ai giovani.
Penso che a loro serva: solo testimoniando tra i giovani c’è speranza. Vedo oggi ripetersi gli
stessi errori di sessant’anni fa.
Mi spiace per loro e mi sforzo di
ripetere le parole di Levi: è accaduto e quindi potrà accadere ancora.
«E constato che i giovani non
sono estranei a questi discorsi.
Ci ascoltano come le ultime voci
di un’epoca, coscienti che ci fu un
tempo in cui chi doveva parlare
ha taciuto, portandosi dietro sofferenze mai dette.
«Lo faccio talvolta con fatica,
a causa dei miei anni, ma è questo il mio dovere della memoria».
Ma senta, Becky, al processo
che si celebrò venticinque anni
dopo l’eccidio di Meina, gli imputati vennero sì condannati
(anche grazie alla sua testimonianza), ma furono presto amnistiati, «e qualcuno fece una
bella carriera; uno divenne presidente della Pepsi Cola»; e ancora oggi si avverte come del fastidio quando un ebreo racconta...
«C’è ancora antisemitismo in
giro, certo, ma è di nuovo lo specchio dell’odio verso il diverso.
Non saprei spiegare diversamente il disprezzo verso gli immigrati più poveri, la xenofobia
che si accanisce nei confronti di
chi non appartiene alla nostra
cultura. Quando assisto a certe
aggressioni anche verbali ai
danni di qualche extracomunitario (che magari qui vende accendini, ma al suo paese è una
persona istruita), ciò che vedo
davanti a me è il volto del tedesco
che ci imprigionò».
La memoria, grazie Becky, è
il presente. «E c’è ancora chi dice
che in Italia non è successo [non
succede] niente».