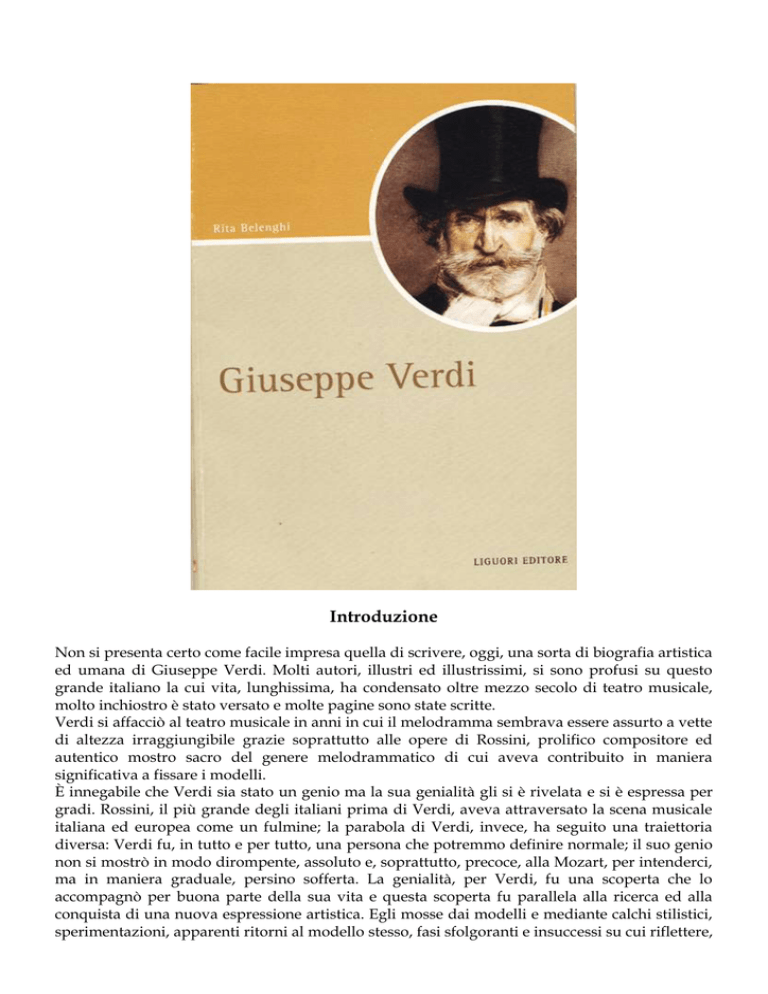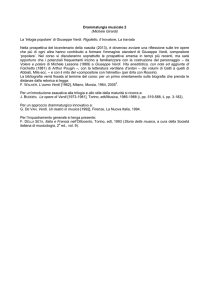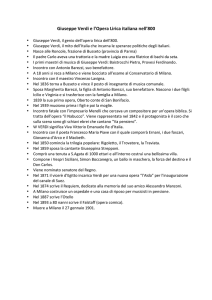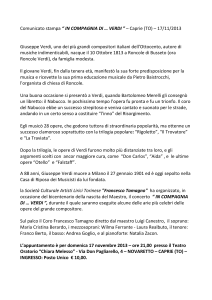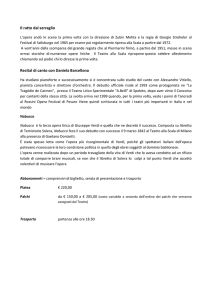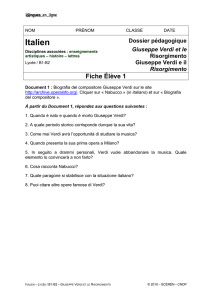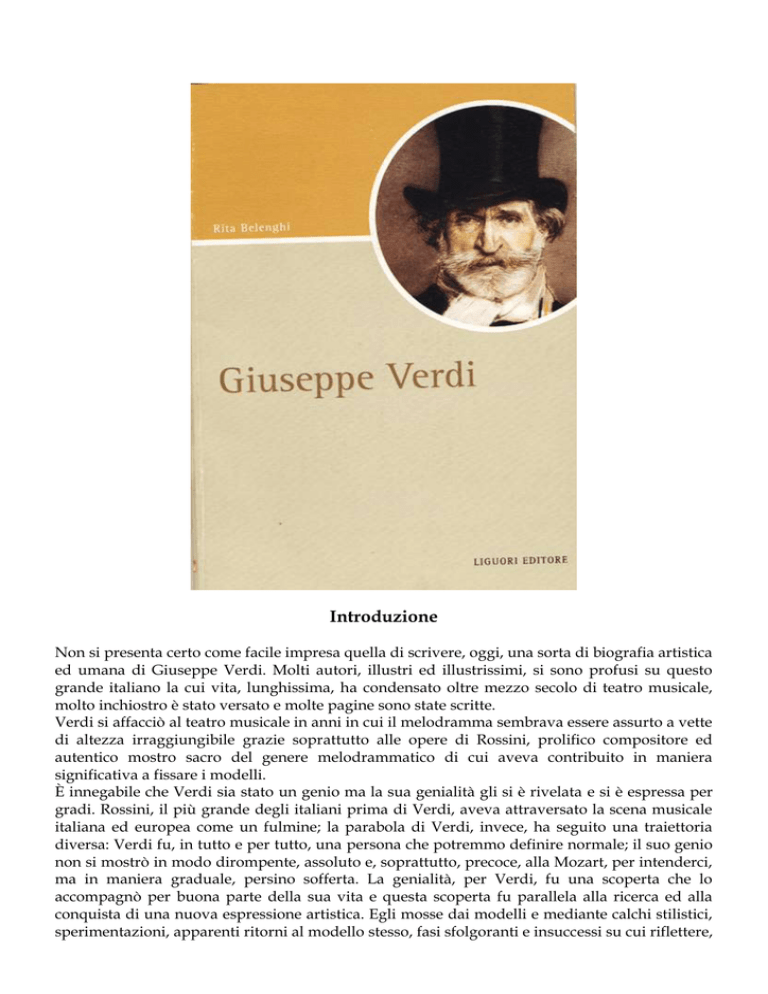
Introduzione
Non si presenta certo come facile impresa quella di scrivere, oggi, una sorta di biografia artistica
ed umana di Giuseppe Verdi. Molti autori, illustri ed illustrissimi, si sono profusi su questo
grande italiano la cui vita, lunghissima, ha condensato oltre mezzo secolo di teatro musicale,
molto inchiostro è stato versato e molte pagine sono state scritte.
Verdi si affacciò al teatro musicale in anni in cui il melodramma sembrava essere assurto a vette
di altezza irraggiungibile grazie soprattutto alle opere di Rossini, prolifico compositore ed
autentico mostro sacro del genere melodrammatico di cui aveva contribuito in maniera
significativa a fissare i modelli.
È innegabile che Verdi sia stato un genio ma la sua genialità gli si è rivelata e si è espressa per
gradi. Rossini, il più grande degli italiani prima di Verdi, aveva attraversato la scena musicale
italiana ed europea come un fulmine; la parabola di Verdi, invece, ha seguito una traiettoria
diversa: Verdi fu, in tutto e per tutto, una persona che potremmo definire normale; il suo genio
non si mostrò in modo dirompente, assoluto e, soprattutto, precoce, alla Mozart, per intenderci,
ma in maniera graduale, persino sofferta. La genialità, per Verdi, fu una scoperta che lo
accompagnò per buona parte della sua vita e questa scoperta fu parallela alla ricerca ed alla
conquista di una nuova espressione artistica. Egli mosse dai modelli e mediante calchi stilistici,
sperimentazioni, apparenti ritorni al modello stesso, fasi sfolgoranti e insuccessi su cui riflettere,
riuscì a mettere a fuoco ed a proporre una propria idea di drammaturgia, più complessa e
nuova da cui emergeva la finalità dell'arte, che era etica e non più prevalentemente emotiva o
estetica.
Da giovane Verdi si era convinto, anche per la serie di lutti che lo colpì nel volgere di pochi
anni, che la sorte non riservasse granché di buono agli esseri umani, che nella lotta tra il bene ed
il male fosse quest'ultimo a prevalere ed aveva espresso nella propria drammaturgia questo
sentimento di pessimismo laico facendo incursioni nel mondo dei diversi, dei diseredati,
creando personaggi memorabili come Rigoletto, Azucena, Violetta, prigionieri di un destino che
non lascia loro vie d'uscita, se non quella dell'unica possibile catarsi, la morte, propria o quella
di qualcuno carissimo che la sorte vuole immolato ad una necessità implacabile.
Anche laddove il protagonista era il popolo, non sempre le cose andavano meglio. Maturando
in anni e in esperienza, confortato anche artisticamente dalla presenza costante e discreta di
Giuseppina Strepponi, compagna intelligente e preziosa, spiritosa ed arguta nonostante i sensi
di colpa, trascinati a lungo, a causa di una vita giovanile non morigerata, Verdi elaborò il senso
profondo della propria drammaturgia arrivando a concepire personaggi complessi, a tutto
tondo.
Su questa maturazione influì molto l'esperienza di Parigi, l'incontro con il grand-opéra, il lavoro
nella capitale europea della cultura sede del tempio del teatro musicale europeo, quell'Opera
per la quale compose Les Véspres siciliennes.
Verdi, allora, non solo genio ma genio europeo. Essere europei significa mettere continuamente
in discussione il proprio sapere, le proprie capacità, addirittura la validità del loro contesto di
espressione, nel caso di Verdi il melodramma.
Ragionando sul melodramma Ezio Raimondi ci dice che in Italia più che altrove il melodramma
era diventato una forma democratica e popolare, non solo ma esso suggeriva comportamenti,
stili di vita. Sottolinea, inoltre come nella nostra tradizione moderna il melodramma sia la
«letteratura in azione: l'opera di Verdi, per esempio, è un romanzo drammatico, avvolto da una
straordinaria musica, capace di dar vita alle passioni precise e necessarie di cui è intessuto» 1. Ma c'è
dell'altro: Verdi non si è limitato alla composizione di opere su soggetto "italiano", nonostante il
suo sentimento di identità
1
E. Raimondi, Letteratura e identità nazionale, Milano: Bruno Mondadori, 1998, p. 179.
nazionale sia stato sempre molto forte ed è ancora Raimondi che ci avverte di un certo
cosmopolitismo di Verdi che deriva dalla ricezione di Shakespeare, dai modelli drammaturgici
greci, dall'espressione di passioni elementari 2.
Sono proprio queste, le passioni elementari che ci consegnano la dimensione europea di Verdi,
non perché sia possibile l'equazione passione elementare uguale a passione semplice, o, peggio
brutale, piuttosto perché passione elementare in Verdi diventa passione universale,
riconoscibile, condivisibile da tutte le culture europee, dalla Francia alla Russia, dall'Inghilterra
alla stessa Germania. Il grande impegno etico di Verdi fu quello di considerare il bene ed il
male, le passioni fondamentali, formulando su di esse un giudizio di valore, lucido e rigoroso.
Questo impegno andò precisandosi nel corso degli anni, con l'irrobustirsi del carisma
professionale e personale, mano a mano che Verdi si sentiva sempre più libero di inoltrarsi nelle
ricerche che gli stavano a cuore, di confrontarsi con gli autori che sentiva più vicini alla propria
sensibilità, primo fra tutti l'amatissimo Shakespeare, che veniva chiamato addirittura «il Papà»,
senza il timore di smarrirsi o di smarrire la continuità con una vocazione artistica che doveva
fare però i conti anche con l'aspetto mercantile della professione. Le opere di Verdi sono le
tracce che conducono a cogliere l'aspetto filosoficamente universale dell'appartenenza europea
del loro autore; alcune si pongono come pietre miliari perché rappresentano i punti di svolta, le
chiavi per decifrare il codice artistico e morale di Verdi e su quelle il discorso si farà più
insistito.
Nell'ottica dei luoghi europei di Verdi, il più importante è sicuramente Parigi, centro culturale
fondamentale; anche se Verdi si sentiva poco adatto a Parigi, come scrisse in una lettera a
Camille Du Locle, non poteva non riconoscere che la Francia avesse dato alla civiltà europea le
basi stesse su cui essa poggiava.
Dall'esperienza parigina di Les Véspres siciliennes, dunque,
2 Ivi, p. 180.
si può parlare di una dimensione europea di Verdi legata anche alla sua presenza sempre più
frequente nei teatri più prestigiosi d'Europa ma la sua dimensione autenticamente europea sta
nell'approfondimento dell'ispirazione drammaturgica che si arricchisce, si rafforza, acquista
sempre più spessore ed esce da un ambito squisitamente italiano legato ad una moda e ad un
modello per entrare in un circuito più ampio di idee e motivi culturali. Investendo il concetto di
umanità e indagandolo nel profondo, consapevolmente, tenendo conto delle innumerevoli
sfaccettature dell'animo umano, la drammaturgia verdiana rende un linguaggio di origine
italiana comprensibile e condivisibile dall'Europa intera.
Nel licenziare questo lavoro desidero ringraziare il professor Davide Monda che mi ha
permesso di dare forma ad argomenti ed osservazioni frutto di un'amichevole conversazione.
1
Il giovane Verdi
1.1. Va' pensiero...
(Nabucco, parte terza, La profezia, scena quarta)
È assai probabile che la sera del 10 ottobre 1813 sulle Roncole ci fosse una cappa di nebbia,
magari non molto fitta ma lattiginosa, insistente e diffusa, una di quelle nebbie che chi ha
dimestichezza con la "bassa" padana è abituato a vedere e a respirare sera e mattina,
dall'autunno e fino a primavera. Nella casa di Carlo Verdi e di sua moglie Luigia Uttini, alle
otto di quella sera, era nato un bambino, un maschio 1, portato al fonte battesimale il giorno
dopo. Al bambino furono imposti i nomi di Joseph, Fortuninus, Franciscus che il giorno
seguente il "Maire" di Busseto, in ossequio al Codice civile napoleonico trascrisse in francese nei
registri di stato civile dove il piccolo Verdi figurava come Joseph-Fortunin-Franois.2
L'infanzia e l'adolescenza di Giuseppe furono anonime: egli era uno dei tanti ragazzi che
sfacchinarono nelle campagne della pianura padana durante il secondo decennio dell'Ottocento
ma, nonostante questo, egli era più fortunato dei suoi coetanei perché mentre altri ragazzi della
sua età lavoravano nei
Nel 1816, il 20 marzo, nacque la sorella di Giuseppe Verdi, battezzata con i nomi di Giuseppa Francesca. La bambina, probabilmente a causa
di una meningite, fu inferma di mente e morì alle Roncole il 9 agosto 1833 a 17 anni. Cfr. F. Waiker, L'uomo Verdi, Milano: Mursia, 1964, p. 8.
2 C. Gatti, Verdi, Milano: Mondadori, 1951, pp. 11 — 12, dove sono riportati l'atto di battesimo desunto dai registri parrocchiali e l'atto di
iscrizione allo stato civile.
1
campi fin dall'alba a lui toccava solo assolvere ai suoi doveri di organista nella chiesa delle
Roncole recandovisi da Busseto, dove studiava. Già, Giuseppe studiava. Suo padre di mestiere
faceva l'oste ed era più povero dei contadini che potevano contare sui frutti delle coltivazioni
dei campi e degli allevamenti del bestiame ma, al contrario di loro, disponeva di contanti e,
anche se il margine su cui poteva contare era piuttosto risicato, quella liquidità gli dava qualche
vantaggio sui contadini e gli permetteva di cullare qualche sogno in più per sé e per la sua
famiglia. Molto probabile che Carlo Verdi nutrisse speranze sul figlio tanto da comprargli una
spinetta e poi acconsentire che andasse a Busseto a studiare. Il dono della spinetta, tuttavia non
era, nelle intenzioni di Carlo, il riconoscimento di un talento precoce nel figlio, piuttosto
rispondeva ad un suo gusto per la musica accompagnato alla versatilità che egli riconosceva in
Giuseppe.
C'era anche qualcun altro che volle in qualche modo contribuire alla formazione musicale del
giovanissimo Verdi regalandogli il proprio lavoro: si chiamava Stefano Cavalletti e venne
chiamato per riparare la spinetta che l'entusiasmo di Giuseppe aveva messo a dura prova.
Cavalletti non volle essere pagato, anzi dichiarò che era contento di lavorare gratuitamente per
amore della « buona disposizione dimostrata dal giovanetto Giuseppe Verdi d'imparare a suonare questo
strumento.»3. Era accaduto poi che l'organista delle Roncole, Pietro Baistrocchi, avesse
cominciato ad insegnare musica a Giuseppe, dopo averlo visto provare sull'organo quello che,
probabilmente, strimpellava a casa sulla spinetta.
Con Baistrocchi si apre la serie dei protettori di Verdi, tra i quali furono alcuni notabili del
paese, come Antonio Barezzi, e poi musicisti, impresari, nobili milanesi e cantanti di fama.
Nell'autunno del 1823 Giuseppe venne iscritto al ginnasio di Busseto. Il suo distacco dalle
Roncole venne sollecitato dai suoi estimatori — protettori Baistrocchi e Barezzi ma il fatto che
3 C.
Casini, Verdi, Milano: Rusconi, 1981, p. 13.
si trattasse di due appassionati di musica non significa che la carriera musicale di Giuseppe
fosse già tracciata, si trattava solo di un'eventualità che comunque, nell'Italia padana del 1820
rappresentava un'ottima alternativa per un ragazzo che altrimenti avrebbe passato la vita a
rompersi la schiena nei campi o, al massimo, avrebbe ereditato l'esercizio paterno dell'osteria. Il
fascino esercitato dalla città capitale, Parma, passava anche per gli spettacoli musicali che la
corte francesizzata del ducato continuava a dare e Milano, con il suo mitico teatro alla Scala era
abbastanza vicina per far sentire gli echi delle proprie produzioni, tanto più che all'epoca erano
molto popolari le compagnie girovaghe che battevano tutti i centri della provincia, anche quelli
minuscoli, portandovi gli spettacoli che cantanti e orchestre di grido davano nei maggiori teatri.
Nei piccoli centri come le Roncole l'organista era il «custode della musica»4: a lui spettava anche
l'attività di didatta e di raccoglitore — diffusore dei melodrammi di maggior successo. Pietro
Baistrocchi, organista delle Roncole, aveva appunto questo compito e, una volta riconosciute le
doti del ragazzo Verdi, aveva fatto pressione su Carlo, con la complicità di Antonio Brezzi, per
strappargli il consenso agli studi di Giuseppe. Del resto, tutto era stato organizzato
perfettamente: agli studi umanistici avrebbe pensato il canonico Pietro Seletti, insegnante al
ginnasio di Busseto, mentre per gli studi musicali ci sarebbe stata la guida di Ferdinando
Provesi, organista e maestro di cappella bussetano.
Il canonico Seletti cullò per qualche tempo l'aspirazione a fare di Giuseppe un buon umanista e
forse anche un prete ma fu costretto ad arrendersi anche perché Barezzi e Provesi non
intendevano sprecare il talento musicale del loro protetto ragion per cui il canonico dovette
arrendersi presto ma non lo fece a malincuore, anzi riconobbe che la vocazione musicale di
Giuseppe aveva diritto di cittadinanza come qualsiasi altra vocazione, tanto più che poteva
aprirgli la strada ad un impiego
4Ivi,
p.15
come organista comunale. Ragioni di prudenza, però, consigliarono di non interrompere gli
studi umanistici che davano maggiori garanzie per il futuro rispetto ad un talento che forse si
sarebbe rivelato duraturo o forse no ma che in un dodicenne era comunque difficile da
pronosticare. Effettivamente, alla morte di Baistrocchi, Giuseppe ne aveva preso il posto
impegnandosi, per un compenso di quaranta franchi l'anno, a suonare nei giorni di festa
l'organo nella chiesa delle Roncole. Il prestigio di Giuseppe crebbe in misura esponenziale
perché nel giro di quattro anni non solo non aveva più nulla da imparare dal suo maestro
Provesi ma ne era addirittura diventato l'assistente nelle varie mansioni didattiche e
professionali. Un po' del proprio tempo il giovane lo dedicava alla Filarmonica, sia per
gratitudine verso l'altro suo protettore, Barezzi, che per avere l'occasione di mettersi in mostra
componendo ed eseguendo le proprie composizioni. Con la pratica Verdi si era impadronito di
una tecnica di orchestrazione rudimentale come, del resto, tutta la sua preparazione musicale lo
era non perché l'insegnamento di Provesi fosse stato superficiale ma perché la preparazione del
suo antico maestro non poteva certo stare alla pari con quella fornita dalle scuole di musica
accreditate, i Conservatori, che stavano nascendo come tali proprio in quel periodo.
Il richiamo del Conservatorio non tardò a farsi sentire: nel 1832, a 19 anni, invece di cercarsi un
impiego tranquillo magari vicino a casa, Giuseppe intraprese il viaggio a Milano per iscriversi
al conservatorio di quella città e proseguire negli studi musicali. Dietro quella decisione
temeraria c'era, ancora una volta, Antonio Barezzi, l'uomo al quale per tutta la vita Verdi non
smise mai di tributare una riconoscenza calorosa e devota, riversando su di lui i sentimenti
filiali che non riservò mai al proprio padre naturale. Barezzi era un uomo d'affari dotato di
intraprendenza e di iniziativa, pieno di fiducia nelle proprie possibilità, generoso e, nel
contempo, cauto e riflessivo. Aveva, insomma tutto il buonsenso tipico di un uomo di
provincia. A Giuseppe, che cominciò presto a considerare come un figlio, arrivando a mettersi
addirittura in competizione con Carlo Verdi per quanto riguardava le decisioni sul futuro del
ragazzo, spianò letteralmente la strada, orgoglioso della buona riuscita del suo pupillo anche se
limitata alla vita del paese, e se lo tenne vicino non soltanto dal punto di vista affettivo ma
proprio fisico perché, a partire dal maggio 1831, il diciottenne Giuseppe Verdi andò ad abitare a
casa Barezzi. Il pretesto fu che la signora Barezzi si era spaventata per via di una rapina
avvenuta nelle vicinanze e gradiva in casa la presenza di un giovane uomo per sentirsi
maggiormente protetta e questo fu sufficiente per non urtare la suscettibilità del
permalosissimo Giuseppe e per aggirare le resistenze di Carlo Verdi che, forse, avrebbe gradito
cominciare a godere i frutti della crescente fama del figlio, cosa a cui sentiva di avere pieno
diritto.
Casa Barezzi era piuttosto affollata perché c'era un bel gruppo di quattro figlie e due figli oltre
ad Antonio e sua moglie, ma per quell'inguaribile ottimista di Antonio Barezzi quello non era
certo un ostacolo e Giuseppe venne accolto con grande cordialità che aumentò quando fu chiaro
che il giovane ospite amava, riamato, la figlia maggiore dei Barezzi, Margherita.
La cosa non turbò i Barezzi che probabilmente conoscevano «la rettitudine e l'intelligenza del
futuro genero»5 ed aggiunse un senso più tangibile al viaggio a Milano per iscriversi al
Conservatorio, cioè affermarsi nella prestigiosa scuola musicale di una città capitale del teatro
lirico e tentare la fortuna nel campo teatrale che, all'epoca, era considerato l'unico serio e
fruttifero per chi lavorasse con la musica. Il futuro di Margherita, una volta diventata la signora
Verdi, avrebbe potuto essere sicuro e molto agiato se Barezzi avesse vinto la scommessa fatta
sul talento di Giuseppe. Fornito di tutti i documenti e del denaro necessario Verdi partì per
Milano ma il suo primo impatto con quella città gli riservò uno smacco cocente dal momento
che la commissione esaminatrice lo respinse con motivazioni, peraltro, ineccepibili: Verdi aveva
19 anni, troppi per l'ammissione
5 Ivi, p.19
in Conservatorio e, come suddito della duchessa di Parma a Milano era uno straniero. A
posteriori, quella commissione fu accusata di oltraggio al genio di Verdi ma, a ben guardare,
essa agì in assoluta buona fede e secondo motivazioni che sono, in parte, valide ancora oggi per
decidere se ammettere o meno un candidato in Conservatorio.
Anche allora, come oggi, si poteva derogare solo se il candidato mostrava di possedere qualità
eccezionali ma a nessuno dei commissari sembrava che Verdi ne possedesse, anzi, quelli che
balzavano agli occhi erano soprattutto i difetti di impostazione e le carenze nel contrappunto e
quei difetti in un diciannovenne sembravano del tutto irrimediabili.
A Milano Giuseppe era ospite del suo antico maestro, il canonico Seletti che si premurò di
riferire a Barezzi, nel corso di una lunga lettera, tutto quello che era successo all'interno delle
austere mura del Conservatorio cittadino. Barezzi, principale finanziatore dell'impresa milanese
di Giuseppe, avrebbe potuto decidere, a quel punto, di interrompere tutto e di richiamare il suo
protetto a casa dove, comunque, il futuro era assicurato. Tra Busseto e le Roncole Verdi era
qualcuno, lì godeva dell'apprezzamento di personaggi forse poco professionali e molto ingenui,
capaci però di intuire in quel giovane una capacità di invenzione musicale originale, anche se
non ancora espressa in modo logico e coerente. I suoi estimatori non ci avrebbero pensato due
volte a creargli tutte le condizioni di lavoro più favorevoli possibili: c'era la Filarmonica che lo
corteggiava, spesso anche bruscamente, per assicurarselo, c'era la chiesa che aveva bisogno di
un organista di talento e a nessuno importava di come Giuseppe mettesse le mani sulla tastiera
o se il suo contrappunto fosse debole e poco corretto dal punto di vista professionale. A loro
piaceva la musica di Giuseppe e mai nessuno, da quelle parti, aveva saputo scrivere come lui e
dare tanto lustro e tanta fama a quei luoghi. Barezzi, però, non era certo tipo da arrendersi: in
luglio, quando Giuseppe stava per cominciare le lezioni con il maestro milanese Lavigna, gli
fece avere in dono una spinetta. Quel gesto fu quasi simbolico: il talento del bambino Verdi
aveva cominciato a cimentarsi su una spinetta regalo di suo padre; ora Barezzi, padre- sostituto,
gli regalava nuovamente una spinetta quasi a sottolineare che quel talento, se c'era — e lui era
sicuro che ci fosse — aveva nuovamente uno strumento con il quale confrontarsi ed irrobustirsi.
Il talento musicale di Verdi non era di quelli assoluti e perfetti fin dall'infanzia, come quello di
Mozart; non si trattava di un genio precoce e indiscutibile ma era di quelli che si scoprono e si
svelano piano piano e, soprattutto, devono essere sollecitati dalla spinta giusta. Il teatro, le
qualità di grande drammaturgo che portarono Verdi alla fama in tutta Europa, non avevano
ancora fatto la propria comparsa nella vita del giovane Giuseppe che appariva come bloccato
nell'espressione di un talento che, mostrandosi a scintille, aveva accontentato ed esaltato i suoi
estimatori paesani ma, una volta sottoposto al giudizio di professionisti abituati ad apprezzare
la musica come discorso omogeneo e non come invenzione di idee, non aveva retto alla prova.
Giuseppe rimase a Milano, con la benedizione di Antonio Barezzi, a studiare con Lavigna per
sette anni, numero biblico, imparando, nonostante il gusto antiquato del suo maestro, cosa fosse
e come si scrivesse il contrappunto. Grazie a Lavigna Verdi non solo potè vedere molti spartiti e
partiture destinate alle rappresentazioni della Scala ma venne anche in contatto col palcoscenico
e con la preparazione degli spettacoli. In tutto il suo splendore gli si stava rivelando il mondo di
un grande teatro europeo.
Gli anni della formazione di Verdi, fra il 1830 ed il 1840, coincisero con l'inizio
dell'emancipazione del teatro italiano dalla presenza ingombrante di Rossini che nel 1829 aveva
prodotto la sua ultima opera teatrale, Guglielmo Tell, il cui secondo atto aveva inaugurato la
prospettiva del melodramma romantico in Italia. Erano sorti gli astri di Donizetti e Bellini i cui
capolavori erano stati rappresentati non solo alla Scala ma anche fuori dall'Italia se si pensa che
nel 1835 Bellini, morente, aveva fatto rappresentare a Parigi l'opera I puritani.
Era stato sancito il passaggio dalle rigidezze dell'opera seria settecentesca agli affiati romantici
nei libretti, nella struttura delle opere, nel canto stesso più impetuoso e legato all'azione. In un
momento particolare della situazione politica dell'Italia, particolarmente sentito dalla
Lombardia che, dopo il ciclone napoleonico, era tornata sotto il dominio dell'impero austro —
ungarico, le trasformazioni del melodramma rappresentavano una sorta di valvola di sicurezza
dalla quale far uscire tutte le tensioni legate al cambiamento della vita pubblica. La sfera degli
affetti riprendeva il sopravvento nei soggetti dei libretti che raccontavano quasi esclusivamente
di passioni amorose e di trasgressioni punite secondo l'etica della borghesia. Tutto ciò aveva
fatto di Milano il più importante centro musicale europeo dopo Parigi. Verdi si trovò
pienamente partecipe di quel clima infervorato che gravitava intorno alla Scala, tra gente di
teatro, musicisti, cantanti ed editori destinati ad essere famosi, anche nella rivalità, come
Giovanni Ricordi e Giovannina Lucca. Il giovane si era messo in luce tra i nobili milanesi
dilettanti di musica e cominciava a frequentare i circoli musicali. In questo ambiente si verificò
la classica buona occasione destinata a promuovere l'esordiente: nessuno dei tre maestri
convocati per dirigere La creazione di Haydn si presentò alle prove e Verdi fu pregato di
sostituirli. La prova e la successiva esecuzione ebbero successo ed il credito di cui il giovane
godeva presso i nobili milanesi aumentò al punto che cominciò una trattativa per un progetto
più interessante che dirigere un coro di nobili: si trattava di un libretto d'opera, forse con la
possibilità di rappresentare il lavoro al Teatro dei Filodrammatici. L'itinerario milanese di Verdi
si svolse insieme a quello bussetano e il giovane fu coinvolto tramite Barezzi, che non cessava
mai di cercare per il suo pupillo nuove e redditizie occasioni di lavoro, in una questione
complicata e noiosa.
Nel 1833, quando Verdi era a Milano da appena un anno, morì l'organista Ferdinando Provesi e
si aprì quindi la duplice prospettiva di impiego come organista nella chiesa parrocchiale e di
maestro di cappella presso il municipio di Busseto. Per un giovane come Verdi sarebbe stata
un'ottima sistemazione ma sulla successione a Provesi nacque una vera e propria faida di paese
perché per prendere il posto del defunto organista Verdi doveva completare gli studi e, secondo
Lavigna, sarebbe stato necessario almeno un altro anno. Antonio Barezzi, Penelope paesana, si
preoccupava di tenere il posto per il suo pupillo, spalleggiato in ciò dai soci della Filarmonica
che pagavano metà salario per quello che riguardava le funzioni di maestro di cappella. L'altra
metà del salario, invece, quella che remunerava le funzioni di organista, era corrisposta dalla
chiesa e siccome Provesi era stato fieramente anticlericale, le antipatie di cui egli era stato
oggetto si riversavano sul suo allievo. Si decise che il posto venisse messo a concorso ma sei
mesi dopo, improvvisamente, il consiglio della chiesa collegiata nominò un altro candidato e lo
fece accettare anche al municipio sapendo che Verdi non aveva ancora terminato gli studi e che,
dovendo scegliere, avrebbe preferito sicuramente Milano e il lavoro nel campo dell'opera. Le
proporzioni della contesa uscirono presto dai loro confini, sfociarono in atti di violenza e la cosa
finì al giudizio della duchessa Maria Luigia che si espresse in modo salomonico: la collegiata si
sarebbe tenuta il proprio candidato a cui non sarebbe stato corrisposto lo stipendio come
maestro di cappella. Il ducale verdetto che rimetteva a concorso il posto di maestro di cappella,
giunse a proposito, proprio quando Verdi ebbe completato gli studi e dovette tornare a Busseto
per onorare gli impegni presi a suo nome da Barezzi. Il posto di maestro di cappella non gli
interessava, come avevano pensato i consiglieri della collegiata, il suo pensiero era sempre
rivolto alle occasioni milanesi e cercò, come potè, di sottrarsi all'impegno, senza riuscirvi, dato
che nel 1836, superò l'esame ed ottenne il posto. In maggio sposò Margherita Barezzi e la portò
in viaggio di nozze a Milano dove riuscì a rinverdire le amichevoli relazioni contratte in
precedenza. Il ritorno a Busseto ed il lavoro come maestro di cappella non erano dei più
esaltanti anche perché il pensiero di Verdi era sempre a Milano ed al suo teatro. Resistette più
che potè poi, nel 1839, considerò saldato il debito di riconoscenza con Barezzi e si trasferì a
Milano. All'epoca del trasferimento a Milano Verdi aveva già conosciuto un acerbissimo lutto,
la morte, a poco più di un anno, della figlioletta Virginia, nata nel 1837. La sua famiglia contava
un altro figlio, Icilio, nato poco prima della morte della sorellina.
A Milano, nella primavera del 1839, erano cominciate le prove per quella che doveva essere
l'opera del debutto di Verdi sulla scena che contava, quella della Scala. Se l'opera era stata
messa in cartellone lo si doveva alle insistenze di una giovane ma già affermatissima cantante, il
soprano Giuseppina Strepponi che aveva usato tutta la sua influenza presso Bartolomeo
Merelli, il potente impresario che dirigeva, oltre la Scala, anche il teatro di Porta Carinzia a
Vienna. La prima dell'opera Oberto conte di San Bonifacio fu fissata per il 17 novembre 1839 ma
il 22 ottobre la sorte riservò al giovane musicista un altro colpo tremendo, la morte del piccolo
Icilio.
La vicenda umana di Verdi e della sua intelligente ammiratrice Giuseppina Strepponi erano
piuttosto simili: Verdi era rimasto solo con Margherita dopo la morte dei loro due bambini,
Giuseppina, invece, sola lo era proprio, nonostante la nascita di tre figli illegittimi, subito
affidati ad altri, ed una famiglia d'origine che contava sui suoi guadagni di cantante per
sbarcare il lunario. Giuseppina non godeva di una buona reputazione, come accadeva del resto
a molte sue colleghe, ma era una donna intelligente e colta e proprio la sua intelligenza la
rendeva quasi immune alle tante disgrazie che l'avevano colpita. Il suo fiuto, nel caso di Oberto,
si dimostrò provvidenziale: l'opera conobbe quattordici repliche, più di quanto aveva fatto
sperare la modesta accoglienza della prima; Giovanni Ricordi, capo della più importante
azienda editoriale milanese, stipulò un contratto per la pubblicazione della partitura e Merelli
impegnò Verdi per le tre opere successive.
All'esordio fortunato seguì il fiasco della seconda opera. Merelli aveva proposto a Verdi un
libretto di Gaetano Rossi, librettista famosissimo, autore di due capolavori rossiniani, Tancredi e
Semiramide. La scelta di Rossi che, nel frattempo, aveva aggiornato il proprio modo di scrivere
alla moda romantica degli anni Trenta, testimoniava la stima che Merelli coltivava nei confronti
di Verdi che, però, non gradì il libretto proposto. Merelli, allora, gli affidò un libretto comico, un
po' per esigenze di cartellone, un po' per l'idea, non del tutto superata, che un buon musicista
dovesse saper comporre musica su qualsiasi libretto e Verdi si confrontò con Il finto Stanislao di
Felice Romani, un altro illustre letterato che era stato collaboratore di Bellini, dirigeva la
"Gazzetta Letteraria Piemontese", era stato amico di Foscolo e Monti ed era anche stato
proposto per la carica di poeta cesareo a Vienna, esattamente com'era stato Metastasio. Nel
proporre a Verdi il libretto di Romani, Merelli gli cambiò il titolo in Un giorno di regno. A Verdi
quel libretto non piaceva ma si costrinse a finire la partitura, malgrado la morte di Margherita
per encefalite, il 20 giugno 1840. Al lutto di Verdi, ormai davvero solo, si aggiunse la delusione
per l'esito disastroso dell'opera andata in scena il 5 settembre di quell'anno. La conseguenza fu
un blocco creativo che paralizzò l'attività del musicista per un anno, fino a quando, una sera di
novembre del 1841, buttò sul tavolo il nuovo libretto che Merelli gli aveva consegnato. Il titolo
di quel libretto era Nabucco. Per Verdi l'incontro con il libretto del Nabucco ebbe il valore della
liberazione dalla crisi e non è difficile immaginare lo stato d'animo del musicista se si pensa che,
oltre ai lutti nella vita privata, gli era toccato anche di confrontarsi con il profondo dissidio tra
la sua vocazione teatrale, ormai consapevole, e le esigenze della produzione teatrale che stava
per soffocarlo nelle spire della routine. Le prime opere verdiane non sono opere brutte, sono
anonime perché ingessate nella tradizione del melodramma italiano fissata da Rossini. La
tradizione era stata ereditata senza problemi sia da Donizetti che da Bellini e, con loro, anche da
tanti altri. Si trattava di un percorso prestabilito di eventi scenici che dovevano porre in risalto
le situazioni drammatiche in cui si trovavano i protagonisti della partitura, normalmente
soprano, tenore, baritono e basso, con possibilità di un secondo soprano e di un secondo tenore
come comprimari. Il libretto organizzava questo schema, secondo un'azione teatrale unitaria,
ambientata in un'epoca ed in un paesaggio caratteristici, già presenti nella poesia, nella
narrativa, nel gusto letterario di moda dell'epoca. L'azione era fondata su alcuni emblemi
convenzionali nei quali si proiettava l'idea eroica che la borghesia aveva di se stessa e i cui
ingredienti erano passioni violente ed estreme che i librettisti esasperavano nella creazione di
personaggi assoluti. I musicisti dovevano adeguarsi attingendo ad un formulario musicale
molto ristretto il cui fondamento era il canto, strofico, dotato di precise simmetrie ed altrettanto
precise concessioni al virtuosismo dei cantanti, a cui era richiesto di definire un personaggio nel
suo carattere e nel suo comportamento in una determinata situazione drammatica.
Verdi accettava pienamente la tradizione drammaturgica italiana: in Italia non erano possibili
grandi cambiamenti e radicali trasformazioni, il clima culturale viveva nel rispetto
dell'accademismo e si teneva ben lontano dalla sperimentazione. L'avanguardia artistica in
Italia non esisteva ed era considerato disdicevole cercare forme nuove: così era stato in
letteratura ed il romanticismo italiano divergeva da quello tedesco o francese proprio per il suo
atteggiamento cauto nei confronti dello sperimentare e si distinse per l'abilità degli scrittori
nell'adattare le forme tradizionali alla nuova sensibilità. Per un genere come il melodramma,
che sopravviveva grazie all'approvazione che il pubblico concedeva seduta stante, dove il
lavoro di mesi si verificava nel giro di una serata, non esisteva altra possibilità che rispettare la
tradizione, anzi di blandire le aspettative del pubblico presentando libretti legati alla
convenzione, la stessa che regolava il canto ed i suoi virtuosismi. Quello era il prezzo che Verdi
si disponeva a pagare nel corso della sua carriera pur di riuscire a realizzare una forma
drammatica senza nessun disegno preordinato. La storia della carriera di Verdi sta tutta nella
lotta tra la volontà di accettare i modelli e la volontà di ricavare qualcosa di nuovo dai loro
schemi. Le idee drammaturgiche di Verdi non erano originali, ma correnti nella cultura italiana
ed europea e si potevano riassumere in un solo nome, Shakespeare, la cui scoperta, da parte del
romanticismo italiano aveva rivoluzionato il teatro destinato ad esporre sulla scena la
complessità della vita e delle passioni umane. La varietà e la verità che Verdi trovava nel
dramma shakespeariano, soprattutto da quando era diventato amico di Filippo Carcano,
traduttore ufficiale del drammaturgo inglese, significavano l'adesione ad una sorta di
naturalismo che approfondisse il senso dell'animo umano e permettesse di costruire un
personaggio in tutte le sue sfumature, nella sua versatilità dal male al bene, nelle sue reazioni
alle passioni ed alle sventure. Per attuare questa concezione Verdi doveva sradicare le
convenzioni approvate dal pubblico del quale era però necessario il consenso. In Italia,
diversamente da quel che accadeva in Francia dove un'opera rimaneva in cartellone per mesi, se
non per anni, e consacrava il suo autore, gli operisti erano sempre esposti al giudizio del
pubblico ed il successo di un'opera, dato che i cartelloni si rinnovavano continuamente, non
garantiva il suo autore che poteva benissimo essere stroncato dalla rappresentazione successiva.
Il processo di sradicamento che Verdi aveva in mente, stando così le cose, non poteva che essere
lento e graduale, non ci si poteva permettere di operare nel vuoto eccessivo- che un eccessivo
strappo alle regole avrebbe creato.
Nel momento in cui Verdi accettò Nabucco non trapela alcunché di questa complessità; relativo
a quel periodo c'è solo il racconto scritto nel 1879 per gli scopi pubblicitari di Casa Ricordi, dal
quale risulta che non fu Verdi a scegliere il libretto ma piuttosto che egli fu scelto da quel
libretto. Al di là del racconto romanzato che tende a costruire un piccolo mito sulla genesi
dell'opera, Verdi fu categorico su un punto: l'intuizione folgorante suggeritagli dal soggetto
biblico e, soprattutto, dal verso Va' pensiero sull'ali dorate nel coro degli ebrei esuli e prigionieri.
Sembrerebbe che Verdi avesse voluto indicare che fu proprio quella dimensione corale a dargli
il vero significato per Nabucco, confermato poi a posteriori dal giudizio del pubblico, ma c'è
anche altro. Il soggetto biblico di Solera gli suggerì un'immagine solenne di popolo e
l'immagine influì sul suo modo di utilizzare il coro, di organizzare il linguaggio dei protagonisti
e persino l'orchestrazione. Si trattò, in sostanza, di sostituire alle passioni care alla borghesia
ammiratrice di Bellini e Donizetti una dimensione austera e contemporaneamente
monumentale radicata nella fantasia del popolo e Verdi poteva prendere a modello soltanto il
popolo che conosceva, vale a dire il proprio, portando il gusto popolare per il melodramma,
quello che aveva conosciuto fin da bambino, sul palcoscenico della Scala.
Il libretto di Nabucco racconta un intrigo alla corte di Babilonia tra due popoli: uno vittorioso, gli
assiri, l'altro ridotto in schiavitù, gli ebrei. La diversità tra i due popoli è rappresentata dalla
religione: da una parte l'idolo assiro Belo, dall'altra la suprema ed invisibile forza di Jeova. La
soluzione del conflitto viene dal colpo di scena imposto da Jeova, il deus ex machina caro
all'opera del Settecento. Fino a qui arrivano le somiglianze con il Mosè di Rossini.
L'intrigo pone i personaggi su tre piani diversi: quello più evanescente è rappresentato dalla
coppia Ismaele, tenore, e Fenena, soprano, i "primi amorosi" secondo lo stile melodrammatico
dell'epoca, a cui Verdi dedicò poca attenzione; i personaggi più corposi sono il sacerdote
Zaccaria, basso, ed il re Nabuccodonosor, baritono, espressione della sorte dei rispettivi popoli
e, per quanto riguarda il re, di una tragedia personale che lo induce a cambiare campo da quello
assiro a quello ebreo mediante la conversione; infine Abigaille, soprano, l'eroina negativa che
conoscerà la sconfitta politica e la morte, non prima, però, di essersi pentita. Il coro, nel libretto
di Solera, rimane allo stadio di ipotesi, ben diverso da quello che diventerà nella realizzazione
musicale di Verdi.
Lo svolgimento e lo sviluppo del libretto sono tipici dell'opera seria, con il pentimento e la
morte dell'eroe negativo, in questo caso Abigaille, posti ad edificazione degli spettatori. Per un
pubblico memore del Mosè di Rossini Verdi sviluppò la vicenda in modo inatteso; dotando per
esempio Abigaille di un ruolo tradizionale, addirittura antiquato e sviluppando tutto il resto
dell'opera in modo molto originale. La parte di Abigaille riscrive nelle sue fioriture, nelle
cadenze, nei grandi intervalli, il bel canto settecentesco secondo il gusto dell'Ottocento.
Abigaille nasce dalla tradizione aristocratica dell'opera seria: questa implicava, per
convenzione, che il personaggio tragico dovesse avere un ruolo altamente virtuosistico e la finta
principessa Abigaille spicca su tutti per questa impronta aristocratica.
I cori sono in stile omofono, quando non all'unisono, come si sente cantare nei cori di paese; la
tessitura rinuncia alla polifonia, anche a quella estremamente semplificata per l'uso teatrale ma
assume l'andamento della canzone. Lo stesso tono hanno le parti di Zaccaria e Nabuccodonosor:
le loro parti sono dotate di una melodia ampia, piana, quasi declamatoria come si addice a chi
voglia farsi intendere dalle anime semplici. Nel momento del conflitto e del dramma si affaccia
un procedimento, ancora in embrione, che Verdi riserverà alle voci virili gravi, quello dei
recitativi molto articolati affidati alle voci di baritono e basso.
Il Nabucco, comunque, non è il dramma dei personaggi ma un affresco corale dove il livello più
alto è raggiunto dalla massa corale del popolo ebraico: i personaggi, come tali non vivono
perché la loro vicenda personale è come schiacciata sullo sfondo di un'altra, ben più grande, che
è la liberazione di un popolo oppresso e schiavo.
1.2. Fenena!!... O mia diletta!
(Nabucco, parte prima, Gerusalemme, scena quarta)
Sullo sfondo del successo di pubblico e di critica ottenuto dal Nabucco si staglia ancora
Giuseppina Strepponi 6, grande esti6 Su Giuseppina Strepponi si veda G. Servadio, Traviata. Vita di Giuseppina Strepponi Verdi, Milano: Rizzoli, 1994.
matrice di Verdi fin dai tempi di Oberto, che, prima interprete di Abigaille, diede al
personaggio quel poco che ormai restava della sua voce.
Nabucco era pronto per andare in scena già alla fine del 1841 ma Merelli non l'aveva messo nel
cartellone della Scala. Verdi protestò vivacemente con l'impresario che, probabilmente scottato
dall'insuccesso di Un giorno di regno, non nutriva più molta stima per Verdi e, soprattutto, non
voleva ripetere un cattivo affare puntando troppo su un giovane autore. Alle proteste di Verdi
Merelli rispose che avrebbe accolto l'opera a condizione che si fossero accettati scenografie e
costumi di un balletto sul medesimo argomento, già rappresentato anni prima e che la parte di
Abigaille fosse sostenuta da Giuseppina Strepponi. La cantante, ormai in declino a causa della
salute malferma, aveva bisogno di lavorare ma il fatto che stesse perdendo sia la voce che la
presenza scenica non sfuggiva certo ai compositori che non la gradivano più come interprete.
Verdi face ascoltare a Giuseppina lo spartito dell'opera e lei la volle assolutamente per il proprio
debutto nella stagione successiva. Giuseppina, per l'occasione, volle assicurarsi la
partecipazione di Giorgio Ronconi, suo amico e compagno d'arte, grande baritono che, a suo
tempo, aveva apprezzato Oberto. Ronconi accettò ed ebbe la parte di Nabuccodonosor. Con
l'appoggio dei due cantanti, Verdi ottenne che Merelli includesse Nabucco in cartellone, prima
recita il 9 marzo 1842. Il successo dell'opera fu senza precedenti e non riguardò tanto i cantanti,
che pure vennero applauditi, ma proprio l'opera in sé tanto che il bis venne chiesto e concesso
per il brano corale «Va' pensiero». Il pubblico e la critica capirono che quella sera si era
presentato un modo nuovo di concepire il melodramma, benché nessuna delle sue regole
fondamentali fosse stata infranta.
Gli effetti immediati di quell'enorme successo furono che, a 29 anni, Verdi diventò un uomo alla
moda e venne ammesso nei salotti che contavano, in particolare in quello della contessa Clara
Maffei, con la quale mantenne sempre un rapporto privilegiato. Da ultimo, ottenne che Merelli
lo mettesse sotto contratto per l'opera d'obbligo della stagione successiva. La riga del compenso
era stata lasciata in bianco perché il compenso sarebbe stato stabilito dallo stesso autore. In
soccorso di Verdi che non sapeva quanto chiedere giunse il consiglio di Giuseppina Strepponi la
quale suggerì di chiedere quanto era stato corrisposto a Bellini per Norma, cioè seimilaottocento
lire. Per quella cifra Verdi si mise al lavoro per l'opera d'obbligo su un altro libretto di
Temistocle Solera intitolato I Lombardi alla prima Crociata.
Solera era un personaggio a dir poco stravagante: quasi venne alle mani con Verdi quando
questi lo obbligò a rimanere chiuso in una stanza finché non avesse apportato al libretto di
Nabucco le modifiche ritenute necessarie. Solera venne accusato di plagio per il libretto di
Nabucco ed anche per i Lombardi che avevano, però un modello dichiarato: un poema di
Tommaso Grossi apparso a Milano nel 1826.
La fonte italiana, dato che i librettisti in genere si rifacevano ad opere inglesi o francesi, era una
novità ma non portò bene all'opera perché, in mancanza di una traccia teatrale evidente, Solera
procedette ad un lavoro autonomo di sceneggiatura da cui uscì uno dei libretti più difficili da
seguire che Verdi avesse mai messo in musica. La prima rappresentazione, l'11 febbraio 1843,
fece seguito agli intoppi della censura preoccupata da quella mescolanza di sacro e profano e
dalla possibilità di entusiasmi troppo accesi da parte di coloro che sognavano la cacciata degli
austriaci dalla Lombardia. La perseveranza di Verdi ebbe la meglio: il pubblico riservò alla
nuova opera un successo anche maggiore di quello tributato al Nabucco. La critica, invece, fu
piuttosto tiepida.
L'impresa che il musicista si proponeva con I Lombardi era quella di fornire un vasto affresco
epico e storico, probabilmente pensava al grand-opéra francese in cui il clima storico, le
avventure, i virtuosismi erano di grande importanza e non fu un caso che quando gli fu chiesto
di fornire un lavoro all'Opéra di Parigi egli scegliesse proprio I Lombardi, rimaneggiando l'opera
e cambiandone il titolo in Jérusalem.
Non è affatto escluso che, dopo il successo di Nabucco, Verdi accarezzasse l'idea di proporre la
sua nuova opera sul mercato francese che tanto bene aveva accolto Rossini e Donizetti,
Mercadante e Bellini. Tali pensieri di natura commerciale non erano estranei al Verdi giovane,
non tanto per venalità, quanto perché il riconoscimento economico rappresentava anche il
riconoscimento artistico del suo valore di musicista. Al di là del modello di Nabucco,
specialmente per i cori, il modello, la fonte di ispirazione di Verdi per i Lombardi è proprio
Donizetti.
Nella leggenda verdiana si vuole che Nabucco e i Lombardi siano state rappresentazioni
fondamentali per il risveglio della coscienza risorgimentale italiana, ma non è vero, non tanto
perché sono opere dedicate a due sovrane, Adelaide d'Austria e Maria Luigia di Parma, quanto
piuttosto perché negli anni in cui vennero composte il sentimento patriottico era un fuoco
tutt'altro che divampante.
Il patriottismo che faceva fremere i cuori italiani e vergare alle mani il famoso "W VERDI" che
campeggiava sui muri, nacque più tardi, alla vigilia della seconda guerra d'indipendenza.
Nonostante nel 1859 fossero passati dodici anni dal Nabucco, i patrioti attribuivano a Verdi una
sorta di precoce ispirazione profetica che lo aveva guidato soprattutto nella composizione di
«Va' pensiero».
Le due opere ebbero un grande diffusione e sembra che non si facesse distinzione al momento
di metterle in cartellone, malgrado il diverso valore e le differenze oggettive, la principale delle
quali consiste nel fatto che pur accogliendo la formula corale e monumentale del Nabucco, i
Lombardi rappresentano una sorta di passo indietro del musicista che aveva abbandonato la via
del grande affresco popolare per un ritorno al gusto ed ai valori della borghesia: Verdi aveva
colto il momentaneo gusto del pubblico conciliando l'originalità del Nabucco con le esigenze
della moda. Verdi aveva ottenuto un successo sufficiente a collocarlo tra i massimi compositori
italiani e, a parte Rossini, che lo ammirava e lo aveva accolto con entusiasmo quando l'ormai
azzimato giovane bussetano si era recato a Bologna per ascoltare lo Stabat Mater del maestro
pesarese, l'unico che potesse oscurare il suo astro nascente era Donizetti.
Le numerose repliche dei suoi lavori condussero Verdi per la prima volta fuori dall'Italia, a
Vienna, al Teatro di Porta Carinzia, per la rappresentazione del Nabucco e, soprattutto,
indussero il presidente del Teatro La Fenice di Venezia, conte Mocenigo, a proporgli di
comporre l'opera d'obbligo per la stagione 1844.
Ambiziosamente Verdi aveva pensato ad un Re Lear di Shakespeare su libretto di Felice
Romani, poi accettò un dramma di Victor Hugo che passava per un succedaneo di Shakespeare
se non altro perché nel 1830 Hugo a Parigi era stato il portabandiera dei principi teatrali che
andavano di moda nella scuola romantica europea e si richiamavano a Shakespeare in funzione
anticlassicista.
Al posto dell'opera Cromwell che il poeta del teatro, Francesco Maria Piave, aveva già pronta,
Verdi impose Ernani. La collaborazione con il giovane ed inesperto Piave, che fu a lungo il
librettista preferito di Verdi, pose alcuni problemi dati i diversi livelli di esperienza teatrale tra i
due ma Piave mostrò subito alcune delle doti che non potevano non far colpo su un uomo come
Verdi: mansuetudine, sottomissione e, soprattutto, pronta comprensione di ciò che Verdi
voleva. Il sodalizio con Piave si interruppe poche volte durante l'attività all'estero del musicista
che lo riutilizzò nel 1861 per La forza del destino dal momento che Piave era l'unico, tra l'altro,
capace di intendere un progetto tra tradizione e progresso.
Con Ernani iniziò l'abitudine mai più dismessa in seguito da Verdi di seguire personalmente
tutte le fasi dell'opera, dall'allestimento alla scelta dei cantanti, dall'orchestra alle prove.
Nonostante a Venezia Verdi non si fosse trovato bene, l'opera andò in scena il 9 marzo 1844 e
registrò un successo modesto. Verdi amava la varietà e la ritrovava in Shakespeare ma amava
anche il melodramma italiano, con le sue regole e le sue convenzioni che si ritrovano nel libretto
di Ernani: Verdi fece comporre a Piave un libretto che conteneva tutte le convenzioni
melodrammatiche di moda negli anni Trenta, fondate su eroismo, passioni e morte.
Con Nabucco Verdi si era staccato da esse ma le aveva recuperate con i Lombardi e fa proprio il
passaggio attraverso quest'opera che convinse Verdi che il problema dei melodramma a
personaggi e non a situazioni andava definitivamente affrontato e risolto. Il segreto stava in una
partitura musicale la cui efficacia dipendesse dal ritmo nel quale le varie sezioni si
susseguivano; il libretto doveva seguire la musica in un'architettura esemplare. Da questo
punto di vista Ernani non è soltanto il manifesto di un programma tutto musicale, nato da una
profonda riflessione sul melodramma, ma è il capolavoro del giovane Verdi. Le opere
successive sono il frutto di un delicato gioco di equilibrismo tra il conservatorismo e la
sperimentazione la cui punta massima è Macbeth, composto nel 1847: finalmente Verdi poteva
misurarsi con Shakespeare.
Ancora prima della rappresentazione di Attila alla Fenice di Venezia nel 1846, Verdi era stato
oggetto di attenzioni piuttosto pressanti, ancorché lusinghiere, da parte di impresari ed editori
stranieri: Léon Escudier acquistò per la Francia i diritti di traduzione delle opere passate e
future mentre l'impresario del londinese Her Majesty's Theatre accarezzava l'idea di poter
rappresentare almeno dieci opere. Verdi era a passare le acque, come si dice, a Recoaro e nella
cittadina termale dove si era recato un po' per riposare ed un po' per rimettere in sesto una
salute non eccellente, godette della compagnia del letterato conte Andrea Maffei. Durante quel
soggiorno, dalle conversazioni con Maffei prese forma il progetto di Macbeth assieme a quello
dei Masnadieri, su soggetto di Schiller. La sfida era interessante e i due se la divisero: Maffei si
sarebbe confrontato con Schiller per trarre un libretto e Verdi, insieme a Piave, avrebbe dato
vita ad un'opera dall'amato Shakespeare.
Tra settembre e dicembre del 1846 Verdi si dedicò a comporre la musica per i Masnadieri, salvo
poi interrompere a metà il lavoro per dedicarsi a Macbeth sul cui libretto Piave stava già
lavorando da mesi, continuamente tiranneggiato da Verdi che non perdeva occasione per
ricordargli che stava lavorando su un capolavoro e che per renderlo in modo appropriato ci
sarebbe voluta la penna di Vittorio Alfieri.
Secondo la sua consuetudine Verdi dedicò una cura quasi maniacale all'allestimento: voleva
evitare l'approssimazione e diede il tormento agli scenografi affinché si documentassero sulle
scene degli spettacoli shakespeariani dati a Londra, ai sarti affinché evitassero l'uso di sete e
velluti che mal si conciliavano con l'abbigliamento della Scozia dell'XI secolo, agli orchestrali
affinché rendessero con esattezza le sfumature sonore che caratterizzavano i personaggi.
Un'altra esigenza fondamentale di Verdi rispetto all'opera fu lo stile del canto: alla prima al
Teatro della Pergola di Firenze nel 1847, la protagonista femminile doveva essere la bellissima
soprano Eugenia Tadolini. Nel disapprovare la scelta della cantante Verdi diede una definizione
fondamentale della sua Lady Macbeth «La Tadolini ha una figura bella e buona, ed io vorrei
Lady Macbeth brutta e cattiva. La Tadolini canta alla perfezione ed io vorrei che Lady non
cantasse. La Tadolini ha una voce stupenda, chiara, limpida e potente; ed io vorrei in Lady una
voce aspra, soffocata e cupa. La voce della Tadolini ha dell'angelico; la voce di Lady vorrei che
avesse del diabolico»'. Nello spettacolo di Firenze, che ebbe una tiepida accoglienza, la parte fu
assegnata ad una cantante di straordinaria intelligenza ma di aspetto indiscutibilmente brutto:
Marianna Barbieri-Nini.
Il canto in Macbeth esce dalla convenzione e si presenta come espressione immediata di stati
d'animo, svelando recessi della psiche nei suoi aspetti più oscuri della menzogna e del delitto. Il
canto è il fondamento del melodramma italiano e mai Verdi avrebbe permesso che la sua
ricerca, la sua convinzione di aver interpretato davvero Shakespeare fosse compromessa da
un’approssimazione già evidente dalle fondamenta.
2
La Trilogia popolare
2.1. Amami, Alfredo, quant'io t'amo...
(La traviata, atto II, scena VI)
Nel settembre del 1849, mentre l'estate scivolava dolcemente verso un autunno dorato, una
carrozza si fermò all'ingresso di palazzo Dordoni a Busseto dove Verdi, fin dal 1845, aveva
fissato la propria residenza. Dalla vettura scesero il musicista e la signora Giuseppina Strepponi;
insieme entrarono in casa.
Quel gesto sanciva l'unione, proprio nel luogo che aveva visto il matrimonio di Verdi con
Margherita Barezzi tredici anni prima. Le relazioni con la famiglia Barezzi, in particolare con il
patriarca Antonio che allora era ancora vivo e vegeto, furono cordialissime: evidentemente
Verdi e la Peppina, come da allora venne chiamata Giuseppina Strepponi, avevano fatto in
modo di essere discreti per non offendere il ricordo della defunta Margherita ancora vivo nella
memoria dei suoi familiari.
Giuseppina era l'esatto contrario della Barezzi, la moglie fanciulla ingenua e devota che il suo
stesso padre aveva ricordato nell'elogio funebre per le sue doti di madre e compagna,
dimenticando che la figlia era, prima di tutto, una persona, una donna. Giuseppina aveva una
personalità ben precisa, era più adulta di Margherita sia per età che per esperienze, conosceva
benissimo il mondo in cui Verdi si muoveva perché era stato il suo stesso mondo per anni,
prima che le traversie patite, le gravidanze e le fatiche di un mestiere che non le dava riposo
neppure mentre era incinta, le togliessero la voce. Dedicandosi completamente a Verdi, spesso
Giuseppina riuscì con intelligenza ad imporre la propria personalità, a far accettare al "Mago",
come chiamava il compagno, il proprio parere ed i propri consigli.
Verdi, pur essendo per natura un uomo di carattere brusco e sospettoso, aveva chiesto ed
accettato molte volte, specialmente in gioventù, i consigli di Giuseppina: la gente di teatro non
gli piaceva granché ma si era rassegnato a viverci e gli era sembrata cosa rara e preziosa aver
trovato proprio in mezzo a loro un'amica tanto saggia e disinteressata, tanto propositiva e
positiva nonostante le vicissitudini alle quali la vita l'aveva sottoposta. Per anni si erano persi di
vista, lui alle prese con una carriera che stentava a decollare, lei insegnante di canto a Parigi,
dove si era recata a vivere, con raccomandazione di Verdi per gli amici Escudier, dopo l'addio
definitivo alle scene.
La composizione di Macbeth aveva distolto Verdi da quella dei Masnadieri alla quale, però, tornò
in gran fretta per onorare gli impegni presi sia con l'impresario londinese Lumley che con gli
editori Lucca, entrambi amici di Giuseppina Strepponi: probabilmente Verdi cominciava ad
essere un po' stanco della routine italiana e magari accarezzava il sogno di trasferirsi all'estero,
Londra o Parigi, come avevano già fatto Rossini, Bellini e Donizetti ottenendo successi e
fortuna, tanto che progettò di accettare impegni con Lumley per opere future mentre stava già
prendendo accordi con l'Opéra di Parigi per la rappresentazione dell'opera che stava traendo
dalla rielaborazione dei Lombardi.
Non è impossibile pensare che Giuseppina avesse persuaso Giuseppe che la Francia sarebbe
stata per entrambi una patria più ricca di soddisfazioni e che lo avesse aiutato, come del resto
aveva già fatto in precedenza, tessendogli intorno una sorta di rete di relazioni importanti ed
influenti. Sulla via del ritorno da Londra, sul finire del 1847, Verdi passò per Parigi a salutare
Giuseppina. Fu un saluto piuttosto lungo tanto che gli amici italiani del musicista non
riuscivano a capire le ragioni di quel trattenersi nella capitale francese dalla quale egli
annunciava il ritorno per poi differirlo ogni volta. Per un uomo pratico come Verdi i sentimenti
ed il lavoro andavano di pari passo e se i sentimenti portavano il nome di Giuseppina, il lavoro
significava approfittare della permanenza parigina per cercare di stringere il più possibile
legami contrattuali con l'Opera.
Gli eventi privati, ad un certo punto, si intrecciarono con quelli pubblici: nel febbraio del 1848
Verdi assistette alla rivolta di Parigi, in marzo ci furono le Cinque Giornate di Milano che fecero
scoprire a Verdi una sconosciuta passione repubblicana, alimentata anche dalla conoscenza con
Mazzini fatta a Londra l'anno precedente.
Arrivato a Milano in aprile, forte di questi nuovi sentimenti, scrisse a Piave, che si era arruolato
volontario, una lettera entusiastica1, grondante di retorica patriottica, supportata anche
dall'entusiasmo antiaustriaco di Giuseppina. Fu in quell'occasione che Verdi inviò a Mazzini
l'inno «Suona la tromba», su versi di Goffredo Mameli, che si augurava sarebbe diventato la
«Marsigliese» italiana2.
Da Milano Verdi andò a Busseto, dove comprò il podere di Sant'Agata, poi si mise di nuovo in
strada per tornare a Parigi, da dove partì per raggiungere Roma perché lì, alla fine di gennaio
del 1849, si sarebbe rappresentata La battaglia di Legnano. Roma sembrava un altro mondo: era
stato cacciato il papa dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi, l'uomo forte che Pio IX aveva voluto
a capo del governo; la febbre romana era arrivata a Venezia dove, dopo la rivolta, era nata la
repubblica sotto la guida di Daniele Manin.
Ma nel 1849 tutte le speranze crollarono; l'esercito di Carlo Alberto fu sconfitto a Novara ed il
sovrano fu costretto ad abdicare, le repubbliche di Roma e di Venezia furono costrette a cedere
agli eserciti stranieri. Giuseppe e Giuseppina decisero che non potevano più restare nel paese il
cui esercito aveva cancellato il sogno della repubblica romana e tornarono in Italia.
A Parigi Verdi aveva composto La battaglia di Legnano, l'unica vera opera nata sotto l'influsso del
Risorgimento.
A partire da quando Verdi aveva iniziato la sua attività come operista, il melodramma italiano
aveva iniziato una lenta
1 Ivi,
2
p. 31.
Ivi, p. 35.
ma inesorabile fase di invecchiamento nella sua forma canonica quella, per intenderci, di
Rossini, Bellini e, soprattutto, Donizetti, devoto continuatore ed amico personale del maestro
pesarese. Il melodramma, inteso in quella forma, non era più adatto ad esprimere le esigenze e
le aspirazioni di una società che si avviava dalla Restaurazione al Risorgimento e che stava
realizzando, sia pur faticosamente, aspirazioni un tempo soltanto immaginate. La principale, tra
queste, era quella di realizzare l'unità politica italiana e l'indipendenza dalle potenze straniere
ed i personaggi del melodramma rappresentavano il sogno irrazionale ed accademico di una
società poco attiva sul piano della politica.
A questa insufficienza del melodramma, non particolarmente patita da Verdi, se ne aggiunse
un'altra che lo coinvolgeva di più: era la struttura stessa del melodramma, il suo procedere
secondo gli schemi oramai consolidati dalla convenzione, quel suo mettere in scena personaggi
svuotati di spessore umano a metterlo in crisi in quanto risultavano sempre meno adatti a
veicolare la sua visione del mondo fondata sul pessimismo circa la natura umana, portata a
rivelarsi come buona o cattiva sotto l'azione scatenante di passioni primordiali. La convinzione
che il male prevalga sul bene fece in modo che Verdi diventasse un drammaturgo portato a
trasfondere nella sua arte una forte carica morale, del tutto diversa dal moralismo imperante del
tempo che si mostrava nel melodramma.
Il rigore di questa posizione si attenuò soltanto con gli anni, tuttavia il melodramma del primo
Ottocento non era certo in grado di trasmettere ed esprimere una concezione così totalitaria, in
cui arte e vita erano strettamente intrecciate. Verdi era per natura un conservatore e, se così non
fosse stato, la sua carriera sarebbe probabilmente durata lo spazio di una sera, ma cercava il
modo per svincolarsi dalle condizioni oggettive del teatro del suo tempo e si ha la sensazione
che la crisi giovanile non fosse dovuta soltanto alla ricerca di un linguaggio e di una
drammaturgia originali ma alla ricerca del nesso profondo tra arte e morale, per sostituire al
tono favoloso del melodramma la descrizione realistica della condizione umana. Macbeth si pose
come chiave di volta in questa ricerca. La battaglia di Legnano, composta sotto l'urgenza della
spinta patriottica che per Verdi voleva dire rinunciare alle vicende storico-sentimentali rarefatte
e trovare un solido aggancio all'attualità, è un'opera che fa un po' il riassunto di molti spunti già
proposti, dai cori popolarescamente omofoni di Nabucco a certi episodi virtuosistici alla
Donizetti, dalle tenerezze belliniane ad accenni di ballabile. Dal baule dei trucchi del mestiere
Verdi però estrasse delle frasi improvvise, appassionate e drammatiche. La battaglia di Legnano
riportava Verdi alla propria identità che era stata quella popolare ai tempi del Nabucco ed ora
era quella borghese e rivoluzionaria infiammata dall'idea di nazione e se il pubblico romano
chiedeva, ad ogni rappresentazione, la replica dell'ultimo atto, era perché aveva capito che
quella musica portava passioni nuove, disprezzando i formalismi.
Se di regresso si trattava, esso non riguardava la sfera artistica inoltre, dal punto di vista
personale Verdi ricominciava ad essere un uomo sereno dato che aveva ricostruito la stabilità
della propria vita accanto a Giuseppina, otto anni dopo la morte di Margherita Barezzi, dopo
conflitti e tormenti relativi al nuovo rapporto.
2.2. ... tutto il mondo è tal figlia per me
(Rigoletto, atto II, scena IV)
Il problema della paternità era stato molto presente nella vita di Verdi: da giovane aveva perso
uno dopo l'altro i due figlioletti in tenerissima età e la sua stessa infanzia era stata complicata
dalla presenza di un padre verso il quale provava sentimenti ambivalenti e che nutriva verso di
lui sentimenti molto complessi che andavano dalla stima al senso del possesso ed alla
conseguente ostentata disistima per quel figlio dal quale non voleva assolutamente sentirsi
messo in ombra. Il rapporto fu presto complicato dalla presenza di Antonio Barezzi, generoso
mecenate, che si assunse però il ruolo di padre sostituto non solo prendendo decisioni
importanti e significative per il proprio protetto ma portandolo addirittura a vivere nella
propria casa.Verdi visse questo rapporto affettivo con Barezzi in maniera davvero filiale, tanto
da dedicargli l'opera Macbeth con parole che non lasciano dubbi «Da molto tempo era ne' miei
pensieri d'intitolare un'opera a Lei che m'è stato padre e benefattore, ed amico [...] Ora eccole
questo Macbeth che io amo a preferenza delle altre mie opere, e che quindi stimo più degno
d'essere presentato a Lei.»3.
Nessuna meraviglia, quindi che le opere di Verdi siano piene di conflitti resi in modo
mirabilmente toccante tra genitori e figli, soprattutto tra padri e figli
Il primo padre che trova luogo nell'opera verdiana è Rigoletto.
Verdi, pur essendo addirittura ossessionato da Shakespeare, amava molto anche Victor Hugo.
Si entusiasmò per un dramma del francese dal titolo Le Roi s'amuse, destinato a diventare
Rigoletto e, per il momento, si tuffò a capofitto in quell'idea al punto da accantonare un dramma
spagnolo, El Trovador, per 1'Opéra di Parigi.
La commissione per il nuovo dramma veniva dalla Fenice di Venezia ed era perciò logico che il
libretto venisse affidato a Piave, che a Venezia era di casa.
Nel novembre 1850, di ritorno da Trieste dove era andato in scena Stiffelio, Verdi ebbe una
sorpresa che dire sgradevole sarebbe poco: la censura veneziana, nella persona dell'autorevole
governatore militare Gorzowski non si fece scrupolo di denunciare la scelta del soggetto
francese come immorale e ributtante. Quello che Gorzowski trovava insopportabile era il
comportamento ribelle di Rigoletto verso il suo sovrano, fosse pure un dissoluto come quello
descritto nel libretto, l'acquiescenza di Gilda alle immorali profferte di costui ed il quasi suicidio
della ragazza nell'ultimo atto. Inoltre la censura trovava
3 Ivi, p. 23.
improponibili un gobbo come protagonista di un'opera ed una ragazza agonizzante in un sacco.
Verdi sapeva benissimo a quali difficoltà sarebbe andato incontro scegliendo come soggetto il
dramma di Hugo che era stato proibito già in Francia, figuriamoci in Italia, tuttavia si era messo
al lavoro senza avere la minima garanzia che da parte della censura non ci sarebbero stati
problemi. Piave, dal canto suo, aveva cercato di ammorbidire i rapporti con la censura
modificando il libretto secondo le indicazioni ricevute; quel che ne risultò fu un'altra cosa
rispetto al progetto originale e la cosa fece andare su tutte le furie Verdi che, presa carta e
penna, scrisse, il 14 dicembre 1850, a Carlo Marzari, presidente del teatro La Fenice, esprimendo
tutto il proprio sdegno per quello snaturamento e concludendo con le parole «In coscienza
d'artista io non posso mettere in musica questo libretto»4.
Quando tutto sembrava perduto, la censura veneziana cedette ed accettò il libretto originale
accontentandosi che fossero modificati nomi ed ambienti. Fu il segretario della Fenice a
sottoscrivere, agli sgoccioli dell'anno, l'accordo con Verdi e Piave ed il definitivo placet da
Vienna giunse in gennaio dell'anno seguente.
Il lavoro di Verdi su Rigoletto fu molto convulso; il maestro si era ridotto all'ultimo momento ed
era così in ritardo da essere provvidenzialmente soccorso dal fatto che un'opera di Malipiero,
difficile da imparare per i cantanti, avesse subito uno slittamento rispetto alla data prevista per
la rappresentazione, slittamento del quale beneficiò Rigoletto che andò in scena l'll marzo 1851.
Fu un enorme successo, destinato a ripercuotersi in maniera decisiva sulla fama di Verdi in
Europa, non soltanto sotto l'aspetto musicale ma anche letterario: Rossini abbandonò tutte le
proprie riserve sul genio verdiano e Hugo, sia pure a malincuore, riconobbe che il proprio
dramma aveva fatto soltanto da supporto a quel capolavoro. Tali riconoscimenti
4 A. Oberdorfer (a cura di), Giuseppe Verdi. Autobiografia dalle lettere, Milano: Rizzoli, 2001, pp. 364 — 365.
sancivano una trasformazione rilevante del teatro verdiano e lo stesso Verdi ne doveva essere
consapevole, dato che aveva lottato fino all'ultimo per mantenere il libretto così com'era
arrivando ad invocare la propria coscienza d'artista. La ragione di tanta lucida consapevolezza
sta nel fatto che Verdi aveva trovato la chiave giusta per passare dal melodramma corrente
nell'epoca ad un vero e proprio dramma in musica; inoltre questa chiave consentiva a Verdi di
restare nell'ambito della struttura tradizionale del melodramma italiano, di conservarne il
carattere fondato sulla vocalità e, nello stesso tempo, di esprimere il proprio concetto di
drammaturgia così come si era andato evolvendo in anni di esperimenti e tentativi. Il
personaggio di Rigoletto gli aveva offerto la possibilità di ampliare il proprio pensiero sul bene e
sul male che compongono la natura umana e di capire che essi non dovevano essere considerati
come due entità separate ma fuse nella stessa personalità, come in Rigoletto che è,
contemporaneamente, personaggio deforme e ridicolo ma anche padre appassionato e pieno
d'amore. Con la censura Verdi aveva adottato questi argomenti, omettendone però un altro che
i censori, preoccupati com'erano di altri motivi di scandalo non notarono e cioè che Rigoletto
possiede sì le caratteristiche paterne ed amorevoli nonostante sia un buffone deforme ma è
anche un assassino in potenza, ben prima che il rapimento della figlia Gilda gli dia l'occasione
di giustificare l'odio che egli porta al duca, un odio gratuito e feroce, dovuto al fatto che il duca
è giovane e bello.
La psicologia di Rigoletto è ancora più complicata di così, c'è più della cattiveria e dell'amore:
egli si prende crudelmente gioco di Monterone, quando costui è prigioniero «Qual vi piglia or
delirio... a tutte l'ore / di vostra figlia reclamar l'onore?», guadagnandosi la maledizione
profferita dall'austero e dignitoso gentiluomo, quasi a profezia degli eventi futuri «Oh siate
entrambi voi maledetti! / Slanciare il cane al leon morente / è vile o Duca...e tu serpente, / che
d'un padre ridi al dolore, / sii maledetto!», ed è anche nemico segreto del duca, suo potenziale
assassino nel colloquio con il sicario Sparafucile. Diventa però un padre amoroso nel duetto con
Gilda, la parte bella della sua vita. Quando i due aspetti della sua personalità si sono
avvicendati ecco il rapimento di Gilda che lo induce a fondere l'amore per la figlia con l'odio
verso il sovrano, per ordire una vendetta finale che avvererà le parole di Monterone in quanto
Rigoletto si ritroverà assassino della propria figlia.
La creazione di un personaggio così complesso avvicina Verdi alla sensibilità di Manzoni, con
esito finale però, diverso perché se il personaggio dell'Innominato, colui che si avvicina
maggiormente a Rigoletto, sarà protagonista di una redenzione tanto più gloriosa quanto più
nefande erano le colpe di cui egli si era precedentemente macchiato, lo stesso esito non esiste
per Rigoletto, imprigionato nelle spire del proprio destino disperato senza spiragli di salvezza: il
buffone è un popolano che vive in modo assolutamente laico il proprio destino, senza speranza,
senza indulgenza.
Dal punto di vista musicale fu una vera novità porre al centro della partitura il personaggio di
Rigoletto facendo predominare la voce di baritono su tutte le altre. Questo predominio portò
all'abolizione delle gerarchie esistenti tra i ruoli vocali, così come era stato fissato dalla
convenzione e stabilito dalla consuetudine. I ruoli del soprano, del tenore e del mezzosoprano
restano definiti convenzionalmente: il Duca, tenore, è tutto compreso tra la canzone virile e
spavalda «La donna è mobile» e la cavatina amorosa del tenore italiano; Gilda, soprano,
raggiunge vertici di vocalità virtuosistica in «Caro nome» ed anticipa il proprio destino di
eroina e vittima in «Tutte le feste al tempio»; su tutti campeggia Rigoletto con una grande varietà
di accenti e di stati d'animo.
Era giunta a maturazione la tecnica che Verdi aveva anticipato in Macbeth, cioè quella di
impiegare le voci all'interno del melodramma puntando a sottolineare il loro significato rituale:
le parti negative sono ricche, elaborate, linguisticamente avanzate, mentre quelle positive
obbediscono alla consuetudine. Per il ruolo di Rigoletto Verdi scelse i recitativi per le occasioni
in cui emerge l'anima nera del buffone, togliendo la melodia ed organizzando una sorta di
colloquio con l'orchestra che insiste sui toni gravi; dove prevalgono i sentimenti paterni egli si
associa al canto luminoso del soprano come se quella luce lo inondasse purificandolo, sia pure
momentaneamente, da ogni infamia e viltà. La stessa sequenza di stati d'animo si verifica nelle
scene che seguono il rapimento di Gilda: dall'apostrofe ai cortigiani «Cortigiani vil razza
dannata», alle lacrime per commuovere l'impassibile Marullo e farsi dire dove la ragazza è
tenuta prigioniera «Ebben piango...Marullo...signore», fino alla cabaletta «Sì, vendetta,
tremenda vendetta», dopo l'aria di Gilda, nel finale del secondo atto.
Pare che il quartetto dell'ultimo atto abbia fatto dire a Hugo che se la letteratura avesse concesso
la stessa possibilità di esprimere la simultaneità dei sentimenti che offriva la musica, anch'egli
sarebbe stato in grado di scrivere un capolavoro di pari drammaticità ma non fu solo la
simultaneità dei sentimenti che Verdi espresse nel quartetto: egli fissò nella musica, con una
tecnica assolutamente in anticipo rispetto al suo tempo, l'istante della coscienza in cui si
affacciano e si accavallano sentimenti, turbamenti, conflitti, ricordi e passioni. Egli espresse in
musica ciò che non è possibile esprimere con la parola non diversamente da come fecero geni
europei del calibro di Mozart e Beethoven.
2.3. D'Alfredo il padre in me vedete.
(La traviata, atto II, scena V)
Nel 1848, mentre si trovava a Parigi, Verdi aveva probabilmente letto il romanzo breve di
Dumas figlio La Dame aux caniélias. La lettura gli aveva fatto venire in mente la possibilità che
da quel romanzo si potesse trarre un'opera e nel 1852, probabilmente con l'opera già in testa,
sempre a Parigi, aveva assistito ad una replica della commedia che lo stesso Dumas aveva tratto
dal suo fortunato romanzo.
L'opera che ne uscì, La traviata, fu oggetto del contratto stipulato con La Fenice nel marzo 1852,
il libretto affidato a Piave.
Dopo gli ultimi successi le offerte di lavoro fioccavano sia da Londra che da Parigi dove, oltre
l'Opéra, anche il Théàtre-Italien voleva un'opera firmata da Giuseppe Verdi. Sotto l'aspetto
professionale Verdi poteva ben considerarsi arrivato: ormai poteva permettersi di imporre i
propri tempi ai teatri che accettavano senza discutere e Giuseppina manteneva il proprio ruolo
di preziosa e discreta consigliera sui soggetti da scegliere e persino sui tempi da dedicare al
lavoro.
I problemi che si presentarono in quegli anni riguardarono la vita privata: nel 1851 morì
improvvisamente Luigia Uttini, la madre di Verdi, ed egli cercò di sopportare il dolore
improvviso e lacerante della perdita meglio che poté, con quella fermezza d'animo che i tempi e
la cultura imponevano ad un uomo; suo padre stette molto male fu quasi per morire ma si
riprese e sopravvisse altri sedici anni. Il rapporto affettivo con il figlio degenerò, fino al punto
di interrompersi, date le pretese che Carlo Verdi avanzava anche pubblicamente sulla
conduzione della tenuta di Sant'Agata, pur sapendo bene come suo figlio ne fosse geloso.
La vita privata del maestro fu spiacevolmente investita anche dai pettegolezzi sempre meno
velati e sempre più sfacciati che i bussetani si scambiavano su Giuseppina Strepponi. A loro non
piaceva assolutamente che Verdi avesse portato a Sant'Agata una donna con quella reputazione
e, soprattutto, che non l'avesse sposata. I pettegolezzi causarono una rottura di rapporti tra
Verdi ed i suoi concittadini che si sentirono oggetto di ingratitudine da parte di chi era stato
tanto beneficato in passato dalla comunità. La situazione si era inasprita proprio quando Verdi
aveva comprato e rimodernato la tenuta di Sant'Agata che si era dimostrata un investimento
fruttuoso ed i bussetani mal tolleravano che Verdi vivesse in mezzo a loro da benestante,
estraneo alle convenzioni sociali al punto da imporre pubblicamente la presenza della propria
compagna, donna dal passato dubbio e manifestasse tanto distacco rispetto alla gente che
l'aveva aiutato e sostenuto. Il disagio maggiore era, naturalmente, quello di Giuseppina, che
cercava in ogni modo di costruirsi una rispettabilità più per Verdi che per se stessa. Sua era
stata l'idea di differire il matrimonio che, essendo entrambi liberi, non avrebbe avuto ragioni di
rinvio se non quella dell'esistenza in vita di almeno due dei figli che Giuseppina aveva avuto in
anni precedenti e questo poneva un problema patrimoniale oltre che morale perché i bambini,
che nessun padre aveva mai riconosciuto, con il matrimonio della loro madre sarebbero entrati
nell'asse ereditario di Verdi, avrebbero fatto parte, in qualche modo, della sua discendenza e
questo non sembrava assolutamente giusto a Giuseppina che si tormentava anche perché non
poteva dare a Verdi quei figli che, lo sapeva bene, egli avrebbe tanto desiderato.
A complicare ulteriormente le cose ci si era messo anche Antonio Barezzi che aveva conosciuto
Giuseppina anni prima a Parigi ed aveva avuto con lei rapporti cordialissimi: malgardo ciò egli
si era fatto portavoce delle dicerie di paese e questo Verdi non lo poteva tollerare, o meglio,
poteva benissimo tollerare le voci dei pettegoli bussetani ma di certo non ombre nel suo
rapporto con Barezzi, con quel padre sostituto a cui lo legavano ancora gli stessi sentimenti di
affetto e rispetto dei primi anni giovanili. Per non dovergli dare spiegazioni Verdi partì per
Parigi insieme a Giuseppina; lì lo raggiunse una lettera di Barezzi che prendeva spunto dal fatto
di non aver ricevuto le solite consegne riguardo a Sant'Agata. La risposta di Verdi, che
rivendicava per sé la libertà di agire secondo il suo giudizio di uomo adulto, reclamava il
rispetto per Giuseppina, per quella signora libera, che viveva del suo e che non era permesso a
nessuno, neppure al «carissimo suocero, di insultare.
L'ispirazione per La traviata era lì, a portata di mano, in quelle vicende personali e familiari che
Verdi stava vivendo. Il complesso rapporto che legava lui, Giuseppina e Antonio Barezzi
ritorna nell'opera che se non è una trasposizione diretta della situazione personale di Verdi ha
comunque fortissime corrispondenze con il suo privato. Violetta non è Giuseppina ma il
personaggio fittizio e la persona reale hanno in comune la condizione di donna sola ed il
tentativo di emergere da un passato socialmente inaccettabile e ad entrambe un uomo offre
amore, infischiandosene delle convenzioni sociali; Antonio Barezzi non è Giorgio Germont ma
con lui ha in comune un ruolo paterno che si vuole socialmente forte ma che in realtà non è in
grado di proteggere i figli, anzi ne sottomette i sentimenti alla reputazione ed al buon
matrimonio che ne può o meno conseguire. Anche i due mesi passati al lavoro a Sant'Agata con
Giuseppina ammalata, trascorsi in un clima triste, potevano aver fornito l'ispirazione per il tono
squallido dell'ultimo atto della Traviata.
L'opera, andata in scena il 6 marzo 1853 al teatro La Fenice di Venezia fu un fiasco che Verdi
riconobbe con tre lettere laconiche ma significative.
Come già era accaduto per Rigoletto, anche La traviata fu costruita tutta attorno ad un solo
protagonista, Violetta, dal quale dipendessero drammaticamente e musicalmente tutte le
situazioni e tutti i personaggi.
Il passato di Violetta è ciò che la rende schiava di un mondo dominato dagli uomini, informato
dai loro principi morali, eppure, in questo personaggio così rischioso da un punto di vista
psicologico, in quanto donna e in quanto deviante rispetto al senso morale comunemente
accettato, Verdi fornisce una prova ante litteram della finezza e profondità d'indagine che si
rivelerà pienamente nelle opere della maturità. La verità artistica di Violetta si riverbera sui due
personaggi maschili che acquistano spessore e passione in rapporto a lei mentre quando aprono
bocca per conto loro dicono, musicalmente, delle banalità e quando duettano si presentano
come la vetrina delle convenzioni melodrammatiche fra tenore e baritono.
Quest'opera, che al suo apparire fu tacciata di immoralità, è quella dove le leggi morali della
poetica verdiana si rivelano con maggior forza e compiutezza nel serio e coraggioso
pessimismo, nel senso rassegnato dell'ingiustizia degli uomini e del mondo che segna ed orienta
in modo irreparabile la vicenda umana di Violetta. Nella sua parabola dolorosa Verdi volle
vedere e proporre una sorta d'atto d'accusa contro la società e le sue convenzioni, quelle che
Germont padre va sciorinando subdolamente per convincere Violetta ad abbandonare Alfredo.
Egli riesce a convincerla usando le armi della retorica paterna e solo nel momento in cui Violetta
piange, singhiozza ed implora egli ha un sussulto di benevolenza convenzionale che non riesce
a spingersi oltre il « Piangi, piangi, piangi», chiosato da un ipocrita « Non ci vedrem più forse.
Siate felice. Addio» mentre se ne va, dopo aver raggiunto il proprio scopo.
Violetta è una creatura alla quale Verdi ha conferito un grande senso di dignità, di
consapevolezza del proprio ruolo, di pietas che ella esercita senza riserve, generosa nei
confronti di chi non lo è stato con lei. Ella muore perché non c'è altra via alla catarsi, ma con una
solennità impensabile per una cortigiana, sbigottita fino all'ultimo dalla morte e piangente sui
piaceri perduti. Gli accordi che accompagnano l'evento sono lenti, ribattuti, segnati con le
quattro p dell'estremo pianissimo ma sono raccolti ed austeri, quasi accompagnassero la morte
di un epico eroe o di un martire.
E Violetta muore come un martire o un eroe.
2.4. Sei vendicata, o madre!
(Il trovatore, parte IV, scena ultima)
Il libretto del Trovatore ha la fama di essere bizzarro e sommario: venne considerato strano, già
all'epoca della prima rappresentazione, il fatto che non si conosca l'identità di Leonora, contesa
tra Manrico ed il Conte De Luna e che, tuttavia, ella sia una donna libera di se stesa senza
parenti o amici; curiosi parvero anche i rapporti tra Manrico e sua madre, la zingara Azucena:
lui trovatore e, nel contempo, capo militare, una sorta di nobile che aspira alla mano di Leonora
ed osa opporsi al conte De Luna; lei, madre non proprio degna di tanto figlio essendo, appunto,
una zingara e piuttosto male in arnese. Fu infine trovato inverosimilmente crudele il
comportamento di Azucena. Nell'antefatto del dramma, per vendicare la madre mandata al
rogo dal padre del conte De Luna che agisce nell'opera, Azucena ha rapito un bambino di nobile
casato e lo ha gettato sul rogo credendolo figlio dell'odiato nemico. In realtà, come scopre in
seguito, ha bruciato il proprio figlio e conservato il piccolo De Luna, appunto Manrico, al quale
ha fatto da madre crescendolo nell'odio per i De Luna. Quando, per quest'odio, Manrico viene
imprigionato e decapitato, Azucena ne osserva la morte esclamando »Sei vendicata, o madre!»,
il che non fa certo dubitare della sua follia vendicatrice ma mette sicuramente in dubbio la
solidità del suo affetto per Manrico. Queste incongruenze del Trovatore furono sottolineate
immediatamente dagli spettatori contemporanei che stigmatizzarono l'opera come antiquata:
alla metà del secolo il teatro d'opera si andava orientando verso temi più naturalistici e realistici
e lo stesso Verdi aveva contribuito a questa svolta con Rigoletto. Il trovatore, invece, ripeteva,
esasperandoli, i modelli della drammaturgia del primo Ottocento sui quali nessuno avrebbe
avuto da ridire se l'opera fosse stata composta venti o trent'anni prima. Verdi aveva
volutamente scritto un'opera di gusto rétro, come testimonia la scelta di affidare il libretto a
Salvatore Cammarano, un poeta che si dimostrava poco sensibile all'evoluzione del teatro
d'opera mantenendosi fedele ai modelli cristallizzati dalla convenzione. Nella fedeltà di
Cammarano a quel tipo di drammaturgia si insinuava, però, qualcosa di insolito, cioè la quasi
totale mancanza di azione, sostituita dall'evocazione, dall'allucinazione, dai ricordi. L'azione,
come tale, fa capolino soltanto in alcuni momenti mentre largo spazio trova la dimensione
onirica e allucinata dei personaggi che raccontano, rievocano e vivono altrove anche se sono
fisicamente collocati in una dimensione spazio temporale descritta come reale.
Azucena, in particolare, vive in una dimensione altra, sempre rivolta ad altri fatti, altri luoghi,
altre persone ed è quella la dimensione che le appartiene e la caratterizza. L'emblema della follia
vendicatrice di Azucena è nel secondo atto, nell'aria «Stride la vampa», dove ella spiega, nel
solito modo allucinato, le ragioni del proprio delirio, così come, nel quarto atto, tra sogno e
delirio, fantastica di trovarsi con Manrico in un paesaggio montano, in un luogo lontano dal
carcere e dall'imminente supplizio. Anche Manrico, per parte sua, vive in una dimensione più
fantastica che reale: con la cabaletta «Di quella pira» risponde alle ossessioni visionarie di
Azucena ed è significativo che il duetto d'amore, immancabile nel melodramma, tra Manrico e
Leonora si svolga con Manrico chiuso in una torre, invisibile alla donna amata, ridotto a sola
voce, e Leonora, invece, in scena.
Nell'opera si rincorrono e si intrecciano il qui e l'altrove, il dentro ed il fuori, la realtà e la
fantasia e la musica salda queste zone differenti con un'intensità nuova in Verdi: non era mai
accaduto, né sarebbe stato considerato un fatto positivo, che la musica prevalesse sul dramma;
nel Trovatore, invece, è il senso della drammaticità musicale che condiziona gli eventi scenici e
ne diventa la coerente cucitura. L'atteggiamento di Verdi in quest'opera dimostra che l'artista
aveva percorso un cammino di evoluzione dalla ricerca di suggestioni musicali nei soggetti e
negli intrecci delle vicende e dei personaggi all'invenzione di un discorso musicale
relativamente avulso da esigenze di verosimiglianza, di rispetto di una trama o delle vicende
dei personaggi. Qualunque elemento era ricondotto nell'ambito di evento musicale. Poiché è
sempre molto difficile separare il Verdi pubblico da quello privato, bisogna accettare che quel
cambiamento pubblico avesse un corrispettivo anche nel privato: egli ormai era arbitro delle
proprie composizioni, poteva decidere come, quanto e quando scrivere e la sua musica era
diventata soggetto, non più oggetto della drammaturgia, ma come non vedere in quella madre
allucinata e tragica che è Azucena, prigioniera di una tenacissima quanto impalpabile ragnatela
di dolore che non le dà vie d'uscita tranne una sola dove morte e vendetta hanno lo stesso volto,
un ritratto dolente, grondante di rimpianto, irrigidito nel senso della perdita e trasfigurato nella
dimensione onirica del ricordo, la madre stessa di Verdi? Non era certo il primo lutto che il
maestro affrontava ma se la morte dei figlioletti e di Margherita avevano posto sul futuro di
Verdi un'ipoteca, un vuoto dei sentimenti che il rapporto con Giuseppina aveva colmato, anche
se in modo parziale, la morte di Luigi Uttini era stata per il figlio come un colpo di scure
improvviso che tronca la radice più salda di un albero e lo ferisce crudelmente. All'interno della
famiglia d'origine il rapporto con la madre era stato più positivo rispetto a quello con il padre,
non foss'altro perché Luigia, come richiedeva il suo ruolo coniugale e materno, si era limitata ad
essere una dispensatrice d'affetto, presente senza essere invadente o prevaricatrice. Senza di lei
quella famiglia, di cui rimaneva il solo Carlo, aveva perso di significato.
La madre, che Verdi aveva perduto due volte, sia con Luigia che con Margherita, gli doveva
apparire come una figura ambiguamente distorta nella promessa di una dolcezza infinita e poi
nell'improvvisa distillazione di un dolore acerbissimo ed è probabile che un po' per questa
ragione, un po' per proseguire l'incursione e l'indagine nel mondo dei diversi, dei deformi in
corpo e anima, Verdi abbia voluto che Azucena avesse la voce di mezzosoprano.
Era la prima volta che nel teatro di Verdi e, praticamente, nel melodramma italiano, il
mezzosoprano veniva arruolato tra i protagonisti. La voce del mezzosoprano aveva sempre
caratterizzato personaggi secondari, come ad esempio, in Rigoletto, quello di Maddalena,
l'insidiosa e perversa sorella del sicario Sparafucile, o che, comunque, agivano fuori dalla legge
o dalla convivenza civile.
Azucena è una madre, ora forse tenera, ora diabolica: cosa c'è di più fuori legge, o di diabolico,
di una madre che dispensa affetto, che improvvisamente ne interrompe il flusso e la corrente e,
morendo, si nega in eterno al proprio figlio lasciandolo desolatamente solo?
3
L'Europa chiama
3.1. Parigi, o cara...
(La traviata, atto III, scena VI)
Nei mesi successivi alla prima della Traviata, Verdi era tornato ad occuparsi di Re Lear. Era la
terza volta che Verdi metteva mano al suo progetto shakespeariano ed aveva affidato la stesura
del libretto ad Antonio Somma, avvocato udinese con fama di drammaturgo, conosciuto a
Venezia. Ma la tragedia di Shakespeare, nonostante Verdi avesse impegnato, a fondo Somma,
presentava dei problemi insormontabili come, ad esempio, la mancanza di unità di azione e di
luogo e la probabile prolissità del testo. Verdi dovette rinunciare ancora una volta. Nel
frattempo il contratto con l'Opéra di Parigi andava avanti: l'opera proposta ed accettata dalla
sovrintendenza del teatro parigino era Les Véspres siciliennes.
Il lavoro per la Francia era l'ultimo impegno preso da Verdi nei suoi tormentati anni giovanili,
nel 1852, quando il successo di Rigoletto non lo aveva ancora fatto sentire, malgrado tutto, libero
di poter disporre di se stesso. La consegna della partitura era prevista per la metà del 1854;
Verdi la consegnò in ottobre e si stabilì a Parigi, insieme a Giuseppina, con un anno di anticipo
rispetto al previsto.
Due mesi prima che Verdi e Giuseppina arrivassero a Parigi Napoleone III aveva conferito al
prefetto, barone Haus-smann, il compito di ristrutturare radicalmente l'aspetto della città. La
Parigi che Verdi aveva conosciuto nel 1848 e nel 1852 stava diventando un'altra città: ampi
boulevards andavano sostituendo le strade e le stradine che reticolavano la città, si dava spazio
al verde urbano con il Bois de Boulogne e il Bois de Vicennes, si abbattevano interi agglomerati
di case, con conseguente sfratto di moltissime famiglie e aumento vertiginoso dei prezzi degli
alloggi. Nel trasformarsi in metropoli Parigi anticipava le nevrosi delle città moderne. L'opera
commissionata a Verdi rientrava nel progetto imperiale di mostrare al mondo la trasformazione
di Parigi come cifra di una nuova epoca, quella ordinata e moderna dell'ultimo Napoleone: la
rappresentazione era stata infatti prevista per il 1855, in occasione dell'Esposizione Universale.
Quella era l'occasione migliore che si potesse offrire a chiunque in fatto di teatro musicale, non
solo perché l'Opéra vantava tra i suoi autori i nomi più prestigiosi, tra cui quello di Rossini, ma
soprattutto per la stabilità dei successi: le opere, una volta andate in scena ed approvate dal
pubblico e dalla critica, venivano replicate per anni anche perché comportavano ingenti
investimenti di denaro per la loro realizzazione. Di conseguenza, il teatro musicale, il solo
ammesso a Parigi assumeva un valore paragonabile a quello di un bene quotato in borsa e gli
autori ne avevano assicurata la fama. Verdi, quindi, benché non ne amasse affatto il
funzionamento, non poteva permettersi di trascurare l'Opéra, il più importante teatro europeo
dal quale persino Wagner, prima di farsi costruire Bayereuth, aveva cercato di farsi accogliere.
La stabilità, la fama assicurata, l'organizzazione stabile del teatro che garantiva repliche
eccellenti aveva però un prezzo che per un uomo come Verdi non era certo facile da accettare,
figurarsi da pagare: quello di adeguarsi alle richieste ed alle condizioni altrui.
Un esempio di come funzionasse l'Opéra, Verdi lo ebbe proprio da Eugène Scribe che gli aveva
approntato il testo de Les Véspres siciliennes. Il precoce trasferimento a Parigi era stato
condizionato in gran parte dal desiderio di Verdi di tenere il letterato sotto controllo e, abituato
a comandare a bacchetta impresari, cantanti e librettisti italiani, Verdi pensava che sarebbe stato
facile imporre le proprie idee sull'allestimento. Invece così non fu: Scribe era un osso duro e le
numerose insistenze di Verdi per modificare alcuni punti del libretto e, soprattutto, la cattiva
luce in cui nel racconto della rivolta siciliana erano stati messi i personaggi italiani, furono
accolte dalla più totale indifferenza. Verdi protestò col direttore del teatro e cercò inutilmente di
liberarsi del contratto. Peggio ancora fu quando Verdi, anni dopo, scoprì che il libretto di Scribe
era, in realtà, un fondo di cassetto: pochi cambiamenti erano stati apportati al libretto del Duca
d'Alba rifilato a Donizetti che non era mai riuscito a finirlo. Infine, cosa che era la peggiore di
tutte, la protagonista, il soprano Sophie Cruwell, italianizzato in Cruvelli, pensò bene di
scomparire al momento di iniziare le prove per ricomparire soltanto un mese dopo senza aver
dato nel frattempo alcuna notizia di sé. Verdi, abituato a ben altro tipo di rapporto con i
collaboratori, in senso quanto mai lato, non poteva certo accettare cose di quel genere.
D'altra parte i suoi rapporti con i teatri parigini non erano dei migliori: c'era il Théàtre-Italien,
specializzato nell'opera italiana e nel quale si esibivano i grandi cantanti italiani, col quale Verdi
ritrovò rapporti civili soltanto nel 1855 quando curò personalmente la messa in scena del
Trovatore, ma era un teatro piuttosto disorganizzato che non si curava particolarmente della
messa in scena ma solo di coltivare il divismo dei cantanti; c'era l'Opéra-Comique, un altro
teatro specializzato in un genere misto di commedia e di opera, un genere tipicamente francese
che Verdi trovava insopportabile. Nonostante lo scalpitare del maestro per avere maggior voce
in capitolo nell'allestimento dell'opera e la grande indifferenza opposta alle sue richieste, Les
Véspres siciliennes andarono finalmente in scena il 13 giugno 1855, con grande successo, grazie
anche alla rete di pubbliche relazioni degli agenti parigini dei Verdi, i fratelli Escudier. Fu
comunque un successo vero, di pubblico e di critica, confermato da cinquanta repliche e da
ottime recensioni dei critici che normalmente non si mostravano molto generosi con chi non
faceva parte del circuito dell'Opéra, come era appunto Verdi.
La scrittura di un'opera in stile parigino, cioè di un grand-opéra suddiviso in cinque atti, con un
testo francese, parti coreografiche ad integrazione di quelle cantate, con un'azione scenica di
proporzioni molto ampie ed un cast necessariamente numeroso, sembrò a Verdi una fatica
immane di cui si lamentò definendola tale «da ammazzare un toro». Durante il lavoro alla
partitura per l'Opéra, Verdi si era dedicato anche ad altro: era tornato sulla scrittura di Re Lear
che gli era sembrata realizzabile dopo la precipitosa quanto misteriosa fuga della Cruvelli, ed
aveva anche ritoccato La traviata per la sua ripresa al Teatro San Benedetto di Venezia nel 1854.
La ripresa era stata un successo, come aveva profeticamente annunciato Verdi in una lettera ad
Angelo Mariani il giorno seguente il fiasco della prima1, anche per l'accortezza di ambientare la
vicenda ai tempi di Luigi XIV, andando così incontro al gusto del pubblico, italiano ed
internazionale, per il melodramma in costume. In costume erano anche Les Véspres siciliennes
secondo un modello che trovava il proprio punto di riferimento in Meyerbeer, le cui tre opere
rappresentate con intervalli di tempo molto lunghi tra l'una e l'altra, lo avevano consacrato
come dominatore del teatro musicale francese: l'assetto monumentale del grand-opéra, i
soggetti storici, le ampie parti cantate che concedevano largo spazio al virtuosismo dei cantanti
ed ai toni eroici, avevano accontentato pienamente l'alta borghesia della monarchia di Luigi
Filippo.
Il nuovo ceto emergente del Secondo Impero, la piccola borghesia, aveva una mentalità più
prosaica ma, in certo qual modo, anche più emotiva e cominciava a preferire argomenti di
carattere più intimista, espressi con toni più sommessi; tornare al grand-opéra alla metà degli
anni Cinquanta, così come richiesto per l'Esposizione Internazionale, sarebbe stata impresa
difficile per ogni musicista parigino, per questo la direzione dell'Opéra affidò l'incarico ad un
compositore che, secondo i criteri francesi, era abbastanza provinciale per accettare ed
abbastanza famoso da incuriosire il pubblico. Non era certo il primo compromesso che Verdi
accettava anzi, durante gli «anni
1M. Porzio (a cura di), Verdi. Lettere. 1835-1900, p.234 "La Traviata ha fatto un fiascone e, peggio, hanno riso. Eppure, che vuoi? non ne sono
turbato. Ho torto io, o hanno torto loro? Per me credo che l'ultima parola sulla Traviata non sia quella di iersera. La rivedranno...e vedremo!
Intanto, caro Mariani, registra il fiasco."
di galera» ne aveva accettati molti mirando ad affermarsi come autore per imporre in un
secondo tempo le proprie idee e le proprie concezioni. A Parigi si comportò nello stesso modo e
la convenienza che gli si prospettava era duplice: da un lato aveva l'opportunità di affermarsi
sulle scene del maggior teatro europeo affidando la propria opera ad un'organizzazione ferrea,
ben diversa da quella dei teatri italiani, dall'altro era ben consapevole che quell'occasione
avrebbe aperto alla sua drammaturgia nuove prospettive. Verdi aveva l'occasione di sviluppare
la propria drammaturgia in forme più ampie e articolate di quanto il melodramma italiano gli
avesse mai richiesto, non più un solo personaggio attorno al quale far ruotare tutta l'azione ma
una struttura molto più variegata. La sua concezione teatrale si doveva arricchire nella stessa
misura in cui si era affinata la sua sensibilità, la sua visione del mondo e del genere umano non
più cristallizzato in buoni e cattivi, come al tempo delle opere giovanili, ma più realistico nella
consapevolezza che il bene ed il male convivono all'interno di innumerevoli sfumature. Verdi
riuscì perfettamente nell'intento, allargò i propri orizzonti, affinò il proprio linguaggio e lo
perfezionò, affinché fosse in grado di esprimere sentimenti e situazioni sempre più complesse e
fornì ai parigini un'opera capace di soddisfare da un lato la curiosità di mettere alla prova il
celebre maestro italiano su un terreno a lui poco noto e, forse, poco congeniale, dall'altro in
grado di tributare un omaggio al grand-opéra, riconoscendone la supremazia nel teatro
musicale europeo.
Se Parigi aveva acquisito Verdi, Verdi aveva conquistato Parigi.
3.2. Ebben, presto morrai... per man d'un amico...
(Un ballo in maschera, atto I, scena X)
Il primo esempio del nuovo corso della drammaturgia verdiana é il Simon Boccanegra che nel
1857 fu clamorosamente fischiato dai veneziani, disorientati da quella musica politico sociale
che, seppur non ancora perfettamente riuscita, era troppo in anticipo sui tempi. Male accolta a
Venezia, l'opera tuttavia trionfò a Reggio Emilia nel 1857, al San Carlo di Napoli nel 1858 ma
registrò nuovamente un fiasco alla Scala dove andò in scena nel gennaio del 1859. L'insuccesso
alla Scala turbò moltissimo Verdi che considerava Milano la propria patria artistica ed amava il
teatro nel quale aveva debuttato.
In una lettera inviata a Tito Ricordi nel febbraio del 1859, in difesa del Simon Boccanegra Verdi
accusa il pubblico di non essere all'altezza del suo lavoro2: non era certo la prima volta che il
maestro assisteva al fiasco di una sua opera ma le reiterate cadute del Boccanegra lo offendevano
in modo particolare perché si colpiva il tentativo di rinnovare il melodramma italiano
ampliandone soggetti e personaggi, modificandone l'architettura procedendo lungo la strada,
già intrapresa negli anni parigini, del melodramma non più a «personaggi» ma a «situazioni».
Questo tentativo non era fine a se stesso ma corrispondeva alla maturità raggiunta da Verdi,
alla consapevolezza di se stesso come artista, capace di cogliere il senso di una realtà che gli
appariva infinitamente più ricca, più sfumata in confronto ai vecchi simboli di passione e di
gestualità del melodramma. In più Verdi aveva scoperto in maniera più profonda, il senso della
passione politica ed aveva colto come essa informasse di sé numerosi aspetti della vita umana.
Di questo, ancora una volta, era debitore alla Francia dove aveva assistito alle rivolte
combattute lungo le strade ed aveva assorbito un senso di partecipazione collettiva, di identità
nazionale dalla quale l'Italia era ancora molto lontana. L'incontro con la politica c'era già stato
nell'esperienza verdiana, ad esempio con i soggetti storico-biblici o con il dramma dal quale era
stato tratto Rigoletto, dopo un estenuante braccio di ferro con la censura, ma Parigi gli aveva
messo sotto gli occhi l'aspetto contemporaneo, umano e popolare della politica, convincendolo
che anche quella passione poteva essere descritta
2 Ivi, pp. 109 — 110.
in musica. Anche l'aspetto politico dunque contribuisce alla ricerca verdiana del modo di
rompere gli schemi tradizionali del melodramma iniziata col Boccanegra dove la consueta
vicenda amorosa rimane in secondo piano per lasciare spazio all'aspetto politico e romanzesco,
ai personaggi legati al potere, alla descrizione del sentimento popolare.
Nel 1881 Verdi rielaborò il Simon Boccanegra, affidando la modifiche del libretto ad Arrigo Boito
ed inaugurando la collaborazione con il librettista delle sue ultime due opere, Otello e Falstaff,
ma questo era ancora di là da venire; per il momento Verdi aveva anticipato i tempi,
proponendo un esperimento che il pubblico non aveva gradito e Verdi, cosciente di aver
imboccato la strada giusta ma alternativa, se ne 'ritrasse per tornare sulla strada maestra. La
situazione del Simon Boccanegra ricorda per alcuni aspetti quella di Macbeth: stessa funzione
anticipatrice, stessa rielaborazione nel momento in cui le anticipazioni diventavano realtà,
stessa difficoltà nell'essere accolte come capolavori proprio per la loro precocità, per l'essere
nate in anticipo sui tempi quindi immature. L'impossibilità per Verdi di proseguire su quel
terreno senza deviazioni o ripensamenti era legata alle condizioni oggettive del melodramma
italiano e del teatro italiano, impiantati in una condizione culturale che non permetteva
l'attecchire di alcun tentativo di avanguardia. La differenza fondamentale tra Macbeth e Simon
Boccanegra è che nei dodici anni che le separano Verdi era diventato un altro uomo ed un altro
artista: prima di Simon Boccanegra c'erano stati Rigoletto, Il trovatore e La traviata, le opere in cui
Verdi aveva trovato la strada per piegare alla propria drammaturgia forme di espressione
musicale ancora tradizionali ed era diventato capace di cedere in apparenza alla tradizione pur
senza tornarvi mai davvero.
Con l'opera successiva, Un ballo in maschera, Verdi riprese le consuetudini melodrammatiche,
almeno in apparenza.
Nel settembre del 1857 Verdi aveva cominciato a pensare all'opera che doveva consegnare al
San Carlo di Napoli: era rispuntato Re Lear ma l'idea si era rivelata impraticabile; era caduta la
soluzione di liberarsi dall'impegno presentando un rimaneggiamento della Battaglia di Legnano e
la scelta cadde su un libretto di Scribe, Gustave III dal quale era stata tratta l'opera omonima di
Auber che Verdi conosceva bene. Nonostante qualche esitazione riguardo alla scelta, il compito
di tradurre e ridurre il libretto francese fu affidato a Somma, un po' per compensarlo della
mancata rappresentazione del Re Lear, un po3 perché Verdi sapeva che Somma aveva capacità
di sceneggiatore e verseggiatore superiori a quelle dello stesso Piave ed affidandogli un lavoro
si poteva star sicuri sul risultato. Una volta deciso, fu inviata, per scrupolo, una traccia in prosa
del libretto alla censura napoletana e tra novembre e dicembre erano pronti sia il libretto
definitivo che lo spartito per canto e pianoforte.
Ai primi di gennaio del 1858 Verdi e Giuseppina Strepponi si imbarcarono a Genova per Napoli
dove giunsero dieci giorni dopo. Al momento di sbrigare gli ultimi preparativi, Verdi venne a
conoscenza dell'inaudito comportamento tenuto dall'impresario del San Carlo: la censura aveva
respinto il libretto fin dall'ottobre precedente ma nessuno lo aveva comunicato a Verdi per
costringerlo a comporre l'opera e fargli poi accettare i cambiamenti necessari nell'imminenza
della rappresentazione. Per essere ancor più persuasive le autorità napoletane minacciarono
Verdi di farlo arrestare quando egli si infuriò davanti a quell'incredibile inganno. Di nuovo si
ripeteva la situazione che Verdi aveva vissuto anni prima' ma in quel nuovo frangente, più
agguerrito, decise di ricorrere al tribunale civile presentando anche una memoria in cui erano
elencati minuziosamente tutti i cambiamenti imposti dalla censura e presentandoli come danni
al proprio lavoro.
Napoli si divise tra sostenitori ed avversari di Verdi: se in città aveva degli amici, non gli
mancavano certo i nemici, quei cultori delle tradizioni locali, pronti a giurare su Cimarosa
3 In occasione di Luisa Miller, rappresentata a Napoli nel 1849, Verdi ebbe serie noie con la censura napoletana e rischiò l'arresto.
e Paisiello, ai quali Verdi appariva un pericoloso progressista tanto in politica come in musica. Il
tribunale consigliò salomonicamente un accomodamento tra impresario ed autore, mosso dal
desiderio di non scontentare l'illustre maestro che tra i suoi estimatori contava anche il fratello
del re ma convinto anche della bontà dello zelo dei censori, soprattutto alla luce del clamoroso
attentato di Felice Orsini contro Napoleone III, fatto che sconsigliava vivamente di mettere in
scena un regicidio.
Furibondo, Verdi aveva convocato a Napoli l'impresario romano Jacovacci e con lui aveva
concordato di far rappresentare l'opera a Roma, salvo il benestare delle censura pontificia:
Verdi voleva che la sua opera fosse rappresentata in una città non lontana da Napoli, sapendo
anche che a Roma era stato rappresentato senza problemi un dramma che aveva più o meno lo
stesso soggetto e che Jacovacci sapeva bene come manovrare in caso ci fossero state difficoltà
sulla forma cantata. La censura concesse il benestare a patto che l'azione fosse spostata dalla
corte svedese al governatorato di Boston, abbastanza lontano ed esotico per non creare fastidi. Il
regicidio, comunque, rimaneva, sia pure con un certo travestimento: i censori probabilmente
ignoravano che l'argomento dell'opera riprendeva un fatto realmente accaduto alla corte
svedese alla fine del secolo precedente, che il colpevole si era sottratto alla morte con la fuga
riparando a Parigi, dove aveva condotto una vita molto ritirata ma non tanto da non assistere
alla rappresentazione del Gustave III di Auber dove si metteva in scena quel tragico episodio.
La proposta di cambiare il luogo dell'azione non era poi così male; Verdi persuase Somma ad
apportare le modifiche richieste e, nel giro di qualche mese, l'opera fu approvata.
Il 10 gennaio 1859 Verdi partì da Napoli per Roma dove, il 17 febbraio, Un ballo in maschera fu
rappresentata, ottenne uno strepitoso successo e dalla platea si alzò il grido VIVA VERDI che
tutti sapevano voler dire Viva Vittorio Emanuele Re D'Italia. Il Piemonte di Vittorio Emanuele II
si stava preparando alla guerra contro l'Austria con il viatico dell'abile Cavour che aveva
manovrato le cose in modo da rendere impossibile all'Austria non attaccare ed alla Francia non
intervenire in soccorso del Piemonte aggredito, così come si era convenuto a Plombières con
Napoleone III. L'opera di Cavour trovava ampio consenso nei moderati, fautori di un'Italia
unita sotto un regime costituzionale e in questa parte si trovò anche Verdi, ex mazziniano, che si
trovava in accordo anche con l'indirizzo propagandistico che si dava al suo cognome.
L'entusiasmo che infiammò le platee da Milano a Roma ed oltre era direttamente figlio dello
spirito del 1848 e fu allora che gli italiani tornarono con il ricordo e la fantasia al giovane Verdi;
incapaci di vedere nelle opere del momento l'espressione di una fase matura del melodramma
italiano e di riconoscere nell'artista un uomo ormai avviato sulla strada dello sviluppo pieno
della propria arte vollero vedere solo ciò che la fantasia e l'entusiasmo di quel particolare
momento li portavano a vedere e sentire, gli echi patriottici di Nabucco, della Battaglia di
Legnano, di Ernani e vollero fermamente credere in un Verdi creatore di un teatro epico ed
eroico. Quel tipo di atteggiamento, fortemente riduttivo, fece in modo che il nazionalismo, lo
spirito risorgimentale che avevano radici borghesi, oscurassero una delle qualità più importanti
del teatro di Verdi, cioè quella di avere una matrice popolare. Fin dal Nabucco Verdi aveva
introdotto nella propria drammaturgia un andamento nuovo, al di là delle forme convenzionali
del melodramma del primo Ottocento italiano, una semplicità priva di quegli ornamenti che
avevano fatto pensare che il livello tecnico dell'autore fosse inferiore a quello di Donizetti, per
non parlare di Rossini e che la sua sensibilità non si sarebbe mai levata ad altezze eccelse ma
sarebbe stata sempre penalizzata da un non so che di rozzo e grossolano. È comunque vero che
il teatro di Verdi mirava a toccare la coscienza morale degli spettatori non solo la loro emotività,
la musica doveva cogliere il senso profondo della condizione umana a cui non far mancare il
legame con la realtà. L'espressione più elementare di questa vocazione al realismo fu Nabucco,
che pure annunciò il rinnovamento del teatro italiano, poi il realismo di Verdi si sviluppò, si
arricchì, maturò, creando un nesso preciso tra la dimensione popolare e la tendenza al realismo
che rimase presente in tutte le opere di Verdi, anche in quelle, come Un ballo in maschera, che
sembrano lontane, se non addirittura estranee all'orientamento verdiano.
L'invenzione musicale del Ballo in maschera si impernia sulla duplicità della passione d'amore:
fino ad allora nelle opere di Verdi l'amore aveva avuto il ruolo di forza scatenante di conflitti
irrimediabili. Esso si trova al centro dell'opera, nel duetto tra Riccardo e Amelia, e si presta a
due interpretazioni: da un lato esso è passione irresistibile, sconvolgimento dei sensi, secondo le
norme tradizionali, dall'altro è soggetto alla distinzione tra amore coniugale, legittimo ed
illegittimo amore adulterino e ad esso Amelia e Riccardo resistono. Gli stessi protagonisti
reprimono l'amore ma si verifica anche la situazione emblematica dell'arrivo del marito.
Prima del duetto — spartiacque Riccardo è un brillante sovrano invaghitosi di Amelia, la
moglie del suo valoroso e saggio favorito, Renato che, ignaro dei sentimenti di Riccardo, si
comporta da leale suddito e fedele amico. Una spinta verso il duetto è l'incontro nell'antro di
Ulrica, la zingara indovina, che Riccardo consulta per gioco e per divertimento ma il gioco
scivola nella drammaticità quando Amelia chiede ad Ulrica come fare per spegnere la passione
che sente di nutrire per Riccardo.
Dopo il duetto, quale che sia stato il destino di quella passione, rimane il suo influsso sui
protagonisti: Renato, da amico fedele si trasforma in nemico e congiurato per finire assassino,
Riccardo, pur avendo rinunciato ad Amelia, non sfuggirà al suo sicario ed Amelia non potrà
sottrarsi al senso di colpa, anche se la vicenda la renderà più consapevole del proprio senso
materno e dei suoi legami familiari. L'unico personaggio che non subisca alcun influsso e
rimane se stesso fino alla fine è il paggetto Oscar, il doppio di Riccardo, giovane, spensierato e
incosciente, come si addice ai giovani, dal suo ingresso in scena fino alla trappola del ballo
finale.
L'amore colpevole genera la contraddizione che nel Ballo in maschera travolge situazioni e
protagonisti: gli amici diventano nemici, gli amanti si separano, gli innocenti appaiono
colpevoli, le predizioni di una zingara frequentata per passatempo di corte si rivelano più
attendibili di quanto dovrebbero ed un ballo al governatorato di Boston si trasforma in
occasione di congiura fatale.
L'opera non ha mai un tono totalmente brillante o totalmente tragico ma l'uno si fonde
nell'altro. Nell'ultimo quadro tutti tornano ad essere immersi in un'atmosfera festosa, quella del
ballo e per giunta in maschera, ma si avverte subito che nulla è più come prima, serpeggia
ovunque un'inquietudine misteriosa in certi ritmi taglienti, agghiaccianti, i gorgheggi di Oscar
sono forzati ed anche la voce di Amelia è alterata dal presagio dell'imminente tragedia.
Un'ultima frase d'amore si scioglie in un lamento funebre sul minuetto ormai irreale che svela la
funzione di danza macabra.
3.3. Amici in vita e in morte
(La forza del destino, atto III)
Mentre si agitavano i furori della guerra, nel 1859, Verdi prese una decisione importante e la
prese in assoluto silenzio: dopo molti anni di convivenza, in un paesino della Savoia, il maestro
sposò Giuseppina Strepponi. Nello stesso anno Verdi conobbe personalmente Cavour nel corso
di un breve viaggio in Piemonte. L'incontro tra i due fu molto cordiale e generò in Verdi una
profonda ammirazione per Cavour che egli avrebbe sempre considerato il vero padre della
patria; dal canto suo Cavour aveva fatto di Verdi un simbolo patriottico quando, per salutare la
guerra dichiarata dagli austriaci al Piemonte, aprì le finestre e si mise a cantare a squarciagola
«Di quella pira», la celebre cabaletta del Trovatore. Durante l'inverno del 1860 Cavour scrisse a
Verdi pregandolo di accettare la candidatura al parlamento italiano: la richiesta, che Verdi
avrebbe probabilmente rifiutato se fosse venuta da altri, faceva leva sul realismo moderato del
maestro. Dal momento che la richiesta veniva da un uomo che egli ammirava moltissimo, Verdi
accettò e il 6 febbraio 1861 fu eletto in parlamento. Per alcuni mesi si trattenne a Torino e le sue
proposte più significative riguardarono i teatri e l'organizzazione delle scuole musicali, per le
quali Verdi caldeggiava l'insegnamento curricolare della musica corale e ciò non stupisce se si
considera la straordinaria importanza, la funzione da coprotagonista che nelle proprie opere
egli aveva sempre riservato al coro, togliendolo dalla mortificante condizione di anonimato
musicale, di accessorio nella quale si trovava. La situazione personale di Verdi era molto ben
consolidata: da oltre dieci anni egli era il più autorevole compositore italiano, era stato eletto
deputato in parlamento e la sua fama cresceva progressivamente in tutta Europa. Nel 1861,
passato il fuoco della guerra e diradate le occupazioni della politica, Verdi ricominciava a
prendere le fila del suo lavoro. In quel momento giunse dalla Russia una lettera da parte del
tenore Tamberlik, romano, che per conto del teatro imperiale di Pietroburgo proponeva a Verdi
di scrivere un'opera dietro compenso di sessantamila franchi. Per trovare il soggetto giusto da
rappresentare in Russia, Verdi vagliò alcune possibilità poi prese in considerazione un dramma
spagnolo contemporaneo, pubblicato nel 1835, opera del duca di Rivas intitolato Fuerza del
sino, su cui venne stipulato il contratto con Tamberlik.
La scrittura della nuova opera sembrava procedere tranquillamente quando giunse improvvisa
la notizia della morte di Cavour. Verdi ne fu profondamente addolorato ed abbattuto al punto
da non avere il coraggio di andare ai funerali dello statista ma, nonostante tutto, la stesura
dell'opera, La forza del destino, continuò così come i preparativi per il viaggio in Russia. Quando
Verdi e la moglie vi giunsero, dopo un viaggio lunghissimo, scoprirono che l'opera non avrebbe
potuto essere rappresentata, a causa di una compagnia di cantanti vocalmente fragile. Alle
richieste di Verdi di sciogliere il contratto fu opposto l'accomodamento di rappresentare l'opera
l'anno seguente con una compagnia adatta.
Sulla via del ritorno dalla Russia i Verdi si fermarono a Parigi dove il maestro era atteso per
consegnare una composizione da eseguire, insieme a quelle di altri, in occasione
dell'Esposizione Universale. L'idea di Verdi era quella di consegnare una marcia ma un altro
autore lo aveva preceduto; si orientò quindi su una cantata per il cui testo si rivolse ad un
giovane italiano conosciuto nel salotto parigino di Rossini. Quel giovane si chiamava Arrigo
Boito, era fratello dell'architetto e letterato Carlo, abile sia come letterato che come musicista,
molto stimato anche dalla buona società milanese. La cantata, intitolata Inno delle Nazioni, non fu
eseguita nell'occasione per la quale era stata composta ma qualche giorno dopo al Iter Majesty's
Theatre di Londra.
Occorreva pensare al ritorno a Pietroburgo, dove il maestro arrivò a settembre. Prima di
cominciare le prove Verdi andò a Mosca per una rappresentazione del Trovatore che venne
accolta con manifestazioni di entusiasmo tali che per il maestro furono un trionfo personale.
Finalmente andò in scena La forza del destino: l'accoglienza fu buona e lo zar Alessandro conferì a
Verdi l'ordine di San Stanislao, seconda prestigiosa onorificenza dopo la Legion d'Onore
ricevuta in seguito alla rappresentazione dei Vespri a Parigi. Tra il pubblico c'era anche un
gruppo di giovani sui vent'anni, il Gruppo dei Cinque, con Musorgskij in testa, che fischiarono
rumorosamente i prodotto di un'arte ufficiale ed invecchiata rispetto alla loro filosofia di una
musica nazionale che assorbisse e rielaborasse il grande patrimonio della musica popolare
russa. Pietroburgo, capitale politica di rango, era una provincia importante del melodramma
ma era un luogo periferico rispetto, ad esempio, a Parigi ed i suoi teatri non potevano
competere con l'Opéra anche se si tenevano aggiornati sulle trasformazioni del teatro musicale
europeo imitando gli spettacoli del teatro parigino ed invitando cantanti celebri. Verdi era stato
invitato a scrivere un'opera per un'occasione ufficiale, i festeggiamenti per i mille anni
dell'impero russo. La corte russa, specialmente all'epoca di Caterina II, aveva invitato operisti
italiani e francesi perché scrivessero direttamente per le scene imperiali ma, nel 1862, le cose
erano molto cambiate e lo testimoniava la reazione infastidita e quasi rabbiosa del Gruppo dei
Cinque alla prima della Forza del destino. La situazione del pubblico russo era piuttosto singolare
perché era un pubblico relativamente arretrato in fatto gusto ma, proprio per la politica che i
teatri di Pietroburgo praticavano, era aggiornato sulle principali forme del teatro europeo. La
situazione si presentava ideale a Verdi per un'opera che fosse il riepilogo dei vari aspetti del
melodramma che egli stesso aveva praticato. Verdi tornò al clima romantico di Ernani e di
Simon Boccanegra, drammi spagnoli come quello da cui derivava La forza del destino. Gli autori,
imitatori di Hugo, avevano trascurato le unità di azione, tempo e luogo a favore di un impianto
più complesso, teatrale, fondato su passioni, colpi di scena, varietà di accenti, ora drammatici,
ora comici, ora popolari. Erano i principi che Verdi ammirava e che ritrovava in Shakespeare,
proponendosi di praticarli in ogni lavoro che intraprendeva solo che, non riuscendo ad
applicarli ai drammi di Shakespeare, come dimostra la lunga ed incompiuta gestazione di Re
Lear, si accontentò di ricavarli dal teatro romantico spagnolo, più marginale ma per questo più
efficacemente adattabile alla riduzione in libretto. Certi personaggi grotteschi presenti
nell'opera, come ad esempio Melitone, dimostrano la loro filiazione dal grand-opéra, così come
denunciano la loro ascendenza teatrale francese le dimensioni e la complessità dell'azione,
l'alternarsi tra dramma romantico ed ambientazione monastica, militare e popolare; il tono
romanzesco dell'intreccio principale, la storia d'amore tra Leonora ed Alvaro, riconduce al
teatro di Donizetti e non a caso, dato che prima che gli giungesse la proposta dalla Russia Verdi
aveva assistito a Torino ad una rappresentazione de La favorita. Gli affetti familiari e l'amore
seguono la traccia del melodramma del primo Ottocento, con la contrapposizione padre-figlia
che culmina nell'assassinio, sia pure accidentale, del padre per mano dell'innamorato della
figlia; il figlio dell'ucciso giura vendetta, insegue la sorella ed il suo innamorato durante la loro
fuga in Spagna ed in Italia ed ancora una volta la vicenda si conclude con una morte, stavolta in
duello; il sentimento di espiazione riguarda sia Leonora che Alvaro e trova il proprio luogo
deputato nel villaggio di Hornachuelos, dove tutti i protagonisti, separatamente, sono spinti,
appunto, dalla forza del destino.
La mescolanza di sacro e profano non ha più, come nel Trovatore, un tono pittoresco ma
assume sia per Leonora che per Alvaro le dimensioni di un caso di coscienza che trova una
conclusione spirituale nel ritorno alla fede di Alvaro dopo lo smarrimento provocato dal fatto
di aver ucciso un uomo, di saperlo fratello della donna amata che egli ritroverà morente. Questo
finale fu sostituito a quello originale, nel quale Alvaro si suicida, nel 1869 con la revisione del
libretto di Antonio Ghislanzoni, il futuro librettista di Aida, al quale Verdi aveva affidato il
compito di inserire delle modifiche ad un libretto che, forse, non lo convinceva del tutto. Il
sentimento religioso che traspare, contrastante con l'abituale laico pessimismo verdiano, è
probabilmente conseguente all'influsso delle idee religiose di Manzoni, per il quale Verdi
nutriva un profondissimo rispetto ed un'accesa ammirazione: questo non significa che Verdi si
fosse convertito, semplicemente aveva accettato il sentimento religioso come parte integrante
della propria drammaturgia dopo averlo considerato per anni soltanto sotto l'aspetto pittoresco.
Anche l'ambientazione militare del terzo atto rappresenta qualcosa in più rispetto al passato: il
clima marziale e la guerra favoriscono il sentimento d'amicizia tra Alvaro, innamorato di
Leonora, e Carlo, il fratello di lei inflessibile vendicatore, nascosti sotto falsi nomi, cosa che
acuisce il dramma quando, nel momento dell'agnizione, Carlo scopre che il suo recente amico è
in realtà il suo antico nemico.
Infine l'ambientazione popolare che include tutta una serie di figure deliziose, come la
vivandiera Preziosilla, o gustose come fra Melitone, l'unico popolano che abbia contatto con i
personaggi aristocratici dell'opera. Verdi si cimentò con grande determinazione con la
mancanza di unità di tempo di luogo e di azione, grande problema soprattutto se si tiene conto
che Verdi voleva rispettare l'impianto del melodramma ad episodi senza abbandonare quelli
che erano i punti fermi della propria drammaturgia, cioè creare personaggi dotati di una loro
verosimiglianza psicologica dalla quale nascessero le azioni e non più, come in passato, dotati
di azioni che ne definissero la psicologia. La forza del destino fu l'opera che, forse meglio di ogni
altra, dato che si poneva come momento massimo di elaborazione iniziata con altri lavori,
rappresentò le nuove esigenze di Verdi: il dramma a situazioni si fonde con il dramma
psicologico, il dramma aristocratico si fonde con la commedia popolare. Per tutti questi aspetti
La forza del destino si configura come un grande riassunto della cultura melodrammatica
europea.
3.4. Le prove son tremende...
(Don Carlos, atto III, parte II)
L'interesse di Verdi per gli emarginati dalla società che si era già manifestato in Rigoletto,
Trovatore e Traviata, dopo aver avuto qualche precedente in Ernani, era stato una vera e propria
partecipazione alla sorte di esseri marginali, relegati in un destino incontrovertibile di
solitudine ed osservati con assoluto pessimismo. Nell'epoca giovanile e matura aveva cercato di
inserire questi personaggi nelle forme canoniche del melodramma e li aveva cercati dapprima
fra i personaggi aristocratici della librettistica ottocentesca come nel caso di Emani, proscritto di
nobili natali; in Macbeth e in Lady aveva cercato un grado di emarginazione più turpe, dovuto
alla malvagità della coppia shakespeariana; Rigoletto e Azucena rappresentavano una
dimensione più umana di emarginazione ma più terribile per il miscuglio di malvagità, di
familiarità da branco e di follia mentre Violetta rappresentava l'emarginazione di una reietta
dipendente da una società ingiusta. Lo studio dell'emarginazione, a prescindere dall'ambiente
sociale, proseguì anche con l'opera successiva alla Forza del destino, Don Carlo ridotto dall'opera
di Schiller per l'Opéra di Parigi. La partitura di Don Carlo, o Don Carlos secondo il titolo
originale francese, venne composta nei primi nove mesi del 1866.
L'eroe, Don Carlo, è un emarginato eppure non lo è, appartiene a quella tipologia di succubi, di
vinti, tanto cara all'indagine psicologica verdiana, ma la sua condizione è complicata dal fatto di
essere figlio di Filippo II re di Spagna e di essere un figlio non voluto e non amato. Dal rifiuto
paterno nasce il carattere nevrotico del principe, la sua ribellione al padre è frutto di un conflitto
che affonda le proprie radici nella politica ma anche nella passione amorosa per Elisabetta di
Valois, la principessa che egli ama, che in un primo momento gli era stata promessa e poi era
andata sposa a Filippo in ossequio alla ragion di stato. Don Carlo ha altri legami che gli
impediscono di essere un marginale vero, è amico del marchese di Posa, politico con velleità di
riformatore, ed è amato dalla principessa Eboli che, non riamata, arriverà per gelosia a
calunniare Elisabetta per poi pentirsi del proprio gesto. Eboli e Posa vedono in Don Carlo
soprattutto il figlio del re, oltre che l'oggetto dei loro sentimenti contraddittori e ciascuno, nel
tentativo di legarlo a sé, gli impedisce di realizzare pienamente i propri desideri: ribellarsi al
sovrano, offenderlo esibendo il suo amore persistente verso colei che è la sua matrigna e la sua
regina.
La passione amorosa ha molte sfumature in quest'opera: limpida, innocente, piena di speranza
per il futuro all'inizio quando Don Carlo è ancora persuaso che Elisabetta sia la sua promessa
sposa, poi via via sempre più corrotta, al limite della passione incestuosa e potenzialmente
parricida quando la ragion di stato secondo la quale Filippo ha sposato Elisabetta strappandola
al figlio si svela come elemento corruttore anche del più puro sentimento d'amore. Nell'intreccio
si inseriscono anche la passione non corrisposta di Eboli che diventa veleno e calunnia e la
gelosia del vecchio re Filippo per la coppia da lui spezzata e che soltanto la virtù di Elisabetta
mantiene separata per amore di lealtà, contro ogni ragione ed ogni sentimento.
Il senso di lealtà di Elisabetta è ciò che fa di lei una creatura succube, come lo era Violetta nei
confronti della società ottocentesca.
I sentimenti di amicizia e di inimicizia che avevano trovato nelle due opere precedenti, sia nel
Ballo in maschera che nella Forza del destino, una collocazione precisa ed erano state, soprattutto
nella Forza del destino, oggetto di studio tanto accurato quanto innovativo, come nel caso
dell'amicizia maschile tra Don Alvaro e Don Carlo, seguono qui un cammino molto tortuoso:
come l'amore esse sono sentimenti positivi e con una loro ragion d'essere ma, esattamente come
l'amore, non sfuggono all'azione corruttrice della ragion di stato e dell'ipocrisia che la sostiene.
L'amicizia tra Posa e Don Carlos trova il proprio specchio nell'inimicizia di Posa con Filippo II:
l'assassinio di costui non è ordinato dal re, che avverte Posa e lo mette in guardia, ma dal
Sant'Uffizio. Come l'inimicizia del re non è leale fino in fondo con Posa, Posa non è leale con
Don Carlo, che pure gli è amico, fino al punto di permettergli di ribellarsi al re: egli lo disarma,
proprio mentre Don Carlo estrae la spada davanti a Filippo II. Il gesto è ambiguo: Posa salva la
vita al re, come il più leale e fedele tra i sudditi, salva la vita del suo amico ma lo consegna di
fatto al grande Inquisitore. La congiura melodrammatica, che di solito avviene tra i marginali,
meglio se sono anche abietti, in questo caso avviene tra i potenti: è l'Inquisitore a tenerne le fila
e, come un abile burattinaio, manovra Filippo II spingendolo ad agire contro Don Carlo e Posa.
Non a caso Verdi volle l'Inquisitore vecchio e cieco, come emblema di un potere religioso
inflessibile ed inumano. La religione, nel patrimonio valoriale di Verdi era diventata, col tempo,
un dato positivo, come avevano dimostrato il secondo ed il quarto atto della Forza del destino;
non manifestazione di fede, che probabilmente Verdi non ebbe mai, ma come uno stato
psicologico, legato alla meditazione ed ai misteri della fede ed alla suggestione dei luoghi in cui
essi si manifestano.
La corruzione e la morte costituiscono, in un certo senso, gli elementi portanti di quest'opera
verdiana; ad essi Verdi ricollega gli atteggiamenti dei protagonisti, la loro psicolgia e l'intreccio.
Il pessimismo non riguarda più, come in passato, soltanto la sorte dei protagonisti ma tutta la
loro vita che viene osservata e proposta in una prospettiva alla quale manca la speranza e dove
bene e male si mescolano nella coscienza collettiva e dei singoli.
L'intreccio di Don Carlos si svolge su due piani: l'uno accoglie lo svolgimento degli eventi, l'altro
li interpreta creando una dimensione più narrativa che teatrale, che richiede tempi più lenti e
maggiormente riflessivi, vivendo più nei colloqui e nelle digressioni che nei colpi di scena.
L'azione, nel Don Carlos, non è particolarmente presente mentre ci sono continue digressioni
destinate a spiegare, sia pure in maniera indiretta, il comportamento dei protagonisti. Nei
monologhi, nei colloqui si rivelano tutte le sfaccettature dei rapporti umani, dall'amicizia al suo
contrario, dalla complicità alla disperazione, dall'implorazione al rifiuto. Con il linguaggio del
melodramma tutto ciò non sarebbe stato esprimibile: la digressione era un ingrediente da
grand-opéra, di cui Verdi volle adottare le forme sia pure nella sua consueta tensione alla
drammaturgia. L'opera testimonia un generale, profondo disincanto: la corte spagnola,
inquietante e sontuosa è in realtà una prigione in cui gli individui devono reprimere le passioni
che, talvolta però, esplodono; Don Carlo è prigioniero della pesante etichetta di corte, dei
vincoli di soggezione a suo padre e di una sua intima, personale debolezza che lo vota alla
sconfitta o, peggio ancora, alla ribellione impotente che nulla gli lascia se non una nostalgica
fantasticheria. Don Carlos segna un momento di svolta nella produzione verdiana con il
debutto di un atteggiamento critico nei confronti del protagonista che verrà sviluppato e
troverà il suo apice in Otello.
Esistono molte versioni dell'opera, per le quali si sono cercate le più diverse spiegazioni, dal
cambio di teatro, alla nazione diversa, al gusto nazionale, all'esigenza di non far restare il
pubblico a teatro troppo a lungo impedendo alle persone di prendere l'ultimo mezzo
disponibile per tornare a casa: di fatto ciò che noi oggi abbiamo è una grande opera narrativa,
che non è un grand-opéra e nemmeno un melodramma in senso stretto che dimostra tuttavia
una grande capacità di sintesi proprio mentre il suo essere non definita una volta per tutte la
rende aperta, disponibile a diverse soluzioni come è possibile solo ai capolavori.
3.5. 0 cieli azzurri
(Aida, atto III, romanza)
Era molto difficile che un'opera complessa e di profondi contenuti espressi in maniera
sostanzialmente nuova come Don Carlos fosse capita immediatamente e, infatti, non lo fu.
Quando l'opera fu rappresentata venne assimilata al grand-opéra, di cui aveva la struttura in
cinque atti e'la grandiosità e quasi nessuno si accorse che l'intreccio di inquietudini individuali e
di contraddizioni del potere la poneva agli antipodi di una ideologia trionfalistica e
conservatrice come era quella su cui poggiava il grand-opéra; contemporaneamente fu accusata
di wagnerismo dalla critica parigina, che probabilmente non sapeva come altro etichettarla.
L'etichetta di wagnerismo era abbastanza elastica da poter essere usata in molte occasioni tanto
più che a Parigi, salvo che per il Tannhauser, Wagner era poco conosciuto. Verdi si rendeva
conto che le convenzioni del grand-opéra erano più d'ostacolo che d'aiuto alla sua
drammaturgia e poco sarebbero convenute, nel futuro, al suo modo di intendere l'opera ed il
teatro, aveva chiaro anche che l'organizzazione dell'Opéra, perfezionista e burocratica, aveva
penalizzato l'esecuzione rendendola fredda ma era soprattutto il paragone con Wagner che lo
infastidiva, anzi lo offendeva perché sviliva la sua personale evoluzione artistica e screditava
contemporaneamente una tradizione italiana di cui Verdi si sentiva, con orgoglio di artista e
patriota, il custode. Egli attribuiva all'arte una funzione molto importante per tenere alto il
nome dell'Italia in un momento politicamente difficile, funestato dalle sconfitte di Lissa e
Custoza, nel 1866, e dall'umiliazione di vedere l'Italia ridotta al rango di paese vassallo della
Francia e della Prussia. Nel 1859, durante la seconda guerra d'indipendenza, Verdi aveva
accantonato la musica per far posto all'impegno politico; nel 1867 l'arte restava l'unico campo in
cui l'Italia potesse ottenere rispetto e in questo campo Verdi, come parte in causa, si sentiva
particolarmente impegnato. Comprese che l'arte poteva apportare prestigio quanto una
battaglia vinta e fu per questo che cercò di compattare gli artisti italiani. La prima ad accorgersi
di questi sentimenti fu la sempre intuitiva Giuseppina che approfittò di un viaggio a Milano per
conoscere finalmente Clarina Maffei, amica di vecchia data di Verdi, e, attraverso lei arrivare al
conoscere l'ormai ottuagenario Alessandro Manzoni ed organizzare l'incontro tra lui e Verdi,
risparmiando così al marito la sgraditissima incombenza di fare il primo passo. L'incontro fu
folgorante e commovente per Verdi che si trovò per la prima volta faccia a faccia con un altro
grande dell'arte italiana e non seppe nascondere l'emozione.
Dopo quella emozionante e lieta parentesi Verdi fu colpito dalla morte di Antonio Barezzi,
spirato ottantenne dopo una breve malattia: quella morte rinnovava il dolore per la morte
recente di Carlo Verdi ma fu più cocente perché, per Verdi, Barezzi era stato il suo vero padre.
In seguito Verdi si recò insieme a Giuseppina, a Parigi per ascoltare il Don Carlos; con loro
viaggiava il direttore d'orchestra Angelo Mariani che si proponeva di dirigere l'opera a Bologna
in autunno. L'idea di Mariani era quella di portare al successo la complessa partitura e di
smentire la freddezza dell'esecuzione francese. Verdi, che non chiedeva di meglio, accettò con
entusiasmo. La prima bolognese del Don Carlos ebbe come protagonista una cantante boema
destinata a giocare un ruolo importante nella vita di Verdi: si chiamava Teresa Stolz 4 e, per la
verità, la rappresentazione bolognese del
Non è il caso, in questa sede, indagare quali furono i rapporti che legarono Giuseppe Verdi e
4 Teresa Stolz: Giuseppina Strepponi, gelosissima del marito, era convinta che tra i due intercorresse una relazione amorosa ma
Don Carlos la vide fidanzata di Mariani che se ne era innamorato a prima vista. Anche Mariani
ebbe un ruolo significativo nella vita di Verdi che lo stimava come direttore d'orchestra ma finì
presto per disprezzarlo al punto da rompere ogni rapporto con lui. Verdi era suscettibile e
permaloso e Mariani possedeva la scomoda abilità di urtarne i lati peggiori. Il punto di rottura
fu raggiunto quando, cinque giorni dopo la morte di Rossini avvenuta il 13 novembre 1868,
Verdi, fedele al suo proposito di compattare gli artisti italiani in nome del prestigio nazionale,
lanciò l'dea di una messa di requiem, a più mani, da eseguire a Bologna nel primo anniversario
della morte di Rossini. I nomi dei compositori furono estratti a sorte e tra loro c'era Verdi, ma
non Mariani. L'idea non trovò mai realizzazione per una serie di complicazioni organizzative e
su Mariani, che a Bologna aveva voce in capitolo, si addensarono alcuni sospetti. Verdi fu poi
offeso dal fatto che Mariani avesse accettato di organizzare e dirigere a Pesaro una
commemorazione rossiniana nell'agosto del 1869. Colpito dalla durezza di Verdi Mariani
formalmente si scusò ma mise in giro le voci che esistesse una relazione tra Verdi e la Stolz e che
quella fosse la vera causa dell'accanimento del maestro nei suoi confronti. I rapporti si ruppero
definitivamente quando Mariani accettò di dirigere la prima del Lohengrin di Wagner al Teatro
Comunale di Bologna. Mariani si era limitato ad accettare le richieste dei bolognesi desiderosi
di essere i primi a conoscere quella che era definita la «musica dell'avvenire» e, in quanto
grande direttore d'orchestra non gli sembrava giusto sottrarsi all'incarico mentre per Verdi
quello era addirittura un delitto antipatriottico, complicato dalla rivalità tra i Lucca, editori di
Wagner, e i Ricordi, editori di Verdi. Lohengrin andò in scena il 1° novembre 1871 e la stessa sera
Teresa Stolz ruppe il fidanzamento con Mariani.
Mentre i rapporti con Mariani non erano ancora del tut4 citò poi la Stolz nel proprio testamento e le lasciò un prezioso gioiello. Di fatto ci basta sapere che Teresa Stolz fu molto vicina a Verdi negli
anni della vecchiaia e della solitudine, il resto non ha importanza.
to deteriorati, Verdi era sollecitato dai suoi amici francesi a comporre una nuova opera.
Escudier e Du Locle gli mandavano continuamente soggetti da esaminare e Verdi li esaminava
per poi rifiutarli sistematicamente fino a quando Du Locle, nell'estate del 1870, non gli mandò
uno scarno soggettino di argomento esotico che attirò l'attenzione di Verdi. Du Locle colse la
palla al balzo ed ampliò subito il soggetto spiegando a Verdi che, se avesse accettato, l'opera
sarebbe stata rappresentata al Cairo nel teatro costruito per celebrare il taglio dell'istmo di Suez,
inaugurato nel tardo 1869: era nato il progetto di Aida. Il libretto fu affidato ad Antonio
Ghislanzoni, che Ricordi convinse a collaborare nuovamente con Verdi dopo i ritocchi apportati
alla seconda edizione della Forza del destino. Sia Verdi che Ghislanzoni lavorarono a grande
velocità e per la fine di novembre libretto e spartito per canto e piano erano terminati.
Secondo il contratto Verdi si riservava tutti i diritti e la facoltà di una seconda rappresentazione
in Europa dopo la prima del. Cairo. Mentre Verdi curava le edizioni per i cantanti e il direttore
d'orchestra accadde un altro strappo ai rapporti con Mariani che condizionarono anche quelli
tra lui e la Stolz e della cantante con Verdi.
Nel 1870 Mariani si era offerto di dirigere la prima di Aida al Cairo pensando che la Stolz, con la
quale era ancora fidanzato, lo avrebbe seguito per cantare la parte della protagonista. In
risposta ebbe un secco rifiuto perché il direttore designato fu Emanuele Muzio, un altro grande
della direzione che, per di più, era capace di non far innervosire Verdi. Quando la data della
rappresentazione al Cairo fu procrastinata e Muzio fu costretto a recedere dall'impegno, Verdi
offrì la direzione a Mariani ma senza la Stolz che Verdi aveva fatto scritturare per la prima
europea di Aida a Milano: la cantante, ovviamente, non avrebbe potuto trovarsi al Cairo e, quasi
contemporaneamente, a Milano.
Nel pieno dei preparativi scoppiò la guerra franco prussiana ed i materiali di scena, in
lavorazione a Parigi, restarono bloccati nella capitale francese. Verdi si affrettò a sospendere le
trattative con la Scala perché se saltava la prima al Cairo non sarebbe stata possibile l'esecuzione
europea prevista subito dopo. La resa di Parigi ai prussiani e la loro entrata in città apparvero a
Verdi come la fine di un'epoca e di una civiltà e malgrado la sua antipatia per i francesi, egli
riteneva che l'Italia avrebbe dovuto intervenire a fianco della Francia, non fosse stato per altro
che per ripagare il favore fatto da Napoleone III nel 1859, contro i prussiani che gli erano ancor
più antipatici. Nemmeno la presa di Roma avvenuta dopo il ritiro dei francesi di guarnigione
gli sembrava una conclusione degna. La caduta di Parigi, però, sbloccava la situazione e lo
spettacolo del Cairo venne fissato per la vigilia di Natale del 1871; il ritardo, che aveva
consentito a Verdi di sistemare alcune parti dell'opera, lo aveva privato del direttore designato.
Nel frattempo, scrupoloso come sempre, Verdi stabiliva i particolari della rappresentazione
milanese affidata alla direzione di Franco Faccio. Faccio era una vecchia conoscenza di Verdi:
era l'autore dei Profughi fiamminghi e di Amleto, opere su cui Boito aveva a suo tempo investito
tempo ed energie nella speranza di rinnovare il teatro italiano, proprio a spese di Verdi perché
dietro alle due opere c'erano Ricordi e l'amica di sempre di Verdi, Clarina Maffei. Fino a qui non
ci sarebbe stato nulla di strano o di sconveniente se non fosse accaduto che, durante un
banchetto in onore di Faccio dopo la rappresentazione dei Profughi fiamminghi, sul finire del
1863, Boito si fosse lasciato sfuggire una frase infelicissima sull'avvento di chi avrebbe
restaurato l'arte sull'altare «bruttato come il muro di un lupanare» 5. L'uscita, pubblicata anche
sui giornali, fece infuriare Verdi, nonostante le lettere concilianti della Maffei e dello stesso
Faccio: Verdi era da tempo impegnato nel rinnovamento del teatro musicale, non solo italiano e
sapeva bene come fosse un compito delicato e difficilissimo la cui natura era del tutto estranea
al fiume in piena dell'eloquio di Arrigo Boito. L'inimicizia con Boito dura5 C. Casini, Verdi, p. 247.
va ancora mentre Verdi si occupava di Aida; quanto a Faccio, diventato insegnante al
Conservatorio, aveva abbandonato la composizione per la direzione d'orchestra. Verdi lo aveva
visto al lavoro come maestro sostituto durante le prove della Forza del destino ed ora gli
affidava la sua nuova opera.
La prima di Aida al Cairo fu un gran successo, anche se Verdi non era presente, ma la prima di
Milano, 1'8 febbraio 1872 fu un autentico trionfo: trentadue chiamate all'autore e l'offerta di uno
scettro crisoelefantino6. Verdi aveva preparato minuziosamente lo spettacolo: si era
documentato sugli antichi strumenti egiziani, lavorò ai gioielli di scena per la Stolz e creò per lei
la romanza «O cieli azzurri» nel terzo atto, scrisse una nuova sinfonia d'apertura che non venne,
però, eseguita.
Il successo di Aida oscurò quello del Lohengrin e cancellò ogni sospetto di wagnerismo sull'opera
verdiana che potesse essere sorto all'indomani del Don Carlos; Verdi aveva ottenuto che nulla si
muovesse senza il suo benestare, compresa la sperimentazione di un accorgimento di Wagner,
quello di porre l'orchestra nella buca davanti al palcoscenico insieme al direttore. Con questo la
battaglia contro i wagneriani era vinta, la capitale musicale italiana era nelle sue mani così come
l'alleanza culturale italiana rappresentata dall'amicizia con Manzoni.
Un'opera su commissione è l'ultima cosa che ci si poteva aspettare da Verdi a quel punto della
sua vita ma è possibile che dopo l'esito incerto del Don Carlos un impegno di circostanza
rappresentasse una specie di solido scoglio, un argine ad una libertà di comporre che poteva
diventare rischiosa. In questo gli «anni di galera» ed il costume teatrale italiano e francese
avevano abituato Verdi al lavoro su un argomento dato entro una certa scadenza e anche dopo
aveva lavorato in vista della rappresentazione, pur potendosi permettere margini di scelta più
ampi rispetto al passato. A differenza di Wagner, Verdi lavorava per un pubblico che si poneva
verso il teatro nell'ottica di una fruizione che precedeva l'accettazione e, a differenza di
6 Ivi, p. 299.
Verdi, Wagner poteva valersi dell'avanguardia, categoria artistica che apparteneva al
romanticismo europeo ma non a quello italiano, se si esclude l'esperienza della Scapigliatura.
«Avanzamento» per Verdi aveva assunto il significato di passare da una drammaturgia a
personaggi e topoi ad un realismo che poggiava sulla complessità delle situazioni psicologiche
che realizzasse la sua visione del mondo, pessimistica certo, ma sempre più articolata con il
passare degli anni. Ogni volta che Verdi si era arrischiato a tentare qualche progresso nella
propria drammaturgia, aveva dovuto ripiegare e tornare sui propri passi. Aida fu un ritorno al
teatro musicale, puro e semplice, nel quale accolse due elementi fondamentali del teatro
musicale francese: l'esotismo ed il taglio da opéra-lyrique.
L'esotismo era di moda in Francia almeno dal 1865 ed avrebbe avuto un destino glorioso negli
anni successivi, da Car-men a Lakmé. Verdi non fece che cogliere un clima che piaceva
particolarmente al pubblico piccolo borghese del Secondo Impero a cui dava l'impressione di
viaggiare in paesi e situazioni favolose senza bisogno, quasi, di uscire dalle mura domestiche; lo
stesso pubblico aveva decretato la trasformazione del grand-opéra nell' opéra-lyrique, cioè la
sostituzione dell'epica eroica con uno spettacolo a grande effetto, in cui trovassero comunque
posto sentimenti ed intrighi.
In Aida i contrasti e gli intrighi riguardano amore, gelosia, tradimento, fedeltà, Egitto ed
Etiopia. La passione segreta di Radames per la schiava etiope Aida suscita la gelosia di Amneris
impostando anche il contrasto tra la classe dominante egizia e quella subordinata etiope
impersonata appunto da Aida e da suo padre Amonasro, un tempo re, ora prigioniero. Il
tradimento di Radames a favore degli etiopi e del loro re Amonasro avviene per amore di Aida
e, involontariamente, fa da contrappasso all'oppressione egizia sugli etiopi sconfitti ma non è il
potere politico a dettare le condizioni della punizione di Aida e Radames bensì uno spietato
potere religioso, altro tema caro all'anticlericalismo di Verdi, che esige la morte dei due amanti.
Nell'accostare gli aspetti esotici ed intimisti dell'intreccio, Verdi tornò alla teatralità di maniera:
invece delle indagini psicologiche care alla sua drammaturgia, tornò al gesto melodrammatico
che definisce il personaggio assegnandogli per tutta la partitura il ruolo rigido di una maschera
piuttosto che quello sfaccettato della personalità per cui Radames rimane sempre il tenore
«eroico» dominato dalla passione d'amore, Amneris il mezzosoprano divorata dalla gelosia,
ferita nella sua regalità e femminilità; Aida il soprano prigioniera di un ruolo suddito del tenore
e del baritono, Amonasro, a sua volta opposto al «cattivo», cioè il basso, nello specifico il Gran
Sacerdote.
Aida rievoca la concezione drammatica degli anni giovanili di Verdi: i personaggi sono
presentati con la stessa energia dei primi anni ma creati con l'esperienza e la maturità di anni di
lavoro in teatro e di riflessione su di esso. In questo punto, nell'innesto di un linguaggio
musicale molto maturo su una linearità drammaturgica quasi da opera seria del Settecento,
nella consapevolezza che era avvenuta una scissione tra la sua concezione drammaturgica ed il
suo linguaggio musicale, è la ragione della crisi susseguente ad Aida che comportò una lunga
pausa, quindici anni, nell'attività operistica di Verdi.
Verdi rifiutò le offerte di molti teatri, italiani e parigini, che volevano rappresentare Aida: aveva
sperimentato di persona la faciloneria con la quale molti teatri preparavano gli allestimenti ed
era del parere che non bisognasse chiudere un occhio in nome della molteplicità delle
rappresentazioni, inoltre il governo aveva tolto la sovvenzione pubblica ai teatri e le opere
erano costose a causa delle pretese economiche di cantanti, musicisti e scenografi che erano
diventate molto alte. Perciò Verdi decise di concedere Aida soltanto ai teatri di Parma e di
Napoli seguendo personalmente l'allestimento e le prove e mantenendo intatto il cast dei
cantanti in cui spiccavano la Stolz e la Waldmann, mezzosoprano, di cui Verdi apprezzava
molto il talento ed il colore vocale, a suo avviso pienamente comparabile a quello di grandi
cantanti italiane del passato. Di ritorno da Napoli Verdi ebbe la notizia che Alessandro Manzoni
era morto: il grande scrittore, provato dal recentissimo lutto per la scomparsa del figlio Pietro,
era caduto battendo la testa sugli scalini della chiesa di San Fedele, a pochi passi da casa sua.
Manzoni si era spento poche ore dopo, senza aver ripreso conoscenza. La popolarità immensa
raggiunta dai Promessi Sposi fece sì che il cordoglio toccasse tutta la nazione. All'indomani
della scomparsa di Manzoni Verdi, che non aveva avuto cuore di partecipare ai funerali, aveva
deciso di dedicargli una messa da requiem e ne aveva parlato soltanto con Ricordi: in realtà si
trattava di completare quel progetto nato ai tempi della fallita collaborazione per la
composizione collettiva in memoria di Rossini. La proposta venne ufficialmente presentata al
sindaco di Milano e immediatamente accettata. Verdi intendeva tributare a Manzoni un
omaggio che andasse oltre alla personale, grandissima stima che egli nutriva nei confronti dello
scrittore: doveva essere un atto pubblico relativo a quel disegno accarezzato da tempo di
un'alleanza fra artisti italiani che contribuissero a tenere alto attraverso l'arte, l'onore italiano di
fronte alle potenze europee. Era una convinzione lucida e precisa sul ruolo dell'arte e degli
intellettuali, sul loro impegno nella vita pubblica, un'idea anticipatrice degli atteggiamenti delle
avanguardie del Novecento che non avrebbero certo guardato a Verdi come ad un prodromo.
C'erano anche delle affinità tra le idee di Manzoni e quelle di Verdi che riconosceva nella prosa
manzoniana, che fondeva tragedia e commedia, realismo e lirismo, il vertice dell'arte italiana,
mentre li distanziava il concetto del male e della morte che Manzoni aveva filtrato attraverso la
fede cattolica ed aveva sublimato nel concetto della provvidenza, mentre Verdi viveva come
irrisolti, l'uno come invincibile afflizione del genere umano, l'altra come uno spegnersi
definitivo dell'uomo, senza alcuna speranza di aldilà.
Il tema centrale della Messa da requiem, 1a morte, non era un tema di circostanza per Verdi,
molte aveva fatto parte delle sue opere come destino dei personaggi rivelando la visione
dell'autore sul mondo e sulle sorti umane. Nella Messa da requiem la morte è un evento oggettivo
che si guarda attraverso il testo liturgico piuttosto che la sua rappresentazione compiuta
attraverso il destino dei personaggi, è una sorta di pensiero conclusivo che, attingendo alla
liturgia dei morti, assume un significato intimidatorio ma nel contempo consolatorio:
l'introduzione invoca con soavità la pace per i defunti e l'irrompere del Dies Irae, sezione
potentissima, la più ampia della messa, crea l'antinomia dell'ammonimento implacabile,
stemperato dalle invocazioni che salgono da solisti e coro che sono sprovvisti di un ruolo
operistico ma impersonano tutta l'umanità. L'andamento della Messa resta orientato in questo
senso, nell'Offertorium, nel Sanctus e nell'Agnus Dei intonato da voci femminili, nei conclusivi
Lux aeterna e Libera me in cui risorge la potenza del «die illa tremenda ».
Il 22 maggio 1875 Verdi diresse personalmente nella chiesa di San Marco a Milano la Messa da
requiem con un organico impressionante di centoventi coristi e cento orchestrali, tre giorni dopo
ripeté l'esecuzione alla Scala, poi a Parigi, a Londra e a Vienna.
4
"Torniamo all'antico, sarà un progresso!"
4.1. Esultate
(Otello, atto I, scena I)
Mentre l'Europa applaudiva la Messa da requiem nasceva una polemica internazionale che, nel
nome di Wagner, andava perseguitando Verdi. I focolai di tale polemica erano la Francia, a far
capo dalla rappresentazione di Don Carlos, e l'Italia, dopo Aida.
Le opinioni che venivano dalla Francia erano più che altro teoriche perché la musica di Wagner
era praticamente sconosciuta dopo il rifiuto provocato dalla prima parigina di Tannhauser del
1861. In seguito un piccolo gruppo di intellettuali cercherà di colmare questo scarto diventando
wagneriano più per ragioni letterarie che musicali. In Italia i contorni della polemica erano più
seri perché le opere di Wagner venivano rappresentate in diversi teatri e riscuotevano sempre
un successo tale che inevitabilmente nasceva il confronto con quelle di Verdi. Ogni
trasformazione del linguaggio musicale di Verdi faceva nascere il sospetto che ci fosse un
riferimento a Wagner e questo amareggiava Verdi anche perché le apparenze davano ragione a
quelle voci superficiali ma in grado di attecchire. Il punto principale era che tanto Verdi quanto
Wagner tendevano alla stessa concezione del teatro, al cosiddetto dramma musicale come
punto d'arrivo del teatro musicale europeo che Wagner, a differenza di Verdi, aveva
lucidamente teorizzato. La questione del dramma musicale, salvo pochissime eccezioni, era
comune e largamente condivisa in tutta l'Europa musicale e, sotto quell'aspetto, non era certo
una questione spinosa per Verdi: ciò che lo amareggiava era che non si comprendesse
l'evoluzione profonda della sua drammaturgia e del suo linguaggio musicale che volevano
rappresentare la complessità della psicologia umana, creare lo specchio del mondo filtrato
attraverso una profonda sensibilità etica. L'ideale di Verdi era quello di "inventare il vero" 1, cioè
di mostrare la varietà e la verità delle vita e delle passioni, il bene ed il male; l'emblema era il
teatro di Shakespeare che Verdi aveva amato per tutta la vita. Wagner aveva alle spalle una
tradizione sinfonica, i problemi di struttura delle opere di Verdi, invece, venivano affrontati e
risolti a partire dalla vocalità. Nel periodo di crisi tra Aida e Otello, che non fu inoperoso, Verdi
riscoprì i valori della polifonia rinascimentale e in essa la funzionalità della musica al testo ed
alla sua metrica e la continuità del discorso musicale, che in Wagner fu di natura sinfonica, per
Verdi fu polifonica e non è un caso che questa evoluzione di Verdi maturasse in una
composizione di genere sacro, come la Messa da requiem in cui trionfa la polifonia.
Fra i sessanta ed i settant'anni Verdi non presentò nuove opere: il suo impegno era rivolto alla
direzione della Messa da requiem, alla preparazione della versione francese di Aida da mandare
all'Opéra ed alla composizione di un'Ave Maria e di un Pater Noster, su parafrasi di brani dalla
Divina Commedia, la cui prima esecuzione avvenne a Milano il 18 aprile 1880. Chi proprio non ce
la faceva ad accettare l' inoperosità operistica di Verdi era il suo editore, Giulio Ricordi, che
stava diventando sempre più importante sia nell'azienda di suo padre Tito che nel panorama
dell'editoria musicale internazionale.
Nel 1879, nel corso di una cena di gala dopo una trionfante esecuzione della Messa da requiem
diretta da Verdi, Ricordi portò casualmente il discorso su un soggetto da trarre da Otello di
Shakespeare. Nel corso della conversazione l'editore fece, altrettanto casualmente, accenno al
nome di Boito come pos1 M. Porzio (a cura di), Verdi. Lettere. 1835-1900, p. 425.
sibile librettista. Nei confronti di Arrigo Boito non era ancora del tutto sopito il rancore
provocato in Verdi dalle affermazioni fatte dal poeta nel corso della famosa cena seguita alla
rappresentazione dei Profughi fiamminghi di Franco Faccio.
Nonostante i due si fossero incontrati nel 1871 a Bologna dove si erano recati entrambi per il
Lohengrin di Wagner e l'incontro fosse stato civile, se non cordiale, non si erano più rivisti in
seguito. Ricordi aveva più volte sollecitato Verdi a prendere in considerazione il libretto Nerone
di Boito, che non era più uno sconosciuto nel campo dell'opera, specialmente dopo che il suo
Mefistofele, fischiato clamorosamente nel 1865, era stato rimaneggiato ed accolto con entusiasmo
a Bologna nel 1875.
A Giulio Ricordi sembrò che il progetto su Otello non avesse lasciato indifferente Verdi e ne
approfittò per mandare Boito, accompagnato da Faccio, a far visita al maestro al Milan, l'albergo
in cui scendeva quando si trovava a Milano. Tre giorni dopo Boito entrava nuovamente al
Milan con una traccia del libretto e ne usciva con l'incoraggiamento a proseguire. Verdi, dal
canto suo, fu riservatissimo sulle intenzioni che aveva per Otello e ce ne volle prima che
capitolasse alle insistenze di Ricordi e Boito: per ripicca, dato che detestava essere tirato per la
giacca, aveva sparso la voce fin dal 1879 che aveva in mente un'opera su soggetto comico e che,
in ogni caso, non l'avrebbe certo affidata a Casa Ricordi per la pubblicazione. Ricordi, sconvolto,
cercava in tutti i modi di forzare la mano a Verdi e gli propose una visita di Boito a Sant'Agata
che Verdi rifiutò. Accettò invece di leggere il libretto sul quale però non fece commenti e tornò
agli impegni presi lasciando Ricordi comprensibilmente sulle spine. A metà del 1880 Ricordi
convinse Boito, reduce dal successo londinese di Mefistofele, a mandare a Verdi la nuova
versione del finale terzo di Otello. Sul problema del finale si aprì una corrispondenza tra Boito e
Verdi: il rapporto, fino a quel momento indiretto e pieno di diffidenza da parte del maestro
nell'impegnarsi, diventò più limpido e diretto anche se le riserve di Verdi erano ancora tante.
Boito, invece, si era impegnato nel lavoro senza garanzie e ce l'aveva
78 Giuseppe Verdi
messa tutta per portare il lavoro in porto e per accontentare Verdi che, alla presentazione del
libretto, non aveva trovato di suo gradimento il finale terzo, quello in cui Otello, dopo aver
insultato Desdemona, sviene. Verdi voleva concludere l'atto con un gran concertato, secondo lo
stile del finale operistico e così scrisse a Boito pretendendo da lui la stessa condiscendenza che
era abituato a pretendere dai librettisti e comunque continuò a rifiutarsi di riceverlo a
Sant'Agata perché questo avrebbe significato impegnarsi. Nell'impossibilità di discutere la cosa
a voce, Boito cercò di seguire le indicazioni di Verdi ma ad una richiesta precisa di far
concludere l'atto con un attacco di Turchi, scrisse quel che pensava, insistendo sull'atmosfera da
incubo che doveva aleggiare sulla vicenda e sulla necessità di mantenere Otello e Desdemona
nell'"ambiente intimo di morte, creato con tanto studio da Shakespeare"2 aggiungendo che
l'attacco dei Turchi gli dava l'impressione "come di un pugno che rompe la finestra di una
camera dove due persone stavano per morire asfissiate"3. Questa lettura di Shakespeare era
abbastanza nuova per Verdi: Boito gli offriva un' interpretazione allucinata, secondo la chiara
impronta della Scapigliatura; gli offriva una propria soluzione del finale che non era quella di
Verdi ma della quale Verdi riconobbe il valore.
Non fu però ancora persuaso a comporre l'opera e trovò la propria tela di Penelope nel vecchio
progetto di rielaborazione del Simon Boccanegra; docilmente Boito lo seguì e lo accontentò con
rapidità. L'opera, aggiustata nel testo in molti punti e rimaneggiata nella partitura per
adeguarla ad esigenze espressive che non erano più le stesse di quando era stata composta,
andò in scena il 24 marzo 1881, protagonisti il tenore Francesco Tamagno ed il baritono Victor
Maurel al quale Verdi promise che avrebbe scritto per lui la parte di Jago, impegnandosi così
formalmente a comporre l'opera e facendo tirare a Ricordi un sospiro di sollievo. Sulla
promessa fatta a Maurel cominciaro2 C. Casini, Verdi, p. 337
3 Ivi, p. 337.
no le indiscrezioni sui giornali, a partire dal titolo della nuova opera che si diceva sarebbe stato
Jago. Nonostante tutto il fervore suscitato dall'idea di una sua nuova opera, per i due anni
seguenti Verdi non mise mano alla composizione, indifferente anche ai moretti di cioccolato che
a Natale Ricordi gli mandava con il panettone; studiava però con l'amico napoletano Domenico
Morelli, pittore, quale sarebbe stato l'aspetto dei personaggi principali, in particolare quello di
Jago4.
Verdi si era ripresentato alla Scala per dirigere personalmente le prove del Don Carlos andato
in scena il 10 gennaio 1884 in una nuova edizione. Da anni egli aveva l'abitudine di
sovrintendere personalmente alle varie fasi della messa in scena, tanto più in quegli anni dato
che si era convinto che i teatri, da soli, non fossero sufficienti a garantire rappresentazioni di
qualità e fosse perciò indispensabile la presenza dell'autore. La nuova edizione del Don Carlos
ottenne un successo modesto anche per il cast dei cantanti in cui l'unico nome di spicco era
quello del tenore Tamagno; in compenso il pubblico era nuovo perché formato dal gruppo
sociale emergente del nuovo stato italiano, la borghesia che teneva le redini della finanza e
dell'industria e che formava il nuovo gruppo culturale di riferimento. Dopo la terza replica,
Verdi lasciò Milano per Genova ed in marzo Ricordi ricevette una lettera di Boito che lo
informava di aver appreso personalmente da Verdi che, finalmente, era cominciata la
composizione di Otello, ma Boito, durante un banchetto offertogli a Napoli dopo una recita di
Mefistofele,
4 Lettera a Domenico Morelli, 24 settembre 1881, da Sant'Agata «[...] Ma se io fossi un attore, ed avessi a rappresentare Jago, io vorrei avere
una figura piuttosto magra e lunga, labbra sottili, occhi piccoli vicini al naso come le scimmie, la fronte alta che scappa indietro, e la testa
sviluppata di dietro: il fare distratto, nonchalant, indifferente a tutto, frizzante dicendo il bene e il male quasi con leggerezza ed avendo l'aria
di non pensare nemmeno a quel che dice; cosi che se qualcuno avesse a rimproverargli: Tu dici un'infamia egli potesse rispondere: Davvero?...
non credevo..., non ne parliamo più!...Una figura come questa può ingannar tutti, e fino ad un certo punto anche sua moglie. [...]».
In M. Porzio (a cura di), Verdi. Lettere 1835-1900, p. 352.
si era lasciato sfuggire alcune dichiarazioni che offesero moltissimo Verdi e misero addirittura
in forse la nuova opera.5. Verdi scrisse a Faccio per comunicargli che il libretto di Otello era a
disposizione di Boito, ne facesse pure quel che voleva; Faccio impiegò un mese per incontrare
Boito e parlargli della lettera e Boito si affrettò a scrivere a propria volta a Verdi, profondendosi
in scuse, spergiurando che il cronista aveva capito male e riportato peggio il senso della sua
dichiarazione e ringraziando Verdi per la delicatezza di non avergli scritto direttamente
preferendo i buoni uffici di un comune amico. Le scuse non smossero Verdi più di tanto e si
ammorbidì soltanto quando gli giunse un nuovo brano del libretto, il «Credo» di Jago. In realtà
Verdi aveva stima di Boito ma non lo giudicava abbastanza docile per i suoi gusti e pensava che
certe lezioni di comportamento gli fossero più che utili. Evidentemente la lezione funzionò
perché, dopo aver sancito la pace, Boito si tenne diligentemente a disposizione di Verdi per
tutto il tempo che il maestro ritenne di dover impiegare per la composizione di Otello. La
partitura fu terminata alla fine del 1886 e nel corso dell'anno Boito ebbe anche l'incombenza
delle audizioni per il ruolo di Desdemona. Per le parti di Otello e Jago era stato lo stesso Verdi a
decidere gli interpreti: il tenore Tamagno, per la cui voce era stato scritto l'«Esultate» del primo
atto, nel ruolo di Otello, il baritono Maurel nel ruolo di Jago.
Il 4 gennaio 1887 Verdi e la moglie arrivarono a Milano: nel giro di qualche giorno sarebbero
cominciate le prove di Otello. La sera di santo Stefano era stata rappresentata Aida con lo stesso
cast di cantanti che avrebbero interpretato Otello:
5 Sul giornale "Roma" apparve questa dichiarazione di Arrigo Boito: "Interrogato sul Jago che egli ha scritto per Verdi, fece notare come
dapprima avesse trattato simile argomento a malincuore ma che poi, terminato il libretto, provò rammarico di non poter essere egli il maestro
destinato a metterlo in musica." In C.Casini, Verdi, cit. p. 346.
oltre a Tamagno e Maurel c'era il soprano Romilda Pantaleoni6 a cui era stato affidato il ruolo di
Desdemona.
Il 5 febbraio, sotto la direzione di Franco Faccio, la Scala presentò la prima di Otello: il successo
fu enorme, l'opera persuase i critici e affascinò il pubblico che si raccolse sotto le finestre
dell'albergo di Verdi reclamandone a gran voce la presenza mentre Tamagno intonava
nuovamente l'« Esultate».
Dopo la terza replica Verdi tornò a Sant'Agata; il successo di Otello lo aveva strappato solo
momentaneamente alla conta degli amici che, uno dopo l'altro, erano morti lasciando vuoti
incolmabili: l'ultima, in ordine di tempo, era stata Clarina Maffei, morta nel 1886, alla quale, in
una lettera di qualche anno prima, aveva confidato che «la vita non è altro che una sequela di
dispiaceri»7.
La lettura di Shakespeare, che aveva accompagnato Verdi fin dagli anni dell'amicizia giovanile
con Carcano, accreditato traduttore delle opere shakespeariane, era stata fondamentale nella
sua drammaturgia. Verdi aveva affrontato il teatro di Shakespeare con Macbeth, realizzato nel
1847, e con Re Lear che, mai realizzato, aveva rappresentato, per un verso, un fallimento ma
anche la prova che quel modello teatrale era sfuggente. Verdi sosteneva che il problema
fondamentale era la mancanza di librettisti all'altezza del compito ma il problema fu risolto
dalla collaborazione con Boito. Le ragioni però erano altre, la mancanza di librettisti era una
scusa: c'erano delle differenze importanti tra la vocazione drammaturgica di Verdi e quello che
egli ricavava dalla lettura di Shakespeare e, tra queste, quella fondamentale riposava
nell'impossibilità per Verdi di trovare una visione del mondo e dell'umanità simile alla propria.
In Shakespeare Verdi aveva trovato il realismo al quale aveva sempre aspirato nella sua carriera
teatrale, la preci6 Su Romilda Pantaleoni si veda P. Adkins Chiti, Almanacco delle virtuose, primedonne, compositrici e musiciste d'Italia. Dall'A. D. 177 ai
giorni nostri, Novara: De Agostini, 1991, p. 118.
7 Lettera a Clara Maffei del 2 maggio 1879, da Sant'Agata. In M. Porzio (a cura di) Verdi. Lettere. 1835 — 1900, p. 80.
sione nel definire le psicologie umane e la loro complessità, la grande varietà di eventi e la loro
espressione nei diversi registri, dal tragico al grottesco ma non aveva mai trovato il giudizio
morale, il rigore nello stabilire un confine tra il bene ed il male che erano invece i veri e propri
pilastri della drammaturgia verdiana. Tutte le volte che Verdi aveva messo in discussione la
propria concezione drammaturgica aveva cercato di partire da Shakespeare, di modellarsi sul
grande inglese, inseguendo spasmodicamente un miraggio che lo aveva portato alla
composizione della Forza del destino, dove sfruttò al massimo le possibilità della tradizione, e di
Don Carlos, in cui tali possibilità vennero forzate al punto da arrivare ad una composizione ai
limiti della rappresentabilità teatrale. Dopo Aida, nei quindici anni di silenzio che seguirono,
Verdi si mise nuovamente in discussione, come negli anni giovanili, per dare nuova veste alla
propria invenzione melodica e ripensare il rapporto tra questa ed il testo fino a ricavarne
un'espressione diretta, immediata, quella che costruisce la situazione e che egli stesso definì
«parola scenica». Il coronamento di questa ricerca lo raggiunse in Otello, opera nella quale si
concentrarono la vocazione al realismo e la drammaturgia: Verdi tornò alla sintesi ed alla
chiarezza con mezzi espressivi talmente evoluti da poter essere considerati nuovi. Egli asciugò
la vicenda, privandola delle digressioni così frequenti nel Don Carlos e restringendola ad un
protagonista unico, così come aveva fatto in Rigoletto e Traviata.
Il fine di tale decisione, cioè di concentrarsi sul dramma della gelosia di Otello, fu quello di
stabilire un contesto musicale omogeneo nel quale, per affinità o per contrasto, si inserissero
altri personaggi. Tornarono alcuni temi cari a Verdi: Otello è un marginale, condotto ai vertici
della gloria dall'eroismo ma questo non serve a guarire il suo senso d'inferiorità dovuto al fatto
di essere un uomo di colore, uno che deve il proprio successo a se stesso, in un mondo di
bianchi, per giunta aristocratici come Jago, Cassio e la stessa Desdemona. Il colore della pelle è
per Otello segno di un destino nefasto, come la gobba di Rigoletto o la condizione di cortigiana
di Violetta; egli è stretto tra la malvagità assoluta di Jago e l'assoluta innocenza di Desdemona,
ovvero tra i due tipi umani in cui si incarnano in maniera assoluta e manichea il male e il bene.
L'unica differenza rispetto al passato è che nell'animo di Otello il bene ed il male convivono e si
danno battaglia, scatenano tutti i suoi fantasmi portati all'eccesso dalla gelosia alla quale
contribuiscono, potremmo dire da presupposti distanti anni luce ma in misura uguale, sia Jago
che Desdemona che con il suo candore, la sua insistenza disarmante alimenta, senza saperlo,
l'incendio che devasta Otello. Ognuno di questi aspetti è reso da mezzi espressivi straordinari
che risolvono la linearità della drammaturgia. Nel primo atto ci sono due grandi parti che
culminano nel duetto d'amore, secondo il codice melodrammatico risalente a Rossini:
nell'introduzione la festa segue alla tempesta, suono puro che rievoca i suoni naturali e rende
subito l'idea dell'intenzione realistica di Verdi. Il coro riveste grande importanza in entrambe le
scene, spezzando la sostanziale omofonia con interventi di tipo trionfale, «Vittoria», e
descrittivo «Fuoco di gioia», arricchito dai preziosismi linguistici di Boito splende, s'oscura,
palpita, oscilla, lampeggia.
I personaggi principali sono caratterizzati dalla dualità: Otello passa dal trionfale «Esultate» del
primo atto al soffio incolore e graffiato del «Niun mi tema» del quarto atto passando per il largo
«A terra» del terzo atto, Desdemona canta «Splende il cielo, danza l'aura», inno alla sua
condizione di sposa felice, nel secondo atto per affidare tutte le sue paure e le incertezze di
persona normale che fatica a comprendere le ragioni della nascita e crescita improvvisa di tanto
furore all'«Ave Maria» del quarto atto, Jago si racconta nel «Credo» del secondo atto, si rivela
nel disprezzo di fronte ad Otello svenuto con «Ecco il Leon» del terzo atto, ma fugge davanti ai
suoi pari che gli ingiungono di discolparsi lasciando di sé un rabbioso «No!» nel quarto atto.
Otello non è tanto il punto di incontro tra Shakespeare e Verdi, quanto il punto d'arrivo della
drammaturgia verdiana nel senso che Verdi colse nella tragedia gli aspetti che meglio si
prestavano al suo modo di concepire il dramma; in Shakespeare egli colse aspetti assolutamente
attuali e Boito fu il garante di una lettura compiuta nell'intento di far cadere la barriera tra lo
schema tradizionale del melodramma e la rappresentazione della verità.
4.2. Tutto nel mondo è burla
(Falstaff, atto III, parte II)
Verdi fu sempre una persona schiva di onori per quanto riguardava se stesso 8 ma quando si
trattava di altri, soprattutto di grandi italiani allora il suo comportamento era diverso: per le
celebrazioni del centenario di Rossini, benché ottantenne Verdi si presentò sul podio della Scala
per dirigere la preghiera del Mosè, si oppose invece con tutte le sue forze al progetto di un
concerto celebrativo dei suoi cinquant'anni di carriera musicale e a quello di una sua statua
accanto a quella di Bellini alla Scala. Accolse invece volentieri gli omaggi che pervennero nel
1889 da tutta Italia, inclusi quelli di re Umberto I e di Giosuè Carducci perché sottolineavano lo
stretto legame del maestro con il sentimento nazionale.
8 In una lettera scritta a Giulio Ricordi il 9 agosto del 1898 Verdi si espresse in questo modo " Sono ora le cinque e leggo sul Corriere "Il
conservatorio di Milano s'intitolerà a Gius. Verdi". Per Dio, non ci mancava altro che seccare l'anima ad un povero diavolo come son io, che
non desidera altro che di star tranquillo e di morire tranquillo!...Ma cosa ho fatto di male per essere tormentato in questo modo!??...Fatemi la
carità di liberarmi e vi sarò eternamente grato...Telegrafate per conto mio a chi credete ma liberatemi da questo supplizio." Alcuni giorni dopo,
il 13 agosto, scrivendo sempre a Giulio Ricordi, Verdi rincarò la dose "Conservatorio "Giuseppe Verdi" è una stonazione! Un conservatorio ha
attentato (e non esagero) alla mia esistenza, ed io debbo sfuggirne fin la memoria. Se quel sant'uomo di mio suocero, sentita la sentenza dei
Profeti del Conservatorio nel Giugno 1832 m'avesse detto "Sento che la musica non è affare per te: è inutile perder tempo e spender denari.
Ritorna la tuo villaggio nativo, torna organista, lavora la terra e muori in pace". Era naturale. Ma a parte questo, chi sa, se io approvo
l'indirizzo degli studj dei nostri Conservatori?..." In M. Porzio (a cura di) Verdi. Lettere 1835-1900, pp. 92 / 93.
In quello scorcio di secolo la letteratura italiana si era arricchita di nuove presenze come
Fogazzaro e Verga, il teatro musicale stava per assistere alle rappresentazioni delle opere di
quegli artisti che sarebbero stati poi riassunti nel titolo di Giovane Scuola, cioè Mascagni,
Leoncavallo, Puccini. Il realismo nell'arte stava guadagnando a sè nuovi modelli culturali che
sopravanzavano il progresso verdiano nella trasformazione del teatro musicale. Verdi era
consapevole di quanto stava accadendo: teneva d'occhio gli emergenti come Puccini9, non
sottovalutava Leoncavallo e Mascagni, anzi, a quest'ultimo aveva offerto Re Lear, sicuro ormai
di non poterlo musicare più. Le sue opinioni sui musicisti che in qualche modo poteva
considerare come propri successori erano condizionate dal rapporto che gli pareva di cogliere
tra costoro e lo spirito nazionale, perciò non si fidava di Puccini, che vedeva troppo
condizionato dal teatro musicale francese o tedesco, quanto invece si fidava di Mascagni, del
quale coglieva una vena popolareggiante e spontanea. Sulle proprie opinioni e sui propri
giudizi Verdi fu sempre discreto e molto riservato, abituato com'era da tutta la vita a non subire
influssi di alcun tipo né sul lavoro né nella vita privata. Per quanto lo riguardava Verdi
continuava lo studio della polifonia vocale alla ricerca di un'espressività che, pur nella
molteplicità delle linee melodiche, lasciasse accessibile il senso della parola, quella ricerca di
espressività che lasciasse chiara e comprensibile la parola che egli aveva definito «scenica».
La concezione del teatro musicale di Verdi si era fatta,
9 A proposito di Puccini, così scrisse Verdi a Opprandino Arrivabene il 10 giugno 1884 "...Ho sentito di molto bene del musicista
Puccini...Segue le tendenze moderne, ed è naturale, ma si mantiene attaccato alla melodia che non è moderna né antica. Pare però che
predomini in lui l'elemento sinfonico! niente di male. Soltanto bisogna andar cauti in questo. L'opera è l'opera: la sinfonia è la sinfonia, e non
credo che in un'opera sia bello fare uno squarcio sinfonico, pel sol piacere di far ballare l'orchestra. Dico per dire, senza nissuna importanza,
senza la certezza d'aver detto una cosa giusta, anzi colla certezza d'aver detto cosa contraria alle tendenze moderne...". In M. Porzio (a cura di),
Verdi. Lettere 1835-1900, p. 432.
nel tempo, molto articolata e difficile, diversa e lontana dall'immediatezza canora di stampo
popolare che circolava nel cosiddetto «verismo musicale»; la ricerca di Verdi era verso una
tecnica nuova, radicata però nella tradizione polifonica che risaliva fino a Palestrina e da lui al
canto gregoriano: in questo senso va intesa la celebre frase «Torniamo all'antico e sarà un
progresso» scritta all'amico Francesco Florimo, bibliotecario al Conservatorio di Napoli, nel
187110. Verdi sperimentò questo ideale a partire dalla composizione dell'Ave Maria su scala
enigmatica11intrapresa quasi per risolvere un rompicapo armonico proposto sulla «Gazzetta
Musicale di Milano» da un musicista che si chiamava Adolfo Crescentini, a cui si aggiunsero
altri tre pezzi polifonici di natura spirituale: le Laudi alla Vergine Maria, su testo di Dante
Alighieri, lo Stabat Mater ed il Te Deum, composizioni che avrebbe tenuto volentieri private se
Boito non si fosse dato la pena di farle eseguire prima a Parigi nel 1898 e, l'anno dopo, alla Scala.
Nel frattempo era nato il progetto di Falstaff, che Verdi accarezzava da moltissimo tempo. Sul
progetto erano corse molte voci: si diceva, ad esempio, che Verdi lo avesse già in cantiere dal
1869 con la collaborazione di Ghislanzoni per il libretto, anche perché nessuno nell'ambiente
musicale ignorava come da tempo Verdi cercasse un soggetto per un'opera comica. Per Boito
non fu difficile riunire tutti gli elementi, fonderli insieme e, dopo un colloquio con Verdi,
inviargli una traccia del libretto. Verdi, che nel frattempo si era riletto tutte
10 Ivi, pp. 412-413.
11 Ivi, pp. 387/ 388, lettera ad Arrigo Boito, 6 marzo 1889, da Genova « Partendo da Milano gettai sul fuoco alcune carte fra le quali anche
quella tale sgraziata Scala [...] Dite che non val la pena di occuparsi di queste inezie ed avete ben ragione. Ma che volete! Quando si è vecchi si
diventa ragazzi, dicono. Queste inezie mi ricordano i miei diciotto anni quando il mio Maestro si divertiva a rompermi il cervello con bassi
consimili. E più credo che di questa Scala si potrebbe fare un pezzo con parole per es: un Ave Maria, aggiungendo però alla quarta del Tono al
Tenore od al Soprano la stessa Scala con modulazioni e disposizioni differenti [...] Un'altra Ave Maria! Sarebbe la quarta! Potrei così sperare
d'esser dopo la mia morte, beatificato.»
le opere di Shakespeare nelle quali compariva il personaggio sir John Falstaff, accettò di
comporre l'opera ma a condizione che ciò avvenisse nel segreto più assoluto. Nel marzo del
1890 il libretto era terminato insieme alla composizione del primo atto. La composizione non fu
veloce, fu costellata di numerose pause ma, finalmente, dopo il consueto rituale delle prove a
porte chiuse, l'opera andò in scena alla Scala il 9 febbraio 1893. Il successo fu straordinario, non
soltanto per l'entusiasmo destato nel pubblico e nei critici ma anche per la singolarità di un
artista ottantenne che era riuscito ad imporre una novità.
Concepire Falstaff non rappresentò per Verdi soltanto una vittoria contro il decadimento fisico e
intellettuale ma anche un nuovo ripensamento della propria drammaturgia e del linguaggio
musicale e un distacco dal suo consueto atteggiamento di autore teatrale. Il fatto che fosse una
commedia a concludere una serie pressochè initerrotta di drammi è il segno di una
trasformazione profonda, dell'acquisizione di una personalità nuova. Il simbolo della tradizione
dell'opera comica italiana era stato Rossini che metteva in gioco i meccanismi musicali comici,
grotteschi o paradossali che fossero con grande oggettività, cogliendone razionalisticamente il
lato comico. Per Verdi il teatro includeva una dimensione morale alta, un fondamento etico con
una ricerca di giudizio sul bene e sul male, sui loro effetti in relazione all'umanità, secondo una
visione romantica ottocentesca che considerava solo l'aspetto drammatico della vita. Nello
stretto legame tra arte e morale c'era la più profonda differenza sia con Rossini che con il teatro
del primo Ottocento, nei quali, in nome della comicità e delle passioni non esisteva alcuna
tensione etica.
Comporre Falstaff, cioè una commedia, significava smettere l'abito mentale del necessario
giudizio sulla vita e sul mondo e sostituirlo con l'osservazione distaccata e questo, in Verdi, fu
un atto di saggezza, come guardare le cose in un modo diverso nella consapevolezza di essere
ormai giunto al traguardo della propria vita e che le idee espresse in altri luoghi ed in altri
tempi avevano un valore storico, relativo ai tempi in cui erano state espresse. Falstaff fu un gesto
coraggioso per un vecchio quale era Verdi, compiuto con ironia e serenità, con spirito
manzoniano, distaccato eppure partecipe dei fatti della vita. Verdi avrebbe voluto
rappresentare Falstaff in un teatro piccolo, non alla Scala: da vecchio, forte anche della gloria
che si era conquistato negli anni, si era concesso il lusso, o la civetteria, di scrivere senza pensare
al teatro che avrebbe ospitato la sua opera ma di farlo solo per sé.
Falstaff richiedeva però anche che si prendessero decisioni fondamentali dal punto di vista
drammaturgico e da queste si facesse discendere la scelta del linguaggio musicale più
appropriato. Il punto di partenza era riprodurre l'oggettività dell'opera comica italiana
fondendone i vari livelli e, soprattutto, rievocarne i caratteri fondamentali: il movimento
rapido, l'allegria, l'osservazione acuta dei tipi umani e degli eventi. Il linguaggio che occorreva
doveva esser molto avanzato, analitico ma anche sintetico, capace di assumere i toni della
conversazione e di lievitare nell'immagine paradossale, molto realistico e lontano dagli schemi
dell'opera comica che, comunque, si erano esauriti con Rossini. Il problema era di nuovo quello
della «parola scenica», come stretta commistione tra canto e tono della lingua quotidiana. Il
libretto scritto da Boito corrispondeva alle esigenze di Verdi: spiccava un protagonista assoluto
nel quale si trovavano tutte le sfumature della commedia, gradasso e cinico nel primo atto,
coprotagonista, insieme a Ford, di una situazione buffa ed equivoca, oggetto di una allegra
burla da parte delle donne che prima lo nascondono e poi lo fanno cadere in acqua; patetico nel
monologo del terzo atto poi nuovamente coinvolto nella scena buffa e surreale nel parco di
Windsor nell'ultimo atto. Causa delle sue disgrazie è l'amore che porta a due donne, Alice e
Meg, dichiaratamente per denaro ma con un inconfessato risvolto sentimentale e amaro in colui
che, paggio bello e sottile del duca di Norfolk, si trova in un corpo distrutto dai bagordi,
costretto a gloriarsi, pubblicamente, della propria enorme pancia ed a scoprire, in malinconico
segreto, che i capelli gli stanno inesorabilmente diventando grigi. Gli altri, non personaggi ma
gruppi umani, appaiono e scompaiono davanti agli occhi di Falstaff rapidamente, come
proiezioni dei suoi desideri e delle sue paure: così la matura spensieratezza delle comari, la
petulanza volgare di Cajus, Pistola e Bardolfo, il tenero amore di Fenton e Nannet-ta. Soltanto
Ford rimane un personaggio isolato che raggiunge una punta di drammaticità.
La decisione drammaturgica per Falstaff fu di comporre un'opera basata sulla conversazione e,
in subordine, su un protagonista. Verdi aveva puntato prima sulla natura dell'opera e poi
sull'intreccio e sui personaggi, atteggiamento eccezionale per lui che, per la prima volta,
lasciava che il linguaggio musicale prendesse il sopravvento sulla materia teatrale. Anche
questa era un'inversione di rotta, un rimettersi in discussione rispetto al passato. La prova che
meglio accredita questo atteggiamento sta nel fatto che Verdi accolse quasi per intero il libretto
di Boito senza interventi che invece in Otello erano stati abituali; quanto alla musica, stando al
carteggio, egli lavorò con lentezza12. Tutto questo contribuisce a spiegare perché Falstaff sia
l'opera più ricca di invenzione musicale della produzione verdiana: le idee sono numerose,
meno sfruttate ed impiegate secondo un metodo nuovo per Verdi eppure perfettamente
sintonizzato sulla commedia.
Lo strumento duttile della realizzazione dell'abbandonarsi a nuove idee, temperato dagli anni e
dall'esperienza per cui Verdi non correva più il rischio di cadere nel puro professionismo, era il
canto, non certo strofico e neppure troppo vicino al parlato. Con Otello Verdi aveva
perfezionato l'uso di due tipi di canto: quello realistico, a cui appartengono le grida di Otello e
12 Ivi, p. 376, lettera a Giulio Ricordi, 1° gennaio 1891 "...Vi dissi e ripeto scrissi per passare il tempo... Quand'ero giovine, benché malaticcio,
poteva restare al tavolo le 10, fin le 12 ore!! lavorando sempre; e più di una volta mi mettevo al lavoro alle 4 del mattino fino alle 4
pomeridiane con un semplice caffé in corpo...e lavorando sempre senza fiato. Ora non posso. Allora io comandavo al mio fisico ed al tempo.
Ora ahimé! non posso [...]."
le insinuazioni di Jago, e quello simbolico che riproduceva nella melodia le immagini e le
metafore presenti nel testo.
In Falstaff questi due tipi di canto si rincorrono e si susseguono con grande rapidità e non sono
affidati soltanto alle voci ma anche agli strumenti, la parola pronunciata dalla voce è ripetuta
anche dall'orchestra. Nella funzione simbolica del canto l'orchestra entra soprattutto quando il
tono diventa colloquiale e gli strumenti hanno un ruolo mimetico rispetto alle voci: un esempio
è nel monologo di Falstaff nel terzo atto, quando sir John, dopo aver malinconicamente
meditato sulla sua pinguedine e sui «peli grigi» che suonano quasi come un messaggio di
morte, si rianima con un bicchiere di vino e punteggia il canto di parole come trilli. . . grillo . .
.brilli... trillo . . . trillante...13 seguite dall'orchestra nella concatenazione melodica. Le possibilità
avrebbero potuto esse infinite ed offrire alla sensibilità ed all'esperienza di Verdi infinite
soluzioni e sfumature. Trattare il canto in questo modo implicava una parità quasi assoluta tra
l'orchestra e le voci che, in alcuni casi, assumono valenze strumentali. Si tratta di un andamento
madrigalistico in cui voci e strumenti si scambiano le funzioni.
Sotto l'aspetto della sintassi musicale, Verdi articolò il canto sulla parola, sulla frase e sulle
interpunzioni con una tecnica molto simile a quella degli antichi polifonisti, per spingersi oltre,
fino al canto gregoriano che riecheggia in certi interventi di Bardolfo e Pistola nel primo atto e
riporta al lavoro compiuto in quel grande laboratorio che fu la Messa da requiem. Sotto l'aspetto
complessivo dell'architettura dell'opera il discorso diventa ancora più complesso perché si va
da episodi colloquiali, come la prima parte del primo atto, verso l'espansione graduale
13 Michele Porzio (a cura di), Verdi. Libretti, Milano: Mondadori, 2005, p. 456 "[...] Buono. Ber del vin dolce e sbottonarsi al sole, / dolce cosa!
Il buon vino sperde le tetre fole / dello sconforto, accende l'occhio e il pensier, dal labbro / sale al cervel e quivi risveglia il picciol fabbro dei
trilli; un negro grillo che vibra entro l'uom brillo. / Trilla ogni fibra in cor, l'allegro etere al trillo / guizza e il giocondo globo squilibra una
demenza / trillante! E il trillo invade il mondo!!!."
in episodi più complessi, come il primo incontro delle comari, ad esempio o la scena della caccia
a Falstaff in casa di Ford, fino alla scena del parco, nella seconda parte del terzo atto, dove si
recupera il pezzo di carattere melodrammatico. È, appunto, un recupero, cioè una citazione che
esprime il clima fantastico ed approda ad una singolare conclusione: quando tutte le maschere
sono svelate a Falstaff, finalmente consapevole, appare il contrappunto nel fugato «Tutto nel
mondo è burla», non senza che il minuetto delle nozze, vere, di Fenton e Nannetta e di quelle,
strambe, di Cajus e Brandolfo, abbia evocato un precedente inaspettato, il Mozart del Don
Giovanni, sul quale, da giovane, Verdi aveva passato ore ed ore di studio, evocato con lucidità,
rigore ed una punta di malizia.
Nell'insieme dei materiali impiegati e ricavati dalla tradizione europea senza distinzione
temporale o geografica, Falstaff si pone in antitesi al melodramma. Di tutti i valori coltivati con
cura da Verdi nel corso di decenni di carriera, quello che ebbe vita più lunga fu il realismo.
Verdi aveva raggiunto, già ai tempi del Nabucco, l'ideale di fare del teatro musicale italiano
qualcosa che non avesse bisogno di aggettivi e nel corso della vita aveva rappresentato il
realismo ed il lirismo attraverso il dramma e la commedia. Se Le nozze di Figaro di Mozart
avevano rappresentato il tornante stilistico del teatro musicale del XVIII secolo, Falstaff occupa
lo stesso ruolo nei confronti del teatro che definiamo contemporaneo perché da quel capolavoro
estremo discendono, quasi in linea retta, come per una sorta di filiazione, opere come Pelléas et
Mélisande di Debussy o come Wozzeck di Alban Berg.
Quello che è straordinario riguardo a Falstaff, è la capacità di Verdi di creare un'opera che da
sola si ponesse come sintesi e contrappeso di tutto un passato: ciò poté accadere perché Verdi si
sentì libero di affidarsi alla propria invenzione, di osare in chiave comica lo sperimentalismo dal
quale si era tenuto ben distante per tutta la vita. In questo Falstaff fu liberatorio per il suo autore.
Dopo la rappresentazione di Falstaff Boito tentò di persuadere Verdi a cimentarsi su un altro
libretto desunto da Shakespeare, Antonio e Cleopatra ma dovette arrendersi all'antipatia che
Verdi provava per i personaggi della tragedia e, soprattutto, alla disapprovazione di
Giuseppina nei confronti di quel progetto.
Era cominciato il cammino della vecchiaia e dell'inoperosità, per altro relativa, di Verdi: terminò
la composizione dei Pezzi sacri, che Boito volle far eseguire a Parigi sostituendo Verdi dal quale
ricevette comunque minuziose istruzioni, secondo le abitudini dell'anziano maestro, si occupò
personalmente dell'allestimento francese di Otello, in cui aveva inserito anche il balletto, di
rigore per la Francia, e di Falstaff, aveva spedito l'ormai più che fedele Boito a Londra a ritirare
in sua vece la laurea ad honorem che gli era stata conferita dall'Università di Oxford.
Nel 1896 aveva fatto cominciare i lavori per la Casa di riposo che sarebbe stata inaugurata nel
1900: alla sovrintendenza dei lavori volle Camillo Boito, fratello del suo librettista ed amico
Arrigo, con il quale litigò sull'impostazione della Casa di riposo che egli non voleva con
l'aspetto di un luogo triste, dove musicisti e cantanti anziani non avessero alcuna comodità, ma
pretendeva accogliente e confortevole come un bell'albergo. Nonostante il progetto, così
sistemato, fosse diventato più costoso rispetto al precedente, l'ebbe vinta lui.
Il soggiorno parigino di Verdi e Giuseppina per l'esecuzione di Otello e Falstaff fu l'ultimo che i
due anziani coniugi fecero insieme. Giuseppina era malata e la sua salute declinava
rapidamente.
Come Violetta, in Traviata, Giuseppina ebbe una grave crisi di polmonite, l'11 novembre 1897,
che sembrò superata il giorno seguente. Come Violetta, Giuseppina peggiorò in fretta e morì nel
pomeriggio del 14 novembre.
Dopo la scomparsa della devota ed intelligente compagna di oltre cinquant'anni, la vita di Verdi
riprese in modo abbastanza normale.
Nel gennaio 1901, mentre si trovava a Milano nel suo solito albergo poco distante dalla Scala, fu
colpito da un malore e rimase privo di conoscenza fino alla morte avvenuta il 27 gennaio di
quell'anno.
Fu sepolto nel Cimitero Monumentale, il feretro seguito da una folla immensa, accompagnato
dal cordoglio di tutti, potenti e gente comune. Un mese dopo le esequie, su sue precise
istruzioni, la salma fu traslata nell'oratorio della cappella della Casa di riposo, accanto a quella
di Giuseppina.
Il sacerdote che gli aveva somministrato i sacramenti giurò che in punto di morte l'anziano
maestro si sarebbe convertito, la lunga stretta di mano ricevuta dal morente non gli lasciava
alcun dubbio, mentre le gerarchie ecclesiastiche, che dubbi invece ne avevano, preferirono
lasciare che i funerali si svolgessero con un cerimoniale quasi laico.
Di fatto Verdi che, a capodanno del 1901, aveva accolto quasi con fastidio gli auguri del vescovo
di Milano, convinto che fossero di cattivo augurio ma avrebbe voluto essere sepolto con la
partitura del Te Deum, aveva già scritto il proprio commiato dalla vita nel modo che sapeva,
coerente con ciò che egli era sempre stato e lo affidò proprio alla sua ultima creatura, a Falstaff:
nell'autografo della partitura Arturo Toscanini trovò un biglietto che Verdi aveva vergato per sé
solo dopo aver concluso la scrittura dell'opera «Tutto è finito / Va, va,vecchio John, / Cammina
per la tua via / Fin che tu puoi. / Divertente tipo di briccone / Eternamente vero sotto /
Maschera diversa in ogni / Tempo, in ogni luogo. / Va, va/ Cammina, cammina, / Addio!!!!».
Un addio a se stesso, alla musica, all'incessante ricerca del modo più etico, rigoroso e, proprio
per questo universale, di rappresentare i drammi del bene e del male su questa terra.