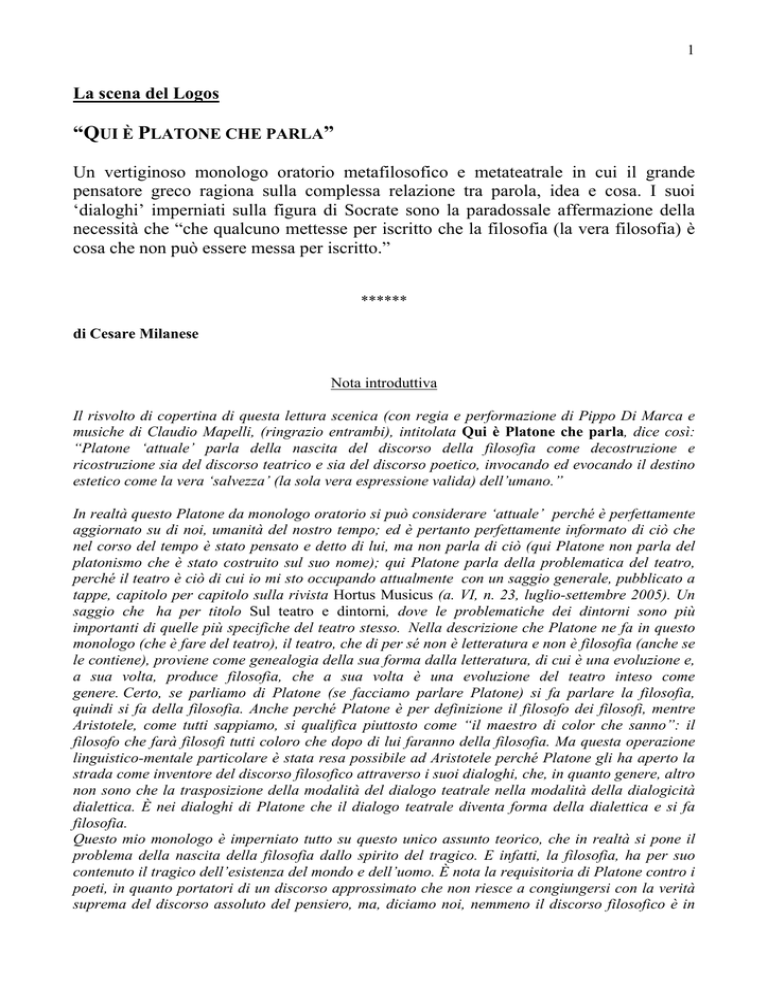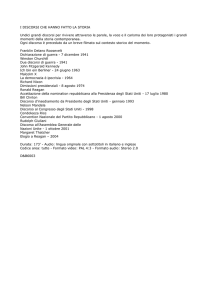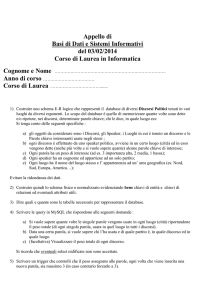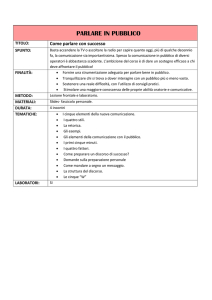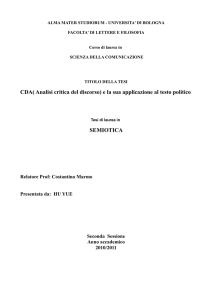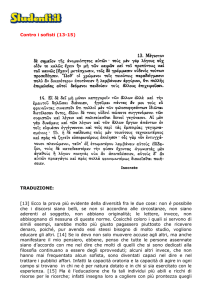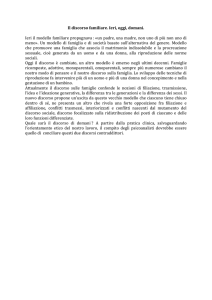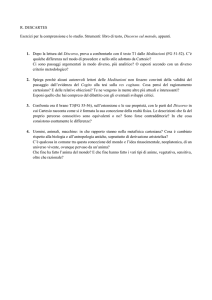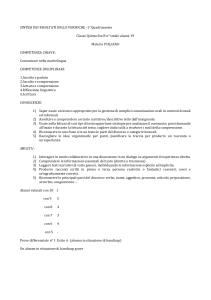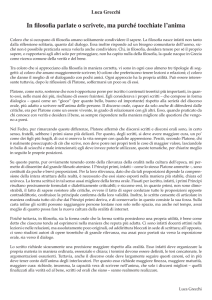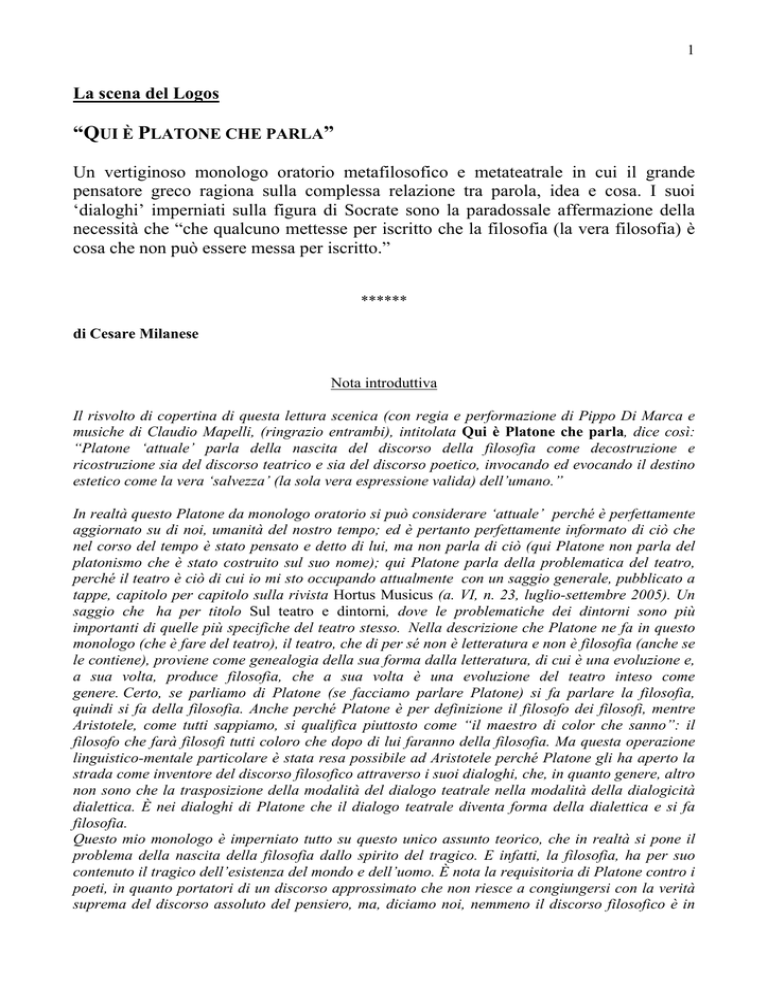
1
La scena del Logos
“QUI È PLATONE CHE PARLA”
Un vertiginoso monologo oratorio metafilosofico e metateatrale in cui il grande
pensatore greco ragiona sulla complessa relazione tra parola, idea e cosa. I suoi
‘dialoghi’ imperniati sulla figura di Socrate sono la paradossale affermazione della
necessità che “che qualcuno mettesse per iscritto che la filosofia (la vera filosofia) è
cosa che non può essere messa per iscritto.”
******
di Cesare Milanese
Nota introduttiva
Il risvolto di copertina di questa lettura scenica (con regia e performazione di Pippo Di Marca e
musiche di Claudio Mapelli, (ringrazio entrambi), intitolata Qui è Platone che parla, dice così:
“Platone ‘attuale’ parla della nascita del discorso della filosofia come decostruzione e
ricostruzione sia del discorso teatrico e sia del discorso poetico, invocando ed evocando il destino
estetico come la vera ‘salvezza’ (la sola vera espressione valida) dell’umano.”
In realtà questo Platone da monologo oratorio si può considerare ‘attuale’ perché è perfettamente
aggiornato su di noi, umanità del nostro tempo; ed è pertanto perfettamente informato di ciò che
nel corso del tempo è stato pensato e detto di lui, ma non parla di ciò (qui Platone non parla del
platonismo che è stato costruito sul suo nome); qui Platone parla della problematica del teatro,
perché il teatro è ciò di cui io mi sto occupando attualmente con un saggio generale, pubblicato a
tappe, capitolo per capitolo sulla rivista Hortus Musicus (a. VI, n. 23, luglio-settembre 2005). Un
saggio che ha per titolo Sul teatro e dintorni, dove le problematiche dei dintorni sono più
importanti di quelle più specifiche del teatro stesso. Nella descrizione che Platone ne fa in questo
monologo (che è fare del teatro), il teatro, che di per sé non è letteratura e non è filosofia (anche se
le contiene), proviene come genealogia della sua forma dalla letteratura, di cui è una evoluzione e,
a sua volta, produce filosofia, che a sua volta è una evoluzione del teatro inteso come
genere. Certo, se parliamo di Platone (se facciamo parlare Platone) si fa parlare la filosofia,
quindi si fa della filosofia. Anche perché Platone è per definizione il filosofo dei filosofi, mentre
Aristotele, come tutti sappiamo, si qualifica piuttosto come “il maestro di color che sanno”: il
filosofo che farà filosofi tutti coloro che dopo di lui faranno della filosofia. Ma questa operazione
linguistico-mentale particolare è stata resa possibile ad Aristotele perché Platone gli ha aperto la
strada come inventore del discorso filosofico attraverso i suoi dialoghi, che, in quanto genere, altro
non sono che la trasposizione della modalità del dialogo teatrale nella modalità della dialogicità
dialettica. È nei dialoghi di Platone che il dialogo teatrale diventa forma della dialettica e si fa
filosofia.
Questo mio monologo è imperniato tutto su questo unico assunto teorico, che in realtà si pone il
problema della nascita della filosofia dallo spirito del tragico. E infatti, la filosofia, ha per suo
contenuto il tragico dell’esistenza del mondo e dell’uomo. È nota la requisitoria di Platone contro i
poeti, in quanto portatori di un discorso approssimato che non riesce a congiungersi con la verità
suprema del discorso assoluto del pensiero, ma, diciamo noi, nemmeno il discorso filosofico è in
2
grado di attingere questa dimensione assoluta. Anzi, il discorso filosofico, nella sua ricerca del
discorso assoluto non fa altro che risolversi nel suo meglio, che è un ritorno all’effetto del discorso
puramente estetico. Il discorso tragico della filosofia si salva, come valore, solo perché nel suo
ciclo altro non fa che ritornare al discorso poetico. Certo il Platone di questo monologo parla ex
cathedra, perché egli rimane il cercatore dell’assoluto che parla in nome dell’assoluto, ma in
questo caso il suo discorso si pone come metadiscorso, che essendo un discorso a risoluzione
estetica, diventa pertanto un discorso metapoetico. Diciamo metaletterario. Il discorso giusto da
fare qui al Meta-teatro, che è il suo posto giusto. Allora diciamo che se non altro, prendendo a
pretesto, il metadiscorso sul teatro di Platone abbiamo fatto della metaletteratura, cioè alla fin fine
soltanto della letteratura, che forse è il vero scopo di tutto ciò, di tutto questo dire e ridire
infinitivo, come il pensiero di Platone stesso.
******
Qui è Platone che parla
Nella mia dottrina si dice (qui è Platone che parla) che le cose di maggior valore non sono affidate
al pensiero detto (al pensiero parlato) (alle parole), bensì al pensiero che pensa senza le parole. A
maggior ragione (le cose di maggior valore) non sono affidate alle parole scritte (alle parole che si
leggono): le parole impresse nei segni che si ‘inscrivono’ sulle superfici materiche dei supporti che
vengono messe a nostra disposizione a questo scopo dalla pietra inerte ma pur viva, dal telàme
lavorato con arte, dal fogliame papirico, dal pellame pergamenico, dal legname piallato, dalla cera
stesa, dalle lastre metalliche, dai fogli cellulosici, dalle pellicole filtrate dalla luce e dalla luce stessa
che a sua volta filtra i suoi segni sugli schermi eletronizzati del vetro, che li rispecchia.
Come ben vedete ed udite, essendo tutti voi riuniti, davanti a me, nell’agone virtuale della parola
sostanziata e sostanziale (essendo questa una delle molteplici definizioni qualificanti il teatrico), in
questo momento io mi sto rivolgendo a voi dall’apsis (la curvatura ellittica) di questo testo che non
è stato scritto per essere propriamente uno scritto che si legge (quindi non è propriamente uno
scritto), bensì per essere uno scritto che è stato scritto per essere parlato (quindi, come appare
evidente dal fatto che lo sto parlando, esso non è intrinsecamente, dal momento che non lo è
esclusivamente, uno scritto). Sarò ancora più esplicito: questo non è nemmeno un testo vero e
proprio. Non ne possiede la forma. È senza forma. Aspira addirittura a non averla, cercando in
questo modo di essere la vettoriale esplicazione di un discorso, il quale andando al di là della forma
(che per quanto esaustiva e perfettiva è pur sempre limitativa) va al di là di se stesso, in quanto mira
a trascendersi. Ho detto in quanto mira a trascendersi, non in quanto ci riesca. Si tenta. Ed è questo
l’intento.
Guidato da tale intento, questo discorso ambisce a conformarsi, ad adeguarsi, a coincidere con la
natura del discorso dell’essere (il fieri stesso dell’essere nell’atto del proprio compimento d’essere),
che essendo per ciò stesso logos è al tempo stesso prodotto e produttore di pensiero: un tendere al
di là di se stesso per confermarsi, in questo modo di procedere, come se stesso. Lo chiameremo
allora un discorso che si avvale di un testo che va al di là di se stesso come testo e che in quanto
anche scritto si avvale dello scritto per andare al di là di se stesso come scritto. Ripeto: discorso di
scrittura e insieme di non scrittura, che fa ricorso alla parola, sia detta che scritta, per andare al di là
della parola sia detta che scritta, essendo questo l’intrinseco del linguaggio, vale a dire essendo
questo (consistendo in questo secondo la mia filosofia) l’intrinseco della vera filosofia: attingere
attraverso la parola il pensiero che si compie senza la parola. Il risalire dal pensiero parlato al
pensiero che è soltanto pensato: avere accesso all’atto del pensiero come pensiero in atto.
Diciamolo pure: all’atto puro.
Quell’orizzonte di pensiero verso il quale tutta la mia filosofia si orienta, al pari di questo mio
discorso che teatralmente è un monologo, ma che al tempo stesso (sempre teatralmente) è un
3
dialogo, perché è rivolto a voi che ascoltandolo gli rispondete, sia pure con il vostro solo silenzio.
Anche il silenzio di parola è un atto dialogante: un atto di parola nel quale la parola si fa presente
come assente. E ciò è pur sempre dialogo che si compie. Ora, che cosa è mai il dialogo, questo
congegno generativo della dialogica, organon del dato e del portato della dialettica (della ragione
dialettica), sia della dialettica del pensare e sia della dialettica del pensato? Il dialogo quindi è un
atto del pensiero estrinsecato nelle parole, che nel nostro caso, ora, sta equiparando me, quale
soggetto che parla, a voi, quale soggetto che ascolta. Qualificati grammaticalmente, noi (io e voi) in
questa nostra esplicitazione, generata dalla dialogica, siamo funzioni della stessa cosa, vale a dire di
questo stesso dialogo che ci genera in qualità di dialoganti.
Sempre teatricamente intendendo, potremmo definire questo mio discorso (questo mio testo non
testo, per quanto privo della forma che lo rende un testo) un monologo-dialogo o un dialogomonologo, intenzionalmente rivolto a dar luogo alla formazione-trasformazione di noi (io e voi)
quali soggetti del dialogo in oggetti generati dallo stesso dialogo. La dialogica che è
grammaticalmente generativa del soggetto è anche dialetticamente generativa della formazionetrasformazione in oggetto di ciò che essa pone come soggetto. D’altronde è per questa via che la
dialettica, di cui la dialogica è l’organon generativo, ci rende reali: ci fa soggetti ed oggetti al tempo
stesso. Consiste in questo il ciclo della parola (la lexis). Ora volendo mettere in figura (in opsis)
questo concetto del ciclo della lexis (della parola), si può benissimo dire che questo mio discorso,
espresso come monologo-dialogo e come dialogo-monologo, è estrinsecato nel discorso stesso
nella figura (l’opsis) del cerchio, immagine del discorso perfetto, essendo il cerchio l’immagine di
un concetto perfetto. È il divino Pitagora che lo disse. Così come lo è (perfetta) l’idea di verità, di
cui io, Platone, sono amico più che di me stesso.
Perciò, in vista di questa idea di verità, qui io colgo l’occasione di precisare la mia visione generale,
che invece, in generale, è stata male interpretata è soprattutto è stata fuorviata dal suo profondo
intendimento proprio nel suo punto essenziale: la concezione dell’essere. Duemilacinquecento anni
falsificati da un colossale equivoco (un equivoco cosmogonico addirittura, trattandosi della visione
totalitaria dell’essere), durante i quali si è andata propalando l’erronea convinzione che attribuisce a
me l’origine dell’edificio mentale a cui i posteri (vale a dire anche voi) hanno dato (avete dato) il
nome di metafisica. E non è vero.
Io, nelle mie opere, non ho mai asserito che l’essenza dell’essere avesse il suo fondamento nella
sussistenza di un essere che sia sovrastante all’essere (come la metafisica suppone od asserisce che
debba dover essere). Io non ho mai separato l’essere dall’essere (il logos dalla physis e la physis dal
logos), se mai ho constatato la praticabilità (ipotetica, si badi) dei discorsi sulla separazione
dell’essere , ma per l’appunto solo come congettura di un’argomentazione sulla predicabilità della
separazione dell’essere. Ma questa è tutt’altra cosa che l’asserire la separazione reale (ontica ed
ontologica insieme) dell’essere; quindi tutt’altro, parlando vulgatamente, che l’aver fatto
volgarmente della metafisica. Io, se mai, sono colui che per primo (e in quanto primo sono rimasto
anche l’unico) che ha argomentato intorno a questa congettura come presupposto e come movente
discorsivo interno del procedere del pensiero dialettico e della forma del discorso dialogico che ci
consente di parlare dell’essere: questione tutta umana, tutta nostra. Pertanto inevitabile.
Si sono lette male (molto male) le mie opere (i miei Logoi sokratikòi). Non si è capito (non si è
voluto capire) che nei miei dialoghi (dispute in forma di controversia) si è voluto far mostra
dimostrativa del principio con cui i discorsi vengono generati; i discorsi filosofici soprattutto, vocati
di per se stessi a far ricorso all’ipotesi della presenza, nella realtà dell’essere, di principi assiomatici
da porre come ipostasi di fondamento alle realtà (alle entità, sia ideali sia materiali dell’essere).
Questo è ciò che fa sì che gli stessi discorsi filosofici, la cui validità deriva tutta dal fatto di essere
essi strutturalmente rispecchiamenti degli esseri di cui parlano, possano estendere a se stessi la
struttura d’essere degli esseri di cui parlano. Sono questi fondamenti dell’ipotetico assiomatico che
fanno procedere i nostri discorsi (va da sé filosofici), che per loro natura ci portano, una volta
praticati da noi, ad inserire noi stessi, la nostra mente, il nostro spirito, il nostro essere stesso, in
quella dimensione d’essere che ci è tanto misteriosamente consustanziale: quella che fa sì che la
4
nostra intenzione d¹essere (la nostra ‘intenzionalità’) si compia come tensione d’esistenza (diventi
‘tensionalità’ d’esistenza) verso l’ideatività di un’aggiunta di esistenza nell’essere: la dimensione
dell’ulteriore dell’essere e della stessa nostra esistenza. Sta tutta in questo punto d’acme la mia
filosofia. Considerata così, la mia filosofia si configura pertanto come una sublimazione dell’essere
nell’atto in cui si compie come essere (physis intesa come logos e logos inteso come physis), quindi
è tutt’altro che una metafisica, come va dicendo che sia, credo come vorrebbe che fosse, la vostra
diceria.
Diceria che è stata infatti causa del risultato del disordine dei discorsi che si sono succeduti dopo
che io ne avevo formulato la procedura costitutiva e creativa, ma con l’intento di procurare ad essi
lo spazio di un’espansione sempre più crescente dell’ordine unitario dei discorsi stessi verso il
conseguimento e il compimento di un ordine superiore (vale a dire superatore) dei discorsi tutti,
che è il vero fine della vera e retta filosofia. Purtroppo la diceria (la falsa filosofia) suscitatrice dello
spettro della metafisica (orrore degli orrori, blasfemamente a me attribuita), nelle sue due varianti
principali (come tra Scilla e Cariddi): da un lato il demonismo del nichilismo (la suggestione della
fine del tutto come il fine del tutto), dall’altro l’imposizione che decreta l’appartenenza della nostra
esistenza ad un’essenza d’essere, che è priva della vera essenza dell’essere... Dicevo, purtroppo la
diceria sulla metafisica diffusa nelle varie filosofie da diceria, ha fatto proliferare (plurificare) una
congerie di discorsi micidialmente inficiati dall’intrusione di una controdialettica dei discorsi stessi,
il che comporta la distruzione stessa dei discorsi. Come si può facilmente arguire la conseguenza
non può essere che quella di un esito da hybris. Conseguenza questa che ben prima di me, prima
della istituzione formalizzante dei miei dialoghi, era già stata evidenziata dalla dialogica della
tragedia, la cui logica esige che ad ogni hybris succeda come risultato ineluttabile la nemesi
castigativa.
C’è un prima di me e c’è un dopo di me nelle teoresi dei discorsi sull’essere, vale a dire dei discorsi
poetici e dei discorsi filosofici, essendo entrambe queste due specie di discorsi dei discorsi
sull’essere. Quelli che dopo di me hanno deviato da me sono diventati un cumulo di discorsi confusi
che si sono sovrapposti ed interposti l’uno sull’altro e l’uno dentro l’altro (un magma): flusso di un
fiume in piena che corre verso il caos. Agglomerato di discorsi in perdita di sè, che come il fiume
eracliteo tutto coinvolge e tutto travolge trascinando le acque (tutti i discorsi) nelle correnti delle
rapide, che le stanno portando (che li stanno portando) alle cascate entropiche nel precipizio
dell’irreversibile.
A questo punto è facile comprendere che questa mia disamina vive del fatto che si sottrae al destino
senza destino a cui il bulicante fiume dei discorsi porta tutti i discorsi alienati dal mio. Il mio
discorso invece vi si sottrae perché si ispira allo spirito del Nus di cui parla il divino Anassagora: il
pensiero che attraversa il vortice senza farsi dissolvere dal vortice che esso stesso genera. Tale vuol
essere il mio discorso, posto al confronto con tutti gli altri discorsi. E tra questi i discorsi perduti dei
poeti, che pur furono validi quand’erano aurorali, prima di me, ma non più tali dopo di me; anzi non
validi più già prima di me, dopo che la tragedia con la sua fine mise fine (è proprio il caso di dire
tragicamente) al valore dei discorsi poetici. Che tragedia fu quella, anche per la tragedia stessa!
Quale enorme frastuono mentale accompagnò la messa a fine del discorso poetico mediante la
messa a fine del discorso tragico, che fino ad allora lo conteneva e lo riassumeva! Io più di tutti
posso testimoniare quanto fu disastroso lo sconcerto che seguì ad una simile fine dei discorsi del
poetico, perché più di tutti allora io mi trovavo in balia di questo fiume eracliteo dei frastuoni dei
discorsi che cominciarono a diventare rumore, a diventare confusi in seguito a quel crollo
catastrofico.
Tutt’ora, mentre ne parlo, mi pare ancora di sentirlo questo frastuono mentale, a tal punto di
intensità da farsi percepire come se fosse fisicamente reale: un frastuono che accomunava il fragore
delle acque del fiume ed il fragore del vento che gli scorreva sopra come se fosse la voce che ne
rappresentava il linguaggio. In questo stesso momento, ripresentandosi in me questa figurazione
possente, e risentendone il rumore, non solo mentalmente, ascolto il suono della mia stessa voce
come un’aggiunta al bovonìo di quel doppio frastuono: lo sciabordare delle acque del fiume
5
eracliteo e l’ululare del vento che vi tumultua al di sopra in quell’andare verso il precipizio della
cascata, dove tutti i frastuoni (compreso quello aggiuntivo della mia voce) finiscono per assordarsi
nella loro stessa esplosione catadupica della caduta nel vortice del nulla.
Fu questa la terribile messa a fine del senso d’esistenza dei discorsi poetici, di cui io sono stato non
solo il principale testimone, ma in qualità di inventore del discorso filosofico vero addirittura
l’artefice, sia pure impersonale, quindi un quasi demiurgo. Ed è una messa a fine che che tuttora
perdura, dal momento che gli umani hanno continuato e continuano assurdamente e stoltamente a
produrre dei discorsi poetici. Pare addirittura che questo errore di locuzione debba durare per
sempre. Ovviamente il per sempre del tempo dell’umano, non il per sempre del tempo del tempo
puro e semplice, del tempo in sé. A questo l’umanità non arriva. Con ciò su tutto ciò, pur tuttavia, si
effonde un grande senso di pietà tutta umana che non si può non provare assistendo al demenziale
sciamannìo dei poeti che hanno continuato a dibattersi (e si dibattono ancora) tra le onde del fiume
dei loro discorsi confusionati e confusionanti che li trascinano come festuche ed investiti dalle
raffiche di questo vento-voce che lacera ancora di più le loro parole che nascono già lacerate dalle
loro bocche.
Nel vederli così sbraccianti ed urlanti in questa loro mistica da dolore non è possibile, essendo
anche noi, come loro, dei viventi fondati sull’umano, non farsi prendere dallo stesso dolore,
soprattutto al pensiero che anche noi (e voglio dire anch’io), per un segmento della vita (il tratto di
giovinezza senz’altro) e forse anche per tutta una parte dell’intero percorso della vita, si è stati e si è
simili a loro stessi e loro stessi restano simili a noi, sia pure solo in parte, anche se noi (noi filosofi,
intendo) (sia ringraziata la ragione, sia ringraziato il Nus, o se si vuole gli dei che hanno consentito
che noi si sia dei filosofi) non siamo più dei loro. Eppure, malgrado questa enorme distanza che si è
stabilita tra noi e loro (noi, i veri filosofanti e loro, i variegati poetanti), resta pur sempre un vincolo
(dovuto alla comune filia per la parola) e insieme a questo resta pur sempre anche la memoria
ancestrale della comune appartenenza al genere della specie umana, sicché, se non altro per il
richiamo ispirato dal sentimento primario e insopprimibile dell’empatia con chi (più o meno
consapevole che sia della sua condizione infelice, in cui essi, i poetanti, si trovano), ci induce a
condividere emotivamente una gran parte (forse la parte tutta intera) della loro angoscia. È quella
parte alta del sentire che si prova sempre quando si accompagna qualcuno che ci è stato affine ad
avviarsi all’imbarco della sua deriva, nel corso della quale, ormai si sa, non ci saranno approdi che
offrano salvezza.
Per cui: “Addio, poeti, addio! Il fiume eracliteo del reale sarà per voi un turbinoso Stige, un
Acheronte in tempesta, che vi trascinerà dal tremore all’orrore. L’errore l'avete compito voi. È tutto
vostro. Ma io, filosofo superiore, vi capisco”. E come se li capisco! Anch’io sono passato
temporaneamente attraverso il loro delirio. Anch’io un tempo sono stato come loro. Ero, anzi, uno
di loro. O per lo meno io credevo di esserlo, giacché volevo essere dei loro. Nel tempo della mia
fervente giovinezza ho scritto da poeta una vasta congerie di composizioni: composizioni epiche,
composizioni liriche, individuali e corali, ripercorrendo tutta la successione evolutiva dei generi
poetici fino ad allora espressi dalle grandi tradizioni poetiche, che ebbero il loro culmine di
conclusione nelle grandi composizioni tragiche.
Dopo Eschilo, dopo Sofocle e dopo Euripide che altro si sarebbe potuto scrivere di più poetico se
non continuando a comporre composizioni tragiche? Così deliberai di diventare anch’io un
individuo sommo in qualità di trageda. Naturalmente mi illudevo e mi sbagliavo.
Non mi ero accorto che il discorso poetico, dopo la sua evoluzione e confluenza nel discorso
tragico, aveva perduto il suo valore di teoresi d’ascesa verso le idee e la verità: non era più
sostititutivo e preparatorio del discorso filosofico vero. Pertanto ho continuato per lungo tempo a
scrivere, inutilmente, in discorso poetico, compitando inutili tragedie. Tuttavia, in quel tempo, c’era
stato il mio incontro destinale con l’uomo che ha saputo essere l’esempio dell’uomo superatore
dell’uomo, il divino e demoniaco Socrate intendo: il rivelatore della parte divina del pensiero, il
concetto quale entità di unità del teoretico e dell’etico, del noetico e del pratico, dell’eidetico e
dell’estetico: ciò consentì a me, più tardi, nel tempo della mia più piena maturità, di farne il nesso
6
dialettico di identità tra il logos e la physis avendo individuato in questo stesso nesso la natura della
teoresi suprema, quella del Nus di Anassagora, il divinissimo.
Vissi quel periodo da discepolo come se fosse duplice, sdoppiando anche me stesso. Mentre di
giorno, durante le conversazioni con Socrate, mi conformavo al pensare seguendo la procedura del
pensare di Socrate, di notte per lo più, quando mi capitava di ritrovarmi con il me stesso di prima,
con ciò che ancora prima ero stato, riprendevo a scrivere in poetico le opere, che in seguito ho
bruciato, ma che però tuttavia servirono a far maturare in me la convinzione finale che il discorso
poetico era ormai un genere di discorso che era giunto alla meta della sua estinzione di valore in via
definitiva. Me ne convinsi appieno dopo la morte per filosoficidio del mio grande maestro, il cui più
grande portento è certamente costituito dall’aver saputo utilizzare la mortalità come argomento di
prova dell’esistenza dell’immortalità: il massimo dell’essere a cui può giungere l’umano.
Ero arrivato ai miei ferventi trent’anni quando quest’uomo che ci ha indicato la via del superamento
dell’uomo fu messo a morte per decisione congiunta di due perversità, quella degli arconti e quella
del popolo. Fu allora, per ribellione di ragione, che cominciai a concepire l’idea di una Repubblica
assoluta, il cui governo dell’umano avesse come suo fine l’escludere dall’esercizio del potere sia
l’arcontato che il demos. Idea tutta sublimamente politica la mia che tuttavia non si è ancora
concretizzata ed affermata, pur essendo trascorso un sufficiente numero di secoli durante i quali
essa si sarebbe potuta rendere attuabile. Ma che in futuro certo lo sarà, perché se non sarà il corso
tutto della storia umana rimarrà senza scopo. Impegnai tutto il resto della mia vita per concepire
questa idea di Repubblica, mentre al contempo redigevo il resto delle mie altre opere (i Logoi
sokratikòi: i dialoghi che tutti voi conoscete, che tutto il mondo conosce e da cui tutte le vere
filosofie, e anche le non vere, venute dopo di essi sono derivate e derivano). Impresa che cominciai
non prima di aver sottoposto a revisione le opere che avevo scritto in poetico in precedenza e che
avevo nel frattempo messo in disparte.
Mi accorsi con orrore che erano opere morte, ma non proprio perché io non fossi stato capace di
produrle vive, bensì perché era arrivato il tempo in cui tutti i discorsi poetici, così fecondi di verità e
di realtà in passato, avendo concluso la loro parabola di evoluzione, epocalmente stavano
diventando discorsi morti. Decisi allora di distruggere queste mie opere precedenti, tutti
componimenti epici, lirici e tragici accumulati negli anni della mia giovinezza e scritti prima della
morte di Socrate. Ne feci un grande rogo, in cui ad una ad una bruciai le mie false tragedie, le mie
false poesie, i miei falsi poemi.
Ahimè come ricordo quel giorno, che fu il giorno di una enorme liberazione, ma anche di un
enorme dolore. Ciò al flusso di luce calda e all’alito vibrante del rogo, ed investito dall’urto di mille
disperazioni aggiunte l’una sull’altra, ad una ad una come le pagine delle mie opere gettate tra le
fiamme, assieme al sentimento purificante, ma nondimeno straziante, dell’autoliberazione del peso
di un errore e di una colpa che se ne stavano acquattati in me fin da quando mi ero accinto a
scriverle quelle opere: ah il peso del rimorso per aver alimentato e preservato l’errore! A ciò si
aggiunga la pena da rimorso per l’atto di vilipendio e di ripulsa col quale in realtà rinnegavo, col
rinnegare i miei scritti, soprattutto me stesso, mandando in cenere ed in vento il valoriale della
tensione di vita che aveva retto il tempo della mia giovinezza, nutrita di volontà di verità, credendo
di averla in qualche modo conseguita, quasi, con quelle stesse opere, frutto delle mie veglie d’anni
su di esse, e che ora, con le mie stesse mani, consegnavo al nulla.
Fu sconvolgente: mi sentivo vile, ma al tempo stesso mi avvertivo eroico. Comunque lacerato anche
per quella parte di me ancora sotto l’influsso dell’idea che la parte divina dei discorsi risiedesse,
prima di tutto, nel discorso precipuamente poetico. Così mentre gettavo ad uno ad uno i miei
giovanili cartigli tra le fiamme, quel mio sentire d’amore per quel mio tempo così tanto amato, ero
io che pronunciavo contro me stesso la sentenza che più di ogni altra è temuta da chi vuol essere
considerato un poeta, da chi vuol essere considerato un trageda: “Tu non sei, non sei mai stato e non
sarai mai un poeta. Tu non sei, non sei mai stato e non sarai mai un trageda”.
Mai più come allora in vita mia mi sentii escluso dal bene della vita, mai più come allora
sperimentai il che cos’è l’essere messi a morte pur restando in vita. Davanti al rogo dei rotoli dei
7
miei scritti piansi le mie più calde lacrime che le fiamme stesse rendevano addirittura roventi. La
notte stessa di quel giorno in cui gettai nel rogo le mie opere fui visitato da un sogno. Nel sogno ero
di nuovo alle prese con un rogo, interamente impegnato a continuare l’opera di distruzione di
volumi di pergamene e di rotoli di papiri, buttati nelle fiamme come se fossero cataste: ma non le
mie, questa volta, bensì addirittura le opere dei grandi pensatori, che furono i miei predecessori, i
fondatori di tutti i grandi discorsi filosofici, che hanno preceduto ed ispirato il sorgere delle mie
stesse opere, che oso dire per l’appunto grandi: i Logoi sokratikoi, che fecero anche di me un
immortale.
Anche quel sogno fu per me un’esperienza del tremendo. Se, durante il giorno, bruciando le mie
opere, mi ero sentito un empio solo verso di me, durante il sogno era come se fossi diventato un
empio verso l’insieme del meglio dell’umanità tutta quanta. E tuttavia mi sentivo sorretto da una
forza che chiamerei senz’altro demoniaca, di cui mi sembrava di essere diventato un emissario,
essendo quella una forza che in sé prefigurava (faceva presagire) di essere una di quelle forze il cui
fine è quello di dar l’avvio alla fine delle cose del mondo: anch’io così come un titanide del nulla.
Eccitato e incitato da quell’impeto nuovo, mai provato prima, davo di piglio con furore entusiastico
a quel lavoro di pura distruzione, che era sacrilego sì, quindi profondamente angosciante, ma anche
liberatoriamente esaltante. Lavoro bracciantile, certo, lavoro da gretto manovale, vile di per se
stesso, ignobile senz’altro, ma non di meno anche nobilitante ed esaltante nel poter dar di piglio, a
bracciate su bracciate, a rotoli di papiro e a volumi a libro di pergamene con gli scritti degli uomini
più eccelsi, da gettare in un rogo che li trasforma in fiamme, in fumo, in vento, in cenere.
Intanto all’interno del vortice del rogo, tra l’ondeggiare delle fiamme come cortine che aprivano e
chiudevano dei varchi, vedevo un balenare di figure simil-umane, riconoscibili a tratti come i
simulacri dei filosofi sommi, dei quali io stavo gettando nei gorghi delle vampe le opere immortali,
di per sé indistruttibili. Il primo che riconobbi fu il simulacro del mio primo maestro, Cratilo, il
filosofo primo del linguaggio, colui che per primo (allievo del divino Eraclito) ha così ben indagato
(eracliteamente quindi) sul rapporto simulativo e insieme simulacrale che intercorre tra le parole e
le cose. Fu lui, Cratilo, l’iniziatore dei discorsi sui discorsi che mi indicava a dito, facendomeli
riconoscere via via che apparivano, i simulacri degli altri spiriti magni, a cominciare da quello
torreggiante del divino Eraclito. Dopo costui, ed insieme a costui variamente accoppiati (per aree
geofilosofiche): Parmenide, Zenone, Pitagora ed Empedocle; Talete, Anassimandro, Anassimene e
Democrito; e in contrapposizione allo stuolo sarcastico dei sofisti (i fenomenisti di allora e della
prima ora), ecco i fenomenologisti puri, i validi per sempre: i simulacri di Socrate e di Anassagora i
miei definitivi maestri.
Avevano tutti impresso sui loro volti trasfigurati quel sorriso enigmatico ed ironico che non saprei
definire meglio se non qualificandolo come olimpico. Ed olimpico era difatti lo scenario sotto le
volte del quale essi comparivano e mi guardavano con attenzione benevola, ma tuttavia irridente.
Guardavano e sorridevano, restando perfettamente in silenzio. Anzi evidenziando il fatto che
stavano in silenzio. Capii allora che gli spiriti magni comunicavano tra loro e con me senza aver
bisogno di ricorrere alle parole. Il loro era il pensiero puro, il pensiero che si compie come pensiero
che viene solo pensato. Capii altresì che quel loro parlare, quel loro dire, senza far uso della parola
altro non era che l’espressione (l’esposizione e la dichiarazione) di una precisa dottrina intorno alla
natura (sia nel valore e sia nel disvalore) della parola come entità del pensiero e come strumentooggetto della sua attività di asserzione). Quei simulacri, come linguisti, decisamente erano degli
eccelsi. Trovandomi ammesso al cospetto loro, mi avvidi che ciò che valeva per loro, per loro
elargizione suprema, valeva anche per me. Anch’io, percependo il loro pensiero attraverso il loro
silenzio che parlava, potevo a mia volta parlare a loro pur restando in silenzio. Anch’io, in quel
frangente, ero stato dotato del dono del pensiero solo pensato, del pensiero che parla e che intende
senza passare attraverso l’uso della parola.
La questione era questa. Si può attingere (e quindi conseguire) l’intima natura del pensiero che
rampolla dentro di noi ed insieme l’intima natura delle cose da cui vengono generate le cose che
stanno al di fuori di noi? Così dovrebbe essere, a quanto pare, per quel che appare esaminando il
8
rapporto che lega le parole e le cose. La parola non è forse il tramite d’unione tra il concetto e la
cosa (tra il concetto e la ‘sua’ cosa) (e tra la cosa e il ‘suo’ concetto)? Essendo essa, la parola,
un¹espressione del pensiero, non è essa il portato (e portatrice) della natura del pensiero? E al tempo
stesso, essendo essa stessa una cosa, non è essa il portato (la portatrice) della natura di se stessa in
quanto parola che si è fatta cosa, giacché la parola è pur sempre anche una cosa. È cosa.
Appunto, mi si rispose (e perciò mi risposi): se la parola è una cosa, in quanto cosa essa è attinente
alla sostanza di sé come parola-cosa, ma non inerente anche alla sostanza della cosa di cui essa
dichiara di essere la parola. È questo il paradosso della parola: intendere d’essere tramite di identità
tra l’idea e la cosa di cui è la parola, ma di essere a sua volta cosa, la cui identità non può
onticamente coincidere con l’identità della cosa di cui dice di essere la parola. In realtà la parola
non è identitaria né dell¹idea di cui dichiara di essere la parola, né è identitaria della cosa di cui allo
stesso modo dichiara di essere, appunto, la parola. La parola è un¹entità che non è in grado di
identificarsi né con l’idea né con la cosa, di cui dice di essere la parola, perché, prima di tutto non è
in grado di definire identitariamente se stessa, non essendo essa né interamente (esclusivamente)
(sostanzialmente) (onticamente) né idea né cosa. Pertanto, se essa non è atta a dar ragione di sé,
tanto più non è atta a dar ragione sia dell’idea, sia della cosa, di cui dice di essere la parola, in
quanto la sua identità non è (non si trova) in attinenza di identità né con l’una né con l’altra, né con
l’idea né con la cosa, di cui dice, per l’appunto, di essere la parola. E lo è, ma in quanto lo è, è cosa
altra e dall’una e dall’altra.
I simulacri degli spiriti magni che stavano al di là delle ondeggianti fiamme del rogo, che io,
diventato incendiario di biblioteche, in preda alla eccitante frenesia da solerzia del manovale
fuochista, tecnicamente idoneo a simile bisogna, avevo alimentato scartasfasciando furiosamente
nel fuoco (anch’esso, come il fiume, eracliteo per sua natura) tutte le loro opere; essi, i simulacri
degli spiriti magni, nella loro ieratica compagine, con quei sorrisi impressi nei loro volti illuminati
dal loro ultrasapere, dal quale con il loro arcano silenzio mi parlavano, mi fecero sapere che
l’argomento trattato, così come lo avevo recepito da loro e a loro ritrasmesso con il solo pensiero,
era arrivato al punto in cui doveva esattamente trovarsi. Ero nel giusto discorso e i simulacri degli
spiriti magni compiacentemente assentivano, ma al tempo stesso facevano presente, sempre
comunicando i loro limpidi pensieri attraverso il solo limpido pensiero, privo dell’attrito delle
parole, che il mio argomento era senz’altro giusto, ma che era giusto perché del tutto ovvio. Quel
che pensavo era difatti l’ovvio.
Il mio argomento altro non era che lo sviluppo elementare e lineare della dottrina di fondamento di
tutte le dottrine che riguardassero il problema della parola, sia che siano assertive (cioè a favore
della realtà di identità della parola con l’essenzialità dell’idea e con l’essenzialità della cosa, di cui è
la parola), sia che siano negative (cioè destitutive della realtà di questa identità della parola stessa).
L’argomento che avevo elaborato e detto (avendolo solo pensato) era lo schema di un teorema che
poteva valere come vero per ogni tipo di sistema di pensiero con cui si fosse affrontato il problema
della natura e dell’identità della parola, assiomatico o scettico che fosse tale sistema. Il mio
ragionamento (il mio schema di teorema), mi si disse dalla compagine dei simulacri degli spiriti
magni, era lo schema d’arrivo che sarebbe valso come dottrina idonea a sostenere tutte le logiche
possibili, anche a venire, intorno alla questione della natura e dell’identità della parola.
Per dirla in breve, il mio schema (dottrina secondo cui la parola è cosa altra dalla cosa di cui dice di
essere la parola e al tempo stesso è cosa altra dall’idea di cui dice di essere sempre la parola)
costituiva ed avrebbe costituito per sempre l’argomento di fondamento, indifferentemente, (secondo
la vostra terminologia) per tutti i platonismi e per tutti gli aristotelismi a venire; e quindi per tutte le
teorie pro e per tutte le teorie contro la validità o non validità ontologica della realtà della parola,
quelle sostanzialistiche e quelle nominalistiche, quelle attinenti ai domini del fenomeno e quelle
attinenti ai domini del noumeno. Insomma lo schema del mio teorema valeva, indifferentemente,
sempre per dirlo alla vostra stessa maniera, per ogni metafisica e per ogni fisica, future o non future
che siano. Lascio che siate voi a giudicare la quantità di stoltezza che è racchiusa in una simile
asserzione, che pone la distinzione tra una realtà fisica ed una realtà metafisica e tra una realtà del
9
futuro fisica o metafisica che essa sia ed una realtà del passato, anch’essa pensata come distinta in
fisica e in metafisica. L’essere del futuro, eracliteo o parmenideo che esso sia, platonico od
aristotelico che esso sia (sempre per parlare alla vostra stessa maniera) non sarà mai diverso
dall’essere dell’origine.
I simulacri degli spiriti magni, che avvertivano perfettamente il farsi ed il disfarsi di questi miei
pensieri, consequenziali d’altronde con il farsi ed il disfarsi nei processi dialettici dell’essere e di
qualunque cosa che si componga o che si compia nell¹essere, dall’al di là del globo (lo sfero) delle
fiamme, mostravano chiaramente di assentire. Per loro non soltanto erano giusti la procedura e il
risultato del mio pensato, ma risultavano giusti anche la procedura e il risultato del mio stesso agito:
buttare al fuoco i libri, i loro stessi libri, tutti quanti i libri, perché con questo gesto molto concreto
io stavo dando esecuzione ad una convinzione essenziale della vera filosofia, chiamata a giudicare
del dove in cui venga depositata la verità. Risposta: non certo nelle parole riportate dai libri, non
certo nelle parole scritte, quindi non certamente nei libri, i quali, pur non essendo del tutto falsi,
sono senz’altro impropri. Promettono di portarci in prossimità della verità, ma invece quasi sempre
ce ne allontanano.
Così siamo di nuovo sul ‘che cos’è la parola?’ C’è la parola pensata, c’è la parola parlata, c’è la
parola scritta. E tutte e tre, come si è visto, a vari gradi di imperfezione, sono forme del pensiero
imperfetto. E l’ultima di queste, la parola scritta, è addirittura la forma di un pensiero più che
imperfetto, essendo essa una cosa del tutto ferma, del tutto irrigidita nei suoi segni muti, muta del
tutto: è la parola che non parla, che non possiede la voce, che non sa rispondere a voce alla parola
corrispondente che la solleciti a voce. I libri sono muti e restano sempre muti. Se interrogati,
tacciono maestosamente; meglio sarebbe dire ottusamente. I libri non sono nient’altro che involucri
delle parole che dentro ad essi giacciono in un silenzio prossimo a quello delle tombe. Una parola
che non parla, in quanto non dispone della voce (o che non vibra come succede invece alla parola
pensata) non è una vera parola, proprio perché non è viva. Non vive. Una parola che non vive (lo si
può dire) è una parola che non c’è.
I simulacri degli spiriti magni continuavano ad assentire. Dapprima interpretai questo loro
consenso come un invito e un’ingiunzione a rinunciare allo scrivere: vi vidi l’emanazione di un
ordine del giorno filosofico, che decretava che anche per me era giunto il momento di buttar via la
penna (di spezzare il calamo) e di astenermi da allora in poi di trattare le cose della vera filosofia
per mezzo della scrittura. Ma in questo mi sbagliavo. I simulacri degli spiriti magni che avevano
perfettamente inteso questa mia versione, mi corressero subito: mi fecero chiaramente capire che il
privilegio dell’uso del pensiero esercitato in stato di astensione della parola, sia pensata, sia parlata,
sia scritta, spettava solo a loro, i capostipiti della vera filosofia. A me, invece, essi assegnavano il
compito di continuare a filosofare non soltanto facendo uso della parola parlata (come aveva fatto
Socrate durante la sua vita mortale), ma anche facendo uso della parola scritta (cosa che infatti
Socrate non fece mai). A me spettava invece l’espletamento di una funzione vicaria, surrogatoria e
successiva a quella stessa che fu praticata da Socrate con la parola solo parlata. Pertanto a me
incombeva l’obbligo di scrivere e trascrivere su ciò che l’eccelso Socrate aveva detto e fatto; e mi si
impose di farlo a beneficio di coloro che sarebbero venuti dopo di loro (e quindi anche di voi che
ora mi ascoltate nella vostra veste di pubblico ideale).
Questo perché, essi mi fecero intendere, era filosoficamente opportuno (anzi filosoficamente
indispensabile) che qualcuno mettesse per iscritto che la filosofia (la vera filosofia) è cosa che non
può essere messa per iscritto. E quel qualcuno dovevo essere io, Platone, colui che qui, ora, vi parla.
Ubbidii al mandato e mi misi all’opera. Compilai le mie opere (scritte) in forma di parola parlata,
elaborandole in dialogo, la forma del discorso del tragico come più vicina alla forma del discorso
dialettico per eccellenza, inteso come forma precipua del filosofico in sé. Ecco in che cosa è
consistita la grande impresa della mia grande opera: nell’aver trasformato il dialogo teatrale in
dialogo filosofico, avendo individuato in entrambi la loro essenza comune in quanto discorsi della
categoria del teatrico. Quindi non era vero, come avevo pensato bruciando le mie tragedie giovanili,
che io non fossi un trageda. Io non ero un trageda, quando scrivevo tragedie come tali, perché la
10
tragedia come genere era ormai cosa morta, che non poteva più procedere nella sua essenza tragica
se non procedendo in altro, trasformandosi in dialogo filosofico, donando lo specifico di sé (il
dialogo, appunto) al dialogo dialettico. E io ne divenni il demiurgo.
Io ho saputo diventare il filosofo che sono in virtù del mio aver saputo essere stato il trageda che ero
(e che tuttora sono); e lo sono in virtù del mio aver saputo, con i miei dialoghi, convertire il discorso
poetico (il discorso della teoresi del mitico) in discorso filosofico (il discorso della teoresi
dell’eidetico): dall’ipotetico del mito all’ipotetico dell’eidetico, dalle supposizioni del poetico alla
assiomaticità dell’ipostasi della convertibilità del logos in physis e della physis in logos. È
metafisica questa? No, se mai è metalogica. Dietro questa unità (dietro questa trascendentalità) del
teatrico e del teoretico da me operata, si è venuta formando tutta la prodigiosa congerie dei discorsi
umani e divini nei quali tutti voi vi trovate a dibattere da secoli e in cui alla stessa vostra maniera
verranno anche a trovarsi i vostri successori, tutti, nei secoli dei secoli, finché ne avrete, sia di
successori che di secoli. Ma ne avrete?
* ( Qui è Platone che parla: testo comparso su Hortus Musicus nel luglio-settembre 2005 e messo
in scena al “Metateatro” da Pippo Di Marca, anche come interprete, e musiche di Claudio
Mapelli, nel dicembre dello stesso anno. )