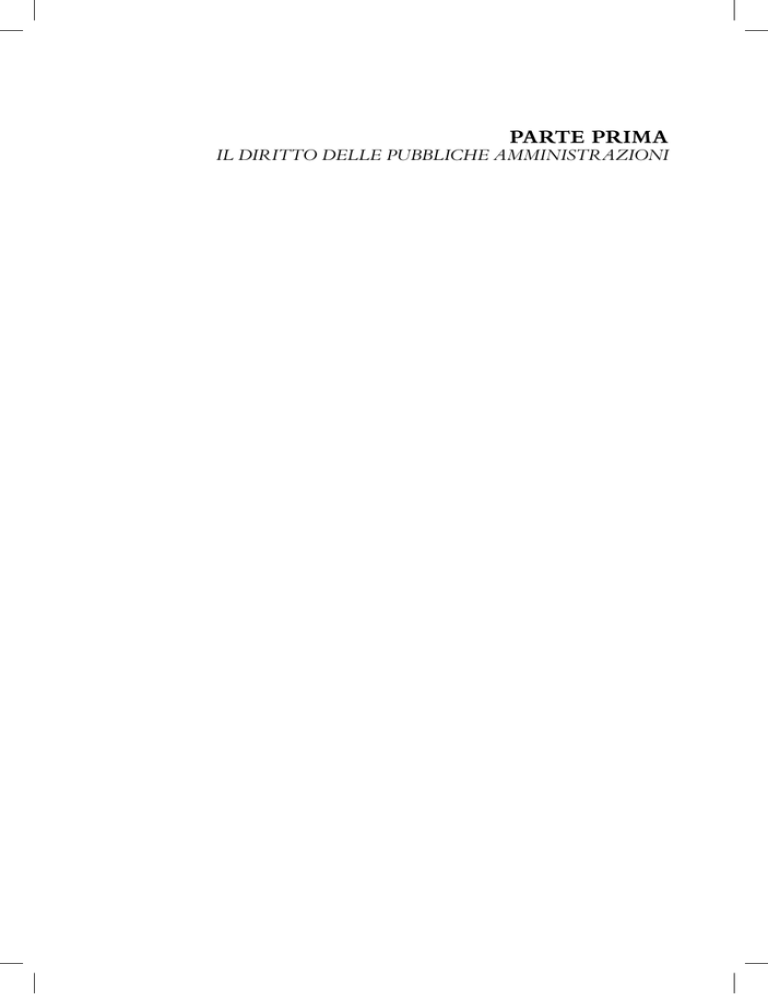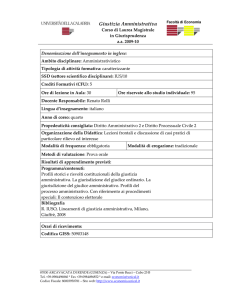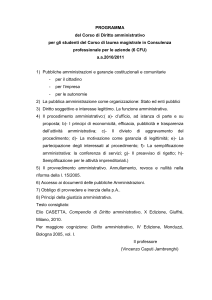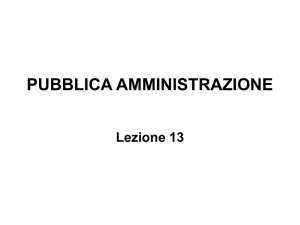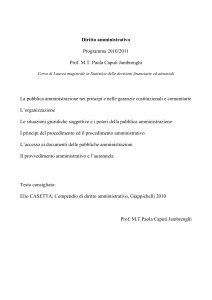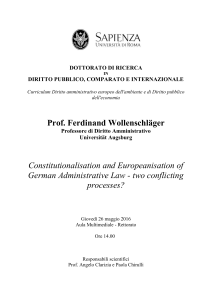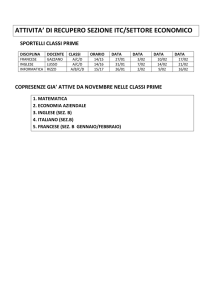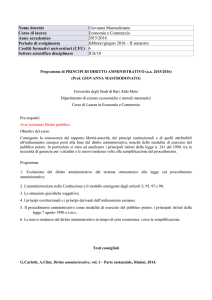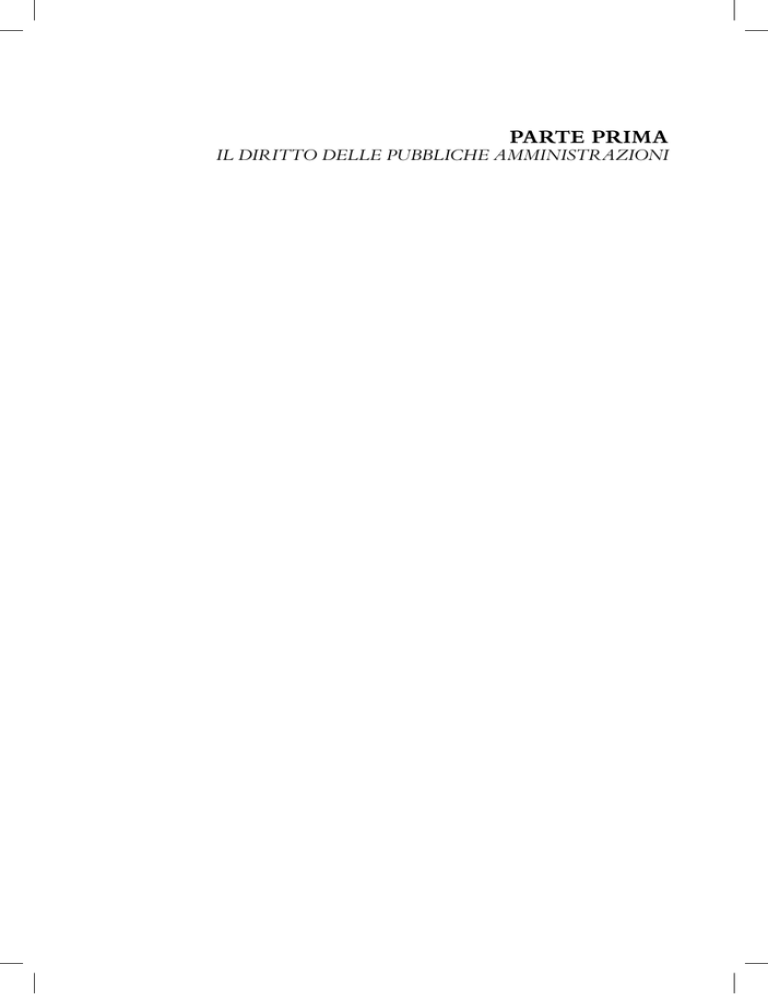
PARTE PRIMA
IL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Introduzione alla parte I
La prima parte del volume è dedicata alla comprensione della materia oggetto
di esame: il diritto amministrativo, o per meglio dire il diritto delle pubbliche amministrazioni. Trattasi infatti di un’opera di perimetrazione che tornerà utile nelle
parti successive dedicate all’analisi degli specifici istituti, sostanziali e processuali, che
permeano questa affascinante branca dell’ordinamento giuridico. Si sono all’uopo
sottoposti ad esame:
1) il profilo soggettivo del diritto delle pubbliche amministrazioni, provvedendosi a definire la nozione e i caratteri dei soggetti pubblici protagonisti della materia (cap. I);
2) il profilo oggettivo, ossia la nozione di azione amministrativa, come attività volta, in
regime pubblicistico o anche privatistico, alla cura concreta dell’interesse pubblico
(cap. II);
3) il profilo normativo, ossia la mappa delle fonti che regolano l’azione amministrativa
(cap. III);
4) il profilo processuale, ossia il sistema dei rimedi giurisdizionali che sono esperibili nel
campo amministrativistico (cap. IV).
CAPITOLO I
COS’È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
UNA NOZIONE A GEOMETRIE VARIABILI
SOMMARIO : 1. Premessa. – 2. Enti pubblici e soggetti privati: l’importanza e la fragilità della distinzione. – 3.
I criteri classici elaborati per distinguere gli enti pubblici da quelli privati. – 4. I limiti alla “pubblicizzazione” legislativa. – 5. Al confi ne tra il diritto privato ed il diritto pubblico: i cd. enti pubblici in forma
societaria. – 5.1. Le norme pubblicistiche applicabili agli enti pubblici societari. – 5.2. Questioni connesse
di giurisdizione. – 5.3. Conclusioni – 6. Dallo status di ente pubblico alla logica delle geometrie variabili: la
nozione comunitaria di pubblica amministrazione. – 7. L’organismo di diritto pubblico. – 7.1. La personalità
giuridica. – 7.2. L’influenza pubblica dominante. – 7.3. Il requisito teleologico. – 8. Classificazione degli enti
pubblici. – 9. Vicende degli enti pubblici: costituzione, modificazione, estinzione. – 10. L’esercizio privato
di pubbliche funzioni.
1. Premessa
Il diritto amministrativo è la branca dell’ordinamento giuridico che studia l’azione
e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ovvero dei soggetti di diritto
pubblico (art. 11 c.c.), che soggiacciono ad uno statuto speciale, sul piano dei poteri e
dei limiti, rispetto a quello che governa l’agire dei soggetti di diritto comune.
In assenza di una norma che, in via generale, definisca il concetto di ente pubblico
(la norma di spessore definitorio più ampio è quella recata dall’art. 1, comma 2, del
T.U. n. 165/2001, tuttavia limitata alla nozione di pubblica amministrazione ai soli fini
della disciplina del rapporto di lavoro pubblico: vedi parte II, cap. III), l’elaborazione
dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa in prevalenza agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Tali sforzi sono stati resi negli ultimi anni ancora
più complessi dall’emersione di tre fenomeni di cui si dirà nel presente capitolo:
a) l’avvento di soggetti sostanzialmente pubblici con forma societaria, una
sorta di tertium genus rispetto ai soggetti privati (di cui hanno la veste) ed agli enti
pubblici (di cui hanno la sostanza come mezzi e fini), la cui ammissibilità ha a
lungo diviso dottrina e giurisprudenza;
b) l’affermazione di un concetto comunitario di pubblica amministrazione (si
pensi, in particolare, alla nozione di organismo di diritto pubblico in tema di
procedure di gara per la stipulazione dei contratti pubblici), basato, per un verso,
sulla valorizzazione del profilo sostanziale del controllo pubblico rispetto a quello
formale della veste organizzatoria pubblicistica; per altro verso, sull’utilizzo di una
nozione a geometrie varabili che non considera quello di ente pubblico uno status
permanente ed immutabile per ogni campo di azione ritenendolo, al contrario, un
concetto elastico da applicare ratione materiae;
6
Compendio di Diritto Amministrativo
c) l’accentuazione di un fenomeno pluralistico che vede la proliferazione delle cd.
autorità indipendenti, soggetti pubblici di nuova generazione, caratterizzati da
un alto tasso di neutralità e di estraneità ai controlli dell’autorità politica, tale da
indurre a dubitare della loro qualificabilità in termini di pubbliche amministrazioni, dovendosi invece riconoscere loro, secondo una certa corrente dottrinale,
stampo paragiurisdizionale (sul tema vedi parte VII, cap. I).
Nel presente capitolo verrà affrontata e sviscerata la nozione di pubblica amministrazione (ammesso che ce ne sia una realmente unitaria) con l’individuazione
dei tratti distintivi delle pubbliche amministrazioni rispetto ai soggetti privati. Si
procederà, infine, a brevi cenni, alla mappa degli enti pubblici, come tratteggiata dal
disegno pluralistico abbracciato dalla Costituzione ed attuato dalla legislazione. Per
l’analisi esaustiva di detta architettura si rinvia alla parte III, cap. I.
2. Enti pubblici e soggetti privati: l’importanza e la fragilità della distinzione
La qualificazione pubblica di un ente come pubblico comporta conseguenze pratiche sul piano disciplinatorio.
Un primo elemento che differenzia l’ente pubblico da quello privato,
è dato dal rilievo che ogni ente pubblico, anche se svolge attività largamente o
esclusivamente privatistica (ivi compresi quindi gli enti pubblici economici che agiscono prevalentemente jure privatorum), dispone sempre di un potere pubblicistico, il cui contenuto minimo si sostanzia nel potere di autorganizzarsi,
e, quindi, di dettare, in via statutaria o regolamentare, le regole fondamentali della
propria organizzazione interna. Ai sensi dell’art. 2 del T.U. n. 165/2001, tali atti restano espressione di un potere pubblicistico di auto-organizzazione anche per gli enti
interessati dalla privatizzazione del pubblico impiego, al cospetto del quale residuano
posizioni di mero interesse legittimo.
In particolare, gli atti organizzatori adottabili dagli enti pubblici si sostanziano in
atti di macro-organizzazione, con i quali le PP.AA. “definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici,individuano gli uffici di maggiore rilevanza e d i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi, nonché determinano le dotazioni organiche complessive” (art. 2,
comma 1, D.LGS. n. 165/2001). Essi si contrappongono agli atti di organizzazione più
minuta degli uffici e di gestione dei rapporti (cd. atti di micro-organizzazione), adottati dalla P.A. nell’esercizio dei poteri e della capacità di datore di lavoro privato (art.
5, comma 2, D.LGS. n. 165/2001; sul tema cfr. parte III, cap. III).
Sul piano disciplinatorio una seconda conseguenza concerne appunto il rapporto di lavoro, in quanto dalla qualificazione pubblicistica dell’ente-datore di lavoro, discende la correlativa qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro
dell’ente con i propri dipendenti. Infatti, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, di cui si è detto (inaugurata dal D.LGS. n. 29/1993 ed ora consacrata
dal T.U. di cui al al D.LGS. n. 165/2001), la regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti pubblici (segnatamente quelli non economici: art. 1,
comma 2, T.U.) conosce alcune peculiarità relative proprio alla soggettività pubblica
dell’ente-datore di lavoro: gli atti con cui l’amministrazione gestisce il rapporto di
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
7
lavoro privatizzato, infatti, rimangono pur sempre atti finalizzati al perseguimento
di un interesse pubblico. Ne consegue che gli atti di gestione del rapporto di lavoro
restano assoggettati al controllo giurisdizionale di rispondenza all’interesse pubblico,
nonché ad alcune regole, motivazionali e procedimentali, che hanno natura anch’esse
sostanzialmente pubblicistiche (sul tema vedi parte III, cap. III).
Sempre sul piano disciplinatorio va poi sottolineato che dalla qualifica di ente
pubblico discende l’assoggettamento alle regole sul procedimento amministrativo ex L. n. 241/1990, che disciplinano l’attività pubblicistica, e in qualche
misura privatistica, degli enti pubblici.
Da contraltare ai poteri speciali di cui dispone l’ente pubblico, che condensano la cd.
“supremazia speciale” verso i privati, si pongono una serie di limitazioni alla libertà d’azione che contraddistinguono i soggetti pubblici rispetto ai soggetti privati.
Un primo limite è rinvenibile nei diversi controlli, di varia natura (controlli sugli
atti, sugli organi, gestionali, interni od esterni, contabili), di cui sono oggetto tutti
gli enti pubblici, finalizzati a valutare la legittimità dell’attività dell’ente e la rispondenza all’interesse pubblico (sul controllo della Corte dei conti vedi parte III, cap. IV).
In terzo luogo una fortissima limitazione si rinviene nell’assenza di una completa libertà negoziale, la quale anch’essa è sottoposta a vincoli, regole e limiti
pubblicistici, finalizzati alla procedimentalizzazione trasparente della scelta contrattuale, in merito all’an, al contenuto del contratto ed alla scelta del partner negoziale.
Più in generale, come si vedrà nel capitolo II, l’azione delle pubbliche amministrazioni, anche quando si svolge con moduli privatistici, non è mai libera nei fini
e, quindi, espressione di un potere di autodeterminazione assimilabile all’autonomia
negoziale dei privati, in quanto è costantemente funzionale all’interesse pubblico
che deve perseguire ai sensi dell’art. 97 Cost. Trattasi quindi di un’attività sempre
funzionale e non libera; caratterizzata cioè da un vincolo teleologico suscettibile di
controllo e sindacato in sede giurisdizionale.
A questo punto è d’uopo una breve riflessione.
In base all’interpretazione più corretta dell’art 1, comma 1 bis della L. n. 241/1990 (come modificata dalla
L. n. 15/2005) l’amministrazione ha una generale capacità di diritto privato e quindi può stipulare negozi
e contratti tipici e atipici senza vincoli legislativi generali, se non quello di soggiacere alle ordinarie norme
privatistiche. Gli atti di diritto privato posti in essere dall’amministrazione che agisce iure privatorum non sono però identici ai corrispondenti atti di diritto privato posti in essere da un qualunque soggetto privato.
L’atto posto in essere dall’amministrazione, invero, è comunque funzionale all’interesse pubblico, distinguendosi pertanto nettamente dall’omologo atto del soggetto privato (si pensi ad un contratto di appalto o
ad un atto di gestione del rapporto di lavoro), che è un atto ontologicamente libero, in quanto finalizzato
al soddisfacimento dei meri interessi egoistici del suo autore. Gli atti iure privatorum dell’amministrazione
pubblica, al contrario, sono per defi nizione soggetti al vincolo teleologico rappresentato dal dover adeguatamente soddisfare un interesse pubblico. È evidente, pertanto, che, anche ove l’atto abbia natura privatistica,
esso mantiene pur sempre a livello funzionale la propria caratterizzazione pubblicistica, e rientra quindi
nell’ambito più ampio dell’attività amministrativa, intendendo per tale l’attività di cura concreta dell’interesse pubblico, che comprende nel suo seno sia gli atti pubblicistici, quanto quelli privatistici, di gestione
dell’interesse pubblico.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, possono sviscerarsi alcune conseguenze pratiche.
In primo luogo il sindacato che il giudice ordinario (in quanto, secondo le ultime acquisizioni della giurisprudenza costituzionale, gli atti che non sono espressione di un potere autoritativo sono conoscibili dal
giudice civile) effettua sugli atti di diritto privato emanati dalla P.A. non si incentra soltanto sul rispetto del
regime privatistico, ma coinvolge anche la valutazione di conformità all’interesse pubblico.
8
Compendio di Diritto Amministrativo
Spesso, inoltre, gli atti di diritto privato della P.A. vengono preceduti da un procedimento pubblicistico,
nell’ambito del quale individuare ed esteriorizzare le ragioni che soggiacciono alla scelta dello strumento
privatistico ed all’opportunità, sotto il profi lo soggettivo e temporale, di prediligere lo strumento iure
privatorum rispetto a quello potestativo di spendita del potere pubblicistico, al fi ne di meglio soddisfare
l’interesse pubblico.
Infi ne, si è osservato che l’istituto dell’accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 concerne non solo l’attività di diritto pubblico della P.A., ma anche quella di diritto privato. La ratio dell’accesso,
infatti, è quella di consentire un controllo dei soggetti interessati sul buon andamento e sull’efficienza della
P.A., e ben si coniuga anche con l’attività di diritto privato, posto che anch’essa deve essere funzionale
all’interesse pubblico.
Un ulteriore limite derivante dalla natura pubblica degli enti concerne il regime
dei beni pubblici (demaniali e patrimoniali indisponibili), che soggiace ai limiti
dettati nel pubblico interesse dagli artt. 822 segg. c.c., nonché dalle norme di diritto
speciale (vedi parte VI, cap. III).
A fronte di tutte le limitazioni sopraesposte, si collocano una serie di privilegi
che derivano dalla qualificazione pubblica dell’ente, in ossequio alla sua natura di ente deputato alla cura di interessi pubblici, meritevole pertanto di uno statuto speciale
di favore.
In primo luogo, gli enti pubblici, come già accennato, hanno il potere di adottare
unilateralmente atti che incidono negativamente nella sfera giuridica altrui.
Gli enti pubblici, – ed in particolare se appartenenti al novero degli enti autarchici
(par. 8. e parte III, cap. I) – dispongono di poteri pubblici di supremazia nei
rapporti con i terzi. Detti poteri si compendiano nell’autarchia e nell’autotutela.
La prima consiste nell’attribuzione della titolarità di pubblici poteri ad una persona
giuridica diversa dallo Stato, con compiti o funzioni di interesse pubblico, mediante
l’equiparazione degli atti da questa emanati a quelli dello Stato. Si parla, al riguardo,
di enti pubblici autarchici, per distinguerli da quelli economici, i quali, al contrario, vedono limitato il proprio potere pubblico alla sfera dell’organizzazione interna,
impegnandosi invece verso l’esterno esclusivamente in regime paritetico, mediante
negozi di diritto privato.
L’autotutela amministrativa, invece, si sostanzia nella possibilità riconosciuta
dalla legge alla P.A. di risolvere i confl itti potenziali o attuali nascenti dalla propria
attività, con i mezzi a sua disposizione, e segnatamente annullando e revocando
i provvedimenti illegittimi o inopportuni (cfr. artt. 21 quinquies e 21 nonies, L. n.
241/1990: vedi parte IV, cap. VI), senza bisogno di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Trattasi di poteri generali che la legge riconosce in deroga all’opposta regola vigente
nei rapporti privatistici, ove solo in casi eccezionali il privato può risolvere un confl itto con un atto di natura unilaterale e senza adire l’autorità giudiziaria (è il caso,
ad esempio, di quanto stabilito dagli artt. 1460 e 1461 c.c. in materia di eccezione di
inadempimento e nell’ipotesi di mutamenti nelle condizioni patrimoniali dei contraenti).
Deve segnalarsi, poi, che anche nel diritto privato l’amministrazione ha un potere molto ampio di
risolvere i confl itti con atti propri. Nel settore dei contratti pubblici, la normativa di settore consente
alla P.A. di recedere o di risolvere il contratto in presenza di una ragione di interesse pubblico o di un grave
inadempimento (vedi artt. 134-138 del codice dei contratti pubblici di cui al D.L GS. n. 163/2006). In materia di fermo amministrativo (art. 69, comma 6, R.D. 2440/1923), inoltre, l’amministrazione, in deroga
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
9
alle ordinarie regole sulla compensazione, può paralizzare i crediti altrui, facendo valere crediti che non
siano certi, liquidi ed esigibili, ma soltanto potenziali ed in qualche misura suscettibili di contestazione. Da
ultimo, nel campo della gestione dei beni pubblici demaniali, e secondo alcuni anche patrimoniali indisponibili, l’amministrazione, ex art. 823 c.c., può esercitare l’autotutela possessoria, legittimandosi in caso
di occupazione abusiva di un bene pubblico l’uso autoritario della forza pubblica ai fi ni della riacquisizione
del possesso della res illecitamente occupata. Sulla differenza, anche ai fi ni del riparto di giurisdizione, tra
poteri pubblici e privati, si veda parte II, cap. I, par. 6.
Le pubbliche amministrazioni si sottraggono, inoltre, alle ordinarie regole del fallimento, consentendosi, al contrario, alle stesse imprese pubbliche, alla luce degli
immanenti fini pubblici che perseguono, di continuare ad operare sul mercato anche
in condizioni di disfunzione.
Sotto il profi lo patrimoniale, poi, i beni demaniali ed indisponibili delle PP.AA.
non sono suscettibili di esecuzione forzata, secondo le ordinarie regole del codice di
procedura civile, né di espropriazione per pubblica utilità, salvi i casi eccezionali di
cui al T.U. sull’espropriazione (art. 4, D.P.R. n. 327/2001).
La qualificazione pubblicistica di un soggetto, infine, incide anche sul riparto di giurisdizione: la natura pubblicistica di un ente, invero, comporta
l’assoggettamento del contenzioso relativo ai loro provvedimenti (e, nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, anche delle condotte connesse all’esplicazione di detti poteri) alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. parte VII, cap.
III). L’art. 103 Cost., invero, qualifica il giudice amministrativo come il giudice munito
di “giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”, con la conseguenza che,
per definizione, in assenza di un soggetto qualificato come pubblico, la giurisdizione
non spetta al g.a. (Cass., Sez. un., ord. 13 giugno 2008, n. 15916)(v. cap. IV).
3. I criteri classici elaborati per distinguere gli enti pubblici da quelli privati
Chiarita l’importanza pratica che riveste l’individuazione degli enti pubblici, è
possibile ora passare alla rassegna dei criteri, elaborati da dottrina e giurisprudenza,
onde distinguerli da soggetti iure privatorum.
In prima battuta,va osservato che l’art. 4 della L. del parastato 20 marzo 1975, n.
70, in ossequio alla riserva di legge sancita dagli artt. 95 e 97 Cost, stabilisce che “nessun
nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”. Trattasi di una
norma che, nell’esprimere un principio generale di riserva relativa di legge, svolge una
funzione attuativa, in chiave di rafforzamento, del precetto di cui all’art. 97 Cost., ove si
statuisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge.
Dall’art. 4, in definitiva, si ricava che la nascita (al pari della modificazione e della
soppressione) di un ente pubblico deve necessariamente poggiare su regole giuridiche
fissate dal legislatore.
Del pari, una decisione del legislatore è necessaria in caso di conferimento di veste
pubblicistica ad un ente privato preesistente.
Vertendosi in tema di riserva relativa (e non assoluta) di legge, deve essere di
creazione legislativa la sola istituzione dell’ente, con la determinazione delle sue attribuzioni e l’individuazione degli organi fondamentali. In via di attuazione di tali
10
Compendio di Diritto Amministrativo
linee direttive, poi, potranno intervenire il potere esecutivo ed il potere statutario di
autoorganizzazione dell’ente medesimo.
La norma in esame, se pure esprime in modo forte il principio della riserva di
legge, non esonera tuttavia l’interprete dal compito di elaborare i criteri di individuazione della pubblicità dell’ente ove manchi un’espressa qualificazione dello stesso
come pubblico. E infatti, la disposizione, se esclude la possibilità dell’attribuzione
della personalità pubblicistica con atti amministrativi, non elimina per certo la
possibilità di un riconoscimento legislativo non esplicito, basato cioè, con i
conseguenti problemi di interpretazione, sulla previsione normativa degli elementi
sintomatici della natura pubblica di un ente.
Ebbene, secondo la dottrina più accreditata, gli indici di riconoscimento degli enti
pubblici sono individuabili, laddove manchi un’espressa previsione normativa, in: a)
un sistema di controlli pubblici (statali o regionali). Tale sistema sarà tanto meno intenso quanto maggiore sarà l’autonomia dell’ente; b) nell’ingerenza dello Stato, o di
altra P.A., nella nomina e revoca dei dirigenti nonché nell’amministrazione dell’ente;
c) nella partecipazione dello Stato, o di altra P.A., alle spese di gestione; d) nel potere
di direttiva dello Stato nei confronti degli organi, in relazione al conseguimento di
determinati obiettivi; e) nel finanziamento pubblico istituzionale; f ) nella costituzione ad iniziativa pubblica (a tal proposito va evidenziato che, mentre nel sistema
costituzionale il potere di creazione di nuovi enti è riconosciuto solo allo Stato e alle
Regioni, gli artt. 112 e segg. D.LGS. 267/2000 hanno conferito anche a Comuni e
Province il potere di provvedere, sia pure sulla base della legge, alla costituzione di
aziende municipali anche consortili, istituzioni, società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, per lo svolgimento di attività anche economiche).
Accanto ai criteri sopra esposti, elaborati dalla dottrina maggioritaria e fatti propri dalla giurisprudenza prevalente, alcuni Autori hanno individuato altri criteri distintivi onde individuare la natura pubblicistica dell’ente:
a) criterio della creazione, secondo cui va considerata pubblica la persona giuridica istituita direttamente dallo Stato;
b) criterio del fi ne pubblico (ZANOBINI), secondo cui è da ritenersi pubblica la persona giuridica che
persegue fi ni pubblici. Tale criterio è stato superato con lo sviluppo e la diffusione di enti pubblici di
carattere imprenditoriale, slegati dalla cura di interessi pubblici;
c) criterio dei poteri pubblici, per cui è pubblico l’ente dotato di generici poteri pubblici (ad esempio
si pensi al potere di certificazione, statutario, disciplinare) connessi ad una speciale competenza;
d) criterio della supremazia, secondo cui è pubblica quella persona che gode di una posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti (cd. imperium), concretantesi in potere normativo, tributario ecc. Anche
tali ultimi criteri sono stati svalutati dall’avvento di enti operanti in campo economico alla stregua di
criteri imprenditoriali.
In ultima analisi, in assenza di una previsione legislativa espressa, il problema della
qualificazione come pubblico di un ente va affrontato di volta in volta sulla base di
una ricerca ermeneutica basata sulla comparazione degli elementi sintomatici di
cui sopra e dei dati normativo-regolamentari (Cons. St., Sez. VI, dec. n. 397/1973).
4. I limiti alla “pubblicizzazione” legislativa
Come si è sopra ampiamente argomentato, un ente si defi nisce pubblico per creazione o qualificazione legislativa, ove, ex art. 4, L. n. 70/1975, stabilisca, con previ-
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
11
sione espressa od in via implicita, la creazione ex novo di un ente pubblico, la conversione di un ente o di una categoria generale di enti preesistenti, conferendo loro una
denominazione ed una qualificazione pubblicistica.
In merito a tale problematica, dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate
sull’estensione dei poteri del legislatore nell’istituzione di nuovi enti pubblici, ovvero
se la creazione legislativa di enti pubblici conosca dei vincoli costituzionali che
impediscano la qualificazione normativa di un soggetto come pubblico,
ove esso conservi una matrice sostanzialmente privatistica.
Il problema concerne principalmente il caso in cui la legge si rivolga ad enti pregressi qualificandoli come pubblici: va infatti chiarito se a questa operazione nominalistica debba corrispondere necessariamente una modifica in senso sostanziale della
disciplina e delle regole di funzionamento dell’ente.
Il problema si è posto per le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), interessate rispettivamente dalle leggi n. 259 e n. 6792 del 1890, le quali
hanno convertito e qualificato in termini pubblicistici l’intera categoria di enti in
parola, senza porre in essere alcuna modifica circa le regole di funzionamento, di
organizzazione ed, in generale, di attività.
La Corte costituzionale con la sentenza del 7 aprile 1988, n. 396, ha posto
dei paletti all’arbitrio legislativo, chiarendo che queste operazioni legislative incontrano i vincoli costituzionali in tema di organizzazione degli enti pubblici
di cui agli articoli 3, 95 e 97 della Costituzione. Ne consegue che la legge
può qualificare come pubblici solo gli enti che abbiano natura pubblica sul piano
sostanziale, ovvero su quello dell’organizzazione, del funzionamento, dell’attività e
delle finalità perseguite. Non è invece possibile dare un nomen pubblicistico a soggetti
integralmente privatistici. Con riferimento in particolare alle IPAB (art 1 della L. 17
luglio 1890, n. 6972 (“Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”), ma con argomentazioni estensibili in generale ai soggetti privati, la Corte ha
osservato che, seppure astrattamente una IPAB persegue un fine di interesse generale,
la creazione, il finanziamento e la gestione ad opera di soggetti privati, rappresentano
elementi che depongono per la mancanza di un’ossatura pubblicistica che, sola, giustifichi la conversione pubblicistica.
La Corte afferma, in defi nitiva, che mutata la situazione originaria presa in considerazione dalla Legge
Crispi, “non possono ormai non essere assecondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell’ambito dell’autonomia privata, di vedersi riconosciuta l’originaria natura. Questa esigenza é imposta dal principio pluralistico che ispira nel
suo complesso la Costituzione repubblicana e che, nel campo dell’assistenza, è garantito, quanto alle iniziative private,
dall’ultimo comma dell’art. 38, rispetto al quale è divenuto ormai incompatibile il monopolio pubblico delle istituzioni
relative. Le considerazioni che precedono denotano, perciò, il contrasto con la norma costituzionale citata, dell’art. 1 della
Legge del 1890, che invece continua ad esigere – pur essendo superata la situazione sociale e l’assetto delle strutture dello
Stato che avevano ispirato la legge stessa – un sistema di pubblicizzazione generalizzato, esteso a tutte le iniziative
originate dall’autonomia privata. Queste perciò ben potrebbero essere restituite all’ambito privato ove fosse constatata la
presenza di requisiti propri di una persona giuridica privata”.
In applicazione del suesposto principio, Cass., Sez. un. 15 marzo 1999, n. 139 ha puntualizzato che “a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396/88 e in assenza della procedura amministrativa di riconoscimento
della personalità giuridica privata, spetta all’autorità giudiziaria adita accertare, di volta in volta, la natura pubblica o
privata dell’I.P.A.B”. Segnatamente il D.P.C.M. 16 febbraio 1990, richiamato dalle Sezioni unite, prevede
una procedura per il riconoscimento della personalità giuridica privata alle istituzioni assistenziali in ordine
alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed
12
Compendio di Diritto Amministrativo
amministrata da privati; c) l’ispirazione religiosa. Il decreto precisa poi che sono da intendersi promosse ed
amministrate da privati le istituzioni nelle quali vi sia un preponderante ruolo dei privati in sede di iniziativa, di gestione e di costituzione del patrimonio.
Le stesse considerazioni hanno indotto le stesse Sezioni unite all’opposta conclusione in ordine al rapporto
di lavoro tra l’ente Ricoveri Riuniti, al quale è succeduto il comune di Reggio Calabria, ed i suoi dipendenti, ritenendo la natura privatistica dell’ente medesimo, posto che, a seguito della pronuncia della Corte
cost. n. 396 del 1988 “deve verifi carsi la natura pubblica o privata di una delle predette istituzioni, facendo ricorso ai
criteri di distinzione tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, indipendentemente dalle denominazioni assunte
dagli enti e dalla stessa volontà dei loro organi direttivi”. (Cass. Civ., Sez. un., 07 maggio 1998, n. 4631).
Le considerazioni che precedono, valide in generale per associazioni e fondazioni,
consentono di affermare che il legislatore, nelle operazioni qualificatorie, è vincolato al rispetto di un parametro di ragionevolezza, alla stregua del quale non è
sufficiente un generico fine pubblico per qualificare un soggetto come pubblico, ma
è necessario un regime di natura pubblicistica. Infatti anche le attività di impresa privatistiche possono perseguire un generico fine pubblicistico, mentre per giustificare
l’opzione legislativa che dia una veste formale pubblica ad un’impresa è necessario
che l’organizzazione, il potere decisionale, il controllo ed il regime finanziario, complessivamente intesi, abbiano una matrice sostanzialmente pubblicistica.
In particolare, per quel che afferisce alle istituzioni aventi struttura associativa, una sicura connotazione
privatistica è data dalla costituzione “per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati”, ovvero dall’elezione
da parte dei soci di almeno la metà dei componenti dell’organo collegiale deliberante e, ancora, dall’esplicazione dell’attività dell’ente prevalentemente attraverso prestazioni volontarie o personali dei soci e con
mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci, nonché da un patrimonio prevalentemente
formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti di soci.
Ove poi manchi una struttura associativa, rileverà, in senso contrario alla possibilità di una trasformazione in
ente pubblico, la circostanza che si tratti di “istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente
con mezzi di provenienza privata”, e che il patrimonio risulti essere “quasi esclusivamente costituito da beni provenienti
da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi”.
5. Al confine tra il diritto privato ed il diritto pubblico: i cd. enti pubblici in forma societaria
Le cosiddette leggi di “privatizzazione formale”, le più importanti delle quali
sono la L. n. 359/1992 e la L. n. 474/1994, hanno trasformato alcuni enti pubblici
preesistenti (enti pubblici economici o amministrazioni statali autonome) in società per azioni, tramite un iter scomponibile in due fasi: ad una prima, nella quale si
procedeva alla privatizzazione meramente formale, con la conseguenza che lo Stato
rimaneva formalmente titolare del pacchetto azionario, seguiva la seconda, che nella
maggior parte dei casi non si è ancora compiutamente perfezionata, nella quale le
azioni venivano progressivamente cedute a privati, con la conseguente dismissione,
da parte dello Stato, del controllo sostanziale del soggetto privatizzato.
Deve tuttavia sottolinearsi, come anticipato, che la seconda fase, di dismissione del
controllo pubblico sull’ente, raramente si è perfezionata compiutamente. Anche ove
il passaggio della privatizzazione sostanziale si è verificato, si è assistito, peraltro,
alla conservazione di un controllo pubblicistico, sub specie di poteri speciali al socio
pubblico, anche se di minoranza: questo regime speciale (cd. golden share o action specific) attribuisce all’azionista pubblico, e persino al soggetto pubblico non azionista, un
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
13
potere decisionale di veto sulle operazioni più significative e strategiche della società
privatizzata.
Il massiccio ricorso alla privatizzazione, sia pur attenuata dalla golden share o dalla
conservazione in capo allo Stato di una partecipazione azionaria, ha posto il problema, speculare a quello esaminato nel paragrafo precedente, di verificare se la legge
possa privatizzare forzatamente dei soggetti pubblici, senza modificarne la
disciplina, le regole, i poteri e le modalità di azione, che, quindi, restano
sostanzialmente pubblici.
Tale problematica, che concerne i limiti e le conseguenze delle privatizzazioni
meramente nominalistiche, che non incidono sull’essenza del controllo, dei poteri e
delle gestioni, abbraccia in modo più ampio la cosiddetta tematica della “neutralità
delle forme societarie” (tematica che riguarda, oltre agli enti pubblici nazionali
privatizzati, anche le società locali miste deputate alla gestione dei servizi pubblici ex
art. 113 T.U. n. 267/2000: sul tema vedi parte VII, cap. II, par. 6. e segg.).
Fino agli anni Settanta la forma societaria era ritenuta incompatibile con la nozione di ente pubblico, che per essere qualificato come tale doveva possedere una veste
ed una forma pubblica.
Nella logica comunitaria, indifferente alle forme ed al nomen, e più attenta agli
aspetti sostanziali, economici e dei poteri conferiti, come si dirà meglio in seguito
(par. 6.), invece, un ente va considerato pubblico quando è titolare di un potere appunto pubblico ed è sottoposto ad un controllo anch’esso pubblico,
indipendentemente dalla circostanza che abbia una cornice formalmente
privatistica.
Trasponendo le coordinate comunitarie al tema che qui ci occupa, è chiaro che il
problema, stante la primauté del diritto europeo, va risolto mediante la verifica di compatibilità dei nostri istituti con il diritto comunitario. Ne consegue che, ove una società
venga privatizzata solo nella forma, pur restando soggetta al controllo dallo Stato e
funzionalizzata al fine pubblico, essa, a dispetto della formale procedura di privatizzazione, dovrà considerarsi un ente pubblico, soggetta pertanto alla relativa disciplina.
Sul piano applicativo, poi, si discute sui criteri da seguire per stabilire se in concreto le singole società possano essere qualificate come enti pubblici.
Secondo alcuni Autori sarebbe necessaria una deviazione fortissima dalle regole
societarie per giustificare la qualificazione pubblica della società: ne consegue, quindi, che non è sufficiente che il socio pubblico sia interamente titolare del controllo
sociale, essendo invece necessario, altresì, che vi sia un generale discostamento dalle
regole che concernono il funzionamento della società, nel senso cioè di attribuire
il potere a soggetti pubblici esterni alla società. Altra dottrina, invece, ritiene
sufficiente, ai fini della individuazione della natura pubblica della società, che il socio pubblico controlli la società dall’interno, secondo le ordinarie regole sociali,
rimanendo quindi la società stessa titolare di poteri pubblici e funzionalizzata ad
interessi pubblici.
5.1. Le norme pubblicistiche applicabili agli enti pubblici societari
È d’uopo a questo punto chiedersi se vi siano delle norme pubblicistiche in
qualche misura incompatibili con gli enti pubblici societari, che, rimanendo
14
Compendio di Diritto Amministrativo
formalmente delle società, sono in ogni caso sottoposte anche alle relative regole
codicistiche, se non espressamente derogate.
La risposta a tale quesito è assai agevole, ove si ponga mente a quanto sopra esposto
in merito alle conseguenze disciplinatorie che derivano dalla qualificazione di un
ente come pubblico.
In primo luogo va sottolineato che un ente pubblico societario non può dettare regolamenti amministrativi di organizzazione. In capo a tali enti, infatti,
non è rinvenibile un potere di adottare regolamenti o atti amministrativi generali,
ma soltanto la capacità di organizzarsi con atti di diritto privato (lo statuto o il contratto sociale in generale). Le scelte organizzative di fondo sono effettuate all’esterno
con leggi o con atti adottati dai Ministeri vigilanti (per le società nazionali privatizzate) o dai Comuni istituenti (per le società locali).
Per quel che concerne il regime del rapporto di lavoro, in linea generale non si
applicheranno, quanto meno alla lettera e in modo pieno, le norme, i procedimenti
e le discipline che riguardano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, come dimostrato dall’art. 1, comma 2, del T.U. sul pubblico impiego (che elenca i soggetti tenuti al rispetto della normativa stessa) che non menziona
le società per azioni (né gli enti pubblici economici), nel novero dei soggetti ai quali
si applica il medesimo T.U. Ne consegue che, in relazione al profi lo giuslavoristico,
non rileva la natura sostanzialmente pubblicistica della società, dovendosi invece aver
riguardo alla veste societaria, formalmente privatistica, dell’ente-datore di lavoro.
Sul punto va però rilevato che, a conferma ulteriore della qualificazione in termini sostanzialmente pubblicistici di tali enti societari, l’art. 18 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della fi nanza pubblica e la perequazione Tributaria”, ha stabilito che “le società che
gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo
35 del D.L GS. n. 165 del 2001. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Il comma 3 soggiunge che le dette
disposizioni non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”.
Analogamente, neanche la L. n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo trova applicazione a questo tipo di società, a meno che l’attività societaria non
si esplichi in poteri pubblici (quale, ad esempio, il potere espropriativo riconosciuto alle
Ferrovie dello Stato s.p.a. e, più in generale, le procedure di evidenza pubblica cui sono
tenute anche le società pubbliche che siano qualificabili come organismi di diritto pubblico: vedi infra). Salve le dette eccezioni, quindi, gli enti pubblici societari svolgono attività privatistiche senza dover ricorrere all’uso di particolari moduli procedimentali.
Ad opposte conclusioni deve invece giungersi in materia di accesso ai documenti amministrativi, per il quale l’art. 23 della L. n. 241/1990 prevede la trasparenza anche degli atti di soggetti privati deputati alla gestione dei servizi pubblici
(vedi parte IV, cap. I).
Sul versante delle limitazioni correlate alla libertà d’azione degli enti pubblici,
certamente resta fermo il controllo contabile della Corte dei conti ex art. 100
Cost., in quanto ciò che rileva è che vi sia maneggio di denaro pubblico, il che, con-
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
15
seguentemente, rende necessari controlli finalizzati a verificare la corretta gestione
dei finanziamenti pubblici. Quindi, ai fini dei controlli contabili e della relativa responsabilità, rileva il dato sostanziale di erogazione di finanziamenti pubblici e non
già quello formale della veste societaria, sotto questo profilo neutra ed irrilevante.
Sul punto va rammentata la storica sentenza della Corte costituzionale,
28 dicembre 1993, n. 466, che, facendo perno sulla valorizzazione dello statuto
sostanzialmente pubblicistico delle società derivanti dalla privatizzazione degli enti
pubblici e delle amministrazioni autonome dello Stato, ha ribadito la permanenza
del potere della Corte dei conti di esercitare, nei confronti delle società per azioni
costituite a seguito della trasformazione dell’Iri, dell’Eni, dell’Ina e dell’Enel, disposta dall’art. 15, d.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. con modificato nella L. 8 agosto
1992 n. 359, il potere di controllo di cui all’art. 12, L. 21 marzo 1958 n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando
permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società.
Vanno riportati alcuni passaggi della decisione, plasticamente evocativi dell’ambiguità di dette società, a confine tra il pubblico ed il privato, nonché della progressiva
opacizzazione dei confini, un tempo ben più netti, tra enti pubblici e privati (cfr.
Cons. St., Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3053).
“Diversamente da quanto asserito dallo stesso Governo, la semplice trasformazione degli enti pubblici economici
di cui all’art. 15 della L. n. 359 del 1992 non può essere, infatti, ritenuto motivo suffi ciente a determinare
l’estinzione del controllo di cui all’art. 12 della L. n. 259 del 1958, fino a quando permanga inalterato nella sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi
nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al
capitale azionario delle stesse. In proposito va, infatti, rilevato che il processo di “privatizzazione”, iniziato con il D.L.
n. 386 del 1991 (convertito nella L. n. 35 del 1992) e sviluppato mediante l’art. 15 del D.L. n. 333 (convertito nella
L. n. 359 del 1992), ha assunto come propri obiettivi fondamentali sia il riordino e la valorizzazione del complesso delle
partecipazioni pubbliche sia la ‘dismissione’ graduale da parte dello Stato, per esigenze di risanamento della finanza
pubblica, del patrimonio azionario risultante dalle trasformazioni e conferito al Ministero del tesoro (v. art. 16, L. n.
359 del 1992). Le ragioni che stanno alla base del controllo spettante alla Corte dei conti sugli enti pubblici economici
sottoposti a trasformazione non possono, pertanto, considerarsi superate in conseguenza del solo mutamento della veste
giuridica degli stessi enti, ove a tale mutamento formale non faccia seguito anche una modifi ca di carattere sostanziale
nell’imputazione del patrimonio (ora trasformato in capitale azionario) tale da sottrarre la gestione finanziaria degli enti
trasformati alla disponibilità dello Stato. E questo tanto più ove si consideri che il passaggio di tale patrimonio dalla sfera
pubblica alla sfera privata avviene, in base al processo di ‘privatizzazione’ in atto, nel rispetto di condizioni particolari
che sono state poste con norme speciali di diritto pubblico.
Il controllo in questione verrà, invece, a perdere la propria ragione d’essere, legata alla sua specifi ca funzione, nel momento
in cui il processo di ‘privatizzazione’, attraverso l’effettiva ‘dismissione’ delle quote azionarie in mano pubblica, avrà
assunto connotati sostanziali, tali da de terminare l’uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica. Contro
la soluzione ora indicata non può valere né il richiamo alla formula letterale dell’art. 12 della L. n. 259 del 1958 né
l’asserita incompatibilità del tipo di controllo previsto da tale norma con la natura di società per azioni assunta dai soggetti
trasformati. Per quanto riguarda il richiamo al dato letterale, se è vero che l’art. 12 della L. n. 259 riferisce il controllo in
questione agli ‘enti pubblici’, è anche vero che la disposizione espressa con tale articolo non può non richiedere un’interpretazione adeguata al dettato costituzionale, anche in relazione alla funzione propria di questo tipo di controllo ed alla
evoluzione subita, rispetto al tempo dell’enunciazione della norma, dalla stessa nozione di ente pubblico.
Su questo piano non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che il controllo regolato dall’art. 12 della L. n. 259 risulti
incluso nell’ambito della sfera disciplinata dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, dal momento che tale dato
emerge chiaramente dallo stesso art. 12 (dove si richiama l’art. 100 Cost.) ed è stato già evidenziato da questa Corte nella
sent. n. 35 del 1962. Ma l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determi-
16
Compendio di Diritto Amministrativo
nazione dei casi e delle forme del controllo, riferisce il controllo stesso agli ‘enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria’,
senza porre distinzione alcuna tra enti pubblici ed enti privati. E questo spiega come nella formulazione originaria del
disegno di legge governativo di attuazione dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, da cui è scaturita la L. n.
259 del 1958 (Senato, n. 27 del 1953), si fosse fatto esplicito riferimento, ai fini della definizione della sfera soggettiva
del controllo della Corte dei conti, agli ‘enti pubblici e privati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria’ (art. 1). Caduta
questa dizione nel corso dei lavori parlamentari – dove emerse la distinzione tra il controllo di cui all’art. 2 e quello di cui
all’art. 12 – è rimasta pur sempre l’esigenza di adeguare l’interpretazione di questa seconda disposizione, formalmente
più restrittiva della prima, al dettato costituzionale: interpretazione che in alcun modo può trascurare la funzione propria
del controllo previsto dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, che é stata da questa Corte collegata ‘all’interesse
preminente dello Stato (costituzionalmente rilevante per l’art. 100 Cost.) che siano soggette a vigilanza le gestioni relative ai finanziamenti che gravano sul proprio bilancio, sottoponendole in definitiva al giudizio del Parlamento’ (sent. n.
35 del 1962). Ora, è proprio la considerazione di tale finalità primaria che può giustifi care la permanenza del controllo
in questione anche nei confronti delle nuove società, se e fino a quando la gestione delle stesse resti nella disponibilità dello
Stato e sia suscettibile, di conseguenza, di incidere, sia pure indirettamente, sul bilancio statale.
D’altro canto, sul piano dell’individuazione dei soggetti sottoposti al controllo, si può anche ricordare come la stessa
dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato si sia andata, di recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, sempre più stemperando: e questo in relazione, da un lato, all’impiego crescente dello strumento
della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico (v. ad es., L. 5 marzo 1982 n. 63; L. 19
dicembre 1983, n. 700; L. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 18, nono comma; L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22); dall’altro, agli indirizzi emersi in sede di normazione comunitaria, favorevoli all’adozione di una nozione sostanziale di
impresa pubblica (art. 2, direttiva CEE n. 80/723, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e
le loro imprese pubbliche; art. 1, direttiva CEE n. 90/531, in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi).
Del resto, la stessa normazione sulle ‘privatizzazioni’ che ha dato luogo al conflitto costituisce un esempio di
quanto si presenti oggi sfumata la linea di confine che, nell’ambito di discipline speciali quali quelle in esame,
viene a distinguere gli enti pubblici dalle società di diritto privato. Basti solo considerare il fatto che le società per
azioni derivate dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici conservano connotazioni proprie della loro originaria
natura pubblicistica, quali quelle, ad esempio, che si collegano alla assunzione della veste di concessionarie necessarie di
tutte le attività in precedenza attribuite o riservate agli enti originari o che mantengono alle nuove società le attribuzioni
in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza già spettanti agli stessi enti (v. art. 14, primo ed
ultimo comma, L. n. 359 del 1992).
Non è dato, d’altro canto, rilevare un’oggettiva incompatibilità tra la nuova disciplina relativa alle ‘privatizzazioni’ ed il
controllo di cui all’art. 12 della L. n. 259, controllo da trasferire, nei limiti sopra enunciati, sui nuovi soggetti societari.
Va innanzitutto escluso che la L. n. 359 del 1992 possa avere determinato – attraverso la clausola generale posta nell’art.
20 – l’abrogazione tacita della L. n. 259 del 1958, sia pure con riferimento ai soli enti trasformati di cui all’art. 15. A
tale evenienza vengono, infatti, a opporsi sia i contenuti che la natura della L. n. 259, attraverso cui è stato attuato, con
una disciplina caratterizzata da completezza e organicità, l’istituto del controllo specifi camente previsto in sede costituzionale dall’art. 100, secondo comma: elemento questo che di per sé induce a escludere l’eventualità di una abrogazione
tacita realizzata attraverso la formulazione di una normazione quale quella adottata in tema di ‘privatizzazioni’, che
appare estranea alla materia del controllo affidato alla Corte dei conti.
A questo si aggiunga che anche la veste formale assunta dalle società che sono venute a sostituire gli enti pubblici economici sottoposti a trasformazione non può dirsi caratterizzata da una naturale incompatibilità con
i caratteri propri del controllo affi dato alla Corte dei conti dalla Costituzione e regolato dalla L. n. 259. In
proposito, si può richiamare la natura di ‘diritto speciale’ che va riconosciuta a dette società e che viene a emergere dal
complesso della disciplina adottata al fine di regolare il processo di ‘privatizzazione’: natura che risulta connotata – com’è
stato ampiamente illustrato negli scritti difensivi della ricorrente – sia dalla costituzione che dalla struttura e dalla gestione
delle nuove società e che viene a specifi carsi attraverso la previsione di norme particolari – differenziate da quelle proprie
del regime tipico delle società per azioni – sia in tema di determinazione del capitale sociale (v. artt. 15 e 16 D.L. n. 333
del 1992, convertito nella L. n. 359 del 1992 e D.L. 21 giugno 1993, n. 198, convertito nella L. 9 agosto 1993, n.
292), sia in tema di esercizio dei diritti dell’azionista (spettanti al Ministro del tesoro, ma previa intesa con altri Ministri:
v. art. 15, terzo comma, D.L. n. 333 del 1992), sia infine, in tema di patti sociali, poteri speciali, clausole di gradimento, modifi che statutarie, quorum deliberativi nelle assemblee, limiti al possesso di quote azionarie da parte dei terzi
acquirenti (v. delibera CIPE 30 dicembre 1992 e D.L. n. 389 del 1993, reiterato con il D.L. n. 486 del 1993). Non
senza, infine, considerare il vincolo esterno connesso al fatto che i ricavi derivanti dalla cessione dei cespiti da dismettere
vanno destinati alla riduzione del debito pubblico (v. art. 16, secondo comma, D.L. n. 333 del 1992).
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
17
Da questo complesso di norme emerge non solo il quadro delle finalità, dei vincoli e delle condizioni di natura pubblicistica
entro cui il processo di ‘privatizzazione’ si sta oggi sviluppando, ma anche la natura differenziata e speciale delle società
sorte dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici economici.
Rispetto a questo quadro ed a questa natura non può, dunque, considerarsi dissonante il fatto che possa permanere, sia
pure in via transitoria – e cioè fino a quando le ‘dismissioni’ non risulteranno effettivamente attuate – il controllo sulla
gestione finanziaria di cui alla L. n. 259: controllo destinato a restare esterno alle società e a garantire l’informazione del
Parlamento anche durante la delicata fase di passaggio che si é aperta, nel sistema delle partecipazioni statali, con l’avvio
del processo di ‘privatizzazione’”.
In relazione al potere di controllo del governo, sub specie di annullamento straordinario del Governo (cap. II, par. 3.1.), questo potrà essere esercitato solo se,
nonostante la privatizzazione, i soggetti in esame rimangano titolari di poteri pubblicistici, emanando quindi provvedimenti amministrativi, ove questi siano lesivi di
interessi nazionali nevralgici.
Inoltre, come già detto, la normativa specifica sugli appalti, che qualifica i soggetti in esame quali organismi di diritto pubblico, unitamente alla definizione
comunitaria tesa a snidare la pubblicità reale di soggetti formalmente privati ma
sostanzialmente controllati dalla P.A., impongono conseguentemente che le società
pubbliche siano assoggettate alle regole di tutela della concorrenza e di svolgimento
di procedure ad evidenza pubblica (v. par. 7.).
Volgendo lo sguardo ai privilegi insiti nell’essenza pubblica di un ente,
in linea di massima la legislazione speciale esclude il fallimento anche per gli enti in
parola, poiché considera ancora una volta il profi lo sostanziale: l’interesse pubblico
perseguito dalle società pubbliche impedisce quindi che si giunga ad un’estinzione
delle stesse secondo le normali dinamiche degli operatori privatistici.
Infine, gli enti pubblici societari sono soggetti alla giurisdizione del g.a. in relazione a tutti i propri provvedimenti di spessore pubblicistico (vedi l’art. 244 del codice
dei contratti pubblici per le procedure di evidenza pubbliche) nonché nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell’art. 103 della Costituzione.
5.2. Questioni connesse di giurisdizione
Urge a questo punto chiedersi, alla luce della doppia anima di questi soggetti, pubblicistica come funzione e poteri, e privatistica quanto all’organizzazione, ed al di là
delle norme speciali che affrontano il problema, quale sia il contenzioso che va
devoluto al g.a. e quale, viceversa, vada radicato in capo al g.o.
Orbene, è evidente come al g.a. saranno devolute le controversie concernenti i provvedimenti adottati
dalle società pubbliche laddove la legge abbia conferito loro poteri pubblicistici. Ne consegue
che il g.a. sarà chiamato a conoscere delle controversie relative alle procedure di evidenza pubblica che
precedono la stipula dei contratti (ove è prevista comunque una giurisdizione esclusiva ai sensi del citato
art. 244 del codice dei contratti pubblici), nonché quelle relative all’accesso, anch’esso devoluto alla giurisdizione (sul tema si rinvia, funditus, al capitolo III della parte VIII).
Di contro, invece, le controversie riguardanti l’organizzazione societaria interessano, in linea di massima, le regole civilistiche sul funzionamento delle società (si pensi all’ipotesi di delibere viziate, ad un
patto sociale illegittimo o ad una lite riguardante i rapporti tra i soci). Per le controversie societarie, in
ogni caso, non è sufficiente il mero coinvolgimento dell’interesse pubblico per giustificare l’attrazione in
capo al g.a., così come sancito dalle recenti acquisizioni della giurisprudenza costituzionale in materia di
riparto di giurisdizione.
18
Compendio di Diritto Amministrativo
In questo senso è stato risolto il controverso caso della revoca degli amministratori di una s.p.a. nominati dall’ente pubblico: l’atto con cui la P.A. (nomina ovvero) revoca l’amministratore è caratterizzato da una duplice natura: esso è sia un atto amministrativo, dal momento che persegue un fi ne pubblico,
sia un atto societario, considerato che il socio pubblico nomina come tale il suo rappresentante nel c.d.a.
Non è però sufficiente a radicare la giurisdizione del g.a., secondo la giurisprudenza prevalente, che l’atto
in questione assolva in parte ad una funzione pubblicistica, perché la nomina del proprio rappresentante in
seno al c.d.a. è atto societario, espressione di una prerogativa privatistica, e non già di un potere pubblicistico. Ne consegue che la tipologia di controversie in commento rientra tra quelle afferenti al funzionamento
codicistico della società, in cui prevale la veste societaria rispetto alla sostanza pubblicistica, venendo in
rilievo l’esercizio dei poteri privati del socio pubblico e non di quelli pubblici della pubblica
autorità.
Il problema si è posto, in specie, per la revoca ai sensi degli artt. 2449, 2450 c.c. di amministratori o sindaci
di una s.p.a. La giurisprudenza prevalente (Cass., Sez. un., n. 7799/2005), ha escluso la sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo a fronte della mera partecipazione in giudizio di una P.A. o del
generico coinvolgimento di un pubblico interesse. Secondo la citata pronuncia, invero, nell’esercizio del
potere esclusivo di revoca di amministratori o sindaci, il soggetto pubblico agisce nella veste di
socio della s.p.a. e non di autorità, attivando un potere che, senza la speciale legittimazione apprestata
dallo statuto o dalla legge, sarebbe comunque spettato all’assemblea dei soci, secondo l’ordinaria disciplina
delle società per azioni. Si ritiene, infatti, che esso sia espressione di una “potestà attinente ad una situazione
giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa” (Cass., Sez. un., n. 7799/2005),
non rilevando, nel senso di una qualificazione in chiave pubblicistica di detto potere, la circostanza che ne
sia titolare l’ente pubblico, socio di maggioranza della s.p.a. Né può giungersi ad una diversa conclusione
in ragione del dettato dell’art. 2450 c.c. (ora abrogato), il quale prevedeva a favore del soggetto pubblico
un potere di revoca degli amministratori, considerato che non esiste una regola di portata assoluta secondo
la quale un potere attribuito dalla legge all’amministrazione debba avere necessariamente natura pubblicistica, tanto più che, in ogni caso, il potere di revoca è comunque spettante alla assemblea alla quale la P.A.
partecipa in veste di socio della società. In defi nitiva, come di recente sottolineato da TAR Campania
Napoli, Sez. I, 17.04.2008, n. 2252, il potere di nomina di amministratori e sindaci di società a partecipazione statale, ex artt. 2449 e 2450 c.c., deve ritenersi attribuito al soggetto pubblico nella sua veste di
socio, risolvendosi nell’esercizio diretto di un potere sostitutivo delle ordinarie competenze assembleari e
che va ad incidere su organi societari che operano in ogni caso secondo diritto privato.
Ne consegue, pertanto, che deve senz’altro ritenersi che la natura eminentemente privatistica del potere di
revoca impone la qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva azionata, la cui tutela spetta, dunque, al giudice ordinario quale giudice dei diritti (in questi termini si è espresso
il TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2008, n. 1184).
Occorre, da ultimo, sottolineare che tali conclusioni sono ulteriormente confortate dalla menzionata abrogazione dell’art. 2450 c.c. ad opera della cd. “legge comunitaria” del 2007 (art. 3, L. 46/2007).
5.3. Conclusioni
Riepilogando e concludendo, deve quindi ritenersi che la forma societaria non
sia incompatibile con la figura di ente pubblico ove, nonostante la veste privatistica, permangano i controlli ed i poteri pubblicistici. Va però precisato
che la struttura societaria dell’ente pubblico comporta ulteriori “anomalie” in merito
alla disciplina applicabile, posto che le norme concernenti l’organizzazione e l’attività
della P.A. potranno trovare applicazione solo in quanto compatibili con la natura di
soggetti che restano comunque assoggettati anche alla normativa codicistica. Da tale
operazione scaturiscono importanti conseguenze sul piano del relativo contenzioso,
che sarà devoluto al g.a. in presenza di attività pubblicistiche o ad esse equiparate,
mentre si radicherà in capo al g.o., ove sia giudizialmente contestato il funzionamento della società secondo le prescrizioni codicistiche, senza che sia sufficiente in senso
opposto un generico coinvolgimento dell’interesse o del soggetto pubblico.
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
19
6. Dallo status di ente pubblico alla logica delle geometrie variabili: la
nozione comunitaria di pubblica amministrazione
Le considerazioni fin qui svolte in ordine agli enti societari pubblici, testimoniano
chiaramente come si vada affermando un concetto di ente pubblico “elastico”, per
il quale essi, più che essere enti pubblici in ogni loro sfera di azione e di manifestazione, siano considerati enti pubblici in riferimento ai singoli istituti che di volta in
volta vengono in considerazione (l’accesso, le gare di appalto, il controllo contabile,
il rapporto di lavoro).
Emerge in definitiva una logica, avallata anche dalla legge, che plasma il concetto
di ente pubblico in funzione della specifica disciplina da applicare, rinunciando a
definizioni ontologiche ed universali.
È chiara la soluzione di continuità rispetto all’impostazione classica di cui
si è dato conto all’inizio di questo capitolo, ove sono esaminati la nozione di ente
pubblico, le conseguenze disciplinatorie di tale qualifica ed i criteri di distinzione
rispetto ai soggetti privati.
Ed invero, in passato si dava per scontato che la qualifica di ente pubblico fosse
uno status permanente, che concernesse il campo generale delle sue azioni e dei
suoi comportamenti. Negli ultimi anni, al contrario, si è andata affermando la cd.
“logica delle geometrie variabili”, di matrice comunitaria, in base alla
quale, almeno nei settori toccati da interventi comunitari, un ente può
essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati
ambiti disciplinatori, mentre invece nella generalità della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, è da considerarsi come un soggetto meramente
privatistico.
Il diritto comunitario sposa, infatti, una nozione flessibile di ente pubblico che ben
si coniuga con il cosiddetto principio “dell’effetto utile” (art. 10 Trattato CE ), in
base al quale la miglior soluzione del caso concreto deve essere quella più corrispondente al fine che la norma comunitaria vuole perseguire.
A seconda dei vari ambiti disciplinatori, dunque, può essere maggiormente funzionale allo scopo che l’Unione si prefigge una nozione ampia piuttosto che ristretta
di ente pubblico, poiché, a seconda dei casi, l’accezione più o meno estesa può meglio
garantire il perseguimento dei fini essenziali della Comunità.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alle diverse nozioni di pubblica amministrazione che l’Unione Europea abbraccia ai fini della regolamentazione dei
rapporti di lavoro, della responsabilità e degli appalti pubblici.
In merito al primo profilo, l’art. 39 del Trattato prevede come regola generale
la libertà di svolgimento dell’attività lavorativa in ogni Paese Comunitario, senza discriminazioni relative alla nazionalità. L’art. 32 stabilisce, a sua volta, in deroga a tale
regola generale, che è possibile limitare la libertà di accesso di un cittadino comunitario ad un impiego presso un altro Paese dell’Unione ove si tratti di un rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che dalla qualifica pubblica dell’ente datore di lavoro consegue la possibilità di riservare l’accesso
all’attività lavorativa ai soli cittadini dello Stato membro, in deroga all’art. 39 Trattato
CE. Orbene, in tali ipotesi, la Corte di giustizia ha dato della nozione di ente
pubblico una lettura restrittiva, finalizzata ad erodere i limiti di accesso
20
Compendio di Diritto Amministrativo
del lavoratore non nazionale alla prestazione lavorativa (Corte di giustizia, 30
maggio 1989, C-33/88).
In prima battuta si esclude che siano qualificabili pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’art. 32 del Trattato gli enti che svolgono attività di impresa; inoltre, la
limitazione dell’accesso all’attività lavorativa ai soli lavoratori nazionali, può essere
disposta dalle PP.AA. solo per rapporti di lavoro caratterizzati dall’esercizio diretto o
indiretto in senso stretto del potere pubblicistico (v. art. 38 T.U. n. 165/2001).
Assai diversa è, invece, la nozione di pubblica amministrazione in materia
di appalti pubblici. In tali ipotesi, invero, l’esigenza prioritaria per il diritto comunitario è quella di obbligare l’ente pubblico, a seguire procedure di evidenza pubblica
per la scelta del contraente, rispettose dei principi comunitari sulla concorrenza e che
consentano ad ogni operatore economico professionale, di partecipare ad una gara
per giocare le proprie chance competitive, senza alcuna discriminazione su base di
nazionalità e di residenza. È chiaro che, a questi fini, è maggiormente rispondente
all’esigenza comunitaria di rispetto delle regole sulla concorrenza e di attuazione
delle libertà fondamentali di circolazione di capitali, persone e servizi, una definizione ampia di ente pubblico, di modo che il diffuso assoggettamento alle procedure
pubbliche di scelta del contraente consenta ad ogni impresa, anche non nazionale, di
partecipare senza alcun ostacolo e senza alcuna discriminazione alla gara. A tal fine
la nozione comunitaria di ente pubblico è finalizzata a snidare la pubblicità reale
dell’ente, che si nasconde al di là del dato formale della mera veste privatistica.
La logica comunitaria consente pertanto di ricomprendere tra le pubbliche amministrazioni, tenute alla procedura di evidenza pubblica, non solo i soggetti formalmente
pubblici, ma anche quelli con veste privata sottoposti ad un’influenza pubblica, onde
evitare che la struttura formalmente privatistica costituisca un facile congegno elusivo onde liberarsi dai vincoli procedimentali che costringono i contratti delle pubbliche amministrazioni. Di qui l’emersione della nozione di organismo di diritto
pubblico di cui si dirà nel paragrafo che segue, in cui si dà rilievo, per l’appunto,
all’“anima” pubblica dell’ente e non già alla mera matrice formalistica dello stesso.
Ancora diversa è la nozione di ente pubblico elaborata dalla giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità dello Stato nazionale per violazione del
diritto comunitario.
Poiché le norme in materia di responsabilità perseguono l’obiettivo di obbligare
al rispetto del diritto comunitario i soggetti che sono investiti di funzioni pubbliche,
è evidente che tale fine è perseguito efficacemente nella misura in cui tale responsabilità sia imputabile indistintamente a tutti i soggetti che detengono a vario titolo il
potere pubblico in senso lato: Stato centrale ed enti periferici, enti autarchici ed economici, nonché i soggetti privati titolari di pubblici poteri (vedi par. 10.). Sul piano
comunitario, in definitiva, ciò che conta è che sia assicurato l’obiettivo di legittimare
passivamente ogni soggetto provvisto di una veste pubblicistica sul piano sostanziale,
affinché risponda dei danni cagionati dal non corretto esercizio del potere o della
funzione pubblica.
Non va sottaciuto che anche la nostra legislazione nazionale, in ossequio al
diritto comunitario, si sta aprendo ad una nozione di ente pubblico non statica, ma applicata a casi specifici, così qualificando un ente come pubblico
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
21
non perpetuamente, ma per scopi peculiari. È quanto è accaduto in materia di
appalti e di accesso.
È quanto è accaduto per il Codice dei Contratti Pubblici ( D.LGS. n. 163/2006),
il quale sottopone alle regole di evidenza pubblica una serie di soggetti (organismi
di diritto pubblico, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici), ai soli fini dell’assoggettabilità alla disciplina relativa agli
appalti, dettata dallo stesso codice. Ne consegue, evidentemente, che, sul crinale
giurisdizionale, anche il relativo contenzioso è devoluto al giudice amministrativo,
ex art. 103 Cost., nella misura in cui i soggetti individuati dal Codice sono da considerarsi enti pubblici.
Analogamente, l’art. 22 della L. n. 241/1990, in combinato disposto con il
successivo art. 23, assoggetta alla disciplina dell’accesso non solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati gestori di pubblici servizi. Anche in questo caso deve
desumersi dall’obbligo imposto a tali soggetti di seguire sul piano dell’accesso gli
stessi vincoli che avvincono i soggetti pubblici, devolvendo il relativo contenzioso
alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 25, che tali soggetti debbano considerarsi enti pubblici.
Si tratta quindi di un altro ambito nel quale è stata elaborata una definizione ad
hoc di ente pubblico, funzionale al perseguimento delle finalità dell’istituto. Esso,
come confermato dal TAR Lazio Roma, nella recente pronuncia del 30 gennaio
2008, n. 714, può essere esercitato nei confronti della P.A. anche quando gli atti e i
documenti dei quali è richiesta la conoscenza riguardino attività di diritto privato,
posto che l’istituto in parola attende ad una generalizzata funzione di controllo della
legittimità dell’azione amministrativa, ove essa incida su interessi di cui è titolare il
richiedente. Sul piano applicativo ne consegue, in materia di pubblico impiego, che la
privatizzazione del rapporto d’impiego del personale statale e degli enti pubblici non
incide sull’ammissibilità del diritto d’accesso ad atti e documenti, la cui conoscenza
soddisfa direttamente l’esigenza di tutela di diretti interessi del richiedente.
Può quindi concludersi che, sulla scorta della disciplina comunitaria, la quale spinge verso una nozione flessibile di pubblica amministrazione, protesa a qualificare
come pubblico un soggetto con riferimento a specifici applicativi con esigenze disciplinatorie peculiari, anche la legge nazionale, come è accaduto per gli appalti e l’accesso, comincia a rinunciare ad una soluzione definitoria universale di enti pubblici,
coniandone a fini settoriali, con l’assunto implicito che al di fuori di tali ambiti questi
soggetti rimangono totalmente privatistici. Ne consegue che tali soggetti, qualificati
come pubblici solo a determinati fini, restano per il resto assoggettati alla relativa disciplina privatistica, in quanto, al di fuori del settore in cui sono qualificati pubblici,
essi non soggiacciono al regime proprio degli enti pubblici.
Oltre che in riferimento agli istituti sopra descritti, poi, la nozione comunitaria “elastica” di P.A. in base al
principio dell’effetto utile, ha trovato ulteriori, numerose applicazioni, sia pur più settoriali e specifiche. Si
pensi al settore radiotelevisivo, in riferimento al quale TAR Lazio Roma, Sez. III, 1 aprile 2008,
n. 2779, ha da ultimo escluso la natura di ente pubblico della Fiera di Genova s.p.a. la quale, ad avviso
del tribunale amministrativo, “non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 41, TUR ( D.L GS. 31 luglio 2005
n. 177), che vede come destinatari le Amministrazioni Pubbliche e gli enti pubblici anche economici”, poiché, ai fi ni
dell’applicazione di detta normativa, esulano “i soggetti privati, tra cui vanno annoverate le società per azioni
partecipate da enti pubblici prive di signifi cativi tratti pubblicistici”.
22
Compendio di Diritto Amministrativo
Analogamente, il TAR Lazio Roma, Sez. III, 3 marzo 2008, n. 1938, ha stabilito che, in materia di
fi nanza pubblica, in relazione al “contenimento d’incremento della spesa pubblica nel limite massimo percentuale
del 2 per cento” di cui all’art. 1, comma 5, L. n. 311/2004, “non giustifi ca l’attrazione nell’ambito della pubblica
amministrazione – pur ove di questa si patrocini la nozione più ampia – di enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e che sono organizzati sulla base di un circuito che si
potrebbe definire ‘chiuso’ dal punto di vista finanziario”.
7. L’organismo di diritto pubblico
Esempio plastico di questa nozione sostanzialistica e settoriale di pubblica amministrazione elaborata dal diritto comunitario è quella di organismo di diritto pubblico, categoria operante esclusivamente nel campo degli appalti pubblici, rectius dei
contratti pubblici.
L’istituto dell’organismo di diritto pubblico è stato introdotto dalle direttive comunitarie che hanno disciplinato la materia degli appalti pubblici, quale soluzione
concepita per individuare le cd. amministrazioni aggiudicatrici, ovvero i
soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte dalle norme
comunitarie.
In luogo del criterio enumerativo prediletto dalle prime direttive degli anni
’70, che qualificava come amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, gli enti pubblici
territoriali e le persone giuridiche pubbliche tassativamente indicate dalle medesime
direttive, l’Unione europea ha successivamente rinunciato ad una rigorosa elencazione – facile all’elusione e all’obsolescenza – ed ha abbracciato un criterio sostanziale
elastico.
Detto criterio è stato confermato dalle direttive nn. 17 e 18/2004, recepite nel
D.L GS. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, che definisce l’organismo di diritto pubblico all’art. 3, comma 26, come “qualsiasi organismo, anche in
forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà
è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
La Corte di giustizia, più volte interrogata sul punto dagli Stati membri con il
meccanismo del rinvio pregiudiziale, ha di volta in volta individuato la nozione di
organismo di diritto pubblico dettando una regola del caso concreto piuttosto che
una definizione uniformante, secondo “un’interpretazione funzionale che consentisse di
perseguire gli obiettivi di non discriminazione e tutela della concorrenza che la disciplina degli
appalti pubblici si pone di preservare” (cfr. ad es. Corte. Giust., 10 novembre 1998, in
C-360/96, in Dir. proc. amm., 1999, 189, e 15 gennaio 1998, in C-44/96, Foro amm.,
1998, 2291).
La normativa comunitaria, oggi confluita nel Codice dei contratti, individua l’organismo di diritto pubblico alla stregua di tre parametri, tutti necessari (sono quindi
requisiti cumulativi): 1) la personalità giuridica; 2) la sottoposizione ad una influenza
pubblica dominante; 3) l’istituzione in vista del soddisfacimento di bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale.
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
23
Verranno di seguito esaminati i tre detti requisiti, con la premessa che il Codice
dei contratti pubblici di cui al D.LGS. n. 163/2006 ha sancito la soggezione degli organismi che non siano pubbliche amministrazioni nazionali alle regole di evidenza
pubblica a prescindere dal superamento della soglia economica stabilita dalle direttive
europee, e quindi anche per gli appalti di rilievo economico meramente nazionale. Si
può quindi dire, a buona ragione, che la nozione di organismo di diritto pubblico è ormai una nozione nazionale, non più solo comunitaria.
7.1. La personalità giuridica
Occorre premettere che il requisito della personalità va inteso come sinonimo,
in senso ampio, della soggettività giuridica, ovvero della presenza di un soggetto
come centro di imputazione di situazioni giuridiche. Non solo quindi le persone
giuridiche del nostro codice civile ma anche gli enti di fatto (si pensi alle associazioni non riconosciute), essendo soggetti di diritto, posseggono il requisito in esame
e, quindi, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, possono assurgere
al rango di organismi di diritto pubblico.
La nozione comunitaria di personalità giuridica è poi riferibile sia alla personalità giuridica di diritto pubblico che alla personalità giuridica di diritto privato. Difatti,
vista l’indifferenza alle forme e l’approccio sostanzialistico che permea il diritto comunitario, il carattere privato di un ente, e più in generale la sua forma di costituzione, non
sono sufficienti ad escluderne la natura di organismo di diritto pubblico, che al contrario
risulta confermata ove l’ente possegga gli altri requisiti cumulativi dinanzi ricordati (cfr.
Corte Giust., 1 febbraio 2001, in C-237/99; 12 dicembre 2002, in C-470/99).
Al fine del conseguimento dell’effetto utile avuto di mira dalle citate direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, si rende poi necessaria un’interpretazione estensiva delle condizioni necessarie per individuare un organismo di diritto
pubblico. In questa logica, può concludersi che l’applicazione della normativa comunitaria – ove siano integrati i presupposti dalla stessa previsti – non può essere esclusa
per il solo fatto che un organismo sia qualificato dal diritto nazionale come ente di
diritto privato (cfr. Corte Giust., 15 maggio 2003, in C-214/2000).
Il problema si è posto per le società miste a capitale pubblico-privato, che svolgono attività di interesse
generale secondo criteri economici (si pensi alle società previste dall’art. 113 TUEL).
Secondo un orientamento più risalente, la società per azioni mista non integra la figura dell’organismo
di diritto pubblico, perché agisce “in sfere diverse, per fini diversi e con diversi strumenti giuridici”, restando un
soggetto di diritto privato che esplica un’attività lucrativa diretta alla produzione ed allo scambio di beni e
servizi e non un’attività fi nalizzata al soddisfacimento di bisogni di interesse generale (Cass. civ., Sez. Un.,
6 maggio 1995, n. 4989, in Giust. civ. 1995, I, 2985 ss.).
È, però, prevalso un diverso indirizzo che, in linea con l’impostazione sostanzialistica della Corte di giustizia, sostiene “l’irrilevanza della forma societaria in base al diritto interno ai fini della qualifi cazione di un organismo
di diritto pubblico, per la quale rileva l’esercizio di un’attività di rilevanza pubblicistica, ovvero di un’attività che pur
eventualmente perseguendo finalità di profitto sia nondimeno funzionalizzata all’interesse generale” (Cons. St., Sez.
V, 21 ottobre 1991, n. 1250, in Giur. it., 1995, III, 1, 25 ss.).
7.2. L’influenza pubblica dominante
Il requisito dell’influenza pubblica dominante è integrato dal verificarsi di uno dei
tre seguenti fattori alternativi (in questo caso, quindi, vengono in rilievo parame-
24
Compendio di Diritto Amministrativo
tri disgiuntivi): 1) il finanziamento pubblico maggioritario; 2) il controllo pubblico
sulla gestione; 3) l’attribuzione alla mano pubblica della nomina di più della metà dei
componenti gli organi di direzione, amministrazione o vigilanza degli organismi.
Costituiscono finanziamento pubblico maggioritario le erogazioni concesse
da un’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito delle proprie attività istituzionali,
svincolate da una controprestazione contrattuale a carico del soggetto beneficiario,
e che hanno come effetto quello di creare o rafforzare un legame di subordinazione
o stretta dipendenza tra il percettore e lo Stato, gli enti territoriali o altri organismi
di diritto pubblico.
Il riferimento al carattere maggioritario implica che l’organismo possa
essere parzialmente finanziato anche in altri modi, senza che per ciò solo venga meno la sua natura di organismo di diritto pubblico.
D’altro canto, la Corte gius. CE , Sez. IV, 13.12.2007, n. 337, ha di recente osservato come, l’interpretazione della nozione di organismo di diritto pubblico alla luce del principio dell’effetto utile di cui si
è detto in precedenza, implica che debbano essere verificati in chiave funzionale anche i relativi requisiti,
in vista dell’esigenza comunitaria di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci
e di proteggere gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro allorquando intendano offrire beni e servizi alle amministrazioni aggiudicatrici di in un altro Stato membro. Ne consegue
che deve ritenersi fi nanziamento pubblico quello “originato da un atto dello Stato, garantito da quest’ultimo ed
assicurato attraverso un sistema impositivo e di riscossione che rientra nell’ambito delle potestà di imperio. Tale metodo di
finanziamento indiretto è suffi ciente affinché sia soddisfatto il requisito relativo al ‘finanziamento statale’ previsto nella
normativa comunitaria”.
Si deve soggiungere che, per ovvie ragioni di certezza dei rapporti giuridici, la
valutazione del requisito va effettuata a fine anno, per operare per tutto l’anno
successivo con riguardo alle risultanze del bilancio (anche preventivo), senza che
abbiano rilievo eventuali modifiche in corso d’anno.
Venendo al parametro del controllo sulla gestione, esso si realizza allorché sussista una stretta dipendenza tra l’ente e i pubblici poteri, che consenta a questi ultimi
di esercitare un’influenza dominante sulle decisioni adottate dall’ente stesso (Corte
Giust., 1 febbraio 2001, in C-237/99, cit.).
Con sentenza del 27 febbraio 2003, resa dalla V Sezione nella C-373/00, la Corte di giustizia ha
affermato che un mero controllo a posteriori non soddisfa il criterio del controllo sulla gestione.
Soddisfa per contro detto criterio una situazione in cui, da un lato, i poteri pubblici controllano non solo i
conti annuali dell’organismo considerato, ma anche l’esattezza, la regolarità, l’economicità, la redditività e
la razionalità dell’amministrazione corrente e, dall’altro, gli stessi poteri pubblici sono autorizzati a visitare
i locali e gli impianti aziendali del suddetto organismo e a riferire sul risultato di tali verifiche a un ente
locale che detenga, tramite un’altra società, il capitale dell’organismo di cui trattasi.
Le Sezioni unite della Cassazione (12 maggio 2005, n. 9940, in Contratti, 2006, 1, 35) hanno precisato che
è possibile l’esercizio del controllo da parte di più enti pubblici.
Nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha affermato che, ove si tratti di organismi di diritto pubblico
che abbiano forma di società per azioni, la nozione di controllo deve ricavarsi dall’art. 2359 c.c. La
norma, che prevede tre diverse ipotesi di controllo, è stata giudicata perfettamente conciliabile con quanto dettato
dalla normativa comunitaria. Nel caso di specie, la Corte ha confrontato il criterio della sottoposizione alla dominanza pubblica enunciato dall’art. 2, comma 7, lett. a) della L. n. 109/1994 (oggi sostituito dalla nozione
dettata dall’art. 3, comma 26, D.L GS. 163/2006), che prevedeva il possesso del 50% più uno delle azioni
della società, con il criterio segnato dall’art. 2359 c.c., il quale considera tra l’altro società controllate “le
società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”. Delle tre diverse
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
25
ipotesi di controllo enumerate dal codice civile, quella menzionata è stata denominata come controllo
di diritto. La norma, inoltre, prevede il caso di società in cui un’altra società “dispone di voti suffi cienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria” (cd. controllo di fatto), nonché il caso in cui vi
siano società “sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali” (art. 2359 c.c.)
(Trib. Milano, 28 aprile 1994). Si è, al riguardo, argomentato che la Corte ha applicato una regola di diritto
privato, enunciata in tema di controllo di società di diritto privato su altra società di diritto privato, alle
s.p.a. in mano pubblica, affermando per tale via il principio dell’applicabilità alle società in mano pubblica
delle norme di diritto comune, in quanto compatibili.
Quanto alla nomina della maggioranza dei componenti degli organi di
gestione – requisito in sé di chiara applicazione – non rileva la circostanza che la
partecipazione di tali componenti all’attività dell’organismo avvenga “a titolo personale” e non invece “a titolo istituzionale”, ovvero in rappresentanza delle istituzioni.
Il Giudice amministrativo ha pertanto ritenuto priva di pregio la tesi secondo cui,
in presenza di componenti di “provenienza pubblica”, occorrerebbe escludere la sussistenza del suddetto requisito allorché detti soggetti partecipino all’attività dell’organismo “a titolo personale”, e non in qualità di rappresentanti delle istituzioni. L’assunto
è stato respinto, principalmente, sulla base dell’incertezza derivante da una distinzione fra partecipazione “a titolo personale” e partecipazione “a titolo istituzionale”, in
contrasto con le particolari esigenze di certezza nell’interpretazione ed applicazione
della disciplina comunitaria, che in numerose occasioni sono state rimarcate dalla
Corte di giustizia (TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 3 marzo 2004, n. 362).
7.3. Il requisito teleologico
Venendo al cd. requisito teleologico, la normativa stabilisce che deve trattarsi di
un soggetto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale.
È l’elemento che ha presentato maggiori difficoltà per l’interprete.
Cominciando con l’avverbio “specificatamente”, la giurisprudenza lo ha interpretato nel senso che è sufficiente che l’ente sia stato istituito in modo specifico pur se non solo, e neanche in via prevalente, al fine di soddisfare detto
bisogno generale. Non è quindi necessario che l’ente eserciti in modo esclusivo
ed assorbente l’attività finalistica, potendo al contrario espletare ulteriori funzioni e
riservare anche una parte relativamente poco rilevante delle proprie attività al soddisfacimento di bisogni generali (Corte Giust., 10 novembre 1998, in C- 360/96).
Ne deriva che ove l’ente persegua molteplici finalità, tra cui una sola qualificata nel senso ora esposto, esso sarà da considerare sempre organismo, e cioè
anche laddove operi per le altre finalità che non abbiano tale connotazione. Per ovvie
ragioni di certezza non è infatti possibile scindere i campi di azione dello stesso ente
e farlo soggiacere alle regole di evidenza pubblica solo quando agisca per il fine di
interesse generale (così Cons. St., Sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2280).
Ci si deve quindi chiedere cosa intendano dire le direttive comunitarie in materia
di appalti pubblici ove rinunciano a definire espressamente quali siano i “bisogni di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale”. La Corte di giustizia (27 febbraio
2003, in C-373/2000, Adolf Truley Gmbh c. Bestattung Wien Gmbh, ) ha affermato
che la formula “bisogni di interesse generale” è una nozione autonoma del
26
Compendio di Diritto Amministrativo
diritto comunitario, che deve essere interpretata tenendo conto del contesto di
riferimento e delle finalità perseguite dalle direttive in tema di appalti.
La Corte di giustizia, ha altresì specificato come i bisogni generali di carattere
non industriale o commerciale siano una species dei bisogni di carattere generale. L’interprete sarà dunque chiamato preliminarmente ad accertare che l’attività
dell’ente sia rivolta a soddisfare bisogni generali, e poi a verificare se questi ultimi
presentino carattere non industriale o commerciale.
La Corte di giustizia ha quindi identificato una serie di indici sintomatici, in
presenza dei quali è possibile affermare o escludere la sussistenza dei bisogni di carattere non industriale e commerciale.
In primo luogo, occorre verificare se l’ente sia istituzionalmente preposto
al soddisfacimento di bisogni diffusi o se, lungi dal prestare servizi in favore
della collettività, faccia fronte alle esigenze di un uno o più enti pubblici di riferimento (Corte Giust., 15 gennaio 1998, in C-44/96, cit.). Se il soggetto opera
esclusivamente per l’ente pubblico, infatti, ne costituisce in ultima analisi un’articolazione (si veda per le società in house la parte VII, cap. II), e, quindi, soddisfa bisogni
riservati di carattere marcatamente pubblicistico sottratti al mercato, come tali non
industriali e commerciali.
Il Cons. St., Sez. IV, 13 febbraio 1996, n. 147, ha in tal modo qualificato come organismo di diritto pubblico la Lombardia Informatica s.p.a. (società per azioni nella quale la Regione Lombardia ha assunto una
partecipazione azionaria di maggioranza e alla quale lo stesso ente ha affidato direttamente, senza cioè
l’indizione di una gara, la gestione di un programma operativo di servizi informatici automatizzati di interesse regionale), muovendo sostanzialmente dalla considerazione del rapporto intercorrente tra la stessa e la
Regione, non qualificabile in termini di terzietà sostanziale, essendo la prima un “modulo organizzativo”
di cui la seconda si avvale per soddisfare esigenze sue proprie.
Per le stesse ragioni, il TAR Valle d’Aosta, 15.11.2007, n. 140, ha negato il carattere di organismo di diritto
pubblico al Casinò de la Vallée s.p.a., nonostante la società fosse in possesso dei requisiti della personalità
giuridica e della sottoposizione ad influenza pubblica.
In secondo luogo, è opportuno accertare se l’ente operi in regime concorrenziale, avvertendo però che tale condizione, che in astratto è sintomatica del
carattere industriale o commerciale dell’ente, può in concreto attagliarsi anche ad un
organismo di diritto pubblico. Si tratta di un indizio presuntivo superabile con prova
contraria; ma non di un dato assolutamente irrefutabile. Difatti, il giudice comunitario non riferisce il requisito teleologico all’attività svolta e alle modalità di gestione
della stessa (cioè al fatto che l’ente operi secondo criteri di rendimento, efficacia
e redditività), bensì ai bisogni che attraverso tale attività l’ente mira a perseguire,
bisogni che possono attenere ad es. alla tutela della salute e dell’ambiente (Corte
Giust., 10 novembre 1996, in C-360/96). Da ciò consegue che “la mancanza di
concorrenza non costituisce una condizione necessaria ai fini della definizione di un organismo di diritto pubblico”, risultando perciò non decisiva la
presenza di imprese private sul mercato che possano soddisfare i bisogni cui l’attività
dell’ente è finalizzata.
Specularmente, la presenza di un ambiente concorrenziale non è decisiva in senso
opposto, ben potendosi rinvenire gli estremi dell’organismo ove esso sia stato istituito
per soddisfare quella quota di bisogni che il mercato non è in grado di soddisfare e che è tuttavia interesse pubblico che non restino insoddisfatti.
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
27
Inoltre, può risultare significativo il fatto che l’ente sia sottoposto ad una gestione
imprenditoriale e che ne sopporti il relativo rischio finanziario.
Non è di norma riscontrabile il carattere industriale o commerciale ove sia lo Stato
o altro ente pubblico a ripianare le perdite e finanziare un ente, pur se in astratto
l’ente persegua finalità di profitto. In questo caso il soggetto opera senza soggiacere
alle regole di mercato, a dimostrazione di un bisogno non soddisfacibile secondo le
logiche ordinarie della vita industriale e commerciale.
Al contrario, “se l’organismo opera in normali condizioni di mercato, persegue lo scopo di
lucro e subisce le perdite connesse all’esercizio della sua attività, è poco probabile che i bisogni
che esso mira a realizzare abbiano carattere non industriale o commerciale” (Corte Giust., 22
maggio 2003, in C-18/2001, in Foro amm. – Cons. St., 2003, 1498). In tal caso la sua
sopravvivenza dipende dalla sua capacità; e ciò testimonia che l’ente opera secondo
logiche di mercato, e quindi, che trattasi di bisogno la cui soddisfazione non necessita
di una deroga alle regole ordinarie: è quindi un bisogno magari generale ma senz’altro industriale e commerciale.
Molto efficacemente TAR Valle d’Aosta, 15 novembre 2007, n. 140, chiarisce che: “Ai fini della sussistenza dell’elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – richiesto per la qualifi cazione di un ente come
organismo di diritto pubblico è suffi ciente la verifi ca della mera idoneità di un’attività a soddisfare le esigenze di una
pluralità di soggetti diversi dall’ente socio, mentre non deve ritenersi necessaria né la configurazione dell’attività in termini
di servizio pubblico, né il conferimento di poteri pubblici o il trasferimento di diritti speciali od esclusivi. Ai fini della
sussistenza dell’elemento negativo – la natura non commerciale o industriale dei ‘bisogni’ (come letteralmente dispone la
norma) o delle ‘attività’ (come sembra più corretto intendere, seguendo una interpretazione sistematica) – richiesto per la
qualifi cazione di un ente come organismo di diritto pubblico è necessario un esame in concreto dell’operatività del soggetto,
prendendo in considerazione a) se il soggetto opera in normali condizioni di mercato; b) se il soggetto persegue scopi di
lucro; c) se il soggetto subisce le perdite commerciali connesse all’esercizio della sua attività”.
È bene infine precisare che, trattandosi di indici sintomatici, è sempre necessario tenere conto della situazione di fatto e di diritto pertinente, al fine di
concludere per la sussistenza o meno di un bisogno di interesse generale, a carattere
non industriale o commerciale.
La giurisprudenza più recente ha fatto applicazione dei principi sin qui esposti onde verificare la natura
pubblicistica degli enti, per lo più ai fi ni dell’applicabilità della normativa, comunitaria e nazionale, in tema
di evidenza pubblica. Le Sezioni unite, ad esempio, hanno affermato la natura di organismo di diritto
pubblico della Rai s.p.a., posto che essa assume la forma di impresa pubblica, sotto forma societaria,
in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante, operante nel settore dei “servizi” pubblici di telecomunicazioni radio e televisive, assoggettata ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita
per soddisfare fi nalità di interesse generale, con il conseguente assoggettamento alle norme comunitarie
di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti nella
stipula dei contratti di appalto (Cass. Civ., Sez. un., 23 aprile 2008, n. 10443).
Ad analoghe conclusioni è poi giunto il Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. IV, 13 marzo 2008, n.
1094) in riferimento alla Società Autostrade per l’Italia s.p.a., atteso che detta società va qualificata
come organismo di diritto pubblico e che “in quanto tale, opera come un’amministrazione aggiudicatrice tenuta al
rispetto delle norme sugli appalti pubblici, anche se ha natura privatistica”.
8. Classificazione degli enti pubblici
Tanto detto per la tormentata nozione di ente pubblico e venendo ai vari tipi di
enti pubblici (con riguardo a quelli tradizionali e non a quelli societari e comunitari),
28
Compendio di Diritto Amministrativo
risulta prevalente in dottrina la seguente classificazione (per approfondimenti vedi
anche la parte III, cap. I, parr. 4. e segg.):
a) Corporazioni e istituzioni
Le corporazioni sono persone giuridiche in cui assume prevalenza l’elemento personale (trattasi, in definitiva, di associazioni di più persone), mentre nelle istituzioni
assume rilievo preponderante l’elemento patrimoniale (si ponga mente agli istituti
previdenziali);
b) Enti territoriali e non territoriali
Nei primi il territorio è uno degli elementi costitutivi, come tale essenziale
per l’esistenza dell’ente e non mero ambito spaziale di sua operatività. Si pensi alla
Regione, al Comune ed alla Provincia (vedi ancora parte III, cap. I).
Tutti gli altri enti sono enti non territoriali, denominati anche enti istituzionali, a loro
volta, a seconda del rispettivo raggio di azione, classificabili come enti a carattere
nazionale ovvero locale;
c) Enti nazionali ed enti locali
Il carattere locale o nazionale di un ente, lungi dall’essere questione di mera teoria, assume rilievo disciplinatorio. Il concetto va rapportato più che alla sola sfera
d’azione all’ambito degli interessi pubblici perseguiti dall’ente stesso. Sono pertanto enti locali quelli che operano in una limitata circoscrizione territoriale per
perseguire un interesse pubblico proprio di tale circoscrizione; enti nazionali sono
invece tutti gli altri, inclusi quelli destinati ad operare in un ambito territoriale
limitato, ma per perseguire un interesse nazionale (si considerino gli enti portuali
ovvero i consorzi tra enti locali e lo Stato per la costruzione o la gestione di opere
e servizi nell’interesse nazionale);
d) Enti necessari
Sono tali quegli enti che per l’organizzazione amministrativa del nostro ordinamento devono necessariamente esistere: si pensi, ad esempio, agli enti territoriali, alle
Camere di Commercio, agli ordini ed ai collegi professionali.
Da ultimo l’art. 26 del decreto L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n.
133, ha previsto, con talune eccezioni, la soppressione: a) degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine; b) di tutti gli altri
enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia
che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni
rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse fi nanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di
lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere
rinnovati o prorogati.
e) Enti ad appartenenza necessaria o facoltativa
Sono ad appartenenza necessaria gli enti di cui si fa parte per il solo fatto di risiedere
sul loro territorio.
Gli enti ad appartenenza necessaria più importanti sono i cd. enti territoriali (cfr.
sub b));
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
29
f ) Enti autonomi, ausiliari e strumentali
Tale distinzione, per la quale si rinvia alla parte III, cap. I, parr. 2. e segg., ai fi ni del necessario approfondimento, evoca le tre note formule elaborate da A LDO M ARIA SANDULLI per mettere in luce i rapporti tra lo
Stato e gli enti pubblici che ad esso si correlano.
Infatti, gli enti strumentali evocano il modello del decentramento autarchico, mercé il quale lo Stato
affida il perseguimento di fi ni suoi propri ed esclusivi ad enti diversi da esso (ad es. ISTAT). Trattandosi di
fi ni propri dello Stato, il collegamento tra ente e Stato deve essere strettissimo e l’autonomia dell’ente assai
limitata. Il fenomeno del decentramento autarchico transita quindi attraverso enti, perciò, defi niti strumentali, i quali sono legati allo Stato da veri e propri vincoli di soggezione (cd. enti statali o governativi).
Un modello similare si realizza, in ambito più territorialmente circoscritto, per gli enti strumentali delle
Regioni, nonché per le società comunali in house o miste che operano in via sostanzialmente esclusiva
per i soddisfacimento dei bisogni degli enti locali giusta il disposto dell’art 113 TUEL n. 267/2000 (vedi
parte VII, cap. II).
Gli enti ausiliari dello Stato si inseriscono nel modello del policentrismo autarchico. Trattasi di
enti pubblici che perseguono fi ni propri dello Stato, ma non esclusivi di esso perché, generalmente, non
essenziali. Tali enti sono collegati allo Stato da rapporti meno rigorosi di soggezione rispetto a quelli che
vengono in rilievo negli enti strumentali (si pensi alle Università libere di diritto pubblico).
Infi ne, gli enti autonomi si inseriscono nell’alveo del pluralismo autonomistico, che concerne tutti i
casi di gruppi spontanei o enti esponenziali i quali esprimono esigenze sociali autonome e sono come tali
riconosciuti dall’ordinamento dello Stato, che li individua quali centri di potere amministrativo. Si pensi
agli enti territoriali e nonché agli ordini e collegi professionali.
g) Enti autarchici propriamente detti ed enti pubblici economici
I primi operano in regime di diritto amministrativo sia nella sfera dell’organizzazione che dell’azione (sono quindi dotati di poteri pubblicistici che possono usare
in alternativa a quelli privatistici), mentre i secondi agiscono in veste imprenditoriale nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi in quanto
all’esterno operano solo con gli strumenti del diritto privato. I poteri pubblicistici sono quindi spesi da tali ultimi enti esclusivamente in sede di organizzazione
interna, e più precisamente nell’enucleazione delle scelte fondamentali di autoorganizzazione in merito a strutture ed uffici.
Gli EPE si pongono in concorrenza con i soggetti economici privati, ma realizzano fi ni pubblici. Pur non
essendo lo scopo di lucro un elemento essenziale dell’EPE (che in ciò si differenzia dalle mere imprese
private), è però necessario che l’ente operi secondo il criterio della obiettiva economicità, cioè di
correlazione di costi e ricavi, nel senso che l’impresa venga esercitata in modo tale che dall’attività si ricavi
almeno quanto occorre per coprire i costi dei fattori di produzione impiegati. L’ente pubblico economico
deve perciò tendenzialmente mirare alla copertura dei propri costi di produzione e gestione attraverso le
tariffe delle prestazioni erogate.
Gli scopi che determinano lo Stato a creare EPE sono diversi: operare interventi economici di controllo
(ad es. calmierare il prezzo di una merce sul mercato, producendola e vendendola ad un costo inferiore a
quello dei beni analoghi prodotti da imprenditori privati); realizzare interventi promozionali (aiutando
economicamente un settore in crisi di un’industria che riveste interesse nazionale), ciò al fi ne di assicurare
servizi pubblici essenziali non adeguatamente coperti da imprese private, od evitare formazioni di monopolio di “fatto”.
Riguardo al regime giuridico degli EPE, occorre rilevare che: a) sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2201 c.c. e all’obbligo di bilancio consolidato ex art. 25 D.LGS. 9 aprile 1991, n. 127; b) non
sono assoggettabili al fallimento; c) a seconda dell’oggetto sociale dell’impresa stipulano con l’utenza contratti disciplinati dal codice civile; d) operano in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati.
Il fatto che operino come soggetti privati non esclude che la disciplina che regola gli EPE sia anche quella
di diritto amministrativo: basti pensare all’autonomia statutaria e regolamentare nonché al potere di autorganizzazione riconosciuti a tali enti (vedi par. 2.).
30
Compendio di Diritto Amministrativo
Trattasi di un modello in via di superamento alla luce della ricordata scelta del
legislatore di avviare la privatizzazione degli EPE con la relativa trasformazione
in società per azioni.
9. Vicende degli enti pubblici: costituzione, modificazione, estinzione
Venendo alle vicende degli enti pubblici (ci si riferirà anche in questo paragrafo,
come nel precedente, agli enti pubblici tradizionali), la costituzione di un ente pubblico può avvenire per creazione (per mezzo di un atto legislativo o amministrativo
sulla base di una legge) o per qualificazione legislativa, operando una conversione
forzata di un ente preesistente (o categoria di enti) e conferendo una qualificazione
pubblicistica (cfr. art. 4, L. n. 70/1975, cd. Legge sul parastato).
Le operazioni di riqualificazione legislativa, come si è detto, non possono essere
arbitrarie, poiché devono rispettare i limiti costituzionali posti a tutela delle formazioni sociali e della libertà di associazione.
Dei requisiti per l’individuazione della natura pubblicistica degli enti si è già detto in precedenza; in questa sede, pertanto, ci si limita a rimarcare il superamento
dell’individuazione della natura pubblica dell’ente in base al mero requisito formale
della qualificazione dello stesso, dovendosi invece avere riguardo, anche alla luce dei
principi comunitari, a requisiti “fattuali” di stampo sostanzialistico, quali l’utilizzazione di denaro pubblico e la finalizzazione alla cura di un interesse pubblico.
È sulla scorta di tali elementi che la giurisprudenza più recente ha indagato la natura pubblicistica degli
enti. Si veda, ad esempio, C. conti, Friuli Venezia Giulia, Sez. giurisd., 23 maggio 2008, n. 200,
che ha ritenuto la natura pubblicistica della FGCI- Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti, poiché,
indipendentemente dalla qualificazione di ente pubblico del Comitato, è fi nalizzato all’interesse pubblico
di “promozione e sviluppo socio morale della popolazione per mezzo dell’attività sportiva dilettantistica”.
Le modificazioni degli enti pubblici attengono a variazioni apportate ad alcuni aspetti organizzativi dell’ente, o incidenti sui rapporti giuridici patrimoniali,
o sui compiti funzionali, senza che ne risulti pregiudicata la configurazione di base
(struttura, funzione, scopi) o la sua operatività (si pensi alle modifiche dell’ambito
territoriale di intervento o alle variazioni della consistenza patrimoniale).
L’estinzione dell’ente implica la soppressione dello stesso, cui può conseguire la
disgregazione delle sue componenti strutturali, organizzative e patrimoniali, o il trasferimento delle stesse ad altro ente.
Nel caso di trasformazione dell’ente, potrebbe profi larsi sia una vicenda estintivo-costituiva, secondo una logica lato sensu successoria, sia una vicenda meramente
modificativa. Di norma, è la legge che fissa i presupposti e le condizioni per dar luogo
alla vicenda, a seconda dei casi, estintiva o modificativa, regolandone il procedimento, nonché individuando l’autorità preposta e l’eventuale ente destinatario (cfr. L. n.
70/1975, D.P.R. n. 16/1977, L. n. 59/1997; D.LGS. n. 112/2008).
Ove si verifichi una vicenda estintiva senza regolamentazione successoria, il patrimonio netto risultante dopo la liquidazione non va attribuito ad enti che
perseguano fini analoghi, similmente a quanto statuisce l’art. 31 c.c. per le persone
giuridiche private, ma si conferisce allo Stato o alla Regione, a seconda che i fini
perseguiti rientrino nella competenza dell’uno o dell’altra.
CAPITOLO I – COS'È LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
31
10. L’esercizio privato di pubbliche funzioni
L’esercizio privato di pubbliche funzioni prevede lo svolgimento di un’attività
di diritto pubblico in nome proprio da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione (sul tema vedi anche la parte III, cap. II).
L’istituto trova un referente normativo nell’art. 1 della L. n. 241/1990, che, al
comma 1, enuncia i principi generali dell’azione amministrativa e al comma 3, dispone che “i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto
dei principi di cui al comma 1”.
Si tratta, in definitiva, di un mezzo utilizzato dagli enti pubblici per il perseguimento dei loro fini. Il soggetto è e rimane privato, e svolge in nome proprio l’attività
che costituisce esplicazione della potestà pubblica.
Il principio di riserva di legge ex art. 97 Cost. impone che la traslazione del potere
pubblico in capo ad un soggetto privato debba avere a fondamento una legge autorizzativa.
Quanto alla natura giuridica del fenomeno, la tesi più accreditata ritiene che
si tratti di un caso di sostituzione di un soggetto privato ad una P.A., che rimane l’esclusiva titolare della funzione pubblica. È quindi trasferito l’esercizio
ma non la titolarità della competenza, similmente a quanto avviene nella delega nei
rapporti tra enti pubblici (vedi parte III, cap. II).
Il fenomeno si manifesta: a) nella titolarità di un particolare ufficio (es. il
commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa; b) nell’attività
professionale (es. notaio); c) nella legge (es. art. 383 c.p.); d) in un atto di concessione
della P.A. o in atti convenzionali (es. concessionario del servizio di riscossione delle
imposte); e) nel pareggiamento rispetto ad attività svolte direttamente dalle P.A. (es.
istituti scolastici privati); f ) in un atto volontario di assunzione (es. azioni popolari in
caso di inerzia degli amministratori).
Secondo la tesi più risalente, gli atti compiuti dal soggetto privato non sono soggettivamente amministrativi e, pertanto, salvo tassative eccezioni, non sono impugnabili in sede giurisdizionale.
Tuttavia, parte della giurisprudenza amministrativa ha qualificato l’esercente una
pubblica funzione (in specie, il concessionario di un pubblico servizio) come organo indiretto della P.A., ritenendo le sue determinazioni impugnabili davanti
al g.a. ove “incidano sulle posizioni soggettive di privati che vi entrino in contatto”
(Cons. St., Sez. IV, 5 giugno 1998, n. 918; contra, Cons. St., Sez. VI, 28 ottobre 1978,
n. 1478).
In tal caso, le norme che trasferiscono (o consentono il trasferimento di) poteri
pubblici a detti soggetti (si pensi alle procedure e di evidenza cui sono tenuti i concessionari di lavori e servizi pubblici) ne sanciscono l’equiparazione alle pubbliche
amministrazioni o, meglio, la qualificazione ratione materiae come tali. Ciò costituisce
ulteriore dimostrazione dello sviluppo di una nozione elastica di P.A., che rifugge
l’idea dello status permanente e che ammette l’emersione di soggetti considerati pubbliche amministrazioni a certi soli fini ed in certi soli campi (vedi par. 3. e segg.). Di
qui la qualificazione dei relativi atti, pur se solo in questi ambiti, come provvedimenti
amministrativi, e la conseguente soggezione alla giurisdizione amministrativa ex art.
103 Cost. (così T.R.G.A. Trento, 23 giugno 2008, n. 158).
32
Compendio di Diritto Amministrativo
In questo senso depone anche l’art. 244 del codice dei contratti pubblici, che
devolve al g.a. in sede esclusiva la cognizione delle controversie relative alle procedure di evidenza volte da soggetti, pur se privati, tenuti al rispetto delle procedure di
evidenza pubblica (vedi parte IV, cap. IX, par. 8.).
CAPITOLO II
L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
SOMMARIO : 1. Introduzione al tema. – 2. La funzione amministrativa nel quadro costituzionale dei poteri pubblici. – 3. L’attività amministrativa: nozione. – 3.1. Rapporti con il potere politico: la controversa nozione di
atto politico. – 3.2. Anche gli atti di diritto privato della pubblica amministrazione rientrano nella nozione
lata di attività amministrativa. – 3.3. Classificazioni dell’attività amministrativa. – 4. I principi costituzionali
dell’attività amministrativa. – 4.1. Il principio di legalità. – 4.2. Il principio di imparzialità. – 4.3. Il principio
di buona amministrazione. – 4.4. I principi di pubblicità e di trasparenza. – 5. I principi comunitari. – 5.1.
Il principio di tutela del legittimo affidamento (o confi ance lègitime o legitimate expectation). – 5.2. Il principio
di proporzionalità.
1. Introduzione al tema
Nel capitolo precedente è stato affrontato il profilo soggettivo del diritto delle
pubbliche amministrazioni, individuando i soggetti pubblici a cui si applica questa
affascinante branca del diritto.
Verrà di seguito affrontato il profilo oggettivo, perimetrando gli atti ed i comportamenti delle pubbliche amministrazioni cui si applica tale diritto. Verranno quindi individuati la nozione di azione amministrativa ed i relativi principi fondamentali
che la presidiano. L’analisi più puntuale delle singole manifestazioni dell’azione pubblica sarà invece compiuta in altra parte di questo volume (parte IV).
Il profi lo inerente l’organizzazione che le PP.AA. si danno per svolgere al meglio
la loro funzione, ossia per perseguire in modo più efficace i propri fini istituzionali,
verrà invece affrontato nell’apposita parte III.
2. La funzione amministrativa nel quadro dei poteri pubblici
I soggetti pubblici, e segnatamente lo Stato a cui tutti gli enti pubblici si riconducono nelle scelte di fondo, sono storicamente deputati al perseguimento di determinati fini comuni a tutta la collettività che di esso fa parte, ossia fini di interesse
generale.
Nell’assetto costituzionale, la realizzazione dei fini pubblici si snoda attraverso tre
momenti fondamentali:
a) la scelta dei fini da perseguire (funzione politico-legislativa);
b) l’attuazione di detti fini, ovvero il loro concreto perseguimento (funzione amministrativa);
c) la tutela, ovvero la garanzia dell’effettiva osservanza degli interessi con la soluzione
dei conflitti al riguardo eventualmente insorti (funzione giurisdizionale).
34
Compendio di Diritto Amministrativo
La teoria della separazione dei poteri, elaborata dal Montesquieu nel suo
L’Esprit des Lois (1748), mette in rilievo l’esigenza che ad ognuna di dette funzioni attenda un determinato potere (ossia un organo od un complesso di organi) autonomo
dagli altri, in guisa che ciascuno di essi funga da limite, scongiurando il rischio di
una degenerazione tirannica di un singolo potere (cd. teoria dei contrappesi). In base a
detto principio, in definitiva, ciascuno dei tre poteri fondamentali è deputato ad una
funzione tipica predeterminata:
– il potere legislativo: è chiamato a creare la norma giuridica;
– il potere esecutivo: nel rispetto della norma ed entro i limiti da essa segnati, svolge l’attività concreta di governo, ovvero di cura concreta dell’interesse pubblico;
– il potere giurisdizionale: interpreta ed attua le norme, applicandole nei casi concreti,
ove sorga contestazione in merito al suo significato o alla sua applicazione.
Precipitato della teoria dei contrappesi è la distribuzione di funzioni sovrane
fra più organi sovrani, autonomi ed indipendenti l’uno dall’altro (superiorem
non recognoscentes). La nostra Costituzione, pur essendo basata su detto principio, non
lo applica in modo rigido. Il rischio di paralisi insito nella fissazione di linee di demarcazione troppo rigorose ha fatto sì che gli organi destinatari di ognuno dei poteri
siano chiamati, in taluni casi e per esigenze di raccordo, ad attendere a funzioni eccentriche rispetto a quelle proprie della naturale sfera di attribuzioni.
Nello specifico, accade allora che:
a) il Governo, al quale è attribuita in via principale l’attuazione, in via amministrativa
(potere esecutivo), delle scelte legislative del Parlamento (potere legislativo), esplica anche la funzione legislativa nei casi di cui agli artt. 76 e 77 Cost. (decreti legge e
leggi delegate). Inoltre, un pregnante potere di normazione è esercitato dal Governo
mediante l’emanazione di regolamenti e delle alle altre fonti secondarie (sul tema
vedi, funditus, il cap. III);
b) il Parlamento, titolare della funzione legislativa, implicante la posizione di norme
generali ed astratte, è legittimato, secondo la giurisprudenza costituzionale, all’emanazione di leggi-provvedimento, aventi contenuto individuale e concreto,
e, quindi, natura sostanzialmente provvedimentale (v. par. 3.1.);
c) il Potere giurisdizionale, chiamato a vigilare sull’osservanza delle leggi, attende
anche a compiti di carattere sostanzialmente amministrativo (cd. attività di volontaria giurisdizione) e, nel colmare lacune normative, svolge una funziona normativa,
latamente creativa del diritto.
Inoltre, accanto alle tre funzioni tradizionali, assume particolare rilievo una quarta, la funzione politica, alla quale partecipano in varia misura i principali organi
costituzionali e altri organismi locali (organi regionali, provinciali e comunali), nonché
vari gruppi e formazioni sociali interni alla comunità statale (partiti, sindacati, associazioni
professionali etc.).
3 L’attività amministrativa: nozione
Nel quadro di detta tripartizione del potere, il diritto amministrativo si occupa
della funzione amministrativa assolta dalla pubblica amministrazione. Più precisamente, esso si interessa dell’attività (o azione) amministrativa, da intendersi
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
35
come manifestazione della funzione pubblica, contenuta entro il limite positivo della
attribuzione normativa di potere, mediante la quale i soggetti all’uopo preposti provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici ad essi affidati. In base ai principi
sopra esposti, infatti, l’individuazione del fine da perseguire, la sua qualificazione
come pubblico e la sua assegnazione alla P.A. sono operate in sede di indirizzo politico, alla cui determinazione concorrono organi cui è attribuita la funzione politica
o di governo, mentre in sede giurisdizionale si accerta che la volontà legislativa
sia rispettata. L’attività amministrativa, invece, cura direttamente gli interessi
pubblici, alla cui tutela ogni ente pubblico è preposto in base alle competenze fissate
per legge (si tratta della cd. riserva di legge ex artt. artt. 95 e 97 Cost.).
Tanto detto a livello di massimi sistemi definitori, verrà di seguito individuata in
modo più puntuale la nozione di attività amministrativa, rinviando alla parte IV, cap.
III per l’analisi organica del procedimento amministrativo.
3.1. Rapporti con il potere politico: la controversa nozione di atto politico
Si può innanzitutto osservare che la nozione di attività amministrativa può essere
ricavata, in negativo, attraverso un raffronto rispetto alla cd. attività politica, ossia
l’insieme degli atti con cui “si realizza in sede di indirizzo politico la direzione suprema della cosa pubblica (l’“indirizzo politico”) e si assicura l’attività di coordinamento e di controllo delle singole manifestazioni in cui la direzione stessa si estrinseca”
(SANDULLI).
La distinzione tra i due tipi di atti ha una portata disciplinatoria non secondaria.
Ai sensi dell’art. 31 del T.U. sul Consiglio di Stato n. 1054 del 1924, infatti, non è
ammesso il ricorso al g.a. nei confronti di atti e provvedimenti emanati dal Governo
nell’esercizio del potere politico. Pertanto, distinguere tra attività amministrativa ed
attività politica significa, in realtà, distinguere tra attività sindacabile, che soggiace
quindi al controllo giurisdizionale ex art. 113 Cost., ed attività politica, non sindacabile, che sfugge al controllo del g.a., secondo quanto prevede l’art. 31 T.U. Cons. St.
Il confine che separa l’attività amministrativa sindacabile da quella politica, per definizione non sindacabile, è dato dall’esistenza o meno di un vincolo funzionale
cogente in capo alla pubblica amministrazione, che costituisce al contempo il
fine ultimo da realizzare ed il vincolo cui soggiacere, nel perseguimento dell’interesse pubblico. L’attività amministrativa non è, infatti, mai libera nei fini, in quanto
su di essa grava il vincolo rappresentato dalla necessità di perseguire il fine pubblico
stabilito dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento; al contrario, l’attività
politica è scevra da vincoli funzionali, atteso che proprio con l’atto politico si
decide il fine da perseguire. Ne consegue che l’attività politica è libera nei fini, in
quanto l’atto politico non deve perseguire fini aliunde stabiliti poiché pone fini esso
stesso. È evidente, quindi, l’insindacabilità dell’atto politico, proprio perché a fronte
di un atto libero nei fini il giudice non avrebbe il parametro per esercitare il proprio
sindacato, ontologicamente deputato alla verifica della corrispondenza dell’atto ai
fini posti dalla legge.
Gli atti politici costituiscono un numerus clausus, in quanto sono inammissibili
al di fuori delle previsioni esplicitamente od implicitamente operate dalla Costituzione.
36
Compendio di Diritto Amministrativo
Venendo alla classificazione degli atti politici, sul piano soggettivo, soggetti legittimati all’adozione
di atti politici sono, secondo la tesi prevalente, il Governo, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la
Corte costituzionale, le Regioni ed il corpo elettorale. Viene tuttavia da chiedersi se, alla luce della riforma
costituzionale del titolo V della parte II della Costituzione (vedi parte III, cap. I), non debba ritenersi che
anche i Comuni siano in taluni casi titolari di poteri politici nella scelta fondamentale degli interessi della
collettività locale da perseguire.
In base alla fonte dalla quale promanano, è poi possibile operare un raggruppamento degli atti in menzione in due grandi categorie:
a) atti di indirizzo politico-costituzionale, adottati da organi statali super partes (Presidente della Repubblica, Corte costituzionale), deputati a garantire l’osservanza della Costituzione. Si pensi agli atti con
i quali il Presidente della Repubblica indice le elezioni politiche ed i referendum od invia messaggi alle
Camere, nonché alle sentenze della Corte costituzionale;
b) atti politici di maggioranza, emanati da organismi statali (corpo elettorale, Parlamento e Governo), titolari della sovranità, e, come tali, chiamati a dare espressione giuridica alle forze di maggioranza della comunità nazionale. A titolo di mera esemplificazione, si pensi alla scelta dei propri rappresentanti da parte
del corpo elettorale, all’elezione del Presidente della Repubblica ed agli atti di iniziativa legislativa.
In riferimento al crinale oggettivo, secondo la migliore dottrina (SANDULLI), deve riconoscersi natura politica agli atti dotati di diversa forza giuridica: infatti, mentre taluni sono espressione del potere legislativo
o di quello giurisdizionale (gli atti di normazione primaria e le pronunce della Corte costituzionale sono,
infatti, atti di suprema direzione della cosa pubblica), altri non sono riconducibili a nessuno dei poteri
tradizionali e possono perciò essere qualificati come atti politici puri, nella misura in cui sono comunque
sottratti al regime giuridico degli atti amministrativi. Si può allora distinguere tra:
– atti aventi forza di legge (quali le leggi del Parlamento e delle Regioni, i decreti-legge ed i decreti legislativi);
– atti aventi forza giurisdizionale (quali le sentenze della Corte costituzionale);
– atti formalmente amministrativi privi di forza legislativa o giurisdizionale (si pensi, ad esempio, alla proposta
di nomina dei Ministri, alla nomina dei Sottosegretari, alla proposizione della questione di fiducia,
all’elezione del Presidente della Repubblica, all’adesione dello Stato italiano ad un embargo deciso dagli
organi internazionali, alla dichiarazione di pericolo pubblico o dello stato di guerra).
A detta classificazione si oppone altra parte minoritaria della dottrina, che limita la categoria degli atti
politici ai soli atti di indirizzo politico che, emanati dall’Esecutivo, non rivestano natura amministrativa (Cons. St.,
Sez. IV, 29 febbraio 1996, n. 217).
Tanto detto sulla nozione di atto politico in rapporto a quello amministrativo, si
registra una categoria attizia “ibrida”, costituita dall’attività cd. di alta amministrazione, che fotografa, secondo la più tradizionale definizione di stampo sandulliano, l’attività con la quale si pongono in essere le scelte amministrative di fondo
della P.A., caratterizzate da una discrezionalità di massima estensione (si consideri
l’atto con cui vengono nominate le supreme cariche o i vertici di stampo non politico, quale, ad esempio, il Primo Presidente della Cassazione).
Tali atti si collocano, in definitiva, in una posizione intermedia tra gli atti politici,
quali atti di indirizzo volti alla scelta dei fini da perseguire, ed i provvedimenti stricto
sensu amministrativi, diretti all’attuazione concreta delle opzioni stabilite a livello
governativo, rappresentando il primo grado di attuazione dell’indirizzo politico nel
campo amministrativo.
È possibile così addivenire ad una loro definizione in termini di atti costituenti
manifestazioni d’impulso all’adozione di atti amministrativi, funzionali all’attuazione dei fini
della legge.
Trattasi di atti che, pur se connotati da notevole discrezionalità, restano nel solco
della cura concerta dell’interesse pubblico fissato in sede politica, e non già della scelta politica degli interessi da raggiungere. Tali atti, in quanto atti amministrativi, sog-
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
37
giacciono pertanto alle ordinarie regole dell’azione amministrativa consacrate dalla
L. n. 241/1990 (sul piano tra l’altro degli obblighi procedimentali e motivazionali) e
sono suscettibili di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ex artt. 24, 103
e 113 Cost. , in ragione dei classici vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza e, soprattutto, eccesso di potere, vizio proprio degli atti discrezionali: sul tema
vedi parte II, cap. I).
In merito alla distinzione tra atto amministrativo ed atto politico, il Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2007,
n. 209 ha precisato che “gli atti politici costituiscono espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai
supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti e che essi
sono liberi nella scelta dei fini, mentre gli atti amministrativi, anche quando sono espressione di ampia discrezionalità,
sono comunque legati ai fini posti dalla legge”.
La V sezione ha altresì evidenziato che “la categoria degli atti politici è stata recentemente sottoposta a rivisitazione
a seguito delle modifi che al titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha fatto venir meno la struttura verticale
delle autonomie, con al vertice lo Stato, che era proprio della Costituzione del 1948”: ne è derivato “un sistema
istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si
coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali”.
Anche nel nuovo assetto istituzionale stabilito dalla Costituzione, tuttavia, i Giudici di Palazzo Spada ritengono che “il principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della Amministrazione pubblica (art. 113 Cost.) [continui ad avere] portata generale, coinvolgendo, in linea di principio, tutte le Amministrazioni anche di rango elevato e di
rilievo costituzionale. Per cui le deroghe a simile principio debbono essere ancorate a norme di carattere costituzionale”. In
conclusione, si osserva che, “per i loro caratteri intrinseci, non sono soggetti a controllo giurisdizionale solo un numero
estremamente ristretto di atti in cui si realizzano scelte di specifi co rilievo costituzionale e politico; atti che non sarebbe
corretto qualifi care come amministrativi e in ordine ai quali l’intervento del Giudice determinerebbe un’interferenza del
potere giudiziario nell’ambito di altri poteri”.
Applicando tali coordinate il Consiglio ha escluso la qualificazione come atto politico dell’atto con cui
il Sindaco revochi la nomina di un assessore comunale ai sensi dell’art. 46, ult. comma, T.U.
n. 267/2000. Vedi da ultimo TAR Lazio, Sez. II. 15 dicembre 2007, n. 13361, che, con riferimento
al caso Speciale, ha ribadito la sindacabilità giurisdizionale anche delle nomine alle alte cariche pubbliche
(nella specie la revoca del comandante generale della guardia di fi nanza), trattandosi di atti di alta amministrazione e non di alti politici.
Analogamente, la giurisprudenza contabile ha escluso la natura politica della deliberazione della Giunta
Regionale contenente la decisione di sottoscrivere un contratto collettivo, ascrivendovi, al contrario, natura formalmente e sostanzialmente amministrativa, con la conseguente conoscibilità, anche incidentale,
dello stesso da parte del giudice contabile ( C. conti, reg. Veneto, Sez. giurisd., 13 giugno 2008, n.
248).
La giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 854/1999) ha poi ricondotto agli atti di alta amministrazione anche
gli atti di esercizio del potere governativo di annullamento di atti amministrativi illegittimi per
motivi eccezionali collegati alla preservazione dell’ordinamento amministrativo (ora contemplato, per quel
che riguarda gli enti locali dall’art. 138 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con D.L GS. 18 agosto 2000, n. 267, per le altre amministrazioni, dall’art. 2, comma 3, lett. p),
della L. n. 400/1988, ove si riproduce la vecchia disciplina recata dall’art. 6 del R.D. n. 383 del 1934, recante il testo unico delle leggi comunali e provinciali). La tesi dell’alta amministrazione ha ricevuto avallo
dal citato art. 2, secondo comma, lett. p), della L. n. 400/1988, che prevede la sottoposizione ad apposita
delibera del Consiglio dei Ministri “delle determinazioni concernenti l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi” già sottoposti al parere del Consiglio di Stato.
Altra dottrina aveva invece parlato di “atto di autotutela” della P.A., ovvero di “atto di controllo o di alta amministrazione”.
La Consulta, con la sentenza n. 229 del 1989, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del potere
di annullamento governativo nella misura in cui si estende agli atti amministrativi delle Regioni ex lege
n. 400/1988, è venuta a qualificarlo come potere di controllo. La soluzione proposta dalla Corte risulta
basata su due considerazioni: da un lato sul rilievo che tale potere fa capo ad un soggetto diverso da quello
da cui l’atto è emanato; dall’altro, sul rilievo che oggetto di valutazione è la illegittimità dell’atto stesso.
38
Compendio di Diritto Amministrativo
I caratteri di eccentricità di detta forma di controllo rispetto ai connotati generali degli atti di controllo
si annidano, invece, nel carattere discrezionale dell’annullamento e nell’assenza di sbarramenti temporali
all’esplicazione del potere di annullamento.
Fermo quanto precede sulla nozione di atto politico e sulle conseguente perimetrazione, in negativo, di quella di atto amministrativo (e segnatamente atto di alta
amministrazione), è necessario operare alcune puntualizzazioni in ordine alla nozione di insindacabilità degli atti politici.
Ed infatti, è chiaro che la nozione di insindacabilità degli atti politici non è
assoluta, in quanto incontra taluni limiti e temperamenti.
In primo luogo, gli atti politici sono, comunque, suscettibili di sindacato
sul versante costituzionale con gli strumenti dei ricorsi principali, delle questioni
incidentali, ovvero dei confl itti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, ove
essi violino i parametri costituzionali.
Il secondo limite al postulato dell’ insindacabilità dell’attività politica è costituito dai vincoli comunitari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117,
commi 1 e 11 della Carta costituzionale, secondo cui le leggi dello Stato devono
rispettare, tra gli altri, i vincoli discendenti dall’ordinamento comunitario. Pertanto,
il principio di primazia del diritto comunitario vincola non solo l’attività amministrativa, ma anche quella legislativa al rispetto dei vincoli comunitari. Questo secondo vincolo rende l’atto politico non più libero nei fini qualora gli stessi siano prefissati
a livello comunitario.
Un ulteriore limite si può individuare nel fenomeno della cd. legge provvedimento, con cui Stato o
Regioni, onde rendere insindacabili ammantandoli di veste politica i propri provvedimenti, legificano in
determinate discipline, dando forma di legge ad un atto amministrativo. A fronte di atti che partecipano di
una doppia veste (formalmente legislativa e sostanzialmente amministrativa), occorre valutare quale natura
abbiano detti atti ai fi ni dell’inserimento nel genus degli atti politici o degli atti amministrativi e del conseguente sindacato. La migliore dottrina e giurisprudenza reputa che, in questi casi, se la fattispecie normativa
complessa resta insindacabile da parte del giudice amministrativo, rimane, invece, sindacabile l’iter che ha
condotto alla adozione dell’atto, in quanto avente natura amministrativa. La legge può, quindi, approvare il
provvedimento, ma non può sottrarre quel medesimo atto al sindacato giurisdizionale; esso viene, pertanto, approvato nell’assunto che sia legittimo e nella misura in cui spiega efficacia come provvedimento. Ne
consegue, pertanto, che l’approvazione della legge non comporta l’improcedibilità nei ricorsi già pendenti
avverso quel provvedimento successivamente legificato; viceversa, nel caso in cui il giudice annulli il provvedimento, l’annullamento travolge la legge in quanto atto di recepimento del provvedimento annullato.
Occorre, quindi, distinguere il caso in cui la legge, in modo del tutto autonomo, con procedimento integralmente legislativo, sostituisca il provvedimento – caso in cui è ammissibile solo il sindacato della Corte
costituzionale e in particolare in relazione al parametro di ragionevolezza ex art. 3 Cost. – , dall’ipotesi in
cui il provvedimento esista e venga successivamente approvato con la legge, in cui cioè il procedimento ab
imis è amministrativo. In tale ultimo caso, in defi nitiva, si realizza una fattispecie complessa di adozione di
un atto amministrativo all’esito di un procedimento amministrativo successivamente coperto dalla legge,
con la conseguenza che tale “copertura” non può precludere il ricorso giurisdizionale proposto o ancora
proponibile nei confronti di quel provvedimento.
Da ultimo Corte cost., con sentenza 18 luglio 2008, n. 288, ha rimarcato che una legge-provvedimento, che incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto,
soggiace ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale, essenzialmente sotto i profi li della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore regionale.
Resta infine fermo, rispetto agli atti politici, il sistema di controlli e di sanzioni
di carattere politico, di competenza del corpo elettorale e del Parlamento, i quali
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
39
possono, ad esempio, non riconfermare gli organi che si siano resi responsabili di una
attività ritenuta meritevole di censura, ovvero (con riferimento alle Camere) esprimersi con un voto di sfiducia.
3.2. Anche gli atti di diritto privato della pubblica amministrazione rientrano nella
nozione lata di attività amministrativa
Venendo all’esame in positivo della nozione di attività amministrativa, va rilevato
che il concetto di attività amministrativa ha subito una profonda evoluzione nel
corso del tempo, che ha visto esaltata la dimensione paritaria dell’agire amministrativo. Nella nuova concezione di attività di cura dell’interesse pubblico, la P.A. può
avvalersi non solo degli strumenti giuridici propri del diritto pubblico, ma
anche dei mezzi e delle forme comuni del diritto privato. Se, infatti, in passato, si riteneva che questi ultimi fossero intrinsecamente inidonei al conseguimento di
finalità pubblicistiche, in modo da essere relegati a casi eccezionali e tipizzati, ora si
è definitivamente riconosciuto che la P.A. può perseguire l’interesse pubblico anche
attraverso lo strumento negoziale privatistico, agendo su un piano di parità rispetto
al privato cittadino e non in veste di organo titolare di poteri autoritativi. Si tratta,
quindi, di attività amministrativa che si esplica secondo moduli ed in ossequio a regole di diritto privato.
Il riconoscimento generale dell’autonomia negoziale della P.A. e, dunque, il superamento del tradizionale concetto del modulo autoritativo-procedimentale quale
strumento esclusivo di realizzazione dell’interesse pubblico, ha trovato un avallo
normativo ad opera della L. 11 febbraio 2005, n. 15, in specie nel testo del nuovo
art. 1 della L. n. 241/1990 (v. amplius, parte IV, cap. IX). La norma in esame, dunque, riconosce alla P.A. la facoltà di curare l’interesse pubblico instaurando rapporti
di carattere privatistico con i soggetti interessati, in alternativa all’utilizzo dello
strumento del provvedimento unilaterale, decretando, implicitamente, la soggezione della P.A. alle norme civilistiche e riconoscendo alla stessa, altrettanto implicitamente, capacità negoziale (nello stesso senso il chiaro disposto dell’ art. 2,
comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.L GS. n. 163/2006,
che sancisce l’applicazione delle norme di diritto civile ai contratti della pubblica
amministrazione).
Del pari, la generalizzazione del modulo degli accordi ex art. 11 della L. n. 241/1990
(sulla natura privatistica o pubblicistica dei quali si veda peraltro parte IV, cap. VIII),
può ritenersi che la preferenza per il modulo consensuale espressa dal legislatore
nell’art. 1 (e la conseguente soggezione del rapporto negoziale che ne origina alle
norme di diritto privato) informi di sé anche tale istituto.
Ancora, la gestione del rapporto di impiego privatizzato viene scandita da atti
con i quali la P.A. non esplica più una puissance pubblicistica, ma un’autonomia organizzativa privatistica propria del datore di lavoro privato (ex art. 5, comma 2, D.LGS.
n. 165/2001). I relativi atti hanno quindi natura privatistica, a fronte della quale viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo o, se si vuole, di interesse legittimo
di diritto privato (vedi parte III, cap. III).
Da quanto detto, si ricava quindi che aumentano gli ambiti nei quali l’amministrazione persegue l’interesse pubblico con l’esercizio della sua capacità di diritto privato;
40
Compendio di Diritto Amministrativo
d’altro canto, anche l’attività privatistica della P.A., in quanto vincolata al
perseguimento dell’interesse pubblico, è sempre connotata dallo stesso limite teleologico che connota l’attività provvedimentale. La natura privatistica
dell’atto nulla sposta, infatti, in ordine alla natura pubblica del soggetto che lo pone
in essere ed alla conseguente tensione funzionale del suo agire all’interesse pubblico.
Gli atti emanati da tali soggetti, pertanto, non sono mai liberi, come i corrispondenti
atti privati, ma sempre ubbidienti al limite funzionale della rispondenza all’interesse
pubblico, nonché ai principi costituzionali dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
(vedi par. 4. e segg ).
In tale ottica è da leggersi, a titolo esemplificativo, la necessità di una procedura di
evidenza pubblica prima della stipula del contratto, che dia conto delle ragioni di interesse pubblico che con esso si vogliono perseguire; la soggezione anche dell’attività
privatistica della P.A. (contratti ed atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico ora
privatizzato), intesa come attività amministrativa di cura concreta dell’interesse pubblico, alle regole in tema di accesso ai documenti amministrativi, come riscritte dalla
L. n. 15/2005 (vedi parte IV cap. I); e, ancora, la soggezione degli atti di gestione del
rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego (cfr. parte III, cap. III), ad un principio di funzionalità amministrativa
che ha riflessi importanti in punto di disciplina (si pensi alle regole procedimentali ed
all’onere motivazionale); nonché, infine, la vocazione del sindacato giurisdizionale
alla verifica del rispetto del limite funzionale.
Gli atti privati adottati dalla P.A., quindi, partecipano di una doppia natura, nel senso che assumono natura giuridica privatistica ma funzione pubblicistica,
e sono quindi atti inquadrabili nella nozione lata di attività amministrativa,
ossia di cura concreta dell’interesse pubblico.
3.3. Classificazioni dell’attività amministrativa
L’attività amministrativa può essere oggetto di numerose classificazioni.
La distinzione tra attività di amministrazione attiva, consultiva e di controllo è sorta, come criterio organizzatorio, per distinguere le singole attribuzioni e ripartirle tra gli
uffici, evitando il loro accentramento nella competenza di un unico ufficio.
La distinzione è stata poi trasferita sul piano giuridico, e viene oggi correntemente
adoperata dalla dottrina a fini sistematici; si noti, comunque, che dalla distinzione in
parola non deriva alcuna diversità di qualifiche giuridiche, in quanto l’amministrazione
costituisce un fenomeno unitario.
In particolare, la dottrina distingue i tre tipi di attività amministrativa:
a) amministrazione attiva: comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per
realizzare i propri fini. Vi rientrano sia le attività deliberative che esecutive;
b) amministrazione consultiva: comprende le attività dirette a fornire - sotto
forma di pareri-consigli, direttive, orientamenti e chiarimenti alle autorità che
devono provvedere su un determinato oggetto;
c) amministrazione di controllo: comprende le attività dirette a sindacare secondo diritto (controllo di legittimità) o secondo le regole della buona amministrazione
(controllo di merito) l’operato degli agenti a cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva.
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
41
Le attività di consulenza e di controllo mirano ad assicurare che l’attività deputata in via diretta alla cura
degli interessi pubblici (ossia l’amministrazione cd. attiva) si svolga nel rispetto della legalità e del buon
andamento e, quindi, che sia legittima ed opportuna.
Alcuni parlano di “attività neutra” con riferimento a determinate attività (notificazioni, registrazioni, etc.),
rinvenibili anche nel campo legislativo e giurisdizionale.
Ulteriori classificazioni, pur risultando essenzialmente descrittive, in quanto ad esse
non corrisponde una tipologia di atti assoggettati ad un particolare regime giuridico,
appaiono opportune per evidenziare taluni peculiari aspetti dell’attività della P.A.
In tale ambito rileva la distinzione tra attività sostanziale ed attività organizzativa: la prima precipuamente volta alla cura esterna degli interessi affidati alla P.A.
(parte. IV), la seconda inerente alla creazione delle strutture e degli organismi che
tali interessi sono chiamati a soddisfare (parte III).
Viene poi utilizzata la distinzione, anche questa meramente descrittiva, tra attività giuridica ed attività materiale: la prima si sostanzia in atti e negozi giuridici
(di diritto pubblico o privato), ossia manifestazioni di volontà, valutazioni o dichiarazioni di scienza basate su un processo di apprendimento e di rappresentazione della
realtà (ad es. pareri, certificazioni, ordini), la seconda in semplici attività materiali,
svolte in esecuzione di atti amministrativi o nell’adempimento di doveri cui l’amministrazione sia tenuta senza necessità di una previa specifica deliberazione, ovvero in
attività materiali svolte nell’esercizio di un pubblico servizio (ad es. le notificazioni
e le pubblicazioni).
In particolare, i comportamenti diversi dagli atti vanno distinti in comportamenti meri, che in nulla si distinguono da quelli posti in essere da soggetti privati, e
comportamenti amministrativi, posti in essere nell’ambito o in connessione con
un rapporto di diritto pubblico, quale quello che è inaugurato dall’avvio del procedimento amministrativo o dall’emanazione di un provvedimento amministrativo. I
comportamenti amministrativi costituiscono quindi, a differenza dei comportamenti
meri, esercizio, diretto o mediato, del potere amministrativo e come, tali, sono sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ordinaria o esclusiva, in base ai
criteri che saranno esposti nella parte VIII, cap. III.
4. I principi costituzionali dell’attività amministrativa
Esaminata la nozione di attività amministrativa si può passare all’esame dei principi generali che la governano, principiando da quelli costituzionali.
Dall’art. 97 della Costituzione che, al comma 1 sancisce “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, si evincono due principi fondamentali dell’azione amministrativa: quello di buona amministrazione e quello di imparzialità.
La disposizione, sebbene faccia riferimento specificamente alla organizzazione,
enuncia principi ritenuti pacificamente applicabili anche all’attività amministrativa
dei soggetti pubblici.
Un altro principio essenziale, che risulta implicito nelle numerose riserve di legge
contenute nella Costituzione, è quello di legalità.
Tali sono ripresi e sviluppati dall’art. 1 della L. n. 241/1990.
42
Compendio di Diritto Amministrativo
4.1. Il principio di legalità
Tale principio, come sopra si è detto, pur non essendo esplicitato nella nostra
Carta Fondamentale, si desume da un’interpretazione sistematica delle disposizioni
costituzionali e, come è stato efficacemente osservato in dottrina, può essere inteso
in modi diversi.
Il principio di legalità costituisce un principio generale del nostro ordinamento giuridico inerente i rapporti tra legge ed attività amministrativa, e quindi tra potere politico che fissa i fini e potere amministrativo che li
persegue (vedi par. 3.1.). Esso, evincibile dall’intelaiatura costituzionale, pur se non
formalmente enunciato in modo espresso, impone la corrispondenza dell’attività
amministrativa alle prescrizioni di legge, sebbene nella sua accezione più ampia il
principio viene applicato non solo alla pubblica amministrazione, bensì a qualsiasi
potere pubblico.
Il principio di legalità è richiamato dall’art. 1, L. n. 241/1990, il quale stabilisce
che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo le modalità fissate
dalla stessa legge, nonché in base ai principi individuati dall’ordinamento comunitario.
Il principio in esame può essere inteso sotto tre differenti accezioni: in senso debolissimo, è conforme a legge ogni atto che non sia con essa in contrasto; in senso debole,
è conforme alla legge ogni atto che sia fondato sulla legge medesima, (cd. legalità
formale); in senso forte, è conforme alla legge ogni atto la cui forma e il cui contenuto
siano predeterminati dalla legge (cd. legalità sostanziale).
In particolare, la legalità formale impone all’amministrazione non solo il divieto di contraddire la legge, ma anche il dovere di agire nelle ipotesi e nei limiti fissati
dalla medesima legge attributiva del potere. A contrario, nell’accezione di legalità
sostanziale, il principio di legalità assume una connotazione ancor più vincolante
per l’azione amministrativa, giacché, esso impone che gli atti della pubblica amministrazione, oltre a rispettare i limiti formali fissati dalla legge, siano adottati in
conformità alla disciplina sostanziale dettata dalla stessa, la quale incide anche sulle
modalità di esercizio dell’azione e, dunque, penetra all’interno dell’esercizio del
potere.
Il principio di legalità deve, quindi, anche essere inteso come parametro di valutazione e come vincolo di scopo per la Pubblica Amministrazione. Va, infatti,
considerato che i parametri ai quali l’attività amministrativa deve fare riferimento
sono più ampi della sola legge in senso formale, sicché si parla non solo di legalità
ma altresì di legittimità, nel senso della conformità del provvedimento e dell’azione
amministrativa a parametri anche diversi dalla legge, ancorché alla stessa pur sempre
collegati (norme regolamentari, statutarie e così via).
La dottrina ha ricercato un fondamento positivo al principio di legalità, ritenendolo talvolta implicito nelle numerose riserve di legge disseminate nella Costituzione (artt. 13 e segg., in particolare l’art. 23): più specificatamente, tale principio
si ricaverebbe dall’dall’art. 97 Cost., il quale, stabilendo che l’organizzazione dei
pubblici uffici segue le disposizioni di legge, porrebbe la legge su una posizione di
supremazia rispetto all’attività di tali uffici. In questo modo, però, il fondamento di
tale principio sarebbe ristretto ai soli settori coperti da riserva di legge e non avrebbe
portata generale.
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
43
Secondo altri autori il principio si ricaverebbe dagli artt. 24 e 113 Cost., che
sanciscono il controllo del giudice sull’attività della P.A. e, per implicito, la sua non
esercitabilità in contrasto con la legge.
Il principio in esame, ricondotto nell’ambito della separazione dei poteri, sottopone
l’azione della P.A., oltre che alla Costituzione, anche alle leggi, che, in un sistema di tipo
parlamentare, costituiscono l’espressione più rappresentativa della volontà del popolo.
In definitiva, in forza del principio di legalità, la P.A., al di fuori dei casi stabiliti
dalla legge, non può godere di nessuna posizione di potere, privilegio o di favore. Il
principio in parola, inoltre, costituisce una garanzia a che le norme riguardanti l’organizzazione amministrativa, le funzioni degli impiegati ecc., siano previste in via
generale dalla legge e non dal potere amministrativo.
Conseguenze di questo principio sono:
– la tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi (non sono cioè
ammessi provvedimenti atipici o innominati);
– l’eccezionalità dell’esecutorietà degli atti stessi, ossia dei casi in cui gli atti possono essere coattivamente mandati in esecuzione in sede di autotutela della P.A.;
– l’eccezionalità degli atti amministrativi destinati a formare certezza legale privilegiata.
È importante sottolineare che il principio in questione impone un particolare obbligo, in capo all’amministrazione, nel caso di provvedimenti destinati ad avere efficacia perdurante nel tempo: in tale ipotesi,
invero, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gravi in capo alla P.A. che ha emanato l’atto l’obbligo di verificare in ogni momento il suo adeguamento al quadro normativo di riferimento, mediante la rimozione o la
modifica dello stesso in sede di autotutela (Cons. St., Sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 106).
Va da ultimo segnalato che una dequotazione della cogenza del principio
di legalità deriva dalla nuova disciplina dei vizi non invalidanti dettata
dall’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, secondo cui “non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato”. In base al tenore letterale della norma, la
cui natura giuridica (processuale o sostanziale) è discussa, si ricava come il mancato
rispetto di alcune regole dell’agire amministrativo, ove non influente sul risultato
sostanziale dell’azione amministrativa, sia irrilevante sotto il profilo della annullabilità del provvedimento amministrativo, così fortemente dequotandosi il principio di
legalità formale (sul tema vedi, funditus, parte IV cap. V, par. 4.3.).
4.2. Il principio di imparzialità
Il principio di imparzialità amministrativa è codificato dall’art. 97, comma 1, della
Costituzione, secondo cui “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la norma sopra citata,
sebbene appaia riferita ai soli pubblici uffici, codifichi in realtà un canone generale
44
Compendio di Diritto Amministrativo
dell’azione amministrativa, che investe tanto l’organizzazione quanto l’attività della Pubblica Amministrazione.
In base a detto principio l’amministrazione ha il dovere, pur nel perseguimento
dell’interesse pubblico, di non discriminare i soggetti privati coinvolti, garantendo
trattamenti simili in situazioni simili e trattamenti differenziati in situazioni differenti. In questo senso, il principio di imparzialità trasfonde, nell’ambito dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3
della Costituzione.
Oltre a questa accezione meramente negativa, il principio di cui si discute ha una
valenza positiva, in quanto postula, da parte della P.A., un comportamento attivo,
volto alla ponderazione e alla valutazione di tutti gli interessi in gioco, di modo che
il risultato finale si mostri coerente e consapevole di una completa rappresentazione
dei fatti e degli interessi coinvolti.
In questa prospettiva, non si può che rilevare che la sede principale di esplicazione del principio di imparzialità è costituita dal procedimento amministrativo, ed in
particolar modo dalla fase dell’istruttoria, nell’ambito della quale l’amministrazione
procede alla ponderazione di tutti gli interessi veicolati nello stesso.
Al fine di comprendere il senso ed i limiti del principio di imparzialità, occorre
partire dal presupposto che le amministrazioni classiche sono, per loro natura, parziali, essendo la loro attività finalizzata al perseguimento degli interessi pubblici che
la legge, di volta in volta, stabilisce.
Il principio di imparzialità non impone, dunque, all’amministrazione di porre sullo stesso piano l’interesse pubblico e gli altri interessi coinvolti nell’azione amministrativa; più limitatamente, impone all’amministrazione, sempre nel perseguimento
dell’interesse pubblico primario, di ponderare tutti gli interessi pubblici e privati contrapposti, evitando sacrifici non necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In questo è possibile individuare la differenza tra principio di imparzialità, proprio
delle amministrazioni classiche, e principio di neutralità, informatore delle autorità amministrative indipendenti (parte VII, cap. I).
In virtù di quest’ultimo principio, le autorità amministrative indipendenti assumono una posizione di terzietà, agendo con equidistanza rispetto a qualsiasi interesse
pubblico o privato coinvolto, senza perseguire interesse alcuno che non sia quello al
mero rispetto della legge.
Numerosi sono i precipitati del principio di imparzialità amministrativa, rinvenibili in molte norme,
costituzionali ed ordinarie:
– l’art. 97, ultimo comma, Cost. stabilisce che, salvi i casi stabiliti dalla legge, ai pubblici impieghi si accede mediante concorso;
– l’art. 98 Cost. prevede che i pubblici impiegati sono ad esclusivo servizio della Nazione e consente la
possibilità, per talune categorie di impiegati pubblici, di limitare il diritto di iscriversi ai partiti;
– l’obbligo di astensione del funzionario pubblico che debba decidere su questioni nelle quali abbia interesse, ed il corrispondente diritto, per i cittadini, di ricusare il funzionario in dette situazioni;
– l’art. 2597 c.c., che con particolare riguardo all’impresa che esercita in regime di monopolio legale,
sottolinea la necessità di erogare i servizi pubblici in favore di tutti coloro che ne hanno titolo, senza
operare discriminazioni tra gli utenti;
– il D.L GS. n. 163/2006 (cd. codice dei contratti pubblici) in tema di obbligo di indire procedure di gara
aperte, trasparenti non discriminatorie, prima della stipula di contratti pubblici ai fi ni della selezione del
migliore interlocutore privato;
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
45
– il principio della necessaria predeterminazione dei criteri e delle modalità alle quali la P.A. deve attenersi
nelle scelte successive (cd. autolimite o autovincolo), consacrato, per quanto attiene ai provvedimenti
attributivi di vantaggi economici, dall’art. 12, L. n. 241/1990;
– i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, i quali, rendendo possibile un controllo
della stessa, garantiscono l’attuazione del principio di imparzialità.
4.3. Il principio di buona amministrazione
Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, codificato dall’art. 97,
comma 1, della Costituzione (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”),
impone l’obbligo, per la pubblica amministrazione, di agire sempre nel
modo più adeguato e conveniente per il fine pubblico che si deve perseguire.
Detto principio, nonostante il tenore letterale del comma citato, non va riferito
solo all’organizzazione dei pubblici uffici, in quanto informa l’attività amministrativa
ad ampio raggio, investendo l’intero funzionamento della Pubblica Amministrazione
(Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 22).
Il principio di buon andamento, così come sopra definito ed esplicitato dall’art. 1,
L. n. 241/1990, lungi dall’essere unitario e di semplice applicazione, risulta il frutto
della compenetrazione di diversi criteri, tutti di uguale peso ed importanza, che
l’amministrazione è tenuta a rispettare e contemperare tra loro.
Detti criteri sono:
– efficienza, ovverosia il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un
dato fine ed il risultato ottenuto;
– efficacia, ovverosia il rapporto tra gli obiettivi prefissati e gli obiettivi raggiunti;
– economicità, ovverosia l’ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione;
– celerità (di qui il divieto di aggravio non necessario del procedimento ex art. 1,
comma 2, L. n. 241/1990);
– miglior contemperamento degli interessi;
– minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa.
Tali criteri da un lato non sono totalmente sovrapponibili tra loro (una P.A. con
pochi mezzi potrà essere efficiente, ma difficilmente sarà efficace, mentre una P.A.
efficace molto spesso lavorerà in diseconomia), dall’altro talvolta sono difficilmente
contemperabili.
A seconda del peso assegnato ai singoli criteri, si ricavano modelli di amministrazione totalmente differenti. In particolar modo, il sempre maggior rilievo assunto dal
principio di efficacia nell’ambito del più generale principio di buon andamento, ha
segnato il passaggio da sistemi basati sulla produzione a sistemi basati sulle competenze (cd. knowledge management), ossia da un modello di amministrazione intrappolata
da ridondanti cicli produttivi ad un modello di amministrazione votata al risultato
(cd. performance oriented).
Si è sostenuto in dottrina (NIGRO) che il principio di buon andamento dell’azione amministrativa funga da contrappeso alla discrezionalità
dell’amministrazione, orientando la stessa al perseguimento, col mezzo più idoneo, del fine pubblico.
46
Compendio di Diritto Amministrativo
Precipitato di questo assunto è stata la riconduzione del canone della buona amministrazione sotto il profi lo del sindacato di merito, con la conseguente impossibilità
di far valere la violazione dello stesso in sede di giudizio di legittimità.
Con la L. n. 241/1990 si sono, invece, aperte nuove frontiere per il giudizio in ordine al rispetto di tali canoni: i criteri di economicità e trasparenza,
prima considerati alla stregua di mere regole metagiuridiche, sono ora stati affermati
nell’art. 1 della legge stessa quali principi generali dell’attività amministrativa. La violazione dei principi di economicità ed efficacia può dunque, alla stregua di una vera
e propria violazione di legge, essere ora azionata anche in sede di legittimità davanti
al giudice amministrativo.
Il principio di buon andamento, così come descritto ed articolato, presenta, invero, non pochi punti di
tensione con altri principi fondamentali dell’azione amministrativa.
L’aspetto più problematico, probabilmente, è il contemperamento tra il principio di cui si discute ed il
principio di imparzialità, ad esso giustapposto nello stesso comma 1 dell’art. 97 Cost.: il principio di
imparzialità, comportando il necessario raffronto tra le diverse posizioni dei soggetti coinvolti, spesso rallenta notevolmente la macchina burocratica, intralciandone di frequente la rapidità e l’efficienza. Gli stessi
principi di pubblicità e trasparenza, quale precipitati del principio di imparzialità, comportano spesso un
notevole aggravio del procedimento, in spregio delle esigenze di prontezza e celerità dell’attività amministrativa. Considerata la matrice costituzionale di entrambi i principi suindicati, possiamo però affermare
che nessuno dei due può considerarsi totalmente cedevole. Spetterà dunque all’interprete, nei casi in cui la
disciplina non sia direttamente dettata dalla legge (cosa che invece accade nel caso del diritto di accesso),
operare le valutazioni del caso e stabilire quale dei due principi è da ritenersi preponderante.
Difficile appare inoltre la conciliazione del canone del buon andamento con il principio di legalità dell’azione
amministrativa: il rispetto delle forme tipico di quest’ultimo principio, invero, male si addice ad un modello
di amministrazione improntato al solo raggiungimento del risultato, in ossequio ai principi di efficacia ed
economicità (il quale ultimo risulta spesso sacrificato dagli innumerevoli aggravi del procedimento legislativamente previsti). Nella direzione di una tendenziale prevalenza dei principi di efficacia ed economicità sul
principio di legalità formale si è da ultimo orientato il legislatore del 2005 ( L. n. 15/2005), con l’inserimento
dell’art. 21 octies, comma 2, nella L. n. 241/1990 in tema di vizi non invalidanti (vedi il par. precedente).
4.4. I principi di pubblicità e di trasparenza
Il nuovo art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990, come riscritto dalla L. 11 febbraio
2005 n. 15, enuncia i principi guida dell’azione amministrativa, da un lato rinviando
ai principi generali che regolano e presiedono all’attività della P.A., quali il principio di legalità, buon andamento della P.A. e di imparzialità, dall’altro introducendo
espressamente il principio di trasparenza, come regola di condotta della pubblica
amministrazione. La pubblicità incarna il criterio che, in sommo grado, soddisfa
l’esigenza di un controllo democratico (rectius: di una “visibilità”) da parte dei cittadini sull’attività della P.A., cui è imposto di pubblicare, comunicare o rendere accessibili notizie, documenti, atti e procedure. Il criterio di pubblicità costituisce senza
dubbio una delle innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla L. n. 241/1990 e
si concretizza sostanzialmente nel dovere dell’Amministrazione di rendere visibile e
controllabile all’esterno il proprio operato.
Nel tentativo di razionalizzazione dei principi posti a fondamento dell’agere amministrativo, la L. 11 febbraio 2005, n. 15, ha individuato un ulteriore criterio, quello
della “trasparenza”, nella stesura precedente della L. n. 241/1990 non espressamente
menzionato tra i principi generali dell’attività amministrativa. Si attribuisce a tale
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
47
termine il significato di “conoscibilità esterna” dell’azione amministrativa, assegnando ad esso valore di principio cui ricondurre gli strumenti pratici per l’esercizio del
controllo e per l’accesso da parte dei privati agli atti e ai documenti del procedimento
amministrativo.
Le applicazioni dei canoni di pubblicità e trasparenza sono assai numerose.
Innanzitutto, esse presidiano l’obbligo di motivazione (parte IV, cap. IV par.
7.), l’accesso ai documenti amministrativi (per il quale si rinvia alla parte IV,
cap. I), nonché l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e la
seguente partecipazione del privato al procedimento stesso (parte IV, cap. III,
parr. 3. e segg.). Ed invero, le finalità delle garanzie procedimentali imposte dalla
L. n. 241/1990, e segnatamente della comunicazione dell’avvio del procedimento,
vanno individuate nell’esigenza di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa
al momento stesso del suo esercizio, e di garantire al contempo, per il tramite del
principio del contraddittorio, la partecipazione del destinatario dell’atto finale alla
fase istruttoria preordinata alla sua adozione (TAR Toscana Firenze, Sez. I, 28
gennaio 2008, n. 62).
Pubblicità e trasparenza, poi, presidiano in maniera particolarmente pregnante l’intero settore dei contratti
pubblici, e particolarmente degli appalti, in cui il procedimento ad evidenza pubblica, imposto dal diritto
comunitario e nazionale a garanzia delle pari possibilità di accesso al mercato e di regolamentazione del
regime concorrenziale, postula la assoluta conoscibilità ed intellegibilità della legalità delle procedure. Nel
settore che ci occupa, pertanto, i principi di pubblicità e trasparenza devono considerarsi prevalenti rispetto
a quello della conservazione degli effetti giuridici e della tutela dell’affidamento del terzo circa la regolarità
delle operazioni di gara. Questi, invero, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza, “non possono
evidentemente valere a sacrifi care il rispetto di fondamentali adempimenti di natura formale, quale quelli concernenti
l’idonea comunicazione, a tutti i concorrenti, delle notizie circa il tempo ed il luogo dello svolgimento delle sedute di gara,
destinate ad essere pubbliche” (TAR Campania Napoli, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 448).
Nell’ambito di svolgimento di quest’ultima, poi, particolare rilievo assume la seduta della Commissione
di gara fi ssata per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti alla gara, onde
consentire ai concorrenti l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura
dei plichi pervenuti alla stazione appaltante. Ne consegue che, anche in assenza di specifiche previsioni
della lex specialis, la violazione del principio di pubblicità indotta dalla mancata tardiva comunicazione ad
uno o più concorrenti della data di svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche “costituisce vizio insanabile della procedura, il quale si ripercuote sul provvedimento fi nale
di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti”
(TAR Basilicata Potenza, Sez. I, 28 marzo 2008, n. 72). Tale principio è da considerarsi, in mancanza
di una opposta previsione espressa, inderogabile per ogni tipo di gara, anche nei settori speciali (da ultimo
TAR Lazio Roma, Sez. III, 5 febbraio 2008, n. 951; TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 21
maggio 2008, n. 1978). L’unica possibilità di deroga, risiederebbe solo nell’ipotesi in cui la Commissione
debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte in ragione del particolare tipo di gara
(TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2008, n. 1373).
L’ineludibile principio di pubblicità e trasparenza, poi, presidia lo svolgimento
delle procedure concorsuali, ove è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio “se non attraverso
diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrano a integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Il rispetto dei principi suddetti
impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia
consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, particolare si-
48
Compendio di Diritto Amministrativo
gnificato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione” (Cons.
St., Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128).
Da ultimo, appare opportuno fare un breve cenno all’obbligo giuridico di provvedere con provvedimento espresso ex art. 2, L. n. 241/1990, per il quale la democratizzazione e la trasparenza nell’esercizio dell’attività pubblica assume tinte particolarmente forti, onde garantire al privato risposte certe da parte
dell’apparato pubblico. Rinviando al capitolo 3 della parte IV per la trattazione esaustiva dell’istituto, ci si
limita in questa sede a sottolineare che la giurisprudenza è assai divisa sull’individuazione del principio generale che presidia tale obbligo. Esso, secondo una recentissima pronuncia ricognitiva del TAR Campania
Salerno (Sez. II, 10 aprile 2008, n. 547), “può originare dal rispetto del principio di imparzialità, quando, ad
esempio, si chieda il riesame di un atto inoppugnabile (situazione che ordinariamente non determina l’esistenza di un
obbligo di provvedere), nel caso in cui, in ragione di un mutato orientamento dell’amministrazione, sia stata modifi cata
in melius la posizione di altri soggetti che si trovino in situazioni analoghe (cfr. Cons. St., IV, 14-11-1986 n.730).
Può trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa, nel caso in cui l’amministrazione,
con il suo comportamento, abbia ingenerato un qualche affidamento in capo al privato, sia che il procedimento amministrativo non sia stato ancora avviato, sia che lo stesso abbia avuto inizio a seguito della istanza dell’interessato (cfr.
TAR Abruzzo, 16 luglio 1990 n. 360). Una ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata
nel principio di legalità dell’azione amministrativa. In conclusione, può affermarsi che oggi, a prescindere dall’esistenza
di una specifi ca disposizione normativa impositiva dell’obbligo, la giurisprudenza ritiene il medesimo sussistente in tutte
quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (cfr.
Cons. St., V, 15 marzo 1991 n. 250); quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni
delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima” (negli stessi termini TAR Campania Salerno,
Sez. II, 31 gennaio 2008, n. 103 e 6 febbraio 2008, n. 164).
5. I principi comunitari
La L. n. 15/2005, recante “Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n.
241, concernente norme generali sull’azione amministrativa”, ha inserito alla fine del
primo comma dell’art. 1 il riferimento ai principi generali dell’ordinamento comunitario quale principio generale che deve regolare l’azione delle pubbliche amministrazioni.
La Corte di giustizia così suddivide i principi generali dell’ordinamento comunitario, che possono così suddividersi:
a) principi a carattere generale, che risultano sul piano comunitario l’equivalente
dei principi costituzionali fondamentali delle esperienze nazionali ed hanno un
valore normativo, rappresentando la base di altre disposizioni. Esempi di principi
generali di tale tipo sono il principio di legalità, il diritto alla tutela giurisdizionale, il principio di non discriminazione, il principio di eguaglianza, il principio di certezza del diritto. All’interno di tale categoria si può poi distinguere tra
principi effettivamente comuni agli Stati membri, che manifestano la medesima
utilità “costituzionale” anche nell’ordinamento comunitario, e principi elaborati
con specifico riferimento alle esigenze comunitarie, come il principio di leale cooperazione, il principio dell’effetto utile, il principio di equilibrio istituzionale;
b) principi di carattere più definito che presiedono ad uno specifico settore,
usualmente definiti come “principi generali amministrativi”. Ne sono esempi:
il diritto al contraddittorio, il principio di legittimo affidamento, il principio di
proporzionalità, il principio di non retroattività degli atti amministrativi. Solo
alcuni di essi sono comuni agli Stati membri, mentre altri (come la tutela dell’affi-
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
49
damento) derivano da particolari esperienze di alcuni Paesi, che la Corte ha inteso
generalizzare nell’ordinamento comunitario nel suo insieme, in quanto ritenuti
funzionali allo sviluppo della Comunità e, da ultimo, dell’Unione.
L’espressione – scaturita dalle modifiche introdotte dalla L. 15/2005 – del nuovo
art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990, secondo cui l’azione amministrativa è retta
“dai principi dell’ordinamento comunitario” viene evocata senza distinguere se si tratti
di procedimenti regolati dal diritto comunitario o meno. La scelta operata
dal legislatore, anche per la trasversalità delle norme comunitarie, è, dunque, quella
di assoggettare ai principi in questione l’intera gamma delle azioni della pubblica
amministrazione indipendentemente dal fatto che nel singolo procedimento vi sia o
meno applicazione del diritto comunitario.
Tra i principi generali dell’ordinamento comunitario, quelli che hanno la più diretta e significativa incidenza nell’attività della pubblica amministrazione, rilevando
per il loro tasso di innovatività, sono i principi della proporzionalità e del legittimo
affidamento. Sono principi che assumono, nella struttura del procedimento amministrativo e, dunque, nella composizione genetica dell’atto amministrativo, un ruolo
fondamentale e al tempo stesso innovativo, che consente una maggiore tutelabilità
degli interessi del privato.
5.1. Il principio di tutela del legittimo affidamento (o confiance lègitime o legitimate expectation).
La tutela dell’affidamento legittimo è l’incarnazione di un principio non scritto.
Se si eccettua infatti l’ordinamento tedesco, che si occupa ex professo del vertrauensschutz, il nostro ordinamento, le fonti comunitarie ed i sistemi europei coniano il legittimo affidamento, ovvero la legitimate expectation o ancora la confiance lègitime (figlia o
parente della securitè juridique) alla stregua di categoria naturale del diritto non scritto.
Nonostante l’assordante silenzio della legislazione, la Corte di giustizia a tal punto non dubita dell’esistenza e della baricentricità dell’istituto da non avere remore nell’affermare (si veda, tra tutte, Corte Giust. 3 maggio 1978, C-112/77) che il
principio di tutela dell’affidamento fa parte del diritto comunitario. Ad
esso quindi fa rinvio l’art. 1 della L. n. 241/1990 che, dopo la riforma di cui alla L.
n. 15/2005, rinvia ai principi generali dell’ordinamento comunitario ai fini della
regolazione dell’azione amministrativa.
Cos’è allora l’affidamento? O meglio, quando questo assume i caratteri della
legittimità e della ragionevolezza in guisa da consumare, erodere o condizionare il
pubblico potere?
In base ad una definizione di larga massima, l’affidamento legittimo e ragionevole
(reasonable) è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico, che voglia esercitare il suo potere nei confronti del soggetto privato, di tenere nel
debito conto l’interesse alla conservazione di un vantaggio/bene/utilità conseguito in buona fede dal privato, grazie ad un previo chiaro atto della pubblica amministrazione all’uopo diretto; e tanto, specie se detto vantaggio si
sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale.
Questa definizione colora con tinte chiare i tre caratteri dell’affidamento tutelabile, evidenziandone gli elementi oggettivo, soggettivo e cronologico.
50
Compendio di Diritto Amministrativo
Principiando dall’elemento oggettivo, che rende l’affidamento ragionevole, esso impone che il vantaggio che il privato difende sia chiaro ed univoco. È all’uopo necessario che esso trovi la sua scaturigine in un comportamento attivo, non bastando
uno omissivo; in un atto formale, non essendo sufficienti meri facta conludentia; in
un atto efficace e vincolante, non essendo idoneo un atto endoprocedimentale ed
inefficace.
In definitiva l’elemento oggettivo si invera quante volte l’esercizio del potere incontri sulla sua strada un preesistente bene attribuito in modo chiaro ed univoco da
un provvedimento espresso ed efficace.
In riferimento all’elemento soggettivo, che rende l’affidamento lègitime, è necessario che il privato difenda un’utilità ottenuta nella plausibile convinzione di averne
titolo. È allora tutelabile solo l’affidamento maturato in buona fede. Non merita
per converso protezione l’aspirazione all’intangibilità di un bene che il privato abbia strappato con dolo (ad esempio inducendo in errore con false informazioni) o,
comunque, versando in una condizione di colpa apprezzabile. Va soggiunto che la
colpevolezza dell’expectation è collegata al carattere palese (e quindi riconoscibile) del
vizio che inficia l’atto (come in qualche modo evoca l’accento che il nuovo comma 1
bis dell’art. 21 quinquies pone sulla decifrabilità dell’errore come fattore che refluisce
sulla misura dell’indennizzo da revoca), in relazione non alla natura ma alla misura
del vizio; e quindi in base ad un profi lo non propriamente qualitativo-ontologico ma
schiettamente quantitativo per non dire ponderale.
L’affidamento, infine, è caratterizzato dall’elemento cronologico, che lo rende
stabile. L’affidamento, infatti, diviene pieno solo quando il vantaggio viene conseguito da un arco di tempo tale da persuadere il beneficiary della sua stabilità, se non
della sua definitività. Proprio tale dato cronologico, che a ben vedere più che essere
elemento costitutivo in senso stretto è fattore di potenziamento dell’affidamento,
distingue l’affidamento dal principio di certezza del diritto, di cui è un corollario
condito dalla salsa del tempo.
Tracciati i connotati dell’affidamento si rinvia alla parte IV, cap. 6, per la verifica
delle tecniche con cui la L. n. 241/1990 – ex artt. 21 quinquies e 21 nonies – tutela
l’affidamento a fronte del potere di ritiro da parte della P.A. di provvedimenti vantaggiosi precedentemente resi, stabilendo il limite temporale e l’obbligo di comparazione degli interessi come presupposti dell’annullamento d’ufficio (vedi da ultimo
TAR Lazio, Sez. III bis, 20 giugno 2008 n. 6978 e TAR Campania Napoli,
Sez. VII, 7 maggio 2008, n. 3524, che mettono in evidenza come il decorso del
tempo possa consolidare, e rendere pertanto inattaccabili, situazioni di fatto sorrette
dall’affidamento legittimo); nonché il diritto dell’indennizzo in favore del destinatario della revoca (art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, come di recente modificato
dal D.L. n. 112/2008).
Va soggiunto che dalla nozione comunitaria di affidamento si deve differenziare la nozione nazionale, collegata al principio di buona fede ex art. 2 Cost.
e di estrazione privatistica, che non costituisce una regola attizia volta a limitare il potere amministrativo di disconoscere i vantaggi riconosciuti con pregressi atti ma una
regola comportamentale, iscrivibile nel generale canone di buona fede, che impone
ad ogni soggetto a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate ad
CAPITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI
51
essere frustrate. Detta regola comportamentale trova la sua sanzione, specie ma non
solo nel campo precontrattuale, con l’affermazione della responsabilità della P.A. per i
danni cagionati da una condotta non lineare e trasparente che abbia ingenerato la falsa convinzione nel privato in ordine all’esito favorevole del procedimento in corso.
5.2. Il principio di proporzionalità
Secondo un vecchio detto tedesco, sparare ai passeri con un cannone significa compiere
un’azione palesemente eccessiva rispetto ai fini perseguiti (“darf die Polizei mit Kanonen auf
Spatzen schiessen?”).
Detto motto è una delle più incisive metafore per il principio di proporzionalità
dell’azione dei pubblici poteri, che si è sviluppato principalmente nell’ordinamento
tedesco, ma che ha poi trovato una significativa elaborazione anche in ambito comunitario.
La proporzionalità è una misura del potere amministrativo che attiene essenzialmente all’equo rapporto tra mezzo e fine, tra presupposto e conseguenza e,
più in generale, tra interessi, pubblici e privati, compresenti. Detto principio era
già presente nel nostro ordinamento come una delle manifestazioni del principio
di ragionevolezza, nel quale confluiscono, a loro volta, i principi di uguaglianza, di
imparzialità e buon andamento.
La proporzionalità consiste, pertanto, nell’esercitare la giusta misura del potere in
modo tale da assicurare un’azione idonea ed adeguata alle circostanze di fatto, che
non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolte nell’azione amministrativa.
Di recente il Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2006, n. 2087.
Conf., TAR Lazio, Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 563) ha messo bene in luce che
il principio di proporzionalità implica che la P.A. debba adottare la soluzione idonea
comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve,
in sostanza, nell’affermazione che le autorità, comunitarie e nazionali, non possono
imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle
libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, ovvero
sproporzionata, a quella strettamente necessaria al pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo. In base tale principio, in definitiva, il provvedimento che incida
negativamente nell’altrui sfera giuridica deve essere idoneo (cioè adeguato all’obiettivo da perseguire) e necessario (nel senso che nessun altro strumento ugualmente
efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile).
Nel diritto comunitario il principio di proporzionalità acquista una forte accentuazione in ordine al rispetto delle posizioni dei soggetti privati a fronte dell’intervento pubblico: esso guarda più all’esigenza di non limitazione – se non nei casi
di stretta necessità – della libertà dei privati, che all’esigenza della migliore soddisfazione dell’interesse pubblico. Ogni misura adottata dalla pubblica amministrazione
che va ad incidere su posizioni private dev’essere proporzionale rispetto a quanto richiesto dagli obiettivi perseguiti. Irragionevole, e perciò sanzionabile sotto il profi lo
dell’eccesso di potere, sarebbe quindi una misura incidente nella sfera privata, non
giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico (così, da ultimo,
Corte gius. CE , Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 37).
52
Compendio di Diritto Amministrativo
Il principio di proporzionalità diviene, in tal modo, anche un fondamentale strumento esegetico per le
autorità ed i giudici comunitari e nazionali, quale parametro interpretativo in sede di recepimento e applicazione delle direttive comunitarie. La Corte gius. CE , 29 gennaio 2008, n. 275, invero, ha sottolineato la necessità che di dette norme comunitarie sia effettuata un’interpretazione “che garantisca un giusto
equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione
delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il
loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di basarsi su una loro interpretazione che
sia in contrasto con i diritti fondamentali, quali in particolare il diritto di proprietà intellettuale, il diritto ad una
tutela giurisdizionale effettiva e il diritto che garantisce la tutela dei dati personali, o con gli altri principi generali del
diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità”.
La “nostra” proporzionalità, quale declinazione del principio di ragionevolezza, guarda essenzialmente al provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione in sé e per sé, come misura intesa a curare l’interesse
pubblico. Non v’è dubbio, però, che il principio di proporzionalità è stato restituito al nostro ordinamento con caratteri nuovi, dovuti soprattutto alla rielaborazione
giurisprudenziale della Corte di giustizia, sicché anche in Italia la proporzionalità,
da strumento del controllo giurisdizionale è progressivamente assurta a principio
dell’agire amministrativo teso alla limitazione degli effetti sulle posizioni private
derivanti dalle misure adottate dalla pubblica amministrazione. Ed invero, tale principio, anche nelle pronunce dei Giudici amministrativi nazionali, ha via via assunto
una valenza generale, esigendo, conformemente alla giurisprudenza della Corte di
giustizia, che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato
rispetto agli scopi perseguiti.
Tale mutamento emerge con estrema nitidezza dall’esame della giurisprudenza più
recente, la quale, ormai, invoca il principio di proporzionalità quale limite intrinseco
all’agere della P.A. e non più quale elemento estrinseco di controllo giurisdizionale
della legittimità dell’azione amministrativa. Ad esempio, il TAR Campania Salerno,
Sez. I, 10 gennaio 2008, n. 17, sulla scorta di tale impostazione, ha sottolineato come
l’ampio potere discrezionale del quale gode l’amministrazione appaltante in sede di
elaborazione della lex specialis della procedura selettiva, deve essere esercitato nel
rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione alla gara.
Alle stesse conclusioni giunge poi il TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 novembre 2007, n. 1721 in materia di autotutela. Il Tribunale Amministrativo calabro,
invero, ha sottolineato come il potere di autotutela debba essere esercitato nel rispetto
di tutti i suoi ordinari presupposti e limiti, tenendo conto della particolare esigenza
di ponderazione dell’interesse del destinatario dell’atto favorevole alla conservazione
del provvedimento, anche in relazione all’affidamento ingenerato dal trascorrere del
tempo ed dai costi dallo stesso sopportati, comparato con l’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità.
CAPITOLO III
LE FONTI
SOMMARIO : 1. Introduzione al tema. – 2. L’individuazione delle fonti secondarie. – 2.1. Le differenze concettuali
e disciplinatorie rispetto agli atti amministrativi generali. – 2.2. I criteri di differenziazione secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. – 3. I regolamenti. – 3.1. Nozione. – 3.2. La potestà regolamentare. – 3.3.
La classificazione dei regolamenti governativi. – 3.4. segue: Regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2).
– 3.5. Il riparto del potere regolamentare tra Stato e Regioni: il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. – 4. segue: La tutela giurisdizionale nei confronti dei regolamenti illegittimi. – 4.1. segue: Il sindacato del
giudice amministrativo sui regolamenti: dalla tradizione dell’impugnazione nel termine decadenziale… – 4.2.
…alla nuova frontiera della disapplicazione. – 4.3. Il problema della disapplicazione degli atti amministrativi
generali: i bandi di gara e di concorso. – 5. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali. – 6. Le ordinanze di
necessità ed urgenza. – 7. Le fonti secondarie dubbie. – 8. Le norme interne. – 8.1. segue: le circolari: caratteri
generali. – 8.2. segue: L’impugnazione delle circolari. – 9. Le consuetudini.
1. Introduzione al tema
Esaminata la nozione soggettiva ed oggettiva dell’azione amministrativa si deve
ora passare, per avviarci a chiudere questa prima parte del volume, all’esame delle
fonti che governano e vincolano l’azione amministrativa secondo gli schemi passati
in rassegna nel capitolo che precede.
In questa sede si può fare solo un cenno alla tematica generale (inerente al diritto costituzionale) delle fonti del diritto, osservandosi che esse annoverano, in linea
gerarchica, la Costituzione, gli atti aventi forza di legge, le fonti secondarie e gli usi
normativi. Si deve aggiungere che la ripartizione della competenza legislativa tra
Stato e Regioni non si basa più su di un criterio gerarchico, bensì su un criterio di
competenza, nei sensi ora scolpiti dall’art. 117 Cost., come modificato dal nuovo titolo V della parte II della Carta Costituzionale (vedi parte III, cap. I).
Si deve soprattutto rimarcare che è ormai acquisto il canone della prevalenza, in
omaggio alla cd. primauté comunitaria, delle norme comunitarie rispetto a quelle
nazionali; canone che viene declinato con lo strumento della disapplicazione diretta
della norma nazionale contrastante da parte del giudice del caso concreto, senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale (salvi i ricorsi principali).
Bene, in questa sede ci si occuperà delle fonti specifiche del diritto amministrativo, ossia le fonti secondarie.
Come noto, il nostro ordinamento giuridico è governato dal principio di gerarchia
delle fonti, per il quale una fonte di rango inferiore non può derogare ad una norma
di rango superiore. All’interno di detta gerarchia, le “fonti secondarie” costituiscono il mezzo normativo con il quale si estrinseca il potere normativo della pubblica
54
Compendio di Diritto Amministrativo
amministrazione – sia a livello centrale che locale – che, loro tramite, disciplina gli
specifici settori assegnati alla sua competenza. Esse sono costituite da atti normativi (idonei, dunque, ad innovare l’ordinamento giuridico erga omnes), privi tuttavia
di efficacia legislativa: essi, in sostanza, sono atti formalmente (o soggettivamente)
amministrativi (in quanto adottati da una pubblica amministrazione) ma sostanzialmente normativi, e quindi caratterizzati da generalità, astrattezza e innovatività,
caratteristiche queste tipiche delle fonti del diritto.
Nello specifico, sotto il primo profi lo, la generalità implica che i destinatari
degli atti normativi secondari (così come i destinatari delle leggi), non sono determinabili, neanche a posteriori a seguito dell’emanazione dell’atto (cfr. infra). Quanto all’astrattezza, essa fa sì che le disposizioni siano indefinitamente ripetibili ed
applicabili a svariate fattispecie concrete che integrino nel tempo gli estremi della
fattispecie astratta. L’innovatività, infine, consiste nella possibilità di modificare
definitivamente l’ordinamento giuridico.
In relazione a tale ultimo profi lo, ci si è interrogati sulla possibilità di riconoscere carattere innovativo agli atti che contengono precetti solo temporanei. Ad una prima tesi, che ritiene requisito
indefettibile dell’innovatività la capacità di innovare permanentemente e stabilmente l’ordinamento, con la
conseguenza che non posseggono tale carattere gli atti abilitati soltanto a derogarvi (quali, ad esempio, le
ordinanze di necessità ed urgenza: in questo senso Corte cost., 19 maggio 1988, n. 569), si contrappone
chi ritiene che anche gli atti che contengono precetti temporanei abbiano carattere normativo, nonostante
le innovazioni da essi prodotti si producano in un periodo di tempo circoscritto (così Cons. St., Sez. atti
normativi, parere 10 marzo 2003, n. 580/03).
In ogni caso, è persino banale osservare che la caratterizzazione delle fonti secondarie quali atti sostanzialmente normativi non vale a renderle fonti
“legislative” in senso stretto: ne consegue che, in ossequio ai principi generali di
gerarchia delle fonti, legalità e riserva di legge che presidiano il nostro ordinamento,
esse restano, in ogni caso, subordinate alle norme di rango primario.
2. L’individuazione delle fonti secondarie
2.1. Le differenze concettuali e disciplinatorie rispetto agli atti amministrativi generali
La qualificazione “ambivalente” delle fonti secondarie quali atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi ha da sempre acceso vivaci dibattiti tra gli addetti
ai lavori onde fissare criteri ermeneutici certi per la loro concreta individuazione.
Nella prassi, invero, la qualificazione degli atti amministrativi quali normativi od
amministrativi in senso stretto, non è sempre agevole: problemi sono sorti, soprattutto, in riferimento all’esatta individuazione della natura degli atti amministrativi
generali, per i quali la loro peculiare destinazione alla pluralità dei consociati rende
meno agevole la distinzione rispetto agli atti normativi.
Per atti amministrativi generali, invero, devono intendersi quegli atti formalmente
e sostanzialmente amministrativi, che tuttavia si rivolgono ad una pluralità indeterminata di destinatari.
Di regola, tale indeterminabilità opera solo a priori, essendo invece agevole, a posteriori, individuare i destinatari dell’atto successivamente alla loro adozione (si pensi,
ad esempio, ai bandi di gara e di concorso).
CAPITOLO III – LE FONTI
55
Tanto vale a distinguere gli atti generali dagli atti collettivi e dagli atti plurimi, entrambi concettualmente distinti dagli atti generali in quanto, pur essendo atti plurisoggettivi, non si rivolgono alla generalità
indistinta del consociati.
In realtà tanto gli atti collettivi che quelli plurimi sono solo apparentemente atti plurisoggettivi, poiché essi
si rivolgono singolarmente a ciascun soggetto destinatario dell’atto. Ed invero, i primi si rivolgono ad un
destinatario “complesso”, ovvero ad un insieme di soggetti legati da rapporti interni e costituenti il diverso
e distinto soggetto a cui l’atto è rivolto (si pensi, ad esempio, all’atto di scioglimento di un organo collegiale). Analogamente, se è pur vero che l’atto plurimo sembra rivolgersi a più figure soggettive (comunque
determinate a priori), esso è scindibile in diversi ed autonomi provvedimenti – sia pur di contenuto identico e esteriorizzati nello stesso locus – tanti quanti sono i destinatari, tra loro autonomi ed indipendenti.
Si è perciò in presenza di una pluralità di provvedimenti individuali, con contenuto identico, contenuti in
un unico atto di esternazione della volontà dell’ente, conservando, di conseguenza, un’assoluta autonomia
ed indipendenza rispetto ai provvedimenti omologhi. Ne consegue che le vicende estintive o patologiche
che investono uno dei provvedimenti contenuti nell’atto plurimo non influisce, neppure in via mediata,
sugli altri provvedimenti.
Lungi dal costituire un problema meramente classificatorio, la diversa qualificazione dell’atto comporta una radicale differenziazione della disciplina applicabile.
La connotazione generale dell’atto, infatti, non ne altera la natura amministrativa, con la conseguente applicazione della disciplina generale degli atti amministrativi: esso è emanato all’esito di un procedimento amministrativo ed è suscettibile di impugnazione alle stesse condizioni e per gli stessi motivi di qualsiasi atto della
P.A. Le uniche aporie disciplinatorie derivano proprio dal carattere generale degli atti
in parola, con la conseguente necessità di interpretare le regole generali tenendo conto
della peculiare mancanza di specifici e predeterminati destinatari.
Per tale ragione, ad esempio, la L. n. 241/1990 esclude per tali atti l’obbligo di motivazione (art. 3, comma
2), l’applicazione delle garanzie partecipative al procedimento (art. 13, comma 1), nonché l’accesso all’attività diretta alla formazione degli atti in questione (art. 24, comma 1, lettera c).
Inoltre, proprio la mancanza di destinatari specifici, subordina l’impugnabilità di tali atti alla verifica, case by
case, della immediata portata lesiva dell’atto impugnato, onde verificare, in ultima istanza, la sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. In applicazione di detto principio il Cons. St., Sez. IV, 18 marzo 2008, n.
1159, ha affermato la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale ad impugnare, ovvero a contrastare in veste di intervenienti, atti amministrativi generali, anche a contenuto normativo, ritenuti illegittimi
o comunque lesivi dell’ambiente o della salute degli associati dalle stesse statutariamente tutelati.
Ancora, l’inosservanza dell’atto amministrativo generale costituisce una figura sintomatica di eccesso di
potere; al contrario, la violazione dell’atto normativo comporta l’illegittimità degli atti seguenti per violazione di legge, secondo i principi iura novit curia et ignorantia legis non excusat. Ne consegue, sul piano processuale, che solo l’inosservanza dell’atto normativo da parte del giudice consente il ricorso per Cassazione
ex art. 360, n. 3 c.p.c. e può essere disapplicato dal giudice amministrativo.
Sul piano strettamente procedimentale, per i regolamenti governativi, l’art. 17 della L. n. 400/1988 prevede un particolare iter procedimentale, la cui violazione determina l’illegittimità del regolamento; per gli
atti amministrativi, invece, la legge prevede l’ininfluenza delle irregolarità procedurali, quantomeno ove
esse non si traducano nell’emissione di un atto diverso da quello legittimo (art. 21 octies, comma 2, L. n.
241/1990, come modificato dall’art. 14, L. n. 15/2005).
La sussunzione di un atto nella categoria delle fonti normative, poi, conferisce all’atto rilievo penale: si
pensi, ad esempio, alla nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, che incrimina “la violazione di norme di legge
o di regolamento” (art. 323 c.p.), con un espresso riferimento, pertanto, come si dirà più innanzi, alla più
importante delle fonti secondarie.
Nessuna distinzione, invece, opera sui livelli delle garanzie partecipative e motivazionale, avendo la L. n.
241/1990 uniformato il trattamento per entrambe le tipologie di atti, con l’esclusione dell’obbligo di motivazione (artt. 3 e 13). Lo stesso dicasi per il controllo di legittimità costituzionale, poiché per entrambi si
esclude il sindacato da parte della Corte delle leggi.
56
Compendio di Diritto Amministrativo
2.2. I criteri di differenziazione secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
Le difficoltà esegetiche nella distinzione tra gli atti normativi e quelli generali, hanno indotto dottrina e giurisprudenza ad individuare diversi criteri discretivi
per mezzo dei quali verificare la natura sostanzialmente amministrativa o normativa
degli atti della P.A. Esclusa la possibilità di utilizzare la generalità quale parametro
discretivo dei due atti in parola, come sopra evidenziato, i criteri elaborati in sede
dottrinale e pretoria possono così riassumersi:
a) Spessore politico dell’atto.
Una prima corrente di pensiero assurge ad elemento peculiare e caratterizzante gli
atti normativi, la natura spiccatamente politica: l’atto andrà pertanto qualificato come normativo ove esso, lungi dal costituire mera esecuzione o specificazione
di altro precedente provvedimento, risulti dotato di uno “spessore politico” che
costituisca esplicazione del potere pubblicistico della P.A. di individuare e definire
le finalità e gli scopi da perseguire con la sua attività pubblicistica (così ex multis
Corte cost., 22 giugno 1990, n. 311). Tale tesi, tuttavia, non appare condivisibile,
posto che si basa su valutazioni, inerenti alla politicità dell’atto, assai opinabili e
soggettive.
b) Criterio formale.
Di contrario avviso, i sostenitori del criterio formale (M.S. GIANNINI) ritengono
doversi prescindere dal contenuto dell’atto, focalizzando invece l’analisi sulla
sua qualificazione, ovvero sul nomen che la P.A. attribuisce al provvedimento e
sulla base del quale organizza il procedimento.
Neanche questa tesi, tuttavia, appare condivisibile, poiché in aperta controtendenza con il principio di effettività dei mezzi giuridici, che ormai presidia l’intero ordinamento. Detto principio generale impone di prescindere dal nomen degli istituti giuridici, soprattutto ove frutto di autoqualificazione, per guardare il profi lo
sostanziale delle singole fattispecie. Ed invero, sarebbe quantomeno irragionevole escludere la natura normativa di atti che, pur presentando caratteristiche sostanzialmente normative, siano stati qualificati come
atti amministrativi stricto sensu, ovvero siano stati emanati in base ad uno specifico iter procedimentale.
Sotto quest’ultimo profi lo, in realtà, la dottrina in commento opera un’inaccettabile inversione logica,
dovendosi adeguare l’iter procedimentale al tipo di provvedimento da emanare, e non viceversa. In altri
termini, è la natura normativa dell’atto ad imporre una specifica forma procedimentale; in mancanza, lungi
dal costituire motivo di mutamento della natura del provvedimento, il defi cit procedimentale costituirà
causa di illegittimità per violazione di legge, e segnatamente per mancato rispetto della procedura prescritta
(cd. vizio in procedendo).
c) Criterio basato sui connotati sostanziali.
Alla luce delle critiche sopra riportate alla teoria formale, emerge in tutta la sua
imprescindibilità la necessità di svolgere un’indagine sui profili sostanziali
dell’atto, al fine di verificare la generalità, astrattezza ed innovatività (cfr. par. 1.)
delle prescrizioni contenute nell’atto, al fine di qualificarlo come normativo.
Quest’ultima tesi ha avuto maggiore seguito in ambito pretorio: in applicazione
di detto criterio, infatti, la giurisprudenza ormai largamente prevalente ha precisato che “gli atti ed i provvedimenti amministrativi generali sono espressione di mera potestà
amministrativa e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei
confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento,
ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita
all’Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi
CAPITOLO III – LE FONTI
57
di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell’astrattezza” (così Cons. St., Sez. atti normativi, parere 14 febbraio
2005, n. 11603/04; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2007, n. 5062;
Cass. civ., 27 settembre 2006, n. 20958).
Da ultimo, TAR Campania, Sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8947 ha rilevato che: “Il regolamento si distingue dall’atto amministrativo generale perché introduce una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici e ha effetti
innovativi dell’ordinamento giuridico: pertanto il provvedimento con cui un Comune dispone che il canone per l’affidamento a terzi di suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione è equiparato al canone per l’occupazione di suolo
pubblico, non introducendo una disciplina generale ed astratta dei rapporti giuridici concessori, non può essere qualifi cato
come regolamento e la sua emanazione è, pertanto, demandata, ai sensi dell’art. 48, II comma, del TUEL alla Giunta
Comunale e non al Consiglio Comunale”.
Esaminati i caratteri generali delle fonti secondarie si può ora passare alla rassegna
delle singole tipologie, a cominciare da quella più importante, i regolamenti.
3. I regolamenti
3.1. Nozione
Una definizione generale di regolamenti amministrativi è contenuta nell’art. 14
del D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, che, in materia di ricorsi amministrativi,
definisce i provvedimenti in parola come “atti amministrativi generali a contenuto normativo”.
Essi, dunque, presentano la natura “bifasica” tipica delle finti secondarie, sommando il profi lo formalmente (o soggettivamente) amministrativo, poiché atti emanati da organi del potere esecutivo, a quello sostanzialmente (od oggettivamente)
normativo, dato il loro contenuto precettivo, destinato ad innovare l’ordinamento
giuridico in via subordinata rispetto alle fonti primarie.
Come tutte le fonti normative secondarie, pertanto, i regolamenti sono caratterizzati da generalità, innovatività ed astrattezza.
Tali caratteri, tuttavia, è bene sottolinearlo, caratterizzano i soli regolamenti esterni,
destinati, cioè,a produrre effetti vincolanti al di fuori della P.A. che li ha emanati, e
non già ai regolamenti interni, espressione, a dispetto del nomen, della sfera dell’autoorganizzazione degli enti pubblici (par. 8.).
3.2. La potestà regolamentare
Originariamente il fondamento della potestà regolamentare della P.A. si rinveniva
nell’esigenza che quest’ultima, non soggetta alla legge nelle antiche monarchie costituzionali, autoregolamentasse l’esercizio del proprio potere discrezionale, altrimenti
illimitato.
L’avvento dello Stato di diritto, e segnatamente della Costituzione, che ha equiparato i tre poteri fondamentali dello Stato soggiogandoli alla legge, ha individuato
in quest’ultima il fondamento della potestà regolamentare. Ne consegue che la legge
che attribuisce il potere di utilizzare lo strumento regolamentare, individua l’organo
competente ad esercitare il relativo potere e fissa i limiti e le materie nel cui ambito
questo può esplicarsi.
58
Compendio di Diritto Amministrativo
La norma attributiva del potere regolamentare a livello centrale è l’art.
17 L. n. 400/1988, che disciplina l’adozione dei regolamenti governativi e
ministeriali. L’assenza di una norma di più ampio respiro, valevole per tutte le amministrazioni, statali e locali, ha imposto pertanto la verifica, case by case, del puntuale
conferimento del potere regolamentare alle singole PP.AA. man mano che vengono
in rilevo i regolamenti da esse emanati nelle singole fattispecie concrete.
Ove manchi un esplicito riferimento alla potestà regolamentare della P.A. e l’attribuzione del potere in parola avvenga solo in via implicita, è necessario verificare
se, in base al criterio sostanziale di cui si è detto (cfr. par. 2.2.), l’atto in questione
presenti i requisiti della generalità, dell’astrattezza e dell’innovatività, indipendentemente dal nomen attribuito al provvedimento.
In ogni caso, l’investitura legislativa, pur essendo presupposto indefettibile per
l’emanazione di qualsivoglia regolamento, si atteggia diversamente a seconda della
tipologia regolamentare. Essa, infatti, deve prevedere criteri direttivi per l’esercizio
del potere in caso di regolamenti di delegificazione (cfr. par. 4.3.) di modo da non
lasciare all’arbitrio della P.A. l’individuazione delle norme da abrogare, ovvero in
caso di regolamenti esecutivi (cfr. par. 4.4.), per i quali la legge deve prevedere un
dettato sostanziale al quale dare esecuzione. Il contenuto della legge di investitura
in materia di regolamenti indipendenti (cfr. par. 3.3.), al contrario, può essere assai
meno stringente, poiché essa deve limitarsi ad attribuire il potere regolamentare,
toccando poi allo stesso regolamento disciplinare in via sostanziale – e pressoché
esclusiva – la materia.
Tale conclusione è stata avallata dal Consiglio di Stato, sezione consultiva, atti normativi, parere 7 giugno
1999, n. 107, secondo il quale “il principio secondo cui il potere regolamentare deve sempre trovare nella legge la propria legittimazione risponde a regole di stretta tipicità e può essere derogato solo con riferimento ai regolamenti cosiddetti
liberi, previsti dall’art. 17, comma 1, lett. c) del 23 agosto 1988, n. 400”. In altri termini, il Consiglio sembra
ritenere che non sia necessaria una previsione legislativa che legittimi ogni singolo regolamento, essendo
sufficiente, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 400/1988, l’ammissibilità costituzionale di una simile forma di
regolamento in settori non coperti da riserva di legge.
Di diverso parere è invece la dottrina prevalente, orientata a ritenere che “si applica il principio di legalità
inteso come conformità in senso formale, il quale impone che ogni manifestazione di attività normativa trovi il proprio
fondamento in una legge generale, che indichi l’organo competente e le materie in ordine alle quali esso può esercitarla”
(E. CASETTA).
Le conseguenze in punto di validità del regolamento emanato in carenza
o travalicando i limiti dell’investitura legislativa, tuttavia, non sono pacifiche: a
fronte di un primo orientamento che ritiene l’atto in parola illegittimo per violazione
di legge o per incompetenza, v’è chi afferma la nullità dell’atto per carenza di potere,
insanabile e rilevabile ex officio senza necessità d’impugnazione negli ordinari termini
decadenziali. A ben vedere, tale ultimo orientamento appare maggiormente condivisibile poiché pone l’accento sull’assoluto difetto di legittimazione della P.A. all’emanazione dell’atto, che sembra richiamare l’indicazione contenuta nell’art. 21 septies, L. n.
241/90, in tema di cause di nullità dei provvedimenti (parte IV, cap. V, par. 2.1.).
In particolare, la giurisprudenza si è interrogata sulle conseguenze in punto di invalidità del regolamento a
seguito della sua emanazione dopo la scadenza dei termini fi ssati dalla legge per l’esercizio della potestà regolamentare. A fronte dell’orientamento dottrinale prevalente, che ritiene che il potere regolamentare non
possa più essere esercitato alla scadenza del termine previsto dalla legge di investitura, la giurisprudenza
CAPITOLO III – LE FONTI
59
più recente (Cons. St., Sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1901) ritiene che il termine non sia da considerarsi
perentorio. A tale conclusione il Supremo Consesso giunge in considerazione della natura “immanente”
alle attribuzioni della P.A. di detta potestà; inoltre, se il legislatore ha ritenuto opportuno demandare alla
normazione secondaria il completamento della disciplina, non è concepibile che questa resti lacunosa e la
legge venga di fatto inapplicata solo perché l’Autorità regolamentare non ha rispettato il termine ad essa
assegnato.
Al di là dei limiti fi ssati dalla legge di investitura, l’emanazione del regolamento, poi, incontra precisi
limiti, rivenienti dal generale principio di gerarchia delle fonti. I naturali corollari di tale principio
generale comportano che gli atti regolamentari:
a) non possono contrastare con le norme costituzionali, sia in riferimento alle statuizioni ivi espresse che ai principi
ivi contenuti, così come peraltro confermato dall’art 117 Cost. (così Corte cost., 9 luglio 1999, n. 291);
b) non possono contrastare con quanto stabilito dalle leggi ordinarie, salvo l’ipotesi in cui sia la stessa legge a attribuire la competenza specifica di incidere su una fonte sovraordinata (cd. regolamento di delegificazione);
c) non possono mai disporre in materie riservate alla disciplina della legge dalla Carta costituzionale: ne consegue che
l’incostituzionalità del regolamento costituisce causa di illegittimità che viene fatta valere dal giudice del
caso concreto, mentre è inibito il controllo della Corte costituzionale trattandosi di atto privo di forza
di legge;
d) non possono derogare o contrastare con le norme Comunitarie, in ragione del principio di primazia del diritto comunitario su quello nazionale, con il conseguente obbligo di disapplicazione delle norme nazionali incompatibili;
e) non possono mai derogare al principio di irretroattività a differenza di quanto accade per la legge. Secondo il
Cons. St., Sez. norm., parere 23 ottobre 2000, n. 177, peraltro, “la regola generale della irretroattività dei
regolamenti, derivante dal principio di irretroattività della legge, è posta a garanzia dei terzi e può dunque trovare
deroga quando si tratti di reintegrare le posizioni giuridiche di questi, incise in via di fatto dal comportamento dell’amministrazione”;
f ) non possono comminare sanzioni di natura penale, in virtù del principio di riserva di legge in materia penale
ex art. 25 Cost., neanche mediante delegificazione (così Cons. St., Sez. consultiva atti normativi, 8 novembre 1999);
g) i regolamenti emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. Nello specifico, i regolamenti ministeriali ed interministeriali sono subordinati
a quelli governativi e non possono derogarvi o contrastarvi: tale principio è stato fortemente ribadito
dalla giurisprudenza, la quale ha più volte sottolineato che “non sono conformi a legge le disposizioni di un
regolamento governativo ‘delegifi cante’ che disciplinano materie [..] devolute da specifi che leggi ad una fonte regolamentare di livello inferiore”. ( C. conti, Sez. controllo Stato, deliberazione 6 febbraio 1998, n. 13. Nello
stesso senso anche TAR Napoli, Sez. III, 27 novembre 2000, n. 4456, che ha chiarito che “per effetto del
principio di gerarchia delle fonti è inammissibile la modifi ca di un regolamento governativo mediante un regolamento
ministeriale”).
3.3. La classificazione dei regolamenti governativi
Come già anticipato, la categoria regolamentare è assai eterogenea, e consta di
tipologie variegate, con tratti caratteristici assai diversi. Esse sono classificate dall’art.
17 L. n. 400/1988, che, novellando la precedente classificazione consacrata dalla L. n.
100/1926, distingue i regolamenti in:
a) Regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi nonché di regolamenti comunitari (art. 17, lett. a), come modificato dall’art. 11 della L. n. 25/1999).
La prima tipologia a venire in rilevo, ai sensi della norma citata, concerne, dunque,
gli atti regolamentari necessari ad eseguire concretamente le statuizioni di una
fonte legislativa.
Il riferimento ai regolamenti attuativi di regolamenti comunitari, è stato introdotto dalla L. n. 25/1999 (cd.
“legge comunitaria 1998”), in ossequio agli obblighi comunitari. D’altra parte, la peculiarità delle fonti
europee si traspone anche sui regolamenti attuativi di direttive, visto il carattere fi siologicamente incompleto di tali fonti comunitarie.
60
Compendio di Diritto Amministrativo
Nell’elenco di cui all’articolo in commento non figurano i decreti legge: tale scelta, invero, appare confortata dalla durata temporalmente limitata di dette norme, che, impedisce, sotto un profi lo squisitamente
temporale, prima ancora che logico, di essere seguiti da un provvedimento di attuazione.
b) Regolamenti attuativi ed integrativi di leggi e decreti legislativi recanti
norme di principio (art. 17 lett. b).
La norma in commento ha equiparato i regolamenti attuativi ed integrativi, superando gli annosi dibattiti sull’ ammissibilità della cd. “normazione di dettaglio”.
Nonostante la chiara lettera della norma, tuttavia, la natura di tali atti resta assai discussa. Qualche Autore
continua a ritenere gli atti in commento regolamenti di esecuzione, ovvero, secondo una diversa impostazione, regolamenti indipendenti, poiché atti a disciplinare materie per le quali il legislatore si è limitato a dettare
prescrizioni di principio. Altra parte della dottrina, poi, li ritiene un tertium genus, inquadrabile in una
posizione intermedia rispetto ai regolamenti indipendenti ed esecutivi.
A chiarire le numerose perplessità suscitate dai dibattiti dottrinari, è intervenuta a più riprese la giurisprudenza, la quale ha individuato l’elemento discretivo tra regolamenti integrativi ed esecutivi nella possibilità, riconosciuta in capo solo ai primi, di ampliare il contenuto o innovare la disciplina dettata nelle leggi
di principio, pur nel rispetto di queste ultime e dei principi generali (cfr. par. 1.) (così Cons. St., Sez. III,
parere 3 settembre 1998, n. 2251).
Accanto ai limiti fissati dalla legge a cui dare attuazione ed a quelli rivenienti
dai principi generali dell’ordinamento, di cui si è detto, è da sottolineare come
i regolamenti in commento rinvengano un ulteriore limite nell’art. 117 Cost., e
segnatamente nel riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. È infatti
da escludere la possibile edizione del potere regolamentare statale in caso di leggi
cornice emanate dallo Stato in materie attribuite alla competenza concorrente
regionale.
c) Regolamenti concernenti materie non disciplinate da leggi o da atti
aventi forza di legge, e che non siano oggetto di riserva (art. 17 lett. c).
Con questa previsione l’art. 17 ha generalizzato lo strumento della regolamentazione
indipendente, conferendo al Governo una generale potestà regolamentare nelle materie in cui non vi sia alcuna disciplina normativa ovvero alcuna riserva di legge.
Nonostante il dettato normativo, si discute sulla compatibilità della categoria dei regolamenti in commento
con il principio di legalità. In particolare, ci si chiede se sia sufficiente la mera attribuzione generale della
potestà regolamentare, contenuta nella norma in parola, onde soddisfare il requisito della riserva di legge,
o, se, al contrario, siano necessarie ulteriori indicazioni di carattere sostanziale in merito all’oggetto ed alle
modalità di esercizio di detto potere. La dottrina maggioritaria è orientata nel senso di ritenere sufficiente
una generica attribuzione della potestà regolamentare affi nché il regolamento indipendente possa essere
validamente emanato, posto che indicazioni “qualitative” in ordine all’emanando regolamento lo trasformerebbe, di fatto, in un regolamento di esecuzione.
Di contro, si è osservato che la generica previsione dell’art. 17 condurrebbe a conseguenze aberranti, in palese dispregio del principio della gerarchia delle fonti. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui venga abrogata
l’intera disciplina legislativa in una determinata materia; tanto basterebbe all’esercizio legittimo della potestà regolamentare indipendente, in palese violazione delle garanzie di cui all’art. 17, comma 2, in materia
di delegificazione (prima fra tutte la necessità di una norma di legge ad hoc che autorizzi la delegificazione e
ne fi ssi i principi). Inoltre, l’estrema elasticità della categoria concettuale delle “materie”, ben si presterebbe
alla creazione di nuove “materie” connotate da un’artificiosa specificità ed autonomia.
Pur essendo condivisibili, in linea di principio, le preoccupazioni della giurisprudenza in ordine alla possibilità di un uso distorto dei regolamenti indipendenti, il problema appare meramente teorico, stante la
CAPITOLO III – LE FONTI
61
sostanziale inesistenza nel nostro ordinamento di materie per le quali manchi una disciplina legislativa: al
di là del carattere spesso alluvionale e caotico della normazione primaria, il pericolo paventato sarebbe, poi,
comunque scongiurabile mediante il ricorso all’analogia legis et juris ex art. 12 disp. sulla legge in generale.
d) Regolamenti concernenti il funzionamento e l’organizzazione di pubbliche amministrazioni secondo disposizioni di legge (art. 17 lett. d).
I regolamenti organizzativi costituiscono l’estrinsecazione dell’imprescindibile
potere di autoregolamentazione della P.A., tanto da trovare già una compiuta disciplina nella L. n. 100/1926, che consentiva loro addirittura di modificare norme
legislative previgenti nella stessa materia e, dunque, li classificava quale strumento
– anche – di delegificazione.
La garanzie costituzionali della nostra Carta Fondamentale hanno imposto anche in materia di organizzazione dei pubblici uffici la riserva relativa di legge (ex art. 97 Cost, secondo cui gli uffici sono organizzati
secondo le disposizioni di legge “in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”), fatta eccezione per il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri, riservate dall’art.
95 Cost. alla legge in modo assoluto (v. parte III, cap. I). Alla luce del nuovo assetto normativo, pertanto,
i regolamenti di organizzazione ex art. 95 Cost. non costituiscono più regolamenti indipendenti, dovendo
invece assumere carattere necessariamente esecutivo delle relative leggi.
e) Regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2), sui quali vedi il paragrafo
successivo.
3.4. segue: Regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2)
Per delegificazione deve intendersi il “trasferimento della disciplina normativa di una
determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare” (M ARTINES). Essa implica la rinuncia dello Stato a disciplinare legislativamente determinate
materie, evidentemente ritenute non più meritevoli di regolamentazione mediante
norme primarie, e si concretizza con i meccanismi più diversi. Spesso viene emanata
una legge che abilita la disciplina della materia in questione mediante regolamenti e che dispone contestualmente l’abrogazione della disciplina legislativa esistente
all’entrata in vigore della normativa regolamentare (cd. abrogazione differita) ovvero
mediante il conferimento di una delega al governo a derogare alla disciplina generale,
senza peraltro inciderla in alcun modo.
L’imponente produzione legislativa degli ultimi due decenni, spesso confusa, ha
indotto il legislatore a ricorrere assai di frequente al meccanismo della delegificazione, con una frequenza sempre maggiore, tanto da suscitare numerosi interrogativi in
dottrina circa la legittimità costituzionale dei regolamenti in commento.
Taluni Autori, invero, hanno dubitato della compatibilità dell’istituto con gli artt. 87 e 77 Cost. (i quali
non prevedono tale fonte normativa tra quelle attribuite al potere esecutivo) nonché con i principi di preferenza della legge e di gerarchia delle fonti.
La prevalente dottrina, tuttavia, ha concluso per la costituzionalità dei regolamenti in commento: alla – ovvia
– considerazione della posizione di autonomia istituzionale del Governo (ex artt. 95 e 97 Cost.), si è aggiunto
il rilievo che i principi di legalità e di preferenza per la legge non appaiono posti in discussione, posto che è la
stessa legge ordinaria che abilita il Governo alla delegificazione e all’abrogazione delle leggi previgenti. Allo
stesso risultato giunge poi chi osserva, sotto un diverso profi lo, che la legge di autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare dispone la degradazione delle norme primarie, ovvero il trasferimento della disciplina di
certe materie dalla sede legislativa a quella regolamentare, in modo da consentire ai regolamenti di derogarvi
e/o di abrogarle senza violare il principio di gerarchia delle fonti (cd. “teoria della delegificazione”).
62
Compendio di Diritto Amministrativo
Ormai fortemente consolidatosi l’orientamento pretorio favorevole alla piena legittimazione costituzionale dei regolamenti di delegificazione, essi hanno trovato
un definitivo riconoscimento normativo nell’art. 17, comma 2, L. n. 400/1988.
La norma chiarisce definitivamente la natura normativa dei regolamenti in parola,
ammissibili a patto che la legge di autorizzazione fissi i criteri per l’esercizio del potere regolamentare e detti le norme generali regolatrici della materia; quest’ultima,
inoltre non deve essere oggetto di riserva assoluta di legge.
Secondo la prevalente dottrina, nell’art. 17, comma 2, trovano fondamento entrambe le tipologie di regolamenti sopra descritte: sia i regolamenti di delegificazione, che disciplinano una materia in precedenza regolata dalla legge, sia i regolamenti
delegati, abilitati a derogare a singole disposizioni di legge, in quanto entrambe producono un effetto abrogativo (o sostitutivo) della legge preesistente in base al dettato
di una specifica norma di legge.
Quanto all’iter procedimentale, i regolamenti in parola devono essere adottati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e parere del Consiglio di Stato.
Il ricorso sempre più massiccio alla delegificazione ha indotto il legislatore a dettare discipline specifiche per
l’adozione di particolari regolamenti di delegificazione, con il risultato di “deviare”, talvolta in modo radicale,
dal modello regolamentare scolpito dal secondo comma dell’art. 17, L. n. 400/1988. È quanto è accaduto, ad
esempio, a seguito dell’emanazione dell’art. 13 della L. n. 59/1997 e del successivo art. 4 D.LGS. n. 300/1999
sulla riforma dei Ministeri. Con queste norme si è introdotta, infatti, una specifica figura di regolamenti di delegificazione in materia di organizzazione amministrativa, con il deferimento stabile alle norme regolamentari
della disciplina di detta materia, senza peraltro alcuna previsione puntuale da parte della legge istitutiva delle
norme generali regolatrici della materia e di qualsiasi riferimento per l’identificazione delle norme vigenti da
abrogare, tanto da ingenerare più di qualche dubbio in ordine alla loro legittimità costituzionale. Allo stesso
modo, l’art. 20 della L. n. 59/1997 (cd. Legge Bassanini) ha previsto la presentazione, da parte del Governo,
entro il 31 gennaio di ogni anno, di un disegno di legge relativo alle materie da delegificare mediante la normazione regolamentare. (cd. legge annuale di semplificazione). In applicazione di detta norma, sono state emanate
tre diverse leggi di semplificazione ( L. n. 50/1999, L. n. 340/2000 e L. n. 229/2003), finalizzate ad una semplificazione amministrativa anche mediante il ricorso ai cd. “testi unici”, al fine di coniugare il principio di
delegificazione con il soddisfacimento delle esigenze di riordino e di armonizzazione delle fonti normative.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti sono concordi nel ritenere che alle fonti normative di “testunificazione” sia da ascrivere natura giuridica mista, posto che essi coniugano l’esercizio della potestà legislativa delegata, con l’esercizio di potestà regolamentare del Governo nella parte in cui agiscono su fonti secondarie.
In realtà lo strumento dei testi unici ha avuto vita relativamente breve: la legge di semplificazione n.
229/2003 ha superato il modello di programmazione annuale di delegificazione organizzativa annuale,
prediligendo, invece, il più tradizionale strumento di leggi annuali che conferiscano delega al Governo per
l’emanazione di decreti legislativi (cd. codici meramente legislativi) che assommino in sé disciplina sostanziale
e processuale, nonché di regolamenti ex art. 17, L. n. 400/1988 in riferimento alle norme regolamentari di
esclusiva competenza dello Stato.
3.5. Il riparto del potere regolamentare tra Stato e Regioni: il nuovo Titolo V della
Parte II della Costituzione
La materia in esame è stata oggetto di nuove riflessioni a seguito della nuova disciplina costituzionale introdotta dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha
modificato il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Difatti, il nuovo articolo
117 Cost. ha senz’altro colmato la precedente lacuna costituzionale in ordine alla
potestà regolamentare delle Regioni, incidendo contemporaneamente sulle materie
affidate alle competenze statali e regionali.
CAPITOLO III – LE FONTI
63
Ed invero, il nuovo art. 117 Cost. impone un sistema di riparto della competenza regolamentare tra Stato, Regioni ed enti locali piuttosto rigido, che esclude
in radice ogni possibilità di interferenza regolamentare dello Stato nelle materie
di competenza regionale, sia esclusiva che concorrente, nemmeno sub specie di atti
di delegificazione. Se ne desume una netta separazione tra competenze regionali e
statali: se, per un verso le prime non possono essere limitate od influenzate in alcun
modo da disposizioni statali, esse incontrano quale limite inderogabile la potestà
regolamentare statale nelle materie di sua competenza esclusiva. D’altro canto, tale
principio è espressamente stabilito dalla L. n. 131/2003 (cd. Legge La Loggia), la
quale ha espressamente attribuito potestà regolamentare allo Stato nelle sole materie
di sua competenza esclusiva.
Questa impostazione è poi stata ribadita dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato, (parere 11 aprile
2002, n. 1), la quale ha affermato che “le norme attributive di competenza regolamentare al Ministro della sanità
(attualmente Ministro della salute) in tema di professioni sanitarie (art. 6 comma 3 D.L GS. 30 dicembre 1992 n. 502)
sono divenute ineffi caci a seguito della modifi ca dell’art. 117 Cost.; infatti la norma costituzionale, nel testo modifi cato,
dispone che le materie ‘salute’ e ‘professioni’ sono oggetto di competenza concorrente, precludendo allo Stato l’intera
disciplina delle stesse materie e per giunta con fonti regolamentari”.
Analogamente, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato (parere 17 dicembre 2002, n. 5), ha sottolineato che “non è esercitabile, da parte dello Stato, la potestà regolamentare su materie non riservate, a seguito della
revisione dell’art. 117 Cost. operata con L. cost. n. 3 del 2001, alla sua competenza legislativa esclusiva e basata su
una normativa primaria anteriore alla suddetta revisione costituzionale (nella specie, i regolamenti previsti dall’art. 50
L. n. 146 del 1994 per rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari
conservati e non)”.
Tale assetto è stato poi lucidamente recepito dalla Corte costituzionale
(n. 303/2003), la quale ha confermato che la delegificazione non può trovare applicazione al di fuori di un rapporto “gerarchico”, escluso dall’assetto costituzionale,
per il quale, in materia di rapporti Stato-Regioni, opera una rigida separazione di
competenze ex art. 117, comma 6, Cost. Ne consegue che deve negarsi in radice la
possibilità che una fonte regolamentare incida sulla potestà di normazione primaria
di competenza regionale, il che, com’è evidente, sostanzia un vero e proprio sovvertimento della gerarchia delle fonti e dei principi che la presidiano: “Neppure i principi
di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea
al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario”.
Da tale rigorosa impostazione è conseguita una vera e propria “fuga” dal modello regolamentare: onde evitare censure di incostituzionalità, il legislatore è
sempre più spesso ricorso alla emanazione di figure normative ibride, la cui natura
regolamentare è stata spesso esclusa dallo stesso legislatore nelle leggi di investitura.
In ogni caso, v’è da precisare che la violazione dei principi costituzionali sin qui
descritti è causa di invalidità del regolamento emanato in contrasto con l’art. 117
Cost.: ad una prima tesi che propugna la mera annullabilità del regolamento, v’è chi
invece afferma la più radicale nullità (se non addirittura l’inesistenza), del regolamento, con la consequenziale caducazione/preclusione ex tunc di qualsivoglia effetto.
Tale principio, tuttavia, rinviene una vistosa eccezione in materia di attuazione delle direttive comunitarie ove la Regione competente al recepimento resti inerte: grava in capo allo Stato, infatti, l’obbligo di
provvedere a che la direttiva sia recepita ed attuata in modo da “entrare a far parte del diritto vivente nazionale” (Cons. St., Ad. gen., Sez. atti normativi, parere 11 novembre 2002, n. 1376). D’altro canto, onde
64
Compendio di Diritto Amministrativo
evitare che l’inerzia regionale possa tradursi di fatto in un’indebita ingerenza della potestà regolamentare
statale in materia di competenza esclusiva e concorrente, si è osservato che il recepimento regolamentare
della direttiva deve limitarsi alle previsioni normative strettamente necessarie, non potendosi sostanziare
nell’adozione di “norme di contorno” che, di fatto, si sovrapporrebbero indebitamente all’attività regolamentare regionale.
Fondamento di tale assunto è rinvenibile nell’art. 117, comma 5, Cost., che ammette la cd.
“sostituzione statale anticipata”: la norma, cioè, consente allo Stato di emanare norme sostitutive di
recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari mediante l’adozione di una legge che entra in vigore
alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione da parte della Regione, e destinata ad una vigenza temporanea, fi no a quando la Regione non adotti i provvedimenti di sua competenza. Tale meccanismo, che
evita l’esposizione del nostro Paese alle procedure comunitarie di infrazione, ha superato indenne il vaglio
della Corte costituzionale (sentenze nn. 126/1996 e 425 /1999), anche in riferimento a norme comunitarie
dettate in materia di competenza regionale esclusiva. Detto orientamento, poi cristallizzato nella riforma
costituzionale, ha trovato defi nitiva applicazione con la recente L. n. 11/2005 (cd. Legge Buttiglione), che
ha abrogato e sostituito la Legge La Pergola.
Il riconoscimento in via generale della potestà regolamentare regionale nei termini sopra riportati, ha sollevato dei problemi applicativi in ordine all’individuazione
dell’ organo titolare del relativo potere regolamentare. La nuova formulazione
dell’art. 121 Cost. ha espunto il riferimento al potere regolamentare dal novero delle
potestà del Consiglio regionale, con la conseguenza, secondo alcuni, di attribuire la
potestà regolamentare in capo alle Giunte regionali. Senonché, la Corte costituzionale ha di recente condiviso l’opposto orientamento, secondo cui l’eliminazione della
riserva consiliare non significa traslazione esclusiva ed automatica delle competenze
regolamentari in capo alle giunte, ma solo l’attribuzione della scelta in capo all’autonomia statutaria delle singole Regioni (Corte cost., nn. 324/2003 e 2/2004).
Qualche dubbio, poi, ha riguardato le tipologie dei regolamenti adottabili dalle Regioni, con particolare riferimento alla possibilità che esse adottino regolamenti indipendenti e di delegificazione. Ci si è interrogati, in particolare, circa l’ammissibilità di un potere regolamentare delegato dallo Stato alle Regioni
nelle materie rientranti nella competenza esclusiva statale, la cui attivazione è rimessa allo stesso legislatore
statale. A fronte della tesi favorevole, che ritiene che si versi, in tali ipotesi, in casi di “regolamenti regionali
indipendenti o riservati”, v’è chi ha sostenuto che una delega di funzioni esclusive dello Stato alle Regioni
frustrerebbe di fatto il criterio di riparto di cui alla Costituzione.
4. segue: La tutela giurisdizionale nei confronti dei regolamenti illegittimi
Stante l’omogeneità delle caratteristiche dogmatiche e concettuali delle fonti secondarie, le riflessioni che seguono concernono la tutela del privato avverso qualsivoglia fonte secondaria illegittima.
In prima battuta è da segnalarsi l’impossibilità che i regolamenti siano oggetto di sindacato incidentale di costituzionalità. L’art. 134 Cost., infatti, sottopone a sindacato di legittimità costituzionale le sole fonti di rango primario (leggi
e atti aventi forza di legge), con la conseguente esclusione dal novero delle fonti
suscettibili di sindacato costituzionale delle fonti secondarie, ivi compresi, quindi, i
regolamenti.
L’interpretazione strettamente letterale dell’art. 134 Cost., peraltro, è stata ribadita dalla Corte costituzionale, la quale ha più volte sottolineato che “la Consulta è il
giudice delle leggi, non della costituzionalità” (ex multis, Corte cost., 23 maggio 1985, n.
154, ed ordinanza 13 dicembre 2004 n. 389, con riferimento alla nota questione della
CAPITOLO III – LE FONTI
65
costituzionalità delle norme che prevedono l’obbligo di affissione del crocifisso nelle
aule scolastiche).
Tale rigida impostazione è stata recepita dalla giurisprudenza amministrativa: la recentissima pronuncia del
TAR Liguria Genova, Sez. II, 29 maggio 2008, n. 1149, ha sottolineato che la natura regolamentare
di un atto, in quanto tale privo di forza di legge, implica che le relative disposizioni non possono essere
sottoposte allo scrutinio di costituzionalità, ma, qualora ritenute in contrasto con norme di rango superiore, possono essere senz’altro disapplicate dal giudice amministrativo, a prescindere dall’impugnazione
congiunta del regolamento (sul tema, vedi funditus, il paragrafo 4.2).
Ne consegue, come si dirà, che i regolamenti restano soggetti al regime giuridico
degli atti amministrativi, con la conseguente possibilità di ricorrere agli istituti della
disapplicazione del g.o. o dell’annullamento del g.a. ove essi siano affetti da vizi di
legittimità.
In ogni caso, ciò non vuol dire che i regolamenti non possano essere travolti da un
giudizio di legittimità costituzionale. Tanto può accadere ove oggetto della falcidia
di costituzionalità sia la legge attributiva del potere regolamentare: è evidente, infatti,
che la censura di illegittimità costituzionale che ha ad oggetto la legge su cui si fonda
il regolamento travolgerà anche quest’ultimo, determinando un controllo indiretto
della Corte costituzionale sullo stesso.
L’art. 134 Cost., poi, non esclude che i regolamenti, possano essere sottoposti al
controllo della Corte costituzionale in sede di confl itti di attribuzione tra Stato e
Regioni, stante la loro natura di atti (anche) amministrativi (sul piano soggettivo). Il
Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. IV, n. 732/1979) ha osservato, in merito, che tale
giudizio dinanzi alla Corte costituzionale non è alternativo, quanto piuttosto integrativo di quello proposto innanzi al g.a. per violazione di legge, con la conseguenza
che, ove la Consulta respinga il confl itto di attribuzione, la questione potrà essere
sollevata dinanzi al g.a., non essendosi formato un giudicato sulla giurisdizione.
Ove il regolamento incida su posizioni di diritto soggettivo, il sindacato
sull’atto è demandabile al g.o., il quale può conoscere incidentalmente dell’atto e
deciderne la disapplicazione nel caso de quo, in conformità con quanto stabilito dagli
artt. 4 e 5 LAC (sul punto parte VII, cap. III).
Una particolare ipotesi di sindacato del g.o. sulle fonti regolamentari, attiene ai regolamenti edilizi. Essi
si sostanziano in provvedimenti a natura complessa, in quanto contemporaneamente regolamenti indipendenti, e delegati in virtù del disposto dell’art. 872 c.c., posto che essi disciplinano il quomodo dell’edificabilità
e contemporaneamente stabiliscono le modalità del procedimento per il rilascio della concessione edilizia
(oggi permesso di costruire). Orbene, ove l’autorità comunale adotti un regolamento edilizio illegittimo
per violazione delle distanze minime stabilite dal codice civile, provvedendo altresì al rilascio di una
concessione edilizia, il privato danneggiato potrà chiedere tutela innanzi al g.o., ex art. 872 c.c., con conseguente disapplicazione dei due atti e condanna della P.A. al risarcimento ed alla riduzione in pristino,
in alternativa al normale processo impugnatorio di concessione e regolamento a monte davanti al g.a. (da
ultimo Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2005, n. 1556).
4.1. segue: Il sindacato del giudice amministrativo sui regolamenti: dalla tradizione
dell’impugnazione nel termine decadenziale…
L’individuazione degli strumenti di tutela giurisdizionale azionabili dal privato innanzi al g.a. nei confronti dei regolamenti illegittimi è strettamente connesso all’individuazione dell’esatta natura della fonte regolamentare. La dottrina tradizionale,
66
Compendio di Diritto Amministrativo
invero, valorizzava la natura soggettivamente amministrativa dei regolamenti, che
evocava la giurisdizione innanzi al g.a. ed un sistema processuale schiettamente impugnatorio: ne conseguiva che il potere demolitorio del g.a. doveva, secondo questa
impostazione, essere azionato dal soggetto interessato entro gli ordinari termini
perentori di decadenza.
Tuttavia, si è osservato in merito che la vocazione normativa dei regolamenti rende assai improbabile l’impugnazione del provvedimento, posto che si tratta di un atto
quasi mai direttamente lesivo delle posizioni soggettive dei destinatari.
Sulla base di tali osservazioni, la giurisprudenza ha allora introdotto la distinzione
tra i regolamenti volizione-preliminare ed i regolamenti volizione-azione,
dovendosi riconoscere solo nei confronti di questi ultimi la possibilità di un classico
giudizio impugnatorio immediato. I primi, infatti, sono caratterizzati dai requisiti di
generalità ed astrattezza e, quindi, non realizzano un’immediata incisione della sfera
giuridica del destinatario (TAR Emilia Romagna - Parma, 8 marzo 2006, n. 95), con
la conseguente necessità di impugnazione differita, congiunta con l’atto applicativo,
questo sì, immediatamente lesivo della posizione soggettiva del privato. Ne consegue che il termine di impugnazione decorre dall’adozione dell’atto di esecuzione
regolamentare: si tratta del meccanismo della cd. doppia impugnativa, che consente di
rispettare il principio dell’attualità della lesione e della coerenza interna del gravame
(Cons. St., Sez. IV, 12 febbraio 2001 n. 663).
I regolamenti volizione-azione, invece, contengono previsioni capaci di produrre immediati effetti lesivi nella sfera del destinatario, con la conseguente assoggettabilità al normale regime impugnatorio. Ne consegue che la mancata impugnazione
del regolamento entro il termine di decadenza preclude anche l’impugnativa degli
atti applicativi per i vizi derivati dal regolamento (così Cons. St., Sez. VI, 5 aprile
2006, n. 1775).
Quanto sin qui esposto, vale a risolvere anche il problema dei regolamenti misti,
ove il provvedimento in questione assommi in sé tanto prescrizioni di carattere programmatico, quanto statuizioni immediatamente lesive: alla luce delle considerazioni
sopra riportate, infatti, è evidente che il regime impugnatorio varierà a seconda della
natura delle singole prescrizione di cui si lamenta l’illegittimità.
Il sistema di impugnativa sopra descritto implica una serie di corollari processuali la cui soluzione non
è agevole.
a) Il problema dei controinteressati
Sotto un primo profi lo, si pone il problema di individuare i soggetti controinteressati, ovvero coloro che
ricevono un beneficio dal regolamento ovvero che hanno interesse alla conservazione dell’atto applicativo,
ai quali, a mente degli art. 21, L. n. 1034/1971 e art. 36, comma 2, R.D. 1054/1924, il ricorso amministrativo deve essere notificato a pena di inammissibilità (parte VII, cap. V, sez. II, par. 1.3.).
La giurisprudenza amministrativa individua il controinteressato, sulla base della verifica di due requisiti di
segno opposto: in senso sostanziale, il controinteressato deve essere titolare di una posizione giuridica di
vantaggio attribuita dal provvedimento impugnato, e, sul crinale formale, esso deve essere specificatamente e nominativamente individuato nel provvedimento impugnato, ovvero agevolmente riconoscibile (così
Cons. St., Sez. V, 3 luglio 1995, n. 991).
Sulla base di tale rigida impostazione, invero, la giurisprudenza tradizionale ha sempre ritenuto l’insussistenza di controinteressati ai quali notificare il ricorso, sulla base della considerazione che, essendo il regolamento un atto normativo, e in quanto tale generale ed astratto, è inidoneo ad incidere su posizioni soggettive dei destinatari (ex multis Cons. St., Sez. IV, 6 giugno 1997, n. 620; Sez. V, 3 maggio 1995, n. 669).
CAPITOLO III – LE FONTI
67
Tale affermazione di principio, tuttavia, non esclude che, a fronte di specifiche prescrizioni regolamentari
che contengono statuizioni concrete (è il caso dei regolamenti volizione-azione di cui si è già detto), sia
possibile individuare dei controinteressati specifici, portatori di utilità diretta ed immediata in caso di
conservazione dell’atto impugnato (Cons. St., Sez. VI, ord. 28 settembre 2000, n. 4723). Ne consegue che,
qualora i controinteressati, ove vi siano, restino estranei alla lite, essi potranno in ogni caso ricorrere allo
strumento processuale dell’opposizione di terzo.
b) I limiti del giudicato di annullamento
Un secondo profi lo problematico in ordine all’impugnazione degli atti regolamentari inerisce all’esatta
individuazione dei limiti del giudicato di annullamento. In merito, la giurisprudenza ormai pacifica ritiene
che il giudicato formatosi sulla base della doppia impugnativa produca effetti erga omnes ed ex tunc, in deroga al principio generale per cui la sentenza fa stato solo tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, ex art.
2909 c.c. (ex multis Cons. St., Sez. IV, 23 aprile 2004, n. 2380), proprio in ragione della natura generale ed
astratta dei regolamenti, cui consegue l’efficacia erga omnes delle relative sentenze di annullamento.
Si superano in tal modo gli ontologici limiti soggettivi del giudicato, con l’estensione dei suoi effetti a soggetti estranei alla lite, in ragione dell’indeterminabilità dei destinatari degli atti normativi e del principio
d’indivisibilità degli stessi, che non consente di frazionarne il contenuto in relazione alla pluralità di atti che
ne costituiscono esecuzione. D’altro canto, tale soluzione ermeneutica risponde anche a precise esigenze di
certezza giuridica: diversamente opinando, infatti, si produrrebbe l’effetto paradossale di un’inaccettabile
applicazione “a macchia di leopardo” di un regolamento dichiarato illegittimo solo in relazione ad alcuni
dei destinatari.
Inoltre tale soluzione è corroborata dall’art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 1199/1971, che prevede che, nei casi
di annullamento degli atti normativi a seguito di ricorso straordinario, ne sia data pubblicità “nelle medesime
forme di pubblicazione degli atti annullati”.
È evidente che tale forma di pubblicità notizia trova giustificazione nell’estensione degli effetti dell’annullamento erga omnes.
Ulteriore e diverso problema è quello, inerente alla portata oggettiva del giudicato, e specificatamente
della sorte dei provvedimenti attuativi del regolamento annullato.
Nulla quaestio in caso di doppia impugnativa, ove l’annullamento del regolamento travolge senz’altro anche
l’atto di esecuzione, impugnato contestualmente.
Più controversa è, invece, la sorte degli atti applicativi adottati medio tempore e non impugnati tempestivamente. A fronte di chi sostiene che l’eliminazione del regolamento produce un effetto caducante nei
confronti dell’atto esecutivo per invalidità derivata, l’orientamento prevalente ritiene, invece, che l’annullamento del regolamento abbia un’efficacia viziante e non caducante rispetto all’atto applicativo (Cons.
St., Sez. IV, 23 ottobre 1998, n. 1376), con la conseguenza che gli effetti dell’annullamento del solo regolamento immediatamente lesivo non si propagano agli atti applicativi in ragione della loro sopraggiunta
defi nitività per decorso dei termini impugnatori. Tale conclusione, d’altra parte, è corroborata da quanto
previsto in caso di provvedimento adottato in esecuzione di legge dichiarata incostituzionale, ove la declaratoria d’illegittimità costituzionale, che pure opera ex tunc ed erga omnes, non tocca i rapporti esauriti, tra
i quali rientra l’ipotesi del provvedimento amministrativo defi nito per lo spirare del termine decadenziale
per impugnare.
c) Competenza territoriale
La natura normativa del regolamento impugnato, infi ne, produce l’ulteriore conseguenza di individuare la
competenza del TAR Lazio a conoscere delle relative controversie, in conformità con quanto stabilito
dall’art. 3, L. n. 1034/1971, a mente del quale, in presenza di provvedimenti amministrativi il cui ambito
di efficacia esorbita i limiti territoriali di una Regione, il relativo ricorso debba proporsi al Tribunale amministrativo centrale che, in applicazione delle regole processuali sulla connessione, estenderà la propria
cognizione anche all’atto puntuale contestualmente impugnato (così, da ultimo, Cons. St., Sez. V, 14
aprile 2008, n. 1614).
4.2. …alla nuova frontiera della disapplicazione
L’impostazione tradizionale basata sull’impugnazione dei regolamenti mediante
il cd. meccanismo della doppia impugnazione, fin qui esposta, è stata messo in forte
discussione da un fi lone giurisprudenziale più recente, il quale individua il mezzo di
68
Compendio di Diritto Amministrativo
tutela avverso i regolamenti illegittimi nella possibilità, per il g.a., di disapplicare atti
amministrativi illegittimi non ritualmente impugnati.
Tradizionalmente la dottrina e la giurisprudenza avevano escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della disapplicazione.
Tale conclusione, corroborata sul piano normativo dall’assenza di una previsione
ad hoc, in parallelo con quanto previsto dagli artt. 4 e 5 LAC (parte VIII, cap. IV), si
basava su un triplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, consentire la disapplicazione del regolamento illegittimo, comporterebbe l’elusione dei termini decadenziali per l’impugnazione degli atti amministrativi illegittimi; la disapplicazione, inoltre, sarebbe impedita dai principi generali
della domanda e della certezza giuridica, che impediscono al giudice di verificare
d’ufficio la ricorrenza dei vizi di legittimità del regolamento senza che questi siano
stati oggetto di specifici motivi di censura. Da ultimo, la disapplicazione d’ufficio del
regolamento illegittimo si porrebbe in aperto contrasto con l’attribuzione al g.a. del
potere di annullamento.
Va detto per inciso che l’impossibilità della disapplicazione è stata sostenuta dalla giurisprudenza tradizionale solo per il sindacato impugnatorio sugli atti nella giurisdizione di legittimità. Diversamente si è
sempre ammesso che, nell’ambito del giudizio sul rapporto relativo ai diritti soggettivi oggetto della giurisdizione esclusiva, il g.a. potesse disapplicare i regolamenti incidentalmente conosciuti. Si pensi, ad esempio, alla disapplicazione dei regolamenti emessi ex art. 24 della L. n. 241/1990,
relativi all’accesso ai documenti amministrativi, materia considerata dalla giurisprudenza prevalente un’ipotesi
di giurisdizione esclusiva, stante la qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione vantata da
chi aspira all’accesso in presenza dei presupposti legittimanti (vedi parte IV, cap. I).
A fronte di tale impostazione, la giurisprudenza più recente (a partire dalla
storica decisione della Sez. V del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1992, n. 154 di
recente recepita da TAR Liguria Genova, Sez. II, 29 maggio 2008, n. 1149)
ha superato le eccezioni propugnate dall’orientamento tradizionale, per la
verità assai deboli, concludendo nel senso dell’ammissibilità di un potere di disapplicazione in capo al g.a.
Quanto all’ assenza di una norma attributiva del potere di disapplicazione, il potere-dovere, in capo al Giudice, di decidere una controversia applicando
la fonte di rango gerarchicamente sovraordinato, deriva dal principio di
gerarchia delle fonti di cui agli artt. 1, 3 e 5 delle disposizioni preliminari
del codice civile in correlazione con il principio jura novit curia scolpito dal
codice di procedura civile. Posto infatti che i regolamenti sono una fonte del diritto,
e che quindi, ai fini delle tecniche di tutela, si deve dare prevalenza al dato sostanzialmente normativo piuttosto che alla veste formalmente amministrativa, ne deriva
che il Giudice deve risolvere il contrasto tra legge e regolamento disapplicando
il regolamento, o meglio inapplicando il regolamento, o meglio ancora
applicando direttamente la legge. Non si può neanche parlare, a rigore, di disapplicazione, concetto che postula la presenza di un atto produttivo di un effetto che si
ignora (ossia è considerato incidentalmente tamquam non esset ai sensi dell’art. 5 LAC ),
mentre nella specie il regolamento che contrasti con la legge è ab origine inidoneo ad
innovare l’ordinamento; e, quindi, è inefficace, ossia non applicabile, anche prima e
al di fuori del giudizio del caso concreto.
CAPITOLO III – LE FONTI
69
Illuminanti appaiono le parole spese dalla decisione del 1992 del Consiglio di Stato
prima citata.
“Nel conflitto tra due norme di rango diverso il Collegio non può che dare preminenza a quella legislativa, di livello
superiore rispetto a quello regolamentare. Questo in applicazione degli artt. 1, 3 e 4 delle disposizioni preliminari al
codice civile e in ossequio ai principi generali sulla gerarchia delle fonti per i quali non è consentito ad un regolamento di
esecuzione dettare disposizioni in contrasto con quelle, di carattere superiore e prevalente, contenute per la stessa materia
in un provvedimento legislativo, a meno che in questo non vi sia un’espressa previsione di deroga.
Inerisce al rapporto di sovraordinazione di una fonte ad un’altra l’idoneità dell’atto maggiore a determinare l’abrogazione
delle norme di minor forza (oltre che di quelle di pari rango) che racchiudono precetti incompatibili. Per converso, ogni
ordinamento non può non prevedere altresì un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano
e urtino contro precetti poziori dell’ordinamento medesimo.
Per l’atto avente forza di legge il meccanismo, nel nostro ordinamento, è dato dall’invalidazione a seguito di pronuncia di
incostituzionalità. Per l’atto normativo emanato dalla pubblica amministrazione il meccanismo è rappresentato, innanzi
al giudice civile e penale, dalla disapplicazione dell’atto stesso, anche se le parti non controvertono sul punto.
Ma se si tratta di un atto di normazione secondaria, e se quindi per esso possano valere criteri analoghi a quelli recepiti in
qualunque caso di concorso di norme, fra loro contrastanti pur se idonee in astratto a regolare la medesima fattispecie, deve
proporsi identica soluzione ove quell’atto (di normazione secondaria) sia in conflitto con un atto di normazione primaria
e non sia oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo.
Ne consegue che, qualora la norma primaria preesista all’atto amministrativo a contenuto normativo, questo deve essere
considerato non idoneo, a causa della maggiore forza della norma primaria, ad innovare sulle statuizioni da essa recate.
Anche nei giudizi amministrativi, quindi, l’atto regolamentare sarà inapplicabile, come qualsiasi atto legislativo altrettanto inidoneo a regolare la fattispecie.
In tal modo – senza violare i principi che informano il processo amministrativo e sulla falsa riga di quanto avviene per gli
atti di normazione primaria per mezzo del sindacato di costituzionalità – al giudice amministrativo è consentito, anche in
mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine,
in generale, ad innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa”.
Si segnala inoltre, sul tema, la recentissima pronuncia TAR Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 9 aprile 2008,
n. 526, che ha mutuato le argomentazioni logico-giuridiche fatte proprie dalla decisione del Supremo
Consesso del 1992, sposandone integralmente le conclusioni. Si riportano di seguito i passaggi più salienti
della pronuncia in parola.
“Il dedotto vizio di violazione di legge, riferito alla norma statutaria finisce sostanzialmente per assumere natura
di vizio ‘derivato’ dalla eventuale illegittimità del regolamento governativo presupposto di cui mutua il contenuto.
Reputa il Collegio che l’approdo della ‘disapplicazione’ sia in astratto senz’altro praticabile, tenuto conto degli esiti cui è
pervenuta la giurisprudenza amministrativa in materia, in base alla quale il g.a. ben può sindacare, anche in mancanza
di richiesta delle parti, gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad
innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa sul rilievo che
ogni ordinamento non può non prevedere un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano
ed urtino contro precetti poziori dell’ordinamento medesimo.
Orbene, se per l’atto avente forza di legge il meccanismo, nel nostro ordinamento, è dato dall’invalidazione a seguito di
pronuncia di incostituzionalità, per l’atto normativo emanato dalla P.A. il meccanismo è rappresentato di fronte al giudice
civile e penale dalla disapplicazione dell’atto stesso, mentre, se si tratta di atto di normazione secondaria, e se quindi per
esso possano valere criteri analoghi a quelli recepiti in qualunque caso di concorso di norme, fra loro contrastanti anche se
idonee in astratto a regolare la medesima fattispecie, deve proporsi identica soluzione ove quell’atto di normazione secondaria sia in conflitto con un atto di normazione primaria e non sia oggetto di impugnazione al giudice amministrativo.
Ne consegue che, qualora la norma primaria preesista all’atto amministrativo a contenuto normativo, questo deve essere
considerato non idoneo, a causa della maggior forza della norma primaria, ad innovare sulle statuizione da essa recate.
Anche nei giudizi amministrativi, quindi, l’atto regolamentare sarà inapplicabile, come qualsiasi atto legislativo inidoneo
a regolare la fattispecie.
Nel caso, in particolare, di provvedimento applicativo di regolamento illegittimo (rapporto di ‘simpatia’), la disapplicazione (rectius, la constatazione dell’effetto invalidante) della fonte secondaria conduce in linea retta, pur in assenza
d’impugnazione rituale del regolamento cd. volizione-azione, al riscontro della trasmissione del vizio nei riguardi del
provvedimento a valle e, in definitiva, all’accoglimento del ricorso (cfr Cons. St., Sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2183; da
ultimo, Cons. St., Sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 123)”.
70
Compendio di Diritto Amministrativo
Non sussiste, poi, alcun rischio di elusione dei termini decadenziali:
attraverso la disapplicazione, infatti, il ricorrente non ottiene l’utilità equivalente a
quella che sarebbe derivata da un’impugnativa tempestiva, con una sorta di “rimessione in termini” della stessa.
Di nessun pregio appare poi l’osservazione in merito all’incompatibilità della disapplicazione con il principio della domanda, stante il carattere
essenzialmente normativo delle fonti regolamentari. Proprio in ragione della natura normativa degli atti in parola, invece, devono trovare applicazione i principi
fondamentali, ricavabili dalle preleggi, iura novit curia e di gerarchia delle fonti, con
la conseguente devoluzione al giudice della cognizione ufficiosa dell’intero quadro
normativo, indipendentemente dalla prospettazione fattane dalla parte nel ricorso,
dando applicazione alla fonte gerarchicamente sopraordinata e disapplicando d’ufficio quella sottordinata contrastante con la prima.
Una spinta verso la generale ammissibilità della disapplicazione dei regolamenti, da
ultimo, deriva anche dal diritto comunitario: il principio di primazia di quest’ultimo, infatti, impone al giudice nazionale di disapplicare la norma interna -di qualsiasi
rango essa sia- contrastante con quella comunitaria.
Ormai aperta la strada alla disapplicazione dei regolamenti, la riflessione dottrinaria e giurisprudenziale si
è concentrata sul piano applicativo.
Si discute, in primo luogo, sulla natura del vizio da cui sarebbe affetto il regolamento contrastante con
la legge: a fronte di chi ritiene che si versi in un’ipotesi di nullità (rilevabile quindi d’ufficio: in questo
senso Cass. civ., Sez. trib., 10 giugno 2008, n. 15285) per carenza di potere, altri ritengono che il
provvedimento sia affetto da mera illegittimità. Nello specifico, secondo una parte della dottrina, solo a
fronte di vizi sostanziali del regolamento sarebbe possibile procedere alla disapplicazione, con conseguente
inammissibilità della cognizione incidentale e necessità dell’impugnazione del regolamento nel caso di vizio procedimentale. A tale distinzione si controbatte che il contrasto del regolamento con norme primarie
non può essere disciplinato diversamente a seconda del tipo di violazione, venendo comunque in rilievo il
principio della gerarchia delle fonti.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che la disapplicazione opera in maniera diversa a seconda che sia
in bonam partem od in malam partem. Si distingue, infatti, la disapplicazione dell’atto applicativo in
contrasto con il regolamento illegittimo (cd. “rapporto di antipatia”) dall’invalidazione dello stesso, ove
il provvedimento di esecuzione mutui il vizio del regolamento (cd. “rapporto di simpatia”). Orbene, la
disapplicazione vera e propria riguarderebbe solo i rapporti di antipatia tra regolamento e atto applicativo,
in quanto il g.a., accertata la conformità a legge del secondo, per il principio di gerarchia delle fonti, darà
applicazione alla legge disapplicando il regolamento. Al contrario, ove il provvedimento mutui il vizio
del regolamento contrastante con la legge, il g.a., ai fi ni della decisione, non disapplicherà il regolamento,
verificandone invece l’attitudine ad invalidare il provvedimento a valle.
Ulteriori problemi sorgono poi in merito al rapporto tra lo strumento della disapplicazione e la
tecnica dell’annullamento mediante il meccanismo della doppia impugnativa. V’è, infatti, chi
ritiene che la disapplicazione sia uno strumento alternativo all’annullamento del regolamento illegittimo,
posto che la caducazione della fonte regolamentare è maggiormente satisfattoria, in quanto esclude alla
radice la reiterazione di nuovi atti attuativi ( TAR Lecce, Sez. I, 25 ottobre 2004, n. 7452). L’opposto orientamento ritiene, invece, sulla base della natura normativa dell’atto, che la disapplicazione del regolamento
costituisca l’unico strumento a disposizione del privato: attribuire al g.a. una cognizione diretta sull’atto
normativo illegittimo, invero, significherebbe riconoscere in capo a quest’ultimo il potere di espungere una
fonte normativa dall’ordinamento giuridico.
Quanto ai limiti della disapplicazione delle norme regolamentari, la giurisprudenza amministrativa
(Cons. St., Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3561) ha precisato che al g.a. è consentito disapplicare, ai fi ni
della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento
qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario cui dovrebbe
CAPITOLO III – LE FONTI
71
dare esecuzione. Ma non quando si trova dinanzi a disposizioni regolamentari che vanno soltanto praeter
legem, limitandosi a precisare l’ambito di operatività della normativa primaria, sempre nell’ottica e nella
prospettiva di una valorizzazione dei principi informatori della medesima.
4.3. Il problema della disapplicazione degli atti amministrativi generali: i bandi di gara
e di concorso
I principi sin qui affermati dall’orientamento giurisprudenziale favorevole alla disapplicazione, hanno indotto parte della dottrina e della giurisprudenza ad interrogarsi sulla possibilità di estendere i risultati ermeneutici cui è pervenuto il Consiglio
di Stato in merito ai regolamenti, anche agli atti amministrativi generali, in base ad
una loro presunta caratterizzazione normativa.
Soprattutto la giurisprudenza di primo grado, invero, ha utilizzato nelle più varie
applicazioni il principio di cui si è detto, soprattutto in relazione ai bandi di gara e
di concorso, per i quali la caratterizzazione normativa sarebbe più evidente. Il tipo di
tutela giurisdizionale apprestabile nei confronti di tali atti illegittimi, invero, è una
diretta conseguenza della natura normativa o provvedimentale che si attribuisce agli
stessi.
L’orientamento tradizionale, da ultimo confermato dall’Adunanza Plenaria con
la decisione n. 1/2003, ha escluso la natura normativa dei bandi di gara e
di concorso, qualificandoli atti amministrativi generali, in quanto rivolti a soggetti determinabili solo ex post e poiché privi di contenuto normativo: essi, infatti,
mancano della capacità di innovare l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare
preventivamente le regole di svolgimento della gara o del concorso. Ne consegue,
pertanto, l’assoggettamento al normale regime impugnatorio previsto per gli atti
amministrativi (Cons. St., Sez. V, 27 ottobre 2005, n. 5992; TAR Liguria, Sez. II,
20 gennaio 2006, n. 40).
Non è quindi estensibile la disapplicazione normativa che riposa sulla qualificazione dei regolamenti come fonti del diritto e sulla loro conseguente soggezione
al principio di gerarchia ufficiosamente applicabile dal Giudice secondo il brocardo
jura novit curia. D’altronde, essendo i bandi di gara provvedimenti amministrativi che
regolano uno specifico procedimento, l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di
tutela degli affidamenti legittimi ingenerati fa sì che per essi si ponga, come per ogni
altro provvedimento che cura in concreto un determinato interesse pubblico, l’esigenza di conquistare la stabilità dell’assetto plasmato una volta inoppugnato nel termine
decadenziale. Ricorre cioè la ratio del termine decadenziale, in omaggio a pacifiche
coordinate anche di diritto comunitario. Né si può invocare la veste di lex specialis del
bando, perché una cosa è il concetto lato di funzione normativa che indubbiamente il
bando riveste nel dettare le regole della procedura; altra è invece la veste di fonte del
diritto,che, sola, giustifica la non applicabilità del regolamento contrario a legge pur
in mancanza di impugnazione (così, ex multis, TAR Abruzzo Pescara, 21 maggio
2008, n. 509; TAR Umbria Perugia, 27 dicembre 2007, n. 1037).
Restano quindi isolate le pronunce favorevoli alla disapplicazione dei bandi rese dal TAR Lombardia, Milano (vedi in particolare Sez. III, 2 aprile 1997, n. 354) e dal TAR Sardegna, Cagliari, (Sez. I, 2 agosto 2005,
n. 1725), che hanno fondato il loro decisum sulla distinzione tra disapplicazione normativa e provvedimentale: la seconda va riferita a singoli atti non normativi incidenti su diritti soggettivi, mentre la prima
72
Compendio di Diritto Amministrativo
prescinde dalle posizioni soggettive incise e implica la rivelabilità d’ufficio dell’esistenza di un atto normativo in contrasto con una superiore disposizione di legge. Ne consegue che la natura latamente normativa degli
atti in parola comporta l’operatività della prima tipologia di disapplicazione, con la conseguente possibilità
che essa venga disposta anche in carenza di precetti immediatamente lesivi di uni diritto soggettivo.
In realtà tale soluzione, seppur non manchi di coerenza interna, non risolve il problema principale e logicamente presupposto della natura degli atti amministrativi generali.
Non appare infatti condivisibile, come affermato in precedenza, l’affermazione della natura normativa
del bando di gara in virtù della sua asserita funzione di lex specialis quale fonte della disciplina di gara
previamente determinata, indifferentemente applicabile alla generalità dei concorrenti non ancora specificatamente individuati. Non è infatti sufficiente ricavare la natura normativa dei bandi dal loro contenuto
precettivo, posto che essa deve necessariamente accompagnarsi all’innovatività, requisito imprescindibile,
come si è detto, di tutte le fonti normative, anche secondarie. Gli atti in parola appaiono invece privi
della capacità di innovare l’ordinamento giuridico. Ne consegue la natura sostanzialmente e formalmente amministrativa dei bandi di gara e di concorso: essi, pertanto, non possono non soggiacere al
principio generale in tema di perentorietà del termine d’impugnazione. Alla luce di tali considerazioni,
quindi, è evidente che la disapplicazione (provvedimentale e non normativa) è possibile, ex art. 5 LAC, solo
da parte del g.o. ovvero, ove si verta in tema di diritti soggettivi, ad opera del g.a. in sede di giurisdizione
esclusiva.
Lo stesso è a dirsi anche in caso di bandi violativi del diritto comunitario, specie se si considera che
anche in ambito comunitario è fortemente avvertita l’esigenza di far conseguire agli atti delle istituzioni
comunitarie non impugnati un assetto stabile. L’assunto è confermato come regola generale dalla Corte
di giustizia, che con la sentenza 27 febbraio 2003 resa nel procedimento C-327/00, la quale peraltro, con riguardo al caso di specie, ha soggiunto che “la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/
CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), come modifi cata dalla direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi),
deve essere interpretata nel senso che essa – una volta accertato che un’autorità aggiudicatrice con il suo comportamento
ha reso impossibile o eccessivamente diffi cile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario a un
cittadino dell’Unione leso da una decisione di tale autorità – impone ai giudici nazionali competenti l’obbligo di dichiarare
ricevibili i motivi di diritto basati sull’incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di
un’impugnazione proposta contro la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla possibilità prevista dal diritto nazionale di
disapplicare le norme nazionali di decadenza in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non
è più possibile invocare una tale incompatibilità”. La Corte, pertanto, bypassa il problema della disapplicazione
dei bandi anticomunitari, stabilendo la disapplicazione della normativa nazionale sul termine decadenziale
per l’impugnazione, ove esso non consenta al giudice nazionale di conoscere l’incompatibilità del bando
di gara con il diritto comunitario.
Esclusa la disapplicazione, resta da valutare da quando decorra il termine per l’impugnazione dei bandi.
Nel caso in cui il bando contenga prescrizioni immediatamente lesive
(si pensi, in particolare alle clausole che richiedano requisiti di partecipazione sicuramente non posseduti dall’aspirante, tali da precludere ex ante la favorevole presentazione della domanda), le clausole devono essere oggetto di tempestiva ed autonoma
impugnazione, con la conseguenza che, decorsi i termini di impugnazione (ossia il
termine di decadenza di 60 giorni a far tempo dalla conoscenza/conoscibilità del
bando, di regola acquisita a con la pubblicazione dello stesso di norma sulla Gazzetta
Ufficiale), le prescrizioni del bando si consolidano, determinando, per l’effetto, la
non impugnabilità dell’atto applicativo di esclusione e l’immodificabilità della disciplina di gara da parte della P.A.
Va infatti rammentato che il bando, recando una lex specialis, costituisce un autovincolo non modificabile e, men meno, disapplicabile da parte della P.A. nel corso
CAPITOLO III – LE FONTI
73
della procedura. La P.A. che si avveda della sua illegittimità può annullarlo in autotutela al fine di ripetere in via integrale la procedura e non certo ignorarlo od alterarlo,
cambiando le regole del gioco quando esso è in corso.
Non è quindi condivisibile quella corrente di pensiero che, esclude l’immediata capacità del bando, in
quanto atto generale che concerne destinatari a priori non determinabili, di ledere gli interessi dei partecipanti alla gara (o al concorso) fi no all’identificazione dei soggetti esclusi, anche alla luce del rilievo che
la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, potrebbe non applicare le clausole illegittime ovvero
applicarle in senso conforme alla norma violata di rango superiore. Tale orientamento non è stato avallato
dall’Adunanza Plenaria, la quale, con l’ordinanza 4 dicembre 1998, n. 1, ha ribadito la necessità dell’immediata impugnazione delle clausole del bando direttamente lesive, osservando che con l’adozione del bando
l’amministrazione consuma la propria discrezionalità: ne consegue che la P.A. non può disapplicare una
disposizione illegittima del bando, ma può al massimo rimuoverla in via di autotutela (così anche Cons. St.,
Ad. plen., 24 gennaio 2001, n. 1).
Al contrario, per le clausole non immediatamente lesive, quali quelle relative
alla composizione della commissione, alle regole procedurali ed ai criteri di valutazione, è invece necessaria l’impugnazione congiunta dell’atto applicativo in
senso lesivo (l’esclusione dalla gara o l’esito di essa non favorevole) e della prescrizione del bando che si assume illegittima: in tali ipotesi, infatti, la lesione per il privato si concretizza nel momento in cui la P.A., facendo applicazione dei criteri fissati
nel bando, escluda o non dichiari vincitrice una determinata impresa (così Cons. St.,
Sez. V, 16 marzo 2005, n. 1079; Cons. St., Sez. V, 7 dicembre 2005, n. 6991).
Il discrimen è quindi dato dalla natura immediatamente lesiva o meno della clausola contestata. Sul punto
vi è chi ha tentato di allargare il novero delle clausole immediatamente lesive, necessitanti, a
pena di decadenza, di impugnazione immediata. Nello specifico, sono state considerate immediatamente lesive le clausole che fissano i criteri di aggiudicazione dell’appalto in modo distorto e lesivo della
concorrenza, influendo sulla proposta economica o tecnica racchiusa nell’offerta e rendendo impossibile la
stessa valutazione in ordine all’opportunità di partecipare alla gara pubblica.
Alla luce di tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto immediatamente lesiva, e quindi immediatamente
impugnabile, la clausola del bando di gara che fi ssa i criteri di determinazione della soglia di anomalia delle
offerte, poiché loro tramite la P.A. autolimita la propria libertà di apprezzamento.
Ad analoghe conclusioni si è poi giunti in merito alle clausole del bando di gara che impongono, a pena di
esclusione, determinati oneri formali per la presentazione dell’offerta (Consiglio n. 2884/2000), ovvero in
relazione alle clausole del bando relative al modus operandi fi ssato per il funzionamento della commissione
giudicatrice. Tali orientamenti, ancora in corso di formazione e di consolidamento, sono per la verità stati
oggetto di critiche assai aspre da parte della dottrina, la quale ha osservato come l’estensione dell’onere di
impugnazione a clausole che non implicano necessariamente l’esclusione o la perdita della gara, fi nisce per
stravolgere gli stessi requisiti di legittimazione a ricorrere e di giudizio amministrativo, che in tal modo
si traduce in un mero giudizio oggettivo sulla legittimità dell’atto a prescindere dalla sua connotazione
effettivamente lesiva degli interessi sostanziali del ricorrente.
La ricordata decisione n. 1/2003 della Plenaria ha battuto in breccia tale tesi, assumendo, quale parametro
fondamentale ai fi ni dell’indagine in questione, l’interesse processuale a ricorrere. Questo consente di
esperire il ricorso giurisdizionale solo ove sussista un interesse ad agire: ne consegue che i bandi di gara e
di concorso vanno impugnati immediatamente solo ove con certezza impediscano l’esito favorevole della
procedura; ciò che, in linea di massima, accade solo con le clausole espulsive che richiedano requisiti non
posseduti dall’interessato (cfr. da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, 4 febbraio 2008, n. 940; TAR Friuli 25
febbraio 2008, n. 126).
Sul piano processuale va poi rammentato che, secondo la prevalente giurisprudenza: a) ai fi ni della legittimazione all’impugnazione del bando di gara è necessaria la presentazione di domanda di partecipazione, che vale a qualificare e differenziare l’interesse del ricorrente, così distinguendolo dal quisque de
populo (anche se c’è chi dubita della coerenza di tale fattore di necessaria qualificazione quando si contesti
74
Compendio di Diritto Amministrativo
una clausola escludente, non essendo logico imporre l’onere di presentare una domanda di ammissione
quando sia certo che essa incontrerà l’esclusione): così Cons. St., Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655; Sez.
V, 25 agosto 2008, n. 4059, ha reputato che sono ipotizzabili taluni casi eccezionali in cui la partecipazione alla gara non costituisce requisito di legittimazione, ossia i casi in cui il ricorrente lamenta proprio
la violazione delle regole di pubblicità del bando, tali da impedire la partecipazione, oppure del caso in cui
l’interessato contesti, in radice, la stessa decisione dell’amministrazione di indire la gara o, infi ne, si contesti una clausola che impedisce la partecipazione di determinate categorie di soggetti; b) l’impugnazione
del bando, ove non connessa all’aggiudicazione defi nitiva o all’atto conclusivo del concorso, non conosce
controinteressati (vedi parte IV, cap. V), visto che la mera chance di aggiudicazione non è sufficiente a
radicare una posizione di controinteresse che si acquisisce solo con l’esito positivo della gara (pur se chi
scrive ha piena consapevolezza dell’insegnamento della giurisprudenza civile in tema di colpa medica e di
procedure concorsuali nel settore privato, in base al quale la chance è in sé un bene, con la conseguenza che
i partecipanti, ove siano identificabili con certezza, assumono la veste di contraddittori necessari); c) infi ne
l’annullamento del bando implica la caducazione automatica degli atti successivi, anche se
questi non siano impugnati, visto che il bando integra per l’amministrazione, come sopra rammentato,
un vincolo assoluto rispetto al quale gli atti conseguenti si pongono in una logica di vincolata e passiva
attuazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4053, secondo cui un diverso principio opera in
caso di ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, che diventa inammissibile in caso di mancata impugnazione dell’aggiudicazione defi niva, posto che tale ultimo atto non va
considerato atto meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando recepisca i
risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli
interessi pubblici sottostanti; cfr. TAR Lazio, Sez. I, n. 3313/2008).
5. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali
Gli statuti degli enti locali si sostanziano in un atto normativo avente ad oggetto
l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della sua attività. Essi sono autostatuti, in quanto emanati dallo stesso ente destinatario, a differenza degli eterostatuti,
approvati da un soggetto diverso dall’ente destinatario.
Le norme in parola sono consacrate a livello costituzionale dagli artt. 5 e 114,
comma 2, Cost., i quali sanciscono l’autonomia degli enti locali, dotandoli di propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Limite all’esplicazione di tale autonomia è costituito dall’art. 117 Cost., il quale, nel ripartire la
competenza legislativa tra Stato e Regioni, attribuisce alla competenza esclusiva dello
Stato la materia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
dei Comuni, Province e Città metropolitane”.
A livello di legge ordinaria, invece, l’art. 4 della L. n. 142/1990, modificato dall’art.
1 della L. n. 265/1999 e poi confluito nel testo unico delle autonomie locali 18 agosto
2000, n. 267 (art. 6), e l’art. 4, commi 1 e 2, Legge La Loggia n. 131/2003 (di attuazione dell’art. 114, comma 2, Cost., novellato dalla Legge costituzionale n. 3/2001),
affermano a chiare lettere la potestà normativa statutaria degli enti locali.
La natura normativa degli atti in questione è indubbia: non è invece altrettanto pacifica la loro collocazione
nella gerarchia delle fonti. Ed invero, secondo la tesi prevalente, gli statuti degli enti locali si collocano
tra le fonti secondarie, nonostante il maggior grado di autonomia di cui godono rispetto alle altre fonti subprimarie. A tal proposito, le Sezioni unite della Suprema Corte (sent. 16 giugno 2005, n. 12868) hanno
infatti osservato che “nel nuovo quadro costituzionale lo statuto si configura come atto formalmente amministrativo, ma
sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifi che, di rango paraprimario o subprimario, posto in
posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto
a fi ssare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da
svilupparsi in sede regolamentare”.
CAPITOLO III – LE FONTI
75
Di diverso avviso è invece la dottrina, la quale, proprio in ragione della particolare ampiezza della sfera di
autonomia degli statuti e della loro esplicita copertura costituzionale, annoverano tali atti tra le fonti subprimarie: ne consegue, pertanto, che non vi è alcuna “subordinazione gerarchica” tra leggi ordinaria e statuti,
configurandosi invece un “riparto di competenze” analogo a quello che, ex art. 117 Cost., riguarda il rapporto tra leggi regionali e norme statali (così Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 2 marzo 2006, n. 69).
Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, il carattere generale ed astratto delle norme statutarie rende assai
difficile la loro impugnabilità diretta, in quanto, in linea di principio, è assai raro che esse possano incidere
in via diretta ed immediata la sfera del singolo. Ne consegue la necessità della cd. “doppia impugnativa”,
ovvero la necessaria impugnazione congiunta di statuto e provvedimento amministrativo lesivo che vi dà
attuazione, secondo il meccanismo di cui si è già dato ampiamente conto (cfr. par. 5.2.).
L’art. 4, L. n. 131/2003 (cd. Legge La Loggia) stabilisce che i regolamenti degli
enti locali debbano occuparsi dell’organizzazione dell’ente, nonché della disciplina
dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni attribuite ai
Comuni ai sensi dell’art. 118 cost. Gli atti in questione dovranno ispirarsi ai principi
contenuti nelle leggi statali e regionali vigenti, al fine di assicurare requisiti minimi
di uniformità.
6. Le ordinanze di necessità ed urgenza
L’istituto dell’ordinanza ha una connotazione assai ampia, poiché in tale categoria
vengono ricompresi tutti quegli atti che creano obblighi o divieti imponendo
ordini.
Anche per le ordinanze, come per tutte le altre fonti secondarie, opera il limite
esterno del divieto di derogare alla Costituzione ed ai principi generali dell’ordinamento.
Le fonti in commento sono classificabili in:
– ordinanze previste dalle legge in campi specificamente indicati: in questa categoria rientrano, ad esempio, i provvedimenti-prezzo del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica:
– ordinanze previste dalla legge in casi eccezionali di particolare gravità, alle quali la P.A.
ricorre per fronteggiare situazioni eccezionali individuate dal legislatore, che consente in tali ipotesi di adottare qualsivoglia misura atipica;
– ordinanze di necessità ed urgenza, emanate da autorità amministrative, espressamente
investite di tale potere per far fronte a situazioni di urgente necessità (vedi art. 50,
comma 5, TUEL in riferimento alle ordinanze sindacali).
Le ordinanze di necessità e urgenza costituiscono la categoria concettuale più
diffusa e controversa: esse si sostanziano in statuizioni straordinarie, espressioni di
un potere amministrativo extra ordinem, al fine di fronteggiare situazioni di urgente
necessità nei casi previsti dalla legge (in materia di ordine e sicurezza pubblica ovvero
di sanità ed igiene pubblica).
Le ordinanze in parola, dunque, sono caratterizzate dalla atipicità ed elasticità delle
statuizioni ivi contenute, in deroga alla regola della tipicità degli atti amministrativi,
onde consentire alla P.A. il compito di valutare in concreto il contenuto del provvedimento. Tale valutazione può spingersi, ove lo preveda la norma autorizzativa,
fino a derogare alle disposizioni di legge (fermo comunque il rispetto dei precetti
costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento), ove ciò sia necessario al fi-
76
Compendio di Diritto Amministrativo
ne di fronteggiare la situazione di necessità, di carattere eccezionale, imprevedibile
ed urgente di pericolo che impone la necessità di individuare con immediatezza lo
strumento più idoneo ad affrontarlo. Naturalmente, proprio in ragione della particolare vis derogatoria degli atti in parola, essi devono essere forniti di adeguato supporto
motivazionale, che dia conto dell’interesse generale che il provvedimento presidia,
con riferimento alla fattispecie concreta in ordine ai presupposti di azione ed agli
elementi costitutivi del provvedimento.
Il legislatore non ha individuato specificatamente i casi di necessità ed urgenza in cui
la P.A. può ricorrere all’adozione di tali provvedimenti. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha provveduto a conferire significato a tali presupposti, affermando che “il
potere sindacale ex art. 50 comma 5, D.LGS. n. 267 del 2000 di adottare ordinanze contingibili
e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed
imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento,
sicché nel provvedimento d’urgenza deve essere indicata la situazione di pericolo, quale ragionevole
probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l’amministrazione non intervenga prontamente” (TAR Campania Salerno, Sez. I, 1 dicembre 2005, n. 2494). Di tale situazione
di pericolo e della necessità che essa venga immediatamente rimossa deve essere fatto
puntuale e specifico riferimento in sede di motivazione del provvedimento, altrimenti censurabile in sede di legittimità (TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 1 aprile
2008, n. 329; TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 2 aprile 2008, n. 792).
Assai controversa è la possibilità che le ordinanze in commento deroghino a norme comunitarie.
La giurisprudenza amministrativa propende per lo più per la soluzione positiva, stante la genericità della
prescrizione legislativa che consente le statuizioni in deroga delle ordinanze urgenti con il solo limite del
rispetto dei principi generali dell’ordinamento (così TAR Puglia, Sez. II, 25 febbraio 1997, n. 208). Al
contrario, la dottrina ritiene che il principio di primazia del diritto comunitario impedisca che le norme
del diritto interno possano derogare alle norme comunitarie, con la conseguente disapplicazione della
normativa interna in contrasto con le disposizioni comunitarie. Ne consegue che i principi generali dell’ordinamento sono sottordinati al principio del primato del diritto comunitario, che, quindi, non può essere
derogato da una fonte secondaria.
Proprio le caratteristiche peculiari degli atti in parola hanno indotto non pochi
dubbi in merito alla loro natura giuridica.
Secondo una prima tesi essi hanno natura normativa, stante il loro contenuto generale e astratto e la loro particolare vis derogatoria a norme di legge.
Di contrario avviso altri autori, i quali sostengono, invece, la natura formalmente e sostanzialmente amministrativa delle ordinanze in commento, sulla
base del carattere temporaneo delle statuizioni ivi contenute, le quali, in ogni caso,
non modificando le disposizioni normative vigenti in modo stabile, non producono
un effetto abrogativo idoneo ad incidere sulle fonti normative alle quali derogano
(in tal senso vedi Corte costituzionale con sentenza n. 4 del 1997, che ha affermato
l’irrilevanza dei caratteri “della generalità e dell’astrattezza ai fini della riconducibilità delle
ordinanze nell’alveo degli atti normativi, il cui tratto rivelatore è rappresentato essenzialmente
dall’idoneità a modificare in modo definitivo ed irreversibile l’ordinamento giuridico”).
La tesi maggioritaria, invece, di matrice intermedia, sostiene il carattere
generalmente amministrativo ed eccezionalmente normativo delle ordinan-
CAPITOLO III – LE FONTI
77
ze di necessità, in quanto esse, sebbene previste per risolvere un problema circoscritto, possono tuttavia dettare eccezionalmente prescrizioni che, pur temporanee,
abbiano carattere astratto, generale ed innovativo.
Naturalmente l’individuazione della natura delle ordinanze si riverbera sulle tecniche di tutela giurisdizionale azionabili dal privato. Vi è infatti chi ritiene che
l’assenza dei presupposti di necessità ed urgenza configuri una carenza di potere,
con la conseguente incardinazione della giurisdizione innanzi al giudice ordinario a
fronte della resistenza del diritto soggettivo inciso da un atto radicalmente nullo; al
contrario, invece, altri e prevalenti autori ritengono che la carenza dei presupposti
prescritti integri un’ipotesi di cattivo uso del potere, con la conseguente attribuzione
al giudice amministrativo delle relative controversie.
In ogni caso, quale che sia la tesi preferibile, il giudice adito potrà garantire la tutela risarcitoria per i danni cagionati per effetto dell’esercizio del potere di ordinanza,
stante la generale risarcibilità degli interessi legittimi a seguito della storica sentenza
della Cass., n. 500/1999 (sul tema, funditus, vedi parte V, cap. I).
7. Le fonti secondarie dubbie
Lo spettro delle fonti sopra descritte è ulteriormente arricchito, secondo un certo
orientamento dottrinario, da ulteriori provvedimenti, per i quali la natura di fonti
secondarie è assai discussa. Le principali fonti dubbie sono:
a) I bandi militari. Sono atti emanati dal Comandante Supremo delle Forze Armate
o, dietro sua delega, dai Comandanti di grandi unità terrestri, navali e aeree in
caso di stato di guerra o di emergenza internazionale dichiarata dal Parlamento ex
art. 78 Cost. Essi contengono disposizioni in deroga al diritto vigente, ed è proprio
in virtù di tale peculiarità che qualche autore li ritiene atti di normazione primaria. Tale qualificazione, tuttavia, desta numerose perplessità, soprattutto in ragione
della mancanza di una copertura costituzionale, il che, per i più, lascerebbe presupporre una tacita abrogazione degli stessi. Non manca, tuttavia, chi rinviene il
fondamento implicito di tali atti nell’art. 78 Cost., ove stabilisce che “le Camere
[…] conferiscono al governo i poteri necessari” a seguito della dichiarazione dello stato
di guerra.
b) I provvedimenti di fissazione dei prezzi e delle tariffe. L’adozione di tali provvedimenti rientra nella competenza del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e, a livello locale, agli uffici provinciali del Ministero
dell’Industria, nonché alle autorità indipendenti in settori del mercato particolarmente sensibili.
Secondo un primo orientamento, ormai superato, i provvedimenti in esame costituirebbero espressione di
scelte di carattere politico in relazione alla rilevanza sociale di certi beni e servizi (Cass., Sez. un., 1982, n.
5030), pur non sostanziandosi in atti politici in senso stretto.
V’è, invece, chi ritiene che i provvedimenti prezzo e tariffari siano atti normativi, in quanto contenenti delle
statuizioni generali ed astratte, applicabili per un certo periodo ad un numero indeterminato di destinatari ed
indefinito di casi (SANDULLI). Qualificati i provvedimenti in parola quali atti normativi, essi sono poi stati collocati variamente nella gerarchia delle fonti quali norme secondarie, sub-primarie o primarie di secondo grado.
Tuttavia, al riconoscimento della natura normativa dei provvedimenti-prezzo osta la mancanza dell’attitudine di tali atti ad innovare l’ordinamento giuridico, requisito imprescindibile ai fi ni della qualificazione
78
Compendio di Diritto Amministrativo
di una fonte come normativa. Come si è detto, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, ritengono di
tratti di atti amministrativi generali, di atti di accertamento, ovvero di atti di autorizzazione: tutti atti, in
ogni caso, di natura squisitamente amministrativa, con la conseguente soggezione alla relativa disciplina.
In ogni caso lo strumento dei provvedimenti prezzo e tariffari è destinato a trovare
un’applicazione sempre più residuale, in considerazione del difficile coordinamento con la normativa comunitaria, orientata all’eliminazione di qualsiasi ostacolo
alla libera circolazione dei beni ed all’armonizzazione dei prezzi in ambito comunitario.
c) Capitolati generali d’oneri. Si tratta di atti predisposti dalla P.A. al fine di disciplinare intere categorie di contratti (per esempio in materia di lavori pubblici), mediante la predisposizione unilaterale di clausole contrattuali per regolare in modo
uniforme il contenuto negoziale di una serie indefinita ed omogenea di futuri
contratti con identico contenuto.
Proprio in ragione della determinazione unilaterale, ad opera della P.A., la natura dei capitolati d’oneri è assai discussa. Parte della dottrina valorizza il carattere programmatico dei capitolati generali, desumendone
la natura normativa ed escludendo, pertanto, l’applicabilità dell’art. 1341 c.c. sulle condizioni generali di
contratto. Secondo una diversa impostazione, invece, posto che i capitolati generali comportano deroghe
spesso assai vistose alla disciplina civilistica in materia contrattuale, va riconosciuta loro natura negoziale
di manifestazione di autonomia privata: diversamente opinando, infatti, si consentirebbe che tale deroga
venga operata da fonti subprimarie, in palese dispregio dei principi di gerarchia del diritto.
Nonostante il riconoscimento della natura negoziale dei capitolati generali, tuttavia, la giurisprudenza è
orientata nel senso di escludere la necessità di una specifica approvazione per iscritto della clausole vessatorie ex art. 1341, comma 2 c.c., ritenendo che in caso di recepimento del capitolato generale in seno al
contratto, il contenuto di quest’ultimo sia sufficientemente determinato per relationem.
In ogni caso, in talune ipotesi, i dubbi inerenti alla natura dei capitolati generali è fugata dallo stesso legislatore, che ha provveduto a qualificare expressis verbis la natura degli atti in parola. È quanto accaduto con
l’art. 3, comma 5 della L. n. 109/1994 (cd. legge quadro sui lavori pubblici), che prevede espressamente la natura di regolamento ministeriale del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici. La natura negoziale del capitolato in parola trova invece supporto nell’art.
5, comma 7, del codice dei contatti pubblici di cui al D.L GS. n. 163/2006, secondo cui tale atto costituisce parte integrante del contratto.
d) Piani regolatori generali: disciplinati dagli artt. 7 e segg. della L. urbanistica n.
1150/1942, costituiscono lo strumento attraverso i quali l’amministrazione provvede a pianificare in via generale lo sviluppo urbanistico-edilizio del territorio
comunale. Essi constano di una struttura assai complessa, comprendente le cd.
“norme di zonizzazione”, che dividono il territorio comunale in grandi aree omogenee caratterizzate da una determinata vocazione (edificatoria, industriale, agricola ecc.) e le “norme di localizzazione” con le quali si individuano le aree destinate alla realizzazione di opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
Proprio la compresenza di queste due tipologie di norme all’interno dello stesso piano ha suscitato non pochi dubbi in ordine alla loro natura. A fronte di chi valorizza la funzione programmatico-pianificatoria del territorio mediante la predisposizione di norme generali ed astratte, qualificando i piani regolatori
come norme regolamentari, la giurisprudenza, al contrario, sostiene la natura di atti amministrativi
generali, in virtù del gran numero di prescrizioni concrete e di vincoli immediatamente efficaci.
Una posizione mediana, accolta dalla dottrina dominante nonché dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato, paventa invece la natura mista degli atti in esame, distinguendo tra clausole di carattere normativo,
contenenti prescrizioni astratte di carattere programmatico, e clausole aventi carattere provvedimentale
in quanto contenenti prescrizioni concrete e dal contenuto precettivo. Tale distinzione rileva anche ai
CAPITOLO III – LE FONTI
79
fi ni dell’individuazione dell’interesse ad impugnare in quanto nel primo caso, trattandosi di prescrizioni
normative non immediatamente lesive, esse dovranno impugnarsi congiuntamente all’atto applicativo al
contrario di quanto accade per le clausole aventi contenuto immediatamente precettivo.
e) Carte dei servizi pubblici. Rese obbligatorie dall’art. 11 del D.LGS. n. 286/1999,
esse contengono una serie di prescrizioni atte a consentire la misurazione della
qualità delle prestazioni erogate da parte degli enti gestori di pubblici servizi,
attraverso l’individuazione di standard che ne fissino il livello minimo. La loro elaborazione avviene per lo più mediante l’apporto collaborativo degli utenti;
esse, inoltre, costituiscono la fonte di obbligazioni unilaterali in capo al gestore
del servizio, in quanto causa di integrazione ab externo dei cd. contratti di utenza
pubblica. L’inosservanza di tali obblighi è sanzionata con l’obbligo per il gestore,
di corrispondere un indennizzo all’utente, determinato mediante un meccanismo
automatico e forfettario.
In riferimento alla natura delle carte dei servizi pubblici, essa assume senz’altro carattere negoziale-giuscivilistico ove sia adottata da un gestore privato del servizio, fatta salva l’ipotesi in cui l’atto in questione
sia contenuto ed inglobato nel provvedimento amministrativo di concessione.
Ove, invece, il servizio sia erogato da un ente pubblico, gli atti in questione assumono senza dubbio veste di
provvedimento amministrativo, in quanto espressione della potestà di autorganizzazione, che presidia
l’attività dell’ente pubblico anche ove esso assuma veste di e.p.e. di ispirazione privatistica (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431). A seconda del tipo di prescrizioni ivi contenute, poi, sarà possibile
ascrivere al provvedimento in parola natura amministrativa o regolamentare, a seconda che contenga
o meno statuizioni od obblighi attuabili in via immediata e diretta. Talvolta, peraltro, è la stessa legge a
qualificare la carta dei servizi pubblici quale atto regolamentare: è quanto avviene, ad esempio, ad opera
del combinato disposto dell’art. 2, comma 12, lett. g) e comma 37, della L. n. 481/1995, che individua il
regolamento di servizio quale fonte di individuazione dei livelli qualitativi garantiti.
8. Le norme interne
Le norme interne sono costituite da tutti quegli atti che tutte le amministrazioni
pubbliche emanano onde disciplinare l’organizzazione e l’azione dei propri organi ed
uffici, dando così vita ad un ordinamento giuridico “particolare”: esse si rivolgono,
cioè, soltanto a coloro che svolgono l’attività nell’ambito di quel determinato sistema,
senza assumere alcuna rilevanza nell’ordinamento giuridico generale.
Esse, dunque, sono espressione del potere di auto-organizzazione della P.A.,
che costituisce il nucleo primario ed indefettibile della natura autoritativa degli enti
pubblici (cfr. cap. I, par. 2.) e del principio generale di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. (cap. II, par. 4.).
Pur inserendosi ed operando all’interno di un ordinamento giuridico particolare,
le norme in questione assumono rilevanza giuridica generale, sia pur in via mediata e
diretta, in tutto l’ordinamento: esse, infatti, impongono ai propri destinatari di darvi
esecuzione, anche mediante l’adozione di atti rilevanti all’esterno, pena l’illegittimità, sub specie di eccesso di potere, dell’atto amministrativo esterno contrastante con le
prescrizioni interne.
Resta fermo, in ogni caso, il margine di possibilità di discostarsene riconosciuto
dalla legge: si pensi, ad esempio, all’art. 17 del D.P.R. n. 10 gennaio 1957 n. 3 ed al
D.LGS. n. 165/2001, che consentono al pubblico dipendente di discostarsi dall’ordine
contenuto in norme interne, ove questo risulti illegittimo.
80
Compendio di Diritto Amministrativo
A differenza di quanto accade per le altre norme secondarie, proprio in ragione
della mera rilevanza interna degli atti in parola, non è necessaria una copertura legislativa che abiliti alla loro emanazione. Se ne desume, quindi, la loro natura non
normativa, posto che il loro fondamento è rinvenibile nel potere di autorganizzazione
di cui si è detto in precedenza.
Le principali tipologie di norme interne sono:
a) i regolamenti interni, che disciplinano il funzionamento degli uffici;
b) gli ordini, che si sostanziano nel comando ad agire in un determinato modo, impartito da una autorità gerarchicamente superiore nei confronti di un soggetto
pubblico sottordinato;
c) le direttive che, fissano un obiettivo da perseguire, ferma restando in capo al destinatario la possibilità di operare scelte discrezionali in merito a modalità, strumenti
e tempi con cui raggiungere l’obiettivo prefissato;
d) le istruzioni, di carattere tecnico, impartite per lo più da uffici tecnici ad uffici amministrativi;
e) le circolari, di cui si dirà abbondantemente nel paragrafo successivo, che costituiscono la fattispecie più controversa di norme interne.
8.1. segue: Le circolari: caratteri generali
Nate storicamente in ambito militare per indicare il mezzo con cui gli ordini venivano trasmessi agli ufficiali subalterni dislocati al fronte, esse rappresentano senz’altro
la fattispecie più controversa di norme interne.
Molto si è discusso sulla natura delle fonti in parola: ad una prima tesi (Sandulli)
che riconosce alle circolari dignità di autonomo istituto giuridico, espressione del
potere di autorganizzazione e del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, si è contrapposta l’opinione di chi (GIANNINI) le ritiene semplici strumenti di
comunicazione, privi di dignità giuridica autonoma.
La giurisprudenza prevalente si è uniformata a tale seconda opzione ermeneutica, osservando che “esse non hanno carattere normativo, ma rappresentano lo strumento
mediante il quale l’amministrazione fornisce indicazioni in via generale ed astratta in ordine
alle modalità con cui dovranno comportarsi in futuro i propri dipendenti e i propri uffici, con la
conseguenza che rientrano nel genus degli atti interni all’amministrazione e possono avere diverso
contenuto, potendo dettare disposizioni sull’organizzazione degli uffici, dare semplice notizia di
determinazioni adottate da organi superiori, e ordini interni, o partecipazioni o diffide” (TAR
Basilicata, 28 marzo 2000, n. 197).
Il problema della qualificazione giuridica degli atti in parola, in ogni caso, si pone
in termini assai diversi ove sia la legge a rinviare esplicitamente alla circolare; secondo la tesi preferibile, infatti, la circolare, recependo la volontà del legislatore, acquisterebbe efficacia legislativa assurgendo al rango di legge di attuazione.
In ogni caso, anche le circolari, come le altre norme interne, possono assumere
una rilevanza esterna mediata ed indiretta, ove esse siano oggetto di applicazione mediante atti amministrativi, con la conseguente censurabilità, sub specie di
eccesso di potere, degli atti difformi. Tanto è stato ribadito da Cons. St., Ad. plen.,
30 novembre 1979, n. 29, che ha sottolineato che “le circolari quali atti meramente interni
dell’amministrazione, diretti ad indirizzare l’azione degli organi subordinati secondo criteri di
CAPITOLO III – LE FONTI
81
uniformità, sono inidonee ad apportare direttamente vincoli o vantaggi a terzi o a disciplinare
i rapporti con l’amministrazione qualora non siano riprodotte o recepite in atti amministrativi
emanati a tal fine”.
In ogni caso, stante la massiccia diffusione degli atti in parola, l’art. 26 della L. 7
agosto 1990, n. 241, prevede la pubblicazione delle circolari, secondo le modalità contemplate dai singoli ordinamenti, unitamente a tutti gli atti organizzativi delle P.A.
Le tipologie di circolari individuate dalla giurisprudenza sono assai numerose: tra
le tante, si ricordano quelle di più frequente applicazione pratica:
a) Circolari organizzative, che disciplinano il funzionamento burocratico e organizzativo degli uffici.
b) Circolari interpretative, che, al fine di un’applicazione uniforme di leggi e regolamenti ne forniscono un’indicazione esegetica. Esse, pertanto, sono prive di efficacia vincolante, “limitandosi a riproporre il contenuto precettivo di atti normativi in vigore,
non sussistendo di conseguenza interesse a ricorrere contro la medesima” (TAR Lombardia Milano, Sez. I, 23 gennaio 2008, n. 126);
c) Circolari normative, attraverso cui gli organi sovraordinati dettano norme di comportamento agli uffici sottordinati nell’esercizio delle loro attività;
d) Circolari di cortesia, prive di rilevanza giuridica, contenenti auguri, saluti, attestati di
stima;
e) Circolari informative, con un contenuto informativo circa determinati accadimenti
reputati utili ai fini dell’esercizio dell’attività amministrativa dei destinatari;
f ) Circolari regolamento, particolari figure di circolari eccezionalmente idonee a produrre effetti
normativi esterni. In realtà, in ossequio al principio di indifferenza del nomen degli
atti (cfr. parte IV, cap. IV), si tratta di norme sostanzialmente regolamentari, caratterizzate dai requisiti della generalità, dell’astrattezza e dell’innovatività propri degli
atti normativi. Esse, pertanto, andranno convertite in regolamenti ove siano presenti i requisiti formali, procedimentali e sostanziali prescritti dalla L. n. 400/1988; in
mancanza andranno considerati quali regolamenti nulli, inesistenti o illegittimi;
g) Circolari interorganiche, rivolte, cioè, ad organi ed uffici dello stesso plesso amministrativo;
e) Circolari intersoggettive, dirette all’esterno dell’organizzazione amministrativa da cui
provengono, onde favorire il coordinamento di enti deputati alla tutela di interessi
identici, omogenei o collegati. Esse sono comunque, per la dottrina prevalente,
prive di efficacia vincolante, stante l’insussistenza in capo all’autorità emanante del
potere di supremazia cui le circolari normative sono riconducibili.
8.1.1. segue: L’impugnazione delle circolari
La rilevanza esterna mediata delle circolari implica il problema della verifica delle modalità di impugnazione delle circolari.
Nulla quaestio ove la circolare – e il relativo atto applicativo – incida su diritti soggettivi, posto che in tali
casi il g.o. può valutare la fondatezza della pretesa attraverso la cognizione incidentale degli atti emanati
dalla P.A. e procedere, eventualmente, alla loro disapplicazione.
Ove la circolare incida su interessi legittimi, invece, si pone il problema della sua diretta ed autonoma
impugnazione.
In linea di principio, invero, è da escludersi l’impugnabilità diretta dell’atto in questione, stante
il suo carattere non vincolante; maggiori perplessità, invece, riguardano la necessità che l’impugnazione
82
Compendio di Diritto Amministrativo
riguardi congiuntamente la circolare e l’atto attuativo (secondo il meccanismo della doppia impugnativa)
o solo quest’ultimo.
Secondo un primo orientamento, l’impugnazione deve riguardare il solo atto applicativo proprio in ragione della non vincolatività della circolare, inidonea perciò ad incidere direttamente sulle posizioni soggettive. Ne consegue che il giudice amministrativo può conoscere solo incidentalmente della circolare, al fi ne di appurare la conformità alla stessa dell’atto amministrativo applicativo, con la conseguente
possibilità di disapplicarla ove risultasse illegittima (così Cons. St., Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2768; TAR
Puglia, Sez. I, 9 luglio 2003, n. 2790; Cons. St., Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 421).
Per la giurisprudenza maggioritaria, invece, l’impugnazione della circolare congiuntamente
all’atto applicativo non è inammissibile, anche se non necessaria, analogamente alla doppia impugnazione prevista in materia regolamentare. L’orientamento in parola, invero, riconosce al privato
la facoltà di decidere se impugnare il solo atto applicativo o anche la circolare (Cons. St., Sez. IV, 16 ottobre
2000, n. 5506): in quest’ultimo caso, essendo generalmente la circolare emanata da un organo di vertice in
sede centrale, si verifica uno spostamento della competenza dal TAR periferico al TAR centrale (Lazio).
Da ultimo, è bene sottolineare che tali principi non trovano applicazione in caso di circolari-regolamento,
dovendosi, in tali ipotesi, verificale l’immediata idoneità lesiva dell’atto: in tal caso, infatti, graverà in capo
al privato un onere di immediata ed autonoma impugnazione della circolare. Tale principio, poi, è stato
ritenuto valido dalla giurisprudenza ogni qualvolta le circolari contengano disposizioni riguardo a situazioni che involgono l’interesse di soggetti estranei all’organizzazione amministrativa (Cons. St., Sez. VI, n.
632/198 e Cons. St., Sez. VI, n. 210/1984. Da ultimo, poi, cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 11 settembre 2007, n. 7481, il quale ha stabilito che “la circolare che disciplini le modalità di effettuazione degli esami di guida
presso le autoscuole non si rivolge agli uffi ci dell’amministrazione dei trasporti ma anche e necessariamente alle autoscuole
autorizzate, almeno per quanto attiene lo svolgimento delle sedute di esame esterne. Pertanto, se è vero che non sussiste
l’onere di impugnazione di una circolare avente natura meramente interpretativa di una disposizione di legge, quale atto
interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, ad opposte conclusioni si deve
giungere quando essa invece abbia effetti esterni, ancorché circoscritti ad una determinata cerchia di soggetti, e possa essere
quindi configurata come atto presupposto del provvedimento ritenuto lesivo, che ne ha fatto puntuale applicazione”).
9. Le consuetudini
Per consuetudine deve intendersi la ripetizione di un comportamento costante ed
uniforme per un certo periodo di tempo da parte di una generalità di persone (cd.
diuturnitas), con la convinzione di ottemperare ad una prescrizione giuridica (cd.
opinio iuris ac necessitatis).
La ripetizione del comportamento deve essere generale (ovvero tenuto
dalla maggior parte della collettività), uniforme (il comportamento deve essere tenuto in modo identico o simile), costante (ovvero la condotta deve essere attuata
sempre nelle medesime situazioni cui essa si ascrive).
Orbene, sono da considerare nel novero delle fonti del diritto amministrativo la
consuetudine praeter legem, che attiene a materie non disciplinate dalla legge, e la consuetudine secundum legem, che ha efficacia soltanto se espressamente richiamata dalla
legge. Restano invece escluse dalle fonti del diritto – anche amministrativo – la
consuetudine contra legem, che implica comportamenti contrari alle norme di legge, in
quanto, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. c.c., le leggi possono essere abrogate solamente
da altre leggi posteriori, e la desuetudine, ossia l’abrogazione di una norma in base
alla convenzione di non applicarla, dal momento che una norma non può essere mai
abrogata in conseguenza della sua non applicazione.
L’esistenza della consuetudine implica necessariamente entrambi gli elementi (opinio e diuturnitas): per tale ragione non costituisce fonte del diritto amministrativo la
prassi amministrativa, in quanto in essa, pur configurandosi un comportamento
CAPITOLO III – LE FONTI
83
costantemente tenuto, manca tuttavia la convinzione della sua obbligatorietà. Essa,
tutt’al più, può costituire un utile punto di riferimento per le scelte discrezionali che
l’organo amministrativo deve effettuare, ma non ha valore vincolante, né carattere
innovativo per l’ordinamento giuridico.
Tuttavia, la prassi non deve essere considerata un fatto puramente materiale, poiché essa può ben costituire fonte del cd. “principio dell’affidamento”: la reiterazione
di una dato comportamento, pur in mancanza della convinzione della sua obbligatorietà, è senz’altro idonea ad ingenerare la buona fede dei cittadini, che confidano nel
dovere di coerenza della P.A., in virtù del quale essa deve provvedere a soddisfare gli
interessi pubblici mediante un’azione coerente, uniforme e costante nel tempo. Per
l’approfondimento del principio dell’affidamento si rinvia al capitolo II, par. 5.1.
CAPITOLO IV
IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SOMMARIO : 1. Premessa. – 2. L’evoluzione del sistema della giustizia amministrativa. – 3. La tutela in sede amministrativa e quella in sede giurisdizionale. – 4. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo. – 5. Le azioni esperibili dal privato nei confronti della P.A.
1. Premessa
Lo studio del diritto amministrativo non può prescindere dalla conoscenza dell’evoluzione del sistema della giustizia amministrativa (sul quale vedi amplius la parte VIII).
La nozione di “giustizia amministrativa” è dotata di due accezioni. Una prima più ampia abbraccia tutti gli strumenti previsti dal legislatore per assicurare la
conformità all’ordinamento dell’azione amministrativa (tutela giurisdizionale, ricorsi
amministrativi, autotutela, controlli amministrativi et coetera). È un’accezione questa
che risente dell’impostazione tradizionale (cd. concezione oggettiva) secondo la
quale, la giustizia amministrativa persegue l’interesse generale all’osservanza dei limiti posti all’azione amministrativa.
Un’accezione più ristretta (cd. concezione soggettiva), che ha poi trovato
conforto negli artt. 24 e 113 Cost., pone, invece, l’accento sulla tutela delle posizioni
giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo vantate nei confronti della
P.A. Da ciò consegue un ambito più ridotto degli istituti riconducibili nella nozione
in esame, in quanto strumenti deputati ad assicurare tutela alle posizioni giuridiche
dei cittadini: a) la tutela giurisdizionale erogabile in sede di giurisdizione amministrativa generale dai TAR e dal Consiglio di Stato ed in sede di giurisdizioni
amministrative speciali dalla Corte dei conti, dal Tribunale delle acque, dalle commissioni tributarie; b) i ricorsi amministrativi, ossia il ricorso gerarchico proprio
ed improprio, il ricorso in opposizione, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Soltanto attraverso lo studio del lungo e complesso processo di sviluppo del sistema della giustizia amministrativa è possibile decifrare gli esatti contorni del rapporto
che lega il privato alla pubblica amministrazione, onde verificare entro quali termini
l’ordinamento concede tutela al primo nei confronti della seconda. In questa sede
verranno scrutinati i principali caratteri del sistema della giustizia amministrativa.
2. L’evoluzione del sistema della giustizia amministrativa
La genesi della giustizia amministrativa consente di eleggere i cosiddetti rimedi
amministrativi al ruolo di primi strumenti di difesa accordati alle pretese dei citta-
86
Compendio di Diritto Amministrativo
dini di fronte allo Stato: attraverso detti rimedi (i cui eredi sono oggi il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio, l’opposizione e il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica), il privato aveva la possibilità di rivolgersi direttamente
alla pubblica amministrazione per ottenere dalla stessa la decisione su una determinata
controversia o il riesame di provvedimenti ritenuti non conformi alla legge.
All’indomani dell’emanazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (L. n. 2248/1865, All. E, cd. LAC ), infatti, il legislatore del “nuovo” Stato italiano
aveva devoluto al giudice ordinario tutte le controversie nelle quali si facesse “questione di un diritto civile o politico, comunque [vi fosse] interessata la pubblica amministrazione,
ancorché [venissero] emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell’autorità amministrativa”
(art. 2).
Viceversa, la tutela degli altri “affari non compresi” nell’art. 2 veniva devoluta alle
amministrazioni, nei confronti delle quali i privati avrebbero potuto rivolgere i propri ricorsi amministrativi (art. 3).
Rispetto all’esperienza preunitaria, dunque, il sistema di giustizia amministrativa
delineato dalla LAC, conforme ai principi dello Stato liberale, appariva innovativo
nella misura in cui determinava l’espunzione dal palcoscenico del diritto amministrativo degli apparati giudiziali deputati alla tutela di quelle particolari posizioni
soggettive (successivamente etichettate come “interessi legittimi”) diverse dai diritti civili o politici, ma comunque vantate dal privato nei confronti dell’amministrazione pubblica: da qui, il fatto che la L. n. 2248/1865, All. E, viene attualmente
ricordata come la legge abolitrice del contenzioso amministrativo. Un modello già utilizzato
nella Costituzione belga del 1831 e mutuato indirettamente dall’esperienza inglese
della common law.
Il sistema delineato dal legislatore del 1865, tuttavia, non ha tardato a mettere in
evidenza le proprie lacune. Invero, le critiche principali mosse a questo sistema derivanti dall’abolizione degli organi del contenzioso si incentravano, da un lato, sul
minor tasso di controllo operato sull’attività amministrativa con una lesione dell’interesse generale (cd. concezione oggettiva). Dall’altro, sulla scarsa considerazione
attribuita alle esigenze di tutela dei cittadini, specialmente per ciò concerne quelle
posizioni giuridiche soggettive che non avevano la dignità di diritti soggettivi (cd.
concezione soggettiva): al riguardo, infatti, si rivelava decisamente insufficiente la
sola tutela garantita attraverso l’espletamento dei ricorsi amministrativi. Peraltro, a
ciò si aggiungeva anche la mancata previsione di uno strumento che garantisse l’esecuzione coattiva delle decisioni del giudice ordinario.
La successiva evoluzione del sistema della giustizia amministrativa ha progressivamente offerto al privato dei validi strumenti giudiziali avverso l’azione della pubblica
amministrazione, abbandonando via via l’idea che scopo ultimo degli istituti in questione fosse la tutela dell’interesse generale alla conformità dell’azione amministrativa
alle regole ordinamentali.
In questo senso, è stata dapprima emanata la L. n. 5992/1889 (la cd. Legge Crispi),
istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato: in particolare, l’art. 3 di questa
legge provvedeva ad attribuire alla Sezione IV del Consiglio di Stato la competenza
a “decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti
e provvedimenti di un’autorità amministrativa che [avessero] per oggetto un interesse di indivi-
CAPITOLO IV – IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
87
dui, di enti morali e giuridici, quando non ci [ fosse] la competenza dell’autorità giurisdizionale
ordinaria”. Peraltro, la stessa legge contemplò la possibilità che, in casi eccezionali,
la competenza della IV sezione potesse estendersi sino alla valutazione nel merito
dell’attività amministrativa: fra questi casi eccezionali, il più importante era certamente quello relativo all’esecuzione del giudicato civile, laddove il giudice amministrativo veniva investito di una giurisdizione di merito che gli consentiva di porre in
essere interventi di tipo sostitutivo nei confronti dell’amministrazione, rimasta inerte
all’esito di un giudizio civile che l’aveva vista soccombente.
Una volta che al g.a. venne attribuita la generale competenza a conoscere della
legittimità degli atti amministrativi, il dibattito interpretativo si è poi orientato
verso l’individuazione del criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario
e giudice amministrativo.
La soluzione di questo fondamentale problema è passata prima attraverso l’introduzione della cd. giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato: in questo
modo, in relazione ad alcune materie tassativamente indicate, in cui appariva difficile
distinguere tra diritti soggettivi ed interessi legittimi (si pensi, ad esempio, alla materia del pubblico impiego), si decise la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo, competente a sindacare anche della lesione di diritti, con “esclusione”
della giurisdizione del giudice ordinario (sul punto, vedi parte III, cap. III.).
Il problema del riparto della giurisdizione, invece, venne concretamente risolto
in sede pretoria attraverso lo storico “concordato giurisprudenziale” del 1930,
con cui venne definitivamente chiarito che il giudice competente va individuato
in ragione della natura della situazione giuridica che si assume lesa (criterio della
causa petendi).
La Costituzione repubblicana ha offerto copertura costituzionale al principio
della doppia giurisdizione ed a quello del criterio di riparto della giurisdizione
tra g.o. e g.a. fondato sulla causa petendi, sì che può attualmente affermarsi il valore
costituzionale della regola in base alla quale la tutela dei diritti soggettivi spetta, di
regola, al g.o., mentre quella degli interessi legittimi al g.a. (art. 103 Cost.), salva l’attribuzione al g.a. anche di una giurisdizione esclusiva in particolari materie (ultima
parte dell’art. 103 Cost.). Sul punto, vedi parte VIII, cap. III.
Dopo il 1948, il legislatore ha provveduto all’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, (avvenuta con L. n. 1034/1971, cd. L. TAR), dando così attuazione al principio del doppio grado di giurisdizione amministrativa contenuto nell’art.
125, comma 2, Cost.
Nello stesso anno, con D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, il Governo ha riordinato il settore dei ricorsi amministrativi, offrendo ad esso una più organica
disciplina.
L’evoluzione del sistema della giustizia amministrativa è proseguita intensamente nel corso degli ultimi anni, muovendosi sostanzialmente lungo due direttrici.
La prima è quella che originariamente si è proiettata verso l’introduzione di nuove
ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a.: in questo senso, si segnala l’attribuzione a detta giurisdizione delle controversie in tema di accordi amministrativi (art.
11, L. n. 241/1990), nonché di quelle in materia di servizi pubblici, edilizia ed
urbanistica ( D.LGS. n. 80/1998); per converso, alla cognizione del giudice ordinario
88
Compendio di Diritto Amministrativo
è stata affidata quella materia che originariamente era stata affidata alla giurisdizione
esclusiva del g.a., cioè quella del pubblico impiego ( D.LGS. n. 29/1993, ora sostituito
dal D.L GS. n. 165/2001). Questo trend legislativo è stato bruscamente interrotto
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, con la quale il Giudice delle
Leggi ha sostanzialmente affermato che in tanto determinate materie possono rientrare nella giurisdizione esclusiva del g.a., in quanto in esse risulti presente un oggettivo imbrigliamento tra i diritti soggettivi e gli interessi legittimi degli interessati,
coinvolti dall’attività che la pubblica amministrazione svolge in veste di Autorità (al
riguardo, vedi parte VIII, cap. III, parr. 3. e segg.).
La seconda direttrice verso cui si è mossa l’evoluzione del sistema della giustizia
amministrativa, riguarda il potenziamento delle tecniche di tutela giurisdizionale predisposte dall’ordinamento a favore del privato leso dall’azione pubblica.
Sotto questo aspetto, vengono in rilievo sia la L. n. 205/2000, con cui sono stati estesi
i poteri istruttori del g.a. (sul punto vedi parte VIII, cap. V, sez. II, par. 3.2.; parte II,
cap. II, par. 6.) sia le leggi nn. 15 e 80 del 2005, con cui il legislatore è intervenuto
per apportare rilevanti modifiche alla L. n. 241/1990, dettando una nuova disciplina
relativa all’efficacia e all’invalidità del provvedimento amministrativo ed offrendo
nuove regole in tema di silenzio della P.A., da cui emerge un sicuro impulso alla configurazione del processo amministrativo come giudizio sul rapporto e non sull’atto.
Da ultimo, occorre segnalare l’importanza storica che nell’evoluzione del sistema
della giustizia amministrativa è assunta dalle decisioni del 13 giugno 2006, nn. 13659
e 13660, rese dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno impresso
un’accelerazione decisiva all’effettività della tutela degli interessi legittimi avanti al
g.a., ammettendo la possibilità di ottenere la tutela risarcitoria dell’interesse legittimo anche autonomamente rispetto all’azione di impugnazione: le pronunce appena
menzionate hanno innescato un intenso dibattito interpretativo, che si protrae sino
ai nostri giorni, in cui si confrontano i fautori della “tesi della pregiudizialità”
(secondo cui la via risarcitoria sarebbe meramente integrativa di quella impugnatoria)
e quelli che propugnano la “tesi della non pregiudizialità” (i quali giungono a
conclusioni diametralmente opposte a quelle prima esposte). Sul punto, vedi parte V,
cap. I, par. 7.2. e segg.
3. La tutela in sede amministrativa e quella in sede giurisdizionale
Il sistema della giustizia amministrativa, come si è detto al par. 1., comprende
tutti i rimedi che consentono al privato di ottenere tutela avverso quegli atti o
quei comportamenti amministrativi che abbiano arrecato un pregiudizio alla propria
posizione giuridica.
Rimandando all’intera parte VIII del Compendio per lo studio dettagliato del
tema, è sufficiente adesso chiarire che la tutela in sede amministrativa è affidata
alla proposizione del ricorso gerarchico proprio, del ricorso gerarchico improprio,
dell’opposizione o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In tutti questi casi, si tratta di un ricorso rivolto ad un’Autorità amministrativa,
che svolge una funzione amministrativa giustiziale, nel senso che essa, ai fini della
risoluzione della controversia amministrativa, deve agire come se fosse un giu-
CAPITOLO IV – IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
89
dice terzo ed imparziale. Il ricorso amministrativo dà vita ad un procedimento amministrativo di secondo grado (in quanto operante proprio sul precedente atto amministrativo
da cui scaturisce la controversia, salva l’ipotesi di ricorso non impugnatorio) e culmina in
un nuovo provvedimento amministrativo avente il carattere di “decisione”.
La tutela giurisdizionale, invece, viene attuata in seguito alla presentazione di
un ricorso giurisdizionale, rivolto ad un’Autorità giudiziaria, che può essere il
giudice amministrativo, il giudice ordinario o un giudice amministrativo
speciale, a seconda del tipo di pretesa che il privato intenda fare valere in giudizio.
A differenza di quanto avviene in sede di “tutela amministrativa”, il ricorso giurisdizionale è presentato ad un giudice in posizione di terzietà (sia rispetto alle parti
che rispetto alla vicenda processuale) ed il procedimento giurisdizionale culmina in
una pronuncia del giudice che assume il crisma della sentenza.
4. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
Come è stato precedentemente evidenziato, una tappa fondamentale dell’evoluzione della giustizia amministrativa è stata scandita dall’individuazione del criterio di
riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa.
Il tema verrà diffusamente trattato nella parte VIII, cap. III.
In questa sede è sufficiente rammentare che la Costituzione repubblicana, ereditando gli approdi cui era giunta la scienza giuridica del tempo, ha accolto sia il principio della doppia giurisdizione, sia quello del criterio di riparto della giurisdizione
tra g.o. e g.a. fondato sulla causa petendi (o sul petitum sostanziale), in base al quale
la tutela dei diritti soggettivi spetta, di regola, al g.o., mentre quella degli interessi
legittimi al g.a., salva l’attribuzione al g.a. anche di una giurisdizione esclusiva in
particolari materie (art. 103 Cost.).
All’indomani dell’emanazione della Carta Fondamentale, agli occhi degli interpreti è parso subito evidente come le coordinate costituzionali, seppur capaci di offrire una guida generale, fossero comunque insufficienti per qualificare, in concreto,
una lite tra P.A. e privato in termini di controversia concernente la lesione di un
diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo: per questo motivo, gli sforzi
della giurisprudenza e della dottrina si sono orientati verso la individuazione di “criteri sussidiari” idonei a completare quello principale della causa petendi.
A questi fini, sono state elaborate diverse teorie.
Tra queste, quella a cui tutt’oggi la giurisprudenza continua a fare riferimento è
la teoria che fa leva sulla distinzione tra carenza di potere e cattivo uso del
potere.
Questa dicotomia è stata per la prima volta elaborata dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione, con la storica sentenza Ferrari del 1949. Invero, quella patrocinata
dalla Cassazione rappresenta una tesi che ha tratto spunto dalla “teoria dell’affievolimento dei diritti”, già sostenuta, prima della Costituzione, sia dalla dottrina
(R ANELLETTI) che dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: in particolare, secondo
quest’ultima teoria, il fenomeno dell’affievolimento del diritto è quello per il quale
il diritto soggettivo, quando si verificano le condizioni per il suo legittimo sacri-
90
Compendio di Diritto Amministrativo
ficio da parte del potere amministrativo, si trasforma (o affievolisce) in interesse
legittimo, con conseguente competenza del giudice amministrativo a conoscere delle
relative controversie.
Ebbene, nel tentativo di specificare ulteriormente il fenomeno dell’affievolimento
(o, come venne successivamente definito, della degradazione), con la sentenza Ferrari
del 1949 le Sezioni unite statuirono che, se il cittadino nega che il potere sia conferito all’autorità amministrativa, la competenza a conoscere di tale controversia spetta
al giudice ordinario, “perché si tratta di accertare se il diritto sia tale anche di fronte alla
pubblica amministrazione”; “se, invece, la controversia abbia per suo oggetto l’esercizio, che
si pretende scorretto, del potere discrezionale conferito, sotto l’aspetto della competenza, della
forma o del contenuto, specie in relazione all’eccesso di potere in tutte le sue manifestazioni, la
competenza a conoscere è del giudice amministrativo”.
Dopo il 1949, la giurisprudenza prevalente ha seguitato a ritenere che si ha carenza
di potere allorquando si contesti la stessa esistenza del potere amministrativo: in questo caso la controversia riguarda il diritto soggettivo e, perciò, la giurisdizione spetta
al giudice ordinario; viceversa, si ritiene che vi sia scorretto esercizio del potere (o,
come anche si afferma, “cattivo uso del potere”) quando si contesti l’uso illegittimo
del potere stesso: in questa ipotesi la controversia riguarda l’interesse legittimo e,
perciò, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Il criterio di riparto elaborato dal grand arret del 1949 è arrivato pressoché immutato fino ai nostri giorni, sebbene non possano considerarsi del tutto risolti alcuni dubbi
serbati da una parte della giurisprudenza.
Sintetizzando, ci si può adesso limitare ad indicare le principali teorie che hanno conteso il primato alla
teoria fondata sul binomio carenza di potere – cattivo uso del potere.
Si tratta, in particolare:
– della teoria della carenza di potere in concreto, secondo cui, al fi ne di verificare se vi sia carenza di
potere, non si deve guardare unicamente all’esistenza o meno della norma attributiva del potere stesso,
ma si deve anche verificare l’esistenza in concreto di quei presupposti giuridici e fattuali che la norma stessa
fi ssa al fi ne di consentire l’esercizio del potere amministrativo;
– della teoria fondata sulla distinzione tra potere vincolato e potere discrezionale, per la quale, ai
fi ni del riparto della giurisdizione, occorre aver riguardo al contenuto della norma che disciplina l’azione amministrativa: in particolare, se la norma vincola integralmente l’azione amministrativa, allora non
può sorgere il fenomeno dell’affievolimento del diritto; viceversa, se la norma non predetermina completamente le modalità di perseguimento dell’interesse pubblico, riservando alla discrezionalità della
P.A. la scelta delle soluzioni più opportune, allora il diritto soggettivo del privato inciso dall’esercizio del
potere amministrativo degrada in interesse legittimo;
– della teoria dei diritti inaffievolibili, in base alla quale, al cospetto di certi diritti del cittadino, protetto come fondamentale da una previsione di livello costituzionale, l’esercizio del potere amministrativo (anche se legittimo) non è capace di produrre il fenomeno dell’affievolimento.
5. Le azioni esperibili dal privato nei confronti della P.A.
Giunti all’epilogo dell’analisi dei caratteri generali del sistema della giustizia amministrativa, occorre indicare quali siano le azioni che l’ordinamento consente che
siano promosse dal privato nei confronti della P.A.
In chiave metodologica, occorre distinguere quelle azioni proposte avverso la P.A.
innanzi al giudice ordinario, e quelle viceversa intraprese davanti al giudice amministrativo.
CAPITOLO IV – IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
91
Rimandando alla parte VIII, cap. IV, sez. III, per l’approfondimento del tema
relativo alle azioni proponibili innanzi al g.o., al riguardo è qui sufficiente considerare gli artt. 4 e 5, all. E, L. n. 2248/1865, di cui è ancora oggi affermata l’applicabilità.
In particolare, l’art. 4 della legge stabilisce che “Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende
leso da un atto dell’autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione
all’oggetto dedotto in giudizio” (comma 1); “L’atto amministrativo non potrà essere revocato o modifi cato se non sovra
ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il
caso deciso” (comma 2).
L’art. 5, in stretta relazione col precedente, statuisce che “In questo caso, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”.
A mente di queste due norme è ora possibile affrontare succintamente il tema della determinazione delle
azioni ammissibili nei confronti della P.A. davanti al g.o., richiamando sul punto i criteri di classificazione
delle azioni individuati dalla dottrina processual-civilistica.
Per questa via, vengono qui in rilievo le seguenti tipologie di azioni giudiziali:
– azioni dichiarative, dirette ad accertare l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico controverso
od incerto tra le parti;
– azioni costitutive: si tratta di quelle azioni che, previste dall’art. 2908 c.c., tendono a sollecitare una
pronuncia giudiziale diretta a “costituire, modifi care o estinguere rapporti giuridici, con effetti tra le parti, i loro eredi
o aventi causa”;
– azioni di condanna: sono quelle volte, previo accertamento dell’esistenza di un obbligo giuridico in
capo ad una delle parti o della responsabilità nascente da un comportamento antigiuridico ex art. 2043
segg., c.c., ad ottenere una sentenza con la quale il giudice ordina una prestazione che può consistere o
nella dazione da parte del soggetto obbligato di una somma di denaro o in uno specifico comportamento
positivo di dare o di fare che soddisfi in concreto il diritto violato.
Per ciò che attiene alle azioni innanzi al g.a. che il privato può proporre, occorre
preliminarmente evidenziare che la giurisdizione del g.a. è suddivisibile in tre tipologie: la giurisdizione di legittimità, la giurisdizione di merito e quella esclusiva (sul
tema si rinvia alla parte VIII, cap. III e cap. V, sez. I).
La giurisdizione generale di legittimità è relativa, appunto, alla sola legittimità
dell’atto amministrativo, cioè alla sua conformità ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico: in caso di accertata illegittimità dell’atto, il giudice può soltanto
disporne l’annullamento.
In caso di giurisdizione speciale di merito, prevista nelle ipotesi tassativamente
indicate dalla legge, il giudice può sindacare anche l’opportunità o la convenienza
dell’atto; in più, egli può non solo annullare l’atto amministrativo, ma anche sostituirlo
parzialmente o totalmente con un proprio atto.
Infine, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, in deroga al principio generale del
riparto delle giurisdizioni, il g.a. ha cognizione anche in materia di diritti soggettivi.
Ciò posto, in questa sede occorre soffermarsi brevemente sulle azioni proponibili
innanzi al g.a. nella sua generale giurisdizione, cioè quella di legittimità, rimandando
alla più completa trattazione offerta nella parte VIII, cap. V., sez. I.
Anche per questa disamina, si utilizzeranno gli schemi concettuali propri della scienza processual-civilistica, dovendo così distinguere le seguenti tipologie di azioni:
– azioni costitutive: questo tipo di azione rappresenta la figura tipica di azione esperibile dinanzi al g.a.,
con cui si chiede l’annullamento di un atto amministrativo ritenuto illegittimo, in quanto viziato per
violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere;
92
Compendio di Diritto Amministrativo
– azioni di accertamento: in seguito alle novità normative di recente innestate nell’originario impianto
della L. n. 241/1990, si ritiene che le azioni di accertamento siano ammissibili anche nel caso di giurisdizione amministrativa di legittimità: il riferimento, in particolare, è al nuovo art. 21 septies della L. n.
241/1990 che, provvedendo alla canonizzazione della categoria della nullità del provvedimento amministrativo, ha prodotto l’ingresso della tutela di accertamento, sub specie di azione dichiarativa di nullità,
nella nuova configurazione dell’intera tutela giurisdizionale amministrativa;
– azioni di condanna: in questa tipologia di azioni, vanno annoverate l’azione ex art. 21 bis , L. TAR, in
tema di silenzio-inadempimento, quella ex art. 25, L. n. 241/1990, in tema di accesso agli atti amministrativi e quella risarcitoria ex artt. 7, L. TAR, e 35, D.L GS. n. 80/1998.