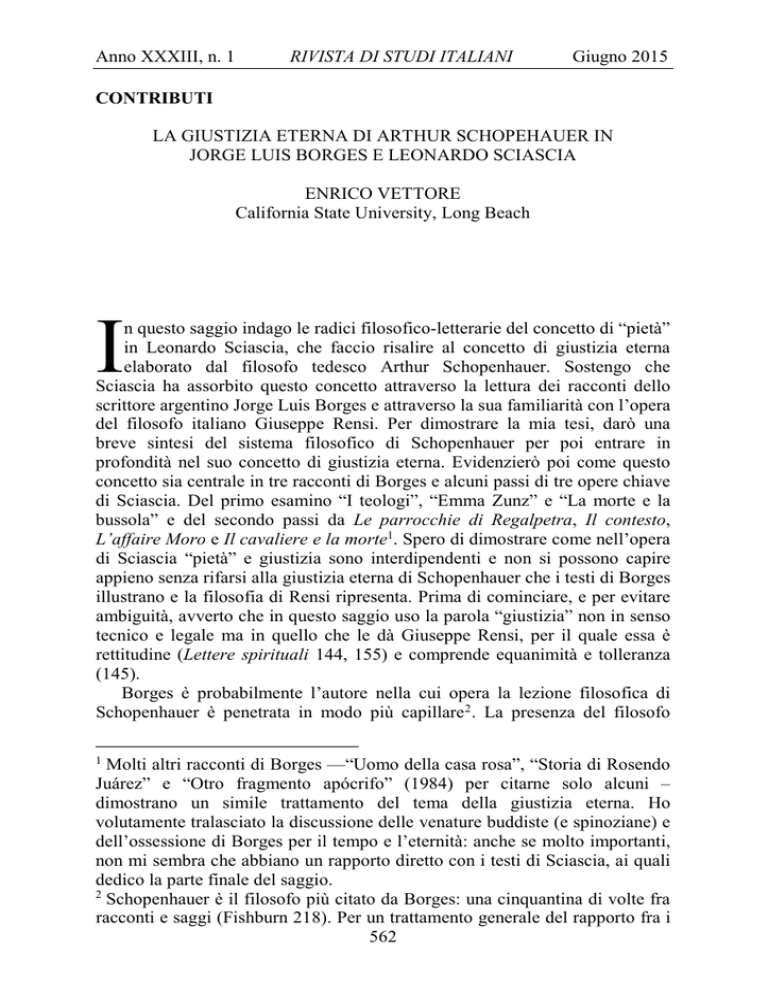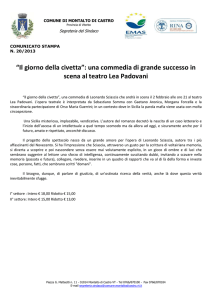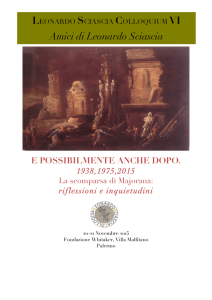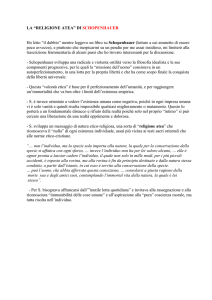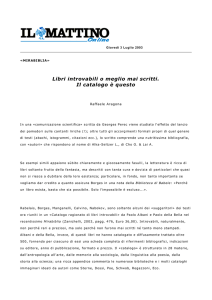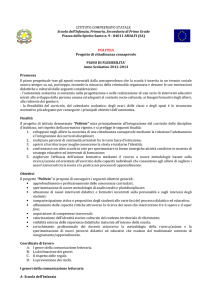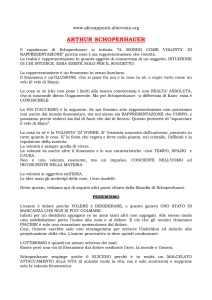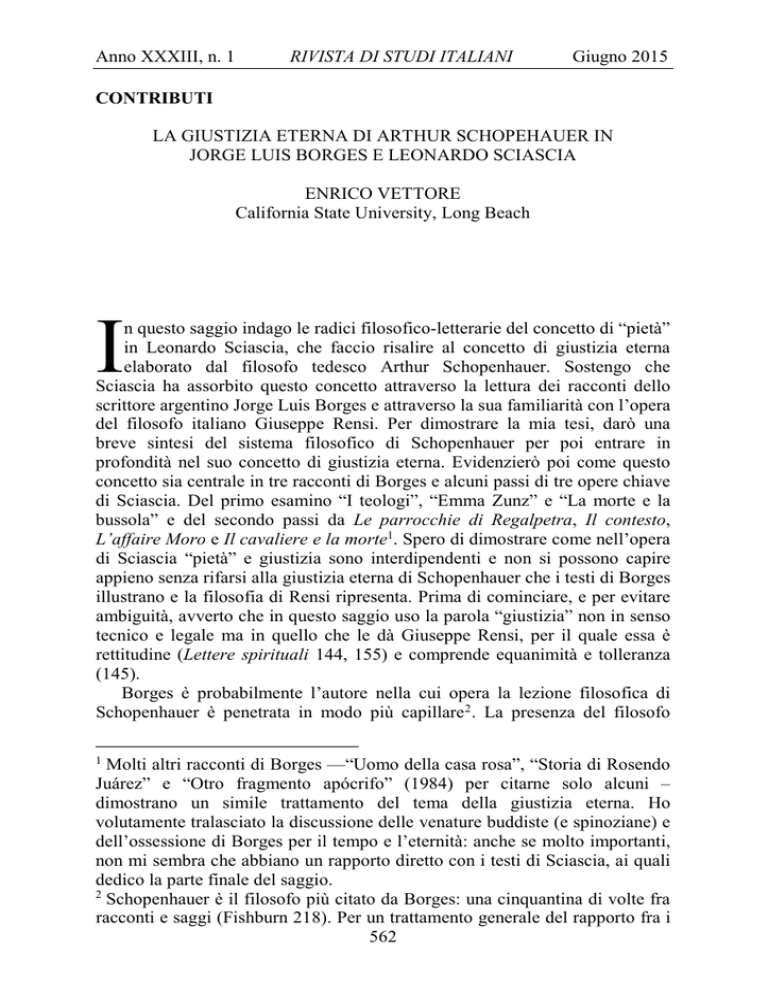
Anno XXXIII, n. 1
RIVISTA DI STUDI ITALIANI
Giugno 2015
CONTRIBUTI
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
ENRICO VETTORE
California State University, Long Beach
I
n questo saggio indago le radici filosofico-letterarie del concetto di “pietà”
in Leonardo Sciascia, che faccio risalire al concetto di giustizia eterna
elaborato dal filosofo tedesco Arthur Schopenhauer. Sostengo che
Sciascia ha assorbito questo concetto attraverso la lettura dei racconti dello
scrittore argentino Jorge Luis Borges e attraverso la sua familiarità con l’opera
del filosofo italiano Giuseppe Rensi. Per dimostrare la mia tesi, darò una
breve sintesi del sistema filosofico di Schopenhauer per poi entrare in
profondità nel suo concetto di giustizia eterna. Evidenzierò poi come questo
concetto sia centrale in tre racconti di Borges e alcuni passi di tre opere chiave
di Sciascia. Del primo esamino “I teologi”, “Emma Zunz” e “La morte e la
bussola” e del secondo passi da Le parrocchie di Regalpetra, Il contesto,
L’affaire Moro e Il cavaliere e la morte1. Spero di dimostrare come nell’opera
di Sciascia “pietà” e giustizia sono interdipendenti e non si possono capire
appieno senza rifarsi alla giustizia eterna di Schopenhauer che i testi di Borges
illustrano e la filosofia di Rensi ripresenta. Prima di cominciare, e per evitare
ambiguità, avverto che in questo saggio uso la parola “giustizia” non in senso
tecnico e legale ma in quello che le dà Giuseppe Rensi, per il quale essa è
rettitudine (Lettere spirituali 144, 155) e comprende equanimità e tolleranza
(145).
Borges è probabilmente l’autore nella cui opera la lezione filosofica di
Schopenhauer è penetrata in modo più capillare 2 . La presenza del filosofo
1
Molti altri racconti di Borges ––“Uomo della casa rosa”, “Storia di Rosendo
Juárez” e “Otro fragmento apócrifo” (1984) per citarne solo alcuni ‒
dimostrano un simile trattamento del tema della giustizia eterna. Ho
volutamente tralasciato la discussione delle venature buddiste (e spinoziane) e
dell’ossessione di Borges per il tempo e l’eternità: anche se molto importanti,
non mi sembra che abbiano un rapporto diretto con i testi di Sciascia, ai quali
dedico la parte finale del saggio.
2
Schopenhauer è il filosofo più citato da Borges: una cinquantina di volte fra
racconti e saggi (Fishburn 218). Per un trattamento generale del rapporto fra i
562
ENRICO VETTORE
tedesco è chiaramente percepibile in tutta l’opera di Borges, ed è a lui che lo
scrittore argentino è tornato costantemente nel corso della sua carriera3. In
Sciascia la presenza delle idee di Schopenhauer è meno direttamente
discernibile, per motivi di genere letterario e di differente impegno politico.
Tuttavia, la sua estesa conoscenza dell’opera di Borges4 e di Rensi invita a
rivisitare la sua concezione della giustizia che si può intendere attraverso il
termine-chiave “pietà”. L’autore siciliano usa questa parola come sinonimo di
compassione, concetto che a sua volta costituisce il fulcro dell’etica
schopenhaueriana e, come vedremo, della giustizia eterna. Per capire come si
arriva a questa concezione, è necessario illustrare brevemente il sistema
filosofico di Schopenhauer.
La filosofia e l’etica di Schopenhauer
Per Schopenhauer il mondo fenomenico, quello che percepiamo tutti i giorni,
è una nostra rappresentazione, il risultato degli schemi che dominano la nostra
capacità di percezione (tempo, spazio, causalità)5. Il vero mondo (la cosiddetta
cosa in sé, non la nostra rappresentazione di esso) è costituito dalla Volontà,
una forza cieca e irrazionale che costantemente vuole e non è mai sazia. Il
mondo dei fenomeni (come lo percepiamo) è cangiante e molteplice a causa
della loro posizione nel tempo e spazio; la Volontà invece è una e unica,
immutabile, inconoscibile, senza causa e scopo, di là dal tempo e dallo spazio.
Le conseguenze interrelate di questa teoria sono due: 1) la vita è segnata dalla
sofferenza perché la volontà non è mai sazia, e desiderare significa soffrire; 2)
tutti i fenomeni (fra cui gli stessi esseri umani) condividono una fondamentale
identità perché sono tutti l’oggettivazione nel tempo e nello spazio di una sola
Volontà. È quindi la loro posizione nel tempo e nello spazio che li differenzia
gli uni dagli altri; la loro sostanza è però, per Schopenhauer, la stessa per tutti.
due autori si veda Roberto Paoli, “Borges y Schopenhauer”, Revista de
Crítica Literaria Latinoamericana, Año 12, No. 24. “Modernidad y
Literatura en America Latina” (1986), pp. 173-208.
3
Borges, richiesto spesso di spiegare perché, con il suo amore per le strutture
intricate, non avesse mai cercato di esporre in modo sistematico la sua visione
del mondo, ha sempre risposto che quel progetto era già stato portato a
compimento da Schopenhauer (Magee 389).
4
Sciascia comincia a leggere negli anni ’50, e leggere a fondo Borges,
vedremo, significa leggere anche Schopenhauer.
5
Per questa breve esposizione del pensiero del filosofo tedesco ho consultato
The Philosophy of Schopenhauer di Brian Magee, Metaphysics as a Guide
to Morals di Iris Murdoch, Schopenhauer di Julian Young, Schopenhauer:
A Very Short Introduction di Christopher Janaway e l’introduzione di
Richard Taylor a The Will to Live.
563
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
Secondo Schopenhauer, ci sono tre vie per porre fine alla sofferenza che
domina la vita umana: la più immediatamente disponibile ‒ ma limitata nel
tempo ‒ è l’esperienza estetica; la più radicale è la negazione della Volontà,
che conduce direttamente all’ascetismo; la più accessibile è l’esercizio della
compassione, fondamento del sistema etico che è il punto d’arrivo dell’opera
di Schopenhauer. Da questa etica scaturisce la giustizia eterna. Nel carattere e
nel comportamento umano Schopenhauer individua tre motivi/incentivi base
per l’azione: egoismo, cattiveria e compassione. L’egoismo, né buono né
malvagio, è la prima oggettivazione della Volontà, essa stessa né buona né
cattiva. L’egoismo ha come obiettivo la sopravvivenza dell’individuo, e non è
interessato a nuocere ad altri, se non quando l’individuo è in pericolo. La
cattiveria, al contrario, è il desiderio di nuocere altri, anche quando non c’è
niente da guadagnare e talvolta addirittura quando chi compie l’azione cattiva
può patirne le conseguenze negative. La compassione (letteralmente “soffrire
insieme”) è invece l’immediato desiderio di aiutare chiunque sia in pericolo e
anche fonte della giustizia e della carità. La compassione non dipende da
concetti, dogmi o insegnamenti ma è “original and immediate, it resides in
human nature itself and, for this very reason it endures in all circumstances,
and appears in all countries at all times” (Schopenhauer, Basis 17). La
compassione scaturisce dall’intuizione della sostanziale identità di sé e
dell’altro cioè dalla realizzazione che la separazione fra io e non-io è
puramente illusoria, giacché tutti condividiamo la medesima essenza. La
misteriosa capacità di rischiare la propria incolumità per un altro, un
sentimento che contraddice la natura profonda (egoistica) degli esseri umani,
si può spiegare quindi “by the fact that each of us is, in his inmost nature, at
one with the noumenal [the thing in itself], and the noumenal is one and
undifferentiable; therefore all of us in our deepest nature are one with each
other, are undifferentiable from each other” (Magee 199)6. La compassione,
non l’amore, è la base della moralità, poiché Schopenhauer vede l’amore
sempre contaminato dall’egoismo (Murdoch, Metaphysics 67). Giacché la
volontà, quando si individua, può essere chiamata ego, è attraverso
l’eliminazione di questo ego, pura illusione, che ci si può liberare dalla cieca
forza della Volontà. Attraverso la compassione e la carità per gli altri, cioè
attraverso la consapevolezza che non esiste un ego e conseguentemente non
6
Schopenhauer così spiega la differenza fra l’uomo di buon carattere e quello
cattivo: “For, as I have said, to the one man [of bad character] humanity is a
non-ego, but, to the other, it is ‘myself once more’. The magnanimous man
who forgives his enemy and returns good for evil is sublime, and receives the
highest praise, because he still recognized his one true nature even where it
was emphatically denied” (Basis 212).
564
ENRICO VETTORE
c’è nessuna barriera fra io e non-io, il santo, l’asceta nega il mondo delle
apparenze superando così la sofferenza e il mondo stesso. “For
Schopenhauer…, salvation is the victory over, and the annihilation of, the
world, which is nothing; of life, which is suffering; and of the individual ego,
which is an illusion” (Taylor, xxvii).
La giustizia eterna
Il concetto di giustizia eterna è diretta conseguenza del sistema appena
esposto. Comprendere che la Volontà che si oggettiva negli individui è unica,
spiega che le barriere fra io e non-io sono illusorie: di qui compassione e
altruismo. Questo spiega anche il rimorso che, per Schopenhauer, è una flebile
consapevolezza che la Volontà di chi ha inflitto un male è la stessa che si
trova nell’individuo che ha patito questo male (Young 180). Schopenhauer
espande questo concetto per creare quello di giustizia eterna. Se, come
Schopenhauer crede, non c’è separazione fra sé e altro, ne consegue che
tormentatore e tormentato sono la stessa persona e che “the tormenter is
mistaken in thinking that he does not share the torment, the [tormented] is
mistaken in thinking he does not share the guilt” (WWR I, 354). Schopenhauer
conclude che il mondo è sempre e assolutamente giusto perché in ogni
momento, se potessimo mettere su un piatto della bilancia (della giustizia)
tutti i dolori del mondo e, sull’altro, tutte le colpe, i due piatti rimarrebbero in
perfetto equilibrio (WWR I, 352). Ci sono molti comportamenti sociali che
svelano che questo concetto è presente a tutti, anche se talvolta sotto forma di
oscura sensazione. Un esempio è quello della parte offesa ma anche dello
spettatore indifferente che desidera vedere punito chi ha commesso un’azione
criminale con una pena eguale al male inflitto. Questo comportamento,
sostiene Schopenhauer, è l’espressione della consapevolezza che la giustizia
eterna si deve realizzare. Il problema è desiderare che essa si realizzi nel
mondo dei fenomeni (cangiante) piuttosto che al livello della cosa in sé (dove
si è realizzato nel momento in cui il crimine è stato perpetrato) (WWR I 357).
La causa di questo fraintendimento è il principio di individuazione che non
percepisce l’essenziale identità fra sé e altro. L’etica cristiana, al contrario, “è
testimonianza del fatto che la conoscenza più profonda, non più legata al
principio d’individuazione, e dalla quale deriva virtù e nobiltà di pensiero, non
condivide sentimenti che esigono vendetta”. Questa etica “proibisce il
desiderio di ripagare il male con il male e lascia che la giustizia eterna governi
nella provincia della cosa in sé che è diversa dal mondo dei fenomeni” (WWR
I, 358).
Né Borges né Sciascia affermano apertamente che il mondo è
perfettamente “giusto” ma entrambi, raccontando storie di vendetta,
compassione e identità personale, sembrano avvicinarsi al punto di vista del
filosofo tedesco. Vediamo come.
565
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
Borges: vendetta e identità
Dei tre testi di Borges che intendo esaminare l’apologo “I teologi,” (1949) è il
più breve ed esplicito. Comincerò da questo testo anche se è l’ultimo dei tre in
ordine di tempo, e passerò poi a “La morte e la bussola” (1942) e “Emma
Zunz” (1948), ripristinando quindi l’ordine cronologico. I racconti di Borges
non sono, vedremo, illustrazioni della visione del mondo e della teoria della
giustizia di Schopenhauer; sono, piuttosto testi permeati da questa visione e
teoria cui Borges sapientemente rimanda per accenni. In questa sezione del
saggio vedremo che la trama di un apologo o di un racconto poliziesco
nasconde un invito a riflettere sui fatti presentati che si possono spiegare alla
luce delle idee del filosofo tedesco. Il tema della sostanziale identità fra
individui è chiaramente espresso in “I teologi” ma la natura fantastica del
racconto stesso lo declassa, a prima vista, al livello di curiosità metafisica.
Questo tema riaffiora, celato, in “La morte e la bussola” e “Emma Zunz,” che
sono racconti realistici7. Borges invita il lettore a scoprire il messaggio etico
sulla vendetta e sulla giustizia tramite certe scelte narrative che cercherò di
evidenziare nelle prossime pagine.
Nell’epilogo a L’Aleph, di cui fa parte “I teologi”, Borges spiega che quel
testo è “un sogno malinconico sul tema dell’identità personale” (Tutte le opere
I: 902). Il racconto narra la storia di due teologi, Aureliano e Giovanni di
Pannonia, che separatamente, dedicano la loro vita alla difesa dell’ortodossia
cristiana da attacchi eretici. Dei due, Giovanni di Pannonia è il più rispettato e
ammirato per dottrina e per i suoi successi nel confutare le eresie. A un certo
punto della storia Aureliano, che invidia lo status, la cultura e la preparazione
di Giovanni, scopre che una delle frasi usate dal suo collega è eretica. Non
può non denunciarlo; Giovanni è trovato colpevole e bruciato vivo. Anni
dopo, Aureliano muore in un incendio. La conclusione della storia, ci avverte
il narratore, non può che essere detta per metafore giacché ha luogo in
Paradiso, dove il tempo non esiste. Nell’ultima scena, Aureliano conversa con
Dio, che però si interessa così poco di differenze religiose che si rivolge a lui
pensando che sia Giovanni. Superato il dubbio che vi sia un errore nella mente
divina, Aureliano scopre così che “per l’insondabile divinità egli e Giovanni
di Pannonia, (ortodosso e eretico, aborritore e aborrito, accusatore e vittima)
erano una sola persona” (Opere complete 1: 803). Se seguiamo la teoria di
Schopenhauer, nella metafora di Borges la mente di Dio è lo stato in cui ci si
trova quando, liberati dal tempo e dallo spazio, si è superato il principio
d’individuazione e si vede il mondo come cosa in sé (Volontà), piuttosto che
7
Al tema dell’illusorietà dell’identità individuale Borges ha dedicato molte
pagine cominciando da quello che considerava il suo primo saggio riuscito,
“La nadería de la personalidad” (1922).
566
ENRICO VETTORE
come nostra rappresentazione (che crea la separazione illusoria fra sé e non
sé). La Volontà, unica eterna e onnipotente, che causa egoismo e sofferenza, è
stata soppressa e Aureliano e Giovanni sono finalmente percepiti come la
stessa persona. La giustizia temporale ha quindi fallito, suggerisce Borges,
perché, come afferma il filosofo tedesco, ha ignorato che in realtà non c’è
sostanziale differenza fra Aureliano e Giovanni.
“La morte e la bussola” (1943) racconta di un caso simile, anche se più
complicato. Il criminale Red Scharlach vuole vendicarsi del detective Erik
Lönnrot, che ha arrestato il fratello di Scharlach, morto poi in carcere. Per
attuare la sua vendetta, Scharlach intesse un labirinto fatto di delitti reali e
fittizi, di indizi matematici, geometrici e religiosi che conducono Lönnrot ad
anticipare l’ultimo crimine, del quale sarà però vittima. Il valore simbolico dei
numeri scelti da Borges è rivelatorio: all’inizio sembra che il numero tre sia la
chiave del mistero (il giorno in cui i delitti hanno luogo; il nome del
commissario con cui Lönnrot collabora: Treviranus). Poi è il numero quattro
che acquista importanza: la data degli omicidi, computata al modo ebraico, è
il 4 del mese; la dislocazione geografica degli omicidi e gli indizi che
Scharlach ha disseminato fanno presagire che non è un triangolo ma un rombo
che appare congiungendo i punti dove sono avvenuti i crimini, perché ci sarà
un quarto e ultimo delitto nella Villa Triste-le-Roy. Quando Lönnrot arriva
alla villa, è il numero due che acquista importanza: la villa abbonda in
simmetrie inutili, specchi che duplicano le stanze, due esemplari di una statua
di Diana e un’altra che rappresenta Giano bifronte. Poi però il numero che
s’impone all’attenzione del lettore è l’uno: Lönnrot nota un singolo fiore in un
vaso di porcellana, si rende conto che c’è un solo giardino, che specchi e false
prospettive moltiplicano. Qui Lönnrot viene immobilizzato da due complici di
Scharlach, che gli svela il suo movente e i dettagli del labirinto nel quale lo ha
inviluppato. Il detective ascolta, e afferma che in quel labirinto ci sono tre
linee di troppo; gli suggerisce poi di costruirne, in una prossima vita, uno di
una sola linea dove “si sono perduti tanti filosofi che vi si può perdere un
mero detective” (Tutte le opere I: 738). In questo labirinto, suggerisce
Lönnrot, Scharlach commetterà (o fingerà di commettere) un crimine nel
punto A, poi un secondo in B, a otto chilometri da A; poi un terzo in C, a metà
strada fra A e B. Scharlach aspetterà Lönnrot in D, a metà strada fra A e C.
Ucciderà quindi Lönnrot in D, proprio come sta facendo ora. Scharlach
promette a Lönnrot questo labirinto “indivisibile, incessante” e poi
“accuratissimamente, fece fuoco” (738).
La vendetta è compiuta e, sembra, con successo. Non appena prendiamo in
esame un paio di dettagli, però il carattere illusorio delle azioni di Scharlach
appare chiaro. Il labirinto di una sola linea proposto Lönnrot è quello del
paradosso di Zenone che, afferma Borges in un testo anteriore, non sfida la
realtà dello spazio ma quella “più invulnerabile e fine” del tempo (Tutte le
opere 1: 385). In questo paradosso lo spazio è infinitamente divisibile e questo
567
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
impedisce Scharlach di raggiungere Lönnrot e di ucciderlo. Hernandez Martín
ha poi notato che la metafora “fece fuoco” “evoca la morte senza però
confermarla” (93). Questa metafora è però legata anche alla concezione del
tempo degli Stoici (Zenone era filosofo stoico) che ipotizzavano il tempo
come un’eterna ripetizione di cicli cosmici, ognuno dei quali terminante in
una conflagrazione detta in greco ekpyrosis8. La radice di ekpyrosis è pyr, cioè
“fuoco”. Fare fuoco su Lönnrot può essere quindi interpretato come la
conflagrazione che segnala l’inizio di un nuovo ciclo temporale. In questo
modo, la vendetta di Scharlach avrà luogo un infinito numero di volte, in
definitiva vanificandola. Questi due dettagli, quindi, sembrano smentire il
carattere definitivo della vendetta di Scharlach.
Una serie di somiglianze che Borges instaura fra i due protagonisti sembra
inoltre suggerire che la vendetta (in generale, non solo in questo caso
particolare) non ha ragione di essere. Borges descrive Lönnrot come un puro
ragionatore, mentre Scharlach sembra incarnare le caratteristiche del criminale
dominato dalle passioni. Eppure è quest’ultimo il freddo ragionatore che, per
passione, tesse una trama razionale ed efficace con la quale attrae e uccide il
detective. La perspicacia di Lönnrot, invece, è subito definita “temeraria”, una
qualità che contrasta fortemente con la sua facoltà raziocinante. Lönnrot è
anche un po’ Scharlach e viceversa. Anche l’onomastica del racconto instaura
una fondamentale identità fra i due protagonisti. Il nome di battesimo di
Scharlach è Red (rosso) mentre il cognome è tedesco per “scarlattina”: essi
riflettono e duplicano la parola rot (tedesco per rosso) contenuta nel cognome
del detective, il cui nome di battesimo è Erik come Erik il Rosso (Erik
Thorvaldsson) esploratore vichingo del X secolo d.C. Questa sovrapposizione
di identità rispecchia la progressiva crescita di importanza che il numero uno
(l’unità) ottiene nel racconto. Possiamo quindi concludere che i due
antagonisti sono, a tutti gli effetti, la stessa persona. (Il dettaglio di Lönnrot
che evita di guardare negli occhi Scharlach potrebbe confermare il timore di
vedere se stesso nel suo avversario.) Se non c’è individuo al di fuori di spazio
e tempo, se c’è solo una sostanza di cui gli individui sono temporanea
incarnazione, non c’è nemmeno, di conseguenza, un “altro” di cui vendicarsi.
Se Scharlach e Lönnrot sono, in fondo, la stessa persona, la vendetta, l’atto di
uccidere è diretto tanto contro Lönnrot quanto contro Scharlach stesso
(torturatore e torturato sono la stessa persona, ci ricorda Schopenhauer).
Scharlach non lo capisce, e non sa che quando Lönnrot menziona la dottrina
8
“The Stoics, for their own purposes, also revived speculations concerning
the cosmic cycles, emphasizing either eternal repetition or the cataclysm,
ekpyrosis, by which cosmic cycles come to their end (see Zeno. Fragments
98 and 109 in H. F. A. Von Armin, Stoicorum veterum fragmenta, I,
Leipzig, 1921). (Eliade 122).
568
ENRICO VETTORE
della reincarnazione sta reintroducendo un’idea di Schopenhauer, per il quale
reincarnazione e karma sono rappresentazioni mitiche della giustizia eterna
(WWR I, 355-6). Scharlach sarà punito attraverso un ciclo di reincarnazioni
durante le quali non potrà mai raggiungere Lönnrot (lui stesso definisce il
labirinto come “incessante”); forse questo lo condurrà a capire la sua intima
essenza e ad avere compassione dell’avversario. Nell’ultima immagine del
racconto, però, la totale devozione di Scharlach all’esecuzione dell’ultimo
dettaglio del suo piano ci fa capire che è del tutto ignaro dell’identità fra sé e
Lönnrot, e quindi della vanità del suo gesto.
In “Emma Zunz” (1948) ci troviamo di fronte a un delitto perfetto che è,
agli occhi di chi lo perpetra, non una vendetta ma un atto di giustizia. In
questo racconto Borges narra la storia di Emma, una giovane donna che
decide di vendicare la morte di suo padre uccidendo Aaron Loewenthal.
Loewenthal è uno dei comproprietari della fabbrica in cui Emma lavora e il
vero responsabile dell’ammanco di cassa per il quale anni prima il padre di
Emma era stato condannato al carcere causandone il disonore e, più tardi, il
suicidio. Emma chiama Loewenthal e chiede di incontrarlo nel suo ufficio per
comunicargli informazioni su un imminente sciopero. Loewenthal accetta di
incontrarla. Emma, prima di andare all’appuntamento, si reca in un locale
frequentato da marinai di passaggio e perde la sua verginità con uno di loro.
Durante l’incontro con Loewenthal lo fa uscire dall’ufficio con uno
stratagemma e si appropria del revolver che sa che Loewenthal tiene nel
cassetto della scrivania. Quando Loewenthal torna, Emma gli spara tre volte.
Loewenthal muore prima che lei possa spiegare perché gli ha sparato e perché
non sarà punita. Emma inscena poi gli indizi di una violenza carnale, chiama
la polizia e spiega che ha ucciso Loewenthal per legittima difesa dopo che
l’aveva violentata. Il narratore dice che tutti credettero alla storia; veri erano
l’intonazione, il pudore e l’odio di Emma, come l’oltraggio che aveva
sofferto, “erano false solo le circostanze, l’ora e uno o due nomi propri”
(Opere complete I 818). Tutto sembra suggerire che Emma abbia perpetrato il
crimine perfetto, cui corrisponde un movente inattaccabile. L’ultima frase
citata e altri dettagli del testo insinuano però che non è così.
Come in “La morte e la bussola”, i due antagonisti sembrano più simili che
dissimili. Emma e Loewenthal condividono la ferma convinzione di avere una
relazione particolare con la divinità che li rende unici. Loewenthal “pensava
di avere un patto segreto con il Signore che lo esimeva dal comportarsi bene,
purché pregasse e fosse devoto (Tutte le opere 1: 817). Emma pensa invece di
essere uno strumento della giustizia di Dio, e che questo le garantisca
l’immunità. “(Non per paura, ma poiché era strumento della Giustizia, ella
non voleva essere punita)” (817).
Al tema della somiglianza e della sostanziale identità fra i due personaggi
Borges affianca dettagli che svelano come Emma non sia in grado di
percepirla: l’egoismo che si cela dietro le sue azioni ne annulla purezza
569
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
dell’intento e motivazione. Mentre Emma si sacrifica concedendo la sua
verginità a uno sconosciuto, il narratore si chiede se Emma abbia pensato una
sola volta al morto che motivava il sacrificio e risponde che ritiene che ci
abbia pensato almeno una volta: “Pensó (non poté non pensare) che suo padre
aveva fatto a sua madre quella cosa orribile che ora facevano a lei” (816). Se
la vendetta è concepita per rimediare a un torto subito dal padre, tutta
l’attenzione di Emma dovrebbe essere concentrata sul padre e sulla sua
sofferenza, sul suo suicidio, e non su se stessa, perché lei si considera un puro
strumento di tale vendetta. Il movente di Emma, quindi, vacilla. Un altro
commento sembra confermarlo: Emma, ci dice il narratore, più dell’urgenza
di vendicare suo padre, “sentì quella di punire l’oltraggio che [lei stessa]
aveva ricevuto” (817-818). Questi due commenti stabiliscono (il primo in
forma di dubbio, il secondo invece appartiene a un narratore onnisciente) che
l’egoismo ha prevalso proprio su quello che doveva rendere questa vendetta
un atto di giustizia. Emma non sembra più preoccupata del fato e del disonore
che suo padre aveva dovuto patire, ma piuttosto del suo (di Emma) sacrificio.
Il padre, da motivazione della vendetta, è declassato a mero catalizzatore
dell’azione, se non addirittura a perpetratore della prima violenza che ora
Emma sente di rivivere. La vera causa dell’omicidio diviene ora il sacrificio di
Emma: pianificato come atto di rinuncia a sé, si trasforma paradossalmente in
un atto che rinforza il sé e l’egoismo. Quest’egoismo inficia la motivazione
che doveva rendere il crimine degno della giustizia personale in cui Emma
crede. L’oltraggio che lei stessa ha pianificato ora appare come un perverso
ferirsi per ferire un’altra persona (il tormentatore e il tormentato sono la stessa
persona). Invocare la giustizia divina è quindi fuor di luogo, ora che la
motivazione del gesto è cambiata. Anche la suggerita somiglianza fra Emma e
Loewenthal suggerisce che Emma, punendo Loewenthal, punisce anche se
stessa. Emma, perduta nella sua percezione del mondo dal punto di vista del
principio d’individuazione, non sembra rendersene conto.
Né Emma né Scharlach, per motivi diversi, possono o vogliono rivolgersi
alla giustizia istituzionale (dello stato, temporale) e per entrambi la vendetta è
l’unica possibile forma di giustizia. Anche se le apparenze sembrano
premiarli, gli indizi disseminati da Borges nei suoi racconti vanificano
l’apparentemente perfetta conclusione dei loro piani. Entrambi i personaggi
incorrono nell’errore di non accorgersi che condividono la stessa sostanza del
loro nemico. La vendetta in generale (che Emma e Scharlach vedono come
forma della giustizia umana o della giustizia divina) è illusoria. La giustizia
eterna, anche se a insaputa degli uomini, ha luogo ed equilibra costantemente i
piatti della bilancia: tormentatore e tormentato sono la stessa persona.
Sciascia: compassione e giustizia fra Borges, Schopenhauer e Rensi
570
ENRICO VETTORE
La storia del più che trentennale rapporto fra Sciascia e Borges comincia nel
1955, quando Sciascia recensì, per primo in Italia, la traduzione italiana di
Ficciones nell’inserto letterario della Gazzetta di Parma9. Il rapporto culmina
poi negli anni Settanta, quando Sciascia comincia a citare Borges in passi
importanti delle sue opere maggiori, Il contesto e L’affaire Moro,
quest’ultimo letteralmente incastonato fra due citazioni di Borges. Sciascia
scrisse sul Corriere della Sera un altro articolo su Borges nel 1979, lo
incontrò di persona a Roma nel 1980 e nelle Cronachette (1985) inserì un
racconto intitolato “L’inesistente Borges”. Sciascia, attento lettore di Borges,
ne assimila certe tendenze “metafisiche” ma ritrova nello scrittore argentino
anche elementi etici che riaffioreranno non solo attraverso le citazioni, ma
anche nella struttura profonda nella sua opera. Attraverso Borges, ovviamente,
Sciascia assorbe (o trova conferma di) alcuni concetti della filosofia di
Schopenhauer, fra cui quello della compassione (pietà) e della giustizia eterna.
Una ventina di anni prima di leggere Borges, Sciascia aveva fatto conoscenza
con l’opera di Giuseppe Rensi, il cui pensiero aveva contribuito alla
formazione, in Sciascia, di un concetto di compassione che ha molto in
comune con quello di Schopenhauer e con la sua versione letteraria quale
appare nei racconti di Borges.
Sciascia cominciò a leggere l’opera di Rensi al liceo ‒ quindi nella
seconda metà degli anni Trenta ‒ grazie al suo professore di filosofia
Giuseppe Bianca, ed è a Rensi che Sciascia deve la sua passione giovanile per
Spinoza10. Nel 1986, Sciascia pubblicò sul Corriere della Sera un articolo su
Rensi (intitolato “Rensi filosofo dimenticato”) dove si sofferma sulla sua
religiosità atea e sulla sua filosofia irrazionale e mistica 11 . Partito da una
posizione idealistica, Rensi passò a una visione scettico-religiosa del mondo
che si svilupperà con un elemento mistico-pessimista culminante nelle Lettere
spirituali (Chiarenza, 227-28). In un’era dominata dalle filosofie di Croce e
Gentile da un ottimistico idealismo, la visione rensiana del mondo, in dialogo
continuo con Schopenhauer e il buddismo ‒ scettica e irrazionale,
misticamente atea ‒ non poteva avere gran seguito. Il suo dichiarato
antifascismo, inoltre, gli fece perdere definitivamente la cattedra di Filosofia
9
Sciascia conosceva già le poesie dello scrittore argentino grazie a un libro
regalatogli da un amico, come lui stesso racconta in “Un affascinante teologo
ateo”.
10
“La sua [di Spinoza] filosofia è suggestiva…A scuola è il filosofo che mi ha
influenzato di più” (Sciascia and Porzio 46). Va aggiunto che Borges ha
scritto due poesie sul filosofo olandese e che Spinoza è uno dei filosofi più
citati da Borges, dopo Schopenhauer.
11
Parte di quell’articolo riappare in Alfabeto Pirandelliano (1986) nel
lemma “Rensi” dove Sciascia evidenzia come la filosofia dell’assurdo di
Rensi ha influenzato l’opera di Pirandello.
571
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
morale all’Università di Genova nel 1934. Nel 1987 la casa editrice Adelphi
ne ripubblicò Le lettere spirituali (uscite postume nel 1943) e Sciascia vi
scrisse un’introduzione che, nonostante la brevità, è particolarmente
importante per il nostro fine. In essa possiamo notare tre elementi interessanti.
Il primo è l’elemento autobiografico e affettivo: Sciascia seppe dell’opera di
Rensi al liceo e la monografia su Spinoza. Questa esperienza l’affezionò
talmente a Rensi che lesse tutto quello che riuscì a trovare del filosofo.
Ancora nel 1987, confessa Sciascia, i libri di Rensi lo aiutavano spesso a
“chiudere la giornata con intelligente serenità, armoniosamente in
accordo…con la vita, con la morte” (3). Il secondo elemento interessante è
che Sciascia definisce Rensi un “eretico” (pp. 3–4), come sarebbe piaciuto a
Borges (il greco antico “hairetikos” si rende in italiano col sintagma “in grado
di scegliere”). Il terzo è che Sciascia sceglie di terminare l’introduzione
parlando dell’egoismo con un tono che ha intenso sapore schopenhaueriano:
“Il più grande, il più vero, il più intrepido sentimento religioso è quello che
nasce dalla distruzione dell’egoismo” (5-6). Sciascia continua affermando che
questo egoismo (personale) produce gli altri egoismi: “delle razze, delle
nazioni, delle chiese, delle classi, delle fazioni” (6). Distruggere l’egoismo
significa quindi, se portiamo a compimento il ragionamento proposto da
Sciascia, aprire le porte alla comprensione dell’altro, mentre chiese, classi e
fazioni fanno l’opposto. Distruggere l’egoismo è anche lasciare spazio alla
compassione che ‒ invece ‒ dell’altro si cura, vuole capire e aiutare. Che
Sciascia ritenga questo sentimento “religioso” è in linea con il pensiero di
Rensi e Schopenhauer, e va interpretato come “etico” poiché né Sciascia né i
due filosofi credono nella religione come istituzione. A questo proposito, è
interessante notare che per Rensi la religione dovrebbe considerare come suo
precetto non l’amore, ma la giustizia (143)12. Per il filosofo, essa è una virtù
che riassume in sé tutte le virtù. Consiste nel mantenere imparziale il giudizio
fra sé e altro, nel considerarlo eguale (143). La giustizia, per Rensi, non va
intesa in senso legale ma in senso lato: contiene tutte le benefiche
conseguenze che si vogliono far derivare dall’amore (144), è rettitudine, e
comprende in sé equanimità e rassegnazione consapevole alle sventure e
serena tolleranza delle stesse (145). Rensi poi sintetizza il suo pensiero
affermando che questa è la giustizia che Schopenhauer chiama “eterna”,
citando i passi dal Mondo che abbiamo già visto all’inizio di questo saggio.
Sciascia lesse Le lettere spirituali solo nel 1986/7 (3): non poteva quindi aver
concepito la sua idea di pietà e giustizia su questo testo. Non è però fuor di
luogo ipotizzare che in questo testo Sciascia abbia trovato conferma della sua
teoria della pietà e della giustizia eterna che si era sviluppata negli anni
12
Ricordo nuovamente che per Schopenhauer l’amore è contaminato
dall’egoismo (Murdoch 67).
572
ENRICO VETTORE
precedenti anche grazie alla sua frequentazione dei testi di Borges e Rensi (e
quindi, indirettamente, di Schopenhauer). Per dimostrare quanto sostenuto
analizzerò dei passi da Le parrocchie di Regalpetra (1956), Il contesto (1975),
L’affaire Moro (1978) e da Il cavaliere e la morte (1988)13.
Sciascia considerava Le parrocchie di Regalpetra (1956), il “fondamento
dell’opera sua” (così Claude Ambroise in Sciascia, Opere: 3 953), e per
questo motivo lo aveva voluto come primo testo del primo volume delle sue
opere complete uscite presso Bompiani. Lo prendo in esame qui per questo
preciso motivo: perché contiene in nuce tutti i temi sciasciani e mostra come
pietà e giustizia sono presenti e collegate fin dall’inizio della produzione
letteraria di Sciascia. Il testo si apre con un atto di compassione di Donna
Beatrice che perdona un servo accusato di aver ucciso suo marito, Girolamo
del Carretto, feroce signore della città. La donna giustifica la sua decisione
dicendo “con più che cristiano buonsenso che ‘la morte del servo non riporta
in vita il padrone’” (14). La scelta di Sciascia di cominciare raccontando un
atto di pietà (e giustizia) da parte di una donna coincide non solo con la teoria
etica di Schopenhauer ma anche con i risultati della ricerca di Carol Gilligan,
per la quale l’etica delle donne è, fra l’altro, più concreta che astratta, più
motivata dalla solidarietà che dal dovere, e più personale che impersonale14.
Più avanti, nel capitolo sugli anni del regime fascista a Regalpetra (“Cronache
di regime”), il narratore dice: “Cominciava per me la vicenda della pietà. Un
terribile sentimento, la pietà. Un uomo deve amare o odiare: mai aver pietà.
Un uomo, dico. E io ero ancora un ragazzo” (48). Il termine pietà compare qui
per la prima volta, e Sciascia sente il bisogno di marcarne la presenza
ripetendolo ben tre volte e sempre in posizione forte: in fine di frase. Secondo
la cultura del luogo e del tempo per gli uomini sono preferibili comportamenti
che non lasciano spazio a sentimenti che non siano forti e netti: o si ama o si
odia.
Sciascia non sembra accettare questo aut aut. La pietà (che nell’uso di
Sciascia equivale a “compassione”), è un “terribile sentimento” perché è più
13
Ho preferito tralasciare testi come Il Consiglio d’Egitto e Porte aperte
perché la loro complessità avrebbe richiesto troppo spazio. Spero di dedicarvi
un’analisi approfondita in futuro.
14
Carol Gilligan, In A Different Voice (1982). Schopenhauer nota che le
donne “surpass men in the virtue of philanthropy or loving-kindness, for the
origin of this is in most cases intuitive and therefore appeals directly to
compassion, to which women are decidedly more easily susceptible” (Basis,
151, corsivo nel testo). Per Schopenhauer la giustizia è una virtù maschile
mentre la filantropia (o loving-kindness) è femminile; per il filosofo, tuttavia,
la più alta delle due è la filantropia (Cartwright xxviii).
573
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
evoluto dell’amore o dell’odio. Implica empatia e abbandono quindi
dell’egoismo, e complica la situazione perché non semplifica, ma rende
complesso il problema. Amore e odio implicano un giudizio che è positivo nel
caso dell’amore e negativo nel caso dell’odio. La compassione/pietà, piuttosto
che semplificare con una scelta netta, si presenta come un “terribile
sentimento” che fa vacillare la razionalità e si rifiuta di giudicare. Giudicare è
terribile, per lo scrittore (“tremo al pensiero di dover giudicare” 67) e per
questo motivo le pagine più toccanti e pietose del libro sono quelle
sull’esperienza scolastica, sugli alunni poveri del protagonista nel capitolo
intitolato “Cronache scolastiche”. La descrizione commovente e senza giudizi
delle condizioni in cui vivono questi bambini, che non riescono a seguire la
lezione perché hanno fame e che si dedicano a furti e a mentire per
sopravvivere, ritorna più avanti nell’ultimo capitolo, ancor più commovente e
sentito, se possibile, intitolato “La neve, il Natale”. Questo nuovo capitolo
Sciascia lo aggiunse per la ristampa del 1967, quasi a ricordare che la vicenda
della pietà era ancora in corso, che era continuata dopo la prima edizione del
libro. Il narratore, ora maestro, sente un “indicibile disagio e pena” a stare di
fronte a loro, lui con il suo “decente vestito” e “armoniose giornate” (103). Il
contrasto è appena accennato, ma la pietà è il sentire la sofferenza di questi
bambini e sapere che questa condizione li sta trasformando, ne sta limitando il
potenziale per ridurli, forse per sempre, a cittadini di terza categoria. A
rendere più amara la situazione è la constatazione che il tutto dipende, per il
narratore, solo da un’ingiustizia dettata dal caso, da un “fragile gioco”, dalla
carta che ti è toccata in sorte, e lui è uno dei fortunati (112).
La dichiarazione di Sciascia che la pietà per lui ha una “vicenda” è
profetica: il termine ricorrerà costantemente nella sua opera portando con sé,
attraverso la frequentazione di Borges, echi della filosofia di Schopenhauer,
rifratta dalla lettura dei testi di Rensi. Non è difficile vedere come l’etica
schopenhaueriana permei le prime pagine di Sciascia, ma è con Il contesto e
L’affaire Moro che Schopenhauer e Borges giocheranno un ruolo ancora più
importante.
In un’atmosfera rarefatta e simbolica Il contesto narra la storia di un
detective (Rogas) che dà la caccia al farmacista Cres, sospettato di aver ucciso
alcuni giudici per vendicarsi di essere stato condannato per un delitto
commesso forse dalla moglie. Mentre segue le tracce di Cres, Rogas incontra
il giudice della Corte Suprema Riches, che ritiene in pericolo perché
presidente della corte che aveva confermato in appello la condanna di Cres.
Durante l’incontro Riches spiega la sua particolare teoria della giustizia
secondo la quale l’errore giudiziario non può esistere. Per Riches, il giudice è
come un prete durante la messa: a prescindere dal valore morale del prete, il
miracolo della transustanziazione deve avvenire. Così è anche
nell’amministrazione della giustizia, che per lui è come una religione.
574
ENRICO VETTORE
Prendere in considerazione l’opinione dell’uomo comune, del laico, che nel
nostro caso sospetta l’errore giudiziario, equivarrebbe a considerare questa
religione morta (70). A questo punto Rogas smette di ascoltare e recita
mentalmente l’ “Argumentum ornithologicum” di Borges (73), un breve testo
paradossale che dimostra l’esistenza di dio attraverso un argomento che ne
dovrebbe provare l’inesistenza. Rogas se ne va, ma mentre esce dall’ascensore
“nel rapido aprirsi dei battenti, nell’atrio, ebbe per un momento la sensazione
di trovarsi davanti a uno specchio. Solo che nello specchio c’era un altro”
(76). Rogas resiste all’impulso di tornare indietro per fermare Cres, e a poco a
poco passa dalla parte del ricercato. “Cres…non poteva mai immaginare che
quell’ispettore di polizia, che i giornali davano tenacemente ma vanamente
impegnato a dargli la caccia, era passato dalla sua parte” (78). Riches morirà
qualche giorno dopo, alimentando il sospetto, nel lettore, che Rogas sia stato
indiretto complice di Cres. Ci si può però chiedere se Rogas si sia messo solo
ora dalla parte di Cres, oppure lo sia sempre stato. Schopenhauer sosterrebbe
che Rogas e Cres (“inquisitore e inquisito,” per usare l’espressione di Borges)
sono sempre stati la stessa persona, e che Rogas ha avuto una rivelazione e si
è liberato dal principio d’individuazione mentre incontrava se stesso sotto le
spoglie di Cres, fatto che gli ha rivelato l’illusorietà di una identità personale.
Questa consapevolezza lo spinge a non fermare Cres, rinfrancato anche dal
fatto che il concetto di giustizia del giudice Riches è abominevole perché
assolutamente rigida e impersonale. Il brano di Borges lo ha riportato alla
realtà dei fatti, e il momento di consapevolezza schopenhaueriano/borgesiano
ha completato l’opera. Rogas e Cres, per Sciascia, non sono mai stati così
diversi ma anche così simili: sono entrambi “eretici” e quindi riscuotono la
simpatia di Sciascia (e di Borges). Cres attacca il potere legale e Rogas non si
piega al potere (al malaffare) politico. Per questo motivo Rogas morirà, ma in
questo modo proteggerà ‒ poiché è l’unico che ha visto il volto di Cres ‒
l’identità del ricercato, ancora latitante nel momento in cui il romanzo finisce
e forse pronto a colpire, in futuro, altri esponenti di questa giustizia
assolutamente fanatica e ingiusta. Rogas concepisce la legge (e la giustizia) in
modo molto diverso da Riches. A torto o a ragione, Rogas non crede
all’assoluta imparzialità dell’investigatore: a differenza del collega che aveva
consegnato Cres ai giudici lui “già allora avrebbe avuto una certezza –
colpevole o innocente – da calare giudiziosamente, con discreta ma tenace
insinuazione, nei verbali” (28). Questa concezione della giustizia deriva da
una frequentazione di un altro essere umano, piuttosto che dalla fredda
applicazione di un codice15. Per lui, più dei fatti stessi e degli indizi contava
“aver davanti l’uomo, parlargli, conoscerlo” (28). L’inaspettata, rivelatrice
somiglianza fra Rogas e Cres è un chiaro rimando a “I teologi” e a “La morte
15
La situazione è simile a quella già vista nelle prime pagine delle Parrocchie
di Regalpetra.
575
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
e la bussola” (due racconti che Sciascia amava molto). In un solo episodio
Sciascia ha quindi condensato il tema della giustizia (in una storia di
vendetta), un testo di Borges e il tema dell’identità personale o, meglio, la
natura illusoria di questa identità, che è un tema borgesiano derivante da
Schopenhauer. La contiguità degli elementi ora citati e la trama stessa hanno
forti risonanze schopenhaueriane, grazie alla presenza di Borges. A differenza
di Scharlach, Lönnrot o Emma Zunz, Rogas ha un momento di
consapevolezza che sfiora il livello della rivelazione che suggerisce un
impatto profondo sullo sviluppo della trama del romanzo, anche se a
conclusione avvenuta.
Con L’affaire Moro (1978), Sciascia intende scrivere un libro religioso,
piuttosto che politico. Naturalmente intende “religioso” non nel senso di
attinente a una religione istituzionalizzata, ma nel senso di una più generale
attitudine verso gli esseri umani, specialmente quando soffrono. Ne risulta
un’opera di letteratura (un’indagine filologica delle lettere di Moro), e un atto
politico di denuncia permeato dai principi della responsabilità individuale e
della compassione. Se il testo di riferimento è la Storia della colonna infame
di Manzoni, L’affaire Moro si apre con una discussione del “Pierre Menard,
autore del Chisciotte” di Borges e si conclude con un’altra citazione
dall’“Esame dell’opera di Herbert Quain”, sempre di Borges. La presenza
pervasiva dell’autore argentino suggerisce il tema della ricerca di una sempre
elusiva verità attraverso l’esercizio della letteratura ma allude anche,
indirettamente, alla compassione e immedesimazione fra autore e personaggio
(Sciascia–Moro, ma anche Menard–Cervantes). A ciò fa contrasto la
mancanza di tale immedesimazione, con conseguente mancanza di
pietà/compassione, fra Brigate Rosse e Moro, ma anche fra personalità
politiche italiane e Moro.
Anche se l’opinione di Sciascia su Moro uomo politico è ampiamente
negativa, lo scrittore è stato in grado di provare compassione per Moro come
essere umano; “Mi sono immaginato di essere al suo posto quanto al posto di
qualsiasi sequestrato. Ho compreso la sua sofferenza e la sua angoscia, l’ho
compatito, nel senso originale del termine”. (La Sicilia come metafora 132,
corsivo mio)
A un certo punto della vicenda, la retorica nazionale (già caratterizzata da
vuota magniloquenza, falsità e slogan) sfocia in un documento firmato da
cinquanta “amici di Moro”, fra cui un cardinale, esegeta di Sant’Agostino.
Qui si afferma, seguendo la teoria dei due Moro, che il Moro imprigionato
non è il Moro che loro conoscono. Sciascia è sorpreso che il cardinale
dimostri una così povera conoscenza dell’amicizia. “Come fa l’esegeta di
sant’Agostino a non sapere quanto è difficile…conoscere un uomo; quanto
arrogante – senza amore, senza carità – il voler apporre certificazione e
576
ENRICO VETTORE
giudizio a quel che era e quel che non è più” (537-538; corsivo mio).
Giudicare e certificare in tal modo, sostiene Sciascia, è dimostrazione di
mancanza d’amore e carità, ancor più sorprendente in un alto prelato. Nella
citazione precedente potremmo sostituire “carità” con pietà, o compassione, e
Sciascia si soffermerà nel 1979 su una simile mancanza di amore e carità per
il Vescovo di Patti da parte di un altro prelato del Vaticano in Dalle parti
degli infedeli (particolarmente le pagine 872, 880, 887-888). Ne L’affaire
Moro, dunque, Sciascia torna alla questione del giudicare, che aveva
dichiarato di temere nelle Parrocchie di Regalpetra. Questo caso è
particolarmente doloroso la mancanza di pietà è il diretto risultato di un
calcolo politico, dettato dagli egoismi di parte e dall’amore del potere che
Sciascia condannerà nuovamente, come abbiamo visto, nell’introduzione alle
Lettere spirituali di Rensi.
Sciascia ipotizza che a quella mancanza di pietà potrebbe corrispondere la
nascita della pietà da parte dei carcerieri di Moro, benché ostacolata da ovvi
motivi ideologici. La scena che Sciascia immagina avvenga nella “prigione
del popolo” è intrisa di quella compassione che lui stesso ha sentito per Moro.
Tanti piccoli gesti; tante parole che inavvertitamente si dicono, ma che
provengono dai più profondi moti dell’animo; un incontrarsi di sguardi nei
momenti più disarmati…sono tante le cose…che, giorno dopo giorno,
possono insorgere ad affratellare il carceriere al carcerato, il boia alla
vittima. E al punto che il boia non può più essere boia. (530, corsivo mio)
Sciascia più tardi ragiona su questa occasione mancata. Una delle ultime
telefonate dei terroristi è diretta a un amico della famiglia Moro. I terroristi lo
vogliono informare degli ultimi desideri dello statista, ma il destinatario della
chiamata, molto agitato, non riesce a capire le istruzioni e deve passare il
telefono a suo padre. Sciascia nota che la chiamata era stata fatta dalla
stazione Termini, dove c’è una stazione della polizia sempre aperta, fatto che i
terroristi non potevano ignorare, e che il numero dell’amico di famiglia era
probabilmente sotto controllo. Nonostante tutto, il terrorista dà
all’interlocutore il tempo di capire le istruzioni. Il messaggio dura così tre
minuti, mettendo in pericolo chi chiama. Sciascia nota inoltre che il terrorista
si riferisce quattro volte a Moro usando il titolo “onorevole” e che una volta,
addirittura, dice “mi dispiace”. “Che cosa dunque trattiene il brigatista a
quella telefonata, se non l’adempimento che nasce dalla militanza ma sconfina
ormai nell’umana pietà? La voce è fredda; ma le parole, le pause, le esitazioni
tradiscono la pietà” (556). “In quell’adempimento, la pietà è penetrata in lui
[nel terrorista] come il tradimento in una fortezza. E spero che lo devasti”
(556). È singolare qui che Sciascia attribuisca alla compassione una forza
dall’impatto devastante, ma ciò si può spiegare come leggera variazione sul
tema della pietà come “sentimento terribile” quale era apparsa nelle
Parrocchie di Regalpetra. La pietà ha una forza sovvertitrice, è un lampo di
577
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
consapevolezza che potrebbe trasformare l’individuo e fargli percepire la
sostanziale identità fra sé e altro, indebolendo il processo del giudizio,
modificando il giudizio finale, ma la “squallida, spaventosa senilità ideologica
e umana” delle Brigate Rosse prevale sul potenziale della compassione.
Sciascia percepisce una pallida possibilità, un lampo di quella che potrebbe
essere la giustizia eterna, ma essa non può aver luogo.
La vicenda della pietà e della giustizia ‒ nella storia personale di Sciascia
‒ riappare anche nel suo penultimo romanzo, Il cavaliere e la morte (1988).
Sciascia, collezionista di stampe, sceglie per titolo e per aprire il suo testo la
famosa incisione di Dürer. Non è impossibile che la scelta sia in qualche
modo legata all’ultima pagina della Filosofia dell’assurdo (1924, 1937) di
Rensi, che Sciascia doveva aver letto negli anni immediatamente successivi al
liceo e dove si legge:
A me piace vedere, quando sollevo gli occhi dal mio tavolo di lavoro,
accanto alla stampa di Salvator Rosa, in cui, sotto alberi desolati,
contorti e tronchi, presso antiche colonne infrante e marmi cadenti e tra
ossami d’animali e d’uomini, ‘Democritus omnium derisor in omnium
fine defigitur’, la riproduzione del rame di Dürer, in cui il maturo
cavaliere procede, severo, rassegnato, impassibile, tra la morte e il
demonio. (224)
Anche il protagonista del Cavaliere e la morte, un vice commissario malato
terminale di cancro, tiene appesa davanti alla sua scrivania la stampa di Dürer.
Nel caso di Rensi l’immagine di Dürer viene a conchiudere un ragionamento
sul senso tragico della vita, che si propone quale vero senso religioso dacché
in esso l’immagine di Dio è sradicata da ogni antropomorfismo (223); nel
romanzo di Sciascia sembra invece rispecchiare il percorso del protagonista
verso la destinazione finale: il castello in cima al colle, la sua morte.
L’esclusione del diavolo dal titolo è rivelatrice: “perché l’acqua sia santa è
necessario il diavolo” dice il protagonista a un certo punto, suggerendo di
conseguenza che, senza diavolo, non ci può essere acqua santa, e viceversa.
L’esclusione del diavolo significa quindi l’esclusione dell’acqua santa, e per
estensione ciò significa che il dualismo bene–male, amore–odio, non ha
ragione di esistere. Ciò propone, ancora una volta, il rifiuto della
contrapposizione amore–odio che Sciascia non aveva voluto far sua nelle
Parrocchie e i cui effetti aveva aborrito ne L’affaire Moro (effetti visibili nel
comportamento dei terroristi ma anche degli uomini politici colleghi di Moro).
In questo breve romanzo, il protagonista prende atto dello stato della sua
particolare vicenda della pietà; si rende conto di questo percorso che lo porta
ora a non giudicare o condannare le persone, ma solo la pena di morte, che
“non ha niente a che fare con la legge” e che egli considera il risultato del
578
ENRICO VETTORE
desiderio oscuro del sacro della massa che sarà sempre a favore di questa
forma di punizione (Opere 3: 453). La massa, secondo Schopenhauer, vuole la
condanna perché sente oscuramente che è necessario che una pena eguale e
contraria sia applicata al colpevole, proprio perché non si rende conto che
colpevole e innocente sono la stessa persona. Schopenhauer, abbiamo visto,
nota che il cristianesimo ha superato il desiderio di vendetta, ma Sciascia sa
che, nonostante il pervasivo cattolicesimo “di facciata” 16 degli italiani, il
desiderio della pena di morte è ancora presente. Il vice non può non
condannare questa barbarie perché è irrazionale, irragionevole e definitiva:
con essa uno dei due termini dell’equazione è eliminato per sempre e non c’è
possibilità di rimediare alla totale mancanza di giustizia umana. Nelle ultime
pagine, malato e stanco, il Vice è sorpreso nel constatare che in lui “ogni
sentimento che era stato di amore o di avversione si tramutasse in pietà”
(457). La compassione ha superato definitivamente le reazioni “da uomo”, i
tagli netti che rendono tutto più facile, anche giustiziare un essere umano, e
che il giovane Sciascia non poteva accettare ne Le parrocchie di Regalpetra:
amare o odiare, ora che vede la vita finire, non hanno più senso: l’egoismo
personale che crea delle fazioni e dei partiti ha lasciato spazio, anche se per il
poco tempo rimasto da vivere al protagonista, alla comprensione dell’altro.
Conclusione
Nei racconti di Borges si può chiaramente distinguere un’ascendenza
schopenhaueriana nell’uso che l’autore fa dei concetti di identità personale,
compassione e giustizia. Nei testi di Sciascia, di natura assai diversa per
contenuto e forma, tale ascendenza è più sfumata e a volte difficilmente
discernibile poiché la natura dei testi di Sciascia è generalmente più concreta
che astratta e, avendo a che fare con la storia e la cronaca, si offre meno
all’illustrazione di principi filosofici che spiccano meglio in situazioni
immaginarie o nel fantastico. Spero di aver dimostrato che, nonostante queste
caratteristiche dell’opera di Sciascia, la filosofia di Schopenhauer vi ha un
ruolo non indifferente e sempre funzionale al concetto sciasciano di letteratura
come impegno civile e luogo di ricerca della verità.
__________
16
“Ma il cattolicesimo degli italiani è formalistico, tridentino: non è un
cattolicesimo di sentimenti, di pensieri, di cultura (e si potrebbe anche
sostituire il termine cristianesimo al termine cattolicesimo)” (Vigorelli 3: 625626).
579
LA GIUSTIZIA ETERNA DI ARTHUR SCHOPEHAUER IN
JORGE LUIS BORGES E LEONARDO SCIASCIA
BIBLIOGRAFIA
Borges, Jorge Luis. Tutte le opere, Milano: Mondadori, 1984. Vol. 1.
Cartwright, David E. Introduction, On the Basis of Morality, By Arthur
Schopenhauer,Trans. E. F. J. Payne. Providence-Oxford: Bergham, 2nd ed.,
1995.
Eliade, Mircea. Cosmos and History, the Myth of Eternal Return, New
York: Harper, 1959.
Farrell, Joseph. Leonardo Sciascia, Edinburgh: Edinburgh University Press,
1995.
Fishburne, Evelyn and Hughes Psyche. A Dictionary of Borges, London:
Duckworth, 1990.
Gardiner, Patrick L. Schopenhauer, Baltimore: Penguin, 1963.
Hernández Martín, Jorge. Readers and Labyrinths. Detective Fiction in
Borges, Bustos, Domecq, and Eco, New York: Garland, 1995.
Janaway, Christopher, ed. The Cambridge Companion to Schopenhauer,
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.
Magee, Bryan. The Philosophy of Schopenhauer, Oxford: Clarendon; New
York: Oxford University Press, 1983.
Murdoch, Iris. Metaphysics As a Guide to Morals, New York: Penguin,
1993.
Rensi, Giuseppe. Lettere spirituali, Milano: Adelphi, 1987.
_____. La filosofia dell’assurdo, Milano: Adelphi, 1991.
Schopenahuer, Arthur. The World as Will and Representation, Trans. E.F.J.
Payne, New York: Dover, 1966. 2 Vols.
_____. On the Basis of Morality, Trans. E. F. J. Payne. Providence-Oxford:
Bergham, 2nd ed., 1995.
Sciascia, Leonardo. “Giuseppe Rensi, filosofo dimenticato”, Corriere della
Sera 5 Febbraio, 1986, p. 3.
Sciascia, Leonardo. “Un affascinante teologo ateo”, Corriere della Sera 30
Settembre, 1979, p. 3.
_____. Introduzione, Lettere spirituali di Giuseppe Rensi, Milano: Adelphi,
1987.
_____. Opere: 1956-1971, Milano: Bompiani, 1987. Vol. 1.
_____. Opere: 1971-1983, Milano: Bompiani, 1989. Vol. 2.
_____. Opere: 1984-1989, Milano: Bompiani, 1991. Vol. 3.
Sciascia, Leonardo, and Marcelle Padovani. La Sicilia come metafora,
Milano: Mondadori, 1979.
Sciascia, Leonardo, and Domenico Porzio. Fuoco all’anima: Conversazioni
con Domenico Porzio, Milano: Mondadori, 1992.
580
ENRICO VETTORE
Taylor, Richard. Introduction, The Will to Live, Selected Writings, By
Arthur Schopenhauer, Garden City: Doubleday, 1962.
Traina, Giuseppe. Leonardo Sciascia, Milano: Bruno Mondadori, 1999. 3
Volumi.
Vigorelli, Giancarlo. Manzoni pro e contro, Milano: Istituto di Propaganda
Libraria, 1975.
Young, Julian. Schopenhauer, London and New York: Routledge, 2005.
581