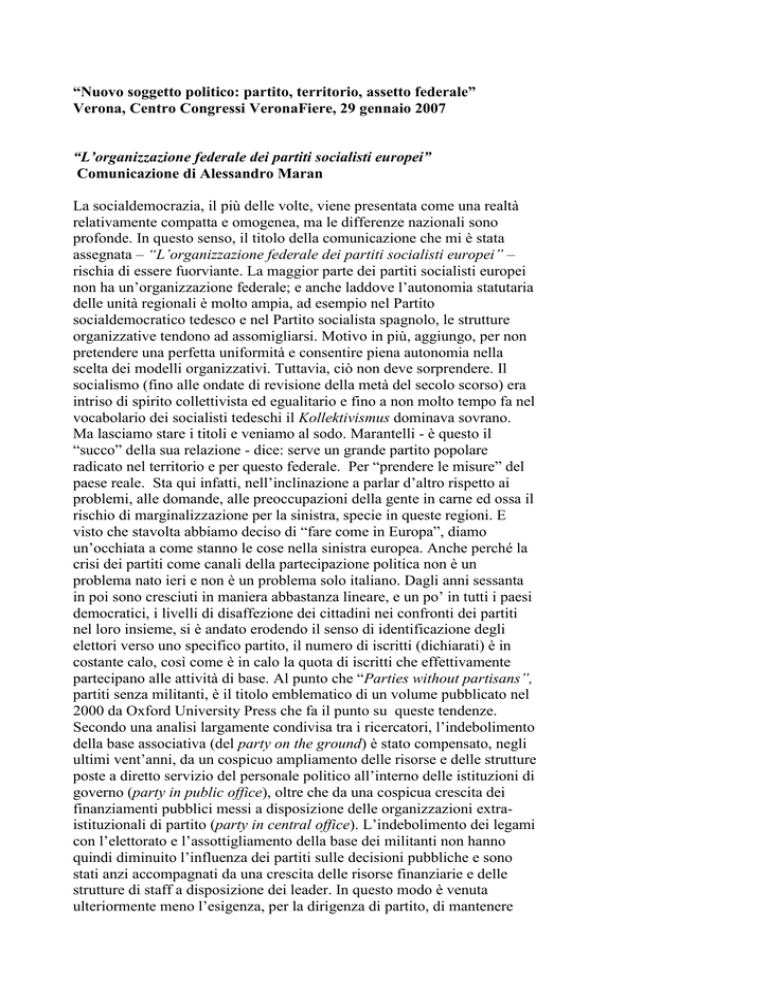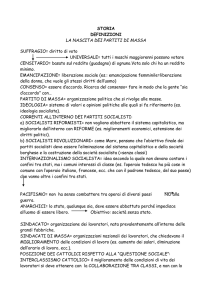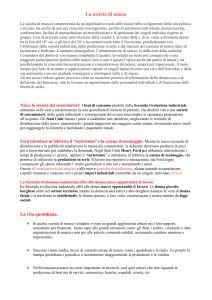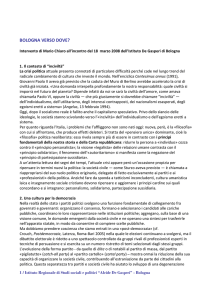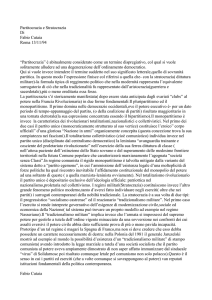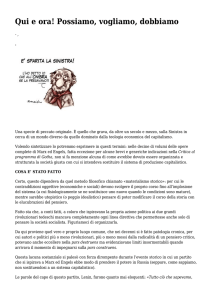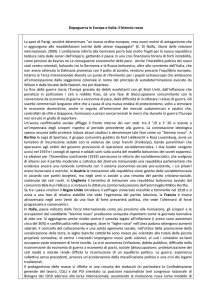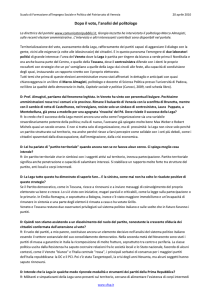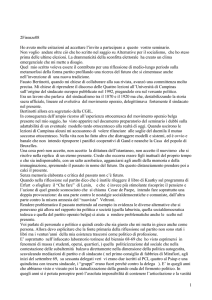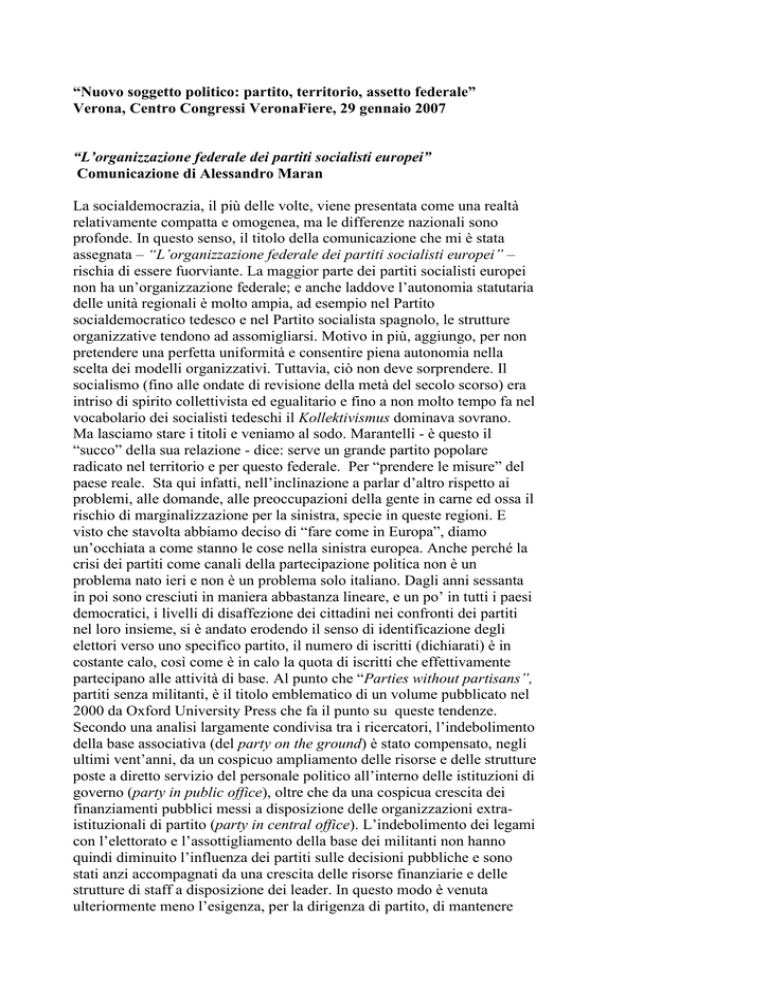
“Nuovo soggetto politico: partito, territorio, assetto federale”
Verona, Centro Congressi VeronaFiere, 29 gennaio 2007
“L’organizzazione federale dei partiti socialisti europei”
Comunicazione di Alessandro Maran
La socialdemocrazia, il più delle volte, viene presentata come una realtà
relativamente compatta e omogenea, ma le differenze nazionali sono
profonde. In questo senso, il titolo della comunicazione che mi è stata
assegnata – “L’organizzazione federale dei partiti socialisti europei” –
rischia di essere fuorviante. La maggior parte dei partiti socialisti europei
non ha un’organizzazione federale; e anche laddove l’autonomia statutaria
delle unità regionali è molto ampia, ad esempio nel Partito
socialdemocratico tedesco e nel Partito socialista spagnolo, le strutture
organizzative tendono ad assomigliarsi. Motivo in più, aggiungo, per non
pretendere una perfetta uniformità e consentire piena autonomia nella
scelta dei modelli organizzativi. Tuttavia, ciò non deve sorprendere. Il
socialismo (fino alle ondate di revisione della metà del secolo scorso) era
intriso di spirito collettivista ed egualitario e fino a non molto tempo fa nel
vocabolario dei socialisti tedeschi il Kollektivismus dominava sovrano.
Ma lasciamo stare i titoli e veniamo al sodo. Marantelli - è questo il
“succo” della sua relazione - dice: serve un grande partito popolare
radicato nel territorio e per questo federale. Per “prendere le misure” del
paese reale. Sta qui infatti, nell’inclinazione a parlar d’altro rispetto ai
problemi, alle domande, alle preoccupazioni della gente in carne ed ossa il
rischio di marginalizzazione per la sinistra, specie in queste regioni. E
visto che stavolta abbiamo deciso di “fare come in Europa”, diamo
un’occhiata a come stanno le cose nella sinistra europea. Anche perché la
crisi dei partiti come canali della partecipazione politica non è un
problema nato ieri e non è un problema solo italiano. Dagli anni sessanta
in poi sono cresciuti in maniera abbastanza lineare, e un po’ in tutti i paesi
democratici, i livelli di disaffezione dei cittadini nei confronti dei partiti
nel loro insieme, si è andato erodendo il senso di identificazione degli
elettori verso uno specifico partito, il numero di iscritti (dichiarati) è in
costante calo, così come è in calo la quota di iscritti che effettivamente
partecipano alle attività di base. Al punto che “Parties without partisans”,
partiti senza militanti, è il titolo emblematico di un volume pubblicato nel
2000 da Oxford University Press che fa il punto su queste tendenze.
Secondo una analisi largamente condivisa tra i ricercatori, l’indebolimento
della base associativa (del party on the ground) è stato compensato, negli
ultimi vent’anni, da un cospicuo ampliamento delle risorse e delle strutture
poste a diretto servizio del personale politico all’interno delle istituzioni di
governo (party in public office), oltre che da una cospicua crescita dei
finanziamenti pubblici messi a disposizione delle organizzazioni extraistituzionali di partito (party in central office). L’indebolimento dei legami
con l’elettorato e l’assottigliamento della base dei militanti non hanno
quindi diminuito l’influenza dei partiti sulle decisioni pubbliche e sono
stati anzi accompagnati da una crescita delle risorse finanziarie e delle
strutture di staff a disposizione dei leader. In questo modo è venuta
ulteriormente meno l’esigenza, per la dirigenza di partito, di mantenere
saldi legami con la base da cui un tempo si traevano risorse finanziarie e
disponibilità di lavoro volontario. Cosicché, sempre secondo la tesi
enunciata da Richard Katz e Peter Mair, i partiti si sono generalmente
trasformati da associazioni di cittadini in società di professionisti, con tutto
quel che ne consegue per il ricambio, sempre meno fluido, della classe
dirigente.
Per ricomporre il rapporto logorato tra società e politica, società e
istituzioni, nel nostro Paese la proposta in questi anni è stata quella del
federalismo. Una proposta confusa (prima della devolution la Lega ha
proclamato e teorizzato come obiettivo politico l’indipendenza del nord,
vale a dire la secessione) e una disputa (di quale federalismo si parla? Con
quali e quante unità territoriali? Con quali poteri e quali risorse?) che ha
assunto connotati fortemente ideologici. Al punto che il federalismo, il più
delle volte, è stato concepito da sostenitori e avversari come una versione
debole della secessione.
Si è parlato infatti non di un programma e un modello per riformare le
istituzioni, l’amministrazione e l’organizzazione dello Stato e rispondere
concretamente alle domande e ai bisogni del territorio, ma di un valore da
affermare in alternativa e in contrapposizione allo Stato, per delineare una
patria e un popolo. Abbiamo assistito, negli anni passati ad una
conversione rapidissima e contraddittoria di tutto il ceto politico di sinistra
al federalismo. Abbiamo sentito di tutto e il contrario di tutto, fino alla
“Repubblica delle città”. Ma ora che è cambiato il vento, il federalismo passatemi la battuta - rischia di fare la fine della socialdemocrazia:
dichiarata morta senza averla neppure sperimentata. Infatti, se prima chi
non era federalista era un nemico del popolo, oggi parlare di federalismo è
diventato sconveniente. Al punto che il dibattito sullo spazio locale sembra
rimosso e stigmatizzato. Come se si fosse trattato di una moda passeggera,
ormai consumata.
Ovviamente, dentro l’istanza federalista c’erano varie componenti. Alcune
di queste ci accomunano al resto d’Europa e, come sempre, altre ci fanno
diversi.
C’era, prima di tutto, l’opposizione ai partiti politici della Prima
Repubblica che si sono sempre più allontanati dalla comprensione del
Paese e delle sue istanze. C’era l’opposizione a Roma “ladrona” che
coniuga la tradizionale avversione delle periferie provinciali nei confronti
della capitale con il fatto che Roma è il simbolo e il luogo di un
centralismo che si ritiene vivere a spese delle “periferie produttive”; una
opposizione che si nutre anche del fatto che la città rientra nella sfera della
cultura meridionale. Dentro l’istanza federalistica bisogna leggere anche
l’insoddisfazione per l’inadeguatezza delle infrastrutture territoriali locali
rispetto al dinamismo dell’economia; e si può leggere il persistere del vivo
localismo italiano e non solo di quello fondato su identità comunitarie.
Inoltre, si può leggere la domanda politica e insieme ideologica di porre
rimedio al mondo in cui è stato costruito lo stato unitario.
Ma a ben guardare la Lega Nord, e non per caso, affondava le sue radici
nella rivolta dei ceti produttori in Italia e nel mondo. Infatti lo stesso filo
rosso – la sollevazione dei produttori contro la burocrazia parassitaria –
legava la Lega Nord alla protesta colta ed espressa, tra i primi, da Ronald
Regan: la rivolta dei produttori californiani contro la “truffa statalista” dei
democratici.
Qualcuno forse ricorderà le due storiche battute di Ronald Regan nel
dibattito televisivo finale con Jimmy Carter. Il moderatore chiese ad
entrambi che cosa del rivale lo infastidisse di più. E Regan rispose: “Il
fatto che dinanzi ad un problema qualsiasi Mr. Carter sappia reagire in un
solo modo: creando un bell’ente pubblico cui affidare lo studio del
problema e i fondi per la sua soluzione”. L’altra battuta fu quella
conclusiva: “Per troppi anni – disse Ronald Regan – abbiamo creduto di
poter affidare allo Stato la soluzione di ogni nostro problema. Ora abbiamo
capito che proprio lo Stato è il nostro peggiore problema”.
Queste storiche battute, che hanno annunciato la rivoluzione liberista degli
anni ’80 e che hanno assicurato a Regan la conquista della presidenza,
sono state riproposte nel nostro Paese dieci anni dopo da Umberto Bossi e,
più tardi, da Berlusconi. Alla nostra maniera. Infatti, in Italia tutte le cose
americane diventano presto sudamericane. Inevitabilmente.
Nel frattempo la Lega Nord è diventata un’altra cosa. Da tempo la Lega,
da fenomeno innovativo, è diventata fenomeno tradizionalista. Non si
occupa più della modernizzazione, ma della tradizione. Ce lo ha ricordato
qualche tempo fa Ilvo Diamanti, lo studioso che ha seguito la Lega per
anni: «Bossi era il Lutero del Nord, oggi è solo il predicatore dei guasti,
delle paure (...). Ieri rappresentava la spinta di una parte della società,
oggi sta cercando di sopravvivere alla trasformazione sociale,
identificandosi con il tradizionalismo religioso e sociale». In questo modo,
tuttavia, la CdL finisce per ispirarsi non al popolarismo europeo, ma al
populismo conservatore americano degli anni 90, un’ampia e diversificata
corrente sociale di cui la Christian Coalition era l’espressione più potente
e meglio organizzata. La Christian Coalition divenne infatti a metà degli
anni 90 il più importante blocco elettorale unitario dentro il partito
repubblicano, nonché una forza decisiva in molte elezioni a livello locale,
statale e federale, diventando l’equivalente funzionale del peso che hanno i
sindacati nel partito democratico. E lo straordinario sviluppo del
fondamentalismo cristiano registrato nell’ultimo decennio negli Stati Uniti
e la sua trasformazione in una forza politica ben organizzata sono in
relazione con la ricostruzione dell’identità e la resistenza alla
disintegrazione della famiglia tradizionale: i punti centrali del programma
elettorale della Lega Nord. Il che spiega perché la Lega è l’unico partito
autonomista che in Europa si sia alleato con la destra. In buona sostanza,
perché, nonostante l’invenzione della Padania, la Lega non è affatto un
“tradizionale” partito autonomista.
Naturalmente, questa circostanza dice qualcosa anche su di noi. Sui
problemi che hanno tradizionalmente viziato la presenza della sinistra in
questa realtà socio- economica. Problemi che, come ha scritto Diamanti,
vanno ricondotti più che al “fattore K” al “fattore E”. E come Esclusione,
anzitutto. “L’esclusione da parte di un ambiente che ha vissuto la
tradizione, la cultura, l’organizzazione del PCI come “alternativi” a quella
dominante fondata sulla Chiesa”. Ed E come Estraneità. “L’atteggiamento
di estraneità del Pci rispetto alle ragioni e ai caratteri che preparano e
accompagnano lo sviluppo del Nord-Est. Rispetto all’economia diffusa,
alle piccole imprese agli imprenditori e ai lavoratori di questa realtà
produttiva, alla dispersione urbana, alle domande di autonomia
amministrativa e di mercato, al peso delle reti sociali di solidarietà. L’idea
di sviluppo della sinistra e del Pci verteva, invece, sulla grande azienda,
sulle grandi concentrazioni urbane, sulla classe operaia della grande
impresa industriale, sulla centralità dello Stato e dei suoi apparati, sulla
“pubblicità” delle politiche sociali. Logico che quel che avveniva nel
Nord-Est venisse considerato marginale, “estraneo”. Una forma di
sviluppo arretrato oppure dipendente dall’esterno”. Per molto tempo è
stato così. Ma non c’è verso: per essere riconosciuta da questa realtà, la
sinistra deve riconoscerne fino in fondo l’identità e le logiche.
In Europa gli stessi problema sono stati affrontati dai partiti socialisti sul
piano del rinnovamento politico e culturale. Infatti, un po’ dappertutto in
Europa socialismo, liberalismo, personalismo cristiano stanno
convergendo nella costruzione di una nuova politica dello sviluppo e
dell’inclusione. Del resto, come dicevo, la sinistra europea si presenta
come una realtà culturale complessa; e solo con molta fantasia si possono
ricondurre le profonde specificità nazionali all’ortodossia di un “unico”
socialismo europeo. Solo limitandoci all’esperienza inglese, a quella
tedesca, a quella francese, si intravedono molteplici fili, schematicamente
riconducibili a tre grandi tradizioni del pensiero politico della civiltà
europea e del secolare movimento democratico europeo: il socialismo,
approdato nel dopoguerra a esperienze socialdemocratiche, basate sul
lavoro dipendente e su politiche di welfare; il liberalismo della giustizia e
dei diritti, di tradizione inglese e americana, cui hanno fornito un solido
impianto teorico Dahrendorf, Habermas, Giddens e la London School of
Economics; il cristianesimo personalista e comunitario, di cui Delors è il
rappresentante più noto a livello europeo, che affonda le proprie radici nel
cattolicesimo sociale e politico bavarese, francese e italiano. Questi filoni
sono variamente intrecciati nei partiti della sinistra europea. L’operazione
melting pot relativamente più recente è quella compiuta da Mitterrand nel
1971 a Epinay, che ha fuso i resti della vecchia Sfio (Section française de
l’Internationale Ouvrière) con frammenti ex-democristiani, radicali,
socialisti di sinistra, liberaldemocratici; e lo stesso Mitterrand era il leader
di una piccola formazione autonoma, non appartenente alla tradizione
socialista. Insomma, i partiti socialisti europei sono diventati (come li ha
definiti Gino Giugni) dei veri e propri “crocevia culturali” che sono stati
capaci di metabolizzare e addirittura egemonizzare le tendenze innovative
sorte su altri terreni. Al punto che “non è ormai azzardato affermare che la
socialdemocrazia è l’erede storica del liberalismo, ovvero che è stata la
riscoperta dei valori di principio del liberalismo a rigenerare
profondamente la socialdemocrazia”.
Basta dare un’occhiata ai valori e agli obiettivi comuni a tutti i programmi
dei partiti socialdemocratici per constatare che, da un bel pezzo, il
socialismo come fine ultimo, come via verso una “nuova società” non
esiste più. E’ stato sostituito dall’ideale del progresso come processo per
tentativi ed errori. Insomma, da tempo il pragmatismo, lo sperimentalismo
e la “società aperta” hanno vinto la partita e “Popper ha sconfitto Marx”.
Ad esempio, il programma della SPD, per quanto riguarda le radici
spirituali del socialismo, parla di cristianesimo, di filosofia umanista, di
illuminismo, di dottrina storica e sociologica di Marx, di esperienza dei
movimenti dei lavoratori e della liberazione delle donne, ecc. Questa
filosofia sincretistica è comune a tutti i partiti socialisti europei. Infatti, la
socialdemocrazia ha assorbito come una spugna gran parte dei progetti più
creativi del liberalismo anglosassone e l’alternativa non è proprio così
netta come spesso viene raffigurata. Anche perché intanto nella cultura
anglosassone la dottrina liberale si è spostata dalla fede assoluta nel
mercato ad una critica avveduta dei suoi limiti; al punto che verrebbe
davvero da chiedersi se ci sia differenza tra socialisti e kennediani, per
usare l’espressione adoperata da Fassino. Ma la questione nominalistica
non ha molto senso. Il punto è che “il socialismo è un fenomeno europeo,
così come il liberalismo nelle sue variazioni più spinte, di New Deal, di
Fair Deal o della New Frontier, è un fenomeno americano”. Ma se il “fine
ultimo” non esiste più, “allora il terreno comune sta nei valori comuni”. E
se c’è una differenza, questa sta proprio nel profilo di cittadinanza che è
sempre stato al centro del messaggio ideologico dei socialisti, al punto che
Bobbio ne ha fatto l’elemento di distinzione rispetto ad altre ideologie
moderne: l’uguaglianza. Ma anche l’uguaglianza non è più concepita come
uniformità ma come diritto alle uguali opportunità; e, non per caso, da
tempo l’auto-realizzazione (Selbst-Behauptung) è uno dei valori più
enfatizzati nel programma della SPD. Al punto che perfino l’attaccamento
dei socialisti all’unica realizzazione che ha resistito alla prova del
consenso e dell’esperienza e che ha caratterizzato la vicenda di un secolo,
lo Stato sociale, ha due importanti correttivi:
- il welfare è costruito sulla disponibilità dello strato sociale più forte a
condividere i propri vantaggi con quello più debole senza però modificare
al peggio la sua condizione di vita. Beninteso, niente di nuovo: già
Vilfredo Pareto stabiliva che un intervento era ottimale quando migliorava
almeno il benessere di un individuo senza danneggiare in alcun modo tutti
gli altri soggetti, ma qui quel che più conta sottolineare è che il pauperismo
o l’austerità non appartengono al way of life socialista;
- compito dello Stato sociale è quello di costituire una guida per
l’iniziativa degli individui e dei gruppi e non di liberare individui e gruppi
dalle proprie responsabilità.
Insomma, l’evoluzione in senso liberalsocialista ha condotto per spinta
naturale ad una ricollocazione dell’individuo al centro della tavola dei
valori e degli obiettivi. La stessa idea di eguaglianza, ma delle opportunità,
esalta l’individuo e la sua capacità di affrontare il proprio destino e fa
riemergere il significato del merito fino a una riconsiderazione in chiave
positiva della stessa meritocrazia. Ovviamente, se corrisponde al vero che
il socialismo si è copiosamente abbeverato alla fonte della “cultura dei
diritti” civili e individuali, è anche vero che se c’è un valore identificante
del vissuto socialista questo è il solidarismo, l’azione collettiva, su cui si
regge lo stesso impianto della democrazia diffusa. E la solidarietà, termine
con molte facce semantiche, è molto simile al comunitarismo che, come ha
ricordato Tony Blair, una volta ripulito dalla patina conservatrice con la
quale è stato ricoperto specie nella cultura sociologica dell’Europa
continentale, significa semplicemente working toghether.
Un valore che non a caso torna in primo piano in un paese in cui un
decennio di sfrenato individualismo ha prodotto fenomeni drammatici di
disgregazione sociale. E che potrebbe tornare buono nel “Paese impazzito”
di cui ha parlato Prodi. Ed è proprio il welfare a costituire il principale
punto di raccordo tra i valori espressi nel secolo socialdemocratico, le sue
realizzazioni e le ragioni di continuità.
Ora anche in Italia c’è l’esigenza di costruire la sinistra come crogiuolo dei
diversi filoni che si sono variamente intrecciati nella sinistra europea,
quale condizione del suo radicamento. Che ci porti all’altezza politica,
elettorale e culturale della sinistra europea.
Se così stanno le cose è evidente che la riforma dello stato che procede dal
federalismo non ha perso nulla della sua urgenza e del suo interesse. Oggi che il
federalismo non gode di grandissima popolarità e sembra diventato un problema
(cessata la protesta e venuta meno la paura della secessione è venuto meno
anche l’interesse verso tale riforma), non sarebbe male tenere a mente che
quella di nuove regole e di nuove istituzioni è una strada “imposta da emergenze
e fratture”, che abbiamo scelto proprio “per sanare il contrasto fra società e
Stato, fra società e politica”. Un contrasto che non è risolto per il fatto che di
marce sul Po non se ne fanno più e i giornali (e le associazioni degli industriali)
hanno smesso di parlare del Veneto come se fosse l’Ulster .
Il fatto è che la riforma non può essere pensata come una mera operazione di
trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni (un centralismo che non viene
cioè riformato, ma frantumato e riprodotto lasciandone intatta la sostanza
intrusiva): deve essere l’occasione di un ripensamento del rapporto cittadinoautorità nel nostro sistema costituzionale. Non è un caso che nel “Manifesto per
la nuova sinistra” che Blair, Kok, Persson e Schroeder hanno proposto qualche
anno fa, tra “i tre pilastri fondamentali del progresso globale” ci sia l’esigenza
di “rafforzare la società civile”. Poiché “la società civile fa da freno sia
all’arroganza dei governi che allo strapotere del mercato”. Infatti, la cosa più
importante non sono i cambiamenti istituzionali, ma l’“empowerment of
individuals”, che anche se è detto in inglese, tutti gli italiani capiscono molto
bene, perché è il cittadino che vuole (e deve) diventare il vero soggetto
decisionale. Persino la maggior parte degli elettori che sostiene Silvio
Berlusconi non domanda un’autorità più forte. Al contrario, vuole maggiore
libertà e meno regole per poter raggiungere i propri obiettivi personali.
Una delle componenti del pensiero federalista è sempre stata la ricerca di spazi
di autonomia e libertà per i cittadini, proprio attraverso forme di contenimento e
di distribuzione articolata del potere pubblico. E questa è un’esigenza che non è
venuta meno. Il compito di riportare l’attenzione sul federalismo come progetto
riformista (e cioè su pochi principi guida: responsabilità, flessibilità-adattabilità,
autonomia fiscale, funzionalità) spetta a chi, nonostante tutto, si ostina a credere
nella sua utilità per l’intero Paese. In altre parole, quel che serve al Paese è una
iniezione di cultura della concorrenza a tutti i livelli; e il punto forte del
federalismo è che inserisce la concorrenza anche nella politica, generando
responsabilità ed efficienza. Il nostro pieno ricongiungimento all’Europa è
ancora incompiuto. Manca il pilastro costituito dai soggetti politici. E il Partito
democratico deve servire proprio al pieno “ricongiungimento” dell’Italia
all’Europa. Se infatti si vogliono salvare i partiti e la loro funzione è necessario
che si modifichino radicalmente il rapporto tra il partito e i cittadini (nel senso
di dare la priorità ai cittadini e ai loro diritti) e il rapporto tra il partito e lo Stato
(nel senso di eliminare completamente ogni base di prevaricazione e di
occupazione dello Stato da parte dei partiti). Tutti noi il 16 ottobre abbiamo
scoperto che l’assenza di partecipazione e l’atrofia della democrazia nei partiti
non è un male incurabile. C’è tanta gente ancora interessata a far pesare le
proprie opinioni. E se guardiamo ai maggiori partiti spagnoli, britannici o
tedeschi, capiamo subito qual è la direzione da prendere e quali sono le eredità
del passato che dobbiamo superare. I nodi principali sono due: la
ricomposizione della leadership di partito e di governo; la reale contendibilità e
dunque il periodico ricambio della leadership stessa. Ne ha parlato Vassallo. Il
nostro Paese ha bisogno di un partito anti-oligarchico, culturalmente plurale,
adeguato alla sfida del governo. Un partito plurale dovrebbe essere anche un
partito federale. Come spesso accade, la forma è sostanza.