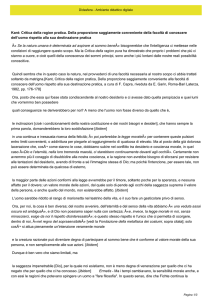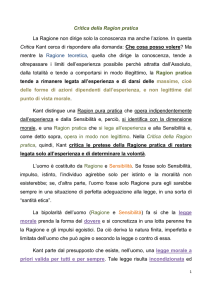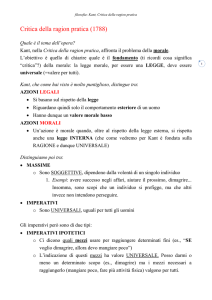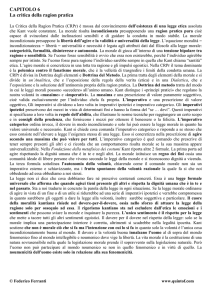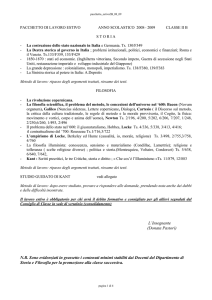La Critica della ragion pratica
La ragione serve a dirigere non solo la conoscenza, ma anche l'azione. Accanto alla ragione
teoretica abbiamo quindi una ragione pratica.
Kant distingue tuttavia tra una ragion pura pratica (cioè che opera indipendentemente
dall'esperienza e dalla sensibilità) e una ragione empirica pratica (cioè che opera sulla base
dell'esperienza e della sensibilità). E poiché la dimensione della moralità si identifica con la
dimensione della ragion pura pratica, il filosofo dovrà distinguere in quali casi la ragione è pratica
e, nello stesso tempo, pura (ovvero morale) e in quali casi essa è pratica senza essere pura (ovvero
senza essere morale). A questo serve appunto la Critica della ragion pratica.
Questa seconda Critica - si badi bene - «non sarà, però, una "critica della ragione pura pratica",
come la prima Critica era una "critica della ragione pura teoretica", perché, mentre la ragione
teoretica ha bisogno di essere criticata, cioè sottoposta ad esame, anche nella sua parte pura,
in quanto tende a comportarsi in modo illegittimo (valicando i limiti dell'esperienza), la ragione
pratica non ha bisogno di essere criticata nella sua parte pura, perché in questa essa si
comporta in modo perfettamente legittimo, obbedendo ad una legge appunto universale.
Invece nella sua parte non pura, cioè legata all'esperienza, la ragione pratica può darsi delle
massime, cioè delle forme di azione, dipendenti appunto dall'esperienza, e perciò non legittime dal
punto di vista morale. Perciò deve essere sottoposta a critica» (E. Berti). In altri termini «la
situazione della Critica della Ragion pratica si presenta come esattamente capovolta rispetto alla
Critica della Ragion pura: nella "ragion pratica" le pretese di andare oltre i propri limiti legittimi
sono quelle della ragion pratica empirica (legata all'esperienza), che vorrebbe essa sola determinare
la volontà; invece, nella "ragione teoretica" le pretese della ragione, al contrario, erano di far a
meno dell'esperienza, e di raggiungere da sola (senza l'esperienza) l'oggetto.
Insomma: mentre nella Critica della Ragion pura Kant ha criticato le pretese della ragione teoretica
(che rappresentano un eccesso) di trascendere l'esperienza, nella Critica della Ragion pratica, egli
ha criticato invece le pretese opposte della ragion pratica (che rappresentano un difetto) di restare
legata sempre e solo all'esperienza. Perciò il titolo è: "Critica della Ragion pratica", e non "Critica
della Ragion pura pratica"» (Reale-Antiseri).
In altri termini - e a questo punto possiamo usare le parole stesse di Kant - il capolavoro morale del
filosofo di Konigsberg si propone di stabilire «non solo che la ragione pura può essere pratica, ma
che essa sola, e non la ragione sottostante a limiti empirici, è pratica in modo incondizionato».
Il fatto che la ragion pura pratica non debba venir criticata, ma semplicemente illustrata nelle sue
strutture e funzioni, non significa tuttavia - l'osservazione è importante - che essa sia priva di
limiti; infatti, come vedremo, la morale, secondo Kant, risulta profondamente segnata dalla
finitudine dell'uomo e necessita di essere salvaguardata dal fanatismo, ossia dalla presunzione di
identificarsi con l'attività di un essere infinito (v. "Glossario"). Certo, scrive Chiodi, articolando
l'interpretazione (abbagnaniana) di Kant come "filosofo del finito", «il mondo morale non ubbidisce
allo stesso genere di restrizioni del mondo della conoscenza. Nel campo morale la ragione umana
non è condizionata dai fenomeni come nel mondo della conoscenza; ma è un errore credere che
Kant restauri nel campo morale l'assolutezza della metafisica. La ragione morale è pur sempre la
ragione d'un essere pensante finito e quindi condizionato. Il condizionamento che la finitudine
umana introduce nel campo morale è costituito dal fatto che la ragione vi incontra costantemente ed
ineliminabilmente la resistenza della natura sensibile dell'uomo». Resistenza che obbliga la legge
morale ad assumere la forma del "dovere".
La realtà e l'assolutezza della legge morale
II motivo che sta alla base della Critica della ragion pratica è la persuasione che esista, scolpita
1
nell'uomo, una legge morale a priori valida per tutti e per sempre. In altri termini, come nella
Critica della ragion pura Kant muoveva dall'idea dell'esistenza di conoscenze scientifiche
universali e necessarie, nella Critica della ragion pratica muove dall'analogo convincimento
dell'esistenza di una legge etica assoluta. Legge che il filosofo non ha il compito di "dedurre", e
tanto meno di "inventare", ma unicamente di "constatare", a titolo di «un fatto della ragion pura, di
cui abbiamo consapevolezza a priori e di cui siamo apoditticamente certi» (Critica della ragion
pratica, A. 81).
Come si vede, che esista qualcosa come una legge morale assoluta o «incondizionata» come la
chiama testualmente Kant) è qualcosa su cui il filosofo non ha dubbi. Dal suo punto di vista, infatti,
o la morale è una chimera, in quanto l'uomo agisce in virtù delle sole inclinazioni naturali, oppure,
se esiste, risulta per forza incondizionata, presupponendo una ragion pratica "pura", cioè capace di
svincolarsi dalle inclinazioni sensibili e di guidare la condotta in modo stabile. Di conseguenza, la
tesi dell'assolutezza o incondizionatezza della morale implica, per Kant, due concetti di fondo
strettamente legati tra loro: la libertà dell'agire e la validità universale e necessaria della
legge. Essendo incondizionata, infatti, la morale implica la capacità umana di autodeterminarsi al di
là delle sollecitazioni istintuali, facendo sì che la libertà si configuri come il primo presupposto - o
«postulato», come Kant dirà in seguito - della vita etica: «La libertà e la legge pratica
incondizionata risultano dunque reciprocamente connesse» (Critica della ragion pratica, A 52).
Essendo indipendente dagli impulsi del momento e da ogni condizione particolare, la legge risulterà
anche, per definizione, universale e necessaria, ossia immutabilmente uguale a se stessa in ogni
tempo e luogo.
L’equazione "moralità = incondizionatezza = libertà = universalità e necessità" rappresenta quindi il
fulcro dell'analisi etica di Kant e la chiave di volta, come vedremo, per cogliere in modo
logicamente concatenato gli attributi essenziali che il filosofo riferisce alla legge morale:
categoricità, formalità, disinteresse e autonomia. Però si badi bene: per Kant la morale è ab-soluta,
cioè sciolta dai condizionamenti istintuali, non nel senso che possa prescinderne, ma perché è in
grado di de-condizionarsi rispetto a essi. La morale si gioca infatti all'interno di una tensione
bipolare tra ragione e sensibilità. Se l'uomo fosse esclusivamente sensibilità, ossia animalità e
impulso, è ovvio che essa non esisterebbe, perché l'individuo agirebbe sempre per istinto.
Viceversa, se l'uomo fosse pura ragione, la morale perderebbe ugualmente di senso, in quanto
l'individuo sarebbe sempre in quella che Kant chiama «santità» etica, ovvero in una
situazione di perfetta adeguazione alla legge.
Invece la bidimensionalità dell'essere umano fa sì che per Kant l'agire morale prenda la forma
severa del «dovere» e si concretizzi in una lotta permanente tra la ragione e gli impulsi egoistici. Da
ciò la natura finita, ossia limitata e imperfetta, dell'uomo, che può agire secondo la legge, ma anche
contro la legge. Pertanto, come nella Critica della ragion Pura circola come tema dominante la
polemica contro l'arroganza della ragione, che pretende di oltrepassare i limiti della conoscenza
umana, nella Critica della ragion pratica circola come tema dominante la polemica contro il
fanatismo morale, che è la velleità di trasgredire i limiti della condotta umana, sostituendo alla virtù,
che è l'intenzione morale in lotta, la pretesa santità di credersi in possesso della perfezione etica.
La "categoricità" dell'imperativo morale
Gli uomini non agiscono – normalmente – a casaccio, bensì seguono delle regole d’azione o
principi pratici. Kant distingue i principi pratici che regolano la nostra volontà in «massime» e
«imperativi». La massima è una prescrizione di valore puramente soggettivo, cioè valida
esclusivamente per l'individuo che la fa propria (ad esempio può essere una massima quella di
vendicarsi di ogni offesa subita o di alzarsi presto al mattino per fare ginnastica). L'imperativo è
una prescrizione di valore oggettivo, ossia che vale per chiunque. Gli imperativi si dividono a loro
volta in imperativi ipotetici e imperativo categorico.
Gli imperativi ipotetici prescrivono dei mezzi in vista di determinati fini e hanno la forma del "se...
2
devi" (ad esempio: "se vuoi conseguire buoni risultati scolastici, devi impegnarti in modo
costante"). Questi imperativi si specificano a loro volta in regole dell'abilità, che illustrano le norme
tecniche per raggiungere un certo scopo (ad esempio le varie procedure per divenire un buon
medico), e in consigli della prudenza, che forniscono i mezzi per ottenere il benessere o la felicità
(ad esempio i vari "manuali" della salute o del vivere felici).
L'imperativo categorico, invece, ordina il dovere in modo incondizionato, ossia a prescindere da
qualsiasi scopo, e non ha la forma del "se... devi", ma del "devi" puro e semplice. Ora, essendo la
morale strutturalmente incondizionata, cioè indipendente dagli impulsi sensibili e dalle mutevoli
circostanze, risulta evidente che essa non potrà risiedere negli imperativi ipotetici, che sono,
per definizione, condizionati e variabili. Infatti, solo l'imperativo categorico, in quanto incondizionato, ha i connotati della legge, ovvero di un comando che vale in modo perentorio per
tutte le persone e per tutte le circostanze. In conclusione, solo l'imperativo categorico, che ordina
un 'devi" assoluto, e quindi universale e necessario, ha in se stesso i contrassegni della
moralità.
Posto che la legge etica assuma la forma di un «imperativo categorico», che cosa comanda
quest'ultimo? Kant risponde che esso, in quanto incondizionato - ossia non richiedente altro che il
rispetto della legge in generale - consiste nell'elevare a legge l'esigenza stessa di una legge. E
poiché dire legge è dire universalità, esso si concretizza nella prescrizione di agire secondo una
massima che può valere per tutti. Da ciò la formula-base nell'imperativo categorico:
Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come
principio di una legislazione universale.
(Critica della ragion pratica, A 54)
In altri termini, l'imperativo categorico - il quale si identifica con la ragione stessa, ovvero con la
sua universalità elevata a legge - è quel comando che prescrive di tener sempre presenti gli altri e
che ci ricorda che un comportamento risulta morale solo se, e nella misura in cui, supera il "test
della generalizzabilità" ovvero se la sua massima appare universalizzabile. Ad esempio, chi mente
compie un atto chiaramente immorale, poiché qualora venisse universalizzata la massima
dell'inganno i rapporti umani diventerebbero impossibili. Questa è l'unica formula che Kant
presenta nella Critica della ragion pratica e che ribadisce con la cosiddetta «Tipica del giudizio puro
pratico» . Invece, nella Fondazione della metafisica dei costumi troviamo anche una seconda e una
terza formula. La seconda afferma:
agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre
anche come fine e mai semplicemente come mezzo.(Fondazione della metafisica dei costumi,
BA 67-68)
In altri termini, rispetta la dignità umana che è in te e negli altri, evitando di ridurre il prossimo o te
medesimo a semplice mezzo del tuo egoismo e delle tue passioni. In questo contesto la parola "fine"
indica quella caratteristica fondamentale della persona umana che risiede nell'essere scopo-a sestessa, facendo sì che a essa venga riconosciuta la prerogativa di essere soggetto e non oggetto.
Tant'è vero che Kant sostiene che la morale istituisce un «regno dei fini», ossia una comunità ideale
di libere persone, che vivono secondo le leggi della morale e si riconoscono dignità a vicenda. La
terza formula prescrive di agire in modo tale che «la volontà, in base alla massima, possa
considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice» (Fondazione della
metafisica dei costumi, BA 76). Questa formula ripete, in parte, la prima. Tuttavia, a differenza di
quella, che puntualizza soprattutto la legge, quest'ultima sottolinea in modo particolare l'autonomia
della volontà, chiarendo come il comando morale non sia un imperativo esterno e schiavizzante,
ma il frutto spontaneo della volontà razionale, la quale, essendo legge a se medesima, fa sì che
noi, sottomettendoci ad essa, non facciamo che obbedire a noi stessi. Tant'è vero che nel "regno
dei fini", precisa Kant, ognuno è suddito e legislatore al tempo stesso. In altre parole:
3
la volontà non è semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in modo da dover essere
considerata autolegislatrice, e solo a questo patto sottosta alla legge (Fondazione della
metafisica dei costumi, BA 70-71)
La "formalità" della legge e il dovere
Un'altra caratteristica strutturale dell'etica kantiana, che emerge chiaramente da quanto si è detto
finora circa l'imperativo categorico, è la formalità, in quanto la legge non ci dice che cosa
dobbiamo fare, ma come dobbiamo fare ciò che facciamo. Anche ciò discende dalla riconosciuta
incondizionatezza e libertà della norma etica. Infatti, se quest'ultima non fosse formale, bensì
"materiale", e prescrivesse quindi dei contenuti concreti, sarebbe "vincolata" a essi, perdendo
inevitabilmente in termini di libertà da un lato e di universalità dall'altro, poiché nessun
contenuto o precetto particolare può possedere l'universale portata della legge. Questo significa che
l'imperativo etico non può risiedere in una casistica o manualistica concreta di precetti, ma soltanto
in una legge formale - universale, la quale afferma semplicemente: quando agisci tieni
presenti gli altri e rispetta la dignità umana che è in te e nel prossimo. Ovviamente secondo
Kant sta poi a ognuno di noi "tradurre" in concreto, nell'ambito delle varie situazioni esistenziali,
sociali e storiche, la parola della legge. L'importante è non dimenticare che le norme etiche concrete
in cui si incarna di volta in volta l'imperativo categorico risultano sempre fondate e mai fondanti nei
suoi confronti, esistendo solo in funzione di esso, che è ciò che le suscita e le giustifica. Il carattere
formale e incondizionato della legge morale fa tutt'uno con il carattere anti-utilitaristico
dell'imperativo etico. Infatti,
se la legge ordinasse di agire in vista di un fine o di un utile, si ridurrebbe a un insieme
di imperativi ipotetici e comprometterebbe, in primo luogo, la propria libertà, in
quanto non sarebbe più la volontà a dare la legge a se medesima, ma gli oggetti a dare
la legge alla volontà.
In secondo luogo, essa metterebbe in forse la propria universalità, poiché l'area degli
scopi e degli interessi coincide con il campo della soggettività e della particolarità.
Il cuore della moralità kantiana risiede invece nel dovere-per-il-dovere, ossia nello sforzo di attuare
la legge della ragione solo per ossequio a essa, e non sotto la spinta di personali inclinazioni o in
vista di risultati che possono scaturirne.
Di conseguenza, secondo la Critica della ragion pratica, noi non dobbiamo agire per la felicità, ma
solo per il dovere:
Dovere! Nome sublime e grande, che non porti con te nulla di piacevole che importi lusinga;
ma esigi la sottomissione; che tuttavia non minacci nulla [...] ma presenti semplicemente una
legge che penetra da sé sola nell'animo e si procura venerazione (Critica della ragion pratica, A
154)
Da ciò il cosiddetto "rigorismo" kantiano, che esclude dal recinto dell'etica emozioni e sentimenti,
che sviano la morale, oppure, quando collaborano con essa, ne inquinano la severa purezza.
Nell'etica del filosofo di Konigsberg, che risulta in polemica con ogni tipo di morale di tipo
sentimentalistico, si riconosce il diritto di cittadinanza a un unico sentimento: il rispetto per la
legge. Sentimento "a priori" (come la legge stessa) e dotato di una forza tale da far tacere tutti gli
altri sentimenti egoistici e da disporre l'individuo all'accoglimento della legge. Il rispetto, come nota
Kant, implica la condizione propria dell'uomo come essere razionale finito:
siccome il rispetto è un'azione sul sentimento e perciò sulla sensibilità di un essere razionale,
esso suppone questa sensibilità, quindi anche la finitezza di quegli esseri a cui la legge
morale impone il rispetto. (Critica della ragion pratica, A 135)
4
II dovere-per-il-dovere nel rispetto della legge: ecco le uniche condizioni affinché vi siano
moralità e virtù e non si passi dalla moralità alla semplice "legalità". Infatti, secondo Kant, non
basta che un'azione sia fatta esteriormente secondo la legge, ovvero in modo conforme a essa. La
morale implica una partecipazione interiore, altrimenti rischia di scadere in atti di legalità ipocrita
oppure in forme più o meno mascherate di autocompiacimento (come accade ad esempio quando ci
si comporta bene per il plauso degli altri).
Kant sostiene dunque che non è morale ciò che si fa, ma l'intenzione con cui lo si fa (morale
dell'intenzione), essendo la «volontà buona», ovvero la convinta adesione della volontà alla legge,
l'unica cosa incondizionatamente buona al mondo (infatti tutti gli altri beni, ad esempio
l'intelligenza o il coraggio, possono essere usati male). Il dovere e la volontà buona, secondo Kant,
innalzano l'uomo al di sopra del mondo sensibile (fenomenico), in cui vige il meccanismo delle
leggi naturali, e lo fanno partecipare al mondo intelligibile (noumenico), in cui vige la libertà. In
altri termini, la vita morale è la costituzione di una natura sovrasensibile, nella quale la
legislazione morale prende il sopravvento sulla legislazione naturale. Nel suo "inno al dovere",
il filosofo, a un certo punto, scrive infatti:
quale origine è degna di te? E dove si trova la radice della tua nobile stirpe, che rifiuta
fieramente ogni parentela con le inclinazioni, quella radice in cui ha origine la condizione
indispensabile dell'unico valore che gli uomini possono darsi da se stessi? Non può essere
niente di meno di ciò che eleva l'uomo al di sopra di sé (come parte del mondo sensibile), di
ciò che lo lega a un ordine di cose che il solo intelletto è in grado di pensare e che nello stesso
tempo subordina a sé il mondo sensibile [...]. Non è altro che la personalità, cioè la libertà e
l'indipendenza nei confronti del meccanismo dell'intera natura, considerata tuttavia
contemporaneamente come facoltà di un essere sottostante a leggi speciali, cioè a leggi pure
pratiche, che la sua stessa ragione gli fornisce; pertanto la persona, in quanto appartenente al
mondo sensibile, è sottoposta alla propria personalità perché appartiene nello stesso tempo al
mondo intelligibile. Non bisogna dunque meravigliarsi se l'uomo, appartenendo a due mondi,
debba considerare il proprio essere, rispetto alla sua seconda e suprema determinazione, con
venerazione e le leggi di essa col massimo rispetto (Critica della ragion pratica, A 154-155)
Questa noumenicità del soggetto morale non significa tuttavia l'abbandono della sensibilità e
l'eliminazione di ogni legame con il mondo sensibile. Difatti, proprio perché l'uomo partecipa
strutturalmente dei due mondi, egli non può affermare il secondo (quello intelligibile o noumenico)
se non nel primo e in virtù del primo (quello sensibile o fenomenico). Anzi, la noumenicità
dell'uomo esiste solo in relazione alla sua fenomenicità, in quanto il mondo soprasensibile, per
lui, esiste solo come forma del monde sensibile.
L'autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale
Le varie determinazioni della legge etica che abbiamo esaminato convergono in quella
dell'autonomia, che tutte le implica e riassume. Il senso profondo dell'etica kantiana, e della sua
sorta di "rivoluzione copernicana morale" , consiste infatti nell'aver posto nell'uomo e nella sua
ragione il fondamento dell'etica, al fine di salvaguardarne la piena libertà e purezza.
Se la libertà, presa in senso negativo, risiede nell'indipendenza della volontà dalle inclinazioni, in
senso positivo si identifica con la sua capacità di autodeterminarsi, ossia nella prerogativa
autolegislatrice della volontà, la quale fa sì che l'umanità sia norma a se stessa. Di conseguenza,
Kant polemizza aspramente contro tutte le morali eteronome, cioè contro tutti quei sistemi che
pongono il fondamento del dovere in forze esterne all'uomo o alla sua ragione, facendo scaturire la
morale, anziché dalla pura "forma" dell'imperativo categorico, da principi "materiali". Ripensando
la storia della filosofia, Kant ha racchiuso in una "tavola" apposita i diversi motivi etici teorizzati
dai filosofi:
5
SOGGETTIVI
ESTERNI
dell'educazione
(Montaigne)
del governo
civile
(Mandeville)
OGGETTIVI
INTERNI
del sentimento del sentimento
fisico (Epicuro) morale
(Hutcheson)
INTERNI
ESTERNI
della perfezione della volontà di Dio
(Wolff e gli
: (Crusius e gli altri
stoici)
moralisti teologi)
Passando in rassegna le varie posizioni (cfr. Fondazione della metafisica dei costumi, BA 88-96 e
Critica della ragion pratica, A 69-71), Kant individua i limiti di ciascuna, che risiedono, in
generale, nel fatto di non riuscire a preservare l'incondizionatezza della legge morale e degli
attributi in cui essa si concretizza.
Infatti, se i motivi della morale risiedessero nell'educazione, nella società, nel piacere fisico o nel
sentimento della benevolenza, l'azione non sarebbe più libera e universale, in quanto tali realtà
sarebbero fattori determinanti e mutevoli, ossia forze necessitanti e soggette al cambiamento.
Inoltre, tali motivi potrebbero al più spiegare in linea di fatto la presenza della moralità in certi
uomini o gruppi di uomini, ma non giustificherebbero il carattere assolutamente obbligatorio della
legge morale.
Se i motivi stessero invece in un generico ideale di perfezione o in Dio cadremmo negli stessi
inconvenienti. Ad esempio, il concetto di perfezione (Wolff) è un'idea vuota, a meno che non lo si
identifichi con quello di perfezione morale. Ma in tal caso, dire che la moralità consiste nel
realizzare la perfezione è una palese tautologia, poiché equivale a dire che la moralità risiede nella
moralità. Analogamente, l'idea di "volontà divina" risulta, di per sé, indeterminata. Pertanto, o viene
determinata sottobanco, in virtù del concetto di perfezione etica, dicendo che Dio è la perfezione
morale stessa, che l'uomo deve seguire - e allora si cade in un circolo vizioso fondato sull'asserzione
che la morale consiste nel seguire la morale (personificata in Dio); oppure viene determinata in
modo volontaristico, dicendo che bisogna sottomettersi alla volontà onnipotente e superiore di Dio e allora la morale cessa di essere libera e disinteressata, poiché l'obbedienza a essa riviene frutto di
una costrizione o di un calcolo dettato dal timore di punizioni o dalla speranza di premi. Senza
contare che le varie religioni o filosofie possono interpretare in modo diverso la volontà divina,
distruggendo così l'universalità del valore morale. In sintesi, anche la morale teologica, come ogni
forma di etica eteronoma, va contro quegli attributi di libertà e di universalità che costituiscono
strutturalmente il mondo morale. Come si può notare, il modello etico di Kant si distingue
nettamente dai precedenti sistemi morali del razionalismo e dell'empirismo. Il razionalismo, pur
fondando la morale sulla ragione, l'aveva fatta dipendere dalla metafisica, fondandola ad esempio
sull'ordine del mondo, su Dio ecc. L'empirismo, pur sganciando la morale dalla metafisica, l'aveva
annessa al sentimento (v. la "simpatia" di Hume). Contro il razionalismo, Kant, sotto l'influenza
dei moralisti inglesi e di Rousseau, afferma invece che la morale si basa unicamente sull'uomo e
sulla sua dignità di essere razionale finito e non dipende da preesistenti conoscenze
metafisiche. Contro l'empirismo e le varie morali sentimentalistiche, Kant sostiene invece che la
morale si fonda unicamente sulla ragione, in quanto il sentimento, anche inteso nel senso
migliore e più alto del termine («benevolenza del prossimo»), risulta qualcosa di troppo fragile e
soggettivo per fungere da piedistallo per un robusto edificio etico. Di conseguenza, anche in sede
etica, il kantismo non nasce da una "sintesi" tra razionalismo ed empirismo, ma da un continuo
critico misurarsi con le più disparate espressioni della filosofia moderna, che produce una forma di
pensiero originale, irriducibile a quelle precedenti.
Il tema dell'autonomia morale, escludendo qualsiasi causa determinante esterna alla condotta,
6
scioglie anche quell'apparente "paradosso" della ragion pratica, secondo cui non sono i concetti di
bene e di male a fondare la legge etica, bensì, al contrario, è la legge etica a fondare e a dare un
senso alle nozioni di bene e di male. La rivoluzione copernicana morale di Kant, che fa dell'uomo
l'unico legislatore del suo comportamento, trova in tal modo il suo ultimo e più significativo
compimento.
La teoria dei postulati pratici e la fede morale
Se nell'Analitica della Ragion pratica, che è la parte che abbiamo esposto, Kant ha studiato il
dovere, nella Dialettica prende in considerazione l'assoluto morale o sommo bene. Come sappiamo,
la felicità non può mai erigersi a motivo del dovere, perché in tal caso metterebbe in forse
l'incondizionatezza della legge etica - e quindi la sua categoricità, formalità, purezza e autonomia.
Tuttavia la virtù, pur essendo il "bene supremo", non è ancora, secondo Kant, quel "sommo bene"
cui tende irresistibilmente la nostra natura, il quale consiste, invece, nell'addizione di virtù e
felicità.
Si noti fin d'ora come Kant, introducendo il concetto di sommo bene, non contraddica il carattere
disinteressato e autonomo della morale, in quanto egli, senza fare della felicità motivo dell'azione,
asserisce unicamente che c'è in noi il bisogno di pensare che l'uomo, pur agendo per dovere, possa
anche essere degno di felicità.
Ma in questo mondo virtù e felicità non sono mai congiunte, poiché lo sforzo di essere virtuosi e la
ricerca della felicità sono due azioni distinte e per lo più opposte, in quanto l'imperativo etico
implica la sottomissione delle tendenze e l'umiliazione dell'egoismo. Di conseguenza, virtù e felicità
costituiscono l'antinomia etica per eccellenza, che forma l'oggetto specifico della Dialettica della
Ragion pratica. Kant rileva come i filosofi greci abbiano vanamente tentato di scioglierla, per
quanto riguarda questa vita, o risolvendo la felicità nella virtù (stoici) o la virtù nella felicità
(epicurei). In realtà, afferma Kant, collocandosi in una tradizione di pensiero che va da Platone al
cristianesimo, l'unico modo per uscire da tale antinomia - che rischia di rendere impossibile il
sommo bene e di ridurre la morale che lo prescrive a un'impresa senza senso — è di "postulare" un
mondo dell'aldilà in cui possa realizzarsi ciò che nell'aldiquà risulta impossibile: l'equazione "virtù
= felicità".
Kant trae il termine "postulato" dal linguaggio della matematica classica. In quest'ultima, mentre si
dicono "assiomi" le verità fornite di auto-evidenza, si chiamano "postulati" quei principi che,
pur essendo indimostrabili, vengono accolti per rendere possibili determinate entità o verità
geometriche. Analogamente, i postulati di Kant sono quelle proposizioni teoretiche non
dimostrabili che ineriscono alla legge morale come condizioni della sua stessa esistenza e
pensabilità, ovvero quelle esigenze interne della morale che vengono ammesse per rendere
possibile la realtà della morale stessa, ma che di per se stesse non possono venir dimostrate. I
postulati tipici di Kant sono l'immortalità dell'anima e l'esistenza di Dio.
Per quanto concerne il postulato dell'immortalità dell'anima, Kant afferma che: a) poiché solo la
santità, cioè la conformità completa della volontà alla legge, rende degni del sommo bene e b)
poiché la santità non è mai realizzabile nel nostro mondo, e) si deve per forza ammettere che
l'uomo, oltre il tempo finito dell'esistenza, possa disporre, in un'altra zona del reale, di un tempo
infinito grazie a cui progredire all'infinito verso la santità.
Se
la realizzazione della prima condizione del sommo bene, ossia la santità, implica il
postulato dell'immortalità dell'anima,
la realizzazione del secondo elemento del sommo bene, cioè la felicità proporzionata alla
virtù, comporta il postulato dell'esistenza di Dio, ossia la credenza in una «volontà santa ed
onnipotente», che faccia corrispondere la felicità al merito.
Accanto ai due postulati "religiosi" dell'immortalità dell'anima e dell'esistenza di Dio. Kant pone un
altro postulato che ci è ben noto: la libertà. Quest'ultima è infatti la condizione stessa dell'etica, che
7
nel momento in cui prescrive il dovere, presuppone anche che si possa agire o meno in conformità
di esso e che quindi si sia sostanzialmente liberi. «Devi, dunque puoi», afferma Kant: se c'è la
morale deve, per forza, esserci la libertà.
Si osservi come il postulato kantiano della libertà si collochi su un piano oggettivamente diverso
dagli altri due, in quanto, pur non sapendo che cosa sia la libertà, possiamo almeno dire che
essa esiste. Questo non avviene anche, a rigore, per gli altri due, di cui non possiamo sostenere con
sicurezza, né che cosa siano, né che siano, essendo unicamente "bisogni" pratici dell'essere morale
finito. In altri termini, mentre la libertà è la condizione stessa dell'etica - ed è quindi una certezza
scaturente dal fatto morale - l'immortalità e Dio rappresentano soltanto delle condizioni ipotetiche
(sia pure razionalmente fondate) affinché la morale trovi, in un altro mondo, quella realizzazione
che in questo le è negata. Per cui, "postulati", in senso forte e caratteristicamente kantiano, sono da
considerarsi soprattutto quelli religiosi.
Ma perché Kant classifica come "postulato" anche la libertà? Ciò avviene perché egli, fermo
alle conclusioni gnoseologiche della Critica della ragion pura, ritiene che l'idea di un'autocausalità, ossia di una fonte spontanea di atti (libero arbitrio), non possa venir
scientificamente affermata, in quanto il mondo dell'esperienza, come si è visto, si regge sul
principio di causa-effetto. Tuttavia, discutendo la terza antinomia, Kant ha sostenuto che «se nel
mondo fenomenico vige il determinismo, nel regno della cosa in sé potrebbe trovar posto la libertà facendo capire, in tal modo, come l'ammissione filosofica della libertà non risulti contraddittoria
con il punto di vista espresso nella Critica della ragion pura.
Il primato della ragion pratica
La teoria dei postulati mette capo a ciò che Kant definisce «primato della ragion pratica»,
consistente nella prevalenza dell'interesse pratico su quello teoretico e nel fatto che la ragione
ammette, in quanto è pratica, proposizioni che non potrebbe ammettere nel suo uso teoretico.
Tuttavia, pur aprendo uno squarcio sul transfenomenico e sul metafisico, i postulati kantiani non
possono affatto valere come conoscenze. Come scrive Pietro Chiodi, il primato della ragion
pratica rispetto alla ragione speculativa «non significa che essa ci può dare ciò che questa ci nega,
ma semplicemente che le sue condizioni di validità comportano la ragionevole speranza
dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima: ma se questa ragionevole speranza fosse intesa
come certezza razionale, non solo il mondo morale non ne uscirebbe rafforzato ma totalmente
distrutto». Infatti le affermazioni di Kant a proposito della non-teoreticità dei postulati sono così
tenaci e ripetute da farci comprendere come egli fosse ben conscio del fatto che un'eventuale
ammissione della loro validità conoscitiva non solo avrebbe violato apertamente le conclusioni
della Critica della ragion pura, ma avrebbe minato il suo stesso modo di intendere la morale
come libertà e autonomia:
Dio e l'eternità, nella loro maestà tremenda, ci starebbero continuamente dinanzi agli occhi
[...]. La trasgressione della legge sarebbe senz'altro impedita, ciò che è comandato sarebbe
compiuto [...]. La condotta dell'uomo, finché la sua natura restasse qual è ora, si
trasformerebbe in un semplice meccanismo, in cui, come in un teatro di marionette, tutto
gesticolerebbe bene, ma nelle cui figure non ci sarebbe più vita.
(Critica della ragion
pratica, A 265)
Di conseguenza, se i postulati fossero delle verità dimostrate o delle certezze comunque intese, la
morale scivolerebbe immediatamente verso l'eteronomia e sarebbe nuovamente la religione (o
la metafisica) a fondare la morale, con tutti gli inconvenienti già esaminati. Rovesciando il modo
tradizionale di intendere il rapporto tra morale e religione, Kant sostiene invece, a chiare lettere, che
non sono le verità religiose a fondare la morale, ma è la morale, sia pure sotto forma di
"postulati", a fondare le verità religiose. In altri termini, Dio, per Kant, non sta all'inizio e alla
base della vita morale, ma eventualmente alla fine, come suo possibile completamento. In altre
8
parole ancora, l'uomo di Kant è colui che agisce seguendo solo il dovere-per-il-dovere, con, in più,
la «ragionevole speranza nell'immortalità dell'anima e nell'esistenza di Dio. A questo proposito, i
testi sono inequivocabilmente chiari. Infatti, da un lato, il filosofo scrive:
La morale, essendo fondata sul concetto dell'uomo come essere libero, il quale, appuri: i
perché tale, sottopone se stesso, mediante la propria ragione, a leggi incondizionate, non ha
bisogno né dell'idea di un altro essere superiore all'uomo per conoscere il proprio dovere, né di
un altro movente oltre la legge stessa per adempierla [...] non ha quindi bisogno sia
oggettivamente, per ciò che concerne il volere, sia soggettivamente, per ciò che concerne il
potere) del sostegno della religione, ma è autosufficiente grazie alla ragion pratica pura . (La
religione nei limiti della semplice ragione, pref. alla 1a ed.)
Ma dall'altro lato sostiene che «La morale conduce [...] inevitabilmente alla religione» perché
«soltanto da una volontà moralmente perfetta (santa e buona) e nello stesso tempo onnipotente
possiamo sperare quel sommo bene che la legge morale ci fa un dovere di proporci come oggetto
dei nostri sforzi» (Critica della ragion pratica, A 233 ). Di conseguenza, con la teoria dei postulati
Kant non ha eliminato l'autonomia dell'etica. perché l'ha solo "integrata" con una sorta di fede
razionale. Tuttavia, queste considerazioni sulla coerenza interna della morale kantiana e sulle
cautele critiche del filosofo circa il significato pratico e non teoretico dei postulati non escludono
che la Critica della: ragion pratica finisca per delineare una sorta di dualismo platonizzante che
spezza la realtà e l'uomo in due: da un lato il mondo fenomenico della scienza, dall'altro b mondo
noumenico dell'etica; da un lato l'uomo fenomenico delle inclinazioni, dall'altro l'uomo noumenico
della libertà e del dovere. Infatti è proprio dalla consapevolezza di questo dualismo che muove, in
parte, la Critica del Giudizio.
9