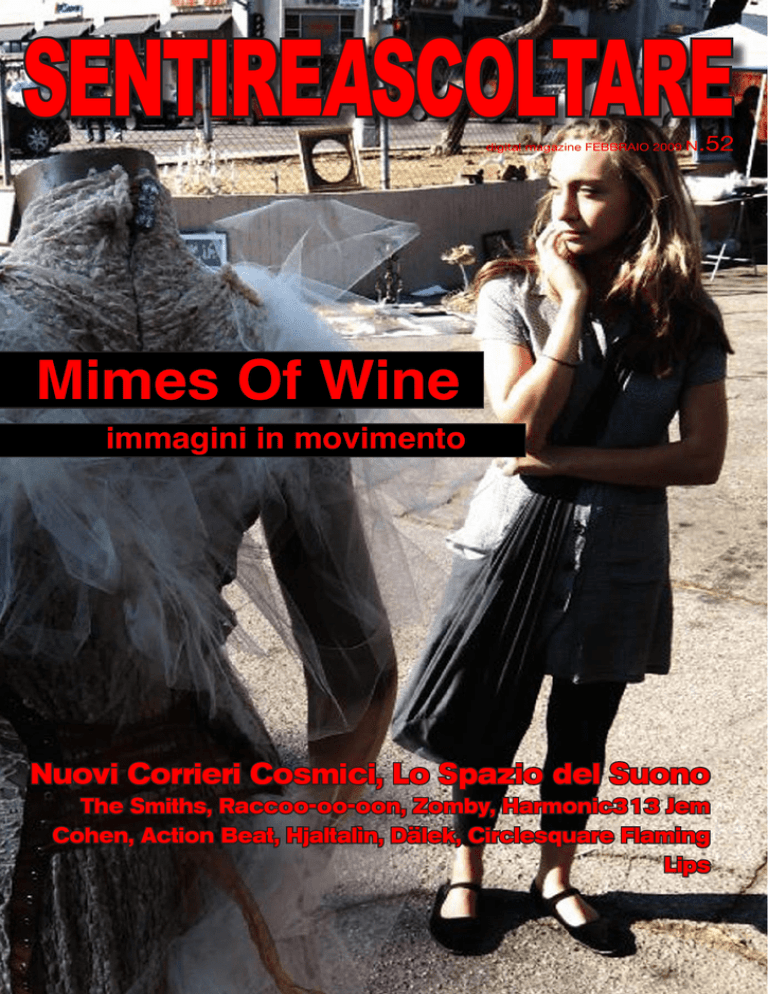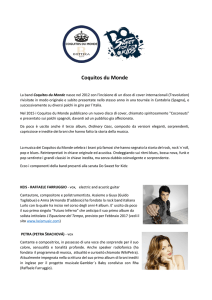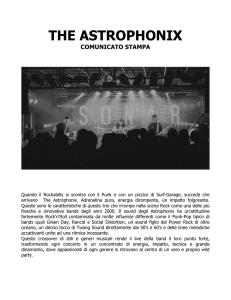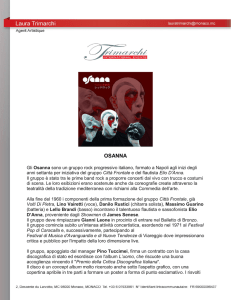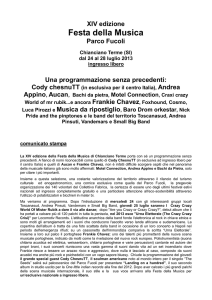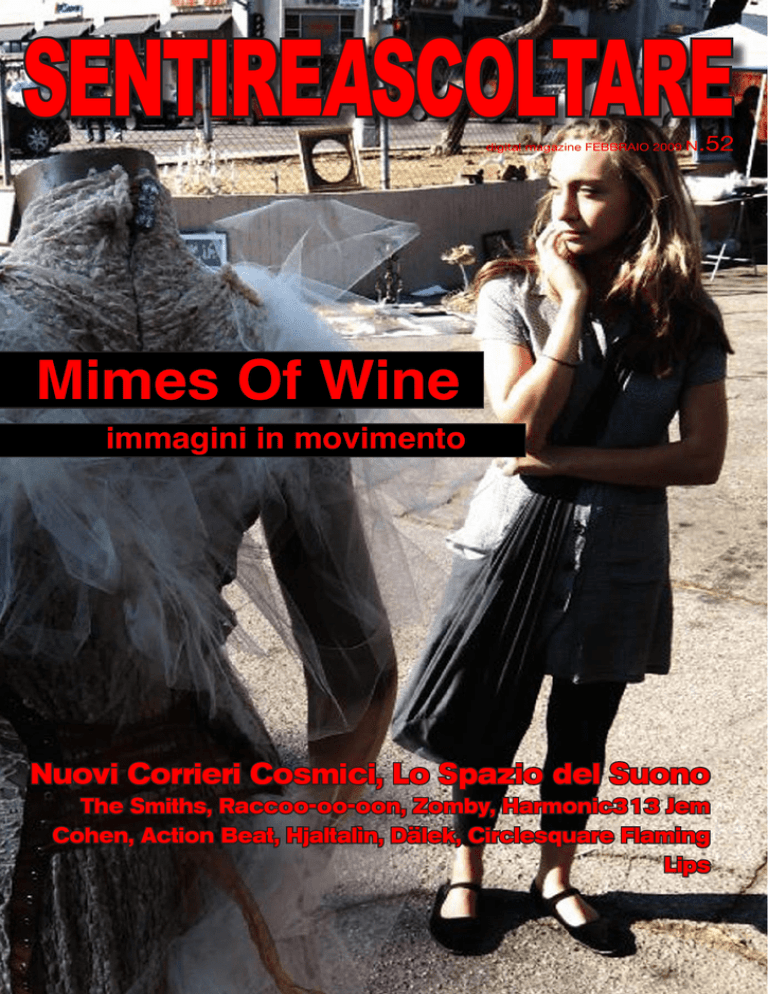
SENTIREASCOLTARE
digital magazine febbraio 2009
N.52
Mimes Of Wine
immagini in movimento
Nuovi Corrieri Cosmici, Lo Spazio del Suono
The Smiths, Raccoo-oo-oon, Zomby, Harmonic313 Jem
Cohen, Action Beat, Hjaltalìn, Dälek, Circlesquare Flaming
Lips
ERATLOCSAERITNES
2 5 . N 9002 oiarbbef enizagam latigid
nuovi
corrieri
cosmici
expo‘70
emeralds
j o n a s
re i n h a rd t
News p. 4-5
Turn On p. 6-13
Raccoo-oo-oon, Zomby, Harmonic 313, Jem Cohen,
Action Beat, Hjaltalìn
Tune In p. 14-25
Dälek, Mimes of Wine, Circlesquare
Drop Out p. 26-43
Nuovi Corrieri Cosmici (Expo’70, Emeralds, Reinhart...)
Lo Spazio del Suono (Ralph Steinbruchel)
recensioni p. 46-101
Svarte Greiner, Andrew Bird, zZz, Mi Ami.....
We are Demo p. 102-103
Rearview Mirror p. 104-121
The Smiths - New Order...
la sera della prima p. 122-128
Christmas on Mars, Tony Manero, Milk
a night at the opera p. 130-131
I Puritani
i “cosiddetti contemporanei” p. 132-135
Shostakovich
Direttore: Edoardo Bridda
Coordinamento: Teresa Greco
Consulenti
alla redazione:
Daniele Follero, Stefano Solventi
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo, Alessandro
Grassi, Andrea Napoli, Francesca Marongiu, Massimo Padalino, Giulio Pasquali, Stefano Pifferi, Andrea Provinciali,
Antonio Puglia, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra, Fabrizio Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
Mimes of Wine
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2008 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Sommario /
3
Necrologio cumulativo questo mese: il 22 gennaio è scomparso Charlie Wesley Cooper metà dei
Telefon Tel Aviv a pochissimo dall’uscita dell’album Immolate Yourself; se n’è andato anche Bill
Powell, tastierista dei Lynard Skynard; Powell
e Gary Rossington erano gli unici sopravvissuti
dell’incidente aereo del 1977 in cui erano morti
gli altri componenti Ronnie Van Zant, Steve Gaines e la corista Cassie Gaines. E ancora se ne va a
60 anni Ron Asheton, chitarrista degli Stooges; il
musicista è stato trovato morto il 6 gennaio scorso nella sua casa in Michigan. A 76 anni muore
il 27 gennaio per un cancro al polmone lo scrittore americano John Updike. E per ultimo il 29
gennaio ci lascia a 60 anni il folk singer scozzese
John Martyn. Ancora una scomparsa: il 4 febbraio
muore in California a 62 anni per problemi cardiaci Lux Interior (Erick Purkhiser) dei Cramps,
fondati insieme alla moglie Poison Ivy nel 1975 a
New York, dove entrarono a far parte della scena
punk rock gravitante intorno al CBGB.
Nuovo album per Bill Callahan, a due anni da
Woke On A Whaleheart. Sometimes I Wish
We Were An Eagle uscirà come i precedenti su
Drag City, in aprile…
Tornano i gallesi Super Furry Animals con
un’uscita ancora senza titolo, che appare prima
in forma digitale sul loro sito ufficiale superfurry.
com dal 16 marzo e poi dal 21 aprile fisicamente
su Rough Trade; l’album vede titoli quali The Very
4
/ News
a cura di Teresa Greco
Best of Neil Diamond e Crazy Naked Girls…
Franz Ferdinand, Kings of Leon, Oasis e Paul
Weller sono i primi headliner dell’edizione 2009
del FIB Heineken 09 che si terrà a Benicàssim
(Spagna) il 16, 17, 18 e 19 luglio 2009. Il resto
della programmazione sara’ svelato non appena
gli artisti confermeranno le proprie apparizioni.
Maggiori informazioni su fiberfib.com…
Nuovi dischi in arrivo tra febbraio e marzo per
Odawas, Julie Doiron e Swan Lake, tutti su
Jagjaguwar; gli Odawas sono al terzo album, The
Blue Depths previsto per fine febbraio, la Doiron torna a marzo con Can Wonder What You
Did With Your Day, così come Swan Lake, con
Enemy Mine. Quest’ultimo progetto di Daniel
Bejar (già con Destroyer e New Pornographers),
Spencer Krug (di Sunset Rubdown e Wolf Parade) e Carey Mercer (di Frog Eyes e Blackout Beach)…
Dopo cinque anni tornano i chicagoani Tortoise con un disco ancora senza titolo che uscirà
il prossimo aprile…
Ristampe in vista per i Monks e il loro garage rock su Light In the Attic: The Early Years e
Black Monk Time in arrivo a marzo con distribuzione Goodfellas. Nel 1967 il gruppo si scioglie
lasciando un album – Black Monk Time – oggetto di culto, causa la sua irreperibilità. Nel 1994
il bassista Eddie Shaw pubblica l’autobiografia
Black Monk Time; il gruppo si riunisce nel 1999
durante il festival americano Cavestomp e poi in
Spagna nel 2004 ed in occasione del tour in Germania ed Austria del 2007…
Dopo ben quindici anni dall’ultima uscita con
la sua band, That’s The Way It Should Be, Booker T pubblicherà su Anti il 20 aprile il nuovo
album Potato Hole, L’artista leader dei Booker
T & the MG’s (session band della Stax Records di
Memphis), ha collaborato con Neil Young, chitarrista in nove canzoni, e con i Drive By Truckers come turnisti. Nel disco sono presenti tre
cover, Hey Ya degli Outkast, Get Behind the Mule di
Tom Waits e Space City dei Drive By Truckers…
sulla tedesca Kompakt. Axel Willner è stato affiancato in fase di composizione di alcuni ritocchi sonori dal batterista dei Battles John Stainer…
I Depeche Mode tornano con un nuovo disco, Sounds Of The Universe, previsto per il
20 aprile su Mute, anticipato dal singolo Wrong
e prodotto da Ben Hillier (già in Playing the Angel del 2005). Secondo quanto da loro dichiarato,
prevede l’uso di synth analogici e drum machine
che bilanciano il sound retro futurista dell’allbum;
come già annunciato saranno nel nostro paese per
due date, il 16 giugno a Roma e il 18 a Milano…
Frank Black torna con l’incarnazione Grand
Duchy, insieme alla moglie Violet Clark: il debutto del duo si chiama Petit Fours e sarà pubblicato in aprile su Cooking Vinyl…
Sarà pubblicato il 14 aprile Fantasies, quarto
album dei Metric, il primo ad essere venduto direttamente dalla band canadese, acquistabile dal
sito ufficiale Ilovemetric.com. Sarà preordinabile
dal 2 marzo. In Canada e Messico sarà anche distribuito regolarmente dalla Arts & Crafts…
I Black Dice pubblicheranno Repo, il loro
quinto disco, il 7 aprile su Paw Tracks…
Novità per gli electroloopers svedesi The Field.
Il nuovo album - che segue il successo del 2007
Here We Go Sublime - verrà pubblicato probabilmente intorno al 16 maggio prossimo sempre
News /
5
Raccoo-oo-oon
Il canto del procione
Dei defunti, almeno in Italia, si tende a parlare
sempre bene. Anche se la cosa solitamente non
corrisponde alla realtà della vita vissuta, nel caso
dei Raccoo-oo-oon è inevitabile. Così come inevitabilmente la memoria ritorna alla famosa frase di
Steve Albini, secondo il quale l’idea di sciogliersi
è venuta troppo spesso ai gruppi sbagliati. Il (fu)
quartetto di Iowa City rientra appieno in questa
categoria, come dimostra il canto del cigno appena uscito col benemerito placet del logo Release
The Bats, eclettica etichetta svedese nel cui catalogo confluiscono weirdità a profusione, Robedoor
e Warmer Milks giusto per fare due nomi. In
tono col ruolo sommesso giocato dal quartetto nel
corso della sua esistenza, anche lo split è passato
sotto silenzio. Cosa privata era e tale è rimasta,
come conferma Shawn Reed: Si, Raccoo-oo-oon ha
chiuso i battenti l’anno scorso ma non l’abbiamo mai annunciato; è semplicemente successo, abbiamo vissuto la band
intensamente per più di 4 anni ed era tempo che ognuno seguisse la propria via, le proprie cose…è stato naturale, come
se avessimo inconsciamente realizzato che avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare e che fosse saggio così.
Così mentre la diaspora del procione è in atto spingendo i 4 membri ai quattro angoli degli States
6
/ Turn On
come in una dispersione così fortemente a stelle e
strisce (Andy è ora a Los Angeles, impegnato a tempo pieno
nella scena artistica cittadina; Daren voleva trasferirsi a NY
e ora l’ha fatto; io e Ryan Garbes viviamo ancora a Iowa
City) non resta che ascoltare i 74 minuti pieni del
personale swansong e da lì intraprendere un percorso
a ritroso alla ricerca delle uscite precedenti e soprattutto minori del gruppo, come i 5 volumi della serie
Mythos Folkways. Suddivisi equamente tra vinili
e cassette mostrano il lato più selvaggio e sperimentale dei quattro; in alcuni casi con registrazioni in
sede live devastanti – il Vol. IV, sottotitolato Future Visions – in altri in condivisione con spiriti
affini, come nel caso del Vol. II – Pre-American
Lands, pubblicato in vinile per Not Not Fun e splittato coi Woods. Oppure non resta che attendere
le pubblicazioni del nuovo progetto di Shawn, da
poco raggiunto da Garbes, a nome Wet Hair – più
ossessivamente synth-drone-oriented – di cui testimonianze sono uscite (il 12” one-sided, la cassetta
Irifi) e usciranno per Night People, etichetta di casa
Reed con un catalogo che più strambo non si può.
I Raccoo-oo-oon non esistono più. Lunga vita ai
Raccoo-oo-oon.
stefano pifferi
Nel giro dubstep c’è una spia che parla il verbo più tamarro
troveranno qualcosa, dato che ci ascolti gli Orbital
e rinnegato della storia degli ultimi anni, l’ardekore. You
e i Nightmares On Wax laser verdi annessi, e gli
know the score? Era l’anticristo di ogni afrofuturista techLFO in gara per il basso più sismico come l’umidino che si rispetti e ora rivive in un album che punta dritto
tà colata dagli specchi mescolata alle deformazioni
alla scienza del breakbeat… ma attenzione, in camuffa. La
della cassa al girar di manopola. Quelle voci brekscorza è anche italo house e technotronik.
kate prese dall’hip-hop che credevamo trashy nelPrendete uno del giro dubla poco esclusiva accezione
step e fatelo andare in fissa
Snap! Technotronik e l’irricon l’ardkore primi Novanta.
tantissima balbuzie messa
Esatto. Proprio l’hardcore talì, da bambini cerebrolesi.
marrissima decantata da
E poi pure gli Orb, gli speReynolds, quella che ha
aker KLF e le sirene Acid
ispirato al critico la famosa
Nation. Tante sirene ein
teoria del continuum sezwei polizei in remember
condo il quale il più vituperadegli scontri e delle retate
to genere dalla scena alla luce
del ‘92: l’anno della crociadei fatti era poi la chiave per
ta governativa inglese antimutare e reinventarsi come
rave, l’act che avrebbe stanl’araba fenice. Fategli incidere
gato tutti e riportato tutto
un disco furbissimo che prennei club istituzionalizzando
de il meglio (o il peggio) di quei
il suono di una generaziorush analogici e appiccicatene. Ci sono pure le tastieci sopra un’etichetta che più
racce, quelle dei Black Box
paracula non ce n’è: dov’eri
nella variante taglia e cuci
nel novantadue? La risposta
di vocal che volgarizzavano
è facile. Ero lì, proprio come
per sempre il romanticismo
lì c’era James Murphy neldi Derrick May, ficcandoci
la famosa canzone e proprio
come un coltello in cuore la
come qui tra le mie mani c’è
disco music di dieci e passa
questo dischetto uscito a noanni prima. Supercafona
vembre 2008 (Where Were
‘sta musica
‘ardekore you know what i mean che puzza di
You In ‘92?) che è una chicca
assurda.
club scalciDentro, dice Mr Zomby, connato; ma più dentro puzza
tattato istantaneamente via fido myspace, c’è tutta
di ghetto, di negroni New York old skool (sentitela jungle techno from u.k, o meglio il suo ombrellone chiamavi la compila di Van Helden - New York A Mix
to ‘old skool hardcore’. E se sei brit come dice lui non
Odyssey 2). Quel kitsch che diede agli inglesi
c’è scampo: jungle garage, hardcore, dubstep ecc. e tutto
e agli europei tutti la voglia di sporcarsi le mani
quel che c’è in mezzo, anche se il focus del disco è
mentre oltreoceano gli intellettuali di Detroit atsu gente mirata e da addetti ai lavori come Manix,
terrivano. Una nuova via per reinventare lo step
Acen, 2 Bad Mice,Origination, Noise Factory, Hackney
inglese è tracciata.
Hardcore, Lennie De Ice e etichette come Formation,
Edoardo Bridda e Marco Braggion
Ibiza e Music House. Del resto dj o no tutti ci ri-
zomby
Turn On /
7
harmonic 313
Quando le macchine spaccano
Grazie all’one man project 313, la Warp si riappropria
dell’ambient che la fece conoscere al mondo intero con una
sorpresa, l’hip hop. E tutti quei bass e break tornano a casa
grazie a un magico brit finora rimasto in penombra.
Sono anni che SA manda missive agli Autechre.
Parola chiave e diktat: reinventarsi, hip hop, ripartire. Rasare daccapo. Via i vicoli ciechi del robo
Cunningham. Via i rebus e i millennium bug. E sì,
pure quel cazzo di snobismo oramai storicizzato e
anni Ottanta che nessuno vuole. Oltrepiù è l’unica
scelta artistica seria possibile, da artisti con le palle
come direbbero i critics di Arte Fiera e Netmage,
un ritorno a casa che non sappia di ripiego a seguire certi ritorni stimolanti, come l‘ardkore per il
misterioso Zomby. Ma poi loro, gli Aut- li ricordate? Nacquero b-boy graffiti e skate. Sangue e pane
del ghetto for real. Krautismo breakbeat stampo
Warp. Label che ora fuori dal mucchio del pure
electro ripesca magicamente le origini, si ricompone e anticipa un revival proprio sulle sue cose,
prima che qualcuno soffi. Ma dicevamo hip-hop.
Che sarebbero stati gli Autechre di Amber tra metalli e sincopi pre-dubstep senza il prezzemolo del
battito? Già, ce lo dicevano pure gli Amari che sul
prototipo del Bbeat si fondano tutti i Novanta. Ce
lo diceva il Dariella prima B e ora electro-pop: “è
tutta trasfigurazione (break)beat”. Da tutto questo
e dalle sacrosante sentenze, attacchiamo anche un
8
/ Turn On
piccolo rewind con un riflettore puntato Beastie
Boys periodo tuta gialla robo, importante quanto
il sottobosco 8bit che non buca la notizia ma non
molla e si reinventa continuamente come il Virtumonde che infesta i PC. Poi voci. Vocoder grezzi,
kraft senza werk lontani dalle sofisticazioni francofone. Voci tirate in grana grossa come i pixelloni
che si vedono nelle pubblicità. E pure l’internet
tutt’uno con il suono. Fateci un giro nella home di
Harmonic. C’è il segmento del loro pezzo chiave
in animazione grafica stile graffiti Warp. Sincopi
che vanno lette come basic beat. Tonde e sorde.
Giochino di voci I/O. Biglietto da visita di mr.
Mark Pritchard, ovvero le palle di reinventarsi
come uno dei più intelligenti hip-hopper strumentali. Lui che ha un passato di ½ Global Comunication e che giustamente si merita un bel riflettore
puntato a fianco di Tom Middleton quello di Lifetracks. Non ci si era soffermati più di tanto in
occasione del paio di EP usciti nel 2008 (EP One
e Dirtbox 12) ma rimediare è facile con un disco
come When Machines Exceed Human Intelligence, uno di quei lavori che reinventano il
Warp sound più tech, rinfocolano il bbeat con dosi
controllate di 8bit e ambient autistica. E per i più
vibertiani c’è pure l’acid. 09=90. E pure la noia
buona del bit quadrato.
Edoardo Bridda e Marco Braggion
jem cohen
Da anni l’americano Jem Cohen rappresenta un esempio di
cinematografia “sul serio” indipendente che pare aver trovato
ennesima conferma nell’uscita in dvd della riflessione sullo
stato dell’unione Evening’s Civil Twilight In Empires Of
Tin.
Chissà se c’è un nesso tra l’insediarsi di Barack
Obama alla Casa Bianca e la quasi contemporanea uscita del dvd Evening’s Civil Twilight In
Empires Of Tin. E chissà che in qualche modo
serva a chiudere il capitolo su un decennio tra i
più tristi in politica estera per gli Stati Uniti, col
suo evidenziare errori e decadenza del (fu?) paese
più importante del mondo. Anche così non fosse,
si tratta in fondo di uno tra gli innumerevoli livelli
di lettura di un’opera che fonde musica, letteratura e politica come in poche altre è dato sentire.
Non poteva che essere altrimenti, visti i pezzi da
novanta impegnati e cioè il regista fieramente indipendente Jem Cohen, il cantautore Vic Chesnutt,
i post-apocalittici rockers A Silver Mt. Zion e l’ex
Fugazi Guy Picciotto. L’ensemble che già si era
trovato in sala per il meraviglioso North Star Deserter e che qui si trova a fornire - con l’ausilio dei
newyorchesi Quavers - adeguato commento sonoro alle immagini. Basata liberamente sul romanzo The Radetzky March di Joseph Roth (propostagli dal “montanaro d’argento” Efrim Menuck:
“La ragione autentica dell’interesse del libro stava
nel fatto che questi sono tempi assai duri, special-
mente in America, sotto l’amministrazione Bush
e dopo il 9/11.”) e commissionata dal Festival del
Cinema di Vienna, la pellicola veniva proiettata
a chiusura dell’edizione 2007 della rassegna. La
sera stessa Cohen filmava l’esibizione ed eccoci
oggi con in mano un dvd pesante come un mattone gettato dentro una vetrata; qualcosa che demolisce la barriera tra rockumentary e film d’autore
attraverso metafore sociopolitiche aguzze e dolorose, secondo le quali il kaiser Francesco Giuseppe
e “Mr. Dabliù” incarnano lo stesso timoniere di
un vascello alla deriva. A tale scopo la macchina
da presa indaga tra le pieghe della Vienna di oggi
e che fu e lo stesso vale per New York, restituendo una metropoli-simbolo percorsa da ectoplasmi.
L’uso del rallentatore e della velocizzazione tipici di Cohen congelano le emozioni per restituirle
intatte nel loro potenziale evocativo e simbolico,
siano esse sgranate istantanee prebelliche, seppiate
intrusioni tra il centro città o panorami restituiti
alle tinte vitali di ogni giorno. L’architettura si fa
narrazione, pagina da indagare per leggere passato, presente e futuro. Sperando che quest’ultimo
non sia come quella bandiera americana che, ridotta uno straccio di brandelli, sventolava sopra il
“ground zero” nei giorni seguenti l’undici settembre di otto anni fa.
giancarlo turra
Turn On /
9
Action Beat
Viene da Bletchley, nord-est di Londra, una delle
sensazioni più vivide dell’attuale panorama indie
del Regno Unito. Una appartenenza sentita che
viene sbandierata sin dal titolo del comeback The
Noise Band From Bletchley appena uscito per
la neonata Truth Cult, sussidiaria della più nota
Southern.
Non una band in senso stretto, però, quanto piuttosto un collettivo piuttosto ampio e mobile che
fluttua intorno ad un nucleo tutto sommato standard di almeno cinque membri. Quando però si
tratta di salire su un palco, la formazione base si
moltiplica fino a prevedere come minimo 3 chitarristi, un bassista e da 1 a 4 batterie. Intorno a
questo core ruota di volta in volta una marea di
collaboratori più o meno occasionali tra cui anche
il drum-kit del nostro Bruno Dorella. Tanto per
rendere l’idea, nelle sessions del nuovo album se
ne contano almeno 10 tra chitarre, bassi, batterie,
sax e trombe, come ci conferma Don McLean,
col quale abbiamo fatto una lunga chiacchierata:
«Non siamo una band classica, dato che ci adattiamo a situazioni differenti. Non abbiamo bisogno
di un nucleo di membri, così se qualche membro
regolare non può suonare un live è molto semplice
10
/ Turn On
farlo lo stesso. Nel nostro ultimo tour il nostro van
si è rotto in Germania e abbiamo affittato un’auto
suonando lo show successivo in Belgio. Quando
però il van fu riparato, alcuni di noi dovettero tornare a recuperarlo a Leipzig e così abbiamo dovuto suonare l’ultimo show ad Amsterdam senza
mezza band. È stato grande lo stesso!»
Totale libertà, dunque. Approccio punk che si materializza in un assoluto distacco da canoni e codici. Libertà, una parola che tornerà spesso durante
la conversazione e che si nasconde in ogni pezzo
del collettivo: «Chiunque può suonare con AB e
questo ci permette grande libertà e indipendenza.
Per questo così tante persone hanno suonato con
noi e permesso una così ampia libertà di suono»..
Date queste premesse – collettivo aperto + attitudine free – sarebbe facile attendersi una potenza
di fuoco impressionante. E invece ciò che stupisce maggiormente all’ascolto di The Noise Band
From Bletchley è che cotanta artiglieria non si
dedica, almeno in studio, ad un parossistico assalto
sonico stordente e cacofonico come sarebbe lecito
aspettarsi, bensì ad uno sviluppo focalizzato, controllato, quasi ragionato delle strutture che però
nasce spesso in circostanze pressoché improvvisa-
te: «Per il nuovo album abbiamo precedentemente
jammato 3 pezzi in sede live (i pezzi sono High Action, Meat Head e Manic Face suonati nel live ripreso
nell’artwork, nda) in modo da sapere cosa stavamo
facendo. Le altre 9 canzoni sono totalmente improvvisate e assemblate in studio, anche se sono
più corte, veloci e “song-oriented” rispetto alle
precedenti. Considera che come AB non abbiamo
mai provato; facciamo canzoni solo quando suoniamo live».
Un discorso valido anche per il precedente
1977-2007: Thirty Years of Hurt, then us
Cunts Exploded, nei cui 6 pezzi l’aspetto improvvisativo è ancor più evidente; in virtù soprattutto di un atteggiamento più jam-oriented che
genera un sound libero, informe, dilatato, ben rappresentato dalle cacofonie e dai vuoti cosmici dei
16 minuti di Maximum Bletchley.
Nel percorso sonoro del collettivo sono però riconoscibili un paio di capisaldi piuttosto evidenti:
Sonic Youth e Glenn Branca «Siamo completamente fan di Sonic Youth e Glenn Branca; da lì
proviene l’idea di accordare le chitarre in maniera
differente». Le dissonanti accordature dei primi e
i vortici ascensionali del secondo sono parte integrante del dna degli sgherri di Bletchley: l’ascendenza Daydream Nation cala come fall-out
post-atomico sugli incastri strumentali solo apparentemente elementari di cui le partiture del collettivo sono piene; le ramificazioni ascensionali di
Branca sfruttano la stratificazione delle chitarre
per creare piccoli tornado noise, senza mai scivolare nell’accademico.
Quello degli AB è però un percorso non circoscritto alla riproposizione, seppur personale, del sound
di quelle pietre miliari; da quelle che sono le vere
e proprie chiavi di volta per l’architettura sonica
del collettivo, il suono di AB si allarga fino ad inglobare quanto di più rumoroso gli States abbiano
prodotto nell’ultimo trentennio abbondante (scorre nelle parole di Don un bignami delle musiche
rumorose Usa: «Stooges, Black Flag, Fugazi, Nirvana, Jesus Lizard, Swans, Big Black»). Il tutto, ov-
viamente, suonato con strafottenza e supponenza
tipicamente british alla Fall «Amiamo molto i Fall,
specialmente quelli degli esordi…Live At The
Witch Trials con la splendida Rebellious Jukebox»
ma memore anche di altri momenti dimenticati e
apparentemente fuori contesto, come Stone Roses
e EMF «Cosa? ��������������������������������
You’re Unbelievable??? Unbelievably Shite!!!»
Nonostante le grasse risate di Don, l’ascolto della
prima metà di Master Beat sembrerebbe dire il contrario. Cioè che a stratificarsi nel background di
gruppi come questo sia una infinità di riferimenti
più o meno consci agli stessi autori e che si riverberano in maniera latente nelle loro composizioni.
Ecco così che dalle impalcature noise-rock in sovrapposizione emergono moloch apparentemente
estranei come le aperture jazzy, i fiati che impreziosiscono e screziano il suono rendendolo schizoide, il motorik krauto che si accende all’improvviso
oppure sorprendenti fascinazioni per drum’n’bass
e musica africana. Se la prima trova giustificazione nelle parole di Don «tempo e ritmo sono controllati dal basso e dalla/dalle batterie…puntiamo
sempre a beat dancey, un po’ come la d’n’b made
in UK» la seconda sottolinea l’aspetto sciamanico
che alcuni momenti più dilatati sembrano evocare:
«Fondamentalmente siamo rockers che ascoltano
underground noise shit e punk, ma amiamo ballare
con James Brown, soul music, Motown e non è una
novità dire che la musica nera, africana è la migliore musica sulla terra. […] Mi piace ascoltare musica
africana come Konono N.1, e recentemente l’etiope
Mahmoud Ahmed. C’è così tanta musica africana
che devo ascoltare che spero, col tempo, possa influenzare gli AB».
Stefano Pifferi
Turn On /
11
dell’album di debutto
degli islandesi Hjaltalín, disco che ben
fotografa la condizione
di ebbrezza cui sopra,
Sleepdrunk Pop
anche da un punto di
vista musicale. Ci si
trova allora davanti, in
quest’album, a canzoni
con massime variazioni
in tempi e mood, uso
di ampia strumentazione tra indie rock e pop
orchestrale, e insieme
un senso di estrema rilassatezza da festa tra
amici, in cui si passa
agevolmente da uno
stato a un altro, dall’euforia alla rilassatezza
alcolica e così via. Con
una leggerezza piacevole e easy derivata dallo
stare bene insieme, anche musicalmente. E in
questo, una non scontata complessità musicale.
D’altronde, l’apparente
facilità del pop è cosa
difficilissima da ottenere, si sa, frutto di intuizioni e talento nonché
di fortunate e magiche
alchimie. Chi sono allora questi newcomers del
Leggerezza e ironia, chamber indie pop e catchyness le caratchamber pop nordico lo andremo scoprendo man
teristiche degli Hjaltalín, nuova scoperta islandese.
mano, basti dire intanto, per ribadire il carattere
di loro (apparente) easyness, che il gruppo messo
La definizione di sleepdrunk in slang inglese così
su nel 2006 da Hogni Egilsson, fresco di studi di
recita: “Lo stato, dovuto alla mancanza di sonno, in
composizione, songwriter cantante e chitarrista di
cui si è talmente stanchi che le inibizioni si abbassano
Reykjavik, nonché deus ex-machina del gruppo,
e i processi cerebrali si affievoliscono, proprio come se si
è in origine destinato a un’unica esibizione. Evifosse ubriachi”. E Sleepdrunk Seasons è il nome
dentemente le cose vanno meglio del previsto e il
©Leo Stefansson
Hjaltalín
12
/ Turn On
combo variegato, che oscilla dalle otto alle dieci
persone, prosegue la sua attività. Accanto ai tradizionali chitarra basso batteria piano e tastiere,
si affiancano i meno usuali fagotto, tromba, trombone, corno francese e clarinetto, e i più consueti violino, violoncello, fisarmonica, harmonium,
banjo. E la voce imperfetta ma efficace di Hogni,
un misto di Jónsi dei Sigur Ros, Antony e Jens
Lekman, doppiata dal lato femminile di Sigga (Sigríður Thorlacius), contribuisce a creare una definita alchimia di gruppo nonché un vero e proprio
tratto distintivo armonico. Siamo dalle parti di un
chamber pop impetuoso ma lirico molto vicino ai
primi Arcade Fire, ai quali cominciano a essere
ben presto paragonati. Il solito passaparola su Internet fa il resto, anche se il gruppo oggi non ama
definirsi, con il senno di poi e con una certa punta
di snobismo, “una internet band tipica”.
L’incontro con il Morr-iano Benedikt Hermann
Hermannsson alias Benni Hemm Hemm segue di
lì a poco (e non si possono non notare le più che
evidenti affinità tra le due band), mentre si cominciano a porre le basi per il disco d’esordio.
Intanto il gruppo si tempra massicciamente dal
vivo, e qui la formazione varia di numero a seconda delle esigenze e delle occasioni. Una mini orchestra la loro, che fa musica ben presto definita
dalla critica locale “beautiful eclectic powerpop”,
con descrizioni del tipo“suonano come se i Teletubbies avessero deciso di formare una band”, per
il loro aspetto elfico e il potere immaginifico ma
d’impatto delle liriche.
A dicembre 2007 esce in Islanda il debutto Sleepdrunk Seasons, prodotto da Hermannsson insieme a Gunnar Tynes dei Múm, ed è da subito
la consacrazione in patria, dove ricevono nel corso
del 2008 numerosi riconoscimenti. Album d’esordio che nei primi mesi del 2009 è pubblicato nel
resto d’Europa.
Accade così che le fredde brume dei ghiacci nordici producono calde melodie laddove non ti aspetteresti, un equilibrio perfetto tra una base melodico ritmica beachboysiana e un’orchestrazione
variegata, con uso massivo di cambio di tempi, alla
maniera di mini suite tematiche (Goodbye July,
cantata per metà in inglese e per metà in islandese)
o colonne sonore classico-orchestrali (Kveldúlfur).
Una passione nemmeno troppo nascosta per Bacharach e Hazelwood così come per la musica colta traspare da subito. Ed ecco ancora Jens Lekman
e i Decemberists incontrare le voci e le variegate
orchestrazioni degli Steely Dan (Traffic Music),
mentre gli ultimi Sigur Ros pop si uniscono alla
sensibilità Antony (The Boy Next Door). Non sorprende quindi incrociare anche il barocco meno
melodrammatico dei canadesi Stars (Debussy,
Selur) e dei Belle & Sebastian più malinconici
alla Drake (nell’intensa e melodica The Trees Don’t
Like The Smoke). Nonché il pop eclettico degli Hidden Cameras e la complessità dell’immancabile
(da citare in questi casi) Sufjan Stevens.
L’unità tematica si ritrova anche a livello contenutistico; Sleepdrunk Seasons può essere definito
un “concept album” atipico, ricco com’è di spunti
ecologisti espressi anche in modo giocoso e non
forzato (così in The Trees Don’t Like The Smoke: “Put
that cigarette out for the trees/ and if you’re so sure that it’s
alright, then why don’t you say it out loud to the trees?”),
dettagli cinematici ed impressionistici alla maniera di una soundtrack, anche se molto spesso, più
che le parole, piuttosto centellinate, è il carattere
prettamente evocativo della musica ad esprimersi
pienamente.
Un gruppo potenzialmente in grado di dare molto
e ce lo dirà il tempo a questo punto. Intanto non
si può non godere, ancora una volta, delle melodie
cristalline e della magia del loro pop.
Teresa Greco
Turn On /
13
dälek
Off -Hop
- Marco Braggion
Il ritorno del doom per due degli hip-hoppers più duri del momento. L’uscita del nuovo album e qualche riflessione sulla contemporaneità direttamente dalla strada. dälek: il nuovo
incubo dal New Jersey.
C
os’è diventato l’hip-hop? I Dälek ne parlano
nel loro nuovo album Gutter Tactics (recensito in questo numero): il genere è un magma
ribollente che attinge da qualsiasi fonte sonora o
linguistica. La voglia di innovare non si è affievolita. Il duo -formato dall’MC Will Brooks e dal
produttore Oktopus (coadiuvati nella prima parte
del loro percorso dal turntablista Still)- è attivo dal
1998. I due si trovano immersi fino alla gola nella pre-millennium tension profetizzata dal santone Tricky. Era la stagione del doom: etichette che
proponevano un hip-hop ‘sperimentale’, avant. I
nomi sulle copertine dei giornali musicali erano
Anticon, El-P e cLOUDDEAD. I drones del rock
e dell’elettronica, che avrebbero fatto la fortuna dei
14
/ Tune In
Radiohead, sfociavano improvvisamente nel ritmo
urban per eccellenza. Oggi che di mesh ne siamo
pieni, queste estetiche suonano normali, a tratti
scontate. E non ci sorprendiamo più degli accostamenti inusuali. Il problema è uscire dal binario pur
restando vicini all’ortodossia del genere. Senza ovviamente perdere la reputazione. Fedeli alla staticità
che premia solo i più decisi, i più ‘massicci’, come si
dice in gergo.
Il duo da Newark (New Jersey) esordisce con una
pletora di collaborazioni ed EP. Il primo è Negro,
Necro, Nekros EP (1998). Un esperimento che
esce dalla stagione post-hardcore e che si fonde
con le estetiche cut’n’paste della Mo’ Wax e con lo
Shadow più illuminato. Ma è in combo con Tech-
no Animal nel Megaton & Classical Homicide
EP (2002) che si avverte un segnale forte. Quattro
tracce che mostrano la ‘shape of hip-hop to come’,
la visione futurista che è ancor oggi il loro biglietto da visita: suoni lunghi, drones alieni mescolati a
ritmiche old school. Vecchio e nuovo che collidono per far avanzare lo stile. Lo stesso anno, dopo
quell’antipasto che ci aveva fatto venire l’acquolina
in bocca, arriva il botto.
L’album sulla lunga distanza si chiama From Filthy Tongue of Gods and Griots. Divinità e cantori africani sono la giusta cornice per entrare in
una visione che ancor oggi spaventa per la potenza
e per la freschezza del suono. Bordate del calibro di
Spiritual Healing hanno la cattiveria del metal melvinsiano e la grazia della strada, tracce lunghe come
l’incubo Black Smoke Rises ci fanno capire che non
c’è compromesso. Il duo ha già il suono in tasca.
Ha già in mente le visioni electro-ambient dei Boards of Canada, mescolate a suoni industriali à la
Nurse With Wound e a un vago sapore etnico che
non si eclissa in sterili elitarismi. L’esordio li lancia
sull’olimpo delle classifiche; li si cataloga come hiphoppers solo perché vengono usate le basi in quattro. Ma sotto il vestito (ritmico) c’è molto di più.
Due anni dopo li troviamo infatti al fianco dei
Faust. Il combo krauto che va oltre la storia del
rock. In Derbe Respect, Alder (2004) esplode
la visione affine al sentire europeo. E non sai chi
stia facendo cosa, se i maghi della psichedelia si
stiano prendendo gioco dei pischelli americani o
se proprio qui l’hip-hop si stia rivoluzionando nello sgretolamento di tutte le certezze; perché non
c’è un pattern ritmico che segni la strada, non c’è
un minuto in cui possiamo sentirci sicuri di quello che succederà. Più che un disco, questo split ci
conferma il fatto che i ragazzi non scherzano. Da
qui in poi non è più solo old school. Si passa alla
maturità.
Absence (2005). Il disco che fa i conti con i classici. La pietra che scava nella storia hip-hop e che
inserisce la freschezza degli esperimenti sonori.
Un lavoro coraggioso: proprio quando l’attenzio-
ne sta calando sulla scena, la crew si fa notare con
l’arte della calibratura perfetta di vecchio e nuovo.
Il rapping incazzato dell’MC che si districa attraverso muri chitarristici in Asylum e i sample cupi
nell’inno che è Culture for Dollars; le cronache dal
dopobomba narrate nell’ambient sinuosa della titletrack o nei paesaggi glitch di Koner ci fanno capire la qualità di un combo che non ha mollato la
corda davanti al compromesso e che sa di poter
scuotere ancora per molto il pianeta del ritmo.
Poi la strada è tutta in discesa. Nel 2007 Abandoned Language e la raccolta di B-sides Deadverse Massive consacrano il gruppo come alfiere di
una ortodossia creata sul campo e sul palco. Gente
che si è costruita faticosamente un seguito, senza
aver bisogno di sponsor o di raccomandazioni.
Scostanti, scivolosi e sfuggenti. Data l’impossibilità della catalogazione, l’anarchia nella scelta della
proposta sonora è ormai d’obbligo. Loro sanno di
dover fare quello che sentono senza dover rendere
conto a produttori o a etichette. Solo a se stessi e a
noi che li seguiamo. A noi, fan stupiti che ci siano
ancora delle sorprese dietro la grancassa e l’hi-hat.
Per toglierci gli ultimi dubbi siamo andati a sentire direttamente uno dei protagonisti. L’intervista
telefonica con l’MC Will Brooks in esclusiva per
SentireAscoltare.
Con il tuo lavoro hai cambiato la prospettiva che guarda all’hip-hop. Il genere oggi
è difficilmente definibile dai critici. Pensi
di aver spostato il limite musicale o di aver
mantenuto le radici?
Per me l’hip-hop è quello che faccio, quello con cui
sono nato e cresciuto, è la mia cultura. Scelgo suoni differenti rispetto ad altri artisti, ma l’hip-hop è
sempre stato questo, è sempre stato così: spostare i
limiti e usare suoni nuovi. Poi è anche diventato un
affare commerciale, ma sicuramente queste operazioni non servono a creare cose nuove.
L’hip-hop è nato come una cosa di strada e
-come dici tu- poi è passato anche al comTune In /
15
merciale. Sì è persa definitivamente la realness?
No. C’è ancora. Penso che l’hip-hop rimanga comunque hip-hop, cioè questa evoluzione non mi
sorprende. Puoi trovare buona musica anche nella
parte commerciale, e anche ovviamente nella parte
underground.
In Europa ci
sono molte crew
che stanno mescolando suoni
diversi:
banghra, hip-hop,
electro,
etc.
pensi che questo mix di suoni
sia la next-bigthing?
Mixare i suoni è
quello che io chiamo hip-hop! Non
c’è niente di nuovo.
Scoprire nuovi suoni e metterli assieme
in una canzone. Il
cuore dell’hip-hop
è sempre stata la
scoperta di sample
da dischi o da film
e il loro riassemblaggio. Pensa alle
prime canzoni. Venivano usati anche samples dei
Kraftwerk: è la mentalità che sta da sempre dietro
l’hip-hop.
Il mood che sta sotto alle tue canzoni è
sempre molto oscuro.
Secondo te si connette con il dubstep?
Ascolti dubstep?
No, non molto.
16
/ Tune In
Pensi che questo modo che hai di descrivere la realtà sia condizionato dai tempi in
cui vivi?
È una domanda soggettiva, dipende sempre
dall’esperienza di ognuno, da che tipo di vita vivi,
da dove provieni.
Ascoltando il tuo
nuovo album ho
percepito due
prospettive diverse. Una più
focalizzata sul
suono e l’altra
sui testi. Come
lavori? Che cosa
influenza cosa?
Dipende da canzone a canzone.
Ma
comunque
non è il suono che
influenza i testi o
viceversa. Si tratta di costruire una
canzone nel suo
complesso. I testi
e la musica si influenzano a vicenda. Ovviamente i
testi sono importanti, ma allo stesso tempo riflettono
il mood dei suoni.
Nessuna delle due
componenti prevale sull’altra. Non ci sono regole
ben definite.
L’album è su Ipecac, l’etichetta di Mike
Patton. Perché hai scelto questa etichetta?
Conosci Patton o lavori con lui?
Non ho mai lavorato con lui ma penso che la sua
etichetta sia “open minded”, dà all’artista tutta
la libertà che vuole. Puoi fare ciò che vuoi, quin-
© Alexandra Momin
di penso sia una buona opportunità lavorare con
un’etichetta del genere.
Nei tuoi album parli spesso anche di politica. Scusa l’ovvietà della domanda, ma
cosa ne pensi di Obama? Pensi che ci sarà
davvero un cambiamento?
Probabilmente è significativo. Penso sia grande
che sia stato eletto Obama. Ma nello stesso tempo
non penso che un presidente possa cambiare così
tanto in 4 anni. Sono felice e orgoglioso, ma non
sono stupido. Non penso che una persona possa
cambiare l’intero sistema.
Pensi che la tua musica ‘politica’ possa
cambiare qualcosa? Perché scrivi se il sistema non cambierà?
Non la vedo come musica ‘politica’. La ragione per
cui scrivo musica è perché ho bisogno di qualcosa per esprimere le mie frustrazioni, i miei sogni o
altro. Non penso che con questa musica cambierà
qualcosa, Se la gente cambia ascoltandola certo
sono il primo ad essere contento, e questa è una
delle qualità della musica, ma non è lo scopo con
cui la scrivo.
Verrai in Italia per un tour?
Certo, ci sono stato qualche mese fa e di sicuro ci
tornerò! Non so ancora quando, ma sta sicuro che
tornerò.
Molte delle tue canzoni sembrano musica
adatta per qualche film. Hai mai pensato
di scrivere colonne sonore?
Certo! Abbiamo già fatto qualcosina e probabilmente nel futuro scriveremo qualcos’altro per
film.
Hai qualche progetto per il futuro? Un nuovo album?
Abbiamo due album su cui stiamo lavorando, ma
adesso siamo in tour, quindi torneremo a lavorarci
da marzo fino alla fine dell’anno.
Tune In /
17
Circlesquare
Berlin Emotronica
18
/ Tune In
Marco Braggion
M oments
L
in love
a lacrimuccia sul dancefloor ci mancava. Che
siano le tonnellate di break o di acidità ad averci un po’ saturato le notti sul dancefloor non lo possiamo dimostrare, ma il riprendere in mano le briglie della melodia di tanto in tanto ce lo possiamo
pure concedere. Dopo essere stati prigionieri delle
camere dubstep e dell’ambient da decompressione
ci mancava l’emozione. Ovvero il sentimento tutto
80 che due decadi fa veniva sprimacciato con tonnellate di paillettes sulle classifiche del pianeta e sugli aperitivi della Milano da bere. Quella sensazione
è mutata dopo il crollo del muro, nelle camerette
che la Morr ha abilmente nutrito con le sue sonorità; il cuore pulsante che nella disco di classe è sempre stato soul (vedi l’ultimo paladino Erlend Øye),
nella bianchissima Europa da un po’ di tempo non
trovava più casa se non in qualche uscita infelice e
ripetitiva.
Gli alfieri di quelle cavalcate epiche sono gli Apparat e i Röyksopp (nord e ancora nord). La loro è
una visione che colpisce la pancia e che punta sulla
voce. Con i primi si recuperano le lezioni tecniche
di warpiana memoria, remiscelate nelle vocals che
bilanciano il diabolico battito in quattro. Un intimismo che non si guarda le scarpe, ma che alza la
testa e fa vibrare. Cose che scuotono, come l’Arcadia (nella storica versione remiscelata dai Telefon
Tel Aviv), un mondo ideale da cui non vogliamo
scendere, o quell’inno che è da sempre uno dei capisaldi del minimalismo: Queer Fellow (magari nella
versione con Ellen Allien). Con i secondi invece
andiamo in direzione pop, quella perfezione che
ci annienta perché non ha una direzione, bensì la
sensazione romantica delle pianure sconfinate, gli
abissi che solo dal nord Europa si possono ammaestrare. I vuoti e i silenzi di una terra che non ti regala niente. La meditazione che ti porta a cercare
nuovi universi nel tuo io.
Dopo i fondatori, lo scettro passa a quel Patrick
Wolf, il nuovo Bowie, che qualche anno fa ha
sorpreso le piste da ballo e le passerelle di mezzo mondo. Un’estetica fatta di synth pop almon-
diano remiscelato rave e dunque step che guarda
furbescamente al rock mentre dal taschino spunta
l’electro da cameretta che fa zero zero come non
mai. Cose che fanno innamorare le girls e che fanno arrossire i boys (ma anche no). E da qui sarà
anche (vedi il riferimento al Duca) sempre più stile.
Sempre più fashion.
La parabola romantica è sempre al confine col
kitsch, perché se non la si prende sul serio la melancolia sovrasta chi la canta, eppure quando qualcuno riporta i remi in barca e sa il fatto suo, allora
si sbanca. Un nome. Kings of Convenience.
Ovvero saper guardare furbescamente a Simon &
Garfunkel, fotografarsi slavati sixties style, apparire
sempre in coppia. Aggiungi qualche color pastello
e qualche atmosfera fumè, l’aria distaccata di chi
sa far parlare di sé entrando di diritto nel magma
pop, magari con qualche esotismo nerdy che ricorda la canzone d’autore ed è fatta, specie se la metà
della coppia di Bergen è il citato Øye, uno che da
solo si è consacrato ‘The Voice’ in fatto di singing
disco pop, salvo ora ritrovare una sua dimensione
suonata con Whitest Boy Alive. Sempre nerd ma
indie soul appalla.
E poi, continuando la passerella, ancora gli Air e gli
esperimenti di eccellenza di Darkel. La francesità
che non è solo confinata al touch da ballare, ma che
sforna icone che stanno in piedi da sole sul palco.
Gente che fa (la) scena. Giacca e occhiali uberchic
che si fanno chiamare Sebastien Tellier. Le sue
rimembranze che pescano (ancora) dall’immaginario gainsbourghiano ma alle quali s’aggiungono
glitch e tastiere, una tradizione vieppiù rivisitata di
macchine e cuori che chiamale se vuoi emo perché
parliamo di una combriccola eterogenea di personaggi che puntano altezza petto e vivono senza
troppi bassi, senza il fumo dei tombini NYC. E sono
gli artisti più posh di tutta la ciurmaglia soul d’oltreoceano, prescindono dalla street culture e amano lo studio di registrazione. A molti piace questo
atteggiamento snob. Un po’ retrò, un po’ cool che
appunto ‘fa fico’, sicuro di accaparrarsi la copertina
o la prossima passerella di turno. A parte Wolf e
Tune In /
19
Øye, vecchi artisticamente ma non di passaporto,
l’età anagrafica va sotto il ’76 e, a guardar bene, di
nuovi adepti non ce ne sono poi molti.
Fino a ieri. Oggi infatti giriamo tra le dita la confezione cd di nuovo ragazzo dal cuore d’oro. Jeremy Shaw in arte Circlesquare.
Q uadrare
il cerchio
È la !K7 del benemerito Herbert a portare sulla
bocca di tutti questo ragazzo canadese. L’etichetta berlinese torna sulle orme del mid-tempo e ci fa
ricordare in un deja vu estraniante le mitiche Sessions di Kruder & Dorfmeister. Paragonare il nuovo pupillo ai due DJ non è esagerato. Anche loro
ci davano di elettronica e di digitale, ma sapevano
distillare l’essenza che punta allo stile direttamente
dalle menti dei remixatori. Quelle tracce che trasudavano un calore mai provato e che stavano bene
nei salotti dei parties più patinati.
Dopo quasi 10 anni, lasciamo da parte il piatto e ci
andiamo di analogico. Si torna in studio ma si suona e si canta. Perché Jeremy non fa il solito disco
impostato sul 4. Jeremy ci fa respirare con vocalizzi
fluidi, senza salti, una melodia cullante e piena di
riferimenti dark-gothic in stile Close To Me. I Cure
pop delle basi synth lanciate all’immortalità.
Lui arriva dal Canada e si racconta al telefono dalla capitale tedesca. “ho vissuto a Vancouver per quasi
tutta la mia vita dove era molto difficile per la mia band
andare in tour. A Berlino ho avuto piena libertà d’azione”.
E infatti, in Europa, si tuffa mani e braccia in un
ricordo post Modest Mouse filtrato con l’electro.
Di fatto un ripristino degli strumenti in chiave minimal ma con radici non proprio indie. “La mia è
una minimal con elementi acustici, ma penso che l’influenza maggiore provenga dalla musica folk. Gente come Leonard Cohen, più che gruppi indie. Forse qualcosa di minimal techno e di drum’n’bass, ma il riferimento principale
è sempre Cohen. Più folk che elettronica”. E la trama si
infittisce: Shaw viaggia infatti attraverso i territori più disparati, elettronica e mesh innestati nella
post-minimal. Un cuore che pulsa dark-folk e tutto ciò si riflette nella produzione di Songs About
20
/ Tune In
Dancing And Drugs (SA N°50), un album nato
dalla collaborazione triennale con Colin Stewart.
“Lui ha uno studio a Vancouver (The Hive). Ha lavorato
con i Black Mountains, i New Pornographers e altre
band valide. Visto che volevo usare molti suoni di batteria e
di chitarra registrati dal vivo nel mio ultimo album, lavorare
con lui è stata la scelta più ovvia. Lo conosco perché ho un
amico che stava in una band negli anni 90 (i Beans, una
band post-rock) a Vancouver. Loro registravano sempre in
quello studio, così l’ho incontrato”.
Acustico barra elettro sembrano essere il marchio
di fabbrica delle produzioni Circlesquare. Già in
Pre-Earthquake Anthem (Output Recordings,
2003) senza troppo clamore aveva mescolato Badalamenti e Joy Division, eppure nel lavoro a sorprendere è la semplicità e la freschezza.
“Non so se sono più minimal o acustico. Dipende dal giorno
della settimana [ride]. Ascolto sicuramente più rock’n’roll.
Se dovessi fare la top ten dei dischi di sempre, penso ci metterei solo un album di elettronica pura. Ma penso che dal
punto di vista estetico, visto che lavoro molto con tools elettronici, sono più orientato verso l’electro. Non so, in fondo
quello che mi piace sono le belle canzoni”. L’ago della
bilancia, insomma. Tanto per capire cosa ha in testa ci dice che ultimamente sta ascoltando molto
“i Deerhunter, Conrad Black e dei remix di Patrick Wolf ”. Un bel miscuglio di electro mutante
ma sempre con le canzoni là a farla da padrone.
Si torna a cantare gli diciamo e lui risponde sicuro
sul fatto che corsi e riscorsi tra disco e non disco
dell’elettronica cantata sono normali. Del resto
le pietre miliari restano i grandi gruppi. “Sono un
grande fan dei Depeche Mode. E penso di avere una strategia simile agli Apparat o B. Fleischmann. In poche parole
usare lo sile techno nella musica pop”.
Avremo modo di vederlo anche in Italia (sarà probabilmente da supporto ai Junior Boys) e di sentirlo in un prossimo remix per Matthew Johnson e
Patrick Wolf a cui sta lavorando.
Insomma, da quanto abbiamo capito questo SADAD
è uno dei punti di svolta per la Berlino minimal. Basta con le tastierine. Torniamo a quei cari e vecchi
amplificatori analogici e rilassiamoci. La lampada
in copertina ci ricorda il modo di aspirare la metanfetamina, che appunto molti ragazzi americani inalano usando pezzi di lampada rotta. Un ritorno al
sintetico da camera. Per il nuovo sballo ritorniamo
tutti a sognare sul materasso. Songs… è la miccia che
scatenerà la rivoluzione. Ne siamo sicuri. Segnatevi
l’appuntamento al Fabric, il 24 gennaio.
Tune In /
21
Mimes Of Wine
Immagini
in movimento
-
22
/ Tune In
Stefano Solventi
Il pianoforte e la voce di Laura Loriga tornano a casa portando in testa e nel cuore immagini di altri tempi e altri spazi.
La California, Parigi, Bologna: un triangolo tanto improbabile quanto plausibile oggi che nulla è incolmabile, che tutto è
mobile, in ogni direzione/dimensione. Una sfida difficile ed esaltante per chiunque abbia voglia di catturare queste immagini
in movimento.
U
n fantasma si aggira nell’occidente globalizzato, atomizzato, apolide. E’ un’inquietudine
febbrile, è un andare avanti comunque anche se di
colpo non riesci a vedere la strada, è un voltarsi che
spedisce i rimpianti e le angosce in un futuro che
sai irrinunciabile. Irreversibile. Forme e movenze
antiche imbastiscono teatrini di sconcertante modernità. Di cui senti l’urgenza ora e qui. Lo hanno chiamato pre-war folk, ma è un’etichetta che
si è presto rivelata angusta rispetto alla ricchezza
espressiva di una Joanna Newsom, dell’immancabile Devendra Banhart, delle ineffabili Cocorosie e persino di una PJ Harvey inaspettatamente – ma emblematicamente - gothic.
Pensavo questo ascoltando l’ep d’esordio dei Mimes Of Wine, moniker dietro cui agisce Laura Loriga, pianista e cantante, nata a Bologna (dove ha
fatto parte dei post-rockers Lanark) ma con base
anche a Parigi e in California (dove ha dato vita al
trio elettroacustico While They Sleep..).
Impressiona la forza e la complessità ammaliante
dei pezzi, di cui lei stessa è autrice. Il piano e la
voce si dannano in un’interpretazione senza sconti, strattonati tra allucinazioni folk-blues da camera, perniciose fatamorgane post-jazz, in un frullare
di percussioni e ottoni, tra imprendibili folate elettroniche, nell’andirivieni di corde che ghignano e
carezzano. Un sound notevole, sviluppato dall’incontro con Enzo Cimino dei Mariposa e Adriano Modica (un altro di cui varrebbe la pena parlare), quindi con Francesco Begnoni e Zeus
Ferrari, già Juniper Band e You Should Play
In A Band. Soprattutto, c’è la sensazione di qualcosa che sta ancora crescendo, in bilico tra antico
insopprimibile e futuro prossimo. Non potevamo
lasciarci sfuggire l’occasione di intervistarla.
Mimes Of Wine è un modo per nasconder-
ti dietro ad un progetto o unprogetto da
perseguire oltre al tuo essere musicista e
cantante?
Una cosa ha portato all’altra. Nascondermi dietro ad un nome che non è il mio ha forse messo
la musica un po’ in primo piano rispetto alla mia
persona, e questo mi ha aiutato perché volevo che
chi avrebbe fatto parte di Mimes of Wine con me
si potesse sentire libero di giocare con forme ed
elementi quanto me. “Mimes of Wine, apocalypse sets
in..” sono i primi due versi di una poesia scritta da
un mio amico, Amir, e ancora adesso mi piacciono
ogni volta che li penso.
Francesco e Zeus della Juniper Band sono
oggi con te nei M.O.W., in passato hai lavorato con Enzo Cimino dei Mariposa e
Adriano Modica: tutta gente in cerca di
sonorità desuete però non estreme, selvatiche ma ad altezza d’uomo, tra frugale e
sperimentale. Quanto sono stati difficili, e
perciò preziosi, questi incontri?
Tutti questi sono stati e sono ancora incontri preziosi. Per quanto diversi possano essere l’approccio
di Francesco e Zeus da quello di Enzo o Adriano,
tutti loro sono stati disposti ad ascoltare molto fin
dal principio, e a venirmi incontro ognuno a modo
suo moderando a volte le mie scelte, e a volte rendendole meno consuete. Con Enzo ed Adriano ho
cominciato ad apprezzare il suono di ogni singolo
campanellino, corda, respiro, rumore, e a mettere insieme le cose partendo da elementi piccoli, a
volte a malapena udibili. Questa parte mi ha appassionato molto, infatti anche ora quando compongo da sola utilizzo lo stesso metodo.
Con Francesco e Zeus invece ho imparato come si
possono creare delle atmosfere che accompagnino
ogni pezzo dall’inizio alla fine, come creare soliTune In /
23
dità, e come sentire strati di suoni diversi influenzarsi a vicenda e impregnarsi l’uno dell’altro come
spugne una sull’altra. Non ci sono state grandi
difficoltà in nessuna di queste circostanze, forse
perchè abbiamo sempre cercato subito un punto
di comunicazione da cui partire. Il fatto che tutti questi musicisti siano sempre pronti a cercare il
suono giusto per ogni particolare, avendo anche
cura del significato che questi possono assumere
a livello di ascolto immediato, credo abbia aiutato
nella creazione di zone d’intersezione con il lavoro
che io avevo fatto da sola.
Credo ci sia ancora molto da poter fare con ognuno di loro, in un futuro più o meno prossimo..
Hai vissuto a Parigi, a Santa Barbara in
California, a Bologna. Che conseguenze ci
sono sulle tue coordinate artistiche?
In California ho incontrato musicisti che sono anche ora molto importanti per me a fianco di quelli
italiani, e che mi supportano anche quando sono
qui. Se ho imparato un po’ a stare su un palco, a
trasmettere tutto il possibile, a farlo con semplicità
e poca paura lo devo a questo strano paese, a San
Francisco e Los Angeles, che negli ultimi due anni
mi ha fatto impazzire dandomi però tantissimo. L’
ottimismo, la creatività, e l’apertura dei musicisti
che ho ascoltato e conosciuto hanno influenzato
ogni cosa che ho scritto, e buona parte dell’album
è stato pensato lì.
A Parigi ho fatto molti meno concerti ma ho camminato molto. Mi veniva voglia di fermarmi e
scrivere tutto il tempo, pensando a tutti quelli che
sono passati per quelle strade prima di me. Infine
ho portato via con me un pochino di swing... Bologna è casa, e credo che in fondo parta tutto da qui,
dalla decisione di comporre cose mie, fino al tipo
di sonorità che finora ho scelto. Non ho raggiunto
una grande saggezza, però ho cominciato a pensare che forse la musica davvero può non avere territorio e che può diventare davvero quello che si
vuole, almeno in parte.
Nel tempo mi è venuta la voglia di scrivere mille
24
/ Tune In
cose vicine a generi, posti e persone diverse, e Mimes of Wine è il risultato della combinazione di
alcuni di questi tentativi.
Le canzoni del tuo ep mettono il dito nella piaga tra avanguardia e tradizione, con
tutto quel che sta nel mezzo. C’è margine
di manovra per sentirsi popular? Ovvero:
quando fai musica ti rivolgi al più vasto
auditorio possibile o ti senti destinata ad
un pubblico di nicchia?
Spero che questa piaga non sia così dolorosa, e che
ci sia molto spazio tra questi due estremi per me
come per molti altri. Non riesco a immaginare un
pubblico di nicchia, forse perché non saprei bene
con che criteri definirlo. Mi piace pensare che ci
sia ancora voglia di ascoltare (anche perché questo
mi da molta più voglia di scrivere e di fare del mio
meglio) e ho fiducia nelle orecchie altrui, come
credo ne abbiamo avuta tutti i musicisti che ammiro di più, cercando di creare la musica che volevano sentire.
Tra le Newsom e le Hyvonen, lanci evidenti
allusioni alle performance saturnine della
Galas e della prima Harvey. Poi c’è quella
fregola jazz venata bossa che ammicca al
post moderno di una Cibelle. Cosa ho azzeccato? Cosa ho colpevolmente lasciato
fuori?
Vedo anche io alcune di queste somiglianze che
perciò mi sembrano azzeccate, però la maggior
parte delle mie allusioni sono tuttora inconsapevoli. Di alcune mi sono accorta dopo aver scritto, su altre mi stai facendo riflettere ora tu... Mi
sono riseduta al piano dopo anni passati piuttosto
lontano da strumenti acustici e voci femminili (PJ
Harvey è una delle eccezioni, con Kim Gordon,
Patti Smith, Kazu Makino), e ho cercato di rielaborare i suoni e i ritmi a me familiari con piano
e voce, usando soprattutto la seconda nel modo
più naturale possibile.
Anche ora se invento una linea di basso mi capita
di pensare più che altro ai Morphine o ai June
of ’ 44. Da allora però, continuando a cercare,
trovando di più, e ascoltando in particolare Nico,
Nina Simone, Mary Timony, Lotte Lenya,
Vashti Bunyan, Meredith Monk, e ancora PJ
Harvey (White Chalk mi piace molto e lo sento
effettivamente vicino a me) la mia prospettiva si è
arricchita. Di Diamanda Galas ammiro molto
la forza sia sonora che di presenza e la capacità
di trasmettere, di Cibelle l’inventiva e la capacità
di incollare insieme mille cose diverse con totale
naturalezza.
a quattro mani per cortometraggi e piccole compagnie di danza. Sono curiosa di vedere che cosa
può venire fuori lavorando a contatto con altri e
con le loro parole, gesti e luci, con immagini in
movimento.
L’immediato futuro sarà targato M.O.W. o
ci sono altri progetti in cantiere?
Come prima cosa vorrei portare Mimes of Wine
in giro dal vivo il più possibile, e portare avanti il
materiale che sto scrivendo ora e che mi piacerebbe presentare. Da poco mi è stato proposto come
“side project” di scrivere piccole colonne sonore
Tune In /
25
Nuovi
Corrieri
Cosmici
Non è la prima volta che la Grande Musica Cosmica diventa oggetto di revival. Oggi ci sono però differenze sostanziali.
Quei suoni, quelle tecniche, quelle atmosfere risuonano nei dischi degli ultimi mesi senza che necessariamente si tratti
di tributi. È diventato uno stilema, un linguaggio trasversale, come tutto il krautrock. Non si tratta di rielaborazioni
del prototipo Irrlicht; ecco a voi i Nuovi Corrieri Cosmici che parlano come quelli di ieri.
26
Gaspare Caliri, Antonello Comunale, Stefano Pifferi; con contributi di Gianni Avella
/ Drop Out
K rautrock - resampler
C
os’è il krautrock? è la musica tedesca dei
primi anni Settanta. Definizione pacifica,
palese, paleontologica, parziale. Eppure
la sua diffusione non ha una storia limitata a quegli anni. Il suo modus operandi, anzi, come vedre-
mo, i suoi due modi principali di fare musica, si
sono raddensati attorno a certa musica degli anni
Novanta, da un lato nel post rock che lo ha rivalutato esplicitamente, dall’altro negli usi e nelle strumentazioni dell’ondata elettronica che fece capo
al suono Warp.
Di fatto conosciamo le prime vicende del genere
anche grazie ad alcuni contributi ad hoc, come
il sempre citato Krautrocksampler di Julian
Cope, che da giovane, come si legge nel libro, era
un “avvertito”, uno di quegli eletti – neanche troppo pochi, in realtà – che in Inghilterra, nel passaggio tra Sessanta e Settanta, seguivano la scena
di quello strano rock tedesco che non tutti reggevano, a fianco del quale solo alcuni riuscivano a
stare, senza annoiarsi o cercare il calore dei suoni
tradizionalmente blu.
In realtà il krautrock ebbe in Inghilterra una diffusione nient’affatto limitata, selezionò cioè parecchi
“avvertiti” – spesso adolescenti - che compravano
le nuove uscite Polydor a scatola chiusa; successe persino che alcuni dischi – i Faust siano da
esempio – uscirono prima in Inghilterra e poi in
Germania, cioè prima in quel paese che era diventato il “mercato” principale e poi nella “madrepatria”. Questo per dire che il rapporto tra apertura
e chiusura nella diffusione del krautrock – dentro
e fuori il territorio tedesco - ha una storia lunga;
anzi, ha una storia che inizia assieme a quella stessa del krautrock, e che forse dovremmo abituarci a
considerare sovrapponibili.
Se volessimo proprio mettere una conclusione parziale di quella liaison anglo-tedesca citeremmo con
rapidissima sicumera la vicenda dei This Heat,
che importarono ad Albione il krautrock più industriale, macchinino e meccanico, e finirono per
essere a tutti gli effetti dei krautrocker, anni dopo
le prime note della kosmische, nonostante la mancata provenienza tedesca. Tutti appena sentono il
loro nome pensano al kraurock. Abbiamo con loro
il primo esempio forse dell’inesattezza dell’equivalenza kraut uguale Germania. E però a dirla tutta
tale fatto non è neanche particolarmente rilevante
Drop Out /
27
o interessante.
Il sampler krautrock di Cope è in realtà la narrazione dell’avvicinamento alla musica tedesca, cosa
che poi si è riflessa nella stessa produzione dell’exleader dei Teardrop Explodes, non a caso proprio
negli anni Novanta. L’articolo che state iniziando
a leggere parla invece di una bolla musicale - negli
ultimi mesi sempre più presente e tangibile - che
è innegabilmente legata al krautrock di inizio Settanta. Vale come sempre la nostra prova del nove:
quante volte è comparso negli ultimi mesi il termine “kraut” nelle recensioni e nelle riflessioni di
SA? Tante. È allora la quantità di occorrenze del
genere ad averci messo sotto gli occhi la necessità
di un approfondimento; ma non solo. È la crescita,
i cui primi passi sono datati a più di due anni fa, di
una lettura critica che ci ha fatto pensare al “revival” krautrock odierno come qualcosa di diverso
rispetto agli atteggiamenti del decennio precedente. Per capire la bolla di quello che oggi finisce nella
casella “krautrock” siamo dovuti tornare indietro
perché sembra quasi che le evoluzioni – a partire dal
krautrock – che hanno avuto corso nei ’90 siano state quasi rimosse nella memoria storica del novello
“avvertito” del 2008. Ovviamente non può essere
del tutto così; ecco la ragione di un approfondimento che tocca sì le origini, ma soprattutto gli
esempi concreti della Musica Cosmica datata fine
Duemila; le ricognizioni spaziali di Emeralds,
Cloudland Canyon e Be Invisible Now!,
nonché le gesta dei californiani di Frisco The Arp
e Jonas Reinhardt, ci hanno aiutato a nutrire le
nostre argomentazioni di dischi da ascoltare; con
la parabola e con la discografia (nutritissima) di
Expo ’70 abbiamo poi sviscerato, discutendo con
il diretto interessato, il rapporto con quella musica
molto ben localizzabile di quasi quattro decenni
fa. [g.c.]
P assaggi
di scal a
Quando si parla di krautrock si intendono certamente almeno due cose, secondo una tradizionale divaricazione critica. Da una parte si parla di
28
/ Drop Out
quell’atteggiamento “macchinico”, percussivo
che prese corpo a partire dalla produzione dei
Neu! e per certi versi dei Faust, e proseguita,
come si diceva sopra, senza ombra di dubbio geografico, dai britannici This Heat. Parliamo naturalmente del “motorik” di Michael Rother e
Klaus Dinger, e qui citiamo ancora Julian Cope,
che nel suo libro confessa che il momento in cui
più di ogni altra circostanza ebbe la sensazione
netta di ascoltare qualcosa di semplicemente
nuovo, sconvolgente, rivoluzionario nel suo essere freschissima “acqua calda” del rock, fu quando, nel 1972, il suo giradischi riprodusse per la
prima volta Hallogallo, cavalcata motoristica per
eccellenza e primo brano di Neu!.
D’altra parte di krautrock si parla anche quando si accenna a quella musica stellare che venne
immediatamente ribattezzata con l’appellativo
di Kosmische Musik; la fascinazione degli astri
non era novità squisitamente appannaggio delle
fredde menti tedesche di quegli anni; il probabile
vero esordio in ambito “rock” fu il gioco dei pianeti di quella Astronomy Dominé di The Piper At
The Gates Of Dawn; e però non è un caso che
il sottotitolo di Krautrocksampler, per rifarcisi
per l’ultima volta, si appellava alla volontà di fare
da guida alla “Grande Musica Cosmica”. In effetti dopo le vicende tedesche di fine Sessanta-inizio
Settanta a quell’espressione si associano immancabilmente alcuni stilemi, alcune tecniche musicali,
alcune atmosfere propri degli iniziatori krauti, soprattutto il Klaus Schulze di Irrlicht, i Tangerine Dream, i Popol Vuh, gli Amon Duul II.
Questi ultimi furono particolarmente esemplari
per il fatto che espressero musicalmente il prodotto
di un’aggregazione quasi da comune hippie, e che
veicolarono in un certo senso la reazione politica
attraverso la colonna sonora dei pianeti.
È una chiave di lettura forse grossolana, ma sociologicamente sottolineata a più riprese; e, soprattutto, ci mette di fronte a una fondamentale
differenza tra quel krautrock e tutti momenti in
cui si ebbe a parlare, successivamente, del gene-
popol vuh 1972
re. Pensiamo al post-rock, alla sua concentrazione
sulla struttura musicale e sulla capacità che ebbe,
a partire da presupposti squisitamente musicali, di
far tornare in auge i corrieri cosmici – e tutto il
krautrock. Pensiamo però anche alla disinvoltura anche questa tutta Novanta – con cui i pionieri di
quello che sarebbe diventato il suono Warp ripreso
strumenti analogici e vintage propri del krautrock
cosmico per una rielaborazione attaccata da più lati,
tattica, della musica cosmica. Con gli inizi Warp
abbiamo assistito a qualcosa di nuovo; ma come
per il post rock vi si arrivava attraverso una ripresa, una riflessione su quel passato; niente filologia,
questo no, ma un ragionamento tecnologico.
I Nuovi Corrieri Cosmici, ci pare di poter dire,
hanno un atteggiamento diverso, che viene appresso a un cambiamento di statuto del kraut. Oggi
come dicevamo il krautrock è stabilizzato in un
.linguaggio, che si è isolato dai precedenti tentativi
di ripristino creativo. Un formato quasi autonomo.
Un insieme di stilemi che vanno ad affiancarsi con
quelli dei Sessanta e Settanta anglosassoni, per cui
oggi si fa blues-rock senza necessariamente mettere in discussione la distanza dalle fonti.
Veniamo a oggi, anzi a pochi giorni fa. Siamo a
Netmage, festival bolognese di “arti elettroniche”,
rumorista e dronico per eccellenza. Ascoltiamo
nella giornata di giovedì, la prima del festival, il
live degli statunitensi Pete Swanson, John Wiese,
Liz Harris. Noise a cui siamo sempre più abituati,
fin troppo piatto nella sua capacità di far vibrare
pericolosamente i timpani. Subito dopo assistiamo
alla performance degli Emeralds, e lì la pulce
nell’orecchio si sfoga. Una presa di peso di Schulze e dei Tangerine Dream, fino a Cluster e ai
Popol Vuh. John Eliott, Steve Hauschildt, Mark
McGuire suonano con una chitarra in secondissima linea, arpeggiata e astrale, ma soprattutto con
un miniMoog, e portano nel tempio dell’elettronica sposata all’arte visual quel linguaggio una volta
prodotto dalle comuni tedesche.
La kosmische musik è insomma entrata persino
nell’arte contemporanea, nella sofisticazione dei
Drop Out /
29
droni e delle ultime linee tracciate dall’esercito ambientale, che a volte vanno allo spazio effettuando
un passaggio di scala, descrivendoci come il vuoto
di una stanza sia omotetico, come in un frattale,
a quello dello spazio. In questo contesto, il nuovo
krautrock dei circuiti dell’elettronica contemporanea si scarta da alcune associazioni assodate per
tornare al passato del sogno al mandarino.
La musica astrale è infatti diventata quasi un gioco, un lavoro sull’opinione collettiva dello spazio e
dei suoi suoni, sui pregiudizi musicali fantascientifici che lega a determinati effetti sonori la rotazione dei pianeti; si legga a tal proposito – altrove su
questo stesso numero di SA - l’epopea di Rafael
Toral, portatore esplicito di “spazitudine” estetizzata – in un gioco al rialzo rispetto allo sci-fi. Ci
sono aziende, come la ditta americana “Yuzoz”,
che hanno registrato per anni i suoni dello spazio dai loro satelliti che esse possiedono; altri siti
web dove è possibile scaricare tracce audio di una
gigante rossa; spazi virtuali che non fanno che alimentare il comune senso di curiosità e la catacresi
della metafora sonica del viaggio cosmico e delle
relative tecniche di reporting immaginario del fischio
dell’astro.
I corrieri cosmici producevano invece un senso musicale che toccava direttamente l’umano, nella fuga
da esso. Come esempio classico, citiamo il solito
Schulze, la cui musica veniva associata agli umori
di Wagner, di quella magnificenza celebrale.
emeralds
30
/ Drop Out
Torniamo allora a capire gli ancoraggi effettivi coi
maestri. Ci concentreremo poi a leggere la parabola di una band che oggi indaga quei rapporti
che le comuni tedesche sperimentavano. Hanno
il nome dell’esposizione universale che avuto luogo a Osaka nel 1970. Era periodo di architetture
megastrutturali, di spazi apertissimi, di progetti di
scala enorme. Ma qui – anche grazie agli Expo
’70 - ci occupiamo di una scala ancora più ampia,
evidentemente.
Del viaggiare verso lo spazio alla ricerca degli effetti
sul terreno. Della geografia della musica cosmica.
A partire dal caposaldo che fece da discrimine tra
un prima e un dopo, magnifica asserzione da e per
la musica tedesca al passaggio di decennio ’60-’70,
al passaggio definitivo tra lo sballo (alla Agitation
Free) e la pesantissima levitazione verso lassù, a
sud di Irrlicht. [g.c.]
Il
mondo a sud di
I rrlicht
C’è una grande differenza tra guardare il mondo
in cui viviamo, sia pure con occhi trasognati e alterati, e agognare le stelle che ci sovrastano. Il mood
per forza di cose si tinge di liturgico e l’esperienza non può che tradursi in un romanticismo dalle
tinte apocalittiche. Klaus Schulze lo sapeva bene.
Non si inventa la musica cosmica di Irrlicht semplicemente svegliandosi un giorno, come illuminati
sulla via per Antares. Basta ascoltare i primi dischi
dei Tangerine Dream e confrontarli con quelli più
tardi e “schulziani”
come Alpha Centauri e Zeit. Irrlicht potrebbe essere
preso come un metodico sistema per misurare la distanza tra
l’uomo e le stelle. Il
metro di questo intervallo tradotto nelle folate d’organo di questa
“Quadrophonische
Symphonie für Orchester
©jamie bayer
und E-Maschinen”. D’altronde ridurre l’intera esperienza e genesi della musica cosmica tedesca alla
sola figura di Schulze sarebbe riduttivo. Ci dimenticheremmo di compagni di viaggio fondamentali come Manuel Göttsching, Sergius Golowin o
Walter Wegmüller. Ma qui non si vuol tracciare
un profilo storico di un periodo musicale o costruire un albero genealogico di una comune visione.
Come sempre più spesso siamo condannati a fare,
guardiamo al passato per tradurre il presente, ed
è in questo senso che possiamo fermarci a parlare
di musiche così attuali e al tempo stesso così tradizionali come quelle dei nuovissimi corrieri cosmici
dei giorni nostri. Sul finire della prima decade del
nuovo millennio quasi tutti quelli che decidono di
trafficare con drones e moods dell’estasi cosmica
tedesca vivono una sorta di dopo sbornia da post
rock. Il suono dei questi anni si rivela così assai più
integralista della commistione di generi e sottogeneri che infuriava negli anni ’90. Quello che contributi a codificare il marchio Kranky, depurato
dei suoi elementi eterogenei e ridotto all’osso della
tradizione. Un percorso in qualche modo simile a
quanto accaduto in ambito folk con il ricorso alle
radici più tarde e vere del pre-war.
La musica cosmica dei primi anni del nuovo millennio si allinea alle coordinate stellari dei maestri
di sempre. Stabilisce ponti e fusioni tra Tangerine Dream e Ash Ra Tempel, con la stella polare di Irrlicht a condurre il viaggio. E’ questo il
caso degli Emeralds, tra i migliori esemplari del
nuovo corso. Trio proveniente da Cleveland, Ohio,
costituito da Mark McGuire, John Elliott e Steve Hauschildt. I documenti migliori del trio prendono il nome di Allegory Of Allergies e Solar
Bridge. La loro è una sintesi illuminata dell’estasi
cosmica tedesca. Le chitarre liquide e oniriche di
Göttsching riprendono vita in brani sostenuti sulle
nuvole come Nereus (Spirit Over The Lake), Lawn Of
Mirrors, Snores. Il trio è poi abile a traghettare queste
corde liquide e oniriche nei gorghi a base di synth
e organo di tradizione schulziana che costituiscono il loro trademark. Gli Emeralds non ci pro-
joseph ragl ani
vano neppure a trovare nuovi modi di coniugare
il verbo. Il loro è un modus operandi quanto mai
classico. Fasci e fasci di drones d’organo e synth
inframmezzati da reticoli di chitarra riverberata.
Il loro viaggio è il classico anelito verso l’infinito
fatto con cattedrali costruite tra quasar e supernova. L’unico aggiornamento che concedono all’aria
dei tempi è un generalizzato sentore d’apocalisse
che adombra la maggior parte dell’anelito mistico
degli corrieri cosmici originali. Quello degli Emeralds è un ponte costruito verso un sole nero. Meno
dark, ma non meno tortuoso il percorso di un altro caso eccellente che risponde al nome di Joseph
Raglani. Altro americano, del Midwest, cresciuto
tra college, comic books e krautrock. Come sempre accade in questi anni, anche Joe è un autarDrop Out /
31
chico self-made-music
e quindi si prodiga
nell’ordinaria amministrazione di una varia e disordinata produzione discografica
a base di microlabel
e formati per feticisti
(cdr, cassette, edizioni
limitate). Per usare le
parole di Brad Rose,
Joe Raglani “segna la
linea di separazione tra la
bellezza e il caos”. Una
definizione altisonante ma stranamente
centrata e giustificabe invisible now!
ta. Tra i capi d’opera
dell’artista troviamo
infatti cose come Oneism Una cassetta che parte
con un ronzio da synth valvolare e che arriva a
due passi dall’harsh noise. Ma il vero trademark
di Raglani è l’eden scomposto e variopinto di episodi come Living Room, Web Of Light e quell’
Of Sirens Born ristampato in fretta e furia dalla
Kranky l’anno scorso. L’attacco di Web Of Light
non lascia dubbi. Dice di un autore che prende in
prestito da Cluster e Tangerine Dream e in misura ancora maggiore da Ash Ra Tempel, e questo tradotto in soluzioni musicali significa erigere
costruzioni animate da fasci reticolari di note d’organo e synth. Episodi più caotici e originali come
Bardophasing vanno per altro a flirtare con i riferimenti quarto mondisti di Hassell, ma come filtrati
attraverso un fitto intrico di riferimenti noise. Of
Sirens Born si rivela quindi come il disco che fa
maggiore sintesi delle diverse sfaccettature del musicista, mettendo dentro di tutto. Dalla quieta stasi
onirica di Rivers al caos estetizzante e imperioso di
Washed Astore. Volendo però prendere in esame un
casus belli esemplificativo al massimo della nuova
stagione, anche in virtù dell’umore prettamente
passatista dell’operazione, il duo americano-tede32
/ Drop Out
sco dei Cloudland Canyon diventa il simbolo
perfetto del nostro discorso. Non che Kip Uhlhorn
e Simon Wojan siano deficitari di un gusto proprio
e di una capacità di rielaborare in modo nuovo la
vecchia grammatica tedesca, ma sta di fatto che
nel corso di due dischi e mezzo (due lp e un ep…)
e di una collaborazione con Lichens, i due abbiano praticamente inscenato un perfetto revival
kraut, che non da spazi a dubbi o incertezze. Da
qui a titolare quindi il primo brano dell’ultimo disco partorito su Kranky, Lie In Light, con il titolo
ammiccante di Krautwerk il passo è breve.
È un piccolo duopolio, invece, quello stanziatosi
dalle parti di San Francisco.
Jonas Reinhardt e The Arp – questi noto all’anagrafe come Alexis Georgopoulos - sono amici di
vecchia data armati di soli synth, e dai loro lavori
si evince una forma mentis oltremodo trance.
Reinhardt in particolare ci sembra quello più
ispirato. Nel debutto omonimo targato Kranky, il
Nostro, che alla maniera dei corrieri cosmici di un
tempo azzera - a suo dire - il gap spazio/epidermico tra uomo e macchina, sciorina tredici istanze dove lo spauracchio dei Cluster addomesticati
dalla cura Michael Rother,
Modern By Nature’s Reward,
risolve senza indugi, come
naturale evoluzione della
specie, nelle architetture
a là Harmonia di How To
Adjust People.
Nel mentre, di contro ai
palesi richiami teutonici,
si tagliano rimandi a Wendy Carlos (la prima parte
di Blue CutawayTore Earth
Clinke) e peculiari appeal
cinematici a piè pari tra
i Goblin di Dawn of the
Dead (Every Terminal Evening) e il John Carpenter di
Fuga Da New York (Tandem Suns).
Contrariamente,
Alexis
Georgopoulos, dopo la
breve parentesi in seno al
combo punk funk Tussle,
al proprio nome preferisce, dal 2006, il moniker
the arp
The Arp.
La first release griffata
Smalltown Supersound In Light gravita, anch’essa, nell’interregno sito tra Cluster, St Tropez, e Harmonia, Potentialities, parimenti a digressioni Brian
Eno, The Rising Sun.
Ciò che lascia perplessi è il mancato effetto sorpresa. Non che sia necessario, ma contrariamente al
dirimpettaio Jonas Reinhardt il canovaccio vive di
pochi scossoni; e alla luce delle palesi qualità tocca
attenderlo fiduciosi al secondo step.
Ma il revival sei suoni cosmici anni ’70 non è soltanto materiale per geek americani. Anche in Italia
qualcuno sta provando a rispolverare i vecchi suoni, i vecchi immaginari valvolari, e questo qualcuno è Be Invisibile Now! al secolo Marco Giotto. Nel suo primo disco, sorta di concept album
dedicato ai neutrini, Giotto riprende a trafficare
con strumentazioni e soluzioni d’antan. Tastiere
Roland e Korg d’epoca e sintetizzatori valvolari,
per una generale atmosfera retro-futirista anni ’70
che collide in egual misura con Klaus Schulze e
John Carpenter. In brani come Antiparticella e Sarin
il Nostro non fa mistero dei suoi riferimenti arrivando addirittura ad una sorta di “mimetismo sonoro”, cercando a tutti i costi di suonare come un
vecchio corriere d’epoca, piuttosto che come un
epigono degli anni 2000. Un approccio a tal punto
simile a quello dell’americano Expo ’70, che i due
non hanno potuto fare a meno di incrociarsi e di
condividere uno split ep, uscito l’anno scorso per
Kill Shaman. Musica minacciosa, brumosa, in perenne stato di ansiosa sospensione. Tutte le liturgie
della nuova epoca hanno in comune un pathos caDrop Out /
33
expo ‘70
34
/ Drop Out
rico d’angoscia che stride platealmente con l’anelito mistico e libertario dell’epoca che fu. I padri
hanno lasciato ai figli un mondo in disfacimento
e il testimone viene passato con un anelito sempre
più pronunciato verso la fine di tutte le epoche. I
nuovi corrieri cosmici tendono al nero e al caos.
Questo oggi ci resta di tanta speme… [a.c., g.a.]
Un
infinito ohm nero pece
Una discografia sterminata per un uomo solo.
Ma anche e soprattutto una discografia sterminata per un suono solo. Justin Wright, l’uomo nero
e solo dietro Expo ’70, propone da pochi anni e
tantissimi dischi un singolo, unico, ossessivo e dilatato suono che si perpetua in eterno: quello di
un drone nero-pece di matrice chitarristica, debitore tanto del minimalismo più astratto quanto del
kraut-rock più lisergico e liquido. Una esperienza del limite, quella dell’artista di Kansas City; di
quelle in cui l’apparente staticità del suono è simile
a quella dello spazio profondo, in cui l’assenza di
gravità rende i movimenti sospesi, quasi impercettibili, rallentati al punto da poterne quasi vedere
la scia.
La metafora spacey non è scelta a caso. La musica
targata Expo ’70 si inserisce, infatti, nel solco di
altre esperienze, spesso sotterranee, protagoniste
della parziale carrellata offerta da queste pagine e dedite più che a una infruttuosa e emulativa
riscoperta, ad una sorta di comunione spirituale
con l’ala più libera e droning del kraut dei ’70. C’è
però nelle musiche (nella musica?) di Expo ’70 e
nell’uomo dietro questa sigla una coesione forte,
una filosofia verrebbe da dire, che ci impone di
approfondirne l’evoluzione attraverso la discografia – in gran parte sconosciuta da noi – e con una
breve ma intensa intervista.
Procediamo però con ordine. Rubato il nome alla
prima expo mondiale tenutasi in Giappone (nella
regione di Osaka, tra il marzo e il settembre del
1970, il cui tema era Progresso e armonia per il genere
umano), l’entità Expo ‘70 mosse i primi passi quando Wright era ancora parte integrante del gruppo
losangelino Living Science Foundation (Psychedelic dub post-rock, nelle parole dello stesso chitarrista).
Sulle prime non un solo-project, ad esser precisi, ma una collaborazione aperta, dato che della
partita erano anche i due cofondatori della Kill
Shaman: Paul Kneejie, del noise-duo The Pope,
e Bryan Levine di Bipolar Bear. Un paio di cd-r
(lo split con l’altro progetto di Kneejie, SXBRS
del 2003 e il live in studio July 18 2004, entrambi
su Kill Shaman) e, causa lo scioglimento di LSF,
Wright se ne ritorna nel Midwest.
Prende così consistenza l’idea di una musica da
sviluppare in solitaria, anche se nella natia Kansas
City Wright/Expo ‘70 inizia a collaborare con lo
spirito affine – si veda la discografia in proprio per
conferme – McKinley Jones a.k.a. Cantus Firmus. L’ottimo album Surfaces (2005), seppur in
cd-r, è il vero e proprio esordio lungo per la sigla
e non fa che confermare l’affinità tra i due: l’aggiunta delle folate di synth e degli ambient noise
sounds di McKinley rendono il suono ancor più
space-oriented nel loro sovrapporsi alle dilatazioni guitar-drone, peculiarità del progetto di Wright
sin dai primi passi. Musica che rimanda da subito
alle suggestioni kraute più liquide ed evanescenti
di Tangerine Dream e Ash Ra Tempel per le
dilatazioni strumentali che la pervade e per l’afflato cosmico cui rimanda.
L’album successivo è sempre un cd-r: Exquisite
Lust, impreziosito da una cover soft-lesbo anni
70, sposta radicalmente le sonorità dell’accoppiata Wright-McKinley verso un approccio più minimalista – specie nella strumentazione ridotta a
corde, synth ed effettistica varia – che fonde loop
e drones in un magma sonoro evocativo. Link perfetto tra atmosfere kraute e ambient-music sempre
made in Deutschland, Exquisite Lust è il primo
vero capolavoro di Wright e sembra attualizzare
gli impro-drones di un leggendario gruppo proveniente da tutt’altri lidi geografici: i giapponesi Taj
Mahal Travellers.
Sciolto il sodalizio con McKinley, è il turno di
Drop Out /
35
Centre Of The Earth, primo disco che vede
Wright agire in completa solitudine. Le 4 lunghe
tracce che lo compongono – che, tanto per sottolineare il continuum delle musiche di Expo ’70,
iniziano con lo stesso drone montante che apre il
recente e definitivo Black Ohms – sono pervase
da una sensazione di assoluto romitaggio, qualcosa che rimanda ad un vagabondaggio psichico
che scaturisce dall’atmosfera notturna in cui sono
state composte. Quattro pezzi untitled per una suite di quasi un’ora di tensione ascensionale simile
ad una marea montante e in cui le stratificazioni
del suono sono apparentemente impercettibili ma
presenti. Le aperture psichedeliche dei 5 minuti
del pezzo conclusivo – Come osservare una tempesta
di fulmini sopra l’oceano, ricorda Wright – fanno da
ideale testa di ponte con i dischi a venire.
Da lì in poi, l’universo sonoro targato Expo ’70 si
fa più coeso così come più densa si fa la poetica
visionaria di Wright. Le atmosfere si sbriciolano
in pulviscolo spaziale, i toni si fanno più riflessivi e
cupi, l’andazzo generale si riduce ancora di più intorno alla ieratica figura dell’uomo in nero e delle
sue chitarre elettriche e acustiche.
I pezzi del cd-r Mystical Amplification, dell’ottimo esordio in cd ufficiale Animism ma soprattutto del recente Black Ohms (per l’ossianica
Beta-Lactam Ring) si avvicinano a certo riduzionismo minimalista ripetitivo alla Riley e traggono il loro senso più compiuto dalle stratificazioni
dei suoni di una chitarra dilatata, trattata, apparentemente statica fino a sfiorare l’immobilismo.
Eppure quel suono – ché di un unico suono, un
ohm primordiale e magico, si tratta – è sempre
mobile, mutevole, in un viaggio siderale per certi
versi molto simile a quello dei kosmische kurier da
cui – come vedremo più avanti – trae direttamente
e esplicitamente ispirazione. Musiche ascensionali,
verrebbe da dire, che puntano indistintamente lo
spazio più profondo dell’io e quello dell’universo.
Space is the place; I am the space.
Prima di proporre uno stralcio dalla fluviale conversazione avuta con Justin, giusto qualche anno36
/ Drop Out
tazione su altre uscite degne di menzione dalla
ampia discografia Expo ‘70. La Audio Archive
series, soprattutto, giunta ora al suo terzo volume, evidenzia l’aspetto più personale ed intimo
dell’operato di Wright. Sorta di progetto di divulgazione in divenire della ricerca sonora wrightiana, la serie, come suggerisce il sottotitolo al primo
volume, Music from Inaudible Depths, rende appieno l’idea di costante crescita di un suono
che sembra scaturire dal più profondo dell’animo
umano e da lì muoversi verso l’infinito dello spazio profondo. Non da meno sono alcuni momenti
dalla discografia “minore” – solo per formato e/o
durata – come il cd-r 3” Illusive Landscaping
o l’edizione limitata per un matrimonio di The
Wedding Album, così come gli split con gente
del calibro di Radhunes (il 12” per Kill Shaman),
I Am Sea Monster (7” + cd-r 3” per Small Doses), il nostro Be Invisibile Now! (in collaborazione Kill Shaman/Boring Machines) e il 3 Way
Split cd-r con spiriti affini, nonché collaboratori
estemporanei di Expo ‘70, Matt Hill e Duane Pitre. [s.p.]
I ntervista
con
E xpo ’70
Mi piacerebbe sapere qual è il tuo rapporto
col fronte più psichedelico del kraut-rock,
I cosiddetti corrieri cosmici…
Tutto è cominciato nei tardi anni 90 quando iniziai ad ascoltare i Can; suonavo in una band e
stavo cercando di sperimentare con pedali ed effetti. Ero affascinato dai Can e pochi anni dopo,
quando un amico mi introdusse ad Ash Ra Tempel, scattò qualcosa tra me e la loro musica. Era
fluttuante e molto più viva delle band rock dei ‘70.
Sembravano rendere vivo lo spirito di Hendrix o
dei Cream, superandone i confini. Più tardi scoprii
Cosmic Jokers e Tangerine Dream. Mi piace il fatto che queste band abbiano preso il concetto del
free-jazz e incorporato l’elettronica, tanto che credo Stockhausen e il minimalismo siano stati una
influenza per loro. Ho sempre preferito l’analogico al digitale e questi gruppi sono stati pionieri di
un certo tipo di musica “elettronica”.
L’amore per la psichedelia viene da Pink Floyd e
Hawkwind, ma è stato l’incontro con un live di
Acid Mothers Temple ad influenzarmi realmente.
Vedere Kawabata Makoto al Knitting Factory di
Los Angeles ai primi del 2000, mi ha costretto a
riflettere ancor di più su quella musica e sulla sua
provenienza.
Expo 70 sembra legato agli aspetti improvvisativi di un’altra grande band: Taj Mahal Travellers…sappiamo che l’improvvisazione è il tuo metodo di composizione
preferito…
Inizialmente ho dato vita alla band per suonare
come i Taj Mahal Travellers; li ascoltavo moltissimo quando July 18, 2004 fu registrato. All’epoca
avevo cominciato ad interessarmi all’improvvisazione con uno dei membri con cui suonavo allora
e con Paul Kneejie che poi fondò la Kill Shaman.
Condividevamo l’interesse per soundscapes e sperimentazioni sui pedali, che divennero fondamentali
nella prima incarnazione di Expo 70. Suonammo
una manciata di show a LA prima che decidessi di
tornarmene a Kansas City verso la fine del 2004.
Expo ‘70 nasce come fuga verso l’improvvisazione, esperienza aperta all’esplorazione di suoni e
textures in collaborazione con altre persone openminded. Per me, essere in grado di prendere un
qualsiasi strumento e creare qualcosa di organico
è molto più soddisfacente del fare prove e suonare
e risuonare qualcosa di continuo. È l’atto del momento, l’immediatezza, il lasciare che l’ambiente
circostante interagisca col corpo ad essere creativo
ed artistico.
Nella tua musica molto presente è l’aspetto mistico, trascendente…c’è un intento
trance-inducing in Expo ’70?
C’è del misticismo, indubbiamente; puoi trovare
del ritmo in natura o nel corpo umano tramite
la meditazione. Da bambino mi piaceva passare
molto tempo immerso nella natura, tanto che in
un certo senso creo questa musica come una via di
fuga, un qualcosa che mi permetta di distaccarmi,
di dissociarmi da ciò che mi circonda e dalla cultura pop. Amo l’estetica di questo suono e credo
che questo sia il modo in cui la mia musica viene
creata. Ho una fascinazione per quei vecchi tipi di
musica che sono in grado di creare un regno in cui
i concetti si fondono insieme.
L’aspetto mistico scaturisce dalla sensazione di
essere profondamente engaged nel regno dei suoni
che sono solito creare esplorando la mia psiche,
componendo inconsciamente questa musica organica e “sentendola” dal di dentro. Questo crea
un aspetto trance-inducing, un feeling di “longevità”
con la musica in grado di lasciarsi andare a ciò che
sta succedendo e non focalizzandosi su un beat o
un ritmo che cerca di imporsi, ma in una maniera
meditativa.
Cosa significa per te la parola spazio? Mi
spiego meglio: taj mahal tangerine dream
ash ra tempel erano artisti con un mood
spacey che è facile ritrovare nelle tue musiche: quella capacità di porre chi ascolta
nella condizione di perdersi, nello stesso
tempo, in se stesso e nelle inaudibili profondità dello spazio…
Sono sempre stato affascinato dallo spazio così
come dalla fantascienza, ma non credo che influenzino la musica. Credo che il genere umano sia
attratto dallo spazio e che le culture antiche, molto più delle moderne, pensassero allo spazio come
ad una entità superiore…i suoni che creiamo non
sono che l’infinita gamma di frequenze e toni presenti in tutta la musica e perciò nello spazio stesso,
e quando li dilatiamo, li facciamo durare molto a
lungo, rendendoli ripetitivi, essi diventano meditativi per il corpo umano… [s.p.]
Drop Out /
37
Lo spazio del
suono
-
Sara Bracco e Vincenzo Santarcangelo
Ci sono almeno due motivi per i quali a partire da questo mese vi proporremo una serie di articoli
dedicati a Lo Spazio del Suono, ossia ad una serie di artisti che hanno focalizzato la propria attenzione
sulla proprietà spaziale del suono.
Innanzi tutto per via del proliferare di giovani leve che affollano la scena della cosiddetta “nuova
musica” animando il dibattito su questo argomento, e in secondo luogo, per cercare di ragionare su
quella che a nostro avviso da semplice attitudine stilistica sta trasformandosi gradualmente in una vera e
propria koinè linguistica.
Alcune premesse ci sembrano dovute: consideriamo innegabile l’affinità che interfaccia l’arte sonora
alla disciplina scientifica che va sotto il nome di acustica, come innegabile è il fatto che si possano
rintracciare modalità estetiche proprie ad installazioni e a performance sonore - proprie cioè, di eventi
sonori che avvengono in uno spazio, di qualunque tipo esso sia.
Come, ancora, si possono considerare similari certe espressioni legate alla sound-art o lezioni care ad
artisti qual Rolf Julius, John Duncan e Carl Michael Von Hausswolff (per citarne alcuni) che in un certo
senso hanno dato il via ai primi dibattiti sulla questione.
Questa materia d’indagine è ancora parzialmente inesplorata, e fonte tutt’oggi di discussione e
produzione a firma dei maggiori artisti ed interpreti dell’elettronica che operano in direzioni affini.
Artisti la cui matrice d’esplorazione consiste in una lettura sonora che va oltre il territorio dell’ascolto,
che conduce la forma e il divenire attraverso lo spazio. Uno spazio immaginato, sommesso o al limite
dell’ architettonico, uno spazio reale, uno spazio nello spazio, legato al luogo o ad esso distante. Uno
spazio organico, effimero, assente o vividamente sommesso.
E’ questo il motivo della nostre indagine strutturata in brevi monografie spesso corredate di interviste,
un momento di riflessione ormai dovuto a fronte del proliferare di pubblicazioni e di artisti.
38
/ Drop Out
Ralph
Steinbruchel
Un’arte preziosa quella dello svizzero Ralph Steinbruchel, noto agli assidui frequentatori delle zone
limite dell’elettronica come uno dei più quotati
sperimentatori sulla piazza.
Classe 1969, una carriera costantemente in bilico
tra musica e grafica che trova consacrazione ufficiale dapprima nel 2002 con il conferimento del
premio “Max Brand Award for Electronic Music” (phono TAKTIK 2002, New York), grazie
alla composizione Zwischen.raum (Domizil),
poi con la borsa di studio “Pro Helvetia” ricevuta
dall’ Art Council of Switzerland che gli permetterà di lavorare a una delle sue prime uscite firmate
LINE.
Ma andiamo con ordine. Ralph Steinbruchel è
senza dubbio un figlio dell’elettronica anni ’90. I
suoi primi esperimenti sonori risalgono al ’96 con
l’lp Stockwerk, il 7” On3 End e il cd-r Sinus,
tutti lavori che si lasciavano già notare per le austere letture sonore che contenevano. Gli esordi
Drop Out /
39
dichiarano apertamente un’estetica riduzionista
fortemente legata all’utilizzo del digitale, grazie al
quale l’artista riesce a catturare l’essenza spaziale di luoghi reali od immaginari e ad immergere
l’ascoltatore in ambientazioni sature di suono.
Ambientazioni glitch come quelle di Circa (Line,
2003), che prendono forma dall’installazione Zeit
, esposta qualche anno prima presso il Parco Platzspitz di Zurigo, un evento importante che oltre a
confermare l’interdisciplinarità della ricerca dello
svizzero, segna l’avvio di una serie di collaborazioni con le maggiori etichette del settore e di uscite
discografiche che lo renderanno celebre al pubblico dell’elettronica. Dalla 12k di Taylor Deupree
e Richard Chartier - in particolare la sussidaria
LINE, nota per il suo prezioso roster d’artisti au-
40
/ Drop Out
dio e visuali - alla parentesi con l’etichetta Bine
(Skizzen, del 2005), dalla Room40 alla più recente Koyuki, saranno molte le etichette a contendersi
i lavori di Steinbruchel.
Tornando al 2005, è da segnalare Status, progetto a quattro mani con Frank Bretschneider,
collaborazione tanto differente dallo stile-Steinbruchel quanto proficua, riuscita a pieni voti grazie alla sua personale identità stilistica che regge
il gioco di dodici tracce in equilibrio tra concrete
astrazioni e relazioni micro-ritmiche.
D’obbligo fermarsi alla tappa con la Room40 nella collezione estemporanea di Opaque (+Re)
(Room40, 2005), o sostare ad ammirare le dieci
scene di Stage (Line, 2006), raccolta di musica per
la performance di danza interattiva Hybridome.
La scrittura di Steinbruchel presta attenzione agli
spazi immaginati e alle elaborate letture minimali,
esibendone elementi o frazioni, assemblandoli con
calibrata avanguardie e liberata intensità.
Non importa quale sia la materia da plasmare.
Drones, i glitch, le microscopiche particelle elettroacustiche, i contributi di chitarra, pianoforte, le
dissonanze o le risonanze: a fare la differenza è la
deliberata trasformazione della massa sonora che
viene frammentata con una tecnica che ha qualcosa del puntillismo. Flussi sonori che si prende
gioco del tempo creando sospensioni o stasi ricche
di dettagli infinitesimali (si ascolti Staub a firma
Steinbruchel&Macinefabriek, minicd-r 2008). O
ancora, spazi sonori microscopici come istantanee
di paesaggi (Sustain, Koyuki 2008).
Attenzioni proprie dell’estetica, che non dimenticano le esperienze dell’universo percettivo, ne
è un esempio il recente Mit Ohme (12k, 2008)
che prende spunto dall’installazione audio-visuale
di Yves Netzhammer, la cui chiave di lettura è
sicuramente quell’aggraziata semplicità di forma
che Steinbruchel riesce a tradurre abilmente tra le
superfici in tonalismi e i panorami di dettaglio.
Volevamo proprio saperne di più e quale migliore
occasione per un ‘intervista.
Hai girato il mondo grazie alle tue installazioni: da Zurigo a New York, da Parigi a
Los Angeles e Seoul. Com’è cambiato il tuo
approccio al suono nelle live performance
con il tempo, l’esperienza e i recenti progressi tecnologici?
Attualmente non sto lavorando a nessuna installazione, ed è da tempo che non sono impegnato in
questo senso. La maggior parte delle mie installazioni sono state collaborazioni con artisti visuli (o
programmatori), o con altri musicisti.Le installazioni mi hanno dato la possiblità di lavorare in profondità con la tridimensionalità del suono, dal momento che erano tutte concepite per performance
multicanale. Per definirle mi sono sempre servito
della dizione audiosculture. Oggi come oggi, mi
piacerebbe esibirmi dal vivo in performance multicanale, laddove possibile tecnicamente, per creare una performance che si situi esattamente a metà
strada tra installazione e live performance. Una
sorta di “performance installativa”.Non credo che
il mio approccio al suono o alla composizione sia
cambiato a causa del progresso tecnologico, o per
simili ragioni. Fermo restando che il progresso nel
campo della spazializzazione del suono e della tecnologia multicanale hanno aperto la porta a nuove
possibilità, che sono ben felice di integrare nel mio
lavoro se conciliabili con la mia estetica.
Il legame tra spazio e suono è al centro del
dibattito musicologico dagli inizi del XX
secolo. Qual è il tuo concetto di sound-art?
Ti senti più legato al filone purista legato
alla materia sonora o a quello più contestualizzante d’indagine sonora e di lettura
del contesto?
A nessuno dei due in particolare. Non mi considero un sound-artist perché quello che faccio è lavorare sulla composizione di musica che mi smuova
emotivamente e che all’atto dell’ascolto risulti piacevole. Nel mio fare artistico c’è meno concetto e
senso della struttura di quanto potrebbe sembrare
ad un primo sguardo. Naturalmente mi servo di
un approccio concettuale se questo può servire
alla resa finale, se il concetto è al servizio di ciò che
senti ed ascolti. Ma sono molto più interessato al
risultato finale che al processo in sè.
Con o senza l’utilizzo dell’elettronica la
tua scrittura sembra plasmarsi in ognuna
delle tue esperienze produttive attraverso
una sorta di naturale “manierismo estetico”. Qual è, se ne esiste uno, il tuo personale concetto di estetica del suono?
Molto difficile rispondere a parole. Come ti ho già
detto, la maggior parte delle mie musiche deve
agire su di me da un punto di vista emozionale,
interagire con me in una qualche maniera. Cerco
di appropriarmi di un mio linguaggio sonoro specifico che sottopongo ad aggiustamenti continui,
com’è ovvio che sia, dato che cambio giorno per
Drop Out /
41
giorno come persona grazie alle esperienze della
mia vita quotidiana. Naturalmente alcuni di questi
cambiamenti avvengono quasi impercettibilmente
e potrebbero rimanere inavvertiti o risultare illogici quando percepiti dall’ascoltatore.
Tra le tue innumerevoli collaborazioni vorremmo ci parlassi di quella uscita per la
12K di Taylor Deupree con Frank Bretschneider, Status. Com’è nata e come siete riusciti a far combaciare due stili così differenti senza perdere l’identità?
Ho incontrato Frank Breschneider qualche anno
fa, in occasione di alcuni festival e performance. Ci
siamo subito piaciuti e abbiamo scoperto di avere
interessi comuni nell’estetica del suono (pur pervenendo l’uno a risultati molto diversi dall’altro).
Entrambi avevamo appena dato alle stampe un cd
e avevamo voglia di lavorare su qualcosa di più
“aperto” e diverso dalle solite cose. Decidemmo di
scambiarci dei suoni di partenza e di vedere cosa
accadeva se il mio approccio “si scontrava” con il
suo. Questi suoni hanno così iniziato a rimbalzare
da un computer all’altro - il mio ed il suo. Ognuno
dei due ha lavorato sulle sequenze di suono fino
a quando la resa finale non fosse risultata del tutto soddisfacente. L’obiettivo era realizzare musica
che nessuno dei due avrebbe mai concepito lavorando in solitaria.
Spesso la tua musica viene comparata al
filone Neomodernista di Richard Chartier
e Ryoji Ikeda che cosa ne pensi? Ti rivedi
in qualche modo nel loro linguaggio sonoro?
In genere sono contrario ai paragoni. Non capisco
perché debbano essere necessariamente fatti, dal
momento che ogni artista – o quasi – segue la sua
propria strada.Mi piace il lavoro di Ryoji Ikeda e
lo rispetto molto, soprattutto quando consiste in
una commistione di sonoro e visuale, così come
rispetto il suo approccio – molto concettuale ma
dotato di un altissimo senso della musica. Potrei
anche concedere che in alcune sue declinazioni mi
ha influenzato - soprattutto in passato. Ma credo
permangano fondamentali differenze tra il mio lavoro ed il suo. Ryoji ha creato ex novo un linguaggio musicale e mi piacerebbe davvero poter dire
lo stesso di me - chissà che un giorno io non possa
davvero farlo!
Puoi parlarci di queste ultime esperienze che potremmo definire concrete, quasi
scultoree: Sustain, uscito per la Koyuki e
Home per la Slaapwel? Come nascono questi due progetti?
Mentre lavoravo al mio contributo per una compilation dell’etichetta and-oar una serie di suoni da
esso “fuoriusciti” mi hanno ispirato un’altra composizione...così è nata Sustain. Ero già in contatto da molti anni con David Sani (dell’eccellente
mailorder Microsuoni), che mi chiese se avevo a
disposizione del materiale per una uscita sulla label Koyuki, che gestisce con Luigi Turra. Fui ben
lieto di affidargli Sustain. Home è stata creata su
invito di Wim di Slaapwel Records. Sono entrato
in contatto con lui perché cercavo un disco appartenente al catalogo di quell’etichetta, e così abbiamo iniziato a scambiarci delle mail. Mi è subito
piaciuta l’idea di comporre un brano di musica che
concilii il sonno. Per usare le parole dell’etichetta,
«music which is interesting enough to listen to, but
boring enough to fall asleep to». Un’idea davvero
meravigliosa!
Mit Ohne è il documento sonoro di un’installazione audio/video di Yves Netzhammer intitolata “The feeling of precise instability when holding things”, ed esposta
al Museum für Gestaltung di Zurigo. Puoi
parlarcene? Che ruolo ha avuto il suono
nel suo funzionamento?
Yves Netzhammer è uno dei miei artisti visuali
preferiti. É in grado di creare animazioni ed illustrazioni 3-D molto belle e poetiche. Aveva ricevuto un invito a creare un lavoro sul futuro dei living
spaces e voleva aggiungere un elemento musicale
alla sua installazione. Così ha pensato di allargare l’invito anche a me. Mi ha inviato una serie di
animazioni che ho sincronizzato a dei suoni. Ho
poi composto sette brevi frammenti di musica che
ora è possibile ascoltare nella recente uscita 12k
Mit Ohne. Durante l’esibizione, le animazioni di
Yves venivano proiettate su tre schermi a loro volta
riflessi da specchi posizionati sotto di essi. Un nuovo spazio prendeva forma grazie a questo sapiente
utilizzo delle leggi di riflessione. Il suono era irradiato grazie ad un sistema multicanale: ogni schermo era dotato di uno speaker che permetteva allo
spettatore un’esperienza spaziale e sonora davvero
uniche.
La tua musica ha la capacità di catturare lo
spazio immergendo l’ascoltatore all’interno stesso del suono e mettendo profondamente in gioco il concetto di “percezione
sonora”. Sei d’accordo? Qual è il tuo personale punto di vista?
In un certo senso è vero, ma non c’è nulla di programmato da un punto di vista teoretico o concettuale. Per me lo spazio in sè funziona come
strumento addizionale. Ecco perché quando mi
esibisco dal vivo è molto importante per me disporre del tempo necessario - solitamente durante
il soundcheck - per entrare in sintonia con lo spazio fisico nel quale sono situato; per capire come
i suoni interagiranno con quello spazio. L’attenzione che riservo al concetto di spazio in sè e alla
percezione del suono nello spazio mi spinge inoltre
a preferire il multicanale, laddove possibile.
Cosa pensi dell’attuale stato di salute della
musica sperimentale?
C’è tanta buona musica, ma anche tanta pessima
musica. Artisti validi e artisti meno validi. Etichette coraggiose ed etichette che non lo sono. Per
quanto mi riguarda, il mio gusto varia giorno per
giorno, dato che quotidianamente scopro nuova
musica. Può piacermi come non piacermi: se non
mi è piaciuta quest’anno, probabilmente imparero’ad aprezzarla l’anno prossimo, o forse no. E viceversa.
►►►►recensioni ►► ►► feb
adriano modica
andrew bird
2 Novembre – Bellorio (Elevator / Jestrai, 2 novembre 2008)
G enere : grunge - stoner
Stoner e grunge, Kyuss e Melvins, a banchettare
amorevolmente tra testi in italiano pieni di buoni
sentimenti (“Merda! Merda! Te lo dico in faccia, Muori!!”) e titoli che alludono ai progenitori senza rivelarli (King Buzzo). Il terreno è fertile per far crescere
chitarre elettriche a profusione, toni angoscianti,
muri di bassi e batterie dispari, con lo scopo di rinverdire i fasti di un’epopea musicale che – ahimè
- se non è morta e sepolta, pare per lo meno in
fin di vita, attaccata com’è al polmone d’acciaio
del tempo. Se è vero, infatti, che pochi tra i reduci dei Novanta continuano a sfornare operette
dignitose e nuove leve autoctone, come i milanesi
Grenouille, ci illudono che in Italia possa nascere
una new wave della musica di Kurt Cobain e Josh
Homme, è vero anche che i 2 Novembre illustrano
loro malgrado quali siano i rischi per chi si aggiri
44
/ recensioni
senza bussola tra pedalini Boss e flanger assortiti.
Nello specifico, confondere l’ispirazione con la didascalia, il mal di vivere con il machismo più pacchiano, l’impeto e la claustrofobia con la noia. In
un’ora di musica che piace solo a tratti e pare fin
troppo abbondante, considerata la quantità di carne messa al fuoco.
E dire che ai tre musicisti genovesi le doti tecniche
non mancherebbero come non manca un certo
buon gusto, tanto che in qualche frangente ci si
diverte non poco ripensando a quei diciottenni capelloni che eravamo una quindicina di anni fa (gli
otto minuti dell’ottima GMB). Eppure, sono momenti sporadici. L’impressione generale, invece, è
che molto si faccia e poco si sia – originali, personali, consapevoli –, che il nichilismo esistenzialista
dei padri si sia trasformato in oltraggio gratuito,
che lo scarto tra opera di finzione e disco pregevole sia fin troppo ampio. (5.5/10)
Fabrizio Zampighi
bbraio
prima che nei suoni e fateli viaggiare indietro nel
tempo all’altezza di Daydream Nation; mandateli a rubare il master di quel disco e fateglielo risuonare tutto. The Noise Band From Bletchley
inanella 12 pezzi pressoché strumentali, costruiti
per stratificazione di suoni e distorsioni di chitarra,
con echi tribaloidi e sovrappiù di energia adolescenziale grezza e coinvolgente. Un muro di suono
che – diversamente da come potrebbe immaginarsi – non tocca picchi parossistici, né si piega su
se stesso, ma piuttosto lascia presagire una certa
maturità compositiva nelle aperture quasi trance
e ridisegna il concetto troppo spesso abusato di
noise-rock. A breve dalle nostre parti, perciò, siete
avvisati. (7.0/10)
Stefano Pifferi
Adam Payne – Organ (Holy Mountain,
febbraio 2009)
G enere : indie power rock
mi ami
Action Beat – The Noise Band From
Bletchley (Truth Cult, febbraio 2009)
G enere : noise - rock
È magma bollente quello che fuoriesce dagli strumenti – tanti, tantissimi – del combo più atteso
d’oltremanica. Altro che cazzate brit-pop o sbruffonate nu-rave; quello del collettivo spavaldamente fiero delle proprie origini provinciali è un vero
e proprio assalto al calor bianco come non se ne
sentiva da tempo, specialmente dalla perfida Albione. Chitarre, chitarre e ancora chitarre; batterie a profusione; un basso; trombe e sassofoni più o
meno occasionali. Il tutto in quantità variabile ma
in qualità costante, a sfiorare in alcuni momenti
l’eccellenza. Avete presente Glenn Branca? Beh,
fatelo tornare adolescente nella grigia provincia
inglese, clonatelo moltiplicandolo per 5, 6 o 10 e
lasciatelo libero di suonare noise-rock in modalità impro. Oppure prendete gli olandesi The Ex e
la loro etica/estetica fieramente punk nell’umore
E’ davvero un bell’esempio di rinfrancante e rinfrescante melting pot, Adam Payne dalla Florida:
figlio di un’italiana e un afroamericano, mostra un
talento musicale assai precoce nutrito dai cartoni
animati del sabato mattina. Polistrumentista, maneggia lui tutti gli strumenti di questo suo (crediamo) esordio - mini piuttosto corposo che un tempo
sarebbe stato un album: trentasei minuti - e appese sul muro vanta quel paio di lauree in statistica e psicologia. Impossibile per uno così fare
brutta musica, ma vatti a fidare in quest’epoca di
intellettuali emaciati o megalomani: tocca invece
ricredersi, perché Organ è disco frizzante e agile,
arguto e ricco d’idee e melodie. Mettete da parte
le ipotetiche influenze soul - dovrete tuttavia tirarle
fuori per giustificare le cadenze a costante rischio
d’inciampo e impennata della tenera In Hell - e
immaginatevi un power pop corretto dalle sottili
sconnessioni “nerd” dei Pavement. Altrimenti
dei Replacements che preferiscono la Red Bull
alla Budweiser e sono di conseguenza cioè iperattivi e non sbronzi, in ogni caso ferrati tanto in math
rock e low-fi (gli otto e passa minuti di Incidental Arrecensioni /
45
Highlight
AA. VV. - Evening’s Civil Twilight In Empires Of Tin (DVD, Constellation / Wide, 26 gennaio 2009)
post rock
Ci sono svariati modi di fare politica attraverso l’arte e, in chi
scrive, il comizio dal palco non ha mai incontrato gran favori. Nel
limitarsi a declamare slogan, sfuggono alla visione quelle intercapedini in cui la gente comune finisce per cadere. dimenticata
dai più. Ad esempio le masse di derelitti che marciano dritte nel
tritacarne bellico, per le quali - causa i corsi e ricorsi della natura
distruttiva umana - non esiste differenza tra la Marna e Bassora,
il gas nervino e le bombe al fosforo bianco. Questo pare volerci In
sostanza dire il regista Jem Cohen tramite questa splendida pellicola, emozionante e leggibile a più livelli: che la Storia si ripete
e gli imperi sull’orlo del collasso generano un nuovo ordine mondiale. Cadeva l’autunno
del 2007 allorché Cohen - tra le tante cose autore del fantastico Instrument dei Fugazi e di
alcuni video dei giovani R.e.m. - venne chiamato a concludere l’International Film Festival
di Vienna con Evening’s Civil Twilight In Empires Of Tin. L’opera, ispirata in parte al romanzo
The Radetsky March di Joseph Roth, sovrapponeva a immagini della Vienna antecedente
il primo conflitto mondiale visioni contemporanee della capitale austriaca e di New York.
L’impero americano come quello austro-ungarico ne uscivano come due Titanic in cui l’orchestra seguita a suonare mentre si cola a picco, tutti insieme inesorabilmente. Un’affermazione “politica” netta e tagliente, offerta sommando in modo indistinguibile letteratura,
musica e coscienza sociale. Il commento sonoro alle immagini lo offrirono nientemeno che
gli artefici del capolavoro North Star Deserter, al tempo fresco di pubblicazione: Vic Chesnutt
e i Silver Mt Zion, più Guy Picciotto e l’ensemble sperimentale Quavers. Tra ondate
di rumore controllato e una decostruzione anticata e ondeggiante della straussiana Marcia
di Radetzky, si dipanano i fili di un folk cameristico da tregenda nelle immense Distortion e
Sponge, in una What He Is And What He Ain’t degna del Tom Waits più luciferino e nella riassuntiva Coward composta per l’occasione. Le immagini alternano sapientemente consunti
fotogrammi d’epoca a paesaggi urbani qui avvolti in un granuloso grigio seppia, là riconsegnati ai propri cromatismi; sono simboli e scheletri di luoghi in cui le persone si aggirano
come fossero brandelli di vita, velocizzate e rallentate secondo lo stile tipico di Cohen. Il
quale si sofferma poi sui volti dei musicisti a coglierne il particolare rivelatore da un gesto,
un’espressione del viso rubata durante l’esecuzione live, in tal modo abbattendo il muro tra
il tema e la sua rappresentazione. Oltre il rockumentary e la denuncia, oltre il film d’autore e
la sperimentazione sonora, camminiamo in una terra a sé stante. Rabbrividente e veritiera
per come riassume un decennio di avvenimenti americani e pertanto anche mondiali che
speriamo destinati a essere definitivamente archiviati. Si resta in quest’ora e quaranta minuti, al contempo incollati alla sedia e al muro. Necessario esporsi a tanta penetrante bellezza,
oggi più che mai. (8.0/10)
Giancarlo Turra
46
/ recensioni
rangement si snodano torpidamente acidi e jazzy, un
po’ Polvo e un po’ Storm & Stress; la cavalcata
wave Wind, Wind, Wind/Take A Look) quanto nello
stile stradaiolo e meticcio canonizzato da Exile On
Main Street (The One After Eyes). Non contento, Payne si ricorda di avere sullo scaffale un lp dei Big
Star e uno dei Dinosaur Jr. e una sera gli viene
in mente che sarebbe una bella idea farli convivere
sotto una patina glam autoironica, facciamo simile
a quella dei primi Urge Overkill (Never See You
Anymore); infine, prima di coricarsi per il meritato
riposo quotidiano, estrae dal cilindro una Fruzstration che - a passo di ballata cupa e sgasata - conduce
i Jacobites al ranch dei Crazy Horse. Penserete
di ascoltare una compilation, un condominio abitato da gente che non si parla e manco si guarda.
Un accidente: c’è il robusto filo conduttore di creatività a ruota libera e calligrafia convincente a
tenere insieme tutto. Ci sono canzoni che canticchierete in men che non si dica e alle quali sarà
impossibile non affezionarvi. T
anta carne al fuoco, mai scotta o bruciata: complimenti al cuoco. (7.0/10)
Giancarlo Turra
Aidan Moffat & The Best Ofs – How To
Get To Heaven From Scotland (Chemikal Underground / Audioglobe, febbraio 2009)
G enere : folk , songwriting , indie
La sfida di Aidan Moffat all’appuntamento ufficiale post-Arab Strap? Scrivere un disco di canzoni
d’amore… felici. E, in effetti, gli umori di cui si
nutre il suo debutto con i Best Ofs - più che una
band, una duttile compagine di accompagnatori,
fra cui l’ex Delgado Alun Woodward – appaiono
lontani dalla malinconia del duo di provenienza,
alla ricerca di diverse aperture e forme espressive.
Se I Can Hear Your Heart, pubblicato un anno
fa come Aidan John Moffat, era più un esperimento di poesia (porno, ovviamente, con le sue buone
dosi di sarcasmo e crudeltà), adesso si tratta di riprendere in mano la canzone con nuove consape-
volezze e nuovi intenti, anche poetici. Nonostante
orfano dell’amico Malcolm Middleton, che ormai
veleggia sicuro in solitaria, l’autore e cantante
sembra già sguazzare in una dimensione ideale,
grazie anche a musicisti che ne assecondano ogni
capriccio e, soprattutto, a buone idee.
Come ad esempio riscoprire le proprie radici folk,
e partire da esse per raccontare storie d’amore sicuramente agrodolci, irrimediabilmente ubriache,
ma sincere e – in primis - a lieto fine.
Ci vorrebbe un capitolo a sé, ma basti l’esempio
di Living With You Now, in cui Aidan riesce a cavare
fuori romanticismo anche da un rapporto che si
esprime, primariamente, nell’azzuffarsi. Sarebbe
bello se prima o poi si riconoscesse universalmente la statura di Moffat non solo come musicista –
sull’apporto del suo vecchio gruppo ci sono pochi
dubbi, crediamo -, ma anche come uno dei poeti
più personali della sua generazione; uno capace
di portarti in posti precisi soltanto con la sua voce
storta, con la maniera inequivocabile di storpiare
e cantilenare frasi e parole.
Quanto ai suoni, il tappeto è il più vario possibile,
in un riuscito amalgama acustico-elettronico sempre adatto a ciò che il brano richiede, sia l’indie
folk di classe del singolo Big Blonde, i sentori etilici
Pogues di Oh Men, That’s Just Love e The Last Kiss
o i semplici a cappella di Lover’s Song e My Goodbye.
Qua e là le suggestioni Arab Strap non mancano,
certo (A Scenic Route To The Isle Of Ewe, Now I Know
I’m Right); ma How To Get To Heaven From
Scotland (un plauso al titolo, ça va sans dire) somiglia più al lavoro di un cantautore dall’impronta
già inconfondibile che al tentativo di un ex di trovare la propria strada - il riferimento a Middleton
è puramente voluto, anche se ce ne duole. Vogliamo infine aggiungere un dettaglio tutt’altro che
trascurabile: l’album viene pubblicato il giorno di
San Valentino. Che sia un po’ di sano romanticismo alcolico l’antidoto ai tempi grigi che stiamo
attraversando? (7.3/10)
Antonio Puglia
recensioni /
47
Alela Diane – To Be Still (Naive /
Self, 20 febbraio 2009)
G enere : folk blues
Dallo scarno folk blues acustico del disco d’esordio The Pirate’s Gospel (2007) sembra passato
un bel po’ di tempo in fatto di produzione: To Be
Still è infatti tutto fuorché minimale. Realizzato
al solito con un ampio gruppo di amici-musicisti e
con la collaborazione del sempre presente padrino
Michael Hurley (qui alla voce nella struggente
Age Old Blue), vede
le
composizioni,
cantate con il solito trasporto dalla
Nostra, riempirsi
di strumenti ed arrangiamenti, che
danno profondità ai
pezzi. Echi di Will
Oldham e spettralità dolenti, nonché desertiche
echeggiano per tutto l’album, come nella splendida title track country con la pedal steel a dominare,
nella già citata Age Old Blue con echi di Karen Dalton. Altrove mandolini (Tatted Lace), archi (Take Us
Back) violini (White As Diamonds) e le solite voci doppiate sua caratteristica, per un suono pieno e tradizionale che ricorda del resto l’ultimissima Larkin Grimm. Di inquietudine, contemplazione e
solitudine qui si tratta, cantati con trasporto lirico
ma senza eccessivi fronzoli. Il salto dal precedente
disco si sente in fatto quindi di coesione e composizioni, segno di avvenuta maturità. (7.1/10)
Teresa Greco
Ando – Habitat (Bine, 2008)
G enere : minimal / dancefloor
Il percorso di Taylor Deupree (Ando) è multiforme,
non è certo una novità per chi lo segue da tempo,
semmai per chi ne ha apprezzato le ultime opere
in bilanciato rapporto tra acustico e sintetico.
Le premesse c’erano già nella scuola anni ‘80 che
ha segnato le sue inclinazioni all’elettronica più
sperimentale, nelle prime collaborazioni con Sav48
/ recensioni
vas Ysatis sotto il nome ARC o Unit Park se parliamo di Schoenemann. Assistiamo così ad un cambio di registro, non un vero e proprio volta pagina,
ma una ponderata analisi di forma che per questa
uscita firmata Bine Music si fa espressione di configurate radici techno. Dimenticate per un attimo,
per quanto nitida ne permanga la memoria, le iterate texture di Northen e il Taylor Deupree più
introspettivo, per fare un passo indietro verso gli
esordi e le energie giovanili. Un dichiarato 4/4 che
funge da filo conduttore di filtrazioni, introduzioni, battiti e linearità. Ma Habitat non è solo questo, è matura esperienza che intreccia elettronica
con miniature-sonore, con la risaputa eleganza di
stile che lo rende brillante. Giocano con il tempo
e con il ritmo, queste quattro tracce, lavorano con
il multiplo, le relazioni, il ripetitivismo e le pause,
senza spogliarsi delle fluenze techno, senza mai diventarne schiave.
Per molti magari un azzardo, sicuramente l’ennesima conferma della innegabile potenza sonora di
Deupree. (7.0/10)
Sara Bracco
Andrey Kiritchenko – Misterrious
(Spekk, 2008)
genere : minimalismi - ambient
Per la seconda prova con la Spekk dopo True Delusion, A. Kiritchenko dimentica per un attimo
le astrazioni in micro-suoni di Kinga Skazok o
l’elettronica “pop” di There Was No End per
condurre la sua creatività verso visionari territori
di confine.
Artista di punta della scena ucraina e fondatore
dell’etichetta Nexsound, con Misterrious l’autore porta avanti le sovrapposizioni di Stuffed
With senza dimenticare l’eredità della passata
collaborazione con Courtis-Moglass.Un capitolo
fondamentale per Kiritchenko, che non si lascia
condizionare dal registrio elettronico per dedicarsi a partiture decisamente più acustiche. Si mettono in circolo gerarchie soliste di un pianoforte
(Let oneself in) dal sapore minimalista (Sparkling early
mornings) che si lascia divorare dalle ridondanze in
percussioni per poi imporsi come forma portante (Wounded by love). Mentre all’elettronica spetta il
puntualismo di Your thoughts in scary forest, trai voluti
eclettismi di batteria o i siderali contributi ambient
(Evening lights wrap me softly). Decisamente riuscite
le formule acustiche in loop di Persistent visions o i
timori in pellicole che trasudano attesa (Untitled inquietudes). Una dinamica che dirige le frequenze, il
cui trait d’union è la scelta di quella voce narrante sotto forma di pianoforte che muta l’approccio
pur mantenendo quella coerenza sintetica di linguaggio concreto. Il tutto eseguito secondo il naturale ordine delle cose proprio dell’improvvisazione, tra attitudini e feeling di delicata morbidezza.
(6.7/10)
Sara Bracco
Asobi Seksu – Hush (One Little Indian, febbraio 2009)
G enere : pop
Terzo disco per il gruppo nippoamericano di Yuki
Chikudate. Ci si aspettava qualcosa di più di uno
scimmiottamento di movenze soniche trite e ritrite
come gli accenni pastorali dell’iniziale Layers che
fa un po’ Enya un po’ Cranberries, le progressività naïve di Familiar Light, i tastieroni
à la Organ di Sing
Tomorrow’s Praise e le
stanze lounge di stereolabiana memoria
(Gliss). Le atmosfere
hanno sorpassato il
citazionismo shoegaze e si sono invischiate in un emo che ha poca intraprendenza
indie e che in fondo è pop di normale amministrazione. La voce della leader fa il suo mestiere, ma
non stupisce. Peccato. Lo spleen si è bruciato nel
giro di due anni. Ritroveranno la scintilla? Staremo
a vedere. Intanto basta e avanza un (5.0/10).
Marco Braggion
Barzin – Notes To An Absent Lover
(Monotreme, febbraio 2009)
G enere : sad slow core
Bisognerebbe rettificare il glossario musicale così
che al posto di “intima ballata strappalacrime” si
potesse inserire Barzin, solamente Barzin. Perché
sì, con il cantautore canadese abbiamo a che fare
sempre con la ricerca della canzone d’amore perfetta, sofferta e straziante. E il suo terzo album già
dal titolo, Notes To An Absent Lover, non fa che
confermarlo, non cambiando assolutamente niente rispetto ai due lavori precedenti. E ciò, in questo caso, è senz’ombra di dubbio un merito: la sua
sommessa ma suggestiva voce fa esplodere struggenti mondi fatti di carezze, assenze, solitudini,
sguardi e intermittenze emozionali, che un attento
e mai invasivo impianto sonoro asseconda dolcemente, ora con ricercati saliscendi strumentali ora
con uno scarno incedere. Il suo è un morbido slow
core cantautorale, affine a quello dei Dakota Suite,
che esce direttamente dal cuore. Insomma, l’estetica dello struggimento amoroso passa sicuramente
da qua. Magari non se ne sentirà il bisogno di accederci, ma mai dire mai. (7.0/10)
Andrea Provinciali
Bastion – Self Titled (Interregnum,
gennaio 2009)
G enere : free - drone
Pratica corrente quella del dialogo a distanza tra
artisti più o meno lontani geograficamente e stilisticamente. Quasi comune verrebbe da dire, con
un po’ di puzza sotto al naso. Senonché incroci
tanto inimmaginabili quanto entusiasmanti come
quello che ha dato i natali al progetto Bastion, ci
fanno tornare in mente che tanto comuni dopotutto non sono. Almeno nell’accezione di banali,
semplici, normali. Jukka Reverberi nelle sue vesti
più sperimentali (il versante in solitaria die stadt
der romantische punks) e Valerio Cosi nelle
sue vesti più incredibilmente camaleontiche sono i
protagonisti dietro Bastion e intessono per l’omonimo esordio un denso 4pieces evocativo quanto
recensioni /
49
Highlight
Adriano Modica - Annanna (Trovarobato, dicembre 2008)
avant folk rock
L’attesa per il nuovo album di Adriano Modica viene
spezzata e ravvivata dalla pubblicazione di Annanna, il
primo capitolo finora inedito della trilogia di cui Il fantasma ha paura era il secondo e La sedia sarà il conclusivo. Trattasi del cosiddetto album di stoffa, perché - come
dichiara lo stesso Modica - rimanda al senso di calore,
sofficità e protezione in cui avvolgiamo l’infanzia, cui le
nove tracce in scaletta si rivolgono come su una voragine
mnemonica. Rispetto al successore, è album più intenso
ed essenziale, di un lirismo crudo sorretto da immagini sconcertanti dall’odore minacciosamente familiare, capace di attraversare con lieve autorevolezza una terra di nessuno
tra folk, psych, prog e post-cantautoriale. Soprattutto: è bello. Tanto che non ti spieghi
come sia potuto rimanere ad ammuffire per tre anni, da non crederci che oggi te lo puoi
scaricare gratis direttamente dal sito dell’artista reggino. Il quale ti conduce come un
Virgilio sotto benzedrina tra flash di ricordi, aprendo vecchi cassetti che è “come rubare
ciò che è tuo”, col passo sognante e irrequieto di un Gazzé via Radiohead (in Le sirene
dello Stretto) o contagiato da emulsioni cosmiche Tiromancino (tolte le fregole festivaliere, come in Sapone Verde e nella title track), tra fiabesche apprensioni Barrett e frastagliati
tremori Marco Parente (Primo volo, Cassetti chiusi a chiave), sbrigandosela tra spasimi
acustici finché la spinta visionaria non spinge su terreni acidi (il flamenco ghignante de Il
settenano di pietra e soprattutto A.C.N.E., mitraglie di sfondo e passo robotico tra il primo
Dalla, i Kuntz e i CSI). Da restare senza parole. Di nuovo in attesa. (7.5/10)
Stefano Solventi
lugubre. Non una citazione casuale quella del progetto privato drone-ambient di Reverberi in vece
del più plausibile e rinomato GDM di postrockiana memoria, perché proprio da lì prende il via Bastion. Oltre che dalle musiche, qui più “corpose”
e screziate grazie alla sensibilità di Cosi, anche da
un rimando postato in un commento sul suo blog
in tempi non sospetti, in cui ad essere direttamente tirato in ballo è l’immaginario Blade Runner:
le mie non sono lacrime nella pioggia. anche se con questo
progetto vorrei vedere i bastioni a largo di orione.... Proprio
50
/ recensioni
come nelle musiche, nelle cui architetture di textures, miscrosuoni, rumori bianchi e sfarfallii vari,
ad essere evocato è quel cielo plumbeo, quel clima
soffocante, quel senso di ottundente claustrofobia
da jungla post-urbana. E se la caratteristica intrinseca fondante di Bastion è la distanza (apparente)
tra i due bastioni, la resa è quella di una materia
magmatica che ingloba l’ascoltatore fino a farlo
precipitare nei suoi meandri. (7.2/10)
Stefano Pifferi
Ashley Beedle/Horace Andy – Inspiration Information, Vol. 2 (Strut /
Audioglobe, 2 marzo 2009)
G enere : electro reggae
Sulla carta è non poco stimolante l’idea alla base
di questa serie di uscite della Strut, qui giunta al
secondo tomo: similmente alla collana In The Fishtank edita tempo addietro della Konkurrent, si
riuniscono un paio di artisti in studio di registrazione per pubblicare poi i risultati della collaborazione. Che è una moneta estemporanea e con
due facce, sulla quale grava il rischio latente che il
materiale possa suonare “tirato via” a causa della
fretta o dell’eccesso di entusiasmo. Va a finire in
parte così tra la leggendaria ugola reggae Horace Andy e il produttore Ashley Beedle, già con XPress 2, Ballistic Brothers e Black Science
Orchestra. Sono comprensibilmente i Caraibi
a rappresentare il terreno comune, anche in virtù
del fatto che Beedle - suddito di Sua Maestà Elisabetta - vanta in parte origini nelle Barbados; un
fattore anagrafico che spiega l’agio col quale si è
in passato accostasto alla battuta in levare e il suo
remixare e “mash-uppare” alcuni classici di Bob
Marley nel 2005. Detto che la forma delle corde
vocali di Andy ha tuttora dello stupefacente, non
possiamo esimerci dal rilevare l’esito altalenante
del disco, che finisce per afflosciarsi nella seconda
metà. Prima di una inqualificabile cover della stoniana Angie - un orrore nell’originale, figuratevi voi
riletta con passo tra reggae e mariachi - sfilano il
martellare militante di Rasta Don’t, una solare e arguta Hypocrite Dog, le cadenze percussive di latinità
modernista in When The Rain Falls. Altrove è una
concezione morbida e “conscious” del reggae a
elargire il frutto in assoluto migliore con The Light,
sviluppo melodico speziato di aromi arabeggianti,
mentre soluzioni prossime a un agile dub elettronico (Watch We) e prossime a intuizioni di scuola
bristoliana (2-Way Traffic) chiudono il cerchio col
passato recente di entrambi. Non disprezzabile il
rimanente, a parte una Hot Hot Hot ruffianotta e
col fiatone, che però scorre senza imprimersi nella
memoria. Nonostante il talento e la sintonia, un
controllo qualità più approfondito avrebbe senz’altro giovato. (6.5/10)
Giancarlo Turra
Beirut – March of the Zapotec &
Realpeople – Holland (Ba Da Bing! /
Audioglobe, 16 febbraio 2009)
G enere : indie folk balcanico
Dopo aver annullato il tour europeo per troppo
perfezionismo, Zach Condon cerca di consolare i
fan con questa nuova uscita, che in qualche modo
prosegue sulla linea della “stranezza” che contraddistingue il percorso del cantante: non di un nuovo
album si tratta, infatti, benché la durata alla fine
sia quasi quella, ma di due EP pubblicati insieme,
col secondo attribuito a Realpeople, lo pseudonimo con cui il nostro pubblicava musica elettronica.
Due facce dell’autore, quindi, rese in teoria ancora
più distanti dal fatto che Zapotec è stato registrato
in Messico utilizzando una tipica banda da funerali locale, i Jimenez, inizialmente contattata per
la colonna sonora di un film poi annullato. In realtà, non solo le due facce si somigliano più di quanto le premesse farebbero pensare, perché Condon
dimostra ancora una volta di saper piegare le sue
fonti a sfumature del suo inconfondibile stile, limitando di molto le differenze tra il materiale costruito con 17 elementi e quello fatto col laptop; ma
scopriamo anche che il Messico e i Balcani non
sono nemmeno così distanti.
Eccettuata la breve intro di Zocalo e qualche sfumatura qua e là (My Wife, The Akara in cui l’ukulele mal si distingue da un charango), l’orchestra
suona infatti per lo più come le sue omologhe
della terra di Bregovic, il cui gruppo si definisce
“orchestra per matrimoni e funerali”: una tradizione che attraversa Mediterraneo e Atlantico che
Condon armonizza grazie anche a partiture che,
come composizione e ritmi (dolenti melodie spesso
a tempo di valzer), hanno risentito poco della trasferta pur lasciando più volte ai Jimenez spazi per
esprimersi.
recensioni /
51
Anche nel secondo cd la penna di Condon mantiene la rotta sulle proprie coordinate (tutto sommato dividere in due il disco non era nemmeno
indispensabile), ma l’elettronica si fa sentire un po’
più del Messico: nel finale di No Dice, uno scherzo-omaggio un po’ allunga-brodo, più seriamente
nei riverberi Yorkiani della suggestiva, splendida
Venice, nei quasi-Offlaga di My Wife… e nell’iniziale My Night… dove si oscilla tra la riconoscibilità dello stile e una rinfrescata sonora ottenuta
curiosamente riandando alle sue origini di manipolatore elettronico. Un disco -o due- che vanno
avanti tornando indietro, che ritrovano le origini
allontanandosi: non tutto è splendido, ma il talento per fare un piccolo miracolo come questo c’è.
(6.9/10)
Giulio Pasquali
Ben Nash / Nautilus – Split (Blackest Rainbow, gennaio 2009)
G enere : drone / folk
Mi ero letteralmente perso dietro ai ghirigori elettro-acustici di The Seventh Goodbye, edito la
scorsa primavera in versione digitale da Aurora
Borealis, marchio solitamente dedito ad esplorazioni in ambiti metal più prossimi al decadentismo
ambient od al teatro della musica eterna. Ben Nash
è cavallo di razza, già da quel confortante album
si coglievano i segni di un’ispirazione quasi divina.
Musica da western da fine del mondo, un senso
inedito di sfida e attesa, pellicole polverose ed una
chitarra sempre protagonista. Un po’ Ry Cooder,
un po’ Morricone, va da sé, ma con ovvi rimandi a quello che è il cosiddetto movimento weird
folk. Perchè i paragoni contemporanei più prossimi non ingannano: in questa spettrale coltre strumentale ci avviciniamo al senso onirico di un Ben
Chasny o di un Alexander Tucker. Con l’ovvio desiderio di travalicare l’epopea folk attraverso
vibranti escrescenze soniche ed un’ovvia dedizione
per il drone. Delle due tracce presentate Plymouth
Bredren Blues spicca suprema, affacciandosi anche
in maniera mefitica verso il delta e convogliando
52
/ recensioni
anomale melodie flamenco. Non male nemmeno
Interloper/Latch, materia che ufficialmente sarebbe
potuta finire negli ultimi dischi di Fahey. Nautilus è invece il progetto solista di Heidi Diehl dei
Vanishing Voice/Time Life (siamo nella Brooklyn
limitrofa alle storie cantautorali off di Wooden
Wand), anche qui arabeschi drone, conditi da una
rilevante componente krauta in area Amon Duul
II/Popol Vuh. Tre brani, di cui Still Rings appare
come personale capolavoro: una psichedelia dei
sensi che lascia ben sperare per prove più estese.
Vinile limitato a 269 copie. (7.0/10)
Luca Collepiccolo
Ben Kweller - Changing Horses (ATO,
2 febbraio 2009)
G enere : alt country
Ricordo Ben Kweller ragazzino al debutto con
Sha Sha (ATO, 2002), quella vena balzana e indolenzita, i guizzi genialoidi lo-fi e una certa versatilità che scomodarono link più o meno immediati
con Badly Drawn Boy, paragone illustro visto
che all’epoca il buon Damon Gough veleggiava
alto tra i favori e le
aspettative di pubblico e critica. Accolgo quindi questo
Changing Horses
- quarto lavoro per
Mr. Kweller - con la
colpevole mancanza
di aver saltato a pié
pari l’omonimo terzo lavoro del 2006, forse inconsciamente scoraggiato dal discreto sophomore On
My Way (ATO 2004) che lo consegnò al rango
dei più, ovvero ad una medietà carina, a tratti intrigante ma abbastanza ovviabile.
Scopro così con un pizzico di sorpresa che l’ex
giovane Ben - oramai ventisettenne, praticamente decrepito - tenta la carta del country, col fare
inevitabilmente “alt” che proviene da un approccio vagamente sbarazzino alla materia. Fermo restando il rispetto di norme e forme, a partire dalla
line-up, composta da lui a chitarra, piano e voce,
dai fedeli Chris Morrissey e Mark Stepro a basso
e batteria (drums), più il bravo Kitt Kitterman ai
ricami di dobro e pedal steel. Insomma, diavolo
d’un Ben: è ovvio che così mi frega. Per forza finisco con l’affezionarmi ad una Old Hat col suo
ciondolare struggente Wilco, al rigurgito vaudeville di una Sawdust Man, ai languori spersi di Ballad Of Wendy Baker (stiepiditi da un refolo d’archi),
all’asciuttezza Dylan di Wantin’ Her Again o ancora
a quella Hurtin’ You come potrebbe un Malkmus
qualora lo cogliesse il morbo Gram Parsons.
Detto ciò, Kwelle è lungi dal sembrarmi un artista
imprescindibile. Facciamo che ha saputo muovere con genuina arguzia le pedine giuste. Nulla da
rimproverargli. (6.4/10)
Stefano Solventi
Black Eyed Dog - Rhaianuledada
(Songs To Sissy) (Ghost Records /
Audioglobe, 22 gennaio 2009)
G enere : cantautorato folk - blues
Non nascondo di provare una certa curiosità per
Fabio Parrinello, cosmopolita o apolide non saprei
bene (nato a Varese, cresciuto tra Londra e Los
Angeles, attualmente domiciliato a Palermo), uno
che si nasconde dietro ad un moniker sfacciatamente drakeiano salvo poi disimpegnarsi più che
altro in direzione Tim Buckley, uno che dopo
i consensi ricevuti dall’esordio Love Is A Dog
From Hell (Ghost Records / Audioglobe, aprile 2007) si è mediaticamente eclissato, magari per
covare con le dovute attenzioni il qui presente successore Rhaianuledada. Nel quale vengono perlopiù abbandonati i buckleismi vagamente freak
dell’esordio in favore d’un cantautorato intimista,
cupo e appassionato, sorta di versione schiva di un
Goodmorningboy oppure un Josh Ritter problematico. Da un certo punto di vista si tratta di
un’implosione, un rifugio morbidamente claustrofobico, però non fai in tempo a sentirti soffocare
che le melodie e l’essenziale lirismo degli arrangiamenti tracciano feritoie da cui soffiano refoli
romantici e tutto sommato consolatori. Capita nel
passo frugale di All 4 You, dove la fisarmonica è
una carezza frugale, oppure tra le brume tenere di
I Got You In con la tiepida benedizione del violino,
e ancora nel soffice guaire dell’armonica nella dolciastra Daly Suicide, nella lunare The Way To My Heart con quei cori da Will Oldham cherubino, per
non dire di quella Salina’s che tra pianoforte e clarinetto sbriglia un piglio da Lanegan ingentilito e
controcanto efebico quasi Rufus Wainwright. Il
tessuto s’increspa complicandosi in Honeysuckle Gal
(delirio piratesco da Devendra Banhart waitsiano), concedendosi fregole jazzy nell’iniziale Roses
(con un piano quasi Paolo Conte) e masticando
certe ugge inafferrabili
vagamente
Peter Hammill
nella notevole Drink
Me (le elettroniche a
perturbare la trama
di chitarre, piano e
percussioni).
Alla fine resti appeso ad un senso di sedazione emotiva che appiana ogni escursione, allestendo un giaciglio forse un po’ monotono e schivo
ma ugualmente - e stranamente - affettuoso. Non
parlerei di una crescita, ma di un riposizionamento poetico che conferma Black Eyed Dog tra le più
interessanti realtà indie nostrane. (7.1/10)
Stefano Solventi
Boozoo Bajou - Grains (!K7/Audioglobe, febbraio 2009)
G enere : post downtempo
L’effetto che restituisce l’ascolto di questa nuova
fatica della coppia tedesca ha del paradossale: richiama alla memoria la breve e felice stagione in
cui esplosero trip-hop e downtempo, che prima di
trasformarsi in salottiero sottofondo buono per i
centri estetici qualche bel disco fecero in tempo a
consegnarcelo. Sembra, insomma, di leggere oggi
una missiva che doveva esser spedita un decennio e
recensioni /
53
rotti or sono per avere reale consistenza, per suscitare le emozioni che chi la scrisse aveva in mente.
Alla prova dei fatti risulta difatti interessante il loro
approccio moderatamente trasversale alla materia
volto a fare cosa sola di elettronica e jazz, soul e
latinità, slarghi dub e inquietudini post: il problema
sorge nel momento in cui realizzi che di calendari
dal muro ne hai frattanto staccati un bel po’. Va difatti benissimo omaggiare e in parte aggiornare gli
Everything But The Girl di Eden tramite la delicata Messengers e genuflettersi ai Michael Brook e
Daniel Lanois del caso nel sentire cinematico di
Fuersattel e nelle tensioni “noir” di Kinder Ohne Strom
e Big Nicks; assai meno l’aver trattenuto di Isaac
Hayes la buccia e non il frutto, oppure perdersi
dentro talune eccessive gassosità del tipo che l’ambiente lo riempiono senza riuscire a crearselo intorno. Accade giusto in un paio di episodi e si deve
tenerne conto, frattanto aggiungendo sul piatto le
title-track e le Same Sun più realiste del re nel loro
rifarsi ai primi Air. Se poi tra gli invitati alla festa sbucano fuori anche Kruder & Dorfmeister
e sotto bracci recano la glassa sinuosa e suadente
che li fece famosi, converrete che Boozoo Bajou
di talento puro non ne hanno poi molto. Piuttosto
abbiamo a che fare con artigiani valenti e moderatamente abili, dal discreto gusto e tecnica adeguata. Prendendo spunto dai “what if ” resi celebri
da Philip K. Dick, viene da pensare cosa sarebbe
accaduto se Grains avesse visto la luce nel 1998. In
questa epoca confusa e indecifrabile, pur convincendoci abbastanza, ci diciamo certi che non potrà
lasciare segni di rilievo. (6.6/10)
Giancarlo Turra
Bruce Springsteen - Working on a
Dream (Columbia, 27 gennaio 2009)
G enere : folk rock
Non è certo per mera convenienza che il Boss si sta
prestando ad uscite tanto… sconvenienti. Perché lo dico subito - Working on a Dream è un brutto disco. Spompa e confusa l’ispirazione, affogata
tra arrangiamenti che tendono inevitabilmente a
54
/ recensioni
“stroppiare”, pensando bene di sconcertarti fin
dall’iniziale Outlaw Pete coi suoi scivoloni morriconiani. No, l’onestà dell’uomo e dell’artista non la
metterei in discussione neanche sotto tortura. Se
Bruce inciampa in questo presenzialismo frettoloso credo sia per generosità, un volerci essere ad
ogni costo in un momento tanto critico ma anche
esaltante per il Paese che da sempre è sfondo, premessa e struttura della sua poetica. Accadde già
con quel The Rising (2002) che spezzò l’astinenza discografica in vigore dall’ottimo The Ghost
Of Tom Joad
(1995), affogando
nello tsunami retorico post-undicisettembre malgrado
una scrittura tutto
sommato energica,
intensa, vibrante.
Oggi, nel ventre cetaceo della depressione, Springsteen chiama a sé i ragazzi della E
Street Band per soffiare tutti assieme sul fuoco della speranza Obama. Anzi, più che una speranza
un sogno, scenografia e orizzonte che ahinoi non
possiede bordi abbastanza robusti per contenere
l’esondazione appiccicaticcia del sentimentalismo
canzonettaro buonista e proattivo (Kingdom Of
Days, la title track, Surprise Surprise, Queen Of The
Supermarket...). Quando ti va bene ti becchi una
My Lucky Day che potrebbe essere la sorellina di
My Love Will Not Let You Down, una Tomorrow Never Knows rannicchiata tra placidi vapori mariachi
e quella The Wrestler (bonus track che avrete già
sentito nei titoli di coda dell’omonimo film) che
sgrana una dignitosa ballad a fari bassi e cuore
pieno delle sue, mentre Good Eye è degna di nota
giusto perché anomala con la sua robotica frenesia
country-blues. Insomma, sembra la soundtrack di
una terapia di recupero collettiva. Mi fa venire il
disagio, voglia di alzarmi e salutare. Speriamo almeno che serva a qualcosa. (4.5/10)
Stefano Solventi
Burning Hearts - Aboa Sleeping
(Shelflife, 10 febbraio 2009)
G enere : indie pop
Supponiamo ordunque che l’electro-pop malinconico, garbato, trepido, nostalgico ma a suo modo
ostinatamente proiettato in avanti, possieda proprieta terapeutiche. Un lenitivo per il malanimo
che sempre più spesso accompagna i nostri giorni saturi di troppe cose a perdere. Supponiamolo.
Ecco, casomai oserei dire che i Burning Hearts duo finnico formato dalla cantante Jessika Rapo e
da Henry Ojala, polistrumentista già nei Cats On
Fire - stemperano nel debutto Aboa Sleeping il
suddetto principio attivo, con la competenza un
po’ scostante dei farmaci generici, cui comunque
finisci per tributare la giusta fiducia.
Del resto, la confezione calda ed essenziale testimonia l’onestà del contenuto, che l’infermiera Jessika ci propina con setosa autorevolezza, mentre
il dottor Ojala si disimpegna tra scaffali Stereolab (A Peasant’s Dream) e provette New Order (I
Lost My Color Vision), distillando morbidezze Lali
Puna via Belle And Sebastian (Iris), concedendosi omeopatie Bowie (una We Walked Among the
Trees che ammicca Ashes To Ashes) e Kraftwerk
(l’angelicamente frigida The Galloping Horse), per
poi planare su una title track col passo delle ballad
importanti, coprendo d’amblé la distanza tra certe
ugge Delgados alle utopiche elevazioni Air.
Un disco non esaltante ma buono. Io comunque lo
preferisco al Prozac. (6.7/10)
Stefano Solventi
Camera 237 – Inspiration Is Not Here
(Foolica, 13 febbraio 2009)
G enere : post - rock
Verrebbe da parafrasare il titolo del disco per tagliar corto sulle scelte stilistiche “un po’ attempate” e in qualche caso prevedibili dei Camera 237.
Verrebbe da parafrasarlo ma sarebbe non rendere merito a musicisti che sanno comunque come
suonare credibili e almeno in qualche frangente,
spiccano per lucidità. Un paradosso? Forse, ma
che riteniamo di poter risolvere in questa sede, in
primis passando in rassegna i principali caratteri
della proposta musicale della band cosentina. Su
tutti, quelli tipici di un “dopo-rock” corposo e
solido che tornano alla ribalta ciclicamente, negli
arpeggi insistiti, nelle porzioni strumentali elaborate, nelle complessità dei fraseggi. Una formula
che come da ultimo aggiornamento del Prontuario
del perfetto post-rocker, vive di veloci cambi di passo,
contempla qualche sprint al fotofinish, cerca di
rinnovarsi richiamando estetiche che poco hanno a che vedere con l’ortodossia e molto con il
carattere, per lo meno nelle intenzioni. Nei fatti ci
si imbatte in episodi elettro-acustici di pregevole
fattura (la title-track) come in ampollose lentezze in
saturazione (If You Are Tired, Don’t Risk), apprezzabili progressioni in controtempo (New Song) e
derive strumentali lasciate alla corrente (elettrica)
(Caracol), in un tira e molla che ha certo il pregio
di non annoiare ma anche il difetto di non suscitare sbalzi emotivi significativi. Mestiere e entusiasmo rendono il prodotto finale apprezzabile e
tutto sommato onesto, pur correndo il rischio di
farlo passare in più di un’occasione per un esercizio di stile che piace alla gente che piace, gratifica
chi ci si è impegnato – al secondo episodio discografico della carriera - ma fatica a lasciare un
segno profondo. (6.7/10)
Fabrizio Zampighi
Camouflage - Live in Dresden (Synthetic Symphony / Audioglobe, 19
gennaio 2009)
G enere : techno pop
Esiste da sempre un pregiudizio di fondo nei confronti del techno-pop, che nemmeno gli sdoganamenti ripetuti di Depeche Mode, Pet Shop
Boys, Heaven 17 e chicchessia tra i maestri del
genere non sono ancora riusciti a scalfire fino in
fondo. Che, insomma, si tratti di materiale vacuo
e “commerciale”, privo di spessore e peso specifico. Come se, attenendoci al rock duro e chitarre, Bon Jovi e i Queens Of The Stone Age
recensioni /
55
fossero la stessa cosa. Non è per fortuna così e lo
sappiamo bene, benché talvolta incappiamo in
personaggi che poco (cioè molto) fanno per procurare ai detrattori prove a carico della loro tesi.
I tedeschi Camouflage traggono il nome da una
canzone dei Yellow Magic Orchestra, e pare
rappresentino da anni una delle band di synthpop più importanti sulle scene. Devono avere un
pubblico comunque folto se si permettono il lusso
di uscire con un mammut come questo - cd audio più dvd con più brani e ulteriore dischetto con
tutti i video - oppure, in caso contrario, nessuno
si è premurato di dirgli che sulla carta d’identità
non hanno scritto Gahan o Gore. Eh, sì, perché
quello è grossomodo l’ambito in cui ci si muove:
quello per l’appunto di un techno pop che vorrebbe avere impatto rock senza epica e ridondanza.
Il problema del quintetto è che tra le sue fila non
vanta un’ugola carismatica, uno scrittore capace
di conciliare immediatezza ed eleganza, uno che
arrangi i brani senza che gli anni Ottanta sfocino
nel 1993. Finisce che afferri l’apparenza e del genere restituisci un’idea tra stadio e alternative club
di provincia, al cui confronto i Subsonica paiono
gente da prendere tuttora sul serio. Arrivare alla
fine della maratona è stata fatica che al sottoscritto ha richiesto numerosi e ripetuti passaggi di The
Luxury Gap e The Hurting per ossigenare i polmoni.
(5.0/10)
meno virtuosa delle due artiste citate in apertura,
potrebbe rientrare a grandi linee in questa tradizione, visto che con The Deep Blue confeziona
un disco fortemente interessato alle stratificazioni
sonore (Behave), attratto dalle linee armoniche
inconsuete (Roll Over), affezionato alle vaghezze
soffici della voce (Dawn Treader). Con in più il
geneticamente modificato delle chitarre elettriche
(I Wan’t You To Know e Very Young) e della psichedelia (Love’s Young e Dream, Be Thankful), a vergare a
caratteri cubitali un proposta finemente arrangiata e, in qualche caso, piuttosto energica. Del resto
non potrebbe essere altrimenti, visto che stiamo
parlando dell’ex chitarrista degli Ash, qui al
secondo disco della sua neo-carriera solista. Una
che oltre ad aver già le idee chiare sulla direzione
da prendere, coinvolge in fase di produzione figure d’alto profilo come Rob Ellis e Eric Drew
Feldman (ex Captain Beefheart’s Magic Band)
e sceglie come co-autore in Dawn Treader Andy
Partridge degli XTC. Tutti segnali da interpretare, per un’opera che arriva in Italia soltanto ora
nonostante una pubblicazione inglese risalente al
2007. (7.1/10)
Giancarlo Turra
La transizione della scena tradizionalmente definita
garage-punk, americana quanto europea, verso certe sonorità anni ’80 è ormai cosa consolidata. Se ce
ne fosse bisogno, ecco qui un’ulteriore prova di questo passaggio di testimone. Molte band e progetti
solisti si sono prodigati negli ultimi tempi nella produzione di materiale dai connotati smaccatamente
e volutamente wave: Mike dei DC Snipers con Blank
Dogs, gli Homostupids con Factory Man (tra l’altro
artefici di un ottimo 7’’ su My Mind’s Eye) fino al
nuovo progetto di Erin Sullivan (cantante e chitarrista negli A-Frames) a nome Rodent Plague, il cui
singolo d’esordio è uscito da poco su Kill Shaman. E
proprio dal famigerato asse A-Frames/Intelligence/
Charlotte Hatherley – The Deep Blue
(Little Sister, 2007– Red House Recordings, 2009)
G enere : pop - rock
Ultimamente sono sempre di più le musiciste che
si cimentano in una rielaborazione del pop in
chiave personale e innovativa. Vengono in mente,
solo per fare un paio di nomi, St. Vincent e My
Brightest Diamond, entrambe capaci di unire
una vena melodica suadente ad arrangiamenti
strutturati e difficilmente etichettabili. Charlotte
Hatherley, pur essendo inglese e tecnicamente
56
/ recensioni
Fabrizio Zampighi
Children’s Hospital – Alone Together (Sacred Bones, dicembre 2008)
G enere : wave industriale
Highlight
Andrew Bird - Noble Beast (Fat Possum / Bella Union/ Cooperative Music, 13 febbraio 2009)
art folk
La continuità dell’incanto, più che la sua intensità, ci
convince del fatto che Noble Beast è - e probabilmente
sarà - il capolavoro di Andrew Bird. Col quinto album
da solista non fa che raccogliere quanto seminato nel suo
frugale orticello, e siccome il nostro musicista chicagoano
da sempre professa il culto della biodiversità sonora, ne
viene fuori un raccolto variegato, ricco, persino robusto
nella generale morbidezza del tono. Rispetto alle prove
del passato sembra semmai più accorta la gestione del canto, tenuto al guinzaglio delle
necessità espressive che pezzo dopo pezzo indagano con frugale gravità il mistero, la meraviglia e la miseria del fattore umano. La scrittura invece è di quelle... nobili, sposandosi
alla misurata brillantezza di arrangiamenti che, innervati su mai eccessive evoluzioni di
violino, conferiscono abiti trepidi e setosi, un carosello discreto e ipnotico di fiabesche
tensioni (Anonanimal e Nomenclature, con le apprensioni acustiche Kozelek contagiate di
languori Rufus Wainwright), di bucolico abbandono (la fatamorgana Al Stewart/
Brian Wilson di Oh No), di esotismi fragranti (l’incalzante Fitz And The Dizzyspells) e randagi (la bossa onirica di Masterswarm, lo sdilinquimento post moderno di Not A Robot, But
A Ghost). Altrove predomina il battito traditional, appena carezzato da una verve freak,
come in quella Tenuousness come potrebbe il nipotino garbato e arguto di Paul Simon,
come in una Effigy scaldata dal tepore Gram Parsons (con la brava Kelly Hogan a fare
la Emmylou Harris della situazione), o come quella Natural Disaster che incede docile e
grave come il Beck di Sea Change. Volendo individuare l’apice della scaletta, punteremmo l’indice verso Souverian, sorta di mini suite che parte come milonga da front porch
e poi trascolora in un camerismo pervaso di languori coloniali, magnifico il ritornello,
ineffabili le ambientazioni all’insegna di scenografie incantevoli e spossate. Inevitabile
tirare in ballo il luogo comune della maturità, che Andrew Bird sta vivendo con la pienezza tipica di chi ha molto da dire. (7.5/10)
Stefano Solventi
AFCGT giunge, inevitabilmente su Sacred Bones, il
primo LP dei Children’s Hospital, nuova formazione nata sotto il grigio cielo di Seattle; accantonate le
chitarre, o almeno poggiate momentaneamente in
un angolo, si estraggono synth, tastiere e archeologia
tecnologica avariata per dar vita a meccaniche nostalgie analogiche, salvo di tanto in tanto riesumare
il fantasma del proprio passato con riff che lasciano
intravedere una minima continuità (Unseen). Il passaggio, va detto, è indolore e in alcuni punti è anche
recensioni /
57
decisamente compiuto (Preschool Of Atonement, If You
Find Me I’m Here); tuttavia a volte tuttavia alle volte i
nostri si lasciano sedurre da scorciatoie compositive
che, più che agevolare, rallentano il percorso (After the Aftermath, Blue/Green Algae). Certo è che
questo è solo il primo lungo passo nella direzione di
quella wave-proto-industriale di cui furono, a loro
tempo, fulgidi testimoni atti come Cabaret Voltaire,
Throbbing Gristle e Factrix e i pezzi posti a chiusura di entrambi i lati lo dimostrano egregiamente.
Tuttavia , pensando ad esperienze più navigate in
questo ambito, si insinua il dubbio che non si sia voluto tentare troppo in fretta un traghettamento non
sempre così naturale come si potrebbe presupporre.
(7.0/10)
Andrea Napoli
Circus Devils – Ataxia (Static Caravan, 2008)
G enere : low - fi
Oltre alla prolifica e discutibile carriera solista, Robert Pollard continua a portare avanti, più o meno
con lo stesso ritmo (ma con esiti senz’altro più interessanti) il progetto Circus Devils. Se c’è qualcosa
ancora degno del passato dell’ex Guided By Voices, va cercato proprio nelle uscite di questa band
che, seppure con qualche riserva, è riuscita ad
esprimere finora le sue (attualmente) migliori idee
musicali. La caratteristica del musicista dell’Ohio
(quando è in forma) è quella di riuscire a comporre su due piani, navigando nell’underground rock
americano senza tuttavia esimersi dallo strizzare
un occhio a piacevoli melodie. Quando riesce a
mantenere il giusto equilibrio tra questi due diversi approcci alla composizione, Pollard dimostra di
meritare le lodi del passato.
Ataxia è un disco complesso, ma anche molto coerente del suo predecessore. C’è qui un’intenzione
di osare mai ascoltata prima, di spingersi fino alle
soglie della psichedelica, del noise rock (Nets At Very
Angle) e della new wave , sfociando addirittura nel
dark ambient di I Found The Black Mind e Fuzz In
The Street. Se evitasse le sdolcinatezze alla He Had
58
/ recensioni
All Day e qualche tocco di banalità, sarebbe proprio un gran bel disco (7.0/10)
Daniele Follero
Cristopher McFall – The City Of Almost (Sourdine, 2008)
G enere : minimalismo - ambient
Andando oltre l’hic et nunc dell’aneddoto, i fields recordings di Cristopher McFall si fanno strumento di
rilevazioni urbane. Linee narrative in quattro tracce
ed un’unica direzione di studio, una città del Kansas un tempo molto prospera colpita con il passare
dei decenni da un evidente stato di degrado urbano.
Una lettura sonora che cela l’origine di registrazione sul campo per concedersi ad un elegante estetica
digitale, deteriorata in claustrofobiche stratificazioni
(Slow Containment) o esposta agli oscuri temi centrali
di drones (One of several possible endings). A colpire è
l’accostamento al luogo, documentato dalle partiture che restituiscono l’evolversi del luogo dispensando di esso immagini vivide. E’ tangibile l’essenza
temporale, nelle ariose decostruzioni in interferenze
di Requiem for Troost (dovuto omaggio al quartiere e al
suo centrale Viale Troost) o tra le estensioni in fondali dal sapore vinilico che accompagnano trame
oblique e microcosmi campionati (Al parts contained).
Disco figlio dell’era post-industriale, a metà strada
tra antropologia sonora e soundscape. (6.8/10)
Sara Bracco
dälek – Gutter Tactics (Ipecac, gennaio 2009)
G enere : doom - hop
Dopo che certe fasce dubstep hanno virato verso
il modernismo techno, ci mancava un po’ di realness. Se i generi subiscono inevitabilmente il destino
dell’eterno ritorno, il duo composto da MC Dälek
e dal produttore Octopus torna a parlare di doom
ed è come una risposta alle fascinazioni banghra di
gente come Dusk+Blackdown, a tutte quegli etno
velluti escapisti ai quali occorre un fermo no con la
crisi a caldo che ci brucia ogni giorno più il culo. Poi
è come se fosse la prima volta, come se la Anticon
non ci fosse mai stata, come se i cLOUDDEAD non
fossero mai esistiti. Rivisitando si cresce, si tirano
fuori quei drones cupi ereditati dai Sunn O))) e dai
Melvins e il deja vù sorprende. In poche parole:
hip-hop is here to stay. Ovviamente mutato da una
sensibilità trasversale che dal 2002 accompagna il
percorso compositivo dei rappers dal New Jersey e
che ancora una volta ci fa capire come il mesh sia
d’obbligo. Ma non solo suono. Cavalcando le roots
ci si va anche di scalpello sul testo. In direzione contraria al
mainstream, che si
dimentica del sociale e del politico, in
un momento come
questo è sempre più
doveroso ripescare
la lezione dei sempreverdi Public Enemy. Parola d’ordine: cattiveria. Già dall’iniziale Blessed Are… si parla di quello
che sta accadendo da sempre: conquiste in nome
del dio denaro che non guardano in faccia a niente
e a nessuno, travalicando confini e diritti. La verve
engagé risuona poi nei colpi apocalittici di Los Macheteros e nelle bordate che attraversano in stile Wu
Tang Clan l’intero album. Cose che non si sentono
più, dischi come questo ci fanno stare male, ci fanno
incazzare. Senza sballo, una cosa che viene dall’anima, un sentimento che nel rock avevamo sperimentato nei pogo dei RATM. Qui l’hip-hop ritrova la
sua possibilità di riscatto con una straightedgeness
che suona nuova, sporcata da mille effetti e disorsioni, imperfezioni che arricchiscono e che sono sempre più necessarie per descrivere la (vita di) strada.
Respect.(7.5/10)
iniziava a stare stretta al caro Dan Auerbach, al cui
estro solistico ha quindi giustamente pensato di concedere un po’ di spazio. Debutta quindi in solitario
con questo buon Keep It Hid, fedele al verbo dei
Keys coi contorni lasciati però sfumare, così come
la direzione delle parabole espressive, che si rannicchiano tra folk ballad acidule e si spampanano tra
svaporate psych, ora tirando per la giacca i fantasmi del blues col ghigno elettrico (I Want Some More),
salvo poi grattare la pancia alle fatamorgane della
nostalgia fifties. La calligrafia è diretta come da copione (arrangiamenti essenziali, col piccolo aiuto di
pochi amici), prevedibile come da rituale, credibile
perché convinta fino al midollo di fare quel che fa,
ragion per cui piuttosto che lasciar prevalere l’effetto sferzante ma catchy alla maniera di certi White
Stripes, lo senti vicino al piglio roccioso d’un Lanegan (Street Walkin, The Prowl, la quasi waitsiana
title track), anche per la tenerezza (Whispered Worlds,
canzone scritta dal padre) e l’obliquità (When I Left
The Room) con cui rimastica certe situazioni Gun
Club. Certo che quando Dan spinge sul pedale del
white soul (come una Real Desire che è quasi i Creedence di Long As i Can See The Light) o della ballata
carezzevole (una When The Night Comes cantata assieme a Jessica Lea Mayfield) il discorso cambia, per
non dire di quando si disimpegna sbrigliato e lirico
rammentando il Devendra Banahrt ultima versione (My Last Mistake) e quello delle reminiscenze arcaiche (Goin’ Home). Come dire, siamo chiaramente
in presenza di un autore versatile e versato in quella
che per semplificare chiameremo Americana, come
già chiarisce in apertura quella Trouble Weighs A Ton
che non sfigurerebbe nel repertorio d’un Will Oldham, così per dire. Non un disco sorprendente, ma
comunque una bella sorpresa. (7.0/10)
Marco Braggion
Stefano Solventi
Dan Auerbach - Keep It Hid (Nonesuch, 10 febbraio 2009)
G enere : blues rock
Dead Letters Spell Out Dead Words
– Lost In Reflections (Release The
Bats, gennaio 2009)
G enere : post - rock / shoegaze / elettronica
La formula Black Keys - tanto collaudata quanto
efficace, ma invero un po’ ripetitiva - probabilmente
Dead Letters Spell Out Dead Words è lo pseudorecensioni /
59
nimo dietro cui si nasconde Thomas Ekelund, artista visuale e musicista di Gothenburg, e Lost in
Reflections è il suo ultimo disco. I luoghi esplorati nelle sue composizioni sono le stesse terre gelide e brumose che hanno fatto la fortuna di gruppi
come Sigur Ros. Ma se la musica degli islandesi
sembra essere soltanto una sfocata concessione del
loro mondo – troppo alieno da capire, troppo distante da descrivere in titoli o parole – Ekelund
vuole invece condividersi apertamente, sin dalle
dichiarazioni riguardanti il ruolo avuto dalla sua
malattia (un disturbo della personalità) nella gestazione dell’album. Anche la sua musica in qualche modo vuole mostrarsi vicina. I lunghi tappeti
ambientali, gli sconfinati riverberi, sono graffiati
da piccoli suoni, glitches digitali, sfrigolii elettrici
di vinili polverosi, come se volesse mostrarci i suoi
luoghi attraverso le diapositive di un vecchio proiettore scrostato. Riducendo cioè il viaggio a una
dimensione più domestica, quindi più accessibile.
Highlight
Harmonic 313 – When Machines Exceed Human Intelligence
(Warp, febbraio 2009)
glitch - electro - hop
Mark Pritchard ritorna su Warp. L’uomo
�����������������
mezzo Global Communication si rifà il trucco e fa parlare di sé. Con
questo album che è un tornare alla meccanizzazione, alla
visione kraftwerkiana (guardate i video e gli artwork del
sito) tutto però sporcato di break nero. E quindi di storia
hip-hop. Una cosa così non te l’aspetti. Non ti aspetti che
la proposta sia coinvolgente e a tratti squassante. Perché
il ritorno sulla scena molte volte è un riproporre cose già
dette senza pensare alla patina di polvere che hai davanti
agli occhi. Qui si ripropone, ma con uno stile che è da archeologia 90. E in questo inizio
anno capiamo che più avanti si va, più gli occhi sono rivolti all’indietro. Ce l’avevano già
detto su altri lidi gli O.R.B. e gli Autechre. I vecchi suoni sono lì, ma chi saprà usarli a
dovere? C’è ancora qualcuno che riesce a cavalcare le sterminate praterie ambient senza
copiare Aphex T.? Sì, ascolta Köln e poi dimmi se il mago del synth ci ha spiazzato o
no. C’è ancora qualcuno che sa parlarti col vocoder e distruggerti con una base glitch à
la Space Invaders? Sì, ascolta Word Problems. Che lesson. Ci sono ancora quei bei break
che sentivamo dalle parti dei Beastie Boys? Vediti il riff di Battlestar e poi muori. C’è
ancora qualcuno che ricorda in modo degno la cultura a 8 bit? Cyclotron C64 SID sì. E
avanti così. I rimandi sono infiniti, ma non sono nostalgia sterile. Qui si riparte per nuove avventure nella matrix gibsoniana. Le guerre stellari le vedremo tra un po’ di tempo,
quando capiremo che i teen del dubstep sono troppo concentrati a sfornare singoli che
durano solo una notte di nerdy videogaming sfrenato. Chi invece ha la forza di prevedere
il futuro va oltre il tempo. E questo, cari amici, è uno di quei dischi. Che voi siate Bad o
no.(7.7/10)
Marco Braggion
60
/ recensioni
Ad introdurre il disco è la semidensa progressione
chitarristica di This Room Seems Empty Without You,
ma nei brani successivi le atmosfere si fanno più
rarefatte, le strutture sempre ascensionali, ma la
tensione non arriva mai a sciogliersi come accade
ad esempio nelle distensioni tipiche del post-rock
di Mogwai o Explosions in the Sky. A chiudere Himmelschreibenden Herzen, la traccia più cupa,
forse quella che meglio trasmette la frustrazione
di cui Ekelund fa riferimento nelle sue dichiarazioni. Le parti più riuscite sono però quelle che
fanno da cornice al nucleo dei pezzi: le lunghe scie
di elettronica statica che introducono o concludono i brani. Quando a prevalere sono piccoli suoni
quasi quotidiani, in cui riconosciamo l’intimo silenzio dei luoghi domestici. Fruscii, sospiri, magri
feedback, hum di elettrodomestici, dettagli spesso
ignorati o sommersi da conversazioni futili, televisori prepotenti, decibel sprecati nel chiasso degli
spazi affollati. Non so se riesce appieno a comunicare le sue sensazioni, ma sicuramente riesce a
creare il miglior luogo possibile in cui si è disposti
ad ascoltare. (6.8/10)
Leonardo Amico
Dente – L’amore non è bello (Ghost,
febbraio 2009)
G enere : canzone d ’ autore
Quale data migliore del 14 febbraio per uscire con
un album intitolato L’amore non è bello? Già da
questa bizzarra scelta, intuiamo fin da subito che la
vena ironico-lessicale di Dente, ben espressa anche
nei suoi primi due album, è lungi dall’inaridirsi,
anzi. Ciò che invece viene smarrito per strada, per
una volontaria scelta artistica, è quell’approccio
lo-fi che faceva da perfetto contraltare alle liriche
del Nostro. Dobbiamo ammettere che infatti questa sua terza fatica ne risente non poco di siffatta
virata stilistica, perdendo in spensieratezza. Però
dobbiamo dargli atto del suo coraggio di non ripetersi: molto probabilmente un clone di Non c’è
due senza te avrebbe stancato e non gli avrebbe
permesso di fare il salto di qualità. Cosa che non
succede neanche con L’amore non è bello, però
almeno esso è da considerarsi come un album di
transizione che lascia speranze per il futuro. I riferimenti sono sempre i medesimi: Battisti e tutta la
canzone d’autore pop anni Sessanta. Alcuni brani
risultano fin troppo monotoni e piatti nella loro
nuova e più elegante veste strumentale, altri invece
incidono sublimi e delicate linee melodiche che si
conficcano in testa senza più uscirne, grazie anche
a delle liriche sempre ironiche e suggestive. Dente
avrà tutto il tempo di maturare, per ora un più che
meritato (6.5/10)
Andrea Provinciali
El Cijo – Bonjour My Love (Still
Fizzy, ottobre 2008)
G enere : folk - blues
Se non ti conoscono che quattro gatti e te ne esci
con un disco d’esordio con sedici tracce in scaletta, o sei un giocatore d’azzardo o sei uno che
crede che le “logiche di mercato” siano una delle
ultime punk band al femminile scoperte da Pitchfork. Non ci sono mezze misure. In tempi in cui
anche un Ep sembra troppo lungo, in un’era discografica logorroica e dispersiva come la nostra,
spiattellare in un’ora di musica micro-frammenti
da un minuto come divagazioni da sei sperando di
farsi apprezzare da scribacchini perennemente in
ritardo sulla tabella di marcia, equivale a puntarsi
una rivoltella alla tempia. Basta un nonnulla per
far partire il colpo. Gli El Cijo ne sono consapevoli, dimostrano una fiducia incrollabile nelle loro
capacità, fanno per un po’ gli equilibristi sul filo
ma alla fine se la cavano piuttosto bene, se è vero
che questo Bonjour My Love non solo non è tempo perso, ma acchiappa pure. Con un tripudio di
folk in bassa fedeltà (Blackbird Messenger), blues
acustico (Every Woman), vaghezze jazz riconducibili al Tim Buckley più etereo (The Guy Of
Yellow Grain), morbidi strumentali (Calamari in
frack) che si fa apprezzare da subito, regalando nel
contempo raffinate incursioni musicali in territori di confine. Ancona la città di provenienza della
recensioni /
61
formazione, chitarre, contrabbasso, kazoo, piano
elettrico, fiati e chissà cos’altro la strumentazione,
Memphis (Tennessee) il quartier generale per queste registrazioni, per un disco che stupisce e non
stanca, nemmeno alla lunga. Le idee, del resto,
non mancano, il linguaggio è forbito, la maturità
davvero a un passo. (7.0/10)
Fabrizio Zampighi
trasforma nel tono imprecatorio di un Allen Ginsberg che legge in pubblico (Februaries) o sopra, a
sua volta, una band; un tono perentorio ma stralunato nella sua aggressività; come in Bells, dove
notiamo quell’intensità di accordo tra carica strumentale e vocale. E tra un voto che inizia per 5 e
uno che iniza per 6 propendiamo per il numero
più alto. (6.3/10)
Gaspare Caliri
Enablers – Tundra (Exile On Mainstream, 26 gennaio 2009)
G enere : spoken word - post rock
È il 2009 e sembra davvero fuori tempo massimo
proporre uno spoken word che declama sopra del
post rock Novanta. È il 2009 e Tundra è il terzo
lavoro del progetto Enablers, ideato da Pete Simonelli – alla voce - e accettato di buon grado dal
chitarrista Kevin Thompson.
A noi che ci abbiamo tanto riflettuto e scritto sopra il progetto non può che ricordare i Massimo
Volume, con la differenza che allora i riferimenti
del post oltreoceano erano – diciamo – coscritti,
mentre ora sono storicizzati per tutti. Lo si capisce
notando l’esperienza e la competenza calibrata
di Carriage, con la sua riuscita struttura angolare.
Mentre la parentela con la tecnica di Mimì e soci
è dirompente, ossimorica rispetto alla riflessività
slow-core del pezzo, nella title-track; e non manca
nemmeno la catarsi, su cui abbiamo tanto insistito
parlando dei MV. È un vortice che ci porterebbe
solo a parlare solo della band italiana, non per deplorevole campanilismo, ma per un debito critico
che sembra sgorgare come linfa e sangue insieme.
Sono però fortunatamente questi i casi in cui prediligiamo le differenze al di là delle somiglianze, e
che spesso le differenze sono quelle che “salvano”
i nostri ascolti. In questo caso parliamo della caratteristica vocale di Simonelli, un crooning parlato che per occasioni selezionate riesce a trovare
un’espressività che non può che giovare al combo
post-rocckettaro. I momenti migliori, a tal proposito e dal punto di vista di chi scrive, sono quando
il teatro baritonale della cassa toracica di Pete si
62
/ recensioni
Fauna – Rain (Aurora Borealis /
Southern, 2008)
G enere : B l ack M etal
Si cela dietro un alone di mistero, questa band
americana, giusto per far perdere un po’ di tempo
prezioso a chi cerca informazioni su Rain, capitolo
primo dei Fauna, ovvero il duo formato da Echtra
e Vines (tanto per rimanere in tema di storie ed
eroi nordici, quando si parla di Black
Metal), provenienti
dal nordest del Pacifico. Una sola traccia lunga sessantatrè
minuti (!). A parte i
neanche troppo velati riferimenti alla
simbologia nazista
e ariana, Rain è la dilatazione estrema di tutti gli
stereotipi del black metal di stampo nord europeo: arpeggi in tonalità minore lenti e scheletrici
alternati a velocissime accelerazioni, saturazione
sonora ai limiti della distorsione, voce strozzata e
macabra. Tutto sommato, questo concept album
non è il peggio che possa capitare tra le mani: meglio ascoltare il black metal in forma di suite che
in un album con 15 brani tutti uguali. Per carità, i
contenuti non si discostano molto dalla brodaglia
di genere, a parte qualche lunga apertura al doom
dei primi My Dying Bride, ma almeno l’intenzione di fare un passo oltre lo stereotipo c’è e si
vede. (5.8/10)
Daniele Follero
Franz Ferdinand – Tonight: Franz
Ferdinand (Domino, gennaio 2009)
G enere : rock post - p - funk
I Ferdinandi alla terza e fatidica prova. Come al
solito ci si aspetta qualcosa dal numero perfetto.
Poi per le band che escono dal nu-rave quest’attesa è ancora più ricca di curiosità, dato che molti
emul-baronetti stanno perdendo mordente (vedi
per dirne due Kaiser Chiefs e Interpol). Già.
Smalto da irresistibili dandy, brit fab-four style
virato amfetamina, mod di ieri e domani cosa? I
ragazzi, già vecchi anagraficamente agli esordi
stanno riproponendo la più classica delle parabole
rock: ci fanno vedere la dark side del loro successo
in Ulysses, e ci ricordano la diaspora Beatles-letit-be. Across the Universe non c’è qui, ma nel rifare
le origini con i soliti ritmi in levare e qualche aggiunta elettronica di tastiera che varia la ricetta, la
dinamica con tutti i se e i ma del caso è la stessa,
come in un disco di Bowie metà Ottanta.
Capitalizzare il successo è ancora l’obiettivo principale e i singoletti del duca di allora ci piacquero
tanto quanto ci piaceranno per un po’ quelli del
quartetto di Glasgow. Del resto ci hanno stuzzicato il basso e i synth che pompano uptempo funk
nella citata Ulysses e No You Girls. Mica male il ricordo northern soul con gli Hammond in Send Him
Away, le atmosfere 80 di Live Alone e - per la prima
volta - un accenno di psichedelia mescolata alla
acid disco nella sorprendente Lucid Dreams. Tutti
ingredienti che ci fanno fare i soliti proseliti per
un prossimo disco spiazzante proprio come quello
dei Supergrass. L’uso dell’elettronica probabilmente agevolerà i remixatori a sfornare singoletti riempi pista, ma Alex, invece di fare il fighetto,
stupiscici la prossima volta. Ne sei ancora capace.
(6.3/10)
Mar co Br a ggion e Edoardo Bridda
John Frusciante – The Empyrean
(Adrenaline Music, gennaio 2009)
G enere : songwriter
Fa sempre notizia John Frusciante in uscita dal
gruppo, e dire che con The Empyrean colleziona il suo undicesimo disco in solo, un bottino
niente male per un musicista che avrebbe potuto
comodamente adagiarsi sugli allori. Che il gruppo
madre sia un’attrazione per scolaresche in libera uscita
non è mistero, ma
non dimentichiamo che prima della
penosa svolta arena
rock i Red Hot Chili
Peppers hanno pur
sempre occupato un
ruolo di primissimo piano nella cultura alternativa americana. Del resto l’emblematico white funk
di dischi come Freaky Styley e Uplift Mofo
Party Plan non è cosa da liquidare in due battute. Chi è il Frusciante solista quindi? Un uomo
sicuramente innamorato delle sue origini, ma anche un impensabile ed impenetrabile songwriter.
Detto che Eddie Hazel dei Funkadelic e Shuggie
Otis rimangono quasi un punto fermo nel suo stile, sorprendono la sottile interpretazione di Dark/
Light quasi un’ outtake dal Pacific Ocean Blue
di Dennis Wilson; ancor più coraggioso il confronto con uno dei più grandi di tutti i tempi: Tim
Buckley. Accedere alle arcane e celestiali volte
di Song To The Siren non è esattamente un’impresa
trascurabile, oltre al fegato ci vuole il buon gusto,
ben intesi. Quando scorre l’apertura psichedelica
di Before The Beginning, ci chiediamo davvero se i
Funkadelic di Maggot Brain, siano dietro ad una
colonna ad osservare in disparte, tanta è l’assonanza col periodo più lisergico della gang di George
Clinton. Idee ed intuizioni che al gruppo madre
sono venute a mancare in un sol colpo, anche se
il commilitone storico Flea è a dar manforte sul
disco, sciorinando le consuete ed avvolgenti linee
di basso. Non è l’unico ospite di rilievo, visto che
Johnny Marr degli Smiths si affaccia con discrezione, forse a causa dei suoi nuovi interessi americani (ha sbancato con i Modest Mouse come rirecensioni /
63
portano le recenti cronache). Di impatto anche la
presenza del quartetto d’archi Sonus Quartet che
di recente è stato ospite in studio di Sparklehorse
e Gnarls Barkley. Lontano è il tempestoso e realmente ‘drogato’ Frusciante del secondo album –
Smile From The Street You Hold, sospeso tra
fantasmi di Butthole Surfers e Jandek – il chitarrista californiano trova nuovamente la quadratura
del cerchio con uno dei suoi più compiuti album
di sempre. Chapeau! (6.8/10)
interpretare impastandone il senso attuale, quelli
passati e - casomai - quelli futuri.
Talora le escursioni danzerecce suonano un pizzico inopportune - come quando in Martinsson scompaginano un assolo cameristico di violoncello, un
po’ come servire un limoncello dopo un sassicaia
– senza però rovinare la buona impressione complessiva. (6.8/10)
Luca Collepiccolo
Grandmaster Flash - The Bridge
(Strut / Audioglobe, 23 febbraio
2009)
G enere : hip hop
Gadamer - Self Titled (AltriSuoni,
gennaio 2009)
G enere : electro / avant / jazz
Il violoncellista (con fregole elettriche) Zeno Gabaglio e il pianista (con tentazioni sintetiche) Andrea
Manzoni avviano questo progetto di avant-fusion
omaggiando nella ragione sociale uno dei padri
dell’ermeneutica, il filosofo tedesco Hans-Georg
Gadamer, morto nel 2002 ultracentenario non
prima però di averci regalato concetti straordinariamente post-moderni come il circolo ermeneutico e
la fusione degli orizzonti.
Bene, ringraziamo wikipedia e proseguiamo tessendo lodi non sperticate ma abbastanza lusinghiere su un disco che riesce nell’impresa di fondere le
allucinazioni cosmiche-ambientali del kraut (Gate)
e le palpitazioni avant-jazz di Esbjorn Svensson Trio (Impro 14, Chiara), la fusion davisiana
e la techno in odor di IDM (Methode), suonando
torva e suggestiva, misteriosa e immediata come
la soundtrack di un lungometraggio suburbano, in
attesa che il miracolo della natura ci assolva dagli
squallidi residui (materiali e spirituali) della ipertecnologia.
Tra scenografie assorte e claustrofobiche (Impro 01)
e carezzevoli ossessioni sbocciate tra loop e fremiti
di violoncello (Orizzonte), tra deep bass ipnotizzati
da un impertinente minimoog e barbagli romantici
nella caligine androide, ti capita di ipotizzare una
situazione in cui Popol Vuh, Brian Eno, Fennesz e Zawinul rilasciano spore semantiche da
64
/ recensioni
Stefano Solventi
Operati i dovuti distinguo di compressione stilistico-temporale, l’effetto è lo stesso.
Quello di ascoltare un disco di Jerry Lee Lewis,
meglio se circondato da ospiti prestigiosi, in pieno
nuovo secolo e con ciò misurare quanto e come il
Pioniere di un genere musicale possa ancora dirsi
al passo coi tempi. Basterebbe in fondo trovare il
Nostro in condizioni dignitose e non ridotto alla
patetica macchietta di se stesso, ma pensateci: c’è
gente che arriva al primo disco ed già suona risaputa, prevedibile, stantia e non importa se fa rock
o hip-hop.
Quindi tocca azzerare tutto e cancellare gli appunti dalla lavagna, ascoltare questo disco come
fosse un album come gli altri. Chi sia Grandmaster Flash (che come ricordava Deborah Harry
in Rapture “is fast”) lo sa chiunque abbia un minimo di infarinatura nel rap e dunque eviteremo di
esibirci in scienza dell’ovvio.
Quel che ci preme semmai sottolineare è come
The Bridge sia - non senza una certa sorpresa - mediamente fresco e godibile, capace di esibire smalto ed equilibrio che difettano a tanti campioni
del crasso e del botteghino. Sarà che il parterre è
più che semplicemente adeguato (citiamo quasi a
caso Q-Tip, Busta Rhymes, KRS-One, Big Daddy
Kane…) e i suoni si adeguano, ma una gommosa e
subliminalmente krauta Bounce Back, il caramello di
Shine All Day e la squadrata però sexy Swagger non
Highlight
Hjaltalín - Sleepdrunk Seasons (Kimi, febbraio 2009)
G enere : chamber pop
Sensibilità pop all’ennesima potenza, chamber e orchestrazioni, apparente facilità delle melodie e leggerezza, con lo
zampino di Benni Hemmm Hemm e Mum: arriva in Europa a inizio 2009 la band che tanto entusiasmo ha suscitato l’anno scorso nella patria Islanda. L’esordio sulla lunga
distanza Sleepdrunk Seasons, che già dal nome (ebbrezza
derivata dalla mancanza prolungata di sonno) evoca facilità e rilassatezza, star bene insieme e piacevolezza, non
smentisce affatto queste caratteristiche. Immaginate una mini orchestra sinfonica che
arriva fino a dieci elementi, aggiungete strumenti non consuetissimi, quali fagotto, tromba, trombone, corno francese e clarinetto, oltre all’usuale armamentario di una band del
genere, immettete canzoni con massime variazioni in tempi e mood, strumentali o cantate a doppia voce, con parti in inglese e islandese, aggiungete un’impetuosità lirica ma
non barocca come i primi Arcade Fire, una facilità alla melodia e una ottima alchimia di
gruppo. Le caratteristiche per creare l’apparente facilità del pop sembrano esserci tutte,
unite a un talento per la composizione, ad opera del leader Hogni Egilsson, vocalmente
un incrocio tra Jónsi dei Sigur Ros, Antony e Jens Lekman. Il risultato è un gioiellino
che unisce una base melodico ritmica beachboysiana con un’orchestrazione variegata,
per mini suite orchestrali (Goodbye July) miste a pop song vere e proprie. L’amore per
Bacharach o Hazelwood così come per la musica colta è palese; ecco poi Lekman e i
Decemberists incontrare le voci e le variegate orchestrazioni degli Steely Dan (Traffic
Music), mentre gli ultimissimi Sigur Ros più pop fanno eco alla sensibilità Antony (The
Boy Next Door), Non sorprende imbattersi anche nel barocco meno melodrammatico
dei canadesi Stars (Debussy, Selur) e nei Belle & Sebastian più malinconici virati Drake
(nell’intensa e melodica The Trees Don’t Like The Smoke). Nonché nel pop eclettico
degli Hidden Cameras. Ed è impossibile da non citare, arrivati a questo punto per gli
Hjaltalín, la complessità di uno come Sufjan Stevens. Se si è già così ben riconoscibili
all’esordio, non dovrebbe essere troppo difficile il proseguimento. (7.2/10)
Teresa Greco
le ascolti ogni giorno; sarà che lo stesso vale per
l’irruenza controllata di Tribute To The Breakdancer,
per il martello esuberante Here Comes My DJ e per
l’oriente immaginato in Those Chix; sarà che le basi
sono per ogni episodio fantasiose ed elastiche, pos-
senti e ingegnose nonostante l’acqua passata sotto
i ponti. Più di tanto al Maestro del Giradischi non
si può a ragion veduta chiedere, pertanto non lo
faremo. Però, che classe. (6.5/10)
Giancarlo Turra
recensioni /
65
Hauschka – Snowflakes & Carwrecks Ep (Fat Cat/Audioglobe, Gennaio 2009)
G enere : chamber music
Ancora una deliziosa offerta da parte del pianista
tedesco – con base a Düsseldorf - Volker Bertelmann, compositore a tutto tondo che ha letteralmente trasposto il suo sapere accademico in contesti
intimamente indie. Un percorso che per certi versi
può rimandarci agli analoghi processi dei Rachel’s
di Music For Egon
Schiele. Volker che
in arte è meglio
conosciuto
come
Hauschka lavora da
sempre sulle ampie
possibilità del piano preparato ed il
nuovo Ep – 7 brani
per quasi 40 minuti
di musica, quasi a rinnegare il formato merceologico- nasce dalle session del precedente Ferndorf,
un album che pur mantenendo la costante ‘minimalista’ introduceva sottili arrangiamenti d’archi
e piccole profezie ritmiche. Un fascino per nulla
snaturato dal nuovo cimento, che anzi si sposta
ancor più con decisione nei meandri della musica
da camera, mantenendo un’ affatto trascurabile
sobrietà. Prossima alle magie di Penguin Cafè Orchestra e del più riflessivo Philip Glass, la musica
di Snowflakes & Carwrecks è puro impressionismo
contemporaneo, delizia auditiva che indica al strada – tutta in discesa – per questo talento germanico, partito in sordina nemmeno 4 anni or sono
con il debutto – Substantial - per la piccola indipendente Karaoke Kalk. (6.9/10)
Luca Collepiccolo
Kieran Hebden & Steve Reid – NYC
(Domino, novembre 2008)
G enere : jazz
Terre di mezzo. New York è stata spesso la città
che ha visto nascere ritmi e melodie creoli, la sede
66
/ recensioni
che ha ospitato germinazioni e inseminazioni tra
generi, a volte a coppie, a volte misti e improvvisi
come una discendenza che si manifesta all’ennesima generazione. La città non può che permeare
il prologo alla recensione di NYC - quarto parto
della coppia formata dal Four Tet Kieran Hebden e dal batterista jazz Steve Reid -, che a sua
volta del resto probabilmente non può fare a meno
di metafore di filiazioni e incroci. Per un motivo
almeno; i precedenti (tre) dischi del combo erano
sì all’incrocio tra le due musiche degli autori, ma
giocavano sul terreno fertile e per certi versi neutro del free jazz, dell’impro, e quindi da un certo
punto di vista erano più sbilanciate verso quello
che dei due fa il jazzista di mestiere. NYC invece cerca altrove; il luogo lo sappiamo dal titolo,
il concetto lo si può desumere senza troppe difficoltà; è quel genere musicale che può indicare un
punto di tangenza neanche così sottile tra Kieran
e Steve; quella cosa che contiene la pulsazione del
funk di fine Settanta (1St & 1St) che a volte si suole
chiamare mutant-disco, peccando di imprecisione
sineddotica; il sibilo dei synth (Arrival); il ritmo fisso
dei crescendo; il groove sintetico e grasso (Lyman
Place). E pensare che una operazione così chirurgica è il prodotto di soli due giorni di registrazione.
Ma non può neanche troppo stupirci la cosa; i due
si sono studiati, prestati entrambi a concessioni e
prove – quasi sempre soddisfacenti, peraltro; e ora
hanno scoperto, guardando verso New York, che a
loro due piace anche fare le stesse cose. Né distanti
o più vicine più all’uno o all’altro; semplicemente
spinti dalla percussività che monta fatta da elettronica e batteria.
E sentite la finale Departure; ritmo, pause e ripartenze che esaltano le due parti in causa e ne fanno
sentire la reciproca necessità; una sincronia di intenzioni di impressionante efficacia; il brano meno
newyorkese forse, quasi continentale, si direbbe
qui in Europa; una specie di jazz-motorik four-tetiano; senza troppi giri di parole, un piccolo capolavoro. (7.2/10)
Gaspare Caliri
Honeychild Coleman - Halo Inside
(Come la luna) (Matteite / Venus,
gennaio 2009)
G enere : cros sover - hop
Inizia come una cuginetta arguta di Erykah
Badu invalvolata della Bjork altezza Enjoy, prosegue concedendosi fregole indie-rock e strali
drum’n’bass, quindi armeggia dense congetture
dub, devozioni post-wave e setosi impasti folk-soul
come se nulla fosse. E’ il debutto solista di Carolyn
“Honeychild” Coleman, versatile artista originaria
del Kentucky ma cresciuta tra spasmi punk e club
culture nel calderone newyorkese (non stupisce
trovare tra le sue frequentazioni i cari Tv On The
Radio), dove ha fatto la busker nella metropolitana e la dj, ha dato vita ad una band “afropunk”,
ha strapazzato allucinazioni videoartistiche e organizzato festival, finché non ha incontrato Matteo Dainese, già batterista per Ulan Bator, ed è
una specie di colpo di fulmine artistico.
Il nome della Coleman compare tra i credits di
Feed the Dog (Matteite / Venus, 16 febbraio
2007), album di debutto di Dejlight, band allestita
da Dainese col bassista dei Tre Allegri Ragazzi
Morti Enrico Molteni. Assieme a Matteo Carolyn
abbozza l’ipotesi di questo Halo Inside, che vede
oggi finalmente la luce. Album che come dicevamo
esplora le sfaccettature espressive della ragazza col
turgore e la flemma di chi la grinta l’ha smerigliata
in prima linea e sa bene come ci si muove a cavallo
tra underground e popular. Buona anzi buonissima
la prima: grazie ad una scrittura capace di esplorare con sagacia e disinvoltura le forme in gioco, ad
una produzione (dell’italianissimo Max Stirner, al
secolo Emanuele Fusaroli) che bilancia preziosismi
e misura, ad un variopinto parterre di ospiti che
porta in dote magia senza invadere la scena (oltre
a Dainese, ci sono tra gli altri The Mad Professor nella fragranza dub di Your Idea Of Time, un
ottimo Jim “Natureboy” Kelly nella palpitante
Never Goin’ Home Again e Robyn Gutthrie nientemeno nell’etera December).
Ma l’ingrediente segreto che tutto avvalora è il pi-
glio di Honeychild, ovvero la sua voce e il modo
in cui la usa per rilasciare un’idea costante di soul
stemperato, smorzato, in agguato tra suggestioni estrose e astruse, siano il funk-jazz torvo à la
Morphine di Torch Song, sia il folk-psych ombroso
della stupenda Molassess, sia la pop-wave trafelata
e sognante di Inside, sia soprattutto la techno-funk
evoluta di Headlock.
Divertente, intrigante, insidioso: un esordio notevole. (7.4/10)
Stefano Solventi
Hot Chip With Robert Wyatt and
Geese – Self Titled (Parlophone
Records, febbraio 2009)
G enere : remix ep
Operazioni del genere, nella maggior parte dei
casi, le si riserva e consiglia - vedi ad esempio il
nuovo 5 track degli of Montreal – ai fan di stretta osservanza, ma
il novello extended
play accreditato a
Hot Chip, Robert
Wyatt e Geese esula
l’assunto. Made In
The Dark, l’ultimo
e indovinato disco
degli Hot Chip, ritoccato in quattro
dei suoi episodi migliori per mano del sempreverde ex Soft Machine e dalla coppia, al secolo
Emma Smith e Vince Sipprell, nota per i servigi
in seno all’Elysian Quartet. L’uomo di Canterbury
impreziosisce, con un cantato ai margini e qualche
orpello di giustezza, la ballad Made In The Dark per
poi intervenire in modo voluminoso nella successiva - già molto wyatt-iana di suo - Whistle For Will
decorandola di un piano elettrico e di una voce, la
sua, che non smetterà mai di emozionare. Il duo
Geese interviene in corso d’opera convertendo,
ancora con Wyatt presente, We’re Looking For A Lot
Of Love in salsa cameristica e privando One Pure
Thought dell’originaria patina dance a favore di un
recensioni /
67
appeal avant-pop decisamente più accattivante.
Per i quanti lo trovassero difficile da reperire (è
stampato in edizione limitata), sul sito degli Hot
Chip è possibile scaricare gratuitamente le tracce
Made In The Dark e We’re Looking For A Lot Of
Love.
Quando si dice “non avere attenuanti”. (7.5/10)
Gianni Avella
Hot Gossip – You Look Faster When
You’re Young (Ghost / Audioglobe,
marzo 2009)
G enere : I ndie rock
Gli italiani non lo fanno necessariamente meglio,
nella fattispecie il rock; ma ogni tanto riescono a
pareggiare se non a superare tanti colleghi della
stessa nicchia: è il caso di questo gruppo milanese che, con un nome azzeccato da next big thing
–apprezzato infatti anche all’estero- e uno stile che
pesca nei classici modelli di questi anni (Devo, in
questo caso, e altra rock-wave assortita), riesce a
tenersi lontano da furberie e facilonerie di tanti
“eroi” (per un giorno, o poco più) d’oltremanica.
Merito di una grinta che, abbandonati certi furori punk e certe ingenuità del precedente Angles
(2006), viene incanalata nel tocco, nel piglio con
cui la band affronta ed esegue i suoi pezzi, dando
loro quel quid grazie al quale riescono ad usare
in maniera intelligente anche qualche fronzolo
abusato e a inventarne di tali da vivacizzare anche
quelle canzoni apparentemente prive di melodie
o ritornelli memorabili o che indulgono troppo al
già sentito.
Più che il materiale in sé, efficace comunque nelle
iniziali Everybody Else e And Again, nel vaudeville di You Better Know e soprattutto negli ammiccamenti Stones-AC/DC della cavalcata Cops
With Telephones, è proprio questo tipo di approccio, questa baldanza mentre si ritirano dal troppo
ovvio -oltre a una maggiore coerenza e focalizzazione stilistica- che alza questo disco un po’ al di
sopra della media odierna e che fa ben sperare per
i loro concerti.
68
/ recensioni
E peccato che non abbiano sviluppato ulteriormente You Name It: finisce, un po’ come il disco,
come se avessero staccato la spina. (6.7/10).
Giulio Pa s quali
Humcrush – Rest At Worlds End
(Rune Grammofon, dicembre 2008)
G enere : jazz / elettronica
Del batterista Thomas Strønen, legato alla scena
avant-jazz norvegese, ci è capitato di parlare recentemente a proposito
dell’ultima uscita
della sua band principale, i Food. Per
avere notizie su Stale Storløkken, guardare, invece, nel
dizionario della musica scandinava, alla
voce Supersilent.
Un duo ben rodato, con all’attivo, prima di questo
Rest At The Worlds End, già due dischi, entrambi
pubblicati dalla Rune Grammofon. A distanza di
due anni dall’ultimo Hornswoggle e di quattro
dagli esordi, la batteria free di Strønen ritorna ad
incontrare le tastiere di Storløkken, in un binomio
timbrico piuttosto inedito. Nel caso dell’album in
questione, si tratta di una raccolta di registrazioni
dal vivo in giro per la Norvegia, improvvisazioni
mai pubblicate prima e decisamente diverse l’una
dall’altra. I suoni delle tastiere forniscono alla musica un elemento inconfondibilmente electro, cui
il drumming si associa, in alcuni casi macinando
groove tra il jazz e la fusion (Edingruv; Rest At Worlds
End), in altri liberando il ritmo e creando imprevedibili impasti sonori con l’altro strumento (Audio Hydraulic; Creak), impazzendo letteralmente nei
conati spastici di Bullfight. Se queste vibrazioni si
rilassano, possono sfociare nell’ambient di Airport o
nel prog di Solar Sail, in cui le tastiere compiono un
tuffo nel passato di almeno quarant’ anni. La creatività dei due, quando riescono (quasi sempre, in
realtà) a combinarsi, dimostra di valere per quat-
tro, facendo dimenticare completamente la mancanza di un supporto ritmico aggiuntivo: ascoltare
la conclusiva Hit per credere. Conclusiva per il cd,
poichè la versione in doppio vinile contiene addirittura sette brani in più. Un’altra conferma, l’ennesima, dell’ottimo stato di salute di cui gode la
scena avant norvegese, sia in qualità che in quantità. (7.2/10)
Daniele Follero
Il Pan del Diavolo - Il Pan del Diavolo EP (800A Rec / Malintenti, dicembre 2008)
G enere : folk , blues , rockabilly
Se è vero che il blues è il “pan del diavolo”, questo duo palermitano lo mastica che è un piacere.
Non solo: lo metabolizza, lo trasforma in un ibrido
a base principalmente di folk (l’assetto acustico –
chitarre, grancassa, sonaglio - è imperativo) e di
vita vissuta, fatta di disgrazie quotidiane affrontate con irriverente sberleffo e parodistica, ironica
disperazione. Genuinità, spontaneità e freschezza sono le armi più affilate dell’arsenale di Pietro
Alessandro Alasi e Gianluca Bartolo: una formula personale che si riversa prepotente ed esplode
fragorosa nelle quattro tracce di questo dischetto
d’esordio, pubblicazione #1 della neonata 800A
Records, affiliata con quella Malintenti già dietro le interessanti uscite di Don Settimo e Toti
Poeta. Come nel caso di quei dischi, parlare di
“segnali positivi provenienti dalla Sicilia” è semplicemente riduttivo: questa è musica che guarda
ben aldilà dello Stretto, pur cibandosi di sensazioni, attitudini, istinti fieramente locali. Vengono in
mente tanto i Violent Femmes quanto il miglior
Bennato, oltre al quasi ovvio Rino Gaetano (riferimento obbligato per la visionarietà dei testi, fra
piante cresciute dal ginocchio, volti cancellati con
le mani e così via); il tutto caratterizzato da una
vocalità sopra le righe che galleggia fra toni rock
blues quasi urbani (Coltiverò l’ortica, complice la
mano del produttore Fabio Rizzo, già in Waines
e Second Grace, altre due formazioni in espan-
sione libera dal capoluogo siciliano) e rockabilly
forsennati (I fiori, Stile roberto il maledetto), pestati al
ritmo di una festa di paese.
In attesa di una conferma sulla lunga distanza
consigliamo di tenerli d’occhio, perché quel poco
che queste canzoni promettono varrebbe già tutta
l’attenzione di solito riservata ad altri act indie nostrani più in vista – a nostro avviso, da qui si possono sviluppare gli anticorpi contro la depressione
da “anni zero” di Vasco Brondi e delle sue Luci
della centrale elettrica; perché per scacciare
via il blues - chase the blues away, come diceva Tim
Buckley -, in fondo, non c’é niente di meglio di
una sonora pernacchia. (7.2/10)
Antonio Puglia
James Yuill – Turning Down Water
For Air (Moshi Moshi / Self, 6 febbraio 2009)
G enere : folktronica
La generazione glitch-pop dei primi anni duemila
in certi territori si è poi tramutata in folktronica,
ossia quel flirtare di bleeps e beat prodotti dal laptop di turno con una chitarra acustica e una voce
melodiosa e rattristita quanto basta. Col senno di
poi, viene da ridere a pensare che intere generazioni di geek musicali abbiano preso quel Give
Up dei Postal Service
totalmente
come monito nonostante siano passati
sei anni e di acqua
sotto i ponti ne sia
scorsa parecchia. A
scanso d’equivoci,
essendo la formula
del genere arrivata da tempo al ripetere se stessa nei modi e nell’espressione, l’unico arbitro della situazione è la compattezza della scrittura e la
presenza di singoli episodi che facciano da traino
all’intero disco. James fa il suo lavoro con passione
e colleziona un buon numero di canzoni riuscite,
dove l’intersecarsi dei soliti ingredienti in gioco
recensioni /
69
provoca un fluire dell’ascolto molto piacevole (l’hit
da dancefloor alternativo No Pins Allowed, la malinconia gocciolante di Left Handed Girl, la ballatona
commovente This Sweet Love e la lezione Morr Music di No Surprise), che però tende alla lunga a mostrare il fianco quando gli stilemi diventano un limite da ricalcare senza troppa fantasia. Quindi un
po’ Maximilian Hecker, un po’ Tunng, un po’
tanto Gibbard + Tamborello, il difetto principale
di certe produzioni seppur supportate da un buon
numero di pezzi sopra la media è il fatto di non
spostarsi di un millimetro da territori già esplorati
appieno, stemperando l’entusiasmo appena sopra
la sufficienza. Il talento si avverte, manca solo un
po’ di coraggio. (6.1/10)
Alessandro Grassi
Jocelyn Pulsar - Penso a Sonia ma
suono per la gloria (Agos Music 2009)
G enere : lo - fi / pop
Siamo al quarto disco dal 2004 per i Jocelyn Pulsar, il repertorio comincia a farsi significativo, roba
da fare i conti con una certa maturità. Invece, loro,
niente: stanno lì a palleggiare lo stesso disincanto
ad alzo zero di sempre, indie a bassa fedeltà con
l’ovosodo in gola e quel prurito al basso ventre subito smorzato da uno spleen frugale, di quelli che
al tempo del telefono fisso finivi per scrivere sulla
paginetta del diario e oggi ti tocca dare in pasto ai
social network e ai telefoni cellulari. L’ingrediente
principale del loro songwriting è una sorta di rammarico stupefatto per lo scarto insanabile dall’immaginario degli ottanta, divorato dall’evoluzione
mediatica che significa anche profonda mutazione
esistenziale. Personaggi e situazioni dell’altro ieri dal portiere che parava senza mani al whiskey che
invecchiava sette anni e non c’erano cazzi, dalla
grande festa al mobilificio al giocatore di basket
sovradimensionato a fine corsa, dal maggiordomo
spacciatore di delizie all’incredibile forno autopulente - talmente obsoleti da sembrare di un altro
pianeta, provocando una pellicola di disarmo at70
/ recensioni
traverso cui possiamo osservare i tormenti inconfessati del campione di calcetto, la boria sotto vuoto
spinto del critico musicale di lungo corso, oppure
il melodramma minimale di chi ama malgrado la
sindrome influenzale. Ballate che ciondolano tra
l’acustico e il sintetico concedendosi talora un’elettricità bonaria, capaci sì di appiccicarsi alle orecchie
ma non abbastanza
da arrivarti al cuore. Questo il difetto
principale del quartetto romagnolo: la
poetica del pensiero
debole conduce ad una debolezza espressiva oserei
dire fisiologica. Un’impostazione rispettabile e ci
mancherebbe, però si condannano da soli a fare i
nipotini sfigati dei Pavement vita natural durante. Mi aspetterei - mi augurerei - da parte loro un
guizzo stilistico verso l’alto, un sussulto d’ambizione. D’altronde, per dipingere una parete grande ci
vuole un pennello grande. O era un grande pennello? Boh. (6.2/10)
Stefano Solventi
Kid606 – Die Soundboy Die EP (Very
Friendly, dicembre 2008)
G enere : deep techno
Più che mai attuale questo EP lungo per uno degli
assi della techno deviata come il ragazzo Kid606.
La proposta si situa infatti nel labile confine tra
le esperienze dei maghi Warp prima maniera, le
atmosfere belgiche che stanno rivivendo nelle avventure di Mr Oizo e inevitabilmente il dubstep.
Come a dire: techno. Come a dire: nord Europa
e raving. Ascoltate ad esempio l’acidità di una
traccia come Loose Noose e sentirete gli echi degli
esordi Chemical Brothers, proseguite poi con Get
In The Way e ditemi se non c’è tutto il clubbing dei
90, con quegli effetti che fanno ancora una volta
’House Nation’ un motto per cui morire col sorriso
plastificato in faccia. Non solo club comunque: You
Can’t Stop A Stepper è l’accenno al dubstep virato
reggae, Bat Manners ripercorre le orme della ambient di gente come Pole e Gas e per finire Death
Is Pain Leaving The Body è un brivido nero che scuote come il soul-grime di Burial. Tre quarti d’ora
che ci ricordano come alcuni vecchi maestri siano
ancora capaci di dire la loro e di come l’eterogeneità sia ormai d’obbligo. Ben fatto, Kid. Ora ci
vuole l’album.(7.0/10)
marco braggion
La Otracina – Blood Moon Riders
(Holy Mountain, gennaio 2009)
G enere : heavy psichedelia
Ultimo parto, temporalmente parlando, in casa La
Otracina con Ninni Morgia in formazione. Dopo
qualche interlocutorio passaggio minore – meglio
il cd-r Crystal Wizards From The Cosmic Weird uscito per Sky-fi con ancora la chitarra del siciliano,
che il “casalingo” The Risk Of Gravitation per Color
Sounds – esce ora in solo vinile per Holy Mountain
questo 5 pezzi che si pone in scia all’ottimo Tonal
Ellipse Of The One. Non per sembrare patriottici, ma lo scarto essenziale rispetto alle nuove cose
pubblicate dal gruppo – virate verso un versante
più metallico e francamente troppo pacchiano –
sembra risiedere proprio nelle volute chitarristiche
di Morgia. Un suonato in grado di trainare il suono
pachidermico e lieve allo stesso tempo del terzetto,
di farlo proprio, di dettare tempi ed evoluzioni in
maniera anche netta (certe aperture hard-prog di
Inner Mind Journey così come i deliqui mantrici di
Ballad Of The Hot Ghost Mama Pt.1) ma mai banale. Non da meno gli altri due vertici del triangolo
newyorchese, qui ognuno al rispettivo zenith: il
bassista Evan Sobel (anche al piano elettrico) e il
batterista/fondatore Adam Kriney non sono comprimari. Ma anzi, i supporter perfetti per il lavorio
della chitarra, col loro affiatamento e soprattutto
con l’estrema duttilità: che si tratti di accendere il
motorik o di contrappuntare i frammenti chitarristici, i due rispondono sempre presente. Il risultato perciò non può che essere un frullatore di rock
acidissimo, psichedelia krauta corrosiva, jam da
Velvet selvaggi, attitudine free, incubi jodorowskyani, evanescenze spacey e tanto altro ancora che
si avvicina ai picchi toccati da Tonal…. La qual
cosa ci fa avvertire ancor di più, come una nube
minacciosa, le dimissioni di Morgia. (7.0/10)
Stefano Pifferi
Lars Horntveth – Kaleidoscopic
(Smalltown Supersound / Family Affair, gennaio 2009)
G enere : contemporanea
Lo si era intuito dal debutto Pooka che Lars Horntveth è personaggio che ama mettersi in gioco.
Kaleidoscopic è una mossa importante, imponente, per mole e giro di vite implicato. La Latvian
Symphony Orchestra al completo (quarantuno
elementi suddivisi tra archi, percussioni, clarinetto, flauto, trombone e arpa) diretta dal norvegese
Terje Mikkelsen e impreziosita dallo stesso Horntveth al piano, fiati e clarinetto. Il canovaccio che
ne viene - una suite di trentasette minuti ispirata,
a detta del suo artefice, a Jim O’Rourke, Robert
Wyatt, Stereolab, Dave Brubeck, Joanna Newson,
Bernanrd Herrmann e l’arrangiatore di archi di
Gainsbourg Jean-Claude Vannier – somiglia ad
una versione high tech di Steve Reich persosi in
un vaudeville venusiano. Lo scorrere dei minuti,
ripresi live in una piccola chiesa di Riga, dal decimo primo in avanti si leva nel suo essere policromo alternandosi in incisi cinematici e leggiadrie
da musical post moderno che, secondo i dettami
dell’autore, variano in funzione dell’umore. In
progress insomma. Immaginifico. A suo modo un
genio, Lars Horntveth rischia seriamente di candidarsi a novello Simon Jeffes. Obbligatorio tenerlo
d’occhio. (7.0/10)
Gianni Avella
Leadfinger – Rich Kids (Bang! Records, 2008)
G enere : rock mainstream
A qualcuno che se ne intende un po’ del panorama
recensioni /
71
pop-rock australiano nomi come Yes Men, Asteroid B612 e Brother Brick può darsi che dicano qualcosa. Così come il
nome di Stewart “leadfinger” Cunningham, chitarrista delle suddette band,
che stavolta si è messo “in
proprio”, dando vita ad
un trio a sua immagine e
somiglianza (e nome), accompagnato dal bassista Wayne Stockes e Stephen
O’Brien alla batteria. Le sedicenti premesse potrebbero anche essere allettanti. Influenze “dichiarate”: MC5, Stooges, Radio Birdman. Risultato: un misto tra il southern rock, i Soul Asylum
e gli U2 più recenti. Non riusciamo veramente a
trovare più felice paragone con un rock decisamente rivolto al mainstream, dagli spigoli limati e
il ritornello facile e scontato, reso leggermente più
maschio da qualche timida distorsione. Speriamo
proprio non sia questo, come qualcuno dice, il
“vero” Sydney r’n’r. (5.0/10)
Daniele Follero
Loney, Dear – Dear John (Polyvinyl,
gennaio 2009)
G enere : indie pop
Gli svedesi Loney, Dear giungono con Dear John al
traguardo del terzo album. Si registra il raggiungimento di una maggiore maturità stilistica, specialmente nello svilupparsi dell’impianto strumentale –
sempre più stratificato e curato da campioni e suoni
elettronici -, e di una più intensa introspezione della
loro idea di pop. Infatti, essa si fa ancor più leggiadra e malinconica concedendo più spazio alla riflessione. Ciò rappresenta simultaneamente un merito
e un difetto: perché sì, le canzoni ora guadagnano
in profondità emotiva, ma finiscono per stancare a
un ascolto intero dell’album. Esclusione fatta per
il buon “tiro” dell’apripista Airport Surroundings,
di Everything Turns To You e di Summers, il resto dell’album si muove su più quiete e distese suite
musicali, ora intensificandone la drammatizzazio72
/ recensioni
ne con ricercate orchestrazioni, ora dilatandole con
eteree sospensioni sonore. Come se i Grandaddy
flirtassero con i Radiohead di Exit Music (For A
Film), tanto per rendere l’idea: su tutte Under A
Silent Sea, ballad lunare che si particolarizza con
aggiunta di vocoder e innesti faithlessiani a contrappuntare, e Harm, costruita sul celebre e dolente
Adagio di Albinoni. Singolarmente, ogni episodio
piace e persuade ma è la loro concatenazione a non
convincere a pieno. Qualche più sbarazzino intermezzo avrebbe sicuramente giovato al risultato finale. Ma, nonostante ciò, Dear John è album coraggioso da considerarsi, comunque, un passo in avanti
e innovativo nel loro percorso artistico. (6.8/10)
Andrea Provinciali
The Lucksmiths - First Frost (Fortuna Pop!, febbraio 2009)
G enere : indie pop
Ci sono gruppi che immancabilmente portano a
riflettere su quanto un certo pop degli ’80 continui
tuttora ad essere seminale nell’indie pop odierno.
Ecco allora che le storie drammatiche e le melodie
degli Smiths, la musicalità dei Go-Betweens e
della Sarah Records tutta affiorano di tanto in
tanto, e quando i riferimenti sia pur così espliciti
sono ben amalgamati e resi intimamente propri,
ecco allora il gruppo che fa la differenza. È giusto il caso degli australiani The Lucksmiths, sulle scene da ormai ben più di 15 anni e cult band
tra gli appassionati del genere.First Frost non fa
eccezione alla regola; vi si ritrovano infatti con
equilibrio perfetto gli ingredienti adatti all’occasione: il giusto amalgama tra melodie e malinconia suadente, il chitarrismo, la liricità, le storie
sull’ordinarietà e la problematicità dell’everyday life
e le liriche, accluse al libretto della bella edizione
cartonata del CD, impetuose e intense che senza
clamore esprimono il malessere “adolescenziale”
in senso lato così caro alla band. Così si procede
tra ballad smithsiane (Up With The Sun, South-East
Coastal Rendezvous), chitarrismo Aztec Camera
e Housemartins (Good Light, Never And Always),
Highlight
Mi Ami – Watersports (Quarterstick, febbraio 2009)
G enere : post - dub - tribal - punk
Avevamo visto giusto incensandoli dopo la manciata di
minuti racchiusa nel 12” d’esordio African Rhythms.
Non che questo sia merito nostro, anzi, tutt’altro. Il merito va tutto a Daniel Martin-McCormick (chitarra, voce),
Jacob Long (basso) e Damon Palermo (batteria), al secolo Mi Ami. Un passato targato Dischord quando si chiamavano Black Eyes e spaccavano cuori ed orecchie a
suon di epilessie no-(p-funk)-wave; un futuro lucente, se
continueranno a mantenere le promesse come in questo
Watersports. Sì, perché nei suoi 7 pezzi prendono corpo in maniera più compiuta
quelle dichiarazioni d’intenti presenti nel 12”: tensione post-punk e instabilità emotiva,
sfaccettato tribalismo terzomondista e dissonanze noise, isterismi vocali e dilagante attitudine dance-dub. È il senso di equilibrio, di perfetto incastro, di vicendevole supporto
tra le varie forme musicali masticate dai tre a stupire, fornendo la chiave di volta per la
comprensione di una musica matura ben oltre la relativamente giovane età del progetto.
Gli 8 minuti dell’opener Echononecho stanno lì a dimostrarcelo: un suono nero talmente
smostrato dai bianchi da venirne quasi rinvigorito. In ogni suo elemento, in ogni sua
componente. Le frecce nell’arco di Watersports sono tante e varie. Riduzionismo dub e
suggestioni da jazz libero dei sessanta, disco-music mutante e manipolazione dei ritmi,
apnee strumentali e continue camere di decompressione. Il bello è che quelle frecce colpiscono sempre il bersaglio. (7.5/10)
Stefano Pifferi
languori Go Betweens (Song Of The Undersea), fiati
e puro B&S (The National Mitten Registry), l’afflato
dei migliori Style Council melodici con moderazione (Pines). In fondo il segreto ben custodito
di questa musica è nel suo rimanere sottotraccia,
leggera ma significativa per chi coglie l’essenza.
(7.2/10)
Teresa Greco
M. Ward – Hold Time (4 AD, 17 febbraio 2009)
G enere : retro folk pop
Non ci voleva certo la recente uscita a nome She
& Him (Volume 1, in coppia con l’attrice Zooey
Deschanel) perché ci accorgessimo del talento di
M. Ward, né ci stupisce, in fondo, che in America il suo sia diventato uno dei nomi più cool da
mettersi in bocca quando si parla di alt-folk (o giù
di lì), al pari dei suoi vecchi compari Bright Eyes
e My Morning Jacket. E’ un nuovo establishment
musicale che, in un certo senso, si sta creando, se
pensiamo che Jim James e i suoi ormai si esibiscono a Las Vegas e che Conor Oberst è una star sdoganata già dai tempi del famigerato tour Vote For
Change. Ed è una cosa assolutamente sacrosanta,
perché Ward è e resta musicista, compositore ed
recensioni /
73
arrangiatore di prima classe, e al bando tutti i giri
di parole. E’ quello che ti ritrovi a pensare quando
stringi tra le mani questo Hold Time, che sin dal
titolo, come l’acclamato Post-War, gioca su certe
inevitabili tendenze retrò da sempre
presenti nella sua
musica; pre-war e old
time music non si possono certo sradicare dal suo dna, ma
adesso ci si è messo
in mezzo anche il
pop dei ’60, e allora
non ce n’è per nessuno. Il punto di partenza in
quella direzione erano già le canzoni del disco con
la Deschanel (peraltro, la ritroviamo come discreta
presenza in un paio di episodi), ma qui è la sostanza ad essere diversa. La densa pasta spectoriana in
cui si diverte a immergere melodie degne di Brian
Wilson, o meglio ancora del suo idolo dichiarato
Daniel Johnston, è qualcosa di più che un mero
esercizio di stile; l’affascinante veste sonora vintage non copre, anzi risalta una scrittura sempre più
ferma e forse mai così pop come adesso (For Beginners, Star Of Leo, To Save Me, insieme all’ex Grandaddy Jason Lytle). Altrove aleggia lo spettro dei
Big Star più disperati virati Scott Walker (la title
track), bilanciati dal treno in corsa rockabilly Johnny Cash di Fisher Of Men. Poi beh, ci sono le
solite fascinazioni legnose alla John Fahey (ShangriLa), c’è l’eccellente cover che conferma la sapienza del sarto (un’ombrosa Oh Lonesome Me di Don
Gibson ricalcata dalla versione di Neil Young, con
la voce da reduce di Lucinda Williams a rendere il tutto ancor più indimenticabile); e se non
bastasse, sui titoli di coda c’è pure la zampata finale: l’Outro, una malinconica chitarra twang su un
tappeto orchestrale che nemmeno il Jack Nitzsche
più celestiale e irraggiungibile. L’avrete già capito,
saranno in molti a dire che questo è il miglior disco che M. Ward abbia pubblicato sinora (lo si era
detto per Post-War, d’altronde). Oltre a covare il
74
/ recensioni
legittimo dubbio che ciò sia effettivamente vero, ci
viene anche da pensare che la sua produzione, se
si manterrà su tale livello, sarà difficile da battere
per altri anni ancora. (7.7/10)
Antonio Puglia
Marissa Nadler – Little Hells (Kemado, 3 marzo 2009)
G enere : folk - pop ball ads
Definire il nuovo disco di Marissa Nadler è lavoro
assai arduo per chi ne aveva cristallizzato l’immagine da sirena delle isole Aran destata dai rintocchi
delle campane di The Saga Of Mayflower May.
Una voce che figurava come l’ultimo degli echi di
Cathy Berberian e una capacità di scrivere ballad folk che incantava al primo ascolto. A due anni
di distanza da Song III: Bird On The Water, la
Giunone di Boston fa il salto verso un altrove che
mai ci saremmo aspettati. Saranno stati gli ascolti
giovanili di Throwing Muses e Mazzy Star o
la voglia di sdoganarsi dalla nicchia o ancora la
curiosità di guardare alla propria musica con occhi nuovi, perché la triade iniziata con Ballads of
Living & Dying non avrebbe potuto perpetuarsi
all’infinito. Da queste parti però ci si attendeva un
salto di qualità sulla via buona, quella che, in almeno un paio di episodi, Little Hells sembra imboccare: Heart Paper Lover e Loner, dove la presenza
degli ospiti Farmer Dave Scher (Jenny Lewis,
Beachwood Sparks) ad organo, synth e piano e
Myles Baer (Black Hole Infinity) alle chitarre
assicura un morbida transizione dagli Appalachi
alle atmosfere dreamy e sintetiche di ascendenza
4AD. Il seguito viaggia disomogeneo alla ricerca
di involucri pop, esauditi di volta in volta in un’alchimia Sandoval-Roback (Rosary) ed incubi alla
Blonde Redhead che affaticano l’ascolto nonostante l’ammaliante scrittura (Mary Come Alive). E’
che qui una volta era tutta campagna, e probabilmente la sontuosa produzione di Chris Coady,
già all’opera con i Blonde Redhead, a tratti ha
prevalso sullo stile di Marissa. D’altro canto la parte centrale del disco rimane ancorata al passato più
che mai (Little Hells, Brittle, Crushed And Torn). Senz’
altro un’opera di transizione, che non tralascia di
nascondere tesori tra le pieghe di un’inaspettata
veste pre-mainstream. Da segnalare la presenza di
Simone Pace dei Blonde Redhead alla batteria. (7.3/10)
Francesca Marongiu
Massimo Falascone – Works
05-007-2008 (Setola di Maiale, dicembre 2008)
G enere : impro - jazz
Con colpevole ritardo torniamo su un interessante
lavoro che sarebbe stato un peccato lasciar giacere
nel dimenticatoio. Un disco di grande spessore e
maturità, quello imbastito da Massimo Falascone,
sassofonista e sound artist di stanza a Milano. In
Works 05-007-2008 l’artista italiano colleziona
lavori sparsi – lavori in proprio, collaborazioni a
distanza geograficamente e temporalmente, musiche per piece teatrali, ecc. – tanto eterogenei che il
titolo dell’album avrebbe potuto tranquillamente
fregiarsi del prefisso patch…. A far da contraltare, oltre che da collante, a tanta frammentazione
c’è però l’omogeneità della cura dei suoni e della
ricerca di Falascone, che unita all’ottima qualità
media degli 8 pezzi, rende questo collected works
un disco immancabile per chi si occupi del versante più impro del jazz. Perché Falascone unisce elementi apparentemente distanti – il caldo del suo
strumento e il freddo dei loop – con convinzione e
gioia, senza seriose verbosità ma piuttosto con una
grossa carica auto-ironica.
Per tutti valgano i 7 minuti dell’iniziale Ottovolante.
Vero e proprio bignami del modus operandi di Falascone e del suo intendere il lavoro di ricerca sui
suoni e sulle possibilità delle interazioni con fonti
e personalità altre, Ottovolante rielabora una composizione di 8 minuti dell’americano Bob Marsh
tramite cut-up invasivo, aggiunte di plug-ins,
bassi e immancabili contrappunti di sax. Ottimo
(7.0/10)
Stefano Pifferi
Monno – Ghosts (Conspiracy, gennaio 2009)
G enere : D rone /S ludge
Non basta imbeccare buoni riff e trascinarli oltre
i 10 minuti per fare un buon disco. Ed è questo il
motivo per cui a volte dischi di questo genere vanno poco oltre la noia. I Monno (duo che maneggia
laptop, basso batteria e sax) per esempio, si sono
spinti molto oltre.
In Ghosts ci mostrano che è possibile scavalcare
il suono caratteristico del drone/sludge, quei bassi
riff che costituiscono il corpo massiccio del genere, senza abbandonarne i territori densi e neri. I
Monno sembra asportino chirurgicamente quella
precisa porzione di spettro delle frequenze, delimitandone i contorni con telluriche
vibrazioni al limite
dell’udibile e graffianti suoni sintetici
e di sax ultraprocessato. Quel che resta
è una pesante mancanza, e una sensazione di vertigine di
fronte alle enormi bolle di vuoto che restano. Forse
i fantasmi a cui si riferisce il titolo. La prima traccia, Negative Horizon, prepara il terreno. Introdotta
da innaturali cori si mantiene su un lento incedere di basso e batteria, poggiandosi interamente su
un cupo accordo immutato per tutta la durata del
pezzo. Ma è dal suono del successivo Troye che crolla l’intero costrutto del drone. Riferimenti forse se
ne trovano nei Today Is The Day più recenti,
ma in questo caso l’effetto è decisamente più devastante. Quella che nella band di Steve Austin è soltanto una strana equalizzazione, qui è un attacco,
dall’interno, ai codici del genere. Merule continua
lungo la stessa linea ma concedendosi un introduzione quasi jazz. Ormai il danno è stato fatto, e se
in Hull si sale a velocità più tipiche di Naked City
o Zu, nell’ultima Endfall si continua a giocare con
opposti, costruendo abissi e disgragando macigni.
recensioni /
75
Sicuramente è solo un obiettivo di settore, ma in
Ghosts i Monno segnano un nuovo traguardo in
un genere dove il rischio di finire nel “già sentito”
è sempre molto alto. (7.3/10)
Mt. St. Helens Vietnam Band - Self
Titled (Dead Oceans / Goodfellas,
febbraio 2009)
G enere : indie emo
Leonardo Amico
Nella nostra era di download selvaggio la paura di
imbattersi nel nuovo DCFC fake è sempre in agguato. E questa si fa
quasi concreta non
appena si ascoltano
le prime due canzoni del nuovo album,
il nono nella sua
carriera solistica, di
Morrissey. Ovviamente è una provocazione, perché impossibile emulare così bene le corde vocali di uno
dei più grandi cantori pop. Ciò, però, va inevitabilmente a discapito del Nostro: la prima sensazione
che scaturisce all’ascolto di Something Is Squeezing
My Skull e Mama Lay Softly On The Riverbed è
quella di trovarsi dinnanzi una band emocore (da
intendersi nell’accezione più nobile del genere) che
ben scimmiotta gli Smiths. Menomale che Years Of
Refusal non è tutto cosi, alcuni brani (la malinconica I’m Throwing My Arms Around Paris e la più
sbarazzina When Last I Spoke To Carol) si rivelano
ben riusciti e con un trainante impatto melodico,
questo sì contraddistintivo di Morrissey, mentre le
due ballad (It’s Not Your Birthday Anymore e You
Were Good In Your Time) riescono finalmente a
rendere al meglio le sue capacità compositive. Ma
nell’insieme, purtroppo, si avverte una certa sua volontà di mostrarsi fresco e giovane, quando noi invece l’avremmo preferito stagionato e maturo. Un
rilevante ma non compromettente passo indietro
rispetto ai suoi ultimi due lavori. (6.2/10)
Di questi tempi basta poco perché un nome divenga
chiacchierato: da più parti si indica infatti il Monte Sant’Elena come futuro e assai plausibile santino
indie, in ragione di un suono debitore - in parti disuguali - a At The Drive In, Modest Mouse e
Cursive. Senza tuttavia padroneggiare l’arguzia, la
scioltezza e il senso per la confidenzialità di costoro
ed è facile capire i motivi: ridi e scherza siamo arrivati al 2009, “emo” è diventata una parolaccia o - nella
migliore (?) delle ipotesi - un’imbarazzante casella di
marketing giovanilista in cui si è infilata gentaglia esecrabile come 30 Seconds To Mars o Chemical
Romance. Non è colpa di questo quintetto proveniente da Seattle, qui all’esordio lungo dopo un e.p.
di riscaldamento; il problema pertiene all’attingere
da una vena inaridita, che di uno stile può restituire solamente la parvenza esteriore. Le motivazioni
originarie sono svanite e chi all’epoca non c’era non
le può ricreare dall’ascolto dei dischi. Di conseguenza, il suono angolare ma tortuosamente pop dei Mt.
St. Helens ecc. si racconta per lo più un ridondante
teatro di buone intenzioni e padronanza esecutiva,
nel quale la spontaneità soccombe ai cambi di tempo
e atmosfera. Nell’alternanza sin troppo studiata dei
quali il gruppo non impressiona granché e persino
irrita con la pompa magna anni ’70 di Little Red Shoes,
En Fuego e Albatross, Albatross, Albatross. Meglio allora
rivolgersi ad Anchors Dropped, filastrocca prossima agli
Xtc, e all’imbrigliata dolcezza quasi soul di A Year Or
Two per fare chiarezza. Le carte restano comunque
nebulose fino alla fine, allorché i sette minuti di On
The Collar - sensazionale scintillio da qualche parte
tra Forever Changes, Skylarking e Tones Of Town - inducono all’applauso a scena aperta. E’ su tali percorsi
la formazione americana dovrebbe investire il proprio talento ancora in embrione, più che cercare di
compiacere l’ortodossia nerd che fa capo a Pitchfork e
dintorni. Speriamo. (6.5/10)
Andrea Provinciali
Giancarlo Turra
Morrissey – Years Of Refusal (Decca
/ Universal, febbraio 2009)
G enere : pop rock
76
/ recensioni
My Morning Jacket - iTunes Live
from Las Vegas At The Palms – EP
(iTunes, gennaio 2009)
G enere : folk , pop , soul
Questa uscita collaterale, in apparenza un approdo sicuro (appartiene a una serie di EP, esclusivamente in digitale, che vede band scelte da iTunes
registrare alcune loro canzoni dal vivo in un lussuoso studio di Las Vegas, presso il casinò At The
Palms), in realtà riconnette i My Morning Jacket
con una parte della loro musica - della loro storia che sembrava ormai dimenticata, sepolta com’era
dalla loro fama di roboante live band (e da recenti
uscite discografiche che si concedono a diversioni
stilistiche fra l’azzardato e l’azzeccato). Quando
invece riposava soltanto sottopelle: l’approccio minimale, narcolettico, sommerso da strati e strati di
riverbero che era tipico del lontano esordio The
Tennessee Fire (1999) lo ritroviamo qui, sia nella ripresa di rare canzoni del periodo - They Ran,
From Nashville to Kentucky, Tonight I Want to Celebrate
With You, a loro volta iniettate di vibrazioni soul
- sia negli arrangiamenti di cose più recenti. E ci
si accorge sia che Knot Comes Loose (da Z, 2005) e
Thank You Too, uno dei gioiellini del’ultimo Evil
Urges, affondano le radici in un passato mai in
fondo dimenticato, mentre l’inedita Dear Wife giochicchia tenuemente con easy listening anni ’70
e primi Beatles. Una pubblicazione tutt’altro che
priva d’importanza, a ben vedere. (6.8/10)
Antonio Puglia
Nancy Wallace - Old Stories (Midwich Records / Goodfellas, febbraio
2009)
G enere : folk revival
Arriva al debutto solista la cantante del combo
folk inglese The Memory Band, e già ospite
l’anno scorso nel primo disco degli Owl Service. Folk britannico tradizionale che si riallaccia
prepotentemente alla tradizione dei ‘60 e dei ‘70
degli immancabili Steeleye Span, Fairport
Convention, Pentangle. Folk rivisitato all’oggi,
mescolando traditional e composizioni originali e
dotandoli del medesimo afflato melodico, resi con
grazia armonica e strumentale. Voce suadente un
po’ Vashti Bunyan, un po’ Shirley Collins un po’
Anne Briggs a seconda delle occasioni. Album che
si fa ascoltare senza essere niente di trascendentale
e nulla aggiunge fin qui al percorso della Wallace,
che preferiamo a questo punto di gran lunga nel
gruppo di provenienza. (6.4/10)
Teresa Greco
Napalm Death – Time Waits For No
Slave (Century Media, Gennaio 2009)
G enere : D eath -G rind
Chi si aspettava di trovarli ancora lì? Chi avrebbe
mai scommesso un euro (una lira dell’epoca, alla
faccia dell’inflazione!) vent’anni fa sul futuro di una
band che nei primi cinque minuti di musica aveva
già portato all’estremo e “macinato” (to grind) tutta la sua radicale carica innovativa? E invece eccoli
lì, i Napalm Death, a galleggiare, avvalendosi del
loro stato di miti, sui resti di una rivoluzione ormai
quasi del tutto dimenticata. Una rivoluzione consapevole di percorrere un binario morto negli sviluppi della musica, ultimo passo verso la totale devastazione iniziata un decennio prima con il punk.
Il grindcore, quello “vero”, radicale, anarchico,
è nato e morto subito, ammazzato quasi subito,
proprio da chi lo aveva creato, salvo lasciare qualche traccia nel metal a venire. L’approdo al death
metal ha rappresentato il percorso di tanti pionieri
del genere (dai Carcass agli stessi Napalm Death) che lì si sono fermati, travolti da tecnicismi
che solo in rari casi hanno rappresentato un valore
aggiunto nella crisi del metal estremo, sempre più
fagocitato dal mainstream.
Persa ogni valenza artistica, la musica dei Napalm Death, dopo Harmony Corruption (Earache, 1990) è da ascrivere quasi completamente
alla storia del death metal e dei sui sottogeneri. E
a distanza di tanti anni, la band di Birmingham
continua a vivere di questo, con dignità ma senza
grandi sussulti, sfornando mediamente un album
recensioni /
77
Highlight
Mimes Of Wine – Self Titled EP (Midfinger, gennaio 2009)
G enere : avant / art / folk / blues
Se fosse un biglietto da visita (lo è) ti brucerebbe nel taschino, dovresti stropicciarlo per sentire se contiene un po’
dell’energia strana, insidiosa, avvolgente, primordiale e
post-atomica che avverti nelle quattro tracce di questo ep
d’esordio. Mimes Of Wine è Laura Loriga. Laura suona
il piano anzi lo scuote con risoluta tenerezza, canta come
se ne aspirasse il veleno e l’antidoto assieme, in mezzo a
vortici di chitarre aspre, a vapori di ottoni, a fatamorgane
di tastiere, folate e tramestii percussivi e impalpabili bave
sintetiche. Prova ad incantarti (ci riesce) coi sussurri foschi e le fughe palpitanti, con
l’agnizione tenue e selvatica di K (dove è una Diamanda Galas ingentilita Tori Amos,
intensa ed eterea come la PJ Harvey di White Chalk). Ti sbalordisce coi languori
teatrali, il passo freak marziale e la frenesia cavernosa di Fishes (dove avverti tracce del
lirismo Jeff Buckley, dove ti figuri una Laura Nyro prigioniera dei Grizzly Bear).
Ti strega con la lunare irrequietezza Hyvönen/Newsom di Carnival Scar (misteri folk e
trepidazione post-blues), ti circuisce con lo struggimento jazzy venato bossa di Oberkampf,
come una Cibelle invischiata nelle tossine Billie Holiday, il siparietto swing rurale a
spettinare il ventaglio delle aspettative.
Appunto: cosa attendersi dal full lenght Apocalypse Sets In, previsto per la primavera?
(7.5/10)
Stefano Solventi
ogni biennio e proseguendo il turnover di membri,
che la caratterizza sin dagli esordi.
Eppure Time Waits For No Slave non ispira i sentimenti di pietà o tenerezza che di solito provocano
i dischi di band-Matusalemme, che non vogliono
proprio demordere e si trascinano per i capelli pur
di far uscire qualcosa di nuovo a proprio nome.
Decisamente orientato verso il Thrash, il quindicesimo album dei Napalm Death dai tempi di
Scum (Earache, 1987) non abbandona del tutto
la violenza esecutiva degli esordi, che però, dopo i
momenti iniziali (Strongarm, Diktat e Work To Rule),
si perde in un suono spurio, a metà tra gli Sla78
/ recensioni
yer, i Morbid Angel. Riff consumati dall’abuso, distorsioni leggermente più pulite e la solita
batteria di Mick Harris a fare la differenza, con
le sue precise variazioni di tempo e i suoi ormai
classici “stacchi” alla velocità della luce. Penose le
escursioni in improbabili territori melodici che gli
sono a dir poco estranei (la Title Track; Downbeat
Clique), e suonano goffi, trasformandoli in un clone
venuto male degli Slipknot. Sì, i Napalm Death
sono vivi. E probabilmente anche il metal d’annata continua ad avere il suoi seguito. Ma…cui
������������
prodest? (5.5/10)
Daniele Follero
Night Horse – The Dark Won’t hide
You (North Atlantic Sound, 2008)
G enere : heavy blues
Per qualcuno il blues è stato un punto di partenza,
per qualcun altro un punto di riferimento stabile. Ma c’è anche chi dal blues “duro e puro” non
vuole proprio staccarsi. Mi sembra sia il caso di
questi Night Horse, band losangelina, neonata ma
già vecchia.
I suoi membri vengono tutti dal blues rock e non
mostrano alcuna intenzione di mollare la presa.
L’ortodossia non ha limiti e i paragoni scomodi
(e piuttosto datati) si sprecano: i Led Zeppelin
più vicini all’hard rock, i Black Sabbath più
anonimi, l’Alice Cooper meno heavy sono tutti
lì, mescolati nel nome della “purezza” rockettara più oltranzista. Ma rassegnamoci, perché non
sono né i primi né saranno gli ultimi cloni di una
generazione di rocker ormai giunta alla meritata
pensione. Per avere un idea di ciò che può offrire
quest’album, basta dare un’occhiata alla copertina:
una foto con al centro un teschio tra due candele
e dietro l’immagine di un nativo americano (quelli
che erroneamente vengono chiamati indiani, per
intenderci). Dietro questa iconografia americanissima e un po’ volgaruccia (se non addirittura ridicola), si nascondono sei brani scontatissimi, anche
se sinceri e in alcuni casi addirittura vivi ed energici. La voce di Sam James Velde richiama il tono
semiserio dell’omonima band del Glenn Danzig
post-Misfits e potrebbe anche risultare interessante se non fosse sostenuta da anonimi riffettoni e
parti di basso e batteria essenziali, come vuole la
tradizione heavy rock. Nota di merito: la durata.
Mezz’ora di heavy blues suonato bene non la si
nega a nessuno. (5.0/10)
Daniele Follero
No Neck Blues Band – Cloneim (Locust, dicembre 2008)
G enere : kraut / psych
Riuscire a intrappolare la ghenga di Dave Nuss non
avrebbe molto senso, sarebbe come snaturarne il
valore. Che gli animali siano liberi di scorazzare
ordunque; i sette che arrivano dalla nera Harlem
conoscono il valore dell’improvvisazione ed una
continua – assai poco leziosa – jam appare questo
Clomeim, che registra il numero 100 in catalogo
per Sound @ One, marchio da sempre associato
alla No Neck Blues Band, anche quando si è tratto
di pubblicare tapes e cd-r in tiratura irrisoria.
Il pagano odore di kraut avvolge le spire della zelante The Coach House, mentre le smorfie tra esoterismi psych folk e brutali nenie black metal (con ampio ricollegarsi al progetto satellite Angelsblood) di
Ministry Of Voices lasciano pensare ad una band
persa alla propria deriva psicotica. Ancora suoni
sfilacciati ma ovviamente tribali in Salai Widnalas,
dove le urla gutturali assumono ancora il senso di
provocazione estrema.
Non va dunque per il sottile la No Neck Blues
Bland, che di cedere ai crismi della normalità non
ha vaga intenzione. In un consumato rituale la
loro proposta si infiamma, abbandonando i lineamenti della forma canzone e della composizione
stessa. Un’immersione totale nello stream of consciousness.
Ragion per cui nessuno dei loro dischi in studio
e delle loro performance dal vivo rispecchieranno una reciproca idea. E’ tutto giocato sul filo del
rasoio, in una rappresentazione spesso isterica,
solo raramente celestiale. Con in dosso I panni
dei sobillatori esistenziali i Nostri marciano verso
un assoluto in musica che si sgretola di continuo,
nell’abbandono delle più terrene certezze.
Una musica che conserva ancora un carattere
iniziatico, cerimonia impalpabile della sofferenza
umana. Mutilando brandelli del catalogo ESP (soprattutto quello più off, si pensi ai Cro-Magnon o
alla Patty Waters di Black Is The Color Of My True
Love’s Hair) ed accedendo alle pagine culto della
musica germanica (Agitation Free e Amon Duul
in cima) con Clomeim fanno un’ulteriore passo
verso l’eternità, quella più scomoda. (7.3/10)
Luca Collepiccolo
recensioni /
79
Of Montreal – An Eluardian Instance; Jon Brion Remix Ep (Polyvinyl / Goodfellas, febbraio 2009)
G enere : remix ep
Sull’onda lunga del vertiginoso Skeletal Camping,
il combo degli of Montreal pubblica un EP manipolato da quel Jon Brion conosciuto per i trascorsi
al fianco di Elliott Smith, Kanye West nonché firmatario di score quali Magnolia e Eternal Sunshine
Of The Spotless Mind da noi noto, al solito, col pessimo
titolo de Se Mi Lasci Ti Cancello. Le tracce in esame
sono due, An Eluardian Instance e Gallery Piece, e il
trattamento di Brion consiste nel dare corpo a
materiale già corposo di suo; quindi se First Time
High (nuova ragione sociale, per l’occasione, di An
Eluardian Instance) si impreziosirà, sia per il Reconstructionist Remix che nella versione acustica,
del mandolino e le backing vocals dell’ospite Chris
Thile dei Nickel Creek, Gallery Piece la si vedrà
sfilare, dancereccia com’è, remixata, allungata e
strumentale.
Operazione, comunque, per i fan di stretta osservanza. (7.0/10)
Gianni Avella
Oginoknaus – Nuclearcunt (Marinaio Gaio – Valvolare Records - Elevator / Jestrai, ottobre 2008)
G enere : post punk - new wave
Narcotici come il Lou Reed più indisponente, alla
moda come un contraccettivo scaduto, essenziali
ed efficaci come sa essere soltanto chi vede ancora
le chitarre elettriche, il basso e la batteria al comando di quel vascello fantasma che è il rock contemporaneo, gli Oginoknaus tornano a quattro anni
dell’omonimo esordio. E lo fanno impilando una
sull’altra dieci tracce ruvide e ringhianti, pronte a
consacrarne ancora una volta l’estro compositivo.
Nessun effetto speciale a foraggiare la meraviglia,
nessun tono acceso a corroborare il bianco sporco
e il nero pece dei suoni, nessuna facile concessione
alla melodia: solo una guerriglia in piena regola
portata avanti tra post-punk malato e spunti noise,
80
/ recensioni
assalti feroci e ossessioni in stile Ian Curtis. Dalle lacerazioni profonde che ne conseguono, esce
un’opera immediatamente riconoscibile, dal fascino ambiguo, claustrofobica e disturbante nella sua
monocorde uniformità, capace di cedere giusto un
paio di parentesi – il sax in bilico tra Morphine e Gallon Drunk di Breakdance e l’accordian
dell’ospite/produttore Rob Ellis di Rainbow Drive
– a contributi strumentali altri. Per un suono lontano dal “pop” ma decisamente attraente. (6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Pains Of Being Pure At Heart – Self
Titled (Slumberland, febbraio 2009)
G enere : noise - pop
Rinnova la sua fama la Slumberland con l’esordio
di un quartetto misto dal nome terribilmente adolescenziale. E rinnova anche i fasti di quel noisepop zuccherumoroso che trova proprio nel catalogo della label una delle sue gemme più nascoste:
i Black Tambourine. Alex (basso), Kip (chitarra +
voce), Kurt (batteria) e Peggy (tastiere + voce) –
questi nomi e strumenti del quartetto newyorchese
– sono tre imberbi
fanciulli e una nippo-girl tutto pepe
in fissa con la musica più semplice del
mondo, da quando
i fratelli Reid accesero gli ampli scoperchiando il vaso
del feedback-pop:
declinare al verbo del rumore le melodie più poppy e appiccicose del rock. Affogarle in un oceano
di riverberi e delay, quasi a volerle soffocare, nella
consapevolezza che le melodie riemergeranno da
quel marasma come niente fosse. Prendete come
ottimo esempio Contender, l’attacco del disco. Gioca su accordi che sembrano quelli di I Don’t Wanna
Grow Up di waitsiana memoria, ma è solo una fugace impressione. Quando entra la voce, catturata
a rimirarsi le scarpe su un tappeto di distorsioni
gentili, esplode il caleidoscopio: reminiscenze Cure
virati shoegaze (This Love Is Fucking Right), trasposizioni Pastels (Gentle Sons), svisate indie-nostalgiche
(Stay Alive), echi morriseyiani (Everything With You),
immaginario college nei suoi dettagli più apparentemente insignificanti (A Teenager In Love). Un debutto coi fiocchi e un disco da avere. Perché ogni
tanto si ha bisogno di tornare adolescenti sognati,
così come ogni tanto si ha bisogno di canzoni. E
qui ne trovate di meravigliose. (7.0/10)
Richard Pinhas & Merzbow – Keio
Line (Cuneiform, dicembre 2008)
G enere : impro - noise
Matthew Houck stavolta mette le carte in regola,
chiarendo una volta per tutte che la sua somiglianza artistica (perché evidente è anche quella fisica)
con Will Oldham, al quale viene da sempre paragonato, è soltanto apparenza e sicuramente figlia di
medesimi ascolti. Il quarto album della sua creatura
fosforescente, infatti, non rappresenta altro che un
personale tributo a Willie Nelson, immenso cantore
folk americano esploso musicalmente a cavallo tra i
Sessanta e i Settanta. Proprio a quel periodo, infatti,
sono debitori gli odierni cantautori indie come Phosphorescent e Bonnie “Prince” Billy, per l’appunto.
Ma la cosa curiosa è che lo stesso guru folk omaggiato in questo album pubblicò, a suo tempo, nel
’75, un tributo dedicato interamente a Lefty Frizzell
intitolato To Lefty From Willie. Da qui la scelta di
To Willie. E l’album in questione contiene undici
cover (reinterpretazione di canzoni anche minori
del catalogo nelsoniano) che, flirtando con il folk più
classico, mostrano l’ottimo livello di maturità stilistica raggiunto dal Nostro: abbandona quell’approccio lo-fi per dedicarsi completamente a una meticolosa ricerca strumentale, impregnandola però di
profonde e sincere emozioni. Adesso non resta che
attendere il vero salto di qualità con il quinto album,
altrimenti a nessuno tra vent’anni salterà in mente
di intitolare un album “To Matthew”. (7.3/10)
Titolo e nomi in ballo permettono di inquadrare
da subito questa ennesima, curatissima edizione
Cuneiform.
Da una parte Richard Pinhas, storico esponente
dell’ala più radicale dell’elettronica rock (o viceversa) spacey & floating d’oltralpe; dall’altra Masami
Akita, aka Merzbow, incompromissorio violentatore sonico e riconosciuto padrino del noise (non
solo) giapponese. In mezzo, a far da anello di congiunzione tra i due,
la Keio Line, linea
metropolitana della
città di Tokyo dove
i due si sono incontrati per registrare
questo doppio cd.
Proprio il titolo e le
dinamiche relative
alla produzione/
registrazione di questo Keio Line rendono perfettamente l’idea di collegamento e viaggio tra la
Parigi di Pinhas e la Tokyo di Masami, così come
evidenziano la perfetta coesistenza tra imput sonori piuttosto differenti: l’elettricità rock dilatata e
estatica del primo e l’elettronica spigolosa e piena
di asperità del secondo. Pinhas fornisce una piattaforma sonora a base di chitarre e loop systems
sulla quale Merzbow esprime al massimo tutto il
potenziale esplosivo dei suoi synth e dei suoi noise
treatments.
L’effetto, vista anche la mastodontica durata delle
suite – viaggiamo sul quarto d’ora abbondante di
media – è quello di una musica visionaria, estatica, sciamanica e perfettamente in equilibrio tra
sporcizia digitale – beats, loop, noises vari, folate
di rumore bianco – e flussi dreaming memori del
kraut più evanescente.
Un signor disco, da due signori della sperimentazione. (7.0/10)
Andrea Provinciali
Stefano Pifferi
Stefano Pifferi
Phosphorescent – To Willie (Dead
Oceans, febbraio 2009)
G enere : cl as sic folk
recensioni /
81
Pixel – The Drive (Raster-Noton,2009)
G enere : elettronica - ambient
Excursus non convenzionali per il compositore ed
ex-sassofonista Jon Ekeskov in arte Pixel nella
nuova uscita firmata Raster-Norton. Le tessiture
di The Drive si ancorano a saporite eloquenze
contemporanee, per poi incontrare gli orizzonti
decisamente poco ovvi dell’elettronica più sperimentale, il tutto grazie a quelle controllate matrici concrete ormai care agli adepti moderni della
sintesi. Sette elementi che dialogano con una improvvisazione minimale “melodica”, per poi farsi
spazio nelle poliritmiche e nelle oscillate strutture
tra dominata sostanza e accentuato dinamismo.
Gli elementi leggibili dialogano tra glitch o microframmentazioni che si lasciano scoprire attraverso
un incontaminato sub-bass, le cui maniere si dichiarano apertamente tra ritmiche in microsuoni,
dualismo e musica puntilista. Rimbalza all’orecchio un potenziale sicuramente buono anche se a
tratti troppo legato all’esercizio tecnico, a discapito
del fascino comunicativo. (6.9/10)
surreale. C’è quella sensibilità post-romantica cara
ad alcuni artisti filo-giapponesi dell’eletronic wave,
le meditate atmosfere glamour e le sonorità chilling (Masato Shuffle,
K3), l’elettroacustica isolazionista
(Veisalgia), improvvisata e sovrapposta al limite della
robotica (Bata) o
contaminata dalle
ritmiche in levare (Not Hearing a
Word). E all’acustica spettano gli arpeggi zuccherati dai colori pastello (Non Hoi), gli archi sottoesposti
(Seizure), le percussioni arabeggianti (Durban Pain)
e le arie cristalline in chiusura (Two Rooms). Frames sonori a cui qualche particolarità e sfumatura
in meno non avrebbe fatto male specialmente se
si considera il lavoro nel suo insieme. In compenso alcune tracce risultano decisamente godibili.
(6.7/10)
Sara Bracco
Sara Bracco
Plaid – Heaven’s Door (Beat Records,
2008)
G enere : colonna sonora
Quivers – 2012 (Tigerasylum, gennaio 2009)
G enere : impro
Ed Handley ed Andrew Turner - ex The Black
Dog - ora Plaid, sono un duo britannico che per
uscita discografica firmata Beat Records concedono le loro propensioni elettroniche ai fotogrammi
del primo live-action dell’animatore americano
Michael Arias. Il loro repertorio sonoro spazia in
album, collaborazioni e remix per innumerevoli artisti, passando per EP, compilation e colonne
sonore. Heaven’s Door infatti è la seconda prova in questo campo: attraverso i mezzi tecnici del
cinema sonoro propongono ambientazioni dalle
sognanti dinamiche cinematografiche. E’ l’elettronica la chiave di lettura di queste sedici tracce,
che si creano il proprio spazio senza perdere in
coerenza ma trascinando con se l’ascolto attraverso un idilliaco paesaggio che cavalca l’onirico e il
Quivers tries to have open minds and to open minds, chiosano i quattro newyorchesi (d’origine o d’adozione, poco interessa) e come dar loro torto.
Il padrone di casa Jordon Schranz (basso), il presenzialista Adam Kriney (batteria), l’iperattivo Chris
Welcome (cello) e l’ubiquo Ninni Morgia (chitarra)
imbastiscono, su supporto vinilico, 5 pezzi untitled che sa di apocalisse impro-rock prossima ventura. I riferimenti non mancano, come l’esplicito
rimando del titolo alle profezie maya; tanto meno
le evoluzioni da “dopo-rock imbastardito con attitudine free-jazz” dei 5 pezzi untitled.
A farla da padrona come al solito è la sei corde del
siciliano: nella più totale libertà d’azione frattura
e spezza, cuce e ricama un suono instabile e umorale, tra gorgoglii e estatici fraseggi. In questa sua
82
/ recensioni
azione di riduzionismo free (termine comprensibile per chi segue anche le altre incarnazioni del
suo fare musica, La Otracina su tutti), Morgia è
ottimamente sostenuto dalla precisa azione di una
sezione ritmica affiatata ed energica e contrappuntato dalle intrusioni rumorose di Welcome.
È di nuovo l’impro di matrice jazz che si riversa
nel corpo morto del rock: ne mantiene lo sfogo
liberatorio, estatico e privo di vincoli strutturali,
senza negare però la tensione e la “corposità” del
secondo. (6.7/10)
Stefano Pifferi
Raccoo-oo-oon – Self Titled (Release
The Bats, gennaio 2009)
G enere : weird america
Mischiare rock in forma libera e psichedelia sognante, carcasse da rock krauto maciullato e prog
mutante, tribalismo primitivista, rumorismo e ninnananne ossessive. Questa la missione dei 4 Raccoo-oo-oon, di cui purtroppo questo omonimo è
l’inatteso canto del cigno. Musiche ostiche, difficili, a volte dissonanti, a volte sussurrate, sempre in
modalità improvvisativa e suonate non con piglio e
supponenza arty, ma con semplicità quasi infantile,
giocosa, tanto è facile immaginarseli immersi nei
boschi dell’america rurale, tra amici, impegnati in
sessions più vicine a baccanali orgiastici che a vere
e proprie sedute in sala prove. È proprio nella totale
libertà da schemi e strutture che Raccoo-oo-oon
da il meglio di sé; nel far convivere nello stesso pezzo, l’una accanto all’altra, cifre stilistiche agli antipodi come xilofoni cinguettanti e percussività free,
slabbrature synthetiche e chitarre accordate a caso,
stralci della tradizione folk americana e avant-rock
devastato. Forse – ma è solo un pensiero ramingo
– proprio lì risiede(va) il fascino e il miglior pregio
dei Raccoo-oo-oon. Che sia la vastità degli spazi
geografici o quella dei confini di una società culturalmente mista, resta un mistero per noi europei. Di
certo c’è che mai canto del cigno fu più inaspettato
e triste. Ad memoriam (7.5/10)
Stefano Pifferi
Rahim – Laughter (Pretty Activity, 9
settembre 2008)
G enere : rock melodico - cantautoriale
I Rahim fanno canzoni, di quella guisa che innerva tutto attorno alla melodia, alla costruzione
vocale solista e coristica. Niente virtuosismi, sia
chiaro; ma sulla strada della chiarezza neanche
solo quello, in Laughter. E forse qui sta il problema maggiore. Primo, le strutture degli accompagnamenti strumentali fanno spesso il verso a quei
tocchi incrociati batteria-basso-chitarra che furono del post-rock americano, tanto di Louisville
che di Chicago, declinati qui alla dilatazione e al
pochissimo rumore. E però, secondo, il gioco non
sempre riesce ai quattro di Long Island, al loro secondo disco.
Non è solo questione di melodie a volte imbarazzanti (Cities Change); c’è che con la finta destrutturazione si rischia di spezzare decisamente in due i
brani, con la voce che va da una parte e gli strumenti che provano a essere più sofisticati negli arrangiamenti. Meglio le armonie di Of Course, che
iniziano a spostare la bussola indietro nel tempo,
o la quasi beatlesiana Dark Harbors; e soprattutto la
title-track, a fine album, che si smarca del tutto dalla tendenza delle prime tracce del disco, estraendo dal cilindro sapori di primi Settanta post-acid,
si direbbe jethro-tulliani. Ovunque di positivo – e
raro, per certi versi – c’è che le melodie vocali non
sono mai troppo patemizzate. Ma visto i successi
con i decenni precedenti, facciamo in conclusione una proposta; Rahim, dimenticatevi i Novanta.
(6.0/10)
Gaspare Caliri
RHumornero – Umorismi Neri (Arroyo - Metamusic / Venus, 20 novembre
2008)
G enere : rock
Banalizzare la spinta centrifuga del rock per tradurne soltanto gli stereotipi più in uso. Questo è
quello che fanno i Rhumornero con Umorismi
neri, allestendo uno spettacolo dal finale già scritto
recensioni /
83
Highlight
Plastic Crimewave Sound – Painted Shadows (A Silent Place,
febbraio 2009)
G enere : rock
Per capire con un solo colpo d’occhio la filosofia di Steve
Krakow, aka Plastic Crimewave, basta prendere uno dei
suoi Galactic Zoo Dossier. In pratica una vera e propria fanzine da lui curata (anche se venduta dal mailorder della Drag City), interamente disegnata a mano e con
argomenti rigorosamente scelti, come – cito a memoria
- articoli sui classici della dark psichedelia, oppure sugli
horror movies hippie e interviste a gente come Clive Palmer o Ed Askew… Il mondo di Krakow sembra flirtare
da una parte con la psichedelia hard di Julian Cope, dall’altra con lo sballo acido di
Wayne Coyne e dall’altra ancora con qualcosa di completamente inedito ma paragonabile con il culto feticista per l’exotica. Un personaggio quindi con un senso della musica e dell’arte che oscilla perennemente tra il retrò e il kitch bello e buono. Che poi la sua
band sia ormai da tre dischi che pesti duro regalandoci alcuni dei migliori nuovi anthem
psych rock non è certo di secondaria importanza. Painted Shadows, quindi, potrebbe
essere un bel lasciapassare per addentrarsi in un mondo come quello di Krakow, in cui
non è certo facile immergersi e per mandare finalmente i Plastic Crimewave Sound
nel patheon dei nuovi psichedelici, da qualche parte tra Black Angels o Indian Jewelry. Confidiamo quindi nella qualità del disco e nel fatto che per la prima volta non si
dovranno aspettare mesi e mesi per vederlo in formato cd, come accaduto per i precedenti che hanno vissuto a lungo in esclusiva versione vinile. Painted Shadows prende
il titolo dalla pratica in voga nell’espressionismo tedesco di dipingere le ombre direttamente sulla pellicola. Come riferimento culturale alla sacra scuola d’arte d’Alemagna, si
fa centro pieno, perché di tutti i dischi pubblicati fino ad ora, questo è certamente quello
dalle vibrazioni meno garage e più cosmiche. L’introduttiva I Feel Evils immerge subito in
una nebbia wave che sembra essere stata filtrata dai Loop di Robert Hampson. Questo,
insieme alla successiva (Can’t) Turn The Key, gli episodi più orecchiabili e “darkwave”. Le
tirata acide non mancano comunque come si capisce quando attaccata la ronzante e febbrile ritmica (quasi motorik) di The Grip e della successiva Ecstatic Song. Ma il capolavoro
del disco arriva alla fine con la title track: venti minuti di delirio cosmico che suona un po’
come uno scontro tra titani, su una ideale battlefield che frulla di tutto, dagli Hawkwind
ai Pink Floyd, dagli Stooges ai Motorhead passando per quintali di krautrock. E’
questo il suono del più feticista di tutti i messia rock contemporanei. (7.5/10)
Antonello Comunale
84
/ recensioni
in cui si recita un hard-rock scuro tutto riff granitici e lentezze marziali. Roba che neanche i Soundgarden meno acidi e più sfilacciati si azzardavano
a proporre, per lo meno non con tale semplicistico
slancio creativo. L’ambito di riferimento è una terra di mezzo tra la band di Chris Cornell e certi Negrita periodo Reset, anche se in realtà, l’idea che
ci si fa a fine programma, è che il naturale sbocco
per la band pisana sia un immaginario decisamente più convenzionale, tipo il palcoscenico di Sanremo rock(?). Per una formula che si accontenta
di collezionare qualche arpeggio in distorsione e
un pugno di fraseggi poco originali, facilonerie
su tempi dispari e temi depressivi da piccola borghesia, senza oltrepassare gli steccati della buona
creanza. Certo, a cercar bene, qualcosa si salva: si
parla comunque di musicisti preparati – in giro c’è
decisamente di peggio –, capaci di tirar fuori un
suono attraente, talvolta in grado di osare qualche
incursione in territori elettrici urticanti. Ma si tratta di piccole parentesi, per un disco che vorrebbe
tanto, ma non fa. (5.0/10)
Fabrizio Zampighi
Robert Pollard – The Crawling Distance (Guided By Voices Inc., 2009)
G enere : lo - fi pop - rock
Abbiamo già avuto modo di notare come, tra le
tante manifestazioni del Pollard-pensiero, quelle
che portano il suo nome di battesimo, siano le più
scadenti. Rieccoci alla riprova delle nostre supposizioni, grazie all’uscita quasi parallela dell’ultimo
e più che soddisfacente Circus Devils e di questo The Crawling Distance, a firma del Nostro.
La prima impressione che si ha ascoltando i due
dischi è che l’autore principale non sia per niente
lo stesso. Lo sbiadito e insipido pop-rock, leggermente “sporcato” negli arrangiamenti, a metà tra
i Dinosaur Jr. e i R.E.M., del Pollard solista non
ricorda, se non molto lontanamente, né il passato
dei Guided By Voices né il presente dei progetti
collaterali del musicista statunitense.
Troppe le banalità e la retorica pop per farlo ap-
parire un disco credibile. L’attenzione è tutta concentrata su linee vocali melodiose, arrangiamenti
semplici ed essenzialmente relegati al sostegno armonico e un uso della forma canzone che, seppure
minimamente esplorata nelle sue possibilità, non
sconfina mai oltre le strutture stereotipate. Qualche volte ci si spinge fino al punk rock annacquato
di By Silence Be Destroyed, ma a prevalere è quasi
sempre un atteggiamento più soft, che non risparmia episodi al limite della decenza, robaccia da
radio ultra-generalista come Imaginary Queen Anne.
Neanche le fluttuanti melodie di una ballata raffinata come No Island o i toni cupi e darkeggianti di
On Shortwave riescono a salvare la barca dal naufragio. (4.8/10)
Daniele Follero
Ryoji Ikeda – Test Pattern (RasterNoton, 2008)
G enere : R yoji I keda
Interfacciano sintesi numeriche i composti parametri di Test Pattern, nuovo progetto dell’artista
giapponese Ryoji Ikeda a tre anni dal sublime radicalismo di Datamatics.
Portavoci di valori performativi, le sedici tracce di
Test Pattern oltrepassano la frequenza assumendo ad ogni capo polarità in pattern per poi mutare
identità nell’elettronica di segnale.
Si ritrattano i principi dell’estetica che acquistano
forma e purezza nella geometria contemporanea
del limite; un limite finito che attraversa le regole
dell’imput/output organizzando pulsioni sonore
che difficilmente superano i 5 minuti.
Soggetti in segnali ad alte frequenze, in certi casi al
limite dell’udibile, che si lasciano condizionare dal
ritmo e da governate regolarità, mentre la struttura composita regola le volute tra sferzati, puntinati
o modulati ripetitivismi.
Geometrie che vanno oltre la minimal-techno e
superano i confini del glitch; che partendo da elementi primari, arrivano a plasmare masse di flussi sonori che s’impossessano del limite spaziale a
tratti annientandolo, o radicandosi nel mutamenrecensioni /
85
to seriale. Senza mai dimenticare poetica e stato
emotivo dell’ascoltatore, a conferma che i cosiddetti nuovi suoni esistono ancora, ed hanno ancora molto da dirci. (7.8/10)
Sara Bracco
Six Organs Of Admittance – RTZ
(Drag City, 20 gennaio 2009)
G enere : psych - folk
Return To Zero, lo si evince dal titolo, è un disco
che va a ripescare nel percorso artistico di Ben
Chasny dagli esordi fino agli split con Charalambides, The Magic Carpathians e Vibracathedral Orchestra, attingendo a piene mani
tra quei materiali pubblicati in edizione limitata
e pertanto attualmente introvabili. E ad iniziare
dalla lunga suite
Resurrection,
divisa in cinque parti,
ritroviamo tutti i
temi che ricorrono
nei dischi più conosciuti del chitarrista
folk californiano: la
profonda empatia
con la natura, la
febbrilità di un fingerpicking mai fine a se stesso
e la dimensione corale e intimista della voce. Immancabile anche l’utilizzo minimale della percussione, spesso usata solo come contorno ambientale e, ovviamente, quella chitarra stratificata che
ha scavato a lungo tra le radici di una tradizione
ben consolidata (John Fahey su tutti) e di un’altra invece, tutta da fare, dove è l’uomo, in buona
solitudine, a immergersi nella visceralità del suono. Più della metà delle tracce resta sospesa tra il
raga indiano e la psichedelia polverosa dei deserti
dell’ovest, alle sorgenti dell’intera scena neofolk
angloamericana, sulla quale il Nostro, indiscutibilmente, troneggia. Warm Earth, Which I’ve Been Told,
la seconda long track del primo cd, rispolvera la
componente arcana e oscura dell’ opera dell’ exComets On Fire, forse la stessa che lo ha avvi86
/ recensioni
cinato, negli anni, a David Tibet. Il secondo cd
non si discosta di molto dal primo, richiamando
alla mente la storica controparte inglese di Chasny, quell’ Alexander Tucker che segue con la
voce le linee della chitarra, fornendo un supporto
non indifferente alla psichedelia selvaggia della sei
corde. E’ forse tardi per gridare al miracolo, ma
contando che si tratta di materiale vecchio è lecito
riportare l’orologio indietro. (7.8/10)
Francesca Marongiu
Susumu Yokota– Mother(Lo Recording / febbraio 2009)
G enere : ( elettro ) pop , noir , dream ecc
Lo avevamo conosciuto poco più di un anno fà con
Love Or die anche se, Susumu Yokota ha già alle
spalle una decina di anni di attività e una trentina
di album.
Tredici tracce e sette collaborazioni tutte al femminile per la neo uscita firmata Lo Recording ma;
purtroppo in questo caso non sono i numeri a far
la differenza. Mother si lascia controllare e lo si
dichiara apertamente già dai primi minuti dalle
scelte vocali, senza nulla togliere alle preziose opzioni in talento che reggono il gioco con gradevole
grazia ma, tramano inganno. E sono proprio i pieni e i vuoti, le identità in pigmenti elettroacustici
e i colori che pagano il pegno, risultando o troppo
accondiscendenti ( A Ray of light ) o decisamente
fuori posto (Meltwater).
Ritornano i residui del Sylvian e gli anni ’90, velati
tra le piste a tre di “Love Tendrilises” o dichiarati
senza timore nei toccati confini d’intro ambienthouse (The Natural Process) che a suo modo cerca rimedio nel dovuto giusto ordine delle cose (Breeze),
tra battiti elettronici e le scritture in frequenza.
C’è un po’ di dead can dance, tanto smalto dream
e persino quella new age dai bozzetti angel-chic
che fanno tanto Enya.
Si salvano gli accostamenti in chiaro-scuro trai riff
in chitarra e il grazioso cantato di Nancy Elizabeth (A Flower White) mentre le multi-tracce in vocalità dall’approccio forse concreto (Reflect Mind) si
lasciano perdere e confondere.
Congeniale a suo modo l’accostamento in percussioni e sintesi con le dualità vocali di “Suture”
o le chiusure in pianoforte che nel voluto eco si
lasciano contaminare dall’avanguardia; anime che
sicuramente troveranno rifugio nei salotti per intellettuali cosmopoliti e stagionati.
Tirando le somme la noia fa da maestro ma, se
volete proprio dirigere l’orecchio e cercare un po’
di sostegno andate verso la fine o centellinate qua
e là l’ascolto dove forse emergono alcune attitudini
migliori. (5.6/10)
Sara Bracco
Telefon Tel Aviv – Immolate Yourself
(Bpitch Control, gennaio 2009)
G enere : electro - ambient - pop
Al terzo disco i telefoni approdano sull’etichetta
berlinese di Ellen Aillen e si votano all’electropop, tralasciando un po’ le atmosfere dilatate che
li avevano contraddistinti sin dall’esordio del 2001.
La svolta a tratti è fruttuosa, soprattutto quando si
punta sui crescendi in stile Apparat (vedi l’opener
The Birds), quando si ricordano in modo estremo
gli Ottanta (le percussioni di Helen Of Troy o gli
archi darkettoni di Your Mouth) o quando ci si va
di progressività puramente synth-pop (You Are The
Worst Thing In The
Word). Il disco risente comunque di
una nostalgia verso
il synth-pop che nel
complesso si rivela
essere troppo melanconica e in certi casi zuccherosa.
Se con Maps Of
What Is Effortless ci avevano fatto capire di
avere qualche colpo in canna ancora da sparare
(che in effetti li avrebbe portati a sfornare dei remix epici per gli Apparat), qui Curtis e Cooper entrano nel tunnel del pop in punta di piedi,
spogliandosi dell’anima e non riescono a togliersi
di dosso la patina di uno scopiazzamento dei Depeche Mode e dei Cure più tastieristici. L’eccellente minimalismo acustic-pop di Circlesquare è
distante. L’album potrebbe piacere a chi non ha
vissuto a fondo la stagione dell’emotronica, ma i
capolavori sono da tutt’altra parte. Senza infamia
e senza lode, buono per un po’ di chilling e ‘mai
niente di più’. (6.0/10)
Marco Braggion
Telepathe – Dance Mother (V2, febbraio 2009)
G enere : synth - wave evanescente
Ce le ricordavamo più tribali, robuste e ossessive,
le Telepathe, all’altezza dei primi passi vinilici. Ma
si sa, le corte distanze possono ingannare nella
stessa misura in cui i primi passi non sempre portano a luoghi (musicalmente) certi. Eccole ora qui,
Busy Gangnes e Melissa Livaudais (synth, beats,
qualche chitarra e tante voci), alle prese con l’esordio lungo; con quella prova che le metterà spalle
al muro e di fronte al mondo, visti anche i nomi
coinvolti nell’assemblaggio di Dance Mother,
in primis quel Dave Sitek di Tv On The Radio
memoria.C’è da dire subito che per chi le seguiva
da tempo lo scarto è notevole. Il suono si fa meno
corposo, si sfilaccia da quella wave “percussiva”
e così tremendamente newyorchese che caratterizzava le uscite minori Farewell Forest e Sinister Militia, per avvicinarsi ad un concentrato
compatto e (quasi) senza fronzoli di synth-wavepop accattivante e giocosa. Ripetitiva e minimale.
Ossessiva nella sua elementarità. Ma è il senso di
evanescenza al limite dell’ectoplasmico a segnare
sottotraccia i 9 pezzi di Dance Mother. Un senso
di sfuggevolezza che assume di volta in volta forme diverse a seconda della strumentazione usata e
che fa pensare ad una sorta di haunted-pop songs.
Qualcuno dirà che sono perfette per l’innocuo
pubblico da performance arty che ingolfa certo
sottobosco indie williamsburghiano. Noi risponderemo che certi dischi, nonostante riferimenti
ovvi e un certo senso di inevitabile dejà-écouté, si
recensioni /
87
fanno apprezzare al di fuori di qualsiasi improduttiva contorsione mentale sull’utilità della musica.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
John Tejada – Fabric 44 (Fabric
Records, gennaio 2009)
G enere : compil ation techno minimal
Il DJ californiano torna a concentrarsi sulla sua ristretta cerchia di amici e sforna un mix degno del
Fabric. Ancora una volta minimal techno a farla
da padrona, dopo lo scherzetto 80 Metro Area (sul
numero precedente della serie del rinomato club
britannico). L’omogeneità della proposta conquista
subito al primo ascolto e man mano che si prosegue
nel viaggio si ricordano le stagioni in cui eravamo
là davanti alle casse a vibrare. Perché questo è clubbismo distillato techno. Un magma di progressioni
(Subharmonik Atoms) e di laser sonori che fanno tanto
sorriso stampato ibizenco (Colorseries Olive B), i confini
con l’acidità sorpassati nella poderosa WAX10001 e
le due tracce autoreferenziali sono le cose deep che
ti stampano il marchio sui timpani per tutta la notte
(la collaborazione con Arian Leviste in M Track 1
e con Justin Maxwell in Benus Boats). Ma al di là di
troppi tecnicismi, qui si parla di uno che va avanti
per la sua strada underground. Con la sua Palette
Recordings il ragazzone classe ‘74 si sta costruendo una squadra di adepti che lo seguiranno ancora
per molto tempo. I nomi sono quasi tutti qui, e noi
siamo felici di poterli ascoltare mixati in maniera
ottimale dal loro produttore. Non solo comunque
un ‘piccolo spazio pubblicità’. Ci sono anche delle chicche da lacrime. La potenza degli Orbital, le
meditazioni di Spooky e il finale in acido con LJ
Kruzer. La techno non muore, finché qualcuno ci
crede. Fabric must go on. (7.0/10)
che divide il comeback da Hobo Sunrise (In The
Red, 2004). E molto probabilmente morti (nel senso
di sciolti) lo sono davvero, o magari si sono appena riformati e festeggiano la rimpatriata con questo nuovo disco. Con gente del genere non c’è mai
da fidarsi troppo. Di certo al momento c’è questo
Exit Dreams, e tanto basta per rendere felici noi
e chiunque ami quello che genericamente si può
chiamare garage. Se poi quello che stiamo ascoltando fosse il canto del cigno degli Hunches, o l’inizio di un’altra sferragliante serie di release, beh, sia
come sia la certezza è che colonna sonora migliore
non potrebbe esserci. Chris Gunn (chitarre), Hart
Gledhill (voce), Sarah Epstein (basso) e Ben Spencer (batteria) (ri)mettono in scena il loro personale
teatrino garage-rock ad alto tasso di squilibrio, con
un piede nella tradizione e l’altro sui distorsori. Da
una parte la storia americana fatta essenzialmente
di country e blues, dall’altra il lerciume depravato e
iconoclasta del punk-rock. Che è un po’ come dire
le ruvidezze dei Pussy Galore intenti a vivisezionare
il cadavere del rock e la sguaiatezza slabbrata, teatrale, oscena dei Cramps. Senza mai raggiungere
però né il parossismo distruttivo dei primi, né l’enfasi caricaturale dei secondi, evidenziando invece
gusto per melodia e perfetto equilibrio formale e
stilistico.
La tradizione è trattata coi guanti mentre viene
seviziata dalla carica irruente dei quattro, fatta
di sporcizia del suono e grezzume dei ritmi. Perle
come la conclusiva Swim Hole con quell’annegare
una melodia infantile e irresistibile in un’orgia cacofonica esaltante, e l’opener Actors col suo stomprock robotico, lo dimostrano appieno. Volume a
palla è quello che si merita un disco del genere.
(7.0/10)
Stefano Pifferi
Marco Braggion
The Hunches – Exit Dreams (In The
Red, febbraio 2009)
G enere : garage - rock
Li davamo per morti, visto lo iato quinquennale
88
/ recensioni
The Vickers – Keep Clear (Foolica /
Halidon, 13 febbraio 2009)
G enere : indie - pop
Ai tempi dell’EP autoprodotto che finì tra le grinfie
del nostro We Are Demo guadagnandosi un quasi
sette, li paragonammo a Pavement, Libertines e Radiohead. Una scelta su cui ritorniamo ora - a disco
d’esordio acquisito - non senza qualche perplessità, dal momento che se è vero che qualcosa delle
formazioni citate la si ritrova ancora nella musica
dei Vickers, è vero anche che ben altro si nasconde
sotto la superficie. Nel nostro outing di inizio anno
potremmo comunque coinvolgere anche illustri
scrivani di altri “lidi”, dal momento che il ventaglio
di riferimenti scomodato per definire il sound del
gruppo toscano è stato ed è tutt’ora, ampio e variegato: Thrills, Coral, Turin Brakes, Bluetones, Charlatans, Oasis, Blur,
ancora Pavement,
solo per fare qualche
nome. Una tendenza che, al di là delle
facili battute di spirito, la dice lunga sul
valore di una formula ricca e ambivalente, per certi versi
riconoscibile ma anche sufficientemente originale
da svincolarsi dalle facili categorizzazioni formali.
Ancora di più in questo Keep Clear, deciso passo
in avanti rispetto al passato recente oltre che – lo
diciamo subito – disco di assoluto di valore. Dodici
tracce per lo più chitarra, batteria, basso, tastiere,
il cui maggior pregio è forse il naturale appeal melodico, unito ad un’orecchiabilità virata seppia familiare quanto spumeggiante. Una scrittura rubata
al brit-pop meno banale come all’incedere energico
di Pete Doherty e colleghi - Here Again -, al Dylan
più sboccato - I’ve Got You On My Mind - come
alle indolenze di Neil Young - I’ll wait -, che riesce
a entusiasmare senza svilire i modelli originali. Collezionando invece piccole gemme con stupefacente
semplicità, giocando con gli arrangiamenti, concedendo a musica e testi il giusto spazio, facendo apparire semplice un lavoro di rifinitura, invece, puntuale. Niente di trascendentale, verrebbe da dire,
ma ce ne fossero di musicisti così. (7.1/10)
Fabrizio Zampighi
The Felice Brothers – Self Titled
(Team Love Records, gennaio 2009)
G enere : A mericana
Capita, è capitato, capiterà ancora. Capiterà sempre. Che un guizzo di tradizione Americana (folk,
blues, swing...) s’incarni in una situazione contemporanea, di cui senti con chiarezza la forza, l’estro
risaputo ma necessario delle cose maturate a contatto con la vita vera. Simone, James e Ian Felice da
Catskill, stato di New York, misero assieme la band
come uno scherzo
della passione nel
non troppo lontano
2006, finendo per
fare i busker nella
metropolitana della
Grande Mela, cogliendo apprezzamenti e strappando
entusiasmi che li
portarono di lì a poco ad un tour in terra d’Albione, laddove licenziarono per la Loose Music il
debutto Tonight At The Arizona (2007). I pochi
che hanno avuto il privilegio di ascoltarlo (tipico
caso di distribuzione a singhiozzo) ne sono usciti
elettrizzati, una di quelle scariche valvolari d’una
volta, che non lasciano in pace nessun nervo o capello. Le esibizioni live, alcune prestigiose come al
Folk Festival di Newport, ribadirono il concetto.
Ed eccoci a questa sorta di secondo debutto, giustamente omonimo, per la Team Love Records.
Un gran disco, quindici pezzi in cui l’estro roots
sprizza uno sghembo, irresistibile vitalismo, come
una scorribanda Tom Waits nella famosa cantina della famosa Casa Rosa, con Dylan e The
Band felici di impastare ebbrezza e arcaicismi,
smarrimento ed eccitazione, sacro e profano. Rag
dinoccolati nella taverna dei buoni sentimenti alcolici, tenerezze country, storie spietate e impietose, violini e fisarmoniche, pianoforti e banjo, il
conforto sbruffoncello della sezione fiati, voci che
ammiccano, sproloquiano, ti consolano e si consolano. Canzoni come agili liturgie sconsacrate, grarecensioni /
89
vi e asprigne come la stupenda Helen Fry, argute e
struggenti come Greatest Show On Earth (venata di infingarda flemma Lambchop), colme di indomita
apprensione come Murder By Mistletoe (di quelle ballad che Grant Lee Phillips non ci regala più da
tempo), trascinanti e scombiccherate come Frankie’s
Gun!, languide e distese come Don’t Wake The Scarecrow. E lì in mezzo Goddamn You, Jim, a fungere da
formidabile anomalia, con la sua gravità degna dei
Low più funerei. Certo, siccome la veridicità è un
lusso che la finzione non sempre può permettersi,
capita di avvertire un vago senso di artificio, di inevitabile edulcorazione, un po’ come accadeva con
gli I Am Kloot (ex busker pure loro), se ricordate.
Ma, vi assicuro, non è un prezzo caro da pagare.
(7.3/10)
Stefano Solventi
These Are Powers – All Aboard Future (Dead Oceans, 17 febbraio 2009)
G enere : electro
Questo è quello che vorremmo da un genere.
Esplorare i confini – in questo caso dell’electro - ma
mantenere riconoscibili i riferimenti classici. Creare
accostamenti inediti. Riprovare strade che si sono
dimostrate pericolose – pensiero fisso alla parabola
post-El Guapo, e ogni esempio di ciò che sarebbero
potuti diventare scegliendo altre strade mette amarezza da un lato e speranza (per il nuovo) dall’altro.
Tanto ci sarebbe bastato per caldeggiare l’ascolto
di All Aboard Future, nuova prova per These
Are Powers. Ad aggiungere interesse nei confronti
di questa uscita c’è poi anche la recente storia della band, con l’auto-definizione “ghost punk” che,
come si ricordava su SA, i TAP proponevano per
se stessi fino allo scorso Taro Tarot. Va allora sommato a quanto detto lo scarto qualitativo dei generi;
e pensate a come sia possibile cercare un ancoraggio
(di velcro, naturalmente) a tutto lo spettro dell’electro, dalla sua declinazione pop all’industrial music
for industrial people, dai Brainiac alle spezie digital hardcore. Si parte così con una versione più tirata dei Blow con Easy Answers; drum machine, co90
/ recensioni
lori, aperture, niente di risparmiato, nessun lavoro
di sottrazione; si va più in là, rasentando gli Adult,
con Life Ob Boards; si incrociano le due proposte con
Double Double Yolk. Ma che ne è allora del fantasmatico e scheletrico suonare cui ci ha abituato la formazione? Proprio qui sta l’asserzione del disco, ci pare.
Sì perché è nella mimesi di Genesis P-Orridge
di Light After Sound riscopriamo il velo oscurantista
della prima industria fatta a musica, e i These Are
Powers sono in grado di metterci dentro un riff tecnologico ma pur sempre chitarristico, ponte (come
etimo vuole) tra il prima e il dopo, il rock e l’elettronica, il fantasma, lo scheletro e la carne. Insomma,
pur corpulenta, anche questa elettronica è scarnificata. Ossimorici i These Are Powers. E, cosa che li
rende ancora più convincenti, gente in grado di far
risbucare la propria ontogenesi nella filogenesi di
questo ultimo lavoro. Non un capolavoro, ma una
prova difficile e superata. (7.0/10)
Gaspare Caliri
Tim Hecker – An Imaginary Country
(Kranky / Goodfellas, febbraio 2009)
G enere : ambient
L’uomo che compone “musica per stati d’animo da
4.00 del mattino” ritorna in proprio. Dopo la parentesi in compagnia di Aidan Baker, Tim Hecker
riprende il discorso avviato con Harmony In Ultraviolet regalandoci un nuovo saggio di allegoria
ambient. An Imaginary Country, volendo smentire
i dettami dell’autore,
lo si può ascoltare in
qualsivoglia fascia
oraria, che sia notte fonda o l’inizio
di un nuovo giorno,
visto che l’effetto
sarà sempre di totale
trascendenza. Meno
austero del predecessore, il lavoro si stende alla maniera di un concept il cui soggetto è un immaginario paese esistito un secolo addietro (100 Years Ago),
bagnato da acque pulsanti (Sea of Pulses, arricchita
da un beat che fa tanto Jetone, il moniker minimal
techno del Nostro) che cingono l’umorale ambiente
(l’elegiaca Borderlands) affinché i corvini orizzonti in
lontananza (Her Black Horizon) vi si possano specchiare imponenti. Non si esagera se ci considera Tim
Hecker alla pari dei Flying Saucer Attack oppure,
giusto per rimanere nel presente, evocativo quanto
l’ultimo Fennesz. C’è
���������������������������������
vita dopo Black Sea (Of Pulses). (8.0/10)
Gianni Avella
Tony Formichella & BaseOne – Not
Too Long Ago (Point Of View / Halidon, 2008)
G enere : jazz
Jazzista d’avanguardia – c’è chi lo paragona, senza
falsi pudori, a Sonny Rollins -, musicista con alle
spalle quarantacinque anni di carriera spesi tra Stati Uniti e Italia, collaboratore di artisti come Rino
Gaetano – suo l’assolo di sax ne Il cielo è sempre più
blu -, Tony Formichella colleziona con Not Too
Long Ago nove spaccati di raffinato jazz d’autore.
Materiale in bilico tra fascinazioni latine (Africa) e
funk anni settanta (Perverso Blues e Shatto), toni caldi (Blue Blues) e rielaborazioni della tradizione (Saint
Lawrence), che oltre ad ammaliare con le sue cadenze misurate, rivela una classe figlia, soprattutto,
dell’esperienza. La si coglie nelle partiture ma anche nell’estetica ricercata dei suoni, con quel distendersi pacato del sax su fantasie minimali di batteria,
chitarra, contrabbasso, flauto traverso e ottoni. Una
musicalità che non pretende sforzi di comprensione fuori dal comune, non nasconde brutte sorprese,
non prevede stravolgimenti, ma vive invece di particolari e sfumature. (6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Van Morrison - Astral Weeks Live at
the Hollywood Bowl (Listen To The
Lion Records / EMI, 10 febbraio 2009)
G enere : folk soul
Se Van Morrison non avesse pubblicato Astral Weeks
lo rispetterei moltissimo ma non lo amerei quanto in
effetti lo amo. E la mia vita sarebbe indubbiamente
più vuota. Il primo a rendersene conto è proprio Van
“The Man”, che quaranta anni dopo quel prodigio
di vinile ha deciso di rendergli omaggio rivisitandolo
live per due serate - ovviamente sold out - all’Hollywood Bowl, in quel di Los Angeles, California.
Durante quei concerti è stato catturato il materiale
per questo Astral Weeks Live at the Hollywood
Bowl, titolo che inaugura l’etichetta personale di
Morrison, la Listen To The Lion. Disco che trasuda
un entusiasmo - va da sé - maturo, dove un disinvolto
delizioso horror vacui riempie gli interstizi con friniti
di viola, svolazzi di fiddle, trilli di mandolino, vampe di ottoni, palpiti
d’organo. Insomma
tutto un ricamare
sbrigliato e friabile
che non sovraccarica semmai spampana i bordi (e i testi) di
quei vecchi gloriosi
pezzi, stemperandone la densità in un rituale liberatorio, capace di sdilinquirsi con la disinvoltura del jazz-rock-soul andato (raggiungendo l’apice in Ballerina e in Listen To The
Lion, una delle due bonus track). In tutto ciò, la voce
del cerimoniere paga impietosamente dazio alle ere
geologiche trascorse, mostrandosi competente (e ci
mancherebbe) ma legnosa nelle movenze, pronta ad
affrontare le dinamiche più impervie ma depauperata del pazzesco bouquet timbrico che ricordavamo.
Insomma, ho una notizia per voi: la nostalgia è un
gioco tenero e crudele, sia quando finge di credersi
vera sia quando - come in questi casi - s’illude di non
averne bisogno. La differenza è sottile come il filo
delle emozioni, e tenace allo stesso modo. La differenza la fate voi. (6.9/10)
Stefano Solventi
Vetiver - Tight Knit (Sub Pop, 17 febbraio 2009)
G enere : folk pop
Smaltito ormai del tutto il flirt col prewar fricchetrecensioni /
91
Highlight
Svarte Greiner – Kappe (Type Records,
febbraio 2009)
G enere : dark ambient
Ritorniamo in Norvegia. Li dove fa sempre freddo e il
sole è un disco magro che non dà luce né calore. Avevamo
lasciato l’eroe del precedente disco Knive, un kafkiano e
ideale “signor K”, alle prese con boschi neri, flutti paludosi, corvi minacciosi e uno spirito d’assenza e abbandono, nella spaesata scenografia d’ambiente architettata da
Erik K. Skodvin. Nel 2009 assistiamo alla seconda parte
di questo immaginario e intangibile excursus. Il signor K è riuscito a tirarsi fuori dalla
selva oscura e pertanto questo sequel cambia buona parte dell’arredo di scena. I suoni
perdono quasi del tutto quel mood onomatopeico che si alimentava a sparsi e disparati
field recordings e inscenava gli andirivieni nella natura minacciosa. L’anelito metafisico verso l’alto è compiuto e il signor K si ritrova in una serie di malevoli e oscuri arredi interni,
con pesanti tendaggi d’archi e un florilegio di note sostenute nel vuoto. E’ questo il nuovo
trademark di Svarte Greiner: lasciare che le note cerchino una via d’uscita senza apparentemente trovarla. Da qui una sorta di pesante stasi armonica, costantemente ostile
e intimidatoria. I sette minuti iniziali di Tunnels Of Love viaggiano via verso riverberi ed
echi sempre più irraggiungibili e quando ti sembra di aver visto la via di fuga, ti accorgi
che dietro la tenda la finestra è murata. Rispetto al primo disco, Skodvin si è ulteriormente raffinato come ambiguo esegeta del mistero. Non cerca più di spaventare quanto
proprio di angosciare, calando ogni cosa in una nube di indeterminatezza. Ne sono
testimonianza i sedici minuti abbondanti di Candle Light Dinner Actress forti della mano di
Kjetil Møster degli Ultralyd e dei macabri riverberi d’oltretomba che si animano sulla
scia del Wendy Carlos di Shining, ideali traghettatori verso il climax sinfonico finale
di Last Light. L’ultimo segno di luce prima che arrivi il buio. (7.5/10)
Antonello Comunale
tone devendriano - mai troppo conclamato a dire il
vero - il quintetto californiano capitanato da Andy
Cabic torna a mettere in scena la consueta fascinazione folk, con piglio assieme frugale e alieno,
ovvero spendendosi con le movenze e i modi delle
ballate country rock ostentando la devozione e il
distacco di chi proviene da altrove. Mai come in
questo quarto album il punto di vista è sembrato
92
/ recensioni
- se me lo consentite - british. Difatti, oltre ai noti
rimandi George Harrison (la dolciastra intraprendenza di Everyday, l’indolenza acidula di Strictly Rule, lo sperso incanto di Rolling Sea), t’imbatti in
una Through The Front Door come potrebbe Badly
Drawn Boy invaghito Mojave 3, oppure in una
Strictly Rule che sembra i Belle And Sebastian di
Legal Man narcotizzati dal peyote Gomez. Quin-
di - su un altro piano di alterità - ecco scorrerci
davanti una mischia oppiacea Lennon-Flying
Burrito Bros (quella Sister che ricicla con svampita delicatezza Stand By Me), una fatamorgana
Califone parecchio ingentilita (il mantra folk tra
caligini elettroniche di Down from Above) e una At
Forest che ciondola soffuso abbandono velvettiano
altezza Loaded, per non dire di quella Another Reason To Go che strascica fiati e chitarrina liquorosa
su disincanto bluesy tipo l’ultima Cat Power. A
parte questa sensazione di riciclaggio tanto affettuoso quanto subdolamente po-mo, siamo dalle
parti di un intrattenimento ipnotico e carezzevole,
tutto sommato innocuo, con qualche pretesa psych
che ne sfuma in meglio i limiti e gli obiettivi. Da
ascoltarsi quindi come un buon lenitivo. (6.4/10)
Stefano Solventi
Claro Intelecto – Warehouse Sessions (Modern Love, gennaio 2009)
G enere : deep techno
Mark Stewart ritorna con l’attesissima compilation che raccoglie in CD i 5 vinili delle sue famose
sessions berlinesi (e aggiunge pure una postilla).
Se l’anno scorso ci aveva stupito per la sua raffinatezza ai confini con l’IDM con quel botto che
è stato Metanarrative, oggi questa antologia ci
conferma che il ragazzo ha uno stile. Punto. Anni
fa lo si sentiva poco, nascosto in qualche compilation o in qualche set che rischiava. Oggi non occorre più andare a inseguire le uscite in vinile o il
downoad selvaggio. La prova ce l’abbiamo qui. Il
suo moniker è più azzeccato che mai. Fa il furbo:
stare con un piede nella deep e non annoiare il
pubblico techno è dura. Mark ci riesce. Dal 2006
a oggi nelle sue corde sentiamo il compagno di etichetta Andy Stott e quel Maurizio come ombre
che assistono la darkness e la visione. Tutta gente
hypercool che sbanca con 4 battute e un po’ di
cassa caldissima. E allora via con la giostra fatta di
trance dub sporcata glitch à la Rhythm & Sound
(New Dawn), l’inno uberBerlin che è X (ascoltatevi
il passaggio in eco a metà e ditemi se non siamo
in zona Basic Channel), la spaventosa parata di
effetti di delay e panning in Instinct e per finire Hunt
You Down, 10 minuti che guardano nell’abisso del
minimalismo. Irresistibile e a tratti oscuro. Qui si
esprime la forza del club, senza alcun riguardo per
l’editing da album. Se l’anno scorso c’erano state
le Carl Craig, quest’anno ci sono le Claro Intelecto
Sessions. Altroché. Lasciamolo respirare. Lasciamolo fare.(7.3/10)
Marco Braggion
Wavves – Wavvves (De Stijl, gennaio
2009)
G enere : lo - fi beach - punk
Noise-pop in modalità lo-fi dalla assolata California. Nascondismo di default e isolazionismo fatto
bandiera ideologica. Immaginario retro-futurista
già ben noto – si veda alla voce Blank Dogs – ed
escamotage puerili – raddoppio delle consonanti,
nello specifico – che cominciano a mostrare la corda. Ce ne sarebbe per dire basta alla terza riga.
Però. Come in tutte le (in)certezze che si rispettino c’è il fatidico però. Però,si diceva, nonostante
tutti gli indizi giochino a sfavore, sto disco spacca
totalmente. Spacca davvero, e per un semplice fatto: perché al versante più synth-cold-wave di altre
sensazioni – si veda sempre alla voce di cui sopra
– Wavves oppone un immaginario di riferimento
totalmente bubblegum-pop. Le sue sono proprio
canzonette dalle melodie irresistibili; spinte, sconce, abbrutite, violate, sia quel che sia ma sempre
e solo canzonette irresistibili sono. Che vengano
totalmente trasfigurate da baccanali di lerciume
elettrostatico o deturpate da ritmiche pestone e
poverissime, beh, poco conta alla fin fine. Anzi,
aggiunge proprio quel nonsochè che porta l’etichetta
a definire questo suono the sound of today’s american
youth e noi a darle ragione. Nathan Williams, classe 1986, da San Diego – perché i misteri, nell’era
del 2.0, non esistono – ha messo su un dischetto,
riedizione della cassetta per Fuck It Tapes, niente,
niente male. (7.0/10)
Stefano Pifferi
recensioni /
93
William Elliott Whitmore - Animals
In The Dark (Anti, 17 febbraio 2009)
G enere : A mericana
Dovessi suggerire un disco al mio migliore amico voglioso di Americana, consigliando questo
Animals In The Dark andrei sul sicuro. Se mi
chiedesse qualche dettaglio, gli direi che col quinto album William Elliott Whitmore porta il suo
country nella zona franca che separa e unisce il
mainstream dall’alternativo, definendo con sempre
maggiore lucidità quella calligrafia fatta di tradizione integerrima, basata su un ristretto novero di
segni immediatamente riconoscibili, intensamente
tipizzati. Una fisarmonica, l’hammond, il dobro,
quella voce che sembra appena strappata al ventre
della terra, alle inquietudini e alle speranze covate
sotto al front porch. E la morbidezza, soprattutto la morbidezza con cui accoglie stemperandola un’ebbrezza black, tanto che - volendo tagliare
un paragone con l’accetta - sembra posizionarsi
rispetto al soul e al blues come Ben Harper si
pone rispetto al folk-rock. Quale esempio porterei
senz’altro la trepida There’s Hope For You, oppure i
tremori espettorati da Who Stole The Soul e Let the
Rain Come In. Inoltre direi buone cose sulla disarmante fierezza che pervade l’invettiva corsara di
Mutiny, così come sulla grana redneck fragrante e
priva di boria di Johnny Law e Lifetime Underground.
Infine lo rassicurerei, che in certi casi la genuinità
la senti a pelle, capisci quanto profondamente è
radicata anche dalla serenità con cui si disimpegna
tra un malanimo e l’altro. Questo è uno di quei
casi. (7.0/10)
ultima band, Hidden Hand, infatti, l’ex chitarrista
di Obsessed e Saint Vitus, gruppi che hanno
scritto le prime pagine della storia del doom, ha
pensato bene di provare la strada solista, firmandosi con il solo nomignolo. L’approccio è un po’ disorientante per la varietà di elementi messi in campo. L’impronta doom conserva la sua influenza su
un lavoro che accosta con disinvoltura, ma anche
con cognizione di causa, la psichedelia (Wild Blue
Yonder) l’acid blues (Release Me), il funk-metal (Smilin’ Road) e il Thrash
(la Title-Track; The
Woman In The Orange Pants), mentre un
brano come Eyes
Of The Flesh ricorda quanto siano
debitrici (ieri come
oggi), le correnti più
oscure del metal, ai
primi Black Sabbath. Non mancano le cadute
di stile, come il rock un po’ amorfo di Secret Realm
Devotion, e gli stereotipati momenti di intimità con
la chitarra (Water Crane e i vari assoli-fiume un po’
noiosetti) molto comuni tra i chitarristi metallari.
Ed abbondano le soluzioni scontate e decisamente
retrò, prevedibile richiamo alle migliori cose fatte
in passato da Weinrich. Ma c’è da tenere conto
anche, che non ci troviamo di fronte l’album di
un povero cristo invecchiato e all’ultima spiaggia,
ma di un musicista stagionato che qualcosa da dire
ancora ce l’ha. Al di là di tutti i possibili, probabili
e concepibili momenti revivalistici (6.4/10)
Stefano Solventi
Daniele Follero
Wino – Punctuated Equilibrium
(Southern Lord / Southern, gennaio
2009)
G enere : metal e dintorni
Yussuf Jerusalem – A Heart Full of
Sorrow (Floridas Dying, dicembre
2008)
G enere : garage folk noir
Dopo venticinque anni di carriera, Scott “Wino”
Weinrich, chitarrista dal passato glorioso negli ambienti metal, ha deciso di fare per la prima volta le
cose da solo. A seguito dello scioglimento della sua
Cosa unisce le tonalità oscure di un certo neo-folknoir con quelle più ruvide, ma anche più solari, del
garage-country-rock? Il disco di Y ussuf Jerusalem
– primo LP di Floridas Dying – da una risposta
94
/ recensioni
ed una testimonianza in questo senso. Questo misterioso gruppo francese (le foto dei live rappresentano un trio, ma potrebbe essere una soluzione
solo per i concerti) arriva al debutto con un album
che fa piazza pulita di ogni purismo di sorta, offrendo in prima battuta una luttuosa copertina che
sembra provenire più dal più tetro e putrido underground black metal che dai circuiti del garagepunk. E su quell’asse si continua con l’opener Gille
De Rais che fa subito tornare alla mente i Celtic Frost nel nome e band ben più estreme come
i primissimi Emperor nel sound. Con il secondo
pezzo, che da il titolo all’album, cambia tutto: chitarre acustiche celticheggianti si sposano con linee
vocali dal sapore di Midwest statunitense, quella
tradizione americana che arriva fino a Lanegan e
Woven Hand.
Da qui si continua con ballate di alto impatto emotivo e di lodevole fattura in cui acustica, elettrica
ed elettronica si mischiano alla perfezione, sempre
in un sottile ma mai precario equilibrio; e allora la
tradizione dei cantautori folk americani (The One
You Really Want) si ricongiunge con i suoi esiti
moderni (We Aint Coming Back ricorda i GoodNight Loving) senza per questo dimenticarsi di un
certa canzone popolare medievale (The End Of
Tomorrow), il tutto intervallato solo dall’obliquo
interludio pianistico di Jihad. Negli ultimi anni raramente Death In June e Roky Erickson, Current
93 e Neil Young sono stati così vicini come nei solchi di questo disco. (7.5/10)
Andrea Napoli
Zeitkratzer – Volksmusik
(Zeitkratzer Records, 2008)
G enere : avant - folk
Ribalta i canoni cari alla scrittura classica del primo ‘900 l’ensemble berlinese Zeitkratzer, e si concede alla direzione di Reinhold Friedl, nel tentativo inesausto di rompere gli schemi.
In Volksmusik è una evidente matrice folk che
attraversa i confini di Austria, Bulgaria e Romania a dettare i tempi di una musica complessa ma
per nulla cerebrale. Nessun atteggiamento nu-folk
e neppure leziosi orpelli strumentali, ma vere e
propria avanguardia in chiave popolare che sembra non rinunciare nemmeno alla presa diretta.
L’impatto è notevole, anche se ad alcuni potrebbe
sembrare trasgressivo per le dissonanze da live, tra
ritmi incalzanti, rallentati o trattenuti a mezz’aria.
Con le vibranti danze di Batuta, le ancestrali rivisitazioni di Picior, la lettura jazz di Mountain e le percussioni tzigane di Bouchimich si abbattono le frontiere di un genere ormai ben radicato negli archivi
sonori di Volksmusik, a conferma anche questa
volta che l’originalità premia. (8.0/10)
Sara Bracco
Zomby – Where Were You In ‘92?
(Werk Discs, novembre 2008)
G enere : hardcore rave - step
Tempo fa un personaggio senza nome usciva in
sordina e ci sfornava un capolavoro del dubstep.
Si chiamava Burial. Solo dopo qualche tempo si è
capita a fondo la potenza del suo esordio. Oggi un
altro che ama nascondersi esce con un disco che
ha qualcosa in più. Lui dice di chiamarsi Zomby.
E fa hardcore. Fin qua niente di sorprendente. Eh
no, dico io! Fare hardcore oggi è come spararsi addosso. Bisogna avere le palle quadre per riproporre ancora una volta le sonorità della generazione
E. Zomby ce la fa e ci sforna il disco che mancava
per iniziare degnamente il 2009. Anche se uscito
alla fine dell’anno appena terminato, questa chicca
entra nel mondo dubstep e lo sfalda in modo inaspettato. Per cui ce ne freghiamo e lo recensiamo
ora, consapevoli che ne sentiremo riparlare. Ma
che cos’è quest’album? Solo un ricordo del rave?
Come già detto in numerose recensioni e speciali,
la cosa per cui ci si distingue oggi è la capacità di
meshing e di rifrullo della storia. E allora se in certi
punti non si può prescindere dalla cupezza (vedi la
citazione dal monologo più famoso di Blade Runner in Tears In The Rain), il grosso di queste 14 tracce esula dalla grimeness e ci riporta direttamente
a contatto con il rave. Tutti quei break spezzati,
recensioni /
95
quei laser che ci attraversavano la mente e quelle tastiere robotiche sono di nuovo atterrate. Le
mitiche sirene à la O.R.B. in Get Sorted, le vocine
velocizzate in We Got The Sound, i beatz superblack
con le voci acute che tanto piacciono al popolo del
drum’n’bass (splendide in Float), il trucco nerdy
che non muore mai (il remix dello Street Fighter Theme). Il resto è un omaggio palese al rave. Ma se il
tributo è fine a se stesso non ci smuove più. Zomby
è invece un vulcano che sta per scoppiare. Perché
con questa mossa disconosce e rifonda in modo
furbissimo le sue origini dubstep. Una mistura intelligente che colpisce il trentenne e che spopolerà
nel popolo di head bangers che nel 92 non era ancora nato. We were with you, Zomby.(7.5/10)
Marco Braggion
Zu – Carboniferous (Ipecac, 17 febbraio 2009)
G enere : jazz core
Zu non sbaglia un colpo. Non ci pensa neanche
la band romana ad indietreggiare e non pare per
niente propensa a fare passi falsi. Dieci anni di
dischi, critiche positive e tour in tutto il mondo,
non sono riusciti ad appagare il trio romano, che si
tiene distante dalla tentazione di accomodarsi sui
famigerati allori. Dieci anni durante i quali Mai,
Battaglia e Pupillo le hanno provate davvero tutte, trovando il coraggio, di volta in volta, di ricominciare da capo, facendo si che ogni esperimento
potesse godere di vita propria. La formula del 3+1
(con il trio a costituire la struttura di svariate collaborazioni) ha concretizzato questo spirito progressivo, creando incroci “pericolosi” che di volta in
volta hanno parlato un linguaggio diverso. Thurston Moore, Steve MacKay degli Stooges, i
jazzisti Ken Vandermark, Han Bennink e
Mats Gustafsson, Nobukazu Takemura, il
violoncellista Fred Lonberg-Holm, la band hip
hop Dälek, sono solo alcuni dei nomi che hanno
vestito i panni del “quarto Zu”, influendo radicalmente sulle idee del trio ostiense Carboniferous è
un disco importante, un ennesimo punto di svolta.
96
/ recensioni
E per vari motivi. Intanto perché, come prima si è
accennato, piazza la decima candelina sulla torta
di una carriera discografica di tutto rispetto. Poi
perché segna l’inizio
della collaborazione
di Zu per la Ipecac
di Mike Patton,
coronamento
di
un incontro musicale già rodato dal
vivo durante il tour
con la doppia band
Melvins-Fantomas. Terzo, perché per la prima
volta non c’è un “quarto”, almeno in organico.
Già perché di ospiti illustri ce ne sono comunque.
A parte lo stesso Patton, che presta la sua voce
trasformista e un pizzico di Mr. Bungle alla causa (come definire altrimenti le atmosfere schizofreniche di Soulympics e Beata Viscera?), si aggiunge
al gruppo anche la chitarra di King Buzzo (Buzz
Osborne) dei Melvins.
Le soluzioni di questa bizzarra equazione sorprenderebbero anche il più scettico. La durezza metal
e i tempi quasi doom, caratteristici del sound del
trio, che trovano espressione nelle atmosfere dark
di Chthonian e Carbon, lasciano spesso e volentieri il
posto a velocissime cavalcate math-noise (Ostia), a
follie hardcore alla Naked City (Erinys), arrivando a spingersi fino all’ambient delirante di Orc. Un
pot-pourri coerente, nel quale neanche per un attimo si perde la bussola dello stile che ormai i Nostri
hanno scolpito nella roccia di un sound granitico,
spigoloso e ormai assolutamente inconfondibile.
(8.0/10)
Daniele Follero
recensioni a confronto
zZz – Running With The Beast (Anti / Self, dicembre 2008)
G enere : wave / post - punk
Mi chiedo dove sia l’hype e soprattutto il buon
gusto. Il duo olandese costituito da Daan (organo) e Tjess (batteria e voce) varca con imbarazzo
il dancefloor rock degli ‘80 con numeri che sanno
di liofilizzato batcave, scimmiottando dove è lecito
i Sucide, senza chiaramente sfiorare la profondità ed il fascino del duo Rev/Vega. Del resto se
gruppi “cartoon“ come gli MGMT (visti lo scorso
anno al Primavera Sound di Barcellona meritavano una simpatica tanica di benzina a bordo palco)
riescono ad ammorbare le fantasie di critici e fruitori deve pur esserci qualche tarlo.
Il migliore duo con questo tipo di
strumentazione rimangono i Silver
Apples, concedetemelo, una sola
nota per mettere a tacere la prova di
questi pur volenterosi ragazzotti dai
Paesi Bassi. Non posso non pensare
alla schizofrenia dei primi Rah Bras
od alle pur contagiose evoluzioni
dei Dance Disaster Movement, che mai hanno
usufruito di una distribuzione “major“ ed hanno
finito per occupare le poco ambite stanze del dimenticatoio. Volete ascoltare un organo creepy?
Beh, allora risentitevi il buon vecchio Ray Manzarek, anche quando si affacciava in Los Angeles degli
X o – se desiderosi di un esempio contemporaneo
– Maya Miller dei Religious Knives. Ammiccanti
e oscuri, su questo binomio costruiscono la loro
fama gli zZz, risultando in ibridi discutibili come
Amanda, un qualcosa tra i Joy Division e l’Iggy
Pop di Cry For Love. Spoil The Party è forse uno dei
brani più spinti e muscolosi con una pressante cassa in 4, troppo poco per ambire ai luoghi culto
della disco moderna, troppo derivativi per aggiungere note alla grande tradizione wave britannica.
Da rivedersi. (5.0/10)
Sulle prime, il nuovo lavoro degli olandesi Zzz suona come l’ennesimo gruppetto di maniera neo-wave preceduto dal suffisso “The” (Departure, Editors
e via discorrendo). Anzi, se ci soffermassimo alla
sola traccia inaugurale, Lover, non potremmo che
pensare ad un clone bramoso di gloria parimenti i
The Killers. Ma Running With The Beast, col
passare degli ascolti, si manifesta disco sinistro e
spigoloso. Prendiamo ad esempio la voce: giocata
su varie tonalità di nero, talvolta evoca lo spauracchio di Ian Curtis (la ballad finale Islands) e tal’altra
il luciferino baritono di Alan Vega (il
boogie di Grip). La ritmica gravita su
registri post-punk epico alla maniera
dei Simple Minds periodo Empires
and Dance (Spoil The Party) o stile
Psychedelic Furs dei tempi moderni (Angel, con tanto di sax in coda),
senza lesinare digressioni à la Man
or Astro-Man? (Sign Of Love), sortite
swamp-wave (Majeur), acidi pastiche pop tra Beatles e Beta Band (The Movies) e invettive space-rock
(Sign Of Love, Running With The Beast) che, riversate
in ambiti new wave, non possono che mirare ai
mitologici Chrome. Fortunatamente la prima impressione è stata smentita. L’onda lunga del suono
a cavallo tra ’70 e ’80 non si spegne, e finché non si
intravedono cloni di A Flock Of Seagulls all’orizzonte ci sta bene così. (7.5/10)
Gianni Avella
Luca Collepiccolo
recensioni /
97
live report
Jamie Lidell – Live @ Velvet, Rimini
(24 Gennaio 2009)
Live: Squartet + Testadeporcu –
Traffic, Roma (15 gennaio 2008)
Nessuna band, solo un gregario al piano, all’organo
e ai svariati tricks. In una parola “soul”. Quello di
prim’ordine, quello con anima vibrante e corpo trascinato al movimento. Quello che si porta dietro la
storia tutta di un genere e non la offende, vedendola
anzi omaggiata da una vocalità fuori dall’ordinario
e da un savoir-faire on stage che elettrizza l’imberbe
ascoltatore che non sa quello che potrà attendersi.
E Jamie, un novello Stevie Wonder bianchissimo,
tiene il palco benissimo con le sue smorfie e le sue
movenze da autistico completamente inebriato dal
proprio senso del ritmo che esterna al meglio facendosi “human beat box”, basi e bassi grossolani
partoriti dalla bocca ma rigorosamente a tempo che
registra e campiona sul momento per crearsi una
fondamenta da cui sprizzare tutto il suo dilagante
entusiasmo, che è tangibile poiché non filtrato. Certo la formula “beat campionati + vocalismi” può
allettare (e lo fa eccome) ma alla lunga tende a risultare un tantinello monotona e la fruizione dei pezzi
(principalmente presi, come ovvio, dall’ultimo Jim)
talvolta richiamano la mancanza di una vera e propria fullband alle spalle. Tanto basta però per assaporare qualche brivido e sentirsi per una volta “neri
dentro”, quando soprattutto si arriva ad un finale
da singalong col pubblico sulle note di una “Another Day” a cappella, di cui prendere e stampare il
testo da esporre sullo specchio come monito positivista al fine di cominciare al meglio ogni singola
mattina. Insomma un figlio della tradizione e della
bizzarria dell’artista a tutto tondo che per fortuna
è ben attaccato al comunicare le proprie sensazioni, forse più dal vivo che su disco. E come si dice,
“quando lo spettacolo si fa emozione”…
Rome is burning. Una nebbia padana sorprende i cieli stellati della capitale e avvolge il Traffic
tutt’intorno. Il locale, dopo il restyling del piano
inferiore, si è assestato in un accogliente mood anglofono anche su quello superiore. Niente più poster grindcore, locandine di gruppi emo né gadget
giovanilisti. Siamo adulti e un po’ navigati, quindi
largo all’ordine e alla pulizia. Stasera assisteremo
all’esibizione di due delle costole della Jazzcore
Inc.: Squartet e Testadeporcu. Romani e con un
disco uscito di recente i primi (Uwaga!, Jazzcore
Inc, 2009), bolognesi e in procinto di entrare in
studio i secondi. Come da copione capitolino, il
concerto inizia tardi; i tre Squartet, Manlio Maresca alla chitarra, Fabiano Marcucci al basso
e Marco Di Gasbarro alla batteria, prendono
possesso del palco mentre dalla consolle fa capolino la testa rasata di Mr. Jamming (soundman e
componente del gruppo ad honorem). Inaugura la
scaletta Il piccolo samaritano, seguita da vari estratti
da Uwaga! (Perky Pat, L’infame, Sexy Camorra). Il trio,
compattissimo, attacca, sbanca, si ferma, cambia
ritmo, ricomincia. I pezzi scivolano metronomici
e goliardici uno dentro l’altro, supportati dal genio
chitarristico di Maresca che rimanda tanto a certo virtuosismo pre-war quanto al rock e al punk,
il tutto annegato in un fertile territorio jazz, regno di febbrili ostinati e cambi di tonalità. Il basso
emette delle bordate sì massicce e armoniche che
quasi non ci si accorge che nei primi pezzi l’ampli
sull’impianto è off. E la batteria è il cuore pulsante
nella corsa scatenata dietro ad un autobus di periferia che va a tutta velocità. Altro che attitudine
punk, qui si prende il testimone di gruppi come No
Means No, Pak e Victims Family sfoderando
Alessandro Grassi
98
/ recensioni
© francesca garattoni
jamie lidell
però un alto tasso di personalità. Musica tosta ma
fruibile, intelligente ma mai leziosa, schietta come
la romanità, energica e contagiosa.
Chiudono il set Radau e un pezzo nuovo, con Carlo Conti (Neo) al sax e il suo dialogo overlapping
con il funk della sezione ritmica.
Dopo una breve pausa si torna giù e, come per
accoglierci al meglio, partono le basi un po’ losche
dei Testadeporcu aka Diego D’Agata (basso, exSplatterpink) e Claudio Trotta (batteria, già
Deus Ex Machina, storica prog-band che forse
qualcuno, più attempato della sottoscritta, ricorderà). I Testa sono un monolite spaccato e ricomposto un’infinità di volte e se la forma e il colore
sono quelli di un grindcore “anomalo”, dalle crepe
fuoriescono gli adorati spettri della contemporaneità. Non a caso i due definiscono la loro musica
punktemporary, punk-temporanea. Ed è il tempo
il terreno dove si gioca un po’ tutta la partita: pezzi
velocissimi, stoppati all’inverosimile, dove la schirecensioni /
99
zofrenia jazzcore mostra ora la maschera tecnica
ora quella iconoclasta. Il tutto accompagnato da
un atteggiamento ironico, di metacritica nei confronti del punk e della musica contemporanea di
matrice intellettuale. Sicuramente meno digeribili
dei romani, ma senz’altro coinvolgenti e da approfondire. All’uscita seguono rituali di aggregazione,
finchè il Traffic chiude le serrande e un singolare
personaggio con una farfalla in testa cerca di convincerci ad accompagnarlo a ballare l’house. Vagli
a spiegare che oltre a vivere veloce bisogna morire
vecchi. Vagli a spiegare che Roma brucia.
Francesca Marongiu
Adem (Velvet, Rimini, 29 gennaio
2009)
Non ci dovrebbe essere bisogno d’altro che di una
bella voce e di un’atmosfera piacevolmente rilassata, quando si assiste ad un concerto con pochi
adem
100
/ recensioni
intimi. Che le corde dell’anima siano toccate in
santa pace senza alcun filtro; poco importa se parte delle canzoni qui proposte non sono autografe,
ma quando la resa possiede una fedeltà emotiva
tale da riempire il cuore, si ha la netta certezza che
l’obbiettivo prefissato è stato raggiunto, almeno
osservando i volti degli astanti.
Ad accompagnare il simpatico turco-inglese Adem
Ihan ci sono due ospiti d’eccezione che si rivelano
decisive per la resa dell’intenso live: Nancy Elizabeth – già esordiente per conto della Leaf fra folk
ed incanto un po’ alla Joanna Newsom – allo
xilofono e all’organo e Sarah Jones – batterista dei
new wavers New Young Pony Club e dei “nuovi” Bat For Lashes – dietro le pelli.
Un inizio in punta di piedi e una voce toccante,
quella del Nostro, che comincia in solitaria prendendo per mano la sua acustica e la sua timidezza,
e traghettando in soffici momenti sonori sulle onde
di Love And Other Planets e della splendida Long Drive
Home, per poi abbracciare la minuta folla quando
il trio si compie, grazie ad armonie vocali pulite e
veramente rare. Dall’ultimo Takes scorrono le celebri Hotellounge e Tears Are In Your Eyes che vibrano
di nuova vita nelle corde del gruppo, per poi giungere alle celestiali derive di Slide di Lisa Germano
e prendere vigore ed energia in Everything You Need
e Launch Yourself. Epico il finale sulle note di Laser
Beam dei migliori Low che dalle mani del terzetto
arriva diretta e pregna di emozione fra un falsetto
di Adem e note solitarie di chitarra. Per una serata
dove l’essenzialità del folk funge da pennello per
dipingere un’atmosfera calda e complice, viene da
sorridere per la gioia, considerando quanto a volte
sia necessaria la semplicità solo stando a guardare
la grazia di Sarah che pacatamente, per tutto il
tempo, ha usato come grancassa una valigia…
Alessandro Grassi
Giant Sand – Circolo Magnolia, Milano 02/02/2009
Parafrasando Forrest Gump, assistere a un concerto dei Giant Sand - o di Howe Gelb, che poco
cambia - equivale ad aprire una scatola di cioccolatini. Nel senso che non sai mai bene che farà e
come lo farà: un pregio/difetto connaturato al suo
rapportarsi alla musica in modo arruffato, sfruttando il caso e il momento. Se l’ispirazione c’è e
i sodali sono all’altezza (nello specifico i danesi
Thoger Lund al contrabbasso, l’abile Peter Dombernowsky dietro la batteria e il chitarrista Anders
Pedersen, più la concittadina di Gelb Lonna Kelley
- sguardo perso degno di David Lynch e incinta di
un paio di mesi - alla seconda voce) può nascere la
serata memorabile, dove si passa come nulla fosse
da rock turgidi e aciduli a siparietti pianistici ragtime, da ballate country impolverate al jazz-lounge,
talvolta tutto insieme splendidamente. Altrimenti
tocca sorbirsi uno sbraco approssimativo, i cui artefici paiono vagare autonomamente dietro a una
bussola smagnetizzata.
Come con ogni album cui il Nostro ha messo
mano in venticinque anni di carriera, insomma,
tutto il bello (tanto) e il brutto (poco, per fortuna)
stanno in questo acuto understatement, nel gioco
- tratti somatici e sguardi luciferini ma sornioni inclusi - con la musica americana, seguendo le regole peculiari di un enciclopedismo simpaticamente
sconclusionato. Gli ci è voluto del tempo, a Howe,
per riuscire a tramutare questo ipotetico limite in
un tratto caratteristico che lo rende riconoscibile e
addirittura geniale. Anche quando gli impasti vocali traballano un po’ o, all’inizio del concerto, la
sezione ritmica e l’armonia suonano scollate. Basta poco per scaldarsi, tuttavia: tra un aneddoto e
un inedito, una toccante The Desperate Kingdom Of
Love sottratta a P. J. Harvey e il medley prelevato
dal sottovalutato Rock Opera Years, arrivi all’ora e
mezza che manco t’accorgi. Allampanato, baffuto
e di residenza desertica, Gelb ricorda Spike, il fratello di Snoopy. Rispetto al quale ha contraccambiato la scalogna con una creatività che scintilla sì
a intermittenza, ma che quando brilla scioglie la
neve nell’anima come poche altre. Lui non se ne
preoccupa, visto che da tempo ha capito di essere
- e difatti ce lo canta pure… - quel che si definisce
un classico.
giancarlo turra
recensioni /
101
WE ARE DEMO
#33
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati dai vostri devoluti redattori di
S&A. Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Shabadà Orchestra - EP
Quattro tracce per cambiare idea riguardo alla
patchanka, ricettacolo di sonorità parecchio abusate
in chiave combat folk al punto da provocarci l’orticaria al solo sentirla nominare. Ma, appunto, gli Shabadà Orchestra arrivano ed è un balsamo, un unguento,
un bicchiere di rhum e polvere da sparo. Aromi mediterranei imbizzarriti, estro balcanico, sentori marsigliesi e aspro spasmo black (errebì + Africa), il tutto
cucinato nel calderone partenopeo che non significa
autoghettizzarsi nel dialettale, infatti l’inno tabagista
40 sigarette potrebbe benissimo essere un Capossela
incazzato e sbarazzino, mentre la sordidella e bluesy
Il gabbiano affonda il bisturi nella piaga strattonando
locale e universale come una favola noir. Tutto in loro
è contagioso, dalla voce - a metà strada tra Peppe Voltarelli e Rocky Roberts - alla foga sferzante della chitarra, dalla ruspante collusione sax-fisarmonica (con
sorprendenti link a certo jazz etiope) ai nomignoli
che si sono scelti (roba tipo Sdugtmbò e LuAplles). Si
attende a breve l’esordio su lunga distanza. Qualcosa
mi dice che non passerà inosservato.(voto:7.2/10 myspace.com/shabadaorchestra ) (s.s.)
Omosumo – Promo EP
Scartabellando tra i crediti di questi Omosumo finiamo per scoprire alle chitarre un Roberto Cammarata già passato per We Are Demo con gli ottimi
Waines e al basso un Settimo Serradifalco, principale
attivista del progetto Donsettimo. Artisti, entrambi,
di buon livello, a cui si aggiungono Giuseppe Megna
alla batteria e un Angelo Sicurella alla voce definito
dalle note stampa come “il miglior cantante rock di
Palermo”. Sia come sia, un fatto è certo: l’EP in oggetto punta i riflettori su una formazione che mostra
carattere da vendere, pur frequentando compagnie
poco raccomandabili per gli amanti dell’originalità
a tutti i costi. Nello specifico, new wave (Sensazioni di
102
/ recensioni
libertà), post-punk, ma anche blues e hard (quasi) à
la Led Zeppelin (Industriale e Di terra e di me), filtrati
da una scrittura che riesce nell’impresa di mescolare
le carte per suonare, infine, originale. (voto: 7.2/10
myspace.com/omosumo ) (f.z.)
Dresda – We Are The Superfunkers
Più che post-rock, malinconie strumentali concepite
per pellicole struggenti, crescendo umorali su arpeggi
rinsecchiti, stratificazioni in punta di plettro intense
ed evocative. Il nome è Dresda – ripreso dall’insuperabile Mattatoio n.5 di Kurt Vonnegut – e l’ideologia
che serra le fila pare essere quella di “descrivere ambientazioni con la musica per rendere i suoni parte
di una scena a più dimensioni”. Tra field recordings
e elettriche urticanti, tastiere e glockenspiel, basso e
theremin, i quattro genovesi riescono nell’impresa,
alternando momenti di stasi a distorsioni violente e
consegnando ai posteri un Ep inquietante e catartico.
(voto: 7.1/10 myspace.com/wearedresda )(f.z.)
Giuda Matti - EP + Il trittico del
male
Quartetto modenese - e non fanno nulla per nasconderlo - i Giuda Matti vantano un repertorio breve ma
impudente, EP del 2008 e il recentissimo Il trittico
del male. Nel primo fregola punk-pop-folk in guazzo sixties come dei Blur circuiti da Ivan Cattaneo e
strattonati da mancanza di riguardo Skiantos, nel
secondo uno spurgarsi l’anima in tre atti senza soluzione di continuità, rievocazioni beat tra il perverso e
lo scazzato (con tanto di pronuncia paraenglish alla
Mal), oppure una versione demenzial-psych e ingrugnita degli Offlaga Disco Pax. Che è un po’ come
cercare nuovi modi di circoscrivere l’ennui periferico prima della bucolica (falsa) resurrezione finale. In
loro c’è del tragicomico che non posso fare a meno di
adorare.(voto:7.0/10 myspace.com/giudamatti) (s.s.)
Sundance Capoeira – A Low Choice EP
C’entrano i Giardini di Miro’ e Il Nucleo, dal momento che in
formazione militano il bassista dei primi, Mirko Venturelli, e il
bassista dei secondi, Mauro Buratti, ma questi Sundance Capoeira, nonostante alcune analogie nell’approccio alla musica, fanno
storia a sé. Anche perché il post-rock qui si trasforma in digressioni
eteree e inafferrabili, suoni morbidi e ovattati, sulle ali di una voce,
quella della svedese Karin Nygren, che funge da collante armonico tra gli strumenti. La vena è inaspettatamente pop – nei limiti
concessi da una forma che privilegia le sfumature -, l’incedere lento e avvolgente, il sentire decisamente godibile, figlio certo dell’esperienza dei musicisti coinvolti
ma anche di un tocco magico che riesce a semplificare una musica per sua natura raffinata e
complessa.
(voto: 7.3/10 web: myspace.com/sundancecapoeira ) (f.z.)
Formanta! - F! EP
Assieme dall’estate del 2008, i romani Formanta!
sono un quartetto col pallino per l’indie pop viziato
wave, roba garrula ma tesa, graffiante ma con una
sua gentilezza di base, informata alla nostalgia degli anni in cui ti capitava di intercettare nelle radio
e sulle piste da ballo le ultime fatiche di Blondie o
Smiths, di Pretenders o Television, però con quella
disinvoltura che ti regala un approccio autorevole e
sbarazzino alla materia. Ovvero: ci vogliamo seriamente divertire, secondo la lezione Broken Sovial
Scene e Blonde Redhead per intenderci. In mancanza di intuizioni davvero geniali - nelle cinque
tracce di questo F! si raggiunge al più un’intrigante
gradevolezza - mi sembra un buon punto di partenza.(voto:6.9/10 myspace.com/formantamusic ) (s.s.)
confluiscono i retaggi prog-rock di entrambi. Detto che ad aiutarli intervengono il basso di Andrea
Castelli e le voci di Elena Antonelli e Alice Bardini,
direi che il risultato finale è un ineffabile ibrido tra
i Massive Attack più atmosferici, un pizzico di Popol Vuh stregati Cocteau Twins, Steve Roach alle
prese con fregole etno, i Floyd persi in un sogno
industrial-psych. A tratti sfiorano certa deprecabile
effettistica new age, ma in genere riescono a mantenersi aggrappati ad un’idea estetica abbastanza
precisa, solenne e suggestiva. Malgrado non sia il
mio genere, mi sono piaciuti. Vorrà pur dire qualcosa.(voto:6.8/10www.vicolomargana.it/(s.s.)
Vicolo Margana - A Perfect Life
I Vicolo Margana sono sostanzialmente un duo,
Francesco Antonelli e Fabio Bizzarri, attivi dai primi anni settanta e quindi non proprio debuttanti
allo sbaraglio, però è fresco questo loro progetto che
esordisce appunto con A Perfect Life, undici tracce all’insegna di una calda electro ambient in cui
recensioni /
103
The Smiths
Teenwave Pop
Gli Smiths sono tornati a far parlare di loro: in primis con l’attuale uscita dell’ultimo album di
Morrissey, indirettamente con la pubblicazione della Rhino di un cofanetto contenente tutti i loro
singoli in versione originale, e (forse) direttamente per il vociferare di una loro possibile reunion.
Quale occasione migliore per tornare a parlare della band che ha fatto la storia del pop, brit e non
solo, e del suo mondo “acquatico”?
Testo: Andrea Provinciali
104
/ Rearview Mirror
Non avete mai visto fare surf a Manchester, grigia città del North West dell’Inghilterra? Peccato,
perché un mercoledì (da leoni) di quasi trent’anni fa l’aria divenne improvvisamente limpida, la
primavera esplose prematuramente e una grande
onda, di dimensioni gigantesche, raggiunse il cuore metropolitano con il suo incedere irrefrenabile. In quel momento quattro ragazzi qualunque
si fecero trovare pronti all’appuntamento, e cavalcarono quell’onda per alcuni anni, disegnando
solchi sublimi che innaffiarono la loro città prima,
l’Europa poi, il mondo intero infine, come se non
avessero fatto altro nella loro vita. Certo, non tutto
dura all’infinito, ma fin quando riuscirono a domare a loro piacimento quell’incontenibile massa
d’acqua, beh, bisogna ammettere che fecero immedesimare molti nella loro impresa, portandoli
metaforicamente con loro lassù, su quella cresta
esuberante. Perché quella non era un’onda qualunque, era quella eterna dell’Adolescenza che da
sempre e ovunque avvolge tutti, lasciando dietro
di sé vortici di rimpianti, ricordi, sogni e illusioni.
Ma, si badi bene, qui adolescenza è da considerarsi con la A maiuscola. Infatti, in una società dove
i principi e le certezze sono smarriti, questa condizione vitale si dilata all’infinito perdendo la sua
limitata accezione temporale. E gli Smiths sono
riusciti a formalizzarla e sublimarla perfettamente
in canzoni pop da tre minuti che proprio come il
moto ondoso hanno invaso tutto e tutti, nel tempo
e nello spazio, fino ad oggi.
Questi signor Rossi qualunque, questi ragazzi della porta accanto, fin dalla pubblicazione del primo
singolo, hanno parlato a generazioni su generazioni, determinando tuttora il panorama musicale,
pop e non solo, inglese e non solo. A loro devono
moltissimo band come Housemartins e The
Wedding Present prima, The Stone Roses
poi, Suede, Blur e Pulp pochi anni più tardi, ma
anche il college rock e le miriadi di gruppi emocore oltreoceano sul finire dei Novanta; non solo,
addirittura compagini post-hardcore e post metal
come Quicksand e Deftones hanno dichiarato
Rearview Mirror /
105
tutto il proprio amore per Morrissey e Co.
Le loro canzoni hanno espresso il linguaggio
dell’amore, quello ideale ma disperato perché difficilmente avverabile, riposizionando l’uomo e la
sua sfera personale al centro di tutto. Una vera e
propria romantica rivoluzione pop, per i canoni estetici imperanti
all’alba degli Ottanta.
Per quattro anni, la
loro spinta artistica è
riuscita a tener testa a
quell’onda irrefrenabile, ma poi - si sa - il successo forse arricchisce
economicamente ma
spegne interiormente
e quel moto sinusoidale ha continuato la sua
corsa disarcionandoli
in maniera definitiva.
Giusto così: l’alba e il
tramonto, il giorno e la
notte, la vita e la morte fanno parte della quotidianità, della natura e
dell’umanità, e chi più della band mancuniana
ha espresso meglio questi concetti? Per cui sentir
vociferare oggi di una loro possibile reunion ci
fa sorridere amaro, perché sappiamo bene che le
canzoni da loro scritte in quegli anni continuano a
propagarsi e a consolarci come lunghe onde infinite. Non saremmo surfisti, ma quel dolce suono di
risacca ci fa sentire come in cima alla cresta pronti
per l’adrenalinica discesa. E no, non pensiamo che
dei redivivi Smiths possano rievocare ciò che fu,
ciò che è stato e ciò che sarà per sempre.
H and I n G love
Manchester, primi anni Ottanta, piena era post
punk. C’è un ragazzo col ciuffo, eccentrico e motivato, che orbita intorno all’ambito musicale della
città, ne scrive su alcune riviste locali, ma soprattutto ne incarna lo spirito più fanatico: diviene ad106
/ Rearview Mirror
dirittura presidente del fan club inglese delle New
York Dolls. Assiste a ogni concerto, aiuta le piccole case discografiche, cerca in ogni modo di alimentare quel fermento artistico che sente intorno
a sé, che sente dentro di sé. Si chiama Stephen
Patrick Morrissey “Moz”, è nato
il 22 maggio 1959
e ha forti e radicate
origini irlandesi.
Questo narrano
le cronache, ma
in realtà tutto si
è originato prima, molto prima,
quando un timido
ed effeminato ragazzino, cresciuto
in un duro contesto sociale, per
fuggire tutto ciò e
dalla sua esterna
apparenza di sfigato si rinchiude
nella sua cameretta consacrando ogni speranza e
felicità agli idoli immortalati nei poster appesi sulle
sue quattro mura, tra tutti David Bowie, Roxy
Music e New York Dolls. Brama il successo, ma
soprattutto riflette su di sé, sulla sua condizione. E
infatti la struggente poetica degli Smiths non può
prescindere dai dolori del giovane Morrissey.
Chi invece interpreta il mondo su scale armoniche è John Martin Maher “Marr”. Nato il 31
ottobre 1963, di lui c’è poco da dire sennonché sia
un dotato chitarrista dal gusto melodico superiore
alla norma. I suoi polpastrelli riescono con una facilità disarmante a far scaturire arcobaleni di note,
a metà tra la pioggia e il sereno, per l’appunto.
Se la poetica degli Smiths è tutta opera di Moz,
non c’è dubbio che l’incisività pop dei brani sia
tutta farina del sacco di Marr: ecco i presupposti
della sintesi perfetta in eterna dualità. Ma come si
incontrano questi poli contrapposti? Tramite mi-
steriosi e segreti bivi del destino, come sempre.
Entrambi orbitanti in band minori cittadine, si
sfiorano in un gruppo chiamato Nosebleed. I
due, buttando giù alcune canzoni insieme, annusano l’aria, guardano l’orizzonte, sentono il boato
lontano e, nella quiete contratta prima della tempesta, scambiandosi occhiate complici, decidono di prepararsi per cavalcare l’onda insieme al
batterista Michael Joyce e al bassista Andrew
Rourke. Alcune prove per testare l’equilibrio e i
quattro sono pronti. L’oceano si allunga ritraendosi, un’irrefrenabile corrente li risucchia fin sulla
cresta spumeggiante, l’adrenalina è al massimo: è
tempo del carpe diem, non c’è un istante in più per
pensare.
Attorno al gruppo si crea sin da subito un gran movimento di manager e discografici, perché il primo
demo registrato dai Nostri riluce di predestinazione. Nel 1982 il verbo degli Smiths inizia così a varcare i confini mancuniani, conquistando
e fidelizzando un po’
ovunque in Gran
Bretagna: i concerti
cominciano ad essere
sold out, e addirittura la EMI si interessa a loro. Ma è il più
lesto e lungimirante
Simon Edwards
della Rough Trade a
farli firmare, assicurandoseli per sempre.
L’onda che arriva
è gigantesca e vertiginosa, e i Nostri
sembrano non aspettare altro. Balzano
in piedi e in quel giorno di primavera del maggio
1983 scivolano a tutta velocità e a proprio agio nel
ventre cristallino, come se non avessero mai fatto
altro. Il loro primo singolo, Hand In Glove, sono tre
minuti e ventitré secondi di pura incisività melo-
dica, con un impatto pop di sicuro successo. Uno
scheletro essenziale di basso e batteria sul quale si
aggiungono le sei corde di Marr, qui ancora trattenute in un refrain ripetitivo ma già in grado di
accendere quel virtuoso e intermittente prisma di
colori che le contraddistinguerà splendidamente, un’armonica a impreziosire, ma soprattutto la
voce di Morrissey a incidere le prime ferite con i
suoi emozionanti saliscendi e con la sua malinconica forza comunicativa.
Questi i pregi dal punto di vista stilistico-musicale.
Chiari sono i riferimenti allo spleen attitudinale
estrinsecato da band come Joy Division, Television e Fall, ma gli Smiths trascendono ogni limite
post punk, creando una loro personale e originale
idea pop, guardando ancora più indietro nel tempo, verso i Sixties. Si canta di un amore idealizzato, quasi ultraterreno nella sua semplicità, perché
inviso dal perbenismo imperante.
Il booklet del 45 giri,
che in copertina immortala in una foto
rétro un uomo nudo
di schiena (tratta dal
libro Il maschio nudo
di Margaret Walters
del 1978) ritenuta
scandalosa alla sua
uscita, inizia quella che sarà l’estetica
iconografica
degli
Smiths: provocatoriamente romantica con
rimandi letterari e cinematografici. Presa
la decisione di non
effigiare mai la band
o qualche suo componente nei booklet, è Morrissey stesso a scegliere
le immagini che andranno a identificare ogni singolo e ogni album della band. Tale decisione, oltre
che alimentare inevitabilmente un alone di mistero intorno alla band, si fa rivelatrice della ricerca
Rearview Mirror /
107
estetica del cantante: la sua straordinaria “omo”
sensibilità feticistica lo conduce ad esorcizzare
ogni frustrazione esistenziale nell’idealizzazione
del bello trascendentale. Ecco perché le copertine
immortalano star cinematografiche degli anni Cinquanta
e Sessanta nella loro
pura e spensierata
eleganza: sono i miti,
come Alain Delon o
James Dean, ad aver
segnato per sempre
la sua adolescenza,
catalizzando i suoi
sogni e desideri.
Oppure sono scatti
anticonformisti, pregni di rimandi androgini, omosessuali
o antimilitaristici, a
rappresentare il lato
più coraggioso e oltraggioso, difficile da
esprimere quotidianamente. Proprio per questo
l’impatto grafico degli Smiths fa tutt’uno con la
loro musica, diviene complementare perché si erge
come perfetto contraltare alle canzoni. Mentre veniamo straziati da testi che cantano delle difficoltà
della vita, di ipocrisie e sogni infranti, si resta affascinati visivamente desiderando di esser rapiti dal
mondo-copertina.
Ma gli Smiths hanno causato un terremoto socioartistico non solo per la loro iconografia. Il fatto
è che in quegli anni il pubblico non era abituato
a tanta sensibilità estetica: erano tempi in cui il
punk e il suo post avevano innalzato l’oscurità, il
nichilismo e la dissonanza a paradigmi estetici, il
nascondere e il decolorare le emozioni e le frustrazioni dietro un atteggiamento iconoclasta. Con gli
Smiths tutto ciò viene ribaltato romanticamente
nel segno della naturalezza e della spontaneità: se i
problemi ci sono essi devono sbocciare luccicanti e
108
/ Rearview Mirror
colorati come fiori, non più celati. Fanno tutto ciò
con leggiadri arpeggi sixties, con falsetti femminei
sopra le righe, con maglioncini a collo alto, con liriche sofferte ma giocose, romantiche ma pensose.
Certo, anche tutte le
band inglesi orbitanti
intorno alla Sarah
Records, con tutte
le loro delicate intermittenze pop, si muovevano parallelamente ai Nostri, causando
simili scosse sismiche
al contesto musicale preesistente. Ma
non di pari intensità
e potenza mediatiche di quelle smithsiane: Morrissey e
Co., infatti, unendo
autenticità, genio e,
soprattutto, carisma
sono riusciti a farsi
trovare nel posto giusto al momento giusto, e la Storia li ha innalzati
e mitizzati, azzerandogli apparentemente la concorrenza. Lo stesso motivo per cui l’amore dei fan
nei loro confronti è infinito quanto l’odio provocato dai loro detrattori. Cose che capitano solo alle
grandi band, purtroppo.
T hese C harming M en
La pubblicazione di altri due 45 giri, This Charming Man - allegro e sbarazzino riff chitarristico,
sul quale il melodioso falsettare di Moz declama
una storia sulla ricerca di maturità di un ragazzo
seduto in un auto affianco ad un uomo affascinante - e What Difference Does It Make?, fa degli Smiths
il nome nuovo su cui puntare. I quattro sembrano
danzare a proprio piacimento su quell’onda vorticante, ora lambendone la cresta con manovre radicali, ora scivolando lineari col sole negli occhi.
Dopo un trittico di singoli capolavoro come que-
sto, l’attesa del vero debutto discografico su grande
formato si fa a dir poco spasmodica. Ma l’uscita di
The Smiths slitta continuamente fino a febbraio
del 1984.
Eccolo qua l’esordio ufficiale: copertina impeccabile e di forte impatto e undici canzoni che hanno veramente poco da farsi recriminare. Si va da
melense ballate bucoliche (Reel Around The Fountain)
a giovanili frenesie umorali (Still Ill), fino a malinconiche introspezioni (Suffer Little Children e I Don’t
Owe You Anything). Da evidenziare come Marr sembri apparentemente soltanto accompagnare, con
giri di chitarra quasi ossessivi nel suo ripetersi, la
voce di Morrissey, salvo poi constatare che proprio
questo loro duettare a distanza si elevi sopra il più
monotono schema post punk da cui prendevano
le mosse, dando vita a ciò che sarà il loro personale sound. Troppa però la differenza tra l’album e
quei tre preziosi 45 giri. E questo sarà un “difetto”
che i Nostri mai perderanno: saranno sempre più
incisivi e a proprio agio nel piccolo formato che
non negli album veri e propri.
Dimostrazione di ciò giunge sul finire del 1984 con
l’uscita di due nuovi singoli, nei quali una glassa
pop multicolore ricopre un cuore tenero e dolce
di marzapane che al solo assaggio la primavera
sembra esplodere nel palato e tutt’intorno: Heaven
Knows I’m Miserable Now e William, It Was Really Nothing.
Ecco qua tutta l’incisività pop degli Smiths, la loro
dualità che si diverte a intrecciarsi continuamente,
mostrando simultaneamente il dolore e la cura, il
giorno e la notte, il riso e le lacrime, a volte addirittura divertendosi a scambiare di posto questi estremi contrapposti. E che sorpresa scoprire
come b side del secondo 45 giri un brano che in
un minuto e cinquantuno secondi provoca intime
rivoluzioni estasianti: Please Please Please Let Me Get
What I Want.
Il 1984 passerà alla storia come l’anno più proficuo degli Smiths. Infatti, con solo un album e
una manciata di singoli alle spalle, la Rough Trade decide di pubblicare addirittura la prima rac-
colta della band, Hatful Of Hollow. Adesso è
l’etichetta a cavalcare le onde create dal passaggio di quella smithsiana, e queste profumano di
soldi e di affari. Male di poco, comunque. Perché
la tracklist dell’album è di quelle che passano alla
storia. Ci sono tutti i pezzi più riusciti dai Nostri,
con l’inclusione di b side e riletture di brani iniziali
composte per l’occasione. Un disco che sintetizza
perfettamente tutta la portata pop rivoluzionaria
della band nei suoi primi anni di attività, che per
molti hanno rappresentato la vetta più alta della
loro produzione artistica. Ma non solo, scorrendo
i titoli se ne scorge uno nuovo di zecca, How Soon
Is Now?: canzone devastante, che oltre cambiare la
vita di molti fans, detterà anche il nuovo percorso
artistico-umano del gruppo.
H ow S oon I s N ow ?
Il brano viene anche pubblicato come singolo nel
febbraio del 1985. È un vortice di riverberi ed effetti, ora, a scandire l’incedere chitarristico, l’atmosfera si fa contratta e umbratile, la sezione ritmica si fa più pensierosa, in altre parole si perde
quell’innocente andatura naif e spensierata che li
aveva contraddistinti fino ad allora, ma si guadagna stupendamente in profondità. Il mood è avvolgente, lisergico, sul quale la voce di un inquieto
Moz non fa che spennellare sfumature ancor più
drammatiche fino a raggiungere un climax emozionale da lasciare tramortiti. E poi quel testo sulla
debolezza e sulla disperazione umana e sul bisogno incommensurabile di amore che molto probabilmente mai arriverà.
Se fino adesso gli Smiths piroettavano su quell’onda indomabile da nessuno se non da loro, con How
Soon Is Now? si intubano nel suo ventre buio e materno per uscirne maturati e più consapevoli dei
propri mezzi. Ma si sa, quando si cresce, quando
il successo ci conquista totalmente, a volte è facile disconnettersi da quel mondo che fino a poco
prima ci era familiare, seppur ostile: l’adolescenza. È come quando un bravo surfista troppo sicuro
diminuisce l’attenzione e viene travolto. Ecco, gli
Rearview Mirror /
109
Smiths hanno rischiato di fare la stessa fine, e menomale che il loro secondo album, Meat Is Murder, ne risentirà solamente in parte, continuando
però a confermare la teoria della loro predisposizione al piccolo formato.
Il disco pur rappresentando un mezzo passo falso,
racchiude in sé buoni episodi,soprattutto per le liriche sempre più pungenti e intelligentemente impegnate di Morrissey. Bellissimo booklet, come sempre, che avvolge dieci
tracce che prendono
in qualche modo le
distanze da quella
spontanea semplicità
dei trascorsi recenti.
Emblematico di ciò
è il minutaggio delle
canzoni che aumenta considerevolmente la propria media
rispetto ai tre minuti
pop. Non dispiacciono i virtuosismi
musicalmente acidi
e liricamente violenti di Barbarism Begins
At Home, la melodica
circolarità pop di The
Headmaster Ritual e le
quiete dilatazioni sonore delle title track e del singolo That Joke Isn´T Funny Anymore. Ma How Soon
Is Now?, però, resta l’unica a toccare certi picchi
artistici, e dunque l’unica vera grande canzone
dell’album.
Stavolta, neanche il successivo singolo pubblicato,
Shakespeare’s Sister, riesce nell’impresa dei suoi predecessori. Il successo di pubblico è sempre tanto,
oramai i due volti trainanti la band, Moz e Marr,
sono considerati alla stregua di vere e proprie icone: il fanatismo che li circonda ha raggiunto livelli
esorbitanti e la loro coppia è già entrata a far parte
della storia della musica. Ma gli Smiths sono in una
fase di stanca, tengono ancora l’onda ma adesso le
110
/ Rearview Mirror
loro manovre virtuose sono limitate al minimo indispensabile. E un cielo livido oltremodo si staglia
sopra le loro teste. Che sia l’inizio della fine?
T here I s A L ight T hat (N ever ) G oes
O ut
Tutto sembra andare per il peggio, nonostante
l’incetta di premi che i Nostri fanno un po’ ovunque: saltano i manager, i rapporti interni si fanno
sempre più tesi. Ma a
far quasi degenerare
il tutto è Morrissey.
Rinchiusosi nella propria torre d’avorio,
sembra guardare tutti dall’alto della sua
spocchia, fino a saltare presentazioni televisive della band senza avvisare nessuno.
Nemmeno la pubblicazione di un nuovo
singolo, The Boy With
The Thorn In His Side
(con una splendida
copertina raffigurante Truman Capote),
riesce a stemperare
gli animi. E sì, che
dentro questi poco più di tre minuti ci sono tutti gli ingredienti giusti: solari e sbarazzini fraseggi
chitarristici, ritmiche vigorose, e il solito falsettare
malinconico e prodigioso a declamare la cecità di
un mondo che non riesce a capire l’amore sofferto
del ragazzo con una spina nel fianco. La primavera sembra germogliare rigogliosa ascoltando il
brano, e invece tutto all’interno della band sembra
appassire inevitabilmente.
Ma forse è proprio vero che nei momenti di difficoltà il genio che si cela dentro ognuno di noi, dentro l’uomo qualsiasi, trova sempre la via migliore
per diradare l’aria malsana intorno.
Il terzo album degli Smiths, uscito nel 1986 dopo
esser rimasto parcheggiato per molti mesi senza
alcun motivo, è la riprova empirica della loro peculiarità artistica. E chi l’avrebbe mai detto che
in una situazione che si apprestava a collassare
definitivamente, i Nostri avessero calato il poker
d’assi vincente, fin già dal titolo e dalla copertina:
The Queen Is Dead impresso in una suggestiva
immagine di Alain Delon. In queste dieci canzoni
il sole sembra esser tornato a baciare di luce abbacinante quella cresta spumeggiante sulla quale
i Nostri, con i virtuosismi da polpastrelli di Marr
e le impennate e le invenzioni vocali di Moz, piroettano armoniosi e veloci con il primo singolo
estratto Bigmouth Strikes Again: canzone ironica e
arrabbiata che ci narra di una Giovanna D’Arco
“lingualunga” contemporanea, con tanto di cuffiette, che “non ha diritto di avere un posto nel genere umano”.
Ecco, proprio le liriche colpiscono nella loro intelligente commistione di cinismo, ironia romanticismo e giochi lessicali, trattando temi ora impegnati ora frivoli, ma sempre anticonformisti anche
quando è una “semplice” storia d’amore ad esser
cantata. Proprio come accade nella ballad dal titolo folgorante, There Is A Light That Never Goes Out:
emblematica sintesi
di quello spirito adolescenziale con la A
maiuscola. Non da
meno è la title track
che nella sua antiistituzionalità,
in
questo caso monarchica, fonde insieme
poeticamente immagini rabbiose, disincantate e disperate.
Oppure l’umorismo
dileggiante in Frankly,
Mr Shankly, il malinconico decadimento
in I Know It’s Over e
l’emozionante pas-
seggiata al cimitero “un terribile giorno di sole”
tra rimandi letterari in Cemetry Gates.
The Queen Is Dead è senza ombra di dubbio
l’album più riuscito degli Smiths: il suono è maturo ma il minutaggio medio delle canzoni difficilmente oltrepassa i tre minuti, si alternano passaggi
frenetici e immediati ad atmosfere dilatate ed intimistiche senza mai cadere nel banale o nel melenso. Ma veramente quella luce mai si spegnerà?
T he S miths I n A n U nderwater D ream
Ora tutto fa pensare che le cose vadano veramente
per il meglio: un nuovo singolo viene pubblicato
e immediato è il successo, forse il più grande dal
punto di vista commerciale. Si tratta di Panic: un
riuscito lavoro di spontaneità, in cui la chitarra di
Marr, ben coadiuvata dalla sezione ritmica, crea
un tappeto sinuoso in cui la voce di Moz declama
ripetutamente il famoso verso “Hang the Dj” (impicca il Dj). Per la prima volta in assoluto i mancuniani decidono di promuovere il brano anche con
un video. Il lavoro viene assegnato al talentuoso
regista Derek Jarman, che ne costruisce un vero e
proprio cortometraggio di una ventina di minuti
da non perdere, con l’inserimento anche di There
Is A Light That Never
Goes Out e The Queen
Is Dead.
Inoltre nel 1987 viene pubblicata dalla
Rough Trade anche
la seconda raccolta di
materiale, intitolata
The World Won’t
Listen, che tra singoli e b-side racchiude il secondo periodo
della band. Di essa
l’etichetta inglese ne
stampa anche una
versione alternativa
ed estesa, Louder
Than Bombs, solRearview Mirror /
111
tanto per il mercato statunitense.
Ma altre e più compatte nubi arrivano improvvise e minacciose ad oscurare il cielo sotto il quale
gli Smiths sembravano finalmente vorticare senza
problemi. Il tour americano, appena intrapreso
sull’entusiasmo dei buoni riscontri dell’album, diviene esperienza disastrosa se non traumatica: la
carovana si interrompe senza portare a termine
tutte le date in programma. Il gruppo viene corteggiato pressantemente dalle major, e la Rough
Trade è sul punto di capitolare. Tutto ciò riacutizza ferite mai rimarginate, provocando un’emorragia, stavolta difficile da tamponare.
Ci provano con il successivo singolo Ask: il brano
ha tutte le carte per sfondare e infatti così è, ma
non riesce ad arginare i malumori che circondano
la band. Quel ritornello che si incunea inesorabilmente nelle orecchie, che fa battere le mani, con
quello zucchero filato che esce direttamente dalla
chitarra, conquista il pubblico, ma non fa tornare
il sole, neanche un raggio. Infatti gli altri due 45
giri, Shoplifters Of The World Unite e Sheila Take A
Bow, che dovrebbero allietare l’attesa per il nuovo
album in registrazione, risultano essere puro manierismo, niente di più.
L’onda si sta avviluppando sugli Smiths incamerandoli nel proprio ventre ora freddo e scurissimo.
Dall’esterno si potrebbe avere l’erronea impressione che il gruppo si stia preparando all’ennesimo
prodigio, dato che si trovano in studio a preparare
quello che invece sarà il loro ultimo album in studio. Strangeways, Here We Come uscirà, infatti, postumo nel 1987, sempre sotto l’egida della
Rough Trade, nonostante la EMI avesse oramai in
pugno la band. Il primo ad abbandonare è Marr,
stufato ed estenuato dall’ennesimo capriccio del
suo vocale alter ego. Disorientati, Rourke e Joyce
non attendono altro che sia proprio un irato Moz
ad ufficializzare la resa nel settembre del 1987.
L’album, con Richard Davalos in copertina (dal
film La valle dell’Eden), rappresenta così il loro testamento artistico, e forse proprio questo alone mistico che lo circonda, questa consapevolezza che esso
112
/ Rearview Mirror
fosse l’ultimo omaggio al mondo, lo valorizza più
di quello che realmente vale.
La verità è che esso è un lavoro dignitoso, che alterna ottimi episodi, ma non memorabili canzoni,
ad altri davvero trascurabili. Certo quella magia
pop a cui ci avevano abituati è lungi dall’essere
evocata, ma l’onda si è chiusa su di loro e questi
sono soltanto gli spruzzi e i riverberi delle ultime
virate multicolori. Girlfriend In A Coma, A Rush And
A Push And The Land, Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, Death Of A Disco Dancer e I Started
Something I Couldn’t Finish gli episodi migliori. Passa
appena un anno e la Rough Trade pone il suo sigillo sulla carriera della band con la pubblicazione
dell’immancabile live: Rank contiene la registrazione del concerto tenutosi al National Ballroom
di Londra nel 1986.
Ma ormai gli Smiths hanno terminato la loro caleidoscopica corsa e la fine è stata autistica: silenziosa
e incomunicabile. Il fatto è che nessuno, esternamente, ha potuto registrare la loro caduta da quella mastodontica massa d’acqua che fino a quel
momento avevano padroneggiato: non si sono visti corpi mulinare nella schiuma e soprattutto non
si sono scorte teste riemergere in superficie, come
se loro non fossero mai stati lì, come se tutto fosse
stato un sogno, un bellissimo e confortante sogno.
Oppure, come se avessero deciso di non riemergere mai più, restando confinati per sempre nell’abisso, e magari lì continuare a suonare e cantare
dell’adolescenza dei pesci, delle alghe, dei cavallucci e delle stelle marine. Ma sappiamo bene che
non è andata così. E tutto quello che è successo
dopo è un’altra storia, ché qui abbiamo narrato di
onde e primavera, di surf e adolescenza.
“Life is very long, when you’re lonely” (The Queen
Is Dead).
Rearview Mirror /
113
Ristampe
Boohoos – Here Comes The Hoo (Spit/
Fire, novembre 2008)
G enere : gl am rock
In Germania i musicisti locali ascoltarono il r’n’r
e ne trassero il krautrock. In Italia quando arrivò
la new wave fu gara a chi riuscisse a somigliare
di più ai modelli anglosassoni. E via dicendo. Può
essere, ma i Boohoos furono una mezza stagione.
Mettersi a fare glam rock nella seconda metà degli
anni Ottanta deve aver significato qualcosa come
battere il pungo sul
tavolo per spazzare
via le tappe obbligate, per rincorrere
la rincorsa di cui
sopra – benché alcuni membri della
band fecero gavetta
nell’hc nostrano.
Ne vennero fuori un
demo (Bloody Mary, 1986), un LP (Moonshiner, 1987), un EP (The Sun, The Snake And
The Hoo, 1987) e una buona risonanza a livello
nazionale, con qualche puntata tattica lassù, nel
mainstream. Qualche mese fa Spit/Fire (divisione
Spittle, e come poteva non esserlo) ha stampato
una sorta di summa/selezione delle tre produzioni
della band, e la intitola Here Comes The Hoo.
Bisogna ammettere che quel rockaccio fatto di riff
e urla d’Iguana (Downtown Train), solo all’apparenza dannato e melmoso, in realtà divertito e diven114
/ Rearview Mirror
terete, conserva anche oggi la sua freschezza. Si
sente che la band amava allo stesso modo tanto
Black Sabbath (vi ricordano niente ritmo e riff
delle strofe di Meet Us?) quanto New York Dolls.
Si sente la determinazione. Si sente Detroit ma anche un pizzico di Pesaro. Nella sfacciataggine forse,
chi lo sa, magari menefreghismo; insisto: è determinazione; e coinvolge come la cover di Search And
Destroy, o, ancora meglio, come Bloody Mary – voodoobilly manualistico, forse, però che spasso.
(7.0/10)
Gaspare Caliri
The Gynecologists – Hoosier Psychopaths 1981-1994: The Official Recordings (Gulcher, 2008)
G enere : punk
Ripercorrere le oscillazioni. Fare una ristampa di
tutta la carriera di una band significa soprattutto
questo. Vuol dire accostare le cose più famose a
quelle meno note, persino mettere nelle condizioni
di far risuonare i brani meno riusciti in quelli più
convincenti. E viceversa.
Viceversa c’è del buono e proattivamente marcio
anche in Jimmy Jones, e in analoghe canzoni punkbanalizzate dei The Gynecologists; l’esempio è
We’re An American Band, sporcatura di qualcosa che
è semplicemente banale, pur se forse il titolo denuncia una certa ironia attorno al pezzo. C’è però
anche di molto meglio nelle trenta tracce di Hoosier Psychopaths 1981-1994: The Official
Recordings, album-ristampa-culto edito da Gulcher per recuperare le gesta della band di Indiana,
che in realtà constava delle fibrillazioni del solo
Tommy Afterbirth – inquieto e repubblicanamente ambiguo, ma capace di essere genuinamente
dirompente, come in Leper Colony, o in Infant Doe,
dove il suo timbro vocale ricorda un misto tra gli
scimmiottamenti cartoonati dei Residents di Not
Available e l’ugola sgraziata di Ian McKaye
C’è tutta la produzione del gruppo in questa raccolta, e l’ascolto fa sentire l’odore acre di scoppiettanti aneddoti; come quella volta che Tommy inviò Faces & Psycopaths, primo EP della band
(qui presente nelle
prime 4 tracce), al
New Yorker per ottenere una recensione, che gli fu negata
motivando il rifiuto
col fatto che c’era
già troppa roba disgustosa, in giro. In
effetti gli esordi erano assimilabili al punk, specie
nella sua proto-versione stooges-iana – citiamo
a testimone il cavallo di battaglia (nonché primo
pezzo scritto dall’Afterbirth), Dog Face; e però indicavano già le tastiere come strada di differenziazione. Ricordate gli Stranglers?
La cavalcata prosegue con un altro EP (Kinder,
Gentler Nation) e due cassette (A Goat...You
Geek e Auto-Erotica Asphyxia & Various
Moldy Turds), dove, come si sottolineava sopra,
si toccano alti e bassi; ma è nella sezione finale della compila che crediamo di aver sentito le cose migliori; sono B-Side e rarità soprattutto live, come
Fart Speak / Fucking Wench, la traccia finale, che
ricorda i Chrome, spettro industriale percussivo
e sporchissimo; dal vivo, dove pare proprio che
Tommy desse il suo meglio. Secondo chi scrive
soprattutto i suoi musicisti. Per una volta le rarità
fanno da vero compimento di una ristampa.
(7.0/10)
Gaspare Caliri
Marlene Kuntz - Best Of (Virgin /
Emi, 23 gennaio 2009)
G enere : rock cantautoriale
Come giudicare un “Best Of ”? Diciamo la verità:
è un dilemma che ci risparmieremmo volentieri,
tanto ci sembra evitabile questo raccogliere il già
raccolto, questo rituale che celebra una (vana)gloria postuma di se stessa, col prosaico seppur lecito
scopo di raggranellar grana. Tuttavia, son vizietti
cui nessuno o quasi sfugge, quindi perché biasimare i Marlene Kuntz se a tre lustri dal debutto si
concedono questo peccatuccio veniale? Tanto vale
entrare nel merito, che in casi del genere significa
spesso fare l’appello e inarcare le sopracciglia per
le “clamorose assenze”. E’ presto detto: tra i titoli
in programma non figurano tracce come Lieve, Sonica, Ape Regina e Le putte, pezzi che ogni fedelissimo
non toglierebbe dalla playlist kuntziana neanche
sotto la tortura di un redivivo Bellarmino tra i deliziosi confort di Bolzaneto. Ma il fedelissimo se ne
faccia una ragione, perché a mio modo di vedere è
una scelta giustificata.
Difatti, la selezione sembra voler porre un deciso accento sulla cifra autoriale che negli ultimi
lavori ha preso il sopravvento sulle intemperanze
soniche, quasi ad indicarvi un approdo naturale,
l’immancabile evoluzione di un discorso che anche nell’asprezza degli esordi tirava in ballo situazioni e modi dai palpabili rimandi letterari. Un
“messaggio” reso ancora più pregnante da episodi
come La libertà, capolavoro firmato Gaber di cui
Godano e soci s’impadroniscono con impeto e naturalezza, rimarcando assieme alle altre due cover
- quella Impressioni di settembre presenza fissa nei live
recenti e una sordidella Non gioco più - link sempre
più saldi con la tradizione canzonettistica (in senso
alto) e finanche progressiva italiana.
Se l’interpretazione fosse giusta, se - in altre parole - la stesura della scaletta riflettesse l’immagine
che la band oggi ha di se stessa (e chissà quanto ha
realmente pesato la volontà di Godano e soci nel
redigerla), questa compilazione raggiungerebbe
appieno lo scopo: tirare in ballo più o meno equaRearview Mirror /
115
mente tutti i sette album disegnando una parabola
che decolla sui furori sonici per avvitarsi via via nei
tormenti acri e pensosi della canzone rock adulta.
Non a caso, ecco che nel bel mezzo del cammin
spunta Il pregiudizio, pezzo inedito - gioia e dannazione del fedelissimo di cui sopra - che
sintetizza egregiamente quanto detto
confezionando una
ficcante e trepida
invettiva in aspra
vestigia rock.
Tirate le somme,
alla fine più che
un’antologia rivolta al neofita bramoso di “farsi
un’idea” - cui consiglierei semmai i due gustosi
live H.U.P. del ‘99 e S-Low del 2006 - sembra un
buon pretesto per farsi una ponderazione su passato, presente e (forse) futuro di una band che - la
si apprezzi o meno - in Italia ha scavato un solco
ancora parecchio trafficato. (6.8/10)
Stefano Solventi
Jeunesse D’Ivoire, La Maison, Other
Side, State Of Art – Milano New Wave
1980-83 (Spittle, 2008)
G enere : new wave
Milano New Wave 1980-83. Quattro band dei
primi anni Ottanta milanesi – Jeunesse D’Ivoire, La Maison, Other Side, State Of Art che la solita Spittle Records decide di pubblicare,
compilate da Fred Ventura (sì, quello della italodisco), per dare loro un corpo stampato (su cd) che
spesso non hanno mai avuto; un invito a nozze per
ovvi giudizi circa la dervivatività dei detti gruppi
nei confronti dei modelli stranieri allora in auge.
Fatto che in realtà sussiste, specie nei confronti dei
Contortions-pensiero (onnipresente ovunque si
palesi un sax o una base funk) e della miriade di
esempi goth-punk inglesi – a loro volta poco originali, nella maggior parte dei casi.
Eppure c’è qualcosa che al di là di questo imprezio116
/ Rearview Mirror
sisce questo cartonato – oltre alle apprezzate scelte
grafiche. È un concetto che sembra scontato ma
solo senza la profondità del tempo; si tratta della
questione della selezione all’interno di un contesto;
cioè dell’importanza di queste band come selettori
e “importatori” in Italia delle proprie fonti che a
loro volta saranno quelle dei successori. Sono decisioni come queste che diventarono “condizioni di
possibilità” per il post punk italiano; e lo dimostrano, a creare peso specifico, le sovrapposizioni tra
quest’album e le compile tratte da Rockerilla che
poco tempo fa la stessa Spittle ha ristampato, nelle
primissime file del suo catalogo della rinascita.
In fin dei conti questo è il mestiere della Spittle; la
ricostruzione – sotto un qualche criterio di pertinenza, qui locale e geografico, per esempio - di un
tentativo di costruire una scena. È una questione
di taglio, più che di riscoperta. E non è operazione
semplice.(7.0/10)
Gaspare Caliri
ROYAL TRUX – TWIN INFINITIVES (DRAG
CITY, GENNAIO 2009)
GENERE: PSYCH/DEMENTIA
A distanza di quasi vent’anni dalla sua originale
messa in circolo – anno di grazia 1990, per la stessa
Drag City - Twin Infinitives non appare più come
quel mostro informe
che in origine fece
gridare – a seconda
degli schieramenti – al miracolo od
allo scandalo. Con
questo non intendo ridimensionare
l’opera eroinomane
dei due, che prima
di passare al metadone e ad una forma canzone in
odor di Rolling Stones (l’ottimo debutto per Virgin, Thank You, e l’altrettanto riuscito Accelerator
per la ritrovata Drag City) seppero inscenare un
tributo sincero alle brutture del rock’n’roll tutto.
Restando ovviamente fuori dal circo. Che in que-
gli anni significava rinunciare all’ottica esistenzialista del lo-fi e alle dorate volte delle multinazionali
alla caccia di nuovi rockers dal Northwest. Jennifer
Herrema e l’ex-Pussy Galore Neil Hagerty muovevano in tutt’altra direzione, pur ammaliati da una
dimensione casalinga. Tra squassanti drum machines, blues al fulmicotone, litanie d’altri tempi e
psicotiche frequenze proto-folk, i nostri realizzavano il loro capolavoro errato. Che Drag City ripubblica nel formato doppio vinile, proprio per ribadire l’importanza dell’ingombrante disco nero. Un
doppio album proprio come in origine, un grosso
punto interrogativo nell’evoluzione dell’indie-rock
dei primi novanta, con una coppia di junkie che
soffriva dei propri incubi musicali, rispondessero
al nome di Captain Beefheart, Wild Man Fischer,
Throbbing Gristle o King Tubby (per godere
dell’estatica componente dub del gruppo consigliamo il postumo Hand Of Glory). Mistificatori o
no con Twin Infinitives sbeffeggiarono – ed anche
sonoramente – il rock più pantofolaio, in una ressa
di idee e screzi affatto calcolati (7.2/10)
LUCA COLLEPICCOLO
Ryoji Ikeda – 1000 Fragments
(Raster-Noton / 2008)
G enere : R yoji I keda
Il primo incontro con l’universo creativo di Ryoji
Ikeda risale al 1995, anno che battezzò la sua carriera artistica con il nome 1000 Fragments.
A distanza di più di dieci anni, la seconda edizione
dell’omonimo disco firmata Raster-Norton diventa quasi necessaria a consolidare il dovuto merito
all’artista giapponese. Bisogna allora ancora una
volta fare i conti con quella che è stata definita e
continuerà ad essere definita un’uscita decisamente influente, che lascia intravedere, leggere per la
prima volta, o riscoprire inclinazioni e anticipazioni. La differenza la fa proprio la distanza,il tempo
che ha legato e tutt’ora lega gli ormai assodati risultati di perle sonore quali +/-, 0°C o Matrix.
La materia si divide in tre principali composizioni
che risalgono a tre periodi differenti e dichiarano
apertamente gli interessi e gli intenti dell’artista.
I nove elementi di Channel X (1985-95) utilizzano
la forma breve per dar voce alla frammentazione elettronica e al collage sonoro fatto d’incisioni
d’eventi e disparate altre fonti sonore. Dalle interferenze in trasmissioni radio alle voci tagliate,
le tracce mutano
forma e spazio per
poi diventare parte
unitaria di una sorta di conversazione
universale: il tutto
ottenuto grazie a
quella personale tenuta d’insieme fatta
d’elettronica di segnale e di drones. Alle cinque
Zones (1994-1995) spettano invece le meditazioni
più profonde, quelle di borbotti atonali, matrici
minimali, astrazioni elettroacustiche e incisioni
sintetiche che entrano in perfetta sintonia con riletture che si sarebbero dette ambient.
Ed infine Luxus (1993), dalle concretezze decisamente attuali, che dialogano rarefacendosi, tra
passaggi di luce in voci ed archi, astrazioni in glissato e basse frequenze.
A fine ascolto 1000 Fragments vince l’ostacolo
del tempo e conquista ancora oggi con quel suo
naturale senso d’appartenenza al suono che in pochi sanno catturare come Ikeda. (7.9/10)
Sara Bracco
New Order – Movement / Power Corruption And Lies / Low Life / Brotherhood / Tecnique ristampe (Rhino
Records, 2008)
I quattro Joy Division avevano già deciso che se
qualcuno avesse lasciato il gruppo, i restanti avrebbero continuato con un altro nome. Dal maggio
1980 quindi c’è stato un dipanarsi temporale che
ha portato la band di Manchester ad una rinascita
personale, che avrebbe fatto perdere la stima dei
fan della prima ora per acquisire un largo seguito,
e che ha consegnato agli ‘80 alcune delle miglioRearview Mirror /
117
ri contaminazioni fra musica di ispirazione pop e
nuove frontiere dance.
Siamo alla fine del 1981. Movement come la migliore elaborazione del lutto possibile. E infatti le
trame tribaloidi del fu singolo Atmosphere dei Joy
Division, accompagnamento definitivo del feretro di Ian, diventano il leitmotiv per entrare nei
chiaroscuri di questo primo disco
New Order. Sentori
dark per un’introspezione opprimente e scomoda, dove
a sgambettare sono
gli spettri di Closer
a braccetto con un
più oculato utilizzo dei synth, ma con il tremendo errore di un Bernard Sumner che tenta di
scimmiottare la voce di Ian invano. C’è ancora il
post punk che talvolta diventa arresa inconsistenza
(Dreams Never End), primordiale sincronizzazione di
synth e chitarra (Chosen Time) o sfogo da rigettare
in decibel di frustrazione (la coda di The Him), ma
c’è soprattutto tutta un’estetica dark, ovviamente
desolata e nichilista (la marcia per organo e percussioni di Denial, i beats elettronici e il basso sottopelle di Truth). Un primo passo che sa di sguardo malinconico indietro, che paga dazio all’ombra lunga
del poeta maledetto e alle sue ultime atmosfere.
La ristampa ridimensiona il voto aggiungendo un
mezzo punto in più alla luce principalmente della
ballata post punk per eccellenza, quella Ceremony
(primo singolo) di bellezza sopraffina e grazie alle
prime avvisaglie “dancey” di Everything’s Gone Green
e della Temptation che traghetta i Nostri in quello
che verrà dopo ossia negli umori dancefloor, cifra
stilistica imprescindibile del dopo 1982. (6.8/10)
Prima di tutto in Power, Corruption And Lies
Sumner prende coscienza della propria vocalità
e inonda le vibrazioni che fuoriescono dalle casse con il suo timbro post-adolescenziale tendente
all’etereo. In secondo luogo la mutazione avvenuta
con Temptation diventa fonte di ispirazione su cui
118
/ Rearview Mirror
costruire numeri di brioso dance/synth-pop (The
Village, Ecstasy, 586), malinconiche canzoni da
spiaggia a fine estate (Leave Me Alone), meravigliose
derive di synth e sequencer in media battuta che
marchieranno a fuoco tutti gli ’80 (Your Silent Face,
Ultraviolence) e non fosse altro (grazie al secondo
cd) per traghettarci nel manifesto di prima “dance
grandeur” che è Blue Monday. Altre chicche risiedono nella ballad languida in chiave synth-pop di
Thieves Like Us e nei beat quadrati della poliedrica
Confusion. (8.0/10)
Low-Life è l’esternazione completa e matura del senso pop che il gruppo si porterà dietro
fino agli ultimi dischi e soprattutto la quadratura
di un cerchio electro-pop che sarà cannibalizzato
e depredato largamente dalla dance da classifica
tutta fino ai primi ’90. The Perfect Kiss è lì a dimostrarlo in tutta la sua fulgida grandiosità: il basso
di Hooky come centro attrattivo e un tripudio di
synth e chitarre a divagare melodia su beat che
sono storia. Love Vigilantes che è canovaccio pop su
cui plasmare mille epigoni, Sub-Culture che ha dato
un perché al suono dei Pet Shop Boys (e di tanti
altri) e This Time Of Night che è bignami di “quel”
tipico romanticismo mitteleuropeo. A impreziosire
la presenza di versioni “lunghe” e remix dei singoli
e una Shame Of The Nation, prima mattonella sulla
costruzione del successivo singolo State Of The Nation. (8.2/10)
Brotherhood è stato il Republic degli anni ’80,
i New Order che fanno con un filo di gas quello
dove sono diventati più “automatizzati”, la loro dimensione più pop e commerciale. Non un album
brutto, perché esempi come Weirdo, Paradise e Way
Of Life veleggiano tutti sopra la sufficienza con il
loro appeal profumatamente catchy, ma è nella
malinconia romantica di Angel Dust e nello “strike
out” di Bizarre Love Triangle che sono ravvisabili le
componenti interessanti di un lavoro che si siede
sugli allori, compiacendosi. Alza di parecchio il
giudizio il secondo cd che contiene l’indispensabile
State Of The Nation, un piacevole remix (abbastanza fedele all’originale) del “powerseller” True Faith,
il delizioso mid-tempo di Touched By The Hand Of
God e il nuovo mix (velocizzato e pericolosamente
iperfarcito) di Blue Monday. (7.0/10)
Gli ultimi New Order degli ‘80 sono quelli che si
radunano nel 1988 a Ibiza per registrare il nuovo
disco e che ci hanno buttato dentro l’l’atmosfeta
esta(sia)tica della fatidica “summer of love”. Beat
prorompenti e basi quasi techno per un profluvio
di sequenze da dancefloor che fanno di Fine Time,
Round & Round e Vanishing Point un culmine dance
che non tornerà mai più così limpido. A braccetto
con la loro vena pista-orientata c’è la dimensione
pop che riscopre la brillantezza di Low-Life in All
The Way, nella circolarità perfetta di Dream Attack
e nell’electro-pop sopraffino di Mr. Disco. Il già ottimo Tecnique originale è infarcito nel secondo
disco del buon singolo Run 2, da un remix di World
In Motion e dalle versioni in 12 pollici dei singoli
estratti dal disco. (7.8/10)
Alessandro Grassi
Zero Boys – Hystory Of / Vicious
Circle (Secretly Canadian, 2 marzo
2009)
G enere : punk
Era la primavera del 1980 quando gli Zero Boys,
band di Indianapolis nata l’anno prima, resgitrarono otto brani di filata in una sola notte, nel
“basement” di un amico. Nacque così il corpus di
Living In The ‘80s, EP con cui esordì quello che
oggi viene presentato come il miglior gruppo hc
del Midwest di allora.
La canzone che diede titolo al mini era un inno
primo-punk speziato di Nuggets e di garage, in
maniera midollare; ma anche dimostrava un gusto
per la scrittura davvero più saporito della media –
ribadito nella combinazione melodica voce-chitarra di Stick In Your Guns. Gli Zero Boys durarono fino
al 1983, mutando in un hard core vero e proprio
(Seen That Movie Before), nel punk hc melodico di
Positive Change, fino a sbucare in Amerika, brano che
li collegò, all’atterraggio della parabola, persino al
rock hard-garagista di Stooges e MC5.
Di mezzo, l’episodio centrale della storia, dove si
scopre che l’assassino è il maggiordomo e l’arma
l’attizzatoio, è Vicious Circle, l’album di vero
esordio sulla lunga durata (più o meno, date le abitudini del genere) e di vera raccolta dei frutti di
Ramones – già peraltro abbondantemente citati
a fonte in Piece Of Me, ultima traccia di Living…
-, Germs, Circle Jerks. Magistrale nel disco era
la brevitas della title-track, il gioco strofa-refrain
di Amphetamine Addiction – che strania nel momento
in cui ci si accorge che usa la struttura armonica
di The Other Window
degli Wire.
Tutto questo – EP,
album e tracce di
quel potenziale secondo album che
non vide mai la luce
– va a comporre
una coppia di uscite
Secretly Canadian
– meritevole da tutti i punti di vista più ovvi, ma
anche per la completezza storica delle note di copertina; oppure solo per lo sforzo discografico di
riscoperta. Basta quello, ad ascolto avvenuto. Le
ovvietà diventano più interessanti, se giustificate.
(7.0/10)
Gaspare Caliri
Rearview Mirror /
119
(GI)Ant Steps #24
Freddie Hubbard
Open Sesame (Blue Note Records, giugno 1960)
Entrò dalla porta principale, accese tutte le luci della stanza,
si pose al centro della scena. Sembrava mosso da una frenesia
incandescente, il talento spedito a mille per colmare il ritardo
anagrafico rispetto alla Storia. Spese molto, e ci riuscì. Ma
non ebbe indietro il resto.
Freddie Hubbard ha lasciato questa valle di lacrime sul finire del 2008, settantenne, solo un lustro
più anziano d’un Mick Jagger, tanto per dire. La
notizia mi ha ovviamente intristito, obbligandomi a
fare i conti con questo trombettista che mi sembra
incarnare la parabola dell’hard bop come pochi altri. Nato nel ‘38 a Indianapolis, era un ragazzino
quando Miles, Dizzy e Bird palleggiavano be bop
nei locali più torridi della Grande Mela, città che
raggiunse ventenne portando in dote l’esperienza
coi fratelli Montgomery (tra cui l’immenso chitarrista Wes) e un talento che scomodò subito paragoni
col compianto Clifford Brown. Suonò tra gli altri
con Sonny Rollins, con Philly Joe Jones ed Eric
Dolphy, persuadendo i luminari della Blue Note a
concedergli subito una chance da leader. L’occhiuto
Alfred Lion pensò bene di mettergli a fianco una
miscela di esperienza e brio giovane: alla flessuosa
autorevolezza delle quattro corde di Sam Jones faceva eco ai tamburi un Clifford Jarvis neanche ventenne ma già all’opera con Chet Baker e Curtis
Fuller, e se al pianoforte sedeva un McCoy Tyner
sul punto di decollare in orbita Coltrane, del sax si
occupava il ventottenne Tina Brooks, uno che smerigliò l’ancia incidendo assieme a Jimmy Smith e
Kenny Burrel, vantando altresì un album come
leader alle spalle (Minor Move del ‘58).
Di Brooks, straordinario compositore ed interprete,
riparleremo presto. Quanto a Open Sesame, facciamo subito: disco stupendo, swingante con impu120
/ Rearview Mirror
denza generosa,
languidamente
declinato latin tinge, insomma il frutto perfetto di
quella cuspide tra cinquanta e sessanta quando il
jazz era una tensione urbana e un brivido liberatorio, un sogno esotico e il lasciapassare per la modernità. A testimoniare il talento fuori dal comune
di Freddie basti il suo assolo in All Or Nothing At All,
standard spedito a cento all’ora col fraseggio della
tromba a centrifugare dinamiche come una turbina,
la calligrafia pastosa spinta in avanti come un prodigio, uno sbattimento festoso d’illuminazioni così rapide da spingere l’improvvisazione sull’orlo del free
(non a caso di lì a poco Hubbard sarà chiamato da
Ornette Coleman a far parte dell’impresa Free
Jazz). Detto ciò, il mio amore per Hubbard ha dei
limiti: lo sento come un suono troppo preoccupato
a manifestarsi nella propria tempestosa epifania, superandosi di evoluzione in evoluzione, lasciando indietro così il dramma, quel peso specifico che sfida
l’inconsistenza materiale – assieme rasserenante e
carnefice - nei Davis e nei Baker. Così mi pare vadano le cose in questo riuscitissimo debutto e un po’
lungo tutti i ruggenti sixties, passando dalla sbandata fusion alle peripezie che ne smarriranno via
via la brillantezza, fino al brutto incidente che nel
’93 danneggerà le preziose labbra. Infine, l’attacco
di cuore, atto senza ritorno, chiusura dello scrigno.
Hubbard mi è sempre sembrato uno che sale al volo
sul treno già in corsa, se ne sbatte dei macchinisti,
del cuore infernale della belva e armeggia per guadagnarsi un buon posto magari in prima. Però che
fantastico compagno di viaggio che eri, Frederick
Dewayne.
Stefano Solventi
classic album rev
Bruce Springsteen
Tunnel Of Love (Columbia, 1987)
Fin dalla copertina Tunnel Of Love rappresentò
uno scarto netto, spiazzante: Bruce vi compare in
stolido piano americano (guarda un po’…), giacca
nera su camicia immacolata, algida cravattina texana, l’espressione così vaga e imbiechita che non
sembra neanche lui, al più un cugino spacciatore
di auto usate. Coi primi ascolti, la drammatica evidenza: ruggito innodico? Piglio blue collar? Epica
rockista? Niente di tutto ciò. Ne discutevamo con
sconcerto, chi imprecando sulla fuoriuscita di Little
Steven dall’entourage - peraltro sostituito dal valido
Nils Lofgren - e chi maledicendo il matrimonio del
Boss con la modella Julianne Philipps. Insomma,
all’epoca questo disco suonò come un mesto doposbronza. Una roba dimenticabile. Lo riascolto oggi
e trovo che sia un disco emblematico. A suo modo
importante. Perché parla del tempo e nel tempo da
cui proviene, errori e orrori compresi, raccontandoci di quando Springsteen (l’uomo e l’artista) volle
spingersi ancora una volta all’indietro, smarcandosi dalla valanga rock da egli stesso provocata (e
dalla band, parcellizzata brano per brano) per non
esserne travolto. Certo, Tunnel Of Love non può
competere con l’intensità di titoli quali Nebraska
o Darkness On The Edge Of Town. Ma è l’intensità di uno sguardo dietro una maschera di cera.
Una “freddezza” - quel posarsi della melodia su
emulsioni algide di tastiera – necessaria, adattissima
a rappresentare quell’intimismo tormentato in cui
Springsteen sentì di doversi rifugiare. Da qui la scelta, consapevolissima, di eleggere a modello melodico la vecchia Stolen Car, concentrando l’obiettivo sui
pochi metri quadri in cui si consuma tanta parte della vita dei più, sul riflesso sfrangiato di mille esistenze
regolari. Certo, le tastiere di Walk Like A Man e Two
Faces sono viscide
come ranocchi
di plastilina, per non dire degli sciagurati “sound
effects” messi in testa alla title track, del drumming polimerizzato e di tanti sciocchi coretti a cura
dell’ineffabile Patti Scialfa. Ma tant’è, erano tempi
in cui l’arte della produzione andava organizzandosi
in rigidi e frigidi format, sintetica mattanza da cui in
pochi usciranno veramente indenni (non Lou Reed,
non Neil Young...). Si potrebbe inoltre cavillare sul
piglio tra l’inane e il tronfio di Tougher Than The Rest,
ma - per quanto mi riguarda - le critiche finiscono
qui. Sinceramente, trovo ragguardevole l’impeto
di Spare Parts, la cui rabbia ancestrale supera (e di
gran lunga) quella “volumetrica” di Born In The
USA, mentre Brilliant Disguise ha semplicemente il
passo delle ballate di razza. Inoltre, se Cautious Man
anticipa di un decennio l’uggia insidiosa del Tom
Joad, One Step Up sa rendere con cruda nitidezza la
resa dei sentimenti al disincanto del quotidiano. In
chiusura, poi, t’imbatti nella leggerezza stagionata
di When You’re Alone e Valentine’s Day, dolci trepidazioni country-folk sull’ultima luce che bagna l’asfalto,
quello stesso che un tempo - irreversibile - era pur
sempre Thunder Road. Oggi, dopo oltre vent’anni di
passi falsi, resurrezioni, recuperi d’archivio e flirt
hollywoodiani, il Boss tenta con ostinazione ammirevole di porre se stesso e la propria musica al
servizio dell’amato Paese. La cruda tenerezza senza
scampo di quei racconti in prima persona è diventato un “noi” saturo di sensazionalismo emotivo ad
alto tasso retorico. Rispetto al quale, quanto più sangue, ossa, tremori, penombre e luce in Tunnel Of
Love. E quanta America: quella più fragile e vera.
Stefano Solventi
Rearview Mirror /
121
The Flaming Lips
Christmas On Mars
A Fantastical Film Freakout
L’ultima fatica del delirante lunapark lipsiano è un viaggio in versione celluloide nei meandri
della coscienza e della vita umana, un dramma tragico venato di humour nero e surreale.
Ben sette anni sono trascorsi dall’inizio delle riprese di Christmas On Mars, ovvero Flaming Lips
on film, impresa cominciata a girare nel 2001, terminata nel 2005 e il resto in post-produzione fino
a metà 2008; a novembre dello stesso anno risale
l’uscita in DVD. Nello stile autarchico della band,
la pellicola è naturalmente artigianale, low budget e autoprodotta, con cast prevalentemente fai
da te (band, staff, parenti, ad esclusione di qualche
amico attore, come Adam Goldberg, il comico di
Saturday Night Live Fred Armisen e Steve Burns),
alla regia c’è Wayne Coyne aiutato da Bradley Beesley, documentarista e co-regista dei video della
band di Oklahoma City.
Cosa aspettarsi allora dall’ennesimo delirante lunapark lipsiano in versione celluloide? Niente di
troppo diverso in fondo, per chi li ha sempre frequentati, dal loro stile psych freak. L’ambizioso ed
elaborato (concettualmente) loro ultimo parto si
può definire l’approdo ultimo di un percorso che
ha fatto da sempre della tenacia, della tensione
morale e dell’ottimismo venato di humour surreale e caustico la loro cifra stilistica. A chiudere un
122
/ La Sera della Prima
cerchio, forse, e riaprire, chissà una nuova fase in
un prossimo futuro.
Ossessione è la parola chiave per entrare in Christmas On Mars. La storia che fa da collante al
film si svolge nel futuro, su uno spettrale pianeta
Marte colonizzato dai terrestri; siamo alla vigilia
del primo loro Natale passato lì, in una stazione
spaziale ormai quasi in avaria, dove si verificano strane allucinazioni, blocchi psichici, suicidi e
paranoie da isolamento, mentre nel frattempo si
sta cercando di riparare le macchine e di dare un
senso di ottimismo, celebrando la festività, anche
in occasione della nascita del primo bambino lì;
nascita artificiale che simboleggia l’inizio della
colonizzazione marziana. L’arrivo di un bizzarro
superessere, Coyne stesso, che ripara il generatore d’ossigeno, infonde speranza alla crew tutta e
si riesce anche a risolvere un problema di gravità.
“It’s magic and hard work that really gets the job done”, la
filosofia coyniana sottesa in questo esprime compiutamente il suo credo (“siamo artefici della nostra
felicità”). In altre parole, ottimismo e realismo. E
un pragmatismo assoluto su tutto.
Ossessione si diceva poc’anzi. La genesi di Christmas parte da lontano e mette insieme alcuni
nuclei tematici delle personali ossessioni della mente
di uno come Wayne Coyne. L’inconscio e i ricordi
dell’infanzia, la differenza tra ciò che ricordiamo a
posteriori e ciò che rimane sepolto nel subconscio,
la parte infantile di noi tutti a cui da adulti difficilmente si riesce più ad accedere. In altre parole, i
nostri viaggi interiori nel tempo. E la capacità difficilissima, che hanno pochi, di riuscire ad accedervi
anche da adulti. Questo il punto di partenza che
ha dato vita all’idea del film, cristallizzatasi dopo
la morte del padre di Coyne, avvenuta nel 1997.
C’è anche la fascinazione per l’oscurità e il senso del magico e dell’imprevedibile, presente negli
anni formativi infantili, insieme al senso di luci ed
ombre, così importante per un graphic designer
qual è anche il Nostro. Luce ed ombra così correlate alle paure infantili del resto.
Ancora la sensazione claustrofobica dell’isolamento e della relativa conseguente paranoia, così dominante in alcuni characters del film, i quali rappresentano la parte psichica che è rimasta intrappolata in
un meccanismo e contro cui altri personaggi oppongono di contro il loro humour surreale e una
certa dose deterrente di ottimismo. C’è in tutto ciò
anche la percezione evidente della nostra fragilità,
pur in un mondo ipertecnologizzato qual è quello
attuale. And the fight for our sanity will be the fight of our
lives. La paranoia da isolamento è anche quella che
circolava nei Settanta intorno a una favoleggiata
conquista USA del pianeta Marte non andata a
buon fine e di conseguenza mai rivelata al mondo.
Leggenda che fa un po’ il paio con la (supposta)
conquista della Luna nel 1969. Teorie cospirative
sul loro governo che tanto piacciono e continuano
a piacere agli americani del resto.
E su tutto, ritorna il senso della comunità e della
famiglia, del clan così tipico dell’universo Lips. A
proposto di ricordi, Coyne rivela come la storia si
basi essenzialmente su di un (falso) ricordo della madre che, rimasta di notte sveglia davanti alla
televisione - siamo a metà degli anni ’70 - aveva
rielaborato, addormentandosi, qualcosa che credeva di aver visto in un film. La storia appunto che
si svolgeva in una pellicola degli anni’40 su di uno
La Sera della Prima /
123
sperduto avamposto, tipo sottomarino o astronave,
dove una ciurma ormai alla deriva per guasti meccanici e convinta di dover morire, nel momento in
cui affronta la morte e la accetta, viene visitata da
un’entità sovrannaturale e si trova così cambiata
positivamente dall’evento. Che è quel che succede
in Christmas d’altra parte. Inutile dire che il film
oggetto del sogno-ricordo si rivelò poi difficile da
trovare nel corso del tempo e che sia stata maturata da Coyne la convinzione che non fosse mai
esistito.
Se la genesi di Christmas ha avuto le radici fin
qui esaminate, quali sono state invece le influenze
filmiche e tematiche che ne hanno determinato il
risultato finale? Si è già detto della sua lunga elaborazione e postproduzione, frammista alla lavorazione degli album da fine ‘90 ad oggi. In mezzo alle riprese anche la dipendenza, poi vinta, da
eroina del protagonista del film, il batterista Steve
Drozd (alias Major Syrtis) tra le altre cose. “Forse
Eraserhead o Dead Man misti a fantasia e aspetti spaziali,
come Il mago di Oz e probabilmente 2001-Odissea nello
spazio, ma realizzati senza veri attori o budget e ambientati
durante il periodo natalizio. La storia che si svolge possiede
124
/ La Sera della Prima
della magia infantile mista a una situazione tragica e realistica”. E’ Coyne stesso ad offrirci suggerimenti
sulle alcune delle influenze, dal commento a Christmas On Mars sul sito ufficiale flaminglips.
com. Certamente essenziali sono stati Kubrick,
la magia e la speranza di un film come Il mago di
Oz di Victor Fleming, l’artigianalità, il paesaggio
industriale ed emotivo desolante di Eraserhead
di David Lynch (ma il bambino dell’allucinazione in Christmas è più tranquillizzante!), il senso del
surreale e del parodistico del Dark Star di John
Carpenter, frammisti a spruzzate di Solaris e
Tetsuo. Senza dimenticare però la science fiction
più popolare di fumetti, b-movies e serie TV, quali
Star Trek, e uno z-movie scombinato quale Santa Claus Conquers The Martians (di Nicholas
Webster,1964) che fa il paio con i film del famigerato Ed Wood. Un immaginario fertilissimo per
chi cresceva negli psichedelici Sessanta-Settanta
tra hippismo e controculture. E il senso del citazionismo diffuso da sempre nei Lips.
Girato in 16 mm con prevalenza del bianco e nero
(il colore viene associato al suono in scene topiche,
come le disturbanti visioni del Major Syrtis o l’ap-
parizione del marziano verdissimo e ipercolorato
Coyne), Christmas On Mars è di base un film
puramente artigianale - girato per la maggior parte nel giardino di casa - ma con ambizioni “arty”:
ritmo rallentato, esplosioni soniche, pellicola invecchiata e via dicendo. Sarebbe un errore considerarlo unicamente come prodotto a sé stante prodotto di modesta caratura, in verità. Altra cosa
è immetterlo contestualmente nell’universo lipsiano, da dove scaturiscono, come si è già visto, una
miriade di sensi compiuti, che partono da lontano
nel tempo e chiudono completando il cerchio di
un’esperienza più o meno trentennale all’insegna
dell’immaginazione e della psichedelica più sfrenata e liberatoria.
Si diceva dell’irruzione della musica in alcune scene; la colonna sonora viene acclusa all’edizione
speciale di questo DVD, ed alcuni estratti erano
già stati pubblicati negli anni scorsi; la composizione risale alle session di quello che sarebbe poi
diventato Yoshimi Battles The Pink Robots
(2002). Lo score strumentale, che irrompe sonicamente a maggior volume in alcune delle scene più
deraglianti, ha derivazione prettamente ambient
con inserti kraut orchestrali: Drozd negli extra del
DVD cita non a caso Bernard Hermann, Brian
Eno e Stravinskji come maggiori influenze compositive. E Coyne parla di tono drammatico della
musica che ben si adatta e amplifica la tragicità e
l’amarezza di fondo della pellicola.
Ultimo paradosso e humour nero dei Nostri, la
mancanza di sottotitoli - inglese compreso - se si
escludono i soli presenti, in cirillico (!). Ad un esame degli stessi nei titoli di coda di Christmas, è
stato sottolineato che la traduzione non è neanche
letterale, ma immette dell’altro, come ad esempio
commenti sulla ricerca della felicità nella vita e via
discorrendo. Ennesimo detour di senso. Ma non ci
aspettavamo davvero niente di diverso.
“La vita è dura per lo più priva di senso. Ma sta a noi renderla migliore. Sta a noi cercarne il magico e il senso di meraviglia sotteso. E nel significato più profondo, scoprire cosa
sia il sublime. Ce la possiamo fare, al di là delle sofferenze,
a creare la nostra gioia e la nostra felicità. Questo è il Natale
di cui parliamo”. (Wayne Coyne, 2008)
Teresa Greco
credits:
• Titolo originale: The Flaming Lips - Christmas On
Mars (DVD & CD - Warner, novembre 2008)
• Regia: Wayne Coyne con Bradley Beesley e George
Salisbury
• Sceneggiatura: Wayne Coyne
• Fotografia: Jeremy Lasky
• Musica: The Flaming Lips
• Cast: Steven Drozd, Wayne Coyne, Adam Goldberg,
Fred Armisen, Steve Burns, Michael Ivins, Kliph
Scurlock, J. Michelle Martin-Coyne
• Genere: Fantastico, drammatico
• Nazionalità: USA
• Durata: 1h 22’
La Sera della Prima /
125
Tony Manero (di Pablo Larrain - Cile
2009)
Abbiamo visto più volte sul grande schermo la
storia tragica delle dittature sudamericane, ma un
film il cui protagonista non è il buono ma risulta
persino sgradevole non ce lo ricordavamo. E neanche un tema all’apparenza frivolo come il ballo,
ma così rivelatorio in realtà della condizione della
popolazione cilena degli anni ’70 alle prese con la
dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990). Popolazione rassegnata e stanca, che vede la violenza
per strada giorno per giorno, gente abbrutita, coprifuochi, esercito e soprusi.
Chi si ribella e chi per sfuggire alla sordida real-
126
/ La Sera della Prima
tà evade, con il cinema “straniero”, americano in
particolare, con il ballo, anche questo importato.
Siamo nel 1978, che vide la “febbre del sabato sera”
di travoltiana memoria (Saturday Night Fever,
1977) diventare globalmente febbre di tutti. O
quasi. E la disco massiccio fenomeno di costume.
Ci troviamo alla periferia di Santiago del Cile.
Raúl Peralta (Alfredo Castro, anche sceneggiatore del film) è un ballerino cinquantenne che
sbarca il lunario arrangiandosi come può, con l’ossessione per questo film, che va a rivedere in sala
in continuazione.
È a capo di un gruppo di ballerini che si esibiscono in un piccolo bar di periferia, e anche loro sognano il successo e l’evasione. Ma a
differenza di chi lo circonda, il protagonista non esita a fare qualsiasi cosa
per perseguire i propri scopi di affermazione, anche rubare, ingannare,
uccidere. Indifferente a tutto quello
che ha attorno, se non lo tocca da vicino per i suoi scopi primari. Tutto
pur di migliorare le sue performance
di ballo e cercare di vincere dei soldi
e la gloria a un concorso in televisione, presentandosi come sosia di John
Travolta alias Tony Manero.
Pablo Larrain, qui al secondo film
dopo Fuga del 2005, affronta il film
realizzandolo con stile documentaristico, incollandosi quasi ai personaggi
e seguendoli strettamente, con alcune
scene anche in fuorifuoco. Assistiamo
così passo dopo passo all’amoralità
di Raúl, fino alle estreme conseguenze; Larrain lascia il finale in sospeso,
dopo averci fatto assistere attoniti alla
vicenda. E l’altra storia parallela, il
cui epilogo è in sottofinale (la figlia
della sua convivente e il suo ragazzo
arrestati dalla polizia per opposizione
clandestina al regime) che era la normalità tragica in anni come quelli, è
vista con gli occhi del protagonista, che al momento
dell’irruzione nella casa in cui anche lui vive, trova
il modo per fuggire, anzi è come un fantasma, coperto come se non fosse mai esistito. Un no man’s
land, uno spettro che si aggira nei meandri di una
dittatura approfittando dell’amoralità generale e
usandola a suo favore.
E il senso di continua tensione in Tony Manero
è avvertibile sin da subito, quando dopo le scene
iniziali in cui il protagonista sembrava solo una povera vittima che cerca di farcela in qualche modo,
si rivela bruscamente per quel che è. Momento rivelatore da cui si procede poi in discesa negativa
per tutto la pellicola.
L’ultima fatica di Larrain si conferma quindi come
un crudissimo spaccato della perdita di valori e di
identità di una società, ormai rassegnata a tutto.
Un fallimento dei personaggi che è quello di tutto il
Cile di allora. E un film estremamente politico.
Vincitore del premio per il miglior film e per il miglior attore al Festival di Torino 2008, premio meritato dall’ottimo Castro, che con la sua mimica, i
silenzi, la gestualità minimale ha reso al meglio la
mancanza di morale del tragico Raúl.
Teresa Greco
Milk (di Gus Van Sant – USA, 2009)
“Sono Harvey Milk e voglio reclutarvi tutti”.
Gus Van Sant alle prese con un biopic? Non proprio,
anzi non solo.
Nel portare sullo schermo un progetto accarezzato
già da un po’ di anni e mai riuscito a realizzare finora, si avvicina abbastanza a suoi film “regolari”
quali Will Hunting (1997) Psycho (1998) e Scoprendo Forrester (2000). La libertà che offre una
storia del genere non è invero moltissima, anche se
pensando al suo recente Last Days (2005) ispirato
a Cobain, i margini di deragliamento ci sarebbero potuti benissimo stare. Invece il regista sceglie
apparentemente un impianto narrativo classico per
raccontare parte della vita dell’attivista Harvey
Milk (1930-1978), il primo americano omosessuale dichiarato a riuscire a ricoprire una carica pubblica, quella di consigliere comunale nell’America
La Sera della Prima /
127
omofoba di fine anni ’70, a San Francisco, e tragicamente assassinato da un suo collega.
Prendendo spunto dalle centinaia di taccuini e registrazioni audio che Milk aveva lasciato, in particolare da un lungo nastro rievocativo della sua
carriera da rendere pubblico in caso di assassinio,
Van Sant usa questo espediente narrativo, partendo dalla decisione del coming out personale e politico del personaggio dopo anni di vita regolare
e conformistica. Si comincia quindi da un disvelamento, iniziando a rivelare se stessi.
“Lo stile più rivoluzionario che mi sembrava giusto seguire
per raccontare la vita di un gay era proprio quello classico,
per lasciare spazio alla storia e a tutto quello che di importante Milk ha fatto, e mettere l’etica prima dell’estetica. Non
volevo che fosse considerato un eroe ma un grande uomo, che
si preoccupava dei diritti di tutti gli esseri umani. Comunque
non penso assolutamente di avere rinunciato al mio personale
modo di girare”. Così dalle parole dello stesso autore.
Il tocco di Van Sant c’è comunque tutto: i lunghi
128
/ La Sera della Prima
pianosequenza, la fotografia minimale, la cura dei
particolari, alcuni dei quali appena appena insistiti. Come il riflesso del fischietto che è inquadrato
durante una manifestazione di protesta, a simboleggiare il movimento tutto, o l’inquadratura in
prefinale, durante l’assassinio, con Josh Brolin
nei corridoi del Comune, inquadrato di spalle alla
maniera di Elephant mentre meccanicamente
dà vita al massacro di Milk e del sindaco che lo
appoggiava. Viene in mente un altro grande alle
prese con film più apparentemente regolari della
sua carriera, il Cronenberg di A History Of
Violence (2005).
E non c’è solo in scena quasi il protagonista, come
in genere nei biopic. Van Sant è Van Sant ed ecco
coralmente la sua massa di diseredati, hobo, adolescenti, emarginati di tutti i suoi film, il popolo gay
di San Francisco, qui al centro dell’attenzione per
combattere e affermare i propri diritti. Contro la
Proposition 6, una proposta di legge che chiedeva
tra le altre cose l’allontanamento degli omosessuali
dalle scuole pubbliche della California e che per
mesi infiammò il dibattito politico e sociale americano. L’abbattimento di catene che imprigionavano la vita sociale degli omosessuali, e di riflesso
anche la loro vita privata, il togliersi le maschere e
rivelarsi per quel che si era: ecco uno dei capisaldi del pensiero di Milk (“dì a tutti chi sei”, rivolto a
chiunque, non solo alla comunità gay).
E per ultimo non si può non citare il gran lavoro sul e del cast tutto: Sean Penn si cuce letteralmente addosso i panni di Milk, conferendo al
personaggio una nota dolente e malinconica da
grande istrione; così anche i tre co-protagonisti,
Emile Hirsch che interpreta l’attivista Cleve Jones, già visto l’anno scorso in Into The Wild, James Franco il compagno di Milk e il tormentato
Brolin, l’assassino Dan White.
Teresa Greco
BEST OF 2008
THE FIREMAN
(Paul McCartney & Youth)
“Electric Arguments” MPL
DAVID BYRNE & BRIAN ENO
“Everything That Happens Will
Happen Today”
BLACK MOUNTAIN
“In The Future”
Jagjaguwar
Silver Arrow
Asthmatic Kitty
FUCK BUTTONS
“Street Horrrsing”
VIC CHESNUTT/ELF POWER
“Dark Developments”
PETE MOLINARI
“A Virtual Landslide”
ELI PAPERBOY REED
“Roll With You”
ATP Recordings
Orange Twin
Damaged Goods
Q Division
RODRIGUEZ
“Cold Fact”
Light In The Attic
SEUN KUTI
“Many Thing”
MURCOF
“Versailles Sessions”
BENGA
“Diary Of An Afro Warrior”
ALBOROSIE
“Soul Pirate”
PATTI SMITH & KEVIN SHIELDS
“The Coral Sea”
Tout Ou Tard
Leaf Label
Tempa
Forward
Pask
JULIAN COPE
“Black Sheep”
WIRE
“Object 47”
THE MELVINS
“Nude With Boots”
JESSE MALIN
“Mercury Retrograde”
Pink Flag
Ipecac
One Little Indian
A SILVER MT. ZION
“13 Blues For Thirteen Moons”
ROSE KEMP
“Unholy Majesty”
WILDBIRDS & PEACEDRUMS
“Heartcore”
EARTH
“The Bees Made Honey In The
Lion’s Skull”
XIU XIU
“Women As Lovers”
Head Heritage
DEERHOOF
“Offend Maggie!”
Kill Rock Star
One Little Indian
Leaf
THE BLACK CROWES
“Warpaint”
MY BRIGHTEST DIAMOND
“Thousand Shark’s Teeth”
Constellation
Kill Rock Star
Southern Lord
DISTRIBUZIONE / PROMOZIONE / EDIZIONI
via Fortebraccio 20/A, 00176 Roma (Pigneto) Tel. 06 21700139 Fax: 06 2148346 - e-mail: [email protected]
www.goodfellas.it - www.myspace.com/goodfellasdistribution - news sempre aggiornate su goodfellasblogspot.com
La Sera della
Prima / 129
RADIATION RECORDS
VENDITA PER CORRISPONDENZA: Ordini telefonici: +39 06 90286578 - Ordini via e-mail: [email protected] Circ.ne Casilina 44 (Pigneto) 00176 ROMA
L’incantevole voce
di Florez
Dopo sei anni ritorna al Comunale di Bologna I Puritani di Vincenzo Bellini, ancora una volta con la regia e le scene di
Pier’Alli, che, per la quarta volta consecutiva mette in scena l’ultima opera di Bellini nel teatro della città petroniana. Un
allestimento bello, anche se non eccezionale, nel quale la splendida voce del tenore Juan Diego Florez ha fatto la differenza..
Testo: Daniele Follero
I P uritani
di
V incenzo B ellini – T eatro C omunale
I Puritani: Opera seria in tre atti su libretto di Carlo Pepoli.
Musica di Vincenzo Bellini. Regia e scene: Pier’Alli. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, direttore Michele
Mariotti
Al di là dei meriti stilistici e di quelli storici, imprescindibili nel caso di un’opera rimasta saldamente
legata al repertorio per 150 anni, ciò che conferisce un’aura quasi mitica ai Puritani di Bellini, è
la stretta relazione che essa ha avuto con la morte
del compositore siciliano, scomparso giovanissimo
e nel pieno del suo successo internazionale, una
manciata di mesi dopo la Prima parigina di quella
che sarebbe stata la sua ultima partitura per il teatro. La morte prematura di un artista che dimostra
di avere ancora molto da dire, ha sempre destato
un certo fascino, orientando la critica verso un giudizio sbilanciato verso ciò che sarebbe diventato,
quell’artista, se il fato non avesse deciso anzitempo
la sua scomparsa. E’ successo con molti musicisti
del passato e succede ancora oggi nei più svariati
ambiti musicali: cosa sarebbe diventato Mozart
se avesse vissuto i primi fermenti romantici, lui
che in anticipo su tutti aveva già impregnato le sue
ultime opere di una drammaticità anticipatrice
dello spirito beethoveniano? cosa sarebbe stata la
musica del Settecento se Pergolesi avesse potuto
esprimere la sua maturità invece di essere stroncato a 27 anni dalla tisi? e come sarebbe il rock aves-
di
B ologna (8 – 17 G ennaio 2009)
se potuto godere ancora qualche anno della presenza di icone viventi come Jimi Hendrix, Jim
Morrison e Kurt Cobain? E Verdi? Il Verdi
popolare, di Traviata e Rigoletto, il musicista
risorgimentale per eccellenza, avrebbe avuto una
carriera così limpida se la vita avesse permesso a
Bellini di andare oltre I Puritani?
Domande inutili, forse, ma che aprono a un ventaglio di ipotesi ampio e suggestivo, che condiziona
inevitabilmente il giudizio storico sull’arte e le sue
espressioni.
L’ultima opera del compositore catanese, pur mantenendo alcune caratteristiche tipicamente belcantiste (non manca il lirismo che aveva reso grandi
due grandi capolavori precedenti come Norma e
La Sonnambula) segna anche un superamento
dello stile belliniano, verso tecniche e atmosfere che
ben presto diverranno caratteristiche fondamentali
del melodramma romantico: maggiore espressività
e colore dell’orchestra; uno sviluppo musicale sempre più intimamente legato all’azione drammatica;
cantanti ai quali è sempre più richiesta la capacità di interpretazione attoriale a scapito del virtuosismo; argomento patriottico. L’estetismo lascia il
posto alla funzione drammatica della musica, che
culminerà nella concezione totalizzante del teatro
di Wagner, per il quale musica, testo e azione diventano un tutt’uno inscindibile.
Il conflitto tra i Puritani seguaci di Cromwell e gli
Stuart assume, nel libretto dell’esule patriota bolognese Carlo Pepoli, toni che preannunciano già il
risorgimento italiano, divenendo un esempio di lotta per la libertà trasferibile idealmente nello spirito
nazionalista italiano dell’epoca. Da questo punto
di vista l’opera di Bellini non acquistò la fama e il
rango di vero e proprio “inno alla Patria” di alcune
musiche verdiane, anche se passi dei Puritani come
“Suona La Tromba, Intrepido” già esprimevano
quel complesso di valori liberali di cui il compositore di Busseto sarebbe diventato, di lì a poco, la più
evidente espressione.
Non sarà la Norma in quanto a successo popolare
e posizione nella particolare gerarchia del repertorio, ma I Puritani è entrata di diritto tra le opere
più eseguite di Bellini e, più in generale, del teatro
musicale della prima metà dell’Ottocento e, con
una certa continuità, sin dai suoi esordi, è arrivato
fino a noi, come dimostrano le rappresentazioni
ospitate dal Teatro Comunale di Bologna, che dal
1836 e prima di questo nuovo allestimento, arrivavano fino al 2002. Nella memoria bolognese
resterà senz’altro la grande interpretazione di un
Pavarotti già maturo, ma non ancora divissimo,
del 1969, accompagnato da Mirella Freni, subentrata a un’indisponibile Joan Southerland
(come dire, calcisticamente, che esce Maradona
ed entra Platini!).
Altri tempi, direbbe qualche nostalgico del belcanto.
“Tiempe Belle ‘E ‘Na Vota…E Pecchè Nun Turnate”, come recita una nota canzone napoletana, con
nostalgia e pessimismo. Domanda legittima per il
melomane. Che forse però, ascoltando la voce di
Juan Diego Florez, qualche speranza l’avrà covata, dentro di sé, come il tifoso (sempre per rimanere
in tema calcistico) che solleva speranze nella nuova
promessa, sognando il ritorno dei grandi campioni
del passato. La voce di Florez, tenore peruviano ancora giovane ma già maturo musicalmente e di notevole fama internazionale, è, secondo la mia ancor
più giovane conoscenza della lirica, la più espressiva
e limpida voce tenorile che abbia mai ascoltato dal
vivo. Una voce che prende la scena con una natu-
ralezza e una chiarezza che oltrepassano il livello
medio delle altre presenze, che riesce a svolazzare
tra le note alte, ma è capace anche di vestirsi di toni
cupi e drammatici senza perdere vigore. In alcuni
tratti il ruolo di Lord Arturo Talbo, sembra cucito
perfettamente per la plasticità della sua voce, ancor
più che i ruoli mozartiani, grazie ai quali si è imposto sulla scena internazionale.
L’allestimento, una collaborazione a tre tra il Comunale, il Massimo di Palermo e il Lirico di Cagliari è
stato, per il teatro bolognese il quarto consecutivo a
portare la firma del regista fiorentino Pier’ Alli, del
quale avevamo potuto apprezzare, lo scorso anno,
la messinscena multimediale del Requiem di Verdi. Niente video, stavolta, ma predilezione per scene
mastodontiche e spigolose, a contatto con le quali
la luce fioca crea un’atmosfera cupamente gotica.
Enormi spade, a mo’ di colonne doriche disegnano
la scena, tenendo ben presente per tutto il dramma
l’idea del conflitto, della lotta a testimonianza della
grande attenzione ai simboli caratteristica dello stile
scenografico di Pier’Alli.
Sul podio, Michele Mariotti, ormai sempre più
lontano dalla qualifica di “giovane” vista la sua
sicurezza nel dirigere, ha interpretato in maniera decisa e accentuata i chiaroscuri presenti nella partitura, dimostrandosi un dignitoso erede di
Daniele Gatti, pur avendo caratteristiche diverse dal direttore milanese.
Quando le cose stanno così, quando la regia funziona e dialoga bene con la musica e con cantanti
“sopra la media” come Florez, è un bene per tutti.
Anche per chi la lode non la meriterebbe.
a night at the opera /
131
Dmitri Shostakovich
Fino all’ultima sinfonia
Stretta tra la voglia di aprirsi ai nuovi linguaggi delle avanguardie europee, la fedeltà agli ideali del socialismo sovietico e le
censure del regime, la carriera artisica di Dmitri Schostakovich ha coinciso del tutto con la vita dell’U.R.S.S., dalla morte
di Lenin alla “normalizzazione” di Breznev, assorbendone tutte le contraddizioni. Personaggio schivo, introverso, amico di
Majakovskij, comunista convinto, ma spesso avversato dal regime, Mitja, come veniva chiamato dai più intimi, rappresenta,
nel bene e nel male il compositore sovietico per eccellenza. Testo: Daniele Follero
“Quando un uomo è disperato vuol dire che crede ancora in
qualcosa”
Dmitri Schostakovich
Affrontare e, talvolta, giudicare la storia e l’opera
di artisti vissuti all’ombra dei regimi totalitari non
è mai cosa facile. In società dove la cultura è controllata da istituzioni create ad hoc e le espressioni
artistiche sono censurate ogni qualvolta non si allineino alle direttive del regime, le soluzioni sono
due, non si scappa: emigrare (laddove si possa) o
adattarsi, reprimendo, in maniera un po’ schizofrenica, gli istinti creativi che rischiano di trasbordare verso libertà non concesse. Molti artisti del
Novecento (ma anche scienziati, come Freud e
Einstein), nati in Germania, Italia o Russia e sensibili ai cambiamenti radicali delle avanguardie
“storiche” (che coincisero, cronologicamente, con
il periodo delle grandi dittature del XX secolo) optarono per la prima soluzione, con la conseguenza
di apparire come degli eroi, pur avendo scelto la
via più semplice (per modo di dire, ovviamente)
ma, in ogni caso, più coerente con le proprie idee,
politiche e culturali.
Una scelta quasi obbligata per evitare di scendere a compromessi umilianti, che qualcuno non
ha avuto il coraggio o la semplice intenzione di
compiere, con conseguenze spesso devastanti per
la propria carriera o, quantomeno, con il rischio
sempre incombente di sacrificare, fino all’insop-
portabile, l’arte alla vita politica. Non lo fece Mascagni, adattatosi senza vergogna alle esigenze
populiste del fascismo e caduto presto nel dimenticatoio; e lo fece solo a metà Prokofiev, prendendo
le distanze dalla rivoluzione leninista per ritornare
in U.R.S.S. all’apice del regime stalinista.
Per Shostakovich, invece, che con gli ideali della
Rivoluzione di Ottobre si era alimentato e credeva
nel socialismo sovietico, restare a vivere in patria
fu atto dovuto, un motivo d’orgoglio, manifestato
attraverso la piena adesione agli ideali del nuovo
potere politico che aveva rovesciato l’ultimo zar.
Ci credette a lungo, nonostante percepisse che
qualcosa non quadrava. Ci credette, almeno fino
a quando, nel 1935, la Pravda non pubblicò quel
maledetto articolo sulla sua Lady Machbeth, dal
titolo: “Caos anziché musica”. A cui seguì il marchio definitivo di formalismo apposto dal regime
alla sua Quarta Sinfonia, Da quel momento, la
contraddizione tra lo Shostakovich artista e il cittadino sovietico cominciò a diventare incolmabile e
a rappresentare un ostacolo sempre più insormontabile per il carattere mansueto e debole (come la
sua salute) del compositore di San Pietroburgo.
L a R ivoluzione
di
M itja
Nato a San Pietroburgo nel 1906, ma vissuto a
Leningrado (il nome che assunse la sua città natale dopo il 1917) Shostakovich è figlio legittimo,
sia per ragioni anagrafiche sia ideologiche, della
rivoluzione bolscevica. Il clima familiare nel quale
cresce il piccolo Mitja (come veniva chiamato dai
parenti e dagli amici più intimi) risente molto delle
idee leniniste e contribuirà non poco a stimolare il
suo spirito progressista, fino a coinvolgerlo di persona (è stato per molto tempo membro dell’Unione dei Compositori). Durante gli anni giovanili dei
primi studi musicali, viene in contatto con Prokofiev, di qualche anno più grande,e con Majakovskij,
personaggi che influenzeranno non poco la prima
sua prima fase compositiva, anche se i rapporti tra
lui e il compositore ucraino non saranno mai idilliaci e si limiteranno ad una cortesia di maniera
non priva di critiche reciproche. Già nella Prima
Sinfonia, che lo impone all’attenzione internazio-
nale all’età di appena 19 anni, il “modernismo”
del primo Prokofiev è presente in tutta la sua carica dirompente, espressa con sonorità spigolose
e ritmi sferzanti, trame melodico-armoniche che
alternano atonalità e politonalità e un particolare
interesse per l’organizzazione timbrica. Ma non
mancano le influenze mitteleuropee, che si concretizzano, nei primi lavori sinfonici di S.(almeno
fino alla Quarta Sinfonia), soprattutto nella figura di Paul Hindemith e del suo neo-oggettivismo.
Pungente, sarcastico, nel complesso uno stile non
certo facile da digerire, per un ambiente musicale
come quello russo, ancora strettamente legato al
sinfonismo tardo-romantico.
Se lo stile guarda all’occidente, però, le intenzioni,
i cosiddetti contemporanei /
133
i messaggi, sono tutti rivolti al socialismo sovietico. Spesso le composizioni di S. sono dedicate ai
miti della rivoluzione o scritte per particolari celebrazioni (ne è un esempio la Seconda Sinfonia,
denominata “Ottobre” e composta per il decimo
anniversario della Rivoluzione, nel 1927).
Anche nell’opera lo stile di S. si mostra ricco di
sfumature ed evidenzia una forte carica ironica,
espressa attraverso un linguaggio musicale a volte
parodistico, altre esasperato, con l’orchestra che assume un ruolo determinante nell’effetto complessivo. Nasce con queste caratteristiche il suo primo
lavoro teatrale, Il Naso (1930), tratto dall’omonimo
racconto di Gogol’. La personale elaborazione dei
linguaggi delle avanguardie europee (Stravinskij,
Hindemith, Berg) e la deformazione di timbri e
voci che assume toni talvolta ironici, talvolta grotteschi, rendono quest’opera assolutamente eccezionale nel mondo in cui prende vita.
I l R ealismo S ocialista , S hostakovich
l ’U.R.S.S.: una storia di censure
e
Il dibattito culturale su un’arte che esprimesse la realtà della società post-rivoluzionaria e sovietica era
già ampiamente avviato all’epoca, ma la censura
non aveva ancora colpito il compagno Mitja che,
seppure in maniera troppo “occidentale” (a quei
tempi sinonimo di borghese e quindi di nemico
politico e culturale) aveva dimostrato di aderire ai
precetti della nuova arte russa. Un’adesione ad un
linguaggio che fosse il più possibile comunicativo,
celebrativo e funzionale al cambiamento radicale
della società. E che S. interpreta a suo modo attraverso una raffinatezza compositiva che gli permette
di esprimersi a più livelli, senza per questo cadere
nelle grinfie della critica più ortodossa e intransigente. Ma questo equilibrio riesce a durare ancora
qualche anno, anche perché sempre più stretta si fa
la morsa del potere politico (che culminerà dopo la
seconda guerra mondiale negli “editti” di Ždanov,
il plenipotenziario “colonnello” di Stalin) sulla cultura e l’accusa di “formalismo” (cioè di un supposto
interesse per la forma in sé a scapito della comuni-
cazione) diventa lo strumento più in voga per “scomunicare” un artista. Una recensione sulla Pravda
critica aspramente la seconda opera teatrale di S.,
Lady Macbeth Del Distretto di Mcensk (rivisitata
poi nel 1963 con il nome della protagonista femminile, Katerina Ismailova), che pure voleva interpretare il delitto di Macbeth come gesto di rivolta antiborghese, bollandola come “caos” e, addirittura,
parlando di “pornofonia” nel caso della descrizione
musicale dell’amplesso tra Katerina e Sergej. Segue
a ruota la stroncatura della sua Quarta Sinfonia. E
in meno di un anno uno dei più grandi compositori della Russia Sovietica, viene messo al bando e
costretto a ritrattare le sue idee artistiche (firmando
addirittura una poco convinta condanna critica alla
figura di Schoenberg), con lo scopo di fornire solide
garanzie al controllo del regime. E’ da questo momento che la contraddizione che covava nel mite
S. esplode in maniera irruenta nella sua vita. Una
condizione sì dell’uomo, ma che si può estendere a
tutta la società sovietica, stretta tra parole di libertà
e un atteggiamento del potere che esprime l’esatto
contrario
Si spiega così la virata improvvisa di S., dalla Quinta Sinfonia in poi, verso uno stile più sobrio e lirico, che abbandona i radicalismi avanguardisti e
si riavvicina al tonalismo. L’orchestra viene ridotta,
il linguaggio si accosta di più a Mahler e al poema sinfonico e spesso e volentieri vengono utilizzati
testi, come nel caso della celebre Settima Sinfonia
“Leningrado”, scritta durante la battaglia del 1941.
La vitalità compositiva di S. non si spegne neanche
durante gli anni della guerra, ma ben presto un altro colpo, un’altra confessione strappata con la forza a seguito del rapporto Ždanov, lo costringe ad
abbandonare qualsiasi benché minima intenzione
innovativa, lasciando cadere la sua musica verso
toni maggiormente celebrativi e un sinfonismo tardo-romantico alla Tchaikovsky.
R iflettendo
sull a morte
La conseguenza di questi colpi bassi, porta un ormai disilluso S. ad allontanarsi sempre di più dal-
la realtà (ormai irreparabilmente confusa con la
propaganda. Una condizione descritta in maniera
eccellente da Orwell in 1984), spingendosi verso
i territori dell’immaginazione. La riflessione sulla
morte diviene il tema più ricorrente dell’ultima
fase compositiva del compositore di Leningrado,
che si chiude così, in un pessimismo fatalista sempre più scuro. Proprio lui, che per tanti anni aveva
creduto nell’”uomo nuovo”! Anche la musica si fa
più cupa: abbandonati già da molto tempo i generi dell’opera e del balletto (altro genere molto
stimato nella Russia sovietica e al quale S. aveva
regalato, prima del ’35 opere di ottimo livello e
“sopra la media” come L’Età Dell’ Oro, Il Bullone
e Il Limpido Fiume, rispettivamente del ’30, ’31 e
’35), S. si concentra sulle sinfonie e sulla musica da
camera, mantenendo costante anche il suo impegno come compositore per il cinema, reso più prolifico ma anche meno interessante, artisticamente,
dall’avvento del sonoro (degne di nota sono le musiche scritte per l’unico film muto musicato da lui,
Nuova Babilonia). Ma se la sinfonia rappresenta
ormai la forma prediletta dal regime per la sua autocelebrazione, nelle partiture per organici piccoli
e destinata a luoghi d’esecuzione ridotti, MItja riesce a sviluppare la sua ricerca musicale più sincera, ancora attratta dai linguaggi della modernità,
dalle avanguardie al jazz. Nei numerosi Quartetti
(15 in tutto) e Quintetti S. può ancora permettersi
di comporre, indisturbato, utilizzando le serie dodecafoniche e i cromatismi più estremi. Tra questi,
l’Ottavo Quartetto (1960) è senz’altro il più significativo: una sorta di epitaffio auto celebrativo, nel
quale il tema è ricavato dalle iniziali del nome del
compositore (D.S.C.H., che corrispondono alle
note Re-Sol-Do-Si).
La contrapposizione tra, da un lato, un atteggiamento celebrativo, sottomesso alle volontà del regime, espresso attraverso un acceso lirismo e l’uso
costante di elementi folclorici (le Sinfonie n.11,
dedicata alla rivoluzione fallita del 1905 e la n.12,
“in memoria di Lenin”) e, dall’altro la voglia di
confrontarsi con i suoi contemporanei europei
sperimentando a suo modo con i linguaggi della
modernità (la Sinfonia n.13 si testi di Evtušenko,
che gli valse l’ennesima censura nel 1962), ha rappresentato una costante, assunta a fondamentale
caratteristica stilistica, dello S. compositore. Che
come abbiamo avuto modo di vedere, non era molto diverso dall’uomo, combattuto in questo eterno
conflitto, rimasto irrisolto fino alla sua morte. Fino
all’ultima sinfonia. Sarebbe stata la Sedicesima.
The Essential Dmitri Shostakovich
* Sinfonia n.1 in Fa minore (1925)
* Sinfonia n.2 in Si maggiore “Ad Ottobre” (1927)
* 10 Aforismi per Pianoforte (1927)
* Musiche per il film muto “Nuova Babilonia” (1929)
* Sinfonia n.3 in Si bemolle maggiore “Il Primo Maggio” (1929)
* Il Naso (1930) tratto da un testo di Gogol’
* Suite per Jazz Orchestra n.1 e 2 (1934 e 1938)
* Lady Macbeth Del Distretto Di Mcensk (1934) tratto da un testo di Leskov
* Sinfonia n.4 in Do minore (1936)
* Sinfonia n.5 in Re minore (1937)
* Sinfonia n. 7 in Do maggiore “Leningrado” (1941)
* Sinfonia n.8 in Do minore (1943)
* Quartetto d’archi n.8 in Do minore (1960)
* Sinfonia n.13 in Si bemolle minore “Babi-Yar”
(1962)
* Quartetto d’archi n.9 in Mi bemolle maggiore
(1964)
* L’Esecuzione Di Stepan Razin (1966) su testo du
Evtušenko
* Quartetto d’archi n. 12 in Re bemolle maggiore
(1968)
* Sinfonia n. 15 in La maggiore (1971)
* Quartetto d’archi n.15 in Mi bemolle minore
(1974)
* Sonata per Viola (1975)
i cosiddetti contemporanei /
135
sentireascoltare.com
a breve di nuovo online......