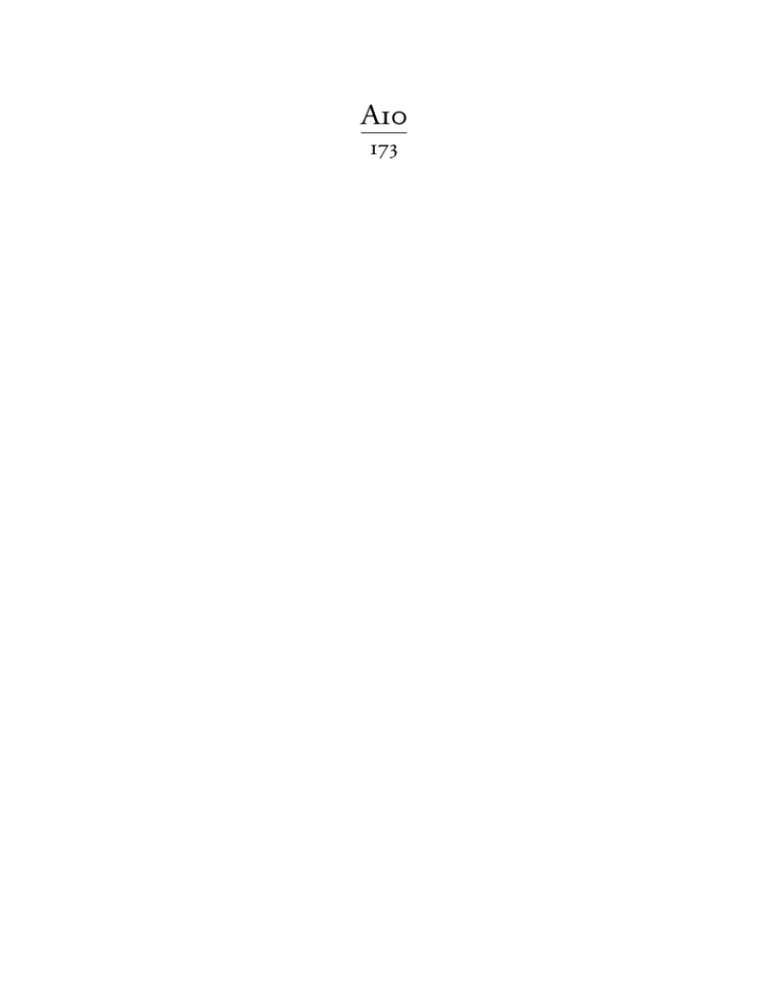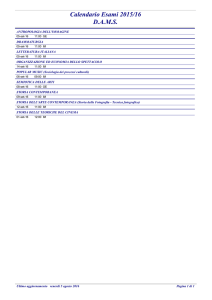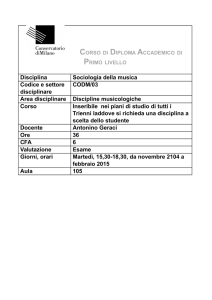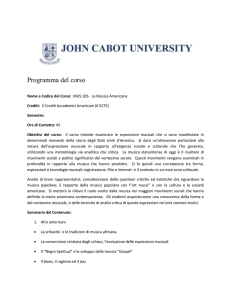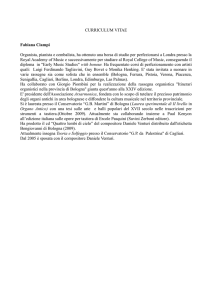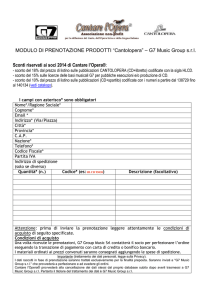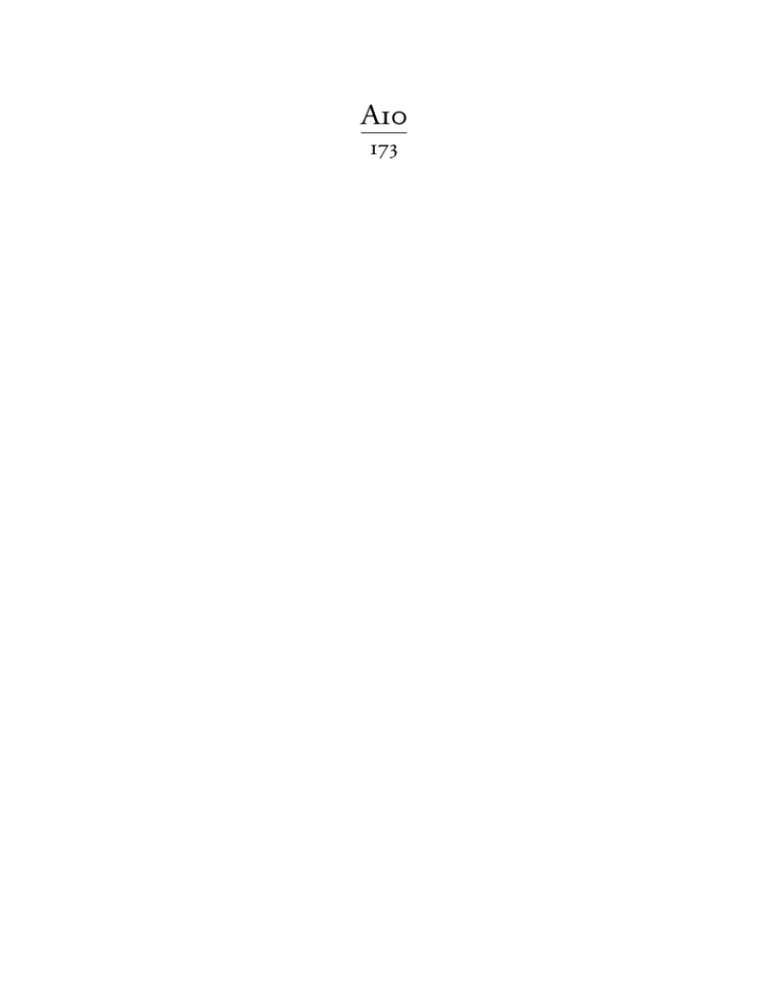
A10
173
Il volume è stato realizzato con il contributo del Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria e del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza.
Popular music
Fare, ascoltare, insegnare
a cura di
Fabrizio Deriu e Massimo Privitera
Copyright © MMVI
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
88–548–0488–6
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: marzo 2006
Indice
Presentazione
7
Introduzione
9
di Massimo Privitera
Prima sessione
Università e dintorni
Roberto Agostini
Origini, sviluppi e prospettive
degli studi sulla popular music in Italia
19
Egidio Pozzi
Lo studio dell'improvvisazione jazzistica:
lick e pattern nei soli di Enrico Rava e Chet Baker
39
Fabrizio Deriu
“Imitare, rifare, esaltare”.
Ipotesi interpretative intorno al fenomeno “tribute band”
63
Bruno Gioffrè
Dalla manifestazione del suono alla musica
(alla logica, alla forma, alla mente…)
81
Luca Marconi
97
Valori, paradigmi, canoni
Nadia Capogreco
Popular music:
dai limiti della definizione alla ricchezza dell'esperienza
107
Massimo Distilo
Popular music e giudizi di valore
5
117
6
Seconda sessione
Conservatori, scuole secondarie, scuole private di musica
Emilio Galante
La popular music nei Conservatori
123
Maurizio Boco
La Fonderia delle Arti (Roma)
133
Davide Beatino
Modern College of Music (Reggio Calabria)
143
Stefano Toni
I Laboratori musicali nel sistema scolastico.
Il Progetto Speciale Musica del Miur – Istruzione
149
Francesco Domenico Stumpo
La popular music come il postino di Bruner
153
Daniele Moraca
Un cantautore (calabrese) alle Fær Øer
159
Gianni Testa
Popular music: comunicazione
e fusione di infinite sonorità… La mia esperienza
163
Gli autori
175
Presentazione
In questo volume sono riuniti gli interventi presentati alle due giornate di studio Popular music. Fare/ascoltare/insegnare, che il DAMS
dell’Università della Calabria e il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza hanno organizzato a Cosenza ed ad Arcavacata di
Rende il 30 novembre e l’1 dicembre 2005 (nell’ambito di un seminario in più momenti sul rapporto tra arti e tecnologie, intitolato Rileggere Benjamin). Scopo di queste giornate è stato far incontrare e confrontare soggetti che a vario titolo si occupano (o intendono occuparsi)
di insegnare la popular music: dunque l’Università e i Conservatori, le
Scuole medie e le Scuole superiori; ma anche — e da un certo punto
di vista soprattutto — le scuole private di musica, le quali rispondono
ad una grande e crescente domanda di istruzione musicale che non
trova adeguate risposte nelle altre istituzioni musicali.
Da alcuni anni le Università italiane si sono progressivamente aperte
alla popular music, includendone la storia e la critica in diversi curricula
musicologici; anche se non si può ancora dire che questa branca di studi
sia veramente entrata di diritto nel panorama universitario (vedi la relazione di Roberto Agostini). Molto di recente anche i Conservatori, che
già da tempo hanno incluso il jazz fra i propri corsi, hanno cominciato a
seguire questa strada, pur fra inevitabili difficoltà e contraddizioni (vedi
la relazione di Emilio Galante). La riorganizzazione degli studi universitari e conservatoriali prevista dalle leggi 508 e 509 (successivamente
emendate ed ampliate) ha infatti imposto, nel bene e nel male, di ripensare a fondo il ruolo e l’obiettivo dell’insegnamento della musica; e
passi interessanti in questa direzione si stanno compiendo proprio guardando alla ricca e complessa realtà della popular music. Un’occasione
di confronto e di dialogo su questi temi, tra quanti operano in spazi,
strutture e istituzioni dell’universo musicale (con la speranza che altre
ne seguano), non può dunque che essere accolta con favore, come peraltro hanno dimostrato la partecipazione del pubblico e l’intensità delle
discussioni che si sono svolte nelle due giornate.
Le diverse provenienze e professionalità dei partecipanti al convegno (musicologi, didatti, artisti — con buona rappresentatività della
realtà calabrese) si è riflettuta nei diversi stili delle loro relazioni. Nelle due sessioni si sono alternati bilanci storiografici, riflessioni critiche, proposte analitiche, resoconti di esperienze didattiche, testimonianze di percorsi artistici individuali (e anche articolati interventi del
7
8
Presentazione
pubblico). La loro proficua interazione è apparsa a tutti i presenti
l’aspetto più vitale e stimolante degli incontri, poiché varie componenti del mondo della popular music vi hanno potuto interagire, con pari
dignità e in un desiderio condiviso di reciproco arricchimento. Per
questo, predisponendo gli atti del convegno, abbiamo deliberatamente
evitato di omogeneizzare la natura, lo stile, la dimensione degli interventi. Siamo convinti che il loro insieme sia un’efficace spaccato del
particolare momento che si sta vivendo nell’Università e nelle tante e
variegate realtà in cui si insegna a far musica. Un momento di grandi
fermenti, ma anche di incertezze, dubbi, esitazioni. Crediamo, con
questo volume, di dare un contributo, certo circoscritto ma ugualmente significativo, al dibattito in corso; ed è con questo auspicio che lo
consegniamo ai lettori.
Fabrizio Deriu, Massimo Privitera
Introduzione
Insegnare (e imparare) la popular music:
le ragioni di un incontro
di Massimo Privitera
Vorrei cominciare riportando un dato; un dato statistico decisamente significativo, diffuso nel 2000 dall’IFPI (Intenational Federation of
Phonographic Industries), sul consumo di musica registrato nel 1997.
Circa il 90% della musica venduta nel mondo rientra nella categoria
della popular music. Seguono, da lontano, la musica classica, che copre il 3,6%, il jazz l’1,2, il blues lo 0,3. Certo, questa immensa percentuale del 90% va disaggregata, anche perché l’etichetta popular music
copre in realtà un amplissimo ventaglio di realtà musicali. Si scopre
così che la musica pop vera e propria copre il 34,3%, il rock il 25,7, la
dance l’11,8, il R&B il 7,7; mentre l’8,3 è ricoperto dal cosiddetto “easy listening”, il 2,1 dal country, l’1,4 da altri sottogeneri minori.
Nondimeno rimane l’eloquenza complessiva del dato.
Per chi si occupa di popular music da anni questi numeri, con tutte
le conseguenze che comportano, sono un fatto assodato [cfr. ad esempio, in ambito italiano, Baroni–Nanni 1989]. Al contrario, nelle istituzioni musicali ufficiali (Conservatorio ed Università) sono assai poco
noti; e, a prenderli sul serio, risultano alquanto destabilizzanti. È per
questo che parto da essi, perché ci dicono qualcosa di molto chiaro sui
flussi musicali globali. Ci impongono una riflessione seria ed approfondita su cosa sia la cultura musicale, e su quali debbano essere i percorsi di una pedagogia della musica che voglia venire incontro democraticamente alla domanda diffusa di musica (e per democraticamente
intendo qui nel rispetto della personalità e dei gusti di chi vuole imparare; senza rinunciare a tutto ciò che noi consideriamo essenziale nell’insegnamento della musica, ma anche senza pretendere che a dover
rinunciare siano i nostri allievi [cfr. Stefani 1985 e Stefani (a c.)
1987]). Non a caso io, che come musicologo non mi occupo direttamente di popular music, ho ricavato questi dati da un bel libro di Lucy
Green, nota pedagogista inglese della musica, che fa il punto sul modo
in cui la maggior parte dei giovani impara a far musica [Green 2002].
Vale la pena segnalare che i risultati dell’IFPI sono sostanzialmente
confermati anche in ambito italiano da un rilevamento ISTAT, benché
risaltino alcune significative differenze (dovute in parte, ma non esclusi9
10
Massimo Privitera
vamente, al diverso modo di rilevare e presentare i dati). Questo istituto,
che monitora annualmente la vita quotidiana degli italiani, approfondisce
ogni cinque anni alcune tematiche specifiche; e nel 1995 ha svolto un’indagine sul tema “Tempo libero e cultura”, nella quale hanno avuto una
specifica attenzione i «comportamenti musicali della popolazione»:
Il primo dato eclatante riguarda il predominio della musica leggera su tutti gli
altri generi ascoltati (genere seguito dal 74,1% degli ascoltatori) […]. Subito
dopo la musica leggera, ma già a grande distanza, si ritrovano il rock (34,3%)
e la musica classica/lirica (29,5%) come generi maggiormente seguiti dalla
popolazione, mentre gli altri generi considerati [folk, regionale, tradizionale,
disco, house music, techno, rap, underground, pop, etnica] riguardano gruppi
di popolazione molto simili in termini di ampiezza (tra il 22 e il 25% circa)
ma estremamente diversificati al loro interno […] in termini generazionali e
culturali. [ISTAT 1999, pp. 18–19]
Benché la terminologia usata appaia abbastanza antiquata, la fotografia dei gusti musicali degli italiani è nondimeno eloquente. La disaggregazione dei dati, poi, fornisce informazioni molto interessanti,
ad esempio quando rende evidente che la musica classica è preferita
soprattutto da quarantenni/sessantenni del nord Italia:
La musica classica e lirica, con il suo 29,5% di ascoltatori, che corrisponde a
circa 15 milioni di persone con più di 10 anni, occupa il terzo posto nella graduatoria dei generi musicali più seguiti in Italia […]. Mentre non esistono differenze per ciò che riguarda il sesso degli ascoltatori di musica classica e lirica, così come per molti altri generi musicali è la variabile generazionale a discriminare ad un primo livello gli ascoltatori di classica e lirica. Al crescere
dell’età aumentano infatti progressivamente le percentuali degli ascoltatori, attestandosi su valori superiori al 32% tra i 35 e i 74 anni (il massimo, 34,1%,
riguarda chi ha tra i 55 e i 59 anni), mentre superata quest’ultima soglia di età
si registra (come d’altronde per molte altre attività del tempo libero) un calo
nella percentuale di ascoltatori (22,5%). La musica classica e lirica è ascoltata
maggiormente nel Nord–ovest e nel Nord–est del paese (35% circa) e nel Centro (31%), mentre al Sud gli ascoltatori di questo genere musicale sono soltanto il 21 –22% circa. [ISTAT 1999, p. 22]
Ma torniamo al libro di Green, e spostiamoci dal piano dell’ascoltare a quello del fare. L’autrice fa notare come oggi la musica sia disponibile in modi inimmaginabili nelle epoche passate, ma anche come i mezzi di riproduzione meccanica del suono abbiano fatto ridurre
in percentuale il numero di persone che praticano la musica.
Green identifica poi due universi distinti dell’apprendimento musicale: da un lato un’educazione musicale formale (cioè quella impartita
Introduzione
11
da Conservatori e insegnanti privati di musica che seguono i metodi
conservatoriali), dall’altro un’educazione musicale informale (cioè
quella molteplicità di percorsi che seguono i giovani quando si accostano alla musica). Questi due percorsi possono talvolta incrociarsi,
quando giovani musicisti di popular music conducono, solitamente solo per qualche tempo, studi accademici; ma sostanzialmente sono alternativi e non comunicanti, non solo perché presuppongono differenti
repertori di riferimento, ma soprattutto perché implicano concezioni
radicalmente diverse di cosa sia la musica [cfr. Stefani (a c.) 1987].
Vorrei riprendere ed ampliare questa distinzione di Green, perché
mi pare fondamentale capire quali siano i modi più diffusi di imparare
la musica, per farne tesoro nella nostra programmazione didattica.
L’educazione musicale formale si basa sugli strumenti tradizionali
dell’orchestra, con la scelta esclusiva di un solo strumento (benché esista la possibilità dello strumento “complementare”) e la rigorosa esclusione di quelli elettrici; dà la precedenza alla lettura della musica
scritta, e prevede un rapporto con la partitura che possiamo definire
sacrale (o feticistico, a seconda della prospettiva). L’improvvisazione
è normalmente bandita. Lo studio e la pratica della musica sono prevalentemente individuali. Il corpo è rimosso o marginalizzato, e la voce
(con l’ovvia esclusione dei cantanti) è confinata in segmenti didattici
limitati e secondari.
L’educazione informale, invece, si basa prevalentemente sulla pratica
collettiva. I giovani imparano a far musica in gruppo, e imparano prevalentemente dai loro pari — anche da musicisti più anziani, ma vissuti
come colleghi più esperti, e non come maestri. Benché venga identificato
uno strumento principale con il quale esprimersi, di norma si prendono
in mano diversi strumenti, usandoli occasionalmente anche in registrazioni e concerti. L’eccellenza tecnica, benché tenuta in gran conto, non è
un obiettivo prioritario. L’espressione corporea è parte integrante del far
musica, e cantare ne è una componente centrale e condivisa. Alla base di
tutto sta l’improvvisazione (o l’estemporaneità).
Ma è nel dominio della composizione che si può cogliere meglio la
differenza fra i due approcci. Nell’educazione formale la composizione è una branca estremamente complessa, altamente specializzata e separata dal resto dell’attività musicale. Richiede un tirocinio lungo e faticoso (in Italia dieci anni, conclusi da prove durissime anche quanto a
resistenza fisica). Al contrario, nell’educazione informale la composizione è uno sbocco naturale del far musica: chi suona, in genere, prima o poi finisce anche per comporre; e spesso lo fa ai primi stadi del
12
Massimo Privitera
proprio percorso musicale. In questo contesto la scrittura e la lettura
della musica possono apparire come un ostacolo piuttosto che come
un’opportunità — così la pensa ad esempio Paul McCartney, che certo
di popular music se ne intende…
Nel mondo della popular music è sempre più rara la figura dell’interprete di canzoni altrui. Fra le stelle più brillanti del panorama internazionale della popular music sono sempre più numerosi i/le songrwiters che interpretano le proprie canzoni: da big come Bob Dylan e
Paul Simon, a nuove stelle come Norah Jones e Rosa Passos, ad esordienti come Amos Lee e Corinne Bailey Rae. Anche in Italia l’autore
e l’interprete vanno sempre più sovrapponendosi: personaggi come
Francesco Guccini, Paolo Conte, Claudio Baglioni — lo stesso Lucio
Battisti —, nati come autori, sono passati ad interpretare da sé le proprie canzoni; e oggi i più interessanti protagonisti della scena musicale
sono autori–interpreti, da Mariella Nava a Elisa, da Zucchero e Carmen Consoli, etc.
Di questo, nel mondo anglosassone c’è piena consapevolezza, riflessa in film quali School of Rock, o, ad un altro livello, in vasta produzione editoriale che va da manuali generali [Citron 2002], ad approcci più specifici (come il comporre sulla chitarra [Rooksby 2000],
o la cura della melodia [Perricone 2000]), a raccolte di testimonianze
dei più importanti songwriters [Zollo 20033].
Certo, stiamo parlando della composizione di una piccola forma —
la canzone. Ma questa piccola forma è certamente la più vitale, la più
longeva e la più amata di tutta la storia della musica [cfr. Fabbri 2001].
In Italia la distanza fra i due percorsi di cui parla Green è forse
maggiore che altrove, per la particolare storia delle istituzioni musicali
nel nostro paese. Chi come me ha una cinquantina d’anni, da ragazzo
ha visto crescere attorno a sé velocemente e inarrestabilmente, dagli
ultimi anni sessanta, la richiesta di musica. Quale è stata la risposta istituzionale a quella formidabile crescita? Invece di rifondare gli studi
musicali, differenziandoli a seconda del tipo di richiesta (di per sé alquanto variegata), si preferì allargare il già esistente. È cresciuto così
il numero dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, senza
però che ne venisse modificato l’impianto di scuola professionale,
cioè di istituzione nata per formare professionisti per le orchestre sinfoniche, i teatri d’opera, ed il concertismo. Di conseguenza una grandissima fetta di potenziali fruitori di educazione musicale pratica è stata di fatto esclusa (o anche rifiutata) da questo assetto istituzionale. Da
ciò è nato quell’interessantissimo fenomeno delle scuole popolari di
Introduzione
13
musica, di cui parleranno nelle pagine successive persone più qualificate di me.
Allo stesso tempo si aprirono spazi universitari inusitati: nel 1970
veniva fondato a Bologna il DAMS, che faceva entrare la musicologia
come soggetto attivo nel panorama universitario (e ricordo, en passant, che il DAMS dell’Università della Calabria è stato il secondo in
Italia). Fin dall’inizio il DAMS ha accolto entrambe le tipologie di
studenti descritte da Lucy Green: da un lato giovani diplomati o diplomandi in Conservatorio, che desideravano ampliare la conoscenza
culturale della musica; dall’altro giovani che avevano praticato e studiato la musica in vari modi, e vedevano nell’Università l’unico spazio loro disponibile per studiare musica dentro un’istituzione [cfr. Stefani (a c.) 1987 e 1989 e Privitera 1988].
Da qualche anno però le cose stanno cambiando velocemente, in
tutte e due le istituzioni. Quando cominciai ad insegnare al DAMS,
dieci anni fa, i nostri studenti erano ripartiti in maniera abbastanza equilibrata fra persone che frequentavano o avevano frequentato il conservatorio; persone che avevano studiato privatamente secondo percorsi para–conservatoriali; persone che avevano praticato il jazz e soprattutto la popular music; e infine una piccola porzione di persone
che avevano un generico amore per la musica, pur senza averla mai
praticata. Oggi invece, anche a causa della riforma che ha reso impossibile il percorso parallelo Università–Conservatorio, la grande maggioranza dei nostri studenti non ha frequentato il Conservatorio, ma ha
avuto una formazione musicale informale. Ad esempio, della trentina
di studenti che frequentano quest’anno il mio corso di Storia della musica dall’antichità al rinascimento, due buoni terzi sono chitarristi
rock, blues, pop; degli altri, alcuni suonano la batteria, un paio il saxofono, qualcuno canta. Solo un paio hanno fatto studi regolari, anche se
non ancora completati, o abbandonati strada facendo. Tutto questo ha
diverse e significative implicazioni per l’approccio didattico del docente. La maggioranza ha con la scrittura e la lettura musicale un rapporto precario: qualcuno legge, ma con difficoltà; qualcuno decifra,
ma fatica a leggere; altri posseggono nozioni di teoria, ma quasi del
tutto staccate dalla notazione. Dunque ci si deve avvicinare alla musica secondo le modalità proprie a questi ragazzi: usando come strumento analitico prioritario l’orecchio, e inserendo in un secondo momento
l’occhio (la lettura e la riflessione).
Anche il Conservatorio è sottoposto a pressioni del tutto nuove.
L’istituzione dei trienni, e dunque l’accesso aperto a studenti che ab-
14
Massimo Privitera
biano già diciassette o diciotto anni, sta cambiando la fisionomia di
molti corsi; e permette di superare certi assurdi sbarramenti che hanno
finora tenuto lontani dal Conservatorio tanti giovani. Ad esempio qui
a Cosenza l’apertura della classe di jazz anche ai non diplomati in
strumento, grazie al nuovo triennio, ha permesso un boom di domande
di iscrizione — benché, a mio parere, non è puntando tutto sul jazz
che si affronti correttamente il problema.
Mi pare dunque, alla luce di queste considerazioni, che dobbiamo
ripensare radicalmente gli obiettivi, i metodi ed i percorsi dell’educazione musicale nelle nostre istituzioni, includendo, secondo modalità
ancora tutte da definire, anche la popular music. Questo non per addomesticarla (o mummificarla) togliendole quell’aspetto erratico che
ne è in fondo il fascino, né per seguire affannosamente e pedissequamente il vento delle mode, ma per un duplice scopo: accogliendo la
popular music nei nostri curricula possiamo vivificare l’insegnamento
formalizzato (come lo chiama Green), includendo e valorizzando in
esso la creatività, la duttilità, l’improvvisazione, l’ascolto, la danza e
l’espressione corporea. Per contro le nostre istituzioni possono fornire
all’apprendimento della popular music strumenti antichi collaudati che
hanno reso grande la tradizione musicale dell’Occidente: la riflessione
teorica, il pensiero polifonico, il poliforme strumentario, l’elaborazione della forma, e tante altre cose impossibili qui da sintetizzare.
Credo insomma che dovremmo tendere ad un modello didattico di
musicista integrale e capace di muoversi agevolmente e senza pregiudizi fra culture e pratiche musicali diverse, riuscendo così a realizzare
compiutamente le proprie potenzialità musicali individuali — come
dice Gino Stefani ad «essere qualcuno musicalmente». E credo anche
che questo modello didattico possa prendere corpo solo con la creazione di una nuova entità istituzionale, in cui si incontrino con pari dignità Conservatorio, Università e Scuole private di musica; un’istituzione capace di graduare le proprie offerte, facendo convergere positivamente le esigenze dell’utenza in una cornice didattica generale che
le valorizzi e le arricchisca con contributi altrimenti ignoti ai giovani e
alle loro famiglie.
Introduzione
15
Riferimenti bibliografici
BARONI, Mario, NANNI, Franco (1989) Crescere con il rock. L’educazione
musicale nella società dei mass–media, Bologna, CLUEB.
CITRON, Stephen (20028) Song Writing. A Complete Guide to the Craft, New
York, Limelight.
FABBRI, Franco (2001) La Canzone, in Enciclopedia della Musica, diretta da
Jean–Jacques Nattiez, vol. I, Il Novecento, Torino, Einaudi, pp. 551–576.
GREEN, Lucy (2002) How Popular Musicians Learn. A Way Ahead for Music
Education, Aldershot, Ashgate.
ISTAT (1999) La musica in Italia, Bologna, Il Mulino.
PERRICONE, Jack (2000) Melody in Songwriting. Tools and Techniques for
Writing Hit Songs, Boston, MA, Berklee Press.
PRIVITERA, Massimo (1988) Recensione a Stefani 1987, in «Musica domani»,
n. 67, aprile, pp. 26–27.
ROOKSBY, Rikky (2000) How to Write Songs on Guitar, San Francisco, CA,
Backbeat.
STEFANI, Gino (1985) Competenza musicale e cultura della pace, Bologna,
CLUEB
STEFANI, Gino (a c.) (1987) Studiare musica: obiettivi e percorsi, Bologna,
CLUEB.
– (1989) Progetto musicologia. I, Bologna CLUEB.
ZOLLO, Paul (20033) Songwriters on Songwriting, Cambridge, MA, Da Capo
Press (trad. it. parziale Songwriters. Interviste sull’arte di scrivere canzoni. Volume primo, a cura di Paul Zollo, trad. di Francesco Pacifico e Veronica Raimo, Roma, Minimum fax, 2005).
Prima sessione
Università e dintorni
Roberto Agostini
Origini, sviluppi e prospettive
degli studi sulla popular music in Italia
1. Popular music
1.1. Origini della popular music
L’espressione inglese popular music è ormai diffusa negli studi
musicali italiani: compare in libri, saggi, tesi di laurea, articoli, ed anche nelle diciture dei corsi universitari e di Conservatorio. La ragione
è nota: adottare la sua traduzione creerebbe confusione, perché in Italia è ormai consuetudine usare l’espressione “musica popolare” come
traduzione di folk music. Si potrebbe obiettare che è l’espressione popular music a creare confusione: perché adottare un termine inglese
per indicare una musica che nella nostra lingua ha già vari nomi, come
“leggera”, “di massa”, “di consumo”, “funzionale”, “d’uso”, “extra–
colta”, “extra–accademica”, “d’intrattenimento”? Una ragione c’è, e
riguarda la messa a fuoco dell’oggetto di studio. Le parole, infatti, sono importanti, e il proliferare delle espressioni italiane, così come le
difficoltà di traduzione, sono indici dell’estraneità del concetto di popular music alla nostra tradizione di pensiero e, soprattutto, dell’imbarazzo degli studi musicali italiani non tanto ad adottare un’espressione inglese1, ma ad accettare l’idea di popular music. Nella prima
parte del mio intervento approfondirò dunque il concetto di popular
music, per poi passare a tracciare una breve storia degli studi con particolare attenzione all’Italia.
Nella loro accezione moderna, i concetti di popular e di folk sono
nati nell’Ottocento, in seno al pensiero intellettuale occidentale, in relazione ad alcuni importanti mutamenti tecnologici, sociali, politici ed
economici che si stavano verificando sulla scia di due importanti rivoluzioni, quella Francese e quella Industriale 2. Tali mutamenti hanno
1
D’altra parte, non sarebbe certo il primo caso d’adozione di un termine straniero
nella lingua italiana: per rimanere nell’ambito musicale, vedi il caso del termine folk e di
espressioni come folk revival.
2
Il problema della definizione di popular music è già stato affrontato molte volte.
Nel ricostruire questo dibattito, farò riferimento soprattutto a Middleton 1990, trad. it.
19
20
Roberto Agostini
trasformato la società occidentale da una società basata sulle comunità
agricole e nobiliari, alla società “moderna”, basata sulle nazioni, sull’urbanizzazione, sul mercato, sull’industrializzazione, sul progresso
tecnico e sulle comunicazione di massa. In questo periodo, gli intellettuali consolidarono l’interesse romantico per le culture rurali, orali e
pre–industriali, denominate folk, e per le civiltà extra–europee. Allo
stesso tempo, cominciarono anche a guardare con crescente preoccupazione le nuove forme di svago cittadino che si andavano imponendo
nelle città del mondo industrializzato, le quali cominciarono ad essere
indicate con l’aggettivo popular. In tali pratiche, la musica assumeva
un ruolo talmente importante che fu presto possibile distinguere un
ambito musicale specifico alle pratiche sociali d’intrattenimento tipiche della società massmediatica e industrializzata, che prese naturalmente il nome di popular music.
Molti intellettuali dell’epoca considerarono l’avvento della modernità negativamente. Denunciando i pericoli dell’americanizzazione e
della mercificazione della cultura, essi paventavano un’omologazione
culturale appiattita sui modelli dell’offerta dell’industria culturale. La
critica musicale e la musicologia, in linea con questa tendenza di pensiero, attaccarono dunque la popular music, che fu definita musica di
consumo, o di massa: in essa sembravano coagularsi gli effetti omologanti dell’industrializzazione di fronte ai quali la musica d’arte e la
musica folk erano destinate ad esaurirsi [cfr. Adorno 1941; Dahlhaus
1980, trad. it., pp. 331–39].
Tali critiche erano destinate ad acuirsi di fronte all’intensificarsi
dei processi della modernità che ha caratterizzato la seconda metà del
Novecento, quando la diffusione dei media elettronici, il consolidarsi
della dimensione transnazionale dell’economia di mercato e il radicarsi dei fenomeni di deterritorializzazione hanno introdotto il mondo in
una dimensione “globale” 3. Allo stesso tempo, però, molti studi hanno mostrato che le visioni che continuano a considerare modernità e
globalizzazione unicamente come spinte omologanti ai modelli consumistici imposti dalle multinazionali dell’intrattenimento, sono semplicistiche e non colgono la reale dinamica dei complessi processi in
atto. Anzi, i processi della globalizzazione producono anche importanti processi di differenziazione tanto sorprendenti quanto difficili da
pp. 19–30; Tagg 2000, pp. 29–38 e Fabbri (a c.) 1985. Per un approfondimento di alcuni
dei temi affrontati in questo primo capitolo cfr. Agostini 2004.
3
Sulla globalizzazione cfr. Tomlinson 1999 e Appadurai 1996.
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 21
cogliere. In questa prospettiva, le visioni ancora diffuse negli studi
musicali basate sull’idea di omologazione e di consumo “passivo”,
oppure su dualismi quali “arte/consumo” o “folk/consumo”, necessitano oggi più che mai di essere riformulate tenendo conto delle recenti
acquisizioni teoriche: far riferimento a tali visioni significherebbe accettare una distinzione tra “cultura alta” e “cultura bassa” nelle sue varie declinazioni (arte vs consumo, testo vs contesto, estetico vs funzionale o d’uso, individuo vs massa e via dicendo) il cui carattere statico
non riesce a cogliere le caratteristiche di una società come quella attuale, le cui dinamiche sociali sono complesse e contraddittorie 4. Modernità e globalizzazione, infatti, non hanno inciso solo in un ambito
musicale, quello popular, lasciando intatti gli altri, come tali opposizioni lascerebbero intendere; esse hanno piuttosto avviato un processo
di radicale trasformazione che riguarda tutti i linguaggi, i saperi e le
attività dell’uomo, e dunque anche tutta la musica.
1.2. Musica e globalizzazione
Le trasformazioni generate nel mondo dalla musica dalla modernità
e dalla globalizzazione sono abbastanza studiate. Per descriverle, mi limiterò — con una spietata sintesi — a menzionare quattro concetti
chiave: fonografia, industrializzazione, mediamorfosi e democratizzazione. Con “fonografia” intendo quella nuova forma espressiva resa
possibile dall’evoluzione delle tecnologie del suono [Eisenberg 1987,
trad. it., pp. 89–sgg; Chanan 1995, pp. 137–sgg.]. Essa si fonda sulla
possibilità di trasmettere e fissare su supporto il suono. Tale innovazione ha rappresentato una rivoluzione nel mondo della musica pari a quella rappresentata dalla radio, dal cinema, dalla televisione e dalla telematica in altri settori della comunicazione e dell’arte: oggi fare e ascoltare
musica significa sostanzialmente fare e ascoltare “dischi”. La fonografia
4
Una prospettiva teorica generale efficace per capire tale complessità è rappresentata dalla teoria dei processi culturali globali avanzata da Appadurai [1996, trad. it. pp. 50–
65]. Tale teoria permette di osservare come i materiali culturali sono costantemente in
movimento e oggetto di riformulazione continua. Ciò genera effetti di “omogeneizzazione” ed “eterogeneizzazione” dove giocano un ruolo tanto inedito quanto fondamentale i media elettronici e «l’immaginazione del sé come un progetto sociale quotidiano»
[Appadurai 1996, trad. it. p. 17]. In questa prospettiva, Appadurai mette poi in discussione l’idea che vuole che il consumo costituisca la fine, il punto terminale di beni e servizi, ricollocando le azioni del consumo nella storia [cfr. Appadurai 1996, cap. III]. Sul
consumo, cfr. anche De Certeau 1980. Sul dualismo alto/basso, cfr. Frith, 1996, pp. 3–
74; 2001, pp. 953–9; e, per una riflessione generale, Levine 1988.
22
Roberto Agostini
ha reso possibile la produzione e la distribuzione di massa della musica,
e dunque ha rappresentato la premessa indispensabile alla sua industrializzazione. La musica è così diventata una merce di massa e il consumo
mediatico è diventata la modalità più diffusa di fruizione musicale.
L’imporsi di questi processi di tecnologizzazione e d’industrializzazione, comuni a tutti i campi della conoscenza umana, ha avuto
un’importante conseguenza: alle due modalità di organizzazione della
conoscenza umana consolidate — l’oralità e la scrittura — si è aggiunta una terza modalità, centrata sui mezzi di comunicazione elettronici, che è diventata quella prevalente 5. Ciò ha naturalmente implicato un adattamento dei linguaggi e dei saperi a tali nuovi mezzi.
Spesso si indica tale adattamento con il termine “mediatizzazione” o
“mediamorfosi” [Blaukopf 1992, pp. 248–sgg]. Un primo effetto della
mediamorfosi è evidente nei modi in cui la musica circola ed è conservata, dunque nei modi in cui una tradizione musicale si tramanda e
si rinnova. Oggi la circolazione e la conservazione della musica si
fonda sul formato fonografico, che prevede ciò che Schafer [Schafer
1977, trad. it., p. 90] chiama “schizofonia”, ovvero la separazione tra
produzione e fruizione, e la duplicazione in serie di originali, dunque
la perdita dell’aura [cfr. Benjamin 1936]. È interessante osservare che
questa dimensione genera l’attivazione di dinamiche legate all’oralità,
o meglio, come direbbe Ong [1982, trad. it. pp. 133–135], all’oralità
“secondaria”. L’oralità della comunicazione mediatica è infatti diversa
da quella “primaria”, proprio in quanto mediata dalle tecnologie elettroniche e radicata nella scrittura. Questo riemergere delle dinamiche
orali in un panorama, per così dire, “schizofonico”, ha generato mutamenti di ampia portata che devono ancora essere studiati a fondo 6.
Più specificamente, la mediamorfosi ha avuto importanti conseguenze anche nei processi di produzione e di fruizione della musica.
Oggi la produzione musicale è professionale, separata dal momento
della fruizione e altamente tecnologicizzata. All’idea di autore come
colui che possiede il pieno controllo tutti gli elementi e di tutte le fasi
di una creazione musicale, si è sostituita l’idea di divisione del lavoro
tra figure specializzate. In questo senso, la produzione musicale è divenuta molto simile alla produzione cinematografica 7. Per quanto ri5
Ong 1982 rappresenta ancora oggi un’ottima introduzione generale alle problematiche chiamate in causa dal rapporto oralità–scrittura e dall’avvento dei media elettronici.
6
Per un approfondimento cfr. Montecchi 2003.
7
Su questi temi cfr., oltre ai citati Eisenberg 1987 e Chanan 1995, anche Zak 2001.
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 23
guarda la fruizione, si noti che oggi, idealmente, chiunque può ascoltare in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento qualsiasi tipo di musica.
I repertori, di qualsiasi tipo siano, si trovano così ad essere costantemente ri–contestualizzati e ad assumere costantemente nuovi significati, spesso imprevedibili se non addirittura irriguardosi rispetto alle
eventuali intenzioni dell’autore o alle interpretazioni più autorevoli di
critici e musicologi. Inoltre, nascono nuovi modi di fruizione, come
l’ascolto privato, o l’abitudine a “sentire” musica in sottofondo svolgendo altre attività 8. Infine, si diffonde in modo pervasivo la comunicazione multimediale, dove la musica ha un ruolo tanto cruciale quanto poco esplorato.
È importante collocare i processi di tecnologizzazione, industrializzazione e mediamorfosi nel loro contesto sociale. Quest’ultimo è
caratterizzato da un progressivo movimento di “democratizzazione”
fondato su valori di derivazione illuminista quali libertà, uguaglianza,
diritti, democrazia e via dicendo. Tale movimento, amplificato dai
processi di modernizzazione e globalizzazione, ha generato la libera
circolazione delle idee nei vari strati sociali e nelle varie culture, la
nascita dell’opinione pubblica e la crisi del ruolo dell’intellettuale, la
scomparsa delle gerarchie di valori assolute, l’emergere di nuove gerarchie culturali e nuove ideologie [Molino 2001 pp. 778–sgg; Appadurai 1996, trad. it. pp. 56–59]. Dal punto di vista musicale, possiamo
esemplificare gli effetti di tale movimento notando che oggi nei vari
gruppi sociali e nelle varie culture circolano liberamente non solo i repertori, ma anche le idee, le esigenze e i valori legati a detti repertori e
alle pratiche musicali. Dunque, non solo i repertori, ma anche le varie
idee, i vari valori e le varie pratiche musicali sono ormai diventati patrimonio dell’intera umanità, non solo dei gruppi sociali o della culture da cui avevano avuto origine, e per questo sono costantemente oggetto di nuove appropriazioni e riformulazioni.
1.3. Il “popolare” in musica
È possibile parlare di “popolarità” della musica in questo contesto?
Gli studi sulla popular music rispondono affermativamente a questa
domanda: essi ritagliano un campo dove il “popolare” in musica as8
In quest’ambito si sono particolarmente esercitati gli studiosi di popular music, che
hano sviluppato studi di carattere sociologico ed etnografico, ed anche analisi di carattere interpretativo centrate sul momento della fruizione.
24
Roberto Agostini
sume aspetti inediti senza per questo perdere i suoi tratti salienti.
L’idea è quella di far riferimento ad un’idea di “popolare” ampia, in
tutte le ricche e feconde sfumature di significato che tale termine possiede oggi: qualcosa di pubblico, di ampiamente diffuso, di quotidiano, di comune e condiviso, di ordinario; qualcosa che appartiene al
popolo, in quanto prodotto e usato dalla gente comune, ma anche
qualcosa di dozzinale, triviale, alla portata delle persone comuni e
prodotto (da altri) per tali persone; qualcosa, infine, che è caratterizzato da subalternità. Parlare di popular music significa dunque esplorare
quei repertori e quelle pratiche musicali più comuni e diffuse nella nostra società, prendendo atto della loro costante mutevolezza, della loro
contraddittorietà, della loro continuità con altre pratiche, del loro essere subalterne.
In questo senso, è interessante considerare la prospettiva di Richard
Middleton, che riprende la concezione gramsciana di cultura popolare
come un territorio di scontro tra cultura egemone e culture subalterne,
rileggendola all’interno delle dinamiche della modernità. Middleton sostiene che né la popular music né i suoi “altri” possono essere considerati puramente “di consumo” o “incontaminati”: «quello che il termine
popular music cerca di fare è di indicare quello spazio, quel terreno di
contraddizione — fra “imposizione” e “autenticità”, “elitario” e “ordinario”, predominante e subordinato, allora e adesso, loro e nostro — e
di organizzarlo in modo specifico» [Middleton 1990, trad. it. p. 24].
Questa concezione, che evidenzia la costante negoziazione e contestazione di cui è satura la vita delle società complesse contemporanee,
può essere arricchita aggiungendovi le considerazioni sviluppate negli
studi di semiotica musicale di Gino Stefani [1977, 1985, 1986]. Egli
condivide con Middleton l’idea che il popolare sia un terreno di conflitto tra culture dominanti e culture subalterne, ma sposta l’attenzione
dai repertori e dalle relazioni sociali alle pratiche diffuse e comuni
nella vita quotidiana, in particolare a quelle creative o — per dirla con
Appadurai — basate sull’immaginazione. Facendo riferimento alla
propria teoria sulla competenza musicale 9, alle ricerche etnomusicologiche, ad esempio, di Blacking [1973] e Maróhty [1981], e, infine,
agli studi sul “quotidiano” e sul consumo come tattica di appropriazione di De Certeau [1980], Stefani giunge ad avanzare una prospettiva di ricerca dove il popolare non coincide né con certi oggetti musi9
Qui la competenza musicale è intesa come la «capacità di produrre senso mediante
e/o intorno alla musica» [Stefani 1998, p. 13] di cui ogni essere umano è dotato.
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 25
cali, né con certi gruppi o contesti sociali, ma con una prassi, con un
modo di usare la musica diffuso nel quotidiano e condiviso tra la gente
comune, caratterizzato da una costante tensione alla negoziazione, alla
contestazione e alla ri–appropriazione dei materiali culturali 10. Emerge dunque una dialettica tra lo “studio della popular music” e lo “studio popolare della musica” cara agli studi sulla popular music e ancor
oggi ben presente nel dibattito.
2. Gli studi sulla popular music
Volendo tracciare brevemente la storia degli studi sulla popular
music, c’è anzitutto una leggenda da sfatare: quella che vuole che tali
studi siano nati e prosperati in ambito sociologico ed economico, e che
solo in un secondo momento la musicologia se ne sia occupata. È certo vero che gli studi sulla popular music di carattere sociologico ed
economico sono assai sviluppati, e che il riconoscimento della popular
music come oggetto d’interesse musicologico è relativamente recente
e non ancora scontato; ciò non toglie, tuttavia, che i primi esempi di
riflessione sulla popular music risalgano addirittura alla fine dell’Ottocento, quando cominciarono a comparire scritti sul Music Hall e su
altri generi dell’intrattenimento musicale, sulla musica alla radio e al
cinema, sugli effetti delle tecnologie musicali, sulle tradizioni folkloriche dei bianchi e dei neri statunitensi. Si trattava però di scritti occasionali e, spesso, divulgativi; dunque, in questo senso, possiamo individuare il punto di passaggio verso un approccio più rigoroso allo studio della popular music negli anni trenta, nelle ricerche avviate da
Adorno, nel consolidarsi, in etnomusicologia, dell’interesse per le trasformazioni urbane delle tradizioni folkloriche dei bianchi e dei neri
statunitensi 11, e nella fioritura degli studi sul jazz 12. Le prime indagini storiche articolate compariranno invece dopo la Seconda Guerra
Mondiale [cfr. Chase 1955; Ewen 1957; Spaeth 1948]. In seguito, la
10
In vari punti Appadurai 1996 riprende questa prospettiva, approfondendola e dandogli maggiori fondamenti teorici (cfr. ad esempio, della trad. it., pp. 187–8).
11
Fondamentale è il lavoro di Alan Lomax, destinato a dare importanti frutti. Cfr.,
ad esempio, Lomax 1950 e Lomax–Guthrie–Seeger 1967.
12
Le musiche dei neri statunitensi — soprattutto il jazz, ma anche il blues e i repertori sacri — possiedono una ricca e florida tradizione di studi musicologici ed etnomusicologici che in questo intervento, centrato su questioni generali, non posso che limitarmi
a menzionare.
26
Roberto Agostini
“classicizzazione” della canzone Tin Pan Alley e l’avvento dei Beatles
e della musica rock stimoleranno la curiosità di personalità autorevoli
come Wilfred Mellers [1964; 1976], Charles Hamm [1979; 1983] e
Alec Wilder [1972], autori di studi esemplari.
Per il decollo definitivo dello studio della popular music bisognerà
però attendere la generazione di studiosi che comprende Philip Tagg
[1979], Richard Middleton [1990], John Shepherd [1988], Peter Wicke [1986] e molti altri. Al di là del loro lavoro di ricerca, va sottolineato che è a questo gruppo di studiosi che si deve l’ideazione, nel
1981, della IASPM (International Association for the Study of Popular
Music), un’associazione interdisciplinare che da allora ha sviluppato
con continuità lo studio della popular music in vari ambiti disciplinari,
fungendo da punto di riferimento per tutti gli studiosi del settore. Da
quest’ambiente prenderanno forma varie iniziative editoriali, tra le
quali è significativo elencare le molte riviste specializzate: Popular
Music (Gran Bretagna, 1981); Beiträge zur Popularmusikforschung
(Germania, 1986); Tracking: Popular Music Studies (USA, 1988), che
dal 1992 diventa Journal of Popular Music Studies; Perfect Beat (Australia, 1993); Popular Musicology (Norvegia, 1996, dal 2000 pubblicata solo on–line); Popular Music History (UK, 2004).
Di fatto, tali iniziative rispondevano all’esigenza diffusa tra un sempre più ampio gruppo internazionale di studiosi di dotarsi di punti di riferimento istituzionali e teorico–metodologici condivisi, al fine di coordinare e arricchire i propri sforzi individuali. Tra questi, troviamo anche
una sempre più nutrita schiera di etnomusicologi che, lasciati alle spalle i
vecchi pregiudizi, solidarizzarono subito con gli studiosi di popular
music, apportando importanti contributi alla discussione in atto e ampliando il raggio delle attività prese in considerazione, inizialmente limitate al pop–rock internazionale e alle sue origini nel folklore statunitense,
verso le popular music locali e i fenomeni d’ibridazione 13.
Il punto di partenza che accomunava questo gruppo di studiosi di
popular music era costituito da una critica alla musicologia consolidata: il suo paradigma disciplinare, focalizzato sulla scrittura, sui concetti di Werk e di canone, su giudizi di valore fondati sulla fruizione estetica e sulla presunta autonomia della musica dai contesti storico–
culturali, non era considerato appropriato allo studio della popular
13
L’interesse dell’etnomusicologia statunitense per la popular music è sancito nel
1996, quando nasce una sezione dedicata allo studio della popular music all’interno della
Society of Ethnomusicology.
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 27
music. Non si trattava di rifiutare in blocco gli strumenti messi a punto
dalla musicologia consolidata in una sorta di tabula rasa, ma di riformularli all’interno di un nuovo approccio che tenesse conto delle specificità della popular music 14. Il lavoro di ricerca svolto sulla base di
questa premessa ha dato importanti frutti, tant’è vero che oggi gli studi
sulla popular music costituiscono un nucleo relativamente omogeneo
di ricerche, caratterizzate da una rosa di strumenti concettuali e metodologici condivisi specificamente pensati per la popular music. In particolare, essi condividono un approccio interdisciplinare, basato sull’idea che la musica sia un oggetto culturale, e che dunque la sua piena
comprensione non possa eludere lo studio delle relazioni che s’instaurano tra oggetti, soggetti e contesti. L’idea fondamentale, insomma, è che lo studio della musica debba essere centrato sulle “pratiche”
o sulle “esperienze” musicali (al plurale), piuttosto che sulle opere, e
che tale approccio non sia specifico allo studio di certi repertori piuttosto che altri, ma utile allo studio della musica tout court 15.
Se allora si affermava che poco lavoro di ricerca si era fatto sulla
storia e sull’analisi della popular music, va anche detto che la comunità di studiosi che stava nascendo era perfettamente consapevole che
ciò era vero solo in parte: quello che davvero mancava era una riflessione sviluppata con metodologie aggiornate, che prendesse in considerazione i repertori nati nella seconda parte del Novecento, fino ad
allora trascurati, e che potesse rispondere ai dubbi e ai pregiudizi della
musicologia. Quest’ultima, dal canto suo, a metà degli anni novanta si
è trovata, per vari motivi, non ultimi quelli generazionali, a non poter
più eludere la “questione popular music”. La risposta è stata tanto improvvisa quanto decisa: nel giro di pochi anni, gli scritti e i convegni
sulla popular music si sono moltiplicati e, nel 1998, è nato un “popular
music interest group” all’interno della Society of Music Theory 16. I
promotori di questa svolta, prevalentemente statunitensi e appartenenti
alla scuola della Music Theory, hanno inizialmente messo in dubbio la
pertinenza musicologica del lavoro di ricerca sviluppato dagli studiosi
di popular music, dando origine ad una polemica sullo statuto disciplinare della musicologia che, non a caso, ricalcava uno scenario ge14
Per una sintesi di tale critica, cfr. Middleton 1990, trad. it. pp. 167–170.
Per un’idea della mole di lavoro sviluppato in questo prospettiva, si consulti il sito
della IASPM (www.iaspm.net) e, in particolare, la sezione delle bibliografie
(http://www.iaspm.net/iaspm/biblio.html).
16
Due pubblicazioni rappresentative di questa tendenza sono Everett (a c.) 2000, e
Covach–Boone (a c.) 1997.
15
28
Roberto Agostini
nerale degli studi musicali ancora attuale: da una parte troviamo la
musicologia consolidata, che tende ad escludere quanto non risulta allineato al paradigma disciplinare e al canone della musica d’arte, ovvero a legittimare solo quanto può rientrarvi 17; dall’altra parte troviamo invece una comunità di studiosi che mette in discussione tale paradigma disciplinare sostenendo che la musicologia, piuttosto che escludere o legittimare le musiche a seconda che queste rientrino o meno nel paradigma disciplinare, dovrebbe assumere la relatività di tale
paradigma e riformularlo in relazione al mutato contesto socio–culturale con l’obiettivo di diventare lo studio di tutta la musica, non solo
di una musica 18.
Proprio per l’attualità di questa problematica, oggi più che mai la
popular music è all’ordine del giorno nell’agenda del dibattito musicologico, dove la polemica è stata riportata al suo giusto livello, quello
teorico. In generale, cresce l’idea che la musicologia debba occuparsi
di tutte musiche: ciò che va discusso non è il “se”, ma il “come” studiarle. E gli studiosi di popular music sono attivi interlocutori in questo dibattito.
3. Lo studio della popular music in Italia
Se gli sviluppi della ricerca finora illustrati sono rimasti per lungo
tempo circoscritti al mondo anglosassone e al Nord Europa, oggi lo
studio della popular music si è diffuso in varie nazioni. Chi vuole specializzarsi può trovare Università che prestano particolare attenzione
alla popular music perlomeno nelle seguenti nazioni: Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Norvegia, Svezia, Brasile,
Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa
19
. Come si sarà notato, l’Italia non è inclusa in quest’elenco. Eppure
gli studi sulla popular music non vi sono certo mancati. Vari segnali
mostrano come il tema fosse presente nel dibattito musicologico italiano fin dagli anni cinquanta, sia per la curiosità della musicologia di
allora 20, sia per la sensibilità assi diffusa nell’etnomusicologia per la
17
Sulla legittimazione cfr. Middleton 1990, trad. it. p. 177.
Per un approfondimento cfr. Agostini 2004.
19
Cfr. http://iaspm.net/iaspm/unis.html (14.12.2005).
20
Cfr. ad esempio la collana “Piccola Biblioteca Ricordi”, dove, accanto a studi di
Pestalozza e Malipiero, troviamo un libro sulla “ballata popolare americana” di Leydi
[1958], vari volumi sul jazz, e persino uno dei primi libri italiani dedicati alla popular
18
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 29
relazione tra musica popolare, canzone urbana e impegno politico 21. È
da tale nodo d’interessi che nacquero progetti artistici e di critica come il Cantacronache, il Nuovo Canzoniere Italiano, l’Istituto Ernesto
De Martino e il Circolo Giovanni Bosio, che raccoglievano intellettuali di varia estrazione 22. In questo movimento, l’influenza di Adorno
era però molto forte, come mostra il libro più rappresentativo di questo momento storico: il famoso Le canzoni della cattiva coscienza
[Straniero–Jona–Liberovici–De Maria 1964]. È dunque curioso notare
che il primo saggio che centra le questioni in modo chiaro ed efficace
è l’introduzione a questo stesso volume, scritta non da uno studioso di
musica, ma da Umberto Eco [1964], che sviluppava alcune importanti
e ancora attuali osservazioni che non si poteva dire fossero del tutto
condivise dal libro che introduceva.
Per i primi veri studi sulla popular music italiani bisognerà dunque
aspettare gli anni Settanta, quando comparvero i contributi di Gino
Stefani e Franco Fabbri, studiosi provenienti da percorsi culturali diversi da quelli precedentemente menzionati che parteciparono attivamente alla fase di fondazione degli studi sulla popular music a livello
internazionale. Stefani si è occupato di popular music all’interno dei
suoi studi di semiotica musicale. In particolare, ha elaborato la già
menzionata rilettura del concetto di “musica popolare” e una teoria
della competenza musicale destinate ad avere largo seguito [cfr. Stefani 1977; 1985; 1986; 1998]. Fabbri è noto anzitutto per la sua influente teoria dei generi musicali, pubblicata in vari saggi intorno al
1980 [cfr. Fabbri 1981], periodo assai fecondo che lo vede, tra l’altro,
coinvolto nella fondazione della IASPM. Da allora, Fabbri è un instancabile promotore di ricerche, attività e pubblicazioni, ed ha arricchito i suoi interessi specifici con ricerche sulle tecnologie musicali
music, scritto da Ionio Prevignano–Rapetti [1962]. Va inoltre menzionato l’intervento
sul rock di Luciano Berio [1967] sulla Nuova Rivista Musicale Italiana.
21
Tali interessi, testimoniati fin dagli anni cinquanta [cfr. Carpitella 1955; Leydi
1958], emergono nell’etnomusicologia italiana stimolati da un lato dal dibattito che si
svolgeva oltre oceano sul folk revival e, dall’altro, dalla lettura degli Scritti di Béla Bartók [1948].
22
Il Cantacronache, ideato da Sergio Liberovici insieme a Fausto Amodei, Franco
Fortini, Italo Calvino, Giorgio De Maria, Emilio Jona, Michele Straniero e altri, si presenta ufficialmente il primo maggio 1958 a Torino [cfr. Jona–Straniero 1995]. Il Nuovo
canzoniere Italiano nasce a Milano nel 1962 su iniziativa di Roberto Leydi e Gianni Bosio [cfr. Bermani 1997]. L’Istituto Ernesto De Martino, fondato da Gianni Bosio, nasce a
Milano nel 1967, mentre a Roma nasce il il Circolo Giovanni Bosio nel 1969.
30
Roberto Agostini
[Fabbri 1984], studi di carattere sociologico e analitico [Fabbri 1996),
e studi storici [Fabbri 2004].
Il lavoro di Stefani e di Fabbri è potuto prosperare anche e soprattutto perché il mondo musicale italiano di allora era assai vivace e curioso, interessato alla contemporaneità e ancora fortemente sensibile
alle relazioni tra musica, società e politica. È da questo mondo che
prenderanno forma iniziative editoriali dove troveranno largo spazio
riflessioni sulla popular music, quali le collane “Il pane e le rose” e
“La chitarra, il pianoforte, il potere”, avviate rispettivamente nel 1976
e nel 1978 dall’Editrice Savelli di Roma, la rivista Laboratorio Musica, nata nel 1979 e diretta da Luigi Nono, e soprattutto il quadrimestrale Musica/Realtà, fondato da Luigi Pestalozza nel 1981, che darà
ampio spazio agli studi sulla popular music nella rivista stessa e nella
collana editoriale “Quaderni di Musica/Realtà”. A coronamento di
questo movimento, nel 1983 il convegno internazionale della IASPM
si tenne in Italia, a Reggio Emilia [cfr. Fabbri (a c.) 1985] 23.
Malgrado quest’esplosione d’attività e di idee, gli studi sulla popular music italiani, al contrario di quanto avveniva nel mondo anglosassone e nel Nord Europa, saranno destinati a svilupparsi ai margini dell’Accademia. Ciò nonostante, il lavoro di ricerca svolto è stato consistente e gli ambiti affrontati sono stati vari, quali ad esempio l’analisi
musicale, la storia della musica, la ricerca sociologica ed empirica, lo
studio delle tecnologie musicali, lo studio della relazione tra popular
music ed educazione musicale 24. Due sono le considerazioni che possiamo avanzare a proposito di questo lavoro: anzitutto, se, fino alla fine degli anni Ottanta, gli studi sulla popular music prosperano all’interno del più ampio dibattito sulla musica, in seguito il campo si specializza, spinto da un crescente interesse per la ricerca delle sue specificità; in secondo luogo, se si eccettuano pochi casi, tutto il lavoro di
ricerca è stato sviluppato dalla IASPM Italiana e dai suoi membri,
spesso in collaborazione con altre realtà (in particolare con le Univer23
Moltissime sono le persone impegnate in queste iniziative e non posso certo nominarle tutte. Oltre ai nomi già menzionati, vale però la pena ricordare almeno quelli di
Nemesio Ala, Mario Baroni, Alessandro Carrera, Umberto Fiori e Paolo Prato.
24
Non è questo il luogo per elencare tutte le attività svolte. Ricorderò solo, a mo’
d’esempio, le varie iniziative editoriali originali (vedi soprattutto i libri di Fabbri) e di
traduzione [Shepherd 1988; Middleton 1990; Tagg 1994; Hamm 1983], i convegni (ad
esempio “Analisi e canzoni”, svoltosi nel 1995 presso l’Università di Trento; cfr. Dalmonte 1996), le molte conferenze organizzate presso l’Università di Bologna, e le iniziative editoriali promosse dal GATM [cfr. ad esempio Agostini–Marconi (a c.) 2002] e
dalla SIEM [cfr. Ferrari–Strobino (a c.) 1994].
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 31
sità di Bologna, Trento, Roma e Cremona, e con le associazioni SIEM
e GATM, della quale la IASPM Italiana è socio fondatore).
In Italia, dunque, esiste da quasi trent’anni una comunità di studiosi
di popular music assai vivace, che ha partecipato attivamente alla costruzione dei popular music studies a livello internazionale, e che ha
continuato incessantemente a lavorare ai margini dell’Accademia. È in
questo contesto che, all’inizio del Duemila, si manifesta un improvviso interesse della musicologia e dell’etnomusicologia italiana per la
popular music testimoniato dall’avvio, dopo alcune esperienze meno
articolate, di veri e propri corsi universitari sulla popular music. Per
l’etnomusicologia, che aveva continuato a coltivare un vivo interesse
per la musica dei neri nord americani e per il folk revival [cfr. ad esempio Leydi 1972], il punto di svolta è rappresentato dall’avvento
della world music, che l’ha invitata a riprendere le posizioni degli anni
Sessanta in un quadro meno dogmatico. Non a caso l’evento che sancisce l’interesse per la popular music da parte dell’etnomusicologia è
il seminario internazionale di studi “World Music ed etnomusicologia”, tenutosi nel 2001 presso la Fondazione Cini di Venezia.
Anche in Italia, come all’estero, tra etnomusicologi e studiosi di popular music si è subito manifesta una positiva condivisione d’interessi, e
il recente avvio di corsi sulla popular music nelle Università ha coinvolto sia etnomusicologi sia studiosi di popular music. Va però precisato
che, se i corsi e i convegni sulla popular music si stanno moltiplicando,
le pubblicazioni e, soprattutto, le ricerche di largo respiro sono ancora
troppo rare. Dunque, se nella didattica si è sentita l’esigenza di integrare
i curricula di studio dei futuri musicologi con corsi sulla popular music
nei trienni e nei bienni, tale esigenza di approfondimento non è altrettanto sentita a livello di ricerca, che ha davvero pochi spazi e risorse
praticamente nulle. Questa paradossale situazione è, d’altra parte, perfettamente rispecchiata dal fatto che la maggior parte dei docenti dei
corsi sulla popular music attualmente attivi fa parte della sempre più nutrita schiera di docenti “a contratto” reclutati per fare ore di lezione ed
esami, non certo per potenziare la ricerca.
Questa situazione non è certo frutto del caso. Anzitutto va notato che
il vuoto della ricerca è attualmente mascherato da un’abbondante produzione di libri compilativi e divulgativi — peraltro assai utili, quando ben
fatti — che non sono frutto di ricerca, ma che sono spesso considerati tali persino dalle Università stesse, che non solo inseriscono nei programmi dei corsi tali testi, ma che stanno anche facendo a gara per coinvolgere nelle attività accademiche i loro autori, perlomeno quando si tratta di
32
Roberto Agostini
giornalisti di fama, personalità televisive o cantanti di successo. Non che
un giornalista o un cantante non possa essere anche un ottimo docente e
ricercatore; ma se a quanto appena detto aggiungiamo le numerose lauree honoris causa conferite a persone dello spettacolo che con la ricerca
hanno davvero poco a che fare, non possiamo trattenerci dal sospettare
che l’interesse per la popular music sia troppo spesso più strumentale che
fondato su una sincera motivazione culturale.
A questa situazione si somma la forte resistenza che ancor oggi mostra la musicologia di fronte alla popular music e alla relativa tradizione
pluriennale di studi. Se è certo vero che recentemente non sono mancate
iniziative che hanno coinvolto costruttivamente tutte le forze in gioco 25,
la musicologia italiana, da vari anni, ha avviato una polemica simile a
quella che ha caratterizzato lo scenario anglo–sassone il decennio scorso, con la complicazione che qui in Italia il retaggio ancora molto forte
di Adorno rende difficile un dialogo che possa tener conto delle recenti
acquisizioni teoriche di cui ho parlato nella prima parte di questo intervento. Il riemergere di espressioni come “musica di consumo” 26, dopo
il primo stupore, suscita preoccupazione non solo per il futuro degli studi sulla popular music, ma per il futuro degli studi sulla musica in genere, che rischiano di rimanere intrappolati in pregiudizi ormai superati
che, per l’appunto, rendono problematico il riconoscimento della popular music come oggetto di studio musicologico e del lavoro di ricerca
sviluppato dalla comunità di studiosi di popular music.
Dunque: mentre a livello internazionale gli studi sulla popular
music sono parte integrante del dibattito musicologico, in Italia, per
vari motivi, questo tipo d’integrazione non è ancora potuto avvenire. E
la ricerca sulla popular music continua ad accumulare ritardi rispetto
ad una richiesta sempre più pressante che proviene non solo dagli istituti di formazione musicale, ma anche dagli studi sociali in generale,
sempre più sensibili ai problemi dello studio della musica nel mondo
contemporaneo in un’ottica interdisciplinare 27, nonché dal mondo del
25
Vedi ad esempio i tre convegni svoltisi nel 2005: “Etnomusicologia e studi di
popular music: quale possibile convergenza?” (Venezia, Fondazione Cini), “Making
Music Making Meaning” (XIII Conferenza Internazionale della IASPM, Roma), e
“Composizione e sperimentazione nel rock britannico: 1966–1976” (Cremona, Facoltà di Musicologia).
26
Ad esempio nella tavola rotonda organizzata da Il Saggiatore Musicale a Bologna nel 2002, intitolata “Musicologia storica e musica di consumo” [cfr. AA.VV.
2005a e 2005b].
27
Sintomo di tale situazione sono, ad esempio, affermazioni provocatorie, ma da
prendere in seria considerazione, come «[…] la musica è troppo importante per lasciarla
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 33
lavoro, ormai completamente trasformato rispetto anche solo a qualche decennio fa. E si noti che la questione non riguarda semplicemente la popular music, ma tutte le musiche “altre”: l’impressione è che,
nonostante le numerose sollecitazioni, la musicologia faccia fatica a
mettere in discussione l’idea che lo studio della musica debba contemplare essenzialmente lo studio della storia e del linguaggio della
musica d’arte occidentale. Le prospettive della ricerca sulla popular
music, così come le prospettive dello sviluppo di una musicologia
moderna, dipendono dunque dal superamento di tale convinzione che,
come abbiamo visto, è radicata in una visione di derivazione adorniana. È dunque auspicabile che si sviluppi prima possibile un dibattito a
trecentosessanta gradi, dove le varie posizioni in gioco possano davvero confrontarsi. Questo significa che è urgente il riconoscimento e il
potenziamento dell’esperienza accumulata degli studiosi di popular
music, che in questo dibattito non può essere ignorata. Lo studio della
popular music ha infatti sviluppato concetti, strumenti e metodi peculiari; possiede teorie e case studies esemplari, varie riviste specializzate e una bibliografia sterminata che accomunano una comunità crescente di studiosi. Essa ha sviluppato strumenti assi raffinati per comprendere come i meccanismi della modernità hanno inciso sulla musica studiando le tecnologie del suono, gli effetti della mediamorfosi, la
comunicazione musicale, la multimedialità e via dicendo. A tutto questo si deve aggiungere che quest’apparato teorico–metodologico non è
specifico alla popular music, ma possiede elementi condivisi con altri
apparati teorico–metodologici sviluppati da scuole musicologiche ed
etnomusicologiche che, pur avendo interessi in altri repertori o in altri
ambiti del mondo musicale, condividono con gli studiosi di popular
music un approccio culturologico ed esperienziale. È possibile pensare
ad una musicologia moderna, che possa tenere conto anche della popular music e più in generale di tutte le musiche “altre”, senza potenziare tematiche e ricerche così attuali, importanti e trasversali rispetto
agli ambiti di specializzazione?
ai soli musicologi professionali. Ma è davvero possibile recuperare la musica allo sguardo, meno ravvicinato certo ma anche si spera meno miope, dello studioso della società,
della politica, dell’economia?» [Santoro 2006]. La relazione tra musicologia e altre discipline e la presenza della musica nei curricula di studio non musicologici è un tema
importante, che però non posso approfondire in questa sede.
34
Roberto Agostini
Riferimenti bibliografici
AA.VV. (2003) Musicologia storica e musica di consumo: una tavola rotonda, in «Il Saggiatore Musicale», X/2, pp. 317–365.
— (2004) Musicologia storica e musica di consumo: completamento della
tavola rotonda, in «Il Saggiatore Musicale», XI/2, pp. 395–408.
ADORNO, Theodor W. (1941) On popular music, in «Zeitschrift für Sozialforschung», IX/1, pp. 17–48 (trad. it. Sulla popular music, Roma, Armando, 2004).
AGOSTINI, Roberto (2004) Il consumo di musica nell’epoca della globalizzazione, in «Il Saggiatore Musicale», XI/2, pp. 399–408.
AGOSTINI, Roberto, MARCONI Luca (a c.) (2002) Analisi della popular music,
numero speciale della «Rivista di Analisi e di Teoria Musicale», VIII, 2.
APPADURAI, Arjun (1996) Modenity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis – London, University of Minnesota Press (trad. it.
Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001).
BARTÓK, Béla (1948) Scritti sulla musica popolare, Torino, Einaudi, 1955
(trad. it. parziale e riveduta di Béla Bartók válogatott zenei írásai, Budapest, Magyar Kórus, 1948).
BENJAMIN, Walter (1936) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen
Reproduzierbarkeit, in «Zeitschrift für Sozialforschung», V, 1936 (trad.
it. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966, pp. 18–56).
BERIO, Luciano (1967) Commenti al rock, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», I/1, pp. 35–45.
BERMANI, Cesare (1997) Una storia cantata. 1962–1997: trentacinque anni
di attività del Nuovo Canzoniere Italiano, Milano, Jaca Book.
BLACKING, John (1973) How Musical is Man?, Seattle – London, University
of Washington Press (trad. it. Come è musicale l’uomo?, Milano, Ricordi–Unicopli, 1986).
BLAUKOPF, Kurt (1992) Musical Life in a Changing Society, Portland, Amadeus Press.
CARPITELLA, Diego (1955) Musica popolare e musica di consumo, in Conversazioni sulla musica (1955–1990), Firenze, Ponte Alle Grazie, 1992,
pp. 41–51 (rist. di Musica popolare e musica di consumo, Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia).
CHANAN, Michael (1995) Repeated Takes, London, Verso.
CHASE, Gilbert (1955) American’s Music. From the Pilgrims to the Present,
New York, McGraw–Hill.
COVACH, John, BOONE, Graeme (a c.) (1997) Understanding Rock Music.
Essays in Musical Analysis, New York – Oxford, Oxford University
Press.
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 35
DAHLHAUS, Carl (1980) Die Musik del 19. Jahrhunderts, Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion (trad. it. La musica dell’Ottocento, Scandicci, La Nuova Italia, 1990).
DALMONTE, Rossana, (a c.) (1996) Analisi e canzoni, Trento, Università di
Trento.
DE CERTEAU, Michel (1980) L’invention du quotidien. 1. L’arts de faire, Paris, Union générale d’éditions (trad. it. L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni del Lavoro, 2001).
ECO, Umberto (1964) La canzone di consumo, in Straniero–Jona–Liberovici–
De Maria 1964, pp. 5–28 (rist. in U. Eco, Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teorie della nuova cultura di massa, Milano, Bompiani, 1964, pp. 277–296).
EISENBERG, Evan (1987) The Recording Angel. Music, Records and Culture
from Aristotele to Zappa, London, Picador (trad. it. L’angelo e il fonografo. Musica, dischi e cultura da Aristotele a Zappa, Torino, Instar Libri,
1997).
EVERETT, Walter (a c.) (2000) Expression in Pop–Rock Music: a Collection
of Critical and Analytical Essays, New York – London, Garland.
EWEN, David (1957) Panorama of American Popular Music: the Story of
Our National Ballads and Folk Songs, the Songs of Tin Pan Alley, Broadway and Hollywood, New Orleans Jazz, Swing, and Symphonic Jazz,
Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall.
FABBRI, Franco (1981) I generi musicali: una questione da riaprire, in «Musica/Realtà», 4, pp. 43–65.
— (1984) Elettronica e musica, Milano, Fabbri.
— (1996) Il suono in cui viviamo, Milano, Feltrinelli.
— (2004) La popular music, in A. Basso (a c.), Storia della Musica, Vol IV,
UTET, Torino, pp. 309–394.
FABBRI, Franco (a c.) (1985) What is popular music? Atti della II Conferenza Internazionale della IASPM, Reggio Emilia, 19–24.9.1983, Milano, Unicopli.
FERRARI, Franca, STROBINO, Enrico (a c.) (1994) Imparerock? A scuola con
la popular music, Milano, Ricordi.
FRITH, Simon (1996) Performing Rites, Oxford, Oxford University Press.
— (2001) L’industrializzazione della musica e il problema dei valori, in Enciclopedia della musica, diretta da J.J. Nattiez, vol I, Il Novecento, Torino, Einaudi, pp. 953–965.
HAMM, Charles (1979) Yesterdays: popular song in America, New York,
Norton.
— (1983) Music in the New World, New York, Norton (trad. it. La musica
degli Stati Uniti, Milano, Ricordi–Unicopli, 1990).
JONA, Emilio, STRANIERO, Michele Luciano (a c.) (1995) Cantacronache.
Un’avventura politico–musicale degli anni ’50, Torino, CREL (Centro
Regionale Etnografico Linguistico) Scriptorium – Settore Università Paravia.
36
Roberto Agostini
LEYDY, Roberto (1958) Eroi e fuorilegge nella ballata popolare americana,
Milano, Ricordi.
— (1972) Il folk revival, Palermo, Flaccovio.
LEVINE, Lawrence (1988) Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural
Hierarchy in America, London (Mass) – London, Harvard University Press.
LOMAX, Alan (1950) Mister Jelly Roll: The Fortunes of Jelly Roll Morton, New
Orleans Creole and “Inventor of Jazz”, New York, Pantheon Books, 1993.
LOMAX, Alan, GUTHRIE, Woody, SEEGER, Peter (1967) Hard–Hitting Songs
for Hard–Hit People, Lincoln, Bison Books / University of Nebraska
Press, 1999.
MARÓTHY, János (1981) A Music of Your Own, in «Popular Music», 1, pp.
15–25.
MELLERS, Wilfrid (1964) Music in a New Found Land, London, Barrie &
Rockliff (trad. it. Musica nel Nuovo Mondo, Torino, Einaudi, 1975).
— (1976) Twilight of the Gods. The Beatles in Retrospect, London, Faber.
MIDDLETON, Richard (1990) Studying Popular Music, Bukingham, Open
University Press (trad. it. Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli,
1994).
MOLINO, Jean (2001) Tecnologia, globalizzazione, tribalizzazione, in Enciclopedia della musica, diretta da J.J. Nattiez, vol. I, Il Novecento, Torino,
Einaudi, pp. 767–782.
MONTECCHI, Giordano (2003) L’oralità ritrovata: paradigmi di una sfida
globale, in «Musica/Realtà», 71, pp. 103–123.
PREVIGNANO–RAPETTI, Ionio (1962) Io, la canzone, Milano, Ricordi.
ONG, Walter (1982) Orality and Literacy. The Technologizing of the Word,
London – New York, Routledge (trad. it. Oralità e scrittura, Bologna, Il
Mulino, 1986).
SHEPHERD, John C. (1988) La musica come sapere sociale, Milano, Ricordi–
Unicopli. (trad. ing. Music As a Social Text, Cambridge, Polity Press,
1991).
SCHAFER, Murray Raymond (1977) The Tuning of the World, Toronto,
McClelland and Stewart Ltd (trad. it. Il paesaggio sonoro, Milano, Unicopli, 1985).
SPAETH, Siegmund G. (1948) A History of Popular Music in America, New
York, Random House.
SANTORO, Marco (2006) Musical Identity and Social Change in Italy, in
«Journal of Modern Italian Studies», 3, in corso di pubblicazione.
STEFANI, Gino (1977) Codice popolare e codice colto, in Insegnare la musica, Firenze, Guaraldi, pp. 27–38.
— (1985) La melodia: una prospettiva popolare, in «Musica/Realtà», 17, pp.
105–124.
— (1986) L’arte di arrangiarsi in musica, in «Carte Semiotiche», 2, pp. 97–
114.
— (1998) Musica: dall’esperienza alla teoria, Milano, Ricordi.
Origini, sviluppi, e prospettive degli studi sulla popular music in Italia 37
STRANIERO, Michele, JONA, Emilio, LIBEROVICI, Sergio, DE MARIA, Giorgio
(1964) Le canzoni della cattiva coscienza. La musica leggera in Italia,
Milano, Bompiani.
TAGG, Philip (1979) Kojak – 50 Seconds of Television Music. Toward the
Analysis of Popular Music Affect, New York, The Mass Media Music
Scholars’ Press (2a ed riveduta 2000).
— (1994) Popular music. Da Kojak al Rave, Bologna, CLUEB.
TOMLINSON, John (1999) Globalization and Culture, Chicago, Chigago
University Press (trad. it. Sentirsi a casa nel mondo, Milano, Feltrinelli,
2001).
WICKE, Peter (1986) Rock Music. Culture, Aesthetics and Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 (tr. ing. di Rockmusik. Zur Ästhetik und Soziologie eines Massenmeduims, Leipzig, Reclam).
WILDER, Alec (1972) American Popular Song. The Great Innovators 1900–
1950, New York, Oxford University Press.
ZAK, Albin J. III (2001) The Poetics of Rock: Cutting Tracks, Making Records, Berkeley – Los Angeles – London, University of California Press.
Egidio Pozzi
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica:
lick e pattern nei soli di Enrico Rava e Chet Baker
1. Metodologia analitica e studio della popular music
In uno studio del 1966, spesso citato come uno dei lavori più importanti del settore musicologico dei popular studies, Charles Keil
[1966] contrappone il carattere “sintattico” dell’analisi della musica
colta occidentale a quello “processuale” tipico delle musiche di tradizione non scritta. Secondo questa opinione mentre nello studio delle
tradizioni colte il significato dell’opera verrebbe rilevato nelle caratteristiche interne della partitura — ad esempio rintracciando la struttura
armonico–contrappuntistica, gli aspetti tematici e armonici e più in
generale studiando quant’altro si può ricavare da un’analisi di un pezzo specifico anche in relazione allo stile di un’epoca e di un determinato autore — nelle tradizioni musicali non scritte ciò che può essere
evidenziato dovrebbe essere l’idea di un processo centrato su aspetti
“estemporanei”, quali ad esempio quelli legati alla gestualità e alle
sensazioni fisiche, all’importanza del sound e delle particolari modalità di emissione della voce, all’improvvisazione, agli aspetti ritmici, alle variazioni e alle inflessioni diastematiche, alla rilevanza della semplicità armonica e dell’ostinato 1. Su tale contrapposizione e sulle diversità tra i procedimenti della musicologia tradizionale e quelli dei
popular studies esistono numerosi lavori che hanno “criticato” l’applicazione della musicologia ai repertori popular 2, individuando pro1
Il concetto viene ripreso da Richard Middleton nel 1990: «Charles Keil definisce
sintattica l’analisi musicale in Occidente, in ragione della sua dipendenza dalla notazione […]. Egli sostiene che essa si concentra sull’organizzazione gerarchica di elementi
pseudolinguistici e sul loro essere messi insieme (com–posizione) in linea con sistemi di
norme, aspettative, sorprese, tensioni e risoluzioni. L’estetica che ne risulta è un’estetica
di “significato intrinseco”. In contrasto a ciò, egli afferma, le musiche non scritte […]
mettono in primo piano il processo. Esse hanno molto più a che fare con gli elementi di
gestualità, sensazione fisica, improvvisazione, immediatezza; l’estetica che ne risulta è
un’estetica di “sentimento ingenerato” ed è inadatta all’applicazione di criteri “sintattici”» [Middleton 1990, trad. it. pp. 167–168].
2
«Non ho intenzione di sostenere che la musicologia non possa capire la popular
music, o che gli studiosi di popular music debbano abbandonare la musicologia. Tuttavia
è anche vero che l’insieme dei metodi, assunti e ideologie che sono andati a costituire la
39
40
Egidio Pozzi
blemi terminologici, metodologici e ideologici fino al punto di ipotizzare addirittura una «inevitabile riorganizzazione della storia della
musica occidentale per intero» [Middleton 1990, trad. it. p. 175].
Ultimamente mi sembra che le critiche si siano ridimensionate non
solo per l’evidente astrattezza di talune proposte, come ad esempio
quella appena riportata, ma anche per la decisa presa di posizione di
alcuni importanti studiosi. Lo stesso Middleton suggerisce ora una
certa cautela nel contrapporre i procedimenti analitici applicabili alle
due tradizioni, sia per quanto riguarda la reale prassi compositiva
(«simili distinzioni dicotomiche sono di solito sospette e probabilmente tutti gli stili musicali mescolano i due approcci in proporzioni variabili») sia perché «lo stesso pezzo può essere sentito in modi diversi.» [Middleton 2002, p. 724]. Portando l’attenzione sulla ricezione, lo
studioso inglese sembra avvertire la problematicità inserita nel tentativo di individuare distinte modalità d’ascolto, non influenzate da quella
commistione di stili e di generi che è invece parte notevole della nostra moderna concezione culturale. L’interazione tra competenze diverse sia in campo compositivo sia interpretativo è evidentemente così
forte e diffusa che la relazione tra i due procedimenti analitici, sintattico e processuale, in moltissimi casi non solo non sarebbe scorretta ma
potrebbe divenire addirittura una necessità.
Naturalmente ciò non significa che le metodologie analitiche rigorosamente messe a punto per la musica antica, classica e romantica
possano essere applicate acriticamente a generi e stili moderni, a meno
che non si vogliano rischiare affermazioni e giudizi azzardati. L’aspetto metodologicamente più problematico e che più separa le due
tradizioni è quello che Philipp Tagg definisce la “centralità della notazione” [Tagg 1979], ovvero quello della priorità degli aspetti compositivi su quelli improvvisativi ed estemporanei. Il problema nasce non
solo da una evidente questione tecnica 3, ma anche dal fatto che nelle
tradizioni popular la mancanza di un riferimento scritto finisce per ridurre l’importanza degli aspetti compositivi rispetto a quelli più estemporanei e contestuali della produzione. Ciò ha inevitabilmente
“musicologia mainstream” della fine del XIX e del XX secolo hanno reso questa disciplina in tanti sensi meno che utile.» [Middleton 1990, trad. it. p. 152].
3
Mentre nella tradizione colta l’esistenza di una partitura consente uno studio analitico profondo e particolarmente dettagliato, nelle tradizioni non scritte occorre riferirsi
direttamente agli aspetti percettivi oppure ad una loro trascrizione in forma scritta con
tutti i problemi connessi alla realizzazione e all’utilizzazione di una forma di notazione
sufficientemente precisa e appropriata al repertorio preso in considerazione.
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
41
delle conseguenze sul fronte storiografico: in mancanza di un “testo”
scritto, garantito e legittimato dall’autore, nonché testimone delle sue
volontà, qual è il soggetto della nostra narrazione storica? Senza un
documento scritto — senza un “ricordo concepito scientificamente”
diceva Carl Dahlhaus — la categoria centrale di una storia della musica può ancora essere il concetto di “opera” oppure occorrerà riferirsi
alla storia della ricezione e utilizzare per la nostra trattazione il concetto di “evento”? [Dahlhaus 1977, trad. it. 3 e 5]. L’impraticabilità di
tale scelta è però evidente:
Quell’aspetto o apparenza di vicinanza alla realtà che costituisce l’attrattiva
dell’approccio rivolto alla storia della ricezione, in parte è quindi solo una illusione e un inganno. A differenza dei testi autentici, gli accadimenti musicali sono ricostruibili solo in misura insufficiente. L’insistere sull’idea che vera musica non
sia la “morta lettera”, ma solo il “processo della comunicazione”, resta presso che
impotente di fronte alla deludente esperienza che gli asserti stereotipati, in cui si
vede respinto sempre di nuovo lo storiografo della ricezione per mancanza di documenti, difficilmente possono reggere accanto alla precisione raggiungibile da
un’analisi musicale strutturale. [Dahlhaus 1977, trad. it. p. 47]
Se nello studio delle tradizioni colte l’impossibilità di una trattazione
che metta al primo posto l’evento — il concerto, la performance — rispetto alla partitura è determinata dall’inconsistenza delle fonti esistenti
o documentabili, nei settori della popular music occorre interrogarsi di
volta in volta sulla valenza dei propri documenti e sull’opportunità di
una metodologia analitica specifica. Nel caso ad esempio della tradizione jazzistica, la volontà dell’interprete o del compositore è spesso testimoniata da ciò che lui stesso ha deciso di lasciare: ogni musicista
nell’affidare un pezzo ad una registrazione opera una selezione che trasforma di fatto un’interpretazione tra le tante in un modello esemplare
per la diffusione e lo studio della propria musica.
Non ho citato quest’esempio a caso. Nello studio delle tradizioni
non scritte uno degli aspetti più problematici riguarda proprio l’improvvisazione, una questione generalmente considerata «come il principale elemento del jazz poiché offre quelle caratteristiche di spontaneità, sorpresa, sperimentazione e scoperta senza le quali la maggior
parte del jazz sarebbe destituito d’interesse» [Kernfeld 2001, p. 128)
L’obiettivo di questo studio è descrivere in che modo e con quali modifiche ai criteri fondamentali la metodologia analitica approntata da
Nicolas Ruwet per lo studio di singole melodie possa essere utilizzata
per lo studio delle parti improvvisate del repertorio jazzistico. Pur non
42
Egidio Pozzi
essendo l’unica metodologia applicabile in questi contesti 4, i procedimenti analitici proposti da Ruwet nel 1966, opportunamente rivisitati e ampliati, possono fornire alcune interessanti osservazioni sia rispetto agli aspetti formali delle musiche studiate sia rispetto alle condotte melodiche proposte da alcuni famosi musicisti 5.
2. Il metodo analitico di Nicolas Ruwet
Nicolas Ruwet pubblicò Méthodes d’analyse en musicologie nel
1966. Secondo il linguista, semiologo e saggista francese il «significato di un’opera musicale non può apparire altrimenti che nella descrizione dell’opera stessa». [Ruwet 1967, p. 85]. Quindi se vogliamo iniziare a comprendere il senso di una partitura dobbiamo indagare sulla
“sintassi” musicale, cioè sul modo con cui il compositore ha ordinato
le diverse unità — cellule, motivi, temi e così via. Nei primi due capitoli Ruwet tratta del rapporto tra codice e messaggio in un sistema semiotico e delle procedure di scoperta fino ad allora individuate negli
studi musicologici. Facendo riferimento alla distinzione tra modello
analitico (il procedimento d’indagine che consente di risalire dal messaggio al codice che l’ha generato) e modello sintetico (il procedimento che permette di generare messaggi partendo da un insieme di regole
rigorosamente esplicitate), Ruwet osserva inoltre: «a) che il problema
teorico della distinzione non è mai stato proposto; b) che nessun modello analitico è mai stato esplicitamente elaborato; c) che le analisi
musicali, anche le migliori […] non formulano i criteri di scoperta su
cui si fondano» [Ruwet 1966, trad. it. p. 90] 6.
4
Nella musicologia anglosassone da molti anni sono disponibili ampi e circostanziati studi sul repertorio jazzistico basati essenzialmente sulla teoria proposta da Heinrich
Schenker per la musica colta tonale. Tra gli autori più prolifici e interessanti vanno ricordati Allen Forte, che alcuni anni fa ha pubblicato un testo dedicato interamente alle
canzoni americane dell’epoca 1924–1950 [Forte 1995], Steven E. Gilbert [1995] che si è
dedicato alla musica di Gershwin e, per quanto riguarda specificamente l’improvvisazione nella musica di Charlie Parker, Lawrence A. Koch [1974], Steve Larson [1996] e
Henry Martin [1996].
5
Il lavoro che qui verrà descritto è parte di un progetto più ampio che affronta il
problema dell’analisi dell’improvvisazione facendo riferimento anche ad altre metodologie analitiche quali, ad esempio, l’analisi schenkeriana.
6
Occorre però precisare che questo tipo di osservazioni, basate per lo più sulla
bibliografia francese, si prestano a molte critiche, soprattutto per quanto riguarda i punti
“b” e “c”. Basti pensare al corpus di studi teorici e analitici di Hugo Riemann o a quello
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
43
Nei capitoli successivi Ruwet esplicita la sua proposta di un procedimento analitico centrato essenzialmente sulla divisione in parti, ovvero sulla segmentazione di linee melodiche sufficientemente estese,
utilizzando come principale criterio quello della rilevazione delle ripetizioni. Dopo aver chiarito in che senso si deve intendere il concetto di
identità — vengono considerati identici quei segmenti musicali che
hanno per ogni evento uguale durata e uguale altezza — si passa alla
descrizione del procedimento analitico, definito dal suo autore una
“macchina per reperire le identità elementari”. Sarà utile chiarire subito che tale procedimento deve essere applicato a “livelli” diversi, cioè
a porzioni diverse della linea melodica analizzata: prima a tutta la linea, poi alle segmentazioni che risultano da una prima applicazione
della “macchina”, poi alle successive e così via.
Le prime applicazioni di questo metodo sono state realizzate da Ruwet
su pezzi tratti dal repertorio trovadorico 7; un repertorio caratterizzato sia
da un’apparente facilità — considerando il fatto che sono pezzi monodici
— sia da una complessità quasi irrisolvibile per quanto riguarda la comprensione delle regole compositive sottostanti (se mai esse furono intese
come tali). Uno degli obiettivi di Ruwet non era solo quello di esplicitare
un metodo per scoprire il codice (la regola compositiva) partendo dal
messaggio (il pezzo musicale), ma anche quello di poter verificare e controllare il metodo e la sua applicazione passo dopo passo.
L’utilità dell'applicazione di questo metodo si rivela soprattutto nei
repertori di cui conosciamo poco o nulla circa la loro sintassi interna: infatti, andando a determinare una struttura gerarchica dal punto di vista
della collocazione formale dei diversi materiali, è possibile ipotizzare
successivamente una gerarchia interna tra gli elementi costitutivi. Naturalmente tutto ciò sembra essere troppo schematico se abbiamo a che fare con i procedimenti dell’elaborazione compositiva armonico–contrappuntistica che, specie nella musica tonale, fanno più riferimento alle categorie della continuità e della linearità piuttosto che a quelle della giudi Heinrich Schenker, redatti all'inizio del secolo; oppure alle analisi dodecafoniche dei
pezzi della seconda scuola di Vienna realizzate dagli stessi compositori viennesi sulla
base di una teoria compiutamente affermata, anche se posteriormente.
7
Il metodo di Ruwet ha trovato particolari e interessanti applicazioni anche nei repertori monodici della musica del Novecento o in passi solistici del tardo Ottocento. È
stato utilizzato, ad esempio, da Jean–Jacques Nattiez nelle analisi di Syrinx di Claude
Debussy, di Density 21.5 di Edgar Varèse o del solo del corno inglese nel terzo atto del
Tristano di Richard Wagner; inoltre viene costantemente e frequentemente adottato in
campo etnomusicologico, dove la determinazione del sistema compositivo è fondamentale per la comprensione di culture musicali profondamente diverse dalla nostra.
44
Egidio Pozzi
stapposizione e della ripetitività. Si consideri d’altra parte che il metodo
di Ruwet si applica generalmente a repertori la cui grammatica è pressoché sconosciuta; in tali casi la determinazione anche approssimativa di
una gerarchia interna di tipo formale è un risultato già di per sé abbastanza interessante e che può aprire le porte a successive investigazioni.
È interessante ribadire che in questo metodo analitico tale gerarchia viene stabilita non su basi armonico–contrappuntistiche, ma su parametri di
ricorrenza e di durata, cioè più le frasi sono ampie e ripetute e più esse
vanno considerate essenziali per lo sviluppo complessivo del pezzo.
Un esempio ripreso dal testo di Middleton del 1990 potrà aiutare a
comprendere meglio l’applicazione del metodo. Lo studioso inglese
analizza A Foggy Day, una delle più famose canzoni di George e Ira
Gershwin (esempio 1), e presenta i risultati del suo lavoro in un grafico, riprodotto nell’esempio 2 8. In questo grafico sono compresenti
due livelli analitici. Il primo livello deriva dalla prima applicazione
della “macchina per reperire le identità elementari”, dalla quale sono
emerse le frasi uguali più lunghe possibili; ciò consente di individuare
la forma complessiva della canzone, ovvero le singole sezioni, qui indicate con lettere maiuscole ABA1B1. Una rilevazione successiva — il
secondo livello — consente di segmentare ciascuna delle quattro sezioni precedenti in due frasi, contrassegnate questa volta con lettere
minuscole: A = a+a1 ; B = b+c ; A1 = av+a1v ; B1 = b1+d 9.
8
Si noterà che nei grafici di questo tipo i segmenti ritenuti identici sono collocati
uno sotto l’altro. L’idea di “tradurre” i risultati dell’analisi in forma grafica proviene, secondo Ruwet, dai procedimenti usati da Claude Lévi–Strauss nelle sue indagini sulla
struttura dei miti [Lévi–Strauss 1958]: «mi è parso chiarificatore, nello studio delle monodie, riprendere un procedimento che Claude Lévi–Strauss applica all'analisi dei miti –
ispirandosi d'altronde egli stesso alla notazione musicale delle partiture d'orchestra. Le
sequenze equivalenti sono, per quanto possibile, scritte al di sotto le une delle altre, in
una stessa colonna, e il testo deve leggersi, facendo astrazione dai vuoti, da sinistra a destra e dall'alto in basso. Così, certi caratteri di struttura sono immediatamente apparenti,
come del resto certe ambiguità» [Ruwet 1966, trad. it. p. 102].
9
Sarà il caso di osservare che è proprio la rilevazione di una ripetizione melodico–
ritmica, seppur variata, a consentire la segmentazione della composizione. Al primo livello ciò che permette di dividere tutta la linea melodica in ABA1B1 è proprio l’individuazione dell’identità tra le due frasi A (misure 1–8 e 17–24); al secondo livello la divisione, ad esempio, della frase A è consentita dall’individuazione della ripetizione dei
due temi “a” (misure 1–4 e 5–8), e così via.
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
Esempio 1: linea melodica di A Foggy Day
Esempio 2: analisi di Middleton di A Foggy Day (I e II livello)
45
46
Egidio Pozzi
Esempio 3: analisi di A Foggy Day (I, II e III livello)
Una ulteriore applicazione della “macchina” di Ruwet consente di
individuare dei segmenti più piccoli. Nell’esempio 3 tali segmenti sono stati segnalati da lettere greche; se si escludono i due segmenti
conclusivi, e che determinano la cadenza finale, il resto della composizione si basa sui due motivi e costituiti rispettivamente da una
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
47
terza ascendente e una discendente, opportunamente trasposti (t), espansi (e) e variati ritmicamente (v). Uno degli aspetti più interessanti
del metodo di Ruwet è proprio nella sua articolazione in livelli: ogni
applicazione della “macchina” consente di individuare materiali melodici sempre più dettagliati. Dopo la prima applicazione che permette
di rilevare la forma della canzone, la seconda rintraccia i materiali tematici (a, b, c, d), mentre la terza rileva i segmenti motivici che ne sono alla base. (cfr. tabella 1) In tal senso il metodo di Ruwet, pur non
scendendo nella “profondità” della composizione (per la quale occorrerebbe attivare un procedimento analitico volto ad evidenziare gli aspetti armonico–contrappuntistici che sono alla base della sua struttura), consente di avere un’idea precisa della forma, dei materiali tematici e della loro interazione.
Tabella 1: forma, materiale tematico e segmenti motivici in A Foggy
Day
II
livello
forma
(divisione
in sezioni)
materiale
tematico
III
livello
segmenti
motivici
I
livello
sezione
A
sezione
B
sezione
A1
sezione
B1
a + a1
b+c
av + a 1v
b1 + d
+ te
tv +
te,v
+ tv
tv +
te,v
v + te,v
tv +
te,v
tv+ t v
+ c + Oltre a questo aspetto occorre aggiungere che il metodo di Ruwet
mostra una grande flessibilità di applicazione. Per il suo essere basato
essenzialmente sul rilevamento di “identità”, si presta ad un’applicazione diversificata, semplicemente modificando i criteri in base ai
quali tali identità sono rilevate. In altre parole potrebbe essere lo stesso repertorio che si vuole studiare a “suggerire” i criteri d’identità più
efficaci. Mentre nel caso di melodie tonali l’adozione di criteri riguardanti l’uguaglianza di durate e altezze sembrano essere più utili, nel
caso di un pezzo di musica elettronica, ad esempio, occorrerà far riferimento ad aspetti timbrici o a modi d’attacco del suono, oppure, in linea più generale, a parametri compositivi specificamente legati allo
stile di quel determinato compositore.
48
Egidio Pozzi
3. Lick e pattern nelle improvvisazioni jazzistiche di Enrico
Rava e Chet Baker
Nell’improvvisazione jazzistica la grande varietà di possibilità melodiche concesse all’interprete, come pure la stessa concezione di estemporaneità e varietà che è alla base dell’evento musicale, non consentono di stabilire dei criteri d’identità validi in generale e tantomeno
di considerare come materiale melodico di base una semplice successione di altezze e durate, seppur variate o trasposte, ritmicamente e
melodicamente. Nello studio delle parti solistiche improvvisate della
tradizione del jazz tonale, occorrerà cercare di volta in volta, sulla base di aspetti stilistici e grammaticali propri di quel musicista o provenienti dalla produzione musicale a lui precedente, quali criteri d’identità si dimostrano essere non solo più efficaci per condurre un’analisi
formale e tematica ma anche più pertinenti rispetto alle concezioni estetiche dello stesso interprete. Di fatto la ricerca di ciò che può rendere paragonabili due frasi improvvisate eseguite ad esempio da Charlie
Parker o da John Coltrane, ovvero lo studio dei criteri sulla base dei
quali i due passaggi possono essere considerati uguali o uno la trasformazione dell’altro, è nella gran parte dei casi uno degli obiettivi
dell’indagine analitica. Tale ricerca può essere agevolata tenendo conto che la segmentazione di un determinato solo è spesso determinabile
a priori, ad esempio rilevando alcune pause significative oppure il
completamento di una determinata successione armonica. Da questo
punto di vista si tratta quindi di “invertire” il procedimento analitico
proposto da Ruwet. Non si partirà dai criteri per il rilevamento delle
identità per arrivare ad una segmentazione, ma si utilizzerà la segmentazione che ci sembra più pertinente per studiare quelle somiglianze
melodico–ritmico–metriche che possono più di altre rappresentare il
particolare stile improvvisativo di quell’interprete.
Nell’esempio 4 ho riportato lo schema analitico proposto da
Giuseppe Di Nardo nel corso del suo lavoro di tesi di laurea svolta
presso il DAMS dell’Università degli Studi della Calabria, riguardante
un’indagine sullo stile improvvisativo del musicista torinese Enrico
Rava. Lo schema riguarda i due chorus improvvisati da Rava all’interno
dello standard Fine and Dandy registrato nel 1960 con Maurizio Lama al
pianoforte, Filippo Faguttin al contrabbasso e Franco Mondini alla
batteria; il pezzo è stato inserito nel disco Jazz in Italy n.1 (Cetra EPD,
1960) e successivamente riutilizzato come brano di apertura di una
raccolta di pezzi che accompagnano un testo biografico preparato da
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
49
Esempio 4: schema analitico dell’assolo di Rava in Fine and Dandy
(Di Nardo 2004)
50
Egidio Pozzi
Rava e da Alberto Riva nel 2004. (Di Nardo, 2004, p. 116) 10. Il brano
è costituito da 32 battute articolate in quattro sezioni di otto battute: A
(dalla tonica principale F alla sua dominante), B (con modulazioni
verso Bb e Ab), A e B1 (con modulazione al Bb e turnaround verso F).
Dallo schema si deduce che le diverse frasi proposte dal musicista
sembrano far riferimento a due tipologie costruttive. Mentre la prima è
una costruzione di tipo “modulare”, cioè basata su brevi motivi collegati
in successione o in progressione, la seconda tipologia (le cui frasi sono
indicate nello schema come frasi “c”) è una costruzione melodica più
continuativa, costituita prevalentemente da successioni di crome e collocata sempre nella stessa sezione del pezzo. Queste frasi, sebbene presentino una successione diastematica spesso molto diversa mostrano, al
tempo stesso, delle forti somiglianze. Evidenziate nell’esempio 5 ed esplicitate nella tabella 2, tali somiglianze sono riconducibili a tre aspetti:
il profilo iniziale, la prevalenza di un certo passo ritmico e l’insistenza su
alcune note. La somiglianza più forte riguarda il profilo iniziale: tre frasi
su quattro presentano un profilo discendente basato su una bebop scale
11
, mentre la terza frase (misure 41–48) aggiunge all’inizio un piccolo
frammentino il cui suono iniziale (C) è lo stesso di quello che inizia la
bebop scale della quarta frase. Dopo un inizio così particolare, il comportamento melodico delle quattro frasi analizzate mostra delle differenze sostanziali. Se dal punto di vista ritmico la prima e la quarta frase mostrano una certa prevalenza nell’uso di crome (al contrario della seconda
e della terza nelle quali è la semiminima la figura prevalente), dal punto
di vista diastematico il musicista propone con insistenza alcune figure
specifiche. Nell’esempio 5 sono evidenziate due figure prevalenti: la ter10
Lo stesso musicista torinese chiarisce i motivi di questa scelta in un’intervista rilasciata successivamente: «ho inserito quel pezzo per un motivo storico. Appartiene a un
disco che nessuno conosce. È un’incisione del 1960, avevo vent’anni. Riascoltandolo mi
è sembrato che suonassi più o meno come suono adesso, il che mi stupisce, considerando che suonavo da appena due anni» [Ughi 2004]. È importante osservare che nello scegliere questo pezzo come una delle registrazioni più rappresentative della sua produzione, il musicista torinese individua una tra le tante incisioni come un vero e proprio “testo”, come un modello interpretativo/compositivo di indubbia efficacia tanto per lo storico quanto per i futuri musicisti che approfondiranno su quel pezzo il proprio stile e la
propria tecnica esecutiva.
11
Le bebop scale sono scale di 8 suoni derivate dalle corrispondenti scale modali
con l’aggiunta di un cromatismo tra il VII e l’VIII grado (nel caso che il relativo accordo
sia una settima di dominante). Nel nostro caso la bebop scale sull’accordo di F7 è: F–G–
A–Bb–C–D–Eb–E–F. Queste scale sono spesso usate nell’improvvisazione per avere sul
battere sempre una nota dell’accordo.
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
51
za minore Ab–F (indicata con “x”) e la terza lineare G–Ab–Bb (“y”). In
particolare si noterà che le due figure sono presentate nella prima frase
(misure 9–16) e riutilizzate in forma trasposta, inversa e ampliata nelle
frasi successive. Ciò che occorre però rilevare è che tali figure non sarebbero sufficienti per considerare le quattro frasi una la variante
dell’altra; infatti ciò che le accomuna all’ascolto è soprattutto la diversità
rispetto alle frasi precedenti e successive, basate su una tipologia costruttiva molto differente perché modulare.
Esempio 5: analisi delle frasi “c” dell’assolo di Rava in Fine and
Dandy
Tabella 2: caratteristiche delle frasi “c” del solo di Rava in Fine and
Dandy
misure
caratteristiche
armoniche
9–16
II–V di Bb e di Ab
25–32
II–V di Bb e
turnaround verso F
41–48
II–V di Bb e di Ab
57–64
II–V di Bb e
turnaround verso F
caratteristiche melodiche
profilo iniziale
discendente
bebop scale
discendente
bebop scale
ascendente
discendente
bebop scale
discendente
bebop scale
con
passo ritmico
crome
con crome e
semiminime
poi
crome e
con
semiminime
con
crome e pause
figure specifiche prevalenti
Ab–F
G–Ab–Bb
Ab–F
Db–C–Bb
F–Ab e Ab–F
52
Egidio Pozzi
Diversamente dalle frasi “c”, le altre frasi del solo di Rava mostrano tutte un elemento caratteristico ben evidente (cfr. esempio 4). Mentre il motivo “a” è basato su una nota di volta ed è immediatamente ripetuto, il motivo “b” è costituito da una piccola progressione di terze
ascendenti, un intervallo che andrà a costituire la sostanza dei motivi
“d”. Anche i motivi “e” e “f”, diversi tra loro e basati rispettivamente
su una nota di volta e un salto di quarta 12, sono più volte ripetuti,
mentre il motivo “g” (basato sulla terza discendente C–A) viene riproposto due volte, come il motivo “a”. Come accennato in precedenza
tutti questi motivi, spesso definiti lick 13, sono alla base di una costruzione fraseologica “modulare”. Un esempio di questo tipo di costruzione è riportato nell’esempio 6, relativo alle misure 17–24 del primo
chorus dell’improvvisazione 14. In questo passaggio Rava propone una
sorta di progressione melodica ascendente costituita da quattro ripetizioni del motivo “d”: mentre le prime tre sono basate su una figura
specifica trasposta sulle fondamentali degli accordi di F, Gm7 e Am7,
la quarta ripetizione, prima di concludersi sulla dominante principale,
è trasposta sul Bb, la terza dell’accordo di Gm9. Il ricorso a questo espediente fa sì che la spinta verso l’alto proveniente dalle misure precedenti prevalga sulla logica armonica che, se la ripetizione fosse iniziata con il G, avrebbe imposto invece la discesa del profilo della progressione. [Di Nardo 2004, pp. 124–125]. È evidente quindi l’intento
di Rava nel privilegiare la condotta lineare rispetto a quella armonica
e ciò può essere collegato al suo dichiarato interesse nei confronti del-
12
Il motivo “e” che apre il secondo chorus dell’improvvisazione è evidentemente
una diminuzione del motivo “a”, poiché è anch’esso basato su una nota di volta.
13
«Dove non viene usata l’improvvisazione per parafrasi, l’attenzione si focalizza su
frammenti musicali usati in vario modo. I frammenti possono essere definiti variamente e
spesso con termini intercambiabili, come idee, figure, gesti, formule, motivi e così via; nel
gergo jazzistico sono spesso chiamati lick, mentre nel primo jazz specificamente hot lick»
[Kernfeld 2001, p. 130]. Secondo il Glossario fornito da Roberto Agostini e Luca Marconi
in un recente testo dedicato all’analisi della popular music «il lick è una frase melodica ben
riconoscibile e chiaramente marcata dal punto di vista stilistico. Può essere tipica di un certo repertorio, ma anche di un singolo musicista» [Agostini–Marconi (a c.) 2002, p. XXVI].
14
Nell’esempio 6 la linea melodica ascendente contrassegnata dai numeri 1–2–3–4–
5 è una “successione lineare”, ovvero un movimento diatonico per grado congiunto unidirezionale che rappresenta «il percorso che il compositore intende perseguire nell’esposizione e nello sviluppo delle proprie idee musicali» [Pozzi 2001, p. 70]. Per ulteriori
chiarimenti cfr. Drabkin–Pasticci–Pozzi 1995.
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
53
la melodia, in virtù di una particolare “indole lirica” che lo stesso musicista ha spesso riconosciuto in occasione di varie interviste 15.
Esempio 6: analisi delle misure 17–24 del primo chorus del solo di
Rava in Fine and Dandy
Un procedimento analitico molto simile è stato adottato da Paolo
Marchese in occasione di una tesi discussa presso il Conservatorio S.
Giacomantonio di Cosenza, dedicata allo studio dell’improvvisazione
di Chet Baker. Il solo preso in esame è quello in Happy little sunbeam
(esempio 7), un brano scritto da Russ Freeman, registrato a Los Angeles nel 1953 e inserito nella raccolta della Blue Note The Definitive
Chet Baker 16. Anche in questo caso l’analisi ha condotto all’individuazione di una serie di frasi dal carattere modulare insieme a frasi più
lunghe e dal profilo approssimativamente sinusoidale. Tutte le frasi
dei due chorus improvvisati da Baker sono state riportate nella tabella
3: si noterà che mentre le frasi “a”, “c”, “d”, “e” e “g”, caratterizzate
15
Nel ricordare le registrazioni della fine degli anni Settanta, Rava ribadisce l’interesse verso il linguaggio della tradizione jazzistica dopo il periodo del free jazz: «io recuperavo l’uso di quel linguaggio che in fondo era il mio linguaggio di partenza […] In
quel periodo nella mia musica accadde qualcosa. Era come se avessi iniziato a dare spazio a un’indole che, a guardare bene, si rintracciava già nel mio primo disco, nel pezzo
del titolo, Il giro del mondo in 80 mondi. Cioè la passione per la melodia e per tutto ciò
che ne consegue. Sono molto romantico, non esito a dirlo. Liberandomi via via delle sovrastrutture questo aspetto veniva a galla. Cominciavo a pensare all’espressione. Dare
l’espressione nel fraseggio, una cosa che io sento molto, come fossi un cantante» [Rava–
Riva 2004, pp. 132–133].
16
Alla registrazione parteciparono insieme a Chet Baker, Russ Freeman al pianoforte, Carson Smith al contrabbasso e Chico Hamilton alla batteria. Il brano è in F e comprende 32 battute, articolate in quattro sezioni di otto battute: A (dalla tonica principale F
alla dominante di Bb), B (con modulazioni verso Ab e C), A e C (con modulazioni diverse che tornano alla tonica F). Baker improvvisa il suo solo sia alla fine
dell’esposizione del tema (cfr. esempio 7) sia dopo il solo del pianoforte; dei due chorus
esistono trascrizioni di Jeff Helgesen (http://www.shout.net/~jmh/), Jacques Gilbert
(http://trumpet.voici.org/) e John Keady (http://www.jazztrumpetsolos.com). Tutte le
trascrizioni sono molto simili tra loro e differiscono solo per dettagli marginali.
54
Egidio Pozzi
dalla presenza di motivi o figure ben definite (lick), sono associate a
gruppi di due o tre e presentano quindi un aspetto “modulare”, le frasi
di tipo “b”, costituite per lo più da successioni di crome, sono più lunghe e non contengono motivi o cellule fortemente caratterizzate dal
punto di vista melodico, ritmico o metrico 17.
17
La frase “f”, pur non presentando ripetizioni interne oppure una qualche forma di
costruzione modulare non può essere confusa con le frasi “b” in quanto presenta un passo ritmico di semiminime, elementi in sincope o controtempo e un profilo nettamente discendente.
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
55
Esempio 7: prima parte del solo di Chet Baker in Happy Little Sunbeam
56
Egidio Pozzi
Tabella 3: schema formale del solo di Chet Baker in Happy Little
Sunbeam
sezione
accordi
frasi solo
(I chorus)
frasi solo
(II chorus)
sezione A
Gm7
C7
sezione
accordi
sezione B
Bbm7
Ab
Eb7
Fm7
(segue b1)
b2
frasi solo
(I chorus)
frasi solo
(II chorus)
a1
F
a2
a3
e1
F Abm7
Gm7
v
C7
a3
b1
e2
b5
Cm6
Dm7 G7 C
Cm7
F7
Dm7 G7 C Abm7
c1
f
b6
sezione
accordi
frasi solo
(I chorus)
frasi solo
(II chorus)
sezione A
Gm7
C7
sezione
accordi
sezione C
Bm7 E7
segue c1
c2
a4
a5
frasi solo
segue d1 d2
(I chorus)
frasi solo
g
(II chorus) 1
F
F Abm7
Gm7
C7
Cm7
F7
b3
a6
d1
a5v
Am7 D7
d3
b7
Gm7
C7
Eb7
D7
Gm7
C7
F
F
b4
g2
b8
Nonostante l’individuabilità delle frasi “b” sia legata principalmente al loro essere precedute e seguite da frasi più brevi costruite modularmente, è possibile evidenziare al loro interno delle ulteriori somiglianze. Nelle otto frasi di tipo “b” sono stati rintracciati sei frammenti
melodici abbastanza simili tra loro, ma collocati in diverse zone formali e utilizzati dall’improvvisatore molto liberamente.
Tali frammenti, indicati nell’esempio 8 come pattern, sono sostanzialmente diversi dai motivi marcati e ben caratterizzati che abbiamo
individuato per le altre frasi del solo, per i quali abbiamo usato il termine lick. Le principali caratteristiche di questi pattern sono riassunte
nella tabella 4.
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
57
Esempio 8: analisi delle frasi “b” del solo di Chet Baker in Happy Little Sunbeam
58
Egidio Pozzi
Tabella 4: caratteristiche dei pattern delle 8 frasi “b” del solo di Chet
Baker
pattern
collocazione
1
frasi b1, b2 , b5, b6, b7
2
frasi b1, b3 , b4
3
frasi b2, b4 , b5, b6
4
frasi b2, b4
5
frasi b1, b2 , b4, b8
6
frasi b1, b6
caratteristiche
costituito da una successione di crome dal profilo ascendente–
discendente, collocato all’inizio contribuisce a connotare il profilo sinusoidale delle frasi “b”
costituito da una successione di crome con profilo discendente– ascendente–discendente, e con una terzina collocata
all’apice della fase ascendente
costituito dalla ravvicinata ripetizione di una figura di tre suoni per gradi congiunti che crea l’effetto di uno spostamento
d’accento
costituito da un frammento di scala ascendente preceduta da
una terza discendente e chiusa da una terza ascendente
costituito da una terza ascendente preceduta da un cromatismo
(o da un grado congiunto) e seguita da una discesa per gradi
congiunti
costituito da cromatismi discendenti chiusi da un grado congiunto
I pattern rintracciati rappresentano la realizzazione “estemporanea”
— ovvero trasformata e adattata al contesto armonico–melodico — di
frammenti melodici tipici che generalmente fanno parte del “bagaglio”
tecnico del buon improvvisatore. Tali frammenti, basati su brevi segmenti scalari o intervallari particolarmente interessanti dal punto di vista stilistico oppure derivati da frasi celebri dei grandi improvvisatori
della tradizione jazzistica, appartengono così profondamente alla tecnica improvvisativa del singolo musicista da essere immediatamente
disponibili per il tipo di composizione “ad alta velocità” necessaria in
questi casi. Di conseguenza il musicista riesce ad introdurli all’interno
delle proprie frasi quasi “senza pensarci”, adattandoli però al contesto
melodico e alla successione armonica sottostante.
Leo Treitler, in un articolo dedicato alle tecniche della composizione improvvisata nel repertorio gregoriano, collegava la particolare
tecnica del cantore in epoca di tradizione orale all’uso di “formule
standard” apprese con la frequentazione decennale del repertorio e
emergenti come “riflessi condizionati” in determinate condizioni formali e testuali. Analogamente i pattern — lungamente studiati dal
musicista e caratteristici della particolare tecnica strumentale di un
jazzista — forniscono il patrimonio melodico al quale egli ricorre nel
momento dell’improvvisazione. Naturalmente sarà molto improbabile
che il pattern studiato possa essere riutilizzato in modo invariato in
quanto i collegamenti melodici, la collocazione formale, le condizioni
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
59
armoniche e gli eventuali significati retorici sono sempre differenti: in
tal senso il pattern non rappresenta un motivo fisso da collocare al
punto “giusto”, bensì un frammento melodico da modificare e variare
estemporaneamente, appartenente alla tecnica strumentale del singolo
musicista e potenzialmente utile non solo nelle diverse situazioni stilistiche dalle quali il pattern proviene ma in tutte quelle che la capacità
e la creatività del musicista possono immaginare.
In un solo improvvisato, lick e pattern rappresentano rispettivamente il contributo individuale e intuitivo del musicista, nonché l’aspetto stilistico ereditato, il patrimonio derivato dallo studio e dall’esperienza personale e collettiva. Essi costituiscono così due elementi
essenziali dell’improvvisazione jazzistica: la loro presenza e le diverse
modalità del loro utilizzo hanno contribuito a caratterizzare non solo
gli stili dei grandi maestri ma anche il significato e l’importanza dell’improvvisazione all’interno di un brano, fino a trasformare queste
zone formali nel momento esteticamente centrale di una performance.
Un patrimonio di conoscenze e di potenzialità creative provenienti
dalla tradizione, da Louis Armstrong a Miles Davis, da Charlie Parker
a John Coltrane, ma disponibile per tutti quei musicisti che nelle loro
proposte innovative vogliono e sanno apprendere dai grandi jazzisti
del passato.
60
Egidio Pozzi
Riferimenti Bibliografici
DAHLHAUS, Carl (1977) Grundlagen der Musikgeschichte, Arno Volk Verlag, Köln (trad. it. Fondamenti di storiografia musicale, Discanto Edizioni, Fiesole, 1980).
DI NARDO, Giuseppe (2004) Vita, produzione e introduzione allo stile improvvisativo di Enrico Rava, Tesi di Laurea, Università della Calabria,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in DAMS.
DRABKIN, William, PASTICCI, Susanna, POZI, Egidio (1995) Analisi schenkeriana. Per un’interpretazione organica della struttura musicale, in «Quaderni di Musica/Realtà», 32, LIM, Lucca (rist. 1999).
FORTE, Allen (1995) The american popular ballad of the Golden Era 1924–
1950, Princeton University Press, Princeton (trad. it. dei capp. 2, 4, 6 e 7
in Analisi della popular music, a cura di R. Agostini e L. Marconi, numero speciale della Rivista di Analisi e Teoria Musicale, 2002, VIII, 2, pp.
45–77).
GILBERT, Steven E. (1995) The Music of Gershwin, New Haven, Yale
University Press.
KEIL, Charles (1966) Motion and feeling through music, in «Journal of Aesthetics and Art Criticism», n. 24, pp. 337–349.
KERNFELD, Barry (2001) Improvisation (§ III Jazz), in The New Grove. Dictionary of Music and Musicians, edited by S. Sadie, Macmillan Pub.,
London–New York, Second Edition, vol. 12, pp. 128–133.
KOCH, Lawrence A. (1974) Ornithology: A Study of Charlie Parker’s Music,
part I, in «Journal of Jazz Studies», vol. II/1.
LARSON, Steve (1996) The Art of Charlie Parker’s Rhetoric, in «Annual Review of Jazz Studies», vol. 8, pp. 141–166.
LÉVI–STRAUSS, Claude (1958) Anthropologie Structurale, Paris, Plon (trad.
it. Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano, 1966).
MARCHESE, Paolo (2005) Osservazioni sullo stile improvvisativo di Chet Baker, Tesi finale del Corso Speciale per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole medie, classe di concorso A077 (L. 143/2004), Conservatorio
Statale di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, Anno Accademico
2004/2005.
MARTIN, Henry (1996) Charlie Parker and Thematic Improvisation, Scarecrow Press, Lanham, Maryland.
MIDDLETON, Richard (1990) Studying Popular Music, Open University
Press, Buckingham (trad. it. Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli, 1994).
— (2002) Lo studio della popular music, in Enciclopedia della musica, diretta da J.–J. Nattiez, con la collaborazione di M. Bent, R. Dalmonte e M.
Baroni, vol. II, Il sapere musicale, Einaudi, Torino, pp. 718–737.
Lo studio dell’improvvisazione jazzistica
61
POZZI, Egidio (2001) Concetto teorico e significato analitico delle successioni lineari: il Largo della Ciacona op. II n. 12 di Arcangelo Corelli, in
«Quaderni di Analitica», Supplemento al Bollettino del GATM, VII, 2,
pp. 47–74.
— (2003) Introduzione alle metodologie analitiche (I livello), Unità didattica
per il Master – Corso di Perfezionamento in Le culture musicali nel Novecento, a cura di Agostino Ziino e altri, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” – Consorzio B.A.I.C.R. Biblioteche Archivi Istituti Culturali di Roma, Roma, 2003, pp. 113.
RAVA, Enrico, RIVA, Alberto (2004) Note necessarie. Come un’autobiografia, Minimum Fax, Roma.
RUWET, Nicolas (1966) Méthodes d’analyse en musicologie, in «Revue belge
de Musicologie», vol. 20, pp. 63–90 (trad. it. Metodi di analisi in musicologia, in Ruwet, Linguaggio, musica, poesia, Torino, Einaudi, 1983).
— (1967) Musicologie et linguistique in «Revue Internationale des Sciences
Sociales», vol. XIX/1, pp. 85–93.
TREITLER, Leo (1974) Homer and Gregory: The transmission of epic poetry
and plainchant, in «The Musical Quarterly», vol. LX, pp. 333–372 (trad.
it. di C. Cimagalli, in Pozzi 2003, Appendice).
UGHI, Francesco (2004) Intervista a Enrico Rava, in
http://www.jazzitalia.net/articoli/int_enricorava.asp
Fabrizio Deriu
“Imitare, rifare, esaltare”.
Ipotesi interpretative intorno al fenomeno “tribute band”
A chi segue con attenzione la popular music in Italia (e non tanto la
produzione discografica quanto piuttosto quella attività diffusa e capillare che ha luogo nei locali dove si suona musica dal vivo) non sarà certamente sfuggito un fenomeno che negli ultimi tempi ha visto una notevole intensificazione, ovvero il proliferare di “cover” e soprattutto “tribute band”. A partire in primo luogo da un tentativo di definizione dell’oggetto e in secondo luogo da alcune considerazioni suscitate da una
polemica sviluppatasi in tempi recenti circa il successo del fenomeno,
questo intervento si propone di sviluppare una riflessione intorno ad alcune ipotesi interpretative (che possono peraltro preludere ad una più
ampia ed articolata ricerca “sul campo”). È opportuno avvertire che non
si tratta di ipotesi di natura musicologica in senso stretto, quanto piuttosto, per così dire, socio–culturale, collegate — per maggior precisione
— a quell’area di ricerca che nelle discipline dello spettacolo è chiamata
“teoria della performance”: l’esame e la riflessione intorno ai caratteri,
le implicazioni e i valori della dimensione esecutiva degli spettacoli dal
vivo nelle sue molteplice specie e manifestazioni, comprendenti a pieno
e pari titolo il teatro, la danza, la musica 1.
Cosa si intende per “cover band” e “tribute band”? E su cosa si basa la distinzione tra l’una e l’altra? Sul tema si rintracciano pareri discordi. Una discussione corretta può prendere le mosse da alcune definizioni rintracciabili su Wikipedia. The Free Encyclopedya: “cover
band” è «un gruppo musicale che suona soltanto cover, che possono
essere di un singolo artista o gruppo (una “tribute band”) o di molte
differenti fonti» 2. Il significato di “cover” nel gergo musicale è noto,
ma dal punto di vista della costruzione logica la frase appare come una
tautologia e un lettore inesperto di popular music non ne ricaverebbe
alcuna informazione; tuttavia ciascun termine compare come link alla
sua propria definizione e dunque è possibile sciogliere la tautologia
1
Per un bibliografia minima di riferimento (in italiano) sulla teoria della performance cfr. almeno Schechner 1984 e 1999; Turner 1982 e 1987; Deriu 1988.
2
Le traduzioni dall’inglese, qui e nelle seguenti citazioni da pagine di Wikipedia,
sono mie.
63
64
Fabrizio Deriu
aprendo il collegamento e agganciando i due brani. Si ottiene così la
seguente definizione: «cover band è una band che suona soltanto versioni cover, ovvero — nella pop music — nuove interpretazioni/esecuzioni di una canzone precedentemente registrata; che possono essere
di un singolo artista o gruppo (una tribute band) o di molte differenti
fonti». “Tribute band” starebbe dunque a “cover band” come una specie al genere; il criterio distintivo essendo dato dalle modalità di formazione del repertorio: selezione dei brani esclusivamente dalla produzione di un singolo artista/gruppo piuttosto che da una varietà di artisti/gruppi. Se però andiamo a leggere anche la voce “tribute band”
troviamo specificazioni più precise e qualche maggiore restrizione:
Tribute band è un gruppo musicale creato con il fine specifico di suonare la
musica di un gruppo noto, spesso un gruppo che si è sciolto o che ha smesso
di esibirsi. Dei membri di una tribute band non fa parte alcuno dei membri del
gruppo originale. La tipica “tribute band” si differenzia da una “cover band”
che semplicemente suona canzoni di altri artisti per il tentativo di catturare
ogni sfumatura dell’artista o gruppo imitato, riguardo al comportamento e al
modo di apparire, allo scopo di realizzare un’imitazione perfetta. Alcune “tribute band” pongono molta cura nell’imitare le apparenze ma re–interpretano
l’opera originale in un particolare genere o per ottenere effetti comici. Ad es. i
Dread Zeppelin suonano i Led Zeppelin in stile reggae con il cantante che
sembra Elvis Presley; oppure i Gabba eseguono le canzoni degli Abba nello
stile dei Ramones. Sviluppo del concetto di “tribute”. È ipotizzabile che le
prime “tribute band” siano state quelle dedicate ai Beatles, che cercavano di
apparire e suonare proprio come i Beatles nell’eseguire il loro repertorio. Si
potrebbero anche menzionare gli imitatori di Elvis Presley. Sebbene create inizialmente con l’intenzione di rendere omaggio ai gruppi originali, molte
“tribute band” sono cresciute al punto da avere la loro propria base di ammiratori (fan). […] Quei gruppi o artisti che hanno ispirato un culto seguito dai loro ammiratori tendono ad avere le loro “tribute band”, come i Kiss, i Grateful
Dead, Van Halen, gli Abba, i Rolling Stones e Neil Diamond.
Come tutte le classificazioni astratte anche questa presuppone l’esistenza di confini precisi fra tipi di fenomeni a se stanti, laddove nella
realtà situazioni, strutture e comportamenti tendono piuttosto a mescolarsi e confondersi. Ci sono comunque diverse questioni interessanti
sollecitate da queste definizioni. Ne segnalo sinteticamente solo alcune, per discuterne poi solo una. Esistono eccezioni notevoli al criterio
che esclude i membri dei gruppi originali (i Muffin Men ad esempio
suonano canzoni di Frank Zappa con membri dei Mother of Invention). Questo aspetto ne solleva un altro, anche più significativo, che
riguarda il tema del rapporto tra dilettantismo e professionismo. Esistono infatti “tribute band” formate da musicisti professionisti che la-
Imitare, rifare, esaltare
65
vorano anche in altri contesti (e suonano anche musica originale); altre
formate da musicisti “dilettanti” che fanno altri mestieri ma che suonano benissimo, a volte quanto i professionisti; altre ancora “ibride”,
composte in parte da professionisti in parte da “dilettanti”. Non è in
gioco qui, però, una questione di qualità musicale, quanto il fatto che
dinanzi al fenomeno la categorica distinzione tra dilettante e professionista appare tutto sommato superata, se non perfino irrilevante — e
di sicuro da formulare meno schematicamente [cfr. François 2002].
Non sarei infine così propenso ad enfatizzare l’aspetto scenico come
discriminante tra la classe dei gruppi “cover” e la classe dei gruppi
“tribute”. Altre fonti fanno una distinzione ancora più restrittiva: “tribute band” sarebbero solo quelle che di un certo artista/gruppo riproducono un periodo, un album, un momento preciso e limitato. Tuttavia
l’obiettivo principale di chi dà vita a una “tribute band” mi pare sia
quello di suonare (possibilmente bene e magari anche con qualche elemento di originalità nell’interpretazione) la musica che piace, non
tanto produrre pseudo–cloni buoni per programmi di trash–TV come
“La Corrida” e versioni aggiornate. Bisogna piuttosto chiedersi cosa
spinge sempre più musicisti (dilettanti e/o professionisti) a scegliere di
ri–fare il repertorio di un singolo artista/gruppo invece che concedersi
un ventaglio ampio di fonti da cui selezionare i brani (o semplicemente insistere nel proporre composizioni originali).
Negli ambienti degli addetti ai lavori è nata una vera e propria polemica sull’argomento, di cui si è fatto portavoce Giancarlo Passarella
(fondatore della associazione musicale e casa di produzione U.d.U. —
Ululati dall’Underground, considerato il massimo esperto del fenomeno). Riprendendo sul sito Musicalnews.com brani di una sua intervista
rilasciata al quotidiano La Stampa il 16 gennaio 2005 per un articolo
uscito in occasione del tour italiano dei Musical Box (un gruppo che
rifà i Genesis del periodo The Lamb Lies Down on Broadway) Passarella, in forma retoricamente interrogativa, lancia l’allarme: “Le cover
band uccidono il rock originale in Italia”?
Perché spuntano così tante “cover band”? Certo perché è più facile raggiungere un club che non cercare i biglietti per concerti lontanissimi e cari. Il nome
dell’artista fa agio su tutto. Però c’è già uno sfruttamento non corretto di questo fenomeno. Io ho dato voce al discorso delle cover band, ma i gestori dei locali mi hanno sfruttato e hanno cambiato la programmazione a danno del rock
italiano. Le cover band fanno sempre il pieno di spettatori e così i gruppi che
fanno musica propria non trovano più lavoro. Alcuni locali poi (nel torinese
come nel milanese) pagano pochissimo queste formazioni: 50 euro e una per-
66
Fabrizio Deriu
centuale sulle bevute, non parliamo poi di borderò Siae e neanche di Enpals.
Ma il gruppo pur di suonare ci sta. 3
A qualche mese di distanza affronta l’argomento anche il mensile
Il mucchio selvaggio, per mano del suo direttore Max Stefani, con interviste ancora a Passarella e ad Alex Petroni degli Achtung Babies
(nota “tribute band” degli U2). Nel darne notizia attraverso il suddetto
sito Passarella ora è perentorio: “Si riaccende la polemica sulle tribute
band che uccidono la musica originale”. Anche Stefani, pur senza allinearsi completamente con la condanna senza appello, sembra tutto
sommato d’accordo (ad esempio definendo quello delle “tribute band”
un «mondo sommerso e pittoresco»): «La copia di un artista sembra
funzionare dal vivo quanto l’originale: soprattutto in Italia da qualche
anno le cover band […] hanno sempre più pubblico. I gruppi spuntano
come funghi (soprattutto in provincia dove i concerti “veri” non arrivano) e ognuno può annusare il profumo degli U2 attraverso gli Achtung Babies o di Vasco Rossi con la Combriccola del Blasco o di
chi più gli piace, dai Pink Floyd ai Cure a Stevie Wonder» 4. È vero
che Passarella punta il dito soprattutto contro i gestori dei locali, cui
sembra attribuire le responsabilità più gravi rispetto a quelle dei musicisti; tuttavia a mio avviso non coglie nel segno quando ritiene che
“cover” e “tribute band” siano causa diretta della scomparsa (o almeno
del serio declino) della musica originale. O meglio: forse Passarella
non ha del tutto torto, ma il suo punto di vista non è di alcun aiuto per
comprendere le ragioni del gradimento che il fenomeno pare ottenere
(se piacciono così tanto e in modo così generalizzato — anche Stefani
non può nasconderlo — un motivo ci sarà).
In definitiva le domande cui mi parrebbe interessante dare risposte
potrebbero, molto semplicemente, essere formulate così: perché il fenomeno “cover/tribute band”? Perché questa diffusione e apprezzamento? E perché, poi, oggi e non quindici, venti o addirittura trenta
anni fa, in piena esplosione della cultura rock–pop? E ancora, quale
potrebbe essere, se c’è, il significato peculiare del fenomeno, la sua
potenziale valenza positiva in una prospettiva non solo musicale ma
più in generale culturale? Il primo passo da muovere consiste nel verificare cosa se ne pensa nell’ambito degli studi sulla popular music,
3
Tratta dall’articolo di M. Venegoni, Fenomeno cover band. Imitare, rifare, esaltare, in La Stampa, 16 gennaio 2005.
4
Cito dall’estratto dell’articolo di Stefani riportato da Passarella nell’editoriale di
Musicalnews.com del 10 aprile 2005.
Imitare, rifare, esaltare
67
consultando ad esempio Studiare la popular music di Richard Middleton, una sorta di “manuale di riferimento” per il settore [Middleton
1990]. L’autore tratta direttamente il fenomeno in un solo e breve passaggio (però molto interessante), ma lungo tutto il libro offre idee,
spunti, concetti e valutazioni che contribuiscono notevolmente alla
messa a fuoco delle idee sul tema. Il passaggio in questione si trova in
un capitolo il cui sottotitolo è “Tecnologia, politica e pop music in
un’epoca oltre la cultura di massa”, nel quale l’autore fa proprie le riflessioni di Walter Benjamin contro la condanna spietata e pregiudiziale di Adorno nei confronti della “musica di consumo”, e dove sostiene che, nonostante la forza dell’apparato socio–economico–tecnologico industriale che mira da un lato alla realizzazione del profitto e
dall’altro a fiancheggiare il potere politico, ci sono situazioni in cui
«talvolta si presentano delle alternative, che suggeriscono nuovi utilizzi per la tecnologia esistente» [Middleton 1990, trad. it. p. 129].
Principali esempi di queste situazioni sarebbero, tra altre, le “radio libere” e appunto le “cover band”, a proposito delle quali afferma:
Si è sviluppata una nuova pratica musicale basata sulla “copiatura” di dischi
da parte di gruppi che suonano nei locali e nei pub. Anche se “copie”, queste
esecuzioni, proprio perché sono esibizioni dal vivo, producono effetti diversi
dagli originali, sia nella musica sia nel significato sociale […] Queste esecuzioni creano inoltre una dialettica importante fra prodotto di massa e ri–
produzione locale. [Middleton 1990, trad. it. p. 129]
Giustamente Middleton ritiene che il fenomeno sia significativo
tanto dal punto di vista musicologico quanto da quello socio–culturale
(qui ci si soffermerà solo sul secondo aspetto, ma tenendo ben presente, in prospettiva, l’interdipendenza tra i due). In molte parti del saggio
egli sviluppa i suoi argomenti chiamando in causa la questione dei
rapporti fra oralità e scrittura, ovvero fra dimensione esecutiva e notazione nella musica: le risposte alle nostre domande credo vadano ricercate proprio in tale direzione; anzi — per maggior precisione —
passando attraverso una migliore riformulazione del tema che abbandoni la semplice dicotomia binaria a favore di una più complessa relazione fra tre termini: oralità, scrittura e registrazione (ovvero quel regime di esistenza del suono possibile grazie ai mezzi della riproducibilità tecnica, per dirla con la formula di Walter Benjamin, propria della
società industriale avanzata del XX secolo). Uno dei primi intellettuali
a segnalare alla consapevolezza critica dell’Occidente che a partire
dalla rivoluzione della tecnologia elettrica ed elettronica stava succe-
68
Fabrizio Deriu
dendo qualcosa di molto profondo e rilevante al nostro modo di percepire e organizzare l’esistenza esattamente in rapporto al conflitto fra
modalità orali e modalità scritte, è stato Marshall McLuhan. Nel suo
celebre Gli strumenti del comunicare l’autore canadese sostiene che la
tecnologia elettrica ed elettronica provoca un rivolgimento radicale rispetto alla tendenza espansionistica (lineare, frammentaria, accentrante e specialistica) che è propria della mentalità alfabetica che usa la
scrittura. La tecnologia elettrico–elettronica infatti favorisce piuttosto
una generale “implosione” (non–lineare, globale, decentrante e totalizzante). Si tratta, con uno slogan, della ben nota (perfino abusata) teoria della “retribalizzazione delle società industriali”, ovvero del “villaggio globale”. Ad un certo punto McLuhan afferma che i paesi e le
culture scarsamente permeati dalla mentalità meccanica e specialistica
associata alla scrittura si trovano oggi assai più preparati delle società
industriali ad affrontare l’“età elettrica”, e che al contrario «Le regioni
[…] da lungo tempo industrializzate, che hanno automaticamente eroso le proprie tradizioni orali, rischiano di doverle riscoprire per poter
affrontare l’età elettrica» [McLuhan 1964, trad. it. p. 32].
Il diffondersi di “cover” e “tribute band” va compreso, a mio parere, proprio come espressione di un tale recupero o riscoperta (o forse
ri–costituzione) di tradizioni orali (diciamo per ora ancora orali, ma
non senza segnalare con forza che la parola è insufficiente e inadeguata ad esprimere la complessità della questione). C’è una spinta diffusa,
profonda e solida in questa direzione, presente non solo nella musica
ma in tutte le arti della performance (ovvero le arti che prevedono costitutivamente esecuzione, anche in presenza di forme di scrittura).
Penso ad esempio, nel teatro, alla ripresa vigorosa del teatro di narrazione: Marco Paolini, Ascanio Celestini, Moni Ovadia e altri, con Dario Fo a fare da capofila [cfr. Guccini (a c.) 2005]. L’interesse suscitato da questi artisti non sta solo nella predilezione (frequente ma non
assoluta) di temi civili, ma principalmente nella scelta delle modalità
costruttive dei loro spettacoli che rinnovano, insieme a tecniche attoriali specifiche, anche il gusto e il valore politico — nel senso greco
antico: civile e collettivo — del teatro.
Il fatto che dei loro spettacoli esistano anche versioni registrate e
commercializzate, in nastri VHS o DVD, non è uno scandalo né una
degradazione: è anzi la norma dell’era attuale che giustappone, combina e intreccia oralità, scrittura e registrazione tecnica. È di questo intreccio che dobbiamo cercare di rendere conto, ripartendo forse proprio da Benjamin, il quale nel suo celebre saggio afferma:
Imitare, rifare, esaltare
69
Verso il 1900, la riproduzione tecnica aveva raggiunto un livello, che le permetteva, non soltanto di prendere come oggetto tutto l’insieme delle opere
d’arte tramandate e di modificarne profondamente gli effetti, ma anche di conquistarsi un posto autonomo tra i vari procedimenti artistici. Per lo studio di
questo livello nulla è più istruttivo del modo in cui le sue due diverse manifestazioni — la riproduzione delle opere d’arte e l’arte cinematografica — hanno
agito sull’arte nella sua forma tradizionale. [Benjamin 1936, trad. it. 21]
Benjamin ha in mente principalmente le arti visive, ma il suo ragionamento è applicabile anche alla musica (egli stesso include le incisioni discografiche nel novero delle “riproduzioni di opere d’arte”).
Ora, Benjamin capisce che con la “riproducibilità tecnica” si entra in
un’epoca radicalmente nuova della produzione e della trasmissione
delle opere d’arte (che peraltro mette in discussione la nozione tradizionale stessa di “arte”), ma non coglie a pieno che per comprendere a
fondo la natura e i caratteri di questa nuova epoca non è sufficiente
confrontarla con l’epoca che la precede. È necessario guardare ancora
più in là e tener conto anche di ciò che c’era prima (o al di fuori)
dell’epoca in cui si afferma la nozione tradizionale (occidentale) di
“arte”. Se, come ormai è accertato e accettato, il concetto di “arte” e le
pratiche ad essa relative sono da associare strettamente con la tecnologia della scrittura (e con la potente metafora epistemologica che essa
impone, ben al di là della mera operazione di rappresentazione visiva
del linguaggio verbale), questo significa, in sintesi, rivolgere l’attenzione a quella dimensione culturale umana che alla scrittura si contrappone dialetticamente: appunto l’oralità. Tuttavia nell’epoca attuale
della riproducibilità tecnica non si tratta (come a volte sembra invece
lasciar intendere McLuhan) di un semplice ritorno alla dimensione
orale. La riproducibilità tecnica (come osserva acutamente anche
Middleton) è infatti ambivalente e contradittoria: mentre da un lato estende la scrittura dal solo linguaggio verbale anche al suono, alla luce
(il visibile) e al movimento (il significato di parole quali fonografia,
fotografia, cinematografia non è infatti altro che scrittura — ovvero
fissazione/immobilizzazione — del suono, della luce, del movimento),
dall’altro lato simultaneamente nastri, dischi, film, cassette, e supporti
digitali esaltano la natura dinamica e fluida del suono e del movimento (proprietà caratteristiche della dimensione espressiva orale, rispetto
alla stabilità e alla silenziosità della scrittura). Secondo Middleton (e
non si può non essere d’accordo) questo fatto ha giocato un ruolo decisivo nella generale rivalutazione del momento esecutivo (cioè della
performance), a discapito del momento compositivo (legato appunto
70
Fabrizio Deriu
all’atto dello scrivere) dominante, anzi perfino assolutizzato, nell’epoca in cui prevalgono tecnologia alfabetica e tipografica (e questo è
valido per tutte le arti che prevedono costitutivamente esecuzione: teatro, danza, musica). Middleton discute quindi l’interessante riflessione
di Chris Cutler [1984], musicista e studioso di popular music, il quale
propone un’ambizioso schema storico «volto a illustrare nientemeno
— commenta Middleton — che l’intero sviluppo storico della musica
mondiale». Sarà pure ambizioso ma, nell’ottica in cui ci stiamo ponendo, assai sensato:
[Lo] schema comprende una serie di tre modi di produzione, ciascuno dominato
da un particolare mezzo di riproduzione (orecchio, notazione, registrazione).
Ognuno di questi mezzi è associato con un particolare tipo di società, rispettivamente la società “folk” (un contenitore piuttosto generalizzato di tutte le forme preborghesi), la società borghese, e la società (potenzialmente) socialista
(dato che il potenziale di media elettronici, in teoria, raggiunge il suo culmine
solo in un contesto egualitario senza divisioni sociali). Questo modello storico è
simile a quello proposto da Benjamin (epica “folk” — letteratura borghese —
riproduzione meccanica), eccetto che Cutler mette ancor più in rilievo il potere
determinante del mezzo di riproduzione. Quindi il modo “folk” nasce dai processi di trasmissione orale e di memoria biologica, e ciò vuol dire che i rapporti
fra musica e musicista, fra musicista e comunità, contenuto muscale ed espressione collettiva, sono diretti, non contraddittori e non alienati. Lo stesso discorso
vale per la composizione e l’esecuzione: chiunque vi può prendere parte, il fare
musica non è oggettivato in “opere” musicali ma è il risultato di variazioni improvvisate di risorse di proprietà collettiva. La notazione è una negazione del
modo folk. Essa mette in rilievo la vista, non l’udito, e quindi incoraggia il calcolo “razionale” di effetti e strutture unici e complessi e la manipolazione di gerarchie di parti strumentali, di unità formali e di ruoli esecutivi. La notazione
congela il lavoro musicale, lo incorpora in una forma tangibile, e quindi lo trasforma in una potenziale proprietà personale (e in un oggetto di consumo). Essa
conduce alla divisione del lavoro (fra compositore e esecutore, per es.),
all’individualismo e alla specializzazione, alla produzione per un mercato invece
che alla produzione da parte di una comunità. Chiaramente, afferma Cutler,
queste caratteristiche corrispondono ai bisogni della società borghese. In conclusione la registrazione — “la negazione di una negazione” — ci riporta all’orecchio, a uno stato in cui si registrano i suoni invece che configurazioni scritte,
in cui gli esecutori si trasformano in compositori e i compositori in esecutori, e
che richiede improvvisazione e produzione empirica collettiva. Quindi «tutte le
caratteristiche principali della registrazione fanno eco a quelle del modo folk»,
anche se sono cambiate qualitativamente. [Middleton 1990, trad. it. pp. 107–108
– corsivi dell’autore]
Cioè: non sono la stessa cosa. E giustamente Middleton ritiene insufficiente e forse perfino ingenuo darne spiegazione semplicemente
nei termini di una “retribalizzazione” indotta dall’era elettronica. È
Imitare, rifare, esaltare
71
necessario al contrario approfondire la complessa rete di somiglianze
e differenze tra modalità e tecniche orali da un lato e modalità e tecniche dell’era della registrazione dall’altro. O meglio tra i modi propri
delle culture ad oralità primaria (cioè completamente prive di scrittura) e i modi propri di culture — come la nostra — che hanno aggiunto
a quelle alfabetico–tipografiche dimensioni nuove e complesse di produzione, immagazzinamento e trasmissione delle informazioni, delle
conoscenze e delle creazioni artistiche [cfr. Ong 1982]. Queste nuove
modalità, come abbiamo già intuito, sfruttano le tecniche di registrazione (una specie moderna di tecnologia della scrittura) ma al contempo sono in rapporto con l’originarsi di forme e comportamenti propri
di quella che potremo chiamare una nuova specie di oralità (che temporaneamente potremo denominare post–alfabetica o forse post–tipografica). Ma non c’è dubbio, a mio parere, che la pratica della “copiatura” di dischi e brani di popular music da parte di gruppi che suonano
nei locali rientri a pieno titolo nel quadro di questa vasta e complessa
dinamica socio–culturale. Con una peculiarità, dovuta al fatto che si
suona — ovvero si ri–produce musica — non a partire da una forma–
modello notata ma da una forma–modello registrata.
Ma perché hanno successo le “tribute band”? E perché il fenomeno
esplode solo oggi e non prima? Ritengo che la risposta alla prima domanda dipenda dalla risposta che si dà alla seconda. Occorre fare attenzione alla storia della riproducibilità tecnica. L’invenzione delle
tecniche di registrazione del suono risale a più di cento anni fà (1877:
fonografo di Edison), ma ci vogliono decenni per la messa a punto e
l’utilizzabilità su vasta scala. Un grande impulso si ha nella seconda
metà del XX secolo quando lo sfruttamento commerciale delle possibilità tecniche di registrazione inventa e impone la cosiddetta cultura di
massa (di cui la popular music è parte organica, per definizione). Ma
proprio a ridosso del passaggio di secolo e di millennio si determina
una nuova condizione, e si può dire raggiunto un nuovo stadio, grazie
alla tecnologia informatica e digitale, i cui caratteri — rispetto alle omologhe tecnologie non digitali — hanno modificato in profondità il
mondo contemporaneo. Le tecnologie digitali (economiche, maneggevoli, permeanti) sono le principali responsabili dell’avvento di un’epoca storica come la attuale che Richard Schechner (un importante regista e teorico della performance americano), propone di chiamare
“neo–ellenistica”. Due ne sono i caratteri principali: un certo genere di
stile culturale euro–americano che si è esteso, imposto ed è stato ricevuto (più o meno con favore) da molta gente in molte parti del mondo;
72
Fabrizio Deriu
e una tendenza conservatrice/conservativa intellettualmente ed artisticamente. Questo non significa però, precisa Schechner, reazionaria o
priva di compassione, né incompatibile con la democrazia: è un conservatorismo basato sulla necessità di preservare, riciclare e usare parsimoniosamente le risorse e fondato sulla disponibilità di numerosi
“archivi” di differenti e acquisite esperienze, opere d’arte, idee, sentimenti, e testi; questa conoscenza immagazzinata (“stored”) e “richiamabile” (“recallable”) può essere usata sia per evitare il ripetersi di certi eventi sia per promuovere certe nuove specie di eventi [cfr. Schechner 1993, pp. 18–sgg.]. Se andiamo a verificare quali siano, secondo
gli storici dell’antichità greca, i caratteri dell’Ellenismo, scopriamo
che, schematicamente, essi sono riasumibili in quattro punti: a) la dilatazione della civiltà greca in un’area vastissima, che si configura come
una nuova specie di “colonizzazione” (grazie in particolare a un ceto
dominante greco o ellenizzato); b) la diffusione di una koiné (una lingua comune) ufficiale e burocratica; c) la mescolanza culturale, linguistica, religiosa; d) la spinta a raccogliere/catalogare/commentare libri in
modo sistematico e massiccio (legata all’implicita consapevolezza di
avere alle spalle una letteratura “classica” da tutelare e studiare) [cfr.
Canfora 2001, pp. 533–sgg.]. Le analogie, in effetti, sono impressionanti. Lasciando da parte le questioni pur importantissime sia della
“colonizzazione” (peraltro indiscutibile: la popular music non è soltanto il rock, ma in gran parte sì e il rock è un prodotto anglo–americano)
che della mescolanza linguistica culturale e religiosa, mi soffermerei
piuttosto sulla spinta alla creazione di “archivi”, incommensurabilmente favorita e accelerata appunto dalla duttilità delle tecnologie digitali, e
sugli effetti profondi e irreversibili che produce nel campo delle arti e
dei linguaggi artistici. Se ne è accorto anche un insigne e attento italianista quale Giulio Ferroni il quale già dieci anni fa scriveva:
[…] tutti gli organismi comunicativi […] sono oggi esposti a una memorizzazione, catalogazione, registrazione, archiviazione, che tende in qualche modo
a farli percepire come “chiusi”, come corpora testuali separati da altri corpora, sufficienti in se stessi. Più o meno variabile può essere il grado di apertura
di questi corpora, la possibilità di accrescerli e integrarli con nuovi testi: ma
l’effetto globale è che ciascuno di essi agisce come un sistema concluso,
un’enciclopedia definitivamente strutturata. Tutto ciò che è alle nostre spalle,
le scritture, le immagini, le testimonianze, i reperti del passato (un passato che
può essere anche quello di ieri, e che a volte coincide con un presente che
nell’atto stesso di porsi si dà già come passato), appare oggi destinato alla catalogazione e all’archiviazione; ogni tradizione, antica o recente, di lunga durata o di corto respiro, soggiace all’azione di una storiografia memorizzante,
Imitare, rifare, esaltare
73
alla titanica aspirazione a una ricostruzione–riproduzione del già dato che lo
cristallizza in una postuma fissità. L’informatica, con la formazione di banche–dati, con la creazione di giganteschi corpi testuali aperti a percorsi e combinazioni illimitate, sembra portare all’estremo questa disponibilità postuma
del già dato, questa riduzione di ogni forma culturale a organismo chiuso, destinato non a comunicare un’esperienza in atto, ma a essere guardato come a
un secondo livello, a essere riflesso in una visione “da dopo”. Ma questo approdo dell’informatica […] era in fondo già contemplato dallo sviluppo di una
storiografia tesa verso la ricostruzione sempre più completa, sempre più esauriente e “soddisfacente”. [Ferroni 1996, p. 134]
L’esaustività è in effetti una caratteristica delle “enciclopedie tribali”, ovvero il complesso di conoscenze, tradizioni, miti e tecniche delle culture ad oralità primaria. Naturalmente queste sono quantitativamente molto più limitate di quella delle società complesse come la nostra, ma la caratteristica è comune. E mai prima d’ora, nella civiltà occidentale, si era creata una condizione come quella attuale, in cui appare possibile la catalogazione/archiviazione potenzialmente totale dei
suoi prodotti culturali. Inoltre oggi, grazie alla potenza delle tecnologie digitali e alla capillarità delle reti informatiche che quelle consentono, esaustività si combina con accessibilità [cfr. Rifkin 2000]. Quasi
tutto lo scibile e quasi tutta la produzione intellettuale è disponibile in
Internet — o perlomeno rintracciabile attraverso Internet (nei negozi
online si trova quasi ogni cosa che si possa immaginare di voler cercare). Non sfugge la musica, che anzi è uno dei campi della produzione
e dell’attività culturale tra i primi (se non il primo in assoluto) ad essere stato investito dal fenomeno: si pensi al caso Napster.
Ora, stando così le cose, immagino che chiunque oggi abbia la pretesa di inventare nella popular music qualcosa di originale troverà il
giorno stesso qualcuno che gli farà presente che quella musica è già
stata suonata dal tale artista o gruppo trenta, quindici, cinque o anche
solo due anni fa. Naturalmente così viene meno la spinta all’originalità, che è sempre (per definizione) difficile da conquistare, ma risulta
completamente inibita e irraggiungibile quando il repertorio tradizionale — vale a dire ciò che si vorrebbe, conoscendolo, oltrepassare —
è così sterminato da aver pressoché quasi esaurito le possibilità; e soprattutto conosciuto e accessibile con grande facilità da ogni angolo
del mondo [cfr. Molino 2001]. Ad un meccanismo di cortocircuito del
genere mi sembra pensi Ferroni quando parla di una inarrestabile “saturazione della modernità”, tanto materiale quanto culturale, collegata
alla “fine delle avanguardie”, che contraddistingue l’epoca che stiamo
vivendo: «il movimento progressivo verso sempre nuovi traguardi, la
74
Fabrizio Deriu
spinta dello “sviluppo”, la creazione energetica del “nuovo”, la rottura
dei modelli culturali assestati, si scontrano con i limiti dello spazio fisico e mentale: la loro accelerazione è costretta a riavvolgersi continuamente su se stessa, a un’implosione che si moltiplica all’infinito»
[Ferroni 1996, p. 123]. Sul piano dei linguaggi artistici, conclude Ferroni, “saturazione della modernità” significa che «la ricerca del “nuovo” si è completamente arenata» [p. 126]. E possiamo perfettamente
capirne i motivi, in base a quanto stiamo argomentando: tutto, o poco
poco meno che tutto, è stato già detto, già raccontato, già dipinto, già
suonato, già filmato, già recitato — ed è disponibile per la consultazione in un qualche archivio online mediante un paio di clic col mouse
del computer. Ma, dato che per fortuna con la spinta all’originalità
non viene meno anche il bisogno di espressione musicale, ci si rivolge
allora positivamente al repertorio. Non solo, però, per fruirlo (ovvero
ascoltarlo), ma per ri–farlo, per ri–produrlo (il che non significa —
come vedremo — copiarlo). È il momento di dare la parola ad Alex
Petroni, degli Achtung Babies:
Hanno un senso i tributi? Andare ad ascoltare una band tributo che ripropone
esclusivamente il repertorio di una band famosa non è diverso che andare ad
ascoltare le opere di Bach o Mozart. Inoltre il desiderio di condividere la propria passione per un artista o per una band insieme ad altri fans ascoltando la
musica suonata dal vivo è indubbiamente molto più coinvolgente. Ovviamente, quando il tributo viene fatto da musicisti che hanno passione per quello che
suonano e sanno montare uno spettacolo professionale.
Non è frustrante per un musicista suonare sempre le stesse cose, per di più
non di propria composizione? No, esattamente come non è frustrante per un
attore recitare una parte. Il repertorio degli U2 è vasto, le situazioni e i modi in
cui lo suoniamo sono alla fine sempre diverse, come ogni volta è diverso il
pubblico ed ogni concerto quindi è sempre una scommessa. Da tre anni inoltre
abbiamo allargato le possibilità di esibizione. Proponiamo il repertorio degli
U2 in versione unplugged, e questo oltre ad essere una particolarità poiché i
brani assumono un fascino molto diverso dal solito (tra l’altro gli U2 non hanno mai fatto un’intera esibizione acustica) ci ha fatto conoscere un modo nuovo e divertente di contatto con il pubblico. Inoltre l’esibizione è sempre accompagnata da un dialogo diretto e da un commento o presentazione dei brani
che spesso diventano un vero confronto con il pubblico, che partecipa in modo
diretto e a volte si è quasi arrivati al dibattito. Molto divertente.
I tributi rubano spazio e possibilità di esibirsi a coloro che invece compongono musica originale? La possibilità di suonare dal vivo a coloro che suonano
musica originale è stata tolta dalla gente, non dai tributi. Se la gente preferisce
i tributi affollando i locali e disertando le manifestazioni di musica originale
forse è perché non c’è molta qualità o forse perché non c’è tutta questa originalità. Andare a sentire una band dal vivo che si dichiara originale e poi sentire il cantante che canta imitando Piero Pelù o tutta la band che suona esatta-
Imitare, rifare, esaltare
75
mente con gli stessi inconfondibili suoni dei Cure o dei Queen, insomma la
trovo un po’ una presa in giro.
Crisi di personalità? Non scherziamo. Ci teniamo alla nostra personalità, e
concentrarsi sul personaggio va bene per quelle due ore che si sta sul palco per
giocare con il pubblico. Anche durante il concerto facciamo dell’ironia e cerchiamo di sottolineare lo spirito con cui facciamo lo spettacolo. Paradossalmente, ci teniamo a sottolineare che gli Achtung Babies esistono proprio per
dimostrare che gli U2 sono inimitabili; non a caso il nostro slogan è “Achtung
Babies: nothing compares U2”. 5
Le considerazioni di Petroni mi sembrano particolarmente interessanti. E non tanto (o non solo) là dove esprimono opinioni di segno
opposto rispetto a quelle di Passarella a proposito delle “tribute band”
che toglierebbero spazio alla musica originale, quanto perché offrono
spunti di sostegno alle ipotesi che stanno prendendo forma. Il resoconto che Petroni fornisce dell’attività di una seria “tribute band” e in particolare del momento del concerto è pieno di indizi circa il fatto che si
tratta di pratiche tipiche delle culture orali. O meglio: di pratiche che
noi conosciamo attraverso quello che sappiamo delle culture orali, ma
che dovremo in futuro spiegare tenendo conto di quel che avviene dove all’oralità si aggiungono e si integrano scrittura e registrazione.
Rimandando il necessario approfondimento ad altra occasione, qui c’è
lo spazio solo per segnalare alcune significative analogie.
La bussola che guida questo passaggio è costituita dal pensiero di
Eric Havelock, uno studioso di letteratura greca antica, e in particolare
la sua magistrale analisi della nota critica platonica contro la poesia e
le arti e contro colui che ancora all’epoca di Platone rappresentava la
fonte somma e autorevole del sapere in Grecia, cioè Omero e i poemi
epici a lui attribuiti [Havelock 1963]. Per primo Havelock intuisce che
la polemica platonica è comprensibile solo in rapporto allo stato orale
delle tecniche di comunicazione dell’epoca pre–platonica (mentre il filosofo appartiene invece ormai a un periodo che ha acquisito l’uso
della scrittura), e la conclusione cui lo studioso giunge dice che la
condanna di Platone non è rivolta alla poesia e alle arti in sé, quanto
piuttosto contro certe caratteristiche proprie delle modalità orali di esistenza ed esecuzione della poesia. In pratica Platone attacca quello
che noi oggi (Havelock usa esattamente questo termine) chiamiamo
performance (non solo lo spettacolo in sé, ma la mentalità, il tipo di
saperi connaturati allo stato orale di esistenza della cultura). Il grimal5
Cito dall’estratto dell’intervista riportato da Passarella nell’editoriale di Musicalnews.com del 10 aprile 2005.
76
Fabrizio Deriu
dello della critica platonica è, come è noto, il concetto di mìmesis.
Poiché — dice Platone — la verità è nelle idee, e le cose che esistono
nella realtà sono solo “copie” ovvero “imitazioni” delle “idee”; il poeta, che produce “imitazioni” delle cose della realtà, ovvero “imitazioni
di imitazioni”, sta due volte lontano dalla verità, e perciò deve essere
bandito dalla Repubblica, cioè dalla società civile, e in special modo
deve essere interdetto da compiti educativi (che invece aedi e rapsodi
— cioè poeti, cantanti, narratori — svolgevano istituzionalmente in
Grecia fino all’epoca platonica). Ma questa accezione spregiativa di
mìmesis altro non è che il frutto della teoria platonica. Nella Grecia
arcaica, spiega Havelock, quella dove Omero e la poesia epica sono le
massime e riconosciute autorità culturali, mìmesis ha al contrario un
netto valore positivo: il termine indica in ultima istanza, al di là di tutte le accezioni particolari che può ricevere, «l’atto totale della rappresentazione poetica», l’azione del poeta che non solo racconta ma si identifica con i personaggi e le vicende di cui narra (e produce nell’uditorio medesima identificazione) 6. Così sintetizza Bruno Gentili nell’introduzione all’edizione italiana del saggio di Havelock:
In questa situazione [di pubblicazione e trasmissione esclusivamente orale del
sapere], l’attività del poeta si configurava come una vera e propria performance durante la quale egli mimava al ritmo di versi e della musica l’azione mitica. Un tipo di esecuzione che, proprio per il suo carattere mimetico–mitico,
non lasciava inerte lo spettatore, ma, attraverso il piacere psico–somatico inerente gli aspetti visivi e auditivi, cioè gestuali e ritmico–musicali, dello spettacolo, lo coinvolgeva sino a renderlo partecipe ed attore stesso dell’azione mimetica. [Gentili 1973, p. IX]
Nelle culture orali la performance poetica dell’aedo (del cantastorie, dello sciamano, del sacerdote) non è un fatto estetico né ludico (o
meglio: mai puramente estetico e/o puramente ludico): è soprattutto lo
strumento per mezzo del quale i cittadini, e i giovani in particolare, si
appropriano del sapere collettivo della comunità (sapere religioso, giuridico, scientifico e perfino tecnico). E nell’unico modo disponibile:
assistendo a una performance mimetica, laddove mìmesis è appunto
«ri–produzione ovvero ri–attualizzazione, attraverso la parola e il gesto del poeta, di un evento mitico». Ora a me pare, senza retorica né
esagerazione, che la formula appena citata tra le virgolette descriva
bene qualcosa di ciò che accade nella pratica delle “cover” e “tribute
6
Cfr. i capp. II e III (e in particolare la nota 22 al cap. III) di Havelock 1963.
Imitare, rifare, esaltare
77
band” 7. Avverto, ad una certa profondità, una analogia significativa
(il cui scioglimento consentirebbe di mettere in evidenza anche le ovvie differenze; e le specificità: ad esempio, di quali “eventi mitici”
verrebbe proposta la ri–attualizzazione? E in cosa consisterebbe la loro dimensione mitica?) 8. Ma intanto credo si possa affermare che il
fenomeno si diffonde perché è finita l’era moderna regolata dalla tecnologia della scrittura alfabetico–tipografica (che apprezza l’originalità, svaluta la copia e dunque scoraggia l’imitazione) ed è cominciata un’era post–moderna che non teme l’imitazione (però nel senso
greco pre–platonico), se questa è usata come strumento di processi reali di appropriazione della musica. La nostra epoca deve fare i conti
con tecnologie nuove sempre più potenti e invadenti; e ciononostante
non può rinunciare a trovare modi per non farsi da queste completamente schiacciare. Middleton dedica ampio spazio al tema: a come
opporsi alla standardizzazione e all’acquiescenza passiva sia mediante
quello che chiama il “pensiero conscio” (la critica razionale) ma anche
mediante l’esercizio di “prassi critiche”: forme di appropriazione consapevole dei “prodotti” (ovvero delle “merci”) dell’industria culturale
in vista di un un loro uso attivo e continuo (da cui nascono tradizioni):
In qualsiasi momento vi sia divisione del lavoro musicale, emerge la questione della risposta alla produzione da parte di coloro che sono collocati nella
parte inferiore della catena di produzione (che siano diffusori, interpreti, ri–
creatori, partecipanti o ascoltatori): sarà appropriazione, accettazione, tolleranza, apatia o rifiuto? In presenza di una stratificazione culturale, e quindi di
musiche alternative, la questione diventa più pressante: da dovunque provenga
questa musica, la faccio mia, la rifiuto come qualcosa di estraneo o la consu7
Non mi pare un caso né un abbaglio che Havelock, nel capitolo intitolato “Psicologia dell’esecuzione poetica” cerchi di spiegare la materia al lettore occidentale moderno
con il seguente paragone, solo apparentemente sorprendente: «Nella nostra moderna civiltà la situazione più vicina a quella greca potrebbe trovarsi nell’effetto che producono
sulla memoria popolare i versi accompagnati da motivi musicali di successo, e registrati
e riprodotti meccanicamente. Particolarmente stretta è l’analogia fornita dal jazz e da altri ritmi di danza, nella misura in cui questi vengono sposati a parole che sono quindi ricordate» [Havelock 1963, trad. it. p. 121].
8
L’adeguata trattazione della questione è qui impossibile per ragioni di spazio, ma
certamente non può essere evitata. La definizione ripresa da Wikipedia terminava sottolineando che le “tribute band” nascono principalmente intorno a quei gruppi e artisti
«che hanno ispirato un culto seguito dai loro ammiratori» (e al centro di un culto c’è naturalmente un nucleo mitico). Ma si può dire di più: le “tribute band” nascono come espressione del culto, sua parte integrante. E il culto, per essere tale, ha bisogno di esprimersi in forme rituali, ovvero performative (sull’importanza del rituale in questa prospettiva, mi limito a rimandare a Schechner 1993).
78
Fabrizio Deriu
mo con più o meno entusiasmo? La musica veramente autentica è la musica di
cui ci si appropria, la musica che viene integrata in una pratica sociale soggettivamente motivata. [Middleton 1990, trad. it. 198]
Il fenomeno delle “cover/tribute band” mi sembra un esempio originale e significativo di tali “prassi critiche”, degno di non superficiale
considerazione. L’integrazione che avviene attraverso un “ri–fare”, infatti, non può essere equiparata al semplice ascolto (o “consumo”),
poiché mette in gioco una serie di aspetti e dimensioni (artistiche e
culturali) assai complessi, articolati, ricchi di senso e di valore, che
chiedono di essere riconosciuti e apprezzati.
Imitare, rifare, esaltare
79
Riferimenti bibliografici
BENJAMIN, Walter (1936) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen
Reproduzierbarkeit, in «Zeitschrift für Sozialforschung», V, (trad. it. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi,
1966, pp. 18–56).
CANFORA, Luciano (2001) Storia della letteratura greca, Roma–Bari, Laterza.
CUTLER, Chris (1984) Technology, Politics and Contemporary Music: Necessity and Choice in Musical Forms, in «Popular Music», 4, pp. 279–
300.
DERIU, Fabrizio (1988) Il paradigma teatrale. Teoria della performance e
scienze sociali, Roma, Bulzoni.
FERRONI, Giulio (1996) Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Torino, Einaudi.
FRANÇOIS, Pierre (2002) Professionisti e dilettanti, in Enciclopedia della musica, diretta da J.J. Nattiez, Torino, Einaudi, vol. II, Il sapere musicale,
pp. 552–572.
GENTILI, Bruno (1973) Introduzione, in Havelock, 1963, trad. it., Roma–Bari,
Laterza, pp. IX–XV.
GUCCINI, Gerardo (a c.) (2005) La bottega dei narratori, Roma, Dino Audino
Editore.
HAVELOCK, Eric (1963) Preface to Plato, Cambridge, Mass., Harvard University Press (trad. it. Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a
Platone, Roma–Bari, Laterza, 1973).
MCLUHAN, Marshall (1964) Understanding Media, New York, McGraw–
Hill, 1964 (trad. it. Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore,
1967; citazioni dall’edizione Garzanti, 1977).
MIDDLETON, Richard (1990) Studying Popular Music, Buckingham, Open
University Press (trad. it. Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli,
1994).
MOLINO, Jean (2001) Tecnologia, globalizzazione, tribalizzazione, in Enciclopedia della musica, diretta da J.J. Nattiez, Torino, Einaudi, vol. I, Il
Novecento, pp. 767–782.
ONG, Walter (1982) Orality and Literacy. The Technolocizing of the Word,
London and New York, Methuen (trad. it. Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, Il Mulino, 1986).
RIFKIN, Jeremy (2000) The Age of Access, Penguin Putnam Inc – © J. Rifkin
(trad. it. L’era dell’accesso, Milano, Mondadori, 2000).
SCHECHNER, Richard (1984) La teoria della performance 1970–1983, a cura
di V. Valentini, Roma, Bulzoni (antologia di saggi).
— (1993) The Future of Ritual. Writings on Culture and Performance, London and New York, Routledge (trad. it. parziale in Schechner, 1999).
80
Fabrizio Deriu
— (1999) Magnitudini della performance, a cura di F. Deriu, Roma, Bulzoni
(antologia di saggi).
TURNER, Victor W. (1982) From Ritual to Theatre, New York, PAJ Publications (trad. it. Dal rituale al teatro, Bologna, Il Mulino, 1986).
— (1987) The Anthropology of Performance, New York, PAJ Publications
(trad. it. Antropologia della Performance, Bologna, Il Mulino, 1993).
Bruno Gioffrè
Dalla manifestazione del suono alla musica
(alla logica, alla forma, alla mente…)
Introduzione
In questa riflessione su alcuni aspetti della popular music, l’attenzione è centrata principalmente sul concetto di sound. Sound inteso
non riduttivamente come singolo parametro timbrico, ma come manifestazione integrale del suono, come somma di tutti i suoi parametri.
A partire da alcune osservazioni di carattere etnomusicologico e riguardanti il rapporto di alcune musiche con i media sarà possibile
considerare un percorso che esalta il sound come la principale espressione del continuo processo di cambiamento, delle contraddizioni e
delle complessità della popular music.
Una sintetico esempio di interazione fra analisi e sintesi nell’indagine sul ritmo musicale cercherà di indicare, oltre al metodo di studio
preso in considerazione, uno spunto a considerare le articolazioni dei
parametri come solidamente strutturati nei sound della popular music.
Popular music e musica dei media
Intendendo la popular music quale fenomeno musicale di larga diffusione, prodotto per la distribuzione tramite mezzi di comunicazione di
massa come il disco, il CD, la radio, la televisione, ecc., importanza rilevante assume la nozione di musica dei media 1. Per una sua definizione è necessario risalire all’invenzione del fonografo a cilindri ad opera
di Thomas Alva Edison nel 1877. Tale strumento, che permetteva per la
prima volta di registrare e quindi riprodurre il suono, catturandolo e fissandolo su un supporto, segnerà i destini della musica. Ascoltare un evento musicale senza dover necessariamente essere presenti nel luogo e
nel tempo del suo avvenimento era per la prima volta possibile, separando strutturalmente l’ascolto dalla visione dell’evento stesso.
1
La definizione qui indicata seppur vicina alla categoria tecnologico–economiche
così come la propone Birrer [1985], se ne differenzia per il punto di vista centrato sul
concetto di Sound, di seguito affrontato.
81
82
Bruno Gioffrè
Uno dei primi utilizzi del fonografo in ambito musicale fu rivolto,
oltre che alla registrazione di esecuzioni musicali in genere, in particolar modo alla registrazione di musiche di tradizione orale, musiche
non scritte, che lo studioso, il ricercatore, registra per fissarne la realtà
fisica di evento sonoro. Nascono conseguentemente agli inizi del Novecento diversi archivi fonografici (Vienna, Berlino, S.Pietroburgo)
rivolti allo studio delle lingue, dei dialetti e della musica. Prima del
fonografo l’annotazione delle musiche di tradizione orale veniva realizzata dallo studioso direttamente durante l’evento, traducendo su
pentagramma la propria e soggettiva interpretazione di ciò che ascoltava, senza che se ne potesse mai più effettuare verifica alcuna. La registrazione sonora realizzava invece per la prima volta un testo, una
oggettivazione dell’evento sonoro. Naturalmente per lo studioso di allora ciò era di portata fondamentale, perché rendeva possibile un processo di indagine e di analisi del suono fissato [cfr. Adamo 1996].
Ma anche così permangono nel processo di trascrizione diversi
problemi: oltre alla soggettività dell’interpretazione, risalta l’insufficienza del sistema notazionale occidentale nel rappresentare adeguatamente parametri quali glissati, vibrati, attacchi, dinamiche, timbri,
ecc. Così come il “dubbio semiografico” davanti ad una musica indigena non permette al trascrittore che arbitrarietà riduttive, ad esempio
nel caso di attenzione di un indigeno verso il timbro più che verso
l’altezza di una nota. I primi sforzi nel tentare una trascrizione oggettiva furono compiuti negli anni venti presso il Dipartimento di Psicologia della State University dello Iowa, diretto da Carl E. Seashore. Il
metodo impiegava una Sound Photography Camera, strumento che
permetteva di fotografare il suono, e che fu utilizzato per uno studio
sull’intonazione nei canti degli afro–americani [Metfessel 1928]. Su
tale studio, pietra miliare dell’etnomusicologia che pone in luce i limiti della tradizionale notazione occidentale, Carl Seashore afferma:
Tra i vantaggi di questo metodo vi è, in primo luogo, il fatto che produce una
registrazione ingrandita e permanente in grado di mostrare i dettagli minuti
nei cui termini possiamo rendere pienamente conto del canto, fino alle più minute caratteristiche dell’espressione emozionale, poiché tutto ciò che il cantante trasmette all’ascoltatore viene trasmesso nelle onde sonore, e questa registrazione fornisce un quadro ragionevolmente adeguato della successione delle onde sonore. In secondo luogo, ci fornisce la base per una terminologia
scientifica descrittiva dell’esecuzione musicale di cui si ha un grande bisogno
per sgombrare il campo dalla spazzatura della corrente descrizione musicale,
letteraria, e persino antropologica della musica, effettuata nei termini di concetti non definiti. [Seashore 1928, p. 8]
Dalla manifestazione del suono alla musica
83
Come ha spesso messo in risalto Charles Seeger [1958], la rappresentazione grafica di alcuni parametri del suono dà un notevole apporto descrittivo dell’evento musicale — cioè rappresenta suoni che ci
sono già — laddove la notazione tradizionale è invece uno strumento
fondamentalmente prescrittivo — cioè fornisce indicazioni su suoni
ancora da produrre.
Dalle prime registrazioni in studio allo studio delle registrazioni
Negli anni successivi migliorarono notevolmente la qualità degli
strumenti di registrazione e le tecniche di “cattura” del suono, e sparirono alcune limitazioni del fonografo. Il disco per grammofono, ad esempio, poteva essere facilmente prodotto in serie tramite stampaggio,
cosa invece difficilmente ottenibile con i cilindri del fonografo. La
possibilità di una facile duplicazione industriale portò, già nei primi
decenni del Novecento, ad un’enorme diffusione del disco in buona
parte del mondo.
La banda di frequenze riproducibile dal disco, per quanto limitata,
permetteva tuttavia una buona riproduzione nel registro medio. Non è
un caso che uno dei più famosi artisti del disco fosse in quegli anni
Enrico Caruso: la dinamica della sua voce e il relativo ambito delle
frequenze ben si sposavano con le limitazioni del disco. Inoltre le dimensioni del nuovo supporto permettevano registrazioni ininterrotte di
circa tre minuti: la durata più o meno di una romanza. È chiaro che la
scelta di cosa registrare avveniva fondamentalmente sulla base di tali
presupposti; dunque strumenti voci e pezzi con una certa sonorità, intensità, registro, durata, ecc., in grado di permettere una riproduzione
che “suonasse”. Nel 1917 la Original Dixieland Jass Band fu convocata in studio dalla casa produttrice Columbia per incidere alcuni famosi
brani da pubblicare, ma i brani registrati non risultarono soddisfacenti
e quindi non vennero stampati. Un mese dopo però ci riprovò un’altra
casa produttrice, la Victor, che fece registrare alla Band alcuni brani
del suo repertorio. Ritenuto “suonabile”, Dixieland Jass One Step fu il
primo disco jazz, e un eccezionale successo commerciale.
Da strumento di registrazione “documentaristico” il disco diventa
pian piano uno strumento di produzione musicale vero e proprio. L’invenzione del microsolco estende il campo di frequenze registrabili, sia
verso il grave sia verso l’acuto permettendo una maggiore fedeltà di
riproduzione. Le tecniche in studio diventano più raffinate; l’intro-
84
Bruno Gioffrè
duzione del mixer e del registratore a nastro multitraccia per fissare,
montare ed elaborare i suoni diventano strumenti fondamentali per realizzare un missaggio che “suoni”, ed ottenere il master da trasferire
successivamente sul disco matrice per la stampa dei microsolchi.
I musicisti, i produttori, gli ingegneri del suono e i tecnici di studio
iniziano a comprendere che il sound è un elemento fondamentale per
la riuscita commerciale di un disco. Essi prestano sempre più attenzione alla manifestazione del suono nei media di riproduzione, (juke–
box, disco, radio, ecc.), e costruiscono nuove sonorità. Danno così vita
a generi, stili, modi di esecuzione utilizzando lo studio di registrazione
quale ulteriore e fondamentale strumento di produzione musicale.
Joni Mitchell ad esempio, con il suo angelico falsetto, ha usato lo
studio di registrazione come un confessionale. Pur avvolgendo la sua
musica di toni orchestrali e colorandola con contributi del nuovo jazz
(Jaco Pastorius, Larry Carlton, Mike Gibbs e Charles Mingus collaborarono alle sempre più sofisticate canzoni) è il particolare uso del timbro vocale, raccolto in studio, il vero segreto della raffinatezza e della
sensualità delle sue canzoni. Così come lo è del canto struggente e
rauco di Mercedes Benz di Janis Joplin, un minuto e venti secondi di
solo canto di una voce aspra e dura…
Altro esempio: i Beach Boys guidati da Brian Wilson, e il metodo in
studio ispirato agli “strati sonori” del produttore Phil Spector. Risultato
di tale approccio rivoluzionario fu Pet Sound, album del 1966, considerato da molti il più grande e influente album nella storia del rock.
E ancora l’album Let It Be dei Beatles (1970), pure affidato a Phil
Spector, diventa tutto il contrario dell’idea originaria, tanto che nel
2003 Paul McCartney, mai contento del risultato originale, mette mano ai materiali originali revisionandoli radicalmente e realizzandone
una nuova edizione, Let It Be… Naked, con un sound del tutto nuovo.
Ed è con il “Liverpool Sound” dell’album Please Please Me del 1963
che i Beatles, da compositori di facile pop, diventano in studio inventori di una musica mai ascoltata prima con Sgt. Pepper’s del 1967.
Di alchemica materia vibrano lavori quali Sgt. Pepper’s dei Beatles, Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd (1973), OK Computer dei
Radiohead (1997), la cui nota irreplicabilità è da attribuire alla difficoltà/impossibilità di ricreare quel “totale sonoro” costruito in studio.
Anche nel jazz lo studio di registrazione diventa uno strumento
musicale: gli album In A Silent Way e Bitches Brew di Miles Davis,
del 1969, sono realizzati dal produttore Teo Macero rimontando i materiali registrati in una fase successiva alle sedute di registrazione, con
Dalla manifestazione del suono alla musica
85
un lavoro sul nastro magnetico (tagliando e incollando parti di nastro
come la musica concreta da tempo aveva sperimentato) che reinventa
così strutture, temi e groove dei brani.
Non possono mancare da questa rapida rassegna Frank Zappa e la
computer music per cucire/incollare parti strumentali prese da diversi
pezzi di registrazioni, e non necessariamente dello stesso brano. Tale
procedimento, definito dallo stesso Zappa come «xenochrony», è alla
base dell’album Jazz From Hell del 1986, realizzato quasi interamente
da solo al Synclavier e «libero della schiavitù di musicisti pigri e sciatti». E analogo carattere presenta anche il disco The Perfect Stranger del
1984, con Pierre Boulez e l’Ensemble Intercontemporain.
L’elenco potrebbe continuare per molte pagine ancora, fino a comprendere il punk dei Sex Pistols, il grunge dei Nirvana, il reggae di
Bob Marley e altri generi (dal funk allo hip hop, alla techno, al crossover, etc.), caratterizzati ciascuno da un’espressione individuale, da un
proprio paesaggio sonoro, da una musica che è sempre più attenzione
rivolta al suono e sempre meno organizzazione formale prestabilita.
L’analisi acustica
Il ruolo di rilievo assunto dal parametro sound, inteso non semplicisticamente e riduttivamente come colore, bensì come esistenza fisica
ed energetica del suono, nell’interagire di tutti i suoi parametri, come
realtà sonora percepita in quanto esperienza attraverso le vibrazioni, è
a mio avviso un elemento di fondamentale importanza per l’indagine
sulla popular music.
Purtroppo i metodi musicologici, con la centralità della notazione,
tendono a privilegiare i parametri musicali che possono essere annotati
secondo la scrittura tradizionale: quindi altezze discrete, durate che
perseguono una logica matematica, raggruppamenti di voci e strumenti,
ecc. Ma così tralasciano o ignorano completamente parametri non notabili come altezze non temperate, inflessioni delle altezze, durate irrazionali, sfumature di espressione, caratteristiche timbriche, tecniche tipiche di studio, ecc. In tal caso «una mentalità legata alla notazione e
applicata a questi contesti musicali non può che alterare profondamente
ciò che vi avviene realmente» [Middleton 1990, trad. it. p. 155], poiché
assegna maggior rilievo ad aree ritenute importanti per la musica classica, ma che non sono necessariamente importanti per la popular
music. Osserva a tal proposito Middleton che «il ritmo, la gradazione
86
Bruno Gioffrè
delle altezze, il timbro e tutto l’insieme di tecniche di articolazione
dell’esecuzione sono spesso di maggior rilievo» [Middleton 1990, trad.
it. p. 153]. Nella popular music la relazione partitura/oggetto sonoro
appare letteralmente invertita, in quanto il testo è l’oggetto sonoro e
non la sua notazione. Anche nei casi di popular music presente in forma scritta, «i parametri non notazionabili sono spesso di importanza
fondamentale […] viceversa i parametri notazionabili sono spesso di
importanza minore» [Middleton 1990: trad. it p. 155]. Per osservare la
popular music è necessario quindi sviluppare approcci differenti e metodi diversi da quelli impiegati solitamente dalla musicologia.
Un punto di partenza per una chiave di lettura della popular music
quanto più possibile oggettivo e neutro è rappresentato dall’analisi del
suono quale dato fisico, manifestazione di un evento musicale che
come tale arriva alla mente. Per chiarire questo concetto, fondamentale nodo semiologico, può essere utile far riferimento al modello proposto da Nattiez–Molino che considera, secondo il seguente schema:
Figura 1
1. una dimensione poietica, quale insieme di strategie per un processo
creativo finalizzato alla realizzazione di una cosa: l’opera;
2. una dimensione estesica relativa alle strategie e modalità di percezione del prodotto dell’attività poetica;
3. e un oggetto materiale fra i due processi, che non esiste pienamente
se non quando si manifesta ai sensi.
Tra processo poietico e processo estesico esiste quindi una traccia
materiale che non è portatrice in se stessa di significati immediatamente leggibili, ma senza la quale il(i) significato(i) non potrebbe(ro)
esistere». In tal senso l’opera, nella sua dimensione sonora, è lecitamente considerabile un oggetto materiale di livello neutro di cui «si
può fornire una descrizione oggettiva, cioè una analisi delle sue pro-
Dalla manifestazione del suono alla musica
87
prietà e delle sue configurazioni immanenti e ricorrenti» [Nattiez
1987a, trad. it. p. 10]. È quindi «compito dell’analisi del livello neutro
descrivere l’organizzazione immanente dell’oggetto, e questa si dice
neutra perché è una descrizione non necessariamente dotata di pertinenza poietica o estesica» [Nattiez, 1987b, p. 4].
Per quanto sopra esposto, l’analisi acustica in quanto indagine sul
suono può essere considerata analisi del livello neutro. Sulla base dei
dati rilevati dall’analisi, è possibile avanzare delle ipotesi su quali siano i tratti materiali pertinenti, cioè significativi, rispetto al processo
poietico o al processo estesico:
A partire cioè da quanto si rileva nella descrizione fisica degli eventi musicali,
è possibile chiedersi se e in che modo determinati tratti caratteristici — rapporti di frequenza, configurazioni dello spettro armonico, rapporti di durata,
ecc. — siano significativi rispetto alle percezioni e concettualizzazioni musicali di chi quella musica produce o ascolta [Adamo 1996, p. 8]
Un esempio di analisi: lo swing dei boppers
A titolo esemplificativo, in relazione ad alcuni punti e aspetti precedentemente messi in rilievo, è opportuno a questo punto osservare
in pratica un esempio di analisi che tiene conto di vitali parametri sonori dell’oggetto di indagine: lo swing dei boppers.
Da non confondere con la musica della “swing era”, il termine swing
qui è inteso come specifica fluidità, scorrevolezza, morbidità del fraseggio di alcuni musicisti jazz degli anni quaranta. Una definizione dello
swing in tal senso è molto generica; e anche le affermazioni dei musicisti
a tal proposito si limitano ad osservare che esso non può essere trascritto
né tantomeno può essere descritto con le parole; il miglior modo per dire
cosa è lo swing è suonarlo, se lo si sente (e analogamente si muovono altre definizioni per lo più metaforiche). Il concetto di swing appare quindi
alquanto vago, e difficile risulta coglierne l’essenza.
L’analisi acustica delle registrazioni di brani storici, carichi di
swing, potrebbe permettere, sulla base dei dati rilevati, di avanzare
delle ipotesi, da verificare, sulla pertinenza dei tratti responsabili della
sensazione percepita di swing.
«Quaerendo invenietis» 2. Si tratta qui, come spesso accade, di indagare alla cieca per raccogliere i dati e formulare una ipotesi, che va
2
“Cercando troverete”. Questa massima di Johann Sebastian Bach che invita a cercare, riconoscere, svelare indizi annotati in forma criptata all’interno delle proprie composizioni, appare nel titolo di un canone dell’Offerta musicale.
88
Bruno Gioffrè
poi verificata in un ulteriore ricerca; cioè l’esatto contrario del procedimento che parte da una ipotesi di ricerca a priori, e si serve dell’indagine per cercare i dati necessari a confermarla.
L’analisi effettuata sul brano Ornithology di Charlie Parker (nella
versione registrata dal vivo al leggendario Birdland, New York, il 30
giugno del 1950), ben si presta a illustrare in sinteticamente il metodo
impiegato. Le improvvisazioni del sax di Charlie Parker e della tromba di Fats Navarro sono state osservate al sonogramma, uno strumento
di rappresentazione del suono. Ecco ad esempio come si presenta una
breve frase suonata da Navarro durante la propria improvvisazione:
Figura 2
La trascrizione musicale, in basso, è stata aggiunta all’immagine
per evidenziare tramite linee verticali le corrispondenze tra gli eventi
rappresentati dal sonogramma e le note del pentagramma. Regolando
opportunamente i valori dei diversi parametri di visualizzazione, in
funzione di ciò che si vuole osservare, con il sonogramma il suono risulta perfettamente osservabile nella sua natura fisica, rappresentato
per il tempo sull’asse orizzontale, e per le frequenze sull’asse verticale. Come si può notare sono visibili le componenti armoniche, e l’intensità del colore è proporzionale all’intensità del suono. Un idoneo
uso degli strumenti a corredo del sonogramma permette diversi livelli
di utilizzo: ad esempio zoomare sulle frequenze fondamentali, individuare la durata dei transitori di attacco, visualizzare alcune caratteri-
Dalla manifestazione del suono alla musica
89
stiche quali glissati, portamenti, vibrati, etc.
Dall’esplorazione dei diversi parametri possibili, si rilevava una particolare e diversa configurazione ritmica degli ottavi adottata dai due
musicisti. Si è proceduto quindi alla misurazione della durata dei suoni.
Il SYVAR–D
È necessario, a questo punto, introdurre un’osservazione importante, che si è rivelata fondamentale negli studi sul ritmo effettuati presso l’Università di Uppsala [cfr. Begntsson–Gabrielsson 1977],
relativamente alla concetto di durata del suono. Nel considerare una
sequenza di due suoni, ad esempio due ottavi, è possibile osservare
almeno tre diverse articolazioni delle durata: il legato, lo staccato e il
portato.
Figura 3
In realtà questi tre tipi di articolazioni rappresentano categorie entro le quali è possibile una vasta gamma di variazione, e quindi di differenti gradi di legato, di staccato e di portato, senza limiti ben definiti
tra le categorie. Ora, rispetto ad una regolarità rigorosa (da logica matematica), è possibile che durante una sequenza di note ci siano delle
variazioni rispetto alla durata ideale delle note. Tali variazioni possono riguardare diversi aspetti, come illustrato nell’esempio seguente:
90
Bruno Gioffrè
Figura 4
La sequenza (a) rappresenta un caso di esecuzione ideale: le note
iniziano esattamente sul beat (rappresentato dalla linea tratteggiata),
ed hanno la stessa durata. Nella sequenza (b) la seconda nota è in anticipo sul beat e le due note hanno differente durata. Nella sequenza (c)
le due note hanno differente durata e iniziano dopo il beat.
Variazioni impreviste non sono intenzionali, ma occasionali; invece variazioni sistematiche sono messe in atto deliberatamente dagli
esecutori per enfatizzare o far emergere strutture interne quali proprietà espressive della musica in questione. Di queste l’esecutore stesso
potrebbe non essere pienamente consapevole, o potrebbe essere incapace di descriverne la realizzazione [Begntsson–Gabrielsson 1977]. Il
discorso vale non solo per le durate ma anche per intonazioni, dinamiche, spettri, ecc. Tali variazioni sono definite SYVAR–D, acronimo di
SYstematic VARiations – Durations; e Middleton in un suo saggio nota che «noi dobbiamo ancora chiederci se questo significa che strutture
intra–musicali non siano importanti per l’analista di popular music»
[Middleton 1992, trad. it. p. 345].
La questione è interessantissima, ma troppo complessa per essere
affrontata in questa sede. Dobbiamo invece tornare all’analisi del nostro esempio e risolvere innanzitutto il problema di come effettuare la
misurazione delle note. Utilizzando il sistema proposto da Bengtsson
definiamo:
– la durata dall’inizio del suono alla sua fine: Dio (duration in–out)
– la durata dall’inizio del suono all’inizio del suono successivo: Dii
(duration in–in)
– la durata dalla fine di un suono all’inizio del successivo: Doi (duration out–in)
Dalla manifestazione del suono alla musica
91
Figura 5
Come si può facilmente notare, Dio e Dii possono essere diversi o
coincidere se tra le due note è presente o meno Doi (la pausa). E ancora è
possibile che Dio possa essere più grande di Dii nel caso in cui le due note
si sovrappongano. Ma l’aspetto rilevante è che, pur essendo Dio la durata
fisica effettiva di una nota, solitamente il valore significativo dal punto di
vista della percezione è invece Dii [cfr. Bengtsson–Gabrielsson 1983]
Fatta questa osservazione, necessaria per comprendere i criteri metodologici della misurazione, si è proceduto al rilevamento delle durate misurando le Dii delle note, e in particolare di ogni terzina e della
propria articolazione interna. Tenendo conto della divisione ternaria
della pulsazione metrica (12/8), le note segnate come coppia di ottavi
sono in realtà il primo e il terzo ottavo di una terzina, convenzionalin calce alla partitura, senza riportare sul
mente notate
pentagramma il 3 per ogni coppia “terzinata”. In Navarro questa articolazione è abbastanza evidente, come si può osservare nell’esempio
successivo. Misurando la durata tra una pulsazione e la successiva, e
le durate delle due note, se ne può osservare la particolare articolazione. Nel caso in esempio la durata della pulsazione è di 230 ms. La
prima nota dura 143 ms. mentre la seconda 87 ms. Se calcoliamo ora
il valore di durata “ideale” delle due note all’interno della pulsazione,
questo risulta essere per la prima nota pari a 230/3*2 = 153,3 ms. e per
la seconda nota pari 230/3 = 76,6 ms. È evidente un anticipo della seconda nota di 10,4 ms., ottenuto per differenza tra la durata reale e la
durata “ideale” della nota (87– 76,6).
Questa variazione dalla norma si presenta sistematicamente anche
nelle successive articolazioni di durata, relativamente agli ottavi di
“terzina”, con valori che poco differiscono da quello preso in esempio.
92
Bruno Gioffrè
Per cui potremmo pensare a un SYVAR–D di 10 ms. che anticipa la
seconda nota della figura ritmica in esame.
Figura 6
Nel solo di Charlie Parker (nella medesima registrazione del medesimo brano, per cui non ci sono fattori esterni differenti quali una diversa velocità, un diverso organico, ecc.) l’analisi permette di cogliere
un’ulteriore accentuazione del fenomeno riscontrato precedentemente.
Osservando il sonogramma qui di seguito è possibile riscontrare che la
pulsazione ha una durata di 232 ms (n.b.: la variabile durata delle pulsazioni è “compensata”, per rientrare nel tempo, dalle successive figurazioni). La prima nota ha una durata di 119 ms., e la seconda di 113
ms. I valori “ideali” delle due note corrispondono per la prima a
232/3*2 = 154,6 ms. e per la seconda nota a 232/3 = 77,3 ms.
L’anticipo della seconda nota rispetto alla norma è questa volta di
113–77,3 = 35,7 ms.
Dalla manifestazione del suono alla musica
93
Figura 7
Anche in Parker questa variazione dalla norma si presenta sistematicamente nelle successive articolazioni di durata, relativamente agli
ottavi di “terzina”, con valori che poco differiscono da quello preso in
esempio. Per cui il SYVAR–D è questa volta di 35 ms., variazione
quindi molto più accentuata in Charlie Parker rispetto a Fast Navarro.
L’analisi via sintesi
Chiaramente non basta la sola analisi acustica e la rilevazione dei
dati a dimostrare la pertinenza di alcuni parametri alla sensazione percettiva; come possiamo esser certi che quanto l’analisi acustica ha
messo in luce, in questo caso la particolare articolazione delle durate
delle note, è responsabile della percezione di ciò che chiamiamo
swing? I dati dell’analisi ci permettono solo di avanzare delle ipotesi.
Ma è possibile usare i dati dell’analisi per osservare quanto questi
possano incidere sulla percezione, e quindi sull’impressione di chi ascolta, modificandone di volta in volta i valori. In tal modo l’ipotesi
può essere verificata. È quanto Philip Tagg definisce hypothetical substitution, cioè, se certi parametri del suono sono portatori di significati, è possibile, con la loro modifica, verificare se e in che misura cambia il significato.
94
Bruno Gioffrè
Sintetizzando quindi una frase eseguita da Fats Navarro, cioè ri–
creandola tramite uno strumento di sintesi con un calcolatore, e inserendo di volta in volta valori diversi relativamente ai modelli di articolazioni delle durate come precedentemente analizzato, è possibile presentare questi nuovi esempi sonori ad un gruppo di ascoltatori e osservarne le risposte e i giudizi.
Il grafico seguente illustra il risultato di un test di ascolto effettuato su
un gruppo di 30 uditori, musicisti, studiosi di jazz e semplici appassionati cui sono state fatte ascoltare tre varianti di una frase di partenza ottenute sinteticamente: la prima usando un SYVAR–D “modello Navarro”; la
seconda con un SYVAR–D “modello Parker”; la terza con un SYVAR–
D “modello intermedio”. Le risposte e i giudizi all’ascolto rivelano una
medio–bassa percezione di swing nelle frasi a “modello Navarro”,
un’alta percezione di swing nelle frasi a “modello Parker”, e una medio–
alta percezione di swing nelle frasi a “modello intermedio”.
Il fatto che la percezione dello swing sia risultata diversa in rapporto
alla modifica dell’articolazione delle durate negli ottavi di terzina, indica che tale tratto è responsabile della percezione dello swing. Inoltre
possiamo cogliere il funzionamento dell’articolazione, per cui ad un
piccolo anticipo del secondo ottavo corrisponde una minima percezione
di swing, viceversa ad un più rilevante anticipo la percezione aumenta.
Figura 8
Dalla manifestazione del suono alla musica
95
Questo esempio è molto semplicistico, perché osserva isolatamente
un parametro del suono senza tener conto dell’influenza di altri parametri fondamentali presenti durante un brano, ad esempio le intonazioni, i diversi aspetti di un timbro, gli effetti di studio, il fronte e gli
spazi sonori. Tuttavia è uno spunto verso una indagine che, nel cogliere i diversi sound della popular music, tenga adeguatamente conto del
suono, in tutto il suo fisico manifestarsi.
96
Bruno Gioffrè
Riferimenti bibliografici
ADAMO, Giorgio (1996) Analisi del suono e modelli psicoacustici nella ricerca musicologia, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma.
BENGTSSON, Ingmar, GABRIELSSON , Alf (1977) Rhythm research in Uppsala,
in «Music Room Acoustics», Royal Swedish Academy of Music, n.17.
— (1983) Analysis and synthesis of musical rhythm, in «Studies of music
performance», Royal Swedish Academy of Music, n.39.
BIRRER, Frans A.J. (1985) Definitions and research orientation: do we need
a definition of popular music?, in «Popular Music Perspectives», 2, a cura
di D. Horn, Göteborg, Exeter, Ottawa e Reggio Emilia.
METFESSEL, Milton (1928) Phonophotography in Folk Music, The University
of North Carolina Press, Chapel Hill.
MIDDLETON, Richard (1990) Studying Popular Music, Buckingham, Open
University Press (trad. it. Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli,
1994).
— (1992) Towards a theory of gesture in popular song analysis, Secondo
convegno di analisi musicale, Atti a cura di Rossana Dalmonte e Mario
Baroni, Università degli Studi di Trento.
NATTIEZ, Jean Jacques (1987a) Musicologie générale et sémiologie, Paris,
Bourgois, (trad. it. Musicologia generale e semiologia, Torino, Edt, 1989)
— (1987b) Il discorso musicale. Per una semiologia della musica, Torino,
Einaudi.
SEASHORE, Carl (1928) Introduction in Mettfessel 1928.
SEEGER, Charles (1958) Prescriptive and Descriptive Music–Writing, in
«Musical Quartely», 44, pp. 184–195.
Luca Marconi
Valori, paradigmi, canoni
0. Approcci al giudizio di valore
Nel corso delle due giornate di studio, a monte delle vivaci e interessanti discussioni che si sono andate via via sviluppando, si sono
spesso profilate due domande cruciali:
• cosa rende uno studio sulla popular music più valido di un altro?
• cosa rende un’attività di insegnamento della pratica della popular
music più valida di un’altra?
Per rispondere a tali domande è necessario innanzitutto considerare
l’ambito nel quale si inseriscono: quello delle riflessioni sul giudizio
di valore; gli approcci nei suoi confronti possono essere ricondotti a
due tendenze generali:
• l’assolutismo, che consiste nel sostenere che, nei confronti del
campo da giudicare, esiste un principio di giudizio unico e universale;
• il relativismo, secondo il quale nei confronti del campo considerato esistono diversi principi di giudizio, che mutano a seconda dei valori 1 e degli obiettivi condivisi dalle diverse comunità che adottano tali principi; l’esplicitazione della relazione tra tali principi di giudizio,
tali valori e tali obiettivi implica la denuncia di chi occulta ideologicamente ed etnocentricamente la relatività dei propri obiettivi/valori presentando i proprio giudizi di valore come se fossero assoluti.
Personalmente mi riconosco in quest’ultima tendenza, che adotterò affrontando in un primo tempo la prima delle due questioni sopra citate, concentrandomi nella parte finale di questo scritto sulla
seconda.
1. Studi e ricerche sulla popular music
I giudizi di valore sugli studi sulla popular music, come anche
quelli sugli studi di altri campi musicali, possono essere inseriti in un
1
Sull’applicazione in ambito musicale del concetto di “valore”, cfr. Baroni 1993 e
2001, e Gasperoni–Marconi–Santoro 2004.
97
98
Luca Marconi
continuum che ha ai propri estremi due principali paradigmi 2, che
chiamerò “canonismo” e “esperienzialismo”:
• il canonismo consiste nel sostenere che una ricerca sulla musica è
tanto più valida/importante quanto più incrementa la conoscenza relativa
alle caratteristiche dei tratti distintivi di uno o più brani canonici e sui fenomeni che hanno determinato che tali brani avessero tali tratti distintivi;
• l’esperienzialismo invece sostiene che una ricerca sulla musica è tanto più valida/importante quanto più incrementa la conoscenza della relazione tra una qualsiasi esperienza musicale, l’oggetto musicale al quale
tale esperienza corrisponde e il soggetto umano che vive tale esperienza 3.
Per approfondire tale distinzione, fornirò due esempi di approcci
alla ricerca musicale, in linea il primo con il canonismo, il secondo
con l’esperienzialismo.
Una linea culturale tendente al canonismo è quella sostenuta dalla
rivista «Il Saggiatore Musicale»: l’identità culturale della comunità
che si riconosce in tale linea ha tra le sue componenti costitutive un
canone 4 consistente in un repertorio di brani musicali che incarnano
un insieme di valori condivisi da tale comunità e che servono loro a
distinguersi da altre comunità. Tale canone viene allora definito come
«la selezione dei grandi “monumenti” che l’uomo colto non può decentemente ignorare» [Bianconi–Gallo–La Face 2001, p. 13]; serve
dunque alla comunità che si riconosce in tale definizione per distinguersi come comunità di uomini colti dalla comunità degli incolti.
Tale ricerca di distinzione porta gli appartenenti a tale comunità ad
affermazioni quali la seguente: «se noi vogliamo conservare la nostra identità culturale (condizione indispensabile per poter conoscere anche le
culture altre e diverse dalla nostra, e mantenere quest’ultima viva ed elastica) non possiamo distruggere il concetto di “canone”, ma al contrario
coltivarne la feconda ambiguità» [Di Benedetto 2001, pp. 101–102].
Questa scelta porta a considerare importanti e a valorizzare il più
possibile le ricerche che incrementano la conoscenza sulle caratteristiche dei tratti distintivi di uno o più dei “grandi monumenti” della mu-
2
Sull’applicazione alla riflessione sugli studi musicali del concetto di “paradigma”
approfondito da Kuhn 1962 cfr. Stefani (a c.) 1990; tale concetto viene utilizzato per riflettere sulle concezioni più recenti della storia della musica in Vendrix 2002.
3
Per una riflessione generale sull’applicazione dei concetti di “esperienza”, “soggetto” e “oggetto” in ambito musicale, cfr. Stefani 1998.
4
Sulla relazione della musicologia con il concetto di “canone”, cfr. Bergeron–
Bohlman (a c.) 1992; Everist 1999 e Weber 1999.
Valori, paradigmi, canoni
99
sica “colta” e sui fenomeni che hanno determinato che tali brani avessero tali tratti distintivi.
Per completare il quadro della descrizione di questo esempio di canonismo, è opportuno aggiungere altre due considerazioni.
In primo luogo va tenuto presente che, se la linea culturale sostenuta dal «Saggiatore Musicale» e altri approcci canonisti sono spesso
appannaggio degli storici della musica, specie di quelli che si occupano di musica colta, tale linea culturale e tale paradigma non coincidono tout court con la storia della musica: esistono storici della musica,
anche di quella colta, e altri studiosi di musica colta, specie nell’area
della “new musicology” 5, che adottano altre linee culturali, riconducibili all’esperienzialismo.
In secondo luogo, va considerato che, se spesso chi adotta un paradigma canonista non studia la popular music, anch’essa può essere affrontata sulla base di tale paradigma, da una parte studiandola esclusivamente per mostrarne la marginalità rispetto al proprio canone 6,
dall’altra scegliendo un canone nel quale siano presenti anche brani di
popular music 7.
Una linea culturale tendente all’esperienzialismo è invece quella
percorsa dall’associazione culturale IASPM italiana, che annovera tra
i propri iscritti soggetti di diversa provenienza (musicologi sistematici,
storici della musica, etnomusicologi, sociologi della musica, ecc.): come nel caso analizzato in precedenza, anche la comunità che si riconosce in tale linea ha una propria identità culturale, e dunque non può
che avere anch’essa un proprio canone; in questo caso, però, la tendenza esperienzialista fa sì che il canone consista non in un certo repertorio di brani musicali, ma in un repertorio di scritti, concetti, metodi, progetti. Ciascun membro di tale comunità indubbiamente consi5
Sulla “new musicology”, cfr. Cook–Everist (a c.) 1999 e Vendrix 2002.
Cfr., ad esempio, Somigli 2003, che sostiene che «la storia della musica d’arte
dell’ultimo secolo […] può trarre giovamento ed alimento da un’indagine sulla musica
popular» [p. 319] aggiungendo però che «una diade del tipo “musicologia storica e popular music”, accostando due prospettive eterogenee fin nel nome, e nominalmente remote fino all’incommensurabile» renderebbe «impervia, se non affatto impercorribile, la
strada d’una comparazione» [p. 321], proponendo piuttosto che la musicologia storica si
occupi di “musica di consumo” presupponendo «che essa consista di tanti episodi singoli
irrelati, connessi all’attimo della loro attuazione, e tra loro slegati, a tal punto da sottrarsi
a una ricostruzione storica» [p. 323].
7
Cfr., ad esempio, Borio 2003, che tende a inserire il “rock sperimentale” sviluppato
in Gran Bretagna intorno al 1968 (esemplificato soprattutto dalla produzione dei Soft
Machine) nel canone delle musiche d’avanguardia.
6
100
Luca Marconi
dera certi brani musicali più validi di altri, sulla base di principi a volte condivisi da gran parte di tale comunità, ma l’obiettivo di quest’ultima non è quello di valorizzare il più possibile tali brani mirando
soprattutto a conservare la propria identità culturale, quanto quello di
valorizzare il più possibile le esperienze musicali che ritiene più valide 8, cioè quelle che consentono a ogni essere umano di modificare la
propria identità culturale mettendola a confronto in dialogo con altre
comunità, con “approssimazioni” 9.
Tutto ciò comporta una condivisione con quanto ha affermato Slobin riguardo all’etnomusicologia: «Gli etnomusicologi ritengono solitamente che la loro disciplina si basi su una particolare prospettiva di
osservazione della musica e non sull’osservazione di un particolare tipo di musica» [Slobin 2002, p. 151]. Possono essere citati numerosi
episodi che documentano l’adozione di tale atteggiamento da parte
della IASPM: ad esempio, i progetti che la IASPM italiana ha realizzato in collaborazione con la Società Italiana per l’Educazione Musicale e col Cimes dell’Università degli Studi di Bologna, sfociati nei
due volumi Il giudizio estetico nell’epoca dei mass media, [Addessi–
Agostini (a c.) 2004] e La musica e gli adolescenti [Gasperoni–Marconi–Santoro 2004], dove vengono affrontate pratiche spesso esercitate con repertori assai diversi dalla popular music; e lo stesso discorso
vale per il convegno internazionale della IASPM. “Making Music,
Making Meaning”, tenutosi a Roma nel 2005.
L’attenzione della IASPM nei confronti della popular music è dunque finalizzata non a valorizzare questo repertorio, bensì a migliorare
la qualità degli studi sulla relazione tra tali brani, le esperienze musicali con essi vissute e i soggetti che le vivono: punto di partenza è il
rilevamento dell’inadeguatezza degli studi che attribuiscono tutta la
responsabilità della produzione di tali esperienze da una parte agli oggetti musicali (la musica intrinsecamente “commerciale”, di consumo)
e ai mezzi di comunicazione di massa coinvolti, dall’altra ai soggetti
8
Considerare certe esperienze musicali più valide di altre non implica sostenere che
solo le esperienze musicali più valide siano degne di essere vissute: sono molti i tipi di esperienza musicale capaci di fornire un contributo positivo alla vita di un essere umano,
che avrebbe il diritto di viverne il maggior numero possibile traendone il massimo di piacere e di giovamento per lo sviluppo della propria identità. Non c’è nulla di male nel vivere
con piacere l’ascolto di una canzone sentimentale, e dunque tale esperienza ha diritto a essere rispettata; è invece criticabile l’idea che la canzone sentimentale sia l’unico genere
musicale valido e la tendenza a vivere con piacere solo l’ascolto di questo genere musicale.
9
Sul concetto di “approssimazione”, come esercizio di valorizzazione della “trascendenza dell’altro”, cfr. Cassano, 1989.
Valori, paradigmi, canoni
101
che vivono tali esperienze. A tale proposito, la IASPM ha cercato di
sviluppare delle pratiche analitiche mirate a individuare una responsabilità dei brani di popular music e dei media ad essi legati sulle esperienze vissute praticando tali brani, tenendo però conto del ruolo giocato dai soggetti coinvolti nel far aver luogo a certe e non altre esperienze: uno dei principali esempi di questa ricerca è costituito dal numero monografico sull’analisi della popular music della «Rivista di
Analisi e Teoria Musicale» 10 [Agostini–Marconi 2002].
Quali conclusioni possono essere tratte dal confronto di paradigmi
qui sopra proposto? È evidente che la mia posizione consiste nel ritenere più valido il paradigma esperienzialista rispetto a quello canonista, non solo nell’ambito dello studio della popular music, ma anche
nello studio della musica colta e di quella di tradizione orale. Altrettanto evidente è che tra i docenti e i ricercatori che si occupano di musica nelle Università italiane il paradigma canonista è molto più adottato di quello esperienzialista.
Rispetto a tale situazione, in questa sede mi limiterò a esprimere
due auspici, rivolti nei confronti sia dei futuri corsi sulla popular
music a Cosenza che degli altri contesti pertinenti:
• da una parte auspico che si sviluppino approfondite e corrette discussioni sull’opportunità di adottare l’uno o l’altro dei due paradigmi
sopra esposti, tenendo conto dei due tipi di posta che sono in gioco nel
loro conflitto: il futuro degli studi sulla musica in Italia e il futuro della musica nel nostro paese;
• nello stesso tempo, auspico che, fino a quando non venga stabilito
in modo inequivocabile che uno dei due paradigmi è più valido dell’altro, ci sia la possibilità di sviluppare sotto forma di ricerche e di
presentare con opportune attività didattiche ai futuri studiosi entrambi
i paradigmi applicati allo studio della popular music.
In particolare, nell’ambito degli studi esperienzialisti sulla popular
music, ritengo siano da sviluppare due filoni, ciascuno dei quali d’impianto decisamente interdisciplinare:
• da una parte, uno studio sincronico delle relazioni tra le esperienze,
gli oggetti musicali e i soggetti coinvolti nelle pratiche della popular
music contemporanea; uno studio con questo taglio potrebbe avvalersi
non solo delle competenze degli studiosi della IASPM specializzati nello studio della tradizione massmediatica, ma anche di quelle degli et10
Questa rivista è legata alle attività del Gruppo di Analisi e Teoria Musicale, associazione che vede la IASPM Italiana fra i suoi soci fondatori.
102
Luca Marconi
nomusicologi capaci di mostrare il ruolo giocato nelle esperienze della
popular music dalla tradizione orale e di quelle dei musicologi sistematici che sappiano adattare la loro disciplina in questo ambito;
• dall’altra, uno studio diacronico delle relazioni tra le esperienze,
gli oggetti musicali e i soggetti coinvolti nelle pratiche della popular
music succedutesi nel passato; anche in questo caso, ci si potrebbe avvalere delle competenze di altri studiosi oltre a quelli della IASPM: ad
esempio, etnomusicologi in grado di di inserirsi in uno studio diacronico delle esperienze della popular music e storici della musica colta
disponibili a inserire la loro disciplina in questo tipo di ricerca.
2. Insegnare a praticare la popular music
Il problema concernente la scelta dei principi in base ai quali esprimere giudizi di valore su attività finalizzate a insegnare a praticare
la popular music non è certo recentissimo: non appena si sono cominciate a realizzare tali attività didattiche (in Italia, all’inizio soprattutto
nei corsi privati e nelle scuole di musica), un nodo di questo tipo non
poteva non venire al pettine. Decisamente più recente, e sempre più
frequente, è l’inserimento di tale questione nell’ambito delle riflessioni sulle attività didattiche da svolgersi nei Conservatori italiani, dove
risulta sempre più evidente che si è passati da una prima fase di discussione se inserire o meno attività volte a insegnare a praticare la
popular music al momento di considerare come inserire tali attività,
con quali obiettivi e metodi 11. Ciò ha comportato che tale considerazione venisse a intersecarsi con un’altra discussione, che in Italia si è
sviluppata in proporzioni maggiori in Conservatorio che in altri contesti didattici, quella sulle competenze dell’insegnante di strumento: discussione nella quale i “disciplinaristi” sostengono che per insegnare
una certa pratica musicale sia sufficiente essere dei validi performer di
tale pratica, mentre i “pedagogisti” ribattono che a tal fine le competenze del valido performer sono necessarie ma non sufficienti.
Personalmente mi riconosco in questa seconda tendenza e ritengo
che il principio di fondo da essa esposto valga non solo per la didattica
dell’insegnare a praticare la musica colta, ambito nel quale, specie in
Italia, la didattica dell’insegnamento strumentale si è particolarmente
11
Cfr. a tale proposito Agostini (a c.) 2005.
Valori, paradigmi, canoni
103
concentrata 12, ma anche per la assai meno dissodata didattica dell’insegnare a praticare la popular music 13. Una volta esposto tale principio, risulta comunque tutt’altro che semplice individuare il profilo dell’insegnante ottimale di ciascuna delle pratiche della popular music
che si intenda inserire in un certo contesto didattico: se è ormai assodato che tale figura, in qualsiasi contesto operi, debba saper applicare
alcuni postulati inderogabili (evitare di fare dello studente un proprio
clone, adattare il proprio progetto di sviluppo all’identità musicale del
discente, ecc.), molti particolari sono tutti da costruire.
Come ho fatto nella prima parte di questo scritto, mi limiterò in
questa sede a formulare un auspicio generale: sarebbe particolarmente
opportuno muoversi in analogia a quanto è stato fatto dalla SIEM per
produrre il documento “Proposta per la ridefinizione degli ambiti di
competenza relativi alla formazione iniziale degli insegnanti di musica” 14: si tratta cioè di far dialogare tra loro soggetti portatori delle diverse forme di competenza pertinenti alla disciplina di insegnamento
considerata (soprattutto gli insegnanti di tale disciplina, gli esperti di
pedagogia della musica e gli studiosi delle pratiche musicali da insegnare) invitando a formulare un elenco adeguatamente articolato di
competenze dell’insegnante che si vuole caratterizzare.
12
Sui fondamenti generali della didattica dell’insegnamento strumentale cfr. soprattutto Parncutt–McPherson (a c.) 2002 e Freschi (a c.) 2002.
13
Sull’insegnare a praticare la popular music cfr. soprattutto Green 2002.
14
Questo documento è consultabile nel sito internet della SIEM (http://www.siem–
online.it/docu/docum_conscuoluni.htm).
104
Luca Marconi
Riferimenti bibliografici
ADDESSI Anna Rita, AGOSTINI, Roberto (a c.) (2004) Il giudizio estetico nell’epoca dei mass media, Lucca, LIM.
AGOSTINI, Roberto (a c.) (2005) Dal garage al conservatorio. Insegnare la
popular music oggi, in «Musica Domani», n. 137.
AGOSTINI, Roberto, MARCONI, Luca (a c.) (2002) Analisi della popular
music, numero speciale della «Rivista di Analisi e di Teoria Musicale»,
VIII, 2.
BARONI, Mario (1993) Linguaggio musicale e valori sociali, in Baroni–
Imberty–Porzionato (a c.), Memoria musicale e valori sociali, Milano,
Ricordi.
— (2001) Gruppi sociali e gusti musicali, in Enciclopedia della Musica, diretta da J.J Nattiez, vol. I, Il Novecento, Torino, Einaudi, pp. 966–986.
BERGERON, Katherine, BOHLMAN, Philip V. (a c.) (1992) Disciplining Music:
Musicology and its Canons, Chicago, University of Chicago Press.
BIANCONI, Lorenzo, GALLO, Alberto, LA FACE, Giuseppina (2001) Tesi del
Convegno “La storia della musica: Prospettive del Secolo XII, in «Il Saggiatore Musicale», VIII, 1.
BORIO, Gianmario (2003) Una storia unitaria delle musiche del secolo XX?,
in «Il Saggiatore Musicale», X, 2.
CASSANO, Franco (1989) Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro,
Bologna, Il Mulino.
COOK, Nicholas, EVERIST, Mark (a c.) (1999) Rethinking music, New York,
Oxford University Press,
DI BENEDETTO, Renato (2001) Canone enigmatico, in «Il Saggiatore Musicale», VIII, 1.
EVERIST, Mark (1999) Reception Theories, Canonic Discourses, and Musical
Value, in Cook–Everist (a c.), 1999.
FRESCHI, Anna Maria (a c.) (2002) Insegnare uno strumento. Riflessioni e
proposte metodologiche su linearità/complessità, Torino, EdT.
GASPERONI, Giancarlo, MARCONI, Luca, SANTORO, Marco (2004) La musica
e gli adolescenti, Pratiche, gusti, educazione, Torino, EdT.
GREEN, Lucy (2002) How Popular musicians Learn: a Way Ahead for Music
Education, Aldershot, Hants, Burlington, Ashgate.
KUHN, Thomas (1962) The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, Chicago University Press (trad. it. La struttura delle rivoluzioni scientifiche,
Torino, Einaudi, 1978),
PARNCUTT, Richard, MCPHERSON, Gary (a c.) (2002) The Science and
Psychology of Music Performance. Creative Strategies for Teaching and
Learning, Oxford, Oxford University Press.
Valori, paradigmi, canoni
105
SLOBIN, Mark (2002) Quali musiche?, in Universi sonori, a c. di T. Magrini,
Torino, Einaudi.
SOMIGLI, Paolo (2003) Musicologia storica e musica di consumo: punti critici di un rapporto necessario, in «Il Saggiatore Musicale», X, 2.
STEFANI, Gino (1998) Musica: dall’esperienza alla teoria, Milano, Ricordi.
STEFANI, Gino (a c.) (1990) Studi musicali: verso un nuovo paradigma, in
«Quaderni di musica applicata», n. 13, Assisi, Edizioni Pro Civitate Christiana.
VENDRIX, Philippe (2002) Concezioni diverse della storia musicale, in Enciclopedia della Musica, diretta da J.J Nattiez, vol. II, Il sapere musicale,
Torino, Einaudi, pp. 591–610.
WEBER, William (1999) The History of Musical Canon, in Cook–Everist,
Mark (a c.) 1999.
Nadia Capogreco
Popular music: dai limiti della definizione
alla ricchezza dell’esperienza
Allorché, nel 1983, si svolse a Reggio Emilia la Seconda Conferenza dell’International Association for the Study of Popular Music
(IASPM) [cfr. Fabbri 2005] l’intento comune era quello di rispondere
in modo chiaro e definitivo all’interrogativo What is Popular Music?,
come recitava lo stesso titolo del convegno:
Non c’è nessuno oggi che sia in grado di definire senza ambiguità il termine
di popular music indicandone con precisione i contenuti e i confini. Il concetto è troppo recente (e il suo referente troppo sfuggente) perché si sia già potuto trovare un accordo fra tutti coloro che lo usano; così la sua definizione è
ancora largamente intuitiva anche fra chi s’interessa sistematicamente al suo
studio. [Baroni–Callegari 1985, p.176]
Questa mancanza di accordo, due anni prima (nella First International Conference on Popular Music Research di Amsterdam, giugno
1981), aveva portato a indire il nuovo convegno per «l’evidente necessità di una comprensione internazionale e interdisciplinare più precisa di cosa veramente sia la popular music», con l’auspicio che dalle
giornate di studio in programma potesse venir fuori «qualche tipo di
accordo operativo sull’effettiva area delle […] ricerche» [Fabbri (a c.)
1985, p. 15].
Stando cosi le cose, nel 1983 popular music era ancora una definizione provvisoria, attribuita provvisoriamente ad un campo di ricerca
di cui provvisori erano anche i confini e i contenuti. Bisognava ancora
capire, infatti, non solo se popular fosse appropriato a denominare il
campo di ricerca, ma anche — paradossalmente — se i confini e i contenuti dello stesso campo di ricerca fossero inscrivibili nella definizione di essi data. Un cane che si morde la coda, insomma, e anche alla
conclusione di quel secondo incontro la situazione sarebbe rimasta sostanzialmente immutata. Ecco, infatti, quello che leggiamo nella nota
introduttiva agli atti del convegno, redatta da Franco Fabbri:
È tutt’altro che chiaro quale termine si dovrebbe usare per indicare collettivamente tutte queste musiche, tutti questi generi di cui “si sente” che esistano elementi comuni, se non altro quello di essere esclusi dai piani di studio tradiziona-
107
108
Nadia Capogreco
li. Musiche “extra colte”? Musiche “d’uso”? Musiche “di consumo”? Musiche
“funzionali”? Musiche “massmediatiche”? Gli anglosassoni […] hanno scelto
decisamente un termine piuttosto vecchio e sicuramente ambiguo, popular
music, che tuttavia coglie uno degli aspetti centrali dello studio di queste attività
musicali: la dialettica problematica tra produzione industriale e consenso […],
tra massificazione e spontaneità [Fabbri (a c.) 1985, pp. 11–12].
Si continua, dunque, a non dare per scontato l’ingresso nella nostra
lingua del termine già in uso in area anglosassone, considerandolo
«piuttosto vecchio e sicuramente ambiguo». Il concetto di popular, in
effetti, è storicamente ambivalente, dato che
in taluni casi sembra prevalere la derivazione dal concetto di “popolo”, il cui gusto
viene contrapposto, con un certo sapore di spregio, a quello di non meglio precisate categorie dalle preferenze più “elevate” […]. In altri casi, invece, […] prevale la
nozione di “notorietà”, ossia l’essere conosciuti ed anche, almeno in certa misura,
apprezzati, da un gran numero di persone. [Baroni–Nanni 1989, p 26]
Ed è proprio uno dei maggiori studiosi di aria anglosassone, Richard
Middleton, ad ammettere che il tentativo di definire cosa sia la popular
music rappresenta, in effetti, una vera e propria “gatta da pelare”. Per
questo nel suo intervento al convegno egli si sforza di chiarire che la
chiave giusta in cui declinare la nozione di popular non è quella positivistica, nelle cui analisi si considera prioritario occuparsi delle dimensioni, della serializzazione, della riproduzione e della produzione di
massa (e qui “popolare” diventa più o meno sinonimo di “massificato”
o di “commerciale”); e nemmeno quella “essenzialista”, per la quale i
concetti chiave sono “autenticità”, “spontaneità”, “radici”. In questa
prospettiva la popular music risulterebbe connessa a un particolare
gruppo sociale [cfr. Middleton 1985, pp. 25–26]. In entrambi i casi, infatti, il campo è organizzato più o meno esplicitamente secondo una
prospettiva storica, col problema che processi culturali concreti in situazioni storiche particolari «si riducono a schemi astratti, totalmente inscritti vuoi nel modo di produzione e nei suoi supposti rapporti sociali,
vuoi in qualche concetto idealistico di “cultura”» [Middleton 1985, pp.
26–27]. La conseguenza è il mancato riconoscimento delle contraddizioni insite nel processo produttivo, col rischio di ridurre i consumatori
a puri ricettori passivi, o a classe intrinsecamente anti–capitalista. Le
implicazioni ideologiche del termine popular, che insieme alle pratiche
culturali ad esse riferibili sono comunque innegabili, hanno invece la
caratteristica di essere «sempre intrinsecamente contraddittorie, per il
semplice fatto che […] è la nostra stessa società ad essere “intrinseca-
Popular music: dai limiti della definizione alla ricchezza dell’esperienza 109
mente contraddittoria”». Ed è causa di questa contraddizione strutturale
che «né la popular music comunque concepita, né i suoi Altri (folk
song, musica tradizionale, musica d’arte, musica borghese) entrano sulla scena della storia in una forma tanto incontaminata» [Middleton
1985, p. 27]. La popular music, in quanto radicata nella vita sociale, è
una forma estremamente viva, soggetta, come la vita stessa, ai compromessi e alle continue rinegoziazioni della propria identità.
Un passo ulteriore nel tentativo di delineare il nuovo campo di ricerca, viene compiuto da John Shepherd, secondo il quale il problema insormontabile nella definizione della popular music è che quasi tutti i
criteri elaborati per distinguerla dagli altri generi (folk e “seria”) non
reggono ad un esame più serrato. Criteri di differenziazione provenienti
dall’“alto”, ad esempio, si basano sulla convinzione che mentre la musica “seria” sarebbe libera da condizionamenti commerciali, e pertanto
puro riflesso del potenziale creativo ed unico del compositore, proprio
le pressioni commerciali impedirebbero nella popular music il dispiegarsi della vera creatività dei suoi musicisti, che risulterebbe standardizzata e finalizzata alla manipolazione e allo sfruttamento dei gusti musicali e culturali dei giovani. Ma è evidente che, in quanto soggetta alle
leggi discografiche, da questo punto di vista anche la musica “seria” subisce pressioni commerciali molto simili a quelle che inquinerebbero la
musica popular. Dalla considerazione di tutti i tratti distintivi — individuati dopo aver passato in rassegna le definizioni correnti — l’unica
conclusione possibile è, infatti, che in una certa misura tutta la musica
può essere chiamata popolare [Shepherd 1985, pp. 51–52]. Per questo
la questione va posta in una prospettiva differente:
Nel mondo accademico c’è a volte la tendenza […] a presupporre che siccome
esiste un’etichetta anche il fenomeno designato da quell’etichetta abbia piena,
discreta e oggettiva esistenza. Se ci sono delle difficoltà nel fornire una definizione esauriente del fenomeno, si penserà allora che il problema stia nell’inadeguatezza di chi sta conducendo l’analisi piuttosto che nel fatto che l’etichetta non sia appropriata. Voglio suggerire non tanto che le etichette folk,
popular, e seria siano irrilevanti, quanto che esse portano con sé una serie di
presupposizioni riguardo alle condizioni estetiche e sociali di queste musiche,
presupposizioni che risultano per lo più fuorvianti. [Shepherd 1985, p. 52]
Stando così le cose, uno dei presupposti più evidentemente impliciti nella definizione popular è che essa designi delle forme musicali
oggettive e discrete. Da ciò la necessità di localizzarle in specifici ambiti sociali e formali, col rischio di trascurare aspetti decisivi — ma
pregiudizialmente ritenuti irrilevanti — del fenomeno. La definizione,
110
Nadia Capogreco
in questo caso, non funziona da “semplice” etichetta ma, paradossalmente, da impedimento alla possibilità di dar conto in modo esplicito
del campo di studi che, nell’ uso corrente, essa intende denominare:
Ci sono due problemi collegati che sorgono quando si accettano le etichette
acriticamente invece di renderle in sé problematiche. Il primo è che per fare in
modo che il fenomeno rientri nell’etichetta l’osservatore comincia a selezionare le proprie impressioni e la propria comprensione del fenomeno, dando spazio a certe caratteristiche a spese di altre che finiscono per restare escluse. E
ovviamente le caratteristiche che passano tendono a essere proprio quelle che
collimano con la visione del mondo dell’osservatore. Ne risulta una forma sottile di imperialismo culturale o, per usare la terminologia di Bourdieu, una
“violenza simbolica” che ricade sul fenomeno in questione. È per questo motivo che, se i termini folk, popular e seria non sono privi di rilevanza, possono
però risultare fuorvianti. [Shepherd 1985, p. 53]
L’imperialismo culturale, in questo caso, verrebbe esercitato dall’establishment attraverso le presupposizioni e le limitazioni implicite
nel linguaggio musicologico ufficiale, carente di un’adeguata strumentazione concettuale capace di rilevare e di analizzare in modo soddisfacente tratti peculiari del fenomeno popular music. Come sostiene
Melucci, infatti, il controllo simbolico è assicurato dalla «capacità di
dominare i linguaggi, le grammatiche e le sintassi che organizzano il
loro senso» [Melucci, 1999, p. 126].
Ci sono enormi difficoltà nel capire, ad esempio, come determinate
caratteristiche tecniche — fondamentali per la specifica espressività dei
vari generi popular — siano in grado di veicolare e articolare significati
sociali e culturali. Timbri “impuri”, particolari inflessioni melodiche,
ritmiche ed armoniche, sono tanto difficili da fissare nell’astratto contesto delle analisi formali, quanto facili da collegare, al livello dell’esperienza, con l’ambiente umano, sociale e culturale che li ha visti nascere. Essi costituiscono un «quoziente di variabilità che non può essere
trascurato e che il più delle volte si concentra nel “sound”, o più in generale in un mix di sound e altri tratti musicali, fino a formare un equivalente (assai specifico) di ciò che nella musica colta chiamiamo stile»
[Baroni–Nanni 1989, p.61]. La loro forza espressiva sfida «il normale
desiderio accademico di mantenere gli oggetti di studio in una condizione passiva, a distanza, e di esaminarli come se fossero dei lepidotteri
morti» [Shepherd 1985, p. 45].
Ciò che è significativo nella popular music, dunque, sfugge al linguaggio accademico, che continua in tal modo ad esercitare il suo controllo sulle valenze potenzialmente eversive implicite nel sapere musi-
Popular music: dai limiti della definizione alla ricchezza dell’esperienza 111
cale “vivo”. Questa natura coercitiva si manifesta pienamente tutte le
volte in cui la ricca e dinamica complessità dell’esperienza musicale è
costretta, se non mortificata, nei presupposti cristallizzanti del linguaggio dato. La musica, infatti, «come forma di significato, con la sua concretizzazione in modelli e strutture di suono dinamiche ed astratte è veramente in contrasto con le statiche e reificate categorie visuali e letterarie prevalenti all’interno del discorso accademico occidentale» [Shepherd 1989, pp. 44–68].
Ma veniamo al secondo problema collegato ad un uso acritico dell’etichetta popular:
Le proprietà fisiche inerti delle etichette […] finiscono per impregnare il fenomeno. Si può arrivare al punto in cui la popular music venga considerata
l’oggetto di uno studio accademico a distanza, piuttosto che un processo dinamico che coinvolge persone vere e veri pezzi musicali. […] Considerare la
popular music come un oggetto o, ancora peggio, considerarla parte di un esercizio di imperialismo culturale, si rende possibile solo se la musica, come
la sua etichetta, viene concettualmente disgiunta dalle condizioni sociali della
sua produzione e del suo consumo. [Shepherd 1985, p. 54]
Il rischio, dunque, è che la popular music venga “oggettivata” (come
genere musicale, ad esempio) e in tal modo neutralizzata, poiché la difettosa prospettiva musicologica tradizionale tende a puntare l’attenzione sui prodotti musicali, svincolati dai processi umani e sociali che li
rendono possibili. Ciò perché «la musica, in quanto realtà d’arte nel significato moderno, tende ad isolarsi, ad ignorare — o ad interrompere
polemicamente, almeno nelle intenzioni — i suoi legami con il contesto» [Serravezza 1987–88, p. 2]. La musica cosiddetta “seria”, infatti, ha
cessato di essere solo un evento immediato, conquistando una forma
d’esistenza permanente distinta dalle occasioni della sua realizzazione
sonora. In tal modo ha attenuato il suo rapporto con le pratiche sociali, a
beneficio del rapporto col mondo dei testi e della cultura intellettualizzata [Serravezza 1987–88, p. 21].
È importante notare che l’aspirazione alla permanenza e la propensione ad intellettualizzarsi, sono intenzioni che generalmente le sono
state attribuite a posteriori, poiché la grande maggioranza delle musiche
ormai incluse nel repertorio “serio”, come si sa, furono originariamente
composte per motivi che oggi potremmo definire banalmente funzionali. Anche l’idea che l’istituzione sociale privilegiata per la “contemplazione” estetica sia il concerto in un teatro chiuso, è un ulteriore pregiudizio che opera a ritroso, visto che, almeno fino a tutto l’Ottocento, era
la funzione di intrattenimento quella costitutiva di tale istituzione. Dalla
112
Nadia Capogreco
consultazione delle numerose fonti iconografiche in nostro possesso è
facile riscontrare, infatti, che l’ascolto era generalmente disattento, e che
l’attenzione prestata alla musica era tutt’altro che omogenea: altro che
contemplazione estetica! Si trattava, allora, di musica popular? Per certi
versi sì, dato l’uso che se ne faceva; per altri no, dato lo statuto di “serietà” oggi attribuito a quel repertorio. Il quesito probabilmente è destinato a non avere soluzione, almeno finché sarà l’appartenenza a specifici repertori o generi ad essere considerata determinante ai fini dell’effettiva distinzione fra popular e non popular.
«Quello che un termine come popular music tenta di fare è mettere
un dito su quello spazio, su quel terreno di contraddizione — tra ciò
che è “elitario” e ciò che è “comune”, tra dominante e subalterno, tra
ieri e oggi, fra nostro e loro, ecc., e organizzarlo in modi particolari»
[Middleton 1985, p. 27]. Quello spazio, nell’immediatezza della tensione tra il reale e il virtuale, e tra l’uguale e il diverso, è dunque la
mia società; il suo tempo è il qui e ora. Ma se la popular music in
quanto fenomeno vero e vibrante, viene neutralizzata e incasellata «in
uno schema accademico che tiene a debita distanza la vita quotidiana
e l’esperienza comune» [Shepherd 1985, p. 63], non si potranno mai
cogliere il suo significato e la sua rilevanza effettivi. Proprio per questo è necessario sapere molto di più su «come la vita quotidiana e
l’esperienza comune entrino nelle strutture e nelle trame musicali, [e
su come] queste strutture e queste trame diano espressione alla vita e
all’esperienza». E sotto questo profilo è importante parlare a produttori e consumatori di musica e trattare le loro informazioni e opinioni sul
loro mondo come valide prima di impegnarsi in spiegazioni critiche e
teoriche [Shepherd 1985, p. 64].
Se il “terreno di contraddizione” (o campo di tensioni) organizzato
dalla nozione di popular, è il qui e ora della vita quotidiana, ci troveremo immediatamente di fronte a una delle valenze implicite nella definizione della popular music come musica di consumo: musica di tutti
i giorni, dunque da consumare quotidianamente. In questa prospettiva
la sua specificità comincerà a delinearsi non più in riferimento a un
repertorio oggettivo, ma all’atteggiamento soggettivo del “consumatore”, con cui essa intrattiene una relazione imprescindibile e costitutiva.
Il campo dell’investigazione teorica pertanto, oltre al prodotto, dovrà
comprendere il produttore, oltre all’oggetto il contesto. Ma poiché gli
strumenti musicologici tradizionali sono efficaci solo per l’analisi delle forme musicali e non per l’analisi delle relazioni (tra forme e contesti, fra produzioni ed esperienza musicale, ecc.), affrontare il problema
Popular music: dai limiti della definizione alla ricchezza dell’esperienza 113
di come la vita quotidiana e l’esperienza comune penetrino le trame
della musica significa necessariamente aprirsi alle griglie interpretative che caratterizzano il più generale campo teorico delle scienze umane; il significato della nozione di popular, infatti, è connesso tanto con
la qualità dell’esperienza umana generata, quanto con la forma musicale prodotta (secondo Mario Baroni è la musicologia sistematica a
dedicarsi «per suo statuto alla conoscenza scientifica dei vissuti o esperienze musicali» [Baroni 1994, p.68]).
La vita quotidiana, afferma la sociologia, consiste in ciò che ci appare prossimo e ricorrente, nello spazio–tempo esistenziale in cui sperimentiamo la sensazione di essere a casa nel mondo [cfr. Jedlowski
2005, p. 18]. Prossimità e ricorrenza sono anche lo spazio e il tempo
della popular music: non è con essa, infatti, che il cinema (dove le
canzoni sono usate particolarmente per sottolineare il carattere quotidiano, comune della storia narrata) ha risolto la contestualizzazione
sonora della quotidianità? Ma prossimità e ricorrenza, ancora, sono le
dimensioni dell’esperienza comune, di quell’esperienza quotidianamente maturata che, come scriveva Walter Benjamin, ci rende capaci
di percepire attorno alle cose il sedimento di senso depositato dall’uso
e dalla memoria [Benjamin 1978, trad. it., pp. 399–400]. Quest’“aura”,
che crea una benefica illusione di continuità fra noi stessi e ciò che ci
circonda, avvolge anche la nostra musica, le nostre canzoni, che entrano a far parte della nostra sfera più intima dopo un progressivo processo di quotidianizzazione, un processo emotivamente assai carico,
che rappresenta «la ricorrente riconduzione dell’ignoto al familiare»
[Jedlowski 2005, p. 24], e che carica le nostre canzoni di affettività,
rendendocele infine familiari.
Ha scritto Paolo Jedlowski [2005, p. 42] che «l’esperienza è un
procedere attraverso la vita, ma è anche la capacità di riconsiderare
quello che si è vissuto e di trarne partito». Se è così, la vita quotidiana
di oggi pone seri problemi alla realizzazione di questo tipo di consapevolezza; non a caso il rischio dell’atrofia dell’esperienza era, secondo Benjamin, ciò che incombeva pericolosamente sulla modernità
[Benjamin 1962, trad. it. pp. 100–130].
Costretta in mutazioni prospettiche troppo accelerate, e sommersa
da un quantitativo impressionante di informazioni mediate e decontestualizzate, oggi la soggettività individuale rischia infatti la disgregazione del proprio vissuto, manifestando quella propensione alla schizofrenia che contraddistingue psicologicamente la sensibilità contemporanea. In questo contesto, la capacità di trovare un senso alle pro-
114
Nadia Capogreco
prie esperienze assume un’importanza vitale. Ed ecco che «nel concreto del proprio quotidiano ciascuno lavora a ricomporre i frammenti
delle proprie conoscenze e di sé» [Jedlowski 2005, p. 46]. Anche la
musica, in questo incessante tentativo di riconnettere e dare ordine al
nostro mondo interiore opera, a suo modo, per rispondere alle domande di senso poste dalla quotidianità.
Si dice che l’umanità del Novecento occidentale abbia consumato in
una sola settimana, sotto forma di canzoni, una quantità di musica pari a
quella che gli antenati di due o tre generazioni prima consumavano nel
corso di più anni. La riproducibilità sonora, in tutto questo, ha certamente le sue responsabilità. Ma è evidente che se questa musica si ascolta è essenzialmente perché piace. Riconoscibilità, familiarità, orecchiabilità, semplicità, ripetitività, comprensibilità, fisicità, sono fra le
piacevoli caratteristiche che fanno di essa l’esperienza privilegiata del
presente soggettivo. L’interesse della popular music risiede infatti «nella complessità dei suoni “del momento, di ora” contenuti nel presente
musicale» [Tagg 1989, p. 38]. Proiettato nella virtualità dello spazio sonoro, infatti, quest’ultimo si dilata magicamente, offrendo la benefica illusione di lasciarsi finalmente esperire nei plurivoci percorsi tracciati
dall’immaginario.
La popular music organizza dunque spazi simbolici “protetti” dove, attraverso una sorta di messa in scena dei vissuti emozionali, si articolano positivamente i significati cruciali di esseri umani concretamente dati. Operando una vera e propria microterapia del — e nel —
quotidiano [Baroni–Nanni 1989, p. 255], essa si incarica di dar voce
alle istanze umane nate dall’insanabile tensione tra il tempo sociale,
inesorabilmente scandito e orientato da logiche esterne, e il tempo individuale che, troppo spesso costretto alla rinuncia di una progettualità
consapevole e attiva, sembra manifestare la superficiale propensione a
consumarsi nella caducità del presente. Non va dimenticato, però, che
«è la domanda di esperienza […] l’altra faccia dell’adesione al presente e al culto dell'effimero» [Jedlowski 2002, p. 13].
Popular music: dai limiti della definizione alla ricchezza dell’esperienza 115
Riferimenti bibliografici
BARONI, Mario (1994) Didattica della musica e musicologia sistematica, in
G. Grazioso (a c.), L’educazione musicale tra passato, presente e futuro,
Milano, Ricordi.
BARONI, Mario – CALLEGARI, Laura (1985) Origini e storia della ”popular music”, in Fabbri (a c.) 1985, pp. 176–191.
BARONI, Mario, NANNI, Franco (1989) Crescere con il rock. L’educazione
musicale nella società dei mass–media, Bologna, CLUEB.
BENJAMIN, Walter (1962) Di alcuni motivi in Baudelaire, in Angelus Novus,
trad. it. Torino, Einaudi, pp. 87–126.
— (1978) Lettere 1913–1940, trad. it. Torino, Einaudi.
FABBRI, Franco (2005) L’ascolto tabù, Milano, Il Saggiatore.
FABBRI, Franco (a c.) (1985) What is Popular Music?, Milano, Unicopli.
— (1989) Musiche/Realtà. Generi musicali/Media/Popular music, Milano,
Unicopli.
JEDLOWSKI, Paolo (2002) Memoria, esperienza e modernità, Milano, Franco
Angeli.
— (2005) Un giorno dopo l’altro. La vita quotidiana fra esperienza e routine, Bologna, Il Mulino.
MELUCCI, Alberto (1999) Diventare persone, in C. Leccardi (a c.), Limiti della modernità, Roma, Carocci.
MIDDLETON, Richard (1985) “Popular Music”, conflitto di classe e campo
storico–musicale, in Fabbri (a c.) 1985, pp. 25–49.
SERRAVEZZA, Antonio (1987–88) La pluralità delle culture musicali e l’estetica, in La musica come sistema autonomo?, in «Culture musicali», nn.
12–13–14, pp. 17–32.
SHEPHERD, John (1985) Definizione e mistificazione: considerazioni sulle etichette come ostacoli alla comprensione dei significati in musica, in Fabbri (a c.) 1985, pp. 50–79.
— (1989) Prolegomeni allo studio critico della popular music, in Fabbri (a
c.) 1989, pp. 44–69.
TAGG, Philip (1989) Musica popolare, innovazione, tecnologia, in Fabbri (a
c.) 1989, pp. 35–43.
Massimo Distilo
Popular music e giudizi di valore*
Come ha notato Dave Laing [1985], il primo uso registrato del
termine punk risale al 1596. Il termine aveva un senso dispregiativo ed
era utilizzato per indicare concetti quali quello di “prostituta, meretrice” e simili. Nell’Ottocento, negli Stati Uniti, il termine era usato per
indicare genericamente qualunque cosa o persona indegna, e specificamente era adoperato per insultare gli omosessuali. Nel Novecento
troviamo il termine punk soprattutto nello slang americano, con uno
slittamento del suo significato: si è passati da un riferimento alla sessualità “deviante”, ad una forma generica di insulto. Negli anni settanta i critici musicali statunitensi cominciarono ad usare il termine punk
rock per indicare un rock di cattiva qualità, che si caratterizzava per
uno stile aggressivo, da classi “inferiori”.
Erano momenti in cui era usuale, con notevole disinvoltura, tramite
l’utilizzo di termini dal significato piuttosto perentorio, esprimere in
forma diretta un giudizio di valore netto (accettabile o meno) su determinati fenomeni musicali. Attualmente la situazione è diversa ed il
formulare giudizi di valore ben precisi su questo genere di fenomeni
musicali, senza incorrere in vivaci proteste che delegittimano a priori
anche il solo voler pensare di esprimere un giudizio di tal tipo, sembra
essere diventata un’impresa ardua.
È ancora viva l’eco del fermento di protesta suscitato da Egidio
Pozzi mentre, in un suo intervento all’interno di questo convegno, accennava a chiedersi quale potesse essere il valore artistico di alcuni
fenomeni musicali oggetto di discussione.
La musicologia, come disciplina che studia le manifestazioni musicali umane, ha certamente come suo compito quello di registrare nel
modo più oggettivo possibile il manifestarsi e l’evolversi di ogni evento umano che abbia in qualunque modo connessione con il fare musica. Ma ci possiamo chiedere: il suo compito termina qui? O ci sarebbe
anche il diritto/dovere di esprimere dei giudizi di valore sui fenomeni
musicali oggetto di studio?
*
Questo breve testo è la forma meditata di un intervento proposto durante la discussione della prima sessione.
117
118
Massimo Distilo
La diversità di posizione geografica delle società umane e il loro
evolversi nel tempo ha, notoriamente, determinato dei notevoli cambiamenti in ciò che l’uomo ha considerato musicale o meno. Siamo
ormai abituati a muoverci al di fuori di ogni parametro prestabilito:
ciò che un tempo era rumore, oggi è suono; ciò che prima era silenzio,
bosco profondo, oggi è musica. Il punk rock degli anni settanta era un
“cattivo rock”, ma qualche tempo dopo il termine punk indicò un genere apprezzato come negazione di vecchi canoni estetico–musicali e
affermazione di nuovi.
Anche alla luce delle teorie di Gadamer [1960] e Dahlhaus [1977],
la musicologia è ben conscia della “storicità” di ogni giudizio estetico,
tuttavia è altrettanto sentita come insufficiente un’impostazione che si
limiti a criteri di tipo analitico–descrittivo e che mutua i suoi metodi
da quelli delle scienze naturali. Se punk era un tempo un insulto, se
folk era quasi sinonimo di “bifolko”, se musica leggera aveva un senso pressoché dispregiativo, ma gradualmente questi generi sono assurti ad oggetto di attenta riflessione musicologica, ciò può esimere del
tutto il musicologo dall’esprimere, sui fenomeni in tali generi ricadenti, un giudizio di valore basato su parametri che devono comunque avere dei solidi e giustificati fondamenti estetici?
La risposta non è facile. Ma sembra comunque opportuno debba essere accettato che la popular music possa essere messa in gioco anche da
questo punto di vista, essendo diventata oggetto di studio e analisi musicologica. Non si può pretendere a priori una sospensione del giudizio,
una sorta di epoché, da parte dello studioso, al momento in cui entra nel
campo della popular music. Nel Novecento avanguardie colte e popular
music hanno attinto non di rado allo stesso materiale sonoro, seguendo in
diversi casi procedimenti tecnologici sperimentali non dissimili. Le avanguardie hanno significativamente contribuito ad abbattere molte di
quelle barriere che per tanto tempo hanno impedito a diverse espressioni
musicali di assumere dignità di evento artistico.
Oggi ci si domanda se le “cover band” siano un fenomeno legato
allo sfruttamento commerciale di forme di mitizzazione spesso generate artificialmente dai media, o se si tratti invece di una interessante
evoluzione del fare musica dei gruppi giovanili in una società che rapidamente crea e disfa i propri miti. Il fenomeno delle “cover band”
ricalca però modalità di fare musica ampiamente affermatisi in altri
ambiti musicali. Riproporre dal vivo musica composta da altri decantati personaggi del panorama musicale, non è di certo un fenomeno
nuovo. Se in un programma attuale di concerto di musica classica o di
Popular music e giudizi di valore
119
stagione lirica troviamo, nella grandissima parte dei casi, opere di
Bach, Mozart, Schubert, Puccini, Verdi, Debussy, Rachmaninoff e simili, tutti miti consolidatisi nel tempo, non dovrebbe spiazzarci più di
tanto il fatto che oggi un notevole numero di giovani gruppi musicali
tende a riproporre in forma monografica nelle proprie serate le “opere” dei Pooh o di Ligabue. Anche in ambito classico infatti è andato di
moda in certi periodi il concerto monografico.
Ma una volta che il fenomeno musicale assurto a dignità di opera
d’arte è stato analizzato dal punto di vista sociologico, commerciale,
semiologico–musicale tramite adeguate metodologie che prendano
magari in considerazione anche il cosiddetto livello neutro, secondo i
dettami di Jean Jacques Nattiez [1987], sulla scorta di Jean Molino, ci
si potrà ancora scandalizzare se il musicologo vorrà esprimere su tale
fenomeno musicale anche un giudizio di valore?
L’unica cosa che si dovrà chiedere alla musicologia è di mettere a
punto degli strumenti adeguati, atti ad impedire che la formulazione di
un tale giudizio possa essere viziata da errori di prospettiva derivanti
da una non raggiunta uniformità di criteri. Non si potrà mai esprimere
un giudizio sul sound di una “cover band”, o sullo swing di Ornette
Coleman avvalendosi delle categorie utilizzate per condurre un’analisi
sulla musica tonale di Beethoven.
120
Massimo Distilo
Riferimenti bibliografici
DAHLHAUS, Carl (1977) Grundlagen der Musikgeschichte, Köln, Arno Volk
Verlag Hans Herig K.G. (trad. it. Fondamenti di storiografia musicale,
Fiesole, Discanto Edizioni, 1980)
LAING, Dave (1985) One chord wonders: power and meaning in punk rock,
Milton Keynes (trad. it. Il punk. Storia di una sottocultura rock, Torino,
EdT, 1991).
GADAMER, George (1960) Wahreit und Methode, Tübingen, J.C.B. Mohr
(trad. it. Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1983)
NATTIEZ, Jean Jacques (1987) Il discorso musicale. Per una semiologia della
musica, Einaudi, Torino.
Seconda sessione
Conservatori, scuole secondarie, scuole private di musica
Emilio Galante
La popular music in conservatorio
Introduzione
Il titolo di questa relazione, oggi argomento dibattuto e fecondo,
solo vent’anni fa sarebbe parso sacrilego ai più. La distinzione sdegnosa fra musica colta, artistica, e musica leggera, commerciale, continua a fare parte dell’ovvio e snobistico patrimonio culturale di molti
musicisti “classici”, come hanno dimostrato anche recentemente certe
interviste a proposito dei tagli alla cultura per la Legge Finanziaria del
2006. Nei musicisti colti delle più recenti generazioni l’atteggiamento
è però poco alla volta cambiato, fino a ribaltarsi quasi radicalmente in
uno sguardo curioso e disincantato verso ciò che è altro, sia esso il
rock, il jazz, la musica da film o più in genere la sconosciuta pratica
dell’improvvisazione, che gli “altri” praticano con tanta facilità.
Chi scrive sapeva perciò di condividere pienamente lo spirito del
tempo quando verso la metà degli anni Novanta cominciò a trascrivere
per un accademico quintetto a fiato (flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto) alcuni capolavori del rock progressivo (Genesis, King Crimson,
Yes, Emerson Lake & Palmer, Frank Zappa, Gentle Giant), poi riunito
in un CD dal titolo Kamera in Rock. L’operazione era almeno doppiamente antifrastica. Da un lato si trattava un ensemble da camera classico
come fosse una band alle prese con un repertorio di cover, dall’altra si
agiva su almeno una di queste cover compiendo il tragitto inverso dell’originale. Se Emerson Lake e Palmer arrangiando Pictures at an Exhibition di Musorgskij cercavano nel “classico” una sorta di certificazione
di professionalità, anche attraverso l’esibizione del virtuosisimo strumentale, noi arrangiando Emerson Lake e Palmer cercavamo una nuova
certificazione di modernità, di adesione alla contemporaneità e non più
solo agli ammuffiti reperti del museo classicista.
La trascrizione su pentagramma e il relativo lavoro analitico su opere prima esperite solo attraverso la pratica dell’ascolto ha inoltre
avuto una notevole importanza sul mio lavoro di compositore che della comprensione di quel linguaggio si è nutrito. Scrivere musica o trascriverla per il proprio ensemble implica inoltre un atteggiamento verso il proprio lavoro musicale che è diventato inconsueto nel corso del
Novecento. La professione dell’esecutore e quella del compositore si
123
124
Emilio Galante
sono sempre più divise e specializzate e gli studi di composizione
all’interno del Conservatorio erano, e sono ancora, un reparto piuttosto esoterico dove lo studente che si forma acquisisce strumenti eminentemente intellettuali e non tecnico–professionali, come fanno invece gli esecutori. Rigettare un ponte fra queste specializzazioni, scrivere e suonare, che fino all’inizio del Novecento erano naturalmente
connesse, è un’esigenza sempre più sentita.
La riforma
Fino all’avvento della riforma, che oggi sta uscendo dalla sua fase
sperimentale (Decreto Ministeriale n. 629 del 8 ottobre 2003), per entrare in quella ordinaria (con regolamento attuativo con D.P.R. n. 212
del 8 luglio 2005), il Conservatorio ha risposto molto debolmente al
cambiamento in atto della società musicale, a causa delle leggi vetuste
che ne governavano l’ordinamento, i programmi didattici, gli orari degli insegnanti (un Decreto Regio del 1930). Nonostante ciò negli ultimi vent’anni sono stati istituiti nel Conservatorio gli insegnamenti del
jazz e della filologia barocca, portando con sé gli ovvi fermenti di novità non accademiche.
È stata però la sperimentazione della Riforma a cambiare completamente le carte in gioco: il Ministero, vuoi per incertezza sul da farsi,
vuoi per la presenza di qualche animo illuminato, vuoi per caso, ci ha
lasciato per un tempo indeterminato nel limbo benefico della sperimentazione, trasferendo ad ogni Conservatorio la potestà di decidere il proprio ordinamento, i corsi da attivare, i programmi. Se da una parte questa libertà è un regalo del quale dobbiamo approfittare a piene mani,
perché probabilmente passeranno molte generazioni prima che venga
nuovamente elargito, d’altra parte ci pone di fronte all’obbligo, anche
fosse imbarazzante, di una riflessione sulle ragioni del nostro esistere.
Si tratta in particolare di comprendere se oggi prevalga fra le nostre
finalità quella di fornire una cultura musicale generale, come nessuna
altra scuola pubblica dà, oppure quella di preparare lo studente ad un
mestiere, sul tradizionale modello delle antiche botteghe artigiane e
artistiche. Alla domanda se si sia professori o maestri non si può che
rispondere in maniera duplice. Insegniamo in un istituto di cultura musicale i cui allievi lavoreranno a loro volta come insegnanti ma aspiriamo ad essere maestri, che tramandino ai loro allievi l’arte di essere
musicisti.
La popular music in conservatorio
125
Se fra le nostre finalità prevale quella di formare professionisti che
posseggano gli strumenti necessari per affermarsi sul mercato del lavoro musicale è quantomeno il caso di chiedersi di che mercato si tratti in Italia: quello delle orchestre liriche o sinfoniche? Dei gruppi da
camera? Del solismo? In quest’ordine ed in senso decrescente, si immagina solitamente vi sia una possibilità di impiego per i nostri migliori allievi. Ciò corrisponde ad uno scenario che tende da ormai parecchi anni a disgregarsi. Meno orchestre, meno concerti di musica
classica, meno pubblico — così appare la realtà della vita musicale
italiana. Sembra un paradosso in quanto la musica è sempre più importante nella vita del singolo, invade spazi di silenzio che un uomo di
un secolo fa avrebbe considerato naturali, come ha notato più volte nei
suoi scritti Franco Fabbri. Ma la musica di oggi è “altra”.
Chi la fa non sono i professionisti della musica classica–colta, ma
altri musicisti, che sanno scrivere, eseguire e produrre musica per il
cinema, per la pubblicità, canzoni pop e rock; insomma ciò che le gente comune è abituata a sentire alla radio, alla televisione, i cui dischi è
solita comprare o scaricare da Internet. Credo sia giunto il momento di
chiedersi perché mai non ci si debba occupare di tutto ciò. Se fino a
qualche decennio fa la risposta snob consisteva nel rifiuto di mischiare
la “vera” musica, quella classica, con la musica leggera, oggi è la preoccupazione per la nostra sopravvivenza a imporci un cambiamento di
prospettiva. Chi vorrebbe ancora la musica leggera fuori dalle Accademie, in quanto estranea all’“alta formazione”, per lo più non conosce esattamente di cosa si tratti. Le competenze necessarie a ideare e
produrre la popular music sono diventate estremamente articolate e
degne di studio. Inoltre ci obbligano ad un confronto con la tecnologia
ed a una riflessione sul suo utilizzo ormai ineludibile.
Il biennio di popular music al Conservatorio di Trento
Da queste considerazioni è nato il progetto di dar vita ad un corso
di popular music al Conservatorio di Trento. Una riflessione sulla sua
collocazione è parsa preliminare alla scelta dei contenuti. L’odierna
strutturazione dei corsi in Conservatorio è affine a quella universitaria
e prevede perciò un triennio di primo livello ed un biennio di specializzazione. Il triennio inferiore corrisponde agli ultimi tre anni dei corsi tradizionali di ogni strumento ed il diploma che si ottiene è equiparato a quello tradizionale. Secondo le linee guida del Ministero la spe-
126
Emilio Galante
rimentazione dei nuovi programmi deve avvenire su insegnamenti preesistenti, soprattutto per quanto riguarda il triennio, mentre può svilupparsi con una libertà parzialmente maggiore per quanto riguarda il
biennio superiore che, non corrispondendo a nessun ordine di studi
tradizionali, soffre di minori vincoli.
Non essendo la popular music un insegnamento preesistente abbiamo deciso, per essere certi di ottenere l’autorizzazione ministeriale
che probabilmente non sarebbe stata concessa per un triennio, di chiedere la sperimentazione di un biennio di secondo livello, nell’ambito
della scuola di Composizione, che prevedesse come requisiti di ammissione un diploma di Composizione o di Jazz e in via eccezionale
(dove l’eccezionalità può però paradossalmente costituire la norma)
un altro e diverso diploma di Conservatorio o di triennio di primo livello, purché siano accertate attività professionali e formative avviate
sul campo e previo esame d’ammissione.
La proposta del Conservatorio di Trento è stata accettata dal Ministero, che ha attivato il corso per l’Anno Accademico 2005/06, ma
non è stata finora premiata da un sufficiente numero di iscritti (a nostro modo di vedere quantificabile in almeno cinque–sei allievi) per
potere sostenere economicamente gli oneri di un corso di studi dispendioso.
Nel nostro piano formativo (POF) si possono distinguere quattro
direzioni parallele. La prima è quella compositiva, sviluppata secondo
i tradizionali sistemi di insegnamento della composizione, anche se
applicati a nuovi argomenti. Ne fanno parte insegnamenti come
“Composizione della canzone”, “Arrangiamento”, “Composizione per
il cinema”, “Composizione per la pubblicità”.
La seconda è quella storico–teorica. È l’unica che possa approfittare
di sedimentati ed importanti contributi accademici, grazie alla più che
ventennale esistenza della International Association for the Study of
Popular Music (IASPM). È l’aerea dove più facile e proficua sarebbe la
collaborazione con l’Università (in particolare modo quella di Trento,
nella quale è sviluppata, grazie a docenti come Rosanna Dalmonte, una
sensibilità particolare verso le tematiche della popular music).
La terza è una area tecnologica, da considerarsi di importanza fondamentale fra tutte: a questo proposito va aggiunta una piccola parentesi. A Trento abbiamo deciso di non chiedere l’apertura di una cattedra di "Musica elettronica" in quanto ciò ci avrebbe costretto ad un
corso accademico legato alla sperimentazione elettronica piuttosto che
allo studio delle tecniche informatiche applicate. Anche in questo caso
La popular music in conservatorio
127
è da temere l’atteggiamento snob di tanto accademismo elettronico
che guarda con un certo disgusto a sequencer e strumenti virtuali, utilizzati intensamente nella popular music. D’altronde abbiamo ritenuto
di fondamentale importanza introdurre in Conservatorio lo studio
dell’informatica applicata, non solo come materia complementare allo
studio di altri insegnamenti “caratterizzanti” (come recitano le linee
guida del Ministero), ma con un suo statuto caratterizzante. Il corso di
popular music è nato come confluenza di due progetti, l’uno più propriamente dedicato alla popular music e l’altro all’informatica musicale. Fanno parte dell’area tecnologica insegnamenti come “Tecniche e
strumenti della produzione discografica (dalla registrazione alla post–
produzione)” e “Tecniche e strumenti della produzione musicale digitale 1 (dalla registrazione alla post–produzione)”.
La quarta direzione è quella esecutiva, in senso passivo per così dire: prevede un laboratorio di musica d’insieme dove il compositore–
arrangiatore verificherebbe la resa pratica dei propri lavori.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Biennio Superiore Sperimentale di II Livello – Conservatorio di Trento
Anno Acc. 2005/2006
Scuola di Popular Music
Requisiti per l’Ammissione
– Possesso del Diploma di “Composizione” o “Musica Jazz”, nella formulazione
tradizionale o in conformazione sperimentale approvata dal Ministero. L’ammissione
al biennio, oltre che dal possesso di tale titolo, è regolamentata da un esame di ammissione, che stabilirà l’elenco degli allievi ammissibili e una graduatoria. In relazione al
numero programmato ogni anno, verrà poi individuato il gruppo di allievi effettivamente ammessi al biennio specialistico.
– In via eccezionale, potrà essere consentito l’accesso all’esame di ammissione
anche a studenti non in possesso del Diploma di “Composizione” o di “Musica Jazz”
o titolo sperimentale equiparato. Questi studenti dovranno essere in possesso di un
qualsiasi altro diploma di Conservatorio — o titolo sperimentale approvato dal Ministero e equiparato a Diploma di Conservatorio. L’accesso all’esame di ammissione sarà vagliato, sulla base di certificazioni di interessi e attività formative avviate nel
campo della popular nusic. L’esame di ammissione costituirà un successivo momento
di verifica della preparazione e delle potenzialità dell’allievo.
– Il possesso di laurea o titolo equipollente consente l’attribuzione di crediti, da
valutare in relazione alla laurea conseguita e al piano di studi cui si è conformato il
percorso formativo universitario, riguardando tutte le peculiarità e le esigenze formative del Biennio specialistico qui in discorso.
128
Emilio Galante
Primo Anno
Attività formative
Di base
Di base
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Affini o integrative
Affini o integrative
Insegnamento
Ore
Esami CF
Storia ed Estetica della Musica:
Storia della popular music
30
1
6
Storia e analisi del repertorio:
popular music
30
1
6
Tecniche di composizione musicale:
Composizione della canzone 1
25
1
8
Tecnica di strumentazione e orchestrazione: Arrangiamento 1
20
1
7
Tecniche di composizione musicale:
Composizione per il cinema
25
1
8
Elettroacustica:
Tecniche e strumenti della produzione musicale digitale 1 (dalla registrazione alla post–produzione)
40
1
8
Laboratorio di improvvisazione e
composizione applicata Musica d'insieme (big band)
20
1
6
Altre attività formative:
Tecniche e strumenti della produzione discografica (dalla registrazione
alla post–produzione)
20
1
2
210
6
9
60
Attività lib. scelte Stages, clinics, master class con
esperti e altre attività formative, anche esterni, a scelta dello studente
Totale anno
La popular music in conservatorio
129
Secondo anno
Attività formative
Di base
Di base
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Affini o integrative
Affini o integrative
Attività lib. scelte
Prova Finale
Totale anno
Insegnamento
Ore
Esami
CF
Diritto e legislazione dello spettacolo:
la popular music
15
1
3
Storia e analisi del repertorio:
popular music
15
1
3
Tecniche di composizione musicale:
Composizione della canzone 2
25
1
8
Tecnica di strumentazione e orchestrazione: Arrangiamento 2
20
1
7
Tecniche di composizione musicale:
Composizione per la pubblicità
20
1
7
Elettroacustica:
Tecniche e strumenti della produzione
musicale digitale 1 (dalla registrazione alla post–produzione)
40
1
8
Laboratorio di improvvisazione e
composizione applicata: Musica d'insieme (big band)
20
1
6
Altre attività formative:
Tecniche e strumenti della performance (amplificazione dei concerti, strumenti, tecniche digitali)
20
1
2
Stages, clinics, master class con
esperti e altre attività formative, anche
esterni, a scelta dello studente
Prova Finale
6
10
185
TOTALE
395
1
8
10
60
214 120
130
Emilio Galante
Il biennio di popular music nei Conservatori di Frosinone e Bari
Vi sono altri due Conservatori in Italia che hanno attivato, con nomi alternativi, corsi sulla popular music. La differente dizione del corso dipende dal tentativo di evitare i veti ministeriali. Non essendo possibile, come si è detto, avviare nel triennio un corso denominato in
modo diverso da quelli già approvati nel 2003 dal Ministero, il Conservatorio di Frosinone, analogamente a quanto fatto dal Conservatorio di Bari, ha deciso di avviare un "modulo B" all'interno della scuola
di Jazz, il cui piano di studi triennale, elaborato sulla base di quello
già approvato dal Ministero nel 2003, aveva avuto l’approvazione ministeriale nel dicembre del 2003. Nell'autunno del 2004, dunque, il
Conservatorio di Frosinone ha attivato un corso di Jazz attivo sul fronte classico (modulo A) e su quello della popular music (modulo B)
(chiamata di “musica moderna” dagli estensori del progetto, Stefano
Caturelli e Paolo Teodori).
Il Conservatorio di Frosinone ha inoltre attivato un corso di "Musica
moderna e per lo spettacolo", come percorso formativo per diverse scuole del biennio (Composizione, Pianoforte, Chitarra, Canto, Clarinetto,
Sax), la cui dizione l’anno seguente è diventata “Musica moderna per lo
spettacolo — popular music”. La risposta dell’utenza è stata entusiastica,
con più di 120 domande di ammissione per l’anno 2005/06.
Il progetto di Frosinone pone due ordini di riflessioni. Da un lato
parrebbe inopportuno chiamare le cose con un nome che loro non
compete: chiamare la popular music “jazz modello B” equivale a nasconderne l’esistenza, ad insegnarla come fosse materia bollata dall’inquisizione ministeriale. Oggi i regolamenti attuativi e il passaggio
da un ordinamento sperimentale ad uno ordinario dovrebbero consentire l’attribuzione di una corretta denominazione, e con essa la liceità
di un triennio di popular music.
D’altra parte l’alto numero di iscrizioni al triennio di Frosinone
versus quello deludente del biennio di Trento si configura come un evidente richiamo alla natura della nostra utenza. Chi studia la popular
music nella maggioranza dei casi non proviene dal Conservatorio, non
ne possiede il diploma, è spesso autodidatta, ha seguito studi di base
(armonia, storia della musica, solfeggio) non sistematici che dovrà espletare in modo più specializzato per diventare un professionista. Insomma deve poter entrare al triennio, probabilmente come esecutore
prima che come compositore. Forse, come accade con il jazz, lo stesso
insegnante di riferimento, qualsiasi sia strumento da lui suonato, po-
La popular music in conservatorio
131
trebbe insegnare ai differenti allievi, siano essi chitarristi elettrici, tastieristi, bassisti, batteristi o cantanti. Un triennio siffatto costituirebbe
poi titolo sufficiente per entrare naturalmente al biennio che segue,
dove gli insegnamenti di tipo compositivo sarebbero prevalenti.
Conclusioni
Si è detto delle ragioni che oggi obbligano il Conservatorio ad interessarsi di popular music, ma ci si può di converso chiedere come reagirà la popular music all’intrusione di un agente sospetto come il Conservatorio. Chi la considera campo della spontaneità e dell’espressione
giovanile, chi ne ragiona in termini sociologici probabilmente è preoccupato piuttosto che rassicurato da questa nuova presenza. Chi invece
ne ragiona in termini musicali comprende come questo sia uno dei terreni più convenzionalizzati della musica d’oggi, e in quanto tale soggetto con estremo profitto all’insegnamento ed all’apprendimento delle sue regole. Un campo di studi altamente convenzionalizzato consente infatti una più semplice elaborazione di metodi didattici.
Grazie alla IASPM un studioso ha oggi a disposizione una notevole
mole di lavori analitici su molti aspetti della popular music, i quali si
riveleranno certamente utilissimi al momento di approntare un metodo
didattico. Nell’analizzarli mi sovviene spesso uno dei miei progetti di
tesi di laurea, poi svanito, sulle Memoires di Gretry, che aveva ideato
un corpo di regole, quasi di ricette, per il compositore d’opera, da insegnare e utilizzare nella propria musica. Operazione possibile nell’ambito convenzionale dell’opera settecentesca e della teoria degli affetti, ed allo stesso modo probabilmente possibile nell’ambito della
popular music, dove mi pare viga, all’interno di strutture formali consuete, che governano la dispositio, un vocabolario condiviso di figure
musicali che governano l’elocutio.
Lascio ad altri ogni considerazione ideologica sui benefici che la
popular music trarrà in una simile prospettiva, ma mi pare ovvio che
l’insegnamento normativo di ciò che è per sua natura convenzionale
(come la popular music) sia congenito allo spirito dell’accademia, e
che di norma il professionismo venga educato all’interno di istituzioni
preposte alla sua cura.
Maurizio Boco
La Fonderia delle Arti
(Roma)
La Fonderia delle Arti è una struttura privata con sede a Roma in
Via Assisi nel quartiere appio–tuscolano, che ha al suo interno corsi di
musica, teatro e fotografia. Ho deciso di creare questa struttura dopo
aver collaudato per anni, con un gruppo di validi musicisti/insegnanti,
un programma didattico altamente qualificato e dopo aver constatato
che purtroppo la cattiva amministrazione o la gestione approssimativa
di alcune scuole private spesso vanifica gli sforzi e le energie di molti
professionisti. Questo è esattamente quanto accaduto recentemente ad
una nota struttura didattica privata romana nella quale ho prestato la
mia opera per oltre un decennio e che ha spinto me e molti miei colleghi ad organizzarci autonomamente.
La particolare architettura degli ambienti che ho rilevato (una ex
fonderia abbandonata dagli anni Sessanta) e l’ampiezza dei suoi locali
mi hanno spinto a realizzare un’idea che inseguivo da qualche tempo.
Ho deciso quindi di coinvolgere immediatamente nell’attività alcuni
amici di vecchia data come il musicista Andrea Polinelli, l’attore
Giampiero Ingrassia e il fotografo Massimo Santorelli, e far nascere
così la Fonderia delle Arti. L’esperienza di Ingrassia, che proviene
dalla scuola di Gigi Proietti, mi è sembrata da subito l’idea migliore
per impostare la didattica relativa alla scuola di recitazione e altrettanto direi di Santorelli, fotografo professionista di esperienza ultradecennale, per l’impostazione dei corsi di fotografia. La mia idea era quella
di dar vita ad una struttura che fosse in qualche modo più rispondente
a certe esigenze dei giovani che vogliono avvicinarsi alla musica e al
mondo dello spettacolo più in generale. Questa è stata circa venticinque anni fa la stessa motivazione che spinse alcuni coraggiosi musicisti/imprenditori ad investire nelle scuole private di musica le loro scarse risorse economiche.
La Scuola Popolare di Testaccio e il St.Louis, che possiamo considerare le prime strutture che hanno tentato di indirizzare la didattica
musicale verso la musica moderna, nacquero proprio sul finire degli
anni Settanta a Roma per rispondere a una esigenza che cominciava a
manifestarsi tra i giovani che volevano avvicinarsi allo studio della
musica moderna. L’obiettivo era quello di creare una alternativa alla
133
134
Maurizio Boco
didattica del Conservatorio che all’epoca (e ancora fino a pochissimi
anni fa) ignorava completamente alcuni corsi come quello della batteria o della chitarra elettrica nonché più in generale l’esistenza stessa di
alcune tra le forme più importanti della musica moderna come il jazz e
appunto la popular music.
Oggi, dopo vari tentativi pionieristici operati da direttori di vari
Conservatori italiani, sono state inserite cattedre di musica jazz in una
prima fase sotto forma di corsi sperimentali. E ora dopo anni da quei
primi tentativi si comincia a parlare di popular music. Cerchiamo di
analizzare il perché oggi si creano i presupposti per questi confronti
tra le varie strutture didattiche.
Il Conservatorio è sempre stato considerato giustamente come
l’istituzione preposta all’insegnamento e alla conservazione del patrimonio appartenente alla musica classica. Lo studio era dunque indirizzato agli strumenti utilizzati nelle orchestre sinfoniche di tutto il mondo e non prevedeva alcuni strumenti fondamentali nella musica popolare ma assolutamente estranei alla cultura classico/sinfonica. L’esame
di storia della musica conseguentemente non prevedeva il minimo
cenno a quegli autori che non avessero punti in comune con la cultura
classica e lo stesso dicasi per il repertorio analizzato. Ora, questo
modus operandi non avrebbe alcun motivo per essere messo in discussione se non per un deciso e brusco cambio di obiettivi e strategie dei
Conservatori stessi come luogo che crea occupazione per i suoi iscritti. Il problema principale infatti è rappresentato dal fatto che la didattica adottata per tanti anni nei Conservatori risulta assolutamente inadeguata dal punto di vista occupazionale in un periodo storico come
quello attuale in cui le orchestre sinfoniche chiudono e i teatri hanno
risorse sempre più scarse per finanziare le opere che un tempo abbondavano nei loro programmi. Prendiamo ad esempio i cantanti, o i chitarristi o ancora i percussionisti diplomati in Conservatorio. Non hanno alcuna opportunità negli ensemble di musica pop e sicuramente anche i suonatori di strumenti a fiato hanno vita difficile. Decisamente
migliore è la situazione per gli strumenti ad arco che restano appannaggio dei Conservatori per la quasi assoluta mancanza di insegnanti
di violino jazz nelle scuole private.
Nei Conservatori tutto, dalla tecnica strumentale allo studio della
Storia della Musica, è stato fino ad oggi finalizzato alla musica classica e dunque limitava l’occupazione dei suoi migliori diplomati a quel
settore. Alcune materie come ad esempio quelle riguardanti l’utilizzo
della tecnologia in tutte le sue forme, dagli effetti per strumenti ai
La Fonderia delle Arti
135
programmi più utilizzati dell’informatica musicale non hanno trovato
adeguato spazio nei Conservatori. Tutto ciò è in realtà sempre stato
appannaggio delle strutture private che invece hanno sempre avuto
come obiettivo, sia dal punto di vista strettamente culturale che da
quello più prettamente occupazionale, l’insegnamento del jazz e della
popular music.
Nella struttura che dirigo insieme al collega Andrea Polinelli, i
programmi di Storia della Musica sono stati al contrario redatti tenendo conto del patrimonio classico che viene studiato obbligatoriamente
dagli allievi del triennio di base per un trimestre ogni anno mentre i
restanti trimestri vengono dedicati alla storia del jazz e della musica
pop. Quello che per ovvie ragioni non trova spazio invece è lo studio
sullo strumento del repertorio classico con qualche piccola eccezione
per il pianoforte.
Nelle strutture private gli insegnanti provenienti da studi classici
hanno sempre trovato una adeguata occupazione nei corsi di loro pertinenza. I corsi di acustica e storia della musica del Novecento che si
tengono presso la Fonderia delle Arti, ad esempio, sono tenuti dal Maestro Marcello Filotei proveniente dal Conservatorio di S.Cecilia di
Roma e quelli di teoria e solfeggio dal Maestro Cesare Buccitti.
Non si può dire altrettanto riguardo la possibilità di inserimento nei
Conservatori di professionisti esterni che a volte, pur avendo buone
competenze e pluriennale esperienza in alcune materie, non trovano
spazio per la mancanza di titoli praticamente inesistenti nel settore
delle musiche extra–colte. Credo sarebbe auspicabile un deciso cambio di direzione su questo ultimo punto e magari il pretesto potrebbe
essere rappresentato proprio dall’inserimento della popular music come materia complementare nei Conservatori.
Credo dunque che questa apertura nei confronti di musiche fino ad
ora escluse dalla cittadinanza nell’istituzione Conservatorio possa essere senza dubbio attribuita ad un cambio di rotta che vada più incontro alle esigenze dei giovani allievi dei Conservatori. Ma a quale prezzo? O meglio: come far convivere le due cose? Le nuove materie inserite prenderebbero il posto di altre o si andrebbero a sommare a quelle
già esistenti? Sarebbero corsi approfonditi o solo delle visioni generali
e di massima di certe materie?
La parte dedicata alla storia della musica classica all’interno della
didattica di una struttura come la Fonderia delle Arti è ovviamente
molto meno approfondita di quella sviluppata nei Conservatori, ma ritengo che sarebbe imperdonabile trascurarla del tutto (come invece
136
Maurizio Boco
fanno i programmi dei Conservatori rispetto alla popular music). Potrebbe essere questa la direzione anche per l’inserimento di nuove materie nei Conservatori?
Altra riflessione che mi viene spontaneo porre è: da quale angolazione verrebbe vista una materia come la popular music? L’insegnante
sarebbe, come avviene per esempio nelle materie teoriche come solfeggio o storia della musica, un musicista esperto della materia oppure
un musicologo o un etnomusicologo? Nel primo caso potrebbe essere
auspicabile una interazione tra i Conservatori e le scuole private che
già operano da anni in questa direzione, mentre nel secondo caso potrebbero subentrare le Università apportando il loro contributo. È solo
appunto una questione di angolazione.
Le Università credo che abbiano meno controversie per quanto riguarda i problemi di carattere occupazionale fin qui esposti. Le lauree
di etnomusicologia ad esempio sono pertinenza della Facoltà di Lettere e Filosofia e non ambiscono certamente a formare musicisti ma
piuttosto professionisti della musica che possano trovare occupazione
o nelle Università stesse o come critici, giornalisti, opinionisti del settore, ecc. In questo caso comunque non siamo in presenza di programmi che siano in grado di creare attori, musicisti o ballerini. Per quanto
riguarda invece i Conservatori e le scuole private il discorso è diverso
perché l’obiettivo finale è proprio quello di creare musicisti, attori,
ballerini, ecc.
A questo proposito vorrei fare un’altra considerazione riguardo il
ruolo degli insegnanti e il loro rapporto con gli allievi. Nelle scuole
private “serie” (mi si passi questo attributo virgolettato perché, visto il
proliferare di tali strutture negli ultimi anni, credo occorra fare dei distinguo tra quelle gestite da docenti di chiara fama e quelle che potremmo definire semplici scuole di quartiere) i docenti hanno un ruolo
ed una importanza fondamentale per determinare il successo o l’insuccesso della struttura stessa. La visibilità, la popolarità, l’attività concertistica e/o didattica sono tutti fattori di grande attrattiva per gli iscritti che generalmente provengono da tutta Italia (a titolo statistico
posso affermare che nella Fonderia delle Arti e nella scuola in cui ho
prestato in precedenza la mia opera sia come docente che come direttore didattico l’affluenza di iscritti provenienti da fuori Roma raggiunge circa il 65/70 percento).
Si determina dunque inevitabilmente una selezione del corpo docente che lavora nelle migliori scuole private che solitamente si compone di professionisti i quali, pur non avendo mai frequentato corsi di
La Fonderia delle Arti
137
pedagogia, dimostrano di possedere spiccate doti didattiche e una
chiara fama in campo concertistico e professionale. Conseguentemente gli allievi che si rivolgono ad una struttura privata sanno già, nella
maggior parte dei casi, con chi vorranno studiare ed anzi spesso, se
non di norma, è per questo motivo che si rivolgono ad una scuola piuttosto che ad un’altra.
Questo fenomeno fa sì che in moltissimi casi l’eventuale allontanamento di un valido docente da una scuola determini anche la migrazione degli allievi che si trovavano a studiare con lui. Tutto ciò è reso
possibile a mio avviso dal fatto che le scuole private non rilasciano attestati o diplomi riconosciuti e dunque gli allievi, quando decidono di
iscriversi, non hanno altri scopi se non quello di ottenere il miglior risultato possibile dal loro periodo di studi.
Nei Conservatori credo vi sia una realtà completamente diversa
perché la tentazione da parte di molti allievi di iscriversi anche per
avere “un pezzo di carta” che dia delle garanzie occupazionali (ma,
oggi più di ieri, quali?) fa sì che spesso non ci sia questa oculatezza
nella scelta di un Conservatorio piuttosto che un altro e si finisca per
andare in quello più vicino a casa. L’attrattiva da parte dei docenti
nel catturare iscrizioni è sicuramente meno marcata e meno evidente
visto che nell’ambito classico la visibilità e la popolarità sono termini da valutare con altro parametro rispetto a quello usato per la popular music.
Anche la difficile gestione degli investimenti da parte dei Conservatori può aver determinato una difficoltà, ad esempio, nell’adeguamento delle strutture e dunque materie come lo studio della musica elettronica vengono spesso svolte ottimizzando quello che si ha a disposizione o privilegiando l’aspetto teorico rispetto a quello pratico.
Tutti questi aspetti hanno a mio avviso contribuito ad un progressivo allontanamento dai Conservatori da parte di studenti che guardano
oggi alla musica come ad un linguaggio sempre più contaminato e
multietnico. L’apertura all’insegnamento della popular music quindi
non può che essere visto con molta attenzione e grande interesse da
parte di chi come me già temeva di dover assistere ad una “accademizzazione” anche del jazz all’interno dei Conservatori. Credo che
questo processo sia comunque già iniziato e personalmente attribuisco
parte delle responsabilità di ciò alla trasformazione che il jazz stesso
ha subito nel passaggio dallo swing al be bop. Nel momento in cui
cioè il jazz ha finito di essere la musica da ballo che era alle origini e
si è trasformato in qualcosa di più elitario fino a diventare musica da
138
Maurizio Boco
auditorium, si è gradualmente allontanato dal grande pubblico divenendo sempre più autocelebrativo; ha infine avuto la sua legittimazione iniziando pian piano a entrare nei Conservatori ma appunto “accademizzandosi” rischia di perdere a sua volta quel contatto con la realtà
e con le nuove sonorità che invece ritengo indispensabile per la sua
stessa sopravvivenza. E soprattutto rischia di perdere quel gusto del
divertimento che era in origine rappresentato dai suoi più grandi autori
e che era probabilmente anche nel DNA dei grandi compositori del
Settecento. Questo temo comunque sia un fenomeno molto più evidente in Italia che non negli altri paesi d’Europa o negli USA.
Quello che invece è un dato globale è il fatto che la popular music
sia in effetti quasi la totalità della musica che si ascolta nel mondo.
Come faceva notare Massimo Privitera nel suo interessante intervento,
la popular music costituisce circa il novantacinque percento della produzione fonografica (CD, DVD, ecc.) venduta ad un pubblico in gran
parte giovane, mentre il restante cinque percento viene rappresentato
dalla musica classica e dal jazz. Questo fatto ci porta inevitabilmente
ad affrontare il tema della didattica di questa materia con un linguaggio e un atteggiamento necessariamente diverso da quelli sopra citati.
I docenti a mio avviso sono obbligati ad approcciare la popular music
parlando il linguaggio dei fruitori principali di questa materia; sono
tenuti a calarsi nei panni dei protagonisti. A loro non è consentito alcuno scollamento con la realtà e nessuna accademizzazione sarà in
questo caso possibile per non correre il rischio di snaturare l’insegnamento della materia stessa.
Se è vero che i Beatles sono ormai entrati a pieno diritto nell’albo
dei grandi compositori della musica moderna e negli ambienti della
musica “colta” si accetta, anche se malvolentieri, il fatto che comunque non fossero assolutamente dei virtuosi, è anche vero che in ambienti jazz o classici la tentazione di disdegnare Dylan perché giudicato “stonato” è ancora oggi molto forte. Questo naturalmente non è un
atteggiamento possibile se si vuole affrontare seriamente l'insegnamento della popular music.
Quello che voglio dire è che comunque è un intero modo di pensare la musica e dunque la didattica che andrebbe forse rivisto, evitando
così che l’inserimento della popular music nei Conservatori finisca per
scontentare un po’ tutti, quelli convinti che una simile apertura possa
rappresentare la fine di una “purezza” di vedute e di intenti basate su
canoni mai messi in discussione e quelli che vorrebbero invece davvero qualcosa di più, magari iniziando dallo studio della popular music.
La Fonderia delle Arti
139
È altresì vero che i grandi cambiamenti avvengono con piccoli passi, a volte senza nemmeno accorgersene tanto sono lenti e per questo
motivo credo che l’iniziativa intrapresa dal Conservatorio e dall’Università di Cosenza vada guardata con grande interesse e incoraggiata
in tutti i modi e con tutte le nostre energie. La speranza è che ci sia un
seguito a questo primo coraggioso tentativo di dialogo e soprattutto
che le istituzioni siano sensibili a questi tentativi di rinnovamento.
140
Maurizio Boco
Fonderia delle Arti
Programma didattico
––––––––––––––––––––––
SCUOLA DI MUSICA
Triennio professionale
settimanale
1° ANNO
Lezioni individuali
Strumento (durata della lezione 45’)
Lezioni collettive Teoria musicale e Ear training (90’)
Ogni 15 giorni a settimane alternate Acustica 60’ / Storia della musica (60’)
2° ANNO
Lezioni in classi
Strumento – 2 lezioni in classi di 3 persone (60’)
o in classi di 2 persone (40’)
Lezioni collettive Teoria musicale, Ear training e Armonia (90’)
Laboratorio di musica d’insieme (90’)
Ogni 15 giorni a settimane alternate Informatica musicale (programmi di
notazione) (60’) / Storia della musica (60’)
3° ANNO
Lezioni in classi
Strumento – 2 lezioni in classi di 3 persone (60’)
o in classi di 2 persone (40’)
Lezioni collettive Armonia (90’)
Laboratorio di musica d’insieme (90’)
Storia della musica (60’)
La Fonderia delle Arti
Biennio professionale
settimanale
4° e 5° ANNO
Specializzazione rock – pop
Corsi obbligatori della durata di due anni
Strumento in classi da 3 (90’) o in classi da 2 persone (60’)
Ensemble (tre incontri mensili da 90’)
Pratica di sala (una sessione mensile di 120’)
Strumento complementare in classi da 3 persone (quindicinale, 75’)
Corso obbligatorio della durata di un anno (incontri quindicinali)
Storia del rock (90’)
Corsi della durata di un anno
(a scelta, 2 per ogni anno, incontri quindicinali da 60’)
Storia del jazz
Storia della musica del Novecento
Storia della musica elettronica
Musica in rapporto alle altre forme espressive
Arrangiamento e orchestrazione per orchestra jazz
Arrangiamento per ensemble rock–pop
Composizione
Coro
4° e 5° ANNO
Specializzazione jazz
Corsi obbligatori della durata di due anni
Strumento in classi da 3 (90’) o in classi da 2 persone (60’)
Ensemble (tre incontri mensili da 90’)
Pratica di sala (una sessione mensile di 120’)
Strumento complementare in classi da 3 persone (quindicinale, 75’)
Corso obbligatorio della durata di un anno (incontri quindicinali)
Storia del jazz (90’)
Corsi della durata di un anno
(a scelta, 2 per ogni anno, incontri quindicinali da 60’)
Storia del rock
Storia della musica elettronica
Storia della musica del Novecento
Musica in rapporto alle altre forme espressive
Arrangiamento per ensemble rock–pop
Arrangiamento per ensemble jazz
Composizione
Coro
141
142
Maurizio Boco
SCUOLA DI TEATRO E MUSICAL
La durata del corso è di due anni accademici con frequenza obbligatoria dal lunedi al
venerdi dalle 10.00 alle 17.00. Alla fine del biennio viene rilasciato un diploma. La
commissione dei docenti seleziona gli allievi mediante un’audizione che prevede una
prova di recitazione, canto e danza.
MATERIE:
Recitazione
Regia
Dizione e Improvvisazione
Caratterizzazione del Personaggio
Training Fisico ed Emozionale, Mimo
Musica
Canto
Danza
––––––––––––––––––––––
SCUOLA DI FOTOGRAFIA
La durata del corso è di due anni, il primo di preparazione di base e il secondo di specializzazione. Frequenza di due lezioni settimanali di 2 ore ciascuna più quattro ore
mensili di sala di posa e laboratorio.
MATERIE DI BASE:
Concetti base (la luce, l’esposizione, gli obiettivi, ecc.)
Fotografia digitale
Generi specifici (still life, ritratto, moda, foto di scena, fotogiornalismo, ecc.)
MATERIE COMPLEMENTARI:
Nozioni pratiche sul comportamento, sulle modalità per ottenere incarichi di lavoro e
per creare un proprio stile.
Le materie verranno trattate in maniera appropriata nel Corso di Fotografia ma anche
attraverso stage. I migliori allievi del corso potranno partecipare in veste di assistenti
ad alcuni lavori degli insegnanti.
Davide Beatino
Il Modern College of Music
(Reggio Calabria)
Mi unisco con entusiasmo al coro degli “hallelujah” che prima di
me ho sentito esclamare ad alcuni illustri ospiti invitati a relazionare
nel corso di questa due giorni di lavoro sulla popular music; la sospirata esclamazione era riferita senza dubbio all’insperato interesse manifestato finalmente dalle istituzioni didattiche nei confronti di una
tematica musicale forse messa da parte per troppo tempo.
Dalla fine degli anni Ottanta svolgo con continuità la professione
di musicista, bassista elettrico per la precisione, che esercito nell’ambito delle produzioni discografiche nel settore della musica leggera italiana. Tra le diverse collaborazioni cito quella con la cantautrice Mariella Nava, con la quale ho preso parte a sette tournée live e registrato
due dischi; da tre anni collaboro con il cantautore Samuele Bersani.
Nel corso della mia attività ho altresì fatto parte dell’orchestra di musica leggera della RAI diretta dal maestro Pippo Caruso e impegnata
nel programma Novecento condotto da Pippo Baudo. Sono laureato in
DAMS, curriculum musica, presso l’Università della Calabria e frequento un corso di laurea specialistica in didattica della musica presso
l’Università di Bologna.
A Reggio Calabria, la città in cui vivo, dirigo dal 1996 una scuola di
musica di indirizzo didattico moderno che si chiama Modern College of
Music e costituisce l’attività didattica ufficiale dell’Associazione
A.R.A. (Artisti Reggini Associati) della quale sono Presidente. Oltre
che nella direzione della scuola di musica, il mio impegno è didatticamente incentrato sull’insegnamento del basso elettrico. Fin dagli inizi la
mia formazione professionale è stata, ahimé, condotta in modo a dir poco avventuroso a causa della mancanza sul mercato di sussidi didattici
che trattassero adeguatamente l’insegnamento del basso elettrico, e, ovviamente, dalla cronica assenza, nella mia città, di insegnanti più o meno qualificati. Vorrei ricordare che il basso è uno strumento nato nel
1951, ed è pertanto da ritenere molto giovane rispetto ai veterani pianoforte e chitarra che trovano anch’essi posto, seppur dopo aver subito
qualche opportuna modifica grazie anche all’avvento dell’elettricità, tra
gli strumenti di norma utilizzati nel repertorio popular. Tra l’altro bisogna anche sottolineare che il basso elettrico è soggetto continuamente a
143
144
Davide Beatino
nuovi sviluppi, sia sul piano organologico che in termini di prassi esecutiva; ecco spiegata quindi la carenza, ai miei tempi, di strutture didattiche “oneste” (termine spesso utilizzato da Maurizio Boco nel corso di
questi incontri per distinguere, oggi, le scuole serie da quelle meno serie), degne di frequentazione e che fossero in grado, pertanto, di agevolare di gran lunga il mio tribolato percorso formativo in qualità di bassista. Nonostante le iniziali difficoltà sono tuttavia riuscito, con il tempo,
a maturare una buona preparazione musicale che mi è servita alla costruzione di un dignitoso profilo professionale, e che mi consente oggi
di ricoprire il ruolo di insegnante di basso elettrico.
Quello che è avvenuto con il basso elettrico non si discosta poi
molto dalle vicende legate all’apprendimento, nonché all’insegnamento, di altri strumenti tipicamente legati alla popular music come, ad
esempio, la chitarra elettrica, la batteria, le tastiere, senza tralasciare le
competenze oggi necessarie all’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche legate alla composizione, all’arrangiamento ed alla registrazione in campo musicale.
Allo scopo di evitare le difficoltà storiche legate al problematico
apprendimento degli strumenti moderni, spesso elettrici, e, non lo nascondo, di approfittare della richiesta sempre più numerosa da parte
degli aspiranti giovani musicisti della mia città, ho fondato, nel 1996,
una scuola di musica (che mi auguro “seria”) avente come scopo precipuo, e forse presuntuoso, quello di occuparsi della formazione del
musicista moderno. La didattica della scuola è stata impostata su programmi di studio notevolmente più “leggeri” rispetto a quelli adottati
dai Conservatori; e questo aspetto è risultato essere molto apprezzato
dai numerosi iscritti, che sono circa 80 l’anno. È ovvio che la scuola
non tralascia assolutamente l’insegnamento della teoria e del solfeggio, ma è pur vero che questi insegnamenti sono solo un aspetto della
reale didattica adottata, che si basa principalmente su lezioni pratiche
e individuali dello strumento prescelto, mirate all’apprendimento delle
pratiche musicali tipiche dei repertori jazz e blues.
Ogni allievo, oltre che la lezione individuale settimanale della durata di un’ora, frequenta lezioni collettive di teoria e solfeggio, di lettura della partitura e di improvvisazione; inoltre (ed ecco la novità più
apprezzata dai giovani musicisti) ogni settimana vengono svolti i laboratori di musica d’insieme, allo scopo di mettere in pratica tutto quello
che si è imparato nel corso delle lezioni individuali. Da questi incontri
collettivi molto spesso nascono entusiaste collaborazioni tra i musicisti che continuano e maturano anche al di fuori della stessa scuola.
Il modern college of music
145
Credo di essere in grado quindi, alla luce di quanto detto, di fornire
oggi un preciso identikit dell’aspirante musicista “medio”, che si rivolge alle scuole di musica private e a pagamento. Si tratta di giovani,
spesso giovanissimi, che si presentano alle lezioni di prova gratuite,
che valgono come audizione per l’ammissione alla nostra scuola, accompagnati da intraprendenti genitori, spesso a loro volta musicisti
mancati e talvolta frustrati, manifestando da subito una sconcertante
chiarezza d’idee su cosa vorrebbero fare in ambito musicale e di conseguenza ci bombardano di centinaia di domande, anche le più assurde, come ad esempio “in quanto tempo imparerò a suonare bene?” ;
oppure “sono qua per imparare a suonare la chitarra ….ma solo quella
solista!!!”; e ancora i genitori: “a casa abbiamo già una tastiera, e noi
vorremmo che imparasse quella, almeno potrà suonarci qualcosa e
magari cantare… ma lui si è fissato con la batteria… lo convinca lei”.
Comunque, al di là di qualche timida resistenza da parte di “irriducibili” genitori, alla fine la scelta dello strumento sospirato dai giovani allievi prevale su tutto e l’avventura ha inizio.
Durante l’anno accademico la maggior parte degli allievi manifesta, parallelamente allo studio dello strumento, un particolare interesse
riguardo le tecnologie analogiche e digitali, responsabili del funzionamento degli strumenti che utilizzano, interessandosi alle possibili
tecniche di registrazione digitale, che consentirebbero loro di poter registrare la musica composta all’interno dei numerosi gruppi che si
formano al di fuori della stessa scuola, e approfondendo le conoscenze
in materia di controllo dell’audio. Allo scopo di fornire le basi informatiche necessarie all’utilizzo dei sistemi digitali di registrazione, la
mia scuola ha ritenuto pertanto opportuno organizzare un corso specifico che trattasse adeguatamente la disciplina dell’informatica musicale; l’adesione è stata considerevole e la proposta ha suscitato notevole
entusiasmo con piena soddisfazione manifestata da parte degli allievi.
Quanto detto fino a questo punto della mia relazione serve soprattutto a sottolineare una caratteristica molto importante che solo le
scuole private, a mio avviso, possono vantare: e cioè la libertà di non
essere in alcun modo legati a obblighi didattico–istituzionali; particolare, questo, che ci consente spesso di cambiare in corsa qualsiasi programma didattico precedentemente impostato, e quindi, se necessario,
di sospendere attività che non registrano positivi riscontri tra gli allievi, dando così corpo ad iniziative didattiche effettivamente valide, dettate unicamente dalle esigenze e dalle richieste che ci vengono formulate direttamente dai nostri ragazzi.
146
Davide Beatino
La figura del musicista moderno, come tutti sanno, prevede necessariamente il possesso di alcune competenze, seppur generali, che esulano dal dotarsi unicamente e semplicemente della sola conoscenza
dello strumento da dover suonare. Ecco spiegato il successo delle numerose scuole di musica, non pubbliche, presenti nel nostro paese; pur
essendo più costose di quelle pubbliche ed istituzionalizzate, bisogna
ammettere che queste, nella maggior parte dei casi, rispondono in pieno alle effettive esigenze espresse da coloro che vogliono provare ad
avvicinarsi al mondo della musica in modo professionale, acquisendo
valide e specifiche competenze nel settore.
Tra l’altro, è vero altresì il reciproco, e cioè che specifiche competenze ed una preparazione adeguata ed aggiornata vengono oggi sempre più insistentemente richieste dai numerosi datori di lavoro dell’industria dello spettacolo agli aspiranti operatori in questo settore. Ed
ecco, credo, spiegato l’interesse sempre maggiore rivolto dalle Università e dai Conservatori, organi preposti istituzionalmente alla formazione, verso questa sempre più numerosa utenza di potenziali operatori nell’ambito della popular music, desiderosi di qualificarsi in
questo ambito professionale e di essere riconosciuti anche in ambito
accademico, dal momento che, e il sottoscritto ne è la prova, le giuste
competenze teorico pratiche, legate al mondo della musica in generale
e in particolar modo alla popular music, portano oggi al possibile esercizio di una vera e riconosciuta nuova professione. Apprezzo pertanto molto l’interesse che gli organi didattici istituzionali rivolgono
verso questo argomento, anche attraverso questi utili incontri, organizzati allo scopo di stimolare un sereno confronto tra le diverse realtà
presenti ed operanti nella comune direzione della ricerca di una nuova
didattica musicale, soprattutto in ambito popular.
Personalmente, ritengo che la direzione che debbano prendere gli
organi competenti in materia di organizzazione didattica, sia di creazione di un nuovo e specifico polo didattico, organizzato sull’esempio
degli istituti politecnici. Tale struttura dovrebbe occuparsi esclusivamente della formazione professionale e specifica degli operatori che si
trovino a dover operare nel campo dello spettacolo, impiegati non solo
come musicisti ma anche nei numerosi ruoli previsti dall’industria
musicale. Un polo didattico che includa quindi non soltanto le conoscenze musicali, ad oggi esclusivamente offerte dai seppur rimodernati Conservatori, ma che si occupi principalmente dell’insegnamento
riguardante sia gli strumenti che non vengono studiati presso i Conservatori sia dell’approfondimento dei nuovi linguaggi musicali e-
Il modern college of music
147
spressi dagli stessi. La caratteristica principale che una tale struttura
didattica dovrebbe possedere consiste, a mio avviso, nell’interdisciplinarità da offrire agli allievi allo scopo di far loro acquisire le molteplici e diverse competenze da possedere in ambito professionale.
La mia personale esperienza di studente DAMS, maturata presso
l’Università della Calabria, mi offre lo spunto per sottolineare la fondamentale importanza esercitata dal necessario approfondimento da
parte del musicista moderno per quanto riguarda le tematiche specifiche che vengono trattate da questo tipo di istituzione universitaria come l’etnomusicologia, l’estetica musicale, l’iconografia musicale, l’informatica musicale, nonché le varie attività di laboratorio organizzate
a supporto del normale curriculum di studi proposto agli studenti.
A conclusione del mio breve intervento, auspico un intenso rapporto
sinergico tra il Conservatorio e l’Università, certo che solo una stretta
collaborazione tra queste due istituzioni potrà tracciare la strada maestra
da percorrere, insieme, verso la realizzazione di nuove frontiere didattiche che risultino essere al passo con i tempi, valide ed allo stesso tempo
efficaci per favorire il rapido e qualificato ingresso nel mondo del lavoro
dei moderni operatori musicali e dello spettacolo in genere.
Stefano Toni
I Laboratori Musicali nel sistema scolastico
Il Progetto Speciale Musica del MIUR – Istruzione
Nell’ambito del fare, ascoltare, insegnare la popular music (come
recita il titolo del nostro incontro) non può essere ignorata l’esperienza
realizzata dai Laboratori Musicali nel sistema scolastico a partire dal
1998/99, anno di nascita del Progetto Speciale Musica dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione.
Durante le prime fasi operative del suddetto progetto vennero attivati sul territorio nazionale circa quattrocento laboratori musicali in
altrettanti istituti di istruzione primaria e secondaria. Intento principale
del progetto era quello di favorire la massima diffusione dell’educazione musicale nella scuola di ogni ordine e grado.
Chi conosce la realtà della scuola pubblica italiana può ben immaginare che, nonostante il lodevole e assolutamente condivisibile principio
ispiratore dell’iniziativa e l’entità non trascurabile dei finanziamenti erogati, il subentrare di problematiche connesse con le specifiche situazioni
dei singoli istituti (maggiore o minore interesse da parte del dirigente
scolastico, maggiore o minore continuità nel coordinamento delle attività, maggiore o minore risposta da parte dell’utenza, ecc.) ha portato ad
un ridimensionamento, forse prevedibile e previsto, della portata dell’iniziativa stessa, con la drastica riduzione delle attività di un numero di laboratori ancora, probabilmente, da quantificare. Laddove, invece, il finanziamento è piovuto su di un humus “fertilizzato” da condizioni particolarmente favorevoli i risultati sono stati più che confortanti.
Presso l’Istituto scoloastico in cui insegno (I.T.T. “Bottardi” di Roma) è in attività un Laboratorio Musicale dal 1995; cioè da circa tre anni
prima che nascesse il Progetto Speciale Musica. Il fatto che, sin dall’inizio, il coordinamento del Laboratorio sia stato sempre a carico dello
stesso docente corrisponde ad una delle condizioni favorevoli di cui sopra. Se poi il docente in oggetto, nella fattispecie il sottoscritto, che nelle sue ore curriculari insegna una materia che non ha niente a che vedere con la musica, è un musicista con una attività professionale ventennale alle spalle, allora è, generalmente, garantita anche la competenza nella “coltivazione”. Se poi, infine, l’ambito in cui il docente ha svolto la
sua attività professionale di musicista è quello della musica rock, da
cinquant’anni il genere di musica più ascoltato dal pubblico giovanile di
149
150
Stefano Toni
tutto il mondo, le probabilità che il “raccolto” (mi si perdoni la metafora
“agricola”) sia abbondante aumentano a dismisura.
Nel corrente anno scolastico le iscrizioni al Laboratorio Musicale
del “Bottardi” ammontano a più di settanta. Il 50 percento degli iscritti
non sono alunni frequentanti l’Istituto, ma giovani del territorio appassionati di musica e desiderosi di imparare a suonare uno strumento o
di esprimersi con il proprio suonando in gruppo. L’iscrizione, fino a
pochi anni fa completamente gratuita, a causa dei tagli operati dall’attuale amministrazione sul budget delle scuole pubbliche, è oggi subordinata al pagamento di un contributo annuale alle spese di gestione
pari a 40 euro per gli alunni interni e 60 euro per gli esterni. È anche
in atto un progetto di rete con un Istituto del medesimo bacino di utenza (l’I.T.I.S. “Giorgi”), i cui studenti, grazie ad una speciale convenzione, partecipano gratuitamente alle attività.
Il Laboratorio mette a disposizione una sala prove attrezzata di circa 40 mq. con annessa sala regia di circa 12 mq. Lo spazio è completamente insonorizzato; la dotazione in esso contenuta comprende una
strumentazione completa (batteria, tastiera elettronica, amplificatori
per chitarra e basso, amplificazione generale con mixer e monitors,
microfoni, chitarre acustica ed elettrica, basso elettrico, percussioni) e,
per quanto riguarda la sala regia, tutto il necessario per una registrazione digitale di livello professionale.
Oltre al Laboratorio di musica d’insieme, che vede attualmente la
partecipazione di dieci gruppi vocali–strumentali, organizzati in un calendario settimanale che prevede, per ciascuno, una prova pomeridiana di due ore coordinata dal docente, sono attivati corsi di voce, chitarra di primo e secondo livello, batteria e percussioni. Nel corso degli
anni si sono svolti anche seminari di fonia ed uso di software audio e
di composizione musicale.
I corsi e i seminari sono, in massima parte, tenuti da esperti esterni provenienti dal settore professionale o da scuole di musica di
chiara fama (vedi Scuola Popolare di Musica “Donna Olimpia” e
Scuola Popolare di Musica di Testaccio) regolarmente retribuiti in
base a parametri economici standard, generalmente più vantaggiosi
rispetto a quelli sui quali è basata la retribuzione presso le scuole di
musica private (un’ora di lezione in qualità di esperto esterno presso
un istituto di istruzione secondaria statale è retribuita con 40 euro
lordi; un insegnante di scuola di musica privata percepisce, in
un’unità oraria, un compenso generalmente non superiore, e a volte
inferiore, ai 15 euro).
I laboratori musicali nel sistema scolastico
151
All’interno del Laboratorio di musica d’insieme, forse l’espressione più compiuta di questo particolare modo di “fare educazione
musicale”, per partecipare al quale si richiede una competenza di base
minima sufficiente a non intralciare il cammino collettivo verso il raggiungimento degli obiettivi (ovviamente proporzionati al livello medio
dei “musicisti”) si privilegia, didatticamente, il metodo, per così dire,
induttivo. Si parte, pertanto, dall’esecuzione di “cover” di brani noti
(scelti nell’ambito pop, rock, metal, etno–folk, soul o blues) le cui parti vocali e strumentali si imparano ad orecchio o tramite l’uso delle
moderne tecnologie (download dei midi–file e delle tablature da Internet), per poi passare allo “smembramento” del brano stesso e all’analisi e allo studio, anche teorico, delle singole parti e, in un secondo
tempo, dell’arrangiamento generale. Spesso si arriva alla rivisitazione
di quest’ultimo attraverso la sensibilità e i gusti degli esecutori, giacché la “cover” non viene considerata un fine, ma un mezzo.
Ad essere stimolata e incoraggiata è, soprattutto, la creatività. Col
crescere del livello di esecuzione, curata dal docente con particolare
attenzione ai suoni (di importanza imprescindibile in un genere che,
da sempre, vede nella dimensione “elettrica” la sua massima specificità) alle dinamiche, alla coesione strumentale e al groove, generalmente cresce anche la voglia di misurarsi con generi musicali diversi da
quello più familiare e, a volte, perché no, con un repertorio originale.
E questo, a prescindere dalla qualità oggettiva dei risultati, è, a mio
avviso, il punto più alto di espressione e realizzazione di un’esperienza che, lungi dal volersi sostituire ai canali tradizionali, istituzionali e non, dell’istruzione musicale nel nostro paese, costituisce, nei
casi in cui si verifichino le condizioni favorevoli di cui sopra (e mi risulta non siano pochi, anche in realtà e con caratteristiche sensibilmente diverse da quelle descritte), una valida occasione per la costituzione, all’interno del bagaglio culturale generale dello studente medio,
di un piccolo patrimonio di cultura musicale utile e spendibile in eventuali approfondimenti accademici o professionali.
Nel caso specifico, e in quelli similari, è proprio nel campo della
popular music, nel significato più ampio del termine, che tale patrimonio diventa particolarmente prezioso, nella misura in cui vengono a
mancare le strutture istituzionali che prestino a tale espressione artistica
la considerazione che merita e risultano scarsamente affidabili, per
competenza, metodi adottati o fini perseguiti, alcune di quelle non istituzionali (vedi scuole di musica private improvvisate, iniziative di
“vecchie volpi” del settore più o meno appoggiate politicamente, ecc.).
152
Stefano Toni
Nel corso dei dieci anni della sua storia il Laboratorio Musicale del
“Bottardi”, immerso nella realtà dell’estrema periferia di una metropoli
tentacolare e soffocante come la Roma di oggi, alle prese con una popolazione scolastica costantemente a rischio dispersione, droga e microcriminalità, è riuscito a costellare il proprio cammino di tappe significative quali l’allestimento e la messa in scena di tre musical originali, la
registrazione di cinque CD (di cui due di materiale originale composto
in parte o in toto dagli studenti), la partecipazione a rassegne e concorsi
(spesso coronata da vittorie o piazzamenti significativi), la realizzazione
di concerti e spettacoli in strutture del territorio e non, l’avvio di una
collaborazione continuativa con le realtà operanti nell’ambito del sociale all’interno del proprio bacino d’utenza. I risultati raggiunti testimoniano l’efficacia del metodo e la validità dell’esperienza.
Francesco Domenico Stumpo
La popular music come il postino di Bruner
Alla luce delle difficoltà che, come mi sembra di capire dagli interventi, si incontrano nel mondo accademico per ritagliare uno spazio a
discipline più recenti come la popular music piuttosto che la musica
da film, chi insegna come me nella scuola di base si può ritenere fortunato per la grande varietà e scelta contenutistica a cui può attingere.
Basta aprire a caso un qualsiasi testo di musica di scuola media per
imbattersi in una foto di Ramazzotti in concerto, di Beethoven o di
una tribù indigena. Vincoli maggiori però si hanno per quanto riguarda le abilità, le conoscenze e, di conseguenza, le competenze da raggiungere a prescindere dai mezzi, dai metodi e dai contenuti.
La canzone, che spesso coincide con l’idea che i ragazzi hanno della musica tout court, è lo statuto ordinario per lo studente della scuola
media e l’uso scolastico della popular music presenta quindi molti e
facilmente intuibili vantaggi. Ne elenco alcuni tra i più significativi:
1. è la musica che fa parte integrante della quotidianità extrascolastica dei ragazzi, che la portano a scuola come qualcosa di già “appreso”;
2. è la musica più diffusa nella società contemporanea e con essa si
evolve;
3. è la musica che può aprire alla multiculturalità essendo la colonna sonora del “villaggio globale”;
4. è la musica che diminuisce le distanze tra alunno ed insegnante
creando in classe un ottimo clima comunicativo ed affettivo.
Tuttavia, se l’intervento didattico non è ben gestito e pedagogicamente sostenuto, tali vantaggi possono cambiare segno e trasformarsi
in altrettanti rischi. Il fatto che la popular music sia spesso l’unica ascoltata e praticata dai giovani ne fa una sorta di paradigma musicale
insostituibile ed incontrastabile.
Il rischio principale dell’uso indiscriminato della popular music a
scuola è quello di promuovere un ascolto acritico e proiettivo, quello
che mi piace definire “effetto del postino di Bruner”.
Negli anni Sessanta J.S. Bruner, proponendo un corso di studio
sull’uomo, si poneva il problema pedagogico di come e quando cominciare a insegnare le scienze sociali. In controtendenza con una certa prassi in uso, egli sconsigliava di partire dalle esperienze familiari
(la strada, la casa, il vicinato) poiché proprio l’eccessiva familiarità fa153
154
Francesco Domenico Stumpo
rebbe perdere di vista gli aspetti generali. L’esempio che lo psicologo
americano indicava era proprio quello del postino, la cui quotidiana
familiarità annullerebbe la sua funzione istituzionale e viceversa. Difficile perciò sarebbe dissociare in lui il volto amico da quello del freddo rappresentante dello Stato.
Una situazione analoga oggi la si può riscontrare a scuola a proposito delle musiche di massa ovvero quelle più familiari ai giovani e
non solo: esse, proprio come il postino di Bruner, danno la sicurezza
del “farci sentire a casa” ed allo stesso tempo sono spesso scelte con
attenzione dall’industria culturale per colpire determinate fasce di popolazione. Con questo non voglio dire che non possano avere comunque un valore musicale, estetico e didattico.
Anche all’interno della stessa popular music ogni gruppo ne elegge
un particolare tipo che difende con agguerrita passione: chi insegna sa
degli scontri tra i sostenitori di Vasco Rossi e quelli di Gigi d’Alessio.
Un altro rischio è perciò quello di relegare gli alunni in una visione
della musica solo parziale, legata solo ad alcune funzioni e contesti,
non promuovendo invece una prospettiva pedagogicamente ed esteticamente valida e storicamente giustificata.
La mia proposta è quella di trattare la popular music a scuola in
un’ottica comparativa sia in senso sincronico, ovvero confrontandone
diversi tipi di diversa provenienza geografica, sia in senso diacronico,
cioè mettendo in relazione la canzone di oggi con forme analoghe che
la hanno storicamente preceduta: dalla canzone trobadorica, alle frottole rinascimentali, ai madrigali monodici di Monteverdi, alle arie del
Settecento ai lieder romantici. Queste forme sicuramente valutate come “altre” e “poco familiari”, nel momento in cui vengono avvicinate
a forme che i ragazzi conoscono perdono parte della loro “alterità” e
diventano, man mano, sempre più accettate.
D’altra parte anche la popular music ha ormai una sua storia se si
pensa che sono passati quarant’anni dall’esordio dei Beatles e che
perciò possono ormai essere inquadrati storicamente come Palestrina
o Wagner. Tra il sincronico ed il diacronico si potrebbe inserire il
rock progressivo degli anni Sessanta–Settanta, che, essendo un crossover tra rock, jazz, blues e musica d’arte del passato e contemporanea, può offrire ottimi spunti sul versante della comparazione analitica anche ai fini della comprensione di opere di più ampio respiro
formale e temporale.
Tra i vantaggi di trattare la popular music a scuola quello della sua
multiculturalità, pur incorrendo nel pericolo di una certa omologazio-
La popular music come il postino di Bruner
155
ne, è uno dei valori più urgenti da coltivare ed è questo il contenuto
dell’esempio che presento.
Ad infoltire i banchi della mia scuola è arrivato Z., un alunno
marocchino di terza media. Z. è magro e alto più di me, ha i capelli
rasi come molti africani, indossa quasi sempre scarpe da tennis, jeans e camicia grigia. Dalla prima lezione cerco di integrarlo nella
classe aprendo una discussione sulle usanze comuni — musicali in
particolare — tra la Calabria e il Marocco. Lui, seduto al primo
banco della fila di destra, sta ad ascoltare ma non sono sicuro che
capisca tutto, interviene solo se stimolato insistentemente. Dimostra
una certa diffidenza e intuisco che non ama parlare volentieri delle
tradizioni marocchine.
In classe sfoggio tutte le mie conoscenze sulla musica marocchina
che si esauriscono molto presto. Ovviamente, chiedo a Z. se conosce
canzoni marocchine, se sa ballare o suonare uno strumento ma dice di
non saper fare nessuna di queste cose.
Mi serve una strategia organica e strutturata per intervenire didatticamente. L’occasione buona me la fornisce la canzone Aischa di Cheb
Khaled, un successo internazionale di qualche anno fa del cantante
marocchino: tutte le carte sono in regola per interessare sia la classe
sia Z. L’esperienza comincia facendo ascoltare la bella canzone che
subito conquista tutti. È in francese e la classe non studia questa lingua, perciò il testo costituisce un terreno neutro per poter lavorare. In
realtà il vantaggio è per Z. che ha studiato a Casablanca nelle scuole
francesi ed ha quindi una buona pronuncia. Una parte del testo è in arabo, e anche lo stile poetico del testo è tipicamente arabo. I ragazzi
italiani hanno dalla loro il fatto che il brano ha una costruzione tipicamente pop e riescono subito a memorizzarne le parti musicali.
Ascoltiamo la canzone scoprendo che è formata da tre parti musicali. La strofa A e il ritornello B sono basate sulla ripetizione dello
stesso giro di accordi: La minore–Fa–Do–Sol. La varietà viene data da
addensamenti e rarefazioni della potenza timbrico–dinamica e dal carattere modale e melismatico del canto. La terza parte, C, è più complessa poiché è basata su un modo di cantare più tipicamente arabo e
presenta all’interno delle piccole modulazioni.
Dopo qualche lezione Z. ha imparato a cantare da solista mentre gli
altri fanno il coro. Noto che il giro armonico della strofa e del ritornello di Aischa è funzionalmente lo stesso della canzone Aida di Rino
Gaetano. Le due canzoni hanno anche delle convergenze testuali a cominciare dal titolo: due nomi di donna, anche molto simili fonetica-
156
Francesco Domenico Stumpo
mente. In più in Aida si parla di Egitto, di safari, antilopi e giaguari –
insomma di Africa. Aischa è invece bella come una “Regina di Saba”.
A casa provo ad intrecciare le due canzoni e ci riesco facendo solo
una piccola forzatura ritmica. Anche armonicamente in un punto c’è
una durezza dovuta all’impatto del mi di una melodia con il fa dell’altra, tuttavia è passeggera e si perde nel fluire temporale. Per il resto
è una magnifica coincidenza! Perfino i due ritornelli arrivano contemporaneamente; mentre una voce canta Aischa écoute–moi!, l’altra le fa
eco Aida, come sei bella.
La somiglianza musicale e testuale tra le due canzoni mi offre lo
spunto per continuare il discorso. Z. impara questa volta a cantare in
italiano anche se la canzone non è proprio di facile comprensione neanche per i ragazzi italiani di quell’età. Tuttavia, essendo una sintesi
della storia italiana del Novecento (che i ragazzi di terza media studiano) risulta molto utile.
In una lezione successiva presento l’Aida di Verdi, ispiratrice della
canzone di Rino Gaetano e profetica rispetto alla conquista fascista
dell’Etiopia negli anni Trenta. Una storia in cui la schiava etiope Aida
e il comandante egiziano Radames superano le rivalità tra i due popoli
e sacrificano le loro vite per amore. Ancora quindi l’Egitto, l’Etiopia
— l’Africa. Non so se Z. riesce a seguire i vari passaggi ma vedendo
una fotografia di Verdi sul libro lo riconosce.
L’ascolto del coro dei sacerdoti seguito dalla “marcia trionfale” è a
questo punto scontato. Successivamente rifaccio ascoltare Aida di Rino Gaetano dando la consegna di riconoscere per alzata di mano in
quale punto della canzone compare la citazione musicale dall’opera
verdiana. Al tema della “marcia trionfale” molti di loro alzano la mano. Anche nella musica c’è quindi una precisa intenzione del cantautore di rifarsi a Verdi. Il riconoscimento all’ascolto di un elemento in un
contesto nuovo e diverso dall’originale è sicuramente un obiettivo musicale di tipo cognitivo. Ogni ragazzo riconosce nei brani che non aveva mai ascoltato prima, se non proprio la confidenzialità del postino
di Bruner, almeno una certa familiarità.
Mi sembra a questo punto di poter giungere a quattro provvisorie
conclusioni:
1. l’integrazione multietnica a scuola con la popular music è possibile;
2. lo scopo non deve essere né di esaltare, né di unificare l’una e
l’altra cultura o musica ma di integrarle in modo che ognuna mantenga le sue prerogative;
La popular music come il postino di Bruner
157
3. la popular music può essere letta in modo comparativo, sia in
funzione sincronica, sia diacronica, aprendo così ad una prospettiva di
familiarità storica, estetica e più ampiamente culturale.
4. senza essere un “cascame” della “musica d’arte”, alla popular
music è auspicabile applicare le stesse categoria della musicologia.
Tabella 1. Confronto tra i brani citati
CONVERGENZE
ARMONICHE
AISCHA
(C.Kaled)
LA– FA DO SOL
AIDA
(R.Gaetano)
FA DO SOL LA–
AIDA
(G.Verdi)
Incipit della
Marcia trionfale
DO SOL LA– FA
CONVERGENGE
TESTUALI
• Idealizzazione di una tipica
bellezza nordafricana.
• Richiami all’Africa si evincono da metafore (regina di Saba,
Paese di ebano e avorio).
• Nome simbolo del colonialismo italiano nel
Nord dell’Africa.
• Richiami
terminologici
all’Africa: Egitto, safari, antilopi e
giaguari).
• Schiava etiope, prigioniera
degli egiziani.
• Ambientazione nel Nord dell’Africa.
Daniele Moraca
Un cantautore (calabrese) alle Fær Øer
Questo convegno dedicato alla popular music, fra le altre cose, ci
ha consegnato l’impegno di indagare sulla qualità del fenomeno musicale nella nostra regione, la Calabria. Sappiamo che in molti paesi del
mondo i popular music studies hanno uno status accademico consolidato: sono una disciplina come un’altra, con tutti i pregi e difetti che
ciò comporta [Franco Fabbri, L’ascolto tabù, Milano, Il Saggiatore,
2005, pag. 61]. In Italia invece l’inserimento della popular music nelle
diverse strutture scolastiche non è stato preso molto in considerazione.
Così saluto con soddisfazione questo nostro incontro di Cosenza, che
unisce musicisti e musicologi per creare le sinergie capaci di eliminare
etichette e distinzioni tra i diversi generi musicali; la musica è infatti
un mondo unico. In questo contesto il mio intervento si propone di offrire spunti sparsi sul tema della canzone, nello specifico quella d’autore italiana, utili a realizzare corsi all’interno di istituti musicali, statali o privati.
Secondo la definizione di un’enciclopedia, la musica
è un’attività sociale dell’uomo costituita dalla produzione, per mezzo del corpo umano o di strumenti, di suoni variamente combinati e coordinati. La possibilità di definire la musica rimanda perciò allo studio dei suoni e delle loro
caratteristiche, nonché all’analisi del suo sviluppo storico. Quanto all’origine
del termine, si suole risalire al greco mùsa, nome generico di ciascuna delle
nove mitiche protettrici delle arti [L’Enciclopedia, vol. XIV, La Biblioteca di
Repubblica, 2003, pag. 498].
Da circa venticinque anni mi occupo di musica. Sono un’autodidatta, e all’età di quattordici anni ho scritto la mia prima canzone, dal
titolo Quell’uomo. L’amore per la musica mi è venuto ascoltando dischi e guardando eventi musicali dal vivo o in televisione, unici mezzi
di diffusione allora esistenti; è così che ho imparato a suonare la chitarra. I miei cari genitori, che avrebbero fatto qualsiasi sacrificio per
me, hanno sempre sostenuto questa mia voglia di suonare, ed il loro
grande desiderio era di farmi studiare pianoforte al Conservatorio. Le
scuole private di musica, che io ricordi, alla fine degli anni Settanta in
Calabria non esistevano; c’erano piuttosto insegnanti che davano lezioni a casa propria.
159
160
Daniele Moraca
Il mio unico obiettivo era inseguire il mio sogno: diventare cantautore. Ho pensato dunque che il modo di avvicinarsi allo strumento, nel mio caso la chitarra acustica, fosse quello di inventarmi un
metodo di apprendimento. Mio fratello maggiore strimpellava la chitarra, ed io di nascosto osservavo con attenzione, cercando di memorizzare tutti i suoni che ascoltavo mentre lui suonava. Iniziava cosi la
mia avventura musicale. Dopo un paio di mesi ebbi la mia prima chitarra, una Eko Ranger 12 corde, e per giunta amplificata… il grande
sogno si stava avverando.
Ascoltavo maggiormente i cantautori italiani. Infatti proprio alla fine
degli anni settanta in Italia c’è stato uno stravolgimento radicale nella
scrittura delle canzoni, con nuovi protagonisti come De Andrè, Venditti,
Guccini, De Gregori, Gaber, Bennato, Conte, Lolli, Jannacci, che con il
loro stile forte ed originale rompevano lo schema tradizionale di canzone, dai contenuti del tutto scontati e dalle tematiche ripetitive, destinate
ad un pubblico nazional–popolare. Essi rivoluzionavano il modello
“canzone”, non solo dal punto di vista della lingua, ma anche introducendo nuove tematiche a sfondo politico e di rinnovamento culturale.
Non bisogna dimenticare che la nostra cultura musicale è stata da sempre portavoce dell’Italia nel mondo: canzoni come Volare di Domenico
Modugno e O sole mio, tradotte in tante lingue, sono diventate in ogni
parte del mondo veri e propri simboli dell’Italia che canta.
Una delle caratteristiche che contraddistinguono sin dall’inizio i
cosiddetti cantautori è la loro spiccata personalità, che emerge dal loro modo di cantare, di presentarsi in pubblico e di rivendicare istanze
nuove con il contenuto delle loro canzoni. L’autore che canta, che
mette in scena la propria musica, nella quasi totalità dei casi è un individuo con un proprio universo di idee musicali, sociali ed esistenziali:
messaggi da lui inviati direttamente al cuore del pubblico, per chi vuole ascoltare, comprendere e condividerne i tormenti interiori.
La parola scritta è un veicolo per far decantare e comunicare la
propria poesia interiore, i pensieri e le idee sul mondo e le circostanze
che lo reggono. Se pure non marcatamente, i meccanismi della canzone d’autore appaiono fin dalle sue origini. La stretta interconnessione
tra parola e musica diventa per i cantautori un modo di differenziarsi
da tutti gli altri cantanti. Colui che canta una canzone d’autore diventa
veicolo di impressioni e suggestioni, e si avvicina quasi alla sensibilità
di un poeta. Non è una novità, del resto, che molti autori della musica
italiana abbiano rivendicato apertamente di essersi ispirati ai poeti,
quasi ne fossero gli eredi naturali.
Un cantautore (calabrese) alle Fær Øer
161
Già dagli anni Sessanta in America spopolavano grandi nomi di
songwriters come Bob Dylan, Carol King, Paul Simon, Lou Reed,
Neil Young, David Crosby, James Taylor, divenuti miti fra i tanti amanti della popular music. Ma per me è stata particolarmente significativa l’influenza dei primi cantautori in Italia: è attraverso l’ascolto
dei loro LP (a 33 giri) che ho iniziato ad amare il mondo della canzone
d’autore. La lettura dello spartito musicale per me era tabù, quindi l’unico modo per suonare e cantare una canzone era quello di ascoltarla
ore ed ore, per individuarne gli accordi; metodo che ancora oggi uso.
Il mio interesse da sempre per la musica, prima in quanto cantautore e poi con il desiderio di approfondire la canzone dal punto di vista
della tradizione culturale, mi ha in seguito spinto a completare le mie
conoscenze di autodidatta, e ad iscrivermi al DAMS dell’Università
della Calabria, dove ho concluso il percorso universitario con una tesi
in antropologia ad indirizzo musicale, dal titolo Antropologia e poetica nella canzone d’autore italiana: il viaggio interrotto di Rino Gaetano. Tutto questo alla fine mi ha dato la possibilità di tenere personalmente dei seminari sulla Canzone d’autore italiana, come complemento al corso di Civiltà della canzone tenuto da Massimo Privitera.
Ciò che tento di trasmettere agli studenti è proprio che fra i diversi
modi di esprimersi musicalmente non esistono confini. E ho pensato
di integrare la conoscenza del fare musica con l’antropologia, perché
c’è qualcosa che accomuna questa scienza al viaggio, alla poesia e alla
canzone. L’antropologia infatti è prima di tutto conoscenza: studia le
differenze tra società e tra culture, ed ha il compito di pensare l’altro.
E la conoscenza dell’altro, oltre ad essere confronto, vuole essere
un’etnografia del sé, un modo di conoscersi attraverso l’altro. Perché,
se con l’immigrazione cambiano i confini geografici, cambiano insieme anche i nostri confini culturali.
A tal proposito ho avuto modo di avere un importante scambio
culturale attraverso un viaggio nelle Isole Fær Øer, nel Nord Europa,
portandovi la nostra cultura musicale. Accade spesso che molti artisti italiani, durante i loro concerti all’estero, preferiscano cantare in
inglese. Io invece non ho ritenuto di dover cantare in una lingua che
non mi appartenesse, perché credo che una canzone scritta in italiano
vada cantata preservandone l’origine; che non è solo idiomatica, ma
è l’insieme della sua natura creativa, nella quale la lingua originale
ha un ruolo decisivo. Pertanto ho preferito realizzare e distribuire
una brochure con la traduzione dei testi in lingua inglese e in lingua
faroese.
162
Daniele Moraca
Nel mio percorso musicale questa esperienza è stata positivamente
di rottura, e ricca di spunti per la composizione di nuove canzoni. Da
essa mi è giunta la conferma che il mondo fantastico e poetico sceglie
senza esitazione la via di fuga dall’omologazione del villaggio globale. L’impatto è stato coinvolgente, e mi ha convinto ancora di più di
come la musica sia senza confini.
Il mio intento è sempre stato, attraverso le mie canzoni, di comunicare emozioni, uscendo fuori da schemi stereotipati, convenzionali, commerciali, per esprimere in forma semplice storie del vivere quotidiano.
Mi capita spesso di fare lezioni–concerto nelle scuole elementari e
medie, al di fuori delle ore curricolari di educazione musicale. Ritengo
che questi incontri interdisciplinari siano interessanti, che diano l’opportunità ai giovani di conoscere il grande patrimonio musicale del nostro paese, e che li spingano ad appassionarsi alla musica senza imposizioni. La lezione–concerto è arricchita dalla visione di concerti live,
dall’ascolto del disco, dall’analisi poetica del testo delle canzoni scelte,
e dall’esecuzione dal vivo. Mi esibisco quasi sempre facendo uso della
mia chitarra e della voce, e questo favorisce la partecipazione collettiva, creando spesso momenti di intensa emozione tra gli studenti.
È vero che oggi gli adolescenti hanno tutto, e sempre meno tempo;
e quando un genitore decide di far loro studiare uno strumento, mi
chiedo: “ma l’amore per la musica sarà una passione non realizzata
del padre o della madre, o è vero che il figlio vuole diventare un cantante rock?”. Mi pongo spesso questa domanda, ma poi penso che,
come è accaduto per me, quando c’è la passione i risultati arrivano, in
un modo o nell’altro. La mia prima chitarra mi è stata regalata da mio
padre a condizione di tagliare i miei lunghi capelli… bene, è stato un
grande sacrificio, ma alla fine ne è valsa veramente la pena.
In conclusione di questo mio intervento penso che ciò che conti sia
l’emozione, al di là delle categorie in cui poi essa viene incasellata; e
conta l’impegno a diffondere gli strumenti per conoscere il grande
mondo della musica popolare. È questo che mi sforzo di fare, perché
ci sia più consapevolezza di ciò che si ascolta.
Gianni Testa
Popular music: comunicazione e fusione
di infinite sonorità… La mia esperienza
Alcuni spunti generali
La popular music — musica di larga diffusione che circola attraverso media come il disco, la radio, la televisione — è un modo di
comunicare che riflette i gusti e i caratteri delle varie culture. La sua
nascita si è contrapposta alle musiche d’élite, come il jazz o la classica; ma il passare del tempo l’ha profondamente modificata, portandola
a confrontarsi con arti sublimi come la letteratura ed il teatro. La poesia di un Leopardi o di un Foscolo ha ispirato in Italia i cantautori moderni, come del resto è successo all’estero con altri grandi scrittori e
poeti. Ma, all’inverso, la grande espansione mediatica della popular
music ha fatto sì che fosse poi essa ad influenzare le altre forme artistiche. In letteratura, ad esempio, essa ha segnato la narrativa italiana
degli ultimi vent’anni, da Brizzi a De Carlo. E la nascita delle star del
pop ha ampliato enormemente l’importanza culturale della musica,
creando in tutto il mondo generazioni di fans: dai miti americani di
Marylin, di Elvis Presley, di Frank Sinatra, fino agli odierni Michael
Jackson e Madonna; e, per quanto riguarda l’Italia, dai miti di Gianni
Morandi, Claudio Baglioni agli attuali Eros Ramazzotti e Laura Pausini, che portano la loro musica e quindi il nostro gusto nazionale in
giro per il mondo.
Purtroppo il nostro paese ignora istituzionalmente l’insegnamento
della popular music, dal momento che per studiare musica si è indirizzati solo a quella classica e alla lirica, o al massimo al jazz. Dalla mia
personale esperienza, essendomi affermato con la partecipazione ad
importanti musical, mi sono accorto che i musicisti del conservatorio
spesso vengono messi in difficoltà dal genere musical, poiché vi sono
messi a confronto con un approccio diverso da quello autoritario e canonico dei loro studi classici o lirici.
Ogni genere musicale potrebbe essere considerato popular music,
nel senso indicato all’inizio, dal momento che ogni epoca e ogni nazione hanno potuto esprimere il proprio gusto musicale. Ma, per quanto riguarda la mia formazione, mi sono imbattuto in una sorta di ignoranza
istituzionale nell’approccio alla popular music; cioè proprio quella mu163
164
Gianni Testa
sica che fa vendere i dischi e riempire i teatri. Oggi non è possibile poter
studiare popular music, o nel mio caso canto pop, presso le istituzioni:
ci si deve accontentare di insegnanti senza diplomi (riconosciuti), magari presso scuole private talvolta dubbie, di cantanti di pianobar che si
improvvisano maestri di canto, senza avere un metodo e senza la capacità di adattarsi alle inclinazioni e alle potenzialità dell’allievo.
Al Conservatorio si studiano strumenti come il pianoforte, il violino, la chitarra classica, le percussioni. Ma per chi volesse studiare la
batteria (che è differente dalle percussioni), la chitarra o il basso elettrico, o destreggiarsi nell’uso dei campionatori o dei sintetizzatori, non
c’è un punto di riferimento istituzionale. Sicuramente sono utilissime
le basi delle percussioni per suonare la batteria, o lo studio della chitarra classica per avvicinarsi a quella elettrica; ma per capirne le specificità bisogna essere autodidatta, poiché ne manca uno specifico insegnamento. Solo in rari casi, e solo da poco, i Conservatori iniziano ad
aprirsi a corsi per l’utilizzo di strumentazioni (tra cui programmi informatici come Cubase e Logic) per la composizione e l’arrangiamento della pop music contemporanea. Troviamo spesso studi di registrazione con tecnici autodidatti; ed è solo grazie allo loro grande musicalità e all’amore per la musica che sono diventati straordinari utilizzatori di macchine sempre più complicate e difficili da gestire.
Al Conservatorio il canto è studiato con il metodo lirico (base indispensabile per cantare ogni genere musicale), ma non esiste un vero
approfondimento per tutte le altre enormi possibilità dello strumento
voce. Trovo ingiusto che un cantante desideroso di esprimersi attraverso il musical o altre forme di popular music non trovi spazio all’interno di un’istituzione come il Conservatorio. Per questo motivo nasce
oggi l’esigenza di creare nuove strutture riconosciute dove la musica
venga considerata senza pregiudizi di genere, e attui i processi comunicativi che già la popular music internazionale opera nel mondo. Sarebbe opportuno aprire gli occhi e vedere che ci sono persone che tentano, come ho fatto io, di essere un artista a 360 gradi, spaziando, sia a
livello culturale che lavorativo, nei vari generi e in tutte le forme di
espressioni musicali moderne.
Un artista come me, che tra le forme di popular music predilige il
musical, oggi è messo a dura prova, poiché viene in contatto con forme di spettacolo sempre più complesse e complete, senza essere passato attraverso un’adeguata scuola di formazione pubblica, organica e
riconosciuta, la quale si affianchi alle migliaia di scuole private che si
espandono in maniera spropositata. Saper cantare, ballare, e recitare
Popular music: comunicazione e fusione di infinite sonorità…
165
insieme oggi in Italia è praticamente impossibile: non abbiamo, infatti,
le strutture necessarie come in America, dove invece esistono vere e
proprie scuole di specializzazione di musical e popular music. Se non
si studieranno mai dizione, canto cosìddetto leggero, canto semi–impostato, falsetti, mezze voci, voci sporche e via dicendo, come invece
si apprendono nelle accademie fuori dal nostro paese, non ci sarà mai
una preparazione appropriata per essere grandi artisti pop.
Avete mai provato a comparare I Miserabili, che ormai è rappresentato con grande successo a Londra da anni, con la versione italiana di
Footlose, dove le critiche hanno parlato di «recita scolastica ben coreografata»? Non esiste a mio avviso in Italia un numero ancora consistente di artisti che riescano a cantare bene e sapere allo stesso modo
recitare o ballare: vi sono grandi lacune ancora incolmabili; eppure
canzoni estratte da musical come Grease o Jesus Christ Superstar, appartengono alle nostre colonne sonore quotidiane! Ecco che la comunicazione tra l’Italia e altri paesi viene interrotta per mancanza di dialogo
musicale. Ovviamente esistono le eccezioni, élite di giovani e meno
giovani che desiderano comunicare in una sola forma di pop mondiale,
fatta di sfumature e di sonorità diverse, e discostarsi da una semplice e
forzata imitazione delle grandi accademie americane ed europee.
La mia esperienza
Sin dall’inizio mi sono avvicinato a sonorità meno conservatrici e
più alla portata di tutti: credo di essere stato fin dal principio un cantante di popular music. Ho trovato molti ostacoli nella formazione:
questo per ribadire i concetti appena espressi e per far sapere la difficoltà con cui ho dovuto combattere per coltivare il mio talento e avere
la forza e l’entusiasmo di esprimerlo. In me c’è sicuramente la parte
autodidatta senza la quale oggi non avrei potuto conoscere o sperimentare altri tipi di musica ritenuti per l’appunto pop, ma sarei stato
ben più contento se la mia formazione fosse stata ancora più meticolosa e perfezionata al massimo in tutte le sue espressioni, quali il canto,
la danza, la musica e la recitazione.
Ho iniziato a cantare quando avevo circa sette anni, durante una piccola recita scolastica, dove le mie maestre di attività pomeridiane, grazie alla loro personalissima cultura, già molto avanti per il contesto sociale e culturale in cui la Calabria si trovava ventitrè anni fa, decisero di
mettere in scena una sorta di piccolo musical che parlava dell’arrivo di
166
Gianni Testa
Gesù sulla Terra. In questo spettacolo io interpretavo un ragazzo di colore che chiedeva la libertà dalla schiavitù, un messaggio importante
comunicato attraverso il canto, la recitazione e la danza. Da quello spettacolo decisi di iniziare i miei primi studi avvicinandomi alla danza.
Ma, non contento di esprimermi solo attraverso il movimento fisico, iniziai a studiare le tastiere. Contemporaneamente iniziai a cantare in una
piccola tournée di musica folk calabrese, e ad affrontare per la prima
volta un pubblico di piazza. A 8 anni feci il mio ingresso in tv, una emittente privata, cantando L’Italiano di Toto Cutugno, brano appena
presentato a Sanremo (uno degli evergreen di popular music italiana).
A quel punto ero ormai affascinato dal mondo della musica e decisi
di continuare ad impegnarmi per seguire questa strada. I problemi e le
sofferenze cominciarono da subito: ero un ragazzino con attitudini allo
spettacolo che iniziava a scontrarsi con la realtà e le istituzioni, con
una scuola dell’obbligo che di anno in anno pretendeva sempre di più
e non giustificava quanto allora veniva definito “una perdita di tempo
pomeridiana”, ovvero il mio iter musicale. Per ribellione e passione
per la musica, iniziai a tralasciare tutto un mondo fatto di amici, sport
e scampagnate, quel piccolo universo pomeridiano di un comune
bambino che cresce seguendo le leggi della società, per inseguire ciò
che dettava il mio istinto.
Ascoltavo musica nei miei momenti liberi, da Anna Oxa ai New
Trolls, da George Michael ai Duran Duran, dallo Schiaccianoci alla
Vedova allegra. Fondevo sonorità, mi cibavo di tutto un mondo musicale che esprimeva diversi concetti, creava molte contraddizioni, ma
era in comunione dentro il mio cuore: vivevo di musica. Di lì a poco
iniziarono i primi concorsi canori locali, tra cui il primo “Festival Città di Cosenza”, il festival “Ragazzi alla ribalta” e il “Festival della
pre–Sila”, dove iniziai a conquistare sempre e solo primi posti. Venivo
spesso premiato da personaggi dello spettacolo: da Anna Pettinelli a
Dan Harrow, al comico Alvaro Vitali. In ogni concorso mi presentavo
con brani inediti scritti apposta per me, e ritengo di aver avuto parecchia fortuna, visto che il pubblico ci mette sempre del tempo a digerire
delle canzoni nuove, come spesso accade a Sanremo. Già a dieci anni
ero alla ricerca di una mia personalità: non amavo cantare brani di altri, preferivo rischiare grosso. Inizialmente, anche se successivamente
intrapresero strade diverse, coinvolsi le mie due sorelle minori, Giada
e Nadja, ad accompagnarmi in questi concorsi e in piccole tournée.
Grazie alla vittoria al “Festival di Sartano”, in cui partecipai con le
mie sorelle, incidemmo il primo 45 giri inedito, dal titolo Fino in fon-
Popular music: comunicazione e fusione di infinite sonorità…
167
do: eravamo il Trio Volpentesta. Intanto intraprendevo lo studio dell’organo elettronico e del canto.
Da un mondo fatto di musica leggera, cominciai ad interessarmi
all’Operetta e partecipai come tersicoreo a La Vedova Allegra, coreografata da Vilma Battafarano e Stainer. Intanto gli anni passavano, e la
scuola dell’obbligo richiedeva sempre più impegno, così fui costretto
a scegliere la mia sorte, alternando ogni anno studi diversi e distogliendo quindi la concentrazione dal perfezionamento del mio talento.
Il Festival di Castrocaro del 1991 mi fece cominciare a conoscere a
livello nazionale: partecipai alle tournée di Scialpi e fui, per alcune serate, il cantante della sigla di “Castrocaro in tour”. L’anno successivo
la seconda partecipazione al festival, dove gareggiai con artisti come
Nek, 883, Silvia Salemi. Ma anche quell’anno non vinsi, e non riuscivo a capire il perché; certamente come molto spesso accade, i concorsi
non sono sempre del tutto trasparenti, e gli artisti con cui mi trovavo a
competere provenivano già da esperienze e formazioni più complete
della mia. Avevano case discografiche che li spingevano, li vestivano,
li consigliavano, li “impacchettavano”, come si dice in gergo. Curiosa
fu la mia partecipazione come ballerino ad una delle puntate di Piacere Rai Uno con Brigitta Boccoli.
Si parlava in quegli anni di una scuola di perfezionamento canoro, ovvero il C.E.T, Centro Europeo di Toscolano, ideata da Mogol, dove ruotavano insegnanti come Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Mango; e produttori come Oscar Prudente e Mario Lavezzi: insomma una cerchia di
nomi di una certa rilevanza con a capo il grande poeta Mogol. Questo
corso di perfezionamento per interpreti di musica leggera, che mi interessò dal primo momento, costava allora la cifra di sette milioni! Erano molti
soldi per un ragazzo di diciotto anni, proveniente da una famiglia borghese del sud. La speranza riemerse, quando mi avvisarono, dalla scuola, di
un bando di concorso, gestito dalla regione Umbria con i fondi dell’Unione Europea, riguardante quindici posti per seguire gratuitamente i corsi. Feci domanda e, su migliaia di richieste, dopo tre incontri riuscii ad ottenere la borsa di studio. Iniziai a frequentare la scuola e a capire cosa
c’era dietro ai grandi artisti, cosa li differenziava da tanta gente che voleva fare questo mestiere ma con scarsi risultati, e ancora da chi aveva tecniche canore eccezionali ma non possedeva il cosiddetto “quid”.
All’interno della scuola non si studiavano i metodi canonici, ma si
cercava di perfezionare e indirizzare degli artisti già tecnicamente formati. Si iniziava con il valutare le capacità globali dell’allievo, cercando
di infondere il senso di critica da parte dei propri colleghi e anche quello
168
Gianni Testa
di autocritica. Dopodiché si passava all’ascolto di brani realizzati da interpreti di vari generi e di varie provenienze, musicali e territoriali, fino
alla scelta del proprio gusto. Era la prima scuola che comunicava attraverso la musica, ne toccava la sua popolarità trascendendone la sua canonicità. Si partiva così con lo studio e l’analisi delle proprie caratteristiche vocali, cercando di trovare coerenza fra ciò che si vedeva e ciò
che si ascoltava; fra ciò che si è sempre ascoltato o studiato e ciò che sarebbe stato invece adatto e coerente con le proprie caratteristiche fisiche, il proprio modo di essere, di muoversi e di interagire con il palcoscenico, e soprattutto le proprie doti vocali. Ad esempio se un artista è
in grado di ballare e vocalmente è portato per cantare un genere dance o
funk, perché gli si dovrebbe far cantare brani melodici?
Altre nozioni che appresi erano il capire i meccanismi discografici
sempre più complessi e contorti, o il capire la differenza tra una major
e una casa discografica indipendente, o cosa fossero le edizioni musicali o un bollettino Siae. Si cercò un’operazione di comunicazione attraverso incontri con allievi di corsi diversi, autori, arrangiatori, compositori, al fine di formare gruppi di lavoro dove potessero nascere
collaborazioni, e dove ogni allievo potesse trovare la propria identità
musicale, in base alla sensibilità del gruppo e dell’interprete stesso.
Molte sono state le critiche verso questa scuola, perché si riteneva
che il C.E.T dovesse portare alla notorietà gli allievi; ma è una scuola,
non uno studio di produzione artistica. Numerosi istituti privati sono inferociti verso il C.E.T., perché lo ritengono uno specchietto per le allodole, non capendo invece che oltre a essere un punto di ritrovo e di incontro per artisti di città e regioni diverse, è un centro di sviluppo artistico per gente già formata, che cerca di capire cosa ha in più un artista
di successo e come questi è arrivato a tale notorietà. Inoltre il C.E.T. insegna come funziona tutto il meccanismo del “dietro le quinte”; riesci a
trovare la forza e il coraggio in te stesso. Non smisi di studiare e imparare quando le luci del palcoscenico si spegnevano, ma ero stimolato e
spronato il giorno dopo con il CD in mano a bussare di porta in porta
per far ascoltare il mio estro. Il C.E.T aiuta un artista in modo creativo,
comunicativo e collaborativo a confrontarsi con l’altro, creando veri e
propri team, dal paroliere al musicista, all’arrangiatore e all’interprete
stesso; a creare brani di popular music, creazioni che cercano di diffondere messaggi nuovi, dalle sonorità diverse e personali, senza mai cadere nel calderone delle solite cose già scritte ed ascoltate.
Durante i corsi ebbi l’opportunità di entrare negli studi di incisione
per studiare e capire come funziona il missaggio di un brano, oppure
Popular music: comunicazione e fusione di infinite sonorità…
169
come si usa un microfono in sala di incisione, e tutto ciò che concerne
la realizzazione finita di un brano. Prima di allora, ero sempre entrato
negli studi di registrazione in modo incosciente e istintivo, attingendo
a consigli o suggerimenti rubati agli addetti degli studi di registrazione; ma dopo il corso tutto divenne più razionale e professionale.
La mia permanenza nella scuola si concluse con un grande festival su
Rai Due, Stella nascente, e con la registrazione di un CD che fu anche
distribuito, ma che purtroppo non ebbe grandi riscontri. Il C.E.T. mi diede comunque un riconoscimento istituzionale, poiché, con la borsa di
studio e gli esami finali l’attestato rilasciatomi dalla scuola è legalmente
riconosciuto. Molte scuole italiane private meriterebbero le stesse opportunità che lo stato ha concesso e concede al C.E.T, ma purtroppo a volte
la libertà di comunicare attraverso la musica viene castrata. Da qui
l’esigenza di far nascere strutture statali capaci, o strutture parastatali
fornite di docenti impeccabili che possano dare spazio alla nostra cultura
artistica contemporanea: la nostra popular music. Alla mia terza partecipazione a Castrocaro (1995) fui prodotto da Donatella Milani, (già autrice di Ma non ho più la mia città, Piccoli già grandi, Volevo dirti), con
un brano scritto a quattro mani con Maurizio Solieri (chitarrista di Vasco
Rossi), Se ci fossi tu, dalle forti tinte funk–rock. Scappo di notte, un altro
mio brano, fu realizzato con l’allora direttore del C.E.T, Marco Brusati, e
arrangiato da Paolo Scarpino, un altro ex allievo del C.E.T.
Con l’“Accademia della canzone” di Sanremo, nel 1997, mi imbattei
in altri corsi — oltre che nel concorso, dove incontrai altri artisti ed ebbi
memorabili scontri con i colleghi in corsa per arrivare al podio di Sanremo. Di lì ebbi il mio punto di rottura, che mi indirizzò verso i musical:
quell’anno in giuria c’erano Massimo Ranieri e Gianni Togni. Dopo le
varie gare, nel salotto culturale della sera, fui invitato a prendere parte ai
provini del primo vero grande musical italiano: Hollywood. Nella mia
più totale incoscienza mi presentai ai provini, lasciandomi alle spalle
Sanremo, con la certezza che qualcosa stava per succedere. Cantai Cambiare di Alex Baroni, brano provato per sbaglio un paio di volte, poiché
la pianista non era stata in grado di accompagnare ciò che in realtà desideravo cantare (Prima di tutto, di Biagio Antonacci). Di fronte a me avevo il geniale regista Giuseppe Patroni Griffi, l’autore Guido Morra e
gli stessi Ranieri e Togni. Dopo diversi incontri firmai il mio primo contratto importante: Hollywood fu un grande successo, e io iniziai a farmi
un nome in quel settore. Credo che durante gli anni questo meraviglioso
spettacolo abbia cambiato in modo radicale la mia formazione, migliorandola in tutti i suoi aspetti umani e professionali.
170
Gianni Testa
Recitare (in perfetta dizione), ballare, avere il rigore, il rispetto, la
resistenza fisica a dodici/quattordici ore di prove quotidiane, e cantare
tutti i giorni per sei giorni a settimana al massimo delle tue capacità,
era un sogno che avevo conquistato. Ogni sera c’era un pubblico nuovo: Hollywood si replicava in teatri con non meno di mille spettatori a
serata, abituati alle performance di uno dei più grandi artisti italiani,
un grande personaggio in grado di cantare, camminando su un filo, o a
testa in giù su di un trapezio: Massimo Ranieri. È uno dei pochi esempi di duttilità artistica esistente nel nostro continente che, sera dopo sera, pretendeva il massimo da ognuno di noi.
Stuzzicato dalla curiosità, iniziai a prendere lezioni–gioco da alcuni cantanti lirici del cast. Solo allora mi accorsi dell’importanza della
lirica nella formazione di un cantante. Scoprii quanto potente e resistente poteva diventare la mia voce usando tecniche esistenti solo in
quel campo. Così in tre anni di tournée migliorai le mie prestazioni e
la mia duttilità vocale, riuscii a governare e a modellare timbrica ed
emissione sino a riuscire oggi a cantare dal musical, al blues, da brani
di artisti come Modugno, alle finezze e le scale di Terence Trent
D’Arby. Certo, non tutto è sempre a un livello eccellente, perché resto
influenzato, come tutti, da ciò che ascolto in preminenza e sono condizionato dalle mie caratteristiche fisiche–vocali.
Dopo Hollywood arrivò un altro musical, sempre con protagonista
Massimo Ranieri, scritto da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, con la
regia del sempre impeccabile Giuseppe Patroni Griffi: Il Grande Campione, storia dell’amore di Edith Piaf per un boxeur degli anni trenta.
Tra una tournée e l’altra mi affacciai al mondo del cinema, interpretando un ragazzo autistico che riusciva ad esprimersi solo attraverso il canto (dal jazz alla lirica) in Karaoke, un film di Ginetto Campanini, con
Ottavia Piccolo. Il teatro mi aveva formato anche come attore, e ne ebbi
conferma quando mi vidi sul grande schermo — pur avendo freddato
alcune tecniche di recitazione in linea con lo stile cinematografico.
Intanto con Hollywood e Il Grande Campione fui ospite assieme a
Ranieri in diversi show televisivi, esibendomi live nei brani di queste
due opere: dalla Notte dei Telegatti a contenitori televisivi come Domenica In, Buona Domenica, e Ci vediamo in tv, fino a programmi
giornalistici leggeri come Fuego e Verissimo. Così continuai il mio
percorso spostandomi da musical come Maledetta primavera show,
dove ero uno dei protagonisti tra atmosfere comiche e tragiche in uno
show pieno di lustrini, fino al successo di M.A.N, rappresentato anche
al Teatro Rendano con l’orchestra diretta dal trombettista jazz Cicci
Popular music: comunicazione e fusione di infinite sonorità…
171
Santucci, e altri musicisti come Giorgio Rosciglione. Recentemente ho
partecipato come protagonista a Mangiaresti, fiaba scritta da Giovanni
Giannini, accompagnata dall’orchestra del conservatorio di Cosenza.
In questa esperienza il mio bagaglio culturale si è fuso e confrontato
con lo studio canonico di musicisti classici, per l’appunto fuori dalla
veduta del musical, ma con un risultato più che soddisfacente.
E intanto per non tralasciare la mia vecchia passione discografica,
mi feci produrre da Paolo Scarpino in un nuovo singolo dal sapore
pop–dance, dove si incontrano sonorità internazionali come quelle di
Janet Jackson o George Michael, scrivendo stavolta sia le musiche dei
brani, con Scarpino, sia i testi, con Giovanni Giacobelli, autore di film
e regista di cinema ma anche di teatro (M.A.N, appunto).
Ultimamente ho concluso una tournée soddisfacente con alcuni dei
ragazzi di Amici, in cui eseguo brani contemporanei o standard dance anni Settanta, e ho cantato la colonna sonora del film sul terremoto dell’Irpinia E Dopo Cadde la Neve, scritta da Maurizio Fabrizio (I Migliori
anni della nostra vita, Almeno tu nell’universo, Strano il mio destino).
Vorrei esprimere un grande consenso alla sensibilità e all’apertura
che il DAMS dell’Università della Calabria ha dimostrato organizzando questo convegno sulla popular music. Esso ha dato la possibilità a
molti e differenti rappresentanti della musica di parlare in modo personale e liberamente di popular music, in una visione intima e professionale, e in base alla propria esperienza. Figure come il direttore del
conservatorio di Cosenza e i Direttori di alcuni istituti privati hanno
potuto discutere e trovare punti su cui poter lavorare insieme, per cercare di risolvere problematiche che l’attuale popular music vive. Io
stesso, intervenendo a questa tavola rotonda, ho cercato di portare il
mio contributo professionale, in base alla mia esperienza lavorativa e
formativa; e illustri professori universitari si sono resi disponibili al
dialogo e al confronto, ascoltando e vivendo la passione della musica
che noi artisti comunichiamo quotidianamente.
La popular music è quindi a mio avviso una musica di confronto
fra i popoli, il loro colore e folklore, una musica di grande forza comunicativa che crea dibattiti, fatta di consensi e dissensi. Una musica
che scopre il mantello culturale del mondo, fatto di esperienza e curiosità; senza doversi contrapporre alle diverse sonorità d’élite, come la
musica classica, ma confrontandosi con esse, e aprendosi ad un dialogo e una comunicazione portatrici di infiniti stimoli.
Gli autori
Roberto Agostini è professore a contratto di Musiche popolari contemporaee
presso l’Università di Pisa. Tiene corsi e seminari sulla popular music, sulla
relazione tra musica e nuove tecnologie, sulla comunicazione musicale e sulla sociologia della musica. Ha pubblicato vari saggi, e ha curato il volume 8/2
(2002) della «Rivista di Teoria e Analisi Musicale», dedicato all’analisi della
popular music. Uno suo studio sul Festival di Sanremo è in corso di pubblicazione sulla rivista «Popular Music».
Davide Beatino è bassista professionista (ha suonato nella band di Mariella
Nava, ed attualmente suona in quella di Samuele Bersani). Dirige il Modern
College of Music di Reggio Calabria, dove insegna anche basso elettrico. Si è
laureato presso il DAMS dell’Università della Calabria con una tesi sulla storia del proprio strumento.
Maurizio Boco ha insegnato presso l’Università della Musica di Roma. È presidente de La Fonderia delle Arti, da lui fondata nel 2005, e della Drummers
United. È batterista professionista (attualmente soprattutto con il trio BFH),
compositore (colonna sonora dello spettacolo teatrale Porci con le ali, e vari
commenti sonori per il DSE di RAI TRE), produttore. Svolge drum clinics in
tutta Italia, promovendo la ricerca sulle potenzialità soliste della batteria.
Nadia Capogreco insegna Semiologia della Musica presso il corso di laurea
in DAMS dell’Università della Calabria. Si occupa prevalentemente di comunicazione e pedagogia musicale, con particolare riferimento al rapporto fra
musica ed elaborazione dell’esperienza. È redattrice della rivista internazionale online «De Musica – Nuove pagine», e consigliere scientifico della Fondazione Ferramonti.
Fabrizio Deriu è ricercatore in Discipline dello Spettacolo presso il corso di
laurea in DAMS dell’Università della Calabria, dove insegna Metodologia e
Critica dello Spettacolo e Teoria della performance. Si occupa soprattutto di
aspetti teorici delle arti performative (teatro, musica, danza). Ha svolto studi
musicali di pianoforte (classico e jazz) ed è iscritto alla SIAE come compositore. È tastierista in gruppi di popular music.
Massimo Distilo collabora con il corso di laurea in DAMS dell’Università della
Calabria (dove si è laureato), presso il quale tiene laboratori di alfabetizzazione
musicale ed è cultore della materia (Storia della musica). È docente di Pianoforte
nelle scuole secondarie e ha all’attivo diverse pubblicazioni musicologiche.
173
174
Emilio Galante, flautista e compositore, ha studiato al Conservatorio di Bologna e alla Hochschule für Musik di Monaco. Insegna al Conservatorio di
Trento. Si è esibito in tutta Europa e negli USA. CD di sue musiche sono editi da BMG–Ricordi e Velut Luna. Sue partiture sono edite da Sonzogno e
Falls House Press (USA). Laureato in Filosofia, è coautore del Manuale di
Flauto pubblicato da EDT.
Bruno Gioffrè ha pubblicato oltre 20 testi di informatica e nuove tecnologie
per la casa editrice Mondadori. Insegna presso il corso di laurea in DAMS
dell’Università della Calabria Informatica musicale, Informatica per i beni culturali (Facoltà di Lettere), e Audio e multimedia (Corso di perfezionamento in
Tecniche e Linguaggi Multimediali presso la Facoltà di Ingegneria). È docente
nel Master in Ingegneria del suono presso l'Università di Roma Tor Vergata.
Luca Marconi è docente di Pedagogia musicale e di Storia della popular
music presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Como. È presidente della sezione italiana della International Association for the Study of Popular Music
(IASPM). Ha scritto alcuni saggi sulla popular music e ha curato insieme a
Roberto Agostini il numero monografico Analisi della popular music della
«Rivista di Teoria e Analisi Musicale».
Daniele Moraca è poeta e cantautore. Si è laureato con una tesi su Rino Gaetano presso il corso di laurea in DAMS dell’Università della Calabria, dove
tiene seminari sulla canzone d’autore italiana. Ha vinto come autore il Premio
Mia Martini ’97 e come cantautore il premio Pianeta Musica ’98 (Lodi). Ha
lavorato come attore, e ha pubblicato tre CD. Nel novembre 2005 ha tenuto
una serie di concerti a Torshawn (Fær Øer Island).
Egidio Pozzi insegna discipline musicologiche presso il Conservatorio di
Cosenza e il corso di laurea in DAMS dell’Università della Calabria. Dirige
la rivista online «Analitica» ed è co–curatore dei Corsi di Perfezionamento a
distanza e dei Master di I e II livello in discipline musicali dell’Università di
Roma Tor Vergata – Consorzio B.A.I.C.R.. Ha pubblicato saggi di analisi
musicale, ed è in corso di stampa una monografia su Antonio Vivaldi. Sta curando l’edizione critica di Improvvisazione n. 2 di Bruno Maderna.
Massimo Privitera insegna Storia della musica dall’antichità al rinascimento
presso il corso di laurea in DAMS dell’Università della Calabria. Ha pubblicato saggi sulla polifonia rinascimentale e una monografia su Arcangelo
Corelli. Ha curato l’edizione critica di opere di Frescobaldi, Vecchi, Falcone,
e l’edizione italiana di scritti di E.E. Lowinsky. Svolge attività di compositore, vocalista e direttore di coro. Ha fondato e dirige il Coro polifonico
dell’Università della Calabria.
175
Francesco Stumpo è diplomato in contrabbasso presso il Conservatorio “S.
Giacomantonio” di Cosenza e si è laureato presso il DAMS dell’Università
della Calabria. Svolge la professione di insegnante di Scuola Media dal 1979
ed ha una lunga attività di formatore e pubblicista nel settore della didattica
musicale.
Gianni Testa, cantante, attore, ballerino e musicista, ha frequentato la Scuola
di perfezionamento canoro presso il CET di Mogol (vincitore di borsa di studio). Ha partecipato a diversi musical (fra i quali M.A.N., Maledetta primavera
show, Mangiaresti), e ha iniziato nel 2004 un’attività di produzione con la
Sound and Sound. Ha recitato in cortometraggi e lungometraggi, ha fatto numerose tournée come cantante, e ha partecipato a varie trasmissioni televisive.
Stefano Toni suona la batteria dal 1968. Ha vinto nel 1980 il primo Festival
Rock Italiano e ha inciso un disco per la EMI. Ha partecipato nel 1993 alla
rassegna Arezzo Wave, e nel 1994 ha inciso un CD per l’etichetta Laser’s
Edge. Insegna Laboratorio di Trattamento Testi e Dati presso l’I.T.T. L. Bottardi di Roma, dove, da più di dieci anni, è referente per le attività del Laboratorio musicale d’Istituto.
Finito di stampare nel mese di marzo del 2006
dalla tipografia « Braille Gamma S.r.l. » di Santa Rufina di Cittaducale (Ri)
per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma