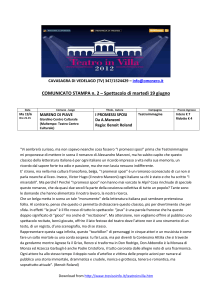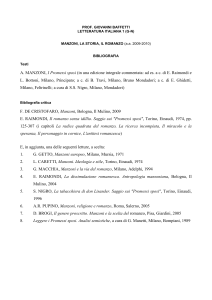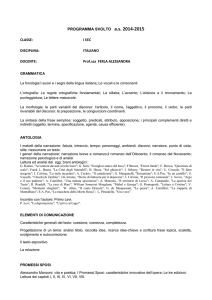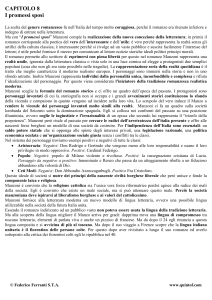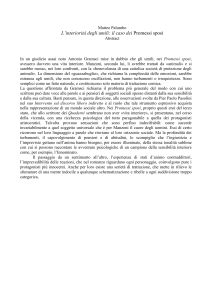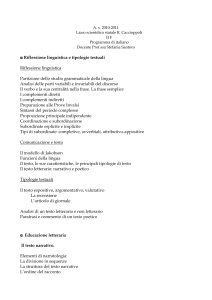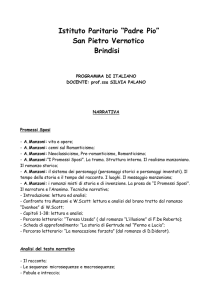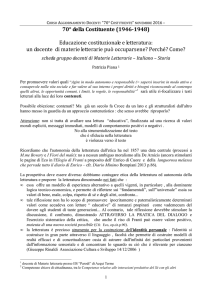Leggere Manzoni
Atti della seconda edizione del convegno letterario ADI-SD
a cura di Barbara Peroni
Ufficio Scolastico per la Lombardia
3
foto di copertina di Michele Benvenuti
progetto grafico www.miteintransigente.it
finito di stampare nel febbraio 2005
4
A Franco Brioschi
in memoria
5
In questo volume sono stati raccolti gli ATTI della seconda edizione del convegno
letterario “Milano da Leggere”, organizzato dalla associazione ADI-DS, tenutosi all’universtià Statale di Milano il 2 e 3 Dicembre 2004.
Lo scritto mantiene i caratteri della comunicazione orale, rispecchiandone l’immediatezza e l’estemporaneità. E’ la trasposizione fedele di tutte le relazioni.
Un doveroso ringraziamento va al prof. Mario G. Dutto, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, che per il secondo anno consecutivo ha permesso lo svolgersi del convegno e questa pubblicazione.
Per ultimi, ma non per importanza, si ringraziano i professori dell’Università statale
di Milano Bruno Falcetto, Claudio Milanini, Vittorio Spinazzola, che hanno presieduto le sessioni del convegno con generosa disponibilità e grande professionalità.
Barbara Peroni, Direttivo ADI-SD
7
Indice
Presentazione e saluto delle autorità
p. 11
Giovanna Rosa, Università degli Studi di Milano
Il patto narrativo dei Promessi sposi
p. 15
Roberto Bigazzi, Università di Siena
Manzoni e Walter Scott
p. 27
Giulio Ferroni, Università di Roma
Manzoni in Sicilia: da Verga a Sciascia
p. 40
Giancarlo Majorino, Poeta
Versi e righe di città
p. 48
Romano Luperini, Università di Siena
Lettere di Verga da Milano e genesi dei Malavoglia
p. 59
Emanuele Zinato, Università di Padova
La guerra a Milano di F.Fortini
p. 70
Franco Loi, Poeta
Camminando per Milano
p. 78
Gianni Turchetta, Università degli Studi di Milano
“ Lo spasma dello spirito e lo spasma della materia”:
I segreti di Milano di G.Testori
p. 88
Gianni Canova, IULM Milano
La Milano nera di Scerbanenco
p. 103
Remo Ceserani, Università di Bologna
Conversando su Milano
p. 110
Tiziano Rossi, Poeta
Le case di Milano
p. 115
Raffaele De Berti, Università degli Studi di Milano
Tra romanzo e industria culturale:
le trasposizioni cinematografiche dei Promessi sposi
p. 126
Giuliana Nuvoli, Università degli Studi di Milano
dalle “Bosinade” al romanzo: storie di seduzione e di virtù
p. 134
Rino Caputo, Università di Tor Vergata
Il cantuccio dell’autore: Manzoni e Pirandello
p. 152
9
Presentazione del convegno:
Apertura lavori
BARBARA PERONI
Direttivo nazionale ADI-SD
Buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere che abbiate accolto con entusiasmo l’invito
dell’ADI-SD a partecipare a queste due giornate di aggiornamento, di ricerca e di
dibattito.
Abbiamo mantenuto la promessa, con cui ci eravamo lasciati un anno fa, di continuare a valorizzare la letteratura, la vitalità e la forza del testo letterario, ed eccoci ad
aprire i lavori della seconda edizione di “Milano da Leggere”.
Grazie al Magnifico Rettore che ospita ancora una volta l’associazione nell’Aula
Magna dell’Università, e grazie alla Direzione Regionale che continua a credere nel
nostro lavoro, lo valorizza e lo diffonde.
La presenza di tanti professori, qui oggi, mi sembra confermare la nostra tesi dell’esigenza di aggiornamento continuo e di esperienze culturali condivise, e sia la
dimostrazione che la collaborazione tra università e scuola debba essere continua,
sempre più allargata, sempre più costruttiva, un punto di forza importante nella costruzione del sapere. Se trasferire i contenuti disciplinari nella sfera di interesse e di
comprensione dei giovani è un “mestiere” difficile, in questa aula ci troviamo a confrontarci su diversi livelli e a cercare di far nascere e crescere un’esperienza circolare.
La letteratura è pensata per aprire un dialogo, e dagli addetti ai lavori a un pubblico
allargato permettere esperienze diverse.
E’ per questo che sono presenti tanti giovani dell’ultimo anno delle superiori di Milano e della provincia tutta (non credo solo perché spronati dai loro professori!). Proprio dal numero così alto di partecipanti, dei più svariati ordini di indirizzi scolastici,
si dimostra come la letteratura abbia un potere coinvolgente e debba essere destinata
al più alto numero di studenti per tutti gli anni di studio.
In quest’aula è la letteratura a risultare vincente, a significare la sua forza per la
formazione. Oggi e domani farà da padrona, spiegherà la sua ricerca di senso, inviterà
alla lettura di testi, al ragionamento e alla critica, poi sarà ripensata, rielaborata, utilizzata per i propri fini di lavoro e di studio.
Dal Convegno del dicembre 2003 era rimasto escluso, volutamente, un discorso su
Manzoni. Il conte Manzoni “spaventa”, spesso è visto come un’icona solo milanese,
uno scrittore imbalsamato, lontano dai gusti degli alunni, uno personaggio malinconi11
co e freddo di cui si deve parlar bene per forza, ma non è detto che lo si ami. Nel convegno del 2004, tra le tante e varie relazioni, molte si prefiggono di dimostrarci come
Manzoni stimoli un confronto impegnativo e dinamico anche con i contemporanei.
Un Manzoni non immobile, privilegiato autore del suo secolo, ma un Manzoni che
invita a confrontare il passato con il presente, un Manzoni portatore di attribuzione di
senso e che suggerisce valori su cui ancora ripensare.
Manzoni offre un patrimonio culturale, che parte dall’asse milanese, ma apre la
letteratura a problematiche internazionali e fornisce significati in un quadro ben più
vasto.
Per la scelta dell’immagine-simbolo della seconda edizione di “Milano da Leggere” ci siamo ricordati dell’aneddoto di Manzoni che passeggiava lungo i Navigli con
i suoi amici toscani e li “assassinava” per sapere l’equivalente italiano di gibigiana.
Se Manzoni scherzava sul “puro raggio ...che gibigianando va”, anche noi con questa
foto abbiamo cercato un sottinteso messaggio poetico. Vorremmo salvare il vicolo
delle lavandare, “le lavandare dalle mani sudicie di pulizia” e consegnarlo ai giovani come un cantuccio testimonianza di storia e di lavoro. Ci è piaciuto immaginare
che anche Verga, Sciascia, Scerbanenco, Testori (di Vittorini lo sappiamo per certo)
sarebbero d’accordo nel vedere tramandato quell’angolo di città e di immaginario
letterario.
L’anno scorso per inquadrare gli autori milanesi e non, di cui stavamo leggendo i
testi, per sottolineare come dovessimo studiarli, non certo chiudendoci in un taglio
campanilistico, avevo fatto ricorso a una frase di Franco Loi, quando afferma il valore della “memoria”, come essenza della scrittura che salva le cose da consegnare
al futuro, supera la nostalgie, apre un dibattito presente- passato. Non credevo che
la frase di Loi ci avrebbe portato tanta fortuna: il poeta ha accettato di partecipare ai
nostri lavori e verrà a parlarci della sua poesia. Altri due poeti, Giancarlo Majorino e
Tiziano Rossi, ci faranno sentire i loro versi sulla città-Milano, metafora ancora una
volta del mondo, per farci respirare una cultura mondiale, forse perché, come dice il
grande poeta siriano Adonis: “i poeti non hanno luogo… Non hanno lasciato né padre
né dimora per le loro storie. Le hanno scritte come il sole scrive la propria storia: in
nessun luogo...”
Concludo. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito all’organizzazione di questo
convegno: un grazie particolare alla Megalibri e all’infaticabile Alessandro Carta, un
grazie al grafico Michele Benvenuti, a Marcello Benvenuti per la collaborazione e
l’assistenza per gli iscritti e gli associati ADI, un grazie alle studentesse del Gentileschi, al servizio d’ordine, ai tecnici tutti.
Un ringraziamento doveroso e sincero ai professori milanesi e non, che hanno offerto il loro tempo, le loro competenze e la loro pazienza.
E infine, non certo in ordine di importanza, un grazie ai professori dell’Università
Statale Bruno Falcetto, Claudio Milanini, Vittorio Spinazzola che presiederanno le
sessioni delle due giornate.
12
MARIO G. DUTTO
Direttore Generale dell’Ufficio Regionale per la Lombardia
Buongiorno a tutti. L’Ufficio Scolastico Regionale si sente veramente onorato di
collaborare con l’ADI sezione didattica per questo convegno letterario, per questo
appuntamento che ogni anno diventa sempre più importante.
Per noi è estremamente rilevante riuscire a vedere una comunità accademica di
interesse disciplinare che mette assieme studenti, studentesse, docenti della scuola, illustri esperti dell’università che operano nel campo della ricerca; noi siamo impegnati
a favorire il dialogo all’interno di questa comunità, dobbiamo ritornare a dare il gusto
della lettura, il gusto della scoperta dei classici della letteratura nelle nostre scuole.
Io credo che per gli studenti e le studentesse, oggi qui presenti, sia quasi un privilegio
uscire dalle proprie scuole, allargare i confini dalle proprie classi e avere un rapporto
diretto con chi opera nel campo della ricerca.
“Leggere Manzoni”, scoprire Manzoni oggi, è sicuramente una grande sfida: ne
abbiamo discusso con i responsabili dell’ADI, e abbiamo dato il nostro appoggio al
Convegno, anche perché noi abbiamo varato quest’anno un progetto di lettura del
Manzoni.
Lunedì scorso a una lettura dell’Adelchi c’erano trecentocinquanta studenti, che
hanno partecipato e ascoltato con grande interesse: mi sembra un segnale di un’attenzione particolare che la scuola deve ritornare a dare ai suoi elementi fondamentali.
Noi riteniamo che sia importante promuovere le vocazioni scientifiche nel campo della matematica e della tecnologia, ma la letteratura deve tornare ad essere, forse anche
più del passato, una componente fondamentale della formazione dei nostri giovani,
come è stato appena detto, non solo studenti del liceo, ma studenti di tutto l’arco delle
opzioni di scuola secondaria.
Mi sembra veramente una grande giornata e un privilegio per chi partecipa, una
soddisfazione per le intese culturali implicite in questo progetto. Non posso che esprimere la mia ammirazione e il mio ringraziamento ai docenti universitari che si sono
mostrati disponibili a parlare agli studenti e comunicare la passione per la letteratura,
non solo attraverso i propri libri e testi, ma anche attraverso incontri diretti; credo sia
un modo diverso di far crescere le nuove generazioni su un tema così importante come
quello che è oggetto del convegno letterario di oggi e domani.
Un ringraziamento particolare all’Università Statale e al Rettore per l’attenzione
con cui segue le nostre iniziative; vorrei ricordare che noi abbiamo con l’Università
Statale, tra le altre iniziative, un progetto on-line che offre un’opportunità agli studenti dell’ultimo anno delle superiori di ampliare e rafforzare la propria capacità di
scrivere, di redigere rapporti. Si chiama Itaonline e potete trovare tutte le indicazioni
sul sito della Direzione Regionale e sul sito dell’Università. Questo per dire che le
diverse istituzioni, in questa “Milano da Leggere”, collaborano e guardano in avanti
per le giovani generazioni.
Mi rivolgo in modo particolare agli studenti per dire loro che intervenire ad eventi
di questo genere è un privilegio e il partecipare con interesse ed entusiasmo rimarrà
nella loro memoria; mi auguro li aiuti a proseguire bene gli studi a conclusione del
ciclo secondario.
Un augurio di buon lavoro per queste due giornate e grazie ancora all’organizzatrice Barbara Peroni.
13
CLAUDIO MILANINI
Direttore del Dipartimento di Filologia Moderna,
Università degli Studi di Milano
Sono lieto di dare il benvenuto ai partecipanti a questo convegno. A tutti, porgo
saluti e auguri di buon lavoro: a nome anche del Magnifico Rettore, prof. Enrico
Decleva; del preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, prof. Elio Franzini; e dei
colleghi che operano nell’ambito del Dipartimento di Filologia Moderna. Desidero
altresì manifestare la mia gratitudine nei confronti di coloro che hanno reso possibile
l’incontro. Ringrazio, in particolare, il prof. Mario Dutto: senza la generosità sua e
dell’Ufficio da lui diretto questo convegno non avrebbe potuto avere luogo; e ringrazio la professoressa Barbara Peroni, che con straordinario impegno e con perseverante
sagacia ha promosso e organizzato queste giornate di studio.
Per la scuola pubblica e per le Università statali corrono tempi difficili. Antiche
carenza logistiche, vecchie e nuove ristrettezze finanziarie, inadempienze legislative,
incertezze normative, precariato diffuso, insufficiente considerazione per la funzione cruciale esercitata dagli insegnanti… In tale contesto, tanto più significativo mi
sembra il fatto che docenti di vari ordini si ritrovino qui, insieme con i loro studenti,
in modo assolutamente libero e gratuito, per rileggere libri di narratori e poeti, per
ascoltare la voce di alcuni fra i più attenti testimoni del nostro tempo, per riflettere
sulla tradizione culturale della nostra città e del nostro Paese.
Mi piace allora menzionare, a mo’ di auspicio, il titolo scelto per una sua raccolta
di versi da uno dei tre poeti che ci onorano con la loro presenza: Dallo sdrucciolare
al rialzarsi. Di questo titolo, che rinvia a uno disegno ironico e toccante di Paul Klee,
Tiziano Rossi fece ottimo uso nell’ormai lontano 1976, in un libro che metteva a
fuoco con estrema sensibilità una condizione innanzi tutto esistenziale. Ma mi pare
che il titolo si attagli perfettamente, per il primo verbo da cui è formato, anche alla
condizione storica in cui oggi viviamo; e che additi, col secondo verbo, un imperativo
etico a cui non possiamo sottrarci. Un invito a non lasciarsi andare, a non cedere alla
tentazione di abbandonarsi pigramente a un assurdo tran-tran, a reagire e ad agire.
Quanto al “come” agire, tocca a ciascuno di noi decidere. Vedo peraltro che lo studio grafico da cui sono stati firmati il manifesto e il dépliant del convegno si chiama
“miteintransigente”. Così vorremmo essere: miti, poiché le armi che ci appartengono,
le uniche che amiamo brandire, sono quelle della parola, dell’intelligenza critica, del
confronto dialettico, del dibattito democratico; intransigenti, perché non siamo disposti a venire a patti con chi accetta o, peggio, alimenta il diffondersi dello sottosviluppo
morale e civile che quotidianamente ci mortifica.
14
GIOVANNA ROSA
Il patto narrativo dei Promessi sposi
Per avviare i lavori di questa giornata del secondo convegno ADI-SD, dedicato
a Milano da leggere, nulla di meglio che ricorrere a una citazione di un autore altamente rappresentativo dell’“illustre tradizione lombarda”. Nel primo centenario della
ventisettana, Carlo Emilio Gadda pubblica su “Solaria” un saggio intitolato Apologia
manzoniana, che si chiude con una domanda provocatoria:
... Don Alessandro, (ma che avete mai combinato?) vi relegano nelle antologie del ginnasio inferiore, per uso dei giovinetti un po’ tardi e dei loro pigri
sbadigli. Che avete mai combinato, Don Ales-sandro, che qui, nella vostra
terra, dove pur speravate nell’indulgenza di venticinque sottoscrittori, tutti vi
hanno per un povero di spirito?1
E’ difficile ancor oggi non concordare con il rammarico crucciato espresso da Gadda, soprattutto alla luce di una secolare pratica scolastica che ha costretto I promessi
sposi entro parametri di così edificante religiosità consolatoria da renderli non solo
indigesti alle scolaresche di tutta la penisola, ma, effetto ben più perverso, estranei
alla coscienza inquieta dei lettori contemporanei.2 A quasi un secolo di distanza, la
domanda dell’autore dell’Adalgisa risuona sempre con insistenza conturbante: perché
il libro che ha genialmente inaugurato la civiltà romanzesca in Italia, induce insofferenza e perplessità?
Per provare a rispondere conviene partire dall’inizio, sì proprio dall’incipit dell’opera. Che non è, come si continua a sostenere, il celebre novenario che apre la
descrizione del ramo del lago di Como, ma piuttosto la sequenza in cui per la prima
volta compare la figura del narratore ottocentesco:
- Ma, quando io avrò durata l’eroica fatica di trascriver questa storia da
questo dilavato e graffiato autografo, e l’avrò data, come - si suol dire, alla
luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla?3
E’ questo il vero inizio del romanzo: sulla soglia del testo, il narratore si rivolge
direttamente ai suoi lettori, per illustrare l’implicazione di reciprocità che intercorre
15
fra atto di scrittura e impegno di lettura. Pochi testi esemplificano con evidenza così
abbagliante la dialettica costitutiva che sorregge la retorica della narrativa:
… l’autore crea un’immagine di se stesso e un’immagine del suo lettore;
crea il lettore come crea il suo alter ego, e la let-tura più riuscita è quella in cui
le due personalità create - au-tore e lettore - riesco-no a trovare un ac-cordo
totale. (…) L’autore crea i suoi lettori. 4
Il dialogismo profondo che innerva il romanzo è avvalorato dall’explicit: che, ancora una volta, non è racchiuso nell’altrettanto celebre “sugo della storia”, ma in un’ultima battuta che l’io narrante indirizza ai suoi lettori:
Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così giusta,
che abbiamo pensato di metterla qui come il sugo di tutta la storia.
La quale se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta e
anche un pochino a chi l’ha raccomodata: ma se in vece fossimo riusciti ad
annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta. (Ps, cap. XXXVIII)
La frase conclusiva, aggiunta nel passaggio dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi,
non solo esibisce la doppia figura del narratore –“chi l’ha scritta”, “chi l’ha raccomodata”-, sintonizzandone la voce colta con la parola popolare dei protagonisti, ma
corrobora la compattezza eccezionale dell’opera che, avviatasi sull’impegno duplice
di scrivere e leggere, rilancia il senso complessivo fuori dal testo, rimettendolo al
giudizio di coloro cui la vicenda è destinata.
Così, ad ogni livello dell’orditura narrativa, lo scrittore ricerca e sperimenta quel
“sentimento per così dire di comunione con il suo lettore, la certezza di maneggiare
uno strumento egualmente conosciuto da entrambi”5, a conferma, decisiva perché
inscritta nelle “zone strategiche” dell’inizio e della fine, dell’ indissolubile nesso di
coerenza che lega scelte di genere, opzioni stilistiche e relazioni dialogiche.
Su questi robusti pilastri poggia la nostra civiltà romanzesca: I promessi sposi fonda
e inaugura la stagione della modernità perché non solo ipotizza l’orizzonte d’attesa in
termini dinamici - pubblico reale vs pubblico potenziale - ma, progetto unico nell’Italia d’allora, chiarisce i dispositivi testuali di un originale “patto narrativo”6. È entro
la griglia polifunzionale dei rapporti fra scrittore e pubblico, narratore ottocentesco e
venticinque lettori, io narrante e io leggente che Manzoni invera la sua ansia di rinnovamento antiaristocratico e post-classicista. Dalle modalità con cui il romanzo declina
le articolazioni del patto scaturisce la sua indiscussa, anche se non pacificamente riconosciuta, caratura europea; in quello stesso reticolo ha origine il disagio guardingo
con cui ancor oggi ci accostiamo alla vicenda di Renzo e Lucia.
L’arditezza compositiva dei Promessi sposi deriva, in prima istanza, dall’atteggiamento coraggiosamente spregiudicato che Don Alessandro assume, agli inizi degli
anni venti, nei confronti della “moderna epopea borghese” (Hegel): la lettura dei libri scottiani lo conquista, incoraggiandolo ad abbandonare le forme tradizionali della
tragedia e della lirica, che pure lo avevano reso celebre e ammirato. Quanto audace
dovesse apparire il cambiamento lo testimonia la reazione di due recensori d’allora:
Paride Zajotti, critico autorevole della “Biblioteca Italiana”, attribuisce alla “sola no16
tizia che l’autore dell’Adelchi, il poeta degli Inni sacri” si sia cimentato nel “genere
anfibio” il merito, o forse la colpa, di averlo “nobilitato” agli occhi di molti “chiari
intelletti”; per parte sua, l’amico Tommaseo, in tono meno diplomatico, lo rimbrotta
per essersi “abbassato a donarci un romanzo”.
Di tale scandalo il primo ad essere consapevole era proprio Manzoni. L’ironia sorniona con cui, nella prima Introduzione, definisce il romanzo “genere proscritto della
letteratura italiana moderna, la quale ha la gloria di non averne o pochissimi” riecheggia i toni polemici che avevano animato le pagine azzurre del “Conciliatore”. Pervase
da un fervore alacre di sperimentazione sono le lettere scritte al Fauriel nella stagione
cruciale dell’ideazione e stesura dell’opera. Nel maggio del 1822 con vivacità inusuale, Manzoni dichiara d’essere un “auteur gros”, e nell’agosto del ‘23 si vanta della
ricchezza strepitosa con cui ha costruito sfondo e personaggi:
Il materiale è ricco; tutto ciò che può far fare agli uomini una meschina
figura c’è in abbondanza; la saccenteria nell’ignoranza, la presunzione nella
stolidità, la sfacciataggine nella corruzione, sono forse i caratteri salienti di
quest’epoca, con molti altri analoghi. Fortunatamente ci sono anche uomini e
comportamenti che onorano la specie umana, caratteri dotati di una virtù forte
e originale, in proporzione degli ostacoli, dei contrasti, e in ragione della loro
resistenza e, a volte, del loro assoggettamento alle idee comuni. Ho voluto
trarre profitto da tutto ciò; Dio sa come. Vi ho ficcato dentro contadini, nobili,
monaci, religiose, preti, magistrati, intellettuali, la guerra, la carestia…
L’entusiasmo insolitamente orgoglioso con cui suggella la lettera, “e questo è aver
fatto un libro”, deriva dalla soddisfazione duplice d’aver accumulato una straordinaria
varietà di materiali, e d’averne trovato le nuove regole compositive. Parafrasando un
famoso passo integrativo alla Lettre à M. Chauvet, vale per il Manzoni romanziere
l’elogio che egli tributò all’amato Goethe: “l’autore non ha solamente prodotto un
capolavoro, ma anche creato un genere”.
A suo fondamento sta la “gran norma dell’interesse”, secondo l’esempio di un altro
importante novel che il nostro scrittore lesse e apprezzò: il Tom Jones di Fielding7.
E’ impossibile enumerare lo sterminio di occorrenze con cui i lessemi di questo
campo semantico affollano la corrispondenza e la produzione narrativa e saggistica
manzoniana. Una sola citazione, tanto scontata quanto esemplare: lo scrittore
deve scegliere de’ soggetti, che avendo quanto è necessario per interessare
le persone più dotte siano insieme di quelli per i quali un maggior numero
di lettori abbia una disposizione di curiosità e di interessamento nata dalle
memorie e dalle impressioni giornaliere della vita.8
Nel passo centrale della Lettera al marchese Cesare D’Azeglio non è solo delineato
il programma di ristrutturazione organica del pubblico romantico, ma è altresì indicato, con l’insistenza puntigliosa della ripetizione interessare-interessamento, il terreno
prioritario su cui questa ricerca doveva essere esperita. È “l’assoluta mancanza d’
interesse”, d’altronde, la colpa più grave che lo scrittore milanese attribuisce ai versi
della sua produzione ancora im-prontata ai dettami ortodossi della tradizione:
17
... sono molto scontento di quei versi, soprattutto per la loro assoluta mancanza di interesse; non è così che bisogna far versi; forse ne farò dei peggiori,
ma non più di questo genere. (lettera a C. Fauriel, 6 settembre 1809)
Al di là delle molteplici dichiarazioni programmatiche che accompagnano sia la
riflessione sulla tragedia sia l’elaborazione del romanzo, è nella pratica di scrittura
che Manzoni ricorre alla strategia dell’interesse per comporre narrativamente storia e
invenzione, e aprire, nel contempo, il dialogo con i suoi “venticinque lettori”. Ancora
una citazione esemplare, tratta dai Promessi sposi:
Però, lasciando scritto quel che è scritto, per non perder la nostra fatica
ometteremo il rimanente, per rimetterci in istrada: tanto più che ne abbiamo
un bel pezzo da percorrere, senza incontrare alcun de’ nostri personaggi, e
uno più lungo ancora, prima di trovar quelli ai fatti de’ quali certamente il
lettore s’interessa di più, se a qualcosa s’interessa in tutto questo (PS, cap.
XXVII)
Il raffronto puntuale del Fermo e Lucia con la ventisettana, che qui non possiamo
sviluppare, conferma la “gran norma dell’interesse” come fulcro progettuale dell’intera compagine romanzesca: solo scegliendo quei soggetti per i quali “un maggior
numero di lettori abbia una disposizione di curiosità e di interessamento nata dalle
memorie e dalle impressioni giornaliere della vita” era possibile riorganizzare, ampliandolo, l’orizzonte d’attesa. E in questa scelta, sia chiaro, non vi è alcuna spinta
all’abbassamento triviale o alla degradazione volgarizzante, anzi. La “moderna epopea borghese” quanto più impone il rigetto delle regole compositive ed espressive del
nostro patrimonio secolare, tanto più esige la rifondazione dei processi di valorizzazione letteraria. E il narratore dei Promessi sposi ne è ben consapevole: per motivare “l’eroica fatica” di raccomodare la dicitura del dilavato manoscritto ricorre a una
spregiudicata ragione d’ordine estetico.
Nell’atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che
una storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta; perché, in quanto
storia, può essere che al lettore ne paia altrimenti, ma a me era parsa bella,
come dico, molto bella. (PS, Introduzione)
L’occorrenza marcata dell’aggettivo- che il passaggio dalla ventisettana alla quarantana intensifica con l’iterazione “bella, come dico, molto bella”- lungi dall’alludere, in tono antifrastico, ad una trama mistificante “inverosimilmente colorita di rosa”9,
vale ad offrire ai lettori una garanzia certa di qualità. Sottolinea Spinazzola:
Al resoconto delle vicende di Renzo e Lucia viene riconosciuto pre-liminarmente il carattere della bellezza, cioè la capacità di suscitare emozioni
universali: di qui la decisione di riscriverlo in modo da ren-derlo effettualmente accessibile alla generalità del pubblico.10
Solo l’opera di fiction volta a suscitare emozioni universali avrebbe abbattuto l’interdetto censorio contro il “genere proscritto”: la storia di Renzo e Lucia era degna
18
di “venire alla luce” e di essere sottoposta al giudizio del lettore perché nasceva dall’impegno arduo ed esaltante di un autore che metteva le sue eccelse risorse inventive
al servizio di un pubblico potenzialmente illimitato. Il romanzo, dotato dei massimi
requisiti di godibilità estetica, era capace, per usare le espressioni illuminanti della
lettera Sul Romanticismo, di sollecitare l’interesse sia delle “persone più dotte” sia
del “maggior numero di lettori non letterati né illetterati”. Sullo sfondo cupo della
Restaurazione, I promessi sposi sprigiona la sua carica di rinnovamento antielitario,
offrendosi come il “libro per tutti”:
Manzoni si propone di collocarsi all’interno del processo di forma-zione
del pubblico borghese ottocentesco, esaltandone lo sviluppo nell’atto in cui
lo proietta entro una salda disciplina di norme, assieme linguistiche e culturali, sociali ed etiche. […] La democraticità del capolavoro manzoniano
nasce dal proposito d’un massimo dispiega-mento di risorse espressive per
attingere la capacità di comunicazione più ampia.11
Forte dell’appartenenza alla cultura della Milano civile e laboriosa, l’autore dei
Promessi sposi puntava a raggiungere i ceti emergenti della borghesia cittadina, per
aggregarli in una collettività larga, resa coesa dal richiamo ai valori del buon senso e
dell’operosità produttiva, sublimati dalla carità e dalla fede religiosa. Grazie a questo
progetto ambizioso, Manzoni si colloca al centro della scena letteraria europea, riplasmando e rilanciando le esperienze più ricche e suggestive del nostro illuminismo
e romanticismo: le discussioni appassionate che avevano animato l’Accademia dei
Pugni, la grande lezione dei monologhi portiani, le riflessioni vive del dibattito conciliatoristico sulla popolarità.
Il dialogo con il “maggior numero di lettori non letterati né illetterati” poteva prendere avvio solo attuando una rottura, questa sì davvero rivoluzionaria, dei procedimenti e delle convenzio-ni che regolavano la relazione testuale fra autore e pubblico.
E qua-le via più diretta di quella di far entrare nello spazio narrativo, di “interessare”
in senso propriamente etimologico12, i destinatari cui il nuovo genere era privilegiatamente indirizzato? È questo il senso primo, polemicamente esibito, della presenza così fisionomi-camente personalizzata di quei “venticinque lettori”: immagine di
narratario ad alta coerenza paradigmatica, elemento dinamico dell’intera macchina
romanzesca13.
Per la durata dell’intero racconto, il narratore dei Promessi sposi dialoga con un
uditorio collettivo, un “narratario di gruppo” , specificamente composto di let-tori
identificati come tali e in nome di questa qualifica costantemente evocati: “i miei venticinque lettori”, “i nostri lettori”, i “nostri lettori milanesi”, “dieci de’ miei lettori”,
“que’ nostri lettori”.
Nella testura narrativa, i venticinque lettori sono raffigurati come moderno “pubblico”, privo di distinzioni particolari, e affatto estraneo a connotazioni d’ ordine naturale, di sesso o di età. D’un balzo, con coraggio ardimentoso, Don Alessandro brucia la
caratterizzazione di “gender” che per secoli aveva accompagnato la prosa narrativa.
Nella Introduzione del ‘21, il destinatario prescelto era ancora identificato nelle donne
“che non conoscono la maniera dotta e ingegnosa di leggere per cavillare lo scrittore,
ma si prestano più facilmente a ricevere le impressioni di verità, di bellezza, di bene19
volenza che uno scritto può fare” (FL, p.7).
Già nella seconda Introduzione del ‘23 scompare ogni richiamo esplicito alle cerchie di utenza femminile: nessun appello alle “gentili lettrici”, amanti delle vicende
sentimentali settecentesche o alle giovinette che si perdevano nel patetismo delle novelle in versi, allora di gran moda. Nessun accenno neanche alle schiere dei giovani
che, atteggiati in pose più o meno byroniche, si erano affacciati sulla scena romantica,
pronti a diventare gli interlocutori privilegiati della narrativa risorgimentale di intonazione melodrammatica. Non è una scelta di poco conto: solo dieci anni prima, in
quell’accoppiata –“ne’ giovani e nelle donne”- Foscolo aveva racchiuso il pubblico
dei “libri amorosi”.
Altra e ben più moderna è la strategia interlocutoria adottata dall’autore dei Promessi sposi.
Se la figura testuale dei venticinque lettori ha un carattere programmatica- mente
collettivo, un pubblico nell’accezione specifica del termine15, non va dimenticato che
nella stragrande maggioranza dei casi, il narratore si rivolge all’individualità singola
dell’io leggente: “il lettore se n’è già av-veduto”, “Risparmio al lettore”, “Non bisogna però, che a questo nome, il lettore si lasci correre alla fantasia l’immagini...”, e
così via.
Il capolavoro manzoniano mette in atto, cioè, una serie di spinte e controspinte
perfettamente bilanciate che chiamano in causa sia l’identità comunitaria di un gruppo ampio e variegato, sia, nel contempo, la coscienza singola dell’io leggente, che
partecipa alle vicende narrate attraverso i processi silenziosi della lettura privata e
libresca16. Nessuna contraddizione oppone le due diverse modalità comunicative che,
anzi, nel loro antagonismo solidale, danno vita alla dialettica sempre sottesa al romanzo, il genere “più giovane della scrittura e del libro”, l’unico “organicamente adatto
alla nuove forme della percezione muta, cioè alla lettura”17. La “moderna epopea borghese” in tanto può raggiungere un’utenza indifferenziata, potenzialmente di massa,
in quanto ogni testo di finzione postula un “patto” fiduciario con il singolo individuo,
coinvolto nella dinamica fruitiva nei suoi tratti idiosincratici e antropologicamente
irriducibili alle spinte omologanti.
Il lettore di romanzi è istituzionalmente “parte di un pubblico”, in quanto simile
ai tanti anonimi che compongono i sottoinsiemi di “opinione pubblica” cui l’opera è
elettivamente rivolta, ma è anche “soggetto di un pubblico”18, in grado di esplicitare
al meglio l’esperienza individuale, critico-emotiva che sorregge, nella modernità, la
lettura libraria, non più sonoramente scandita a voce alta.
Nasce da questa consapevolezza il netto rifiuto manzoniano di usare i procedimenti
fàtici della retorica convenzionale: il narratore rigetta gli “appelli” indirizzati ad un
“uditorio” tradizionalmente configurato, per privilegiare le formule conversevoli, che
mai alludono alle pratiche dell’ascolto: a orientare il dialogismo fra io narrante e io
leggente è adibito un rigoroso patto di finzionalità19. Il repertorio della locuzioni “inclusive” - notate bene, si pensi ora, né si creda, - suggerisce una relazione di sintonia
amicale fra i due interlocutori, ma tale “prossimità” è determinata dalla dimensione
propriamente libresca della fiction. L’impegno del narratore che ricopia la storia di
Renzo e Lucia dal dilavato autografo non solo certifica la verità dell’invenzione, nobilitandola con i materiali documentari della cronaca passata, ma corrobora l’origine
“manoscritta” del racconto e diluisce le note dell’oralità entro le cadenze elaboratissime della “raccomodatura”. Con uno scarto palese rispetto al modello scottiano,
20
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
21
ROBERTO BIGAZZI
Manzoni e Scott
1
Il 24 aprile 1821, come è scritto sull’autografo, Manzoni comincia il suo romanzo, nella prima versione che oggi ci è nota con il nome Fermo e Lucia. Tra aprile e
maggio, in una quarantina di giorni, scrive i due capitoli iniziali e la cosiddetta prima
introduzione. Poi lo lascia perché si dedica all’Adelchi, che porta a termine (e scrive
anche il Cinque maggio). Finito l’Adelchi, è incerto tra tornare al romanzo o mettere
mano a una terza tragedia, lo Spartaco. Una incertezza, questa, non dell’individuo
Manzoni ma del tempo: nella cultura di quegli anni ha fatto clamorosa irruzione un
genere considerato inferiore, il romanzo, ma lo ha fatto sotto vesti inedite, quelle appunto del romanzo storico, con grande successo: un successo e delle vesti che rendono
incerto chi, come Manzoni, si muove già nella storia, affidandola però ai generi tradizionalmente alti del teatro e della poesia. Per capire dunque quell’avvìo narrativo,
bisogna manzonianamente fare un passo indietro.
Responsabile del lancio europeo del romanzo storico è Walter Scott che all’altezza
del 1821 ha già scritto, conquistandosi clamorosamente il pubblico europeo, quasi
tutti i suoi capolavori, a cominciare dal prototipo, Waverley, del 1814. E ‘pubblico’
non significa soltanto le masse anonime dei nuovi e magari sprovveduti lettori, visto
che tra i sedotti ci sono o ci saranno, oltre a Manzoni, quelli che consideriamo tra i
fondatori della narrativa moderna, cioè Stendhal e Balzac. Accanto a loro, tanti storici di primo Ottocento, che debbono a Scott lo stimolo e l’esempio verso una storia
diversa, come riconosceva Carlyle:
…questi romanzi storici hanno insegnato a tutti questa verità, che sembra
una cosa ovvia e tuttavia era ignorata dagli scrittori di storia e dagli altri
prima di questa lezione: le età passate del mondo erano piene di uomini vivi,
non di protocolli, carte ufficiali, controversie e astrazioni di uomini. Non
erano astrazioni né diagrammi né teoremi, ma uomini in giacconi di cuoio o
altre palandrane e braconi, con colore sulle guance e passioni in corpo, e la
parlata, i tratti e la vitalità di uomini veri.
In altre parole, a una società borghese in via di assestamento dopo la rivoluzione e
desiderosa di darsi una identità diversa da quella delle società di ancien régime, Scott
27
aveva offerto lo strumento per rileggere la storia alla luce dei valori appunto borghesi,
liberali, post-rivoluzionari, cioè quell’insieme di principî, sentimenti, comportamenti, in rapporto alla vita e alla società, che confluiscono nel concetto di “costumi” (la
grande parola d’ordine del periodo tra Sette e Ottocento).
Scott aveva da tempo le idee chiare sull’importanza del rapporto tra letteratura e
storia. Già nel 1806 poteva recensire sulla Edinburgh Review una raccolta di poemi
cavallereschi in questi termini sorprendenti:
Per farsi una giusta idea della nostra storia antica, non possiamo fare a
meno di pensare che questi lavori della fantasia [i poemi, appunto] dovrebbero essere letti insieme alle fatiche degli storici patentati. Quelli ci insegnano che cosa pensavano i nostri antenati, come vivevano, in base a quali
motivazioni agivano e che linguaggio parlavano; e avendo raggiunto questa
conoscenza intima dei loro sentimenti, usi e costumi, siamo certamente meglio preparati a imparare dai particolari di fatto dei loro annali. Dal romance
impariamo chi erano, dalla storia cosa facevano: e se ci dovesse essere sottratto uno di questi tipi di informazione, ci sarebbe da chiedersi quale è il più
utile e interessante.
Certo, il teatro storico stava già facendo qualcosa del genere, ma i costumi richiedono una folla di personaggi e una narratività a cui la tradizione teatrale risponde a
fatica, come testimoniano Schiller con il suo Wallenstein lievitato a proporzioni enormi o Manzoni con i suoi cori. D’altro canto, il romanzo del tempo poteva solo fornire
proposte insufficienti: tra romanzo gotico, sentimentale, epistolare o di costumi contemporanei, si guarda allo stato delle famiglie o degli individui ma non a quello della
nazione, della cui identità non ci si preoccupa perché viene data per scontata. Nello
stesso Ortis la patria è presente come ideale, non potendolo essere nella realtà. Se si
pensa alla data dell’esordio di Scott - Waverley è del 1814, alla vigilia di Waterloo - si
capisce perché l’identità e i costumi sono invece al centro del romanzo storico: alla
fine degli sconvolgimenti provocati dalla Rivoluzione francese e dall’avventura napoleonica c’è l’urgenza di definire il mondo che ne è uscito, dando alla borghesia non
più rivoluzionaria una storia reinterpretata a sua immagine e somiglianza e quindi una
genealogia storica che ne legittimi la presenza alla ribalta del mondo.
Così, con la storia, la politica in senso lato entra nel romanzo, e doveva essere una
cosa che appariva problematica. Prendiamo il già citato Waverley, in cui si parla della
rivolta scozzese del pretendente Stuart contro la corona inglese a metà Settecento,
Scott si preoccupa qui subito di far accettare la politica ai lettori, anzi alle lettrici,
destinatarie convenzionali della narrativa da Boccaccio in poi, a segno di un pubblico
poco colto, dedito al mero piacere della lettura. A loro spiega appunto che cercherà
di mescolare al diletto romanzesco la tonalità più prosaica e meno dilettosa della politica:
Chiedo scusa una volta per tutte a quei lettori che ricorrono a un romanzo
per divertirsi, per il fatto di tormentarli tanto a lungo con una politica antiquata, Whig e Tory, Hannoveriani e Giacobiti. Il fatto è che non posso promettere loro che questa storia sarà comprensibile, per non dire probabile, senza
di quella. Il mio progetto richiede di spiegare i motivi su cui poggia l’azione
28
nel suo procedere, e questi motivi necessariamente sono nati da sentimenti,
pregiudizi e fazioni del tempo. Non invito le mie graziose lettrici, a cui il
sesso e l’impazienza danno tutti i diritti di lamentarsi di queste circostanze,
in un carro volante tirato da ippogrifi o mosso per incantamento. La mia è
un’umile diligenza inglese, procedente su quattro ruote [...] Quelle che si
contentano di rimanere con me, saranno talora esposte al disagio inseparabile
dalle strade cattive, dalle salite impervie, dalle pozze e altri ostacoli terrestri,
ma con dei cavalli passabili e un cocchiere dabbene mi impegno ad arrivare
prima possibile in una terra più pittoresca e romantica. (Waverley, 1814, fine
del cap. V)
Ecco dunque il primo colpo di genio: perfezionando la lezione del teatro storico, il
romance, ricco di avventure, di amori e quindi di diletto e di pubblico, entra dunque a
far parte di una struttura narrativa di per sé antiromanzesca, da cui viene controllato.
Il carro volante affascina, ma la diligenza è solida. La dimensione storica, realistica,
ricca di colore locale e di personaggi, può allora ridimensionare quanto ci può essere
di irregolare, di trasgressivo nei comportamenti individuali e sociali, mettendo i sentimenti e gli ideali in dialettica con la società, invece di lasciarli sfrenatamente liberi
come è tipico di un romance che invada la pagina. Non sono più tempi da Werther
o da Ortis, né da romanzo gotico, non sono cioè tempi di ribellioni e di paure, ma di
intelletti impegnati nel reale, da interpretare alla luce della storia e delle sue leggi.
Questa miscela di base tra storia e romance che è tipica del romanzo ottocentesco
anche quando la storia diventa quella contemporanea, ha bisogno però di una quantità di marchingegni di tecnica narrativa, e Scott ha il merito di averli forgiati. Così,
rivolgendosi alla tradizione, Scott mette a punto tutta una serie di elementi strutturali
del romanzo creandone la forma ottocentesca, merito che i contemporanei gli riconobbero subito ma che la critica di oggi stenta invece a attribuirgli, visto che è scaduto
nell’immaginario collettivo a produttore di fumetti medievali (ma la riscossa è in
corso). Vediamo questi elementi.
Il primo e fondamentale è la forma drammatica, cioè la miscela tra voce descrittiva
dell’autore e dialogo dei personaggi, cosa di per sé non nuova, ma messa in opera in
maniera drastica. Recensendo anonimamente una delle proprie opere, Tales of my
Landlord, nel 1817, Scott fa finta di criticare le proprie innovazioni per spiegarle in
realtà ai critici del tempo, incapaci di capirle perché ancorati a una estetica classicista:
…abbiamo notato che, con una attenzione che giunge persino all’affettazione, egli [cioè appunto Scott] ha evitato il linguaggio comune della narrazione e messo la sua storia il più possibile in una forma drammatica. In
molti casi ciò ha contribuito molto all’effetto, col tenere continuamente sia
gli attori che l’azione di fronte al lettore, ponendolo in certo qual modo nella
situazione del pubblico a teatro, che è indotto a ricostruire il significato della
scena da quanto i personaggi si dicono l’un l’altro, e non da una qualche
spiegazione che gli venga data direttamente. [...]
Audacemente, nello stesso passo, Scott fa derivare dal principio drammatico la
figura stessa dell’antieroe, che sul suo esempio caratterizza la narrativa ottocentesca:
29
Oltre allo stile narrativo slegato e incoerente, un altro fondamentale difetto
di questi romanzi è la totale mancanza di interesse del lettore nei riguardi del
personaggio dell’eroe. Waverley, Brown o Bertram in Guy Mannering e Lovel nell’Antiquario appartengono tutti alla stessa famiglia: un tipo di giovane
molto amabile e molto insipido. Ci sembra di capire che anche questo sbaglio
ha in qualche modo la sua ragione nel principio drammatico su cui lo scrittore
costruisce le sue trame. I suoi personaggi principali non agiscono mai, ma
vengono sempre agiti dal pungolo delle circostanze, e il loro destino viene
determinato in modo uniforme per intervento dei personaggi secondari. Questo deriva dal fatto che di solito l’autore li ha rappresentati come stranieri, per
i quali tutto, in Scozia, è insolito - circostanza che gli serve da giustificazione
per addentrarsi in molti particolari minuti, che sono di riflesso, per così dire,
rivolti al lettore attraverso la mediazione dell’eroe. Mentre egli si addentra in
spiegazioni e dettagli che, rivolti direttamente al lettore, potrebbero apparire
noiosi e inutili, egli li rende interessanti mostrando l’effetto che producono
sull’interprete principale del suo dramma, e nello stesso tempo ottiene un
paziente ascolto per ciò che altrimenti avrebbe potuto sfuggire all’attenzione.
Ma se ottiene questo vantaggio lo fa sacrificando il personaggio dell’eroe.
Sembra il ritratto di Renzo quando entra a Milano. Ma resistendo per ora all’impazienza di tornare a Manzoni, bisognerà dire che Scott ha dichiarato più volte che la
fonte delle sue innovazioni strutturali è l’Orlando furioso, il cui principio costruttivo
evita la trama lineare a favore di un andamento multiplo, dovuto al fatto che le storie
dei singoli personaggi si intersecano continuamente tra di loro: una struttura che per
Scott trovava la conferma in quella dei drammi ddi Shakespeare, tornato prepotentemente da pochi anni alla ribalta europea a scapito della tradizione del teatro classicista
delle regole. Nasce così una struttura a sequenze intrecciate, a blocchi che si alternano, con il risultato di una immagine complessa del reale, dove i vari mondi e i vari
personaggi non possono che congiungere i loro destini. Ecco una spia rivelatrice, nel
punto di Ivanhoe in cui il colloquio tra il re Riccardo travestito e il frate viene interrotto da qualcuno che bussa alla porta del romitorio, alla fine del capitolo XVIII:
La ragione di questa interruzione la possiamo spiegare solo rifacendosi alle
avventure di un altro gruppo di personaggi, perché, come il vecchio Ariosto,
non ci sentiamo impegnati a rimanere costantemente in compagnia di nessun
personaggio del nostro dramma.
E bisognerà quindi dire che al centro di questo insistere sul principio drammatico
con le conseguenze relative c’è appunto, come in teatro, la parola dei personaggi.
Lo chiarisce in modo fulmineo una delle prime pagine di The Bride of Lammermoor
(1819):
Un antico filosofo [...] era solito dire: ‘Parla, in modo che io ti possa conoscere’; e quale modo più attraente ed efficace ha un autore per presentare al
lettore le sue personae dramatis se non il dialogo [...]?
In questo dilagare del personaggio, vero fondamento del romanzo ottocentesco,
30
quale parte resta all’autore, che nella narrativa del Settecento si era abituato a dialogare tranquillamente e spesso umoristicamente col lettore, invadendo la pagina?
L’autore si specializza ora nel rendere minutamente la scena e i personaggi, assume
cioè lo statuto della didascalia, certo molto allargata rispetto a quella teatrale, come
Scott chiarisce nella sua introduzione a Fielding (1821):
L’autore di un romanzo, per dirla in breve, non ha né palcoscenico né chi
gli dipinga le scene, né compagnia di attori, né sarto, né guardaroba; le parole, impiegate nel modo che sa meglio, devono supplire a tutto quello che
tali aiuti offrono al drammaturgo. L’azione e il tono, e il gesto, il sorriso dell’innamorato, il cipiglio del tiranno, la smorfia del buffone - tutto deve essere
detto, perché niente può essere mostrato. Così, lo stesso dialogo si mescola
con la narrazione; perché egli deve riferire non solo quello che i personaggi
hanno detto, nel che il suo compito è lo stesso di quello del drammaturgo,
ma deve anche descrivere il tono, l’aspetto, il gesto, da cui quel discorso era
accompagnato, - raccontare, in breve, tutto ciò che nel dramma rientra nei
compiti dell’attore di esprimere.
Ho già accennato a Shakespeare. E se adesso torniamo finalmente a Manzoni, vediamo che proprio Shakespeare ha mediato il rapporto con Scott. Mi riferisco alla
Lettre a M. Chauvet, scritta nel 1820 ma pubblicata nel 1823, e vorrei subito sottolineare che non casualmente nella Lettre l’ingegno manzoniano mette subito in relazione il teatro shakespeariano con il romanzo storico, e lo fa a proposito della mescolanza fra tragico e comico (pur con tante incertezze, visto che maneggia un problema
esiziale per l’estetica classica)
[...] Shakespeare ha mescolato spesso il comico agli avvenimenti più seri.
[...] io penso, né più né meno di un buono e leale partigiano del sistema
classico, che la mescolanza di due effetti contrari distrugga l’impressione
unitaria che necessita per produrre emozione e simpatia. [...] Peraltro, che sia
veramente e definitivamente impossibile ottenere un’impressione armonica
e gradevole accostando questi due elementi, è cosa che io né ho il coraggio
di affermare né la docilità di ripetere. Vi è solo un genere nel quale si può
in anticipo negare, anche ad un genio, ogni speranza di durevole successo,
e questo genere è il falso [...] Non si rileggono forse ogni giorno opere, sia
pure di genere narrativo, nelle quali è presente assai spesso questa mescolanza, e senza che ci sia stato bisogno di giustificarla, perché essa è talmente
incorporata nella verità avvincente dell’insieme che nessuno l’ha notata per
censurarla? [trad. di A. Sozzi Casanova]
Ma Shakespeare per Manzoni è anche l’esempio di come, allontanandosi da una
poetica classica, cioè dalle regole, si possa essere più vicini alla realtà perché non si è
costretti a creare un ordine artificiale per far coincidere gli eventi con le unità di luogo
di tempo e di azione; e creare, nel vocabolario manzoniano, vuol dire privilegiare il
falso, uscendo dall’impegno morale alla verità. Misurando infatti Shakespeare alla
luce delle regole, afferma la Lettre,
31
si potrebbe dirgli che l’attenzione che egli ha posto nel rappresentare le
vicende nel loro ordine naturale e con le situazioni fondamentali più accertate storicamente, lo assimila a uno storico più che a un poeta. E potreste
aggiungere [Manzoni si rivolge a Chauvet] che proprio la regola delle unità
l’avrebbe reso poeta, costringendolo a creare un’azione, un intreccio, delle
peripezie; perché, voi dite, “è così che i limiti imposti dall’arte danno stimolo
all’immaginazione dell’artista, e lo costringono a diventare creatore”. E’ proprio questa, ne convengo, la vera conseguenza di una tale regola [...] Secondo
voi, questo è un gran vantaggio. Io mi permetto di non essere dello stesso
parere, e, al contrario, di considerare tale effetto come l’inconveniente più
grave prodotto dalla regola; sì, questa necessità di creare, imposta arbitrariamente all’arte, la allontana dalla verità e la danneggia tanto nei suoi risultati
che nei suoi mezzi.
Evidentemente per lui, come per i nuovi romanzieri, intrecci e peripezie si identificano con l’aborrita tendenza romanzesca che il dibattito tra Sette e Ottocento aveva
condannato. E la condanna è tanto più forte perché per Manzoni la verità è un valore
anche etico-religioso. Spunta però nelle pagine della Lettre un altro tipo di creazione
accettabile, anzi auspicabile, ed è legata al bisogno di capire gli esseri umani e quindi
i personaggi:
Ma, si potrà dire, se al poeta si toglie ciò che lo distingue dallo storico, e
cioè il diritto di inventare i fatti, che cosa gli resta? Che cosa gli resta? la
poesia; sì, la poesia. Perché, alla fin fine, che cosa ci dà la storia? ci dà avvenimenti che, per così dire, sono conosciuti soltanto nel loro esterno; ci dà
ciò che gli uomini hanno fatto. Ma quel che essi hanno pensato, i sentimenti
che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro progetti [...] tutto questo,
o quasi, la storia lo passa sotto silenzio; e tutto questo è invece dominio della
poesia. Sarebbe assurdo temere che, in tale ambito, manchi mai alla poesia
occasione di creare nel senso più serio, e forse nel solo serio, della parola.
Queste parole assomigliano molto a quelle della recensione scottiana da cui siamo
partiti; e anche Manzoni fa presto a arrivare dai sentimenti ai costumi:
Trovare in una serie di fatti l’elemento che li costituisce in vera e propria
azione, cogliere i caratteri di coloro che vi agiscono, dare a questa azione e
a questi caratteri uno sviluppo armonico, integrare la storia, ricostruirne, per
così dire, la parte che è andata perduta, immaginare, anche, dei fatti là dove
la storia non dà che delle indicazioni, inventare, se occorre, dei personaggi
per rappresentare i costumi di una determinata epoca, costumi di cui si è a
conoscenza, prendere insomma tutto quello che esiste e aggiungere quello
che manca, ma in modo che l’invenzione si accordi con la realtà, sia un mezzo in più per evidenziare la realtà, ecco quel che ragionevolmente può esser
definito creare.
E’ chiaro che qui l’invenzione, in quanto legata alla realtà, è lontana dal romanzesco. A questo punto Manzoni non può non prendere atto che le sue esigenze, le sue
32
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
33
GIULIO FERRONI
Manzoni in Sicilia:
da Verga a Sciascia
È vero che la cultura italiana ha un rapporto difficile con Manzoni, o almeno contraddittorio: se ufficialmente si riconosce il valore, l’essenzialità, l’importanza anche
rivoluzionaria dell’opera manzoniana, tutto questo non corrisponde ad un vero e proprio amore dei lettori (specialmente dei lettori del secondo Novecento) nei confronti
del Manzoni e dei Promessi sposi. E si suole dire che la scuola ha le sue gravi responsabilità: essa allontanerebbe i lettori, non tanto perché insegna male, ma per il fatto
stesso che ve lo insegna, magari troppo precocemente. Lo hanno ripetuto in tanti: tra
gli altri l’ha detto un siciliano come Vitaliano Brancati, insieme al romagnolo Leo
Longanesi, nell’ironico Piccolo dizionario borghese pubblicato su “L’Italiano” del
settembre-ottobre 1941 (una serie di brevi voci collegate a brevi definizioni, ripresa
in chiave leggera, in un gioco tra battute scherzose e idee consunte, del celebre Dizionario dei luoghi comuni del Bouvard e Pécuchet di Flaubert), in cui la voce Manzoni
comporta la definizione: “Il male è di averlo letto a scuola”.
Manzoni fino a pochi anni fa è stato fatto valere come modello scolastico e nazionale su quattro piani: quello religioso, quello etico, quello politico, quello linguistico.
Tutto questo ha depositato sui suoi testi una oppressiva pesantezza, lo ha reso ostico e
difficile aldilà della stessa difficoltà dei suoi testi (ed è vero del resto che la splendida
prosa dei Promessi sposi appare sempre più lontana dal linguaggio oggi corrente).
Ma che dire del fatto che il “Corriere della Sera”, nel primo numero del nuovo inserto domenicale ha inaugurata una serie di cronache su incontri con gli scrittori nelle
scuole, presentando la visita, in una scuola di Milano, di Giorgio Faletti, scrittore che
viene considerato grandissimo, in quanto autore di vendutissimi best sellers del genere cosiddetto noir? Guardate la prosa di questo Faletti e capirete perché, se questa è
letteratura, il buon Manzoni vada tranquillamente messo nel dimenticatoio. Io non ho
nulla contro la paraletteratura e i suoi cultori, ma credo che la promozione canonicoscolastica di un autore di quella fatta sia per lo meno equivoca.
Questi equivoci sono collegati alla situazione che viene fotografata da una preoccupante pagina del numero di oggi del “Corriere della Sera”, che riporta dati oggettivi
sulla situazione della cultura e della lettura a Milano: nel 1989 vi furono vendute un
milione e 552.000 copie di libri, mentre nel 2003 solo 966.309. Insomma il numero
è quasi dimezzato: la situazione è difficile e problematica, anche se la stessa pagina
40
mostra come dietro questo dato ci sono altri segnali positivi pur se contraddittori:
e comunque, quando si pensa al valore che ha avuto per la libertà intellettuale, per
l’esercizio della critica, ha avuto il diritto d’autore (legato appunto alla vendita dei libri), non si può non ritenere preoccupante un calo cosi forte, in una grande città come
Milano, della vendita dei libri nel giro di soli dieci anni.
Lascio da parte questa premessa, che però non potevo trascurare in un contesto in cui
si discute del rilievo e della difficoltà della lettura di Manzoni, e passo al tema specifico della mia conversazione.
Manzoni e i siciliani: è strano che, nel quadro del rapporto difficile degli Italiani
con Manzoni, gli scrittori siciliani si distinguano per un particolare interesse, una
particolare attenzione alla sua opera. E’ difficile trovare uno scrittore siciliano che
non riconosca l’importanza di Manzoni e non lo senta come un punto di riferimento
determinante per la sua attività. Si potrebbe dire, forse, che ciò accade perché Manzoni rappresenta un emblema di Milano e per i siciliani Milano ha sempre rappresentato
un approdo, il contrario della Sicilia, l’“altro”, il punto di riferimento per percorrere
la strada della modernità, per uscire fuori dalle contraddizioni della realtà siciliana.
Certo gli atteggiamenti e le soluzioni sono vari e diversi: sarebbe interessante fare una
storia della letteratura siciliana dell’Ottocento e Novecento in funzione del rapporto
con Milano e del ruolo che in questo rapporto gioca Manzoni, come emblema di una
modernità tutta tradizionalmente milanese, che non recide il legame con il passato,
con la tradizione della intera storia letteraria e politica italiana, con quella storia rispetto alle quale la Sicilia si è sentita quasi sempre diversa, un po’ a parte (e sappiamo
del resto che, lasciando da parte la scuola siciliana delle origini, solo a partire dall’Ottocento si è sviluppata in Sicilia una grandissima letteratura, forse più che in qualsiasi
altra regione italiana),
Qui non ripercorrerò la varia storia dei rapporti degli scrittori siciliani con Milano
e con Manzoni: tanto più che in questo convegno sono previsti interventi proprio su
Verga (Luperini) e Pirandello (Caputo). Certo bisognerebbe chiedersi in particolare
cosa sia stato Manzoni per quei siciliani che non solo l’hanno letto e amato, ma sono
venuti nella sua Milano e vi si sono installati: è il caso di due poeti come Salvatore
Quasimodo, e di lui più grande, Bartolo Cattafi, o di prosatori come Elio Vittorini (la
cui sicilianità è venuta addirittura a sovrapporsi e a confondersi con una particolare
milanesità) e quello che è oggi il maggiore scrittore siciliano, Vincenzo Consolo, che
a Milano ha abitato e abita, anche se con rincrescimento per quello che oggi la città è
diventata, e considera Manzoni un punto di riferimento essenziale, anche se percorre
strade molto diverse. Ma, ahimè, un nuovo tracciato di rapporti tra la Sicilia e Milano,
potrebbe oggi essere indicato dal legame tra Berlusconi e il bibliofilo Dell’Utri….
Ma, prima di insistere su Sciascia, che forse è il più autenticamente manzoniano
degli scrittori del Novecento, vorrei dire qualcosa sul manzonismo del già ricordato
Brancati, i cui romanzi possono sembrare molto poco manzoniani, ma che mostra, da
vari segni, la sua stima, la sua attenzione verso il grande milanese. In vari interventi
dell’immediato dopoguerra raccolti nel cosiddetto Diario romano, Brancati fa riferimento a Manzoni anche in polemica con l’anti-manzonismo del romano Moravia,
autore di molti interventi contro Manzoni (ma sul suo anti-manzonismo qualcuno
potrebbe scoprire un caso tipico di quell’angoscia dell’influenza di cui ha parlato
Harold Bloom). Già nel maggio del ’47 Brancati accenna a quell’anti-manzonismo
moraviano, rivendicando il grande respiro di libertà che emana dalle opere dei grandi
41
autori dell’Ottocento e mettendo insieme i due maggiori, che scolasticamente siamo
abituati ad opporre, Manzoni e Leopardi. I promessi sposi e i Canti appaiono a Brancati esempi supremi di quella grande libertà espressiva ed ideologica che sembra completamente assente dagli scrittori contemporanei. Ancora nel gennaio ‘53 Brancati
risponde su “Epoca”, rivista milanese, ad un articolo di Moravia pubblicato su “Corriere della Sera”, e ribatte punto per punto alle sue riserve su Manzoni, rivendicando
la forza comica dell’inventore di don Abbondio e dicendo addirittura che la commedia
di Goldoni è molto più debole di quella che si incarna in don Abbondio, grandissimo
personaggio, vero centro de I promessi sposi (Brancati aveva allora cominciato a scrivere Paolo il caldo, romanzo dove in cui sull’aspetto comico-satirico si sovrapponeva
una fortissima tensione drammatica). Moravia parlava di gusto sfatto della corruzione per la narrazione delle vicende di Geltrude; Brancati afferma decisamente che in
Manzoni non c’è niente di morboso o decadente e rifiuta l’etichetta di “realismo” che
Moravia usava per I promessi sposi. In implicita polemica contro il realismo socialista o il dominio del realismo di quegli anni, Brancati definisce Manzoni, piuttosto
che realista, metafisico, storico che scende nel corpo vivo di un secolo (ma in fondo
potremmo aggiungere che anche questo è realismo, ma un realismo più profondo ed
essenziale): “Manzoni è tutt’altro che un realista. È addirittura un metafisico, o meglio uno storico che, percependo lucidamente gl’ideali, i gusti, gli errori di un secolo,
mette il poeta nella condizione di commuoversi davanti alla eterna lotta fra il bene e
il male, e alle forme diverse che essa prende nelle varie epoche. Non chiamerei dunque il Manzoni né realista né storico e gli lascerei il puro nome di poeta” (Racconti,
teatro, scritti giornalistici, a cura di M. Dondero, Milano, Mondadori 2003, p.158).
Moravia sosteneva inoltre che Manzoni avrebbe una scarsa capacità di rappresentare
gli individui: abilissimo nel rappresentare le folle e le masse, non riuscirebbe a scendere dentro la psicologia degli individui. Brancati risponde che ad un grande poeta
come Manzoni basta spesso solo un aggettivo, una semplice battuta, per fissare l’immagine complessa o psicologicamente contraddittoria di un personaggio; e ne trae
occasione per polemizzare contro la prima moda della psicanalisi, di cui Moravia era
già un superficiale simpatizzante: “Scarsa capacità del Manzoni nel rappresentare gli
individui? Certamente Manzoni non si serve di termini psicanalitici, nemmeno nelle
forme che esi potevano avere prima di Freud. Ma con questo? Un poeta può caricare
un aggettivo sugli occhi di un personaggio di tale potenza rappresentativa da svelare
con esso solo una verità psicologica che un artista, fornito di esperienze moderne, ci
dà stentatamente con tre pagine irte di complessi, rimozioni ecc.” (cit., pp.1588-1589).
La forza individualizzante di Manzoni non è insomma legata a categorie precostituite,
ma si fissa nella rapidità del linguaggio letterario. E non dimentichiamo che questo
filo-manzoniano Brancati è stato un autore molto importante per Leonardo Sciascia.
Guardando alla letteratura siciliana del Novecento, Sciascia ha individuato due linee
opposte, una linea Vittorini e una linea Brancati, puntando decisamente sulla seconda.
Credo che oggi, pur riconoscendo il valore di Vittorini, siamo più disponibili a capire
la maggiore forza, la maggiore intensità della narrativa di Brancati.
Su Manzoni Sciascia ritorna molteplici volte: ne parla come un autore fondamentale nella famosa intervista del 1979 a Marcelle Padovani (La Sicilia come metafora).
Già ai suoi primi esordi letterari Manzoni si affaccia come presenza essenziale: già
in saggio del ‘50 su Emilio Cecchi, egli lega strettamente la prosa di Cecchi a quella
manzoniana; poi in un saggio apparso nel ’54 su “Letteratura”, Un cruciverba su
42
Carlo Eduardo, ripreso poi nel 1983 in Cruciverba (a proposito di quel Carlo Edoardo
Stuart che aveva tentato l’impresa scozzese a cui partecipa Waverley, il personaggio
del romanzo di Scott), si svolge una sorta di inchiesta che riconduce da quel personaggio a Vittorio Alfieri (amante e compagno della moglie dello Stuart, la Luisa Stolberg
duchessa d’Albany), a Pietro Giordani, a Walter Scott e, in posizione tutt’altro che
marginale, Alessandro Manzoni. Insomma, già negli anni ‘50 Sciascia ama ripercorrere la storia culturale come un puzzle, interrogando incontri, intrecci, separazioni di
personaggi reali e fittizi: nel suo percorso l’interessante scritto sulla vicenda dello
Stuart si trova a confrontare direttamente il Waverley con i personaggi manzoniani,
trovandolo molto inferiore rispetto ad essi, ma individuando gli stretti rapporti tra la
figura di Renzo e quella di Waverley (che qui sono stati motivati nella precedente relazione di Bigazzi), e chiamando in causa un fondamentale personaggio della letteratura
di quegli anni, l’italiano di fattura francese Fabrizio Del Dongo. E ricordo che in altre
occasioni mi è capitato di invitare i docenti a fare un confronto tra la celebre pagina
sul lago di Como, quell’incipit- non incipit de I promessi sposi e la descrizione del
lago di Como fatta da Stendhal ne La Certosa di Parma, dove si parla del castello della
famiglia di Fabrizio (e, anche se non ci sono diretti rapporti tra i due testi, è comunque
evidente che, nell’intraprendere la sua descrizione, Stendhal non poteva non tener
presente la pagina manzoniana).
In Cruciverba c’è anche un saggio di Sciascia su Goethe e Manzoni, dove a Manzoni si giunge attraverso un altro singolare intreccio e una verifica di differenze ed
equivoci (sappiamo che lo scrittore siciliano ama molto questi percorsi tortuosi, con
incontri imprevisti e coincidenze tra personaggi anche diversi e lontani). Vi si parla di
folgoranti pagine di Goethe con l’acutissimo giudizio su I promessi sposi, letti nella
prima redazione del 1827, e della parziale trascrizione che ne fece Pirandello in un
Taccuino, senza citare la fonte e ingannando così molti critici che hanno creduto che
il giudizio fosse dello stesso Pirandello. Tra le battute di Goethe citate qui da Sciascia
c’è ne una in cui si criticano certe digressioni storiche del romanzo, sostenendo che lì
“lo storico ha giocato un brutto tiro al poeta”: ma qui le vicende testuali giocano un
piccolo “tiro” allo stesso Sciascia, che giustifica Goethe in quanto lettore dell’edizione del ’27, domandandosi se avrebbe mantenuto la stessa riserva nel caso avesse letto
l’edizione del ’40, dove c’è una maggiore fusione tra storia e invenzione. In realtà
Sciascia confonde l’edizione del ‘27 con l’allora inedita redazione del Fermo e Lucia,
in cui il rapporto tra parti storiche e parti d’invenzione è in effetti diverso da quello de
I promessi sposi, mentre tra la redazione del ’27 e quella del ’40 non ci sono differenze
strutturali così essenziali, ma solo differenze linguistiche. La redazione del ’27 letta
da Goethe non coincide con il Fermo e Lucia, pubblicato solo nel 1905: Sciascia in
effetti confonde la “ventisettana” con il Fermo e Lucia e ripete l’errore anche in un libro successivo, La strega e il capitano, in cui si fa riferisce alle equivoche attribuzioni
a Pirandello delle pagine manzoniane di Goethe.
Ma a parte questo così sciasciano intreccio di equivoci, è interessante il consenso
che Sciascia dà a quanto dice Goethe a proposito del legame tra “angoscia” e “felicità”, del nesso che si dà tra questi due sentimenti nella lettura de I promessi sposi,
che “è un libro angoscioso e, in un certo senso, disperato; ma è anche un libro felice”
(Opere 1971-1983, a cura di C. Ambroise, Bompiani, Milano 2001, p.1061). Da qui
Sciascia risale al proprio rapporto personale con I promessi sposi, dicendo di essere
stato salvato dall’averlo letto, negli anni tra il ’30 e il ’40, prima di doverlo leggere
43
a scuola (siamo nel solco della consueta polemica sulla lettura scolastica di Manzoni); Sciascia, come aveva fatto Brancati, prende le distanze dall’anti-manzonismo
di Moravia e sottolinea il rilievo centrale del personaggio di don Abbondio. Se già
il siciliano Pirandello, nel celebre saggio su L’umorismo, aveva insistito sul rilievo
di don Abbondio, Sciascia lo vede come il vero protagonista del romanzo, autentica
incarnazione di “un sistema di servitù volontaria”, caratteristico della storia italiana:
I promessi sposi sono “un disperato ritratto delle cose d’Italia”, quindi ancor oggi di
grandissima attualità (fatte tutte le dovute differenze tra i nostri tempi e il Seicento del
romanzo). E se alla fine Renzo e Lucia, quando tutto è risolto, se ne vanno dal paese,
ciò è dovuto, secondo Sciascia, al fatto che “hanno già pagato abbastanza, in sofferenza, in paura, a don Abbondio, al suo sistema”. È lui il vero vincitore: “Il suo sistema
è uscito dalla vicenda collaudato, temprato come acciaio, efficientissimo” (op. cit.,
pp.1064-1065): è insomma una lettura del romanzo in chiave crudamente polemica
e moralistica, che si incontra con altre essenziali letture del Novecento (come quella
folgorante di Italo Calvino, che ha definito I promessi sposi “il romanzo dei rapporti
di forza”, lucidissima e spietata rappresentazione della violenza profonda dei rapporti
sociali, del suo esplodere sia sulla scena pubblica che nel più immediato scambio tra
gli individui).
Al finale de I promessi sposi Sciascia aveva accennato già in un saggio del ’59 su Il
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, raccolta nel volume del 1961 Pirandello e la Sicilia: un saggio che prende posizione nella polemica che seguì l’uscita de Il Gattopardo, che opponeva chi lo considerò un capolavoro a chi lo considerava opera attardata,
decadente, addirittura reazionaria. Nella prospettiva gramsciana, che Sciascia seguiva
in quegli anni, esprime una forte riserva sul romanzo, che più tardi avrebbe un po’
sfumato, ma mai definitivamente rinnegato: ne parla come di “un libro scritto da gran
signore” e lo confronta con I promessi sposi, libro scritto da un altro “gran signore”,
ricordando il presunto lieto fine del romanzo manzoniano, dove l’autore si mette nella
posizione stessa del marchese che invita a pranzo gli sposi Renzo e Lucia e si mette
un po’ lì accanto a loro solo per aiutare a servirli, evitando quindi di mettersi sul loro
stesso piano. Il “gran signore” Manzoni è ben attento alla divaricazione di classe: fa
come il marchese del romanzo e “si mette al di sotto degli umili” per servirli, mentre
Lampedusa si comporta sempre e soltanto come “un gran signore” che vede disfarsi
il suo mondo e guarda agli umili solo “di sfuggita” come “sgradevole manifestazione
della condizione umana” (in appendice a Opere 1984-1989, a cura di C. Ambroise,
2002, pp.1162-1163). A tal proposito va poi ricordato un dialogo molto interessante
su Il Gattopardo tra Sciascia e lo scrittore spagnolo Jorge Guillén, pubblicato sulla
rivista “Mondo Nuovo” il 5 febbraio 1961 (non compreso poi nelle edizioni delle
Opere di Sciascia): Guillén considera quello di Lampedusa un grandissimo romanzo,
mentre Sciascia conferma le sue riserve, confrontandolo proprio con I promessi sposi:
“sosteniamo la grandezza di Manzoni e abbiamo forti perplessità se non avversione
per il libro di Tomasi; gli stranieri danno un giudizio diverso”. Qui dobbiamo notare
che oggi sono venute quasi generalmente meno le riserve della critica su Il Gattopardo, quasi generalmente riconosciuto come uno dei maggiori capolavori del Novecento
italiano: si può pensare che tante riserve su di esso siano state determinate proprio dal
peso che da noi aveva il modello manzoniano; rispetto a quegli anni siamo diventati
più internazionali e sappiamo confrontarci di più col valore che gli “stranieri” eventualmente attribuiscono ai nostri scrittori (è cosa comunque su cui discutere e riflettere
44
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
45
GIANCARLO MAJORINO
Versi e righe di città
Sono nato a Milano e sono sempre vissuto a Milano. Contro la tendenza di dire che
Milano è diventato un luogo disastroso, tenterò di controbattere che è quantomeno
discutibile, nel senso che Milano è per fortuna una città che si addice molto agli artisti,
sembra un paradosso ma non lo è, aldilà di certe città troppo caratterizzate, anche per
virtù dei loro monumenti, anche in senso lato, come città d’arte, Milano è una città
come molte altre, però un dato significativo è che qui è molto difficile sbagliare sulla
valutazione delle cose, la realtà si presenta nuda e cruda e se l’artista, come io credo,
debba imparare dalla propria città, Milano si presenta per quello che è, non imbroglia:
questo per un artista è molto importante.
Mi sono sempre servito a fondo di due tipi di fonti, delle fonti scritte, culturali,
ma anche delle fonti viventi, sono un appassionato di persone, una specie di vampiro
buono, a me le persone interessano enormemente, è logico che una grande città sia
l’ideale anche da questo punto di vista.
Se dovessi cercare illustri precedenti direi che non a caso Baudelaire è il primo che
ha caratterizzato a fondo la città come luogo di poesia, di potenzialità poetica, sempre
che questo luogo sia davvero scrutabile per la ricchezza delle sue possibilità, delle
potenzialità che nutre in sé. Se pensiamo per esempio a quello che io considero il vero
erede di Baudelaire, il primo Eliot, ecco di nuovo che la città torna ad avere questa
mescolanza cosi fruttuosa di mistero e frequentazione, di simili dissimili, questo incrocio è proprio della città.
Eliot parlando di Baudelaire, in un saggio, lo cita come uomo onesto, è un termine
oggi un poco logorato, ma cosa intendeva Eliot dicendo di Baudelaire che era un
uomo onesto? Ci fornisce una seconda caratterizzazione importante per caratterizzare
il grande poeta che sarà l’ideatore della poesia moderna; è riuscito a spostare il modo
di fare della poesia dai precedenti in modo molto risoluto (non dimentichiamo che
anche Saba, interrogato nel 1911 su quanto debbano fare i poeti, dice “devono fare
della poesia onesta”).Teniamo congiunti questi due elementi: la grande proliferazione
in atto nella città di risorse anche per gli artisti e l’onestà, un senso di adeguatezza
profonda al proprio tempo. Ho cercato di fare mio tutto questo.
Il mio primo testo pubblicato si intitola La capitale del nord, uscito nel 1959.
È un breve poema. Ho cominciato con un poema perché sognavo e forse conti48
nuo a sognare che la restituzione di un luogo così molteplice come la città sia più
profondamente corretto se avviene attraverso un poema, segmenti che compongono
inevitabilmente la realtà riescono a operare una connessione tra loro. La capitale del
nord comincia con un incidente divertente: l’unica recensione che ha avuto è stato un
attacco furibondo sul Borghese , “era un cosa pazzesca e bestiale”, “troverà qualcuno
più stupido di lui che lo prende sul serio”. Sono andato da Vittorini, che mi pubblicava
sul Menabò, e naturalmente ne abbiamo riso…
Vi leggo l’inizio:
O mia città vedo le porte gli archi
che un tempo limitavano il tuo cauto
intrecciarsi di case strade parchi
oggi spezzarti come una frontiera
o come una catena di pontili
congiungere le tue zone più vili
ai box del centro dove grandi banche
rivali o consociate in busta chiusa
dan vita o morte in crediti d’usura
legate col cordone ombelicale
del capitale e in loro trasformate
e quelle in queste ritmica simbiosi
le sedi razionali dell’industria
con l’asino alla mola e i nuovi impianti
la rapida salita - la discesa
più rapida - la sedia dei trent’anni
intorno curve schiene di negozi
la Galleria col tronco fatto a croce
in fondo oltre la Scala la gran piazza
Cavour congestionata la questura
la pietra dell’ Angelicum trapassi
violenti e luminosi in via Manzoni
il tufo è ancora base ai grattacieli?
contro il centro e soltanto qualche raro
sabato sera in blu nei suoi ritrovi
s’addensa l’altra razza la sicura
nemica della pace dei signori
e topi sul formaggio ogni mattina
dalla Nord da Varese dalle strade
fitte di bici e scooter le tribù
compagne di lavoro o traversanti
le piazze con stendardi per San Siro
o incolonnate per dimostrazioni
«da quanto tempo il tavolo rotondo
della terra è quadrato?»
«per quanto tempo ancora notte e giorno
saranno scarpe al piede dei padroni?»
49
nel mezzo come un uomo tra due fuochi
uno che brucia l’altro che risplende
il ceto medio spirito e materia
all’ombra dei potenti per la pace
per lunga convenienza e religione
contro di loro nella propria essenza
costretto a verità di sottomesso
se fedele dev’essere il poeta
al tempo scriveremo di partenze
frenate di ricorsi in cassazione
di lenze che catturano usignoli
gettati in acque ritornati pesci
con versi che la biro dell’ufficio
(la marca della ditta l’attraversa)
la vespa delle ferie la ragazza
di tutti e rabbia/amore detteranno.
Non vorrei dare l’idea che tutto il poemetto si legga mettendo in evidenza fattori
di tipo sociale, ve ne sono anche altri; la seconda poesia che ho scritto, si trova in una
raccolta, Le trascurate, pubblicata tardi, con poesie che non avevo collocato, e porta
all’inizio degli anni’50.
La leggo anche per far capire questo rapporto tra me e la città.
I campi rossi al termine del viaggio
breve con l’auto, cinti da leggere
reti tra case e acqua, il Villoresi
con un barcone al centro, piatto, carico.
Inghiotto un sorso d’acqua d’aranciata tiepida.
Un uomo cantando traversa in sandali l’erba col figlio
una signora gioca distrattamente sopra
gli spogliatoi si ride sotto la doccia mentre
l’uomo seduto canta inizio il gioco:
braccio teso vola la palla.
Cauto, ma già preso
dalla voglia di vincere, ragazzo mi rivedo chino a cogliere
e ribattere i colpi, non guidato
che da impulsi dell’attimo affrontare
il biancovestito, fantasma familiare.
La vanità sparisce?
La vanità s’interra:
dal volto retrocede serrando alle cervella.
E gioco, gioco: nell’arena il premio
corona chi è più forte senza inganni.
50
La palla vola, se riuscissi a battere
quell’uomo, s’avvicendano nel cielo
l’esile luna, le celesti stelle..
Con gli anni ‘60 muta il clima, muta molto il clima, ho fatto un testo critico e antologico intitolato Poesie e realtà dove si parla di questi continui passaggi, di questo
continua e cambia di Milano; il capitolo che si riferisce agli anni sessanta si intitola
“il sogno critico e l’arrivo delle cose”: sogno critico perché molti di noi sognavano
che la criticità potesse funzionare da alimento vero e, insieme, l’arrivo dei prodotti,
delle cose (gli anni sessanta sono stati gli anni del boom economico).
Le poesie che seguono, si riferiscono agli anni sessanta ,sono tre piuttosto diverse: la
prima, tratta da Lotte secondarie è degli inizi dell’anno ‘60, le altre due, tratte da Equilibri a pezzi, hanno a che fare con il ‘68, che a Milano è stato molto forte e vitale
Achtung
O luminosa città,
un doppio petto di gonfi negozi centrali
arrossa guance di donne, bambini con pacchi,
ebbri di ciò che verrà.
Regali, regali, la gente regala e dimentica;
anch’io, città, che cammino e s’è aperta una fossa,
ti regalo qualcosa:
una poesia nuova (m’aiuta l’auto nera di Krupp tornata in cortile),
Tozze case scientificamente disposte
quasi filari alveari (non paragoni)
zeppe di scheletri umani prima di notte saranno
sotto le docce nel gas a scavare le fosse terra che poi coprirà
le membra umane aghi pinze fruste caverne paludi tane letame
uomini donne tornati sugli alberi o rane carogne con calzoni giubbe sottane
strappano denti unghie dita mani con denti unghie dita mani vincenti
otto quintali di capelli urgono alla fabbrica Rosch?
questa bambola che acquisti hai guardato i suoi capelli?
l’orsacchiotto ha gli occhi tristi? sono gli occhi di un ebreo
che suo figlio giudica (esagerato) colpevole Eichmann.
Poesie che si tradiscono galleggiano
come scatolette, feci, preservativi usati, saliva, macchie sull’acqua,
Krupp è tornato: festeggiato da amici e diplomatici
beve lo champagne che per fine anno abbiamo prenotato
anche noi;
anche tu che leggi , e c’è poco da leggere qui,
le donne violentate, ovvio, in quel momento
sono beate: nessuno le strazia in quel momento.
Ilse netta le zampe nel grembiule della bimba che càpita
«torturerò anche te quando sarai più grande»;
51
penzolano ai ganci quarti d’uomo,
orbita presso l’orbita, come i quarti di bue
che cuochi apprestano per cena a noi che passeggiamo
tra i negozi centrali, brava Milano.
Questa poesia si riferisce al grande industriale tedesco compromesso a fondo con i
nazisti. Le altre due, molto brevi, hanno a che fare con il ‘68.
Sit-in
Ma c’era qualcuno, in quella folla di giovani
vibratili e prefiguranti la nuova brughiera,
così usciti dall’ossessione dell’eros, belle e belli,
uniti nel volere e nel recitare la Rivoluzione, c’era,
è triste scriverlo, c’era qualcuno, io,
che sbirciava coscie seni labbra, pare incredibile.
Questa poesia prende spunto da Ovidio, dove raccomanda di abbordare le ragazze
durante i cortei imperiali, sono emozionate ed è il momento giusto. Quella dopo, di
due soli versi, avanza una tesi su qualcosa che attirava nel ‘68 anche le persone non
giovanissime, intitolata Ora
chi ha sempre vissuto un po’ troppo poco
trema - è certo
C’era un balenare di felicità che non si era mai visto, c’era un agire insieme
che colpiva, colpiva enormemente
Gli anni sessanta passano, negli anni settanta io modifico in parte il mio “modostile”, non è solo un problema di ricerca formale, è un problema del mio atteggiamento
verso la ricerca formale e la realtà di riferimento, entra una frenesia che prima non
c’era e allora anche la mia poesia risente della frenesia, di accumulo di ritmi diversi,
cerco in qualche modo di essere pari con il tempo.
Leggo da Le Frenetiche, da questo libro che si chiamerà Provvisorio, una poesia
avanti avanti avanti
proseguono, implacabili, coatti,
rasaerba
mentecatti che siamo, circondati
da flussi di petrolio, urlandoci ti amo
o isole di mota
l’anarchia del globo, gomitoli disfatti,
luride animelle
52
ripeti gesti liberi tamburo
ripeti gesti liberi ripeti gesti liberi ripeti
luride animelle sbatacchianti
tamtamburo motoso tamtamburo
ma tu/ Bianca, lo sai/ che non ci/vedremo più?/che finiremo remo
io lì tu là/ tre metri sotto / tu bocca nera spa/ lancata come
bambola nera/ rotta per sempre
na bambola / come nera / rotta per sempre
na bambola / come nera / rotta per sempre
ripeti gesti liberi tamburo
ripeti gesti liberi ripeti gesti liberi ripeti
tu con la bocca nera spalancata
io io coi denti e basta
lo sai Bianca?
tu che sei l’amica dell’Enrica
e ieri parlavamo allegri mangiucchiando la tavola fiorita
sotto la lampada lustra di plurima luce
tavola fiorita rima luce
Negli anni successivi continua questo mio andamento da vampiro buono, certe volte prendo il metrò con le prime corse per vedere cosa succede, queste facce truccate o
rabbiose che vanno verso il lavoro, questo teatro permanente che sono i mezzi pubblici, i negozi, le strade, questa molteplicità mai interrogata. Qui comincia un discorso
che mi è caro, che prevede che siamo come dei singoli di molti, non siamo individui
fissi né delle particelle di una massa, siamo dei singoli di molti che via via si formano
attraverso gli altri, questo accade fin dall’inizio: la mamma, il papà, gli amici, poi
continua questo formarci attraverso altri.
Di un nuovo libro, La solitudine e gli altri, leggerei alcuni testi centralizzanti una
sorta di interrogazione dell’altro.
è picchiettando sul nulla,
che rimane così suolo bagnato,
che la lettura, lo studio, magari veloci,
creano la gabbia di un tempo
acutamente solitario
semicoincidente con lo spazio orario
tollerabile camera
*
E’ impossibile capirti?
giro intorno ai suoni
della tua voce, scruto
i lineamenti a specchio
53
la luce sulla tavola
imbianca il circospetto
rilevo accostamenti
rifletto: tu sei tu.
E «noi» cosa sta a fare?
è infisso anche di più?
una brina leggera il ragionare
*
Ma, chi sei tu? persona somigliante,
estranea insieme , chiedo un po’ pedante
mentre furiosi conversiamo in tanti .
Fisso lo sconosciuto rovistando
architetture e macerie, balzi e stralci
di un comparabile volti sgrumato.
I suoi occhi mi tengono lontano
preferirebbe ci legassimo a un gioco:
ci sto e continuo a misurare quel poco
che nega e torna, dentro e fuori, già,
la superficie e la profondità.
Metropolitane
e viali colle ali.
*
come l’acqua viene
ghiaccio d’un tratto
ho la rivelazione della connessione:
atomi dei corpi separati
dagli atomi slacciati dello spazio
nell’ombra lavorata delle imposte
infantile, un bicchiere di latte
*
l’albero e la sua virtù
per me misteriose
compiono nel viale
movimenti di foglie
pezzi di pelle celeste
stanno tra i rami
54
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
55
ROMANO LUPERINI
Lettere di Verga da Milano
e la genesi dei Malavoglia
Il tema che considero è legato alla storia di un siciliano, Giovanni Verga, che ha
passato buona parte della propria vita a Milano ed a Milano ha conosciuto la sua grande stagione letteraria. Questo però potrebbe sembrare un clemente estrinseco di natura
sociologica. La questione che qui vorrei affrontare è il legame fra questo aspetto
estrinseco e un aspetto invece profondamente intrinseco, cioè interno alla ricerca verghiana: infatti Milano ad un certo momento diventa per Verga emblema della modernità. Prima Verga era stato a Firenze, che era capitale d’Italia, poi si reca a Milano in
cui andò a risiedere quasi ininterrottamente a partire dal 1873. La questione di Milano
come emblema della modernità vorrei poi collegarla ad un vecchio problema critico
che potrei anche esporre così come lo esponeva Benedetto Croce, che nel saggio su
Giovanni Verga di cento anni fa faceva una obbiezione ovvia, anche se assolutamente
coerente con le sue teorie, osservando che la teoria della impersonalità non aveva
nessun fondamento dato che ogni scrittore è personale. Un giovane, Michaelstaedter,
ebbe a scrivere malignamente, ma giustamente, che la grande capacità di Croce era
quella di abolire dal problema ciò che costituiva il problema. Mi pare che ciò valga
anche in questa occasione. Verga riesce ad essere personale attraverso l’impersonalità,
ma questo appunto è il problema, l’interessante è come possa essere personale essendo in realtà impersonale.
È questo il percorso che vorrei seguire, in cui il tema di Milano e della modernità ha
un forte valore impattante. Per affrontare questo problema, dobbiamo fare riferimento
a due traumi che Verga subisce: uno è un trauma individuale, personale, camuffato o
nascosto dietro la maschera dell’impersonalità: è un trauma legato al senso di colpa
e alla figura della madre. L’altro trauma è invece storico-collettivo, il trauma di una
generazione che però, quando Verga diventa impersonale, cioè quando Verga aderisce
al verismo, viene raccontato in una forma oggettiva, che di tale trauma finisce per
essere l’equivalente allegorico. Questo trauma storico collettivo a cui Verga dà forma
oggettiva è il trauma collegato all’emergere della modernità.
Tra questi due traumi, uno individuale e l’altro collettivo perché proprio di una generazione di artisti, c’è un nesso, e questo nesso è messo in risalto soprattutto dalle lettere, quelle spedite da Firenze, e soprattutto quelle da Milano, inviate sia ai familiari
sia all’amico Capuana. Quindi io dovrò leggere alcune di queste lettere per dare conto
59
appunto di questo doppio trauma.
Le prime risalgono in realtà al viaggio a Firenze e raccontano di quanto sia stato
lacerante e vissuto come un peccato, e dico peccato in termini quasi religiosi, il distacco dalla famiglia, dalla madre e dalla Sicilia. La partenza dalla Sicilia è avvertita
cioè come una violazione di ordine etico. Queste lettere, che non leggo per intero per
ragioni di tempo, sono trascorse da un vero e proprio terrore che la madre non approvi
la partenza del figlio, sin dalla prima lettera da Firenze che è del maggio del 1869:
vorrei sapere con tutta verità come state tutti, se la mamma è allegra o se
sta sovrappensieri, il solo pensiero che mi abbia è che ella sia triste, vi ripeto
che ad un minimo suo cenno me ne verrò via subito.
Quindi stia tranquilla nel pensiero che sto bene, se vorrà non avrà
altro che a chiamarmi anche per telegrafo….Io mi accorgo con dispiacere
che costo qualche sacrificio anche pecuniario alla famiglia, ma cercherò di
ricompensarlo tracciandomi una carriera, se Dio vuole
e dopo scrive al fratello (cito tagliando e riassumendo con parole mie ): “è vero
sono partito molto triste perché ripenso ogni momento a mamà così angustiata per la
mia partenza. L’unica consolazione che ho è che potrò fare carriera, guadagnare soldi
e così farmi perdonare”. Poi continua:
Firenze è davvero il centro della vita politica ed intellettuale d’Italia, qui
si vive in un’altra atmosfera di cui non potrebbe farsi alcuna idea chi non
l’avesse provato, e per diventare qualche cosa bisogna vivere a contatto di
quelle illustrazioni (cioè gli uomini importanti che ha conosciuto), vivere in
mezzo a questo movimento incessante, farsi conoscere, respirarne l’aria.
Anche quando poi Verga si sposta a Milano, questo motivo del perdono e della
paura di essere considerato dalla famiglia un parassita, e soprattutto che la mamma
non lo approvi, ritorna continuamente. Nel 1874, l’anno di Nedda, Giovanni scrive
alla madre parole che già anticipano quelle che ‘Ntoni dirà alla Longa quando dovrà
giustificare la propria partenza da Trezza per andare a cercare fortuna. Infatti Giovanni scrive alla madre:
Cara mamma ti prometto che a costo di qualunque cosa io mi farò perdonare tutto e principalmente il dispiacere che provi dalla mia lontananza con il
successo del mio lavoro, e tornerò tra voi spero con molto denaro, almeno in
modo da farvi contenti di me.
Tra l’altro l’arrivo a Milano, una città dove l’industria culturale era ormai avanzata,
porta a modificare anche l’idea di gloria e di successo che aveva Verga, inducendolo a
quantificare in termini economici l’affermazione letteraria. Le lettere ai familiari sono
costellate da calcoli di quanto potrà guadagnare. I sogni di gloria insomma vengono
quantificati. In una lettera dice che “farsi conoscere” equivale ad “imporsi anche come
valore commerciale”. E questa è certamente una lezione appresa soprattutto a Milano.
Tra l’altro questo è un motivo che Zola tratta in quegli anni nel suo Roman expérimental là dove afferma che la condizione moderna dello scrittore consiste nell’affidarsi al
60
mercato e non più alla benevolenza capricciosa di qualche signore. Come è evidente,
il tema del successo economico è già un tema profondamente moderno.
Dal punto di vista psicologico è abbastanza eccezionale e per certi versi decisiva
una lettera che Verga scrive da Firenze, questa volta poco prima di partire, quando
chiede alla famiglia con vera e propria angoscia di poter restare un mese di più. Lui
era stato a Firenze sei mesi, ed ecco che arriva agosto, in cui aveva promesso alla
mamma di tornare. Ha già quasi trent’anni, eppure chiede di restare un mese in più
con affanno, con rigiri di parole, con insistenze, dichiarazioni di affetto per la famiglia, richieste incessanti di perdono. È una lettera assai lunga tutta su questo tema, io
mi limito a leggerne alcuni righi:
Se potessi fare ancora questo piccolo sacrificio di denaro e di privazione
di me per un altro mese io ti confesso che desidererei rimanere l’agosto e di
ritornarmene i primi di settembre, non per alcuna altra considerazione che tu
puoi immaginare, te lo giuro, ma soltanto per quella di raccogliere il frutto
dei sacrifici fatti. Ma se tu desideri che men venga per i primi di agosto non
hai che scrivermelo ed io ti prometto che verrò subito. Mia cara mamà, vi
prego di dirmi con tutta libertà e sincerità e francamente se vuoi che ritorni
presto o resti qui ancora tutto agosto, ti prego di dirmi schiettamente il tuo
minimo desiderio che sarà una legge per me, e ti obbedirò completamente e
subito. Insomma se dovrò restare voglio essere sicuro che non sia a tuo malincuore ma con il tuo pieno gradimento.
P.S. Se dovrò ancora rimanere ancora l’agosto qui ne voglio avere il permesso formale per iscritto da mano di mamà, e voglio essere assicurato che me lo
permette senza soverchio dispiacere e di tutto cuore per mia tranquillità
Nelle lettere da Milano non sfugge a Verga che questa sua ossessione non è dovuta
a motivi oggettivi, a pressioni o ricatti della famiglia. In una lettera al fratello del
1874 avverte che i suoi “sfoghi” non nascono da dubbi circa il sostegno famigliare,
bensì, spiega con parole che poi egli stesso sottolinea ,”per giustificarmi agli occhi
miei medesimi”.
Ora io credo che qui siamo alle radici dell’alternativa di tipo etico e tragico, che
caratterizza tutti i grandi protagonisti dell’arte verghiana. Pensate a Rosso Malpelo
intrappolato nella dialettica ragazzo buono-ragazzo cattivo, e pensate che la prima che
lo considera ragazzo cattivo è proprio la madre. Oppure pensate alla dialettica interna
che divide ‘Ntoni Malavoglia e Mastro don Gesualdo.
In ‘Ntoni e Mastro Don Gesualdo compare ad arricchire questa dialettica, che altrimenti sarebbe solo psicologica, un altro motivo: il motivo della contraddizione tra
mondo arcaico-rurale e mondo moderno, tra radici siciliane e mondo moderno della metropoli e della grande città. Le lettere scritte da Milano e soprattutto le lettere
scritte a Capuana confermano un impatto con la città di Milano e con la modernità
di grande intensità. Vi sono tre lettere milanesi a Capuana, in cui la modernità viene
presentata come seduzione. Il termine “seduzione” in una lettera ricorre tre volte. E’
una seduzione che produce effetti contraddittori, affascina, può distogliere dalla dura
disciplina del lavoro, ma può anche eccitare al lavoro suscitando nuovi stimoli alla
fantasia dello scrittore. Ecco la prima di queste tre lettere su Milano: “Si, Milano è
proprio bella amico mio, e credimi che qualche volta c’è proprio bisogno di una tena61
ce volontà per resistere alle sue seduzioni e restare al lavoro”. Ecco quindi il motivo
masochistico della resistenza alle tentazioni, dell’ubbidienza alla legge dietro la quale
c’è la figura della madre. Poi continua: “Ma queste seduzioni stesse sono fomite, eccitamento continuo al lavoro, sono l’aria respirabile perché viva la mente, ed il cuore
lungi dal farci torto non serve spesso che a rinvigorirla. Provasi davvero la febbre di
fare in mezzo a codesta folla briosa, seducente e bella che ti si aggira attorno, provi
il bisogno di isolarti assai meglio di come se tu passi in una solitaria campagna, e la
solitudine ti è popolata di tutte le larve affascinanti”(ricordiamoci queste “larve affascinanti” perché le troveremo tra un po’ in Eva) “che ti hanno sorriso per le vie e che
sono diventate patrimonio della tua mente.”
Quindi il giovane romanziere avverte nella modernità una seduzione, un rischio di
natura etica che può portarlo via da se stesso. Questo è un tema assai rilevante che
torna, in Mastro-don Gesualdo, nel famoso dialogo con Diodata, alla fine del quarto
capitolo, dopo che in vari incontri con personaggi anonimi Gesualdo era stato identificato con colui che aveva venduto l’anima al diavolo ed era stato identificato egli
stesso con il diavolo da Pertuso, il sensale. A Diodata che gli dice “vossignoria siete
il padrone” (e quindi, s’intende, la responsabilità di decidere se sposare Bianca o no
è tutta e sola di Gesualdo) Gesualdo risponde che da quando è diventato padrone
non è più padrone della sua vita. E’ come se fosse posseduto da un demone, Gesualdo
è diventato ostaggio della roba. Dunque la roba, o se si vuole la logica egoistica e
naturale dell’uomo che il moderno ha esaltato, porta via l’uomo da se stesso, è un
demone divoratore, come il cancro che rode le viscere del protagonista e lo porta alla
morte. Questa idea di essere come portato via da se stesso, di essere scisso dalle radici,
e travolto dalla logica della modernità, questo terrore di essere strappato dai valori
autentici della Sicilia è tema etico costante in Verga, e documentato dall’epistolario.
Nel medesimo tempo però è fortissima la coscienza che per diventare scrittore bisogna vivere a Milano. Verga scrive a Capuana dicendogli che deve venire a Milano
perché solo a Milano si può diventare grandi scrittori, solo dentro la modernità si
può conoscere la modernità. Insomma la corruzione del moderno è un rischio che va
corso, e comporta il tradimento, una violazione, ma si tratta di conseguenze dolorosamente necessarie, inevitabili. Di qui la storia di Eva, romanzo composto a Firenze ma
finito a Milano, la storia di un pittore siciliano che arriva nella grande città. A Firenze
conosce Eva e le cede la marina di Trezza, l’autenticità di Trezza. Il dono che Enrico
Lanti fa alla ballerina è simbolico: una marina di Aci Trezza per avere accesso alla
modernità, l’anima in cambio del successo nella modernità. E infatti Enrico Lanti si
afferma come pittore diventando falso, cedente alle esigenze inautentiche del pubblico: “più ero falso più il pubblico mi batteva le mani” si legge in Eva.
Nella seconda lettera a Capuana si legge (in alcuni tratti riassumo con parole mie):
Tu hai bisogno di vivere la grande aria come me. E per noi altri infermieri
di mente e di nervi la grande aria è la vita di una grande città, le continue
emozioni, il movimento, le lotte con se e con gli altri. Tutto quello che senti
ribollire dentro di te, se vieni a Milano, irromperà con improvviso vigore, qua
ti troverai in mezzo ai combattenti di tutte le passioni e di tutti i partiti, costà
tu ti atrofizzi
(e qui c’è già la prefazione ai Malavoglia, l’idea di una lotta, dei nella lotta
62
all’interno della fiumana del progresso).
Quel Milano che tu ti sei immaginato sarà sempre inferiore alla realtà, non
perché tu non abbia immaginazione tanto fervida da fantasticare una babilonia più babilonia della vera”,
(e si noti che “babilonia” è immagine di corruzione, seduzione e traviamento), “ma perché ho provato su di me che non arriveremo mai ad accostarci
alla realtà di certe piccole cose che ci fanno piccini a loro volta e che ci danno
forza da giganti. Io mi immagino te venuto improvvisamente dalla quiete
tranquilla della nostra Sicilia, te artista matto poeta impressionabile e nervoso come me, a sentirti penetrare da tutta questa febbre violenta di vita in tutte
le sue più ardenti manifestazioni, l’amore, l’arte, la soddisfazione del cuore,
le misteriose ebbrezza del lavoro, pioverti da tutte le parti, dalla attività degli
altri, dalla pubblicità qualche volta clamorosa, dagli occhi delle belle donne,
dai facili amori ….. Senti, caro mio, a momenti facevo una tirata da farti ridere, vieni, vieni e prova anche te, non ti pentirai ti prometto.
In uno scritto del 1881 su I dintorni di Milano Verga ha scritto che “Milano è la città
più città di Italia”. Insomma vivere a Milano significava vivere l’esperienza moderna
della grande metropoli. Mentre sta scrivendo I Malavoglia in una altra lettera a Capuana osserva che questo romanzo lo deve scrivere proprio a Milano. Dice:
Avevo pensato di venire in Sicilia per dare l’ultima mano, e avrei voluto, se la
disgrazia (la morte della madre) non mi avesse perseguitato, darvi quell’impronta di fresco e sereno raccoglimento, che avrebbe dovuto fare un immenso
contrasto con le passioni turbinose ed incessanti delle grandi città, con quei
bisogni fittizi, con quell’altra prospettiva delle idee e direi anche dei sentimenti. Perciò avrei desiderato andarmi a rintanare in campagna sulla riva del
mare tra quei pescatori e coglierli vivi come Dio li ha fatti. Ma forse [aggiunge per spiegare perché è rimasto a Milano] non sarà male d’altro canto che
io li consideri da una certa distanza, in mezzo alla attività di una città come
Milano o Firenze. Non ti pare che per noi l’aspetto di certe cose non ha risalto
che visto sotto un dato angolo visuale? e che mai riusciremo ad essere tanto
schiettamente ed efficacemente veri che allorquando facciamo un lavoro di
ricostruzione intellettuale, e sostituiamo la nostra mente ai nostri occhi?
Insomma I Malavoglia non sono una “copia dal vero”, ma la “ricostruzione intellettuale” di un paese siciliano, ricostruito basandosi sui documenti, sulle informazioni
etnologiche, sull’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. Una rielaborazione intellettuale e nel medesimo tempo nostalgica perché vi si avverte l’ottica da lontano,
il peso del distacco dalla Sicilia, e, comunque, tuttavia, ricostruzione squisitamente
intellettuale.
C’è qui un problema su cui la critica non ha cessato di interrogarsi: come mai qui
si parla di “sereno e fresco raccoglimento”? E a conferma si potrebbe leggere Fantasticheria, la novella scritta nel ‘79 quasi come introduzione ai Malavoglia. Qui si
parla di “pace serena di quei sentimenti miti semplici che si succedono inalterati di
generazione in generazione”. Dove sta il problema? In sede ideologica o filosofica
63
Verga dichiara innumerevoli volte che ad ogni gradino della scala sociale c’è la lotta
per la vita e una feroce selezione naturale. D’altronde anche chi legge il romanzo si
accorge subito che il mondo di Aci Trezza è tutt’altro che un mondo di sereno e fresco
raccoglimento; anzi, è un mondo feroce, in cui se i Malavoglia si tengono in casa padron ‘Ntoni ammalato e quindi improduttivo è perché sono superbi e vogliono farselo
mangiare dalle pulci. Se questa è la logica maligna di Trezza, dove sta il fresco e sereno raccoglimento? Come si spiega la contraddizione tra una filosofia materialistica
che vede la lotta per la vita anche ai livelli più bassi e l’idea che invece esista una oasi
felice, una Sicilia mitica?
In realtà la ragione di questa contraddizione è di tipo più psicologico che ideologico. Nelle lettere che ho letto la famiglia appare sempre come un luogo tranquillo e
sereno, gli aggettivi sono gli stessi che ora vengono attribuiti ad Aci Trezza, e cioè a
un mondo del passato che viene mitizzato E’ il ricordo, la nostalgia, il senso di colpa
che abbelliscono quello che in realtà l’intelligenza conosce come un mondo invece
scisso e crudele.
Torniamo un attimo al trauma psicologico. A proposito di Una peccatrice Debenedetti aveva osservato che il vero titolo avrebbe dovuto essere “Un peccatore” nel
senso che è il protagonista, lo scrittore, che si travia e tradisce gli ideali, compreso
quello dell’amore romantico. Anzi in questo romanzo giovanile la figura della madre
è l’unico ostacolo al traviamento, è lei che cerca invano di fermare la corruzione del
figlio, che poi è un personaggio chiaramente autobiografico. Pietro Brusio finirà per
sprofondare in una vita indegna ed abbietta, nelle orge più impure, per questo evita lo
sguardo della madre e questa a un certo momento ricorre ai carabinieri. Troviamo una
scena da un punto di vista psicoanalitico molto interessante: la mamma e i carabinieri
che cercano di fermare ed arrestare il protagonista e dunque stanno dalla stessa parte
come figure dell’ordine e del divieto. Troviamo qui Pietro Brusio che come ‘Ntoni va
nella bettola, beve, si ubriaca, diventa il capo di una banda di malfattori. Ma anche
quando egli ritorna nel suo ambiente e comincia a frequentare le classi più alte, anche
allora si rivelerà indegno, indegno dell’amore di Narcisa, la donna che muore per lui
mentre lui invece si stanca, non riesce a stare all’altezza dei propri valori romantici.
Quindi Pietro Brusio si mostrerà indegno non solo della madre ma anche di Narcisa.
E questo è un tema che tornerà anche in Mastro-don Gesualdo dove le figure femminile pongono l’eroe di fronte alle proprie contraddizioni etiche, quest’eroe che vince
sempre è sconfitto nella propria anima e le donne stanno lì a ricordargli la propria
sconfitta: fino in fondo, Diodata, Bianca, Isabella ritornano negli incubi di Gesualdo
ammalato.
Eva è un documento interessante di questa contrapposizione tra al tranquillità della
Sicilia e le “larve affascinanti” della vita moderna e del necessario traviamento dello
scrittore che si mescola con la modernità. Mi limito a leggere un brano: “pensavo alla
mia famiglia lontana ed a tutte le tranquille gioie che avevo abbandonato per correre
dietro a larve affascinanti.”
“Larve affascinanti”: abbiamo trovato questa espressione nella lettera a Capuana
ed ora la troviamo qui nelle pagine di Eva. C’è inoltre un passo particolarmente interessante dove Enrico dice all’amico che lo esorta a tornare in Sicilia quello che poi
dirà ‘Ntoni: non posso tornare in Sicilia dalla famiglia perché la Sicilia e la famiglia
sono “per le anime pure”. I valori della famiglia sono per le anime pure e lui ha tradito
questi valori.
64
mio caro, i sentimenti puri non sono che per le anime pure. Che cosa porterei in mezzo alla mia famiglia che ha sacrificato tutto al mio egoismo? I miei
infami sogni, i miei sozzi desideri, i miei disinganni colpevoli?
Qui bisogna riflettere sul “disinganno”. Il disinganno è la presa d’atto di un inganno. Ma allora perché liberarsi di un inganno è colpevole? L’inganno è costituito dai
valori romantici. Enrico si è dimenticato a contatto con la modernità dei valori romantici ed ora pensa che i valori romantici siano ingannevoli, anacronistici e superati.
Non è paradossale che l’essersi liberato da un inganno sia vissuto come una colpa?
Si può cogliere qui il percorso di una generazione, passata dall’entusiasmo risorgimentale di Verga che tra i venti e i ventitre anni aveva diretto tre giornali politici e che
ora sta diventando scettico, materialista e pessimista, ma vive questa sua conversione
al moderno come una colpa. Di qui l’interesse di questa espressione, “disinganni colpevoli”.
Notate che c’è un intreccio, un interscambio continuo tra autobiografia e invenzione romanzesca. Non manca nelle lettere da Milano la fantasia del ritorno: nell’immaginario di queste lettere campeggia al scena del ritorno in famiglia, la scena che troveremo alla fine dei Malavoglia. E’ una scena in cui si sovrappongono e si potenziano
a vicenda desiderio di accoglimento, di protezione e tranquillità domestica e aspirazione finalmente soddisfatte alla tacitazione del senso di colpa. Giovanni immagina di
tornare ricco, di essere accolto e reintegrato felicemente in famiglia. E’ una lettera da
Milano del marzo del 1874 in cui vi sono delle sottolineature fatte dall’autore stesso.
Sottolineando certe parole che sta scrivendo, Verga contrassegna proprio i passi psicologicamente più rilevanti. Ve la leggo:
Sapete che in fondo la famiglia è il primo pensiero e l’affetto più intimo. I
piaceri di tutti i generi non possono farmi dimenticare le ore tranquille e qualche volte anche stizzose ma sempre più care che passo in mezzo a voi. Una
delle feste più grandi del mio pensiero è l’immaginarmi il ritorno accompagnato dalla buona riuscita di tutto quello che mi sono proposto di fare.
“Immaginarmi il ritorno” è una espressione che spalanca un orizzonte di fantasie
in cui i termini contrastanti del conflitto interiore, l’obbedienza alle leggi della madre
e il rispetto per le tradizioni da un lato e l’esigenza di successo nella modernità dall’altro siano finalmente conciliati. Ricordate l’undicesimo capitolo dei Malavoglia:
‘Ntoni promette alla madre che sarebbe tornato presto e carico di denari e sarebbero
stati allegri tutti. Ma anche la fine del romanzo, con quell’”addio perdonatemi tutti”,
va collegata a questo passo della lettera ai familiari. Insomma, in questo scrittore
che è sempre sembrato così impenetrabile, in realtà si possono trovare dei varchi per
entrare dentro i suoi conflitti interiori. Nei Malavoglia va colto un autobiografismo
“travestito” che si distende in figure oggettive ed in sentimenti mediati, ma per questo
è tanto più efficace rispetto all’autobiografismo più diretto ed esplicito di Eva.
Nelle lettere da Firenze e da Milano si percepiscono tre temi che sono fondamentali
per I Malavoglia: il primo è il tema del sacrificio, della rinuncia, della disciplina del
lavoro, della tenace volontà, della fedeltà alla famiglia, ed è questo il tema che appare
in padron ‘Ntoni e in Mena. Un secondo è il il tema della vergogna, dell’umiliazione,
dell’inferiorità sociale, dell’inadeguatezza, dell’esclusione. Tutto il Verga fiorentino
65
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
66
EMANUELE ZINATO
La guerra a Milano di Franco Fortini
I. La mia relazione intende delineare un percorso nella scrittura in versi e in prosa
di Fortini incentrato sul tema della rappresentazione della forma urbana e articolato
su alcuni campioni tratti dalle raccolte poetiche, da alcuni saggi e soprattutto dalla
prosa testimoniale del 1947 dal titolo La guerra a Milano.1
Le città più rilevanti della scrittura di Fortini sono Firenze, la “città nemica” dell’infanzia e dell’orto umanistico, e Milano, la città delle rovine della guerra e del
“miracolo” neocapitalistico. A Milano Fortini arriva nel 1945 e vive gran parte della
sua vita, dagli anni dell’immediato dopoguerra e della collaborazione al “Politecnico” fino alla morte. Abita prima in via Milazzo, nel quartiere Garibaldi, poi in via
Strobel, poi ancora in via Novegno, nei pressi della Fiera, e infine di nuovo a ridosso
del quartiere Garibaldi, in via Legnano.2 Dunque: un intero cinquantennio, lungo il
quale Milano si trasforma dalla città di macerie e di cantieri, del dopoguerra, divisa
tra speranze di cambiamento e volontà di restaurazione, alla metropoli dei grattacieli
di vetrocemento e dei dormitori di periferia del boom, fino alla città pubblicitaria,
finanziaria e postmoderna degli anni Ottanta.
Mentre Firenze è presente in modo più compatto nella poesia fortiniana - dalle liriche che occupano un’intera sezione di Poesia e errore (In una strada di Firenze) a Il
custode in Composita solvantur, - Milano compare disseminata per lampi e bagliori,
per lo più, dunque, per dettagli apparentemente irrelati. Posto che in entrambi i casi lo
spazio urbano è in Fortini un enigma da decifrare, le differenze tra le rappresentazioni
delle due città risiedono soprattutto nel diverso modo di rendere pertinente nei testi
il rapporto tra gli spazi e il decorso di tempo: nello spazio antico fiorentino le erbe, i
marmi d’argento, le logge, le pietre, possono custodire, incistati per sempre, il nemico
o la rosa; lo spazio milanese è invece l’esperienza della modernità, la vertigine del
nuovo, dell’autodistruzione innovativa, in cui, come ha affermato Marx “tutto ciò che
è solido si dissolve nell’aria”. Si tratta insomma - e significativamente in ritardo di un
secolo - del medesimo processo europeo di modernizzazione in primo luogo architettonica e urbanistica - emblematizzato dai boulevards parigini aperti da Haussmann o
dalle prospettive della Pietroburgo cantate da Gogol o da Puskin che definì il Faust
un’ “Iliade della vita moderna”.
Fortini traduce, oltre che Goethe e Brecht, anche alcune poesie di Baudelaire negli
70
anni ‘50. Ed è un indizio altamente significativo ai fini del percorso tratteggiato in
questa mia conversazione che, proprio a proposito di Milano, un verso capitale delle
Fleures du mal sia ripreso nella seconda raccolta fortiniana Poesia e errore (1959),
nel titolo stesso di una folgorante poesia: La forme d’une ville (del 1957)
La disgrazia di queste case,
cortili di tisi e panni,
presto non sarà più.
Gresìte e vetroflèx
faranno giustizia degli anni,
di noi, di me, di te.
Si tratta di un esplicito rimando a Il cigno, la poesia sulla forma di Parigi inviata da
Baudelaire nel 1859 a Victor Hugo esule dopo il colpo di stato di Luigi Napoleone.
La vecchia Parigi non c’è più l’aspetto
Di una città cambia più in fretta – ahimé – del cuore d’un uomo.
(…)
..Palazzi nuovi, impalcature, blocchi
vecchi quartieri, tutto per me diventa allegoria
e pesano più di macigni i miei cari ricordi
La poesia di Baudelaire accomunava figure difformi di perdita e di catastrofe:
Andromaca esule, il cigno assetato fuggito da un serraglio, una donna nera emigrata
a Parigi, e la vecchia città stessa, spazzata via dai nuovi lavori urbani. La dittatura
borghese di Napoleone III aveva travolto con i sobborghi parigini anche le speranze
rivoluzionarie: Baudelaire attestava esemplarmente - in forma d’allegoria - uno scacco epocale.
Fortini in Poesia e errore (esattamente un secolo dopo) attesta il medesimo trapasso italiano spostato alla fine degli anni Cinquanta del Novecento. A prima vista
le raccolte fortiniane sembrano dunque il documento di un processo evolutivo lineare, anche se repentino, di trasformazione urbana. Alcuni testi-chiave compresi nella
prima raccolta intitolata Foglio di via, del 1946, raffigurano la Milano dalle case
di ringhiera e dei sobborghi operai, dove “il mio popolo desto /attende la grande
sirena” e dove “In Via Nicola Piccinni /a una grata d’officina /c’è una bandiera rossa
/ricordo dell’insurrezione”. Nella raccolta del 1959 – specie nella polemica in versi
con Pasolini dal titolo Al di là della speranza - l’antagonismo e la speranza politica
dei destini generali resistono e si alimentano nelle contraddizioni dialettiche di uno
scenario metropolitano
In queste lente /sere di fumo e calce la città /che mi porta s’intorbida nei viali
/sui battistrada di autotreni, muore /fra ponti di bitume, fari, scorie. /Qui sarò
stato io vivo; e ai generali /destini che mi struggono, l’errore /che fu mio, e
il mio vero, resterà.
71
Uno scenario in cui l’aziendalismo, le banche e la borsa sono onnipresenti e onnipervasivi, come in Piazza Affari, dove i passanti percorrono vie come fosse tra mura
di banche e ogni giornata si recide come una cedola obbligazionaria.
Ora che il canto della città si è quietato
E i vetri non ronzano più;
ora che le gronde gorgogliano
sui cementi degli edifici
e i passanti della sera
nelle fosse delle vie
sono tra mura di banche, di marmi, ed è inverno;
prima di calare
tra i fuochi rossi e verdi
dei molli ascensori e recidere
con la cesoia del cancello/
questa giornata come una cedola
In Questo muro, raccolta del 1973, fa la sua comparsa una città avvelenata, che
intreccia in modo sempre più convulso distruzione e modernizzazione: “L’ossido lede
le antenne sui tetti /i marmi le vernici e le catene. /Il piombo e il bronzo si piegano
piano. /Eppure crescono palazzi / che fulminano azzurri all’occidente/ e di lassù scoprono alti monti”. E nel settimo componimento del Falso vecchio “le auto /mettono
ossido di carbonio e piombo negli alveoli”. In Paesaggio con serpente (1984), infine,
si immagina a Milano una porta inesistente (Porta tenaglia) attraverso cui nei week
end edonistici transitano su luccicanti kawasaki “infanti opliti del sabato” raffigurati
- parodia constatativa e definitiva - come vittoriosi alfieri del “nuovo che avanza”,
come poco dopo accadrà per i soldati dell’Occidente nelle Canzonette del Golfo dell’ultima raccolta Composita solvantur (1994)
Che maschio sapore di acciai, adesivi e solventi
ragazzina che slacci il tuo casco di plastica!
II. A ben guardare, la scrittura fortiniana nasconde nelle rappresentazioni dell’autodistruzione innovativa urbana un percorso a sbalzi, traforato di andirivieni temporali, per niente evolutivo o lineare. Il tema della forma della città e l’esperienza
della trasformazione milanese nella scrittura di Fortini infatti hanno origine ben prima
delle raccolte poetiche coeve al “miracolo economico”. Fortini scrive tra l’ottobre e
il novembre del 1943, in un campo profughi del cantone di Zurigo, La guerra a Milano: un diario, con puntuale indicazione del mese e del giorno della settimana, degli
avvenimenti a cui partecipò come sottotenente di fanteria da “giovedì 22 Luglio” a
“martedì 14 Settembre” del 1943. “Scrissi quel che dei mesi precedenti volevo ricordare. (p. 8)”
L’ immediatezza diaristica, ricostruita a posteriori, è il risultato di una elaborata e
selettiva messa in atto formale. Alla sintassi in prevalenza spezzata e paratattica si
72
accompagnano l’attenzione per i dettagli e il rallentamento temporale, che conferiscono alla scrittura non solo i tratti della minuta registrazione di eventi ma anche i segni
dello spaesamento, fino a limiti oniroidi e surreali:
Esco. Tendo l’orecchio per sentire se dalla città vengono rumori. Ma nulla.
Cammino nel buio lungo la scarpata della ferrovia (...) guardando i fuochi
verdi e rossi dei segnali e sperando. (p. 27)
Una sentinella corre nera nel candore del bengala, agitando il fucile, cade, si
rialza, sparisce. (p. 70)
Vesti umane si agitano sui platani; (p. 73)
Viene buio; e un nugolo di zanzare. Entro in una casa per ascoltare la radio,
ma l’apparecchio funziona male o la trasmissione è disturbata. (p. 118)
La guerra a Milano - un testo proponibile anche a scuola - si può agevolmente
ripartire in tre sequenze: la prima incentrata su Firenze (pp. 19-32), la seconda, più
vasta, su Milano (pp. 33-142), la terza sull’attraversamento del confine fra Como e
Lugano (pp. 143-157).
Fortini stesso ci dice che la sua “vera università” non fu quella degli anni fiorentini bensì il breve periodo della Svizzera e della Valdossola. Il confronto bruciante
e drammatico fra queste due educazioni è il tema principale de La guerra a Milano. Le strade e le mura di Firenze, “non paiono reali” ma “invilite”, “stonate” (p.
20) proprio perché al momento di rimemorarle una porzione rilevante di esperienze
decisive si è già consumata. Tutto il testo si regge sulla giustapposizione straniante
di un prima e di un dopo: i dettagli appartenenti all’ordine della giovanile Bildung
fiorentina (i palazzi e le chiese, le Giubbe Rosse, i corridoi dell’università, le prove
scritte del concorso, i giovani dell’aristocrazia locale, la Scuola Nornale pisana, i
libri ingialliti) vengono rievocati con ironia melanconica: “Firenze. Mi prende l’ironica melanconia di passeggiare per i caffé dove sedevano sino ad un mese fa l’arte e
la letteratura.” (p. 103)
La memoria fiorentina subisce di continuo la smentita e i morsi dell’irruzione della
storia: i bagliori dei bengala, i colpi di radio Londra, la cinquantina di fortezze volanti
che interrompe le prove del concorso, (p. 22) e, soprattutto, gli incendi e le macerie
spettrali di Milano bombardata.
Le pagine più elaborate stilisticamente e a più alta carica espressiva sono infatti
senza dubbio quelle relative ai quattro grandi bombardamenti aerei di Milano “della
seconda ottava d’agosto” (p. 65) del ‘43. Qui la contraddizione da tematica si fa stilistica. Un lessico e un abito mentale tradizionali, “da poeta fiorentino” (segnalati da
termini desueti, nobilitati da una consacrazione letteraria), deve convivere con la torsione linguistica e col sovvertimento caotico e carnevalesco di ogni ordine urbano.
L’animazione antropomorfa della città, l’ uso di un lessico coloristico a forti toni
contrastanti, il dinamismo costruttivo o decostruttivo dei verbi di cui Fortini tenta
spesso di intensificare la pregnanza espressiva tramite la -s in posizione prefissale,
sembrano debitori delle arti di area espressionista (le “ceneri fredde”, il caos degli
“schizzi nerastri”, le “mobili geometrie” dei riflettori). In un primo tempo dominano
73
irrealtà e incredulità, come nelle due discese ahòi inferi di Renzo nella Milano de I
promessi sposi:
Pareva uno spettacolo all’aperto. I colori, i lampi, i riflettori, una scenografia wagneriana. Tutto il cielo della città, il cuore della città palpita a una
velocità altissima, gli alberi si gelano in verdi quinte istantanee (p.71)
All’incredulità fa seguito ben presto la concretezza tangibile della morte e della
devastazione: gli “edifici sventrati”, “l’odore della putrefazione” (p.74.). La metropoli
insomma è scavata dall’espressionismo di Fortini, ed è raffigurata in un parallelismo
con la Milano pestilenziale di Manzoni. Fanno la loro comparsa i topoi delle viscere
della terra denudate e vive (p.73) e alcuni emblemi inerenti al caos sessuale: il “sabba” (p.71) e la scena d’amore notturno metropolitano:
Stasera, verso Lambrate, spuntava all’orizzonte una luna enorme e gialla in faccia ad una grande casa sventrata. Sull’asfalto della via, al suono di
un’armonica, giovani donne e operai in tuta ballavano, cantavano e ridevano.
Ho visto uno degli uomini abbracciare la sua vicina e baciarla sulla gola: tutti
gli altri applaudivano ridendo. (p.102)
Il rimando alla città straniata dall’epidemia in Manzoni non è marginale o incidentale: molti componimenti più tardi, come ha mostrato esemplarmente Luperini
per la poesia dal titolo Stanotte… in Composita solvantur, sono intessuti di richiami
metrici agli Inni sacri, al Cinque maggio e al coro di Ermengarda, e la penultima
raccolta poetica di Fortini Paesaggio con serpente è incentrata sulla figura biblica e
manzoniana dell’Angue Nemico: figura della violenza storica ineliminabile ma anche
dell’inevitabilità dei limiti oscuri della materia vivente, figura insomma dell’inconscio privato e politico.
Nel dialogo con Santarone sui classici italiani, dal titolo Le rose e l’abisso, Fortini
ha rivelato come entro la crudeltà delle immagini degli Inni manzoniani abitino, non
meno che nella Colonna infame, i conflitti storici: il sarcasmo, la disperazione politica, lo scatenarsi della reazione.3
E’ insomma l’attualizzazione del Seicento e la constatazione manzoniana e insieme fortiniana della “feroce forza” che “il mondo possiede”. La stessa che, ricorda
Fortini, compariva nella conclusione dei Promessi sposi meno idillica, e in seguito
cassata, in cui faceva capolino la famiglia di Giangiacomo Mora, vittima di tremende
torture nei processi agli untori: “Non se ne sa nulla. Nessuna memoria ci fu trasmessa
di quella stirpe pur degna di tanta pietà. Quel secolo non pensava alla stirpe dei condannati.”
La “feroce forza” cala dal cielo nel ’43 e getta la città in preda a un caos alchemico.
L’incontro con Vittorini nella sede della Bompiani pervasa dalle schegge di vetro e
legno degli infissi (p.83) assume i tratti di un’apparizione emblematica in un interno
sinistro, in cui tutto è decontestualizzato:
le dattilografe passano da una stanza all’altra con gli occhi rossi di sonno,
una specie di angelo surrealista di alluminio e cartone pende dal soffitto e
oscilla ai riscontri di vento. (p.81).
74
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
75
FRANCO LOI
Camminando per Milano
Voglio leggere poesie, mi sembra che sia più chiaro di tanti discorsi; voglio leggere
poesie scritte in tempi differenti, rispetto a una Milano veramente diversa. Ho sentito
con gran meraviglia che Verga descriveva Milano come di una città tentacolare..,
lascia proprio perplessi.
Io ho conosciuta Milano negli anni trenta, poi negli anni quaranta, mi sembrava
un paesino, per me Milano era un paesino straordinario, basta pensare che noi bambini giocavamo per la strada, nel ‘54, in una via che adesso porta alle autostrade, via
Teodosio, io giocavo a palla in mezzo alla strada: passava qualche macchina ogni
tanto, si fermava, aspettava che noi andassimo sul marciapiede e poi proseguiva; noi
andavamo in giro per tutta la città, andavamo a cercare i libri, negli anni trenta avevo
otto/nove anni, andavamo a cercare i libri della “biblioteca dei miei ragazzi” per tutta
la città, nelle edicole, nelle librerie.
Milano era una città sicura. Basta ricordare che mia madre lasciava aperta la porta
della casa, diceva a una vicina di stare, ogni tanto, attenta a me. Non era la Milano di
oggi.
Io leggerò delle poesie proprio perché ci si renda conto della diversità.
La prima si riferisce al ‘45 e ricorda l’atmosfera particolare dalla fine della guerra
al ‘48-‘49, (leggerò una parte italiana, non tutto, perché molte cose si capiscono perfettamente), dove dico che c’è il paradiso parlo di un personaggio che è in manicomio
e ha memoria del paradiso, i medici gli dicono che forse è una memoria indotta, dall’infanzia, dai momenti felici della vita e lui dice:
Il paradiso si fa in fretta! Ma, come quello là,
forse vien prima l’inferno, o questo pasticcio
di limbo purgatorio e una sorpresa
di minestrone di riso e piselli,
ché un pensiero appena viene lo attraversa un altro
e l’altro è già un ricordo tra mille e più…
I nomi per esempio, o le canzoni.. Ecco,
sono lì che cammino, non ho neanche per le balle
quel che mi pirla… E trac!… da una vetrina
78
ti miagola una mina con la tosse..”(bisogna che precisi che quando si passava con il tram tutti i negozi di fotografi avevano gli altoparlanti, per cui si
sentivano queste canzoni cantate, si passava per esempio in Piazzale Loreto
e si sentivano sempre canzoni… nel ‘49 c’era Il Terzo Uomo, e ecco dentro
di noi si creava un grande rimescolamento).” E’ un quarantotto, una russia
intricatissima,
uno slacciarsi di tutti i bottoni..
Nella seconda parte della poesia si parla della Milano che balla, festosa e dico:
Che giorno, ragazzi! Dappertutto balera!
Balere in strada, balere nei cortili…
E’ la mania del ballo, Milano che balla!
C’è un gioco di bocce, un prato…Su tre cannicci,
e tràccheta, la sala è già pronta…
Un’orchestrina…Tre strapelati pescati
Fuori Lambrate… (”balabiott” ha il senso anche di diavoli, di ingenui, di
strapelati) E via volare! Il night
È una sola luce! Basta che pendano
Quelle quattro lampadine di carta rosa…(e qui nomino i luoghi di Milano
dove si ballava)
…E ogni nome una storia,
Ché basta dire «era il Quarantacinque»
E poi «Quarantasei», e a tanta gente
si drizzavano le orecchie, gli vengono i formiconi…
…Venivamo dalla guerra, (mi vengono i brividi]) e per la strada
ci avevano passato insieme amori, dolori.
Ancora sparavano, ancora c’erano i morti,
ma eravamo noi, eravamo classe operaia,
noi eravamo gli scampati dalla fame e dalle bombe,
noi, gente di strada, gente fatta di morte,
noi eravamo come germinati dalle fosse del mondo,
e non per crudeltà, non per disprezzo,
mancanza di pietà, vomito di noi,
ma, come una passione di sole esplosa,
anche la note noi volevamo il sole…
Chiamatela libertà, chiamatela sbornia,
chiamatela come volete…Festa ai coglioni!
… ma noi, che l’abbiamo patita proprio tutta,
anche la libertà ci siamo goduti!
Qui ci vorrebbe la canzone.
“ Tuuu, che mi sorridi verde luna
El Paradis… se fa svelt! Ma, ’me quèl là,
forsi vègn prima l’infernu, o ‘stu pastìss
de limbu, purgatori, e ‘na surpresa
de minestrun cuj risi e i bisi,
79
ché un penser se ‘l vègn traversa ‘n alter
e l’alter l’è in regôrd tra milla e pü…
I nòm pr’esempi, o i cansun…Eccu,
sun lì che camini, g’û gnanca per i ball
quèl che mi pirla…E tracch!…da ‘na vedrina
te miagola ‘na mina cun la tuss…
l’è un quarantott, na rüssia girabolda,
un declassàss de tütt la buttunera…
Solitude, el Men ai lov, Carioca,
i blus de l’Amstrongh, Ciattanuga ciu-ciu,
…e le patate si chiaman patate..
T’amo, t’amo, se per me la vita, intera..
E pö la Gilda, Sciarlot con Viuletera,
la Ingrid Bergman, el Uels del Terso Uomo,
e nüm taccâ dré i tram càntum Brasil…
Che dì, ragassi! In depertütt balera!
Baler in strada, baler den’ di curtìl…
L’è la mania del ballo! Milan che balla!
Gh’è un giögh de bocc, un prâ… Sü tri canìcc,
e, tràcheta, la sala bell’e prunta…
Un’urchestrina…Tri balàbiott pescâ
föra Lambrâ…E via volare! El Nait
‘na lüsa sula! Basta che pénden
chi quatter lampadìn de carta rösa…
Gardenia, Miralago, Stella Russa,
el Lido, Lago Park, La Capanina…
Fina nel Trotter…E ogne nòm ‘na storia,
ché basta dì «l’era ‘l Quarantacinq»
e pö «Quarantasess», e a tanta gent
s’indrissa i ùregg, ghe vègn i furmigun…
…Vegnivum da la guèra, e per la strada
gh’evum passâ insèma amur, dulur.
Amô sparaven, amô gh’eren i mort,
ma serum nüm, serum class uperara,
nüm serum i scampâ da fam e bumb,
nüm gent de strada, gent fada de mort,
nüm serum ‘me sbuttî dai fòpp del mund,
e, nun per crüdeltâ, no per despresi,
mancansa de pietâ, roja de nüm,
ma, cume ‘na passiun de sû s’ciuppada,
anca la nott nüm la vurevum sû…
Ciamila libertâ, ciamila sbornia,
ciamila ‘me vurì…Festa ai cujun!
…ma nüm, che l’èm patida propi tüta,
anca la libertâ se sèm gudü!
80
Adesso leggo una poesia che indica il momento del cambiamento:
Come parlano bene l’inglese i milanesi,
dicono war-games, disgusting, walke-talkie
e tramano sul lombardo coi meridionali.
Prima hanno ucciso il paesaggio, poi tra calchi
di benzinai, industrie e autostrade
hanno massacrato la lingua, e al buon De Marchi
hanno strappato il gusto del canto e delle bambinate.
E’ roba patinata, puzza al naso, socialavanderia di spartizione di torte,
mezzi uomini e mezze donne, gente a cui piace
parlarsi addosso e far tanti soldi.
Così, amici a Milano gli tocca tacere
E far una sbornia di wisky e di sakè,
tra gran sarti, politici senza storia
e manager che leccano i bignè.
‘Me pàrlen ben l’ingles i milanes,
dìsen uorgheim, desgasting, uolkitolki
e furchen sül lumbard cuj giargianes.
Prima àn massâ ‘l paesagg, pö tra i calchi
di benzinar, indüstri e autostrâd
àn sacanâ la lengua, e al bun De Marchi
g’an strepâ ‘l güst del cant e di cinâd.
L’è roba patinada, spüssa al nâs,
sucialavanderia de inturtinâd,
mèzz òmm e mèzz dunètt, gent che ghe piâs
parlâss indòss e fà tanti dané.
Inscì, amîs. Milan ghe tuca tâs
E fà ‘na sbornia uischi e de saché,
tra gran sartur, pulitegh sensa storia
e managér che lécchen i bigné.
Voglio leggere, anche, una poesia su Vittorini, che abitava a Milano in via Gorizia,
lungo la Darsena.
Prima c’è un pezzo sulla morte di Vittorini e poi i versi che ricordano il mio incontro
del ‘54 con lo scrittore. quando mi ha parlato a lungo di Milano.
Non leggerò le parole di Vittorini, perché sono in italiano
E Vittorini era uomo d’amore.
…
….e sentivo il sapore
degli alberi come un mare oltre la Darsena,
e lui come un astrologo nascosto nella luce
diventa la parola la sua faccia
e io che guardo mi perdo e sono recluso
dalla sua vita, dal suo essere lì a parlare
81
e sembra sia Milano che con la luce
viene nella stanza dove sto ad ascoltare.
…..
Alto elegante, con gli occhi di sera
Quando dal loro chiaro il giorno diventa azzurro,
sembrava il rispecchiamento di un mosaico,
uno di quei Re che stanno nell’ombra al buio,
e io lo guardavo, ascoltavo e vera
sentivo la sua voce tra le mie paure…
…..
Ah, Vittorini, bell’uomo di tempi antichi,
la memoria di te, come la vita,
si sfa e mai passa, e sembra un grido
che perdersi pare in aria ma si ferma
e sta sospeso tra gli uomini come per dirgli
che niente si fa per niente e niente è niente
e la coscienza porta nei suoi sogni
con i segni del giorno anche il suo sentimento,
così la storia si fa di carne
e porta avanti il peso della sua vita
contro il marcio della rogna, i soffi del vento,
e l’ombra del dolore che dentro ci respira.
E Vittorini l’era ‘n òm d’amur.
«Vede, Milano, dalla mia finestra
è tutta in Conca…» e sentivi el savur
di àlber cum’ un mar ulter la Darsena,
e lü me ‘n stròlegh scund denter la lüs
deventa la parola la sua faccia
e mì che vardi me perdi e sun reclüs
da la sua vita, dal sò vèss lì a parlà
e par che l’è Milan che cun la lüs
vègn ne la stansa in due stù a scultà
«Lei scrive il grigio come fosse grigio…
Ma il grigio è fatto di colori e di beltà.
Lei guardi Gogol, le metope del frigio,
le spente vite di Cechov, Balzac…
La luce sta segreta dentro il bigio
E ogni noia si avverte dentro un crac...»
Alt, elegant, cunt j öcc de sera
Quan’dal sò ciar el dì deventa azür,
pareva d’un musaich una speggera,
vün di quj Re che stan ne l’umbra al scür,
e mì’l vardavi, el scultavi e vera
sentivi la sua vûs tra i mè paür…
«Non badi al tempo, e sempre sia sincera
la sua canzone, la forza del parlare …
82
Chi scrive, sia per gioia o che dispera,
lascia l’impronta come un camminare…»
Ah, Vittorini, bèll’òm di temp antîgh,
la memoria de tì, cume la vita,
se sfà e mai la passa, e par un sîgh
che spèrdess par ne l’aria ma se ferma
e sta suspés tra j òmm cume per dîgh
che nient se fa per nient e nient l’è nient
e la cusciensa la porta ind i sò sògn
cuj sègn del dì anca el so sentiment,
ch’inscì la storia la se fa de carna
e porta avanti el pés de la sua vita
cuntra ‘l marsc de la rogna e i buff del vent,
e l’umbra del turment che dent ghe lita.
La Milano di oggi a me si presenta così:
Cambiano le facce non le riconosco più,
vengono avanti a me come morti
e sembrano guardare, sembrano salutare
uno dietro l’altro nella stessa sorte;
e le case sono di Milano, le strade, la nebbia,
i tram che passano, i Navigli alle Porte…
ma le facce sono pallide, gli occhi di cispa e scabbia,
e mancano le voci dei bambini, le belle ragazze
che vanno in bicicletta al filo della Vettabia
soffocata sotto la terra, e non ci sono più le canne
dei fossi e dei laghettti, non c’è più la vita
delle radio accese e l’acqua di Milano…
Ah, quante facce camminano senza vita!
Càmbien i facc e j recunussi pü,
vègnen devanti a mì cume vèss mort
e par che vàrden, par che me salüden
‘me vün dré l’olter ne la stessa sort;
e i câ în de Milan, i strâd, la nèbia,
i tram che passa, i Navili aj Port…
ma i facc în smort, j ögg de cispa e scàbia,
e manca i vûs di fjö, i bèj tusann
che van in bici al fil de la Vettabia
sufféga sott la tèra, e gh’in pü i cann
di foss e di laghètt, gh’è pü la vita
di radio acés e l’aqua de Milan…
Ah, quanti facc camina sensa vita!
Pezzi di Milano che fate muro agli uomini,
cemento di Misurata alle case del viale,
83
sotto il cielo nascosto vuote stanze dove muoiono gli uomini
tra smog e macchine e voci di notte e ciarle
d’una Milano nel suo cemento perduta,
Milano che va in malora al crescere delle menzogne
tra le banche e le puzze dei ricchi e la ventata
degli odi della gente che impesta le strade,
Milano che si vende alla giornata
e butta il tempo nello sporco delle sue malefatte,
ah mia città che nebbia ci copre!
senza che i sogni portino libertà.
Tòcch de Milan che fì de mür aj òmm,
cement de Misürada aj câ del vial,
nel scund del ciel vöj stans due mör j òmm
tra smog e macchin e vüs de nott e ciall
d’una Milan den’nel cement perdüda,
Milan che la va in vacca al crèss di ball
Tra i banch e i spüss di sciur e la ventada
Di ödi de la gent ch’impesta i strâd,
Milan che la se vend a la giurnada
E trasa el temp nel vunc di sò purcâd,
ah mia citâ che nèbià che ghe cuatta!
Sensa ch’j sògn ghe pòrten libertâ.
Volevo aggiungere una nota negativa: da casa mia, viale Misurata, ho impiegato
un’ora per arrivare qui all’università: eravamo tutti arrabbiati, tesi, respiranti smog e
gas di scarico. Penso ai pendolari: si alzano alle quattro, arrivano al posto di lavoro,
lavorano tutto il giorno, tornano a casa, e vi arrivano alle dieci; mi domando se questo è il mondo dove tutto va bene, dove tutti sono contenti. Oggi “Il Corriere della
Sera” riportava dei dati in cui tutti hanno soldi, tutti sembrano mangiare, ma quello
che spaventa è la qualità della vita, che vita fa un lavoratore?, e uno studente? E’ un
continuo indorare la pillola: tutto è bello, alla televisione ridono sempre, e poi invece
basta entrare in un ospedale o non avere la macchina (chi ha la macchina passa le
giornate dentro la macchina, quando andavo alle Mondadori arrivavo in bicicletta
sempre prima di un amico che arrivava in macchina!). Mi domando il perché di questa
follia di una città immobilizzata: quanta gente infelice!, qual è la vita dei vecchi, qual
è quella dei giovani?
Io ho conosciuto una città dove si viveva e ci si conosceva bene, le case con la
ringhiera, tanto vituperate, creavano solidarietà: oggi non so neanche chi sia il mio
vicino di casa. Se quando esco saluto qualcuno, mi sembra che mi guardi stranito,
quasi avessi fatto una cosa strana.
Penso a “Miracolo a Milano” quando tutti volevano scappare per andare in un posto
dove buongiorno volesse proprio dire buongiorno. Ora la gente è stupita se la guardi
in faccia…
Gli studenti mi hanno chiesto se valga ancora la pena di scrivere poesie, se la poesia
sia la voce della resa o sia la voce di qualcosa che può andare aldilà del degrado e
84
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
85
GIANNI TURCHETTA
“lo spasma dello spirito
e lo spasma della materia”:
I segreti di Milano di Giovanni Testori
Per cominciare: un autore di non facile collocazione
Vorrei cominciare il mio discorso commentando, sia pure molto velocemente, il
titolo del mio intervento: un titolo che deriva da uno degl’innumerevoli studi di critica
d’arte di Testori (sono molte centinaia, e ancora oggi non ne possediamo un censimento completo: ma a questo sta meritoriamente lavorando l’ “Associazione Giovanni Testori” di Milano). Come spesso accade, lo scrittore che commenta le opere di
altri artisti sembra anche parlare della propria stessa poetica. In particolare, è difficile
resistere alla tentazione di applicare a Testori stesso le considerazioni ch’egli fa a proposito di Tanzio da Varallo, il quale sarebbe riuscito a realizzare il suo “proposito di
identificare [...] lo spasma dello spirito e lo spasma della materia” (G. Testori, Palinsesto valsesiano, Milano, Scheiwiller, 1964, p. 23), di raggiungere cioè la verità, pulsante e nascosta, dell’uomo e del cosmo. La verità, per Testori, non può essere trovata
alla superficie delle cose, ma va cercata nel profondo, attraverso una sorta di discesa,
non meno tormentosa che affascinata, verso l’originario, cioè verso la dimensione, al
tempo stesso, dell’autentico e del primordiale: una dimensione, e quasi un punto alchemico di fusione, dove corpo e anima si confondono, rivelandosi inestricabilmente
intrecciati, non più distinti né distinguibili.
È sicuramente utile avviare il discorso intonandolo ad affermazioni esplicite dell’autore. D’altro canto, è pure opportuno non fidarsi del tutto, o almeno non aderire in
modo troppo passivo alle affermazioni di poetica dell’autore stesso: in questo senso,
proprio gli scrittori molto lucidi intellettualmente offrono ai critici molti appigli, ma
insieme fanno loro correre qualche rischio di troppo. E questo rischio è particolarmente grave in un caso come quello di Testori: cioè di un autore che è stato molto
recensito ma poco studiato, cioè poco (pochissimo!) studiato in modo approfondito
e tecnico. Il che, certo, capita spesso agli autori a noi vicini nel tempo, anzitutto per
motivi cronologici: perché non c’è stato ancora tempo di metabolizzarli, e perché la
critica, quando si occupa di contemporanei, soffre sempre di una specie di presbiopia.
Ma in questo caso c’è molto di più: Testori infatti è stato un po’ troppo assorbito, per
sua stessa volontà, da un certo ambito ideologico e politico (Comunione e Liberazione). Così che i giudizi critici su di lui sono andati troppo spesso a confondersi con i
giudizi ideologici: il che ha determinato un fuoco incrociato di, da un lato, apologie
88
troppo corrive, troppo vicine alle posizioni dichiarate dall’autore; e, dall’altro, opposizioni complementarmente troppo rigide, troppo preoccupate di respingere quanto,
purtroppo per lui, Testori stesso spingeva tendenziosamente a mettere in primo piano.
In questo secondo tipo di equivoco, lo ammetto senza difficoltà, sono per molti anni
caduto anch’io.
L’interpretazione di Testori si è poi caratteristicamente incagliata (come, di nuovo,
accade spesso nella critica sulla letteratura del Novecento) su categorie interpretative
non prive di utilità, ma un po’ troppo irrigidite, e portatrici, visibilmente, di un imbarazzo non meno storiografico che teorico. Basti pensare, tanto per rendere subito
l’idea, all’impaccio con cui si continua a maneggiare una coppia oppositiva un po’ stereotipa come “avanguardia” vs. “naturalismo”. Rimando, per questa questione, a un
recente e lucido resoconto degli equivoci critici sorti a proposito di Il dio di Roserio
e, più in generale, di I segreti di Milano: lo si trova in un bel volume di Paola Ambrosino (Da Guernica a Roserio, in bicicletta, Milano, C.U.S.L., 2003, in particolare nel
paragrafo Criticità della critica, pp. 95-114). Semmai, provando a maneggiare prudentemente qualche categoria, qualche “-ismo”, potrebbe valere la pena di ridefinire
la posizione di Testori in rapporto alla costellazione, ampia e variegata, del cosiddetto
espressionismo realistico, o realismo espressionista (o magari, come ebbe a proporre
provocatoriamente Sanguineti per la poesia del Novecento, di “sperimentalismo realistico”, che è quasi un ossimoro).
Al di là degl’imbarazzi storiografici, è soprattutto necessario dire, senza esagerare
in premesse di metodo, che Testori è autore ricchissimo, che possiamo e dobbiamo
ricominciare a leggere senza paraocchi ideologici. Non è del resto un caso che energici inviti a rileggerlo ci siano arrivati, in anni vicini, da due voci molto autorevoli, e
certo ideologicamente assai lontane da Testori, due voci che qui voglio ricordare con
speciale affetto: Franco Fortini (di cui ricorre il decennale della morte) e Giovanni
Raboni, che ci ha purtroppo lasciato poco tempo fa. Protetto dalla loro prestigiosa
auctoritas, voglio ripetere anch’io che è proprio ora di ricominciare a leggerlo, questo
Testori, con una rinnovata attenzione analitica, e con una nuova serenità.
Un progetto artistico a tutto campo
Nato a Novate Milanese nel 1923, Testori, come abbiamo subito ricordato, è un
acutissimo storico e critico di arti figurative, ed è anche un notevole pittore in proprio.
Ed è scrittore, eccezionalmente prolifico, ma anche uomo di teatro, che è tutt’altra
cosa: ma certo, come vedremo meglio fra poco, fra scrittura e teatralità ci sono rapporti profondi. È necessario poi sottolineare con forza come, in ogni momento della
sua vicenda artistica e intellettuale, Testori abbia sempre dato grande rilievo a quelle
che chiameremo le sue radici, al suo rapporto cioè non solo, com’è ovvio, con una
certa area geografica, ma anche con una certa idea dell’arte, caratteristica della tradizione milanese e più generalmente lombarda. A corollario di quest’ultima affermazione, vorrei ricordare come Testori sia, certo, uno scrittore di Milano, ma a patto di
intendere Milano come “grande Milano”: cioè come una realtà (urbanistica, sociale,
antropologica) più ampia, che comprende le periferie e l’hinterland.
Tornando alla difficoltà di classificare Testori, bisogna ricordare come egli si sia
accostato alla fronda contro il fascismo, senza però mai essere propriamente antifascista, e senza impegnarsi direttamente nella Resistenza. Sempre tendente a far parte
per se stesso, egli partecipa però intensamente, su una linea coerente con la tradizione
89
lombarda di eticità (una tradizione che va dritta dritta da Parini a Gadda, passando per
Manzoni), all’avventura del gruppo di “Corrente” fra le due guerre e poi, nell’immediato dopoguerra, a quella del gruppo di artisti del Manifesto del realismo conosciuto
anche col titolo di Oltre Guernica (marzo 1946). Con ogni evidenza, Testori condivide una poetica che intende riprendere la lezione delle avanguardie (in particolare, del
cubismo e della linea che va da Cézanne ai fauves e a Matisse), ma conservando sempre una profonda attenzione alla concretezza del reale. Allo stesso tempo egli rifiuta
però ogni realismo ingenuo. In altre parole, Testori persegue, in tutti i campi, un’arte
capace di contemperare esigenza morale e sperimentazione formale, impegno civile e
tensione modernista, senza mai perdere di vista la realtà sociale, intesa però in modo
problematico e decisamente non “naturalistico”. E certo bisognerebbe anche parlare
analiticamente (ma dovrò qui limitarmi a questo brevissimo accenno) dell’influsso
che ebbero su Testori due maestri quali Roberto Longhi, per quanto riguarda la storia
dell’arte, e Mario Apollonio, per quanto riguarda la storia del teatro.
Fatto sta che, a partire da una costitutiva poliedricità, la carriera artistica di Testori
mostra una costante e quasi direi fondativa attenzione nei confronti del teatro. Non è
certo un caso che la sua prima opera edita sia un’opera teatrale (La morte. Un quadro, Forlì, Edizioni di Pattuglia, 1943; ora in Opere. 1943-1961, Introduzione di G.
Raboni, a cura di F. Panzeri, Milano, Bompiani, 1996, pp. 1-25), e che, oltre ad avere
scritto numerosissime opere per il teatro, Testori abbia partecipato in prima persona a
non poche delle intraprese teatrali più prestigiose del secondo Novecento: dal lavoro
al Piccolo Teatro, con Giorgio Strehler, Mario Missiroli e Luchino Visconti (che peraltro avrebbe anche tratto da tre racconti di Il ponte della Ghisolfa la sceneggiatura di
uno dei suoi capolavori cinematografici, Rocco e i suoi fratelli), a quello con Franco
Parenti e Ruth Shammah (con i quali nel 1971 avrebbe fondato la Cooperativa del Pier
Lombardo), e con Franco Branciaroli, fino alla costituzione della Compagnia dell’Arca (1978) e al lavoro con Emanuele Banterle e Andrea Soffiantini.
Già molti critici hanno osservato che Testori ha sempre lavorato, per così dire, in
direzione del teatro. Ma a noi qui interessa soprattutto sottolineare come il teatro sia
l’arte che meglio, o quanto meno più percepibilmente consente di cedere la parola
ai personaggi, e, di più, di imporre fisicamente la concreta presenza dei corpi: affermando, con quasi indiscutibile perentorietà, il valore di testimonianza e di verità
dell’esperienza dei singoli. Si potrebbe avere anche la tentazione di parlare, a questo
proposito, di teatro di poesia: ma sarebbe una definizione profondamente riduttiva.
Certo è che il complesso progetto di I segreti di Milano, sembra trovare le proprie
ragioni costitutive, e quasi vorrei dire la propria struttura trascendentale, nell’esigenza
di far parlare direttamente i personaggi, di metterli in scena e lasciar loro la parola:
che è quanto (con le specificazioni che vedremo fra poco) accade, vistosamente, anche e proprio nei testi narrativi. A rigore, il ciclo comincerà con la narrativa (Il ponte
della Ghisolfa e La Gilda del Mac Mahon), e proseguirà con il teatro La Maria Brasca
e L’Arialda), per poi tornare alla narrativa (Il Fabbricone e Nebbia al Giambellino).
Forse però il momento più alto di tutto il ciclo è proprio quello narrativo inziale,
quello cioè dei primi due grandi libri, Il ponte della Ghisolfa e La Gilda del Mac
Mahon (sui quali soprattutto concentrerò la mia attenzione). Ma, per l’appunto, anche
i protagonisti narrativi dei Segreti di Milano, non meno dei personaggi propriamente
teatrali, mettono in scena e quasi esibiscono le loro anime sofferenti proprio in quanto
si manifestano nella fisica concretezza dei loro corpi, e delle loro materiali percezioni;
90
perché è nella concreta corporeità, e soltanto in essa, che si può manifestare l’anima:
“lo spasma dello spirito e lo spasma della materia”, appunto.
Singolarità e totalità
C’è un rapporto profondo fa questo atteggiamento e l’attenzione costante da parte
di Testori, nel teatro come nella pittura, alla dimensione locale. Basti pensare al suo
amore per la pittura lombarda, soprattutto del periodo fra manierismo e barocco, e in
genere per i secentisti, come Francesco del Cairo, Fra’ Galgario, Foppa, Borgognone, o il già citato Tanzio da Varallo. Bisogna però anche specificare che, per Testori,
l’amore per la dimensione locale vuole, programmaticamente, evitare tuttavia ogni
facile regionalismo, così come ogni idea troppo ingenua di realismo (neorealista o
naturalista o anche impressionista).
Stare vicini una realtà che si conosce è comunque una maniera, che Testori sente
pressoché indispensabile, per riuscire a conoscere e penetrare nel concreto, anzi nell’assolutamente singolare. Con la ferma convinzione, solo apparentemente paradossale, che proprio l’impavida discesa verticale verso gli abissi rischiosi e vischiosi della
concreta singolarità può condurre a verità generali, universale: è però indispensabile
che la verità generale non sia in nessun modo una verità astratta. In una sorta di geometrica progressione dal particolare al generale, potremmo dire che, per Testori: nel
piccolo c’è il grande; nella singolarità c’è la totalità; nel mistero dell’individuo c’è il
mistero del cosmo; nell’uomo c’è Dio.
Il che equivale anche a dire che la messa in scena dei Segreti di Milano vuole essere, e non potrebbe essere altrimenti, una messa in scena dei segreti del mondo tutto: di
quei segreti, per l’appunto, che si celano negli abissi dell’interiorità. Ma l’interiorità,
ancora volta, lungi dal ridursi a una dimensione psicologica, convenzionalmente introspettiva, è qualcosa che chiama in causa insieme, inestricabilmente, la dimensione
fisica non meno della dimensione morale. Testori, insomma, vuole un’arte che non si
limiti ad imitare l’apparenza delle cose. Ad essa corrisponde, sul piano delle tecniche
narrative, un uso massiccio del discorso indiretto libero (soprattutto), che talvolta (ma
in modo più contenuto e, per così dire, condizionato) può arrivare a confondersi con il
monologo interiore. Su questo torneremo fra poco. In una sintesi provvisoria, diciamo
però già che la stessa tecnica di Testori si caratterizza come un viaggio verso l’interiorità, realizzato nelle forme di una teatralizzazione della singolarità, o, più precisamente, dell’esperienza dei singoli, colta nel suo farsi.
Così come vuole una letteratura, e, più in generale, un’arte che non sia troppo intellettualistica o troppo formalistica, Testori ama i pittori che cercano di penetrare le
cose e le persone al di là della loro superficie. Basti pensare alla vicinanza, e alla pluridecennale amicizia, con Ennio Morlotti (Lecco 1910-1992), che per molti aspetti è
un suo punto di riferimento in pittura: anch’egli legato a “Corrente”, seguace al tempo
stesso di Cézanne e del cubismo, capace, specie nella parte finale della sua carriera, di
avvicinarsi originalmente alla pittura astratta, ma conservando una corposa concretezza, che arriverà fino a una specie di esaltazione fisica della materia, a un’emblematica
e quasi direi esemplare convergenza di concettuale e materico.
Si è parlato, per Testori, di “poetica della profondità” (R. Rinaldi, Testori o della
profondità, in Il romanzo come deformazione, Milano, Mursia, 1985, pp. 63-177).
Ma resta ancora quasi tutto da fare il lavoro analitico sui procedimenti con cui lo
scrittore di Novate Milanese cerca di raggiungere gli abissi al tempo stesso fisici e
91
anzi, con gli aspetti più grevi e più squalificati della comicità più andante, quelli legati
alle viscere e alle funzioni digestive.
Lo scontro sistematico fra intonazione seria e oggetti comici (insisto: attinti anche, con evidente intenzionalità, dall’ambito della fisicità più bruta, cioè dai meno
nobilitabili “spasmi della materia”), s’intreccia, in modo altrettanto sistematico, con
la ferma volontà di attingere, senza alcun tipo di censura, tutta la ricchissima gamma
delle percezioni e delle emozioni umane. In altre parole, la pluralità delle intonazioni
mette chiaramente radici in un programma di ricchezza emotiva, o emotivo-percettiva: un programma che davvero non è possibile sottovalutare. Testori vuole infatti
costruire figure umane capaci di mostrare tutta la carica emotiva (ancora una volta:
psichica, ma anche fisica) che li attraversa, la folla di sensazioni che ne costituisce la
vita, tout court. Dove, certo, troveremo soprattutto sofferenze, ma troveremo anche,
e in quantità molto notevoli, esaltazioni e qualche volta addirittura felicità (come nel
mirabile Andiamo a Rescaldina, in Il ponte della Ghisolfa, cit., pp. 446-455). Il fatto
è che, ancora una volta, la sfida dello scrittore è rivolta alla ricchezza e complessità
stesse della vita: ma in quanto questa vita viene vissuta e esperita da persone concrete,
fisicamente individuate. Tutte le scelte rappresentative di Testori sono orientate a costruire e far percepire sulla pagina l’intensità stessa dell’esperienza.
In questa maniera, la discesa verso le profondità della psiche e della materia si
configura non solo, genericamente, come una teatralizzazione, ma più specificamente,
come una teatralizzazione dell’intensità dell’esperienza vissuta. Inoltre, la tensione
verso realtà (sia pure psichiche, o meglio psicofisiche) concrete e individuate produce
costantemente una sorta di corto circuito, che la proietta inequivocabilmente verso
una dimensione simbolica, cioè, di nuovo, generalizzante. Accade cioè nelle pagine di
Testori proprio quanto lui stesso individuava nei pittori più amati, e in particolare nel
Caravaggio e nei suoi eredi; come scrive persuasivamente Annamaria Cascetta, in essi
lo scrittore di Novate Milanese scopriva
la possibilità del segno artistico di toccare il massimo dello spessore simbolico attraverso l’adesione alla realtà, di esprimere l’irruzione del metafisico
nel quotidiano, nella povertà dell’oggetto e nella intimità dolente ed affettuosa di una umanità modesta, di svelare l’iscrizione della morte incipiente nelle
pieghe di una vita pur piena e la sua inquietante domanda di senso.
(A. Cascetta, Invito alla lettura di Testori, Milano, Mursia, 1983, p. 31)
Caratteristica del realismo espressionistico di Testori è però anche e proprio, come
dicevamo, l’insistenza sulla materia, cioè proprio sulla materia bruta, colta nella sua
più densa fisicità. E si pensi a quante volte Testori ha rappresentato le intensissime
fatiche e le intensissime sofferenze dello sport, ciclismo e pugilato in testa. Dove la
fisicità esasperata diventa a sua volta uno strumento per spingere e quasi forzare la
realtà verso il simbolo: per “tagliarla”, torcerla e deformarla, mescolando senza soluzione di continuità i fatti minimi della quotidianità con il senso ultimo delle esistenze,
i sussulti minimi e più ignobili della carne con la parabola inesorabile di un destino.
La coerenza delle scelte testoriane organizza, vistosamente, non solo l’impianto
stilistico e tematico, ma anche le strutture stesse della narrazione. I suoi testi (narrativi
ma anche teatrali, in quanto dotati di una struttura narrativa) obbediscono infatti a una
logica narrativa profonda, e di indiscutibile modernità, in cui, con sapiente alternanza,
93
gli eventi forti (delitti, violenze, scontri, amori, abbandoni e così via) si intrecciano
con eventi minimi. Questa stessa vistosa oscillazione strutturale fra azioni violente,
drammatiche (teatrali?) e lo scialo spudorato di azioni comunissime, prive a prima
vista di qualsiasi rilievo narrativo, costituisce al tempo stesso un elemento di costante
deformazione e un ingrediente decisivo della significazione complessiva, cioè del significato simbolico dei testi.
Del resto, non è certo un caso che spesso gli eventi drammatici, che segnano le
esistenze dei personaggi, finiscano per essere piuttosto degli eventi mancati: le storie
di Testori sono infatti significativamente piene di rapporti amorosi mancati, di matrimoni mancati, di gesti pensati e non compiuti, di conflitti che non possono essere
manifestati, spesso addirittura di omicidi progettati e non commessi. Il lettore vede
così da un lato balenare in continuazione fatti violenti e persino atroci, crimini piccoli
e grandi, violenze, scontri e gare. Da un altro lato Testori dispiega senza pudori quello
che il grande Auerbach ebbe a definire genialmente “il trionfo dell’insignificante”.
Si pensi, tanto per fare un esempio, al ralenti spettacolare (cioè, per essere precisi,
spettacolarmente anti-spettacolare...) sul caffè che Enrica (già protagonista del ciclo
narrativo eponimo di Il ponte della Ghisolfa) prende al bar in Appena fuori Luino (in
La Gilda del Mac Mahon, cit., pp.526-527).
Riprendendo una nota coppia oppositiva formulata da Seymour Chatman, possiamo
certo dire che in Testori, nonostante gli eventi forti, la narrativa “di rivelazione” prevale nettamente sulla narrativa “di risoluzione”. In altre parole, le storie dei Segreti di
Milano puntano molto di più sulla rivelazione di una condizione esistenziale che non
sulla costruzione di un intreccio con un conseguente scioglimento narrativo. Il che
però, ancora una volta, ha evidenti implicazioni non solo strutturali ma anche semantiche. Queste storie infatti danno costantemente l’impressione di non essere chiuse,
anche quando si chiudono; e potremmo dire, forzando appena appena le cose, che nei
Segreti di Milano i finali aperti sono la regola. Ma l’assenza di un finale forte coincide
con l’assenza di consolazione; cioè, per ricordare i termini della poetica aristotelica,
l’assenza di λυσισ coincide con l’assenza di καθαρσισ. Sul piano ideologico, sarei
tentato di parlare di un manzonismo senza Provvidenza. Sul piano strutturale, certo
anche il lettore meno esperto viene colpito e quasi ferito dall’impressione che le storie
dei Segreti di Milano non siano soltanto intrecciate fra di loro, ma possano in teoria
continuare all’infinito.
Gli intrecci multipli e la totalità: una Commedia umana
Stiamo evidentemente approdando alla questione della struttura complessiva del
grande ciclo testoriano: una struttura che a molti critici è parsa (forse non del tutto
a torto) macchinosa. Però di questa stessa struttura non possiamo in alcun modo nasconderci la ricchezza, la complessità e l’originalità. In prima approssimazione, Testori si propone anzitutto di scrivere dei libri di racconti; ma questi, lungi dall’essere
soltanto dei racconti isolati, sono collegati tra loro, in vario modo e a vari livelli, tanto
da costituire in buona sostanza un’unità narrativa, al tempo stesso sempre proiettata
verso il romanzo e sempre ben distinta dal romanzo propriamente detto. Nell’Avvertenza alla prima edizione di Il ponte della Ghisolfa Testori scrive:
Questi racconti, dei quali solo alcuni son qui direttamente conclusi mentre
i più verranno ripresi e portati avanti nelle raccolte successive, formano la
94
morali dell’uomo, di cogliere il groviglio dei sentimenti e delle percezioni, mentre si
produce all’interno di una concreta individualità. Testori è evidentemente in sintonia
con l’aspirazione, che caratterizza la maggioranza della narrativa novecentesca, a privilegiare lo showing sul telling, cioè a raccontare mostrando le persone e le cose, più
che riassumendole, interpretandole e spiegandole.
Leggiamo, per capire meglio, almeno un passo. Vi vedremo emergere, in modo
molto vistoso, un discorso indiretto libero (con le sue marche formali caratteristiche:
la terza persona, l’uso del passato), che però tende irresistibilmente al discorso diretto
(come mostrano la sintassi, la folla di esclamativi, i tratti linguistici colloquiale e persino dialettali): si tratta, più precisamente, di un indiretto libero molto mimetico, cioè
molto vicino alla lingua del personaggio di cui si riporta mediatamente il discorso
(in questo caso: il pensiero). È qui in scena uno dei personaggi più felici dei Segreti
di Milano, e di tutto Testori: Rita Boniardi, meglio conosciuta come la Gilda, per la
sua somiglianza con il leggendario personaggio cinematografico interpretato da Rita
Hayworth. Gilda sì, ma del Mac Mahon. L’uomo che lei ama, Gino, l’ha convinta
(non senza fatica...), a diventare la mantenuta di un uomo ricco e sposato, al quale
poi Gilda avrebbe dovuto chiedere una cifra molto ingente, minacciandolo di rendere
pubblica la relazione: l’uomo, dopo aver appena abbozzato qualche debole tentativo
di resistenza, cede facilmente, a patto che Gilda continui a far l’amore con lui:
“Povero bamba, povero fescione d’un fescione, che forse aveva finito con
l’affezionarlesi davvero! Gli uomini! Che meraviglie, madonna! Ma che
schifo! In quella maniera lei del ricatto non aveva potuto sentir neppure il
rimorso, neppur l’orrore! Insomma, all’ultimo, quando i suoi crocifissori
avrebbero dovuto piantarle in testa la corona e nelle mani i chiodi, niente!
Le caramelle, ecco, le caramelle le avevan dato! E tutto per la paura... ’Ste
femminette, ’ste fife che son gli uomini! Tranne il suo Gino, naturalmente,
tranne lui; perché lui della paura non sentiva neanche l’ombra...”
(La Gilda del Mac Mahon, in La Gilda del Mac Mahon, in Opere. 19431961, cit., pp.504-505)
Ambivalenza e deformazione
La rappresentazione di Testori s’impernia però anche su una programmatica sfida
all’ambivalenza del mondo: il che implica un progetto di stile, cioè di mescolanza di
toni. Che è poi anche un programma in qualche modo di genere, nella misura in cui
prevede un sistematico, flagrante e per vari aspetti perfino esibito cozzare di tragico
e comico. Mi si potrebbe obbiettare che Testori è autore prevalentemente tragico: è
vero! Ma d’altro canto è anche altrettanto vero che pochi scrittori hanno saputo come
lui rappresentare impavidamente il basso corporeo. Tanto per intenderci, è per esempio pressoché impossibile trovare in altri autori italiani, perlomeno a quell’altezza
cronologica, la rappresentazione analitica di un rutto, come accade in Sotto la pergola
(in Il ponte della Ghisolfa, in Opere. 1943-1961, cit., p. 201): si tratta davvero di una
rarità assoluta! Così come, esemplificando ancora, per chiarezza, proprio da questi
casi clamorosamente “comici”, sul confine dello sconcio e del goliardico, numerose
sono le rappresentazioni di “una scorengia” (per esempio in I delitti del Carisna, in La
Gilda del Mac Mahon, cit., pp. 673 e 674). La provocazione, evidentissima, sta proprio nel far cozzare situazioni molto serie, anzi normalmente tragiche, con il comico:
92
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
95
GIANNI CANOVA
La Milano nera di Scerbanenco(*)
Ci spostiamo di qualche anno rispetto allo scenario che tracciava poco fa Gianni
Turchetta con Testori ed i segreti di Milano, io parlerò di una Milano a trasformazioni
già compiute: siamo sulla fine degli anni ‘60 e questo strano scrittore, Scerbanenco,
mette in scena e rappresenta nei suoi libri una realtà anomala, rispettando, mi pare di
poter dire, quello che è lo scenario complessivo della letteratura italiana di quegli anni
e forse della letteratura italiana tout court.
Mi piace partire proprio dal sottolineare una anomalia nello scrittore e nei libri che
proverò molto rapidamente a ricordare e a sottoporre alla vostra attenzione.
Scerbanenco innanzitutto non è uno scrittore italiano, se non altro perché l’italiano
non è la sua lingua madre, nasce a Kiev da madre italiana e padre ucraino e arriva poi
in Italia ancora relativamente giovane, l’italiano rimane una lingua appresa e questo è
già un dato da tenere presente.
La seconda anomalia è che non solo non ha mai goduto di fortuna critica o di interesse specifico in ambito accademico, ma che forse è stato sprezzantemente disprezzato con una battuta ricorrente: “Scerbanenco non è uno scrittore è una macchina per
fabbricare storie”, una catena di montaggio per fabbricare storie, a me l’idea dello
scrittore come macchina per fabbricare storie piace molto. Scerbanenco ha scritto
tra i 100 e 200 romanzi, non ancora pubblicati ed ordinati in modo filologico, migliaia di racconti, e poi novelle, romanzetti a puntate, rubriche per cuori infranti su
settimanali femminili, migliaia di pagine, una produzione sterminata. Io trovo essere
una questione importante questa della prolificità, mi pare che Scerbanenco sia uno
dei primi se non l’unico scrittore che già nell’Italia degli anni ‘60 pone se stesso al
servizio dell’industria culturale, della cultura di massa; non sarà un grande scrittore
probabilmente, ma non è questo che conta, il suo lavoro intellettuale è in sintonia con
quelle che sono le esigenze di una modernizzazione del paese, che passa anche per un
aumento di consumi culturali.
“Scrive male” dicevano e dicono tuttora alcuni critici accusandolo di trasandatezza
e sciatteria, a me piace sottolineare soprattutto la velocità di esecuzione di Scerbanenco, il suo costante riferirsi ai modi del parlato come modello non solo lessicale ma
anche sintattico della sua scrittura, una scrittura che assume in se le pause, l’andamento spezzato e paratattico del parlato, come se Scerbanenco volesse o cercasse portare
103
sulla pagina il disordine e la frantumazione tipiche del parlato, ma che sono segno
e simbolo linguistico di un qualcosa che anche nel sociale presenta caratteristiche
analoghe.
Un’altra anomalia: Scerbanenco è uno scrittore che si confronta senza nessun sussiego e senza nessun timore con i generi, è uno scrittore che lavora dentro alla definizione di genere ed accetta i generi come scenario di riferimento per la produzione
letteraria e per il consumo, quindi attraversa i grandi generi della letteratura di massa:
il romanzo rosa, per esempio, la spy story, il romanzo giallo o il thriller, o forse ancora
meglio il noir. E’ uno scrittore che affronta i generi senza il tentativo di sottoporli ad
una operazione metacritica, parodistica o paralinguistica; produce dentro i generi, altro elemento non così comune nella narrativa italiana degli anni ‘60. Accettare i generi
significa ancora una volta accettare la dimensione dell’industria culturale, che trova
nel genere una guida al consumo.
Un’ultima anomalia: la dimensione seriale, cioè non solo la scelta di lavorare dentro i generi, ma anche di lavorare dentro la serialità. I romanzi su cui concentrerò la
mia attenzione sono tutti usciti nella seconda metà degli anni ‘60 e sono romanzi seriali, che in qualche modo pongono Scerbanenco di fronte ad altri autori di genere che
hanno costruito personaggi e modelli seriali, in particolare nella letteratura gialla.
Scerbanenco ha sempre lavorato dentro i generi e già negli anni ‘40 aveva realizzato
alcuni gialli, poco riusciti, molto meno riusciti di quelli di cui parleremo oggi, già
però romanzi seriali, ambientati a Boston con un detective iperletterario, desunto da
letture e da romanzi della tradizione anglo-americana.
La grande serie di Scerbanenco è quella dei romanzi che hanno per protagonista
Duca Lamberti, un ex medico radiato dall’ordine che fa il detective privato nella
Milano della seconda metà degli anni ‘60 ed è protagonista di quattro romanzi che
escono a distanza molto ravvicinata. Il primo è Venere privata del 1966, a cui seguono
Traditori di tutti sempre del ‘66, I ragazzi del massacro del ‘68 e I milanesi ammazzano al sabato del ‘69.
Scerbanenco muore nel ‘69, proprio quando attraverso questa serie di romanzi polizieschi con protagonista Duca Lamberti stava raggiungendo il successo di pubblico
in Italia e di critica all’estero; nel ‘69 il suo romanzo Traditore di tutti vince a Parigi
il “Gran prix della letterature policiere”: era la prima volta che un premio letterario
così importante veniva dato ad uno scrittore italiano.
Purtroppo la morte prematura, muore relativamente giovane a 59 anni, gli impedisce di andare avanti in una serie che avrebbe potuto diventare una delle grandi serie
poliziesche della letteratura mondiale. Lascia altri racconti brevi, straordinari e folgoranti, raccolti in volumi con il nome Milano calibro 9 oppure I cento delitti: sono
pagine straordinarie, spesso racconti brevissimi di una pagina o due.
Ecco un’altra anomalia: Scerbanenco è in particolare sintonia con quello che possiamo definire l’immaginario della modernità o della contemporaneità.
Io insegno cinema e, quando nei laboratori adattiamo la pagina letteraria per raccontare per immagini, uno dei testi che usiamo maggiormente è proprio quello di
Scerbanenco perché ogni pagina è l’invenzione di un mondo, di un personaggio, di
una storia sempre molto visiva, sempre senti di vederla, ha una visività fortissima
come pochi altri scrittori sono riusciti ad avere; il testo si presta molto da un lato a una
intertestualità, quindi a un adattamento ad altri linguaggi ad altri mezzi di comunicazione, dall’altro è dentro all’immaginario, un immaginario che non è solo letterario
104
ma è mas-mediatico, come non poteva non essere in quella strana modernità che caratterizza.
Veniamo ad analizzare più da vicino, anche se molto sinteticamente, i quattro romanzi.
Un pregio prima di tutto: sono quattro storie che raccontano Milano, assumendo la
modernità di Milano come luogo del conflitto. Pochi altri scrittori hanno saputo cogliere la durezza delle contraddizioni e dei conflitti che il processo di modernizzazione
rapidissimo, e per certi versi violento, aveva colpito l’Italia nei primi anni ‘60, gli anni
del boom economico. Il conflitto diventa la chiave decisiva per leggere quella Milano,
quell’Italia, quel paese. Pochi altri scrittori lo sanno fare con la forza, se non altro
con la lungimiranza sociologica, con cui lo fa Scerbanenco. Basta pensare al modo
con cui Scerbanenco tratta gli oggetti: i quattro romanzi che hanno come protagonista
Duca Lamberti sono strapieni di oggetti, ci sono tutti gli oggetti simbolo del nuove
feticismo delle merci che si è affermato con il boom economico e che nella seconda
metà degli anni ‘60 costituiscono lo scenario della quotidianità. In apertura di pagina
trovi in Scerbanenco una specie di bric-à- brac oggettual-letterario che non dimentica
nulla: c’è la macchina da cucire comprata a rate, i biscotti omogenizzati, la coca-cola,
i fazzoletti kleenex, gli scooter, i flipper, i joke-box, i mangiadischi portatili sempre
accesi, emblemi di una società che ha cominciato, se non a praticare, a sognare il benessere. Questi oggetti non svolgono più la funzione inquietante di cui erano investiti
nella tradizione poliziesca americana classica, non sono più depositari di impronte, di
segni misteriosi, che consentivano a un detective di impostare una investigazione, ma
sono banali come i delitti commessi per il loro possesso, sullo sfondo di un universo
sociale che è dominato dal valore assoluto del valore di scambio. Questi oggetti non
hanno neanche tanto un valore d’uso, sono significativamente spesso usati come armi
del delitto.
Quello che era l’oggetto feticcio della letteratura poliziesca tradizionale, la pistola,
il revolver non c’è nei romanzi di Scerbanenco, dove non si usano mai le armi tradizionali per uccidere, per uccidere si usa di tutto. C’è una frase molto illuminante che
dice “un strumento in sé non è né buono né cattivo, dipende dall’uso, con bocciolo di
rosa si può soffocare una persona se glielo si spinge abbastanza nella gola.”
Nei romanzi di Scerbanenco si fa questo: si uccide con ciò che si trova a portata di
mano.
Ho studiato un catalogo delle armi di Scerbanenco e sono davvero gli arnesi quotidiani: cacciaviti, forbici, ombrelli, ma anche calze di nailon, lamette da barba, attrezzi
di macelleria .
Si uccide con i medesimi oggetti per cui ci si uccide. Si uccidi in base a motivazioni immediate, istintive, brutali, per un possesso di una donna, per la conquista di un
carico di droga, per vendetta, per disperazione…
La Milano di Scerbanenco, e non potrebbe essere altra città, è atroce perché non c’è
più nulla di etico, neanche nel male, la stessa criminalità è una criminalità ipocrita,
meschina, banale. I luoghi non sono più le banche, le bische clandestine, i teatrini
scalcinati che erano diventati familiari grazie ai thrillers americani, ma sono luoghi
modesti e mediocri, come macellerie, bar, squallide aule di scuole serali; gli stessi
criminali sono poco più che relitti umani, uomini della folla, marginali ed emarginati,
incapaci di grandezza persino nel crimine e nel delitto in un mondo in cui l’innocenza
105
e la colpa cessano di essere categorie antitetiche per diventare contigue, si sovrappongono, si confondono e la vittima riesce a volte a punire il carnefice solo facendosi
carnefice a sua volta.
Tutto questo accade a Milano, non a caso è significativo che ci sia questa dimensione urbana anzi direi metropolitana. Scerbanenco è il primo scrittore in assoluto, almeno nella tradizione del genere poliziesco, ad abbandonare la tradizione provinciale
agreste, bucolica; i gialli italiani degli anni ‘30 preferivano la campagna, scimmiottavano Agatha Christie, vagolavano su paesaggi di una natura inesistente dal punto di
vista sociale o sociologico. Scerbanenco invece arriva in città e arriva a Milano.
Io non sono d’accordo con le tesi di molti studiosi del romanzo poliziesco che
affermano che il romanzo poliziesco sarebbe l’analogo del coro della tragedia greca
o l’analogo della selva oscura e quindi il detective sarebbe l’equivalente di colui che
si aggira; non sono d’accordo perché credo che la città-metropoli abbia un elemento
fondamentale di scarto rispetto ai modelli o del coro della tragedia o della selva oscura, la città è il luogo della massa, del conflitto e Scerbanenco di questo si fa carico, la
città è protagonista, non c è il coro, Scerbanenco lo dichiara, se si vuole, in modo un
po’ rozzo, ma chiaro.
Sta parlando Duca Lamberti, l’ex-medico radiato che per arrotondare lo stipendio
fa il detective:
c’è qualcuno che non ha ancora capito che Milano è una grande città, non
hanno ancora capito il cambio di dimensioni, qualcuno continua ancora a
parlare di Milano come se finisse a porta Venezia, o se la gente non facesse
altro che mangiare panettoni, se uno dice Marsiglia, Chicago, Parigi, quelle
si che sono metropoli con tanti delinquenti dentro, ma Milano no… A quel
che è stupido non dà la sensazione della grande città, cercano ancora quel che
chiamano il colore locale, la brasera, la pesa e magari il gambe de lègn, si dimenticano che è una città vicina ai due milioni di abitanti, ha un tono internazionale e non locale, e in una grande città come Milano arrivano sporcaccioni
da tute le parti del mondo, alcolizzati, drogati o semplicemente disperati in
cerca di soldi che si fanno affittare una rivoltella rubano una macchina, saltano su un bancone di una banca gridando stendetevi tutti per terra come hanno
sentito dire che si deve fare. Ci sono tanti vantaggi nell’ingrandimento delle
città, ma ci sono cambiamenti che fanno pensare ed è ora di pensarci.” Poi
conclude “è qui a Milano che ci sono i soldi ed è qui che vengono a prenderli
con ogni mezzo, anche con il mitra.
Questa è la Milano di Scerbanenco: una spietatezza, una ferocia, una diagnosi lucidissima della metropoli come luogo dei conflitti di classe portati dalla modernità.
Dentro i romanzi su questa città, dove ci sono i soldi e tutti vengono a prenderli anche
col mitra, c’è poi una città che si porta dietro la sua nobile storia e di tanto in tanto le
pagine dei romanzi si aprono in squarci dove viene fuori un’altra Milano, ne leggo
una da I ragazzi del massacro:
entrarono nel portone odoroso di cantina, erano tutte case vecchie, avevano ancora pochi anni di vita, cadevano quasi da sole nessuno pensava certo
a migliorarle con la sorte segnata sul piano regolatore, era una vecchia e po106
vera Milano, ma genuina, c’erano perfino due “trani”, autentiche osterie che
non avevano fatto nulla per tramutarsi in “ bar”, avevano soltanto cambiato i
tappeti verdi sui tavoli, con tavoli dal ripiano di plastica sui quali gli ubriachi
si addormentavano ancora, come ai tempi del Porta, con la testa appoggiata
sul banco, e c’erano le prostitute anziane che venivano anche loro a bere un
bicchiere per rilassarsi, dopo un lungo battere per le vicine vie Fabio Filzi o
Vittor Pisani, e c’era la fioraia stanca e gentile, dolcemente claudicante, che
sotto un ombrellone davanti alla chiesa di San Gioachino vendeva fiori con lo
stesso stile dell’epoca della scapigliatura, di Praga, di Rovani, di Boito La fila
di auto che parcheggiavano per tutta la lunghezza della strada non toglieva
nulla a questa genuinità: le intruse erano loro.
C’è questa Milano che si porta dietro il ricordo fisico, materico, di un passato già
diventato letteratura, ma poi c’è l’intrusione, ci sono le macchine, c’è la modernità.
Scerbanenco racconta, come pochi altri, questa città, città impietosa, allucinata. Leggo qualche citazione: “Milano è un intrigo folle di binari, è un groviglio di treni che
corrono epiletticamente, è un traffico caotico di taxi neurotici e di mastodontici autocarri...” e ancora “è una città piena di aiuole senza erba, di cadaveri, luci di lampioni,
lunghi vialoni quasi desertici violacei alla luce delle lampade fluorescenti…”, “è una
città che emana effluvi di sporcizia e tuttavia è una città che pulsa”, dice in uno dei
suoi romanzi, “non ci sono provinciali limiti di orario e conformistiche divisioni tra
giorno e notte”.
Siamo nel ‘66. È una città che vive uscendo dai propri confini e significativamente
il crimine non avviene quasi mai nel centro di Milano, la città genera il delitto, lo stimola, lo provoca, lo fa, gli dà una motivazione, una causa, ma poi i delitti avvengono
fuori in periferia o nell’hinterland, che vengono visti come grandi discarichi di rifiuti
etico-criminali. Il delitto non si consuma in centro, nei salotti buoni della borghesia,
borghesia che nei romanzi di Scerbanenco non c’è, si scarica tutto in periferia, periferia descritta da Scerbanenco in modo straordinario, ci sono pagine bellissime su posti
che noi ora consideriamo Milano città, per esempio pagine sulla zona di Lambrate,
di viale Padova, di viale Palmanova, dove la città finiva e cominciava il nulla, c’è un
condominio vicino a Lambrate ancora esistente e ormai in piena città che Scerbanenco
chiama il condominio Ulisse, perché è quasi il faro ultimo.
In questa Milano ci sono tre figure che ossessivamente si ripetono ed impregnano,
dal punto di vista narrativo, le storie di Scerbanenco: il massacro, la vendetta e il tradimento, in particolare il tradimento, non a caso il più famoso dei romanzi si intitola
Il traditore di tutti. Scerbanenco lo giustifica così:
tradivano tutti, la madre sul letto di morte, la figlia nella clinica- parto,
vendevano il marito la moglie, l’amico l’amante, la sorella il fratello, ammazzavano tutti per mille lire e ammazzavano chiunque per un gelato.
C’è una spietatezza atroce, ma che pone questo tipo di rappresentazione in sintonia con quanto veniva prodotto qualche anno prima dalla grande tradizione del noir
americano, la grande tradizione del romanzo poliziesco realista. La mia valutazione
è che Scerbanenco sappia adeguare il delitto romanzesco a quelle che sono le mutate
107
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
108
REMO CESERANI
Camminando per Milano
Ci sono tanti modi possibili di camminare per Milano, pensare al rapporto fra la
città e la letteratura, avviare una conversazione su questo argomento con gli amici
(con alcuni, come Tiziano Rossi, presente a questo convegno, mi piacerebbe molto
di poterlo fare). Si può cercare negli scrittori, da Bonvensin de la Riva a Stendhal a
Manzoni a Porta e via via sino a Fortini e Loi, testimonianze sul loro rapporto con la
città, estrarre dalle loro opere delle “scene milanesi” (lo stesso si potrebbe fare con i
pittori, cominciando da certi scorci che si vedono nelle pale d’altare della scuola quattrocentesca lombarda via via sino a Boccioni): molti studiosi l’hanno fatto e parecchi
lo stanno facendo in questo convegno. Oppure si possono cercare, camminando per
Milano, le testimonianze di vita degli scrittori che hanno abitato in questa città, che
ci hanno vissuto a lungo, o che l’hanno visitata. C’è, per far questo, da affrontare una
difficoltà: Milano è una città che, molto più di altre, ha cambiato continuamente il
suo volto, in certi casi lo stesso suo impianto urbanistico, cancellando le tracce del
tempo o vedendosele cancellate da guerre e bombardamenti; bisogna lavorare con
pazienza, ricostruire angoli e ambienti che sono nascosti dietro le nuove strutture,
lavorare di immaginazione. Bisogna farlo, per esempio, per immaginare la casetta di
Petrarca, vicino a Sant’Ambrogio, e cioè quasi al margine della Milano di allora, che
davanti guardava verso la chiesa e dietro sulle mura della città, o per immaginare il
poeta che faceva esperimento di giardinaggio, coltivando spinaci, rape e finocchi nel
vicino orto di Sant’Ambrogio, oppure per seguirlo mentre si muoveva su barcone o
a cavallo, visitava San Colombano, la certosa di Garegnano, il castello visconteo di
Pagazzano sull’Adda, o si trasferiva, come avvenne negli ultimi due degli otto anni
trascorsi nella città viscontea, in una nuova casa, vicino al monastero benedettino di
San Simpliciano, poco fuori dalle mura, oltre la porta di Como. Ma di fantasia bisogna
lavorare anche per trovare le tracce della permanenza a Milano di personaggi molto
più vicini a noi nel tempo, come per esempio Stendhal. Sì certo, i palchi della Scala
(frequentati da lui assiduamente) sono più o meno quelli che erano, anche dopo il
recente restauro; a palazzo Sormani c’è la sua biblioteca portata qui da Civitavecchia;
e si può cercare a porta Venezia il palazzo Bovara, sua residenza nel 1800, quando lì
si trovava l’ambasciata di Francia, o ritrovare qua e là il ricordo di altre sue dimore
milanesi, o dei salotti frequentati. Lo stesso per Porta, per il quale, se non si riesce a
110
far rivivere il Verziere, si possono trovare altri luoghi suoi, o andare a visitare i manoscritti nell’archivio storico al Castello. E così per altri: i navigli di Vittorini, la via
Bigli di Montale, i teatri di Strehler e Fo.
Ma ho pensato, per l’occasione di oggi, di scegliere un’angolatura diversa: cercherò
di analizzare il rapporto fra Milano e la letteratura e il modo in cui Milano concepisce
la letteratura e la rappresenta, e celebra, ai suoi cittadini, attraverso i nomi dati alle
strade della città agli scrittori italiani e stranieri. Lo stradario di una città si può definire una piccola enciclopedia (della storia, delle arti, della letteratura, delle grandi
scoperte scientifiche. Per quanto riguarda la letteratura, le commissioni municipali,
quando decidono di dedicare una strada a uno scrittore funzionano come un’istituzione canonizzante, al pari di altre simili, addette alla costituzione delle liste degli
scrittori da ricordare e di cui celebrare la memoria (a questo modo, per esempio, funzionano la scuola, altra grande istituzione canonizzante con i suoi programmi oppure
i manuali e le antologie). Queste istituzioni canonizzanti obbediscono ad alcune leggi
generali: 1) tengono conto dei valori consacrati, sui quali si è formato un generale
consenso; 2) sono tendenzialmente conservatrici: prudenti nell’inserire nuovi nomi,
non arrivano quasi mai a espellerne, semmai espellono quelli che rinviano a situazioni
particolari o alla storia locale (via degli orti, via dei mercanti, ecc.); 3) si celano dietro
un anonimato istituzionale, limitandosi a ricevere sollecitazioni da associazioni di
studio, gruppi di seguaci dello scrittore scomparso, lettori appassionati; (4) devono
tenere conto di alcune esigenze pratiche: evitare, per esempio, i cognomi uguali, che
potrebbero confondere i postini, evitare nomi stranieri troppo ardui da riconoscere e
memorizzare, e così via.
Certo questo mio esame dello stradario della città di Milano, per stabilire che immagine della letteratura esso consegni ai cittadini, ha dei limiti: non ho, per esempio,
gli strumenti per ricostruirne le successive fasi nel tempo e quindi la stratificazione
degli stradari che si sono succeduti negli anni e che hanno imposto immagini diverse
della nostra tradizione letteraria (quello risorgimentale, quello fascista, quello democratico-resistenziale, ecc.). Mi limito, qui, ad analizzare la toponomastica attuale,
quale risulta dai documenti del comune1 e dagli stradari della Guida rossa del Touring
e di TuttoCittà della SEAT.
Prima, tuttavia, di fare un breve elenco delle più sorprendenti assenze (o presenze)
degli scrittori e dei letterati nella toponomastica milanese e di dare un giudizio sui criteri e sulle tendenze che sembrano aver guidato le commissioni municipali di Milano
(e di conseguenze sull’immagine della tradizione letteraria che li ha ispirati), devo
dire che mi ha molto commosso scoprire che a Milano è stato trovato un angolino per
intestare una strada al mio maestro, Mario Fubini, grande critico e professore di letteratura italiana in Statale negli anni Cinquanta e Sessanta: la via si trova a Greco, non
molto lontano dalla via Umberto Saba, il che gli avrebbe fatto molto piacere (non mi
pare che ciò sia stato fatto a Torino, la sua città, o a Pisa, dove ha concluso la carriera
come professore alla Scuola Normale).
Tra le assenze, non colpiscono particolarmente quelle degli scrittori del Medioevo,
che non sono molto numerose: mancano Cecco Angiolieri, Guittone D’Arezzo, Brunetto Latini, Salimbene de Adam. Più rilevanti le assenze rinascimentali (alcune forse
dovute a un certo severo moralismo milanese: mancano Donato Acciaiuoli, Bernardo
Accolti, Pietro Aretino, Baldassarre Castiglione (forse respinto da due vie Castiglioni), Francesco Colonna, Agnolo Firenzuola, Teofilo Folengo (assenza clamorosa!),
111
Battista Guarini, Niccolò e Ludovico Martelli, Cristoforo Landino, Nicolò da Correggio (ma ci sono i Correggio pittori), Albertino Mussato, Francesco Patrizi, G. C.
Scaligero, Vittorino da Feltre. Per Sei e Settecento, e anche per l’Ottocento, non ci
sono lacune gravissime: mancano Giuseppe Acerbi (ma c’è un altro Acerbi), Claudio
Achillini, Daniello Bartoli, Saverio Bettinelli (ma ci sono altri Bettinelli), Camillo
Boito (ma c’è il fratello Arrigo), Edoardo Calandra, Ranieri Calzabigi, Giovanni Camerana, Alberto Cantoni (ma ci sono altri Cantoni), Lorenzo Da Ponte (ed è un’altra
assenza clamorosa!), Luigi Da Porto, Federico Della Valle, Giovanni Faldella, Scipione Maffei (ma ci sono già due altri Maffei), Lorenzo Magalotti, Giovan Battista
Marino (assenza quasi incredibile, anche se ci sono altri Marino), Pier Jacopo Martello, Filippo Mazzei, Caterina Percoto, Mario Pratesi, Paolo Rolli, Alessandro Verri
(mentre naturalmente c’è Pietro), Remigio Zena, Apostolo Zeno. Con il Novecento si
va ovviamente su un terreno molto più difficile e incerto. Possono colpire le assenze
di Sibilla Aleramo, Giorgio Bassani, Italo Calvino (ma c’è il Calvino riformatore),
Achille Campanile, Carlo Cassola, Beppe Fenoglio (assenza pesante, come quella di
Calvino), Primo Levi (assenza molto grave, anche se in parte giustificata dalla presenza di Carlo Levi), Curzio Malaparte, Biagio Marin, Carlo Michaelstaedter (nome
troppo difficile?), Elsa Morante, Alberto Moravia, Angelo Silvio Novaro (ma c’è Mario Novaro), Aldo Palazzeschi, Pierpaolo Pasolini, Vasco Pratolini, Alberto Savinio,
Leonardo Sciascia, Giovanni Testori (che non compare neppure dalle parti del Ponte
della Ghisolfa), Federico Tozzi (nonostante ormai faccia parte del canone ristretto dei
grandi autori della modernità). Dovute forse alla loro specifica identità meridionale
sono probabilmente le assenze di Giambattista Basile, Benedetto Cariteo, Eduardo De
Filippo, Jacopo De Jennaro, Salvatore Di Giacomo, Michele Marullo, Isabella Morra,
Iacopo Sannazzaro, Edoarso Scarfoglio. Alcune presenze sono fin troppo sottolineate:
sarà dovuta al premio Nobel la presenza di una via Deledda non solo a Milano ma
anche nei comuni di Segrate e Vimodrone. In altri casi la presenza c’è, ma relegata
molto lontano dal centro, come avviene a esempio per Giuseppe Gioacchino Belli,
Emilio Cecchi, Benedetto Croce, Guido Gozzano, Eugenio Montale, il quale ha una
via a lui dedicata a Lampugnano, vicino al parco di Trenno; Salvatore Quasimodo
invece è riuscito a infilarsi vicino a piazza Vetra; Ippolito Nievo è finito vicino alla
Fiera, ma in compenso è presente anche a Sesto e Settimo Milanese; Elio Vittorini non
è accanto ai suoi navigli ma al parco Lambro; Neera c’è, ma anche lei verso i navigli,
accanto ad Anton Giulio Barilli e (curiosamente) Francesco De Sanctis. C’è una via
Spinazzola nell’estrema periferia occidentale, a Muggiano, ma immagino che essa sia
dedicata al paese della provincia barese e non al nostro collega professore di italiano
in Statale. Come avviene in altre città, c’è poi il fenomeno di alcuni quartieri in cui si
addensano improvvisamente i nomi di scrittori e letterati (come in altri casi i musicisti, i pittori, gli scienziati, ecc.). A Quarto Oggiaro, per esempio, c’è una fittissima rete
di strade dedicate ad attori di teatro e non molto lontano tutta una piccola enciclopedia
di letterati: Capuana, De Roberto, Graf, Trilussa, Buzzati, ecc. e fenomeni analoghi si
trovano in altre parti della città.
Un fatto curioso, che mi sembra avvenga molto di rado, è che per Alessandro Manzoni non c’è solo la centralissima via a lui dedicata, ma ci sono anche una via intitolata al romanzo: largo Promessi Sposi (un largo privato, lungo il Naviglio Pavese)
e addirittura alcune vie intitolate ai suoi personaggi: Via Don Rodrigo, Via Renzo e
Lucia, via Donna Prassede, via dell’Innominato, via Fra Cristoforo, tutte nella stessa
112
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
113
TIZIANO ROSSI
Le case di Milano
Secondo uno dei filoni del pensiero estetico, che ormai è tradizione, la poesia non
è tanto un conoscere quanto un fare, non tanto una interpretazione della realtà quanto
la costruzione di una realtà o di più realtà inedite, si è addirittura parlato di universo
verbale autosufficiente, divaricato e autonomo rispetto al mondo. Se questo è vero, ne
consegue che la poesia ha scarsa capacità conoscitiva e può essere solo oggetto di indagine e di analisi, non soggetto, in quanto quello che dice risulta ben poco affidabile.
Allora il contributo di un poeta a un dibattito come questo, che è un dibattito critico, si
rivela scarso. Io scrivo versi, non sono un critico e non so se la mia poesia possa fornire lumi sul tema: penso che quanto ho scritto non rispecchi credibilmente la cosiddetta
realtà, credo tuttavia che tra i testi poetici e ciò che è fuori del testo qualche relazione
- nel fondo - esista. Cercherò dunque di fare luce su queste relazioni, accompagnando
le poesie che leggerò con un minimo di presentazione e commento.
La mia scelta non si affida a criteri di valore (non sono un buon giudice), ma a un
criterio di aderenza al tema “le case di Milano”. I testi che leggerò sono contenuti
in questo libro, che raccoglie appunto tutte le mie poesie e che è stato pubblicato da
Garzanti l’anno scorso. Comincerò con una breve premessa autobiografica: c’è una
specie di archetipo infantile nel mio immaginario, una sorta di piccola ossessione
fissatasi nei primi anni di vita, che ha nutrito molte mie composizioni: è l’immagine
o il sentimento dell’assedio. Da bambino ho giocato molto alla guerra come tutti i
bambini, ma anche per motivi generazionali, perché allora la guerra c’era davvero: in
quei giochi mi piaceva fare la parte del difensore e non dell’assalitore, il mio eroe era
Ettore e non Achille. Ricordo certe letture appassionate dell’Iliade in una edizione per
ragazzi nella celebre collana della Scala d’oro della Utet (parlo degli anni Quaranta):
di lì credo sia venuta la mia propensione a disegnare personaggi impegnati - in alleanza - a contrastare un nemico assediante, un nemico da non intendersi certo in chiave
sociologica, ma esistenziale, o forse metafisica (il nemico può esser la morte, il nulla,
la Natura cieca, il male, il Tempo che tutto cancella, la dimenticanza, ecc; nel che si
riaffaccia la Ginestra leopardiana).
In un simile contesto Milano assume un ruolo ambivalente: da un lato le sue case,
le sue vie, le piazze e coloro che le abitano, le amicizie e i nuclei familiari diventano
protagonisti di questa resistenza, Milano si oppone cioè a un avversario che sta fuori
115
di lei. D’altro lato è proprio Milano il nemico: città ostica, difficile - abbiamo visto il
quadro emerso dalle pagine di Scerbanenco - città disagevole, Milano sa soffocare.
A questo avversario bisogna allora opporre le nostre modeste forze. Milano si carica
probabilmente anche di altri significati, più o meno metaforici, ma non voglio inoltrarmi qui in un terreno che non ha confini. Al termine “case”, che fa parte del titolo
del mio intervento, ho dato comunque un’accezione allargata: la “casa” può essere
l’appartamento in cui si vive, il caseggiato, il condominio, ma anche l’intero quartiere,
la città stessa intesa come spazio in cui si dimora, luogo in cui le persone si incontrano, si respingono, cooperano, si osteggiano, si amano. Se l’argomento può essere
inteso in senso lato, comincerò la mia chiacchierata con un omaggio a quella presenza
importante che è l’insieme di case, cioè il rione cittadino: bello o brutto che sia, è lo
spazio che ci contiene e ci abbraccia. Leggerò la poesia PAVIMENTO, del 1976, che
prospetta un rapporto cordiale, quasi domestico, tra i suoi abitatori: è una Milano
come forse era molto tempo fa, o come io immaginavo che fosse.
PAVIMENTO
Ancora -così- nutrimento di città.
Come soffiando si dia da fare
il viale Gian Galeazzo
e intanto cincischi paziente
la piazza di Porta Ludovica
e come la via Col di Lana
più povera in là si travagli,
dove tremula quel tram con il numero la gente
(nei luoghi -difatti- le persone, il droghiere
Ottorino Ferrario persevera,
Sabrina attenta s’affaccia): il giorno
ripieno in ogni nicchia,
la scatola fitta del mondo!
E tu gomitolo che sei e di dentro luccichi
ma con la bocca non dici volendo dire
fra rigenerarsi di pellicine e ingoiate salive!
Tutto come un grand’uovo, e mai niente si perde
fuori dall’asfalto sostenente
con la sua tiepida superficie:
ancora -figure- levarsi chiamare
avanti scarpinando moltiplicarsi, qualche
ferita si slabbra ma gloriosa
in un sangue verso nuova sussistenza!
Anche se non è terra salvifica
(e perché mai questo presente riscattare),
o pavimento dell’anima nostra!
Leggerò ancora una poesia dedicata a un quartiere, ma diverso, ossia a Porta Ve116
nezia, dove io sono nato e vissuto prima che i bombardamenti del ’42 costringessero
la mia famiglia a lasciare la città. Il filo conduttore della breve poesia è una quête, la
ricerca di una persona amata che lì vive e che io inseguo. La poesia appartiene a una
raccolta dell’82 e si intitola RIONE.
RIONE
Sopra il bagnato magari scivolando
ma con accelerato respiro, io
verrò dunque al più denso groviglio
della sua via
dove nasceva e poi tossiva (il severo
balcone sovrastando),
e fino al continente della sua cartoleria
nell’aria dagli anni infoltita:
per meglio internarmi in Maria
a lei un po’ sommarmi.
E allora viaggiare nel grandioso
rione di Porta Venezia (la sua forza)
per invisibile spuma e mare:
giù a ritroso nel tempo di lei
ancora attraverso una scorza…
Qui il cerchio si stringe un po’ e io metto in primo piano un casamento con i suoi
inquilini e la vita di tutti i giorni: è una poesia che fa pensare un po’ a Hitchcock e alla
sua Finestra sul cortile, ma volevo evocare qualcosa di non visibile e tuttavia capace
di collegare le figure del “teatrino”. La poesia si intitola TERRESTRI e fu pubblicata
nel ’98.
TERRESTRI
Come barbagliano le
aperte finestre del luglio!
da dove biancheggiano un poco
quei corpi non separati
o con gesti maestosi si buttano briciole, e
tre bambini bolìnano in un letto
e il vecchio ha intrecciato le dita, frulla i pollici,
o ci si inchina sopra i (ma sfolgoranti si sprigionano
anche le loro domestiche contese)
sui fornelli celesti di cucina o si combacia
coi tanti visi televisivi, e qualcheduno
- tappato strazio - va alla volta delle
meraviglie che i desti non vedranno.
117
O tempo favorevole alla maturazione delle uova!
E come tutti li ha fasciati e cova
l’afa materna dei marciapiedi! Sono i
variopinti terrestri, transitanti
adesso e nell’ora che li sfarinerà.
E muta se ne resti la questione
dei significati reconditi, più veri; e invece
si dia da mangiare alla ragazza, è tutta ossa.
Qui lo sguardo è ancora fisso sull’interno di una abitazione. In questo componimento la casa ha un ruolo rasserenante, e il tempo è un Natale molto lontano, il Natale
del 1942, al quale si sovrappone con naturalezza quello presente: la poesia disegna la
regressione verso un’esperienza infantile, ma straordinaria e incancellabile. La poesia
si intitola CORNICE e fu pubblicata nell’88.
CORNICE
Venienti da soli per l’àndito semioscuro
col loro bisbiglio “siam qui!” da ogni canto
ecco i nostri cari pettoruti pulcini
cioè insomma i bambini, cioè ancora noi,
che sempre ricredono nella
magnifica moltiplicazione dei giocattoli
non dimenticando l’astuccio coi pennini.
La cuccia della mente così densa e questa
cornice della casa così adatta
con le sue tenere scempiaggini, la notte
e lo scomparire adagìno di ciascuno
(ah, la consumante febbre di risalire
quel corridoio di muffa e chiarori!).
Io dirò i loro nomi e Sandrina sopra tutti.
All’opposto ecco un quadro meno idillico: si tratta di una poesia, pubblicata nel
‘68, che vorrebbe far luce sulla casa che divide, sulla non-comunanza e la non-comunicazione tra gli inquilini, ma insieme esprime il tentativo di oltrepassare questo
steccato.
CASEGGIATO
Grandissima casa, nostre dolci dimore…
ma per troppe ragioni oggettive qui potenti
non si sa nulla, a ruminare, di nessuno.
Forse mediante, però, un’interposta persona
118
(a ciò pregata, pagata con riserbo) alla lontana
appurare si può i lì reclusi sentimenti, che ne so;
e magari da più presso e da solo, fendendo
sulla punta dei piedi il pianerottolo, afferrare
almeno l’ascesa delle voci, un irrompere d’anime,
un confuso inviluppo che significa;
e in più: degli inquilini tuoi vicini, che diresti
che son così e cosà - le facce trite -, invece
le tante serbate loro complicazioni
(ma sperare che questo sia vero, che questo sia vero).
Ora leggerò una poesia in cui l’abitazione si configura come una sorta di roccaforte (prima infatti ho accennato al motivo originario dell’assedio): al centro ci sono i
pensieri di un personaggio che sopporta un’esperienza difficile. Nel metaforico verso
finale si auspica che questa storia “minima” ne possa inglobare altre più serene. La
poesia si intitola MANDORLA e fu pubblicata nel 1988.
MANDORLA
In mezzo alla casa si è alzato, a immaginare
- ombra sul bordo di importante frontiera se mai nel nero resistano scintille.
Da tutte le parti pesano i dolori
contro i quattro muri,
ma pulsano davvero
quei luccicori di piazza Cairoli, sul serio
un sassofono parla con lui, gli domanda,
intanto che là i suoi bambini
sotto i morbilli continuano a cantare
che a scuola si sta bene, s’imparan tante cose.
E buffamente in un cantone della testa
gli trepida un amico buono e vecchio
sventolante soltanto liso vessillo.
E adesso ha saputo di lei, che si dice che forse
trasparendo pioverà dentro questo
grande dipinto di grazia ricevuta
per ancora una volta il carezzarsi, e dopo basta.
Che la mandorla un’altra mandorla racchiuda.
Qui mi si permetta un cambiamento di prospettiva, perché mi affaccio su una Milano violenta: da una finestra si scorgono i segni di un conflitto, e i personaggi in scena
meditano di andarsene e di lasciare la città divenuta invivibile. La poesia si intitola
appunto FINESTRA e lo sguardo viene ovviamente dall’alto.
119
La poesia fu pubblicata nel ‘93
FINESTRA
Finita la piva dei piagnucolii
e sollevati sulla punta delle scarpe casalinghe,
di qui ci si affaccia verso le sfilanti
figure innumerabili sotto la finestra,
le lucine delle auto, il ritmo
sfasato dei pedoni e i guizzi
di nuovi levati coltelli…
fino a questa carneficina - pare - fantastica:
con un primissimo piano addosso a quel
quell’uomo basso coi baffi, abito scuro,
che perde sangue dalla bocca fracassata (“non
so niente di Rolando Parmesano - ascolta davvero non c’entro, non sono stato io”).
Allora, compattati i tre fagotti, ci allacciamo
con ogni cura i bottoni del cappotto, se
questa è la pancia degli anni Novanta.
Ma non tutto - si dice - è in questa vita,
e le gambe legnose ci sospingono alla volta
del punto invisibile che flotta
alla bassezza delle nostre capacità.
Comunque ti ripeto che i ragazzi stanno bene.
È comprensibile che il discorso possa ora slittare dall’immagine dell’abitazione a
quella del nucleo familiare che vi risiede: la poesia ALDIQUA’, del ’93, configura la
famiglia un po’ come un anello forte, come il corpo della pazienza e della costanza.
ALDIQUA’
(Non ancora, non ancora dissolvenza,
e così fosse fino alla fine dei tempi!)
Guardate la neve come si corica
sopra i dominii della conformità,
sui risaputi confini:
girano in aria invisibili le lune,
procedono le formiche
nei loro traslochi,
la foce del fiume ammucchia i suoi portati.
120
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
121
RAFFAELE DE BERTI
Tra romanzo e industria culturale:
le trasposizioni cinematografiche
dei Promessi sposi
1. Premessa
Le trasposizioni cinematografiche dei Promessi sposi sono numerose nel periodo
del muto, ben cinque tra il 1908 e il 1923, per poi limitarsi a due soltanto fino al 1966
quando la televisione realizzerà in più puntate uno sceneggiato diretto da Sandro Bolchi e interpretato da Paola Pitagora (Lucia) e Nino Castelnuovo (Renzo)1. In questo
intervento ci si limiterà a indagare i rapporti fra il romanzo di Manzoni e il cinema,
soffermandosi in particolare sul caso esemplare di un film muto del 1913 realizzato
dalla casa di produzione Ambrosio di Torino con la regia di Eleuterio Rodolfi e le
cui immagini sono utilizzate sia per illustrare una nuova edizione del libro da parte
della Hoepli e sia per produrre una serie di cartoline postali. A sua volta il film, come
vedremo, ha come evidente riferimento iconografico le famose illustrazioni di Francesco Gonin volute dallo stesso Alessandro Manzoni per l’edizione a dispense uscita tra
il 1840 e il 1842. Lo scopo principale sarà di dimostrare, attraverso questo esempio,
come le riduzioni cinematografiche dei Promessi sposi siano fortemente influenzate e
determinate dalla tradizione iconografica di Gonin e come a loro volta contribuiscano
a diffonderla e a rinnovarla, immettendo le immagini dei film nel grande circuito della produzione culturale. Data la scelta di questa prospettiva d’indagine si tralascerà,
per ovvie ragioni di spazio, l’analisi comparativa fra testo letterario e filmico.
2. I promessi sposi e l’industria culturale
Nel 1913 escono quasi contemporaneamente due riduzioni cinematografiche dei
Promessi sposi edite da due case di produzione torinesi; una della Pasquali, diretta
da Ubaldo Maria Del Colle, e l’altra dell’Ambrosio per la regia di Eleuterio Rodolfi2. Non si tratta dei primi casi di riduzione cinematografica del celebre romanzo di
Manzoni: nel 1908 si registra una versione prodotta da Luca Comerio con la regia di
Mario Morais e nel 1911 è Ugo Falena per la Film d’Arte Italiana a cimentarsi con il
“monumento” della nostra letteratura nazionale. I promessi sposi rappresentano non
solo un punto di riferimento per la cultura alta, ma sono un testo diffuso fra un pubblico di massa, grazie alle riduzioni nelle più diverse forme espressive: dalla sua uscita
nella versione definitiva del 1840 fino ai giorni nostri si possono trovare riduzioni per
il teatro, per la musica lirica, per il cinema, per i fotoromanzi, per i fumetti, per la te126
levisione, ecc.. Come scrive Gianfranco Bettetini “ I 25 lettori-modello auspicati dal
Manzoni si sono così trasformati in molti milioni di consumatori, impegnati ai diversi
livelli della pluralità di accostamenti consentiti dal romanzo”.3
Per altro è lo stesso autore a contribuire in modo decisivo al destino di diffusione
del romanzo nelle forme produttive più popolari. Infatti, dopo la prima edizione del
1827 Manzoni progetta l’edizione illustrata del romanzo, intuendo il ruolo decisivo
che possono avere le immagini nel successo dei Promessi sposi presso un vasto pubblico.4 Dopo varie contrattazioni, compresa una fallita con il pittore Hayez, Manzoni
si accorda con Francesco Gonin per la realizzazione di una versione illustrata con la
nuova tecnica della xilografia. Tra il 1840 e il 1842 esce a dispense, presso gli stampatori Guglielmini e Redaelli, l’edizione curata direttamente da Manzoni e ampiamente
illustrata dalle xilografie di Gonin e in numero minimo da altri artisti come Massimo
d’Azeglio. Gonin lavora su precise indicazioni di Manzoni, che decide il soggetto
da rappresentare e la sua collocazione all’interno delle pagine del libro. Dal punto di
vista economico l’operazione, finanziata dallo stesso Manzoni, si rivela un fallimento anche per le scarse tutele sul diritto d’autore, ma rimane un punto di riferimento
fondamentale per il rapporto fra testo e immagine nelle tante edizioni illustrate dei
Promessi sposi stampate nel corso degli anni.
All’edizione illustrata da Gonin, soprattutto dopo la morte di Manzoni nel 1873,
seguono diverse ristampe con nuove illustrazioni realizzate da pittori come Giacomo
Campi nel 1895 per Hoepli o Carlo Chiostri nel 1898 per Paravia. In generale non si
aggiunge molto a un’iconografia ormai abbastanza consolidata e che si diffonde anche a livello di spettacoli per burattini, che entusiasmano un pubblico popolare con la
storia di Renzo e Lucia. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento circolano
anche numerose edizioni ridotte del romanzo realizzate da piccole case editrici, come
la Società Editoriale Milanese, che contribuiscono alla diffusione capillare presso tutti gli strati sociali dei Promessi sposi. La novità è rappresentata dal lavoro fatto dal
pittore divisionista Gaetano Previati, che con 228 vignette e 13 tavole in eliotipia
illustra l’edizione Hoepli del 1900.5 Si è in presenza di un’interpretazione dai toni
forti ed inquietanti in completa rottura con quella di Gonin, ormai divenuta una sorta
di stereotipo di riferimento a livello di tutti i tipi di forme espressive. Il successo di
questa edizione è scarso e Hoepli nel 1904 stampa una seconda versione dei Promessi
sposi illustrata da Campi. Nel 1910 esce dall’editore Nerbini di Firenze un’edizione
a dispense, illustrata con 40 tavole di Tancredi Scarpelli, che riscuote grandi favori
di pubblico.
Qui dominano le caratteristiche tipiche dell’illustrazione popolare ... enfatizzazione delle manifestazioni di sentimenti e affetti, secondo una logica
tutta fumettistica: se la situazione è allegra si legge felicità negli occhi di tutti... se Lucia è triste, non c’è parte del suo corpo che non denoti smarrimento
e abbandono .6
Per chiudere il discorso sui precedenti figurativi rispetto all’edizione illustrata con le
immagini del film Ambrosio, si possono ricordare le serie di cartoline postali di fine
Ottocento del pittore lecchese Giovan Battista Todeschini edite dai fratelli Stoppani e
quelle del 1910 di Vincenzo Polli per Signorelli, dove prevale la centralità del ritratto
dei singoli personaggi rispetto al luogo e allo svolgersi dell’azione.
127
3. Dal film Ambrosio al libro Hoepli
Nel 1914 Hoepli pubblica nella sua biblioteca classica l’ennesima ristampa dei Promessi sposi illustrata da Campi e curata da Alfonso Cerquetti, ma l’anno dopo esce
l’edizione con le 24 tavole cinematografiche Ambrosio, curata sempre da Cerquetti,
che rappresenta un netto distacco rispetto ai disegni di Campi: forse l’intenzione è di
fare una pubblicazione più popolare, sfruttando il grande successo di pubblico che il
cinema sta riscuotendo in quegli anni. Il film di Rodolfi ha sicuramente come referenti
iconografici soprattutto due delle versioni illustrate: quella classica di Gonin e quella
più recente di Tancredi Scarpelli pubblicata da Nerbini.
Questa edizione dei Promessi sposi riscuote un buon successo presso i lettori, visto
il numero di ristampe effettuate e probabilmente nelle intenzioni dell’editore doveva
rappresentare l’inizio di una nuova collana caratterizzata dall’utilizzo d’ immagini
dei film, collana che, invece, non ebbe seguito. Le ragioni dell’interruzione non sono
note, ma potrebbero dipendere dall’inizio della guerra, dalla successiva crisi del cinema italiano e dalle nuove leggi sul diritto d’autore.
Passiamo ora a vedere più nei dettagli come le illustrazioni tratte dal film dell’Ambrosio si collocano in relazione alla precedente tradizione iconografica dei Promessi
sposi che rimane sempre viva.
In particolare vediamo il confronto con l’edizione illustrata da Gonin. La prima
osservazione sul libro del 1840 è che su indicazioni dello stesso Manzoni le immagini di Gonin non presentano didascalie, perché inserite nel testo scritto di cui sono
la rappresentazione visiva. Si è in presenza di un testo in cui parole e immagini sono
perfettamente amalgamate e procedono di pari passo. Invece, l’edizione Hoepli del
1915 ha solo 24 tavole cinematografiche del film Ambrosio e perciò la funzione delle
immagini non è tanto di costruire un romanzo visivo che proceda in stretto parallelo
con quello scritto, ma d’illustrazione e richiamo memoriale delle situazioni narrativamente più coinvolgenti. Per inciso le “tavole cinematografiche” sono poste diverse
pagine dopo rispetto alle situazioni che rappresentano e potrebbero funzionare da
ricordo visivo di quanto letto in precedenza. Data questa prima sostanziale differenza
si riscontrano fra le due edizioni numerosi elementi comuni a livello iconografico,
che denotano come il film si sia ispirato ai personaggi e alle scene disegnate da Gonin, la cui opera, nonostante l’insuccesso commerciale, pervade tutta una produzione
d’immagini sui Promessi sposi circolante a livello popolare come, ad esempio, le
numerose edizioni ridotte del romanzo. Incredibili sono, ad esempio, le somiglianze
di scene come quella della notte popolata da incubi di Don Abbondio dopo le minacce
dei Bravi e del Griso che deruba Don Rodrigo malato di peste.
All’interno del comune riferimento iconografico non mancano, però, alcuni scarti,
che segnalano come l’introduzione del cinema nell’illustrazione per i libri non comporti solo una ripresa degli elementi figurativi tradizionali, ma una trasformazione
che porterà nel corso degli anni all’uso sempre più frequente dell’immagine fotografica rispetto al disegno.
Il primo elemento innovativo nell’edizione Hoepli, come si è detto, è dato dalla
totale scomparsa dei ritratti dei personaggi, che affollano, invece, secondo la consuetudine ottocentesca, il lavoro di Gonin. Inoltre, buona parte dei disegni di Gonin
sono incentrati su pochi personaggi, mentre i fotogrammi Ambrosio illustrano situazioni e ambienti di maggior respiro narrativo. Le scene tratte dal film mostrano una
128
Cartolina postale dal film I promessi sposi
di E. Rodolfi, 1913 produzione Ambrosio Film
Cartolina postale dal film I promessi sposi
di E. Rodolfi, 1913 produzione Ambrosio Film
129
profondità di campo tale da creare più piani dell’azione perfettamente a fuoco. Il
lettore/spettatore si trova nella posizione ideale di un osservatore che assiste in diretta allo svolgersi di un’azione. Non a caso spesso lo sguardo dei personaggi è rivolto
verso un fuori campo, che appare come un voler chiamare direttamente in causa il
lettore/spettatore per coinvolgerlo in quanto accade. A ulteriore dimostrazione di una
maggior attenzione della versione Hoepli-Ambrosio alla vicenda complessiva e alla
sua ambientazione, rispetto allo studio sui singoli personaggi che prevale nei disegni
di Gonin, c’è la totale assenza d’immagini della Monaca di Monza e del lungo “flashback” sul passato di Fra Cristoforo.
In conclusione si può dire che dal confronto fra le due edizioni emerge una continuità indiscutibile a livello dell’iconografia dei personaggi e delle situazioni più note,
ma si osserva, almeno a livello embrionale, lo scarto che comporta il passaggio dall’illustrazione con il disegno a mano a quella fotografica- cinematografica, con una
maggior focalizzazione sulla rappresentazione dell’azione complessiva rispetto ai
singoli personaggi.
A chiudere il flusso continuo e circolare dei prodotti dell’industria culturale che si
rimandano e influenzano l’un l’altro in un costante rapporto intermediale è la notevole produzione di cartoline postali. Le cartoline, immesse sul mercato direttamente
dalla società Ambrosio, sono illustrate con scene del film, molte delle quali identiche
a quelle usate per il libro. Il cerchio, dunque, si chiude: i disegni di Gonin creano una
tradizione iconografica che si diffonde in vari campi fra cui il cinema, il quale a sua
volta metabolizza le immagini rimandandole, con qualche variante, nel flusso circolatorio “alto” dei libri illustrati e in quello “basso” delle cartoline.
Si può, forse, ipotizzare, volendo riportare ad osservazioni più generali le conclusioni di questa parte, che il cinema negli anni Dieci comincia a svolgere una sorta di
funzione cerniera, di terreno comune d’incontro, fra un consumo che si rivolge a un
pubblico borghese più colto e un pubblico popolare, facendo contemporaneamente
da punto di confluenza e da cassa di risonanza di tradizioni letterarie e iconografiche
diverse e diffuse nelle varie forme espressive.
4. Da “I promessi sposi” di Mario Camerini a “Lo spettacolo dei Promessi
sposi”
Nel 1941, nel pieno della guerra, esce una nuova edizione cinematografica del romanzo di Manzoni diretta da Mario Camerini, uno dei registi italiani più noti e apprezzati dal pubblico degli anni Trenta per le sue commedie. Il film, prodotto dalla
Lux, si propone negli intenti come una perfetta operazione dell’ industria culturale
italiana, cercando di mettere insieme spettacolarità e cultura.7 Per pubblicizzare il
film ancora prima della sua uscita si organizza un concorso per cercare l’interprete
ideale di Lucia. Dopo aver esaminato ben 2324 candidate, secondo i comunicati della
Lux, viene scelta Dina Sassoli, una giovane ventenne di Rimini. Per gli altri interpreti
ci si affida a nomi noti come Gino Cervi per la parte di Renzo e a prestigiosi attori
teatrali come Ruggero Ruggeri ( Cardinal Federigo), Armando Falconi (Don Abbondio), Carlo Ninchi (L’Innominato)e Evi Maltagliati (La Monaca di Monza). Per le
musiche si chiama Ildebrando Pizzetti, che oltre a essere un apprezzato musicista, era
stato il compositore di due film spettacolari del cinema italiano come Cabiria e Scipione l’Africano. Gli scenari del film vengono ricostruiti a Cinecittà, compresi piazza
Duomo e il Lazzaretto, sul Lago di Como si girano alcune riprese di sfondo da inserire
130
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
131
GIULIANA NUVOLI
Dalle “Bosinade” al romanzo:
storie di seduzione e virtù
Siamo in Milano, la capitale del Regno Italico, palcoscenico ideale per tutti quelli
che intendano rappresentare una parte nell’epopea di quel tempo. E’ la Babylo Minima di Ugo Foscolo1; la Milano di Eugenio di Beauharnais, viceré e seduttore principe, nella quale fulgido astro risplende
La contessa A..., bellissima fra le belle: aveva molto spirito, molto ingegno, molta coltura (parlava quattro lingue); era buona, generosa e affabile;
costituiva insomma il complesso rarissimo di egrege qualità; ma tutte parevano sfasciarsi sotto l’uragano di un difetto solo. Ella faceva dell’amore
l’unico passatempo; ma un passatempo tumultuoso, fremebondo, irrequieto;
né occorre il dire che quell’amore era parente di quello rimasto nudo in Grecia, come disse Foscolo. Ma lo stesso Foscolo si trovò un bel giorno avvolto
e impigliato nell’ampia rete che la contessa teneva sempre immersa nella
grande peschiera della capitale lombarda.2
Lei è Antonietta Fagnani Arese, che il galante Foscolo da subito difende paragonandola ad Aspasia. La contessa lo viene a sapere e al primo appuntamento, appena
Ugo compare sulla soglia del gabinetto, le prime parole che gli rivolge sono: “Ho sentito che voi mi chiamate Aspasia; accetto la lode e, pur troppo, anche il biasimo; ma
voi che siete greco, dovreste fare assai bene la parte di Pericle”. Foscolo quella parte
la fa, e con trasporto assoluto. E’ una passione breve e intensa che inizia nel luglio
del 1801 e si consuma sullo sfondo del palco della Scala F n° 14 del 1° ordine. Ma la
costanza in amore è ignota alla contessa:
Non è da credere che non amasse; amava assai, amava ardentemente; e nei
primi istanti che le entrava nel sangue la scintilla incendiaria, ella non aveva
pace e si struggeva finché non avesse potuto accostare l’oggetto dei suoi desideri. Ma un amante nelle sue mani non era né più né meno di un cappone
messo in sul piatto di un ghiotto. In pochi momenti non rimanevano che le
ossa, e la fame chiedeva tosto altro cibo. Ella era tanto bella e cara e seducente, e nel periodo acuto del suo innamoramento faceva provare tali estasi a chi
134
ne era il passeggero oggetto, che questi subiva tosto quella passione acuta che
non soffre commensali alla medesima tavola. Ognuno voleva essere il solo
possessore di quel caro bene. Ma il caro bene (…) non volendo vincoli di sorta, metteva tosto alla porta i pretendenti che ambivano un posto esclusivo.3
Antonietta si inserisce a buon diritto nella schiera dei seduttori che, nella letteratura moderna, nasce nel 1630 col Burlador de Sevilla Tirso De Molina, e che conosce
fortuna smisurata con gli esiti straordinari di Molière (1665) e di Mozart/Da Ponte
(1787) e, nella prima parte dell’Ottocento, con il Don Juan di Hoffman (1813) e quello di Byron (1821). Due secoli in cui la seduzione si muove sempre più nel sfera del
libertinaggio: sono esemplari, in questo senso, due personaggi che appartengono all’immaginario collettivo: Casanova morto da poco (all’altezza dei fatti che narriamo)
nel 1798, e il marchese de Sade4 che vive ancora in questo inizio di secolo: morirà,
infatti, nel 1814. Morte in qualche modo esemplare, che si colloca alla fine della disinvolta età napoleonica e subito prima dell’arrivo di una più severa Restaurazione.
Accanto al seduttore per antonomasia, Don Juan, non è possibile ignorare la sua
omologa: Ninon de Lenclos (1615-1705) , curiosamente coetanea del burlador, e
tanto celebre da essere ricordata anche da Parini nel Giorno
Tu de la Francia onor, tu in mille scritti
Celebrata Ninon novella Aspasia,
Taide novella ai facili sapienti
De la Gallica Atene i tuoi precetti
Pur dona al mio Signore
Il fantasma di Aspasia si sovrappone al personaggio di Ninon e connota la seduzione come figlia dell’ingegno, della cultura, di un eloquio sapiente. E non v’è dubbio
che l’ingegno e la cultura siano elementi primari del fascino della contessa, l’Aspasia
per eccellenza della Milano degli inizi Ottocento che, con Foscolo, non condivide
solo il talamo: conosce il francese, l’inglese e il tedesco, così bene da avere un ruolo
importante nella revisione della prima stesura delle Ultime lettere di Jacopo Ortis,
traducendo per l’amante I dolori del giovane Werther.6
Non vi è, in ogni modo, dubbio che il suo potere di seduzione partisse dal corpo la
cui presenza è quasi ossessiva nell’opera di Foscolo: nell’Ortis, nelle odi, nei sonetti.
Un realistico ritratto di Antonietta lo troviamo nell’Ortis, sotto le spoglie della moglie
del patrizio M., che accoglie Jacopo nel suo budoir alzandosi “rugiadosa” da letto:
- La padrona è a letto ancora; a momenti uscirà. – Un campanello la fe’
correre nella stanza contigua ov’era il talamo della Dea (…) In questa le porte
si schiusero, ed io sentiva l’aere d’improvviso odorato di mille quintessenze,
e vedeva madama tutta molle e rugiadosa entrarsene presta presta e quasi intirizzita di freddo abbandonarsi sovra una sedia d’appoggio che la cameriera
le preparò presso al fuoco7
Questa era la moglie del patrizio M. nell’Ortis, e questa è l’amica risanata:
Qual dagli antri marini
135
l’astro più caro a Venere
co’ rugiadosi crini
fra le fuggenti tenebre
appare, e il suo viaggio
orna col lume dell’eterno raggio,
sorgon così tue dive
membra dall’egro talamo8
Precisa memoria autobiografica, naturalmente, come gli occhi, la bocca, la pelle:
E narro come i grandi occhi ridenti
arsero d’immortal raggio il mio core,
come la rosea bocca, e i rilucenti
odorati capelli, ed il candore
delle divine membra, e i cari accenti
m’insegnarono alfin pianger d’amore.9
(…) e co’ molli contorni
delle forme che facile
bisso seconda 10
Antonio Canova, Le tre Grazie danzanti, c. 1799, dettaglio.
136
Antonietta, maestra di seduzione, in ogni dettaglio del corpo, dunque, e maestra
nella cura del corpo, a partire dai “capelli odorosi”, presenti anche nel sonetto E tu ne
carmi avrai perenne vita (“mentr’io sentia dai crin d’oro commosse / spirar ambrosia
l’aure innamorate”11; e nelle Grazie (“Ed ella d’immortal lume e d’ambrosia / la santa imago sua tutta precinse”12 e che torna con memoria non peregrina nei Sepolcri
dove l’ambrosia scende dalla chioma di Giove chino su Elettra morente (“piovea dai
crini ambrosia su la Ninfa /e fe’ sacro quel corpo e la sua tomba”13). Lei seduttrice in
particolare quando danza, quando i capelli si sciolgono sulle spalle e le vesti scivolano
scoprendo il corpo in movimento: del resto chi non sa che è la grazia, la bellezza in
movimento, a possedere il massimo della capacità di seduzione?
Accanto alla contessa libertina c’è un’altra figura femminile che ha già preso forma
e le si contrappone: quella della fanciulla virtuosa. Bella e piena di grazia, ma vereconda.
(…) ho trovato Teresa nel suo gabinetto su quella sedia stessa ove io la vidi
il primo giorno, quand’ella dipingeva il proprio ritratto. Era neglettamente
vestita di bianco; il tesoro delle sue chiome biondissime diffuse su le spalle
e sul petto, i suoi divini occhi nuotanti nel piacere, il suo viso sparso di un
soave languore, il suo braccio di rose, il suo piede, le sue dita arpeggianti
mollemente, tutto tutto era armonia: ed io sentiva una nuova delizia nel contemplarla. Bensì Teresa parea confusa, veggendosi d’improvviso un uomo
che la mirava così discinta14
Sì, Antonietta è ancora lì, bionda come Isabella, ma ancora Antonietta. Il discrimine è rappresentato dal modo in cui si relazionano con l’esterno: si mostra la prima,
si nasconde la seconda. Teresa possiede quella virtù che sola, a detta di Jacopo, può
generare l’amore: la verecondia.
Il tema non è nuovo se già nel 1764, nelle Osservazioni sul sentimento del bello e
del sublime, Kant scriveva:
Il pudore serve a tirare un velo misterioso persino davanti agli scopi convenienti e indispensabili della natura, perché una troppo comune familiarità con
essi non cagioni nausea o almeno indifferenza rispetto all’intenzione ultima
di un istinto a cui convergono le più sottili e vivaci inclinazioni della natura.
Questa qualità è assai propria al bel sesso, e ad esso specialmente si addice.
Le nobili qualità del sesso femminile, (…) non si manifestano mai in modo
così chiaro e sicuro che per mezzo della modestia: una specie assai meritevole di nobile semplicità e ingenuità. Da essa traspare un pacato affetto, un
rispetto per gli altri, collegato ad una dignitosa fiducia in se stessi, a quella
giusta considerazione di sé che sempre ha da trovarsi in un nobile carattere.
(…) una tale fine combinazione [di modestia e fiducia in se stessi] conquista
con le attrattive, e col rispetto soggioga (…). Persone dotate di un simile temperamento hanno anche un cuore propenso all’amicizia; il che in una donna
non sarà mai apprezzato abbastanza, perché è così raro e al tempo stesso
attraente oltre misura15
La modestia si conferma, dunque, come potente arma di seduzione. Con l’Ortis,
137
nella nostra letteratura, torna il topos dell’amore alto fra due individui, simili per età,
avvenenza e virtù morali, sì che il primo livello di seduzione è quello del reciproco
riconoscimento come anime sublimi e capaci di forte sentire. E’ la seduzione di quelle
affinità elettive che Goethe, pochi anni dopo, racconterà mirabilmente nell’omonimo
romanzo (1808-1809); una seduzione fatale che sfugge al controllo dell’uomo:
Ci sono cose che il destino si propone ostinatamente. Invano gli attraversano la strada la ragione e la virtù, il dovere e tutto ciò che c’è di più sacro;
qualcosa deve accadere, che per lui è giusto, che a noi non sembra giusto; e
possiamo comportarci come vogliamo, alla fine è lui che vince.16
Era accaduto a Jacopo e Teresa e accade ai quattro protagonisti delle Affinità elettive: il destino irrompe sulla scena, turbando irrimediabilmente l’esistenza serena, e
scatenando passioni contro le quali nulla potranno né la ragione né la virtù.
Come il canone tragico prescrive, i protagonisti di queste passioni appartengono alle
classi alte e alle classi colte, in grado analizzare la propria anima e la qualità delle
relazioni instaurate. Così, in situazioni in cui l’intervento del Fato potrebbe destabilizzare lo statuto sociale e disgregare le istituzioni (leggi il matrimonio), l’uomo può
tentare di opporsi ad esso con l’esercizio di una virtù sovrana, l’autocontrollo, su cui
si incardina l’etica della rinuncia. Jacopo, Teresa, Calotta, Eduardo, Ottilia, il capitano fanno della rinuncia l’esercizio massimo di virtù.17
Si raccontano storie di seduzione e di virtù nei salotti, e le si cantano nelle piazze:
il componimento principe è la bosinada, che Francesco Cherubini, nel Vocabolario
Milanese-Italiano, così definisce:
Composizione in versi vernacoli milanesi, la quale per lo più viene recitata
e gridata per città dai così detti Bosin. (…) Il nostro popolo però suol chiamare Bosinada anche oggi altra scrittura in dialetto milanese e specialmente
ogni poesia vernacola, ma dai bei versi del Balestrieri e del Tanzi, dalle inimitabili poesie del Maggi e dei Porta e dalle bellissime del Grossi e del Rajberti
a questa specie di vere Bosinade vi corre quella diversità che ognun vede.18
Celebre la bosinada Pepp el perucchée, che Giuseppe Bossi scrive nel 1814 e modella sul Lamento di Cecco di Varlungo19: un giovane uomo si duole per la freddezza
dell’amata ed è convinto che il dolore lo porterà alla morte.
La protagonista della bosinada è Ninetta, che ha un banco di pesce al mercato del
Verzee: generosa con tutti delle sue grazie, e tanto brava da diventare la mantenuta
del Marchese Villani; da quel momento in poi se la tira da matti e fa sospirare Pepp,
colui che l’aveva, a suo tempo, iniziata ai piaceri amorosi: e Pepp, come Cecco, si
consuma, senza speranza per lei. In Bossi la sedotta, che si è allontanata e ha trovato
un amante migliore, diventa seduttrice; e la seduzione, in questo caso, deriva dalla
nuova immagine di benessere: tonda e ben vestita essa prende gusto all’eterno gioco
del darsi e negarsi, in un universo in cui sesso e fame - come nel teatro di Ruzante - la
fanno da padroni.
Ma nella Milano napoleonica un autore, sopra gli altri, sa raccontare l’amore/passione dei ceti popolari: Carlo Porta; e lo fa in due capolavori assoluti della nostra
138
letteratura: La Ninetta del Verzee e il Marchionn di gamb avert: due sedotti.
L’amore, per entrambi, è una forza primigenia e incontenibile: è il sale, anzi la
ragione stessa dell’esistenza, che si manifesta in tutta la sua forza devastante. Entrambi raccontano la loro storia in prima persona a un interlocutore esplicito: Ninetta a
Baldassarre, il cliente; il Marchion agli amanti traditi, in una sorta di confessione ad
oltranza, impudica e senza remore come tutte le vere confessioni.
Il genere letterario cui appartengono è, formalmente, quello del lamento, come denuncia il titolo del Marchionn e la nota anteposta dallo stesso Porta alla Ninetta20. Il
modello esplicito e ravvicinato è la bosinada di Bossi: e di quel lamento Porta mantiene l’aspetto parodistico della narrazione; ma la parodia non ha funzione dissacrante:
essa è piuttosto una sorta di omaggio al personaggio di cui si parla. E’ una confessione
in cui la parola ha valore terapeutico e liberatorio, e nella quale una travolgente omodiegesi dà vita ad attori e affabulatori di forza titanica. Entrambi narrano la storia di
una seduzione che avrebbe potuto distruggere la loro vita senza, tuttavia, riuscirvi.
Questa è Ninetta:
Sent mò che macciavella de birbon
l’è rivaa a tira a man per mettem sott.
L’ha comenzaa a fà el trist, el lumagon,
a fass vedè a mangià pocch o nagott.
Lu el me schivava, el fava repetton,
el sospirava come on mantes rott,
e con pù mì ghe andava per el vers
con pussee el fava el pregn, el gnucch, l’invers.
Infin quand l’ha creduu de vess a tir
vedi ch’el mett a volta on cortellasc
e ch’el sbassa i cannij incontra al fir:
mi, bona a dagh a trà, fermegh el brasc,
e prepotenta e franca come on sbir,
Cossa farisset mai, dighi, pajasc?...
Cossa vuj fà, el respond... mazzamm... morì...
fornì sta vitta... contentatt anch tì...
Sanguanon! che dianzer de paroll!
m’è calaa i forz de sbalz, m’è vegnuu frecc.
Me sont pondada a lu coj brasc al coll,
e lu borlonem là a travers al lecc,
e lì in terra el cortell, in aria el cioll,
lecchem, basem, stroffignem, brascem strecc,
Ninin... tas... lassem fà... pensa nagotta...
sto fioeul d’ona vacca el me l’ha rotta.21
Lui è Pepp el perucchée; lei la Ninetta che tiene il banco del pesce al Verziere.
Hanno lo stesso nome dei personaggi della bosinada di Bossi: ma l’esito, in Porta, è
di altra forza. Ninetta ha dato a Pepp tutto ciò che aveva: se stessa, l’eredità della zia,
i pochi gioielli di famiglia e, infine, per lui vende anche il suo corpo. Ma a Pepp non
139
basta: cerca di infettarla, sì da impedirle di guadagnarsi il pane come prostituta. Lei
riesce a evitarlo e a lui ancora non basta: con una bosinada, nel quartiere sparge la
voce che lei è malata. Amorale e contorto, Pepp vuole la sua distruzione, come talora
accade agli amanti messi alla porta22. Ma Ninetta è lì, a combattere per mantenere la
sua dignità di essere umano: la sua virtù coincide con la sua forza. E’ lei a dire basta
agli iterati soprusi: e alla morte contrappone il sesso come emblema di vita.
Storia di seduzione, simile per molti aspetti, è quella del Marchionn, più esplicita
nella sua forma di lamento: si lamenta il maschio, narra la femmina:
Particolare del frontespizio delle Opere di Carlo Porta pubblicate nella
Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese
curata da Francesco Cherubini (Milano 1817)
Moros dannaa, tradii de la morosa,
pien de loeuj, de fastidi e pien de corna,
sercemm chì tucc d’intorna,
stee chì a sentì l’istoria dolorosa
del pover Marchionn,
del pover Marchionn che sont mì quell,
striaa e tiraa a bordell
de la cappa de tucc i bolgironn!
(…)
140
Ma el colp che m’ha traa là come on per cott
l’è staa quand ona sira sta baltrocca
la m’ha strappaa de bocca
la caraffa lì lì in sull’ultem gott
e postandela in mezz
de quij duu laver ch’even de bornis,
Sur Marchionn, la dis,
bevi con pocch respett i soeu bellezz!
In quell pont ona vampa de calor
la m’ha quattaa la faccia, el coeur, el coll;
soltaven i paroll
e i oeucc voreven soltà foeura anch lor,
e fin l’armandorin,
che ghe l’eva de car come on fradell,
el m’è borlaa anca quell
debass del pè di pee de l’orchestin.
A vedella chì inscì con che premura
la s’è sbassada giò per toeummel sù,
Cristo! n’hoo possuu pù,
che bombè, che gambott, che inquartadura!
La m’ha daa de maross
tra el manegh e i borieu ona strengiudina
de man tant moresina
ch’hoo sentuu i sgrisor fina in mezz di oss.23
La Tetton gli ha preso tutto, ma gli ha lasciato un figlio: e questa è vita.
In quell stat de passion, de primm bullor
me sarev fors scannaa mì come on can,
se a tertegnimm la man
no me vegneva in ment quell car amor,
quell car angerottell,
quell pover innocent del mè bambin,
che l’è nanch settemin,
e el par squasi d’on ann, tant che l’è bell.
Fioeuj tender de coeur che sii staa chì
a scoltà i mee lument con cortesia,
innanz de passà via,
compatimm, consolemm, piangii con mì;
piangii col Marchionn,
col pover Marchionn che sont mì quell,
striaa e tiraa a bordell
da la cappa de tucc i bolgironn.24
141
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
142
RINO CAPUTO
Il “cantuccio dell’autore”:
Manzoni e Pirandello
C’è una sorta di ‘milanesità’ specifica di Pirandello, riprendo la formula di Vittorio
Spinazzola, e, tra le altre, molteplici e varie, quella di Pirandello è acquisita, concretamente, soprattutto nell’ultimo decennio della sua vita. È noto quanto la ‘città’ conti
per Pirandello. Ma la (sua) città è sempre stata Roma. Si pensi al Fu Mattia Pascal
di cui quest’anno ricorre il centenario. Adriano Meis deve decidere dove risiedere e
sceglie Roma, perché Roma è più adatta a un “forestiere della vita”. Non è, per così
dire, (e per riprendere una suggestione icastica di Barbara Peroni), ancora pronto per
“le vie di Milano”, in cui, come si narra nel cap. IX del romanzo, il rinnovato alter
ego di Mattia “rientrava in albergo, stanco di vedersi solo, in quelle tristi giornate
d’inverno”, pur “intronato di quella vita fragorosa, col tram elettrico, con la luce elettrica, ecc. ecc.” (L. Pirandello, Tutti i Romanzi, vol I, Milano, Mondadori, 1984 p.
428-429).
Nell’orizzonte iniziale di Pirandello non c’è Milano, bensì la Lombardia, la terra
di passaggio del giovane studente universitario di filologia romanza diretto alla più
tranquilla sede accademico-scientifica di Bonn. Pirandello si ferma a Como, fruisce
della bellezza dei laghi, ricorda e ritrova l’Italia nel passaggio tra Roma e Bonn e
viceversa. Il primo vero contatto con Milano è indiretto, ma fortemente profetico. Nel
maggio del 1921 Pirandello presenta I sei personaggi a Roma, scontando un mezzo
‘fiasco’: i fautori del drammaturgo vengono alle mani con i numerosi detrattori sparsi
in mezzo al pubblico, in larga maggioranza contrario, e l’opera sembra essere destinata a una vita incerta. Pochi mesi dopo, il 27 settembre, al Teatro Manzoni di Milano
I sei personaggi hanno un’accoglienza trionfale: Milano è la città in cui l’arte nuova
e, in particolare, la nuova drammaturgia consegue la sua consacrazione. Si potrebbe
dire che già negli anni della prima guerra mondiale Milano e Torino sono le realtà
socioculturali che riconoscono, prima di ogni altra città italiana, il valore del teatro
pirandelliano. Sulle pagine dell’edizione torinese dell’Avanti Antonio Gramsci, ad es.,
intuisce immediatamente la novità del teatro pirandelliano. L’ancor giovane critico
teatrale, oltre che dirigente politico-culturale del movimento operaio, scriveva già nel
1917 che le commedie di Pirandello “sono tante bombe a mano che scoppiano nei cervelli degli spettatori e producono crolli di banalità, rovine di sentimenti, di pensiero”
(A.Gramsci, La città futura 1917-18, Torino, Einaudi, 1982, p. 950).
152
Può essere interessante sapere, inoltre, che a Milano hanno luogo le prime rappresentazioni di alcune tra le opere più significative di Pirandello. Tra il 1917 e il 1930, a
Milano, appunto, sono messe in scena per la prima volta Pensaci, Giacomino!, Così è
(se vi pare), L’innesto, L’uomo la bestia e la virtù, Enrico IV , Ciascuno a suo modo,
Bellavita, Diana e la Tuda , Come tu mi vuoi.
Ma Milano diventa una realtà centrale nella vita di Pirandello soprattutto dopo l’incontro con Marta Abba, dal 1925-26 fino alla morte del drammaturgo, avvenuta il
10 dicembre del 1936. Pirandello mantiene un rapporto costante con Milano proprio
perché Milano è la città di Marta Abba. Milano è un luogo che può essere elettivamente un’alternativa alla disgregazione e alla disperazione di un Pirandello che, pur
celebre, è diventato, come i suoi personaggi, “viaggiatore senza bagaglio”, “forestiere
della vita”.
Il rapporto con Milano del Pirandello degli ultimi anni è quindi da valorizzare ed è
possibile oggi farlo, proprio ribadendo la validità anche metodologica di un approccio
che soltanto in questi ultimi anni è stato, per così dire, nobilitato in sede teorico-critica
e che mira ad assumere la dimensione dell’epistolario, del testo epistolare come un
ambito precipuamente ‘letterario’: la ‘lettera’ come un romanzo, una poesia, ecc., in
particolare quando la missiva contiene esplicitamente parti componenti riferite alla
‘letterarietà’. Per Pirandello, non c’è dubbio, la lettera è un testo di storia e di letteratura. E il valore tematico di Milano è quasi condensato in quel ‘cantuccio dell’autore’
che sono le numerosissime lettere, scritte dal 1925 al 1936 a Marta Abba, religiosamente conservate dall’accorta destinataria.
Verso la fine degli Anni Venti lo scrittore trascorre mutevolmente il suo tempo tra
Parigi, Berlino e le altre grandi città dell’Europa continentale. Raramente mette piede
in Italia, configurando un esilio che ha ragioni di vario genere, umane e artistiche,
culturali e politiche. E Milano è, innanzitutto, in questo frangente, per lui, un centro
di cristallizzazione vitale concreta, e non solo simbolica. È il luogo in cui si organizza
l’attività politico-culturale, oltre che la pratica organizzativa, del teatro italiano. Le
compagnie si formano a Milano, l’organizzazione dello spettacolo, tutto interno alla
gestione del fascismo, divenuto partito-stato e regime reazionario di massa, prende
le mosse da Milano. Qui ci sono i fautori della possibilità di costruire il teatro ‘nazionale’, e qui ci sono i nemici, i gestori occhiuti e ottusi delle grandi compagnie,
che hanno collegamenti organici con le gerarchie fasciste. Si evidenzia una sorta di
paradossale ‘antifascismo’ di Pirandello, nella polemica contro le irrigidite strutture
burocratiche della vita artistica teatrale e Milano è la sede, pur ambigua e alterna, di
tale configurazione.
Dunque si evidenzia una Milano come centro di interesse per il teatro in se stesso e
di unione (ormai soltanto artistico-intellettuale) con Marta Abba. Viene rinnovato in
parte lo stereotipo: il 5 maggio del 1929 Pirandello scrive: “a Milano fa brutto tempo,
un tempo che ti mette tanta tristezza dell’anima”; però, con grande letizia, il 29 dicembre del 1935 riceve il “monumentale panettone Motta” e, qualche giorno prima, il 15
dicembre, mentre è a Milano, scrive a Marta Abba, che non è a Milano, che “in città ci
sono già sei centimetri di neve”. Ma Milano è anche un “posticino quieto dove lavorare nonostante il brutto tempo!” (8 ottobre 1930). Prende corpo un’opposizione Milano-Roma che si traduce anche in termini storicamente documentabili: il 19 maggio
del 1930 scrive che, a Roma, i suoi “nemici hanno ormai il loro quartier generale, la
ragione politica, c’è una oscura camorra dei nazionalisti che hanno in mano la stampa:
153
Roma è veramente avversa”; allora la soluzione sarà quella di lavorare a Milano, “a
Milano per ispirarmi”. Il 6 agosto del 1931 Milano è “un focolaio d’arte da accendere
come non s’era potuto fare a Roma e non importa se ci sono anche quei masnadieri
di Milano”. C’è un atteggiamento complesso, contorto in alcuni momenti, ma viene
fuori la scoperta di una Milano come luogo positivo rispetto ai tanti aspetti difficili
della vita di Pirandello negli anni Trenta (cfr. L.P., Lettere a Marta Abba, Milano,
Mondadori, 1995, cit. secondo la data).
Ma il rapporto tra Pirandello e Milano, che, pure, è oggi pieno di nuovi elementi
talora persino inediti, passa ancora una volta, inevitabilmente, attraverso l’incontro
con l’opera di Alessandro Manzoni. Occorre dire subito, in tale direzione, che sarebbe
riduttivo limitare l’incontro alla pur importantissima valorizzazione di don Abbondio
contenuta nell’Umorismo, nelle novelle costitutive della tematica del ‘personaggio’,
come la novella Personaggi del 1905, La tragedia di un personaggio del 1911, I
colloquii coi personaggi del 1915 e negli stessi Sei Personaggi (rinvio, per brevità,
in proposito, al mio Il piccolo Padreterno. Saggi di lettura dell’opera di Pirandello,
Roma, Euroma, 1996, in part. pp. 50-51).
C’è una testimonianza del valore che l’opera di Manzoni ha per Pirandello in Arte e
scienza, saggio contenuto nell’omonima raccolta del 1908 e, dunque, coevo all’Umorismo. In esso Pirandello loda del Manzoni la capacità tutta artistica di trasformare
il dato oggettivo in interpretazione soggettiva, esaltando, insieme all’amico e sodale
critico-letterario Cesareo, quel passo del capitolo XVII dei Promessi sposi in cui lo
stesso autore, parlando dal suo “cantuccio”, esclama: “il cielo prometteva una bella
giornata”. Il sintagma permette a Pirandello di ribadire che Manzoni è diverso da tanti
autori che hanno cercato di presentare la realtà in modo più riduttivamente diretto,
tanto da diventare perciò un esempio di come si deve scrivere: va valorizzata la prosa manzoniana che “esce dal tormento di una triplice elaborazione”, come afferma,
ancora nel 1931, nel saggio su Giovanni Verga ( in L.P., Saggi, poesie e scritti varii,
a c. di M. Lo Vecchio Musti, Milano, Mondadori, 1960, p. 397). Manzoni è riconosciuto come un “poeta dell’Italia moderna” (p. 105) e, certamente, il romanzo “è
tutto infuso di genuino umorismo”, come Pirandello sostiene nell’Umorismo (p. 118)
. “Dopo Manzoni” - dice Pirandello in “Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa”, ricompreso in Arte e Scienza - non si può prescindere dal fatto che “le persone
del racconto vengono innanzi, rappresentano da sé la loro azione, parlano con la loro
viva voce” (p. 200). Questa formula è molto ‘pirandelliana’ ed è un’immagine che
Pirandello insegue fin da giovanissimo. Ancora una volta nelle lettere leggiamo una
testimonianza del suo rapporto con il teatro, quando, ventenne, a Roma, assiste a una
rappresentazione e poi racconta ai suoi familiari che non può fare a meno di vivere
contemporaneamente una duplice emozione: “Spesso mi accade di non vedere e di
non ascoltare quello che veramente si rappresenta, ma di vedere e ascoltare le scene
che sono nella mia mente […] uomini e donne, da drama e da commedia, viventi
nel mio cervello, e che vorrebbero d’un subito saltare sul palcoscenico” (Epistolario
Familiare Giovanile 1886-1898, a c. di E.Providenti, Le Monnier, Firenze, 1986, p.
22).
Un altro elemento significativo riguarda la lingua. Si parla spesso di un Pirandello
seguace di una linea linguistica alternativa a quella manzoniana, per così dire più
‘ascoliana’, che sente di più l’aspetto evolutivo della lingua ed è meno attento all’aspetto normativo che nasce dalla esperienza dei Promessi sposi. In realtà, da un lato
154
Per ricevere una copia degli atti contattare:
Prof. Barbara Peroni
tel 02-26145465
[email protected]
Tesseramento annuale ADI-SD 20 euro
155