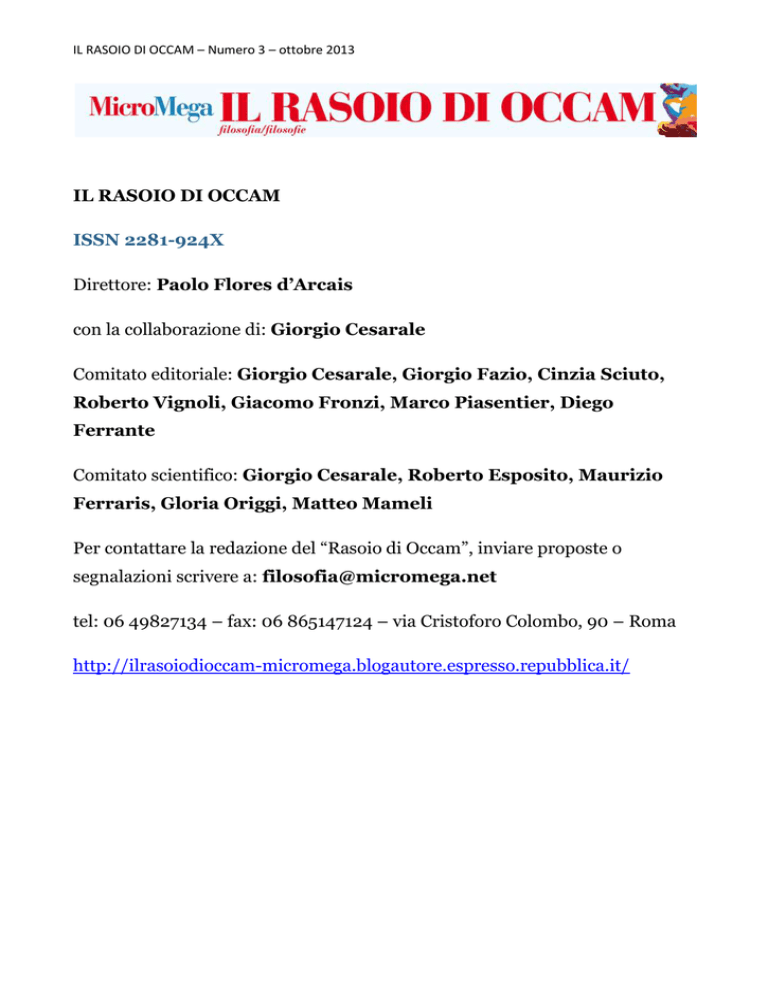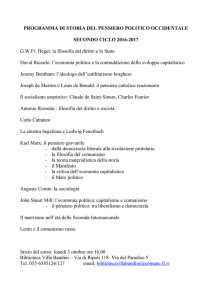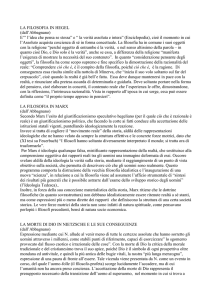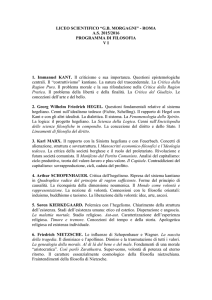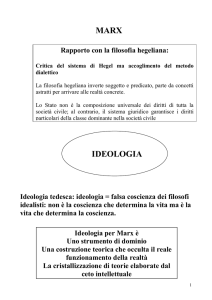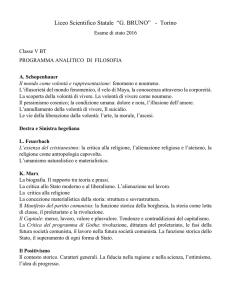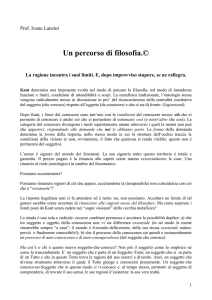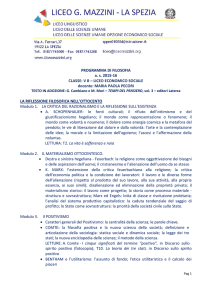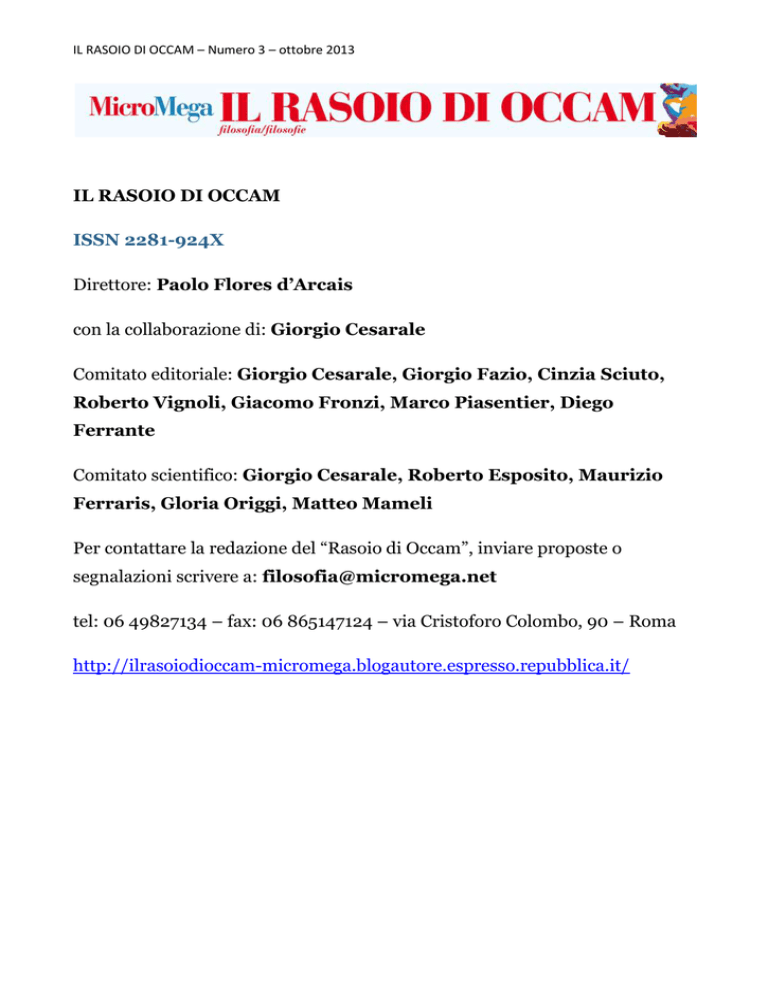
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
IL RASOIO DI OCCAM
ISSN 2281-924X
Direttore: Paolo Flores d’Arcais
con la collaborazione di: Giorgio Cesarale
Comitato editoriale: Giorgio Cesarale, Giorgio Fazio, Cinzia Sciuto,
Roberto Vignoli, Giacomo Fronzi, Marco Piasentier, Diego
Ferrante
Comitato scientifico: Giorgio Cesarale, Roberto Esposito, Maurizio
Ferraris, Gloria Origgi, Matteo Mameli
Per contattare la redazione del “Rasoio di Occam”, inviare proposte o
segnalazioni scrivere a: [email protected]
tel: 06 49827134 – fax: 06 865147124 – via Cristoforo Colombo, 90 – Roma
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Ronald Dworkin: i diritti presi sul serio, l’uguaglianza e i
fondamenti della moralità politica
di GIORGIO BONGIOVANNI e GIOVANNI SARTOR
Poche settimane fa, il 14 febbraio, è morto uno dei più importanti giuristi e filosofi del diritto del
’900, Ronald Dworkin. Giorgio Bongiovanni e Giovanni Sartor, filosofi del diritto dell’Università
di Bologna, ci offrono con questo articolo una ricostruzione complessiva del suo pensiero.
La riflessione dworkiniana*, secondo molti teorici del diritto, ha rappresentato un vero e proprio
cambio di paradigma rispetto alle posizioni classiche della teoria giuridica quali il giuspositivismo,
il giusnaturalismo e il realismo giuridico. Nel dibattito italiano e dei paesi di lingua neolatina,
Dworkin viene considerato come uno dei principali ispiratori della corrente del
“neocostituzionalismo”. Le analisi dworkiniane non si sono limitate al diritto, ma si sono estese a
temi fondamentali della politica e dell’etica: si può dire che le sue indagini abbiano preso in esame i
principali aspetti della ragion pratica.
L’opera di Dworkin a nostro parere può essere vista come lo sviluppo di un’unica tesi
fondamentale, quella della connessione tra diritto e moralità politica1. Questa tesi fornisce una
chiave di lettura coerente delle sue riflessioni teorico-giuridiche, filosofico-politiche e filosoficomorali.
In relazione alla teoria del diritto, la tesi della connessione comporta la critica del modello
positivistico del diritto, cioè la negazione della riducibilità del diritto alle fonti formalmente valide,
quali le statuizioni autoritative del legislatore, dell’amministrazione e dei giudici. Al contrario, per
Dworkin il diritto include necessariamente valutazioni morali, la cui validità si fonda non solo sulla
loro accettazione da parte dei giudici e dei cittadini, ma anche sulla loro intrinseca correttezza, quali
aspetti della moralità politica della comunità. Si tratta in particolare dei principi inclusi nel sistema
costituzionale, che esprimono primariamente una serie di diritti degli individui.
Questa prospettiva comporta un’implicazione politica importante al livello della struttura del
sistema giuridico, cioè il vincolo del legislatore di fronte ai principi e ai diritti che fondano la
comunità. Nella visione di Dworkin l’interpretazione e l’attuazione di quei principi è affidata ai
giudici, cui pertanto egli riconosce un ampio ruolo, anche in contrapposizione al legislatore. Ad essi
spetta garantire il principio “liberal”, della eguale considerazione e rispetto degli individui (e
innanzitutto la tutela dei loro diritti), che rappresenta il necessario presupposto della legittimità dei
sistemi giuridici.
Si noti che per Dworkin la moralità politica non è un mero fatto sociale: non possiamo determinare i
principi morali della costituzione mediante una mera analisi sociologica che raccolga gli
orientamenti dei giudici e della popolazione. La determinazione di tali principi richiede il ricorso a
una moralità critica, quale attività razionale volta a identificare i principi corretti. Quindi
l’orientamento di Dworkin presuppone una forma di cognitivismo morale: l’idea che il diritto si
fondi sulla moralità politica presuppone la possibilità di dare una fondazione razionale ai giudizi
morali. Al riguardo Dworkin sembra adottare un’epistemologia coerentista secondo cui la
correttezza dei principi morali si connette soprattutto alla loro coerenza reciproca, alla possibilità di
integrarli in una visione complessiva, che si estende alle diverse pratiche sociali.
La riflessione più nota di Dworkin (e quella che ispira le sue tesi in ambito politico e morale) attiene
alla teoria e filosofia del diritto, e può essere caratterizzata per tre aspetti principali: in primo luogo,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
in relazione ai caratteri individuativi del diritto e al nesso tra diritto e morale politica; in secondo
luogo, con riferimento alla nuova struttura delle norme e del diritto nei sistemi costituzionali; in
terzo luogo, in rapporto alla dimensione e al ruolo della interpretazione giuridica.
Il primo aspetto ha quale punto di partenza la visione del diritto come “concetto interpretativo”.
Secondo Dworkin, a differenza dei concetti “criteriali” (che fissano convenzionalmente una serie di
criteri, più o meno precisi, mediante i quali circoscrivere gli enti cui il concetto fa riferimento) e di
quelli di “genere naturale” (la cui estensione è definita dal riferimento ad una certa struttura fisica),
il concetto di diritto è di natura interpretativa2. Per stabilire che cosa sia il diritto ci dobbiamo
interrogare su quale sia la migliore prospettiva dalla quale guardare alla pratica sociale cui
appartiene il diritto, la prospettiva che possa meglio consentirci di individuare norme atte a
governare la comunità politica, secondo la (corretta) moralità politica che attribuiamo alla stessa. In
questa visione, definire cosa prescrive il diritto in determinate condizioni e situazioni presuppone
l’individuazione dei valori che ispirano e debbono ispirare la prassi giuridica: Dworkin pone
esplicitamente questo legame e sostiene che l’interpretazione e l’applicazione del diritto dipendono
“da valori”. Pertanto l’individuazione del contenuto precettivo delle norme si fonda sempre su una
dinamica tra essere (fatti sociali) e dover essere (valori morali).
La riflessione di Dworkin si concentra sull’attività dei giudici, quale decisione di casi concreti che
presuppone la determinazione delle norme applicabili (infatti si è talvolta affermato che egli
propone una teoria della giurisdizione piuttosto che una teoria del diritto o anche che egli riduce la
teoria del diritto alla teoria della giurisdizione). In tale prospettiva l’interpretazione del diritto
appare come un’attività pratica, finalizzata a determinare le norme applicabili al caso concreto e
quindi alla decisione di tale caso. Tale determinazione secondo Dworkin presuppone una fase
preinterpretativa, in cui l’interprete raccoglie le fonti del diritto potenzialmente rilevanti (leggi,
sentenze, ecc.), ma poi si sviluppa nella valutazione delle scelte possibili secondo due dimensioni:
la dimensione del “fit” cioè la corrispondenza con le scelte passate (in particolare quelle legislative
e giurisdizionali) e la dimensione della giustificazione, cioè la loro corrispondenza con i principi
della moralità politica. Le scelte concernenti l’interpretazione del diritto rispetto ai casi concreti
dipendono pertanto dall’appropriatezza rispetto alle prassi precedenti, ma anche da valutazioni di
correttezza morale.
Da questa prospettiva anche l’indirizzo positivistico, inteso come l’esclusivo riferimento alle fonti
autoritative del diritto, appare come una scelta morale e politica, cioè quella di privilegiare la
prevedibilità delle scelte giuridiche, e quindi la tutela dell’interesse dell’individuo a pianificare le
proprie azioni sulla base di tale previsione. L’opzione di Dworkin è diversa: accanto alla
prevedibilità ci sono anche i valori della giustizia e dell’uguaglianza, che si realizzano in una
comunità ispirata da coerenti principi di moralità politica. Secondo Dworkin, infatti, un ordine
giuridico è legittimo se si basa sul vincolo che si stabilisce in una comunità di “principio”
caratterizzata dal fatto di imperniarsi su una serie di principi comuni di equità e giustizia (che
fissano lo schema di diritti e doveri degli individui contenuti nella costituzione) che le istituzioni
politiche devono rispettare e sviluppare. Questa idea si concretizza nell’esigenza che siano
riconosciuti “eguale considerazione e rispetto” a tutti membri della comunità: il fondamento
dell’obbligo giuridico è perciò un’idea della comunità basata sull’assunto che “ogni individuo abbia
lo stesso valore degli altri”, abbia cioè uguale dignità sia in termini di diritti, sia di interventi delle
autorità politiche. È ciò che Dworkin chiama “ideale dell’integrità politica”, che si traduce nella
visione per cui ciò che rende legittimo il potere dello Stato è il fatto di “governare attraverso un
insieme coerente di principi comuni” che realizzano una dimensione di “uguaglianza” dei soggetti3.
Quale esempio di applicazione dell’idea di uguaglianza di Dworkin possiamo ricordare la sua
valutazione della cosiddetta “azione affermativa” (il trattamento preferenziale dei membri di gruppi
sociali svantaggiati, ad esempio, nell’accesso alle università o ai contratti pubblici). Secondo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Dworkin l’azione affermativa, quando volta esclusivamente a superare situazioni di svantaggio,
garantendo eguaglianza sostanziale, risulta pienamente giustificata: è vero che i membri degli altri
gruppi non godono del trattamento preferenziale, ma ciò non segnala una minore considerazione e
rispetto nei loro confronti.
La connessione tra diritto e morale comporta profonde implicazioni per la struttura del diritto (in
particolare delle norme giuridiche). A partire da Taking Rights Seriously, Dworkin pone in evidenza
come il diritto contemporaneo sia composto non solo di “regole” ma anche di principi. Con
riferimento a tale distinzione, Dworkin ha richiamato diverse caratteristiche differenziali dei
principi rispetto alle “regole”. I principi si caratterizzano per gli aspetti seguenti: esprimono i valori
supremi dell’ordinamento di una comunità; si fondano sulla propria correttezza morale; la loro
applicazione può richiedere ponderazione e bilanciamento; specificano diritti fondamentali;
prevalgono su considerazioni di utilità pubblica; servono da riferimento necessario per l’attività
interpretativa; possono condurre alla disapplicazione di regole incompatibili con essi. Ad esempio,
con riferimento al caso Riggs v. Palmer, Dworkin contrappone alla regola secondo la quale l’erede
indicato nel testamento ha diritto di ottenere l’eredità, il principio secondo cui nessuno può
avvantaggiarsi del proprio illecito (il termine inglese è “wrong”, che denota la violazione di un
diritto, ma significa anche azione ingiusta o scorretta, ed esprime quindi l’inevitabile connessione
tra diritto e morale), principio secondo il quale i giudici esclusero dall’eredità l’erede che aveva
ucciso il testatore. L’aspetto della discussione dworkiniana dei principi che ha avuto maggiore
influenza sulla discussione teorico giuridica è probabilmente quello strutturale (poi sviluppato in
particolare da Robert Alexy): i principi debbono essere bilanciati nei casi concreti alla luce della
loro rilevanza in tali casi, e rimangono validi anche se talvolta disapplicati per la prevalenza di
principi contrastanti.
La tesi della connessione tra diritto e morale si riflette infine nel ruolo che Dworkin assegna
all’interpretazione e applicazione del diritto. Come abbiamo già osservato, secondo Dworkin, la
specificazione delle norme giuridiche avviene nei processi di interpretazione e applicazione. Per
Dworkin, è necessario che tali processi rendano possibile lo sviluppo “migliore” dello schema di
principi di equità e giustizia posti alla base della comunità. Ciò significa che le istituzioni pubbliche
debbono agire “con coerenza” e nel rispetto dei principi nei confronti di tutti i cittadini, e inoltre che
tali istituzioni debbono fornire l’interpretazione “migliore” dei principi fondativi del diritto. Si
tratta, da un lato, della “coerenza in linea di principio” che si realizza nel “trattare i casi simili in
modo simile”, e, dall’altro lato, nella lettura morale (“moral reading”) dei principi della comunità e
della costituzione. Ciò si traduce in un’interpretazione del diritto (e della costituzione) che deve
attualizzare i principi e i diritti posti alla base della comunità individuando la “best conception of
constitutional moral principles” in relazione ai casi e all’evoluzione storica. Secondo Dworkin, il
riferimento alla moralità politica offre la prospettiva per risolvere i dubbi nell’interpretazione del
diritto: in ultima istanza esiste sempre, per qualsiasi questione giuridica, un’interpretazione più
giustificata, una “risposta giusta” al caso che dobbiamo affrontare, anche se non sempre saremo in
grado di trovarla.
Come osservavamo sopra, il contributo di Dworkin non si limita alla filosofia del diritto, ma si
estende a temi attinenti alla filosofia politica e morale. La filosofia politica di Dworkin ha quale
punto di partenza la connessione tra teoria del diritto e moralità politica: ciò avviene per il tramite
del concetto di comunità basata su principi. In questa idea, Dworkin sintetizza la dimensione
“costituzionale” dell’esperienza giuridica contemporanea, intesa come l’accoglimento di “contenuti
morali” da parte del diritto, in relazione ai diritti e agli obiettivi dell’attività pubblica. Dworkin
sviluppa le implicazioni politiche di questa assunzione in una duplice direzione: da un lato, in
relazione al ruolo dei diritti e dell’eguaglianza nei sistemi costituzionali, e, dall’altro lato, rispetto
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
alla visione “costituzionale” e “deliberativa” della democrazia che presuppone il vincolo del potere
delle maggioranze politiche.
In relazione al primo aspetto, Dworkin sottolinea che i sistemi costituzionali sono basati su diritti
“morali” e “politici” (che precedono la decisione politica) e che sono volti alla realizzazione
dell’idea di “eguale considerazione e rispetto”. A questo riguardo dobbiamo sottolineare la
prospettiva “liberal” adottata da Dworkin. Secondo tale prospettiva, la moralità del diritto non
comporta l’imposizione alla vita dei singoli di un determinato ideale etico (l’imposizione della
morale attraverso il diritto, paventata da John Stuart Mill così come da Herbert Hart), ma comporta
invece la garanzia assoluta di un’eguale libertà, nel rispetto delle scelte di ciascuno, libertà che si
estende, per esempio, tanto alla sfera sessuale quanto alle determinazioni sulla fine della propria
vita.
Con riferimento all’eguaglianza, Dworkin ne propone una visione quale eguaglianza di “risorse”,
intesa a consentire la convivenza di eguaglianza e libertà. Tale visione può quindi essere vista come
una risposta “liberal” alle teorie che assolutizzano i diritti di proprietà, e respingono quindi ogni
forma di ridistribuzione in quanto incompatibile con i diritti individuali (riprendendo temi
sviluppati in particolare Robert Nozik). La posizione di Dworkin si inquadra nell’ambito del
cosiddetto egualitarismo della fortuna (“luck egalitarianism”), che tenta di coniugare l’esigenza
della eguaglianza e quella della responsabilizzazione: a tutti debbono essere fornite eguali risorse,
ma ciascuno sarà libero di usarle come preferisce e subirà le conseguenze delle proprie scelte. Tale
eguaglianza di risorse tuttavia va al di là della mera uguaglianza di opportunità, superando l’ideale
meritocratico: oltre alle differenze nelle condizioni economiche e sociali di partenza, si debbono
superare anche le differenze “naturali”, cioè le differenze nelle capacità fisiche e intellettuali,
capacità che consentono ad alcuni di avere maggiore successo economico rispetto ad altri. Quindi,
chi possiede una dotazione inferiore nei talenti dovrà essere compensato da chi possiede una
dotazione maggiore, cioè capacità che gli consentono di ottenere maggiori risultati nella situazione
economico-sociale data. A tal fine Dworkin immagina che si mettano all’asta le risorse che
ciascuno possiede, sia le risorse esterne (i beni posseduti), sia le risorse interne (le capacità). Tale
asta determina il valore delle risorse che ciascuno possiede, e chi si trova a possedere risorse aventi
un valore superiore avrà l’obbligo di ridistribuire l'eccedenza a vantaggio di chi è stato meno
fortunato. In concreto, ciò giustifica, data la differenza nelle risorse possedute da ciascuno,
meccanismi di redistribuzione finanziati dalla tassazione che mirino alla concretizzazione di
programmi volti a limitare le “diseguaglianze”. L’eguaglianza delle risorse, peraltro, non tocca la
libertà di ciascuno di utilizzare le proprie risorse nel modo che ritiene più opportuno4.
In relazione al secondo aspetto, si può dire che la presenza dei principi e dei diritti conduce a una
visione della democrazia quale sistema in cui gli individui hanno diritti che le istituzioni politiche e
le maggioranze “non hanno il potere di superare o compromettere”, diritti che proteggono le scelte
del singolo, ma anche favoriscono il corretto dispiegamento della deliberazione democratica. La
democrazia, secondo Dworkin, richiede “la protezione costituzionale dei diritti individuali”5.
Dworkin sottolinea la necessità della tutela: dei diritti di libertà degli individui e delle minoranze,
della non discriminazione, della libertà di scelta sessuale e di livelli minimi di diritti sociali. Ciò
permette di distinguere due diverse concezioni della democrazia: quella “maggioritaria”, per la
quale tutte le decisioni sono legittime se approvate dalla “maggioranza dei cittadini”, e quella
costituzionale e deliberativa per la quale il “governo è soggetto a delle precise condizioni”.
Le riflessioni giuridiche e politiche di Dworkin trovano il loro esito finale nella riflessione
filosofico-morale. Per Dworkin, il fatto che la dinamica del diritto si concretizzi nella
interpretazione e che quest’ultima implichi “scelte morali” pone una “questione fondamentale”: si
tratta della possibilità di stabilire criteri di oggettività dei giudizi etici. L’integrazione tra diritto e
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
moralità politica presuppone l’oggettività dei giudizi morali. Infatti, se le scelte morali fossero in
ultima istanza arbitrarie, o mera espressione di preferenze soggettive, lo sarebbero anche le
interpretazioni giuridiche che si basano su di esse. Per Dworkin esiste una risposta positiva: i
giudizi morali e giuridici possono aspirare all’oggettività, ed è possibile accettarli in quanto veri e
respingerli in quanto falsi. Egli individua tale risposta a partire dal postulato della “indipendenza
della verità morale dalla scienza e dalla metafisica”6, adottando un’epistemologia di tipo
coerentistico. Secondo Dworkin, infatti, la verità (oggettività) dei giudizi morali può essere stabilita
solo a partire da criteri interni alla morale: la verità di una conclusione morale dipende dalla
coerenza degli argomenti addotti a suo sostegno. Tale coerenza si deve misurare rispetto ai concetti
morali caratterizzanti la pratica cui si fa riferimento, ma anche rispetto a valori più generali (comuni
ad altre pratiche), e alle decisioni adottate nel passato. La verità dei giudizi morali dipende quindi
da una valutazione olistica che si allarga a tutti tali aspetti.
Come risulta dalla nostra sommaria esposizione, il pensiero di Dworkin ha affrontato molti dei temi
fondamentali del pensiero giuridico, etico e politico. Le sue tesi sono state oggetto di molti
apprezzamenti, ma anche di numerose critiche: la sua metaetica oggettivistica è stata criticata da
prospettive non-cognitiviste o relativistiche; la sua idea della connessione tra morale e diritto è stata
contestata da chi vuole scindere la determinazione empirica del diritto vigente dalle scelte
discrezionali fatte nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto; la sua
caratterizzazione “interpretativa” e olistica dell’attività del giudice è stata rifiutata da chi ha posto
l’accento sulla necessità di limitarne i poteri rispetto alle scelte politiche e alle competenze
dell’amministrazione; l’idea che vi sia sempre una risposta giusta a ogni questione giuridica è stata
respinta da chi ha messo l’accento sull’indeterminatezza dei sistemi giuridici e sui conflitti tra
norme morali.
Qui non possiamo affrontare le innumerevoli questioni connesse con le diverse valutazioni
dell’opera di Dworkin e dei suoi impatti sul pensiero giuridico contemporaneo. Ci limitiamo a
osservare che la sua opera rappresenta oggi un riferimento imprescindibile non solo per il dibattito
filosofico giuridico, ma anche per la teoria liberale dell’etica, dell’eguaglianza e della democrazia.
NOTE
* Ronald Dworkin, scomparso il 14 febbraio 2013, è stato uno dei giuristi più influenti degli ultimi
decenni. Nato nel 1931 a Providence, Rhode Island, dopo aver studiato all’Università di Harvard e
al Magdalen College dell’Università di Oxford, ha insegnato alle Università di Yale, Oxford e New
York. Tra suoi lavori principali (tutti tradotti in italiano) ricordiamo: Taking Rights Seriously
(1977); A Matter of Principle (1985); Law’s Empire (1986); Life’s Dominion (1993); Freedom’s
Law (1996); Sovereign Virtue (2000); Is Democracy Possible Here? (2006); Justice in Robes
(2006); Justice for Hedgehogs (2011).
1 R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge,
MA, 2011, sostiene che il diritto è una parte della moralità politica.
2 Nelle sue diverse opere, Dworkin per spiegare questa dimensione ha fatto riferimento a casi
giudiziari nei quali emergono dei disaccordi “teoretici”, cioè disaccordi su quale sia effettivamente
il diritto da applicare a questi casi. La questione giudiziaria più nota è sicuramente Riggs v. Palmer
(un caso nel quale la Corte dello Stato di New York si appella al principio non statuito per il quale
“non si può trarre vantaggio da un illecito” per la sua decisione). A questa questione si può
aggiungere quella inglese McLoughlin v. O’ Brien nella quale le decisioni delle Corti nei tre livelli
di giudizio si appellano a valori diversi per decidere il caso. I due casi sono discussi in R. Dworkin,
L’impero del diritto, Il Saggiatore, Milano, 1989.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
3 R. Dworkin, La giustizia in toga, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 16.
4 Sui lineamenti dell’eguaglianza liberale, R. Dworkin, Virtù sovrana. Teoria dell’uguaglianza,
Feltrinelli, Milano, 2002.
5 Su questi aspetti, si veda R. Dworkin, Constitutionalism and Democracy, in “European Journal of
Philosophy”, n. 1, 1995.
6 R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, cit., p. 14.
Giorgio Bongiovanni (CIRSFID e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Bologna), è docente di Filosofia del diritto. Tra le sue pubblicazioni, Costituzionalismo e teoria
del diritto, Laterza, 2005; Oggettività e morale (a cura di), B. Mondadori, 2007; la voce
“Neocostituzionalismo” in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 2011.
Giovanni Sartor (CIRSFID e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna;
Istituto Universitario Europeo di Firenze), è docente di Informatica giuridica e di Teoria del
diritto. Tra le sue pubblicazioni Legal Reasoning: A Cognitive Approach to the Law, Springer,
2005 e L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Giappichelli, 2012.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Alienazione e natura umana. In dialogo con Sean Sayers
di MARCO PIASENTIER e ANDREA SOARDO
In questa intervista, Sean Sayers, uno dei più importanti fra i filosofi inglesi appartenenti alla
tradizione marxista, ha risposto ad alcune domande circa il rapporto fra natura umana e
alienazione, cercando di chiarire in che modo si dispongono all’interno del pensiero marxiano.
Vorremmo aprire questa intervista con una breve domanda biografica inerente la sua
provenienza filosofica. Quali sono gli autori che l’hanno maggiormente influenzata e com’è
arrivato allo studio del marxismo?
Iniziai i miei studi filosofici a Cambridge per poi ultimarli all’università di Oxford. Mi distaccai
presto dalla filosofia analitica e, attraverso la lettura di Laing e Marcuse, mi interessai alle idee di
Freud e Marx. Quando cominciai ad insegnare mi impegnai per la diffusione di idee anche
fondando la rivista Radical Philosophy. Scopo di questo giornale era ed è tuttora fornire un forum
per la discussione di idee radicali in filosofia. Si trattò di un successo immediato che favorì un
rinnovamento nel modo stesso di insegnare la filosofia: Freud e Marx e tutti i pensatori continentali
furono, per la prima volta, oggetto di corsi nelle università inglesi. Uno stimolo
all’approfondimento della filosofia sociale radicale lo trovai nella mia stessa tradizione familiare:
infatti mia madre era la figlia di Luigi Galleani, un famoso anarchico italiano che ebbe tra gli altri
Sacco e Vanzetti come suoi seguaci.
Uno degli obiettivi di Knots consiste nel prendere in esame argomenti che permettano di
mettere in luce le differenze e i nessi tra la cosiddetta tradizione analitica e continentale. La
nozione di natura umana ci sembra uno di questi argomenti; il dibattitto tra Chomsky e
Foucault è probabilmente l’esempio più noto di un’antica querelle sulla definizione di questo
concetto. Sebbene non possibile creare una netta separazione tra le due tradizioni e si
debbano, piuttosto, rintracciare delle somiglianze di famiglia, le posizioni di Chomsky e
Foucault permettono di isolare due nuclei in chiara opposizione. Secondo il programma di
naturalizzazione della mente e del linguaggio proposto da Chomsky, il comportamento umano
può essere spiegato attraverso un ‘gruppo di schemi, di principi organizzativi innati’[1]. Al
contrario, Foucault, in ultima analisi, definisce la natura umana come un ‘indicatore
epistemologico’, attribuendo ad essa la sola funzione di marcare linee di esclusione-inclusione
all’interno delle nostre società. Il marxismo apre una prospettiva differente, che permette di
collocarsi a cavallo tra le prime due. Uno dei suoi libri si intitola Marxismo e natura umana[2].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
La prima domanda che vorremo farle riguarda precisamente questa nozione e più nello
specifico il modo in cui può essere definita alla luce della teoria di Marx?
Elogio lo scopo della vostra rubrica volto ad incoraggiare un dialogo tra filosofia analitica e
continentale. Questo è stato anche uno degli obiettivi guida nel dar vita alla rivista Radical
Philosophy. Le due definizioni di natura umana che descrivete hanno sostenitori in entrambe le
tradizioni e come correttamente sostenete, in Marxismo e natura umana, spiego come il marxismo
rappresenti una terza alternativa.
A dispetto dell’enorme divario che separa filosofia analitica e continentale, entrambe sono unite
dall’ostilità nei confronti di Hegel. Questa è un’altra ragione per cui il marxismo rappresenta una
terza alternativa ed è impossibile avere una comprensione profonda del pensiero di Marx senza
riconoscere il debito che tale pensiero ha nei confronti di Hegel. Un importante obiettivo del mio
libro consiste nel sottolineare e dimostrare questa connessione.
Ritengo che il marxismo chiami in causa una forma di umanesimo storico che affonda le sue radici
nella filosofia hegeliana. Contrariamente a quanto si ritiene solitamente, ‘umanesimo storico’ non è
una definizione contraddittoria. Il marxismo è una forma di umanesimo. Marx critica il capitalismo
e difende il comunismo in senso umanista. E’ impossibile negare ciò. Inoltre, ci sono caratteristiche
universali chiaramente condivise da tutti gli esseri umani, in quanto organismi biologici (ad
esempio, il bisogno di un minimo di cibo, acqua e protezione). Ma non è, a mio avviso, corretto
enfatizzare solo questo aspetto (come nel caso di Norman Geras, per esempio), in quanto va anche
tenuto in considerazione che gli esseri umani si sviluppano storicamente e socialmente. Marx,
seguendo Hegel, sottolinea in modo eguale il carattere storico e sociale della natura umana, dei
nostri bisogni e delle nostre capacità. In tempi recenti questa posizione è stata spesso interpretata
come un rifiuto dell’idea di natura umana stessa. Questa tipo di ‘anti-umanesimo’, caratterizzato dal
rifiuto di ogni caratterizzazione storica, è altrettanto erroneo. Non c’è dubbio che la natura umana,
in ogni momento dello sviluppo, è presa entro le maglie della storia e quindi è relativa, ma ciò non
toglie che essa sia completamente malleabile: essa si sviluppa sulla base dei bisogni materiali e
delle relazioni sociali, il risultato è la base data ed oggettiva per comprendere e giudicare, ad ogni
stadio, l’attività umana.
Nel suo libro dedicato alla natura umana lei porta alla luce ed affronta un nodo cruciale nel
pensiero di Marx. Come lei stesso scrive, da un lato Marx sviluppa una teoria della storia
oggettiva e scientifica, ‘un principio fondamentale secondo cui i valori morali - inclusi quelli
del marxismo stesso - sono prodotti sociali e storici. Dall’altro, il marxismo non si propone
come un approccio «neutrale o imparziale»: la condanna al capitalismo e il sostegno al
socialismo emergono chiaramente nella teoria marxista; una prospettiva critica è intrinseca
ad essa’ (p. 130). Come possiamo articolare una relazione tra questi due punti
apparentemente contraddittori?
Questa è una domanda cruciale: si tratta di una questione estremamente controversa ed è stata
oggetto di un largo dibattito negli ultimi anni, soprattutto sul versante analitico del marxismo. Uno
degli obiettivi portanti del mio libro, Marxismo e natura umana, consiste proprio nell’affrontarla a
viso aperto. Come mettete in luce nella vostra domanda, il marxismo viene spesso accusato di
riposare su una contraddizione. I pensatori analitici che si sono fatti portavoce di questa critica
sono, in particolare, G.A. Cohen e Norman Geras. Essi ritengono che la teoria sociale di Marx,
secondo cui i valori politici e morali sono prodotti storico-sociali, conduca inevitabilmente ad una
forma di relativismo puro. In altre parole, se i nostri valori sono prodotti della società presente,
questi valori possono solo riflettere le condizioni esistenti, rinforzando così l’ordine stabilito. Ne
segue che la critica in generale, e quella marxista in particolare, deve fondarsi su principi trans-
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
storici (sebbene Marx vorrebbe sostenere il contrario). La posizione difesa da Cohen e Geras porta
quindi a concludere che la teoria marxista debba essere divisa in due aspetti tra loro indipendenti.
Da un lato va sviluppata una posizione etica e politica che faccia appello a valori trans-storici;
dall’altro, va pensata una teoria sociale scevra da qualsiasi valore etico-politico.
Al contrario, è mia ferma convinzione che il marxismo non può essere compreso in questi termini,
in quanto esso è l’intreccio inscindibile di una prospettiva pratico-sociale e critica, entrambi questi
aspetti sono inseparabili e vanno presi in esame come costitutivi di un unico insieme. La critica al
capitalismo va considerata come immanente e non trascendente; le condizioni esistenti stesse
contengono la base per la prospettiva critica, senza che vi sia alcun bisogno di fare appello a valori
trans-storici per questo. L’ordine sociale esistente non è un’unità monolitica, ma è abitato da un
insieme di conflitti e contraddizioni. Quindi non vi è alcun bisogno di gettare lo sguardo oltre esso
per trovare delle linee di fuga, delle tendenze critiche e contraddittorie.
Va anche tenuto sempre in considerazione che l’ordine sociale non ha un carattere statico e fisso. I
conflitti sociali conducono al cambiamento sociale e quest’ultimo non consiste in una successione
arbitraria di differenti tipi di società. Nel normale corso di sviluppo, le società europee si sono
mosse da uno stadio feudale al capitalismo; e, come sappiamo, Marx ritiene che le contraddizioni
del capitalismo condurranno, alla fine, al comunismo.
Questa teoria storica fornisce le basi per il metodo critico di Marx, il quale è basato su standard
storici e relativi – ed è realista proprio per questa ragione. Relativamente alle condizioni feudali che
lo precedono, il capitalismo rappresenta uno sviluppo. Ma, con il venire alla luce in modo sempre
più inteso delle sue contraddizioni, e con lo svilupparsi al suo interno di condizioni che rendono il
socialismo possibile, il capitalismo diventa progressivamente di ostacolo ad un ulteriore sviluppo e
quindi non è più progressivo.
In questo modo, il marxismo critica il capitalismo - non facendo appello a valori universali
apparentemente senza tempo – ma sulla base di tendenze attuali verso il comunismo che sono
immanenti al capitalismo stesso. Come Marx e Engels sostengono nella Ideologia Tedesca: Il
comunismo, per noi, non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà
dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose
presente.[3]
Il marxismo, quindi, comporta una teoria storica e questa si articola a partire dal concetto di
progresso. Questo è spesso criticato dai marxisti di matrice analitica, in quanto sostengono che il
ricorso a questo concetto viola la distinzione fatti-valori, non potendo quindi fornire la base per dei
valori. Se il termine ‘progresso’ viene usato in modo puramente fattuale per significare ‘ciò che
segue’, essi sostengono, esso non può fornire alcun terreno per fondare dei valori. Se, invece,
incorpora tacitamente dei valori e questi valori devono essere giustificati, tale processo di
giustificazione non può essere compiuto sulla base di un approccio fattuale alla storia. Marx viene
quindi accusato di cercare di derivare valori da fatti, commettendo quindi la cosiddetta ‘fallacia
naturalistica’.
Il marxismo è una forma di naturalismo, ma questa non è una fallacia. Al contrario, il naturalismo è
un solido approccio nel pensiero etico e politico. Come i filosofi naturalisti, a partire da Aristotele,
sostengono, alcuni fatti hanno implicazioni valutative, nella fattispecie, riguardo le condizioni
necessarie affinché l’essere umano possa prosperare. L’idea che il naturalismo sia una fallacia
presuppone una distinzione dualista tra fatti e valori che è inaccettabile.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Il marxismo è una teoria storica, ma questo non significa che sia una teoria puramente descrittiva ed
esplicativa sul modello della fisica o della chimica. Al contrario, essa implica sia valori politici che
il compito di assolvere fini pratici ad essa intrinseci. Secondo Marx, lo sviluppo storico significa
crescita delle capacità e del potere materiale umano, una crescita della natura umana e dei bisogni.
Ritengo che la riconciliazione di Marx tra il versante storico e ‘sociale-scientifico’(il sociale e
l’economico) del suo pensiero e quello inerente la sua politica sia basato in ultima analisi su questa
teoria storica.
Affermare che esita una nozione di natura umana che possa fungere da misura per le diverse
culture umane solleva uno sciame di problemi e questioni sia etiche sia ontologiche. Lei ritiene
che, in una prospettiva marxista, si possa e si debba sostenere l’esistenza di una nozione di
natura umana che serva da guida per la realizzazione di una ‘società veramente umana’?
Ritengo che il marxismo sia una forma di umanesimo e il suo fine consista nel creare una ‘società
veramente umana’. Con ciò intendo, come ho precedentemente affermato, che esistono
caratteristiche universali della natura umana, per esempio abbiamo tutti bisogno di una minima
quantità di cibo e acqua per sopravvivere. Il marxismo non mette in discussione questo assunto. Ci
sono aree del mondo dove questa minima quantità non è assicurata e, persino nelle nazioni
opulente, c’è un serio problema di accesso ai beni di sussistenza. Certamente il marxismo condanna
queste condizioni e le combatte. A tale scopo è sufficiente fare appello alle caratteristiche universali
della natura umana. Nulla di più è necessario.
Ma il marxismo non si limita a tutto ciò. L’idea di una ‘società veramente umana’ richiede di più
che le mere risorse per la sussistenza: i bisogni umani non si limitano ad esse. Al pari delle nostre
capacità produttive si sviluppano anche i nostri bisogni. Questi bisogni più complessi sono la base
per le idee marxiane. Infatti il marxismo immagina una società in cui noi - ogni essere umano e non
solo pochi privilegiati - possiamo fiorire e realizzare pienamente le nostre capacità - una società
disalienata che promuove uno sviluppo completo dell’essere umano ‘ricco in bisogni’. Al fine di
comprendere come questi temi si dispiegano nel pensiero marxiano è essenziale una nozione
articolata e storica di natura umana che sta alla base della sua idea di “società veramente umana” e
dello stesso programma marxista. Lo sviluppo delle nostre capacità produttive è oggi spesso visto
come minaccioso e pericoloso. Esse sembrano essere diventate forze ostili e aliene che ci
opprimono invece di liberarci e che minacciano di distruggere il nostro ambiente e persino l’intero
pianeta. La visione marxista della società, basta sulla crescita delle nostre capacità produttive, è
spesso criticata perché ritenuta non più accettabile in un mondo segnato dalla minaccia della
catastrofe ambientale. Non c’è dubbio che sotto il capitalismo, le nostre capacità produttive, che
potrebbero e dovrebbero essere utilizzate per accrescere il benessere umano, spesso assumano una
forma aliena e ostile e servano ad opprimerci e a distruggere le condizioni della vita umana. Ma è
necessario comprendere le ragioni di questi fenomeni. E’ errato pensare che lo sviluppo materiale in
quanto tale sia dannoso, desiderando così condizioni più semplici e meno sviluppate. In modo
almeno potenziale lo sviluppo delle nostre capacità produttive può essere usato per creare una
società veramente umana che realizzi il bene per l’uomo. Dobbiamo ricondurle sotto il controllo
dell’uomo utilizzandole non per il profitto di pochi ma per il bene di tutti. Questo è ciò per cui
dovremmo combattere.
Il suo ultimo libro è intitolato Marxsimo e alienazione. Saggi su temi hegeliani[4].
L’alienazione è uno dei principali e più caratteristici concetti marxiani. Alla luce dei suoi
studi, può darci una breve chiarificazione di questa idea?
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Sono d’accordo che il concetto di alienazione sia uno dei concetti capitali di Marx; e mi preme
affermarlo anche considerato il modo in cui tale concetto è stato sottovalutato dai marxisti analitici
e rifiutato da Althusser e dai molti marxisti da lui influenzati.
Il concetto di alienazione è uno dei pochi termini marxiani passati nel linguaggio quotidiano. Nella
filosofia marxiana, esso significa il modo in cui, specialmente nel capitalismo, le nostre attività e i
nostri prodotti assumano una forma a noi avversa. Marx descrive l’alienazione nella religione, nelle
relazione sociali ma soprattutto nel mondo economico. In esso il lavoro diventa pura fonte di
guadagno e base per lo sfruttamento dell’uomo. La stessa economia diventa un potere che lavora
contro di noi, minacciando il nostro benessere. Possiamo e dovremmo essere in grado di realizzare
noi stessi attraverso il lavoro e le relazioni sociali. Il capitalismo tuttavia nega tali possibilità – ciò è
la base su cui Marx fonda la sua critica. Al contrario, Marx immagina un mondo in cui ci
riappropriamo del nostro lavoro, dell’economia al fine della realizzazione del bene generale invece
che del profitto di pochi.
Marx eredita il concetto di alienazione da Hegel, dal quale eredita inoltre l’approccio dialettico e
storico. E’ infatti sotto questa luce che va compresa l’alienazione. Essa non è una caratteristica della
condizione umana o una malattia morale, ma un fenomeno storico.
Lo sviluppo umano accade attraverso un processo di alienazione e il suo sviluppo. Pertanto,
l’alienazione non è una nozione puramente negativa. Esso è innanzitutto un concetto storico. Ciò
non significa che Marx non sia critico del capitalismo e del suo impatto. Infatti, lo scopo centrale
del concetto di alienazione è proprio di esprimere tale critica, che è storica. Tale concetto non mira
solo a criticare il capitalismo ma anche a comprenderne lo sviluppo: l’alienazione non è il semplice
male morale. Il giudizio che essa implica è storico e relativo. Nella precedente età feudale, le
relazioni economiche erano dirette e personali. L’alienazione, nella sua forma moderna, era quasi
del tutto assente. Con l’avvento del capitalismo le possibilità di una società disalienata aumentano,
ma anche le relazioni economiche diventano più oppressive.
Marx ritiene che alla fine le stesse forze contraddittorie presenti nel capitalismo condurranno le
persone a respingerlo, dando così vita a quella società veramente umana di cui parlavamo prima.
Una società in cui una completa – o, forse, più completa forma - di sviluppo umano sarà possibile.
Dal suo punto di vista, come si configurerà, secondo la filosofia marxiana, il mondo non più
alienato? E come interpreta la presente situazione socio-economica?
Il superamento dell’alienazione porterà una trasformazione radicale della società; non solo
l’abolizione della proprietà privata del capitale ma anche l’eliminazione delle forme alienate di
lavoro e di mercato. Ciò che Marx immagina è una società governata dal principio: “Da ciascuno
secondo le sue abilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Il denaro e i salari saranno eliminati,
mentre i beni e i servizi saranno prodotti volontariamente e distribuiti secondo i bisogni (questo è un
aspetto discusso che affronto nel mio libro). Le persone lavoreranno perché vogliono e non perché
sono costrette.
Certamente, queste sono idee radicali e visionarie ma non impossibili. Sono invece in parte
realizzate nella società contemporanea. Ad esempio, nel National Health Service in Gran Bretagna,
avviene una distribuzione in base ai bisogni.
La stessa crisi attuale conferma la filosofia marxiana. Tuttavia, questa crisi è un fenomeno
puramente negativo, ed una delle lezioni di questi ultimi anni è che molto più di questo è necessario
per un cambiamento del sistema. Una trasformazione radicale avverrà solo quando gli agenti
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
positivi incominceranno farsi strada. Secondo Marx ciò sarà possibile nella fase avanzata del
capitalismo.
Penso che alla fine l’idea marxiana di una comunità cooperativa si realizzerà. Questa è l’idea che ha
ispirato mio nonno e mia madre e che cerco di esprimere nel mio lavoro.
NOTE
[1] N. Chomsky e M. Foucault, Della natura umana. Invariante biologico e potere politico,
DeriveApprodi, 2005, p. 11.
[2] S. Sayers, Marxism and Human Nature. Routledge, 1998 (edizione paperback 2007).
[3] Karl Marx and Frederick Engels, The German Ideology Part I. International Publishers, New
York, 1970, pp. 56-7. Ed. italiana, Karl Marx e Frederick Engels, Ideologia tedesca, Editori Riuniti,
1971.
[4] Marx and Alienation: Essays on Hegelian Themes (Palgrave Macmillan, 2011)
Sean Sayers è professore emerito di filosofia all’Università del Kent. E’ stato uno dei
fondatori della prestigiosa rivista Radical Philosophy ed è attualmente editore di Marx and
Philosophy Review of Books. I suoi interessi di ricerca includono la filosofia sociale, la filosofia
della storia e la filosofia morale ed ha scritto testi di significativa importanza sulla filosofa di
Hegel e Marx. Tra i titoli più rilevanti si ricordano Marx and Alienation: Essays on Hegelian
Themes (Palgrave Macmillan, 2011), Plato's Republic: An Introduction (Edinburgh University
Press, 1999), Marxism and Human Nature (Routledge, 1998, paperback 2007), Reality and
Reason. Dialectic and the Theory of Knowledge (Blackwell, 1985), and Hegel, Marx and
Dialectic: A Debate (with Richard Norman 1980, ristampato con Gregg 1994).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Rileggere Marx con le lenti della filologia
di ROBERTO FINESCHI
È da poco uscita la nuova edizione italiana del I libro del Capitale per le Opere Complete di Marx
ed Engels. Il curatore, Roberto Fineschi, ci spiega perché era necessario mettere mano a questa
opera di rinnovamento editoriale.
1. La nuova edizione del I libro del Capitale da me curata per le Opere Complete di Marx ed Engels
(vol. XXXI, Napoli, La città del sole, 1600 pagine) è il tentativo di presentare al lettore italiano lo
stato dell'arte dopo le significative novità emerse nel corso della pubblicazione della nuova edizione
storico-critica, la seconda Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2), monumentale progetto in 114
volumi in corso di realizzazione da quasi quarant'anni e lungi dal completamento[1].
La circolazione delle opere di Marx è stata scarsa negli ultimi decenni; recentemente si è assistito
alla ripresa di alcune pubblicazioni, fatto da salutare positivamente. Tuttavia, nella quasi totalità dei
casi si sono semplicemente riproposti i vecchi testi, oppure li si è ripresentati sulla base delle
edizioni tradizionali. La grande novità della MEGA consiste invece, sostanzialmente, nell'aver
mostrato come molte delle opere più significative di Marx fossero in realtà una cosa diversa rispetto
a quelle storicamente lette. A cambiare sono quindi non tanto, o non solo, le interpretazioni di Marx
o Engels, ma la stessa base testuale su cui tali interpretazioni si sono sviluppate o possono
svilupparsi. La nuova edizione del primo libro del Capitale muove, prima nel mondo occidentale,
da questa premessa.
È noto che Marx non ha pubblicato personalmente il secondo ed il terzo volume; fu Engels a farlo
dopo la sua morte, rispettivamente nel 1885 e nel 1894. Per il secondo, egli disponeva di 8
manoscritti redatti dal 1864 alla fine degli anni 70, a livelli assai diversi di compiutezza, nessuno
comunque pronto per la stampa[2]; per il terzo aveva sostanzialmente un grande manoscritto del
1864/5 e poche rielaborazioni successive di scarsa ampiezza[3]. Il terzo libro, seppur uscito per
ultimo, è dunque, in verità, poco più che allo stato di abbozzo; meglio vanno le cose per il secondo,
benché, pure in questo caso, non esista in alcun modo una versione definitiva. Il primo libro è
apparentemente quello più compiuto, in quanto Marx stesso ne dette alla stampe due edizioni
tedesche – 1867 e 1872/3 – ed una francese – 1872-5 –, tutte con moltissime varianti. Anche del
primo, tuttavia, non disponiamo di un’edizione definitiva in quanto l’ultima uscita nel tempo, la
francese, è considerata da Marx migliore per il contenuto, ma decisamente insufficiente a livello
linguistico[4]. Nel 1883, anno della morte di Marx, Engels diede alle stampe la terza edizione
tedesca, alla quale Marx non partecipò in prima persona; aveva lasciato degli indici e delle
annotazioni a margine nelle edizioni precedenti, ma sarà Engels a seguire e a non seguire le sue
indicazioni[5]. Da ciò sono risultate situazioni paradossali, per es. relativamente alla divisione in
capitoli e sezioni, per cui chi segue l'edizione francese ed inglese ha una divisione, chi segue la
tedesca e le traduzione da essa derivate, ne ha un'altra. L'unico testo pubblicato da Marx è
paradossalmente quello su cui ci si intende meno. Insomma: per comprendere Marx non si può
prescindere dalla complessa stratificazione del testo, che, nel caso della teoria del capitale, consiste
di ben 15 volumi in 24 tomi, vale a dire tutta le seconda sezione della MEGA.
2. Questa edizione intende presentare al lettore italiano tutti i testi a noi pervenuti che Marx scrisse
con l’intenzione esplicita di realizzare il I libro del Capitale. Nel far questo si è cercato di tener
conto di un certo numero di traduzioni esistenti – italiane e non –, sia da un punto di vista
linguistico che editoriale in senso più generale. Nessuna di esse – ad eccezione, in parte,
dell’edizione in castigliano a cura di P. Scaron – è all’altezza della problematica odierna. Il fatto
fondamentale è infatti che oggi, dopo la MEGA, non si sa esattamente cosa pubblicare quando si
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
intende dare alle stampe il I libro del Capitale. Qual è l’edizione di riferimento se non ne esiste una
di ultima mano di Marx? Si è visto che non è possibile utilizzare la francese per vari motivi. Le
scelte sono allora due: o la II ed. tedesca, o la IV (in cui Engels continua ad inserire (pochi)
passaggi dalla francese, ma che per il resto è quasi uguale alla III). Nel 1975, in chiave
antiengelsiana e con l'idea di pubblicare un “autentico” testo marxiano, nella sua edizione in
castigliano Scaron decise di usare la II, mettendo come varianti le versioni successive. Se questa
scelta è per certi aspetti legittima, si presta tuttavia a critiche a mio parere sostanziali; la principale è
la seguente: troviamo in nota, e non nel testo principale, parti non solo considerate da Marx
superiori, ma effettivamente da lui pubblicate nell'ed. francese; i materiali “vecchi” si trovano
invece nel testo principale. Usando al contrario la IV (sostanzialmente uguale alla III), si ha almeno
la maggior parte di quel contenuto nel corpo del testo. Si noti comunque, per es., come nessuna
delle due scelte (II o IV ed. tedesca) presenti il testo principale secondo la suddivisione “finale”
dell’ed. francese. In realtà, unica soluzione sarebbe pubblicare tutte le edizioni integrali, operazione
editorialmente proibitiva. “Creare” un’opera, ricostruendo il testo sulla base dei manoscritti
marxiani per il I volume sarebbe operazione redazionale, di cui sarebbe difficile valutare la
“marxianità”. In questa edizione è parso dunque ragionevole adottare come base testuale la IV ed.
tedesca del 1890 a cura di Engels; rispetto ad essa si sono date le principali varianti di tutte le altre
(I, II, III ed. tedesca, ed. francese). I testi di riferimento sono quelli apparsi nella MEGA, II sezione,
voll. 5-10.
Non si fornisce tuttavia solo il tradizionale testo del Capitale con le sue varianti; oltre ad esse
(centinaia di pagine) si ha la prima traduzione del Manoscritto 1871-1872, presentato secondo la
ricostruzione critica data nel vol. 6 della II sezione della MEGA; si tratta di un testo molto
interessante, in quanto è il cantiere di lavoro per la totale riscrittura del primo capitolo sulla Merce
del 1867 e della relativa appendice per i “non-dialettici” in preparazione della II ed. tedesca e
dell'ed. francese. Esso dà delle indicazioni fondamentali su come leggere il testo a stampa. Si ha
infine una nuova traduzione del cosiddetto VI capitolo inedito tratto dal manoscritto 1863/4
secondo quanto pubblicato nella MEGA, II sezione, vol. 4.1.
Vediamo infine, brevemente, come sono strutturati i due tomi. Nel primo il lettore trova il testo
della IV ed. tedesca. Nel secondo tomo si hanno le varianti dalla I, II e III edizione tedesca e dalla
francese, i due manoscritti indicati (I parte del Manoscritto 1863-65 – il cosiddetto “VI capitolo
inedito” – ed il Manoscritto 1871/2) e tutti gli strumenti critici: glossario, note esplicative e indici
(pesi e misure, letteratura citata, nomi, argomenti). Si tratta, complessivamente, di circa 1600
pagine.
3. Per quanto riguarda la traduzione, è noto il detto “traduttore-traditore”; valido in genere, esso
assume un particolare significato nel caso del Capitale, un mix di linguaggio hegeliano, sarcasmo
pubblicistico, verve umoristica, e via dicendo. Difficile rendere tutto ciò. Si è cercato di fare il
possibile per la vivacità dello stile, ma, in relazione alle problematiche più strettamente scientifiche,
è parso necessario dedicare alcune pagine alla spiegazione della traduzione di alcuni termini chiave.
Le scelte fatte in questa nuova edizione si legano, infatti, ai problemi emersi dal confronto fra le
traduzioni esistenti e le problematiche metodologiche sviluppatesi parallelamente alla pubblicazione
della nuova edizione storico-critica.
Si era inizialmente pensato di utilizzare la traduzione Cantimori e di dare semplicemente le varianti.
Pur restando essa un valido strumento anche a distanza di tempo, ci si è resi conto, tuttavia, di
come, similmente a quanto accaduto nella maggior parte delle traduzioni occidentali esistenti, non
si fosse riusciti in quella sede a risolvere vari e significativi problemi legati alla complessità
categoriale del testo, soprattutto nei primi capitoli. Tale insufficienza ha reso impossibile a chi non
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
potesse accedere al testo tedesco una più profonda comprensione delle problematiche
metodologiche e dell'effettivo sviluppo categoriale.
Per quanto riguarda la quarta edizione tedesca, si sono allora ritradotti ex-novo i primi sette capitoli
e si è significativamente rivista la parte restante (le traduzione delle varianti e degli altri manoscritti
sono tutte nuove). Come accennato, per un principio di trasparenza e chiarezza, si è deciso di
rendere conto delle scelte di traduzione in un ampio glossario. Tradurre un certo termine in un certo
modo significa, infatti, fare delle scelte interpretative. Se ciò è inevitabile, pare corretto palesarlo.
Ecco qui una lista di alcune delle categorie interessate di ciascuna delle quali si rende:
Veräußerung/Entäußerung, Ding/Sache, wirklich/reell, darstellen/vorstellen/repräsentieren,
Erscheinung/Schein e varie altre.
Per questa via, il lettore ha accesso al testo tedesco e, se pur dissentisse con la scelte adottate,
avrebbe la possibilità di risalire al termine/categoria in questione.
4. Non in questa sede vorrei parlare delle possibili nuove interpretazioni del testo, per non
sovrapporle al carattere critico dell'edizione. In maniera più generale mi pare si possa tuttavia
affermare che diverse delle interpretazioni tradizionali, anche relativamente a punti fondamentali
diventati senso comune perché trasformati in assiomi da manuale, paiono, direi, “imprecise” ad una
lettura filologica e disinteressata del testo. Con ciò intendo dire che anche sviluppi sofisticati della
teoria di Marx, risultato di dibattiti complessi e di grande valore conoscitivo, non di rado hanno
preso le mosse da una non precisa formulazione dei presupposti. Credo che il grande contributo
della filologia, in un momento di crisi e ristagno generale nel panorama teorico in qualche modo
connesso a Marx, stia non tanto nel far rivivere dibattiti secolari ormai sostanzialmente chiusi da
decenni, o nell'andar oltre quel Marx mal letto, quanto nel ripensare la correttezza delle premesse di
quelle interpretazioni, il loro fondamento filologico. A me sembra che, pur nell'ampio spettro delle
letture possibili, la filologia aiuti ad escluderne alcune sicuramente infondate, o a dare maggiore o
minore supporto ad altre plausibili. A mio parere è questa la scelta più proficua e scientificamente
feconda da fare e mi auguro che questa nuova edizione possa contribuire in tal senso.
[1] Per maggiori informazioni sulla MEGA rimando al mio Un nuovo Marx, Roma, Carocci, 2008
ed al volumetto in corso di pubblicazione MEGA2, Marx ritrovato, a cura del compianto A.
Mazzone, Roma, Mediaprint.
[2] Sui manoscritti per il II libro rimando al mio Il secondo libro del Capitale dopo la MEGA2 in
“Marxismo oggi”, 2010/3, pp. 32 ss., ripreso nella nuova introduzione al menzionato libro curato da
A. Mazzone. pp. 25 ss.
[3] Sui principali problemi legati al manoscritto per il terzo libro del 1864/5 in rapporto al libro a
stampa, rimando al mio Ripartire da Marx, Napoli, La città del sole, 2001, pp. 370 ss.
[4] Il fatto che Marx stesso abbia detto che questa edizione era da preferire ha spinto molti a
ritenerla migliore “in generale”. In realtà, la ricostruzione filologica permette di mostrare con
estrema precisione quali siano le migliorie e quali i difetti. Senza entrare nel merito di questo
dibattito, per il quale rimando alla mia Introduzione al Capitale, si può affermare che le migliorie
sono da trovarsi nella settima sezione sull'accumulazione, mentre i difetti sono....la traduzione
stessa, che per circa un terzo del testo si discosta significativamente dall'originale, al punto che non
vi si trova addirittura il concetto di “valorizzazione”!
[5] Cfr. K. Marx, Verzeichnis der Veränderungen für den ersten Band des "Kapitals“ in K. Marx,
F. Engels, Gesamtausgabe, sez. II, vol. 8, Berlin, Dietz, 1989.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Roberto Fineschi ha studiato filosofia ed economia a Siena, Berlino e Palermo. Fra le sue
pubblicazioni ricordiamo Ripartire da Marx (Napoli 2001), Marx e Hegel (Roma 2006) e Un
nuovo Marx (Roma 2008). Vincitore del premio Rjazanov, è membro dell'International
Symposium on Marxian Theory, con il quale ha pubblicato vari saggi e libri, fra cui Re-reading
Marx. New perspective after the critical edition, Palgrave 2009.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Nuovi orizzonti per la filosofia del linguaggio
di CLAUDIO FASCHILLI
A cavallo tra il XIX e il XX secolo nasceva la cosiddetta "filosofia del linguaggio". Quali sono state
le sue principali caratteristiche e verso quali nuovi orizzonti si sta muovendo oggi? Ma,
soprattutto, quale può essere il ruolo del filosofo del linguaggio nell'attuale panorama scientifico,
che vede il proliferare di numerose discipline che si occupano specificamente del linguaggio
naturale?
Non ritengo di dire un’assurdità se affermo che il linguaggio è uno degli aspetti dell’essere umano a
cui è stata dedicata maggiore attenzione nella storia del pensiero occidentale. Il motivo di tanto
interesse è presto compreso se consideriamo quanto sia importante possedere un linguaggio per le
dinamiche della nostra vita sociale, culturale e interpersonale. Grazie alla nostra facoltà di
linguaggio siamo, infatti, in grado di scambiare opinioni e conoscenze, di scrivere e di leggere, di
ascoltare o di seguire lezioni, conferenze, programmi televisivi e radiofonici, ma anche di dichiarare
guerre, di stipulare una pace, di sposare qualcuno, di esprimere sentimenti ed emozioni e persino di
riflettere e di ragionare con noi stessi.
A fronte di tutto ciò, potrà risultarci non così sorprendente la gran quantità di discipline che,
partendo da prospettive differenti e concentrandosi su distinte componenti, si sono occupate e
ancora oggi si occupano del linguaggio naturale. Mi riferisco, ad esempio, alla psicologia, alle
neuroscienze, alla linguistica, alla psicolinguistica, alla glottologia, all’ermeneutica, alla fonologia,
alla semiotica, alla sociolinguistica, alla lessicografia; e, non ultima, alla filosofia.
Ebbene, di fronte a una tale proliferazione di discipline, sarebbe opportuno soffermarsi a porre una
domanda almeno apparentemente semplice: qual è il ruolo che la filosofia ha avuto nello studio del
linguaggio e qual è il suo ruolo attuale? E quale contributo possono dare oggi i filosofi a tale
ricerca?
Cominciamo col dire che da un punto di vista storico sarebbe certamente più corretto invertire
l’ordine delle discipline sopra citate, dando alla filosofia non l’ultimo posto, bensì il primo. Infatti, i
primi a porsi domande specifiche sul linguaggio furono proprio dei filosofi e in particolare i
cosiddetti “filosofi naturalisti”, alcuni dei quali, tra il VI e il V secolo a.C., iniziarono a indagare
quale fosse la relazione sussistente tra le parole e la realtà esterna. Possiamo perciò già osservare
come la filosofia ai suoi primordi si rivolse alla sfera del linguaggio a partire da una prospettiva
squisitamente ontologica, analizzando il legame linguaggio-mondo.
Già in Eraclito, ad esempio, era possibile rinvenire un segno di tale relazione: dico questo pensando
ai frammenti in cui il filosofo di Efeso utilizzava il termine logos attribuendogli una pluralità di
significati, indicando ora la legge che governa il divenire di tutto l’esistente ora il discorso – e
quindi l’aspetto linguistico – con il quale il saggio è in grado di parlare, di descrivere e perciò di
comprendere tale legge. Una stretta relazione tra linguaggio ed essere era poi riscontrabile anche in
Parmenide, il quale sosteneva che si può parlare solo di ciò che è, mentre di ciò che non è nulla può
esser detto.
Il primo filosofo, tuttavia, a fornire una sistematizzazione di queste riflessioni fu proprio Platone nel
suo dialogo Cratilo, dove espose in modo chiaro e analitico le due possibili posizioni in merito al
rapporto sussistente tra linguaggio e realtà. Platone poneva da un lato la tesi difesa da Cratilo – una
tesi “naturalistica” – secondo la quale le parole rispecchierebbero la realtà, e vi contrapponeva
dall’altro lato la tesi sostenuta da Ermogene – tesi “convenzionalista” – per il quale invece è solo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
per una pura convenzione che le parole sono come sono e si trovano in relazione a certe entità del
mondo piuttosto che ad altre.
Senza entrare oltre nel merito di questa specifica discussione, diciamo semplicemente che a partire
da Platone la ricerca sul linguaggio si fece sempre più serrata. Aristotele vi dedicò intere opere e,
dopo di lui, i filosofi dei secoli successivi – dagli stoici ai medievali, sino agli esponenti della
filosofia moderna – continuarono a prestarvi attenzione soffermandosi sulle più disparate tematiche,
come le questioni inerenti alle parti del discorso, alla teoria dell’argomentazione, all’ermeneutica
biblica o ancora all’origine del linguaggio umano.
Una linea di rottura, tuttavia, può essere individuata nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo,
quando l’attenzione filosofica per il linguaggio assunse definitivamente la forma di una disciplina
specializzata e a sé stante. Tale metamorfosi fu possibile grazie al contributo di alcuni autori come
Gottlob Frege, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, a partire dai quali si è appunto soliti parlare
di una vera e propria “filosofia del linguaggio”.
Una caratteristica di questa disciplina filosofica era innanzitutto quella di possedere un oggetto di
studio ben preciso: l’attenzione degli autori che contribuirono a dar vita a tale corrente si focalizzò,
infatti, prevalentemente sugli aspetti semantici – ovvero inerenti al significato – trascurando e
lasciando in secondo piano quelli sintattici, morfologici e fonologici, la trattazione dei quali fu
tacitamente demandata ad altre discipline (prima fra tutte la linguistica). In tal senso, potremmo da
subito precisare che la filosofia del linguaggio novecentesca fu più che altro una filosofia della
semantica del linguaggio. I primi “filosofi del linguaggio” si occupavano quindi di questioni
relative a che cosa fosse il significato delle espressioni linguistiche, al riferimento che queste hanno
nel mondo e al tema della verità.
Ma quella che a mio parere può essere considerata la principale caratteristica di questa nuova
disciplina filosofica fu l’impostazione metodologica che i suoi autori assunsero sin da subito:
impostazione nota come antipsicologismo. La tesi centrale dell’approccio antipsicologista era data
dall’idea per cui lo studio filosofico del linguaggio – e, nello specifico, del significato, del
riferimento e della verità – non dovesse in alcun modo fare appello a entità o a rappresentazioni
mentali. Si lasciava quindi da parte la sfera psicologica, in quanto ritenuta filosoficamente
irrilevante.
Per comprendre la motivazione che sta dietro a una posizione così radicale è opportuno considerare
il contesto storico-teorico in cui la prima filosofia del linguaggio si inseriva. Lo stesso Frege, infatti,
prima che essere un filosofo era innanzitutto un logico e un matematico, tanto che con il suo lavoro
contribuì ampiamente al superamento della logica aristotelica classica e alla nascita della logica
moderna. Questa sua radice logica e matematica non poté far altro che orientare di conseguenza le
ricerche degli autori che lo seguirono. Lo stesso Richard Montague, espressione più alta del
paradigma classico della filosofia del linguaggio, ancora negli anni ’70 sosteneva che la semantica
dovesse esser concepita come una branca della matematica (e perciò della logica), piuttosto che
come parte della psicologia.
Nello specifico, l’antipsicologismo di questi autori era giustificato in quanto forniva una soluzione a
un problema concernente la comunicazione e la comprensione inter-individuale. La questione era la
seguente: poniamo il caso che il significato di una parola corrisponda a una rappresentazione
presente nella mente del parlante; tale rappresentazione – avrebbe detto Frege – sarà una
rappresentazione privata, ossia non accessibile alle altre menti e non analizzabile da un punto di
vista teorico oggettivo. Pertanto, non avendo noi accesso alle menti degli altri parlanti della nostra
lingua, non potremo mai essere sicuri che essi stiano associando a una stessa parola la medesima
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
rappresentazione che noi mentalmente vi associamo: ciò apre al rischio che la comunicazione
linguistica sia in realtà una non-comunicazione.
La soluzione stava allora nel rigettare ogni appello a entità psicologiche per spiegare i valori
semantici delle espressioni linguistiche. Frege, ad esempio, sosteneva che il senso di una parola non
dovesse esser confuso con un’immagine mentale (dipendente quindi dal punto di vista soggettivo
dell’individuo), ma che fosse piuttosto «un possesso comune di molte persone e non dunque una
parte o un modo della psiche individuale».
L’impostazione metodologica antipsicologista caratterizzò per decenni la filosofia del linguaggio e
ancora negli anni ’70 autori come Michael Dummett sostenevano che la filosofia non dovesse
occuparsi del processo psicologico del pensare. In tal modo, tuttavia, questi autori stavano
deliberatamente escludendo l’elemento fondamentale del linguaggio umano – ovvero l’essere
umano stesso.
Approccio metodologico nettamente opposto lo ebbero invece gli studi condotti a partire dalla fine
degli anni ’50 nel campo della linguistica. In particolare, una figura centrale fu quella di un giovane
docente dell’MIT di Boston, che in quegli anni aveva dato alle stampe una versione ridotta della sua
tesi di dottorato, destinata a diventare di lì a poco una pietra miliare nello studio del linguaggio. La
pubblicazione era intitolata Syntactic Structures, mentre il giovane docente si chiamava Noam
Chomsky. Da questo lavoro ebbe inizio nei decenni successivi quella che ancora oggi può essere
riconosciuta come la più influente teoria della linguistica contemporanea: sto parlando della
Grammatica Generativa chomskiana.
Mentre i filosofi del linguaggio lavoravano agli sviluppi della semantica modellistica e persistevano
nella difesa dell’antipsicologismo, Chomsky affermò molto semplicemente di considerare lo studio
del linguaggio umano come facente «parte della psicologia e in ultima analisi della biologia».
Insomma, secondo il linguista statunitense, per studiare il linguaggio era essenziale soffermarsi
sulla dimensione interna e individuale, analizzando quelle strutture che a livello mentale rendono
possibile a un essere umano lo sviluppo di una lingua.
Le ricerche di Chomsky ebbero fin da subito un grande impatto in diversi ambiti di ricerca e, non da
ultimo, in filosofia del linguaggio. Chomsky fu del resto uno degli attori principali della cosiddetta
“svolta cognitiva” avvenuta nella seconda metà del secolo scorso: fu lui a far sì che in ambito
psicologico si abbandonasse il comportamentismo – che pretendeva di spiegare i comportamenti
degli individui trascurandone gli stati mentali – a favore della ricerca cognitiva in psicologia; e fu
sempre grazie a lui che alcuni filosofi del linguaggio cominciarono ad avvicinarsi a un approccio
più “cognitivista”, interessandosi ai progressi che la linguistica stava avendo in quegli anni.
A partire da questa fase – a partire quindi dalla svolta cognitiva – si può dire che l’approccio
unitario della filosofia del linguaggio di inizio ‘900 cominciò a vacillare. Sebbene, infatti, rimase
centrale l’attenzione per le questioni semantiche, su un piano metodologico si assistette invece a
una frammentazione delle posizioni: alcuni filosofi rimasero legati ancora al modello tradizionale,
antipsicologista, mentre altri cominciarono a contemplare la necessità di avvicinarsi alle teorie
cognitiviste moderne. Fu così che negli anni successivi l’interesse di parte dei filosofi “analitici” –
la precisazione è d’obbligo – si spostò verso tematiche inerenti alla mente umana e ai processi
cognitivi.
Fu così che si ebbe quindi un’apertura da parte della filosofia del linguaggio nei confronti delle altre
discipline scientifiche che si occupavano di linguaggio con metodi e strumenti teorici differenti,
prima fra tutte la linguistica. Questa apertura – e la frammentazione di cui dicevamo sopra –
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
ricevette ulteriore slancio con l’avvento di una famiglia di teorie, nata sempre in seno alla
linguistica e vicina all’istanza cognitivista, conosciuta con il nome di Semantica Cognitiva. Queste
teorie si presentavano come teorie della comprensione umana e identificavano i significati delle
espressioni linguistiche con i concetti presenti nella mente degli individui. In tal senso si ponevano
in aperto contrasto rispetto alla filosofia del linguaggio classica. La Semantica Cognitiva intendeva,
infatti, studiare le strutture e i processi mentali alla base della comprensione e della produzione
linguistica; eppure, al tempo stesso, era in grado di fornire un’interessante soluzione al problema
fregeano della comunicazione: la comprensione e la comunicazione reciproca potevano essere
ammesse nonostante si dicesse che i significati erano rappresentazioni mentali, poiché si affermava
che noi esseri umani fossimo dotati di strutture mentali e cerebrali simili tra loro (il che garantiva
appunto la reciproca comprensione e comunicazione).
Da questo momento in poi la filosofia del linguaggio – almeno quella che definirei la “buona
filosofia del linguaggio” – non smise più di porsi in dialogo e a confronto con i risultati che
emergevano dalle altre discipline scientifiche orientate allo studio del linguaggio.
Ma torniamo quindi alla domanda posta inizialmente. Quale può essere oggi il ruolo della filosofia
del linguaggio e quale contributo può ancora fornire alla ricerca?
Diciamo innanzitutto che il filosofo, per sua natura, dovrebbe essere aperto a ogni forma di
conoscenza e indagine. Se accettiamo tale impostazione, allora possiamo dire che la filosofia è in
grado di porsi al di là delle varie specializzazioni scientifiche, superando i limitati punti di vista che
si soffermano su particolari elementi, trascurandone altri. Uno dei rischi, infatti, a mio parere, della
ricerca contemporanea sul linguaggio è proprio quello dell’eccessiva specializzazione. In
linguistica, ad esempio, ma anche nelle altre discipline, si tende molto spesso a focalizzarsi su
aspetti e su questioni talmente particolari e specifici da perdere la visione di un orizzonte comune di
ricerca. Tutto ciò a discapito del progresso della conoscenza.
Il filosofo ha invece la possibilità di posizionarsi al di sopra delle singole divisioni disciplinari, per
cercare di comprendere e di problematizzare le questioni più disparate, per poi porre nuove
domande e formulare altre linee di ricerca, alimentando in un circolo virtuoso il lavoro delle altre
discipline. In altri termini, la filosofia del linguaggio oggi ha ancora la possibilità di assumere il
ruolo di coordinamento e di regia tra le singole scienze che si occupano del linguaggio naturale. Il
filosofo può recepire i dati e le ipotesi che vengono formulate nei più disparati ambiti e può, a
partire da questi, tirarne le somme, ponendosi da una prospettiva generale, che permetta di dare
nuovo slancio alla ricerca stessa.
Ovviamente ciò può essere fatto a patto che non si pretenda di condurre uno studio puramente apriori, slegato dai dati empirici e non aperto al dialogo con le singole scienze. Fare questo vorrebbe
dire cadere in un peccato di hybris che rischierebbe, come nel caso di alcuni strenui difensori del
programma antipsicologista, di portare la filosofia a uno stato di isolamento sterile e muto, incapace
di dire alcunché di concreto e di rilevante sul fenomeno del linguaggio, se non astratte e vacue
elucubrazioni.
Claudio Faschilli è dottore di ricerca in Filosofia del linguaggio e della mente. Attualmente
insegna filosofia e storia presso il Liceo classico San Raffaele di Milano, dove ricopre anche il
ruolo di Vice Preside. Da due anni cura il blog linguaggionaturale.wordpress.com dedicato alla
filosofia del linguaggio.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Contro la povertà
di DONATELLA DI CESARE
Segnali sempre più forti ci indicano che nella sfera pubblica sta nascendo una sorta di
“neopauperismo”. Non ci si può tuttavia rassegnare all’esistenza della povertà, né tantomeno
giustificarla. Bisogna restituire al povero la possibilità di dare.
L’esplosione della povertà nel ricco Occidente costringe a ripensare un fenomeno che sembrava
relegato in gran parte ai confini del passato e alle periferie del mondo. A parte rare eccezioni, hanno
dominato finora sconcerto, sdegno, rassegnazione. Ed è risuonato il messaggio: «la povertà rende
liberi»[1]. Quasi che al filosofo, o al teologo, non restasse, di fronte alla povertà altrui, che
condividerla indicandola a stile di vita. C’è da chiedersi se stia nascendo, o sia già nato, un
neopauperismo.
Certo si comprende l’esigenza che la vita pubblica non umili ulteriormente chi è nel bisogno. La
ricchezza sfacciata ha di questi tempi un aspetto lugubre. E si comprende anche l’urgenza, avvertita
da molti, di sottrarsi all’iperconsumo imposto dalla crescita infinita[2]. Ma la stessa regola di
Francesco d’Assisi era il progetto di abdicare alla proprietà per una forma di vita comune fondata
sull’uso[3].
Appare perciò dubbio il tentativo di anestetizzare con un concetto elevato di povertà il dolore
dell’indigenza. Chi è povero subisce una privazione che non può essere in alcun modo giustificata –
né come volere divino, né come calamità naturale, né tanto meno come inevitabile esito della storia.
Proprio perché non può essere giustificata, reclama giustizia.
La povertà ha a che fare con la schiavitù, non con la libertà. Ed è dunque tra i mali peggiori. Perché
il povero è oppresso dalla mancanza, prigioniero del debito. È lo schiavo. Non occorre risalire
all’antichità. Le nuove forme di schiavitù – a cominciare dall’indebitamento incoraggiato dal
sistema economico – sono sotto gli occhi di tutti. Che il debito sia stato contratto o, più spesso,
ereditato, e non voluto, i nuovi schiavi sono schiacciati dal fardello del passato che non permette di
intravedere il futuro.
Non stupisce, perciò, che la povertà sia sempre stata vista non solo come privazione dei beni
materiali. Il povero, soffocato dalla ristrettezza, vive nell’angustia e nell’angoscia. E questa
condizione esistenziale va di pari passo anche con l’esclusione sociale. Il povero è isolato, rinviato a
se stesso, estromesso dalla condivisione non solo della proprietà, ma anche della dignità. Ecco
perché nella Bibbia è paragonato allo straniero, avvicinato, per la sua debolezza, all’orfano e alla
vedova. Di qui l’ingiunzione: «e se un tuo fratello impoverirà e le sue forze vacilleranno presso di
te, tu dovrai sostenerlo, sia anche un forestiero o un avventizio, sicché possa vivere presso di te»[4].
Alla base di questo versetto vi è l’idea – dimenticata in molte epoche e occultata nel capitalismo –
che la povertà non sia un evento naturale e ineluttabile. Povertà e ricchezza sono condizioni
provvisorie, dovute a un processo che con il tempo si fa iniquo e che perciò deve essere interrotto.
Non c’è una equità intrinseca al mercato. Chi lavora duramente viene premiato. Ma non sempre. E
chi si affatica, può sperimentare l’inutilità dei propri sforzi. Nel corso degli anni le traversie
personali, le disgrazie familiari, i rovesci finanziari, decretano la povertà di molti, la ricchezza di
pochi. Dall’andamento dei rapporti economici non emerge una giusta ripartizione. E se è così,
sarebbe semmai un furto mutare il possesso temporaneo in appropriazione definitiva.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Il povero non è colpevole. Porta il peso del debito, non quello della colpa. Non ha bisogno che altri
condividano la sua condizione in un ideale di rinuncia. Quel che il povero, con la sua stessa
presenza, richiede è che venga spezzato il circolo vizioso della povertà.
In nessun modo, dunque, il povero può essere stigmatizzato. È la posizione di Marx che, com’è
noto, radicalizza la prospettiva: dove da un canto c’è accumulazione di capitale, dall’altro c’è
accumulazione di povertà, tormento lavorativo, schiavitù. La ricchezza, nella produzione
capitalistica, è fondata sulla povertà. Non si tratta allora né di disprezzare, ma neppure di esaltare la
povertà – prendendo la strada di un pauperismo egualitarista. Piuttosto occorre recuperare ricchezza
e povertà, fuori e oltre l’economia politica, nei loro valori umani. Ricco è chi ha bisogno
dell’umanità dell’altro, chi nella povertà avverte quel vincolo passivo che «fa sentire all’uomo il
bisogno della ricchezza più grande, dell’altro uomo»[5].
Se oggi si tende a giudicare l’economia non più solo in termini economici, è perché non è possibile
ignorare quanto il capitalismo abbia deteriorato nel profondo le relazioni interpersonali. Non c’è
economia che non debba rispondere della giustizia sociale e della dignità umana. Ha assunto così un
nuovo rilievo la domanda sulla povertà che non va misurata solo sul reddito. Sono in molti – da
Amarya Sen a Martha Nussbaum – ad aver introdotto criteri ulteriori che tengono conto dell’essere
umano nella sua complessità. Così la povertà non si limita solo ai bisogni materiali della
sussistenza, ma si amplia alla istruzione, alla partecipazione, alla libertà personale, al rispetto della
dignità, alla condivisione dei beni pubblici. Sotto quest’ultimo aspetto è chiamata in causa la
comunità. In breve, essere poveri vuol dire non poter attuare le proprie capacità[6].
D’altronde già il Talmud distingue tra ciò di cui il povero «ha bisogno» e ciò che «gli
mancherà»[7]. Cibo, alloggio, arredi indispensabili costituiscono quel bisogno materiale che
riguarda tutti. Non si tralascia però una povertà ulteriore, più difficilmente definibile, anche perché
varia da caso a caso: è l’assenza di quel che si aveva prima e che viene a mancare. Questa povertà
provoca umiliazione, incrina il rispetto di sé, toglie la dignità. E asservisce – nei modi più subdoli.
I nuovi poveri di oggi, che d’improvviso restano senza ciò che prima avevano, a cominciare dal
lavoro e dalla casa, sono colpiti da questa “mancanza”. Colpevolizzati nel fallimento, mentre sono
rinviati all’aiuto altrui, vengono paradossalmente estromessi dai legami sociali.
La carità non basta. Perché non muta i rapporti esistenti. Pur alleviandone lì per lì le sofferenze,
lascia il povero nella povertà. Ma l’aiuto non può essere occasionale. E il sostegno è obbligo
costitutivo della comunità. Qui chi è rimasto nell’indigenza deve essere reintrodotto per ritrovare la
sua libertà. L’atto supremo di giustizia sociale è offrire un posto di lavoro.
Spezzare il circolo della privazione vuol dire restituire al povero la possibilità di dare. C’è infatti
una dignità umana del dare che si traduce nella comune responsabilità per un terzo. Prima ancora
che dalla condivisione della proprietà, nessuno può essere escluso dalla condivisione di questa
dignità.
NOTE
[1] Cfr. ad esempio l’articolo di B. Forte, La povertà che rende liberi, “il Sole 24 ore”, 31 marzo
2013.
[2] Cfr. S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, trad. it. di F. Grillenzoni, Bollati
Boringhieri, Torino 2008, pp. 30-31.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
[3] Cfr. G. Agamben, Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita, Neri Pozza, Vicenza
2011, pp. 151 sgg.
[4] Levitico 25, 35.
[5] K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in id., Opere filosofiche giovanili, trad. it.
di G. Della Volpe, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 234.
[6] Cfr. M. Nussbaum, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, trad. it. di R. Falcioni, Il
Mulino, Bologna 2012.
[7] Talmud, bKetubot, 67b.
Donatella Di Cesare è professore ordinario di Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma. Ha
insegnato presso numerose università straniere ed è stata Distinguished Visiting Professor of
Arts and Humanities alla Pennsylvania State University. Gli ultimi volumi pubblicati sono:
Utopia of Understanding. Between Babel and Auschwitz, Suny Press, Albany 2012; La
giustizia deve essere di questo modo. Paesaggi dell’etica ebraica, Fazi, Roma 2012; Se
Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo, Il melangolo, Genova 2012; Grammatica dei tempi
messianici, Giuntina, Firenze 2011.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Una libertà controversa. Il diritto di possedere e portare armi
negli Stati Uniti
di ERNESTO DE CRISTOFARO
La questione della diffusione delle armi da fuoco è, da tempo, al centro del dibattito politico,
mediatico e scientifico negli Stati Uniti. Il suo sfondo, tuttavia, non va ridotto al campo degli
interessi economici che la riguardano e delle pressioni politiche che ne conseguono, ma va
considerato nella sua pienezza, tenendo conto delle radici ideali della cultura costituzionale
americana. A partire dalle quali, il diritto ad essere armati mostra di avere pressoché lo stesso
rilievo di altri diritti fondamentali della persona.
Quando un uomo con la pistola incontra un uomo
col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.
S. Leone, Per un pugno di dollari (1964)
Le stragi nei luoghi pubblici – scuole, università, residenze studentesche, cinema – rientrano tra i
delitti che negli ultimi anni hanno scosso nel modo più intenso l’opinione collettiva degli Stati Uniti
(ma i mass media ne hanno amplificato l’impatto su una scala molto più ampia), generando acuti
sentimenti di sdegno ed esecrazione. Ogni crimine violento contro una o più persone è egualmente
inaccettabile sul piano morale, ma questo tipo di eventi ha – persino se confrontati al terrorismo di
matrice politica o religiosa, vulnus primario della memoria americana nell’epoca più recente –
specifiche caratteristiche che enfatizzano le reazioni di repulsione e rabbia: il fatto che sovente le
vittime siano adolescenti o bambini colpiti nelle scuole, luoghi-simbolo della prima socializzazione;
inoltre, il fatto che essendo molto spesso tali aggressioni effetto di azioni solitarie da parte di
individui giovani e incensurati, esse siano del tutto imprevedibili quanto alla tempistica, agli
obiettivi, alle modalità di esecuzione ed ai possibili esiti. Una duplice angoscia si genera, dunque,
considerando la dinamica di questi fatti sia dal versante delle vittime che da quello dei colpevoli.
Nell’ultimo quindicennio, periodo successivo alla strage nella “Columbine high school” verificatasi
il 20 aprile del 1999 a Littleton (Colorado)[1], il dibattito pubblico sulla circolazione delle armi,
sulla loro accessibilità e sull’assenza (o l’insufficienza) di controlli che garantiscono a questi
articoli livelli di diffusione equivalenti a quelli dei più comuni beni di mercato è stato riacceso con
frequente cadenza di fronte ai nuovi episodi che hanno riaperto le ferite appena cicatrizzatesi dei
precedenti, sino al picco traumatico del 14 dicembre 2012, data dell’uccisione di venti bambini in
una scuola elementare a Newtown (Connecticut)[2]. In quasi nessun caso, e nemmeno in
quest’ultimo - rispetto al quale il governo aveva deciso di reagire varando restrizioni alla vendita di
armi automatiche ad alto potenziale offensivo (le c.d. armi d’assalto)[3] – si è messo radicalmente
in discussione il principio di fondo, ossia che pistole e fucili possano essere commercializzati come
avviene per altri oggetti di consumo.
Ma contrariamente a una tesi riduzionista, sebbene suggestiva, tale idea non è – o non è solo - la
conseguenza del forte potere di pressione della “lobby delle armi”[4], bensì trova il suo fondamento
nel secondo emendamento della Carta dei diritti (Bill of rights), che dal 1791 accompagna la
Costituzione degli Stati Uniti. Esso recita così:
Essendo una milizia ben organizzata necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto dei
cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Si tratta, allora, di capire che rapporto esista tra questa facoltà e altre che vengono elencate nel
medesimo documento, quali il diritto di libertà di culto, di opinione, di riunione, di libertà e
sicurezza del proprio domicilio, di subire un equo processo nel caso in cui si sia fatti oggetto di
azione penale. Nel condurre questa ricostruzione può essere utile adottare un punto di vista che
consideri storicamente tre profili: filosofico-politico, legislativo, giurisdizionale.
1) Il diritto dei cittadini di portare armi ha un antecedente storico nel Bill of rights inglese del
1689[5]. Dopo la deposizione di Giacomo II, il suo successore (e marito della figlia Maria II)
Guglielmo D’Orange sottoscrive questa Carta costituzionale destinata a divenire uno dei pilastri del
sistema di governo britannico. Essa sancisce la libertà di parola, la libertà di religione, il divieto per
il re di mantenere un esercito stanziale in tempo di pace senza il consenso del Parlamento e, in
generale, è caratterizzata dalla priorità dei diritti individuali rispetto al potere politico. Nell’elencare
i passati abusi della monarchia contro cui la Carta avrebbe posto un argine, i Costituenti avevano
fatto cenno anche alla disparità di condizioni tra “papisti” e protestanti nel possesso delle armi:
riconosciuto ai primi, negato agli altri. Cosicché, tra le disposizioni del Bill of rights si legge che “i
sudditi protestanti possono tenere armi per la loro difesa, secondo le loro condizioni e in accordo a
quanto consentito dalla legge” (articolo 7). Nel coevo Secondo trattato sul governo di John Locke, il
capitolo XVIII è dedicato alla “Tirannide”, ossia l’esercizio del potere oltre il diritto. In esso viene
sviluppato un ragionamento sulla facoltà di resistenza che ha due capisaldi: nessuno è al di sopra
della legge e pertanto l’abuso di autorità è illegittimo sia che provenga dal re che da un piccolo
funzionario, “anzi è tanto più grave nel caso del primo perché maggiore è la fiducia a lui
conferita”[6]; inoltre, se in condizioni normali nessuno può opporsi all’autorità, è possibile farlo
contro “la forza iniqua e illegittima”[7].
Si è osservato che la versione americana del Bill of rights del 1791 fa, a differenza di quella inglese,
riferimento a una “milizia” e che, quindi, si tratti di due regole più eterogenee di quanto il loro
tenore letterale non lascerebbe a prima vista supporre.[8] Ma è incontestabile che la teoria dei diritti
naturali che si sviluppa alla fine del Settecento nei dibattiti politici delle colonie americane sia una
diretta filiazione di alcune delle principali idee del giusnaturalismo inglese, anche perché “gli
americani avevano più diritto della maggior parte degli altri popoli di parlare dello stato di natura
come se fosse stato o potesse essere una situazione reale”[9]. Nella teoria politica della rivoluzione
americana legge naturale e diritti naturali degli individui erano un binomio inscindibile. Questi
ultimi erano qualificati come: assoluti, eterni, essenziali, inalienabili e investivano le sfere primarie
dell’esistenza al fine di garantire l’autoconservazione, la libertà, la proprietà, la resistenza contro la
tirannide.[10] In particolare, Thomas Jefferson aveva sottolineato la necessità di proteggere la
libertà dei cittadini contro l’oppressione delle truppe militari britanniche enfatizzando la tesi della
“supremazia civile” per la quale solo una milizia composta da cittadini avrebbe scongiurato i rischi
derivanti dall’esistenza di un esercito professionale[11]. Un risultato di queste elaborazioni è la
Dichiarazione dei diritti della Virginia, stesa da George Mason e adottata il 12 giugno 1776.
Essa, al punto 13, stabilisce:
Che una milizia ben organizzata, composta dal popolo addestrato all’esercizio delle armi,
rappresenta la naturale e più idonea protezione di uno Stato libero; che devono essere evitati, quali
pericolosi per la libertà, gli eserciti stanziali in tempo di pace: e che in ogni caso l’autorità militare
deve essere rigorosamente subordinata al potere civile e ubbidire a quest’ultimo.[12]
Il secondo emendamento della Costituzione americana viene chiaramente da qui. Esso mescola, nei
due periodi da cui è composto, la necessità di una milizia civile a difesa di una comunità libera e il
diritto individuale di detenere armi già noto nella legislazione della madrepatria inglese. Secondo
alcune interpretazioni, questi due profili sarebbero del tutto equivalenti. Nessuno dei due dovrebbe
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
prevalere sull’altro[13]. Secondo altre tesi, viceversa, sebbene esso non contenga un esplicito
riferimento alla “difesa comune” come taluni degli estensori auspicavano, non si può trascurare che
sia l’unico tra gli emendamenti a contenere un preambolo finalistico (“essendo necessaria…alla
sicurezza di uno Stato libero”) e che l’espressione “ben regolata” riguardante la milizia renda assai
problematico l’uso di tale disposizione contro la possibilità di esercitare un controllo sulle armi[14].
2) Nei due secoli successivi all’entrata in vigore della Costituzione e con intervalli scanditi dalla
maggiore o minore recrudescenza dei crimini di sangue, numerose leggi federali sono intervenute a
regolare la materia delle armi. Nel 1934, il “National Firearms Act”, di pochi anni successivo
all’eclatante “massacro di san Valentino” (Chicago, 1929) che aveva colpito una banda rivale di Al
Capone, introduce alcune restrizioni alla spedizione postale di armi, ne sottopone alcune a tasse
speciali, per altre fissa un obbligo di registrazione. Nel 1968, il “Gun control act”, che ugualmente
arriva in un decennio carico di violenze traumatiche per la nazione americana quali furono gli
omicidi di John F. Kennedy (1963), di Malcolm X (1965), di Martin Luther King e di Robert
Kennedy (1968), introduce alcune restrizioni al possesso di armi escludendolo per una serie di
categorie: persone sotto processo o condannate per delitti puniti con la reclusione superiore a un
anno, persone con problemi di salute mentale o già internate presso strutture psichiatriche, latitanti,
persone congedate con disonore dalle Forze armate, persone cui era stato rifiutato un visto di
ingresso nel Paese, persone che avevano volontariamente rinunciato alla cittadinanza americana.
Ma negli anni ottanta, il vigoroso recupero dell’ideologia liberista e individualista conduce
all’emanazione del “Firearms Owners Protection Act” (1986) che attenua taluni di questi vincoli e
reintroduce, ad esempio, la vendita interstatale di armi o la spedizione di munizioni attraverso il
servizio postale. Pochi anni dopo, il “Brady Handgun Violence Prevention Act” (1993) stabilisce
che la vendita di armi a livello federale da parte di un commerciante autorizzato possa essere, salvo
alcune eccezioni, preceduta da controlli sugli aspiranti acquirenti[15].
A tale ondivaga regolazione federale, fa riscontro una condizione molto diversificata della
legislazione dei singoli Stati. A livello costituzionale vi sono quattro tipologie: Stati che non
riconoscono alcun diritto inalienabile di possedere armi (solo quattro: California, Iowa, Maryland,
New Jersey); Stati che collegano tale diritto costituzionale alla difesa comune; Stati (la parte
largamente maggioritaria) che definiscono tale diritto come un insopprimibile diritto individuale;
infine, lo Stato del Minnesota che non riconosce esplicitamente il diritto alle armi ma nella cui
Costituzione esso può essere implicitamente ricavato da altre disposizioni[16]. Nella legislazione
ordinaria degli Stati che riconoscono il diritto di possedere armi vi è poi un campionario di
specifiche condizioni riguardanti l’acquisto (che può essere o meno sottoposto ad autorizzazione),
la verifica di requisiti personali (l’essere incensurati, la buona salute mentale), la possibilità di
detenere armi o portarle anche con sé e l’eventualità che presso particolari luoghi (aeroporti, scuole,
tribunali, prigioni) non si possa in nessun caso circolare armati.[17] Ma se si guarda semplicemente
al diritto di detenere e portare armi così come configurato dal secondo emendamento della
Costituzione federale, occorre prendere atto che persino sul suo contenuto gli esiti dell’attività
ermeneutica della Corte Suprema sono stati nel tempo sensibilmente differenti.
3) Prima del “National Firearms Act” la Corte era intervenuta solo in due casi sul secondo
emendamento: nel 1876 (U.S. vs Cruikshank) e nel 1886 (Presser vs Illinois). Una volta che, con il
N. F. A., si comincia a legiferare sui limiti di tale diritto si determina, in modo più stringente, la
necessità di stabilire se e come questi limiti intacchino una prerogativa di rango costituzionale. Nel
1939, nel caso U. S. vs Miller riguardante il trasporto di un’arma non registrata dall’Oklahoma
all’Arkansas da parte di due delinquenti di piccolo taglio, la Corte Suprema stabilisce che nessun
diritto individuale era stato violato con l’imporre regole sulla trasportabilità delle armi giacché
chiaramente il secondo emendamento difende la possibilità di costituire milizie civili e va applicato
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
tenendo a mente solo quello scopo.[18] Tutt’altra vicenda quella del caso District of Columbia vs
Heller su cui la Corte si pronuncia nel 2008.
Nel 1976, nel Distretto di Columbia, era stata introdotta una legge molto severa in materia di armi.
Essa imponeva che il possesso di pistole e fucili fosse subordinato a registrazione e prevedeva
regole di custodia in casa molto dettagliate. Tale normativa fu impugnata da Dick Heller che
reclamava il diritto di registrare una pistola che avrebbe portato con sé per difesa personale. In
questo caso la Corte suprema, introducendo una sottile distinzione tra la prima e la seconda parte
del secondo emendamento (definite: “clausola introduttiva” e “clausola operativa”) stabilì che, per
quanto non si potesse dissociare dal contenuto della disposizione l’intento dei padri costituenti di
creare le condizioni per organizzare una milizia civile e sebbene nessun diritto individuale possa
essere inteso come illimitato, di certo il secondo emendamento è posto a difesa di un diritto
individuale e, come tale, esso non può essere limitato da nessuna regolazione oltre una certa soglia
se non violando la Costituzione medesima. Le stesse valutazioni sostengono una decisione
successiva della Corte suprema nel caso McDonald vs City of Chicago, Illinois. In questa
controversia, oltre a censurare una legge municipale che aveva escluso quasi tutti i privati cittadini
dal possesso di pistole, la Corte precisa che il secondo emendamento va ritenuto come posto a tutela
di un diritto individuale spettante indistintamente a tutti i cittadini degli Stati Uniti[19].
Le strategie argomentative utilizzate nel caso “Heller” sono state fatte oggetto di numerose critiche.
Un autorevole docente ha affermato che la derubricazione della prima parte del secondo
emendamento a semplice dichiarazione di intenti e l’affermare che non esiste tra parte
“introduttiva” e parte “operativa” alcun vincolo sintattico con la conseguenza che esse possono
essere lette separatamente, “fa violenza non solo a coloro che lo scrissero, ma anche al pubblico che
lo ha letto, gli ha conferito significato e l’ha ratificato”[20].
Le sentenze della Corte suprema possono essere contraddette da altre sentenze di tenore differente
e, d’altronde, anche le ultime lasciano spazio al criterio della limitabilità, entro una certa estensione,
al diritto di possedere armi. È ragionevole supporre che il dibattito su quest’argomento continuerà a
lungo.
NOTE
[1] Un evento che ha costituito un punto di svolta nel sistema di rappresentazione di questa
tipologia di delitti divenendo oggetto, oltre che di numerose ricostruzioni giornalistiche, di quattro
diversi lungometraggi: Duck.The carbine high massacre (W. Hellfire e J.Smack, 2000), Bowling for
Columbine (M. Moore, 2002; premio Oscar come miglior documentario e premio César nel 2003),
Zero day (B. Coccio, 2003), Elephant (G. Van Sant, 2003; Palma d’oro e premio alla migliore regia
a Cannes nel 2003) nonché di due saggi monografici: Fixing Columbine. The challenge to american
liberalism (D. Lambert Coleman, 2002) e Columbine (D. Cullen, 2009).
[2] Un resoconto degli ultimi venti anni di stragi nelle scuole e nelle università degli Stati Uniti è
proposto da F. Seneghini, Da Columbine alla strage degli Amish. La lunga scia di sangue nelle
scuole americane, in “Corriere della Sera”, 15 dicembre 2012, p. 18.
[3] Iniziativa che nello spazio di due mesi, da gennaio a marzo 2013, si arena sulle spaccature del
Partito democratico e sulla resistenza ai cambiamenti della componente dei suoi senatori eletti negli
stati del sud.
Cfr.http://www.repubblica.it/esteri/2013/03/20/news/armi_affonda_la_riforma_obama_no_allo_sto
p_dei_fucili_da_guerra-54946015/
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
[4] O di una delle sue più eminenti espressioni, la N. R. A (National Rifle Association).
[5] Punto terminale di un secolo attraversato da sanguinosi conflitti civili. Cfr. L. Stone, Le cause
della rivoluzione inglese, Torino, Einaudi, 2001; G. Carocci, La rivoluzione inglese: 1640-1660,
Roma, Editori Riuniti, 1998.
[6] J. Locke, Il secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l’estensione e il
fine del governo civile, trad. it. di A. Gialluca, Milano, Rizzoli, 20012, p. 339.
[7] Ivi, p. 341. Esiste, beninteso, una tradizione teorica sul “diritto di resistenza” anche prima della
riflessione di Locke. Per approfondimenti si vedano: G. Cassandro, Resistenza (diritto di), in
“Novissimo Digesto Italiano”, volume XV, Torino, Utet, 1968, pp.590-613; Le droit de
résistance.XIIe-XXe siècle, textes réunis par J.C. Zancarini, Paris, ENS editions, 1999; A. Buratti,
Dal diritto di resistenza al metodo democratico: per una genealogia del principio di opposizione
nello stato costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006.
[8] Cfr. D. B. Kopel, It isn’t about duck hunting: the british origins of the right to arms, in
“Michigan Law Review” 93 (1995), p. 1349.
[9] C. Rossiter, L’alba della Repubblica. Le origini della tradizione americana di libertà politica,
trad. it di C. Scelba, Pisa, Nistri-Lischi, 1963, p. 499.
[10] Ivi, pp. 514-517.
[11] Ivi, pp. 529-530.
[12] Ivi, pp. 546-547.
[13] Cfr. R. Shalhope, The ideological origins of the second amendment, in “The journal of
american history”, 69 (1982), p. 610. Per approfondimenti sull’argomento “sovranità politica –
diritti naturali” nel costituzionalismo americano si vedano: B. Schwartz, The great rights of
mankind. A history of the american Bill of Rights, New York, Oxford University Press, 1977; G. S.
Wood, I figli della libertà. Alle origini della democrazia americana, trad. it. di D. Panzieri, Firenze,
Giunti, 1996; M. Fioravanti, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Roma –
Bari, Laterza, 2009.
[14] Cfr. L. H. Tribe, American constitutional law, Mineola - New York, The Foundation Press
Inc., 19882, p. 299, n. 6.
[15] Cfr. R. Spitzer, The right to bear arms: rights and liberties under the law, Santa Barbara, ABC
– CLIO, 2001; A. Winkler, Gunfight: the battle over the right to bear arms in America, New York,
W. W. Norton & C., 2011.
[16] Cfr. R. A. Creamer, History is not enough: using contemporary justifications for the right to
keep and bear arms in interpreting the second amendment, in “Boston College Law Review”, XLV
(2004), pp. 919-925.
[17] Cfr. R. Golden, Loaded questions: a suggested constitutional framework for the right to keep
and bear arms, in “Minnesota Law Review”, 96 (2012), pp. 2185-2187.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
[18] Cfr., L. Epstein, T. G. Walker, Constitutional law for a changing America: rights, liberties and
justice, Washington D. C., CQ Press, 20128, pp. 388-389.
[19] Ivi, pp. 390-396.
[20] D. T. Konig, Why the second amendment has a preamble: original public meaning and the
political culture of written constitutions in revolutionary America, in “UCLA Law Review”, 1233
(2009), p. 1297.
Ernesto De Cristofaro (1972), ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno presso il
Dipartimento “Seminario Giuridico” dell’Università di Catania, pubblicato i saggi: Sovranità in
frammenti. La semantica del potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann (Ombre Corte
2007), Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista
(Giappichelli 2008), Il senso storico della verità. Un percorso attraverso Foucault (Il
Melangolo, 2008). Con Carlo Saletti, ha curato Precursori dello sterminio. Binding e Hoche
all’origine dell’“eutanasia” dei malati di mente in Germania (Ombre Corte, 2012).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Le tre missioni di Nietzsche
di SOSSIO GIAMETTA
È vero che Nietzsche non si può e non si deve capire? Chi era e che cosa ha fatto? A fronte delle tre
crisi: della filosofia, della civiltà cristiano-europea e della religione, ha compiuto tre missioni:
distruzione della filosofia concettuale a favore del moralismo; trasfigurazione del tramonto
dell’Occidente in poesia e filosofia tragica e d’altra parte legittimazione e accelerazione della
crisi; fondazione della religione laica, meta della modernità.
“Ho letto come sempre con piacere il Suo saggio sul Crepuscolo degli idoli di Nietzsche, che non
conosco o non ricordo. La Sua scrittura chiara ed efficace mi aiuta, come sempre, a capire. Ma, una
volta che ho capito, il pensiero complessivo di Nietzsche mi sfugge. Mi appassiona, mi avvince, ma
alla fine mi sfugge.” Così mi scrisse, il 30 aprile 1997, Norberto Bobbio, un faro della cultura
italiana, che mi onorava della sua amicizia.
La difficoltà di comprendere Nietzsche è così diffusa, che in Italia è finita in una canzone di un noto
cantante pop, “Zucchero” Fornaciari. La canzone si domanda e ripete: “Nietzsche, che dice? Boh,
boh!”
Lo strano è che questa difficoltà c’è con Nietzsche, che scrive in modo chiaro, e non con pensatori
che scrivono in modo oscuro, come Heidegger, Hegel, Schleiermacher ecc. Si può allora dire anche
di lui ciò che egli ha detto dei filosofi tedeschi, che sarebbero tutti degli “Schleiermacher”, cioè
facitori di veli? oscuratori?
Certo, questa non era la sua intenzione. Anzi, la sua intenzione era esattamente il contrario. Egli
voleva essere un portatore di luce.
Ma allora, dove sta la difficoltà?
La difficoltà sta sia dalla parte degli interpreti, sia dalla parte delle molteplici e intricate missioni di
Nietzsche.
Per quanto riguarda gli interpreti, io parlo di solito del “bue squartato”. Cioè ogni interprete si
ritaglia dalla carcassa del bue una bella bistecca e se la cucina a modo suo. Così offre sempre
qualcosa di sostanzioso. Ma non si preoccupa di tutto quel che lascia. Ciò fa sì che le interpretazioni
di Nietzsche siano state finora tutte parziali e tutte diverse tra loro. È mancato cioè uno studio di
Nietzsche come problema globale, dentro e fuori della storia della filosofia. E però solo uno studio
di tutto Nietzsche, di tutti i suoi aspetti essenziali tra loro collegati, può fornire il criterio per
giudicare i suoi aspetti singoli. Solo il significato del tutto determina il significato delle parti. Ma il
significato del tutto, appunto, è rimasto finora inesplorato, perché non si è trovato il filo che collega
i diversi aspetti. Inoltre, negli interpreti prevale un interesse assimilante, attualizzante,
strumentalizzante. Una ricerca puramente interpretativa, storico-critica, è finora mancata.
D’altro lato c’è il contenuto del pensiero di Nietzsche. Esso è così complesso, intricato e
plurivalente che molti hanno rinunciato a capirlo nel suo insieme, come a sciogliere i nodi
aggrovigliati dei suoi molteplici e contrastanti talenti. Altri predicano addirittura che non si deve
neanche tentare di capirlo.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Dice per esempio Rüdiger Safranski: “Di Nietzsche non si può venire a capo. Neanche lui è venuto
a capo di se stesso” (“Mit Nietzsche kann man nicht fertig werden. Er ist auch nicht mit sich fertig
geworden”).
Per Jaspers “Nietzsche è inesauribile. Non rappresenta un problema che possa essere risolto nella
sua interezza”. E per Gottfried Benn, che tale giudizio riporta nell’Introduzione ai Ditirambi di
Dioniso,[1] questa è una “frase assai significativa! Con criteri europei moderni in realtà Nietzsche
non può essere risolto, egli appartiene alle ‘Parole primordiali’” [Urworte].[2]
Si arrende perfino il grande biografo di Nietzsche, Curt Paul Janz. Egli spiega, più chiaramente, che
Nietzsche ha
lasciato un’opera che ci starà sempre davanti come uno stimolo, che nella sua molteplicità offre
bensì varie possibilità di accesso e di interpretazione, ma non potrà mai essere abbracciata nella sua
totalità da un singolo osservatore, misurata da un singolo rielaboratore. Collocare Nietzsche nella
sua epoca e nel fluire dei secoli, nel contesto del suo ambiente e in quello delle correnti spirituali
che risalgono fino ai primordi dell’antichità classica, è impresa che fuoriesce dai canoni
interpretativi normali.[3]
Insomma, secondo costoro, Nietzsche non si può capire. Ma può la critica dichiarare forfait solo
perché un’interpretazione si presenta a prima vista, e magari anche a seconda vista, come
“impossibile”, ossia come più difficile di altre? E si può, d’altra parte, sostenere di un qualsiasi
autore ciò che Safranski, Jaspers, Benn, Janz e altri sostengono di Nietzsche: che sfugge all’analisi,
“échappe à l’analyse”, come disse un critico francese di Beethoven dopo un concerto, quasi che
Nietzsche o Beethoven fossero fuori o al di sopra del genere umano? Nel genere umano anche il
genio più grande è inscritto con una sua chiara funzione. Il genio è infatti l’estrema risorsa
dell’umanità nelle sue crisi più difficili.[4] Dunque la difficoltà di capirlo corrisponde in genere alla
difficoltà di capire la crisi stessa a cui il genio è la risposta. Perciò non resta che affrontare questo
problema e cercare di risolverlo con i mezzi a nostra disposizione.
Ma per capire l’albero cominciamo dal seme, per capire la quercia cominciamo dalla ghianda, per
capire l’opera di Nietzsche, cominciamo dall’uomo. Non si dice, infatti, che lo stile è l’uomo?
Domandiamoci: chi era Nietzsche? Nietzsche era un uomo di animo nobile, un allievo dei classici,
per sua natura mite e affettuoso, amante della virtù e della verità, ma che non sopportava, aveva
orrore della falsità. La falsità, però, è talmente mescolata in tutte le cose umane, specie nelle grandi,
che opporsi ad essa, se l’opposizione è audace, tenace ed efficace, significa scatenare un terremoto.
È quello che fece Nietzsche. La sua opera non è, per così dire, un’azione ma una reazione, una
reazione alla falsità. Egli diceva di sentire la falsità all’odore e proclamava: “Il mio genio è nelle
mie narici”.[5]
Ma che cosa significa ciò? Significa, anzitutto, che l’opera di Nietzsche è una grande ricerca
morale, come riconosce Benedetto Croce, che parla del “nobilissimo intento morale dell’opera sua”
come “suo intimo impulso”. La lotta contro ogni forma di falsità – contro la menzogna, l’ipocrisia e
l’illusione – nei sistemi filosofici e nei costumi, nelle religioni, nelle morali, nelle istituzioni e nelle
tradizioni, contraddistingue tutte le manifestazioni di Nietzsche, al punto da costituire il criterio
chiave per interpretarle.
Un criterio di interpretazione unitario dunque esiste, come esiste un’unità e una coerenza sotto la
ricchezza e la varietà, contro tutto ciò che si dice in contrario.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Ma significa anche un’altra cosa. La medaglia ha il suo rovescio. Nietzsche non era, in senso stretto,
un filosofo. Era un moralista applicato alla filosofia. Esistono due categorie di pensatori: i filosofi e
i moralisti. In Francia, che è la nazione più ricca di moralisti, questi – Montaigne, Pascal, Diderot
ecc. – fanno parte della letteratura e non della filosofia, come invece Descartes, Malebranche e
Bergson. Nietzsche stesso fa valere questa fondamentale distinzione in più luoghi della sua opera,
ma soprattutto nell’aforisma 5 di Opinioni e sentenze diverse:
In tutti i tempi i filosofi si sono appropriati i detti di coloro che scrutano gli uomini (i moralisti) e li
hanno corrotti, – proprio quando credevano di elevarsi in tal modo al di sopra di essi, – col
prenderli in senso assoluto e col voler dimostrare come necessario ciò che dai moralisti era inteso
solo come indicazione approssimativa o addirittura come verità di un decennio, particolare a un
paese o a una città.
Qual è la differenza tra moralismo e filosofia?
Il filosofo si basa sulla logica, sui concetti, sul principio di ragione nelle sue tre forme: principio di
identità, principio di non contraddizione e principio del terzo escluso. Questo principio aristotelico
serve a dimostrare le proposizioni filosofiche, ma non può dimostrare se stesso, perché ogni
tentativo di farlo sfocia in un regresso all’infinito. Il moralista si basa invece sull’esperienza e
sull’acutezza del suo senso morale. Nel saggio giovanile, secondo molti mai superato, Su verità e
menzogna in senso extramorale, Nietzsche nega la conoscenza in base alla mancanza di ponte tra
l’intelletto e la realtà. Per lui i concetti sono immagini, “rappresentazioni”, finzioni, accettate
tradizionalmente come verità. La logica è una macchina autoaffermativa che rende pensabile quello
che non lo è, cioè la realtà. Essa funziona in base a cose uguali, ma nel mondo non ci sono cose
uguali. Ingabbia la realtà ma non la penetra, dunque è incapace di conoscerla.
Al posto della logica Nietzsche pone la psicologia, che, nell’aforisma 23 di Al di là del bene e del
male, definisce signora delle scienze, per preparare la quale esistono le altre discipline.
Le verità di Nietzsche sono verità morali, non filosofiche. L’unica grande verità filosofica, il
nichilismo, egli la raggiunge non con la logica, ma con la psicologia. Psicologizza prima
l’individuo, poi i gruppi, quindi i popoli e infine quel grande individuo che è l’umanità stessa. Così
scopre che sia la conoscenza sia la morale hanno un senso intraumano, antropomorfico, non sono
valide in assoluto, perché sono al servizio di quello che per lui – come già per Spinoza, da lui eletto
a suo “grande precursore” – era l’essenza fondamentale dell’uomo, il conatus suum esse servandi,
lo sforzo di conservare il proprio essere.
Ma così facendo, Nietzsche, il filosofo Nietzsche, come anche noi senza difficoltà lo chiamiamo,
distrugge la filosofia, non solo in quanto sistema, ma anche in quanto concatenazione concettuale in
genere. E questa è appunto la prima delle sue tre missioni fondamentali, corrispondenti ai tre aspetti
della crisi europea: 1) crisi della filosofia; 2) crisi della civiltà; 3) crisi della religione. La
distruzione della filosofia a favore del moralismo, cioè la sostituzione dello studio della realtà di cui
l’uomo è parte con lo studio dell’uomo sull’uomo immerso in ciò che è diverso dall’uomo, è una
rivoluzione copernicana. Nietzsche la esprime appunto così: “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal
centro verso una x”.[6]
Così la realtà è diventata una “x”. Cioè è inafferrabile, impensabile. Anzi non esiste come una
qualunque stabile costituzione delle cose. È semplicemente l’altro dall’uomo, che si può per
comodità anche chiamare “accadimento”. Se però non esiste la realtà, “una realtà”, non esiste
neanche la verità. Perché la verità è ciò che corrisponde alla realtà. Che cos’è allora quella che
chiamiamo verità? “La verità è la specie di errore senza di cui una determinata specie di esseri
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
viventi non potrebbe vivere”.[7] Ecco, questa è la verità per Nietzsche. “Ciò che decide da ultimo –
egli dice – è il valore per la vita”. La verità, cioè, è ciò che favorisce il nostro sforzo di conservare il
nostro essere, dunque è qualcosa di strumentale, un’utilità. Inoltre, poiché nel conservare è incluso
il potenziare, e anzi lo sforzo del potenziamento prevale, secondo Nietzsche, su quello della
conservazione, egli teorizza la Volontà di potenza al di sopra della Volontà di vivere di
Schopenhauer e della Volontà di conservarsi di Spinoza.
Ma se la verità non è più il criterio della filosofia, quale sarà allora il criterio della sua validità?
Nietzsche non esita: è valida quella filosofia che aiuta i forti nella lotta contro i mediocri. In questa
lotta i forti, secondo lui, sono destinati a soccombere, perché i mediocri hanno dalla loro la forza del
numero.
In corrispondenza con la negazione della conoscenza e della morale, cioè della Verità e del Bene,
Nietzsche afferma la visione dionisiaca.
Dioniso è il dio della pura esistenza, della pluralità contraddittoria senza aspirazioni di redenzione,
senza giustificazioni fondate su valori originari; è il dio del libero gioco delle forze naturali, dei
contrasti irriducibili, non componibili in un senso superiore, delle infinite metamorfosi, della
creazione e della distruzione, senza origine, fine, identità, essenza, verità. Ogni presunta origine,
fine, identità, essenza, verità, riconduce a forze che non hanno origine, fine, identità, essenza, verità;
tutto ciò che è ritenuto stabile e provvisto di senso, si rivela fluido e insensato, ogni supporto viene
meno.
Tutti i tentativi di redenzione della finitezza e limitatezza umana sfociano in altrettante negazioni
della vita. Nel teatro della vita tutto è maschera. Tutte le verità affermate nella storia sono altrettante
maschere che nessuna verità fondante può smascherare. Perché non c’è nessuna verità che porti a un
fondamento primo, a una pienezza, che possa inibire il godimento temporaneo e occasionale del
dominio delle forze primarie, attive, sulle forze secondarie, reattive. Le prime, nobili, affermano la
vita aggredendo, assoggettando, dominando; le seconde, basse, si oppongono a tutto ciò che esse
non sono, si adattano alle prime, congiurano contro di loro e, con la forza del numero, le separano
da “ciò che può”, ossia le esautorano e le dominano; ma non come azione, bensì come reazione,
come sottrazione del loro potere. Questo è ciò che accade nel cristianesimo, in cui la morale degli
schiavi diventa creativa, mette in campo per risentimento i concetti di buoni e cattivi, di colpa e
cattiva coscienza, e scalza la morale aristocratica dei forti.
Queste idee sono confermate negli aforismi 230, 257 e 259 di Al di là del bene e del male. In essi si
afferma rispettivamente 1) la ri-naturalizzazione dell’uomo, cioè la liberazione o ripulitura del
“terribile testo di base homo-natura” dalle “molte vanitose e fantasiose interpretazioni e
significazioni aggiuntive che sono state finora scarabocchiate e spennellate” su di esso; 2) la
necessità di una casta aristocratica, violenta e barbarica, per ogni elevazione del tipo “uomo”; la
necessità della gerarchia e del pathos della distanza, ossia di un fossato tra la casta e il popolo, e la
necessità della schiavitù. Ciò perché 3) “La vita stessa è essenzialmente appropriazione, offesa,
sopraffazione di ciò che è estraneo e più debole, oppressione, durezza, imposizione di forme
proprie, incorporazione e perlomeno, nel caso più moderato, sfruttamento”.
Se a tutto questo aggiungiamo la negazione della libertà del volere e quindi della responsabilità:
l’uomo non è da tenere responsabile per niente, né per il suo essere, né per i suoi motivi, né per le
sue azioni, né per i suoi effetti;
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Nessuno è responsabile per le sue azioni, nessuno per il suo essere; giudicare equivale a essere
ingiusti.[8]
nonché la “trasvalutazione di tutti i valori”, che traduce e riduce tutti i valori spirituali a valori
naturali, fisici, esaltando “le splendide creature sotto il sole cocente: tigri, palme e serpenti a
sonagli”, vale a dire la belluinità, l’animalità selvaggia, bisogna dar ragione a Croce, che pure fa
parte dei suoi ammiratori, quando dice che Nietzsche “depresse valori spirituali ed espresse ideali di
rapacità e di ferocia”.
Fu questa la conseguenza di un indebito sviluppo sistematico di quella che era stata una grande
intuizione demistificante (la trasvalutazione), da parte di un pensatore che non era un filosofo in
senso stretto, capace di sviluppi sistematici, ma un moralista. Con ciò comunque egli contravveniva
alle legge da lui stesso proclamata nel citato aforisma 5 di Opinioni e sentenze diverse, e
dimenticava il patere legem quam ipse tulisti.
Fece come “fa il viandante che vuole sapere quanto sono alte le torri di una città: abbandona la
città”.[9] Per soppesare, da moralista, il valore sostanziale della filosofia, che è la sua forza,
Nietzsche abbandonò la città. Ma una volta uscito dalle mura, non poté più rientrarvi. E quando
filosofò sistematicamente, tentazione alla quale non seppe resistere, perduto com’era nel sogno del
capodopera, dell’ Hauptwerk, fece disastri.
Ora, è strano notare come i risultati di questo percorso strettamente filosofico, strettamente
personale, avulso da ogni politica, di uno scrittore che non fu mai uno scrittore politico ed ebbe
sempre in disdegno la politica, coincidano puntualmente con i disvalori innescati dalla crisi di
civiltà (negazione della realtà, della verità, della moralità, della libertà del volere, della
responsabilità ecc.), che maturò nella seconda metà dell’Ottocento. Questi disvalori sarebbero poi
scesi nel popolo, si sarebbero coagulati in correnti politiche e sarebbero sfociati, una prima volta
dopo trent’anni e una seconda dopo cinquanta anni, in due spaventose guerre mondiali, che
avrebbero segnato la fine del primato europeo nel mondo.
Una così puntuale coincidenza di un percorso strettamente individuale con il corso della crisi di una
civiltà e di un continente sembra un miracolo. Ma naturalmente non si tratta di un miracolo. Si tratta
del fatto che la crisi storica investiva allora tutte le attività umane, si irradiava nella morale,
nell’arte, nella politica, nella filosofia eccetera, sicché, senza rendersene conto, Nietzsche, che si
vantava di essere lo spirito più indipendente dell’epoca e il più inattuale, si trovava ad essere una
creatura della crisi e il più attuale degli attuali; e la sua filosofia, tendente a valorizzare un
neopaganesimo nutrito di valori antichi: la virtù, la gara, la guerra, la gerarchia, la patria e il sangue,
si sarebbe scontrata con la filosofia e l’azione di Marx, che raccoglieva nel comunismo i valori
opposti, i valori nuovi portati dal cristianesimo: la solidarietà, l’uguaglianza, la dignità di tutti,
l’amore, la pace, l’internazionalismo.
Dunque da un lato Nietzsche, come pensatore-poeta, fece quello che fanno in ogni epoca i pensatori
e i poeti, cioè trasfigurò la crisi storica in poesia e filosofia tragica: e questo fu il frutto del suo
libero genio; dall’altro, trascinato inconsciamente dalla corrente dominante, conferì corpo spirituale
alla crisi (di autodistruzione) della civiltà cristiana, la legittimò e l’accelerò, costruendo quello che
alla fine sarebbe diventato, grazie a tutte le sue negazioni e affermazioni, il cuore spirituale del
fascismo.
Questa fu, in questo senso duplice, la sua seconda missione.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Nietzsche ne compì però anche una terza. Essa si collega alla stessa crisi e riguarda il suo aspetto
più spirituale: la religione.
Con i rivolgimenti causati dal risveglio dei valori antichi e dalla nuova scienza nell’umanesimo e
nel Rinascimento, il cristianesimo, che era giunto alla sua massima realizzazione ed era ormai
incamminato sulla strada della corruzione, come è di tutti gli organismi invecchiati, cominciò a
ritirarsi dalle coscienze europee. Subì poi il duro colpo della Riforma di Lutero e il suo posto fu
preso sempre più, nei secoli che seguirono, dalle tendenze secolarizzanti. Nel suo rapporto con la
laicità si creò quello che Spinoza dice che avviene con la teologia e la filosofia: quanto più si alza il
piatto della bilancia della filosofia, tanto più si abbassa quello della teologia, e viceversa.
Dette tendenze laicizzanti, però, senza l’ausilio della fede e del Dio padre, del Dio provvidente,
avevano grande difficoltà a sostituire la religione, della quale l’uomo ha un naturale bisogno. Perché
facevano appello all’intelletto e non all’anima. Questo processo laicizzante, consistente nel
sostituire Dio con la natura, si sviluppò dunque da allora oscillando in due direzioni parallele: una
negativa, scettica, pessimistica, e una positiva, affermatrice, ottimistica, non senza ripetuti tentativi
da parte dell’una di incorporare l’altra.
I protagonisti di questi due rami della laicizzazione dell’Europa sono i protagonisti della cultura
(Kultur) europea: Nicola Cusano, Erasmo da Rotterdam, Lutero, Giordano Bruno, Giulio Cesare
Vanini, Montaigne, Descartes, Pascal, Hume, Kant, Hegel, Stirner eccetera eccetera, fino al picco
della tendenza negativa con Schopenhauer e la sua scuola, Philipp Mainländer, Julius Bahnsen e
Eduard von Hartmann. Questi ultimi furono l’ultima grande provocazione in senso negativo, ed è ad
essa, a Schopenhauer in particolare, suo “perfetto antipode”, che Nietzsche più immediatamente
risponde con la sua tendenza affermatrice, rappresentata soprattutto da Così parlò Zarathustra.
Schopenhauer e i suoi discepoli si erano essi stessi opposti a quella che era stata l’ultima grande
provocazione in senso contrario. Dopo il tentativo di Cartesio di “portare il cristianesimo a
compiuta efficacia innalzando la ‘coscienza scientifica’ alla sola coscienza vera e valida”,[10] il
tentativo di Pascal di ri-saltare con una “scommessa” dal campo laico a quello cristiano, dopo il
tentativo di Leibniz di fare ingoiare all’uomo il male del mondo come una purga sgradevole ma
benefica, e il tentativo di Hamann di rovesciare l’illuminismo col ricorso al cristianesimo profondo,
c’era stato il grandioso tentativo di Hegel di divinizzare il mondo portando la filosofia al
cristianesimo, invece che il cristianesimo alla filosofia.[11]
Con lo Zarathustra, in cui si esprime con la massima forza la tendenza affermatrice che è la
caratteristica principale del suo genio, Nietzsche fonda la religione laica. Questa passa attraverso la
radicalizzazione del pessimismo schopenhaueriano, fondato sull’ineluttabile dipendenza dell’uomo
dalle sue condizioni di esistenza, come parte infinitesimale di un immenso organismo, l’universo,
alle cui leggi è sottoposto (religione dunque dell’umiltà e non della superbia, come sostiene
Benedetto XVI), e l’affermazione dell’essenza divina della vita, di cui tutti gli esseri sono partecipi.
L’essenza sublime e beatificante della vita non può essere negata, ma solo oscurata o impedita dalle
circostanze o condizioni di esistenza. Dunque slancio, passione, entusiasmo, amore della vita sono
giustificati nonostante tutti i possibili orrori e tragedie dell’esistenza. Questa è la grande novità
predicata in sostanza da Nietzsche.
Come tale la religione laica di Nietzsche-Zarathustra supera quella predicata da Spinoza, da
Nietzsche eletto a suo “grande precursore”. Al desensualizzato amor dei intellectualis spinoziano,
infatti, Nietzsche contesta la mancanza della passione, dell’ardore, del “sangue” (quanto a lui, dice:
“io amo il sangue”). Può darsi che Spinoza intendesse questo amor dei intellectualis in maniera
calda e non fredda, e si limitasse a usare un’espressione fredda per coerenza con l’“odine
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
geometrico” (scientifico) impresso al suo capolavoro, L’Etica dimostrata secondo l’ordine
geometrico. Egli ha infatti anche un’altra espressione che appare fredda, ma che potrebbe essere
intesa nel senso più caldo, specialmente da coloro che considerano Spinoza un mistico, come, in
Italia, Giorgio Colli, Piero Martinetti e Luigi Pareyson: “L’uomo conosce l’eterna e infinita essenza
di Dio”. Sta di fatto però che amor e intellectualis sembrano cozzare e Nietzsche critica Spinoza,
nell’aforisma 198 di Al di là del bene e del male, per la sua fede nella “distruzione delle passioni per
mezzo della loro analisi e vivisezione”, mentre nell’aforisma 372 della Gaia scienza definisce
l’amor dei intellectualis uno “scricchiolio”.
Quando, composto il primo Zarathustra, Nietzsche non sapeva quale valore, quale senso esso
potesse avere, e lo domandava agli amici oltre che a se stesso, Peter Gast sentenziò: “È una sacra
scrittura”. Ciò lo illuminò, lo aiutò a capire se stesso, finché non ebbe più dubbi. Parlò allora dello
Zarathustra come “la Bibbia del futuro, la massima esplosione del genio umano, in cui è racchiuso
il destino dell’umanità”.[12]
Ciò nonostante, in seguito si fece riassorbire dallo Zeitgeist e dai dibattiti dell’epoca, agitata dai
venti selvaggi della reazione alla decadenza e impegnata soprattutto nello scalzare gli ostacolanti
valori cristiani. Come suprema antenna e strumento dell’epoca, Nietzsche si distaccò pian piano
dalla sua più grande e gloriosa conquista, celebrata nello Zarathustra appunto, per tornare a
combattere il cristianesimo non più con l’eccellenza, con la divinità della vita concepita laicamente,
ma con la lotta corpo a corpo, con lo scontro aperto. Ma ciò vuol dire che il suo genio si oscurò. Da
Al di là del bene e del male in poi, attraverso la Genealogia della morale, il Crepuscolo degli idoli,
L’Anticristo e Ecce homo, egli precipitò in una specie di monomania, si dedicò a uno scontro
personalissimo col cristianesimo dai toni stridenti, esagerati e in definitiva grotteschi.
Nietzsche era stato sempre agitato dal genio religioso. Questo cercò di venire in luce in tutti i modi,
anche per vie traverse: nell’adolescenza come adesione appassionata al cristianesimo, che però, per
la sua stessa radicalità, sfociò nella negazione; poi con la teoria dell’Eterno Ritorno, che egli
concepì appunto come religione e di cui si pensava, sia pure con raccapriccio, destinato ad essere il
maestro.
Ma l’Eterno Ritorno era contraddittorio. Pensato come stimolo a una vita degna, di cui ci si potesse
compiacere per l’eternità, dunque come incitamento morale, guardava al futuro ma saltava il
passato. Se l’Eterno Ritorno è veramente eterno, la nostra vita attuale non è che la pedissequa
ripetizione di quella che è dall’eternità e tale sarà per l’eternità, immutabilmente. Dunque nessuno
sforzo per il suo miglioramento è possibile e ha senso. In tal modo il progettato incitamento morale
si capovolge in deprimente fatalismo. Pertanto l’Eterno Ritorno, come religione, non funzionava.
Funzionava invece quello che egli, in opposizione a Schopenhauer, chiamava il “pessimismo
dionisiaco” o pessimismo della forza. A patto però di distinguere i due elementi che erano in esso
intrecciati. Il dualismo in filosofia è di solito un problema. Ma qui esso sarebbe stato la soluzione. Il
dualismo ha in effetti due corni: l’essenza divina e beatificante della vita e le condizioni di
esistenza, che possono essere ostacolanti e impedienti fino all’orrore. Nella vita le due cose si
fondono e confondono, ma sono diverse e vanno distinte.
Nietzsche esemplificò in Goethe il grande vessillifero di questa nuova religione. Oggi se ne può
aggiungere un altro che c’è stato dopo: Bertrand Russell. Questi, in particolare nel suo libro On God
and Religion, si manifesta seguace della religione laica, senza esservi stato spinto da Nietzsche ma,
evidentemente, per la maturità dei tempi. Ma già prima di Russell c’era stato in Italia Croce, che in
particolare col suo saggio Perché non possiamo non dirci cristiani, propugnò la religione laica, a
sua volta non spinto a ciò da Nietzsche.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Ma se per proclamare questa religione nella sua chiarezza c’è bisogno dei filosofi in veste di profeti
religiosi, per seguirla non c’è bisogno di filosofia, di teoria: la potenza, la bellezza e la divinità della
vita, cioè l’eterna e infinita essenza di Dio, come dice Spinoza, le sentono tutti, come pure, d’altro
lato, le terribili condizioni d’esistenza.
Come fondatore della religione laica, Nietzsche raggiunge dunque Lutero, non soltanto come genio
linguistico, quale è da tutti riconosciuto, ma anche come genio religioso.
In conclusione due immagini che possono dare una chiarezza intuitiva:
1) L’opera di Nietzsche è come il globo terrestre, con una superficie fredda e rigida e con un
nucleo infuocato, magmatico, che preme verso l’esterno. Il cuore di questo nucleo è il genio
religioso, che solo sporadicamente trova vie di sfoogo.
2) Così parlò Zarathustra illumina le opere precedenti e susseguenti come il sole i suoi pianeti,
dove è da notare che il sole è immensamente più grande dei pianeti. Questi sono le opere scettiche,
in funzione di difesa e di offesa, che spazzano via tutte le false credenze per far posto all’alto e
sereno tempio dello Zarathustra. Questo si può anche configurare come un sacro monte, attorniato
alla base dalle opere scettiche (la “filosofia” di Nietzsche).
NOTE
[1] F. Nietzsche, Ditirambi di Dioniso, Guanda, Parma 1967, p. 21.
[2] Ibidem.
[3] C.P. Janz, Vita di Nietzsche, III volume, Roma-Bari 1982, p. 215.
[4] Questa non era l’idea di Nietzsche, per il quale l’individuo non deve servire nessuno, neanche
l’umanità. Quanto a se stesso, nella lettera del 25 novembre 1888 a Heinrich Köselitz dice: Mi sono
posto […] al di là, non al di sopra di ciò che conta ed è in auge oggigiorno, ma al di sopra
dell’umanità”. Ma bisogna considerare che era prossimo a impazzire.
[5] Ecce homo, “Perché io sono un destino”, 1.
[6] Frammento postumo 2 [127] 5, autunno 1886.
[7] Frammento postumo 34 [253] aprile-giugno 1885.
[8] Umano, troppo umano, 39.
[9] F. Nietzsche, La gaia scienza 380.
[10] Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum (L’unico e la sua proprietà), Reclam, Stuttgart
2011, p. 92 (… das Christentum zu vollendeter Wirksamkeit zu bringen, indem sie das
“wissenschaftliche Bewusstsein” zum allein wahren und geltenden erhob).
[11] Come ultimo ostacolo Nietzsche non vede Schopenhauer, ma il cristianesimo, che era e restava
il suo più grande nemico, e a cui correva sempre il suo pensiero: “Persino il cristianesimo diventa
necessario: solo la forma suprema, più pericolosa, più seducente del no alla vita ne sfida la suprema
affermazione” (Frammento 25 [7] dicembre 1888-gennaio 1889). Nel frammento 14 [25] primavera
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
1888 aveva indicato tuttavia in Schopenhauer, oltre che in Vigny, Dostoevskij, Leopardi e Pascal, il
principale ostacolo al pessimismo classico o della forza.
[12] F. Nietzsche, lettera del 26 novembre 1888 a Paul Deussen.
Sossio Giametta è nato a Frattamaggiore (Napoli) nel 1929 e vive a Bruxelles. Collaboratore di
Colli e Montinari all’edizione Nietzsche, ha tradotto tutte le opere del pensatore tedesco, oltre a
quattro volumi di frammenti postumi e a opere di Cesare, Spinoza, Goethe, Hegel,
Schopenhauer, Freud. Ha pubblicato libri di saggistica filosofica e letteraria e un libro di
narrativa, Madonna con bambina e altri racconti morali (2006). Il suo ultimo libro è L’oro
prezioso dell’essere. Saggi filosofici (Mursia, 2013).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
I beni comuni tra vecchi cliché e nuove sfide
di RICCARDO CAVALLO
Le aggressive pratiche di accaparramento delle risorse naturali da parte delle multinazionali tese
alla sottrazione di beni alla collettività per piegarle alle spietate logiche di mercato, come il land
grabbing, sembrano richiamare alla mente gli idilliaci processi del capitale già denunciati da Marx
più di un secolo fa. Di fronte ad un siffatto scenario la tutela giuridica dei beni comuni potrebbe
essere una rivoluzionaria via d’uscita da un sistema prigioniero dell’asfittica logica binaria
pubblico/privato.
1. I beni comuni: tragedia o farsa?
Da ‘acquabenecomune’ campagna portata avanti con successo dal Forum dei movimenti per
l’Acqua contro la privatizzazione delle risorse idriche e conclusasi con la vittoria referendaria nel
2011 è stato un crescente proliferare di proclami ‘ariabenecomune’, ‘naturabenecomune’,
‘marebenecomune’, etc. fino a costituire uno dei punti cardine del ‘soggetto politico nuovo’ ALBA
(acronimo per Alleanza, Lavoro, Beni comuni, Ambiente) o culminare nel motto di una coalizione
politica (“Italia. Bene comune”). Il ‘benecomunismo’ come è stato ben presto etichettato sembra
dunque essere diventata una sorta di virus che ha permeato tutti gli aspetti della nostra società,
diventando il vessillo di nuovi movimenti più o meno politicizzati. Come sempre accade in questi
casi, però, quando un termine viene utilizzato nei contesti più disparati può rimanere facilmente
preda di malintesi, fino alla desemanticizzazione del termine stesso ‘beni comuni’: se ogni cosa che
ci circonda è bene comune nulla lo è. Per evitare di cadere in pericolose semplificazioni è forse
necessario fare un po’ di chiarezza, cercando innanzitutto di comprendere se il fenomeno dei beni
comuni sia figlio dell’attuale società globalizzata o se, al contrario, sia qualcosa che affonda le sue
radici in un passato ben più lontano. Non è un caso infatti che ci sia stato un fiorire di pubblicazioni
e dibattiti, sia in ambito accademico che all’interno delle meno paludate assemblee di partiti e
movimenti, sull’origine dei beni comuni. Mai come in questo caso il crescente interesse per questa
tematica ha dato luogo a una serie eterogenea di significati e funzioni a volte anche in netta antitesi.
Da un punto di vista filosofico-giuridico, ad esempio, le prime teorizzazione dei beni comuni
vengono fatte risalire sia al diritto romano di epoca precristiana, sia alla filosofia di tradizione
tomistica della ‘Seconda Scolastica’, o ancora, a quella che viene definita la prima Costituzione
scritta della civiltà occidentale, la Magna Charta del 1215 e la sua meno conosciuta ‘sorella
minore’ Charter of the Forest, che garantiva al popolo il libero accesso alle foreste e ai beni
comuni, fino ad arrivare, con un salto di parecchi secoli, al codice civile napoleonico del 1804, in
cui accanto all’art. 544 che definisce la proprietà privata, vengono disciplinati con l’art. 542 i beni
comuni intesi come «quei beni la cui proprietà o sui cui frutti gli abitanti hanno un diritto
acquisito». Com’è facile capire dunque, cercando di ripercorrere la genealogia dei beni comuni ci si
può imbattere nei personaggi più disparati, da Guglielmo da Ockham a Thomas More, passando per
Rousseau ed Hegel, per giungere fino a Toni Negri e Michael Hardt che elaborano una nuova
proposta filosofico-politica tesa alla riappropriazione del ‘comune’ da parte della moltitudine,
depredata dal sistema economico di stampo capitalistico. Tralasciando per il momento la questione,
non certo dirimente, della derivazione, più o meno risalente, dei beni comuni, l’idea di sottrarre dei
beni alla proprietà privata per rimetterli a disposizione della collettività, senza tuttavia che essi
ricadano nei beni pubblici o demaniali (da qui lo slogan di successo ‘al di là del pubblico e del
privato’) e di come tali beni possano materialmente essere fruiti ha dato luogo soprattutto ad un
dibattito sviluppatosi in ambito economico a partire dal noto articolo del biologo Garrett Hardin The
Tragedy of the Commons pubblicato su Science nel 1968. Tale articolo, il cui titolo è diventato negli
anni una sorta di anatema nei confronti di chi volesse portare avanti politiche di incentivo dei beni
comuni, occupandosi del problema della sovrappopolazione mondiale mette in evidenza il rapporto
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
direttamente proporzionale tra la messa a disposizione in maniera illimitata di risorse in comune (ad
esempio, la possibilità di far pascolare un gregge su un terreno) e la tendenza all’accaparramento di
risorse da parte dei singoli fino all’impoverimento delle stesse. Quello che appariva un dilemma
insanabile è stato risolto con efficacia da Elinor Ostrom, la quale dimostrando empiricamente come
fosse possibile governare i commons grazie ad una accresciuta capacità di comunicazione tra i
consociati, ha del tutto sovvertito la tesi pessimisticamente sostenuta da Hardin, con risultati così
sorprendenti da farle conquistare il premio Nobel per l’economia (mai attribuito prima ad una
donna) e riportare in auge la tematica dei beni comuni.
2. La rivoluzione dei beni comuni: il panorama italiano
Tra gli svariati tentativi di tematizzare in maniera più organica un concetto per sua natura sfuggente
e variegato emerge, almeno nel nostro Paese, l’opera da diversi anni svolta da un gruppo di studiosi,
per lo più giuristi ed economisti, che hanno lavorato in seno alla Commissione Rodotà con il
precipuo scopo di elaborare principi e criteri direttivi che potessero fungere da base per una
modifica radicale delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. La Commissione,
istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007 e presieduta dal noto civilista Stefano Rodotà, si
è posta come obiettivo la regolamentazione, del tutto inesistente nel nostro codice civile, di
determinate categorie di beni come quelli immateriali che rivestono ormai nell’attuale sistema
economico una rilevanza fondamentale. Ben lungi dall’essere solo un mera operazione di
‘aggiornamento’ di una disciplina codicistica ormai per molti versi desueta, trattandosi di un codice
approvato agli inizi degli anni Quaranta del Novecento, in realtà, l’obiettivo della Commissione
Rodotà era molto più ambizioso. Posta la crescente scarsità di risorse naturali come l’acqua, l’aria e
i boschi, si è ritenuto necessario puntare l’attenzione ad una maggiore tutela delle stesse mediante
l’elaborazione di una nuova categoria di beni giuridici, per l’appunto quella di ‘beni comuni’ che
avessero un nesso indissolubile con la tutela dei diritti della persona e degli interessi pubblici
sostanziali per come stabiliti dalla nostra Costituzione. Da qui la definizione, per alcuni
rivoluzionaria, per altri, al contrario, dai contorni troppo incerti, di beni comuni come «quei beni
che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo». A
dispetto di quanto si possa desumere da una lettura superficiale, non si tratta tanto di una
riaffermazione del ‘pubblico’ a dispetto del ‘privato’ in quanto si discute di modificare il regime di
appartenenza del bene, quanto le sue modalità di fruizione che, nell’ottica della Commissione, va
collocata, al di là del pubblico e del privato. È necessario, quindi, elaborare una nuova categoria che
riesca ad andare oltre le vecchie logiche pubblico/privato (Stato/mercato) per adeguarla ad un totale
cambio di prospettiva che richiede la tutela dei beni comuni nell’attuale società. Infatti, questi ultimi
dovrebbero rispondere ad una diversa forma di razionalità, in grado di fronteggiare i cambiamenti
profondi che attraversano la contemporaneità investendo la dimensione sociale, economica,
culturale, politica. In altre parole, occorre abbandonare quella logica che ha ‘condannato’ il nostro
diritto a rimanere ancorato ad un sistema rigidamente binario, poiché, come ha affermato Rodotà
già oltre trenta anni addietro, solo gli interessi collettivi e un’impostazione non proprietaria possono
far «guadagnare al mondo istituzionale una terza dimensione, nella quale si muovono a disagio i
cultori della geometria istituzionale piana». La battaglia portata avanti da Rodotà non è rimasta
tuttavia confinata nell’alveo delle mere teorizzazioni giuridiche ricevendo persino l’avallo delle
Sezioni Unite della Cassazione Civile (SSUU 14.02.2011, n. 3665) che con una decisione relativa
alla proprietà delle valli da pesca della laguna di Venezia, ha affermato «oggi non è più possibile
limitarsi all’esame della normativa codicistica del 1942, risultando indispensabile integrare la stessa
specificamente con le norme costituzionali» che vengono individuate nell’articolo 2 (diritti della
persona, intesa non solo singolarmente ma nelle formazioni sociali dove sviluppa la personalità),
art. 9 (tutela del paesaggio) e art. 42 (proprietà pubblica e privata, di cui bisogna assicurare la
finalità sociale). Da tali richiami la Suprema Corte esprime «l’esigenza interpretativa di “guardare”
al tema dei beni pubblici oltre una visione patrimoniale-proprietaria per approdare ad una
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
prospettiva personale-collettivistica» a partire, cioè, dal «dato essenziale della centralità della
persona da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento di diritti inviolabili anche mediante
l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Da tali premesse
arriva la conclusione che laddove «un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per
le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico,
destinato alla realizzazione dello Stato sociale, come sopra delineato, detto bene è da ritenersi
“comune” vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato agli interessi
di tutti i cittadini». Forte di questa vittoria la Commissione non sembra essersi fermata tant’è che è
di questi giorni la notizia relativa alla sua ripresa dei lavori: dismessi i panni più prettamente
istituzionali essa diviene “aperta” ed “itinerante”, quasi volendo anche nella forma incarnare lo
spirito della tanto auspicata ‘rivoluzione dei beni comuni’. Composta in maniera più fluida da
accademici afferenti a diverse discipline e attivisti dei movimenti sociali, essa procederà facendo
tappa nei luoghi più significativi della battaglia per i beni comuni come il Teatro Valle Occupato,
che il giurista Ugo Mattei, uno degli esponenti di punta di questo movimento, ha definito vera e
propria «esperienza di legalità costituente».
3. Il futuro alle nostre spalle
Ma se si mettono per un attimo da parte sia l’entusiasmo movimentista degli ultimi anni, sia
l’ambizioso tentativo di enucleare un concetto di beni comuni necessariamente agganciato alla
tutela dei diritti fondamentali, non si può non scorgere nell’idea di ‘riappropriazione’ a beneficio
dei consociati sottesa al ‘benecomunismo’ attuale – nonostante la complessità della tematica dei
beni comuni e le ovvie diversità di contesto storico-sociale – gli echi di quanto già affermato da
Karl Marx nei suoi scritti giovanili da sempre ritenuti, forse a torto ‘minori’ e, in particolare, quelli
riguardanti i dibattiti della Dieta renana sulla legge contro i furti di legna. Il filosofo di Treviri,
all’epoca caporedattore della Rheinische Zeitung, incomincia a misurarsi con i conflitti economicosociali che caratterizzano la società tedesca dell’Ottocento come si evince dalla lettura di questi
articoli pubblicati nell’autunno del 1842. Con la consueta prosa ironica Marx si avventura nei
meandri della scienza giuridica, schierandosi a difesa del diritto consuetudinario dei non proprietari.
La forza ermeneutica del suo discorso sta nella capacità di svelare l’arcano che si nasconde dietro il
paravento giuridico dove si celano dei veri e propri rapporti di forza tra classi antagoniste. Difatti, la
legge che estende la qualifica di furto alla raccolta di legna, fino allora considerata del tutto
legittima in base agli usi civici consolidatisi nel tempo come diritto consuetudinario, era in realtà
una sorta di grimaldello utilizzato dai possidenti per scardinare il diritto consuetudinario al fine di
sanzionare, addirittura con i lavori forzati, il comportamento della plebe che in stato di necessità, a
causa della crescente povertà, si procurava la legna necessaria al soddisfacimento dei bisogni
primari. L’argomentazione di Marx risulta sorprendente per la sua abilità nell’utilizzare le
conoscenze giuridiche a sostegno della propria tesi. Come in un’ideale aula di giustizia Marx veste i
panni di un beffardo avvocato che riesce a demolire la tenuta giuridica della legge sui furti di legna,
evidenziando l’insostenibilità della nuova fattispecie di reato. Ad esempio Marx contestava come
fosse impossibile equiparare due fatti materiali del tutto diversi come l’asportazione o raccolta di
legna caduta dagli alberi alla sottrazione furtiva di legna verde dagli alberi (c.d. taglio furtivo di
piante). I sostenitori di tale equiparazione, con la conseguente criminalizzazione di condotte prima
consentite, affermavano che fosse necessario porre un argine al comportamento doloso che molti
‘raccoglitori’ erano soliti porre in essere: intaccare gli alberi verdi per farli perire e,
successivamente, trattare il legname da essi derivato come ‘legna caduta’. A tale obiezione che lo
stesso Marx giudica ‘acuta’, oppone un altro argomento difficile da contestare: se si pongono sul
piatto della bilancia la salute di ‘giovani alberi’ e quella degli uomini chi è necessario salvare? Marx
ovviamente non ha dubbi sul suo propendere a favore di questi ultimi e inveisce con vivo sarcasmo:
«trionfino gl’idoli di legno e cadano le vittime umane!». Già da tali riferimenti è facile intuire come
nelle sue parole fosse racchiuso il dilemma che avrebbe arrovellato, a distanza di più di secolo,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
economisti e giuristi di ogni parte del globo: la ben nota tragedia dei beni comuni e il suo
interconnesso problema del rapporto tra sostenibilità ambientale e sostentamento dell’uomo.
Nonostante la costante causticità, Marx sembra ben comprendere qual è la posta in gioco, anche in
una questione limitata territorialmente come quella degli usi civici del legnatico nella Renania. Ben
prima che i tempi fossero maturi per poter sviluppare una vera e propria coscienza ecologista, egli
aveva colto che il rapporto tra natura e uomo non poteva che svolgere un ruolo cruciale, malgrado
egli scelga di propendere per quest’ultimo, cosa che alle nostre menti ormai avvezze alle battaglie
ambientaliste può apparire come un tragico errore (del resto erano ancora inimmaginabili i danni
che la deforestazione selvaggia o le piogge acide avrebbero prodotto in futuro ma erano, al
contrario, ben evidenti le miserrime condizioni degli uomini e, in particolare, dei lavoratori
appartenenti al gradino più basso della scala sociale). È chiaro allora che l’obiettivo di Marx non era
(non poteva esserlo!) quello di uno ‘sviluppo sostenibile’ ma di una lotta senza remore non alla
proprietà tout court ma a quella borghese troppo idealizzata ed idolatrata, come si evince dalla
lettura del Manifesto dove la sua critica assurge a vero e proprio tratto portante della teoria
comunista. Quello che viene prima solo abbozzato (la riappropriazione di qualcosa che spetta ai
consociati liberamente) viene ribadito con forza nelle taglienti pagine del capitolo XXIV del
Capitale sulla cosiddetta accumulazione originaria. Qui Marx intende confutare ab imis gli ‘idilliaci
processi’ che hanno caratterizzato l’accumulazione originaria, cioè la tanto celebrata accumulazione
primitiva intesa come frutto del lavoro e del risparmio dei lavoratori. Non c’è nulla di ‘idilliaco’
afferma Marx con fermezza, portando alla luce una realtà ben diversa da quella descritta dagli
economisti classici (e, in particolare da Adam Smith): «il furto dei beni ecclesiastici, l’alienazione
fraudolenta dei beni dello Stato, il furto della proprietà comune, la trasformazione usurpatoria,
compiuta con un terrorismo senza scrupoli, della proprietà feudale e della proprietà dei clan in
proprietà privata moderna». In altri termini, una storia violenta di soprusi perpetrati da chi si è
arricchito a dismisura nei confronti degli ‘spossessati’. Le espropriazioni forzate delle terre a danno
della popolazione rurale e, più in generale, la pratica delle enclosures, ovvero la recinzione delle
terre comuni destinati al pascolo a favore dei proprietari terrieri, comportavano l’arricchimento dei
proprietari e l’impoverimento dei contadini non proprietari, costretti alla fame e ben presto
trasformati nella forza lavoro salariata. «Questi metodi – sottolinea Marx – conquistarono il campo
all’agricoltura capitalistica, incorporarono la terra nel capitale e crearono all’industria delle città la
necessaria fornitura di proletariato eslege».
4. Contro nuovi idilliaci processi
Le enclosures tuttavia non sono da relegare ad un passato ormai lontano, poiché oggi stiamo
assistendo a nuovi e forse ancora più devastanti fenomeni di recinzione, come il c.d. land grabbing
(incetta di suoli o furto della terra). Si tratta di un processo in forte espansione messo in atto da
multinazionali, fondi immobiliari e persino governi dei Paesi economicamente più forti (si pensi
alla Cina e alla Corea del Sud) che hanno iniziato a comprare enormi estensioni di suoli fertili e le
relative risorse idriche ed energetiche a prezzi risibili dai Paesi più poveri dell’Africa, dell’Asia e
dell’America Latina. Ad esempio, solo in Madagascar la metà dei terreni agricoli del Paese, cioè
circa 1.300.000 ettari, è stata acquistata dalla Corea del Sud che destinerà queste terre alla
coltivazione di mais e altri prodotti da esportazione. Queste spregiudicate operazioni hanno portato
alla sottrazione ‘legale’ di milioni di ettari di terreni, destinati ad una forma di agricoltura
industrializzata ed intensiva a discapito delle popolazioni locali che avevano in quelle terre le loro
uniche fonti di sostentamento. Invero chi compra queste terre non è minimante interessato alla sorte
di chi ci vive da sempre che, nei paesi più poveri sono addirittura privi di qualunque documento
legale che comprovi la loro proprietà. La vendita avviene in questi casi a livello governativo e
dunque all’insaputa dei suoi abitanti che si ritrovano improvvisamente spossessati e scacciati dalle
proprie terre mentre i più ‘fortunati’ vengono assunti come bracciati a bassissimo costo nelle stesse.
Il land grabbing si può considerare come una vera e propria forma di ‘rapina’ del mondo ‘ricco’ nei
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
confronti di quello ‘povero’. Allo stesso modo, anche le legislazioni di alcuni Paesi operano contro i
loro stessi abitanti con il risultato di favorire un saccheggio di terre e risorse senza fine. È il caso
della Cina, dove negli ultimi decenni più di settanta milioni di contadini hanno subito gli effetti di
una privatizzazione selvaggia dei loro terreni agricoli, destinati dal governo ad opere di
urbanizzazione. Un quadro ancora più sconsolante è quello presentatosi in Messico, dove grazie ad
una modifica legislativa agli inizi degli anni Novanta è stato eliminato il sistema delle terre comuni
(ejjdos), prima garantite addirittura dalla Carta costituzionale, in quanto ritenute poco redditizie,
con il risultato di ‘sfrattare’ milioni di contadini a vantaggio di una privatizzazione sfrenata che ha
favorito solo investitori stranieri senza scrupoli. Non si può non scorgere pertanto
nell’accumulazione di risorse nelle mani di pochi e nella conseguente sempre maggiore
pauperizzazione di intere masse, la stessa logica criminale denunciata, a suo tempo, da Marx. Anzi
attualmente quegli effetti deleteri che egli metteva in evidenza non possono che risultare, in una
società globale, amplificati fino a raggiungere proporzioni, a dir poco, allarmanti, tali da far
assumere ad un fenomeno ristretto come quello delle recinzioni verificatosi originariamente in
Inghilterra dimensioni mondiali. È proprio la globalizzazione e la logica di profitto sfrenato ad essa
sottesa imposta dalle multinazionali a concepire l’intero pianeta in termini di proprietà privata da
sfruttare fino al collasso. Le privatizzazioni e le ‘nuove recinzioni’ effettuate più o meno legalmente
dalle multinazionali dell’agrobusiness stanno non solo mettendo in ginocchio intere popolazioni ma
stanno distruggendo ogni forma di diversità, sia biologica che culturale, finendo col trasformare,
come ha efficacemente osservato Vandana Shiva, il mondo in un «gigantesco supermercato, in cui
beni e servizi prodotti con costi ecologici, economici e sociali estremamente alti vengono rivenduti
a prezzi stracciati». Le nuove forme di enclosures of the commons figlie della ‘filosofia di morte’
dell’economia neoliberista conducono non solo ad una sorta di neocolonialismo che trasforma in
merce ogni risorsa, ma ad un impoverimento oltre che di tipo strettamente economico anche
culturale e politico. Per tale ragione è più che mai necessario non sprecare l’occasione offertaci
dalla possibilità di tutelare i beni comuni. Sarà possibile farlo proseguendo il percorso più che
virtuoso, ma anche irto di pericoli, della Commissione Rodotà? Molti sono ancora i nodi irrisolti, ad
esempio: se sia possibile muoversi dentro la tradizione giuridica occidentale utilizzando le categorie
della tradizione romanistica (come l’actio popularis o la res communis omnium) o se sia necessario
elaborare delle categorie ex novo. E ancora: come risolvere le questioni relative alle decisioni
sull’erogazione di una risorsa e la distribuzione dei costi del suo utilizzo e mantenimento? In ogni
caso, la strada da percorrere è ancora lunga e per andare avanti sarà necessario operare un cambio
radicale di paradigma che implichi una reale alternativa alla deriva neoliberista. Per fare ciò è
necessario non dimenticare la lezione di Marx: mettendo da parte le implicazioni più
smaccatamente ideologiche, sarebbe opportuno oggi riprendere in mano le ‘armi del diritto’, come
fece egli stesso utilizzando il diritto consuetudinario contro il diritto dei ‘potenti’. Per porre in
essere una chiara inversione di tendenza alle logiche di mercato e alla ‘dittatura proprietaria’,
tuttavia, non è più possibile utilizzare il diritto consuetudinario che, come abbiamo visto nei casi di
land grabbing risulta, nient’altro che un’arma spuntata rispetto al diritto ‘forte’ delle multinazionali.
Il diritto del resto, come si evince non solo da questi recenti fenomeni di ‘espropriazione legale’
delle terre, ma anche dalla lettura dello stesso Marx, è un’arma a doppio taglio utilizzabile in senso
regressivo o progressivo, per consolidare le pretese dei ‘forti’ o per tutelare le istanze dei più
‘deboli’. I tempi sono ormai maturi affinché un uso alternativo del diritto nel campo dei beni
comuni possa imporre un reale cambiamento riuscendo ad incanalare positivamente la ‘violenza
creatrice del diritto’ di cui parlava Walter Benjamin a favore della collettività e non delle logiche di
mercato.
Bibliografia minima di riferimento
AA.VV., Oltre il pubblico e il privato, a cura di M.R. Marella, Ombre Corte, Verona 2012;
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
AA.VV., La società dei beni comuni, a cura di P. Cacciari, Ediesse, Roma 2010;
AA.VV., Lessico marxiano, Manifestolibri, Roma 2008;
AA.VV., L’uso alternativo del diritto, a cura di P. Barcellona, Laterza, Roma-Bari 1973;
D. Bensaïd, Gli spossessati, Ombre Corte, Verona 2009;
A. Ciervo, I beni comuni, Ediesse, Roma 2012;
A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Laterza, Roma-Bari 2013;
D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano 2007;
S. Liberti, Land grabbing, Minimum Fax, Roma 2011;
P. Linebaugh, M. Rediker, I ribelli dell’Atlantico, Feltrinelli, Milano 2004;
K. Marx, Scritti politici giovanili, Einaudi, Torino 1975;
K. Marx, Il Capitale, La Città del Sole, Napoli 2011;
U. Mattei, Beni Comuni, Laterza, Roma-Bari 2011;
U. Mattei, L. Nader, Il saccheggio, Bruno Mondadori, Milano 2010;
E. Ostrom, Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia 2009;
S. Rodotà, Il terribile diritto, Il Mulino, Bologna 1981;
S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari 2012;
S. Settis, Azione popolare, Einaudi, Torino 2012;
V. Shiva, Il bene comune della Terra, Feltrinelli, Milano 2006.
Riccardo Cavallo svolge attività didattica e di ricerca con la cattedra di Filosofia del Diritto
presso il Dipartimento Seminario Giuridico dell’Università degli Studi di Catania. La sua tesi
dottorale si è aggiudicata nel 2005 il Premio di filosofia “Viaggio a Siracusa”. Tra le sue
pubblicazioni più rilevanti le monografie: L’antiformalismo nella temperie weimariana
(Giappichelli, 2009) e Le categorie politiche del diritto. Carl Schmitt e le aporie del moderno
(Bonanno, 2007).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Il comunismo dei beni comuni
di MAURO BARBERIS
La questione dei beni comuni è seria, ma ne va evitata la retorica. Per questo occorre mettere da
parte il “benicomunismo” di Mattei e appoggiarsi decisamente a quello di Rodotà e Ferrajoli, nel
cui solco si inscrive anche il recente libro di Ermanno Vitale, "Contro i beni comuni. Una critica
illuminista".
Abbiamo votato tutti per il referendum sull'acqua pubblica, assistendo poi sgomenti ai vari tentativi
di riprivatizzarla. Molti di noi, alle politiche, hanno persino votato una coalizione denominata Italia
bene comune, salvo vederla subito implodere alla prova dei fatti, ossia dinanzi all'inciucio con il
berlusconismo. Quella dei beni comuni, in effetti, rischia di diventare un'etichetta meramente
decorativa, come è avvenuto con l'aggettivo 'sostenibile', inventato dall'ambientalismo profondo e
poi divenuto una qualifica che non si nega neppure all'insostenibile. Per fortuna, di fronte al rischio
concreto che quella dei beni comuni diventi l'ennesima retorica, buona per tutti e per nessuno,
stanno emergendo due reazioni.
Una reazione in senso stretto, una reazione reazionaria, è il benicomunismo di Ugo Mattei, giurista
di Torino, autore di un Manifesto dei beni comuni (2011) che sembra più un vangelo apocrifo,
l'incunabolo di una setta eretica, che un libro di diritto e/o di politica. Anche per questo, non userò
qui il termine 'benicomunismo' che – proprio come Guido Viale sul “Manifesto” dell'11 maggio
2012 – trovo «orribile, ridicolo e neogotico», soprattutto neogotico. Userò invece la locuzione
«comunismo dei beni comuni», senz'altro meno maneggevole della precedente ma molto più
confacente alla reazione reazionaria di cui sopra.
Una reazione salutare, invece, è quella dei migliori teorici italiani dei beni comuni, come Stefano
Rodotà, o piuttosto dei beni pubblici, come Luigi Ferrajoli: i quali, rifuggendo dalle tentazioni
dell'escatologia movimentista alla Mattei o alla Hardt & Negri, fanno due cose molto più utili,
oltreché molto più da giuristi. Intanto, spiegare cosa diavolo siano, i beni comuni, definendoli e
fornendone una lista che comprenda almeno l'acqua, i farmaci salvavita, l'accesso a internet,
insomma cose palpabili. Poi, e soprattutto, proporre come si potrebbe concretamente tutelarli, i beni
comuni, invece di eleggerli a oggetto di culti (m)isterici da parte di moltitudini invasate e osannanti.
S'inscrive autorevolmente in questa seconda scuola di pensiero il libro di un filosofo politico di
scuola bobbiana, Ermanno Vitale, ossia Contro i beni comuni. Una critica illuminista, appena
uscito da Laterza: che non è affatto un attacco ai beni comuni, come potrebbe apparire dal titolo, ma
una critica devastante al comunismo dei beni comuni e in particolare alle sue declinazioni
millenaristiche e misticheggianti, come chiarisce il sottotitolo. Parlandone, non vorrei davvero
togliervi il piacere di leggerlo – costa solo dodici euro, se vi interessa io l'ho pagato nove e rotti con
lo sconto – o peggio ancora fornirvi un pretesto per non leggerlo. Ma sono persino disposto a
correre il rischio che non lo leggiate purché il libro non passi inosservato, travolto come tanti dalla
crisi galoppante della saggistica.
Il testo si divide essenzialmente in due parti, secondo il classico schema pars destruens/pars
costruens (non è inglese, è latino, lo dico per i miei figli che hanno fatto lo scientifico). La prima
parte è una spassosa contro-narrazione della narrazione benicomunista, contro-narrazione
particolarmente efficace quando ne colpisce punti nevralgici quali il folklore medievista e l'irenismo
comunitarista (mi scuso di tutti questi paroloni, ma mi sono fatto contagiare dalla narrativa
benicomunista, che del resto vi consiglio, a volte è meglio della fantascienza). Toglietevi dalla testa,
però, che il libro di Vitale sia solo un pamphlet (neppure questo è inglese, lo dico sempre per i miei
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
figli, non certo per il lettore di questa rubrica): ad esempio, leggetevi la parte in cui Vitale rovescia
il luogo comune secondo cui Elinor Ostrom sarebbe favorevole ai beni comuni e Garreth Hardin
contro, e poi ne riparliamo.
La seconda parte, invece, ossia la pars costruens (che, detto per Enrico, si pronuncia com'è scritta) è
un'ottima sintesi delle ragioni per cui la sinistra del Duemila (la sinistra-sinistra: o qualcuno pensa
ancora che ce ne sia un'altra?) dovrebbe darsi una politica dei beni comuni, beninteso nel senso
intelligibile di Rodotà o di Ferrajoli e non in quello inintelligibile di Mattei, che rimette la
definizione stessa di bene comune alla pratica rivoluzionaria dei movimenti, sicché qualsiasi
scalmanato che occupa un bene, pubblico o privato, lo definisce per ciò stesso come bene comune.
La parte migliore del libro, secondo me, è quella sorta di decalogo che si trova fra pp. 105 e 122, e
che costituisce poco meno di un programma politico: un programma politico di governo, sottolineo,
e non di opposizione alla Fiat iustitia, pereat mundus (per Beniamino: non è la pubblicità di
un'utilitaria), perché con tutto il mio disgusto per la dirigenza del Pd io non mi sono mai rassegnato
all'idea che la sinistra non possa o non debba governare. Per carità, nel decalogo di Vitale non c'è
nulla di inaudito, molto si trova in autori come Tony Judt e Luciano Gallino, David Harvey e
Pierfranco Pellizzetti: ma insomma, ce ne fossero.
Per non suscitare il legittimo sospetto che tutto ciò sia solo una sviolinata per Ermanno o peggio
ancora il frutto di un complotto delle multinazionali per riprivatizzare il teatro Valle, come
qualcuno infallibilmente denuncerà, non basta segnalare gli inevitabili difetti del libro: come quella
frase sulle dure repliche della storia, ripetuta troppe volte e che personalmente ho sempre trovato
odiosa. Non occorre neppure aggiungere che la letteratura sui beni comuni cresce ogni giorno:
penso alla bella discussione fra Mattei e Pivetti, l'economista non la show girl, sull'ultimo numero
di “Micromega”, al dibattito ospitato recentemente da “Notizie di Politeia”, alla voce omonima di
Ulderico Pomarici in un manuale di filosofia del diritto fresco di stampa, ma anche – la pubblicità è
l'anima del commercio – al numero di “Ragion pratica” curato da Giulio Itzcovich e dal sottoscritto
in uscita a fine anno, nel quale Mattei certamente metterà con le spalle al muro i suoi critici, spero
non per fucilarli.
Piuttosto, bisognerebbe dire che il mondo è finito, nel senso che non è infinito e che non
disponiamo di un pianeta di riserva: sicché torna di stretta attualità il Lockean Proviso di Roberto
Nozick, l'idea che il mondo non è indefinitamente appropriabile e che la sua appropriazione
incontra sempre il limite che restino abbastanza risorse per chi dall'appropriazione è escluso. Su
questo bisogna lavorare: non sulle mitologie di chi abita i promontori della storia, stranamente
situati tutti nelle valli attorno a Torino, ma semmai su un costituzionalismo di diritto privato alla
Ferrajoli; non sulle fiabe della decrescita felice propalate sul web, e destinate a scontrarsi con la
realtà di nuove guerre fra poveri, ma su una critica anche economica dello sviluppo senza limiti,
ultimo hurrà della vulgata neoliberista.
Mauro Barberis studioso di Teoria del diritto e Storia delle idee politiche, autore di una
ventina di volumi scientifici come Libertà (1999), Etica per giuristi (2006) ed Europa del diritto
(2008) e condirettore di riviste come “Materiali per una storia della cultura giuridica” e
“Ragion pratica”.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Kafka e Derrida: l’origine della legge
di MARC CRÉPON
Leggere Kafka attraverso Derrida permette di comprendere in che modo la filosofia aiuta a mettere
in connessione diritto e letteratura. Si pone così la questione cruciale della “proprietà” della
lingua, e quindi della necessità, per ognuno, di inventare un idioma proprio, di affermare la propria
singolarità nella lingua.
Quando ci si interroga sulla relazione tra diritto e letteratura, viene subito in mente un terzo termine,
senza che si sappia in anticipo quale statuto accordare alla cosa che designa: se quello di una
disciplina, di un sapere o di un ordine del discorso. È la filosofia. Da lungo tempo essa riflette sia
sull’uno che sull’altra: esiste una “filosofia della letteratura” come esiste una “filosofia del diritto”.
Ma, soprattutto, una delle sue domande ricorrenti essendo l’origine della legge, la filosofia ha
sempre fatto ricorso a delle “finzioni” per tentare di dare risposta a questo enigma. Limitandoci a
due esempi, è il caso della novella di Rousseau sull’uscita dallo stato di natura, nel Discorso
sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini. E vale lo stesso per il modo in cui
Freud rende conto dell’origine della colpa, del divieto e della legge – quindi di tutte le istituzioni
morali e giuridiche – in Totem e tabù, con la sua storia dell’orda primordiale e del parricidio. Subito
sorge una domanda, tuttavia: questi testi possono ritenersi “letterari”? Qual è il loro statuto? E chi è
in grado di stabilirlo? A quale tribunale devono sottomettersi perché sia emesso il verdetto? A
quello dei giuristi, a quello dei teorici della letteratura, a quello dei filosofi o degli psicanalisti?
Senza dubbio, esistono almeno due modi di pensare la relazione tra diritto e letteratura. La prima,
estrinseca, riguarda i racconti, i romanzi o i drammi che hanno per oggetto il rigore della legge,
dell’apparato o della macchina giudiziaria – che fanno, in altri termini, delle cancellerie, delle aule
di tribunale e dei processi, con la loro trafila di interrogatori, testimonianze, requisitorie e verdetti, il
loro “soggetto”. Com’è noto, la descrizione implicata da tale relazione può essere realista, ai limiti
di un’inchiesta sociologica, quanto mostrarsi farneticante, allucinante, da incubo. In questo secondo
caso, non è questione soltanto dell’apparato giudiziario, ma proprio dell’“immaginario della
giustizia”, per come esso determina il nostro rapporto con la legge e i differenti affetti che lo
rendono complesso o lo contaminano. Se è vero, infatti, che il rapporto con la legge non è mai
puramente razionale, ma anche affettivo, a volte fino all’eccesso – angosciato, ansioso, se non già
ansiogeno –, è ovviamente nello spazio di questi affetti (e fino al desiderio o alla follia della legge)
che la letteratura può fare del diritto il suo oggetto. E il risultato non è trascurabile. Dal momento
che il rapporto con la legge è un elemento costitutivo della genesi di ogni soggettività – o, per dirlo
ancora diversamente, che in questo rapporto ne va della singolarità di ciascuno, la quale è per tutti
insostituibile –, è proprio questa singolarità che la letteratura fa conoscere e che richiama
all’attenzione del diritto.
Ma vi è una seconda relazione (quella che si evocava all’inizio) che è ancora di un’altra
complessità. Si costruisce intorno a una duplice incertezza: quella dell’origine della legge e quella
della letterarietà del testo letterario. O meglio, articola l’una all’altra le due questioni essenziali:
quella dell’accessibilità (o dell’inaccessibilità) di questa origine e quella della possibilità del
racconto che pretende di darvi accesso (o della sua impossibilità). Ora, non appena si entra nel
campo di questi prefissi negativi (inaccessibilità della legge, impossibilità del racconto), c’è
un’opera che richiama subito l’attenzione: quella di Kafka, iscritta nel segno di una duplice
incompiutezza e di una duplice ricerca inconclusa. Quella degli eroi kafkiani che non arrivano mai a
sapere da dove vengono le leggi, i decreti, le ragioni dei giudizi che sono applicati loro; e quella dei
racconti, che spesso non giungono alla fine.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Nondimeno, i racconti di Kafka non sono estranei neanche alla prima relazione descrittiva che si
evocava poco fa. Come tutti sanno, hanno dato luogo a numerosi commenti, che si ripartiscono in
almeno due diverse costellazioni di ricezione, secondo due grandi orientamenti. La prima riunisce,
negli anni 1930 e 1940 (segnati dall’ascesa del fascismo in Europa, dalle politiche discriminatorie,
dall’esilio, la deportazione e lo sterminio degli ebrei d’Europa), le letture di Hannah Arendt, Walter
Benjamin, Günter Anders o ancora Thomas Mann. La peculiarità di questa prima costellazione di
lettori è che essi hanno tutti in comune il fatto di leggere, commentare o scrivere prefazioni ai
racconti di Kafka in un periodo in cui sono costretti a fuggire dal loro Paese – condividendo con K,
l’“eroe” de Il castello, quella stessa situazione di “straniero” o di “esiliato” che costringe chi la
subisce a vivere nell’attesa di una decisione manifesta che gli riconosca il diritto di esistere là dov’è
arrivato. Nell’universo di Kafka, scoprono di volta in volta la descrizione o la profezia dell’incubo
nel quale l’Europa sta precipitando, quando ogni nuovo decreto, ogni nuova legge si identifica con
una minaccia per la libertà e i diritti fondamentali. La seconda costellazione, quarant’anni più tardi,
negli anni ’70 e ’80, riunisce un’altra generazione di filosofi: Gilles Deleuze e Felix Guattari, JeanFrançois Lyotard e Jacques Derrida, senza contare Maurice Blanchot che dagli anni Quaranta agli
anni Ottanta non ha mai smesso di tornare su Kafka. Anche qui, tra i loro diversi approcci non
mancano i punti di contatto: hanno tutti in comune il fatto di interrogarsi, a vario titolo, sulla
funzione politica di questi racconti come “politica della letteratura”. Da un punto di vista più
generale ancora, questi filosofi prendono spunto dai racconti di Kafka per pensare l’“essenza” o la
“funzione” della letteratura, laddove essa non è separabile da una riflessione sul diritto.
Ma questi due grandi orientamenti – quello che cerca nella letteratura una descrizione della nostra
relazione, reale o immaginaria, alla legge e all’apparato giudiziario; e quello che si interroga sulla
possibilità di un racconto che dà accesso alla legge, alla sua origine o al suo fondamento – questi
due grandi orientamenti sono davvero rigorosamente separabili? Non è, invece, il loro intreccio e il
loro intrico che ci fanno pensare e sperimentare i racconti di Kafka? Supponendo di accettare
l’ipotesi, ci sarebbe almeno un testo a confermarla: il racconto breve intitolato Davanti alla legge –
a maggior ragione se si ricorda che, prima di esserne stralciato per costituire un racconto a parte,
questo testo faceva parte de Il processo. Infatti, si tratta di una storia raccontata a K per bocca di un
prete, in un momento in cui egli sospetta tutti quelli che si occupano del suo affare di essere
prevenuti nei suoi confronti. In ambito romanzesco, questo racconto ha dato luogo a qualcosa di
molto simile a una vera e propria esegesi talmudica, che da allora si è globalizzata al punto che, in
tutte le lingue, non si contano più non solo le interpretazioni, ma anche le riprese e le riscritture che
ha suscitato – a cominciare da quella di Coetzee in La vita e il tempo di Michael K o Boubacar
Boris Diop.
È nel solco di una di queste riscritture in particolare che si iscriveranno le pagine che seguono. Si
tratta dalla lettura proposta da Derrida in un testo intitolato Pre-giudicati[1], pronunciato in
occasione di una decade di Cerisy dedicata al lavoro di Jean-François Lyotard. Questa lettura,
infatti, ha più di ogni altra il merito di aver posto, attraverso l’analisi del testo di Kafka, la duplice
questione dell’accessibilità dell’origine della legge e della possibilità di un racconto “letterario”
capace rendere quest’origine pensabile, laddove si gioca la tensione paradossale tra la generalità o
l’universalità della legge e la singolarità assoluta di ogni rapporto specifico con questa stessa legge.
I
Il racconto è ben noto: narra la storia di un “uomo di campagna” che, arrivato alle porte della legge,
si scontra con l’opposizione di un guardiano che gli impedisce di entrare. Pazienta per anni e anni,
urtandosi al medesimo rifiuto ogni volta che rinnova la sua richiesta. Infine, logorato e invecchiato,
si stupisce di essere da così tanto tempo il solo a reclamare l’accesso alla legge, e ottiene la
seguente risposta: «Nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato soltanto a
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
te. Ora vado a chiuderlo»[2]. Ne va dunque dell’accessibilità della legge (o piuttosto della sua
inaccessibilità, del mistero o dell’opacità della sua origine) come Derrida non manca di ricordare.
Ma, fin dall’inizio, l’autore di Pre-giudicati pone allo stesso modo la questione che associa alla
domanda su questa origine un’interrogazione sulla definizione o la circoscrizione della letteratura,
come se le due tematiche fossero in realtà indissociabili: «Il doppio problema sarà quindi il
seguente: “chi decide, chi giudica, e secondo quali criteri, dell’appartenenza di questo racconto alla
letteratura?”»[3].
Non a caso abbiamo scelto di cominciare citando la fine del testo: «Nessun altro poteva entrare
qui». Fin dalla prima lettura, infatti, si evince che, se si può ritenere questo testo emblematico delle
relazioni tra diritto e letteratura, è in virtù del fatto che esso mette in prospettiva il rapporto
paradossale tra la generalità della legge e l’assoluta singolarità di colui a cui si applica. In effetti,
pochi racconti quanto quelli di Kafka hanno mostrato, della legge, a qual punto il rapporto che si ha
con essa si iscriva singolarmente nel corpo di ognuno, nella voce, nei gesti e nelle posture, nella
maniera di star dritti o curvi, come quei profili che disegnava l’autore de Il processo. Lungi
dall’essere astratta, estranea alla sua vita, la legge fa parte della storia più intima del corpo. Nessuno
sa, tuttavia, quando tutto ciò sia cominciato e come la legge si sia incorporata. Probabilmente questa
incorporazione è anche, insieme alla coscienza della nostra finitezza, la parte più segreta di ciò che
ci è stato imposto, a nostra insaputa. Nondimeno, nessuno può ignorare di essere obbligato a convivere con essa, per tutta la vita. Poiché se resta indeterminata l’origine del rapporto con la legge,
almeno il suo termine è conosciuto. La lunga durata è il primo tema di Davanti alla legge. Non si
conosce l’età dell’uomo della campagna, quando si presenta alla porta della legge per entrarvi, ma
si sa quando finisce la storia: alle soglie della morte. Così, il racconto, pure brevissimo, è
punteggiato di note che evocano il tempo che passa, inesorabilmente, aspettando una risposta e un
esito:
Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere di fianco alla porta. Là rimane seduto per giorni e
anni.[…] durante tutti quegli anni l’uomo osserva il guardiano quasi senza interruzione. […] poi
quando invecchia si limita a brontolare. Rimbambisce […]. Ormai non vive più a lungo. Prima di
morire, tutte le esperienze di quel tempo si condensano nella sua testa in una domanda che finora
non ha rivolto al guardiano. Gli fa cenno poiché non può ergere il corpo che si sta irrigidendo.[4]
Ma la legge non si lascia conoscere e l’accesso resta sbarrato. Dopo tutto, non si sa nemmeno di che
tipo di legge si tratti: legge della natura, legge morale, legge giuridica, legge fondamentale. Vale a
dire che la sua generalità si ritrova raddoppiata. C’è senz’altro una “legge”, reale o immaginaria,
attestata dalla singolarità del rapporto che l’uomo di campagna intrattiene con essa, ma non se ne sa
niente. Soprattutto, il racconto non riesce a dirci di più. Non rende la legge più accessibile. L’unica
cosa che è in grado di fare è ripetere e riprodurre, raddoppiare, nella scrittura stessa, l’inacessibilità
della legge. Ecco lo iato: la legge dice il generale, si vuole universale, dovrebbe trattare solo casi
singoli, non deve tener conto degli alea soggettivi della sua incorporazione, né dell’enigma
costituito, per coloro ai quali si applica, dalla sua origine – mentre il racconto mette in scena la
singolarità di un’attesa, di una richiesta, di un’inquietudine e di un’angoscia, forse. Dal racconto, ci
si potrebbe dunque aspettare che apporti un correttivo a questa generalità, mettendo la legge in
relazione con quella singolarità che essa ritiene di aver il diritto di conoscere. Come ci si potrebbe
aspettare che, ne Il processo, la narrazione renda infine note a Joseph K le ragioni della sua
imputazione e, ne Il castello, all’architetto la fonte e la logica dei decreti che stabiliscono il suo
arrivo, o ancora, ne La metamorfosi, la causa effettiva della trasformazione improvvisa e
imprevedibile di Gregor Samsa in un enorme insetto. Ma non è così. A render conto di tutti questi
eventi “straordinari”, ci deve pur essere una legge che li spieghi e li giustifichi, di qualunque natura
sia (naturale, morale o giuridica). Ma più questi eventi appaiono usuali, banalizzati e perfino
ammessi come ordinari, più sembrano rientrare nei costumi o essere da sempre appartenuti a essi,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
meno questa legge si lascia conoscere. Più si va avanti nella narrazione e più la prospettiva di avere
accesso alla legge si perde in infinite giravolte.
Ecco perché, leggendo Davanti alla legge, Derrida evidenzia subito, come tema centrale del
racconto, il fallimento dell’incontro tra la singolarità del rapporto con la legge e l’essenza generale
o universale di questa stessa legge:
Vi è una singolarità a proposito della legge, una legge della singolarità che deve mettersi in
rapporto, senza mai poterlo fare, con l’essenza generale o universale della legge. Ora questo testo,
questo testo singolare, l’avrete già notato, designa o menziona a suo modo questo conflitto senza
incontro della legge e della singolarità, questo paradosso o quest’enigma dell’essere-davanti-allalegge.[5]
E prosegue poco più avanti:
Ciò che resta invisibile e nascosto in ogni legge si può dunque supporre che sia la legge stessa, ciò
che fa che queste leggi siano leggi, l’essere-legge di queste leggi. La domanda e la ricerca sono
ineluttabili, in altre parole l’itinerario in vista del luogo e dell’origine della legge. Questa si dà
rifiutandosi, senza dire la sua provenienza ed il suo sito. Questo silenzio e questa discontinuità
costituiscono il fenomeno della legge.[6]
Se richiamiamo ora alla mente le due questioni che sollevavamo all’inizio, ciò che deve attirare
l’attenzione è il modo in cui la questione dell’accessibilità (o dell’inaccessibilità) della legge si
rivela effettivamente indissociabile da quella della possibilità (o dell’impossibilità) del racconto e,
in ogni caso, del suo compimento. Com’è noto a tutti, questa inaccessibilità è una delle gradi
questioni su cui si concentra il lavoro di Derrida negli anni Ottanta. Se è vero che, fin dall’inizio –
cioè dai tre grandi libri del 1967: De la grammatologie, L’écriture et la différence e La voix et le
phénomène – il pensiero del filosofo ha per oggetto la decostruzione del soggetto sovrano, nella sua
stessa sovranità, in questo periodo la decostruzione assume una dimensione più apertamente
politica, che passa attraverso la messa in evidenza di ciò che, seguendo Montaigne, l’autore di
Forza di legge chiama “il fondamento mistico dell’autorità”. È dunque in questa prospettiva che si
deve leggere il commento a Davanti alla legge. Niente impedisce, infatti, di concepire l’impossibile
accesso della legge, nelle storie di Kafka, come un’altra figura o, più esattamente, come l’effetto,
ogni volta singolare, proprio di questo “fondamento mistico”. Ciò che, in ultima istanza, fa sì che le
leggi siano delle leggi e che noi dobbiamo sottometterci a esse, quali che siano le ragioni addotte in
favore di questa sottomissione: ecco il “fondamento” che ci sfugge sempre. E non sono, checché ne
dicano i rappresentanti della legge, l’attaccamento alla patria, la cittadinanza, il senso del dovere e
tutte quelle domande che il guardiano della legge pone all’uomo di campagna senza interesse,
«come le fanno i gran signori», che possono cambiare qualcosa. Le risposte date, quali che siano
(quelle, per esempio, che possono dare la filosofia del diritto, la filosofia morale o un trattato di
educazione del cittadino), non risolvono minimamente l’enigma del nostro rapporto con la legge.
Soprattutto, non esauriscono minimamente il desiderio dell’origine.
II
Tre fatti richiedono allora di essere articolati. Il primo è la resistenza della legge che conserva la sua
autorità categorica soltanto mantenendo segreto il suo fondamento. Per rispettarla, infatti, non c’è
alcun bisogno di conoscere la sua storia. Al contrario, in se stessa e da se stessa la legge non
richiede alcun racconto, che potrebbe venire a porre condizioni a questo rispetto. Deve anche
proteggersi da ogni tipo di tergiversazione storica che rischierebbe di contestare la sua autorità e
rimetterla in questione. Non c’è nemmeno nessun bisogno di ripiegare su se stessi, né di interrogare
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
il proprio passato in qualche vana introspezione. Nessuno sa, del resto, per quali buone o cattive
ragioni, nel racconto di Kafka, l’uomo di campagna si sia presentato alla porta della legge. Per darsi
un motivo supplementare per sottomettervisi? O per imparare a conoscersi meglio? Si è davvero
certi che voler “entrare nella legge”, come dice il racconto, sia un intento legittimo? Tuttavia, il
desiderio di smascherare il mistero o il segreto della legge è innegabile, forse perfino ineluttabile. E
perdura, ci dice il racconto, per tutta una vita. Ecco perché il secondo fatto che chiede di essere
preso in considerazione e che bisogna articolare a questa resistenza è la “pulsione genealogica” che
ne risulta. Ecco a che punto siamo: c’è da un lato la sovranità de la legge che non si lascia
avvicinare, che non chiede alcuna giustificazione, che tratta soltanto casi singoli, che li tiene a
distanza (non si sa quanti guardiani la proteggano), che non deve rendere conto a nessuno. E poi
c’è, nello stesso tempo, il fatto che nessuno al mondo vive in questo modo il rapporto con la legge –
che ciascuno è votato, nella sua carne, a un rapporto assolutamente singolare con la legge (che si
traduce nei suoi gesti e nella sua voce, nelle sue parole e nei suoi silenzi). Per dire tutto, c’è che
questo rapporto è anche, probabilmente, la prima prova della singolarità della legge, nella quale
ognuno è impegnato, corpo e anima. L’uomo di campagna vuole sapere, dunque. Nessun altro al
mondo desidera conoscere quanto lui. Vuole entrare nella legge, vederla o toccarla. La sua pulsione
è irresistibile – e scompare soltanto con la morte –, perché ne va della vita, perché forse conoscere il
segreto della legge renderebbe infine la vita più vivibile. Sì, è sempre in questi termini che ne va del
rapporto con la legge: di vita e di morte.
Entrare in relazione con la legge, con ciò che dice “Tu devi” e “Tu non devi”, è fare nello stesso
tempo come se essa non avesse storia o in ogni caso come se non dipendesse più dalla sua
presentazione storica e, contemporaneamente, lasciarsi affascinare, provocare, apostrofare dalla
storia di questa non-storia. È lasciarsi tentare dall’impossibile: una teoria dell’origine della legge, e
dunque della sua non-origine, ad esempio della legge morale.[7]
Il terzo fatto, allora, è la possibilità stessa della letteratura e della lingua che vi si inventa. Se è vero
che l’origine della legge è inaccessibile, che è essa stessa (la legge) imperiosa e che al contempo
ognuno è costituito, nel più intimo di se stesso, da un rapporto con la legge assolutamente singolare,
irriducibile, insostituibile, allora per colmare questo iato è chiamata, cercata, desiderata una lingua–
cioè per rendere giustizia [rendre droit] al desiderio di accordare la singolarità del rapporto e la
generalità della legge. Ma come dare diritto al singolare? Che cos’è che fa la “singolarità del
singolare”? La sua storia, innanzitutto. Il singolare esiste, come tale, raccontandosi. Ecco perché
bisogna partire da un racconto, nella speranza che finisca per giungere al luogo da cui proviene la
legge – legge che resta tuttavia, a dispetto di tutto, generale, ovvero che continua a resistere. È
questa la verità che porta il racconto di Kafka: è l’enunciato di questo difficile paradosso – un
enunciato anch’esso paradossale, dal momento che il racconto resta impossibile. Perché prenda
corpo, perché risponda alle attese che suscita, ci sarebbe bisogno, in effetti, di almeno due cose. Ci
sarebbe bisogno che la legge divenga accessibile, innanzitutto; ci sarebbe bisogno, inoltre, che si
trovi modo di esprimere la singolarità di colui che chiede di entrare nella legge.
Ora, da entrambi i lati, la prova della singolarità è messa sotto scacco. La legge persiste nel
mantenere il segreto del suo fondamento, e la singolarità di colui che si vota alla ricerca dell’origine
inciampa sulla generalità del linguaggio. In altri termini, potrebbe essere che il guardiano della
legge non sia nient’altro che la lingua stessa – che dice soltanto il generale e nel contempo porta
iscritta in se stessa la promessa impossibile di rendere giustizia al singolare. Questo rapporto tra
lingua e legge, Derrida l’ha messo in evidenza molte volte. Ci ritorna sopra soprattutto in un testo
scritto una decina d’anni dopo Pre-giudicati: Il monolinguismo dell’altro, o la protesi dell’origine
(di cui è importante sottolineare il sottotitolo). Tra i numerosi temi che costituiscono la trama di
questo libro, ce n’è uno, infatti, su cui dobbiamo concentrare l’attenzione. C’è sempre qualcosa di
perduto, dice Derrida (e perfino di sperduto [éperdu]) nel nostro rapporto con la lingua, in cui
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
alberga per sempre la nostalgia di un’origine introvabile: noi tutti non abbiamo che una lingua, ci
pieghiamo alla sua legge e, nello stesso tempo, poiché questa legge ci è imposta, la lingua non è mai
la nostra. Per questa ragione non esiste rapporto trasparente con se stessi che possa assicurare l’ego
della sua identità. Siamo stranieri nella lingua: sradicati, esiliati, estranei a noi stessi, come l’uomo
di campagna davanti alla porta della legge, e come spesso si sentiva Kafka in società, se stiamo al
suo diario. In altre parole, niente ci garantisce o ci prova che ci ritroveremo in quello che diciamo,
in quello che pensiamo, in quello che crediamo poter esser convinti di pensare e di esprimere da
noi.
Ecco perché la questione del nostro rapporto con la lingua non è separabile da quella della follia,
come forse altrettanto inseparabile è quella del nostro rapporto con la legge. Tre forme di follia
incombono sull’impossibile identificazione dell’ego, non davanti alla legge, ma nella lingua e con
la lingua, spiega Derrida ne Il monolinguismo dell’altro. La prima è la disintegrazione completa
dell’identità – un rapporto con se stessi e con la lingua talmente frammentato, talmente destrutturato
che è distrutta la possibilità stessa di ogni invenzione di linguaggio singolare (invenzione cui
Derrida dà il nome di “idioma”): una quasi afasia dunque, come in cui sprofondò Hölderlin, nella
sua torre, abbandonato alle cure del falegname Zimmer; o quella di Nietzsche, guardato da sua
sorella per anni. La seconda forma di follia, invece, non si confessa mai come tale. Lungi dal
pensarsi in questi termini, è anzi convinta della sua “normalità” – e probabilmente non c’è niente di
più folle e di più minaccioso di questa convinzione. Questa è la follia che abita ogni identificazione
normativa, anche in ciò che quest’ultima può avere di escludente e di discriminante. Rimuove il
lavoro della différance nell’illusione di un’identità con sé che è al contempo, e integralmente, quella
della collettività con la quale si identifica. È, senza dubbio, quella follia che siamo meglio preparati
ad affrontare dalla famiglia, dalla scuola, e da tutte le forze che ci dettano legge. Ma non è
nemmeno estranea ai romanzi e racconti di Kafka, il quale, dopo tutto, ne Il processo, Il castello o
La metamorfosi non racconta forse nient’altro che la disgiunzione di un’integrazione sociale,
familiare (la relazione col padre), professionale e così via, in uno spaventoso cortocircuito della
legge, del corpo e del linguaggio.
È poi c’è quella terza forma di follia che Derrida descrive così:
La follia di una ipermnesia, un supplemento di fedeltà, un sovrappiù o un’escrescenza della
memoria: avviarsi, al limite delle altre due possibilità, verso dei tracciati – di scrittura, di lingua, di
esperienza – che portano l’anamnesi al di là della semplice ricostruzione di un’eredità data, al di là
di un passato disponibile. Al di là di una cartografia, al di là di un sapere insegnabile. Si tratta qui di
tutt’altra anamnesi, e anche di un’anamnesi del tutt’altro[8]
«Un’anamnesi del tutt’altro»: comprendere di cosa si tratta, per quanto poco ci si riesca, sembra
permettere, retrospettivamente, di cogliere la posta in gioco di Davanti alla legge. Supponendo,
dunque, di ripartire dal punto che abbiamo appena stabilito: l’assenza di “identificazione stabile
dell’ego” attraverso (e dentro) la lingua, cioè attraverso (e dentro) la padronanza, il possesso, la
possibilità di disporre di una lingua che sia la nostra, perfettamente nostra, con la quale ci fosse
sempre possibile trovarci e ritrovarci; supponendo, ancora, che non si possa riposare sulla (propria)
lingua per rispondere alla domanda “chi sono?”, bisognerebbe comunque ammettere che ognuno di
noi parla. Bisognerebbe ammettere che c’è effettivamente una lingua per ciascuno: la lingua che
ognuno parla. E anche che, in realtà, di lingue ce n’è più d’una. Ogni evento singolare, ogni
percezione, ogni emozione, ogni sensazione, infatti, noi tentiamo di tradurle in una lingua che si
confaccia loro – cioè che renda giustizia a quello che rende la loro venuta un evento singolare. In
altri termini, ci è necessario, ogni volta, trovare nella lingua, con la lingua, una singolarità
linguistica – non per rendere giustizia alla nostra propria singolarità, ma per renderla (questo
giustizia) alla singolarità di ciò che viene, e che fa evento.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Ecco perché Derrida può scrivere, in maniera paradossale, che in questo nostro monolinguismo non
ci sono che «lingue di arrivo». Ecco perché vi è pluralità di arrivo. Se non ci fosse, se stabilissimo
in anticipo che non dovesse esserci, che sarebbe un’illusione pensare che dovrebbe essercene,
saremmo improvvisamente sull’orlo di quell’altra follia (quella dell’integrazione – la seconda
possibilità) che si evocava precedentemente: la follia della padronanza e del possesso sovrano di
una lingua di partenza.
Ma non appena si cominci ad ammettere o riconoscere che tutto questo non c’è, non resta
effettivamente altro che lingue di arrivo – ma di un arrivo che resta indefinito, che non arriva al suo
termine, come dice Derrida: «che non arriva mai ad arrivare». Perché? Probabilmente è questo li
punto più decisivo o più nodale, che ci ricorda che il termine, la fine, il completamento sono
impossibili. Se non fosse così, non ci sarebbe follia della lingua, ma solo programmi, che la lingua
rispetterebbe e che tornerebbero ogni volta allo stesso punto: la riduzione allo stesso. Invece, quello
che fa la follia della lingua è l’irriducibile trascendenza di ciò che le avviene [ce qui lui arrive], di
ciò che viene a lei – ossia di ciò che ci fa aprire la bocca. Ogni volta che parliamo (o che
scriviamo), facciamo prova di questa trascendenza; proviamo l’irriducibile alterità di ciò che viene.
E non c’è ipseità (non c’è rapporto con sé) al di fuori di questa prova. Non v’è ipseità che si
costituisca al di fuori del desiderio di rendere giustizia a questa alterità, che tuttavia, di fatto, non è
mai possibile raggiungere. Come se la costituzione interminabile dell’ipseità fosse sempre in
sospeso – sospesa al desiderio d’inventare una lingua, piegata alla promessa di una lingua a venire.
In questo modo, si impone a ognuno la necessità di inventare la propria singolarità nella lingua. Che
ne è allora della relazione con il diritto? Che ne è dell’“uomo di campagna”? Se il suo stazionare
dinanzi alla porta assomiglia a una forma di follia, di quale follia si tratta? Il racconto di Kafka,
l’abbiamo detto, combina due forme di inaccessibilità della legge: quella dell’uomo che sta dinanzi
alla sua porta e al quale il guardiano impedisce l’accesso, e quella del racconto stesso, anch’esso
impossibilitato a raggiungerla. Così il racconto è insieme possibile e impossibile, leggibile e
illeggibile, necessario e vietato, o piuttosto, come la maggior parte dei testi di Kafka, la sua
possibilità e la sua leggibilità non vanno da sé. Resistono come la legge resiste a colui che e
vorrebbe vederla e toccarla, entrare in essa, in modo diretto e immediato, senza deviazioni. Quello
che sa il guardiano, e che l’uomo di campagna ignora, è che non va mai così – per nessuno. E che la
legge, come ogni testo, chiede di essere decifrata da ciascuno, in modo assolutamente singolare.
Chiede, come ogni racconto, l’invenzione impossibile di una lingua che la decifra. Derrida lo
sottolinea con forza:
La lettura può in effetti rivelare che un testo è intoccabile, propriamente intangibile, poiché
leggibile, e nello stesso tempo illeggibile nella misura in cui la presenza in esso di un senso
percettibile, coglibile, resta tanto nascosto quanto la sua origine. L’illeggibilità allora non si oppone
più alla leggibilità. E forse l’uomo è l’uomo di campagna in quanto no sa leggere, o sapendo
leggere, ha ancora a che fare con l’illeggibilità in ciò stesso che sembra darsi da leggere. Vuole
vedere e toccare la legge, vuole avvicinarsi ad essa, “entrare” in essa perché non sa forse che la
legge non è da vedere o da toccare, ma da decifrare. È forse il primo segno della sua inaccessibilità
o del ritardo che essa impone all’uomo di campagna.[9]
È in questa sola invenzione – quella di una lingua che decifra – che lo iato tra la generalità della
legge e la singolarità del rapporto che ognuno intrattiene con essa torna a essere vivibile. Non sarà
colmato, tuttavia – ed è in questo che il racconto, comunque possibile e necessario, resta in fine
impossibile e impedito. Ma almeno ci si sarà promessi di rendere possibile l’impossibile, con la
certezza che ogni cammino in direzione opposta alle porte della legge conduce ancor più
sicuramente sull’orlo della rovina. Se torniamo ora alle tre forme di follia che Il monolinguismo
dell’altro ci ha permesso retrospettivamente di identificare, risulta che nessuna delle prime due è
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
assente dal racconto di Kafka. La prima, innanzitutto – la destrutturazione completa della
soggettività che conduce progressivamente al silenzio o precipita nell’afasia più brutale – descrive
in modo molto preciso ciò che accade all’uomo di campagna. Forse non abbiamo sufficientemente
sottolineato il rapporto di quest’ultimo con il linguaggio, che evolve nel corso degli anni passati alle
porte della legge. Prima, «stanca il guardiano con le sue richieste», poi «maledice il caso disgraziato
[…] ad alta voce». Poi «quando invecchia si limita a brontolare tra sé. Rimbambisce». Rimane
prostrato, silente. Solo un ultimo guizzo gli restituisce la parola per la domanda finale: «Tutti
tendono verso la legge, come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare?». Stremato,
annientato, l’uomo di campagna raggiunge la corte di tutti quelli che la legge, inaccessibile e
imperiosa, stronca dall’interno.
Tuttavia, anche la seconda forma di follia descritta da Derrida è altrettanto presente in Davanti alla
legge. Si traduce in sottomissione, rassegnazione, accettazione dei codici e delle regole,
incorporazione passiva delle stesse, che sono altrettante ragioni di voler entrare a ogni costo nella
legge, di fare tutt’uno, di fare uno con essa. Questa seconda follia concorda con quella di K ne Il
processo e quella dell’agrimensore ne Il castello; follie che colpirono molto i primi lettori di Kafka,
tanto che alcuni, come Günther Anders, arrivarono perfino a biasimarlo per questo. Questo tipo di
follia, in realtà, incombe su ogni venerazione, su ogni sacralizzazione della legge. Resta allora
questa «escrescenza della memoria» che, dice Derrida, porta molto vicini alle altre due forme di
follia, nella loro prossimità e nella loro minaccia, come testimoniano il destino di Hölderlin, quello
di Nietzsche o di Artaud: «verso dei tracciati – di scrittura, di lingua, di esperienza – che portano
l’anamnesi [cioè la ricerca dell’origine e specialmente dell’origine della legge] al di là della
semplice ricostruzione di un’eredità data, al di là di un passato disponibile, al di là di una
cartografia, al di là di un sapere insegnabile»[10].
Quest’escrescenza dipende da un’ingiunzione che si sarebbe già potuta leggere in filigrana
nell’ultima risposta del guardiano, se non fosse stato troppo tardi e se lui non avesse dovuto
chiudere la porta: «questo ingresso era destinato soltanto a te». In altri termini: «esigeva da parte tua
un deciframento, un’invenzione singolare, un tracciato di scrittura – un racconto, forse». Perché
questa ingiunzione è anche quella dello stesso racconto, come «racconto impossibile
dell’impossibile». Laddove l’uomo di campagna richiama un ingresso immediato nella legge, il
racconto, per le sue vie contorte, tenta invano de trovare un accesso, di fare l’impossibile – di
rendere possibile l’impossibile. Derrida lo ricorda:
In qualche modo, Vom dem Gesetz è il racconto di questa inaccessibilità, di questa inaccessibilità al
racconto, la storia di questa storia impossibile, la carta di questo percorso proibito: nessun itinerario,
nessun metodo, nessun cammino per accedere alla legge, in ciò che in essa avrebbe luogo, nel topos
del suo evento.[11]
Ma quali sono queste strade tentate dal racconto? Innanzitutto, bisogna ricordarlo, la scelta di
riderne. A torto si riterrebbero trascurabili, infatti, le risorse comiche del racconto di Kafa, e i suoi
tratti umoristici; che rappresentano senza dubbio uno dei tanti modi per con-vivere con il divieto
della legge. C’è, per prima cosa, la descrizione caricaturale del guardiano, che fa pensare ai ritratti
di Ivan il Terribile «avvolto nel cappotto di pelliccia, il suo lungo naso a punta, la lunga barba
tartara, nera e rada». C’è in seguito la richiesta rivolta alle pulci dall’uomo di campagna: «siccome
studiando per anni il guardiano conosce ormai anche le pulci del suo bavero di pelliccia, implora
anche queste di aiutarlo e di far cambiare opinione al guardiano». C’è infine, forse, il ribaltamento
della differenza di stazza tra i due alla fine del racconto. Ridere dell’inaccessibilità della legge
(ridere e far ridere di lei, raccontandola), in un racconto cui è impossibile mantenere la sua serietà
davanti questa stessa legge, per quanto sia essa sovrana, maestosa, imperiosa e misteriosa, significa
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
già sfuggire alle due forme di follia rilevate più sopra: la paralisi alienante e l’incorporazione cieca
(o il suo fantasma).
Ma, soprattutto, la via primaria – quella che forse l’opera di Kafka esemplifica nel suo insieme, i
racconti come i diari o la corrispondenza – è la scrittura, la scrittura come proroga. Probabilmente è
compito del guardiano imporre all’uomo di campagna la prova di un accesso indefinitamente
differito alla legge, ma prima di ogni altra cosa è il racconto che dà forma a questa inaccessibilità.
Come i racconti di Sherazade ne Le mille e una notte, non produce nient’altro che la messa in opera
(o la messa in lingua) della différance – come se fosse questa, in fondo, la ragione di ogni scrittura,
come se l’impossibile anamnesi dell’origine ci condannasse a differire indefinitamente l’incontro
con essa, nella (e attraverso) l’invenzione di una lingua e in (e attraverso) una ripresa di un racconto
che sono altrettante sospensioni del rapporto con la legge, o almeno di ogni supposta relazione
diretta, immediata, frontale con essa. Sì, potrebbe anche essere, in fin dei conti, che sia in questo
luogo improbabile, la letteratura, che si leghino, come crogiolo di ogni singolarità, la nostra
relazione con la legge e la nostra relazione con la lingua:
Il presente divieto della legge non è quindi un divieto, nel senso dell’obbligo imperativo, è una
différance. […] L’uomo dispone della libertà naturale o fisica di penetrare nei luoghi, se non nella
legge. Deve dunque vietarsi egli stesso di entrare e fa bene, fa bene a contrastarlo. Deve obbligarsi
egli stesso, deve darsi l’ordine non di obbedire alla legge, ma di non accedere alla legge che
insomma gli fa dire o lasciare sapere: Non venire a me, tri ordino di non venire ancora fino a me. È
là ed è in ciò che io sono la legge e che tu accederai alla mia richiesta. Senza accedere a me. Poiché
la legge è l’interdetto. […] Si può arrivare fino a lei per avere rapporto con lei secondo il rispetto,
bisogna non, non bisogna aver rapporto con lei, bisogna interrompere la relazione [come fa il
racconto]. Bisogna entrare in relazione solo con i suoi rappresentanti, i suoi esempi, i suoi custodi.
E sono tanto interruttori quanto messaggeri. Non bisogna sapere che essa è, ci che essa è, dove essa
è, dove e come essa si presenta, da dove essa viene e da dove essa parla.[12]
Quindi non è sorprendente che, in fine, Derrida attribuisca alla follia questa différance della legge –
il riso, la follia, ma forse anche un desiderio sovversivo. Perché, prima di tutto, quello che il
racconto contrappone alla lingua della legge è la singolarità del suo idioma, per come essa si
distribuisce tra tutti coloro che la intendono – è anche, con più precisione e senza giochi di parole,
la legge di questa singolarità. Qui, dice Derrida, sta la sovversione! La letteratura “impone” la sua
legge che, davanti alla legge (vor dem Gesetz), la mette fuori legge. Resiste alla resistenza della
legge in (e attraverso) l’invenzione ripetuta del suo idioma. Non c’è altra via. È questo che ignora
l’uomo di campagna, per cui la legge resta chiusa.
(traduzione di Riccardo Antoniucci)
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Politica e utopia: la 'Repubblica' di Platone nel XX secolo
di FRANCESCO FRONTEROTTA
La politica disegnata dalla Repubblica platonica è stata fortemente condannata nel Novecento, in
specie da Popper, a causa del suo “totalitarismo” e della sua distanza dai valori del liberalismo.
Un modo per “discolpare” il progetto politico platonico da queste accuse è stato quello di
rivendicare il suo carattere di “utopia”. Tuttavia, più che sulla “utopia” della Repubblica
bisognerebbe insistere sulla sua “normatività”.
La Repubblica di Platone non cessa di suscitare, fra i filosofi e i commentatori, un dibattito intenso
e controverso, tanto dal punto di vista del progetto etico e politico che disegna, quanto sul piano
delle implicazioni psicologiche, epistemologiche e ontologiche connesse alla definizione del sapere
dei filosofi che, secondo Platone, devono essere collocati alla guida di tale progetto. Non è questo,
naturalmente, il contesto opportuno per suggerire un’interpretazione d’insieme della Repubblica;
quanto mi propongo è, più modestamente, di segnalare alcune delle principali linee di discussione
emerse nel dibattito del XX secolo e limitatamente all’esame del progetto platonico della
καλλίπολις. Una difficoltà preliminare, che va in qualche modo immediatamente affrontata,
riguarda proprio l’oggetto del dialogo: se Diogene Laerzio non mostra dubbi nel catalogare la
Repubblica fra i dialoghi politici di Platone (III 50-51), è abbastanza facile constatare come l’opera
sia caratterizzata da un intreccio tematico che non si lascia sciogliere in una scansione disciplinare
ben determinata, se non al prezzo di schematizzazioni in parte forzate.
Il dialogo, infatti, si snoda come segue: mentre il libro I introduce il tema della giustizia, della sua
natura e della sua definizione, con un’andatura e uno stile che ricordano abbastanza esplicitamente
le indagine socratiche condotte nei cosiddetti “dialoghi giovanili”, con la consueta
contrapposizione, a tratti assai violenta, alle posizioni ascrivibili alla sofistica, a partire dal libro II,
il problema della giustizia viene esteso, per analogia, all’ambito della costituzione e della struttura
della città, forse meglio identificabile per il suo carattere concreto e storicamente determinato
(368b-369b), con il tentativo, condotto ancora nel libro III, di effettuare una ricognizione completa
della struttura socio-istituzionale della città, con l’individuazione delle classi che la compongono e
con la rigorosa ripartizione dei compiti e delle funzioni che a ciascun cittadino sono assegnati. Ma è
il libro IV che produce una svolta nell’analisi, perché, riproponendo l’analogia fra l’indagine sulla
giustizia a livello individuale e al livello della città, giunge a stabilire la sua definizione universale
come consistente nell’esercizio, per ogni individuo (e per ogni componente psico-fisica di ogni
individuo) o per ogni agente istituzionale (cittadino, classe sociale, città), della sua funzione
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
propria: la giustizia è, di conseguenza, τά έαυτου πράττϵιν (433a), in base al principio, che
rappresenta un filo conduttore narrativo e a un tempo un nucleo teorico situato, implicitamente ed
esplicitamente, al cuore della Repubblica, secondo cui l’esercizio, da parte di ogni elemento
particolare di un insieme, della propria funzione naturale compone, garantisce e preserva
l’equilibrio armonico dell’insieme, dunque, in tal senso, la sua τάξις, che coincide di fatto con la
“giustizia” della sua disposizione strutturale e funzionale. A partire dal libro V, la sfida rivolta a
Socrate dai suoi interlocutori consiste nel precisare le condizioni di possibilità di una simile
struttura istituzionale, di cui vengono fissate dapprima le “scandalose” tappe socio-politiche, con le
celebri “ondate” relative alla necessità della comunanza pianificata della proprietà, della produzione
dei beni e della procreazione, fino alla più ardua esigenza del governo dei filosofi. Particolarmente
quest’ultimo assunto richiede, dall’ultima parte del libro V e fino al VII, una rigorosa
giustificazione, che si articola attraverso un’assai complessa dimostrazione che sancisce la
differenza fra il sapere dei filosofi e le opinioni degli uomini comuni, premessa indispensabile per
spiegare e difendere il ruolo dominante dei filosofi nella città, e di seguito stabilisce l’opportuno
curriculum formativo dei futuri filosofi-governanti. Il libro VIII esamina poi, con il rigore
diagnostico di una vera e propria analisi sociologica della natura e delle degenerazioni del potere
politico nella dialettica del suo esercizio istituzionale e sociale, le diverse forme di governo
storicamente corrispondenti alle forme assunte come canoniche nel pensiero politico greco e, del
resto, di fatto coincidenti con i principali generi di regime concretamente prodottisi nel mondo
greco, cui segue, nel libro IX, una ripresa del tema originale della giustizia, al fine di dimostrare,
tornando nuovamente sul piano psicologico individuale, la superiorità e la felicità del giusto rispetto
all’ingiusto, in virtù del parallelismo stabilito, sul piano della forma di governo, con la relazione fra
il sistema istituzionale più giusto rispetto all’ingiusto. Il dialogo, che potrebbe a questo punto dirsi
compiuto, prosegue invece nel libro X, nel quale si torna, pur se con accenti diversi, sulla
giustificazione della superiorità del sapere dei filosofi, che va assunto come paradigma pedagogico
e gestionale della condotta individuale e collettiva, rispetto al sapere comune rappresentato dalle
forme abituali della cultura tradizionale, per esempio dell’arte imitativa e della poesia, epica o
tragica. Un lungo e complesso monologo mitologico, dedicato all’esposizione del destino
dell’anima individuale nel corso della sua vicenda immortale, conclude la Repubblica, trasponendo
di fatto l’affermazione della superiorità e della desiderabilità della giustizia rispetto all’ingiustizia,
dall’ambito psico-fisiologico e socio-politico all’ambito propriamente metafisico ed escatologico.
Di fronte a un’articolazione tematica così complessa, è inevitabile chiedersi dove si collochi
esattamente il nucleo propriamente “politico” del dialogo, a meno che, naturalmente, non lo si
voglia identificare nella messa in scena dei personaggi, con i loro diversi ruoli dialettici, o nella
continuità della sequenza argomentativa che essi costruiscono, ma si tratterebbe, a mio avviso, di
un’evidente diminutio. Del resto, come ha osservato Vegetti[1], è possibile individuare alcune linee
di riflessione abbastanza nette nella concezione platonica della politica: dalla definizione dello
statuto del governo della città, con la determinazione dei requisiti per accedervi, degli obiettivi da
raggiungere e degli strumenti di consenso per conservarlo, alla corrispondente struttura sociale,
economica e istituzionale della città, con l’esame dei rapporti di classe cui essa dà luogo e delle
diverse possibili situazioni concrete in cui la città storicamente si trova (in pace o in guerra,
stabilendo oppure no relazioni di scambio con altre città e così via). Il punto di partenza abituale per
questa indagine è rappresentato dalla constatazione che la città esistente è “malata” (VIII 544c) e
che occorre pertanto studiare le cause e il decorso di questa malattia per poterla curare e per poter
infine proporre un modello istituzionale immune da tali rischi; il sintomo principale della malattia
della città è il conflitto perdurante, non solo nell’Atene di Platone, fra le sue distinte componenti
sociali, la στάσις, che produce una sorta di guerra civile permanente, interna alle singole città
oppure fra le diverse città del mondo greco: in questo ambito, l’imputato principale è certamente il
regime democratico ateniese, che Platone considera come ineludibilmente esposto all’esito di una
degenerazione demagogica, coincidente con l’asservimento dei fini di governo alle spinte irrazionali
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
provenienti dalla massa e dunque in contraddizione radicale con il principio platonico del
perseguimento del bene, individuale e collettivo, sulla base del sapere[2]. Si è ricordato poco sopra,
nella forma sintetica e puramente riassuntiva del resoconto dell’argomento della Repubblica, quali
siano gli elementi principali della “cura” che Platone suggerisce per guarire la “malattia” della città:
si tratta di stabilire un’organica distribuzione di funzioni e compiti basata sulla natura e le
competenze di ogni individuo e di ogni gruppo sociale che componga un equilibrio efficiente e
armonico. La condizione di realizzabilità di questo sistema organico viene individuata da Platone
attraverso l’attribuzione del governo a un gruppo quantitativamente ristretto di “sapienti”, i filosofi,
che svolgono la propria funzione direttiva in virtù della facoltà e delle competenze razionali che
prevalgono in loro; a questo gruppo dirigente Platone associa un gruppo più numeroso, composto
dai “guerrieri”, che, rigorosamente subordinato al primo e in esecuzione delle direttive di quello,
opera le funzioni di controllo e di salvaguardia dell’ordine pubblico, come un apparato di sicurezza
che garantisce, in virtù del proprio carattere “aggressivo”, la conservazione dell’insieme; a un terzo
e ultimo gruppo sociale, il più numeroso, appartengono infine compiti produttivi e commerciali,
indispensabili al benessere della città e tuttavia necessariamente sottoposti al controllo e alla
disciplina imposta dei gruppi superiori, per evitare che l’elemento individualistico e potenzialmente
capace di sovvertire l’equilibrio dell’insieme, connesso alla produzione, all’accumulo e allo
scambio di ricchezze, possa incrinare la buona disposizione della città.
Da questa rigida scansione gerarchica derivano altrettante conseguenze, teoriche e pratiche, sul
piano dell’ingegneria politica e istituzionale. A garanzia dell’obiettivo generale perseguito
dall’azione dei governanti, e dell’applicazione esclusiva di un criterio razionale nell’esercizio di tale
azione, Platone prescrive la norma che estirpa ogni possibile fonte di interesse o inclinazione
individuale nella formazione e nella vita quotidiana dei membri di questo gruppo: la
collettivizzazione patrimoniale e affettiva e, subito oltre, la durissima selezione, genetica e
pedagogica, dei filosofi mirano precisamente a sancire le condizioni necessarie per l’accesso al
potere e per il suo esercizio. E, nonostante la complessa articolazione di questo percorso di analisi e
prescrizione politica, Platone avverte, e dunque fa emergere con acutezza, l’inevitabilità della
degenerazione di ogni forma istituzionale, che, per quanto vicina al modello descritto, si trova
esposta alla natura instabile delle vicende umane e della storia o, in altre parole, alla caratteristica
deficienza ontologica del mondo sensibile, irrimediabilmente vincolato al divenire in opposizione
all’eterna stabilità del modello ideale intellegibile.
Lo sfondo del dibattito novecentesco intorno all’etica e alla filosofia politica della Repubblica è
rappresentato certamente, e tuttora, dalle violente accuse che Karl Popper ha rivolto a Platone in
The Open Society and its Enemies (Popper 1944). Come è noto, secondo Popper, Platone avrebbe,
per un verso, preteso di identificare le “leggi della storia” e, con esse, di predeterminare lo
svolgimento e la realizzazione delle vicende umane e, particolarmente, della condizione dell’uomo
e della sua funzione in seno alla città e allo stato; per altro verso, e di conseguenza, avrebbe
costruito nella Repubblica uno schema socio-istituzionale fondato su una serie di principi a-priori
che sono finalizzati alla realizzazione della felicità collettiva, a scapito di ogni forma di
individualismo e di libertà o inclinazione individuale. Quella platonica si configurerebbe perciò
come un’“utopia totalitaria”, nella misura in cui il carattere utopico dipende appunto dal riferimento
a un set di principi eterni e immutabili “posti in cielo”, cui ispirarsi e da riprodurre nell’azione
politica e istituzionale, che sfocia a sua volta in una prospettiva totalitaria in quanto, per realizzare
questo progetto, occorre piegare qualunque tendenza soggettiva dei singoli cittadini alla superiore
esigenza di costituire una società perfetta, sacrificando intereressi e opzioni delle parti in nome della
suprema indicazione del benessere e dell’efficienza del tutto[3]. Ora, come è noto, l’accesa
requisitoria di Popper ha suscitato un’ampia serie di reazioni, per lo più dominate dall’intento, del
resto in gran parte esplicito, di difendere Platone dalle accuse rivoltegli, finendo spesso, tuttavia, per
optare piuttosto per uno sforzo implicito di difendere Platone da se stesso, senza invece operare
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
un’attenta disamina, storica e filosofica, dei presupposti esegetici della ricostruzione popperiana –
senza considerare, insomma, che l’estraneità di Platone alla tradizione etica e politica liberale o
democratica, denunciata da Popper, potrebbe evidenziare più che un limite o una colpa da ascrivere
allo stesso Platone, un presupposto interpretativo miope, che a sua volta non tiene conto dei diversi
momenti della storia del pensiero, quasi assumendo il liberalismo moderno come la dottrina
definitiva e definitivamente stabilita in base alla quale misurare, e giudicare, i pensatori del passato.
È chiaro come, adottando simili strategie difensive, ancora oggi ben presenti e documentabili negli
studi recenti, si corra il rischio di indebolire e depotenziare la riflessione politica di Platone,
neutralizzandola sotto ogni profilo, pur di evitare, di fronte alla constatazione innegabile che egli
non fu un liberale e un democratico, di farne un nemico della libertà e della democrazia, un
pensatore totalitario diretto precursore dei regimi dittatoriali del novecento[4].
Un’analoga strategia, almeno rispetto alla tesi secondo la quale non bisogna considerare come
autenticamente platoniche le affermazioni relative alla καλλίπολις e al progetto politico della
Repubblica, si ricollega ai nomi di due celebri filosofi del Novecento: Hans-Georg Gadamer e Leo
Strauss. Gadamer (cfr. specialmente Gadamer 1934 e 1983), come è noto, ha insistito sul carattere
esclusivamente utopico della costruzione politica di Platone: ponendosi fondamentalmente come un
socratico, più attento alle esigenze del metodo della ricerca della verità che non alla determinazione
di una prospettiva dogmatica, Platone avrebbe rappresentato nella Repubblica (ma ancora fino alle
Leggi) una città immaginaria, edificata come fantasiosa e piacevole evasione nella mente e non
certo nella concretezza della realtà e della storia, il cui scopo si riduce essenzialmente al gioco
puramente astratto del confronto intellettuale, così sistematicamente minimizzando i forti richiami
platonici alla realtà attuativa del suo progetto politico e naturalmente tutti i riferimenti storici e
biografici che testimoniano del suo specifico interesse e impegno negli eventi politici del suo
tempo. Appena più avvertita nell’esigenza di un esame più accorto e verosimile dello stile narrativo
di Platone si presenta la strategia esegetica straussiana, riconducibile, nelle sue linee generali, a
Strauss 1964 (pp. 50-138). La ragione per cui non si deve prendere alla lettera la riflessione politica
condotta nella Repubblica, secondo Strauss, non attiene ai tratti utopici del progetto che vi è
disegnato, ma alla caratteristica modalità della “dissimulazione” che Platone avrebbe messo in atto,
allo scopo di evitare il rischio di urtare la morale prevalente e la communis opinio dei suoi
contemporanei, di incorrere in contrasti o punizioni da parte dell’autorità. Non si tratta soltanto di
nascondere, tramite prudente reticenza, le proprie tesi autentiche, ma di proporre alternativamente,
dissimulandone i contenuti attraverso un complesso schema dialogico che ne cela ironicamente i
contenuti effettivi, un progetto ben preciso, i cui contorni risultano identificabili e accessibili ai
lettori che sappiano oltrepassare l’immediatezza letterale di quanto Platone scrive, per cogliere i
riferimenti esoterici che egli tratteggia attraverso gli articolati scambi dialogici fra i suoi personaggi.
Incontriamo qui il nucleo originario del cosiddetto “dialogical approach”, che prende le mosse dalla
constatazione banale che Platone non si esprime mai in prima persona nelle sue opere e che
pertanto, anche nell’ipotesi che egli si serva di alcuni dei suoi personaggi come propri portavoce,
resta l’asimmetria o la discrasia, più o meno profonde, fra autore e attore del dialogo, più ancora nel
caso di Socrate, protagonista indiscusso della maggior parte dei dialoghi, il cui ruolo di portavoce di
Platone deve comunque fare i conti con la ben nota attitudine all’ironia che tradizionalmente viene
associata al suo nome. Questo intreccio di portavoce e di interlocutori implica la stratificazione, nei
dialoghi, di punti di vista e di livelli di comunicazione distinti, ed è appunto dalla decifrazione di
questo meccanismo di stratificazione di personaggi e di piani di comunicazione che dipende la
possibilità di apprezzare l’autentico contenuto esoterico del pensiero platonico. Nel caso specifico
della Repubblica, essa andrebbe letta, secondo Strauss, in stretto rapporto con la commedia
aristofanea, ripercorrendo così con vivace ironia i tratti esclusivamente ironici, e perciò
dissimulatori, del progetto platonico. Il disegno fondamentalmente comunistico della Repubblica,
che recide ogni aspirazione e dimensione individuale, trascurerebbe volutamente, e perciò
ironicamente, gli impulsi riconducibili al corpo, alle differenze specifiche dei singoli cittadini e di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
genere fra i sessi, manifestando così il suo carattere assolutamente contro natura e perciò ideale, e in
tal senso utopico, e dunque di fatto consapevolmente impossibile rispetto alla sua realizzazione
concreta. Gli stessi filosofi che dovrebbero governarla appaiono estranei alla καλλίπολις, dalla
quale si ritirano volentieri, come mostra il libro VII, per accedere alla contemplazione delle idee.
Impossibile e perfino indesiderabile, la città ideale della Repubblica avrebbe allora solo il fine di
denunciare i limiti di ogni progettualità politica che, secondo la nota concezione straussiana, deve
astenersi dall’invadere gli spazi propri della filosofia e della teologia.
Non pochi interpreti recenti, specie in ambito anglo-americano, hanno approfondito, più o meno
criticamente, l’esegesi straussiana della Repubblica: chi riflettendo sulla relazione fra scrittura
ironica o “dissimulatoria” e carattere utopico del dialogo[5]; chi sottolineando soprattutto gli
elementi, già indicati da Strauss, dai quali si evincerebbe l’esigenza di una comprensione esoterica
del dialogo, mostrando come la repressione dell’eros, esplicitamente sancita dalla legislazione,
risulti incompatibile con la naturale condizione umana e, a un tempo, con l’investimento
psicologico necessario alla realizzazione del progetto politico[6]; chi, infine, valorizzando e
radicalizzando, nell’approccio straussiano, la conclusione relativa all’egemonia della filosofia (ma
non della teologia!) rispetto alla politica, sostenendo la superiorità di quella rispetto a questa come
oggetto privilegiato della riflessione condotta nella Repubblica, con un’analoga e parallela
valorizzazione, al livello dell’anima, della funzione razionale e conoscitiva rispetto alle altre e
rispetto anche all’equilibrio dell’insieme[7]. Una più matura e articolata presa di posizione è quella,
recente, di Rosen 2005, che, distaccandosi in parte dalla sua interpretazione precedente (difesa in
Rosen 1990), riconosce l’effettiva serietà teorica e progettuale della Repubblica, ma fissandone
alcuni limiti insuperabili: ogni forma di riflessione politica, che abbia come scopo il mutamento
sociale e l’instaurazione di un nuovo sistema, è esposta al rischio, o piuttosto alla necessità, della
degenerazione; la filosofia stessa, quando si assuma il compito dell’esercizio del potere e del
governo dello stato, non può che declinare verso la tirannide, quasi capovolgendo le proprie stesse
premesse teoriche e ideali[8].
Come si vede, al centro di questi complessi, e talora assai contorti, tentativi esegetici, si colloca, pur
se con diverse sfumature e da diversi punti di vista, la questione della cosiddetta “utopia” platonica,
come forma estrema di difesa, o via di fuga, dalle accuse popperiane di totalitarismo politico. Ma,
che si evochi un’utopia “fantastica” o un’utopia “dissimulatoria”, pare impossibile non tenere conto
dei numerosi richiami, contenuti nella Repubblica, all’essenziale problema della concreta
realizzabilità del modello che viene via via disegnato (cfr. per esempio 450d, 458a-b, 499c etc.),
anche se, appunto in virtù della differenza fra il modello ideale “nel cielo”, eterno e perfetto, e il
mondo sensibile del divenire e della storia, le condizioni di possibilità di tale realizzazione sono
ardue e di difficile attuazione (cfr. per esempio 499d, 502c, 504d etc.). Il tratto utopico del progetto
della Repubblica risiede allora nello iato che inevitabilmente sussiste fra la perfezione del modello,
che nulla, tuttavia, rende di per sé oggettivamente irrealizzabile, e le sue condizioni di possibilità,
che si scontrano invece con l’altrettanto inevitabile imperfezione della sua realizzazione. Ma questo
tratto utopico non dipende dal progetto platonico, la cui perfezione ideale costituisce anzi, per il suo
valore paradigmatico, il principale elemento di forza e di attrattività politica, bensì dalla dimensione
pratica e concreta nella quale occorre realizzarlo, secondo un gesto filosofico non dissimile da
quello che caratterizza il mito cosmologico del Timeo, in cui un divino demiurgo, la cui azione si
basa su una perfetta riproduzione degli altrettanto perfetti modelli ideali, produce il mondo sensibile
come “il migliore possibile” – “bello”, dunque, ma “meno bello” del suo modello ideale – e ciò in
ragione dei limiti e dell’imperfezione del materiale concreto di cui egli dispone per la sua opera
(cfr. Tim. 29e-30b). In questa misura, ed entro questi limiti, è certo possibile individuare una
tensione utopica nella riflessione politica di Platone, appunto quella tensione insopprimibile
determinata dalla distanza mai definitivamente colmabile fra il modello e la sua realizzazione
concreta, e a un tempo, per converso, dall’attrazione mai sopprimibile che quello esercita su questa,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
come molti hanno recentemente sottolineato[9]. Nello iato così determinato, fra il modello e la sua
realizzazione concreta, si apre lo spazio per l’elaborazione di una vera e propria teoria normativa,
con l’indicazione di una serie di requisiti necessari per la sua attuazione efficace, che, per quanto a
loro volta di difficile applicazione, appaiono nuovamente non impossibili, in linea teorica, rispetto
alla loro esecuzione: il governo dei filosofi, o la conversione dei governanti alla filosofia,
rappresenta da tale punto di vista la prescrizione fondamentale che, abbinata a un rigido controllo
sociale, può indirizzare la costituzione della “città in terra” a imitazione della “città in cielo”[10].
Si noterà come, a questo punto, il quadro esegetico intorno all’interpretazione “politica” della
Repubblica si collochi al di fuori della gabbia polemica costruita da Popper, ma accettata di fatto
anche dai suoi critici, che intendeva imbrigliare la riflessione politica di Platone all’interno del
confronto esclusivo con il pensiero liberale e democratico moderno e della sua contrapposizione,
tutta novecentesca, alle contemporanee dottrine totalitarie; gli sviluppi più recenti fin qui descritti
per sommi capi, con le relative acquisizioni esegetiche, ormai abbastanza diffuse, e a mio avviso
assai salde specie fra gli scholars continentali, ci restituiscono un Platone estraneo, perché non
assimilabile neanche in linea di principio, tanto al liberalismo quanto al totalitarismo, un Platone
attraverso il quale tornare a pensare ai termini generali della progettualità della politica, dei suoi
requisiti normativi, giuridici e istituzionali, e alle condizioni della sua azione concreta, nella società
e nella storia degli uomini.
Questo testo ha fatto da base all’intervento sullo stesso tema realizzato da Francesco Fronterotta
per l’Osservatorio filosofico
Riferimenti bibliografici
Bertelli, L. 2005. “Platone contro la democrazia (e l’oligarchia)”, in Vegetti 1998-2007, vol. VI
(2005), pp. 295-396.
Burnyeat, M. 1992. “Utopia and Fantasy. The Practicability of Plato’s Ideally Just City”, in J.
Hopkins and A. Savile, eds., Psychoanalysis, Mind and Art, Oxford: Oxford Univ. Press, pp. 17587.
Dawson, D. 1992. Cities of the Gods. Communist Utopia in Greek Thought, Oxford: Oxford Univ.
Press.
Ferrari, G.R.F. 2003. City and Soul in Plato’s Republic, Sankt Augustin: Academia Verlag.
Ferrari, G.R.F. 2007a. The Cambridge Companion to Plato’s Republic, ed. by G.R.F. Ferrari,
Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Ferrari, G.R.F. 2007b. “The three-part soul”, in Ferrari G.R.F. 2007a, pp. 165-201
Gadamer, H.-G. 1934. Plato und die Dichter, Frankfurt am Main: 000.
Gadamer, H.-G. 1983. “Platos Denken in Utopien. Ein Vortrag vor Philologen”, in H.-G. Gadamer,
Gesammelte Werke, Tübingen: Mohr, 1985 ff., vol. VII, pp. 270-89.
Laks, A. 2005. Médiation et coercition. Pour une lecture des Lois de Platon, Villeneuve-d’Ascq:
Presses Univ. du Septentrion.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Lisi, F.L. – Pradeau, J.-F. 2009. Le philosophe, le roi, le tyran. Études sur les figures royale et
tyrannique dans la pensée politique grecque et sa postérité, éd. par F.L. Lisi – J.-F. Pradeau, Sankt
Augustin: Academia Verlag.
Ludwig, P.W. 2002. Eros and Polis: Desire and Community in Greek Political Theory, Cambridge:
Cambridge Univ. Press.
Morrison, D.R. 2007. “The Utopian Character of Plato’s Ideal City”, in Ferrari G.R.F. 2007a, pp.
232-55.
Popper, K. 1944. The Open Society and its Enemies, vol. I: The Spell of Plato, London: Routledge
& Kegan Paul.
Pradeau, J.-F. 2005. Platon, les démocrates et la démocratie, Naples: Biblipolis.
Roochnik, D. 2003. Beautiful City. The Dialectical Character of Plato’s Republic, Ithaca: Cornell.
Univ. Press.
Rosen, S. 1990. Introduzione alla Repubblica di Platone, Napoli: Istituto Italiano per gli Studi
filosofici.
Rosen, S. 2005. Plato’s Republic. A Study, New-Haven/London: Yale Univ. Press.
Rowe, C. J. 1999. “Myth, History and Dialectic in Plato’s Republic and Timaeus-Critias”, in R.
Buxton, ed., From Myth to Reason?, Oxford: Oxford Univ. Press, pp. 263-78.
Schofield, M. 1999. Saving the City: Philosopher-Kings and other Classical Paradigms, London
and New York: Routledge.
Schofield, M. 2006. Plato: Political Philosophy, Oxford: Oxford Univ. Press.
Strauss, L. 1964. The City and the Man, Chicago: Univ. of Chicago Press.
Vegetti, M. 1998-2007. Platone, La Repubblica, traduzione e commento a cura di M. Vegetti, 7
voll., Napoli: Bibliopolis.
Vegetti, M. 2000a. “Beltista eiper dynata. Lo statuto dell’utopia nella Repubblica”, in Vegetti 19982007, vol. IV (2000), pp. 107-47.
Vegetti, M. 2000b, “Il regno filosofico”, in Vegetti 1998-2007, vol. IV (2000), pp. 335-64.
Vegetti, M. 2005. “Il tempo, la storia, l’utopia”, in Vegetti 1998-2007, vol. VI (2005), pp. 137-68.
Vegetti, M. 2009. «Un paradigma in cielo». Platone politico da Aristotele al Novecento, Roma:
Carocci.
Zuolo, F. 2009. Platone e l’efficacia. Realizzabilità della teoria normativa, Sankt Augustin:
Academia Verlag.
Note
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
[1] Vegetti 2009, pp. 19-24; cfr. inoltre Schofield 2006 e, più in generale in riferimento alla
riflessione politica classica, Schofield 1999.
[2] Particolare attenzione alle forme e ai contenuti della critica platonica alla democrazia greca da
parte di Bertelli 2005 e Pradeau 2005, pp. 85-101.
[3] Si vedano, per un’efficace sintesi delle accuse di Popper al progetto politico platonico, il
capitolo 5 di Schofield 2006 e Vegetti 2009, pp. 109-17.
[4] Faccio ancora riferimento, in quanto segue, alla felice sintesi proposta da Vegetti 2009, pp. 12242 e 145-67.
[5] Morrison 2007.
[6] Roochnik 2003, per esempio pp. 69-77; si veda inoltre, più in generale, Ludwig 2002.
[7] Ferrari G.R.F. 2003 e, con particolare riferimento all’esame delle funzioni dell’anima, Ferrari
G.R.F. 2007b.
[8] Rosen 2005, p. 229. Sul rapporto fra filosofia e politica, e particolarmente fra filosofo-re e
tiranno, in riferimento alla Repubblica e più in generale nel pensiero greco contemporaneo, si
vedano Vegetti 2000b e i saggi raccolti in Lisi-Pradeau 2009.
[9] Cfr. per esempio, con sfumature diverse, Burnyeat 1992, Schofield 2006, pp. 199 ff., Morrison
2007, p. 247, e soprattutto, in termini più realistici, Vegetti 2000a, Vegetti 2005, Vegetti 2009, pp.
161-67; per quanto riguarda gli sviluppi del disegno “utopico” nel posteriore pensiero politico di
Platone, nel Politico e nelle Leggi, cfr. Rowe 1999 e Laks 2005; infine, per la questione più
generale dell’utopia nel pensiero greco, cfr. Dawson 1992.
[10] Zuolo 2009.
Francesco Fronterotta è Professore associato di Storia della filosofia antica presso la “Sapienza”
– Università di Roma. Su Platone ha pubblicato, tra l’altro, Methexis. La teoria platonica delle
idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide, Scuola
Normale Superiore - Pubblicazioni della Classe di Lettere e Filosofia, Pisa, 2001.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
La (nuova) «grande trasformazione»: Badiou e il risveglio
della Storia
di PAOLO ERCOLANI
Con il 1989 il mondo occidentale e liberale ha subito una seconda grande trasformazione, dopo
quella degli anni fra le due guerre mondiali, che ne ha messo in discussione l’identità e le
prospettive. Secondo Alain Badiou si sono riaperte le porte per l’affermazione dell’Idea comunista.
La crisi del sistema capitalistico è oggettiva, con buona pace di chi aveva decretato la «fine della
storia», ma a leggere l’autore francese, più che di una «rinascita della Storia», sembra di trovarsi
di fronte all’ennesima, sterile utopia.
Il mondo contemporaneo è protagonista di rivolgimenti straordinari che ne stando mutando assetti e
configurazioni. Tanto che, ai più vari livelli, ci si può tranquillamente esprimere in termini di
«cambiamento epocale».
I giornalisti e poi gli storici, dovendo rispondere alla necessità di individuare delle date simboliche,
solitamente si rivolgono all’11 settembre del 2001 e ai terribili accadimenti di New York e
Washington.
Ma se non c’è dubbio sul valore tragicamente simbolico di questa data, ce ne sono molti, invece,
sulla sua capacità di spiegare cause ed origini della nuova e grande trasformazione in atto.
Coloro che vogliono comprendere servendosi della ragione storica, infatti, e non (solo) emozionarsi
ricorrendo a quello strumento senza tempo (e spesso privo di nessi causali che agevolino
l’intelligenza dei fatti) che è il sentimento del dramma immediato, devono piuttosto ricorrere a una
data anteriore a quella del 2001, che semmai è uno dei frutti avvelenati del 1989.
E’ con il 1989, insomma, con la fine del mondo diviso in blocchi e, soprattutto, con la caduta della
presenza fattiva dell’Idea comunista nei paesi del blocco sovietico (latente in quelli occidentali), che
abbiamo assistito all’inizio del passaggio epocale, della seconda grande trasformazione del XX
secolo dopo quella descritta da Karl Polanyi, che si riferiva agli anni fra le due guerre mondiali.
1 La prima grande trasformazione
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
La prima grande trasformazione del Novecento, era quella seguita alla pace dei cento anni (18141914), ossia a quel vero e proprio accordo internazionale che impedì l’esplodere di conflitti tra le
grandi potenze, fondato su un sostanziale «equilibrio di potere» (a spese dei paesi poveri e
colonizzati), sulla «base aurea internazionale» che simboleggiava un’organizzazione unica
dell’economia mondiale, nonché sul «mercato autoregolantesi», che produceva un benessere
economico senza precedenti. Il tutto, tenuto insieme dallo «stato liberale», vero e proprio collante di
un mondo occidentale costituito su queste basi (Polanyi 1974: 3).
La grande trasformazione, titolo dell’opera omonima di Polanyi, trovò la sua sostanza nel crollo
radicale di tutte queste caratteristiche che avevano permeato le nazioni liberali fino a quel momento,
trasformando il mondo occidentale prima attraverso la «soluzione fascista (secondo la controversa
tesi dell’autore), poi attraverso un rivolgimento più generale, che vide da una parte la Russia
approdare al «socialismo dittatoriale», dall’altra i campioni del liberalismo economico (Usa e Gran
Bretagna) costretti a ricorrere al New Deal e alle soluzioni keynesiane (stataliste) per riuscire a
sopravvivere alla terribile crisi economica del 1929.
Comun denominatore di tutti questi stravolgimenti, annotava Polanyi, era l’abbandono del dogma
liberale del laissez-faire (Polanyi 1974: 245, 250-2).
Il mondo occidentale uscito da questa imponente trasformazione aveva assunto dei connotati
straordinariamente nuovi, tanto che uno storico come Hobsbawm, nella sua fortunatissima sintesi
del «secolo breve», riferisce del «capitalismo post-bellico» come di un sistema partorito da «una
sorta di matrimonio fra il liberalismo economico e la democrazia sociale […] con aspetti non
secondari presi a prestito dalla politica economica dell’Urss, che per prima aveva praticato la
pianificazione economica» (Hobsbawm 1994: 212).
Tutto ciò malgrado la fervida opposizione da parte dei teologi del libero mercato (su tutti il von
Hayek di The Road to Serfdom, del 1944), i quali ritenevano che questa grande trasformazione
dell’economia (e in genere delle politiche e delle società) dell’Occidente avrebbe condotto
direttamente a una nuova servitù della gleba: «Essi – ricorda ancora Hobsbawm – si erano schierati
per l’intoccabile purezza del mercato anche durante la Grande Crisi. Continuarono poi a condannare
le politiche che fecero aurea l’Età dell’oro, quando il mondo divenne più ricco e il capitalismo
(insieme col liberalismo politico) rifiorirono grazie alla mescolanza di mercato e di stato
nell’economia. Ma fra gli anni ’40 e gli anni ’70 nessuno prestò orecchio a questi vecchi credenti»
(Hobsbawm 1994: 318-9).
2 La seconda grande trasformazione
L’occidente liberale, uscito dalla prima trasformazione del Novecento con le caratteristiche che
abbiamo sommariamente ricordato, è durato effettivamente fino agli anni Settanta, quando qualcosa
cominciò a incrinarsi, fino all’esplosione raffigurata simbolicamente dal crollo del Muro di Berlino
e, con esso, di un blocco ideologico e politico che aveva rappresentato, e difeso, a livello mondiale
le istanze comuniste.
Tutto ciò, sarebbe scorretto negarlo, in un contesto che vedeva comunque le potenze occidentali
continuare ad «esternalizzare» (nei confronti dei paesi più deboli, del Medioriente, dell’Africa,
dell’America latina) quelle forme di sfruttamento che si sono rivelate consustanziali al sistema
capitalistico nel corso della sua travagliata storia, e che hanno spinto l’Occidente a dipingersi ogni
volta come l’«araldo di una modernità trionfante», mosso dalla «vocazione a costituire il modello
della modernizzazione del mondo» (Bessis 2001: 56-7).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Né le cose sono cambiate ai nostri giorni, tanto da spingere un autorevole studioso a definire gli
stati occidentali come «cattivi samaritani», pronti cioè a proteggere anche militarmente le proprie
economie e i propri interessi salvo imporre ai paesi più deboli i dogmi del liberismo più rigido e
assurdo, fino a fare della competizione economica globale «un gioco di giocatori ineguali» (Chang
2008: 218-9).
Ma certamente l’esistenza del forte blocco comunista, e con esso di influenti partiti di ispirazione
marxista all’interno degli stati occidentali, aveva spinto gli stati liberali da una parte a mollare
(seppur limitatamente e con palesi contraddizioni) gli istinti colonizzatori nei confronti dell’esterno,
dall’altra a rafforzare al proprio interno quel matrimonio fra libero mercato e giustizia sociale
destinato a garantire crescita economica e benessere per più ampi strati della popolazione.
Questa è almeno la convinzione, nonché la premessa, contenuta nel libro di Alan Badiou Il
risveglio della storia. Filosofia delle nuove rivolte mondiali, uscito in Francia nel 2011 e tradotto
in Italia l’anno dopo per i tipi di Ponte alle Grazie.
Badiou che, certamente, non manifesta simpatia per la forma di «democrazia» elaborata dagli stati
occidentali, frutto dell’inconfessabile alleanza (con tanto di finta opposizione reciproca) fra il
capitalismo di mercato dei liberali e il capitalismo di stato dei traditori di Marx (che pure a lui
hanno continuato a richiamarsi per molto tempo).
In questo ricordando oltremodo le tesi dell’ultimo Debord, quando nei Commentari sulla società
dello spettacolo escogitava la formula dello «spettacolare integrato» per descrivere la forma di
dominio di un potere, quello del capitalismo di stato (così chiamato anche da Badiou), che si era
costruito sull’alleanza tra vecchi (e finti) oppositori, marxismo e liberalismo, su quel connubio
inossidabile fra stato e mercato in grado, come nessun potere prima, di esercitare un dominio
assoluto sulla totalità della dimensione umana (Debord 1988: § 4).
Ma a differenza di Debord, Badiou è convinto che oggigiorno ci troviamo di fronte a una possibilità
di riscatto radicale, resa possibile da quella seconda grande trasformazione del Novecento che si
connota per due aspetti fondanti: da una parte, a partire proprio dal 1989, stiamo assistendo alla
«reazione» del capitale contro le conquiste sociali faticosamente ottenute in decenni di lotte dai
movimenti comunisti e socialisti, fino ad arrivare al compromesso storico e sociale del welfare
state; dall’altra si assiste a un «risveglio della storia» (con buona pace di chi ne aveva proclamato la
fine, proprio nel 1989, come nel caso di Fukuyama) caratterizzato dall’esplodere di movimenti di
massa, più immediati e latenti in Occidente, più storici e quindi capaci di una rivoluzione fattiva in
Oriente (Primavera araba).
3 Il ritorno dei morti viventi
Risveglio della storia a cui mancherebbe, per completare il progetto rivoluzionario, l’incontro di
questi movimenti con l’Idea in grado di fornirli di senso, entusiasmo, unità e, quindi, di un progetto
unitario volto alla distruzione di quell’ordine capitalista oggi finalmente colpito da una crisi
strutturale e irrimediabile (le previsioni di Marx si sono avverate con un secolo e mezzo di distanza,
secondo la tesi di Badiou).
L’Idea di cui parla l’autore francese, ed è lui stesso a usare la maiuscola, è quella «comunista»,
finalmente rispettosa del disegno marxiano e non disposta a corrompersi e degradarsi come nel caso
della dittatura di stato sfociata in Urss e nella Cina maoista.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
L’armamentario a cui Badiou decide di ricorrere è quello classico, seppure rivisitato in chiave
moderna e alla luce delle sconfitte storiche: parliamo di «ritorno dei morti viventi» non in senso
spregiativo o dileggiante, quanto piuttosto nel senso tecnico di riportare alla luce, e al ruolo di
protagoniste, delle «entità» che troppo semplicisticamente si erano date per sconfitte e defunte,
quando invece si erano ritirate a uno stato di latenza (non privo di una qualche oggettiva capacità di
influenza).
Si parte dalla spinta anarchica (propria delle pulsioni messianiche del giovane Marx, da lui stesso
poi ampiamente corrette) per cui inserire lo stato fra i nemici da combattere e quindi superare (esso
è produttore di stragi, di divisioni umane, di finzioni inesistenti ma funzionali al potere, oltre ad
essere naturalmente il rappresentante legale degli interessi capitalistici).
Si condanna la democrazia occidentale (sì, anche quella rappresentativa) come una forma capziosa
di dominio su masse deleganti e, quindi, auto-relegantesi al ruolo di strumenti passivi della
macchina del potere.
Si biasima l’ingenuità, oltre che la disonestà intrinseca, di quel relativismo culturale per cui
abbiamo imparato a non riporre fiducia (meno ancora fede), in «verità assolute», portatrici di un
progetto totalizzante, e salvifico al tempo stesso, di riconfigurazione totale della società umana:
Badiou rivendica per l’Idea comunista il valore di Verità cui aderire con «entusiasmo» (da notare il
termine di marcata origine religiosa, visto che alla lettera vuol dire «avere dio dentro»).
L’autore francese si pone anche il problema del «soggetto rivoluzionario», in grado di dirigere il
processo di organizzazione delle masse rivoluzionarie (che abbisognano di «rettitudine e vera
fedeltà alla lotta»), che egli riconosce, alla luce delle esperienze storiche, non poter essere
rappresentato dalla forma-partito, ormai diventata obsoleta: «E’ il problema principale che ci è stato
lasciato in eredità dal comunismo di Stato del secolo passato» (p. 83).
Ma ecco che, dopo tanti decenni di sconfitte, «sta arrivando (tornando?) il nostro turno. E per noi il
problema centrale sarà quello di un’organizzazione politica in cui il “fuori tempo” sia anche il
“fuori-partito”, se è vero che l’epoca dei partiti, inaugurata dal club dei giacobini durante la
Rivoluzione francese, alla fine del XVIII secolo, scandita dai “comunisti” nel senso
dell’Internazionale fondata da Marx a metà del XIX secolo, istituzionalizzata dal partito
socialdemocratico tedesco negli anni intorno al 1880, rivoluzionata dal Lenin di Che fare? all’inizio
del XX secolo, si è chiusa negli anni Sessanta e Settanta, quando la Rivoluzione culturale cinese
non è riuscita a realizzare il desiderio di Mao e degli studenti e operai rivoluzionari di trasformare il
Partito della dittatura socialista in Partito del movimento comunista» (p. 84).
La differenza più forte rispetto al marxismo tradizionale (e ancor di più rispetto a Marx), è quella
per cui Badiou, diremmo paradossalmente, vede il terreno più fertile di realizzazione di questa
rivoluzione comunista ben «fuori dall’Occidente» del capitalismo avanzato (e in agonia), riponendo
una fiducia incredibilmente esagerata e persino ingenua nei movimenti della Primavera araba
(contemporanei al momento di composizione del libro).
4. Risveglio della Storia o ritorno dell’Utopia?
Ma è proprio a partire dalla questione del soggetto rivoluzionario, di cui lo stesso Badiou ammette
tanto la centralità quanto le difficoltà connesse, a portare alla luce un limite intrinseco al suo
progetto di risveglio della storia (e della rivoluzione comunista).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Certamente egli ha il pregio di chiamarsi fuori dalle fragili e curiose proposte (ad esser buoni) di
individuare un soggetto politico avanzate da alcuni dei più illustri autori di ispirazione marxista
della contemporaneità.
E’ sufficiente aprire alcuni di questi volumi per rendersi conto della fragilità teorica che lo ha
preceduto rispetto a tale questione: il Marco Revelli di Oltre il Novecento riteneva di individuare il
nuovo soggetto rivoluzionario nel «passaggio dall’estenuata figura del militante a quella, ancora
incerta e vacillante, del Volontario (scritto, anche qui, con la maiuscola); Hardt e Negri, nel loro
celebre Impero, dopo una raffinata e fascinosa analisi delle nuove contraddizioni insite nel
capitalismo globalizzato, riponevano le speranze di riscossa nientemeno che nel «militante
creativo», ispirato da un «progetto di amore» che deve trarre spunto dalla figura di S. Francesco.
Né le cose vanno meglio se ci rivolgiamo al testo, più recente, di Žižek, che individuando nelle
«baraccopoli» il fenomeno geopolitico quantitativamente più rilevante del capitalismo globale,
suggerisce che da questi abitanti, e dalle vittime dell’apartheid e del «terzo mondo» in genere
possano emergere i nuovi soggetti rivoluzionari: si tratta, per Žižek, nientemeno che di
«politicizzare, organizzare e disciplinare le “masse destrutturate” degli abitanti delle baraccopoli»
(Revelli 2001: 286; Hardt-Negri 2000: 381; Žižek 2008: 424-7; Ercolani 2011: 444-8).
Grande è la confusione sotto al cielo, e a questa confusione ci sembra fornire un apporto non
indifferente anche Badiou, soprattutto laddove decide di ritirare fuori (ed è l’ennesimo
ferrovecchio) la proposta della «dittatura», una «dittatura popolare» rappresentata da «un’autorità
che si legittima da sola proprio a partire dall’autolegittimazione della propria verità» (p. 62).
Al rifiuto della democrazia rappresentativa, insomma, Badiou fa seguire la proposta di una
«democrazia di massa» in grado di imporre la dittatura delle proprie decisioni, in virtù del fatto che
è costituzionalmente portatrice di una verità in grado di affermarsi come «volontà generale».
Il pensiero corre a Rousseau, certamente, ma occorre ricordare che persino il ginevrino giungeva ad
ammettere, alla fine dei conti, la necessità di una «figura mitica» come Mosé o Licurgo, insomma
un legislatore in grado di elaborare e codificare la volontà generale, che è sì sempre retta, ma non
sempre guidata da un giudizio illuminato, poiché «il popolo vuole sempre il bene, ma non sempre è
capace di vederlo» (Rousseau 1959-69, tomo III: pp. 380-2).
La storia non finisce, e quindi non si risveglia. Essa, piuttosto, segue un percorso che è bene
conoscere per trarne delle lezioni che possono tornare utili nel momento presente.
Il limite di fondo di Badiou, invece, consiste proprio in questa sua riproposizione, per quanto
aggiornata, di schemi che non tengono per nulla conto delle lezioni della storia.
Non sono le masse a poter guidare la storia, e qualunque dittatura popolare è sempre sfociata nel
potere dispotico di un grande Capo o, tutt’al più, di un’oligarchia privilegiata.
Non sorprende affatto che questa soluzione populistica provenga da un autore che ha trascurato,
nella sua analisi del mondo contemporaneo, due fenomeni invece centrali per evitare il pericolo di
nuove forme di anarchia e di teologia senza dio (apparentemente): la religione e la Rete (nuova
forma di religione panteistica).
Si tratta, in fondo, di un meccanismo ben compreso dal filosofo spagnolo Ortega Y Gasset, quello
per cui l’uomo si ammanta di «credenze» cui aderire totalmente, fino a sostituirle alla realtà, perché
a differenza delle «idee» esse non presentano aspetti problematici. Se è vero, insomma, che uno
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
storico che voglia comprendere un uomo o un’epoca deve prima investigare il «sistema di
credenze» (Ortega Y Gasset 1946-68, tomo IX: 500) che li caratterizza, l’errore principale di
Badiou risiede proprio nell’incapacità di innalzarsi su un piano scientifico e razionale, finendo per
rimanere lui per primo coinvolto da una nuova forma di teologia politica che egli chiama «risveglio
della storia», ma che in realtà somiglia assai di più a quel «sonno della ragione» generatore di
mostri che non vorremmo vedere più.
Riferimenti bibliografici
Bessis S. (2001): L’Occident et les autres. Histoire d’une suprématie, La Découverte, Paris
Chang H.J. (2008): Bad Samaritans. The Mith of Free Trade and the Secret History of Capitalism,
Bloomsbury Press, New York
Debord G. (1988): Commentaires sur la société du spectacle, Éditions Gérard Lebovici, Paris
Ercolani P. (2011): La storia infinita. Marx, il liberalismo e la maledizione di Nietzsche,
presentazione di Luciano Canfora, La Scuola di Pitagora, Napoli
Fukuyama F. (1989): The End of History?, in The National Interest, Summer
Gasset O.Y. (1946-1968): Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid
Hobsbawm E.J. (1994): The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991, Abacus,
London
Polanyi K. (1974): The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time
(1944), Beacon Press, Boston
Revelli M. (2001): Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Einaudi,
Torino
Rousseau J.J. (1959-69): Oeuvres Complètes, Gallimard, Paris
Hardt M. – Negri T. (2000): Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano
Žižek S. (2008): In Defense of Lost Causes, Verso, London – New York
Paolo Ercolani insegna storia della filosofia e teoria e tecnica dei nuovi media all’Università di
Urbino. Collabora all’inserto culturale del Corriere della sera («La Lettura»), è redattore della
rivista Critica liberale e membro dell’Osservatorio filosofico. Fra i suoi libri, che più volte
hanno suscitato un dibattito acceso sui media nazionali: Il Novecento negato. Hayek filosofo
politico (Perugia 2006), Tocqueville: un ateo liberale (Bari 2008), La storia infinita. Marx, il
liberalismo e la maledizione di Nietzsche, presentazione di Luciano Canfora (Napoli 2011) e
L’ultimo Dio. Internet, il mercato e la religione stanno costruendo una società post-umana,
prefazione di Umberto Galimberti (Bari 2012).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Tra estetica e politica. La funzione sociale della musica a
partire da John Cage
di GIACOMO FRONZI
Quello della funzione sociale (e quindi politica in senso ampio) delle arti è un tema controverso. Il
rapporto tra estetica e politica non può essere considerato né un rapporto di generazione reciproca
né di congiunzione teorico-concettuale. Pur tuttavia, è possibile individuare un terreno comune ai
due ambiti, all’interno del quale alcune esperienze artistiche hanno trovato fertile terreno
d’espressione. Tra queste, una delle più avvincenti, è senz’altro quella di John Cage (1912-1992),
poli-artista americano che ha lasciato un segno profondo nella storia, non solo musicale,
dell’Occidente contemporaneo.
Molte sfide lanciate alla riflessione filosofica in ambito estetico sono legate a due gruppi di
questioni. Uno è relativo all’evoluzione delle arti contemporanee, l’altro è invece legato allo
sviluppo dell’idea e della pratica della bellezza. Questi due ambiti di discussione rendono piuttosto
articolato e composito il discorso sull’esperienza estetica, nella diversità dei suoi caratteri, delle sue
funzioni e dei suoi esiti. All’interno di tale ambito discorsivo troviamo anche il tanto dibattuto tema
dell’intreccio tra estetica e politica.
Il rapporto tra estetica e politica non può essere considerato evidentemente né un rapporto di
generazione reciproca né di congiunzione teorico-concettuale. Se volessimo fare riferimento alle
analisi di Jacques Rancière, potremmo dire che estetica e politica condividono non i mezzi, bensì il
contesto, l’ambito, quello dell’aisthesis. All’interno di questo contesto, estetica e politica operano,
configurando e riconfigurando nuove «partizioni del sensibile»[1]. Se la politica si presenta come
qualcosa che, attraverso la partizione del sensibile, «definisce ciò che è comune in una comunità,
nell’introdurvi soggetti e oggetti nuovi, nel rendere visibile ciò che non lo era e nel far sentire come
parlanti coloro che non erano percepiti se non come animali rumorosi», allora essa esprime in tal
modo e così operando una certa «estetica». D’altra parte, l’estetica esprime una certa «politica»
mediante i propri modi di partire e riconfigurare il sensibile, «ritagliando spazi e tempi, soggetti e
oggetti, comune e singolare»[2].
L’oggetto e il luogo della politica, dunque, sono la configurazione del mondo sensibile comune,
pertanto politica ed estetica finiscono con il coabitare lo stesso spazio[3]: «il rapporto tra estetica e
politica è allora, più precisamente, il rapporto tra questa estetica della politica e la “politica
dell’estetica”, cioè la maniera in cui le pratiche e le forme di visibilità dell’arte intervengono esse
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
stesse nella partizione del sensibile e nella sua riconfigurazione, ritagliando spazi e tempi, soggetti e
oggetti, comune e singolare»[4].
Questo significa che, secondo Rancière, la politica ha una propria estetica, «che consiste nei modi
d’invenzione dissensuale di scene e personaggi, di manifestazioni ed enunciazioni», per quanto
questi si differenzino – talvolta opponendovisi – dalle invenzioni dell’arte. D’altra parte, l’estetica
ha la propria politica o, meglio, la propria tensione tra due politiche opposte: «tra la logica dell’arte
che diventa vita al prezzo di sopprimersi come arte, e la logica dell’arte che fa politica all’espressa
condizione di non farne affatto»[5].
In questo quadro, quella che Rancière chiama «arte critica» deve cercare di mediare tra la tendenza
ad avvicinare l’arte alla vita e quella a separare la sensorialità estetica dalle altre forme d’esperienza
sensibile. C’è però probabilmente una proposta estetica e poetica che sembra puntare proprio alla
ricomposizione di tale divaricazione, una proposta che alcuni hanno bollato come una forma di
clownerie, ma che altri hanno cercato di prendere sul serio. Si tratta dell’esperienza musicale e
artistica di John Cage (1912-1992), del quale, nel 2012, si sono celebrati i vent’anni dalla morte e i
cento dalla nascita[6].
La figura di Cage coinvolge analisi di vario tipo poiché essa si colloca trasversalmente in vari
campi: musica, arte figurativa, letteratura, danza, filosofia, buddhismo zen, micologia, cucina…
Questa particolarità, per un verso ha fatto di Cage un personaggio da prendere musicalmente poco
sul serio, data la sua a-tipica attività di compositore, per altro verso, però, ha contribuito a renderlo
una delle figure più affascinanti e rivoluzionarie della cultura occidentale novecentesca. Ma
soffermiamoci ora sul “pensiero sociale” di Cage o, meglio, sulla funzione sociale che l’arte e la
musica possono avere nel mondo contemporaneo, in un mondo, cioè, a chiara connotazione
anestetica.
La premessa cageana è che arte e musica vadano concepite non come azioni creative avulse dal
proprio contesto storico-culturale, ma come situazioni sociali che coinvolgono le persone e le loro
attività. Vi è quindi uno strettissimo nesso tra arte e mondo, tra arte e vita. A questo riguardo,
varrebbe la pena riprendere le parole, decisamente condivisibili, di Edoardo Sanguineti: «Quando
Cage insiste sopra il superamento di qualunque divorzio e distanza tra l’arte e la vita, non intende
per nulla militare in favore di un’estetizzazione dell’esistenza, come accadrà non poche volte presso
non pochi suoi ammiratori e seguaci, forse soprattutto sul terreno musicale, e forse soprattutto in
Europa. Al contrario, il problema è quello di riversare sopra il vissuto quotidiano, nell’azione
sociale di ognuno, quanto l’arte addita in forma simbolica ma reale, fornendo modelli
sperimentabili di nuove relazioni con gli uomini e con le cose»[7]. In Silenzio e poi in una
conversazione con Roger Reynolds, Cage spiega il rapporto arte-vita a partire dall’esagramma sulla
grazia dell’I Ching. Questo esagramma è generalmente considerato quello dell’Arte, la quale qui
appare sotto forma di luce che brilla sulla cima di una montagna, illuminando e penetrando, seppur
parzialmente, l’oscurità tutt’intorno. Il significato è chiaro: l’Arte penetra la vita, anche se
parzialmente. Ora, prosegue Cage, «se lei separa le due, diciamo se prende questa luce […] e la
chiama Arte… allora ha solo questa luce. Ma ciò che ci occorre è farci strada nel buio perché è lì
che sono le nostre vite […]: nell’oscurità, o, come dicevano i cristiani, “nella notte profonda
dell’anima”. È in queste situazioni che l’Arte deve agire e allora non sarà soltanto Arte ma sarà
anche utile alle nostre vite»[8].
Da queste parole emerge con chiarezza la complessità e la totalità entro la quale il compositore
americano colloca fenomeni e attività differenti, generalmente vissuti separatamente e che invece
vanno intesi come profondamente interconnessi, in quanto riconducibili all’universalità
dell’esperienza (sociale) umana. È peculiare, nel pensiero cageano, questa radicale e intima
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
comunicazione tra gli elementi, che lo porta ad aprirsi al suono del mondo, al di là delle rigide,
stereotipate, consolidate e accademiche barriere tra “suono”, “silenzio” e “rumore”, concedendo
diritto di cittadinanza, nella repubblica della musica, a tutto ciò che può risultare interessante
all’orecchio e alla mente del compositore (e dell’ascoltatore), rendendo così questa repubblica
molto più democratica. Anzi, anarchica.
Cage, perciò, oltre alla sua musica, alla sua inventiva debordante, alla sua ironia e alla sua
“leggerezza”, ci ha lasciato in eredità una scelta di campo, una prospettiva nuova, una missione,
quella di rimettere in questione le nozioni acustiche stabilizzate a poco a poco nel corso
dell’evoluzione musicale dell’Occidente. Nonostante non abbia avuto nessun allievo o “seguace”
diretto, l’influenza di Cage è stata sottile, a volte quasi «sottocutanea», spesso non riconosciuta[9].
Credo allora che il lascito maggiore di Cage sia legato ad un concetto-chiave, quello di libertà.
Libertà creativa, libertà di pensiero, libertà dai vincoli, a volte troppo stretti, non tanto della morale,
quanto del moralismo.
«Dov’è il “dovrei”, – scrive Cage – quando dicono che dovrei avere qualcosa da dire? Tre. In
pratica, quando mollate una cosa quella cosa è ancora con voi, no? Quattro. Dove la mollereste se
voleste sbarazzarvene del tutto? Cinque. Perché non fare come me, sbarazzandovi di ogni pensiero
come se fosse vacuo? Sei. Perché non fate come me, sbarazzandovi di ogni pensiero come se fosse
un legno marcio? Perché non fate come me, sbarazzandovi di ogni pensiero come se fosse un sasso?
Perché non fate come me, sbarazzandovi di ogni pensiero come se fosse le fredde ceneri di un fuoco
spento da tempo, o anche soltanto fornendo la minima reazione adatta all’occasione?»[10].
Questa dichiarazione conferma, ancora una volta, lo spirito antiaccademico e anarchico di Cage,
ispirato anche da Henry David Thoreau. Sulla sua scia, ma nella consapevolezza del definitivo
tramonto del pensiero anarchico americano ottocentesco, il compositore continuava ad immaginare
un mondo in cui l’individualismo (come anche l’individualismo al potere) potesse essere superato a
favore di una collettività armonica, aperta e solidale. Cage sembra volare molto alto e, per questo,
appare, da un lato, quasi come un incorreggibile sognatore, al limite della tenera ingenuità, ma,
dall’altro, come l’ultimo dei romantici, consapevole della propria “diversità” di vedute, ponendosi
perciò stesso come orizzonte regolativo. Da questo punto di vista, Cage rappresenta un musicistafilosofo che ha proposto una concezione del binomio arte-vita (ed in generale tra attività umane e
vita) chiaramente utopico, che si presenta come obiettivo lontano, lontanissimo, ma che può
rappresentare per l’uomo contemporaneo un laboratorio all’interno del quale svolgere prove
tecniche di salvezza.
È questo, in ultima istanza, la funzione della musica e del compositore. È quella di proporre modelli
alternativi, di muoversi in spazi nuovi che possano essere traslati e trasposti in altre attività umane.
Se la musica anticamente ha avuto lo scopo di calmare e tranquillizzare la mente, così da renderla
aperta alle influenze divine, la musica del presente, secondo Cage, deve essere pensata e realizzata
in relazione alla Mente, della quale facciamo tutti parte, grazie alla tecnologia (e questo è molto
“mcluhaniano”), una Mente che, però, è confusa, disturbata e divisa. La musica, in una prospettiva
che possiamo tranquillamente definire «relazionale»[11], deve continuare a muoversi nella
direzione dell’«interazione sociale», deve promuovere lo stare insieme della gente, «non per
politica»[12]. E difatti una delle eredità lasciate da Cage agli artisti del Novecento e del terzo
millennio è l’idea di progetto artistico elaborato in funzione di un generale interesse sociale,
lavorando, sperimentando e realizzando opere che possano avere una loro utilità «in quanto esempio
di una società. Con questo non intendo dire che pensi di aver risolto qualcosa dal punto di vista
sociale con la musica, ma che ho cercato di fornire degli esempi di miglioramento nella
società»[13].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
La posizione di Cage sembra in qualche modo assimilabile alla cosiddetta arte pubblica, vale a dire
a quelle forme di espressione artistica che prevedono l’elaborazione di “progetti”, ideati e realizzati
da artisti interessati ad inserirsi nel tessuto sociale, allo scopo di captare e decifrare le oscillazioni e
le degenerazioni tipiche del mondo contemporaneo, ma anche proponendo nuove forme sostenibili
di convivenza, cercando il più ampio coinvolgimento possibile di persone comuni.
Ciò, secondo Cage, è possibile attivando processi rivoluzionari positivi, e non negativi, costruttivi, e
non distruttivi, ma sempre in maniera «anti-istituzionale»[14]. La musica e le arti in generale
possono contribuire a raggiungere questi obiettivi, e lo possono fare sollecitando il potenziale
critico della società. L’arte ha la grande capacità di aprire gli occhi e le orecchie della gente. Cosa
potrebbe fare di meglio, si chiede Cage. Gli artisti devono sentire la responsabilità di volgere la
propria attenzione alla società, alle sue possibilità e ai suoi drammi[15].
Il pensiero e l’esperienza di Cage, allora, in una fase di profonda crisi culturale, morale ed
economica globale, possono essere presi come modello di «resistenza attiva non violenta», come
una sollecitazione a «praticare l’impossibile»[16]. Cage suggerisce di opporre alla politica e alle
logiche di potere una sorta di «socialità artistica», come l’ha definita Edoardo Sanguineti, intesa
come «pratica ideologica di consenso diffuso e profondo, e si vorrebbe dire molecolare, che
attraverso il messaggio effettuale delle opere musicali e pittoriche, letterarie e coreografiche, rende
egemone, per gradi, un’idea di comunità altra e migliore, liberata dai conflitti d’interesse e di
dominio, dalle opposizioni di classe»[17]. Non si tratta di un’illusione candidamente irenica,
conclude Sanguineti, ma di una convinzione.
Cage ci ha consegnato in eredità l’idea della possibilità di convertire l’egoismo in solidarietà, il
privato in comunitario, facendo leva sulla cultura, sul pensiero, sullo spirito, nella sicurezza che in
essi vi sia riposto un potenziale di libertà che va ben al di là di ogni costrizione e di ogni
subordinazione. Probabilmente, in un discorso di questo tipo, il nodo centrale del pensiero cageano
sta tutto qui: nella convinzione che il casuale possa contribuire a superare l’egoismo e l’egotismo
desiderante, favorendo «la sconfitta dell’io che opera per porre in atto soltanto le sue avide
intenzioni individuali, e che è vincolato al carcere della volontà chiusamente soggettiva, della
volontà di potenza»[18].
NOTE
[1] Cfr. J. Rancière, Le Partage du sensibile. Esthétique et politique, La Fabrique, Paris 2000.
[2] J. Rancière, Il disagio dell’estetica (2004), trad. it. di P. Godani, ets, Pisa 2009, p. 38.
[3] P. Godani, Prefazione a J. Rancière, Il disagio dell’estetica, cit., pp. 7-17: 9.
[4] J. Rancière, Il disagio dell’estetica, cit., p. 38.
[5] Ivi, p. 55.
[6] A questo proposito, mi sia consentito rinviare al volume da me curato John Cage. Una
rivoluzione lunga cent’anni, con un’intervista inedita, Mimesis, Milano 2012.
[7] E. Sanguineti, Praticare l’impossibile, in Lettera a uno sconosciuto, trad. it. di F. Masotti, a cura
di R. Kostelanetz, con un ricordo di M. Cunningham, prefaz. di E. Sanguineti, Edizioni Socrates,
Roma 1996, pp. 13-18: 13-4.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
[8] J. Cage, Conversazioni con Roger Reynolds, trad. it. di E. Grazioli, in G. Bonomo - G. Furghieri
(a cura di), John Cage, Marcos y Marcos, Milano 1998, pp. 146-7.
[9] D. Nicholls, John Cage, University of Illinois Press, Urbana 2007, p. 111.
[10] J. Cage, Comunicazione (1958), in Silenzio, trad. it. di G. Carlotti, ShaKe Edizioni, MilanoRimini 2010, pp. 54-70: 61 (i ed. Silenzio. Antologia da Silence a A Year from Monday, trad. it. di
R. Pedio, Feltrinelli, Milano 1971); ed. orig. Silence: Lectures and Writings, Wesleyan University
Press, Middletown, Conn. 1961.
[11] Su questo argomento cfr. N. Bourriaud, Estetica relazionale (1998), Postmedia, Milano 2010;
G. Fronzi, Etica ed estetica della relazione, Mimesis, Milano 2009.
[12] J. Cage, Il futuro della musica (1974), trad. it. di G. Iannaccio, in G. Bonomo - G. Furghieri (a
cura di), John Cage, cit., pp. 119-31: 123.
[13] J. Cage, Filosofia sociale, in Lettera a uno sconosciuto, cit., pp. 347-83: 351.
[14] Scrive Cage: «Lavoro meglio come individuo e non come una pecora nel gregge. Ho fatto una
quantità di dichiarazioni di natura sociale, tutte di carattere piuttosto anarchico. Recentemente mi è
stato chiesto di firmare una petizione contro l’energia atomica. Ma ho risposto dicendo che non
l’avrei firmata. Non ero interessato ad azioni critiche o negative. Non mi interessa contestare cose
sbagliate, mi interessa piuttosto fare qualcosa che sembri utile fare. Non penso che l’azione critica
sia sufficiente» (ivi, p. 373).
[15] Ivi, p. 364.
[16] J. Cage, La musica (dopo il 1970), in Lettera a uno sconosciuto, cit., pp. 131-56: 147.
[17] E. Sanguineti, Praticare l’impossibile, cit., p. 14.
[18] Ivi, p. 15.
Giacomo Fronzi (1981), laureato in Filosofia (Lecce) e in Musicologia (Venezia), dottore di
ricerca, diplomato in pianoforte, svolge attività di ricerca presso la cattedra di Estetica
dell’Università del Salento. Tra le sue ultime pubblicazioni: Theodor W. Adorno. Pensiero
critico e musica (Mimesis 2011), John Cage. Una rivoluzione lunga cent’anni (Mimesis 2012),
Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica (EDT 2013).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Quando comprendere è simulare
di CLAUDIO FASCHILLI
Recenti studi condotti da neuroscienziati, psicologi, linguisti e filosofi del linguaggio portano
sempre più a favorire l'ipotesi secondo la quale quando noi comprendiamo il significato di una
parola in realtà stiamo simulando inconsciamente l'esperienza di ciò che tale parola denota (un
oggetto, un'azione, un'emozione). Questo articolo illustra tale teoria, analizzandone le tesi dal
punto di vista neuroscientifico e cognitivo, e ponendola a confronto con le teorie semantiche più
tradizionali.
Il linguaggio umano è caratterizzato da un tale livello di complessità che chi ha cercato di studiarlo
nel corso dei secoli passati è stato costretto a focalizzarsi – e quindi a specializzarsi – su aspetti
sempre più particolari, al fine di portare la propria ricerca a un livello esplicativo adeguatamente
sviluppato. Per questa ragione, al giorno d’oggi vi sono almeno cinque ambiti di ricerca che si
occupano del linguaggio umano: la fonologia, la morfologia, la sintassi, la semantica e la
pragmatica.
Illustrando questi ambiti molto brevemente, diciamo che il primo si occupa dei suoni linguistici,
ovvero di come essi si possano e di come non si possano combinare tra loro in una data lingua; il
secondo analizza le regole che determinano la struttura interna, la formazione e la flessione delle
parole, facendo ricorso al concetto di “morfema” come unità minima portatrice di significato;
l’ambito della sintassi si occupa invece di come gli elementi linguistici possano combinarsi tra loro
in senso lineare e gerarchico; il quarto ambito – ossia la semantica – si occupa di come le
espressioni linguistiche siano in grado di veicolare contenuti dotati di significato; infine la
pragmatica si occupa di illustrare come il linguaggio sia messo in uso, ossia di come i parlanti
utilizzino certe espressioni all’interno di determinati contesti.
Ora, la filosofia del linguaggio contemporanea, sviluppatasi a partire dagli inizi del ’900, si è
soffermata prevalentemente su uno di questi ambiti di ricerca, quello della semantica, sollevando
questioni inerenti a come un’espressione linguistica (una parola, una frase) possa essere dotata di
significato; oppure domandando che cosa sia un significato; o, ancora, cercando di spiegare in che
modo noi esseri umani comprendiamo il significato di specifiche parole come ‘galoppare’, ‘sedia’,
‘cane’, ecc.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Poiché, tuttavia, il linguaggio umano è innegabilmente un prodotto della nostra mente – e in ultima
istanza del nostro cervello – negli ultimi decenni queste domande sono state riformulate spostando
l’attenzione sui meccanismi e sulle strutture mentali/cerebrali che rendono possibile la
comprensione delle espressioni linguistiche. Una delle domande di maggiore attualità è quindi la
seguente: che cosa avviene nel nostro cervello quando afferriamo il significato di una parola?
Per fornire una risposta adeguata a tali questioni dal punto di vista filosofico, ci si presentano due
alternative: la prima consiste nell’adottare una prospettiva puramente storica, mettendo in luce le
tappe fondamentali che sono state raggiunte nella riflessione sull’argomento; la seconda alternativa
invece è quella di considerare quale sia al giorno d’oggi la teoria più diffusa e più condivisa.
La mia intenzione, in questo articolo, è di fornire una risposta del secondo tipo, presentando perciò
la teoria che da circa due decenni sta riscuotendo sempre maggiori consensi non soltanto nel
panorama filosofico, ma anche in quello scientifico. Si tratta di quella che (in un modo non troppo
sintetico, ma di certo esplicativo) definirò tesi simulativista della comprensione linguistica.
La tesi simulativista si è diffusa a partire dalla fine degli anni ’90 del Ventesimo secolo grazie al
lavoro congiunto di linguisti, filosofi, neuroscienziati e psicologi. Tra questi, uno dei ricercatori più
conosciuti è Lawrence Barsalou, autore di un importante e noto articolo pubblicato nel 1999 dal
titolo Perceptual Symbol Systems[1].
La tesi simulativista fa a sua volta capo a una più ampia e complessa teoria conosciuta con il nome
di Embodied Cognition (in italiano “cognizione incarnata”), il cui punto di forza e novità sta
appunto nella caratterizzazione che essa dà del livello cognitivo e dei concetti, considerati i
depositari del significato delle parole. Secondo la Embodied Cognition, infatti, la cognizione
sarebbe “incarnata” nel senso che i processi cognitivi (come il giudicare, il pensare, il comprendere)
dipenderebbero in ultima istanza dal funzionamento del nostro corpo e dalla sua interazione con il
mondo esterno. Nello specifico, la teoria afferma che la cognizione si fonda sul nostro sistema
senso-motorio, ovvero su quella parte del cervello adibita al controllo della percezione e del
movimento.
La tesi simulativista può essere declinata su due piani esplicativi differenti, sebbene tra loro
complementari. Possiamo, infatti, formulare una spiegazione simulativista della comprensione del
linguaggio sia da un punto di vista neuroscientifico sia da uno cognitivo.
Per quanto riguarda l’ambito neuroscientifico, un consistente numero di esperimenti condotti da
psicologi, neuroscienziati e linguisti ha di recente fatto pensare che quando comprendiamo una
parola o una frase si attivano esattamente gli stessi sistemi neurali (per semplificare diciamo le
stesse aree del cervello) che si attivano quando percepiamo o agiamo (o riconosciamo azioni di altri
individui). La comprensione linguistica pare insomma richiedere l’attivazione del sistema sensomotorio.
Nello specifico, si è osservato che quando si comprende una parola, il nostro cervello attiva le stesse
aree cerebrali che sono attive quando si percepisce l’oggetto cui quella parola si riferisce. Ad
esempio, quando sentiamo pronunciare o leggiamo la parola ‘cane’ si attivano nel nostro cervello le
medesime aree che si attivano quanto percepiamo un cane. Quando poi sentiamo o leggiamo la
parola ‘galoppare’ si attivano le aree motorie del nostro cervello attive quando riconosciamo
l’azione del galoppare, ossia quando vediamo un cavallo che galoppa. Ancora, quando sentiamo o
leggiamo la parola ‘camminare’ si attivano le aree motorie che sono attive quando noi camminiamo
o quando vediamo altre persone che camminano.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Ciò è interessante perché fa pensare che la comprensione linguistica si fondi sulla ri-produzione di
esperienze percettive e motorie avute in passato e ciò avverrebbe grazie alle medesime strutture
cerebrali attive durante la percezione o (il riconoscimento de) l’azione.
Come ho già anticipato, questa spiegazione neuroscientifica ha un suo corrispettivo anche sul piano
cognitivo. Possiamo, infatti, dire che comprendere una parola o un’espressione linguistica in
generale consista nel simulare un’esperienza precedentemente fatta, oppure uno stato percettivo o
motorio.
Per fare un altro esempio, diciamo che quando comprendiamo la parola ‘gatto’ noi simuliamo (e si
badi che lo facciamo inconsciamente) la percezione di un gatto, i suoi movimenti tipici, le sue
fattezze, le sue caratteristiche, recuperandole dalla nostra memoria a lungo termine. Insomma,
quando il nostro cervello comprende una parola che denota un oggetto, si comporta come quando
percepisce quello stesso oggetto, tranne per il fatto che noi non abbiamo in quel momento la
consapevolezza di star percependo qualcosa.
Mi pare che sia chiaro allora perché si parli di “tesi simulativista della comprensione linguistica”:
perché la comprensione è spiegata in termini di simulazione della percezione di oggetti di cui
abbiamo fatto esperienza in passato – simulazione che avviene grazie alla riattivazione delle stesse
aree del cervello che si attiverebbero durante la percezione o il riconoscimento del movimento.
Questa teoria, che come ho già avuto modo di dire si è sviluppata solo negli ultimi due decenni, si
discosta nettamente dalle teorie più classiche della semantica novecentesca, le quali invece
affermavano che il livello cognitivo fosse distinto e separato dal livello percettivo-motorio. In
passato, infatti, han prevalso teorie che descrivevano i concetti come rappresentazioni simili a
simboli linguistici, scritti in un vero e proprio “linguaggio della mente”. La mente era concepita
dagli autori di tali teorie come un meccanismo in grado di manipolare e di combinare tra loro
simboli astratti e la comprensione linguistica si riduceva perciò a una mera rielaborazione di questi
simboli/concetti.
Secondo tali teorie, durante la percezione di un oggetto il nostro cervello codificherebbe le proprietà
dell’oggetto secondo le differenti modalità sensoriali e motoria: la forma e il colore sarebbero
codificati nella modalità visiva, il suono in quella sonora, l’odore in quella olfattiva, i movimenti (se
si tratta di un oggetto che si muove) in quella motoria, ecc. Per ottenere un concetto, tuttavia,
occorrerebbe un ulteriore passaggio: la rappresentazione senso-motoria dell’oggetto dovrebbe,
infatti, esser tradotta in una nuova rappresentazione concettuale, appartenente a un diverso livello
mentale e dipendente periciò da differenti aree del cervello.
Il concetto così ottenuto sarebbe quindi un simbolo astratto, codificato in quel “linguaggio della
mente” di cui si parlava prima e ben distinto dalle rappresentazioni del livello percettivo-motorio
che lo hanno generato. Sempre secondo tali teorie, la comprensione linguistica avverrebbe grazie
all’attivazione di queste rappresentazioni concettuali astratte e non avrebbe più nulla a che fare con
i sistemi percettivo e motorio. In altre parole, nella nostra mente dovrebbero essere individuabili un
sistema percettivo-motorio e un sistema cognitivo – e soltanto quest’ultimo permetterebbe la
comprensione linguistica attraverso l’elaborazione dei concetti.
Al contrario, come abbiamo visto, la teoria simulativista ha abbandonato questa distinzione
tradizionale e ha favorito invece una posizione che pone l’accento sulla radice percettiva dei
concetti. In questo senso si può allora dire che la conoscenza concettuale è incarnata: poiché i
concetti sono costituiti da rappresentazioni del livello senso-motorio. La comprensione linguistica
stessa risulta, infine, essere a sua volta incarnata, ovvero legata al modo in cui facciamo esperienza
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
del mondo attraverso il nostro corpo, in quanto comprendere un significato coincide con la
simulazione di un’esperienza percettiva o motoria.
NOTE
[1] Si possono vedere anche i seguenti articoli nel caso si volesse approfondire l’argomento:
- Bergen B. [2007], Experimental methods for simulation semantics, in M. Gonzalez-Marques, I.
Mittelberg, S. Coulson, M.J. Spivey (eds.), Methods in cognitive linguistics, John Benjamins,
Amsterdam, pp. 277-301.
- Faschilli C. [2012], La negazione e le teorie simulative della comprensione linguistica, in Rivista
Italiana di Filosofia del Linguaggio, 5, pp. 54-63.
- Paternoster A. [2010], Le teorie simulative della comprensione e l’idea di cognizione incarnata, in
Sistemi intelligenti, XXII, 1, pp. 129-159.
Claudio Faschilli è dottore di ricerca in Filosofia del linguaggio e della mente. Attualmente
insegna filosofia e storia presso il Liceo classico San Raffaele di Milano, dove ricopre anche il
ruolo di Vice Preside. Da due anni cura il blog linguaggionaturale.wordpress.com dedicato alla
filosofia del linguaggio.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
“La verità che si fa”, intervista a Vito Mancuso
di CARLO CROSATO
In questa intervista con Il “Rasoio di Occam” Vito Mancuso riepiloga i temi fondamentali della
sua teologia, dalla natura pratico-vitale e non teoretica della fede alla valorizzazione della
misericordia come superamento della giustizia retributiva e alla necessità di pensare una morale
non “autoritaria”.
Vorrei iniziare con una questione “teoretica”, in modo da accordarci su certi elementi che
possono poi tornare utili. La questione teoretica centrale è quella del rapporto tra
l’atteggiamento fideistico e la conoscenza epistemica. Tra la fede e il sapere filosofico,
potremmo dire.
Pongo questa prima questione perché è di capitale importanza: se anche il senso comune
accorda alla conoscenza fondata su evidenza la massima legittimità, nessuno può vivere
esclusivamente ordinando la propria condotta su una simile conoscenza. È infatti inevitabile
vivere fidandosi di qualcosa, fosse anche la sola certezza infondata e induttiva che domani
mattina il sole sorgerà.
La fede religiosa, però, si presenta in maniera ulteriormente problematica, cioè come dotata
di una stabilità che, però, proprio in quanto fede – quindi in quanto «argomento che rende
visibile l’invisibile»[1], come «sacrificium intellectus» diceva Tommaso –, non può vantare.
Lei, in un recente lavoro a quattro mani col direttore Flores D’Arcais, parla della fede come
di un «pensiero del cuore»[2].
Il dilemma che le pongo è: la fede, per presentarsi come atteggiamento legittimo e non cieco, è
costretta necessariamente a scegliere tra l’essere gnosi o l’essere un sentimento
contraddittorio[3]?
La fede ha a che fare con l’esperienza vitale: è qualche cosa che si spiega, più che teoreticamente,
praticamente. È gestione dell’energia vitale nella direzione della fiducia nei confronti della vita. Poi,
sulla base di questo, a mio avviso, si costruiscono dottrine, storie, miti, che le teologie formalizzano
e fanno diventare dogmi, articoli di fede, rivelazioni. Ma l’esperienza originaria alla quale occorre
tornare per comprendere davvero ciò che è in gioco nella vita di fede è, come dicevo prima, la
fiducia di fondo nei confronti di quelli che io chiamo i “sacri ideali dell’umanità”: il bene, la
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
giustizia, la possibilità della comunità e dell’armonia fra gli uomini – la dimensione comunitaria è
molto importante in tutte le tradizioni spirituali: la possibilità di una vera communio sanctorum, la
comunione dei “santi”, ovvero dei giusti.
Tutto questo non è evidente: tutto questo è ideale, e proprio per questo ogni giorno oggetto di
contestazione, di smentite. Per cui questo non può essere oggetto di una conoscenza epistemica
incontrovertibile. E tuttavia questo è esperienza, è ciò che i credenti sperimentano o sognano di
sperimentare. Ma è la base, l’humus primordiale da cui nasce il proprio rapporto con la vita.
Quindi: che cos’è la fede? Ultimamente è una modalità di interpretare l’esistenza, non qualcosa che
ha a che fare immediatamente con l’intelletto. Non è una dottrina, non è gnosi, non è un sapere.
Anzi, si dà fede esattamente perché non c’è sapere. Se si ha sapere, che tipo di fede si può avere? Si
ha solo un prendere atto, un conformarsi.
E, c’è da dire, la vita, nella sua globalità, è fatta in modo da non poter essere oggetto di un sapere
certo. Già solo a livello etico non c’è sapere certo.
Proprio su questo vorrei tornare a insistere. Nella storia del pensiero si sono alternate
“scommesse” e “dimostrazioni razionali”. Ha ancora un senso, oggi, una scommessa
pascaliana[4] (se ce l’aveva negli anni in cui Pascal la proponeva)? E reggono ancora i
tentativi dei filosofi del passato di dimostrare razionalmente l’esistenza di Dio (Cartesio,
Anselmo, Tommaso, …)?
Non ho mai sentito probanti e non mi hanno mai convinto né esistenzialmente né intellettualmente
gli argomenti sull’esistenza di Dio[5]. Né l’argomento ontologico, né l’argomento cosmologico.
Quelli sono argomenti che traggono il proprio senso se in primo luogo c’è questa dimensione di
esperienza vitale di cui parlavo. E allora sono argomenti, non prove, per dire la fondatezza di questa
esperienza.
Personalmente sono più sulla linea pascaliana e, se si vuole, kantiana di una ragione che cade in
contraddizione e in antinomia. Ci sono argomenti a favore della tesi e ci sono argomenti a favore
dell’antitesi: l’intelletto si chiude necessariamente nella contraddizione. Ed è per questo che ci sono
le filosofie, le religioni: perché non c’è la filosofia, sebbene per ciascun filosofo la propria sia la
Filosofia? Questo esattamente perché la ragione non riesce, di fronte al tutto dell’esperienza della
vita, a chiudere il cerchio: io credo che Pascal prima e Kant dopo – tra l’altro due pensatori di
estrema razionalità, che avevano nei confronti delle scienze esatte una grandissima disposizione –,
essendo andati fino in fondo nel voler sottoporre al tribunale della ragione le diverse affermazioni
della ragione stessa, si sono resi conto che la ragione, come tale, non è sufficiente, non “chiude” il
discorso, non ha l’ultima parola.
E quindi, certo, alla fine si tratta di una scommessa. Ciò che non apprezzo dell’argomento
pascaliano è il suo fondo di utilitarismo, per cui “conviene”. Questo fondo di utilitarismo lo ritengo
uno degli aspetti più deboli del pensiero di Pascal. In realtà, poi, non so nemmeno se convenga o
meno credere: ci sono giorni nei quali, personalmente, penso che possa convenire; ci sono giorni,
poi, in cui penso che non mi convenga. Ci sono momenti in cui la fede è consolazione; ci sono
momenti nei quali la fede è disperazione. Questo lo si trova nella stessa Bibbia.
Ci sono i Salmi, ci sono Giobbe, Geremia a testimoniare questo.
Appunto.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Dopo aver inquadrato la questione del rapporto tra fede e conoscenza epistemica, vorrei
portarla su un terreno morale, sfruttando, in prima battuta, il riferimento evangelico che le
Letture ci hanno proposto nella quarta domenica di Quaresima: la parabola del “Padre
misericordioso”[6].
È una parabola che lascia sgomenti tutti proprio a causa della sproporzione tra la giustizia
divina e la giustizia dell’uomo. La giustizia divina, lì, è per l’occhio umano assolutamente
ingiusta. Così come in altri casi, in cui Dio concede la grazia, facendo scelte totalmente altre
rispetto a quelle remunerative che l’uomo avrebbe compiuto.
E allora, come può una religione proporre una condotta di vita per gli uomini, se l’uomo si
sente così distante da una giustizia che non può comprendere? Cos’ha da dire, oggi, quella
parabola all’uomo della post-modernità? Come parlare, oggi, all’uomo della giustizia e della
misericordia divine? E la Chiesa, oggi, ne sta parlando in modo corretto o sostituendo
categorie umane, troppo umane al mistero del sacro?
Cominciando dal primo punto, riguardante la dimensione straordinariamente rivoluzionaria che il
Cristianesimo, i Vangeli soprattutto, contengono: il superamento della giustizia retributiva per
inaugurare il paradigma della misericordia. Quest’ultima, la misericordia, è pure giustizia: non è la
giustizia retributiva, ma non è qualcosa in meno. Il cardinal Martini, per ben due volte in
Conversazioni notturne a Gerusalemme[7], sostiene che l’attributo fondamentale di Dio è la
giustizia – e naturalmente non ci si riferisce alla giustizia umana. È un’altra dimensione: una
dimensione in cui tra giustizia e misericordia non c’è più antitesi. Probabilmente la vera giustizia è
giungere alla misericordia.
E la misericordia è quella comprensione che fa delle persone “ingiuste” le prime vittime: se noi
comprendessimo che la gran parte di coloro che noi chiamiamo “colpevoli” – e che lo sono sotto un
certo punto di vista, per i delitti e i crimini che compiono nei confronti della società – in realtà sono
i primi a essere stati, a loro volta, oggetto di violenza, di sfruttamento, di ingiustizia per le
condizioni nelle quali sono dovuti crescere a livello socio-economico, ma anche per le pressioni a
livello psicologico; se noi comprendessimo che alla base di molte dimensioni di ingiustizia ci sta,
non un peccato volontario di chi sceglie, ma anzitutto un’ingiustizia subita, allora capiremmo che
dire “giustizia” e dire “misericordia” può voler dire la stessa cosa.
In seconda battuta: la Chiesa è coerente con questo? Non lo è anzitutto a livello dottrinale. Fino a
quando si sosterrà la dannazione eterna, fino a quando si sosterrà che la dottrina dell’apocatastasi[8]
è eretica, insomma fino a quando si continuerà a sostenere una visione della pienezza del divino
come diviso in due: buoni da una parte e cattivi dall’altra, sopra i beati e sotto i dannati, saremo
sempre molto lontani da Luca 15 e dalla misericordia come superamento della giustizia retributiva;
perché anzi, una tale dicotomia funziona proprio sfruttando una giustizia retributiva.
La filosofia, dal secolo scorso, ha intensificato il dibattito interno, alla ricerca di un
fondamento “resistente” per parlare di morale. Si possono prendere come riferimento i
pensatori della “Scuola di Francoforte”, i quali partono proprio dal presupposto che il senso
della loro ricerca è da rintracciare nell’inaffidabilità per l’uomo d’oggi di (1) un metodo che
adotti una prospettiva divina, di (2) contenuti che ricorrano a un ordine creazionistico o
escatologico, e di (3) una teoretica che sfrutti un apparato categoriale metafisico[9]. In altre
parole, l’uomo d’oggi, perso ogni riferimento stabile, è alla ricerca di un qualche statuto
morale in grado di accogliere una pluralità di contenuti.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Come può la voce cattolica, portatrice di una verità assoluta e “dall’alto”, accompagnare
l’uomo e contribuire alla sua ricerca? Per stare nel contemporaneo, la Chiesa non può
presentarsi come un autoritarismo coercitivo: per evitare ciò, deve abbandonarsi all’odiato
relativismo, o c’è una via media?
Gli uomini, per quello che posso vedere io oggi e soprattutto qui in Occidente, non sono più disposti
ad accettare un’etica che cali le cose “dall’alto”, per riprendere la sua espressione. Ovvero, non
sono più disposti ad accettare una morale precettistica, dirigistica, verticistica: lo si vede in maniera
molto evidente per quanto concerne la morale sessuale. Basti pensare come la morale sessuale
proposta nella linea ecclesiastica tradizionale dell’Humanae Vitae[10] sia completamente disattesa
dalla gran parte del popolo cristiano: cito l’ultimo sondaggio che ricordo a memoria, risalente al
2000, che indicava come solo l’8% delle donne praticanti – non solo credenti – segua con il
coniuge, all’interno della propria vita matrimoniale, le indicazioni dell’enciclica di Paolo VI.
Ne viene che la morale, secondo me, oggi si deve sempre più determinare a livello formale. Per me
è l’unica vera strada; e anche in questo credo che la lezione kantiana debba essere ripresa, come la
formulazione laica di quanto tutte le grandi religioni insegnano, ovvero la “Regola d’Oro”, presente
nelle tradizioni religiose sia nella sua forma positiva – fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano
a te – sia nella sua forma negativa – non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. E
questa è l’indicazione squisitamente e supremamente formale, che Kant ci propone nel duplice
aspetto dell’imperativo categorico, quello della Zweckform[11] e quello della Gesetzform[12].
E questo ci attesta semplicemente la libertà del soggetto: il fatto che ognuno deve obbedire, ma
questa dimensione di obbedienza non si può imporre a livello contenutistico – salvo per alcuni
pochi precetti super-decisivi, che d’altra parte sono rintracciabili in tutte le culture e le tradizioni
religiose. Quindi una dimensione di obbedienza: l’etica si dà solo nella misura in cui si obbedisce a
un sentimento di rispetto, che è qualcosa di più grande dei propri meri interessi; e questa
obbedienza è rilevata dall’inevitabile presenza di un imperativo nel pensiero di Kant, che pure vuole
fondare un’etica dell’autonomia di contro a un’etica dell’eteronomia. Ma una dimensione di
obbedienza che si fa formale, se si escludono le eccezioni dei principi quale, per esempio, “non
uccidere” oppure “rispettare la dignità d’altri”.
Quindi, potremmo dire, salvo alcuni “grandi comandamenti”, i “piccoli comandamenti”, che poi
sono i “comandamenti di ogni giorno”, non possono che essere lasciati alla libera interpretazione
del soggetto. Ed è questo che la Chiesa deve fare: richiamare i grandi principi e sollecitare la
coscienza del singolo all’esercizio di questi grandi principi. L’azione etica, il momento etico si dà
esattamente come costruzione di un ponte tra una dimensione che possiamo chiamare universale e
la dimensione contingente e concreta: l’azione etica inizia proprio quando l’individuo deve costruire
un ponte tra quelli che abbiamo chiamato i “grandi comandamenti”, ovvero la dimensione
universale, e la sua situazione concreta. L’azione etica, allora, è la coniugazione nel concreto dei
grandi principi: non l’obbedienza supina ai precetti che avrebbero lo scopo di normare ogni tipo di
caso, catalogandolo – come avveniva nel ‘700 o nell’‘800 – in maniera rigida e secondo una
precettistica casualistica che produceva un’etica a mo’ di prontuario del giusto e dello sbagliato.
Una situazione di simile obbedienza, oltre a non essere possibile, non è degna dell’essere umano.
Stiamo quindi parlando dell’affermazione della libertà come autonomia: non come un fare ciò
che si vuole, ma come l’azione che obbedisce alla regola che ognuno si dà, tenendo presenti
quei principi universali.
Un’azione che ha come sfondo quei principi che sono di natura prevalentemente formale, così come
indicato dall’imperativo categorico o dalla analoga Regola d’Oro.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
L’etica, direi allora, è l’esercizio di una libertà che si fa obbediente: senza questa obbedienza non
c’è etica. Se la libertà non diventa obbediente, partendo da una situazione di indeterminazione quasi
caotica, non c’è nemmeno l’uomo; tanto meno un’etica degna di un uomo, che necessita di questo
movimento, di questo dinamismo: un caos che accetta di organizzarsi in una situazione concreta.
In relazione a questo, lei, il 4 marzo, scriveva su Repubblica[13] del rischio che un’autorità
diventi autoritarismo e che una tradizione diventi tradizionalismo. Il rischio è quello di una
presenza deduttiva, scriveva; ovvero, se interpreto bene, di una presenza fatta di principi
(quelli che nella scienza verrebbero chiamati “teoria” o “tesi”), da applicare indistintamente
sui diversi casi.
Spesso gli interventi della Chiesa vengono reputati essere troppo ingerenti. Altrettanto spesso,
invece, si critica la Chiesa di non dire abbastanza. Qual è il giusto grado di intervento della
Chiesa, se ce n’è uno?
Come si diceva prima, il rischio è quello di un’etica precettistica. Quando la Chiesa cattolica oggi
parla di “principi non negoziabili”, pone, a mio avviso, il soggetto cattolico in una condizione
tremendamente contraria all’esercizio responsabile dell’etica. Perché l’etica è conoscere quei
principi universali di cui si diceva prima, conoscere la situazione concreta e, in terza istanza,
negoziare. Con la libertà personale e con la libertà degli altri.
Tanto più se il discorso dall’etica passa al dominio giuridico-politico, dove la negoziazione è parte
costitutiva della questione: non si dà diritto e non si dà politica senza negoziazione. Se si può dire
che le etiche possono essere diverse nel mondo post-moderno, il diritto non può che essere unico in
una comunità civile. E come si può arrivare a scrivere un diritto unico partendo da etiche diverse?
Ovviamente negoziando.
La negoziazione è la ricerca di un punto d’incontro con chi non condivide la nostra stessa
prospettiva etica: sarebbe coercitivo e deresponsabilizzante il contrario, ovvero la situazione di una
precettistica rigida e indiscutibile.
Concentriamoci ora sulla più stretta attualità. Un’importante scossa al rapporto che rischiava
di diventare autoritario tra la Chiesa e il fedele è quella delle dimissioni di Papa Benedetto
XVI, con tutti i significati che osservatori e pensatori hanno individuato. Sempre nell’articolo
del 4 marzo, lei scrive che si passa dal “magistero” al “ministero”: se provocatoriamente le
dicessi che così facendo il Papa si riduce a essere una sorta di sindaco di una piccola cittadina,
senza più quell’aura di infallibilità che caratterizzava la sua figura, lei cosa mi
risponderebbe?
Non vedo perché. Cos’ha fatto Benedetto XVI? Ha fatto un semplice ragionamento, per cui,
riconoscendo di non avere la possibilità di esercitare il ministero petrino, ha deliberato di abdicare,
di “dimettersi” e smettere così di essere Papa. L’essere Papa è diverso e più importante dell’io,
dell’identità personale dell’individuo. C’è un ministero così importante da compiere, un ministero
che richiede capacità, energie, motivazioni, desiderio; c’è un ministero per esercitare il quale ha
confessato di non sentirsi più adatto: prendendo atto proprio dell’importanza del ministero petrino e
prendendo atto dell’impossibilità per lui di continuare in quell’impegno se non in maniera ondivaga
e poco efficiente, la deliberazione di fare un passo indietro è liberare la possibilità che qualcun altro
possa continuare con vigore nell’esercizio petrino.
Viene certamente meno quell’identificazione per cui “io uguale Papa”, nel senso che l’io del
singolo eletto è minore del ministero petrino. E così il ministero petrino continua a essere così
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
importante da presupporre un io sempre all’altezza di questo esercizio. Non solo queste dimissioni
non hanno inficiato il ministero petrino, ma, a mio avviso, l’hanno reso ancora più significativo,
rilevandone la maggiore importanza rispetto al singolo soggetto.
Prova ne sia ciò che sta avvenendo, da un mese a questa parte, nella Chiesa cattolica. Prova ne sia
ciò che ha significato il rinnovamento del ministero petrino a partire dall’elezione di Papa
Bergoglio: non mi sembra che il ministero petrino, dopo le dimissioni di Benedetto XVI, si sia
sgretolato. Anzi, ha trovato nuova linfa vitale, nuove energie, in maniera notevole in tutto il mondo.
Il passaggio dal magisterium al ministerium non è da intendersi come qualcosa che sminuisce il
ruolo del Pontefice. In quell’articolo a cui faceva riferimento, l’intento era quello di sottolineare il
passaggio da magis- a minus-; ma la logica evangelica è tale che quando si sceglie il “minus”, si
acquisisce potenza. Non la potenza del mondo, non la Wille zur Macht, ma l’unica vera potenza che
dovrebbe competere alla Chiesa, che è quella di chi parla alle anime le parole del Vangelo,
evocando energie positive, volontà di dedizione, e non sottomissione.
Questo lo sottolineo perché molte volte il magistero papale, così come si è configurato, era un
magis-, una potenza di sottomissione, che non può che produrre una fede coincidente con
l’obbedienza a tutti i dettati che vengono proposti, pena l’esclusione dalla comunione ecclesiale.
Porsi invece nell’insieme del ministerium, ovvero dello star sotto, del suscitare desiderio di
impegno e servizio, significa invece riconoscere il proprio ruolo di servizio, spogliato dalla potenza
di questo mondo, peculiare di ben altri ruoli mondani.
Affrontando il tema dell’infallibilità di Benedetto XVI non trasferibile sulla persona di Joseph
Ratzinger, lei propone di riprendere l’idea del teologo Hans Küng dell’indefettibilità del
“cuore”[14].
Il 22 febbraio, l’Unione dei Cristiani Cattolici Razionali[15] bolla questa sua proposta come
una debolezza di fede: a loro detta, non avendo più argomenti a sostegno del suo credo,
preferisce passare “dall’altra parte”, per salvare almeno le simpatie del mondo laico “ribelle”.
La sua proposta, allora, sarebbe la semplice eliminazione di ciò «che è difficile da capire» e da
spiegare. Lei dimenticherebbe che Gesù è venuto scegliendo «di essere ‘scandalo per il
mondo’ e ‘segno di contraddizione’»; e che Gesù ci ha ammoniti dal guardare con gioia ai
momenti in cui dicono bene di noi. Intende rispondere?
Non ho granché da dire: non ho mai interpretato la mia attività di pensatore e scrittore come
concessione facile ai tempi. Più di tutto vorrei dire, però, che la cosa che più mi interessa, a livello
esistenziale e personale, è servire la verità che si dice come bene, e non la verità che si dice come
dottrina. Lo specifico della concezione cristiana della verità è esattamente quella che emerge dai
Vangeli quando Gesù dice che chi fa la verità vede la Luce. Fa la verità: il verbo greco “poiein”
rimanda a uno statuto della verità diverso rispetto alla verità dottrinale. La dottrina non “si fa”: la
dottrina si accoglie e la si professa a livello intellettuale; e questa è una dimensione razionalistica di
verità, che però non ha a che fare con la dimensione ampia, biblica, di verità come azione tesa al
bene e alla fioritura della vita buona.
Siamo in primavera [l’intervista si è svolta ad Aprile, n. d. r.] e mi viene in mente una suggestione,
sulla cui correttezza filologica, però, non garantisco: l’assonanza tra “veritas” e “ver, veris”, cioè tra
“verità” e “primavera” che, nei termini latini, condividono la radice. Un’assonanza che ci indica ciò
che fa fiorire l’esistenza: così come in primavera scorre linfa nuova e vita nuova, l’élan vital di cui
ci scrive Bergson, allo stesso modo la verità evangelica deve entrare nel cuore e sciogliere il
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
ghiaccio della prospettiva retributiva, nei poteri di questo mondo, introducendo una logica diversa.
Questo è il “fare verità” a cui Gesù richiama.
Se questa è un’idea facile, sia. Ma ciò che bisogna fare è che nel profondo dell’animo umano si
avverta un nuovo slancio.
Gianfranco Brunelli, direttore della Rivista “Il Regno”, indica, fra le sfide che aspettano il
futuro Pontefice, la necessità di rivalorizzare «la libertà religiosa in rapporto con il primato
della coscienza»[16]. Quindi la libertà come condizione stessa della manifestazione della verità
cristiana. Concorda? E quali altre sfide toccherà affrontare al nuovo Papa?
A proposito del nuovo slancio di cui dicevamo prima: io sono entusiasta di come si sta muovendo
Papa Bergoglio. Quando, subito dopo le dimissioni di Benedetto XVI, ho avuto occasione di
confrontarmi con Lucio Caracciolo e Massimo Franco[17], mi è stato chiesto quale dovesse essere
la prima caratteristica del “nuovo” Papa: in quell’occasione non ho esitato a rispondere che era di
primaria importanza che questo “nuovo” Papa fosse un “uomo di Dio”. La prospettiva secondo cui i
miei interlocutori rispondevano era tesa – con un suo senso innegabile – a rilevare l’importanza
geopolitica della scelta che si sarebbe fatta. Secondo me, però, l’importanza geopolitica è seconda
rispetto alla vera e prima dimensione che deve competere a un uomo di fede: l’essere un “uomo di
Dio”, un uomo che sa scaldare il cuore parlando della verità evangelica non come dottrina da
professare, ma come disposizione dell’anima e di tutta la persona che si relaziona al mondo. Una
verità che è generosità analoga alla continua fecondazione del mondo da parte del Divino: questo è
il gesto eucaristico, che è lo stesso gesto creaturale, il continuo gesto che il credente deve sempre
riprendere.
Il Papa, con gesti semplici ma efficaci, dimostra esattamente qual è il senso del Cristianesimo.
Siccome siamo in un mondo nel quale esattamente questo è in pericolo – e non primariamente
l’infallibilità pontificia, i finanziamenti nelle scuole, le questioni bioetiche, l’etica sessuale, che pure
sono questioni che hanno un valore – l’azione del Papa mi pare stia dando significato al senso del
credere; senza grandi discorsi, ma con i gesti, che sono le vere encicliche dei nostri giorni.
Proprio il giorno dell’elezione papale discutendo l’evento con Massimo Cacciari[18], ho affermato
che il primo passo che il Papa avrebbe dovuto fare era relativo alla curia. Cacciari, in
quell’occasione, sosteneva invece che il primo punto dell’attività doveva inerire alla nuova
evangelizzazione. Ma è una distinzione che, a mio avviso, non regge: è chiaro che l’attività del Papa
deve concernere la nuova evangelizzazione, ma ovviamente da Papa. Tutti i cristiani sono chiamati
al lavoro della nuova evangelizzazione; ma il compito del Papa è il governo della Chiesa, con il
compito di orientare tutta la Chiesa a questa attività di annuncio e missione permanente. Per questo
il passaggio assoluto e decisivo è la ristrutturazione della curia, perché essa non sia impedimento
ma vera spinta evangelizzatrice: ciò che si sta effettivamente avviando con le otto personalità da cui
si è fatto affiancare, con l’intento di riprendere la Pastor Bonus[19]. Quindi c’è, sì, una missione di
testimonianza, ma, prima di tutto, un’azione di governo concreta: un testimone, ma testimone in
quanto Papa, in quanto “pietra angolare” su cui tutto si regge.
Lei indica il “peccato della Chiesa” nella sporcizia delle inimicizie fra i Principi della
Chiesa[20], che – aggiungerei io: in modo analogo a quanto succede nella politica – allontana
la gente. Se Gesù tornasse sulla Terra sotto mentite spoglie, troverebbe uno scenario simile a
quello della “leggenda del Grande Inquisitore” di Dostoevskij[21]? Troverebbe un Dio
esanime, un Dio morto[22] e ucciso da noi?
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
È difficile rispondere con proprietà a una simile questione. Io sono tentato di dire che probabilmente
non troverebbe niente di diverso da quanto trovò duemila anni fa e da quanto un secolo e mezzo fa
Dostoevskij dipinse nella sua leggenda del Grande Inquisitore. Troverebbe un Tempio sempre da
purificare, troverebbe una continua tensione, all’interno dell’istituzione Chiesa, tra coloro che
vogliono effettivamente servire a una missione spirituale e coloro che strumentalizzano la
dimensione spirituale per finalità politiche o, peggio, personali e carrieristiche.
Troverebbe i mercanti nel tempio, troverebbe i sommi sacerdoti così come duemila anni fa. I
sinedri, gli scribi e i farisei; ma anche discepoli: persone di buona volontà che, naturalmente con
tante imperfezioni, ma con generosità intendono seguire il suo messaggio. Troverebbe persone che
diranno «Signore da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna»[23].
Troverebbe persone che danno la vita per lui. Ci sono, oggi! Penso ai vescovi come Romero o
Câmara, penso ai preti anti-mafia come don Diana, don Puglisi. Io sono di origine siciliana, non
posso dimenticare, per esempio, i martiri della giustizia, i magistrati martiri: Falcone, Borsellino,
Livatino, Chinnici. Luther King, Gandhi, Rabin, Mandela. E tanti altri che per la verità o per la
causa evangelica hanno dato la vita fino anche a perderla, senza tirarsi indietro mai.
E troverebbe il mondo esattamente come l’ha trovato duemila anni fa: abitato da pecore senza
pastore. Sarebbe ancora preso da compassione guardando alle folle; guardando a noi come a pecore,
ma anche come a pecoroni, cioè come a persone che hanno perso il desiderio della libertà, che
finiscono per seguire ciecamente la corrente. E, in merito a ciò, si badi che proprio questo è quello
che diceva il Grande Inquisitore. La grande lezione di teologia politica che l’inquisitore
dostoevskijano fa a Cristo: “tu pensi che gli uomini volessero la libertà e sei venuto a portare la
libertà; ma sei un ingenuo – pare dire a Cristo – perché gli uomini non vogliono essere liberi”. E
non sbagliava poi di molto: anche oggi, allora, Gesù troverebbe le dinamiche della folla, che
applaude prima e crocifigge poi.
Al di là della questione storica e filologica degli eventi che narra, il Vangelo ha una dimensione di
verità perché è universale, cioè va a toccare degli aspetti che sempre e da sempre accompagnano il
cammino degli uomini. Per questo non credo che oggi – pur nell’incommensurabilità di certe realtà,
come quella tecnologica, quella scientifica, quella economica –, per quanto attiene alle dimensioni
cardine dell’esistenza – libertà, senso di giustizia, il dolore e il male, la morte e, in una parola: il
dramma del vivere –, siamo ancora tutti quanti fermi allo stesso punto. Ci sono questioni
dell’umano che sono così universali e insuperabili dall’uomo, che non possono essere risolti, che
non mutano: leggere Gilgamesh oggi, per fare un esempio, è decisamente più attuale che leggere un
settimanale patinato fresco di stampa!
L’uomo, ancora oggi, si chiede, in mille contraddizione, se abbia un senso essere qui, quale senso
abbia; l’uomo si chiede ancora da dove viene e che ne sarà di noi. Il noto detto che Jaspers cita
all’inizio de La fede filosofica di fronte alla rivelazione[24]: «Vengo, non so da dove. Sono. Non so
chi. Muoio, non so quando. Vado. Non so dove. Mi stupisco di essere lieto»; questo detto medievale
è la sigla di tutti gli uomini per quanto concerne le domande. Per quanto, invece, concerne il finale
dello stupore della letizia, molti risponderebbero, alla luce di questa ignoranza fondamentale: “non
mi stupisco per nulla di essere angosciato, triste o depresso”. E qui entrano diverse sensibilità,
esperienze; anche qui si tratta di un mistero di come, di fronte allo stesso statuto di indecifrabilità
della conoscenza rispetto alle questioni fondamentali, alcuni si riscoprano lieti, altri euforici, altri
angosciati, altri depressi.
Comunque, per concludere la risposta, sono convinto che Gesù si troverebbe ancora al cospetto del
grande problema del mestiere di vivere. E si troverebbe in una società che ancora crocifigge, o
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
comunque condanna i profeti; e perché questo accada immancabilmente non lo so. Ma ci sono
esempi nella letteratura sacra, come in quella filosofica, di questo: «il giusto – proprio per i suoi
atteggiamenti – verrà flagellato, torturato, gettato in ceppi, avrà bruciati gli occhi e infine, dopo
avere sofferto ogni sorta di mali, verrà affisso al palo»[25]. Qui leggiamo una profezia non tanto del
Cristo nel senso del Gesù storico, ma è una profezia di quello che io chiamo Cristo “cosmico”, cioè
una profezia del bene e della sorte del bene e della giustizia in questo mondo. Una sorte che è quella
di un bene affisso al palo, come è successo a Gesù.
E quando nel quarto Vangelo si parla dell’“ora che deve venire”, oppure, nel caso dei Vangeli
Sinottici, del cosiddetto “dei” (verbo greco impersonale: “è necessario”, “occorre”) per parlare della
necessità della morte di Cristo, si intende indicare proprio questa logica abissale della passione,
della croce che la giustizia e la verità devono subire in questo mondo. Ed è ancora questo che Gesù
troverebbe nel mondo anche oggi: se Dostoevskij alla fine ha “graziato” dal rogo Gesù, attraverso la
scena del bacio del Grande Inquisitore, se Gesù tornasse sarebbe ancora quello il rischio che
correrebbe, come ogni voce di verità.
NOTE
[1] San Paolo, Lettera agli Ebrei, 11, 1-2: «Prágmatōn élenchos ou blepoménōn».
[2] P. Flores D’Arcais, V. Mancuso, Il caso o la speranza? Un dibattito senza diplomazia, ed.
Garzanti, Milano 2013.
[3] Cfr. E. Severino, Pensieri sul Cristianesimo, ed. Rizzoli, Milano 19952, pp. 79 e ss.
[4] Cfr. B. Pascal, Pensieri, § 233.
[5] Cfr. V. Mancuso, Io e Dio, ed. Garzanti, Milano 2011.
[6] Vangelo di Luca, 15, 11-32.
[7] Cfr. C. M. Martini, G. Sporschill, Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della
fede, ed. Mondadori, Milano 2008.
[8] «Ritorno allo stato originario», «reintegrazione»: cfr. Atti degli apostoli, 3, 21.
[9] Cfr. J. Habermas, L’inclusione dell’altro, tit. orig. Die Einbeziehung des Anderen (1996), tr. it.
L. Ceppa, ed. Feltrinelli, Milano 2008, pp. 19-23.
[10] Paolo VI, Humanae Vitae, 25 luglio 1968.
[11] «Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre
anche come fine e mai semplicemente come mezzo». (I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten, BA 66-67).
[12] «Agisci secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi voler che divenga una legge
universale» (I. Kant, Kritik der Praktischen Vernunft, A 54).
[13] Vito Mancuso, Il mestiere di Pietro, in La Repubblica, 4 marzo 2013, p. 42.
[14] Vito Mancuso, L’infallibilità con la scadenza, in La Repubblica, 14 febbraio 2013, p. 45.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
[15] Cfr. www.uccronline.it : La confusione teologica di Vito Mancuso, 22 febbraio 2013.
[16] G. Brunelli, Le tre sfide per il nuovo Papa, in Famiglia Cristiana, 20 marzo 2013, p. 33.
[17] “Otto e Mezzo”, 11 febbraio 2013: http://www.youtube.com/watch?v=ttb6QQ06b...
[18] “Tg3”, 13 marzo 2013, speciale sul Conclave.
[19] Costituzione apostolica datata 28 giugno 1988, promulgata da papa Giovanni Paolo II.
[20] Vito Mancuso, Ma il peccato è nella Chiesa, in La Repubblica, 24 febbraio 2013, p. 31.
[21] Cfr. F. M. Dostoevskij, I Fratelli Karamazov, V, 5.
[22] Cfr. F. Nietzsche, La gaia scienza, tit. orig. Die fröhliche Wissenschaft (1882), tr. it. F. Masini,
ed. Adelphi, Milano 200817, § 125, pp 162 e ss.
[23] Vangelo di Giovanni, 6, 60-69.
[24] Cfr. K. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, tit. orig. Der philosophische
Glaube angesichts der Offenbarung (1962), tr. it. F. Costa, ed. Longanesi, Milano 1962.
[25] Platone, La Repubblica, II, 361e-362a. Riportiamo qui la traduzione a cura di F. Sartori, ed.
Laterza, Roma-Bari 20114.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Caro Eco, grazie a Nietzsche ho scoperto il principio della
modernità
di SOSSIO GIAMETTA
In una lettera aperta a Umberto Eco, Sossio Giametta spiega perché Nietzsche gli avrebbe
permesso di scoprire il senso del nostro accadere storico e perché occorre che se ne diventi
consapevoli.
Ill.mo e caro Eco,
ebbi il piacere di salutarla alla serata in onore di Raffaele La Capria. Lei mi disse di aver ricevuto il
mio libro, L’oro prezioso dell’essere, ma di non averlo letto. Tutto normale. Immagino le montagne
di libri che le arrivano. E poiché le arriveranno anche montagne di lettere, invoco il suo generoso
perdono per il mio farmi vivo pur sapendo tutte queste cose. Perché lo faccio? In generale perché
noi poveri autori non famosi non possiamo onestamente sperare che nel riconoscimento di coloro
che possono capirci, e perché in particolare io ho motivi personali per rivolgermi a Lei. Credo
infatti di aver fatto una scoperta che, se è fondata, non può non interessarla quale filosofo e
commentatore degli evi antico, medio e moderno. Questa presunta scoperta riguarda appunto l’evo
moderno, sul quale è uscito ultimamente un libro da Lei curato.
Approfondendo lo studio semisecolare di Nietzsche, sono arrivato a capire il suo genio profondo, da
tutti ancora ignorato e insospettato, e poiché esso è, secondo me, il punto d’approdo della
modernità, sono arrivato a capire anche il senso, tuttora ignorato e insospettato, della modernità.
Questo è un processo unitario, drammatico, angoscioso, che impone la reinterpretazione dei suoi
protagonisti in base alla posizione da ciascuno occupata in esso. Tutto ciò è contenuto nel capitolo
mediano del libro, intitolato Come fu che intuii quello che avevo capito. Ma per non obbligarla a
leggere il libro, lo ripeto qui in altra forma.
Tutto comincia con la decadenza del cristianesimo e con l’incapacità dei popoli di vivere senza un
tetto, una copertura religiosa, come la storia dimostra. Con i rivolgimenti causati dal risveglio dei
valori antichi e dalla nuova scienza nell’umanesimo e nel Rinascimento, il cristianesimo, che giunto
alla sua massima realizzazione era ormai incamminato sulla strada della corruzione, come è di tutti
gli organismi invecchiati, si ritirò sempre più dalle coscienze europee. Subì il duro colpo della
Riforma di Lutero e il suo posto fu preso sempre più, nei secoli che seguirono, dalle tendenze
secolarizzanti. Nel suo rapporto con la laicità si creò quello che Spinoza dice che avviene con la
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
teologia e la filosofia: quanto più si alza il piatto della bilancia della filosofia, tanto più si abbassa
quello della teologia, e viceversa.
Dette tendenze laicizzanti, però, senza l’ausilio della fede e del Dio padre, del Dio provvidente,
avevano grande difficoltà a sostituire la religione, della quale l’uomo ha evidentemente un naturale
bisogno: perché facevano appello all’intelletto e non all’anima. Questo processo laicizzante,
consistente nel sostituire Dio con la natura, si sviluppò dunque da allora oscillando in due direzioni
parallele: una negativa, scettica, pessimistica, e una positiva, affermatrice, ottimistica, non senza
ripetuti tentativi da parte dell’una di incorporare l’altra.
I protagonisti di questi due rami della laicizzazione dell’Europa sono i protagonisti della cultura
(Kultur) europea. Solo alcuni nomi: Nicola Cusano, Erasmo da Rotterdam, Lutero, Giordano Bruno,
Giulio Cesare Vanini, Montaigne, Descartes, Pascal, Hume, Kant, Hegel, Stirner eccetera eccetera,
fino al picco della tendenza negativa con Schopenhauer e la sua scuola, Philipp Mainländer, Julius
Bahnsen e Eduard von Hartmann. Questi ultimi furono l’ultima grande provocazione in senso
negativo ed è a essa, a Schopenhauer in particolare, suo “perfetto antipode”, che Nietzsche più
immediatamente risponde con la sua tendenza affermatrice, rappresentata soprattutto da Così parlò
Zarathustra.
Schopenhauer e i suoi discepoli si erano essi stessi opposti a quella che era stata l’ultima grande
provocazione in senso contrario. Dopo il tentativo di Cartesio di “portare il cristianesimo a
compiuta efficacia innalzando la ‘coscienza scientifica’ alla sola coscienza vera e valida”,[1] dopo il
tentativo di Pascal di ri-saltare con una “scommessa” dal campo laico a quello cristiano, dopo
quello di Leibniz di fare ingoiare all’uomo il male del mondo come una purga sgradevole ma
benefica, e quello di Hamann di rovesciare l’illuminismo col ricorso al cristianesimo profondo,
c’era stato il grandioso tentativo di Hegel di divinizzare il mondo portando la filosofia al
cristianesimo, invece che il cristianesimo alla filosofia come credeva.[2]
Con lo Zarathustra, in cui si esprime con la massima forza la tendenza affermatrice che è la
caratteristica principale del suo genio, Nietzsche fonda la religione laica. Questa passa attraverso la
radicalizzazione del pessimismo schopenhaueriano, fondato sull’ineluttabile dipendenza dell’uomo
dalle sue condizioni di esistenza, come parte infinitesimale di un immenso organismo, l’universo,
alle cui leggi è sottoposto (religione dunque dell’umiltà e non della superbia, come ha sostenuto
Benedetto XVI), e l’affermazione dell’essenza divina della vita, di cui tutti gli esseri sono partecipi.
L’essenza sublime e beatificante della vita non può essere negata, ma solo oscurata o impedita dalle
circostanze o condizioni di esistenza. Dunque slancio, passione, entusiasmo, amore della vita sono
giustificati nonostante tutti i possibili orrori e tragedie dell’esistenza. Questa è la grande novità
predicata da Nietzsche.
Quando, composto il primo Zarathustra, egli non sapeva quale valore e senso esso potesse avere, e
lo domandava agli amici oltre che a se stesso, Peter Gast sentenziò: “È una sacra scrittura”. Ciò lo
illuminò, lo aiutò a capire se stesso, finché non ebbe più dubbi. Parlò allora dello Zarathustra come
“la Bibbia del futuro, la massima esplosione del genio umano, in cui è racchiuso il destino
dell’umanità”.[3]
Ciò nonostante, in seguito si fece riassorbire dallo Zeitgeist e dai dibattiti dell’epoca, agitata dai
venti selvaggi della reazione alla decadenza e impegnata soprattutto nello scalzare gli ostacolanti
valori cristiani. Come suprema antenna e strumento dell’epoca, Nietzsche si distaccò pian piano
dalla sua più grande e gloriosa conquista per tornare a combattere il cristianesimo non più con
l’eccellenza, con la divinità della vita concepita laicamente, ma con la lotta corpo a corpo, con lo
scontro aperto. Ciò vuol dire che il suo genio si era oscurato. Da Al di là del bene e del male in poi,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
attraverso la Genealogia della morale, il Crepuscolo degli idoli, L’Anticristo e Ecce homo, egli
precipitò in una specie di monomania, si dedicò a uno scontro personalissimo col cristianesimo dai
toni stridenti, esagerati e in definitiva grotteschi.
Nietzsche era stato sempre agitato dal genio religioso. Questo cercò di venire in luce in tutti i modi,
anche per vie traverse: nell’adolescenza come adesione appassionata al cristianesimo, che però, per
la sua stessa radicalità, sfociò nella negazione; poi con la teoria dell’Eterno Ritorno, che egli
concepì appunto come religione e di cui si pensava, sia pure con raccapriccio, destinato ad essere il
maestro.
Ma l’Eterno Ritorno era contraddittorio. Pensato come stimolo a una vita degna, di cui ci si potesse
compiacere per l’eternità, dunque come incitamento morale, guardava al futuro ma saltava il
passato. Infatti, se l’Eterno Ritorno è veramente eterno, la nostra vita attuale non è che la
pedissequa ripetizione di quella che è dall’eternità e tale sarà per l’eternità, immutabilmente.
Dunque nessuno sforzo per il suo miglioramento è possibile e ha senso. In tal modo il progettato
incitamento morale si capovolge in deprimente fatalismo. Pertanto l’Eterno Ritorno, come religione,
non funzionava.
Funzionava invece quello che egli, in opposizione a Schopenhauer, chiamava il “pessimismo
dionisiaco” o pessimismo della forza. A patto però di distinguere i due elementi che erano in esso
intrecciati. Il dualismo in filosofia è di solito un problema. Ma qui esso è la soluzione. Il dualismo
ha in effetti due corni: l’essenza divina e beatificante della vita e le condizioni di esistenza, che
possono essere ostacolanti e impedienti fino all’orrore. Nella vita, negli esseri, le due cose si
fondono e confondono, ma sono diverse e vanno distinte. L’una non tocca l’altra.
A questa scoperta, illustrissimo e caro Eco, se ne aggiungono nel libro altre, fatte continuando il
lavoro dei “miei” autori. Se Lei, magari spinto dalla bella recensione del sedicente incompetente La
Capria, dovesse, potesse e volesse, con opera di santità, leggere almeno in parte il libro, cioè
accettare questa seconda sfida, dopo quella delle Eterodossie crociane, allora due sono i casi: se Lei
trova che il libro non è che uno dei tanti magari buoni che girano attualmente in Europa, bene, la
finisca lì; se invece trova che in Europa non gira un libro con un simile carico di intuizioni e
scoperte, che sia altrettanto vasto e profondo, chiaro semplice e solido, allora, per piacere, ne scriva
qualcosa, perché solo a Lei e a Repubblica e a L’espresso i giovani credono, non al Corriere: i
giovani che sono i soli veramente aperti alla filosofia.
Voglia, ripeto, perdonarmi per tutte queste vanterie e pretese, ispirate certo anche dal bisogno
dell’artigiano di veder riconosciuto il suo lavoro, dunque dalla vanità, ma soprattutto dal bisogno di
vedere che i risultati del lavoro di chiarificazione fatto in tutta una vita di studio e di ricerca arrivino
al pubblico.
NOTE
[1] Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum (L’unico e la sua proprietà), Reclam, Stuttgart
2011, p. 92 (… das Christentum zu vollendeter Wirksamkeit zu bringen, indem sie das
“wissenschaftliche Bewusstsein” zum allein wahren und geltenden erhob).
[2] Come ultimo ostacolo Nietzsche non vede Schopenhauer, ma il cristianesimo, che era e restava
il suo più grande nemico, e a cui correva sempre il suo pensiero: “Persino il cristianesimo diventa
necessario: solo la forma suprema, più pericolosa, più seducente del no alla vita ne sfida la suprema
affermazione” (Frammento 25 [7] dicembre 1888-gennaio 1889). Nel frammento 14 [25] primavera
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
1888 aveva indicato tuttavia in Schopenhauer, oltre che in Vigny, Dostoevskij, Leopardi e Pascal, il
principale ostacolo al pessimismo classico o della forza.
[3] F. Nietzsche, lettera del 26 novembre 1888 a Paul Deussen.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Cosa è un atomo (ammesso che sia qualcosa)?
di MLADEN DOLAR
Mladen Dolar, benché ancora poco noto in Italia, è uno degli esponenti più lucidi e significativi di
quella che correntemente viene chiamata “Scuola di Lubiana” (con Slavoy Žižek, Alenka Zupančič
etc.). In questo saggio, Dolar sviluppa alcune delle vedute che distinguono questa scuola in
rapporto alla questione della costituzione “ontologica” dell’atomo e del den.
L’atomismo, così dice la storia, è stata la prima apparizione del materialismo nella storia della
filosofia, nonostante la parola “materialismo” abbia fatto la sua comparsa soltanto nel diciottesimo
secolo. Le battaglie filosofiche che infuriavano in precedenza, e non sono state di certo poche, sono
state combattute sotto bandiere di diverso tipo e l’imposizione retroattiva della grande
contrapposizione antagonistica tra materialismo e idealismo potrebbe presentare problemi, come
vedremo, nonostante chiami in causa delle poste in gioco molto alte. Hegel, l’arci-idealista, o
almeno così si dice, sembrerebbe quindi essere un sostenitore dell’atomismo piuttosto improbabile:
eppure ogni qualvolta abbia toccato la questione, cosa che ha fatto in poche occasioni, ha trattato la
posizione atomistica con entusiasmo, considerandolo come il presagio di un’idea speculativa
profonda e di ampia portata emergente all’alba della filosofia, un’intuizione da tenersi stretta anche
se insufficiente, una visione del mondo che ci riportasse indietro alle basi, al minimo, alle
condizioni preliminari del pensiero.
La rivendicazione dell’atomismo al materialismo non dipende dalla celebrazione della materia
come sostanza ultima, con la pretesa che lo spirito e l’anima siano materiali allo stesso modo della
natura: piuttosto implica un’operazione che va molto oltre. Per metterla nei termini più semplici e
scusandomi per questa considerazione breve ed estremamente semplificata, la filosofia prende le
mosse da una tesi fondamentale: tutta la diversità dell’essere può essere spiegata da un solo
principio. Può essere ridotta all’Uno, che sia l’arché dei primi naturalisti o, nella sua prima vera
comparsa, la grandiosa idea speculativa di Parmenide che “l’Essere è uno” (e quindi indivisibile).
Questa operazione presuppone la possibilità di sottoporre l’essere a una conta: fondamentalmente
alla conta di uno. L’Essere può essere contato? Può essere misurato da un numero? Quanti essere vi
sono?[i] Platone, nel Parmenide, offrirà la lista esaustiva di tutte le possibili trasformazioni basate
soltanto su due elementi, Essere e Uno, in quanto matrice minima con cui ricondurre tutte le cose a
un unico concetto. Perché un logos sia possibile, l’Essere deve essere contato: deve essere
calcolabile e calcolato. In una parola, vi è un “matema” dell’Essere, per usare un’espressione di
Lacan - questa è la “tesi filosofica zero”.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
La filosofia eleatica si è basata su due principi chiave: 1. che l’essere è uno e indivisibile, e 2. che
l’Essere è (non può non essere) e il non-essere non è. L’atomismo, come reazione a questa
posizione, ha adottato una visione decisamente opposta su entrambi i lati: primo, che l’Essere sia
divisibile per uno, non indivisibile come uno. Ha posto l’atomo come particella indivisibile in cui
qualsiasi cosa può essere scomposta, imponendo così il semplice contare a tutti i diversi e infiniti
aspetti dell’essere. L’atomo può essere contato come uno, senza alcuna possibilità di ulteriore
divisione, ed ogni cosa che esiste può essere ridotta essenzialmente a questo “conto-per-uno”, fino
all’infinito. Secondo, nel momento in cui si pone questo “uno” come l’elementare particella
dell’essere, si pone, nello stesso momento, il vuoto che separa gli atomi e che rende possibile il loro
movimento: ancor di più, il principio del loro stesso movimento. In questo modo il non-essere viene
posto al centro dell’essere. La “tesi zero” degli atomisti è: il non-essere è, ed è reale proprio come
l’essere. Si scompone così la complessità dell’essere in due elementi: l’uno e il vuoto. Se vi è una
divisione negli atomi, essa non riguarda le particelle indivisibili, ma il vuoto che le circonda e che
permette loro di essere contate per uno. Da qui, il principio eleatico poggia sull’Uno come comun
denominatore di tutto l’Essere, l’uno della totalizzazione, dell’hen kai pan, mentre l’uno atomistico
è l’uno di una rottura, un uno-che-rompe, uno in quanto introduce una rottura, un’incrinatura
nell’Essere. Vi sono due tipi di “uno” che si confrontano: l’uno che provvede alla totalità e ne
riempie ogni possibile spaccatura, conservando l’Essere come un tutto; e l’uno che perturba
l’Essere, introducendo un’apertura nel tutto, per usare un (cattivo) gioco di parole in inglese, senza
essere complice della totalità (e piuttosto facendo in modo che vi sia un “non-tutto”). Nietzsche, in
una delle sue note postume, ha visto nella mossa eleatica “un articolo di fede metafisica, derivato
da un’intuizione metafisica e che attraversiamo in tutte le filosofie, col tentativo sempre nuovo di
esprimerlo meglio – l’affermazione che “tutto è uno”[ii]. Bene, le filosofie del “non-tutto”, gli
atomisti, erano lì pronti a contrastare immediatamente questa mistica.
Hegel, il presunto arci-idealista, qualora ve ne sia mai stato uno, è sempre stato entusiasta di ciò che
egli vedeva come la più grande conquista speculativa dell’atomismo antico: cioè che alla base
abbiamo sempre non un’unità, ma un’unità spaccata in qualcosa e un vuoto, così che dobbiamo
includere il vuoto come “l’altra metà”, “la metà perduta” dell’essere fisso degli atomi. Lui stesso
ritorna su questo punto più e più volte. La questione del materialismo è immediatamente in gioco:
perché se il problema viene posto in questi termini per Hegel si tratta ovviamente di idealismo
antico, dal momento che gli atomi, le unità e il vuoto sono chiaramente “principi ideali”. Non sono
qualcosa che possa essere visto o esperito: nessuno ha mai visto, percepito, esperito un atomo, non
solo a quei tempi, ma in ogni secolo, anche con i migliori strumenti alla mano. L’atomo è
chiaramente un’idea, l’idea di uno e della divisione, l’idea del vuoto e del non-essere. “Il principio
dell’uno è interamente ideale [ideell ], appartiene interamente al pensiero, anche nel caso si voglia
ammettere che gli atomi esistano. L’atomo può essere considerato in un senso materiale, ma questo
rimane non-sensibile [unsinnlich], puramente intellettuale”. (TWA[1] 18, p.358). Gli atomi sono
invisibili, non solo per via della loro dimensione minuscola, ma perché “non è possibile vedere
l’Uno [das Eins kann man nicht sehen], è un’entità astratta del pensiero… Il principio dell’uno è
interamente ideale, ma non nel senso che esso esista solo nel pensiero, nella testa, ma nel senso che
il pensiero è la vera essenza delle cose [der Gedanke das wahre Wesen der Dinge ist].” (pp. 35859). Così gli atomi sono ideali in primo luogo nel senso più debole secondo cui in principio non
sono materia di percezione, esperienza e sensi, quindi in un senso più forte, nel senso hegeliano
paradigmatico, che queste entità ideali presenti nella testa toccano l’essere. Queste non sono
opposte all’essere sensibile, ma in realtà esprimono chiaramente il loro nocciolo. Da qui la
conclusione di Hegel che questo sia “idealismo in un senso più alto, non in quello soggettivo
[Idealismus im höheren Sinne, nicht subjektiver]” (p.359): in ballo qui non c’è, infatti, alcuna idea
soggettiva nella testa di qualcuno (piuttosto, è il soggetto in sé a non essere altro che un effetto di
questo divisione). Questo è anche in linea con uno dei frammenti di Democrito (riportato da
Plutarco): il fatto che l’atomo sia un’idea, atomos idea. (Si potrebbe anche aggiungere che atomos
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
per Democrito era di genere femminile, come un aggettivo sostantivato in corrispondenza con
l’idea, mentre diventerà neutro più tardi, seguendo il soma, il corpo. La questione del genere
grammaticale non è neutrale: l’atomo è stato reso neutro separandolo dal suo genere e
trasformandolo in un corpo. E’ una questione di genere il fatto che un atomo sia un corpo o un’idea.
Cosa è il sesso degli atomi? Sono nati come idee e resi neutri come corpi).
Alla base dell’argomentazione hegeliana vi è l’affermazione che l’essere e il pensiero si incrociano,
non devono essere opposti, e il punto in cui si essenzialmente si incontrano è la spaccatura e nel
vuoto. Come dirà Hegel più tardi nella Storia della Filosofia (discutendo di Epicuro):
Questa rottura [interruzione, Unterbrechung] è l’altro lato degli atomi: il vuoto. Il movimento del
pensiero è un movimento tale che ha in se stesso la rottura (il pensiero è nell’uomo precisamente ciò
che gli atomi e il vuoto sono nelle cose, il loro Interno[das Denken ist im Menschen eben das, was
die Atome und das Leere in den Dingen, sein Inneres]). (TWA 19, str. 311).
Questo è il vecchio Hegel. Così il pensiero è la rottura dell’essere, la sua Unterbrechung, la sua
interruzione, e ciò che il pensiero e i suoi oggetti hanno in comune è la rottura che interrompe
l’oggettività, introducendo il vuoto. Il pensiero e il mondo s’incontrano nel vuoto introdotto dal
pensiero; ma questo è il reale accesso all’essere che ha il pensiero, l’interruzione pensante
interrompe l’essere stesso, apre l’essere per noi o, all’inverso, il pensiero è posto in una frattura
dell’essere, e le due direzioni sono indistinguibili per Hegel. La questione qui non è tanto se
l’atomismo sia una buona teoria e se Hegel lo abbia accolto nella sua spiegazione dell’essere: lui
stesso lo avrebbe considerato insufficiente e troppo astratto. La questione non è nemmeno se questa
sia una buona ricostruzione storica dell’atomismo antico, visto che sul tema sono state prodotte
numerose ricerche filologiche di grande rilievo. La questione vera è che l’atomismo include una
certa intuizione che lo stesso Hegel considerava valida e di ampia portata: il fatto che sia un
principio di negatività a muovere insieme il pensiero e l’essere; che questo principio forma
l’interiorità di entrambi nel profondo, sein Inneres. Per dirla nei ben noti termini hegeliani: il modo
in cui la sostanza e il soggetto si reggono insieme deve essere legato a questo principio. E in questo
modo vediamo che la divisione fra idealismo e materialismo assume una diversa proporzione: in
questione non è la precedenza della materia rispetto al pensiero e alle idee, della materia posta come
indipendente da questi, ma se e in che modo il pensiero si incontra con la materia o se la divisione
della materia sia il luogo reale in cui il pensiero si iscriva. Non vi è alcun materialismo senza
l’esposizione di questo paradosso: in caso contrario la materia diventa solo un altro nome per la
tradizionale sostanzialità. Così la questione non è chi venga prima, ma come pensare la loro frattura,
quindi la loro articolazione[iii]. La questione di ciò che viene prima, materia o idea, assume già la
divisione che struttura la domanda: la compiuta divisione in materia e pensiero. Ma materialismo e
idealismo differiscono piuttosto nel modo stesso di porre questo schema.
Hegel torna su questo punto nella Logica, nella nota sull’atomismo, quando introduce il suo
concetto dell’Uno:
Il principio atomistico, con questi primi pensatori, non è rimasto nell’esteriorità, ma, nonostante la
sua astrazione, conteneva una determinazione speculativa: che il vuoto era riconosciuto come la
fonte del movimento. Ciò implica una relazione completamente differente fra gli atomi e il vuoto
rispetto al mero uno-accanto-all’altro [Nebeneinander] e la mutua indifferenza dei due. […] Il punto
di vista secondo cui la causa del movimento risieda nel vuoto contiene quel pensiero più profondo
per cui causa del divenire è il negativo. (Logica, TWA 5, p. 185-6)
In un certo senso si potrebbe dire che Hegel stia tutto in questo passaggio fondamentale. Ponendo
l’uno, come entità positiva, si pone inevitabilmente il vuoto, il non-essere, come il vero elemento in
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
cui l’uno possa prosperare. Così ciò che è indivisibile, per Hegel, non è né l’uno né il vuoto: ad
essere indivisibile è la divisione in se stessa. Per quanto si possa cercare lontano un elemento
minimo, non arriveremo mai ad un uno che sia il minimo e l’indivisibile: ma alla divisione. Il
vuoto, come la platonica metà perduta dell’elemento come uno, risponde a questa descrizione
essendo appunto scomparso (ciò che scompare). L’atomo di Hegel, la sua particella elementare è
quindi l’atomo in sé in questo senso preciso: 1. ciò che non può essere diviso ulteriormente è la
divisione in sé; 2. il negativo è la condizione interna del positivo; 3. non vi è alcuna unità, ma
un’unità frammentata; 4. essere e pensiero si incontrano in questa spaccatura. L’atomo del pensiero
hegeliano è l’atomo.
Vi è un quinto punto, che è tutto fuorché evidente, che tuttavia costituisce il momento cruciale per
Hegel. Con un altro colpo audace, Hegel vede in questo vuoto e in questa rottura precisamente il
luogo del soggetto. Un altro passo in avanti è richiesto: gli antichi vedevano molto bene questa
rottura e il negativo, ma ciò nonostante non avevano ancora realizzato che questo fosse il luogo
reale del soggetto, e che il soggetto, in senso hegeliano, altro non è se non ciò che emerge in questa
rottura, che abita la disparità dell’uno con se stesso, racchiuso proprio da questa divisione. Quindi
questo atomo del pensiero hegeliano deve essere esteso: non è un mero atomo dell’essere, ma allo
stesso tempo l’atomo del soggetto, il modo autentico attraverso cui il soggetto appartiene all’essere,
il modo in cui, profondamente, “la sostanza è soggetto”, come recita il suo noto adagio. Hegel
afferma questo in un passaggio in qualche modo enigmatico della “prefazione” alla Fenomenologia:
…certi antichi concepivano il vuoto [das Leere] come ciò che muoveva le cose [das Bewegende],
dal momento che questi concepivano ciò che muove le cose come il negativo, ma non avevano
ancora colto questo negativo come il sé [das Selbst][iv].
Così gli antichi avevano visto bene il principio della negatività nel vuoto, rompendo ogni “uno” alla
radice. Si erano anche figurati il negativo come la forza movente, ma non sono stati in grado di
cogliere in questa negatività il vero luogo del sé: il soggetto. Si sono accorti che la sostanza è
permeata di vuoto, abbracciando l’assenza in seno suo, ma non hanno avuto alcun sentore del fatto
che questo avrebbe avuto una relazione con il luogo del soggetto. Ma questo è Hegel al suo minimo
– il luogo del soggetto, nell’adagio “la sostanza è il soggetto”, non è nient’altro che questa scissione
in sé, questo taglio nell’essere introdotto dal vuoto come principio del movimento.
Il soggetto, come Hegel concepisce questa entità, non è un essere positivo e non ha essere: deve
essere posto nella rottura ed è questo ciò che spinge ogni entità all’agitazione (eben diese Unruhe ist
das Selbst – il sé non è nulla se non l’agitazione dell’uno, la sua rottura. Esso risiede
nell’impossibilità che ogni entità sia uguale a se stessa: il soggetto è ciò che spinge oltre se stesso,
non è altro che questa diseguaglianza, la parte invisibile di ogni entità positive che causa la
diseguaglianza, Ungleichheit. Se si volesse esprimere chiaramente il progetto hegeliano in poche
parole, estendere questa forma atomica e portarla all’atomo del pensiero hegeliano, si potrebbe dire:
dall’atomo al cogito. Vi è un corto-circuito in questa espressione che lega immediatamente
l’introduzione del vuoto da parte degli atomisti, l’unità speculativa dell’uno e il vuoto, e la figura
della soggettività come essa emerge con il cogito cartesiano. La novità del cogito, infatti, è stata
precisamente nell’aver eliminato i precedenti modi di pensiero relativi alla soggettività (anima,
coscienza, individualità, persona) e introdotto il soggetto all’interno della rottura nell’essere, nella
grande catena dell’essere. (Žižek ritorna più volte su questo punto, “il cogito è la rottura
nell’edificio dell’essere”). Non è una sostanza, nonostante Descartes lo fissi subito dopo averlo
compreso entro la res cogitans, ma quasi l’opposto, almeno nella concezione radicale che ne ebbe
Hegel: esso è ciò che impedisce a ogni sostanza, a ogni sottostante principio di unità, di persistere
mai nell’uguaglianza con se stessa. Vi è una frattura nell’essere, già compresa entro il vuoto
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
nell’atomismo antico, come un luogo che stesse attendendo il soggetto, come poi fu. (Wo es war,
soll ich werden?)
Per semplificare le cose: se la sostanza era la parola chiave della filosofia, la sua idea guida per
portare la molteplicità al fondamentale principio uno, oltre le apparenze e il cambiamento, allora si
potrebbe dire che il soggetto, in Hegel, è il nome dell’uno che si rompe in due, l’impossibilità reale
che ogni sostanza sia uno. L’adagio “la sostanza è soggetto” segue direttamente dall’idea di atomo,
dalla comprensione di ciò che l’atomo implica. Ma quali due dividono in questo modo l’uno? Gli
atomi e il vuoto sono sufficienti a questa rottura? E questa linea retta può bastarci o non sarebbe
forse il caso di fermarla o schivarla?
Ci sia permesso di passare a una seconda versione dell’atomismo: quella che è in diretta
opposizione all’interpretazione hegeliana. La questione del clinamen (il termine è usato solo una
volta, De rerum natura, 2.292)[v], per come viene posta di solito, suona così: gli atomi, le particelle
indivisibili, sono dotate di peso come principio del movimento e tutte insieme cadono con la stessa
velocità. Così date le loro proprietà minime ed essenziali, il loro movimento può essere soltanto
quello di una caduta parallela, come le gocce di pioggia (“imbris uti guttae caderent inane
profundum”, [“Ma se non solessero declinare, tutti cadrebbero verso il basso, / come gocce di
pioggia, per il vuoto profondo”, tr. it. cit. in nota, p. 77]; da cui il famoso incipit di Althusser, la
prima frase del suo trattato sul materialismo dell’incontro: “Piove”)[vi]. In questo modo nulla
emergerebbe mai [“…così la natura non avrebbe creato nulla”, tr. it. cit. in nota, p. 77]. Per questo
deve esservi una declinazione, uno scarto, una deviazione dal movimento verso il basso, che causi il
conseguente scontro e collisione tra gli atomi, e da qui l’universo “come lo conosciamo”.
Devo scusarmi di nuovo per questa illustrazione estremamente semplificata: ricorderò soltanto che
Lucrezio sostiene, piuttosto paradossalmente, tre cose riguardo al clinamen. Questa declinazione, in
primo luogo, ha luogo in uno spazio e in un tempo non definite, come ripete non meno di tre volte –
non ha alcuno spazio o momento attribuibile, è senza luogo e senza tempo, ma presenta ciò che sta
al di fuori dell’unità di spazio e tempo. In secondo luogo: questa declinazione è assolutamente
minimale: “nec plus quam minimum”, [“…non più del minimo possibile”, tr. it. cit. in nota, p. 77].
La deviazione è la più debole che si possa concepire, la differenza al di sotto della soglia di ogni
differenza positiva o osservabile – una differenza differente da tutte le tipiche differenze e in grado
di condizionarle tutte. Terza cosa: Lucrezio, senza alcun preavviso, si discosta improvvisamente dal
suo argomento cosmogonico (in che modo il mondo ha avuto origine dal clinamen) per gettarsi
nell’argomento della libera volontà. La cosmologia, improvvisamente e senza alcun passaggio,
stringe le mani all’antropologia: la causalità della natura con la causalità della cultura, o piuttosto,
un errore nella causalità naturale che si sovrappone a un errore nella “causalità psichica”. Così come
gli atomi deviano dalla loro traiettoria, allo stesso modo la nostra volontà si sottrae ai legami della
necessità e rompe I decreti del fato: la volontà viene strappata via dal destino che mette sullo stesso
piatto la nostra voluntas e voluptas, il volere e il piacere[vii]. Non è solo il destino dell’universo ad
essere qui in questione, ma il destino della nostra volontà e passione, iI desiderio e il piacere: non il
destino in realtà, ma davvero l’opposto, cioè l’autentica possibilità di rompere il destino. Il
clinamen è il punto in cui il cosmo e l’umanità si sovrappongono: questo momento fuori dallo
spazio e dal tempo mostra ciò che essi hanno in comune. Così la causalità naturale e la causalità
psichica sono la stessa cosa per Lucrezio, ma proprio come deviazione: una declinazione dell’uno e
dello stesso, la nostra anima composta di atomi come ogni altra cosa.
Ci si potrebbe azzardare a chiamarla una “indifferenza ontologica”, o un’univocità di movimenti
dell’anima e dei movimenti della natura.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Questa storia ha incontrato un’ampia e ostinata resistenza, insieme a una dura critica, passando da
Cicerone ad Hegel, e in qualche caso arrivando fino ai giorni nostri. Il più irremovibile è stato
Cicerone che ha stabilito il tono del discorso per secoli e millenni:
…questa è una finzione interamente infantile… da una parte la declinazione è arbitrariamente
inventata ([Epicuro] dice che l’atomo declina senza una causa; per un fisico non c’è nulla di più
ignominioso che affermare questo: che qualcosa accada senza una causa), e dall’altra ha escluso gli
atomi senza una causa dal movimento naturale di tutti i corpi… (De finibus bonorum et malorum, 1,
19) Tirano a sorte fra loro per decidere chi declinerà e chi no? E perché declinano seguendo un
minimo intervallo e non uno più grande?... Questa è solo una pia illusione, non un argomento (De
fato,46)[viii].
E così via con queste critiche. Molte di più ne sono arrivate da un mucchio di altri autori, come
Plutarco, Plotino, Agostino, per arrivare fino a Kant (“Epicuro fu anche tanto sfacciato da
pretendere che gli atomi declinassero dal loro movimento rettilineo senza alcuna causa, così da
potersi scontrare fra loro”[ix]) e infine ad Hegel, che deve averne avuto una migliore conoscenza.
Hegel, in altri casi entusiasta ammiratore, ha trattato la nozione di clinamen allo stesso modo: con
disprezzo. Scrive, infatti, nella Storia della filosofia, che per Epicuro gli atomi deviano dal loro
movimento rettilineo “in una linea curva [in einer krummen Linie] che in qualche modo si discosta
dalla direzione retta, così che collidano l’uno con l’altro, e formando in questo modo un’unità
meramente superficiale [eine oberflächliche Einheit], che non deriva dalla loro essenza” (TWA 19,
p. 313). Nell’Enciclopedia afferma più o meno la stessa cosa: gli atomisti hanno considerato con
giustezza che il fatto di postulare che l’uno è basato sulla repulsione dell’uno come sua sorgente
interna (essenzialmente come uno che respinge se stesso), ma non hanno visto che la concomitante
forza opposta di attrazione segue concettualmente da questa in modo inevitabile, così per loro gli
atomi “sono tenuti insieme dal caso [Zufall, coincidenza], cioè da ciò che è privo di pensiero [das
Gedankenlose]. (…) qualcosa di completamente esterno [etwas ganz Äusserliches]”. (TWA 8, p.
206). Così il clinamen rappresenta ciò che è senza pensiero ed esterno, l’assenza di pensiero e di
un’inerente deduzione concettuale.
Arriviamo così alla questione cruciale. Cosa appartiene all’essenza dell’atomo? Il clinamen è
un’aggiunta esterna meramente superficiale che non tocca affatto la sua essenza? Uno scarto senza
alcuna ragione sufficiente? E’ un destino essenziale o solo esterno per gli atomi?
Contrario a questo punto di vista, chiamerò in causa Deleuze, non proprio un hegeliano, (anzi
tutt’altro che questo), ma che in questo caso dà vita a un colpo di scena molto hegeliano: direi più
hegeliano dello stesso Hegel. Così leggiamo su Lucrezio in appendice alla Logica del senso:
Il clinamen, o declinazione, non ha nulla a che fare con il movimento in pendenza che giungerebbe
a modificare per accidente una caduta verticale. Esso è presente da sempre: non è un movimento
secondario e neanche una determinazione secondaria del movimento che avrebbe luogo a un certo
momento, in uno spazio preciso. Il clinamen è la determinazione originaria della direzione della
direzione di movimento di un atomo[x].
Seguendo questa linea interpretativa, contro il buon senso della tradizione sprezzante, il clinamen è
da sempre già lì: è la diseguaglianza radicata nella definizione dell’atomo dall’inizio, la sua
“interna” diseguaglianza con se stesso. L’atomo è la sua stessa declinazione, la paradossale unità
non soltanto dell’uno e del vuoto, ma allo stesso tempo l’unità dell’entità con il suo distaccarsi da se
stessa. Non si tratta di una sorte secondaria che accade all’atomo in sé e al suo supposto moto
rettilineo – dal momento che vi è una deviazione dalla traiettoria, si suppone che doveva precederla
una direzione rettilinea: ma questa non esiste affatto in sé. Il distaccarsi degli atomi produce
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
retroattivamente “l’in-sé”, in termini hegeliani. Il racconto temporale che pone le cose in sequenza –
prima la caduta parallela, in seguito il clinamen – è un’illusione retroattiva necessaria. La
declinazione risiede negli atomi dal principio e risiede sempre in essi, in ogni tempo. Il loro essere
fuori dallo spazio e del tempo sono parte e pezzo del loro spazio e tempo. Gli atomi non possono
essere pensati separatamente dal loro essere-deviati, il clinamen è la loro anima, nel caso ne
avessero una. E’ una cosa sola con la loro unicità, dal momento che la loro unicità è già una
separazione dall’uno: un uno deviato. Ma non era Hegel a essere nella migliore situazione per poter
apprezzare tutto questo? Il clinamen è il suo luogo cieco, lì dove avrebbe dovuto vedere il
necessario “divenire accidentale dell’essenza”, il modo in cui l’essenza può essere se stessa soltanto
mostrando la sua piena contingenza, o è piuttosto un’inerente deviazione dalla sua interpretazione
dell’uno e del vuoto, qualcosa che deve aver perso a livello strutturale?
Deleuze presenta la questione essenziale in maniera sintetica ed efficace, ma ha avuto in questo un
predecessore illustre. Il giovanissimo Karl Marx ha discusso la sua tesi dottorale nel 1841 a Jena (la
stessa Jena dove Hegel scrisse la Fenomenologia dello Spirito e dove vide Napoleone in sella al suo
cavallo bianco) che aveva come argomento, tra tutte le cose, La differenza tra le filosofie della
natura di Democrito ed Epicuro: da lì si vede come Marx abbia stabilito il destino della sua impresa
proprio sull’idea di clinamen. Permettetemi dunque di citare qualcosa da Marx, autore che
praticamente non viene mai citato:
Cicerone lamenta in seguito… che la declinazione egli atomi accade senza una causa; e niente di
più vergognoso, afferma Cicerone, può accadere a un fisico. Ma, in primo luogo, una causa fisica
come quella che vorrebbe Cicerone farebbe tornare la declinazione dell’atomo alle serie
deterministiche da cui essa dovrebbe essere sollevata. Inoltre, l’atomo non ha mai luogo prima di
essere determinato dalla declinazione. [Dann aber ist das Atom noch gar nicht vollendet, ehe es in
der Bestimmung der Deklination gesetzt ist]. Domandare la causa di questa declinazione quindi
significa domandare la causa che fa dell’atomo un principio – una domanda che non ha alcun senso
per chi considera l’atomo causa di ogni cosa, e quindi in se stesso senza una causa. (MEW Ergbd. 1,
p. 282).
Cosa è la causa della causa? La causa ha una causa? Cosa è richiesto perché una causa sia un
principio? Una causa può zoppicare? L’argomento di Marx è fondamentalmente questo: una volta
che l’atomo viene posto come principio non vi è alcuna altra causa che possa interessarlo a parte la
causalità già iscritta in esso: per questo la declinazione appartiene alla sua causalità interiore, non
alla sua sorte successiva. L’atomo è ugualmente uniforme e univoco come peso, ma precisamente
come diseguaglianza di uniformità e univocità. L’apparente distanziarsi dalla causalità porta la
causa allo scoperto. E’ la causa de ce qui cloche (Lacan), la causa zoppicante, sempre co-presente in
ogni causa.
Paradossalmente, Marx nella sua dissertazione ha insistito a lungo sul clinamen, non per criticare
Hegel, quanto piuttosto come “strada privilegiata” per appoggiare Hegel: superando il maggiore
difetto del materialismo, cioè l’istanza deterministica, in modo tale che il clinamen venisse
concepito essenzialmente come la rimozione della materia, la sua sostituzione, l’intrinseca
separazione dalla sua determinazione, e allo stesso tempo per abbracciare la contraddizione
(oggettiva) contro il principio di non-contraddizione. Ciò che Marx ha implicitamente sostenuto è
che Hegel abbia letto scorrettamente la filosofia post-aristotelica laddove avrebbe potuto arruolare
Epicuro come alleato (e troviamo un excursus nella dissertazione che pone Kant nel ruolo di
Democrito ed Hegel in quello di Epicuro)[xi]. Tuttavia, e questo è un grande “tuttavia”, laddove
Hegel ha visto il movimento concettuale necessario che porta all’attrazione come funzionale alla
sostituzione dell’unilateralità, dell’astrazione, della mera repulsione degli atomi, per mezzo della
quale restano bloccati nella divisione in uno/vuoto, Marx insiste sul clinamen per mettere in scena
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
la stessa dialettica. E questa è forse la massima ambivalenza di questo primo tentativo di Marx: il
clinamen è rimozione della materia in ciò che vi è di determinismo meccanicistico o piuttosto
qualcosa nella materia che la rende irremovibile? La sua persistenza nell’autentica contraddizione?
Il materialismo del clinamen (e questo non è stato abbastanza considerato da Marx) va contro
alcune risorse fondamentali dell’ontologia aristotelica che si assumono spontaneamente e
tacitamente. L’atomo non è né hyle, né morphe, non è materia né forma, ma precisamente un
principio che elude questa divisione e tutte le intricate complicazioni dell’ilemorfismo aristotelico.
E’ insieme materia e forma “in uno”: non richiede una forma come principio separato per
informarlo; è informato e spinto da sé, dotato in se stesso del suo proprio impulso e impeto, nel suo
movimento rettilineo come in quello deviato. E’ qui che si rivela la sua opposizione alla nozione di
materia derivante dalla divisione cartesiana in cui la materia è largamente vista come inerte e
passiva, governata da leggi meccaniche. Gli atomi in effetti confondono la linea di confine tra
l’animato e l’inanimato, così come la demarcazione tra materia e idea, quella tra la dimensione
fisica e la psichica, tra la necessità e il caso. La cosa semplice e insieme difficile da comprendere in
questo atomismo è il fatto che esso si ponga contro il buon senso di un dualismo aristotelico
apparentemente auto-evidente; è il modo in cui aggira questo dualismo; il pensiero di un “due in
uno”, ma in un uno che non può più essere “l’Uno” e neanche del tutto un uno. Ogni “uno” è la
deviazione interiore dell’unicità che demolisce la sua unicità.
Non c’è dubbio che vi sia un problema qui. La lettura di Deleuze e di Marx, profonda e lucida nella
sua svolta speculativa (adesso largamente seguita dalla maggior parte della critica contemporanea),
può ridurre facilmente il clinamen a un non-concetto: può velocemente diventare una chiave
onnipresente. Nel peggiore dei casi esso è idealmente adatto a distinguersi come campione dell’era
post-moderna: il suo slogan di moda e la parola chiave, fondendo insieme gli sviluppi della fisica, le
‘strutture dissipative’ di Prigogine, i frattali, il caos e i quanti, con gli strumenti della poesia
(post)moderna, cui Jarry e Joyce, entrambi sottili ammiratori di Lucrezio, hanno spianato la
strada[xii]. E non vi è che un breve passo per includere la différance-détournement di Derrida e la
lignes de fuite di Deleuze, la “necessità della contingenza” di Meillassoux ecc… nella mischia
generale. Si può facilmente immaginare come il clinamen possa ampliamente prosperare in questo
modo: un passe-partout universale nella sua apparente singolarità e il riserbo è al proprio posto se
non si ha lo stomaco per una simile prospettiva. Ma questo uso appariscente non squalifica il
concetto in sé che ha prodotto questa affascinante progenie: più in particolare l’idea althusseriana di
materialismo aleatorio, o “materialismo dell’incontro”, ha come premessa il clinamen, ma non
posso discuterne più a fondo in questa sede[xiii].
Essenzialmente abbiamo due possibilità: o si situa il clinamen come un’eccezione (costitutiva),
qualcosa che deve sempre già essere accaduto così da far emergere l’universo, accadendo al di fuori
dello spazio e del tempo, senza alcun luogo o movimento all’interno della spazio e del tempo nel
momento in cui si sono costituiti. O piuttosto può essere un principio “quasi-universale”
onnipresente che deraglia immediatamente ogni dato uno in ogni luogo e in ogni spazio. Sembra
che Badiou, nella sua interpretazione perspicace del clinamen contenuta nella Teoria del soggetto,
opti più o meno per la prima soluzione:
E’ assolutamente necessario che il clinamen venga abolito nella sua stessa svolta… Ogni
spiegazione particolare di ogni cosa particolare non deve richiedere il clinamen, nonostante
l’esistenza di una cosa in generale sia impensabile senza di esso… L’atomo interessato dalla
deviazione dà origine al Tutto senza alcun resto o traccia di questa azione. Ancora meglio: l’effetto
è la rimozione retroattiva della causa… la deviazione, non essendo né l’atomo, né il vuoto, né
l’azione del vuoto, né il sistema degli atomi, è inintelligibile[xiv].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Deleuze, d’altra parte, opta per la seconda soluzione, e si potrebbe leggere la sua nozione del
virtuale come l’intrinseco e immanente clinamen, l’essere deviato, che si situa in ogni momento ed
entità. – Avendo in mente le formule di Lacan sulla sessuazione si potrebbe anche porre la
questione: Badiou è un uomo? Deleuze è una donna?
Nel primo caso lo prendiamo come un’eccezione che non ha “mai luogo”, nonostante sia sotteso a
ogni “aver luogo”, come una “trascendenza immanente”, fuori-dal-mondo. Nel secondo caso
“quasi-universalizziamo” l’eccezione e la rendiamo immanente ad ogni “aver luogo”, facendone
così una deviazione universale di ogni universale, il fuori-dall’unicità di ogni Uno (col pericolo di
fornire in questo modo un passe-partout conveniente e non vincolante). Come pensare insieme
l’Uno e l’Altro? E’ possibile una terza opzione?
È allora l’intuizione speculativa hegeliana, con le conseguenze di ampia portata che Hegel stava per
trarre, la trama fondamentale del racconto dell’atomismo come materialismo? L’uno, il vuoto, la
spaccatura, la negatività, il soggetto inscritto nella spaccatura? O forse la trama principale risiede
nella deviazione, nel clinamen, nella separazione dall’uno e dal vuoto? – In conclusione proverò a
proporre una terza versione di questa storia sull’atomo. C’è qualcosa nell’atomo che potremmo
tradurre nello slogan: “dimmi cosa pensi dell’atomo e ti dirò chi sei”. Chi sei tu – Hegel, Marx,
Deleuze, Althusser, Badiou?
Torniamo indietro a Democrito e consideriamo un’opzione che né Hegel né Marx hanno valutato:
un passaggio oscuro che è stato posto in evidenza da Lacan, vedendovi qualcosa come “l’atomo del
pensiero e dell’essere”, opposto all’atomo hegeliano. In un famoso passaggio ne I quattro concetti
fondamentali, Lacan dice:
Quando Democrito ha provato a designarla [l’origine], presentando già se stesso come avversario di
una pura finzione della negatività così da introdurre il pensiero in essa, questi afferma: Non è il
meden [non-essere] che è essenziale, e aggiunge… non è un meden, ma un den, che in greco è un
neologismo. Non ha detto hen [uno]: figuriamoci se avesse detto on [essere]. Cosa dice invece?
Dice questo dell’idealismo, rispondendo alla domanda che ho fatto oggi: Niente, forse? – non forse
niente, ma non niente” (pp. 63-4)[xv].
Ma cosa è un den, ammesso che sia qualcosa?
Democrito nel famoso frammento 156 (nell’edizione canonica Diels-Kranz) ha introdotto
enigmaticamente proprio qualcosa che non sarebbe caduto in alcun lato della partizione tra uno e
vuoto. Ha coniato il termine den che ha provocato non pochi grattacapi ai filologi classici,
trattandosi di una parola costruita impropriamente in greco (“una parola coniata”, dice Lacan). La
parola deriva dalla negazione di hen: uno. Hen può essere negato in greco in due modi: o come
ouden (negazione oggettiva) o come meden (negazione soggettiva), entrambi significando “niente”
(sebbene con diverse sfumature): più precisamente “non uno” o “neanche uno”. Den, questo
termine inappropriato, significa qualcosa come “meno di uno, ma non ancora nulla”, o, forzando un
po’, “meno di niente”. Rappresenta quindi una questione complessa per il traduttore. Diels tradusse
questa parola curiosa con das Ichts (Das Nichts existiert ebenso sehr als das Ichts)[xvi]. La
traduzione inglese di W. I. Matson ha proposto “hing”, opposta a alla parola “thing”: “Hing is no
more real than nothing” oppure “Hing exists no more than nothing”[xvii]. Una resa più accurata
sarebbe stata “othing”, sottraendolo dal “nothing”. Barbara Cassin, formidabile studiosa francese,
ha proposto nella sua traduzione ien – non rien, niente, ma ien, precisamente “non niente”, come
dice Lacan (o in alternativa iun, non uno).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
La peculiare fusione dell’ultima lettera della negazione con la positività negata ci obbliga a
interpretare l’atomo non solo come non affermazione o posizione, essere o uno, ma ancor di più non
essendo neanche la loro negazione, mancando della consistenza di “niente” o “rien”: l’atomo è
letteralmente meno che niente, lo si deve chiamare “ien”… Den è il nome dell’atomo nel momento
in cui non si può mescolare con l’essere dell’ontologia e neanche considerarlo come corpo
elementare della fisica[xviii].
Ma allora cosa è questa entità, il den? Non è qualcosa, non è il nulla, non è essere, non uno, non
esiste positivamente, non è assente, non contabile – non è precisamente l’oggetto di cui siamo alla
ricerca? Qual è il nome del den – l’objet a? Questo è il punto che Lacan mette in evidenza nella
nostra citazione, nonostante non possa davvero sfuggire alla negazione: “Niente, forse? – non forse
niente, ma non niente”. Non è una negazione, ma piuttosto come la decapitazione del niente:
tagliandogli la testa, trasformandolo in Ichs, hing, othing, ien. O per usare un termine di Badiou:
non negazione, ma sottrazione. Non è una sottrazione dall’essere che introduce un vuoto e neanche
il resto di una negazione dell’essere che non è riuscita del tutto, ma piuttosto – è questo è
l’incredibile speculativo – una sottrazione dal non-essere, una negatività che rimuove se stessa. Vi è
come una mancata doppia negazione, un errore nell’hegeliana negazione della negazione. Qualcosa
emerge in questa imposizione e fallimento della negatività, ma non è davvero qualcosa, non ha
positività né identità: e tuttavia questo è proprio l’essere dell’atomo.
Heinz Wismann, uno dei più grandi specialisti di Democrito, non esita a tirare questa conclusione:
In realtà il “reale” evocato dal termine rudimentale (den) creato da Democrito deve la sua esistenza
solo alla rimozione della negazione (me) che è intrinseca sia alla realtà concettuale che lessicale del
“niente” (meden). L’essere, si potrebbe affermare, è soltanto uno stato di privazione del non-essere
[l’être … n’est qu’un état privatif du non-être]; la sua positività è un’esca. E’ un tipo di sottrazione
operata sul niente [soustraction opérée à partir de rien, sottrazione eseguita a partire dal niente]:
l’atomo può essere pensato come l’avatar del vuoto [avatar du vide]”[xix].
Da qui il titolo del libro di Wismann, Les avatars du vide). Se l’atomo è den, allora per Democrito
non può avere peso, non vi può essere alcuna caduta parallela né il problema stesso del clinamen.
E’ stato solo Epicuro in realtà ad attribuire un peso agli atomi, essendo in questo involontariamente
fedele all’ontologia aristotelica, incapace di concepire che l’atomo non fosse un corpo. Gli atomi
non sono corpi, ma mere traiettorie che producono corpi. Sembra esservi come una conferma in
anticipo del dilemma presentato dai fisici atomici moderni: o il corpo o l’onda, non si possono avere
entrambi; c’è una parallasse. E se Democrito, inconsapevole di tutto questo, ha optato per le onde (il
rhysmos era per lui la proprietà fondamentale degli atomi), l’ontologia aristotelica, invece,
compreso Epicuro, ha optato per i corpi[xx]. Ne è seguita una certa ontologia e fisica. – Non
sorprende dunque che Platone, così ci racconta Diogene Laerzio, voleva dar fuoco a tutti gli scritti
di Democrito (ma erano troppi), come non sorprende che, arrivato ad Atene, nessuno lo
riconoscesse.
Il den è come uno scandalo ontologico. Lacan ci torna sopra ne Lo stordito:
Democrito ci ha dato in dono l’atomos, il reale radicale, con l’elisione del “no”, me, ma in una
modalità la cui domanda richiede la nostra attenzione. In questo modo il den è stato il passeggero
clandestino il cui guscio adesso forma il nostro destino. In questo non è stato più materialista di
chiunque abbia qualcosa di sensato [n’importe qui de sensé], ad esempio me o Marx” (Autres écrits,
Paris: Seuil 2001, p. 494).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
E per aggiungere un riferimento da un’area completamente diversa: quando a Samuel Beckett
veniva chiesto insistentemente conto delle implicazioni filosofiche del suo lavoro, scrisse (in una
lettera del 1967): “Se fossi nella non-invidiabile posizione di dover studiare le mie opere, il mio
punto di partenza sarebbe “Nulla [Naught] è più reale…”[xxi]. Così Beckett stesso propone il
frammento 156 di Democrito il nucleo (uno dei due nuclei) della sua intera opera. Se ne è servito
spesso, in varie occasioni, e nelle sue tarde opere ha inventato un altro nome per esso: l’ultimo nonannullabile (espressione che porta in realtà a una direzione sbagliata, indicando qualcosa dell’essere
che non può essere annullato, laddove den è letteralmente “meno che niente”, come recita il libro di
Žižek [Less than Nothing, n. d. .t.]: una sottrazione dal niente).
Il den condensa la nostra questione al minimo. Ciò che sorprende in particolare è la sua intrinseca
connessione con il racconto hegeliano, che ho considerato come la migliore spiegazione
dell’impatto filosofico dell’atomismo, secondo la divisione discriminante uno/vuoto, essere/nonessere. Il den emerge letteralmente nello stesso luogo, nella stessa divisione, nel mezzo della rottura
che Hegel ha considerato come lo spettacolare fondamento. Il den è co-estensivo e allo stesso tempo
incommensurabile rispetto “all’uno”, l’uno che gli atomi introducono come conto dell’essere, e
anche rispetto al vuoto in quanto rovescio dell’uno spaccato. Si potrebbe dire che si tratti della metà
scomparsa dell’atomo hegeliano, l’uno che era già spaccato nella metà presente e in quella
scomparsa, con la co-appartenenza di essere e non essere, dell’uno e del vuoto come matrice
dialettica – ma il den è la metà scomparsa di questa unità spaccata in se stessa, esattamente dal non
essere del tutto scomparsa e neanche essere del tutto qui, dal non essere in alcuna relazione
dialettica con la rottura fondativa dell’atomo. E’ il puro sovrappiù della rottura, una (non) entità che
fugge la divisione non essendo ancora da qualche altra parte, risiedendo nella divisione in sé. Non
una presenza originaria o un’assenza, non un principio fondativo, una mera hing (o othing) derivata
dalla rottura (in uno/vuoto, essere/non-essere) e irriducibile ad essa.
Il den può essere pensato soltanto dopo l’uno, come l’operazione che sottrae e non come una
provenienza, troncata o meno. Non può essere soggetto alla dialettica proprio perché non si tratta di
una negazione della negazione, assorbita e rimossa, ma una sottrazione della stessa negazione…
Non è un’entrata, ma un’uscita: una via di fuga che incespica l’origine e svia l’intera storia della
filosofia… (Cassin, pp. 83-4).
Ecco la materia cruciale della questione (in senso figurato e letterale): il den non giunge del tutto
dopo “l’uno”, ma nello stessa scatola dell’uno, senza per questo diventare un due o uno zero.
Rappresenta l’altra faccia dell’uno, essendo né il niente della sua negazione e neanche la
molteplicità della sua proliferazione. Si sottrae al conteggio e tuttavia dipende dall’uno: è il taglio
del significante ai suoi minimi termini.
La questione del clinamen è forse indicativa a questo punto. Abbiamo visto che Hegel ha parlato
con disprezzo del clinamen, affiancandosi ai numerosi detrattori di esso, apprezzando allo stesso
tempo la profonda intuizione della rottura nell’uno e nel vuoto come costitutiva dello stesso atomo:
un nucleo per la sostanza, il soggetto, la negatività, l’essere, il niente, la dialettica. D’altra parte
Deleuze ha dato grande risalto al clinamen, essenzialmente come modo per evitare l’uno e il vuoto:
esso sarebbe un movimento che permette di aggirare questo taglio, la negatività, la mancanza ecc…,
nascosto nell’atomo, insieme a tutte le trappole della dialettica hegeliana, e questo aggiramento
spiana la strada per la positività del divenire. Sembra quindi che siamo come parallasse quando
consideriamo l’atomo: o si vede la rottura, l’uno/il vuoto ecc..., come ha visto Hegel, o si vede il
clinamen, la deviazione interna, la torsione, la declinazione, il divenire immanente non premesso al
taglio della negatività, che poggia sulla deviazione come il divenire senza un vuoto. E’ come se
vedere una parte precludesse la possibilità di vedere l’altra: non si può trovare un compromesso o
una sintesi tra le due.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Riprendendo la coda della felice invenzione democritea del den, potremmo forse evitare questa
parallasse: è solo sulla base dell’uno e della spaccatura che il den può emergere, come sottrazione
della negatività, non la sua esorcizzazione. In questo modo si evita di porre il clinamen come
“eccezione fondativa” (Badiou) o virtualità universalizzata (Deleuze). Si possono sostenere così
entrambe le parti, l’uno e il den, nella loro autentica incommensurabilità, come il vero spacco
dell’essere, il luogo dove sia l’essere che il pensiero emergono e si confondono. Produce un nuovo
oggetto ancora nascosto dall’alba della filosofia, come suo passeggero clandestino: un oggetto
senza identità e che non fonda alcuna ontologia. Questo è forse il punto in cui la psicoanalisi , come
abbiamo cercato di fare con i miei amici di Lubiana, debba essere compresa come l’erede alla
dialettica hegeliana, non il suo abbandono, ma anche immaginandola come qualcosa che emerge al
suo interno e che non può essere spiegata nei suoi termini.
Se questo è materialismo, allora lo è di un tipo molto particolare. Non è il materialismo del corpo,
non il materialismo della materia, non il materialismo della scienza e neanche un materialismo
come istanza ontologica. Esso dipende, alla base, dall’affermazione che un due non è un due che
risulti dal contare, quanto piuttosto un “uno in più”, uno più qualcosa che non ha mai avuto la
consistenza di un essere o un niente. E anche il suo “uno” non è nient’altro che un puro taglio, una
rottura che non ha mai avuto la consistenza di un’unità – è il “meno-uno”, piuttosto che l’uno. Un
meno uno più il den – il minimo prerequisito per la teoria? Così, con questa coppia dispari, che non
è neanche una coppia, con queste due entità, che non sono neanche entità, con questa non-relazione
di non-entità, io ho esposto il caso.
NOTE
[1] Con TWA si intenda G.W.F. Hegel, Werke, l’edizione delle opere complete uscita per
Suhrkamp e basata sulla prima edizione delle opere complete di Hegel, quella 1832-1845.
[i] La versione più sintetica di questo problema è fornita da una citazione di Isocrate,
contemporaneo di Platone: “Per alcuni vi è un numero infinito di esseri, per Empedocle ve ne sono
quattro, per Ione solo tre, per Alcmeone due, per Parmenide e Melisso uno, mentre per Gorgia non
ve n’è alcuno”. Cfr. soprattutto il Sofista di Platone, 242c-d.
[ii] Citato da Heinz Wismann, Les avatars du vide, Paris, Hermann 2010, p. 80.
[iii] Il reale lacaniano – e se vi è un materialismo lacaniano, questo si riferisce alla nozione di reale
– non è né un pensiero, un’idea, né un essere (e neanche una materia per quella materia), ma
qualcosa che emerge precisamente nella loro frattura: qualcosa che va perduto nella conseguente
divisione auto-evidente in essere e pensiero, insieme alla loro opposizione.
[iv] The Phenomenology of Spirit, TWA 3, p. 39. Mi sto servendo della traduzione di Terry Pinkard,
disponibile on-line: “Die Ungleichheit, die im Bewußtsein zwischen dem Ich und der Substanz, die
sein Gegenstand ist, stattfindet, ist ihr Unterschied, das Negative überhaupt. Es kann als der Mangel
beider angesehen werden, ist aber ihre Seele oder das Bewegende derselben; weswegen einige Alte
das Leere als das Bewegende begriffen, indem sie das Bewegende zwar als das Negative, aber
dieses noch nicht als das Selbst erfaßten” [abbiamo tradotto le citazioni di Hegel dall’inglese,
perché Dolar introduce delle modifiche nelle traduzioni inglesi dei testi hegeliani, n. d. t.].
[v] “id facit exiguum clinamen principiorum / nec regione loci certa nec tempore certo” [“Ciò lo
consegue un’esigua declinazione dei primi principi, in un punto non determinato dello spazio e in
un tempo non determinato” (tr. it. La natura, a cura di Francesco Giancotti, Garzanti, Milano 2006,
p. 81)]. Mi sono servito dell’edizione del De rerum natura tradotta da W. H. D. Rouse e rivista da
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Martin Ferguson Smith, Cambridge (Mass.), Harvard UP 2006. Il termine latino usato generalmente
(soprattutto dallo stesso Lucrezio) è declinatio, declinazione, e l’unica occorrenza di clinamen,
questa deviazione dall’uso comune, sembra aver eclissato il suo gemello meno affascinante. E’
come una parabola: il clinamen è già una deviazione dalla/della deviazione.
[vi] Louis Althusser, Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre (1982), in Écrits
philosophiques et politiques 1, Paris: Stock/IMEC 1994, p. 553. Althusser celebra la singolarità del
clinamen precisamente non in quanto principio o ragione – in quanto opposto a tutte le altre
filosofie che poggiano su un fondamento – ma appunto allontanandosi da ogni principio o logos.
[vii] Cfr. Derrida: “Mes Chances: A Rendezvous with Some Epicurean Stereophonies.” in: Joseph
H. Smith and William Kerrigan (eds.), Taking Chances: Derrida, Psychanalysis, and Literature.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1984, p. 7.
[viii] Per queste fonti e per la ricostruzione del dibattito faccio riferimento a Ernst A. Schmidt,
Clinamen, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2007, pp. 53-60
[ix] Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755, TWA 1, p. 234.
[x] Logique du sens, Paris: Minuit 1969, p. 311. Simile e più in breve anche Différence et
repetition…
[xi] Cfr. Peter Fenves, “Marx’s Doctoral Thesis on Two Greek Atomists and the Post-Kantian
Interpretations”, Journal of the History of Ideas, Vol. 47/3, pp. 433-452.
[xii] La prima frase di Fineggans Wake inizia col celebre: “river run, past Eve and Adam’s, from
swerve of shore to bend of bay...”. Troviamo la ‘swerve’ (deviazione) proprio in apertura e alcuni
commentatori hanno visto in questo passo un richiamo a Lucrezio: il clinamen come il più
appropriato incipit.
[xiii] Per Althusser, la grandezza di Epicuro sta nel fatto che ogni altra filosofia ha proposto un
principio fondativo di una sorta o di un’altra, e lo ha posto all’origine, mentre Epicuro ha proposto
la separazione, la deviazione da ogni principio fondativo come l’origine.
[xiv] Théorie du sujet, Paris: Seuil 1982, p. 79-80.
[xv] The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, transl. Alan Sheridan, London: Penguin
1979.
[xvi] Hermann Diels & Walther Kranz (eds.), Die Fragmente der Vorsokratiker II, Berlin:
Wiedmannsche Buchhandlung, 1935, fr. 156, p. 174. – Posso aggiungere che nella mia lingua il
traduttore sloveno Anton Sovre ha seguito questa scelta, coniando il neologismo ‘ič’, opposto a
‘nič’, niente. Predsokratiki, Ljubljana: Slovenska matica 2002, p. 200.
[xvii] W. I. Matson, “Democritus, Fragment 156”, The Classical Quarterly, 13, 1963, pp. 26-29.
[xviii] Alain Badiou & Barbara Cassin, Il n’y pas de rapport sexuel, Paris: Fayard 2010, p. 81.
[xix] Heinz Wismann, Les avatars du vide, Paris: Hermann 2010, p. 65.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
[xx] Democrito ascrisse tre proprietà all’atomo: rhysmos, il ritmo, l’onda; diathigè – il toccare, il
contatto; tropè – il ritorno. Aristotele li tradusse nei suoi termini come schema, taxis, thesis, che in
latino sono diventati forma, ordo, positio. Si dovrebbe notare come tutte le descrizioni che
Democrito fornisce sono quelle di un movimento, laddove Aristotele si riferisce a uno stato.
[xxi] Disjecta, New York: Gove Press 1984, p. 113. Aveva già usato questo termine in Murphy, il
suo romanzo giovanile (1938) (“… naught than which, in the guffaw of old Abderite, nothing is
more real”), e ancora in Malone dies (1951).
(traduzione dall’inglese di Giuseppe Montalbano)
Mladen Dolar (1951) è un filosofo sloveno ed è membro della Scuola psicanalitica di Lubiana.
Dal 1982 insegna all’Università di Lubiana. Fra le sue pubblicazioni (in inglese), ricordiamo
soprattutto A Voice and Nothing More (Cambridge: MIT Press, 2006).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
Marx a lezione da Goldmann (e viceversa)
di GUIDO GRASSADONIO
All’inizio delle pubblicazioni del “Rasoio di Occam” si è svolto un dibattito fra Stefano Petrucciani
ed Ernesto Screpanti intorno al fondamento normativo del pensiero marxiano. In questo articolo,
Guido Grassadonio ne riprende alcuni spunti per svolgerli in una diversa direzione.
Per iniziare, provo a riassumere i termini del discorso già fatto da Petrucciani e Screpanti, per poi
introdurre i miei argomenti. Sia comunque chiaro che l'atto di riassumere è sempre interpretazione
e riqualificazione dei concetti usati in funzione diversa. Non si rimanga allora stupiti se in qualche
punto il mio linguaggio divergerà da quello di Screpanti e Petrucciani.
Il problema posto nel botta e risposta è semplice da spiegare: posta un'innegabile tendenza morale
nelle opere di Marx, qual è il fondamento filosofico su cui potere articolare tale tendenza, senza
tradire la loro coerenza. Marx voleva essere un pensatore “scientifico”, le cui proposizioni erano
meramente descrittive, eppure ha anche fondato un dover essere preciso e fatto ricorso a giudizi
morali sul presente abbastanza netti. Come, infatti, può una teoria sullo sfruttamento essere solo
descrittiva? Chiaramente è anche un giudizio di valore. Ma questo valore come lo fondiamo,
mantenendo un rapporto forte col momento descrittivo?
Occorre, allora, indagare il pensiero marxiano come un pensiero anche morale, forzando i limiti
voluti dallo stesso Marx. Ora, il tentativo di trovare un fondamento etico possibile in una teoria
della giustizia appare quantomeno arduo. Soprattutto perché, a mio parere, tradisce totalmente
l'impianto teorico del Moro, che come nota bene Screpanti – ma anche Petrucciani ne è cosciente –
è più orientato verso una teoria della libertà di stampo hegeliano. Screpanti ritiene che tale teoria sia
limitata al pensiero del giovane Marx e che vi sia una cesura con tutto ciò nelle opere mature. Come
si vedrà non concordo con tale diagnosi, perché ritengo piuttosto che con le Tesi su Feuerbach
Marx abbia semplicemente aperto la strada ad un autentico superamento della dialettica hegeliana,
che va oltre il tema del rovesciamento materialistico. Ma non voglio anticipare troppo il discorso.
Che si parli di libertà o di giustizia, Petrucciani ritiene a ragione che il problema della coincidenza
fra descrizione e giudizio vada risolto. E, con precisione encomiabile, segnala tre vie possibili per
affrontare la questione.
Le soluzioni possibili sono:
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
1) risolvere il problema attraverso una via hegeliana: trovare in che modo oggettivo e soggettivo
possano coincidere nello stesso discorso. In altre parole, in che modo la descrizione di una tendenza
storica può fondare una critica alla stessa tendenza?
2) ammettere un certo grado di relativismo. Ogni giudizio di valore si fonda sopra un postulato.
Tale postulato, in quanto tale, non è dimostrabile e va assunto o respinto. Quindi dovremo
aggiungere accanto all'analisi dei fatti marxiana, un insieme di postulati che ne sorreggono
l'impianto morale.
3) riferirsi ad una normatività esterna al pensiero di Marx. È possibile, cioè, costruire un'etica
normativa su basi filosofiche ben diverse, ad esempio sulla base dell'analisi del linguaggio umano
(Habermas, Apel). Si tratta poi di integrare questa filosofia morale al pensiero di Marx,
evidentemente inadeguato sotto questo profilo.
Petrucciani rifiuta con forza la seconda ipotesi, perché ritiene che l'affidarsi a postulati non sia che
una scappatoia a basso costo. Ognuno, infatti, può farsi i suoi ed il discorso filosofico perde di
senso o quantomeno di valore.
Anche la prima ipotesi viene scartata perché si considera difficile che ne esca davvero qualcosa. La
terza, invece, nonostante le evidenti difficoltà, è per Petrucciani la strada da prediligere.
Il mio lavoro verte, al momento, attorno allo studio delle opere di Lucien Goldmann, filosofo e
sociologo marxista, che ha partecipato al dibattito filosofico internazionale dalla metà degli anni ’40
fino all'anno della sua morte (1970). Non posso certo riprendere qui l'insieme del lavoro di
ricostruzione del suo pensiero, ma volevo in qualche modo introdurre nell’arco del dibattito la
soluzione suggerita da Goldmann del problema posto da Petrucciani e Screpanti. In fondo,
Goldmann già negli anni ’50 poneva come centrale il problema della coincidenza fra descrizione e
giudizio di valore.
In quale dei tre riquadri, delle tre possibili soluzioni, possiamo inscrivere la proposta
goldmanniana? Essendo egli soprattutto un grande interprete della filosofia espressa dal Lukács di
Storia e coscienza di classe, siamo portati ad inquadrarlo nella prima casella. Ma la soluzione
hegelianeggiante proposta da Goldmann – e costruita sopra un'attenta esegesi delle 11 Tesi su
Feuerbach – ha la caratteristica di “inghiottire” anche la seconda casella. In questo, qualsiasi sia il
valore che se ne voglia dare, sta sicuramente l'originalità del suo pensiero: la coincidenza fra
descrivere e dover essere si radica in una scommessa.
Ovviamente, la scommessa è qualcosa di diverso da un postulato ed è per questo motivo che non è
possibile, secondo me, dire che Goldmann stia tra la soluzione 1) e 2). Quel che è possibile dire è
che nel suo modo di cercare una soluzione di tipo hegeliano, spiega fino in fondo anche cosa voglia
dire affidarsi ad un “postulato morale”.
L'idea di Goldmann è quella di definire la posizione di Marx come un monismo, un «monismo
immanentista», se vogliamo restare all'ottima descrizione data più recentemente da Costanzo Preve.
Che vuol dire? “Monismo” è qui un modo per segnalare la differenza fra Marx ed Hegel (ma anche
fra Marx ed il materialismo). Hegel, sappiamo, pone la coincidenza fra soggetto ed oggetto. Ma
nella coincidenza dei due momenti, possiamo dire vi è un momento dominante che riesce a risolvere
l'altro in se stesso: è il soggetto a «mangiarsi» l'oggetto (la metafora del «mangiare» stavolta la
desumo da E. Bloch). Anche una critica “materialista” dell'hegelismo può cadere in soggettivismi
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
simili: ad esempio, se radica la propria dialettica attorno ad una nozione di uomo che è data al di là
della storia e dello svolgersi oggettivo degli eventi.
Può, però, esistere un'idea di coincidenza soggetto-oggetto orientata verso l'oggettivismo. Il livello
spirituale non sarebbe allora che l'esatto derivato di necessità strutturali o comunque oggettive,
contingenti. Su questo livello si pongono tutte le posizioni marxiste deterministe, scientiste o che
comunque annullano il momento della libertà soggettiva. Per Goldmann, esempi di oggettivismo
sono, in questo senso: lo stalinismo, lo spontaneismo, l'althusserismo, ecc. Anche alcune delle opere
pre-1845 di Marx ricadono in questa tendenza (mentre altre sono al contrario soggettiviste o
umaniste).
Ma, Marx, secondo l'autore, dalle Tesi in poi non parteggia né per l’una né per l'altra opzione. La
coincidenza soggetto-oggetto va intesa come momento in cui nessuna delle parti è dominante: si
tratta di monismo, appunto.
Cosa è l'uomo? L'uomo è ciò che si dà nell'immanenza dell'accadere sociale. Ma nel suo darsi ha un
momento riflessivo: è materia che riflette ed orienta la propria prassi. I soggetti individuali ed i
soggetti sociali – non c'è qui spazio per tratteggiare a dovere la nozione di soggetto transindividuale in Goldmann – agiscono all'interno di condizioni date, ma sono in grado di riflettere su
di esse ed in questo modo determinano nuove condizioni (si cfr. qui la terza Tesi su Feuerbach).
Come ha notato E. Balibar in La filosofia di Marx – la cui affinità su questo tema con Goldmann
sarebbe probabilmente impensabile negli anni '60 –, Marx pone la coincidenza fra theoria, praxis e
poiesis. Quello che penso, faccio e produco s'inscrive completamente all'interno del complessivo
agire sociale .
Questo dovrebbe, in realtà, indurre a mettere in discussione i termini di soggetto, oggetto e praxis:
la rottura con lo hegelismo infatti è, a mio parere, così forte da essere resa opaca dal mantenimento
di tali categorie così come sono. A mio parere, fra l'altro, questo si lega anche alla decisione di
Marx di abbandonare un certo tipo di tematiche e di linguaggio. Si tratta, però, di un tema
complesso, che non posso ridurre qui se non al prezzo di dimenticare quali sono le ragioni per cui
effettivamente Goldmann le mantenga. Preferisco allora concentrarmi nel mio percorso ed arrivare
rapidamente al dunque.
Sì, perché si sarà osservato che siamo ancora lontani dall'avere espresso una soluzione al problema
del fondamento morale del marxismo, mentre abbiamo sottobanco reinserito nel discorso il tanto
vituperato concetto dialettico di «totalità». Si tratta di una nozione che dopo la frantumazione della
teoria emancipativa nella proliferazione dei “discorsi” voluta dal post-modernismo trova una sua
difficile giustificazione all'interno del dibattito attuale. Inutile però negare la sua centralità
all'interno del discorso goldamanniano, anche se Goldmann lo interpreta, come vedremo fra poco,
in una maniera decisamente originale.
Va subito precisato che Goldmann propone una correzione al discorso marxiano/lukacciano intorno
alla coincidenza soggetto-oggetto. Per lui essa è possibile, ma sempre e soltanto «parzialmente».
Ma che vuol dire nella pratica che soggetto ed oggetto coincidano? Vuol dire che, ad esempio,
quando studio i fatti umani, essendo anche io un uomo, studio un complesso di fattori entro cui vivo
anche io. Non soltanto: studio un complesso di fattori che possono variare grazie al mio agire o
all'agire della classe di cui faccio parte e che muta anche semplicemente in base al sapere che ho
prodotto (secondo una direzione che, però, non è detto sia quella da me voluta).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
In questo senso, per farla breve, un discorso oggettivo non è possibile e dietro ogni descrizione ci
sta sempre un giudizio di valore. Là dove non sembra esserci, il giudizio in realtà è semplicemente a
favore di un mantenimento necessario dell'ordine vigente. Dietro il semplice catalogare gli eventi,
sta sempre una postulato legato a un insieme di valori e a una visione del mondo (Goldmann
preferisce usare raramente l'espressione Weltanschauung).
La visione del mondo non è che l'idea di come si connettano (o non si connettano) i vari momenti
della vita sociale. Si tratta della succitata idea di Totalità. Ma posta in questo modo, si capisce
perché Goldmann insista a non volerla definire come un concetto. Si tratta più che altro di un
presupposto gnoseologico-esistenziale: per orientare il pensiero faccio sempre riferimento ad un
visione del mondo, anche se la metto, magari, costantemente in discussione.
Ed accanto questa visione del mondo, ritrovo, come detto, un sistema di valori che serve,
quantomeno, ad indicarmi cosa, dell'enorme numero di elementi che mi circondano, sia
significativo e cosa no.
E dato che pensiero, prassi e produzione coesistono nello stesso livello, sarà all'interno dell'agire
sociale, della prassi sociale condivisa, che il mio pensiero, la mia prassi e la mia produzione, ovvero
le mie istanze soggettive, troveranno conferma o no. È nel mondo reale che un agire (teorico o
pratico che sia) trova la sua funzione. Tenendo presente che la coincidenza soggetto-oggetto sarà
sempre e comunque parziale, rendendo impossibili quelle situazioni «apocalittiche» (per citare lo
stesso Lukàcs) di coincidenza assoluta fra descrizione e valutazione che sono presenti in Storia e
coscienza di classe.
Per questi motivi, Goldmann recupera con grande energia e fatica intellettuale la nozione pascaliana
di scommessa. Le pari pascalien viene inserito nella dialettica come suo motore. Il marxismo
diventa, allora, il primo pensiero capace di comprendersi per quello che ogni pensiero è: una
scommessa su un sistema di valori, su una configurazione possibile del tutto sociale e su una
funzione che la nostra prassi può avere nel riconfigurare quello stesso mondo.
Molte precisazioni da fare sarebbero ancora da fare, ma mi limiterò solo ad alcune di esse:
1) La nozione di scommessa non va intesa come se stessimo dinanzi a una roulette. Si scommette
sapendo che la “vittoria” o la “sconfitta” passeranno attraverso i nostri corpi e le nostre azioni. È
dunque in gioco anche il principio di responsabilità;
2) Le varie posizioni soggettive, nonostante siano in grado di determinare nuove configurazioni
sociali, sono anche determinate dalle stesse. Si tratta indubbiamente di uno dei momenti più
complessi e problematici del pensiero goldmanniano.
3) La forma sintetica con cui ho esposto i concetti, che spero non mi abbia portato a fraintendere il
pensiero di Goldmann, mi ha costretto a utilizzare esempi soggettivo-individuali. Per Goldmann
tuttavia sono decisive le tendenze dei soggetti sociali.
Detto ciò, resta la domanda, su quale sistema di valori scommetta Marx. Ovvero, posto che il suo
pensiero sia il risultato di una scommessa su una rivoluzione possibile e su una configurazione
particolare del tutto sociale, radicata nella posizione sociale espressa dal proletariato dalla metà fino
alla fine dell’800, quali sono però i valori sui quali egli insiste?
Per Goldmann, la risposta è semplice: un’idea di libertà che si incarna in una comunità umana
autocosciente ed autodeterminata. Più concretamente, una società dove siano possibili controlli
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 3 – ottobre 2013
democratici dei processi produttivi, forme di organizzazione del lavoro votate all'autonomia ed
all'autodeterminazione.
Tornando ad una terminologia più hegeliana, sarebbe l'idea di una prassi autocosciente. In questo
senso, al contrario di Screpanti, Goldmann (ed io con lui) vede una continuità fra il concetto di
libertà del giovane e del vecchio Marx. Continuità con un forte elemento di discontinuità che pone
anche nuovi problemi teorici: parlare di una prassi autocosciente vuol dire parlare della coscienza
come di qualcosa che si dà nel pratico e non (soltanto) nel momento spirituale. Se le nuove
tecnologie di comunicazione propongono idee innovative rispetto alla possibilità di organizzare
orizzontalmente lavoro e comunicazione, sappiamo bene che la soluzione resta problematica. A tali
problemi del passaggio da una configurazione utopica ad una concreta, Goldmann non dà altre
soluzioni se non attraverso il manifesto interesse per le opere degli anni ’60 di Vittorio Foa o
attraverso il – risibile se visto con gli occhi di oggi – sostegno al sistema cooperativistico jugoslavo.
Pur con tali limiti, credo si possa dire che Goldmann offre una via alternativa a quella prevista da
Petrucciani. Una soluzione che non si radica tanto nella filosofia morale, quanto nell'epistemologia
hegeliana (e pascaliana). Una soluzione che reintroduce parole d'ordine come autogestione,
orizzontalità ed organizzazione dal basso che possono essere care anche a un marxista di
orientamento più libertario come Screpanti.
Guido Grassadonio è dottorando all'EHESS con una tesi su Lucien Goldmann. Ha pubblicato
anche Libertà, Prassi, Soggettività. La filosofia di Marx, Malatempora 2013.