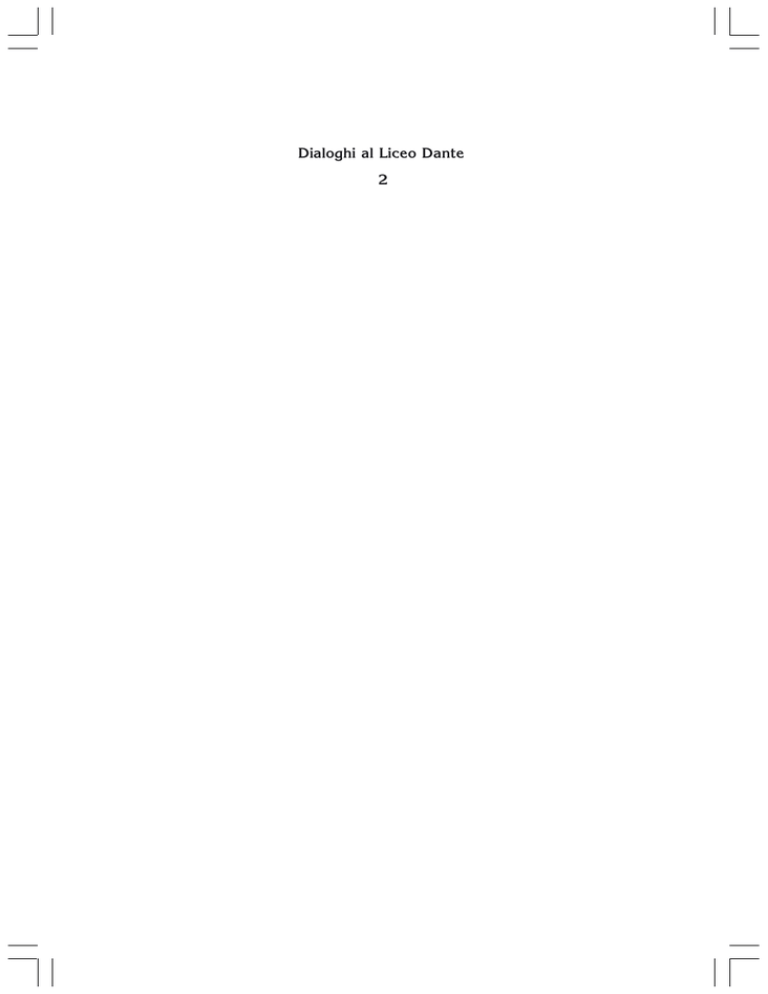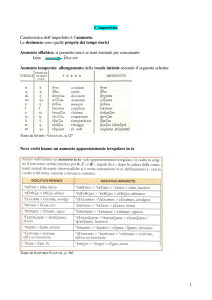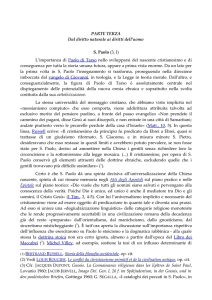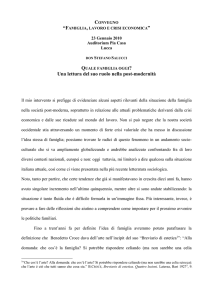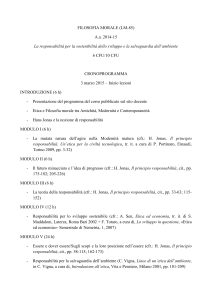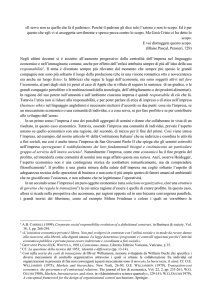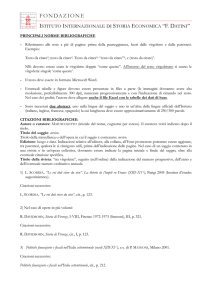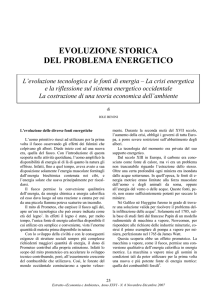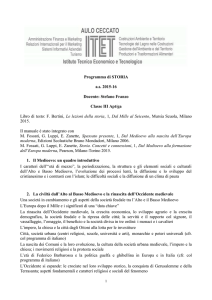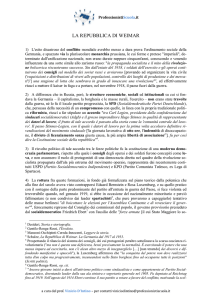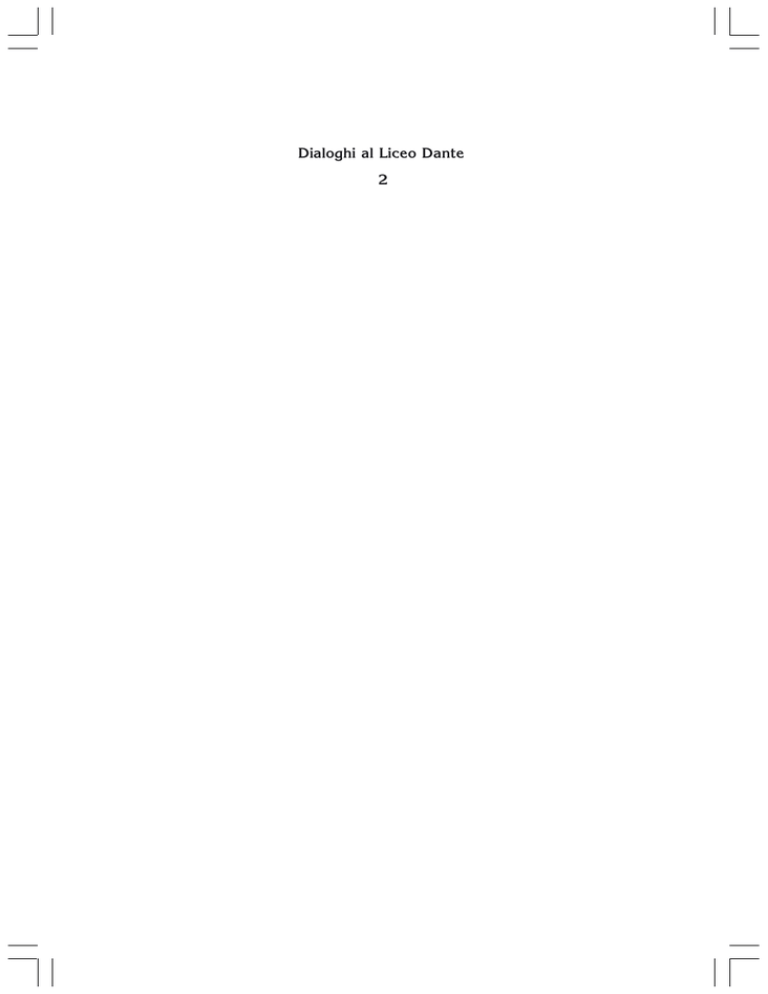
Dialoghi al Liceo Dante
2
B. BIANCHI - F. BRANDMAYR - R. COSIMI
F. CREAZZO - D. STROPPOLO - M. ZOCCHI
DIALOGHI
AL LICEO DANTE
pagine di cultura e didattica
numero 2
Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri”
Trieste 2011
Prima edizione: novembre 2011
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge
© 2011 Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri”
via Giustiniano 3 - 34133 Trieste
www.liceodantets.it
pubblicazione realizzata da:
LINT Editoriale srl - Trieste
www.linteditoriale.com
ISBN 978-88-8190-234-7
Indice
Nota introduttiva di Federico Creazzo .............................. »
7
Anestetismi musicali. Breve saggio sull’utilizzo ideologico della musica (Daniele Stroppolo) ................................... »
11
Medioevo: un pregiudizio secolare che perdura nel discorso comune? Esercizi di decostruzione alla luce delle
scienze sociali (Franz Brandmayr) ....................................
»
37
Nessuno è come sembra. Breve saggio sulla letteratura migrante (Brigitta Bianchi) .........................................
» 117
Dal sapere letterario al “saper essere”: sviluppare una competenza interpretativa (Raffaela Cosimi) ..........................
» 129
Diario di una settimana di scuola diversa dal solito
(Marco Zocchi) .....................................................................
» 153
5
Nota introduttiva
di Federico Creazzo
Difficile non è sapere, ma saper far uso di
quel che si sa.
Han Fei Tzu (280-233 a.C.)
A circa un anno di distanza dal primo numero, ecco il secondo
volume dei “Dialoghi al Liceo Dante”, frutto anch’esso della collaborazione tra i docenti della storica istituzione scolastica triestina. Vincendo la tradizionale ritrosia ad apparire in vesti diverse da
quelle della quotidiana mediazione didattica, gli autori di queste
pagine propongono ai colleghi, ai genitori e a tutti i lettori interessati e di buona volontà, le proprie riflessioni sui più diversi aspetti
della formazione culturale e didattica, ciascuno secondo un personale percorso di ricerca e di approfondimento, spesso legato
agli stimoli – ma anche alle difficoltà – dell’azione didattica svolta
in classe. Si tratta, in alcuni casi, di pagine tratte da un immaginario diario di bordo, in cui i docenti annotano a futura memoria,
propria e dei colleghi, le piccole o grandi scoperte fatte durante la
non facile navigazione didattica, le strategie ma talvolta anche le
trovate “tattiche” e i paradossi di cui si servono per motivare gli
alunni all’ascolto, per rendere efficace una lezione, interessante
un argomento. Il confronto, il dialogo e la condivisione di tali
esperienze è una pratica decisamente virtuosa in una scuola che
cerca di ridefinire la propria immagine (e funzione) e per evitare
di essere semplicemente al traino di conformistiche e a volte
deprecabili tendenze sociali e di costume, in un’epoca che forse
più di ogni altra sembra aver smarrito i necessari riferimenti valoriali
e culturali. È convinzione di chi scrive che la scuola potrà tornare
7
Federico Creazzo
a essere per gli alunni (e cittadini!) un fecondo laboratorio di ricerca e formazione solo se anche i docenti sapranno più spesso
abbandonare la sicura terraferma delle pratiche consolidate e sempre più “burocratiche” e accettare l’azzardo del mare aperto della
ricerca e del confronto.1
Con ciò non si intende svalutare il ruolo svolto dall’esperienza, ma affermare che essa sarà tanto più efficace se saprà evitare
pratiche ripetitive e demotivanti, se saprà sfuggire al pigro
ripiegamento nella routine.
Questo volume, senza eccessive ambizioni, ma con onesta
convinzione, si muove nella stessa direzione che la maggior parte dei docenti vorrebbe imprimere alla scuola italiana del futuro: una scuola decisamente colta per non cadere nella soddisfatta insipienza del “tempo del mercante”, ma che al tempo stesso
non fa del suo sapere mummia o reliquia del passato. Una scuola
che dà voce al pluralismo degli stili didattici, e valorizza le differenze come una ricchezza da proporre allo studente, come un
antidoto contro la minaccia di un presente senza spessore.
Il cosiddetto comitato di redazione della rivista costituito dai
docenti “pionieri” di questa esperienza ormai giunta al suo secondo traguardo, ha a lungo discusso intorno all’opportunità di
caratterizzare la forma editoriale della pubblicazione, e cioè se
si dovesse predeterminare la tipologia e la distribuzione dei contributi secondo un criterio certo, o se piuttosto la rivista dovesse rimanere un contenitore neutro e aperto. Alla fine si è optato
per la seconda ipotesi. Ciò ha favorito la più ampia partecipazione da parte dei colleghi della scuola i quali hanno potuto
proporre con la massima libertà i loro contributi. Per involontaria alchimia questo secondo numero ha assunto una fisionomia
esattamente complementare al primo. Tanto in quello dominavano i contributi teorici, quanto in questo prevalgono i saggi di
1
8
DE LUCA E., Opera sull’acqua e altre poesie, Einaudi, Torino 2002, passim.
Nota introduttiva
carattere didattico. È mia speranza che in futuro i “Dialoghi al
Liceo Dante”, pur mantenendo la forma aperta di cui abbiamo
apprezzato i vantaggi, possano ospitare delle rubriche fisse dedicate a eventi musicali, teatrali e cinematografici, data la grande importanza che queste forme espressive hanno assunto nella
paide…a dell’uomo contemporaneo e di cui anche la scuola dovrebbe tener maggiormente conto. Sarebbe bello, infine, se nei
prossimi numeri comparisse in appendice una sorta di tavola
rotonda (non troppo estemporanea) tra gli autori su uno o più
argomenti trattati nel libro, un modo, insomma, per dare ai temi
quel sapore vivo e dialogico che per Socrate era il contrassegno
autentico della ricerca.
Nell’anno della transizione, che doveva preludere alla creazione dell’ISIS “Carducci-Dante”, il dirigente scolastico Franco De
Marchi e il direttore dei servizi generali amministrativi Lucia
Napolitano, pur oberati da una mole non indifferente di lavoro
aggiuntivo, hanno guardato con grande simpatia a questo nuovo
tentativo di mettere in comune, oltre alla stima reciproca, i rispettivi interessi, le competenze e le conoscenze. Di questo noi docenti del “Dante Alighieri” siamo loro grati, come siamo riconoscenti a tutti i colleghi che ci hanno dimostrato il loro interesse e
a quelli che, per vari motivi, non hanno fatto in tempo a produrre
un loro contributo da aggiungere alla presente pubblicazione.
Auspichiamo che ciò possa avvenire in un prossimo volume,
magari unitamente agli apporti che – sicuramente – giungeranno
dai nuovi colleghi acquisiti in seguito alla fusione con il già Liceo
“Giosuè Carducci”.
Buona lettura!
9
Anestetismi musicali. Breve saggio
sull’utilizzo ideologico della musica
di Daniele Stroppolo *
1. Due cugini a confronto
Questo scritto è il prodotto di una riflessione che procede, a
strappi e pause, da molti anni, cioè da quando ero occupato
nella redazione della mia tesi di laurea che intendeva comprendere in che modo le teorie estetiche e musicologiche di Theodor Wiesengrund Adorno avessero influenzato la produzione
musicale italiana. A margine di quel lungo lavoro di catalogazione di articoli, interviste e biografie di musicisti e critici italiani, si
è radicata in me l’idea che le riflessioni di quel pensatore intimamente legato agli strumenti d’indagine del reale tipici del marxismo, ormai così demodé, fossero tutt’altro che obsolete e che anzi
il suo approccio ai prodotti musicali di consumo fosse terribilmente attuale; così ho approfittato dell’occasione di questo secondo numero dei “Dialoghi” per sfogliare nuovamente un paio
di quei saggi e per redigere uno scritto più o meno ordinato
sull’argomento. L’intento è quello di provare a osservare il grande
insieme della produzione musicale odierna e della sua fruizione
con uno sguardo influenzato dall’approccio critico che Adorno
aveva applicato alla sua realtà sin dalla pubblicazione del fonda-
* Docente di italiano e latino.
11
Daniele Stroppolo
mentale saggio Il carattere di feticcio in musica e il regresso dell’ascolto1,
pubblicato nel 1938.
Il testo adorniano viene redatto in risposta allo scritto del
suo cugino e collega di studi Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica,2 nel quale il filosofo tedesco
propone una riflessione sul cambio di qualità della fruizione
artistica dovuto al diffondersi di alcune tecnologie industriali
applicabili all’arte stessa. Benjamin delinea un fenomeno estetico che egli definisce «perdita dell’aura»: l’opera d’arte, grazie
alle possibilità tecnologiche della fedele riproduzione seriale è
destinata a emanciparsi dal proprio elemento sacrale, strettamente vincolato alla sua unicità:
Le opere d’arte più antiche sono nate, com’è noto, al servizio di
un rituale, dapprima magico, poi religioso. Ora, riveste un significato decisivo il fatto che questo modo di esistenza, avvolto da
un’aura particolare, non possa mai staccarsi dalla sua funzione
rituale. In altre parole: il valore unico dell’opera d’arte autentica
trova una sua fondazione nel rituale, nell’ambito del quale ha
avuto il suo primo e originario valore d’uso. Questo fondarsi,
per mediato che sia, è riconoscibile, nella forma di un rituale
secolarizzato, anche nelle forme più profane della bellezza. [...]
La riproducibilità tecnica dell’opera d’arte emancipa per la prima volta nella storia del mondo quest’ultima dalla sua esistenza
parassitaria nell’ambito del rituale. L’opera d’arte riprodotta di-
1
ADORNO TH. W., Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des
Hörens, in “Zeitschrift für Sozialforschung”, Paris 1938. Tale rivista era emanazione dell’Institut für Sozialforschung di Francoforte. Il testo del saggio fu poi
ripubblicato nel volume Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, Göttingen
1956; trad. it. Dissonanze, Feltrinelli, Milano 1959.
2
BENJAMIN W., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in
“Zeitschrift für Sozialforschung”, Paris 1936, poi in Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main 1955; trad. it. L’opera
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966.
12
Anestetismi musicali
venta in misura sempre maggiore la riproduzione di un’opera
d’arte predisposta alla sua riproducibilità.3
Secondo Benjamin, tale fatto implica una trasformazione dei
parametri estetici tout court paragonabile a quella avvenuta in
ambito letterario con l’invenzione della stampa:
Gli enormi mutamenti che la stampa, cioè la riproducibilità tecnica della scrittura, ha suscitato nella letteratura sono noti. Ma
essi costituiscono soltanto un caso, benché certo particolarmente importante, del fenomeno che qui viene considerato sulla scala della storia mondiale.4
Infatti, a suo modo di vedere, la riproducibilità tecnica consente
di creare un rapporto totalmente diverso tra opera e fruitore:
Mentre l’autentico mantiene la sua piena autorità di fronte alla riproduzione manuale, che di regola viene da esso bollata come un falso,
ciò non accade nel caso della riproduzione tecnica. Essa può, per
esempio mediante la fotografia, rilevare aspetti dell’originale che sono
accessibili soltanto all’obiettivo, che è spostabile e in grado di scegliere a piacimento il suo punto di vista, ma non all’occhio umano,
oppure, con l’aiuto di certi procedimenti, come l’ingrandimento o la
ripresa al rallentatore, può cogliere immagini che si sottraggono interamente all’ottica naturale. È questo il primo punto. Essa può inoltre introdurre la riproduzione dell’originale in situazioni che all’originale stesso non sono accessibili. In particolare, gli permette di andare incontro al fruitore, nella forma della fotografia oppure del
disco. La cattedrale abbandona la sua ubicazione per essere accolta
nello studio di un amatore d’arte; il coro che è stato eseguito in un
auditorio oppure all’aria aperta può venir ascoltato in una camera.5
3
BENJAMIN W., L’opera d’arte, cit., pp. 24-25.
Ivi, p. 20.
5
Ivi, pp. 22-23.
4
13
Daniele Stroppolo
Ecco quindi che si delineano due fondamentali questioni circa
le possibilità di fruizione dell’opera d’arte attraverso le sue riproduzioni: innanzitutto è da considerare che l’indagine analitica su un’opera può rendersi più approfondita grazie agli strumenti tecnologici che permettono non solo di crearne copie
fedeli, ma anche di decifrarne particolari altrimenti difficilmente percepibili. Secondariamente, l’opera perde parte della sua
unicità “andando incontro” al fruitore attraverso le proprie fedeli riproduzioni. È la «perdita dell’aura»:
L’autenticità di una cosa è la quintessenza di tutto ciò che, fin
dall’origine di essa, può venir tramandato, dalla sua durata materiale alla sua virtù di testimonianza storica. Poiché quest’ultima è
fondata sulla prima, nella riproduzione, in cui la prima è sottratta
all’uomo, vacilla anche la seconda, la virtù di testimonianza della
cosa. Certo, non soltanto questa; ma ciò che così prende a vacillare è l’autorità della cosa. Ciò che vien meno è insomma quanto
può essere riassunto con la nozione di “aura”; e si può dire: ciò
che vien meno nell’epoca della riproducibilità tecnica è l’“aura”
dell’opera d’arte. Il processo è sintomatico; il suo significato rimanda al di là dell’ambito artistico. La tecnica della riproduzione, così si potrebbe formulare la cosa, sottrae il riprodotto all’ambito della tradizione. Moltiplicando la riproduzione, essa pone
al posto di un evento unico una serie quantitativa di eventi. E
permettendo alla riproduzione di venire incontro a colui che ne
fruisce nella sua particolare situazione, attualizza il prodotto.6
Tale perdita si configura quindi come un’emancipazione dell’arte dal senso sacrale che ha sempre accompagnato ciascuna
opera proprio in virtù delle sue autenticità e unicità; la sottrae alla
sua «esistenza parassitaria nell’ambito rituale»7 inducendo il pub-
6
7
Ivi, p. 23.
Ivi, p. 27.
14
Anestetismi musicali
blico a fruirne attraverso la distrazione, intesa sia come svago o
divertissement, sia come percezione distratta, scarsamente concentrata: la riproduzione di un’opera non richiede quel rispetto che è
invece indotto dalla veneranda autorità dell’originale.
Benjamin intende leggere tali dinamiche in un’ottica ottimistica: il grande pubblico, soprattutto attraverso quelle forme d’arte nate già nell’alveo della riproducibilità e grazie a essa stessa
(la fotografia e ancor più il cinema), tramite una fruizione epidermica e fors’anche distratta, ma emotivamente partecipata delle
opere, avrà modo di sviluppare un atteggiamento valutativo che
mobiliterà le coscienze delle masse.
Adorno, invece, nel suo saggio ribalta tale assunto e intende
dimostrare che la riproducibilità tecnica, se non altro in ambito
musicale, ha prodotto risultati devastanti sul piano della capacità critica del pubblico, al punto da rendere del tutto privi di
significato i tradizionali criteri di gusto: l’arte, nell’epoca della
società di massa, non può più sottostare a criteri meramente
estetici, ma deve invece rispondere a esigenze etiche; è necessario quindi che la categoria del giusto sostituisca quella del piacevole. Questo in virtù del fatto che il soggetto moderno non è
più in grado di stabilire che cosa gli piaccia e che cosa non gli
piaccia, e il piacere che egli trae dalla musica risiede nel solo
fatto di riconoscere strutture o motivi già noti o equivalenti a
quelli noti. In un mondo in cui l’offerta è standardizzata, il criterio della preferenza diviene arbitrario. Il senso critico è ottuso
dalla continua stimolazione attraverso composizioni superficialmente piacevoli, ma incapaci di fornire un’autentica attrattiva
musicale rispettosa di criteri significativi; oppure dalla riproduzione di brani, di estratti da opere di ampio respiro che vengono
ridotti a orecchiabili e insignificanti frammenti:
Il piacere dell’attimo e quello della facciata variopinta diventano un pretesto per sgravare l’ascoltatore dal pensiero del tutto,
sempre presente e necessario in un ascolto esatto, e l’ascoltato-
15
Daniele Stroppolo
re viene mutato in compratore convinto sulla linea della minima opposizione. I momenti parziali non hanno più una funzione critica di fronte a un tutto preordinato, ma sospendono la
critica che la vera totalità estetica esercita nei confronti della
totalità incrinata della società. Viene insomma sacrificata loro
l’unità sintetica, ed essi non ne producono più una che sostituisca quella reificata, ma si mostrano condiscendenti proprio
verso questa. I momenti isolati di fascino sensoriale si dimostrano inconciliabili con la costituzione immanente dell’opera
d’arte e sacrificano ciò che innalza l’opera d’arte a conoscenza
vincolante: essi non sono cattivi di per se stessi ma per la loro
funzione smorzatrice. Servi del successo, si spogliano di quel
tratto di insubordinazione loro inerente, e si vincolano alla connivenza con tutto ciò che l’attimo isolato è in grado di offrire a
un individuo che è a sua volta isolato e da tempo non è nemmeno più un individuo. Nell’isolamento gli stimoli si ottundono e producono clichés tratti dal patrimonio corrente.8
La musica leggera e quella colta, quella definita comunemente
“classica”, finiscono quindi per assumere la stessa alienante funzione di intrattenimento meramente epidermico. Ciò non solo
per il fatto che tale fruizione è connaturata nella musica leggera e
può facilmente essere applicata anche all’ascolto di arie famose o
estratti celebri da opere più strutturate, ma soprattutto perché
l’ascoltare, opportunamente addestrato dalla radio, anche all’ascolto di una composizione completa, non è in grado di mettere in
funzione gli strumenti critici necessari per decodificare l’opera
nella sua interezza. L’ampio respiro di ogni sinfonia, di ogni opera lirica finisce per ridursi ad una serie spezzata di brevi spasmi
più o meno orecchiabili, e quindi più o meno piacevoli.
Rimane estranea a tale meccanismo la musica colta moderna, quella che oggi noi definiremmo d’avanguardia, la quale ha
scientemente rinunciato a ogni traccia di eufonia, di piacevolez-
8
ADORNO TH. W., Dissonanze, cit., p. 13.
16
Anestetismi musicali
za, in nome dello smascheramento della realtà, in nome della
riproduzione in suono dell’alienazione dell’io nella società moderna. Tale fatto, però, non le permette di penetrare con efficacia nell’orecchio ormai deteriorato dell’ascoltatore:
L’unità delle due sfere della musica è l’unità della contraddizione
insoluta. Il loro rapporto non va inteso nel senso che la musica
inferiore costituisca una sorta di propedeutica popolare per quella
superiore, o che quest’ultima possa riacquistare dalla prima la forza collettiva ormai perduta; il tutto non può essere ricostituito addizionando semplicemente le due metà separate con violenza, ma
in ciascuna di esse compaiono, sia pure in prospettiva, le modificazioni dell’insieme, che si muove esclusivamente entro la contraddizione. Nel momento in cui la fuga dal banale si fa definitiva e in
cui la smerciabilità della produzione seria, a causa delle sue esigenze reali, si riduce a nulla, nel campo della musica inferiore la standardizzazione del successo fa sì che non sia più possibile un successo alla vecchia maniera, ma solo la totale connivenza. Tra incomprensibilità ed inevitabilità non esiste un terzo anello: lo stato
delle cose si è polarizzato agli estremi che ormai realmente si toccano. Tra questi due poli non c’è posto per l’“individuo”, le cui
esigenze, ammettendo che ancora ne abbia, sono solo apparenti,
cioè ricalcate sugli standard stessi: la liquidazione dell’individuo è
il vero suggello del nuovo stadio della musica.9
La produzione disinteressata, colta, non commerciale produce quindi l’incomprensibile, l’imponderabile nel quale l’ascoltatore moderno non è in grado di entrare. D’altra parte non ha
neppure alcun interesse nel tentare di farlo, dal momento che i
suoi gusti sono stati debitamente appianati sullo standard dal
lavorio dell’offerta musicale di consumo. L’ascoltatore non è
più un individuo con i suoi gusti personali, ma un cliente che si
muove tra prodotti preconfezionati e che si illude di avere liber-
9
Ivi, p. 17.
17
Daniele Stroppolo
tà di scelta, mentre non può far altro che aderire alle imposizioni della grande industria scegliendo esclusivamente entro i confini di ciò che essa offre.
A fronte di questo ascolto sordo si sviluppa nell’ascoltatore
un tipo di fruizione musicale alienato e feticistico che investe
ogni ambito della produzione musicale: l’adorazione delle star,
siano esse cantanti di musica leggera o maestri d’orchestra, il
rispetto imbalsamato e fiacco per le grandi composizioni classiche, il culto del suono di uno Stradivari, il collezionismo di dischi, l’adorazione per cantanti d’opera dalla voce particolarmente
brillante (indipendentemente dalla qualità dell’interpretazione)
e così via. Tutto ciò che dovrebbe essere periferico diviene centrale, in quanto facilmente mercificabile e vendibile. La sostanza musicale, invece, rimane estranea, neppure sfiorata, oppure
banalizzata attraverso una percezione inefficace.
D’altra parte in una situazione così compromessa, anche l’intenditore, l’esperto, il musicologo e persino l’esecutore filologico finiscono per contribuire al compimento di questa enorme
degradazione dell’ascolto:
Il feticismo coinvolge anche l’attività musicale che vorrebbe essere seria e che mobilita contro la musica leggera elevata il pathos della distanza. La purezza e la fedeltà con cui essa presenta
le opere si dimostra spesso altrettanto ostile alla causa quanto la
depravazione dell’arrangiamento,10 e l’ideale ufficiale delle esecuzioni musicali, diffusosi in tutto il mondo in seguito alla straordinaria opera di Toscanini, è un nuovo ausilio a sanzionare e
convalidare uno stato di cose che, con le parole di Eduard Steuermann, può ben essere detto «barbarie della perfezione». È vero
10
Adorno si riferisce qui al fatto, enucleato nei precedenti paragrafi del suo
scritto, che molto spesso i mezzi espressivi della musica colta vengono raccolti e banalizzati negli arrangiamenti della musica leggera, divenendo così
strumenti volti ad un’enfasi precalcolata e falsa.
18
Anestetismi musicali
che qui non vengono più trasformati in feticcio i pochi nomi
delle opere più famose, anche se quelle meno famose che trovano posto nei programmi farebbero desiderare una simile delimitazione; è vero che qui non vengono più sbandierate ai quattro
venti le «idee musicali», che i grandi crescendi dinamici non hanno lo scopo di provocare una determinata fascinazione, e che vi
domina una disciplina ferrea: ma è appunto una disciplina ferrea. Il nuovo feticcio è l’apparato in sé, che funziona con perfezione e risplende come metallo, nel quale tutte le rotelline combaciano con tale regolarità che non resta più nemmeno uno spiraglio
per il vero senso dell’insieme. L’esecuzione musicale oggi impostasi, perfetta e senza macchia, conserva l’opera al prezzo di reificarla definitivamente. [...] Nel momento stesso in cui un’opera viene fissata a scopo di conservazione, essa soccombe proprio a questo processo di fissazione. L’estremo feticismo che afferra la cosa
la soffoca, e l’assoluta fedeltà all’opera smentisce l’opera stessa e la
fa scomparire con indifferenza dietro l’apparato.11
L’opera, fissata nella propria immagine perfetta, nella dinamica studiata minuziosamente, risuona come un blocco statico
e già dato, bene culturale privo di vitalità.
Al feticismo del mezzo, di qualsiasi mezzo, corrisponde un
regresso dell’ascolto. Il regresso non si attua a confronto di una
precedente situazione dello stesso individuo, né sarebbe possibile
parlare di una decadenza del livello complessivo, dal momento
che la situazione moderna di massificazione non è paragonabile
alle epoche precedenti. Il regresso dell’ascolto si compie invece
nel senso che il consumatore di musica ha una capacità di fruizione simile a quella di un individuo regredito, bloccato coercitivamente allo stadio infantile. L’assimilazione acritica di prodotti privi
di significato e ridotti a slogan atomizzati in brevissime dimensioni ne è il sintomo più evidente. Si consuma un’adesione al prodotto al fine di sentirlo proprio nonostante la sua estraneità, men-
11
Ivi, pp. 29-30.
19
Daniele Stroppolo
tre il meccanismo di immedesimazione con il divo popolare, irraggiungibile e al tempo stesso sempre vicino grazie alla sua onnipresente visibilità, allevia ogni senso di frustrazione nei confronti della propria impotenza sul mondo.
Il modo di ascolto imposto dal prodotto, al tempo stesso
promosso per una sua maggiore efficacia e necessario per la
sua riuscita, è quello della deconcentrazione. Pochi particolari, evidenziati a proposito, distinguono brani estremamente
simili gli uni agli altri e sempre uguali a se stessi, al punto che
un ascolto concentrato risulterebbe insopportabile. L’ascolto
atomizzato, che frammenta la musica superiore degradandola
ai suoi singoli elementi, è invece l’unico possibile nella musica
leggera, che è già frammentata in sé. L’aspetto che maggiormente colpisce l’ascoltatore alienato, incapace di cogliere l’essenza musicale, è quello del timbro, sintesi perfetta del feticcio del materiale, in questo caso lo strumento, e della ricezione facile, assimilabile a quella di un infante che predilige gli
oggetti particolarmente colorati.
Al piacere effimero dell’ascolto atomizzato corrisponde un
immediato senso di nausea, riscontrabile nel fatto che l’ascoltatore di musica leggera necessita continuamente di nuovi brani
in grado di fornirgli stimoli rinnovati, ma al tempo stesso sempre uguali a quelli precedenti. Vi è anzi un odio, un’ostilità marcatissima nei confronti di ogni novità sostanziale, che non può
essere tollerata in alcun modo. Addirittura spesso si ricorre a
citazioni di brani già noti affinché la novità possa risultare tale
senza richiedere alcuno sforzo.
Adorno chiude il proprio saggio con alcune considerazioni
dedicate all’autentica nuova musica, all’avanguardia e in particolare alla scuola di Vienna che aveva ideato la tecnica di composizione dodecafonica. La produzione musicale di Schönberg o
Webern risulta insopportabile al pubblico alienato non perché sia
incomprensibile, ma al contrario perché esprime in maniera fin
troppo diretta l’angoscia e lo spavento per una situazione cata20
Anestetismi musicali
strofica alla quale l’individuo integrato si può sottrarre esclusivamente regredendo. La musica di tali autori, definita dalla critica
conservatrice “individualistica”, è in realtà in rapporto dialettico
con le forze oggettive atte alla distruzione dell’individuo.
2. A complemento: On Popular Music
Gli studi di Theodor Adorno sulla musica di consumo proseguono in un altro breve saggio, pubblicato per la prima volta
negli Stati Uniti nel 1941: Sulla popular music.12 In questo nuovo
scritto vengono approfonditi alcuni aspetti specifici, più strettamente musicologici, che riguardano la struttura stessa della canzone commerciale. In particolare Adorno si sofferma sulle differenze che si evidenziano nel rapporto tra il particolare e la
totalità del brano nella musica di consumo rispetto a quella colta, che egli preferisce chiamare “seria”:
Nella buona musica seria in generale – non siamo interessati qui
alla musica seria cattiva, che può essere rigida e meccanica come
la popular music – il dettaglio contiene virtualmente il tutto e porta
all’esposizione del tutto, mentre, allo stesso tempo, esso è generato dalla concezione dell’insieme. Nella musica popular la relazione è invece accidentale. Il dettaglio non ha influenza su una
qualche totalità, che si presenta qui come uno schema generale
ad esso estraneo. Così, il tutto non è mai modificato dall’evento
singolo e perciò rimane, per così dire, lontano, imperturbabile,
inosservato per tutto il pezzo. Al contempo, il dettaglio è mutilato da un meccanismo che non può mai influenzare e modificare,
cosicché esso resta privo di conseguenze. Un dettaglio musicale
12
On Popular Music, in “Studies in Philosophy and Social Science”, vol. 9,
New York 1941; trad. it. Sulla popular music, a cura di Marco Santoro, Armando, Roma 2004.
21
Daniele Stroppolo
cui non è permesso di svilupparsi diventa una caricatura delle
sue stesse potenzialità.13
Secondo Adorno, quindi, ciò che nella musica colta è funzionale e consequenziale, nella musica di consumo diventa aleatorio e arbitrario. Nei richiami tra macrostruttura e microstruttura musicale si racchiude, secondo Adorno, lo spessore artistico di un brano. La sua configurazione complessiva deve dialogare con le sue melodie, con le sue scelte armoniche, con l’arrangiamento, con la dinamica. Tutto ciò, a suo modo di vedere,
viene annullato nella musica di consumo, che si struttura secondo forme standardizzate e rigide, riconoscibili anche nel momento in cui vi vengano applicate in modo posticcio forme
estrinseche di complessità, con precise ricadute sulla sua percezione da parte del fruitore e di conseguenza sul significato che
la musica assume:
L’ascolto della musica popular è consapevolmente trasformato, non
solo dai suoi promotori ma per così dire dalla natura intrinseca di
questa musica, in un sistema di meccanismi reattivi totalmente
antagonistici all’ideale di individualità in una società libera e liberale. Questo non ha nulla a che vedere con la semplicità e la complessità. Nella musica seria, ogni elemento musicale, anche il più
semplice, è proprio “lui”, e più l’opera è altamente organizzata,
meno possibilità vi sono di sostituzione dei singoli dettagli. Nella
musica di successo commerciale, invece, la struttura sottostante al
pezzo è astratta, esistendo indipendentemente dallo specifico sviluppo musicale. [...] L’orecchio tratta le difficoltà della musica di
successo facendo sostituzioni minime derivate dalla conoscenza
dei modelli. L’ascoltatore, quando è alle prese con il complicato,
ode in realtà solo il semplice che esso rappresenta e percepisce il
complicato solo come una distorsione parodistica del semplice.14
13
14
ADORNO TH. W., Sulla popular music, cit., p. 73.
Ivi, p. 75.
22
Anestetismi musicali
Così la musica di consumo si configura come il frutto di una
tensione duale: da una parte strutture conosciute e rassicuranti
con la loro costante presenza, strutture che il fruitore finisce
per ritenere connaturate alla musica in sé; dall’altra una serie di
variazioni di superficie che creano l’illusione del nuovo e che
danno all’ascoltatore/cliente l’idea di poter scegliere liberamente tra brani/prodotto diversi tra loro, ma che in realtà sono intimamente identici.
In condizioni così degradate d’ascolto, il successo di un brano rispetto a un altro dipende soprattutto dal suo plugging, ovvero da quanto esso sia “spinto” attraverso i media: il suo riconoscimento indotto diviene lo strumento principe per decretarne
ascolto, gradimento e vendita. Naturalmente, aggiunge Adorno, anche nella musica seria il riconoscimento è un passaggio
fondamentale per la fruizione della musica: il riconoscimento di
determinati temi e di certe strutture permette di individuare le
connessioni delle singole parti di una composizione con il tutto,
e della composizione con il suo genere d’appartenenza, con il
suo contesto di produzione e così via. Insomma, il riconoscimento è presupposto per la comprensione, al fine di far emergere il nuovo, la novità intrinseca al brano. Nella musica di consumo, invece, riconoscimento e comprensione coincidono, perché la profonda novità è bandita, e accolte sono invece esclusivamente quelle modulazioni che permettono di confermare
strutture già note. In questo modo viene promosso e rafforzato
un tipo di ascolto distratto e disattento, che diviene anche l’unico possibile per riuscire ad accettare la monotonia della popular
music senza incorrere nel tedio. Tale fatto implica precise ricadute sociali tutt’altro che innocue:
Nella nostra società attuale le masse sono intrise dello stesso
modo di produzione nascosto dietro il materiale manufatto che
viene loro rifilato. I clienti dell’intrattenimento musicale sono
essi stessi oggetti o, in effetti, prodotti dello stesso meccanismo
23
Daniele Stroppolo
che determina la produzione della popular music. Il loro tempo
libero serve solo a riprodurre la loro capacità lavorativa. È un
mezzo invece che un fine. Il potere del processo di produzione si
estende sugli intervalli di tempo che in superficie appaiono essere “liberi”. Essi vogliono beni standardizzati e pseudo-individualizzazione, perché il loro riposo è una fuga dal lavoro e allo stesso tempo è plasmato da quegli atteggiamenti psicologici ai quali
il loro mondo quotidiano del lavoro li abitua in modo esclusivo.
[...] Essi cercano il nuovo, ma la tensione e la noia associate al
lavoro reale induce ad evitare qualunque sforzo in quel tempo
libero che offre l’unica possibilità per esperienze realmente nuove. Come surrogato, essi chiedono insistentemente qualcosa di
stimolante. La popular music viene ad offrirlo. Le sue stimolazioni
si incontrano con l’incapacità di fare qualche sforzo nel sempreidentico. Questo significa ancora noia. È un cerchio che rende
impossibile la fuga. L’impossibilità della fuga produce il diffuso
atteggiamento di disattenzione verso la popular music. Il momento
del riconoscimento è quello di una sensazione senza fatica. La
subitanea attenzione associata a questo momento si brucia all’istante e relega l’ascoltatore in un regno di disattenzione e distrazione. Da un lato, il dominio della produzione e del plugging
presuppone la distrazione e, dall’altro, la produce.15
Non si deve però presupporre che l’ascoltatore di musica di
consumo sia totalmente inconsapevole rispetto ai meccanismi
produttivi e psicologici appena delineati; viceversa, il fruitore di
popular music è ben cosciente dell’intrinseca vacuità dei brani radiofonici e del loro mero scopo commerciale. Ed è proprio grazie a tale coscienza e al sentimento ambivalente suscitato da
essa che la sottomissione alla musica di consumo si attua al livello più profondo: accettarne le regole, accettarne la natura
significa vincere una resistenza interna nei confronti della consuetudine imposta:
15
Ivi, pp. 107-108.
24
Anestetismi musicali
Quando la popular music viene ripetuta ad un livello tale da non
sembrare più uno stratagemma ma un elemento intrinseco del
mondo naturale, la resistenza assume un diverso aspetto perché l’unità dell’individuo comincia a frantumarsi. Questo naturalmente non significa l’eliminazione completa della resistenza. Ma essa viene sospinta negli strati sempre più profondi della struttura psicologica. L’energia psicologica deve essere direttamente investita allo scopo di vincere la resistenza. Perché
questa resistenza non scompare del tutto cedendo a forze esterne, ma resta viva entro l’individuo e ancora sopravvive anche
nel momento dell’accettazione. Qui fa la sua drastica comparsa
il risentimento. [...] Per essere accettato, il materiale musicale
ha bisogno di questo risentimento. Il suo carattere di merce, la
sua predominante standardizzazione, non è così nascosta da
non essere percepibile. Esso richiede un’azione psicologica da
parte dell’ascoltatore. La passività da sola non basta. L’ascoltatore deve sforzarsi di accettarlo.16
Così ascoltare musica commerciale diviene un atteggiamento parallelo a quello di coloro che sostengono di guardare programmi televisivi di infimo livello pur riconoscendone perfettamente la pessima qualità. O meglio, proprio in nome di essa:
una fruizione che permette e anzi invoglia la distrazione, lo sguardo disattento, l’assopimento graduale e rassicurante. La distrazione fino all’incoscienza come risposta alla noia delle proprie
attività obbligate.
3. Obsolescenza?
Potrebbe sembrare del tutto inattuale riproporre uno studio sulla
produzione musicale degli anni Trenta del Ventesimo secolo,
con relativo compendio di poco successivo, e sulle capacità
16
Ivi, pp. 118-120.
25
Daniele Stroppolo
d’ascolto del pubblico di quell’epoca distante quasi un secolo
dal nostro presente. Eppure nella durissima analisi proposta da
Theodor Adorno si evidenziano problemi che non solo non
sono stati superati, ma si sono infinitamente esacerbati a causa
del progresso tecnologico; il quale, sosteneva Adorno stesso,
comporta non solo costanti miglioramenti in alcuni aspetti oggettivi dell’esistenza, ma implica anche continue rinunce sul piano
soggettivo e individuale, a causa del suo inevitabile portato di
violenza e di reificazione17.
Sotto il profilo della fruizione musicale è indubbio che all’ampliamento dell’offerta di apparecchi d’ascolto e al moltiplicarsi degli strumenti di registrazione e riproduzione sia corrisposta una mutazione, in negativo, sempre più radicale e irreversibile delle capacità di concentrazione e di penetrazione da
parte dell’ascoltatore nel testo musicale. Affinché queste affermazioni, però, non sembrino aleatorie, pregiudiziali o addirittura nostalgiche rispetto a un passato che, peraltro, è ormai estraneo all’esperienza diretta di ogni pubblico attuale, è opportuno
che l’argomento sia affrontato sul piano concreto.
Esiste un’affermazione, una frase particolarmente fortunata, tanto da essere diventata una sorta di moderno proverbio e
che spietatamente riassume l’odierno rapporto tra musica e ascolto: «Music is the soundtrack of your life.» È solitamente attribuita a un tale Dick Clark, uomo di spettacolo statunitense, speaker
radiofonico e presentatore televisivo. Al di là della paternità di
tale frase, è sicuramente interessante il fatto che essa abbia incontrato una tale popolarità da divenire una sorta di verità acquisita per ciascun ascoltatore di musica commerciale. Il termi-
17
Riguardo all’approfondimento di queste tesi è opportuno rimandare alla
lettura di A DORNO T H. W.-H ORKHEIMER M., Dialektik der Aufklärung.
Philosophische Fragmente, Amsterdam 1947; trad. it. Dialettica dell’illuminismo,
Einaudi, Torino 1966.
26
Anestetismi musicali
ne che connette music con life è soundtrack, ovvero colonna sonora. Accompagnamento. Sottofondo. E in effetti è questo il ruolo che la musica ha assunto nella società di massa: accompagnare il soggetto nel corso delle sue attività quotidiane; soprattutto
nel tempo libero, ma in taluni casi anche durante la propria attività produttiva. Ciò comporta una serie di implicazioni necessarie: la prima è che la musica trova un numero infinito di collocazioni. Una radio o una selezione musicale sono presenti nella
maggior parte degli ambienti commerciali, dove esse non siano
sostituite dalla televisione, la quale emette anch’essa una costante
“colonna sonora” composta dall’insieme dei motivi e dei jingle
che scandiscono la programmazione e la commentano. D’altra
parte anche nelle abitazioni private tendenzialmente si fa uso
degli stessi strumenti di compagnia: televisori e, meno diffusamente, radio o lettori musicali; con le stesse implicazioni. A ciò
si aggiunge il fatto che negli ultimi due decenni si è diffuso l’utilizzo sempre più frequente di apparecchi d’ascolto portatili (a
partire dagli obsoleti mangiacassette, per giungere ai lettori
multimediali ora in commercio, con l’aggiunta ulteriore degli
smartphone con le loro versatili applicazioni) che garantiscono al
soggetto un adeguato supporto sonoro in tutte le occasioni in
cui le attività non sono socializzate:18 un viaggio su un mezzo
pubblico, una passeggiata, una sessione di sport individuale. Non
di rado gli utenti più giovani utilizzano tali dispositivi anche come
strumento di socializzazione: una cuffia auricolare a testa e si
possono condividere le emozioni di un ascolto comune senza
arrecare alcun disturbo a chiunque altro si trovi nello stesso
ambiente. Poco importa se la compressione digitale delle tracce
18
E naturalmente anche in tutte le occasioni in cui il soggetto intende diminuire il proprio grado di socializzazione rispetto all’attività svolta: indossare
le cuffie auricolari significa spesso porre un volontario ed evidente limite
all’interazione altrui.
27
Daniele Stroppolo
e l’utilizzo di materiale scadente nella costruzione dei dispositivi di riproduzione e di amplificazione abbia tendenzialmente
fatto scemare la qualità del segnale d’ascolto: l’importante è la
diffusione sempre più capillare, con lo scopo che la nostra soundtrack personalizzata lasci sempre meno spazio al silenzio.
La costante presenza di una musica di sottofondo implica
una riduzione dell’attenzione su un doppio piano: quello dell’ascolto e quello della percezione del reale. Ad auricolari inseriti ci si muove immersi nella propria selezione musicale, e la realtà viene colorata, filtrata dalla musica; ogni tappa in bus diviene
la brutta copia di un film on the road, una corsa nel parco è la
riproduzione del massacrante allenamento di un prodigio nascente grazie all’American dream; e la dimensione del reale si riverbera di finzioni e citazioni, sbiadendo l’hic et nunc contingente e individuale in una dimensione standard e condivisa. Al tempo stesso la musica non può che essere sottofondo: il suo ruolo
è sempre relegato a quello di coro, di commento; la sua fruizione è puramente epidermica e sempre in relazione con un immaginario extramusicale che a sua volta colora e profuma la musica con toni e sfumature che non le appartengono. L’ascolto
concentrato, emancipato, non automatizzato diventa l’eccezione. E diventando eccezione, finisce per essere in costante dialogo con la fruizione da colonna sonora: chi decide di dedicare
parte del proprio tempo libero a un ascolto attento e non distratto deve in ogni caso forzarsi rispetto all’ascolto da sottofondo al quale è stato sicuramente ammaestrato attraverso la
presenza incessante di soundtrack nei luoghi pubblici e nei mass
media, quand’anche non sia tra i volontari fruitori di musica da
auricolare. E oltre all’influenza individualizzata rispetto al suo
personale modo di ascolto, il soggetto si trova anche in condizione di dover contrastare un ascolto ormai accettato come
modus principe di approccio alla musica dal punto di vista collettivo. La cultura odierna della musica è la cultura massificata,
standardizzata e volta alla fruizione di cornice.
28
Anestetismi musicali
4. Le musiche leggere
Si potrebbe obiettare che l’analisi di Adorno potesse essere valida alla metà del secolo scorso e non più oggi: la musica leggera
si è diversificata in un numero elevatissimo di generi e sottogeneri; esistono culture sotterranee e antagoniste che hanno fatto
proprio lo strumento della canzone, o della canzonetta, per esprimere messaggi di protesta e di denuncia del tutto non allineati
rispetto ai grandi poteri economici. L’industria musicale non è
più in mano a pochi grandi marchi generalisti, i quali addirittura
si trovano a fronteggiare una crisi di mercato che invece non
riguarda i prodotti musicali meno smaccatamente popular; i dischi si registrano e si stampano in piccoli laboratori; la distribuzione via Internet non comporta alcuna spesa e raggiunge immediatamente un mercato pressoché illimitato.
Ora, si tratta di obiezioni ragionevoli e sensate; tuttavia ciò
che non è cambiato è il prodotto musicale nella sua essenza, e di
conseguenza la sua funzione di ammaestramento allo standard.
Innanzitutto è opportuno sviluppare la questione sul piano strettamente musicale. In base ai propri gusti un ascoltatore è portato a preferire un brano rispetto a un altro, che può trovare noioso, indifferente o addirittura disturbante o rumoroso. Tale fatto
è notorio ormai da decenni, a partire dalla promozione di generi musicali quali il beat e il rock’n’roll, ritenuti poco orecchiabili
dal pubblico più conservatore e invece energici e vitali da quello
giovanile o giovanilistico. Credo che non sia necessario dilungarsi sul fatto che entrambi i generi citati non abbiano introdotto nulla di particolarmente innovativo rispetto alla musica commerciale precedente; fondamentalmente si tratta di un leggero
inasprimento dei timbri utilizzati e una moderata accelerazione
del ritmo di base; dal punto di vista vocale, soprattutto nel
rock’n’roll, vi è una minore presenza del controcanto in favore di
una linea melodica più asciutta, ma sempre perfettamente intelligibile nel suo andamento diatonico.
29
Daniele Stroppolo
Dal solo rock’n’roll si sono sviluppati diversi approcci alla
canzone, talvolta con esiti molto aggressivi sul piano timbrico: hard rock, progressive rock, heavy metal, punk rock, grunge, hard
core, grind core e così via. Elencare tutti i nomi che sono stati
assegnati a ciascun tipo di variazione diventerebbe quasi impossibile, oltre che tedioso; analizzarli in modo sistematico
secondo le caratteristiche di ognuno sarebbe compito più di
un’enciclopedia che di un articolo. È quindi necessario sottoporre la questione a una qualche forma di generalizzazione
che, spero, verrà compresa e giustificata.
Sul piano armonico la musica leggera si muove fondamentalmente all’interno della diatonia, in una scala maggiore o minore
ben definita e facilmente intelligibile dall’inizio alla fine del pezzo.
Praticamente assenti i cambi di tonalità, tranne per qualche semplicissimo escamotage quale l’innalzamento di un tono rispetto alla
scala di partenza alla terza o quarta ripresa del ritornello o poco
altro.19 Se l’armonia presenta accordi particolarmente carichi o
complessi, tale ricchezza si dimostra puramente posticcia, in quanto l’andamento generale del brano censurerà qualsiasi variazione
significativa rispetto al modello diatonico. A queste rigide norme
si rifanno anche generi considerati particolarmente rumorosi, quali
l’heavy metal o il punk: la loro aggressività è puramente timbrica,
mai strutturale. La dissonanza è bandita.
Quanto all’uso della voce, sul piano melodico sono ammesse ampie escursioni, a patto che siano evitate tensioni e dissonanze rispetto alla base musicale e che il cantante gestisca gli
intervalli, per quanto ampi, in modo tecnicamente ineccepibile
(non è tollerata un’imperizia che denoti sforzo o disagio, tranne
19
È ad esempio tollerato il passaggio da una scala minore alla corrispondente maggiore nel passaggio da strofa a ritornello, ma si tratta di espedienti tipici di alcune tradizioni (come la canzone melodica napoletana),
che in virtù di questo fatto vengono solitamente confinati nei rispettivi
generi d’appartenenza.
30
Anestetismi musicali
che in rari casi)20. Sul piano timbrico il discorso si fa più articolato: vi è ampio margine di tolleranza rispetto all’approccio canoro. Accanto a voci impostate e sicure da crooner si possono
ascoltare agili timbri tenorili, canti dimessi al limite del sussurrato, andamenti soavi e gole roche e consumate. Vi è un’apparente libertà in tutto ciò, che presuppone però un fatto che riguarda nell’insieme ciascuna voce ritenuta vendibile: il timbro dev’essere pieno, completo nei suoi armonici. Le voci più graffianti e “sporche”, come quella dell’italiano Vasco Rossi, o del
defunto Kurt Cobain dei Nirvana o ancora di Chester Bennington dei Linkin Park mantengono intatto il proprio spettro armonico anche nei momenti in cui esprimono il massimo livello
di rabbia: il loro “grido” dev’essere ben modulato e risultare
sempre perfettamente in focus rispetto alla nota emessa. Non
sono ammesse sbavature che denotino una mancanza di controllo o la perdita della maschera da cantante consumato: la performance non deve uscire dallo specchio della rappresentazione,
il grido dev’essere l’immagine melodica di un grido.
Sul piano ritmico l’andamento della canzone è regolare, scandito da un metronomo che relega eventuali rallentamenti o accelerazioni nel rango dell’abbellimento di cornice, usato esclusivamente in un eventuale finale particolarmente a effetto o in
simili funzioni periferiche. Le misure generalmente utilizzate
sono quella di 4/4 e quella di 3/4, sulle quali si possono proporre accenti diversi a seconda del tenore che si intende fornire al
pezzo. Quasi sempre il ritmo è scandito in modo molto netto e
chiaro da qualche strumento percussivo, acustico o elettronico.
20
Ancora una volta è necessario ribadire che le componenti in stretta minoranza rispetto a tendenze costituite e consolidate non esistono in quanto tali,
ma solo in rapporto al tutto: così il cantante pop imperfetto o leggermente
stonato è tollerato solo come variazione rispetto alla regola che presuppone
voci sempre piene e cariche di armonici, mai in difficoltà nell’esecuzione.
31
Daniele Stroppolo
Quanto ai testi, sarebbe impossibile riassumerne i contenuti
secondo una qualche forma di semplificazione; certo, esiste naturalmente una quantità incommensurabile di canzonette d’amore, ma è pur vero che esistono brani che riguardano gli argomenti più disparati. È interessante, invece, cercare di comprendere in che modo il testo interagisca con una musica siffatta.
Ribadendo che le strutture della musica leggera sono atte all’ottundimento dovuto a un ascolto distratto, disattento e paralizzato nello standard, diventa chiaro che un testo “impegnato”
viene sconfessato nel momento stesso in cui tenta di essere veicolato dalla forma-canzone. Cantare di utopie, di pacifismo o
di diritti delle minoranze nella forma del jingle musicale o della
hit da classifica significa mercificare e quindi reificare il messaggio stesso, che proprio in virtù del suo tramite viene svilito e
irriso. La canzone impegnata è la parodia di una canzone impegnata; l’effetto anestetico dell’apparato musicale esonda dal puro
suono per coprire il valore semantico della parola.
5. Mondi alternativi
Eppure, si potrebbe obiettare, non tutta la musica leggera rientra in questo quadro; esistono le autoproduzioni e le distribuzioni gratuite, che rifuggono in ogni modo dall’idea di profitto.
Esistono canzoni in cui il grido è vero grido e in cui la diatonia
o la regolarità dei due ritmi dominanti non è affatto rispettata.
Che succede di tutto quel movimento “alternativo” che tenta
autenticamente di resistere alle tendenze totalizzanti della musica di consumo? È opportuno affrontare questo punto con la
dovuta attenzione, dal momento che la questione è complessa e
articolata. Innanzitutto sarebbe opportuno fare chiarezza rispetto
al termine “alternativo”. Alternativo a che cosa? Moltissime band,
moltissimi cantanti mainstream vengono definiti alternativi dai
mass media, e scalano le classifiche grazie all’appoggio di qualche
32
Anestetismi musicali
grande marchio internazionale e a qualche buon contratto di
sponsorizzazione. Non è di questo tipo di musica che può essere interessante discutere nei termini espressi: in questo caso si
tratta semplicemente di un’etichetta di genere come può esserlo
qualunque altra, e il prodotto musicale rientra perfettamente
negli standard descritti precedentemente. Esiste poi un grande
movimento che si autodefinisce alternativo perché costretto
dall’industria musicale a rimanere ai margini: il confinamento
dovuto a scarsi mezzi economici o a performance non professionalizzate diviene oggetto di rivendicazione, ma la verità è che
tale movimento esiste solo in quanto retropalco dell’industria
dell’intrattenimento, la quale attinge da esso per trarne i prodotti più vendibili. Si tratta quindi di un circuito parallelo a
quello principale, con gli stessi intenti e lo stesso approccio,
ma che funziona secondo un sistema di investimenti ridotto;
nella speranza o meglio nella prospettiva che qualche suo ingranaggio possa essere raccolto e utilizzato entro il meccanismo di ordine maggiore.
Esistono infine musicisti che non possiedono alcuna velleità
di professionalizzarsi, che scrivono, eseguono e producono i
propri brani senza lo scopo del profitto, e che intendono muoversi con assoluta libertà rispetto ai canoni della smerciabilità
del proprio prodotto. Alcuni di essi, oltre che nelle intenzioni,
sanno distaccarsi dai parametri standardizzati della canzone commerciale anche nei fatti. Con quali esiti?
Naturalmente il primo problema è che l’esclusione dal grande circuito permette di utilizzare mezzi di esecuzione, registrazione e distribuzione di gran lunga inferiori rispetto a quelli a
disposizione dell’industria dell’intrattenimento. Ciò comporta
un livello di produzione molto spesso amatoriale e di scarsa rilevanza artistica. Ma tale fatto non costituisce una regola e si può
ammettere che una produzione di alto livello tecnico possa avvenire anche al di fuori del circuito mainstream. E in effetti in
alcuni dei brani composti ed eseguiti al di fuori del circuito com33
Daniele Stroppolo
merciale si riscontrano sostanziali differenze rispetto alle rigide
regole che governano la produzione allineata.
Per quel che concerne l’aspetto armonico si può riscontrare
una disinvolta emancipazione dalla diatonia e in molti brani vengono utilizzate anche dissonanze non risolte, con valore funzionale e non puramente accessorio. Sotto il profilo ritmico è
lasciato spazio a misure diverse da 4/4 e 3/4; talvolta si
avvicendano variazioni di misura significative durante il brano e
non mancano tempi composti e poliritmie. Riguardo alla vocalità,
si possono evidenziare fondamentalmente due distinti esiti del
canto: un canto melodico e uno gridato. Il canto gridato consiste in un’emissione vocale che non fa risuonare una nota in particolare, ma si risolve in una sorta di recitazione ritmica dai toni
esasperati. Esistono vari stili, catalogati con nomi diversi, per
questo tipo di vocalità; essa tenta di esprimere in modo diretto e
immediato uno sfogo di fronte al negativo. L’operazione, però,
sembra scontrarsi con la natura stessa della musica, che in quanto arte presuppone una mediazione tra quanto viene espresso
nell’opera e l’opera stessa. Il grido in sé non può essere musica
nella stessa misura in cui non può esserlo un qualsiasi suono
spontaneo e non mediato. Questa contraddizione non riguarda
solamente l’aspetto teorico della questione, ma anche le sue caratteristiche concrete. In particolare il suo andamento ritmico,
la sua cadenza musicale contraddice istantaneamente il suo tentativo di essere libero e liberatorio. Si tratta anche in questo caso
dell’immagine sonora di un grido e non di un grido in quanto
tale, e il suo tentativo mimetico rispetto a un’emissione spontanea ne evidenzia in modo inequivocabile il fallimento. Anche
sul piano timbrico la soluzione sembra insoddisfacente: al fine
di conservare la propria integrità fisica, il cantante che intende
eseguire il canto gridato deve sfruttare alcune tecniche di respirazione e di emissione che ne deformano la sonorità in una direzione facilmente percepibile come artificiosa e innaturale; di
conseguenza il grido non viene percepito come sfogo sponta34
Anestetismi musicali
neo, ma come l’imitazione parodistica di uno sfogo, un tentativo di riproduzione che oscilla in modo totalmente scisso tra
l’esternazione spontanea e una sua primitiva figurazione. Quanto al canto melodico, nella musica leggera non commerciale il
suo andamento non si distacca molto dalla canzonetta; e molto
spesso è proprio la linea melodica vocale a semplificare la comprensione armonica e strutturale del pezzo dimostrando il suo
diatonismo anche a fronte di qualche soluzione d’arrangiamento complessa e articolata. Infatti le dissonanze non risolte non
sono contemplate nell’andamento vocale, e dove esse sono presenti nella base strumentale la voce si fa da parte rimanendo in
silenzio o affidandosi a soluzioni puramente ritmiche (come
quelle del grido) o di commento attraverso una qualche forma
di recitato. Da questo punto di vista, quindi, le soluzioni della
musica underground più che sconfessare quelle della musica da
classifica sembrano confermarle per sottrazione.
Al di là degli esiti estetici in sé, sembra importante tentare di
comprendere se queste forme musicali non allineate promuovano un tipo di ascolto diverso da quello che viene inculcato
dalla musica commerciale; se, insomma, il loro insieme sonoro
esca effettivamente dagli standard imposti all’orecchio del
fruitore di musica popular inducendolo a un grado di attenzione
e di concentrazione maggiore; o se, invece, sia anch’esso appiattito nel ruolo di soundtrack dell’esistenza.
Ebbene, se anche alcuni aspetti della musica leggera non
commerciale si allontanano da alcuni logori aspetti di quella da
classifica, ve ne sono altri che invece conducono il fruitore a
schemi d’ascolto stereotipati: passività, distrazione, uso di
sottofondo. Vi sono infatti alcune componenti della musica non
colta che le sono, almeno allo stato degli sviluppi attuali, del
tutto connaturate: la diatonia nelle parti melodiche e l’uso di un
beat, di una regolarità ritmica che schematizza ogni metro in una
uniformità di fondo per cui l’uso di tempi composti, poliritmie
e tempi dispari (anche nei casi non frequenti in cui sono utiliz35
Daniele Stroppolo
zati) finisce per ridursi a una sorta di variazione attorno alle
pulsazioni sentite come necessarie e immanenti, ovvero il 4/4 o
in alternativa il 3/4. Questi elementi concedono all’ascoltatore
di non concentrarsi sulla musica, perché il suo fluire procede
con andamento rassicurante e all’interno di schemi armonici
riconoscibili, in modo che i suoi esiti non si emancipino mai
dalle aspettative standardizzate del fruitore.
Vi è inoltre un ulteriore aspetto non trascurabile della musica leggera nel suo insieme, che penetra strutturalmente anche nelle canzoni underground: il cliché di genere. Si tratta di scelte
timbriche e di costruzione dei brani, o anche di una determinata prevalenza di certi intervalli musicali nelle armonie e nelle melodie, o ancora dell’utilizzo di brevi fraseggi chitarristici
che fungono da unità minima del pezzo, i cosiddetti riff; questi
elementi introducono il fruitore in un sistema conosciuto, nel
quale le novità sono sempre puro contorno rispetto all’essenza del brano stesso. È in questo modo che si creano ascoltatori specializzati, frequentatori di determinati generi nei quali
essi si muovono a proprio agio riconoscendo stilemi precisi
che corrispondono perfettamente alle aspettative del fruitore:
un meccanismo di autorafforzamento che oscilla tra il rassicurante territorio conosciuto e l’introduzione periferica di novità marginali; lo stesso automatismo della musica da classifica,
con analoghi risultati sul piano dell’ammaestramento allo
standard conoscitivo.
36
Medioevo: un pregiudizio secolare che
perdura nel discorso comune. Esercizi
di decostruzione alla luce delle scienze sociali
di Franz Brandmayr *
1. Introduzione. Un contributo ab extra
La vita del medievalista potrebbe consumarsi
tutta nel raddrizzare torti: perché quasi sempre
i fatti, i testi del tempo, smentiscono le leggende
accumulatesi a partire dal XVI secolo e diffuse
soprattutto con il XIX secolo.1
Provengo da una formazione storica, anche se già prima degli
studi universitari (si era negli anni Settanta) i miei interessi antropologico-culturali si erano ben caratterizzati. Indirizzai poi decisamente le mie ricerche nel campo degli studi sociali, all’interno
dei quali mi sono mosso fino a oggi in maniera quasi esclusiva. In
ogni caso la storia ha continuato a rappresentare un mio interesse
costante, spesso anche ineludibile, tanto nella ricerca sociale,2
* Docente di I. r. c.
1
PERNOUD R., Medioevo. Un secolare pregiudizio, Bompiani, Milano 19985
(1977), p. 146.
2
Per una introduzione dal punto di vista dell’antropologia ai rapporti intercorrenti fra le scienze etnoantropologiche e la storia rinvio a BELLAGAMBA A.,
s.v. Annales, Scuola delle, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), Dizionario di
antropologia. Etnologia antropologia culturale antropologia sociale, Zanichelli, Bologna 1997, p. 49; COMBA E., s.v. Storia, ivi, pp. 709-710; CIRESE A.M., Cultura
37
Franz Brandmayr
quanto nell’attività di insegnamento della Religione cattolica,3 nella
quale è noto che essa debba intessere un confronto serrato con
altre discipline diacroniche (soprattutto con la Storia delle Religioni e con la Storia della Chiesa), oltre che, più in generale, con
tutte le Scienze delle Religioni.4
Ciò nonostante – come esplicito fin dal titolo – non vorrebbe essere quello prettamente storiografico l’angolo visuale di
questo contributo. Il mio vorrebbe configurarsi come un approccio antropologico-culturale alla “narrazione”5 del Medioevo nel discorso comune. Data la vastità del campo considerato,
proverei a sperimentare qualche forma di esercizio critico avvalendomi soprattutto di poche pubblicazioni (qualche manuale
scolastico e una sintesi divulgativa), prese quasi a caso dalla pletora di produzioni di qualità assai diversificata, che hanno per oggetto l’epoca medievale o qualche suo aspetto specifico.
egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale,
Palumbo, Palermo 19732 (1971), pp. 24-39; RIVIERE C., Introduzione all’antropologia, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 18-19; TULLIO-ALTAN C., Antropologia.
Storia e problemi, Feltrinelli, Milano 19852 (1983), pp. 267-304.
3
Dalle mie matrici culturali non ho ricavato una grande propensione a
soffermarmi sul dato autobiografico; tuttavia nell’ambito antropologico-culturale è divenuto ormai costume consolidato il farlo, allo scopo di esplicitare
al lettore, almeno indicativamente, le premesse teoriche di partenza e i possibili
condizionamenti che vi sono connessi [cfr. GEERTZ C., Opere e vite. L’antropologo
come autore, Il Mulino, Bologna 1995 (1992), pp. 85-86].
4
Cfr. BUCARO G., Filosofia della religione. La riflessione sul “senso” del fatto religioso
da Spinoza a Nietzsche, da Bloch a Eliade, Città Nuova, Roma 1986, pp. 13-15;
FILORAMO G.-PRANDI C., Scienze delle Religioni, Morcelliana, Brescia 19973 (1987),
passim; RAGOZZINO G., Il fatto religioso. Introduzione allo studio della religione, Edizioni Messaggero, Padova 1990, pp. 50-75; TERRIN A.N., Introduzione allo studio comparato delle religioni, Morcelliana, Brescia 1991, pp. 13-29.
5
Conferisco al termine tutta la pregnanza storiografica che gli deriva dalla riflessione dei Post-colonial Studies [cfr. ad es. CHAKRABARTY D., Storia delle minoranze, passati
subalterni, in ID., Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma 2004 (2000), pp. 135-155].
38
Medioevo: un pregiudizio secolare
In queste pagine cerco anche di configurare alcune linee ipotetiche di un possibile successivo lavoro di ricerca più esteso,
volto ad accertare con criteri anche quantitativi l’eventuale persistenza del pregiudizio antimedievale nel discorso comune. Nel
caso la presente riflessione dovesse portare a sviluppi di questo
genere, si renderebbe naturalmente necessario operare concretamente su un “terreno” accuratamente definito, come da consolidata tradizione antropologico-culturale.6
Tuttavia questo elaborato potrebbe risultare forse già apprezzabile anche sotto due altri profili: in prima istanza in una prospettiva didattica, in quanto esprimo il punto di vista del docente,
che da più di un quarto di secolo rileva – o ritiene di rilevare –
negli studenti la persistenza di una forte stereotipizzazione delle
conoscenze e delle competenze interpretative intorno al Medioevo europeo. Queste sembrerebbero – in buona sostanza – riprodurre pedissequamente i luoghi comuni che numerosi storici denunciano essere ricorrenti in tanta manualistica e pubblicistica
attuali. Pernoud scriveva già nel 1977 di «opere “storiche”» o addirittura di collane storiche scritte con «procedimenti giornalistici»7.
6
Cfr. ad es. BERNARDI B., Uomo cultura società. Introduzione agli studi etno-antropologici, Franco Angeli, Milano 19848 (s.d. orig.), p. 119; BIANCO C., Dall’evento al
documento. Orientamenti etnografici, C.I.S.U., Roma 1988, passim; «è proprio su questo punto che può individuarsi la distinzione fra ogni tipo di filosofia e ogni
tipo di antropologia culturale scientificamente valida: la falsificabilità delle proposizioni antropologiche e il suo carattere sperimentale» [TULLIO-ALTAN C., Manuale di antropologia culturale. Storia e metodo, Bompiani, Milano 1979 (1971), p. 573].
7
CARMO FELICIANI S., Introduzione, in DAWSON CH., Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, Rizzoli, Milano 19972 (1950), p. 6; PERNOUD R., op. cit.,
p. 145; cfr. PIVATO S., Vuoti di memoria. Usi ed abusi della storia nella vita pubblica
italiana, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 22, 26, 34, 74, 87-88, 129, 131 et alibi. Il
pensiero non può non correre ai giorni nostri, in cui – ad esempio – un
«libraccio» (F. Cardini) come Il codice Da Vinci viene accolto anche da un
soggetto laureato come una sorta di rivelazione esoterica (colloquio 1.1.
02.02.2006). Vd. anche infra nt. 291.
39
Franz Brandmayr
Peraltro la critica storiografica a queste produzioni di consumo è
destinata a rimanere confinata in riviste erudite8 e non riesce a scalfire il complesso stereotipico antimedievale sedimentato nell’immaginario collettivo, che – invece – di questa pubblicistica sembra
nutrirsi abbondantemente. Inoltre – più in generale – pare che questo senso comune pervada anche i cosiddetti ambienti colti.9
In queste rappresentazioni collettive10 il Medioevo costituirebbe, pertanto, proprio come asserivano gli umanisti, un periodo storico «vuoto» e «scadente»,11 un autentico «iato» fra due
epoche che sarebbero invece significative, quella classica e quella moderna. Per gli storici delle più svariate impostazioni è oramai acquisito il fatto che sia vero «il contrario»,12 ma le ricerche
scientifiche dell’ultimo secolo e mezzo13 sembrano non avere
ancora raggiunto il grande pubblico e – talvolta – neanche i
manuali scolastici;14 e – lo si sa bene – sono questi ultimi a rappresentare più efficacemente la «verità storica ufficiale»15. Al
posto della storiografia più avanzata potrebbe prevalere – è questa l’ipotesi antropologico-culturale che formulo, in vista di un
8
PERNOUD R., op. cit., p. 145; SANFILIPPO M., La storia in edicola: biografie, romanzi, gadget, in “Memoria e Ricerca”, gennaio-aprile 2007, passim.
9
LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario medievale, Laterza, Roma-Bari
19982 (1985), p. XVIII.
10
DURKHEIM E., Rappresentazioni individuali e rappresentazioni collettive, in ID., Le
regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Comunità, Torino 2001 (1898),
pp. 137-164.
11
LE GOFF J., Prefazione, in ID., Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Einaudi,
Torino 1977 (1976), pp. VII-VIII.
12
LE GOFF J., ivi, p. IX.
13
DAWSON CH., op. cit., pp. 23-24 scriveva questo già nel 1950; PERNOUD R.,
op. cit., p. 16.
14
Cfr. ibidem.
15
CONTI F., Massoneria e religioni civili. Cultura laica e liturgie politiche fra XVIII e
XX secolo, Il Mulino, Bologna 2008, p. 8.
40
Medioevo: un pregiudizio secolare
possibile rilevamento empirico sul campo – una sorta di
rielaborazione e di amplificazione mediatica;16 questa sembra
alimentarsi (anche questo andrebbe dimostrato con uno studio
sistematico) – oltre che di sintesi manualistiche – della
pubblicistica non-specialistica sopra menzionata, di documentari televisivi, di enciclopedie on line, in cui il controllo della produzione spesso sfugge a una selezione seria, e di altre opere di
divulgazione più o meno dilettantesche.17
Non nutro dubbio alcuno sulle gravose difficoltà insite nella
didattica della storia;18 io stesso le sperimento quando tento di
porgere dei contenuti la cui distanza culturale dal “mondo vitale”19 degli studenti è particolarmente marcata. È per questo motivo che invito i colleghi storici e/o insegnanti di storia o di altre
discipline interessate20 (la filosofia,21 le letterature italiana e straniere, la storia dell’arte ecc.) ad avviare un dibattito che prenda sul
serio il difficile compito del docente che si impegna a trasmettere
una certa sensibilità storica22 agli allievi, con un particolare riferi-
16
Cfr. PERNOUD R., op. cit., p. 149.
Ivi, pp. 9, 16, 145, 156 et alibi. Cfr. supra anche nt. 7 e infra nt. 291.
18
PIVATO S., op. cit., p. 37.
19
ABBAGNANO N., s.v. Mondo della vita, in ID., Dizionario di filosofia, U.T.E.T.,
Torino 19712 (s.d. orig.), p. 596; PARDI F., s.v. Soggettività, in DEMARCHI F.ELLENA A.-CATTARINUSSI B. (a cura di), Nuovo dizionario di sociologia, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 19943 (1987), p. 1986.
20
Cfr. PERNOUD R., op. cit., pp. 153 e 168. Devo ai colleghi e amici Paolo
Emilio Biagini, Brigitta Bianchi, Federico Creazzo, Lucia D’Agnolo, Silvia
Visintini e Marco Zocchi svariati stimoli e suggerimenti preziosi per la stesura di queste pagine: colgo qui l’occasione per ringraziarli. Va da sé che ascrivo
a me stesso ogni carenza di questo scritto.
21
Vd. ad es. PORCARELLI A., Insegnare la filosofia medievale. Stereotipi e innovazioni
didattiche, in http://archive.sfi.it/cf/cf4/articoli/porcarelli.htm.
22
Cfr. MARROU H.-I., La conoscenza storica, Il Mulino, Bologna 1988 (1954), p.
36; PERNOUD R., op. cit., p. 168.
17
41
Franz Brandmayr
mento all’epoca in questione. All’inevitabile semplificazione del
discorso storiografico congenito alla manualistica e alla sproporzione esistente fra la lunghezza dell’arco temporale considerato
nei programmi e le scarse risorse (misurate in unità orarie scolastiche, in pagine di libri di testo e altro ancora) disponibili per lo
studio del Medioevo,23 vengono spesso ad aggiungersi ancora tante
difficoltà: tra le altre quelle determinate dalla diffusa svalutazione
della storia,24 ma anche quelle originate da una cultura dominante
(non solo didattica) ossessionata dal problem solving,25 oramai incline a formare l’allievo al “saper fare” senza indurlo a concentrare
l’attenzione sul “perché fare”, cultura inoltre sempre meno propensa a cogliere le sfumature – di cui la narrazione storica è invece
solitamente ricca. Nel nome di una sorta di pragmatismo cognitivo
– infine – si spaccia talvolta per un attardamento passatistico26 la
presa in esame di tematiche che si presumono antiquate.
Su queste premesse della questione articolerei il mio discorso
focalizzando l’attenzione su un secondo obiettivo, in qualche modo
conseguente e funzionale al primo: ritengo che, per allentare la
presa del pregiudizio antimedievale, ci possa provenire un supporto epistemologico importante dalla strumentazione concettuale più “classica” delle scienze sociali.27 Gli allievi (ma, perché
23
Ivi, p. 153.
PIVATO S., op. cit., pp. 37-46.
25
Vd. ad es. CICATELLI S., Conoscere la scuola. Ordinamento didattica legislazione, La
Scuola, Brescia 2004, p. 117.
26
A questo proposito PERNOUD R., op. cit., p. 177 scriveva negli anni Settanta
che la scuola francese produceva soggetti «amnesiaci», che rischiavano di
diventare inabili all’esercizio della responsabilità e della libertà.
27
Per un’introduzione all’utilizzo delle prospettive concettuali antropologiche nella storiografia vd. LE GOFF J., Prefazione, cit., p. VIII; LE GOFF J.-NORA
P. (a cura di), Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia, Einaudi, Torino
1981 (1974), passim; BOGLIONI P., Introduzione, in MANSELLI R., Il soprannaturale
e la religione popolare nel Medio Evo, Studium, Roma 1985, p. XVI.
24
42
Medioevo: un pregiudizio secolare
no? forse anche qualche adulto…) potrebbero ricavarne qualche spunto per elaborare una sintesi (perché pur sempre di questo si tratta) autonoma sull’“Età di Mezzo”, una sintesi forse
meno inficiata da etichette categoriali,28 che credo non soddisfino adeguatamente le loro esigenze di comprensione29 di quest’epoca storica.
All’interno di questa trattazione riserverei ancora qualche
spunto all’intento di sensibilizzare i colleghi di storia o, chissà,
forse anche qualche storico30 circa l’opportunità di un ulteriore
approfondimento del dialogo metodologico fra l’antropologia
e la storia. È possibile che, in un futuro lavoro, una sorta di
complemento di queste riflessioni, io tenti di cercare una risposta a determinate aporie del discorso storiografico medievistico
operando una serie di confronti con i Subaltern Studies, i Postcolonial
Studies e con la corrente dell’antropologia critica.31 Non è impossibile che da ciò possa scaturire qualche suggestione valida
per affinare le metodiche scientifiche32 di approccio allo specifico medievale. Sotto questo profilo, del resto, non faccio che
28
Le etichette categoriali o etichettazioni sono espressioni che diventano «un
punto di ancoraggio per l’interpretazione di tratti di personalità e descrizioni
comportamentali ad essa associate» [ARCURI L., Percezione e cognizione sociale, in
ID. (a cura di), Manuale di psicologia sociale, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 128129]; mediante le etichettazioni viene poi attivata la memoria semantica del
soggetto, nella quale viene così innescata una serie di associazioni di tali
espressioni con altre che a esse si collegano. Cfr. infra nt. 65.
29
Cfr. infra paragrafo 3.
30
PERNOUD R., op. cit., p. 165, nt. 3 non sottace la differenza di formazione fra
gli storici, avvezzi al trattamento dei dati documentali, e gli insegnanti di
storia, che non sempre fanno esperienza in tal senso.
31
Per una prima introduzione vd. CHAMBERS I. (a cura di), Esercizi di potere.
Gramsci, Said e il postcoloniale, Meltemi, Roma 2006, passim; PASQUINELLI C. (a
cura di), Occidentalismi, Carocci, Roma 2005, passim; vd. anche infra nt. 171.
32
Cfr. MARROU H.-I., op. cit., p. 5, che scrive di una «filosofia critica della storia».
43
Franz Brandmayr
pormi al seguito di parecchi storici, che sottolineano la criticità
dell’utilizzo di categorie rigidamente e, talora, inconsapevolmente
etnocentriche nella ricerca storiografica.33
1.1. Limiti del saggio
Riuscire a fondare in poche decine di pagine un’ipotesi, che si
colloca sul versante opposto rispetto a quanto una plurisecolare rielaborazione mediatica (dapprima prodotta dalla letteratura polemica colta, poi – nell’ultimo secolo e mezzo – “discesa” al “livello”34 del senso comune) va alimentando, è senz’altro impresa improba. Va interpretata in questa prospettiva la
trattazione selettiva che seguirà, dalla quale potrà emergere
una versione consapevolmente migliorativa dell’Età di Mezzo; si tratterà di un’esposizione che – però – non intende suffragare alcuna «leggenda fantastica»35 sul Medioevo stesso. Do
pertanto per valida la ricerca storiografica precedente, anche
quella più scopertamente denigratoria,36 e propongo al lettore
di sostituire all’aut aut di un certo tipo di approccio, forse talvolta manicheo, un et et «multivocale» più in sintonia con l’orizzonte metodologico di certe correnti di pensiero delle scienze
33
Cfr. ad es. BURKE P., Cultura e società nell’Italia del Rinascimento, Einaudi, Torino 1984 (1972), p. 21; CHABOD F., Storia dell’idea di Europa, Laterza, RomaBari 20014 (1961), p. 18; GUREVIČ A.J., Contadini e santi. Problemi della cultura
popolare nel Medioevo, Einaudi, Torino 20002 (1981), p. 182; LE GOFF J., Prefazione, in ID., Tempo, cit., p. IX.
34
Rinvio ai concetti di “livelli di cultura”, “prodotto culturale”, “processo di
discesa/salita dei fatti culturali” (CIRESE A.M., op. cit., pp. 15-23 e ID., Dislivelli
di cultura e altri discorsi inattuali, Meltemi, Roma 1997, passim.
35
Cfr. ad es. DEDIEU J.-P., L’Inquisizione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2003 (1987), p. 6.
36
Ivi, pp. 76 e 77; MERLO G.G., Eretici ed eresie medievali, Il Mulino, Bologna
1989, p. 10.
44
Medioevo: un pregiudizio secolare
umane,37 ma compatibile – suppongo – anche con uno studio
storiografico aperto alla logica del Verstehen.38
All’inizio della ricerca avevo formulato una serie di ipotesi alla luce del «secolare pregiudizio» colto da diversi angoli
prospettici. In particolare, avevo pensato di occuparmi di
quattro ambiti o aspetti del preconcetto antimedievale: quello della solidarietà e dei diritti umani39, all’interno del quale
avrei considerato soprattutto i nodi problematici delle crociate40 e dell’Inquisizione,41 quello della condizione femminile, 42 quello della presunta ignoranza e, infine, quello del-
37
Cfr. CHAKRABARTY D., Storia, cit., p. 146.
Vd. infra paragrafo 3.
39
Intorno all’influenza del pensiero cristiano medievale ai fini dell’elaborazione della nozione di “diritti umani” cfr. FACCHI A., Breve storia dei diritti
umani, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 26-27, 37 et alibi. Altre indicazioni sull’incidenza del cristianesimo medievale sulla solidarietà sociale e sul tramonto
della schiavitù si trovano in BLOCH M., Come e perché finì la schiavitù antica, in
ID., Lavoro e tecnica nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 20013 (1947), pp. 221-63;
DOLZA L., Storia della tecnologia, Il Mulino, Bologna 2008, p. 51; FROMM E.,
Psicanalisi della società contemporanea, Mondadori, Milano 1987 (1955), pp. 9596; GUGLIELMI N., Il medioevo degli ultimi. Emarginazione e marginalità nei secoli
XI-XIV, Città Nuova, Roma 2001, passim; LE GOFF J., Il Medioevo. Alle origini
dell’identità europea, Laterza, Roma-Bari 20037 (1996), pp. 53-54; PERNOUD R.,
Le rane e gli uomini, in EAD., Medioevo, cit., pp. 87-99.
40
FLORI J., La cavalleria medievale, Il Mulino, Bologna 2002 (1998), passim; ID.,
Le crociate, Il Mulino, Bologna 2003 (2001), passim; HÖFFNER J., La dottrina
sociale cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19863 (1983), p. 237.
41
CARDINI F.-MONTESANO M., La lunga storia dell’Inquisizione. Luci e ombre della
“leggenda nera”, Città Nuova, Roma 2005, passim; DEDIEU J.-P., op. cit., passim;
MEREU I., Storia dell’intolleranza in Europa, Bompiani, Milano 1988, passim;
PERNOUD R., L’indice accusatore, in EAD., Medioevo, cit., pp. 119-142.
42
Vd. ad es. CONTE F., Gli slavi. Le civiltà dell’Europa centrale e orientale, Einaudi,
Torino 1991 (1986), pp. 161-201; DUBY G., Il potere delle donne nel Medioevo, Laterza,
Roma-Bari 2001 (1995), passim; LE GOFF J., Il Medioevo, cit., p. 105; cfr. anche
PERNOUD R., La donna priva di anima, in EAD., Medioevo, cit., pp. 101-117.
38
45
Franz Brandmayr
l’anticlericalismo43. A un certo punto dell’indagine questo progetto si è rivelato essere decisamente troppo vasto rispetto
alle caratteristiche della presente pubblicazione, perciò, ho
voluto ridimensionarlo notevolmente, limitandomi a considerare più in particolare una sola di queste tematiche e operando
– al limite – qualche digressione più o meno ampia con riferimento alle rimanenti piste di ricerca.
Fra le quattro opportunità ho inteso privilegiare quella offerta
dalla presa in esame della presunta ignoranza44 del Medioevo. I
topoi della staticità intellettuale e dell’oscurantismo retrivo, dell’incapacità innovativa in ambito tecnico e del supposto culto della
ripetizione in ossequio alle auctoritates sono fra i più significativi
nella rappresentazione del Medioevo e, se si vuole, sono anche
quelli che influenzano sensibilmente gli altri stereotipi, quasi dei
corollari, della brutalità e della prevaricazione della donna. Anche
il tema dell’anticlericalismo non potrà non emergere – fra l’altro –
anche per la strettissima correlazione che, notoriamente, intercorre fra la cultura medievale e l’ordo dei clerici.45
2. Falsificazione o selettività?
Humanas actiones non ridere, non lugere neque
detestari, sed intelligere.46
Dopo quanto premesso credo che, a fornire qualche spunto su
quanto già da molto tempo conosciamo intorno al Medioevo,
possano contribuire alcuni strumenti concettuali ricavati
43
Vd. un accenno in questo senso in PORCARELLI A., op. cit.
PERNOUD R., op. cit., p. 45.
45
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI M., L’intellettuale, in LE GOFF J. (a cura di),
L’uomo medievale, Laterza, Roma-Bari 199913 (1987), p. 205.
46
SPINOZA B., Tractatus teologico-politicus, Einaudi, Torino 1958 (1670), 1, 4.
44
46
Medioevo: un pregiudizio secolare
dall’etno-antropologia, dalla psicologia sociale e dalla sociologia,
che consentono di limitare, almeno in parte, l’influenza derivata
da una lettura storica troppo semplicistica come è, qualche volta, quella riportata dai manuali scolastici e, come abbiamo visto,
da certa divulgazione mediatica. I concetti di cui scriverò potrebbero – in effetti – consentirci di prendere maggiore consapevolezza di una serie di “impliciti del discorso”.47
Alla domanda da cui parto, che non vorrebbe essere retorica, potrà rispondere l’eventuale lettore integrando nel proprio
bagaglio concettuale gli strumenti che cercherò di fornirgli
lungo il percorso. Credo il quesito non abbisogni di soverchie
spiegazioni: mi pare sia abbastanza chiara la differenza fra
l’azione consapevole della falsificazione e, invece, l’eventuale
inconscia (o parzialmente inconscia) selezione delle notizie
congruenti con la propria concezione del mondo effettuata
ad opera dell’autore che scrive di Medioevo.48 È appena il caso
di aggiungere che la risposta del lettore potrà riguardare, ovviamente, solo ed esclusivamente i pochi testi che saranno oggetto della nostra analisi e, perciò, senza alcuna pretesa di dare
risposte totali a un problema, la cui risoluzione comporterebbe un rilevamento empirico da effettuarsi all’interno di un campione di ben più vaste proporzioni.
2.1. Schemi culturali, stigmatizzazione ed epoché
Gli studiosi registrano la tendenza di ogni epoca storica, gruppo sociale, cultura a giudicare le epoche, i gruppi sociali e le
culture “altri” (out-groups) secondo i parametri peculiari del pro-
47
Vd. SBISÀ M., Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, Laterza,
Roma-Bari 2007, passim.
48
GILI G., Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?, Franco Angeli, Milano 2001, p. 119.
47
Franz Brandmayr
prio gruppo di appartenenza49 (in-group)50. È certo che gli scienziati sociali e – in particolare – gli etnoantropologi hanno fatto
della differenza culturale51 il loro campo specifico di osservazione e di riflessione. Almeno teoricamente essi dovrebbero
essere particolarmente consapevoli della pervasiva influenza degli
schemi culturali52 del ricercatore sugli strumenti concettuali (che
si vorrebbero “oggettivi”), che questi adopera nel suo lavoro.
Tuttavia non manca certo anche fra gli storici chi prende molto
sul serio il rischio di contrabbandare per indagine storiografica
ciò che è frutto, invece, di meri giudizi di valore.
Il problema non è di poco conto; intorno alla questione si
sono scritti fiumi di parole e non mi illudo certamente di poter
dire una parola definitiva in merito. A mio avviso, però, certa
produzione storiografica e – chissà – forse anche un certo tipo di
insegnamento della storia potrebbero essere inclini a esercitarsi
troppo poco – o troppo maldestramente – a fare tabula rasa53, in
particolare, degli idola fori e degli idola theatri54 della propria epoca
storica o del proprio gruppo sociale di appartenenza.
In che misura l’osservatore può considerarsi immune da queste
categorie prevalenti (stereotipi ed etichettazioni), se esse sono
incorporate nella sua cultura? […] nulla garantisce automaticamente l’immunità del ricercatore dai pregiudizi […] la pretesa
che le scienze umane si siano liberate del linguaggio e delle cate-
49
STRUFFI L.-POLLINI G., s.v. Appartenenza, in DEMARCHI F.-ELLENA A.CATTARINUSSI B. (a cura di), op. cit., pp. 155-168.
50
Cfr. MALIGHETTI R., s.v. Etnocentrismo, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di),
op. cit., pp. 273-274.
51
HANNERZ U., La diversità culturale, Il Mulino, Bologna 2001 (1996), passim.
52
Cfr. TENTORI T., Antropologia culturale, Studium, Roma 1960, p. 19.
53
Sui limiti storiografici dell’utilizzo di questo strumento concettuale
«cartesiano» vd. PERNOUD R., op. cit., pp. 170-171.
54
BACONE F., Novum organum, La Scuola, Brescia 1968 (1620), I, pp. 264-266.
48
Medioevo: un pregiudizio secolare
gorie di senso comune è solo una pia illusione […] L’implicazione nella cultura retroagisce sull’osservatore […] in un gran numero di modi, spesso indiretti e scarsamente visibili […] Molto
frequentemente, il solo fatto di formulare un problema relativo a
un oggetto contiene un pregiudizio implicito che qualifica in
modo distorto quell’oggetto, indipendentemente dalla buona
volontà o dalla correttezza procedurale del ricercatore […] Gli
orizzonti di senso comune […] non sono semplici dimensioni
cognitive […] vincolano chi vi si riconosce al mantenimento di
gerarchie, di micropoteri, di inclusioni e di esclusioni […] sostengono le forme di identità, le appartenenze, quel senso del
“noi” che è essenziale alla vita di ogni comunità.55
Probabilmente nel prendere in considerazione il Medioevo
questo sforzo, che è di autoanalisi e di autoeducazione, non risulta essere sempre facile: uno storico contemporaneo si sente «gelare il sangue» quando legge le pene previste nei penitenziali monastici irlandesi per infrazioni alla regola che noi, donne e uomini del Terzo millennio, riterremmo assolutamente irrilevanti.56
Parimenti, ci rallegriamo di non dover più manifestare la nostra
piena appartenenza al gruppo con assordanti urla corali57 e dopo
avere attraversato le durissime prove iniziatiche dei berserkr58 ger-
55
DAL LAGO A., I nostri riti quotidiani. Prospettive nell’analisi della cultura, Costa &
Nolan, Genova 1995, pp. 12-13.
56
LAWRENCE C.H., Il monachesimo medievale. Forme di vita religiosa in Occidente, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993 (1989), pp. 76-78; cfr. DAWSON CH., op.
cit., p. 77; PENCO G., Il monachesimo, Mondadori, Milano 2000, p. 85.
57
Per la verità certe forme espressive degli ultras negli stadi di calcio mi
dissuadono ancora dal cantare la vittoria definitiva della dea ragione nel nostro vecchio Occidente [cfr. BROMBERGER C., La partita di calcio. Etnologia di
una passione, Ed. Riuniti, Roma 1999 (1995), passim; DAL LAGO A., Descrizione
di una battaglia. I rituali del calcio, Il Mulino, Bologna 20012 (1990), passim].
58
ELIADE M., La nascita mistica. Riti e simboli d’iniziazione, Morcelliana, Brescia
19883 (1958), pp. 125-130.
49
Franz Brandmayr
manici, anche se i progressi forse più significativi rispetto agli antenati europei del Nord sembrano riguardare – piuttosto che una
maggiore propensione alla vita pacifica – la nostra maggiore dimestichezza con l’acqua…59 Considerare i contadini alla stregua
di «mostri appena umani»60, trasformare un mite rabbì ebreo in un
konung, un re sassone in armi,61 percorrere in massa strade e villaggi infliggendosi penitenze le più sanguinose,62 praticare i crudeli rituali carnevaleschi…63
Che cosa rimane da fare a chi si accinge a studiare questa
realtà storica così distante? Gli “stigmi” – così li chiamano certi
antropologi – della superstizione, della brutalità (anche
masochista), dell’autoritarismo, della rozzezza dei costumi, dell’ottusità, dell’aggressività più selvaggia, del disprezzo degli umili
e altri ancora sembrerebbero potersi applicare senza esitazione
alcuna ai pochi esempi richiamati. Potremmo non sentirci indotti a svolgere neanche un’opportuna verifica documentale,
tanto essi paiono scontati nella loro chiarezza, inoltre continuamente rievocata e ribadita dai media.64 Essi – gli stigmi –
indica{no} un attributo (fisico o morale) profondamente dispre-
59
CONTE F., op. cit., pp. 117-118.
Cfr. LE GOFF J., I contadini e il mondo rurale nella letteratura dell’alto Medioevo
(secoli V e VI), in ID., Tempo, cit., p. 107.
61
GUREVIČ A.J., op. cit., pp. 78-79.
62
TOSCHI P., s.v. Flagellanti, in AA.VV., Enciclopedia Cattolica, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico – Sansoni, Città del Vaticano – Firenze 1950, vol. V, cc. 1439-1441.
63
Cfr. ad es. BACHTIN M., L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino 1979
(1965), passim.
64
Vd. il concetto di «manipolazione per inondazione», che risulta funzionale
alla creazione di pseudo-eventi in GILI G., op. cit., pp. 244-250: una “verità”
continuamente proclamata alla fine diventa tale anche se non lo è.
60
50
Medioevo: un pregiudizio secolare
giativo e [...] mett{ono} in relazione tale attributo con gli stereotipi relativi alla “normalità”, espressi dalla cultura dominante65,
cultura dominante che – in questo caso – neanche a dirlo, è
quella occidentale attuale: secolarizzata, urbanizzata, postborghese, ispirata alla “gabbia di ferro” della razionalizzazione
weberiana, postindustriale, telematica, individualistica66 (talvolta fino al narcisismo)67, consumistica,68 tesa a dare attuazione la più completa al freudiano principio di piacere e via
dicendo.
Da almeno tre secoli nelle “descrizioni” medievalistiche del
discorso comune, dove abbondano delle autentiche “clave
terminologiche” – fortemente peggiorative – come «feudale»,
«gotico»,69 «barbaro/barbarico»70 ecc. sembrano manifestarsi una
sovrabbondanza di alterità, un divario incolmabile e gli stigmi
rispondono proprio all’esigenza di contenere una diversità
debordante, eccessiva. Nel campo della verbalizzazione, infatti,
essi ottemperano alla funzione di esorcizzare ciò che è “strano”, “estraneo”, “straniero”, “forestiero”, in quanto viene “da
65
AIME M., s.v. Stigma, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), op. cit., p. 709; le
parentesi quadre sono mie. Nel corso della trattazione potrò usare come
quasi-sinonimi anche le espressioni etichetta categoriale o etichettazione (vd.
supra nt. 28) adoperate, solitamente, dagli psicologi sociali.
66
Vd. ad es. BAUMAN Z., La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna 2002 (2001), passim.
67
LASCH CH., La cultura del narcisismo, Bompiani, Milano 20014 (1979), passim.
68
Cfr. ad es. il classico BAUDRILLARD J., La società dei consumi, Il Mulino, Bologna 1976, passim.
69
PERNOUD R., op. cit., pp. 80-86.
70
Come è noto si tratta, inoltre, di un’espressione pesantemente connotata in
senso italocentrico e francocentrico [AZZARA C., Le invasioni barbariche, Il
Mulino, Bologna 1999, p. 9; cfr. anche WOLFRAM H., I germani, Il Mulino,
Bologna 2005 (1997), p. 89].
51
Franz Brandmayr
fuori” rispetto al gruppo-noi.71 Sotto questo profilo corrispondono funzionalmente a quanto mirano a realizzare le liturgie
apotropaiche nell’ambito della ritualità.
Ritengo di semplificare l’esposizione eleggendo a terreno
di fondazione di alcune delle mie ipotesi sugli stigmi o
etichettazioni soprattutto un testo della fine degli anni Novanta. La Breve storia delle grandi scoperte scientifiche di Giovanni
Caprara dedica soltanto ventidue pagine al Medioevo,72 ma il
volume mi sembra rappresentare validamente un certo tipo di
approccio divulgativo al nostro tema. Mentre fornisce notizie
sullo stato della scienza nel Terzo secolo, il nostro «giornalista
scientifico del “Corriere della Sera”», autore di diversi volumi
e premiato per la sua attività di divulgazione scientifica,73 sintetizza lapidariamente un millennio e più di storia con due
brevi frasi introduttive della storia alla scienza medievale. Secondo me queste due proposizioni – vergate con accenti
apodittici – potrebbero rappresentare emblematicamente la
diffusa pratica della stigmatizzazione antimedievale per il tramite dell’etichettazione oscurantistica. Ecco la prima:
I padri della Chiesa rifiutavano la cultura classica perché la ritenevano troppo compromessa con la religione pagana.74
Un asserto di questo genere presenta notevoli errori e lacune anche se lo si voglia riferire al solo alto Medioevo, ma l’Autore non lo integra né lo ridimensiona nel prosieguo dell’esposi-
71
Vd. infra nt. 289.
CAPRARA G., Breve storia delle grandi scoperte scientifiche, Bompiani, Milano 19992
(1998), pp. 43-64.
73
Ivi, quarta di copertina.
74
Ivi, p. 42.
72
52
Medioevo: un pregiudizio secolare
zione, lasciando – con ciò – intendere che tale situazione perduri addirittura per tutta l’età medievale.
Un’analisi, ancorché generica, delle letterature patristica e
scolastica nel loro rapporto di dipendenza e innovazione rispetto alla tradizione classica non si può neanche accennare in
queste pagine.75 Forse vale la pena di fare qualche richiamo,
piuttosto, alla tradizione monastica occidentale, intorno alla
quale gli storici non nutrono dubbi sul fatto che nel VI secolo
l’intellettuale di origine siriaca (e già ministro di Teodorico)
Cassiodoro creava «il primo esempio di monachesimo dotto e
umanistico, che conciliava l’otium classico e la preghiera»76. In
Italia egli agì soprattutto nell’ambiente calabrese e i suoi scritti
si diffusero, pare, fino all’ambiente romano e alla biblioteca
papale del Laterano in particolare,77 da dove – secondo alcuni
– la sua influenza si sarebbe propagata a tutte le successive
esperienze monastiche occidentali. A lui si devono, fra le altre
cose, la composizione di «una vera e propria ratio studiorum», di
un autentico «programma enciclopedico […] tracciato con
l’esame delle sette arti liberali […] nella linea degli enciclopedisti
del tardo mondo antico [… (che)] prepara l’avvento di quelli
dell’Alto Medioevo, Isidoro, Beda, Rabano Mauro».
75
Una prima introduzione al tema si può ricavare, da un punto di vista teologico, in RAHNER K.-VORGRIMLER H., s.v. Patristica, in IID., Dizionario di teologia,
Herder-Morcelliana, Roma-Brescia 1968, pp. 475-476; da una prospettiva filosofica vd. VANNI ROVIGHI S., s.v. Aristotelismo, in AA.VV., Dizionario teologico
interdisciplinare, Marietti, Casale Monferrato (AL) 1977, vol. I, pp. 419-423; EAD.,
s.v. Platonismo, in AA.VV., Dizionario, cit., vol. II, pp. 731-735. Anche in ambito
manualistico una sintesi critica argomentata e in totale disaccordo con il Caprara
viene proposta da CONTE G.B.-PIANEZZOLA E., Corso integrato di letteratura latina,
5, La tarda età imperiale, Le Monnier, Firenze 2004, pp. 146-147.
76
AA.VV., s.v. Cassiodoro, in IID., Enciclopedia Garzanti di filosofia, Garzanti, Milano 19822 (1981), p. 130.
77
PENCO G., op. cit., p. 47.
53
Franz Brandmayr
Egli getta, inoltre, «le basi di tutta la morfologia della cultura
medievale», nella quale la cultura greca e quella latina, quella sacra
e quella profana vengono impostate nei loro sviluppi futuri.78
Di lì a poco sarà il monachesimo benedettino a farsi via via
promotore di istanze culturali di portata sempre crescente, operando una sintesi fra la humanitas ereditata dalla cultura romana e le esigenze di un evangelismo radicale mutuato dalle esperienze monastiche copte e siriache.79 Ne scaturirà uno stile cenobitico originale, praticato secondo modalità autoctone «latine»80; ciò costituirà la premessa indispensabile alla creazione
di una sorta di identificazione della romanitas e della christianitas,81 che si realizzerà fin dall’epoca altomedievale.82 I rigori
ascetici degli anacoreti e dei monaci orientali troveranno nel
movimento benedettino un’interpretazione meno austera,83
progressivamente sempre più aperta alla dimensione culturale,84 di cui è opportuno sottolineare la «polivalenza»85 sotto
vari profili: le interpretazioni – diversificate a seconda delle
78
Ivi, pp. 46-47; parentesi rotonda dello scrivente; cfr. anche ivi, pp. 48 e 176.
Ivi, pp. 32-33.
80
LAWRENCE C.H., op. cit., pp. 100-104; TURBESSI G., Il monachesimo in Occidente
fino a S. Benedetto (c. 480-547), in ID., Ascetismo e monachesimo prebenedettino,
Studium, Roma 1961, pp. 134-148.
81
ULLMANN W., Radici del Rinascimento, Laterza, Bari-Roma 1980 (1977), p. 36;
DAWSON CH., op. cit., p. 37 riferisce che «“Romano” e “cristiano” divennero
quasi termini sinonimi» (cfr. anche ivi, pp. 63 e 81). Il terzo e il quarto elemento dell’amalgama culturale della Civiltà occidentale saranno quello
germanico-pagano (ULLMANN W., op. cit., p. 29) e quello «“tradizionale” delle
vecchie culture indigene» (LE GOFF J., Guerrieri e borghesi rampanti. L’immagine
della città nella letteratura francese del secolo XII, in ID., L’immaginario, cit., p. 32).
82
Ivi, p. 3.
83
LAWRENCE C.H., op. cit., p. 69; PENCO G., op. cit., pp. 60 ss.
84
Cfr. infra le nt. 91 e 95.
85
PENCO G., op. cit., p. 175.
79
54
Medioevo: un pregiudizio secolare
situazioni – del contemptus mundi e l’enorme varietà delle attività culturali (teologia monastica,86 letteratura, scienze e arti,87
scriptoria e biblioteche88), della quale non è possibile rendere
ulteriormente conto in queste pagine.89 Si tratta di un’opera
immensa, efficacemente riassunta nel celebre motto ora et labora, che in seguito, allargata ad altre componenti ecclesiali e
sociali, fonderà, secondo molti autori senza possibilità di equivoco, l’edificio della Civiltà occidentale.90 L’influsso poderoso
dei benedettini diventerà ancor più trainante nei secoli X-XII91
e riguarderà in maniera eminente, oltre l’avanzamento tecnologico92, tanto gli aspetti dell’alfabetizzazione e dell’istruzione
quanto la cultura dotta.93
È sul fondamento monastico, quindi, che si costruisce la
cultura medievale nel suo rapporto con i classici greci e latini.
Questi sarebbero stati trascurati, oppure selezionati a seconda
delle esigenze di «purificazione» della Chiesa94 o addirittura cen-
86
Ivi, pp. 181-186.
Ivi, pp. 186-192.
88
Ivi, 192-193.
89
Cfr. anche MICCOLI G., Il monaco, in LE GOFF J. (a cura di), L’uomo medievale,
cit., p. 48 et passim.
90
Cfr. ad es. CHABOD F., op. cit., pp. 162-163; CROCE B., “Perché non possiamo non
dirci cristiani”, in “La Critica”, XL (1942), pp. 289 ss; DAWSON CH., op. cit., pp.
26-27 et alibi; NOBLE D.F., La religione della tecnologia. Divinità dell’uomo e spirito
d’invenzione, Comunità, Torino 2000 (1997), pp. 4-5.
91
DOLZA L., op. cit., p. 52; MICCOLI G., op. cit., pp. 56-68 dal punto di vista
dell’importanza storica del fenomeno monastico definisce questo periodo
come gli aurea saecula.
92
Vd. infra paragrafo 2.3.
93
GRAFF H.J., Storia dell’alfabetizzazione occidentale, 1, Dalle origini alla fine del
medioevo, Il Mulino, Bologna 1989 (1987), p. 22; LAWRENCE C.H., op. cit., p. 65.
94
Cfr. MICCOLI G., op. cit., p. 75.
87
55
Franz Brandmayr
surati e messi in ombra. Anche tutto ciò è senz’altro vero (almeno fino all’epoca carolingia)95, ma, al contempo,
ci si è potuti accorgere che, in effetti, nel Medioevo, gli autori
latini, e anche quelli greci, erano già parecchio conosciuti e […]
l’apporto del mondo antico, classico o no che fosse, era a quell’epoca lontano dall’essere disprezzato o rifiutato.96
Non va ignorato, inoltre, il fatto che persino nei cosiddetti
«anni bui»97 (V-VII) non si potesse parlare di ignoranza del latino neanche tra gli stessi laici,98 fra i quali si potevano annoverare delle donne nonché «alcuni barbari»99.
Già all’epoca di Carlomagno e, ancor di più, al tempo di Bernardo da Chiaravalle la conoscenza degli autori greci e latini
viene coltivata al punto che «taluni studiosi […] hanno parlato
allora di una “Rinascita carolingia” […] di “Rinascita del XII
secolo”, o anche di “umanesimo medievale”»100 anche con un
riferimento preciso alla frequentazione dei classici. Perciò, almeno per quanto riguarda il latino, l’idioma e i testi sarebbero
sempre stati «fascinosi» per la civiltà medievale presa nel suo
95
Va precisato che LAWRENCE C.H., op. cit., p. 78 osserva una più spiccata
libertà di spirito presso i monaci irlandesi, che – come è noto – operarono in
gran parte dell’area centro-occidentale del continente e diffusero la sensibilità verso la cultura classica (DAWSON CH., op. cit., pp. 71-77) proprio nel periodo in cui i benedettini ne fecero talora oggetto di ascetica diffidenza.
96
PERNOUD R., op. cit., pp. 20-21; cfr. anche LE GOFF J., Prefazione, in ID.,
L’immaginario, cit., p. XX.
97
GRAFF H.J., op. cit., p. 69; cfr. LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., p. XVI.
98
Sull’alfabetizzazione dei chierici e dei monaci, peraltro, non è bene operare
troppe generalizzazioni; lo stesso discorso si pone intorno alla loro conoscenza del latino; cfr. infra nt. 267.
99
GRAFF H.J., op. cit., p. 72.
100
PERNOUD R., op. cit., p. 21.
56
Medioevo: un pregiudizio secolare
complesso e non soltanto fra il 1380 e il 1450.101 Per quanto
concerne il latino liturgico, inoltre, Graff rileva che esso sarebbe stato conosciuto in misura persino maggiore fra le donne e
per tutto l’arco temporale del Medioevo.102
In definitiva, secondo Garin il pensiero cristiano medievale,
dopo «secoli di meditazione», di «critica insistente, inesorabile e
sempre più consapevole della concezione classica»,
si impadroniva delle armi dell’avversario, pur col pericolo, scendendo sul suo terreno ed usando i suoi mezzi, di confondersi con esso;
che è l’impressione che, dalla patristica in poi, dà così spesso il pensiero medievale, tutto fatto di apparenti ritorni e di strani miscugli:
platonismo, stoicismo, neoplatonismo, aristotelismo, averroismo,
fino a pervenire alla «formulazione cosciente, e cioè filosofica
[…] della propria concezione, e delle proprie ragioni»103. Peraltro,
è noto che una delle più profonde operazioni culturali dell’intero
percorso filosofico europeo è consistita nella faticosa adozione
del sistema aristotelico nel XIII secolo,104 a riprova di un rapporto
con la classicità vissuto intensamente e ricco di sviluppi originali.
La Pernoud ricorda ancora che «i cataloghi delle biblioteche
che ci sono stati conservati […] provano abbondantemente»
che non fu la caduta di Costantinopoli (1453), se non in minima
parte, a determinare «l’introduzione in Europa delle biblioteche
di autori antichi conservate a Bisanzio»105.
101
GRAFF H.J., op. cit., p. 162; cfr. ULLMANN W., op. cit., p. 35.
GRAFF H.J., op. cit., p. 119.
103
GARIN E., La crisi del pensiero medievale, in ID., Medioevo e Rinascimento. Studi e
ricerche, Laterza, Roma-Bari 19803 (1950), p. 18.
104
PERNOUD R., op. cit., p. 162.
105
Ivi, p. 22; cfr. LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., p. XX, ove
l’Autore menziona il «ritorno all’antico» fin dal secolo XIII e l’«invasione di
Aristotele» nelle forme scultoree dei Pisano.
102
57
Franz Brandmayr
Dai semplici richiami prodotti scaturisce – pertanto – una
notevole ricchezza di sfumature, di situazioni diversificate a seconda dei vari segmenti sociali, cui andrebbero aggiunte le diversità rispetto alle aree geografiche. Si tratta di differenze, delle
quali una divulgazione, effettuata sulla scorta di studi specialistici non si sa quanto fondati e che si esprime con affermazioni
lapidarie, non sembra riuscire a rendere ragione neanche approssimativamente.
Caprara insiste nel proporre l’immagine di un Medioevo oscurantista, cui continua a soggiacere il tema, che a lui pare fondamentale, del rapporto antitetico fra la scienza e la religione:
Se nei secoli precedenti, l’ondata di misticismo aveva demolito
l’interesse per la scienza, ora l’insistenza sui temi della salvezza e
della fede predicati come fondamentali e prioritari rafforzava ed
ampliava l’opera di chiusura culturale. E quando non si dimostrava avversione si esibiva indifferenza.106
Sulla fragilità documentaria di un’affermazione tanto lontana
dalla realtà abbiamo già scritto qualcosa per quanto riguarda il
rapporto con i classici; per quanto concerne lo spirito di invenzione, invece, dovremo soffermarci ancora oltre.107 Già a questo
punto mi piace, però, richiamare un passo di Bertrand Russell,
uno dei tanti del suo Misticismo e logica, che può contribuire a liberare dai gravami del pregiudizio questo tema, che i più affrontano
in una condizione di coinvolgimento preconcetto:
Anche la cauta e paziente ricerca della verità per mezzo della
scienza, che sembra l’assoluta antitesi dell’incrollabile certezza
106
107
58
CAPRARA G., op. cit., p. 42.
Vd. infra paragrafo 2.3.
Medioevo: un pregiudizio secolare
del mistico, può essere incoraggiata e nutrita da quell’autentico
spirito di venerazione nel quale il misticismo vive e opera.108
Punto di vista dell’osservatore, da una parte, e società, cultura, civiltà osservata, dall’altra: come stabilire un rapporto corretto con l’oggetto dello studio storiografico? Credo non vi sia
indagine seria, non c’è scienza storica senza una sospensione
del giudizio,109 cioè senza la messa tra parentesi dei propri schemi culturali da parte del ricercatore. È umano, umanissimo provare sentimenti di ripulsa o assumere atteggiamenti irridenti di
fronte a palesi manifestazioni di differenza culturale, ma essi
vanno considerati per quello che sono: mere reazioni emotive,
oltre che difensive. Nella migliore delle ipotesi, se vengono inserite in un quadro filosofico coerente, potrà trattarsi di riflessioni etiche, ma quando i piani filosofico-morale e storiografico
vengono sovrapposti fino a confondersi, difficilmente il discorso eviterà uno slittamento su di un piano puramente moraleggiante e – con ciò – antiscientifico.110
108
RUSSELL B., Misticismo e logica, in ID., Misticismo e logica e altri saggi, Longanesi,
Milano 1970 (1914), p. 12; cfr., da un punto di vista antropologico-culturale,
BASTIDE R., Un misticismo senza dei, in ID., Il sacro selvaggio, Jaca Book, Milano
1979 (1931), p. 22. Sul rapporto fra mistica e spirito innovativo possono
risultare interessanti anche le riflessioni riportate nei paragrafi 2.3. e 2.4.
109
Si tratta, come è noto, dell’™poc» = epoché; vd. ABBAGNANO N., s.v. Epoché,
in ID., op. cit., pp. 309-310. Nella traduzione tedesca il lemma presenta sfumature quasi ascetiche: Ausschaltung significherebbe, quindi, «esclusione»
ed «eliminazione» (MACCHI V., s.v., in ID., Dizionario Sansoni. Tedesco-Italiano.
Italiano-Tedesco, Sansoni, Firenze-Roma 1977) del proprio Io, delle proprie
preoccupazioni di studioso (cfr. MARROU H.-I., op. cit., p. 78); la forma verbale ausschalten, inoltre, si adopera per indicare lo «spegnere» (ad es. di fonti
di energia elettrica).
110
WEBER M., La scienza come professione, in ID., Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 1966 (1919), pp. 18 e 26-27.
59
Franz Brandmayr
2.2. Avalutatività, anacronismo, luoghi comuni ed etnocentrismo
È quando lo studioso si colloca in una disposizione mentale di
“avalutatività”111, dunque, che trova attuazione pratica la metodologia baconiana della tabula rasa, della almeno provvisoria disattivazione degli idola tribus e degli idola fori. Gli storici e – nondimeno – gli antropologi non coltivano più alcun mito della
pura oggettività,112 tuttavia caldeggiare questo genere di autoanalisi e autocontrollo nello studioso, ma anche nel docente e
nello studente stessi, può «evitare (a tutti costoro) il vicolo cieco
[…] dell’anacronismo»113.
Propriamente, l’anacronismo è un «errore in cui si cade attribuendo certi fatti ad un’epoca diversa da quella in cui sono avvenuti»114. Si tratta, in buona sostanza, di un meccanismo proiettivo,115 che può agire almeno in due modi, positivo il primo e
negativo il secondo. Nel primo caso il soggetto può assegnare
positivamente a un’epoca o a un personaggio del passato dei
sentimenti o degli atteggiamenti che sono, in realtà, estranei all’epoca o al personaggio in questione. Come esempio richiamo
quello portato dalla Pernoud, che scrive di come certi studiosi
abbiano ascritto ad Abelardo una miscredenza e uno scetticismo, che non emergono assolutamente da una attenta e completa disamina documentaria. In studi parziali e – spesso – ela-
111
ID., Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino, 19812 (1922), pp.
309-375.
112
MARROU H.-I., op. cit., p. 44.
113
Ivi, p. 78 (parentesi rotonda mia).
114
DEVOTO G.-OLI G.C., s.v. Anacronismo, in IID., Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 1995.
115
TOMAN W., s.v. Proiezione, in ARNOLD W.-EYSENCK H.J.-MEILI R. (a cura di),
Dizionario di psicologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19863 (1980), pp.
894-895.
60
Medioevo: un pregiudizio secolare
borati sulla scorta di ricerche puramente compilative vengono
fatte risaltare del teologo, invece, delle caratteristiche di presunta modernità che – perlomeno negli anni Settanta – erano date
per acquisite pur in assenza di un adeguato approfondimento
dei testi originali.116
La modalità negativa dell’anacronismo, invece, rivela una tendenza del soggetto a proiettare a ritroso lungo l’asse del tempo
la propria energia psichica117 nel senso di una colpevolizzazione
dell’epoca o del personaggio considerati. Qui la negatività non
va letta nel suo significato psicologico e morale (di acrimonia
che, invece, può essere sottesa al lemma “colpevolizzazione”),
bensì nel senso etimologico del mancato riscontro, ad opera del
ricercatore, di una sintonia di atteggiamenti e sentimenti fra il
periodo storico esaminato e il ricercatore stesso. In definitiva,
questi attiva un meccanismo di difesa118 (perché di questo in
definitiva si tratta) mediante il quale egli, lo studioso, tutela – in
qualche modo – la propria concezione del mondo e la propria
gerarchia dei valori, rilevando, talvolta lamentando o, addirittura, deprecando la loro assenza o il loro misconoscimento nell’epoca, nel personaggio o nella cultura specifica che è chiamato
a indagare e conoscere. Gli esempi in questo ambito potrebbero essere numerosi: valga per tutti il richiamo alla mentalità guerriera119 dell’uomo medievale, che indigna, forse giustamente, il
pacifista europeo contemporaneo. Si potrebbe, forse, dare per
scontata la capacità dello storico di professione – abituato a lavorare sui documenti – di evitare quell’anacronismo, per cui si
proiettano sul Medioevo le sensibilità e le esperienze dei movi-
116
PERNOUD R., op. cit., pp. 149-150.
MULLER P., s.v. Psichica/energia, in ARNOLD W.-EYSENCK H.J.-MEILI R. (a
cura di), op. cit., p. 902.
118
Cfr. TOMAN W., v. cit., p. 894.
119
LE GOFF J., Il Medioevo, cit., pp. 36 e 100-107.
117
61
Franz Brandmayr
menti pacifisti del secolo XX.120 È possibile, però, che qualche
insegnante e, più ancora, gli studenti risultino particolarmente
esposti a questa ingenuità metodologica.
Va detto che il meccanismo proiettivo di difesa sussiste anche nel primo tipo di anacronismo, quando – cioè – il soggetto
si addentra a esplorare un’epoca, un personaggio, una cultura
che portano valori dissonanti rispetto ai propri schemi culturali
e tende a plasmare a propria immagine e somiglianza l’oggetto
della propria ricerca per renderlo meno unheimlich121 e, in qualche modo, più domestico e utilizzabile.122 Una dinamica di questo genere si ripropone anche quando, con rialzismo cronologico123 patente, si cercano antenati illustri, che solitamente conferiscono prestigio e avvalorano la posizione culturale propria di
chi effettua l’indagine, come probabilmente è accaduto nel caso
della vulgata costruita intorno ad Abelardo e denunciata dalla
Pernoud. È verosimile, inoltre, che un simile atteggiamento di
riplasmazione della storia a immagine e somiglianza della memoria storica del proprio gruppo di appartenenza possa produrre più facilmente esiti configurabili come œpoj (= epos) collettivo piuttosto che come vera e propria storiografia.124
120
Per un’introduzione al tema vd. GIACOMINI M.R., Antimilitarismo e pacifismo
nel primo Novecento. Ezio Bartalini e “La Pace”. 1903-1915, Franco Angeli, Milano 1990, passim con le relative indicazioni bibliografiche.
121
Tengo presente il concetto di Unheimlichkeit = «spaesamento» (HEIDEGGER
M., Essere e tempo, Longanesi & C., Milano 1976 (1927), p. 548), cui ricollego
l’aggettivo unheimlich, che significa: «sospetto», «poco rassicurante» (s.v. in
MACCHI V., op. cit.).
122
TULLIO-ALTAN C., Soggetto simbolo valore. Per un’ermeneutica antropologica,
Feltrinelli, Milano 1992, pp. 26-32.
123
CIRESE A.M., Cultura, cit., pp. 110-114.
124
Lo spazio non consente di trattare l’importante argomento [per un primo
approccio vd. ad es. PIVATO S., op. cit., p. 47-49; RICOEUR P., La memoria, la
storia, l’oblio, Cortina, Milano 2003 (2000), passim; TRAVERSO E., Il passato: istru-
62
Medioevo: un pregiudizio secolare
Il concetto di avalutatività, che vado richiamando in queste
pagine, viene spesso confuso con un’improbabile asetticità (talvolta scambiata a sua volta con l’oggettività) di tipo veteropositivistico; essa affonda le proprie radici culturali – come è
noto – nell’approccio sperimentale proprio delle scienze della
natura.125 L’entusiasmo ottocentesco per l’enorme sviluppo
metodologico di questo ambito della conoscenza umana e la
grande mole di risultati ottenuti sul piano strettamente cognitivo
hanno finito per influenzare profondamente anche le scienze
umane, facendo ritenere che lo storico, 126 il sociologo e
l’antropologo127 potessero osservare i fenomeni umani alla stregua dello scienziato nel suo laboratorio, impegnato con le proprie sperimentazioni in campo fisico o chimico. Tramontato del
tutto – suppongo – fra gli storici questo tipo di sensibilità, esso
non è per niente scomparso dal discorso comune,128 quell’immenso terreno di gioco verbale nel quale tutti noi, studenti e
insegnanti (e – nonostante tutto – anche gli storici), siamo immersi. È ancora Max Weber, però, a ricordarci che l’atteggiamento avalutativo non comporta affatto il rinnegamento delle
appartenenze né delle personalissime concezioni del mondo del
singolo ricercatore, dell’insegnante e dello studente; 129 il
sociologo tedesco invita – semplicemente – a non confondere i
zioni per l’uso. Storia, memoria, politica, Ombre Corte, Verona 2006, passim], decisivo anche per individuare le «strategie del discredito» [che sono: la «costruzione del nemico», la «disconferma» e l’«insinuazione» (GILI G., op. cit.,
pp. 98-102)] dell’Età medievale e gli eventuali imprenditori delle stesse.
125
GRANGER G.-G., La scienza e le scienze, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 77-92.
126
MARROU H.-I., op. cit., pp. 44 e 74.
127
TULLIO-ALTAN C., Antropologia, cit., pp. 38-49.
128
GEERTZ C., Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna 1988 (1983), pp.
91-117.
129
WEBER M., Il metodo, cit., p. 68.
63
Franz Brandmayr
due piani: quello valutativo-etico personale e quello espositivo e
analitico della materia considerata. Per di più – come si sa – lo
studioso manifesta la propria onestà intellettuale nella misura in
cui esplicita i presupposti metodologici e, al limite, ideologici
dai quali prende le mosse la propria ricerca, offrendo – in questo modo – al destinatario del proprio lavoro gli strumenti atti a
confutare, eventualmente, la tesi della quale lo studioso stesso si
facesse portatore.130
Forse legata a questo atteggiamento positivistico di distanza
e di osservazione dall’esterno, va menzionata anche una specie
di ipercriticismo, che si presumeva dovesse sostanziare, in un
certo immaginario collettivo non estraneo neanche agli storici,
la ricerca storiografica di qualità:
Storico […] era soprattutto il critico […] capace di scorgere
l’interpolazione, smascherare il falsario, respingere un’attribuzione usurpata. Di qui […], a lungo andare, l’accentuazione di
un atteggiamento odioso, che consisteva nel sottolineare ironicamente le altrui miserie e debolezze, una disposizione all’arroganza e al disprezzo; in definitiva, una sorta di incapacità a
comunicare a riconoscere e ad accogliere – laddove esistessero
– gli autentici valori umani.131
Si tratta dunque di un atteggiamento complessivo, che può inficiare
un approccio storiografico o una esposizione storica corretti e che
tende ad assommare le componenti valutative, stigmatizzanti e
anacronistiche, che ho cercato di evidenziare sopra.
Altre volte ancora chi scrive di Medioevo può fare ricorso a
vari artifici retorici, talora piuttosto manifesti. Riporto qui brevemente un passaggio di un noto e peraltro validissimo manua-
130
POPPER K., Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Fabbri, Milano 19982 (1962), vol. I, pp. 66-67 et circa.
131
MARROU H.-I., op. cit., p. 88.
64
Medioevo: un pregiudizio secolare
le scolastico della fine degli anni Ottanta e cerco di confrontarlo con un’opera più recente, che ci permette di ipotizzare una
possibile evoluzione nella tematizzazione della didattica
medievalistica. Gli Autori, citando un passo di Le Goff dal registro quasi confidenziale, invitano a diffidare di una visione troppo
rosea del rivalutato Medioevo:
Se mi si permetterà di dare un consiglio assai grossolano, dirò al
lettore che, di fronte a queste tentazioni di evasione verso un
Medioevo trasfigurato, chieda onestamente a se stesso se gli piacerebbe, per virtù del mago Merlino […] essere trasportato in
quel tempo e viverci.132
Questa soluzione scelta dai nostri per equilibrare i presunti
eccessi di un certo revisionismo storico, oltre a prestare il fianco
a una facile ironia (gli Autori del testo avrebbero ambito «onestamente» – forse – di «evadere» in qualche paradiso di una «trasfigurata» classicità, modernità o postmodernità? …), non riesce a nascondere le proprie connotazioni valutativa e retorica.
Valutativa, in quanto gli Autori ritengono sia «importante non
cadere nell’eccesso opposto» alla tabuizzazione del Medioevo,
in quanto esso configurerebbe una «tentazione ancora più grave della precedente». L’asserto non risulta argomentato in alcun
modo, ma viene da chiedersi se si possa lasciare a uno stadio
tanto “grezzo” la trattazione della Parola chiave Medioevo, quella
che – in fondo – dà, o dovrebbe dare, il “la” all’intero volume
primo dell’opera. Viene pertanto spontaneo porre una serie di
quesiti a Giardina, Sabbatucci e Vidotto, come ad esempio: perché proporre un’immagine «ottimistica» del Medioevo sarebbe
un errore più grave rispetto alla divulgazione della precedente
132
LE GOFF J., cit. in GIARDINA A.-SABBATUCCI G.-VIDOTTO V., Uomini e storia,
1, Dal Medioevo all’età moderna, Laterza, Roma-Bari 19902 (s.d. orig.), pp. 6-7
(citato senza indicazione della fonte).
65
Franz Brandmayr
immagine pessimistica dello stesso? Perché non potrebbe essere
semplicemente un errore storico, esattamente come lo è la versione peggiorativa del periodo in questione? Esiste per caso una
classifica degli errori storici (una “serie A” e una “serie B”, per
intenderci)? Inoltre: a chi era allora funzionale un’immagine negativa del Medioevo? È sicuro che servisse solo agli interessi
degli «umanisti italiani»? Come mai fra i medievisti si chiamano in
causa anche molti pensatori illuministi,133 che invece gli Autori
del nostro manuale non menzionano nemmeno? È certo, inoltre,
che non persista ancora adesso un «uso o un abuso della storia»134
medievale simile – in qualche modo – a quello realizzato dagli
umanisti e da una parte delle correnti illuministiche? In considerazione del fatto che è «opinione comune» che il Medioevo sia
«sinonimo di età buia e barbara, di epoca segnata da un grave
regresso economico e culturale» 135, come mai non viene
configurata alcuna ipotesi né – tantomeno – viene esposta alcuna
tesi136 in merito alla rivalutazione del periodo in questione? Ecco
tutta l’argomentazione proposta dal manuale in questione:
Contro questa valutazione negativa ha reagito una parte degli
storici moderni, che ha cercato di rivalutare, soprattutto sotto il
profilo culturale, la vitalità dell’epoca medievale. Questa reazione ha fatto compiere notevoli progressi alla nostra conoscenza
del periodo.137
Il fatto che la “finestra” dedicata dal suddetto manuale alla
Parola chiave Medioevo non riporti alcuna suggestione che possa
133
Cfr. infra nt. 294.
Cfr. PIVATO S., op. cit., passim.
135
GIARDINA A.-SABBATUCCI G.-VIDOTTO V., op. cit., p. 6.
136
In merito vd. infra al paragrafo 2.4.
137
GIARDINA A.-SABBATUCCI G.-VIDOTTO V., op. cit., p. 6.
134
66
Medioevo: un pregiudizio secolare
aiutare lo studente a riflettere anche nelle direzioni sopra indicate, ma che denoti – al di là del generico riconoscimento di
una certa validità cognitiva alla reazione di «una parte degli
storici»138 – una malcelata e più evidente preoccupazione di
inibire un’improbabile concezione ottimistica del Medioevo,
lungi dallo scandalizzare, consente di scorgere con maggiore
chiarezza un certo tipo di approccio manualistico, che sembra
orientato a preservare l’«opinione comune»139 intorno alla civiltà medievale.
La posizione valutativa dei nostri Autori pare confermata
anche dall’espediente retorico da loro adoperato; essi fondano,
infatti, il proprio giudizio riassuntivo circa il Medioevo per il tramite dell’ironia di Jacques Le Goff, senz’altro «un grande medievista contemporaneo»140, ma anche – e questo non viene invece
da loro riportato141 – un grande estimatore del Medioevo.142 Osserviamo – in questo caso – il riferimento a una auctoritas indiscussa, all’ipse dixit dello storico affermato. Di per sé in certi frangenti ciò è inevitabile: è naturale (lo sto attuando con una certa
frequenza anch’io nella presente trattazione) fare un consapevole
e abbondante utilizzo di autori che godono di un prestigio scientifico universalmente riconosciuto; è essenziale – tuttavia – non
farne un esercizio meramente retorico e cercare di esporre le loro
descrizioni e argomentazioni in chiave dialettica,143 fornendo an-
138
Lo stesso Le Goff sembra invece intendere che la totalità degli storici
abbia rivalorizzato l’epoca medievale (LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., p. XVIII; cfr. supra anche nt. 12).
139
GIARDINA A.-SABBATUCCI G.-VIDOTTO V., op. cit., p. 6.
140
Ibidem.
141
Cfr. infra nel paragrafo 2.3. le indicazioni circa la selettività.
142
Cfr. ad es. infra nt. 354 e – più in generale – il volume di LE GOFF J.,
Medioevo, cit., passim; cfr. anche infra nt. 156.
143
Cfr. ad es. PIVATO S., op. cit., pp. 87-88.
67
Franz Brandmayr
che indicazioni contrarie144 e cercando di fornire al lettore gli strumenti atti a cogliere i punti deboli della propria trattazione.145
Al contrario, Giardina, Sabbatucci e Vidotto sembrano seguire una via più facile e ad effetto: a una auctoritas146 – come
abbiamo visto – viene delegato il compito di liquidare il tema in
oggetto con una battuta ironica; questa è – per sua stessa natura
– agonistica 147 e mirata non a porre le premesse per una
tematizzazione adeguata (per esempio mediante la definizione
più precisa delle diverse posizioni esistenti fra gli storici), bensì
tesa a sottrarre all’avversario la possibilità di argomentare proprio per l’“evidente” plausibilità148 del contenuto proposto. In
questo modo viene strumentalizzato il prestigio sociale di un
luminare, attingendo a una sua produzione, di cui non si danno
gli estremi,149 selezionata fra le numerosissime testimonianze di
ammirazione per l’Età medievale formulate dallo stesso storico,
nella quale questi pronuncia apoditticamente una frase che si
propone come un entimema.150 In questo «sillogismo ellittico» è
144
GUITTON J., Arte nuova di pensare, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 198611
(s. d. orig.), pp. 109-110 e 114-117.
145
Vd. supra nt. 130.
146
Cfr. l’«argomento d’autorità» in MORTARA GARAVELLI B., Manuale di retorica,
Bompiani, Milano 1997 (1988), p. 77.
147
Il passaggio al registro confidenziale da parte di Le Goff rinvia alla comunicazione orale, nella quale è sovente implicito un «tono agonistico» [ONG
G.W., Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna 1986 (1982),
pp. 73-75], che pare confermato dal fatto che «dal punto di vista della retorica l’ironia acquista la funzione di arma oratoria» (INFANTINO M.G., L’ironia.
L’arte di comunicare con astuzia, Xenia, Milano 2000, p. 8).
148
Mi rifaccio al concetto di «struttura di plausibilità» di BERGER P.L.-LUCKMANN
TH., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna 1969 (1966), cap. 3.
149
Vd. supra nt. 132; è certo che individuare la fonte consenta al lettore una
sua più agevole messa in discussione critica.
150
MORTARA GARAVELLI B., op. cit., pp. 77-78.
68
Medioevo: un pregiudizio secolare
dato cioè per presupposto dal senso comune (orizzonte nel quale
pare scontato che non vi sia alcuno che «onestamente» asserirebbe
di ambire a vivere nel Medioevo), ciò che andrebbe invece appena argomentato151 con gli strumenti metodologici storiografici e
non con una battuta ad effetto. La tautologia sottesa a questa
pseudo-argomentazione è tipica, come abbiamo già evidenziato,
delle retoriche del senso comune,152 che solitamente attingono
alla ricca messe dei topoi, dei «luoghi comuni della quantità»153,
cioè approvati dalla massa. Di questo tipo di paralogismo si può
dire, ancora, che – scritto al più tardi nel 1990 – esso pare ricordare, per la sua levità, un certo modo «giornalistico» di affrontare gli
argomenti154 e – in particolare – la storia.155
Può risultare di qualche interesse rilevare che, invece, nell’impostare il quadro storico-letterario medievale, un recentissimo manuale di letteratura italiana supera senza alcuna reticenza
il vecchio pregiudizio e, sempre per il tramite di Le Goff, pone
in particolare luce il novum, che sembra emergere soprattutto a
partire dall’anno Mille.156
Ai nostri fini – comunque – ciò non sposta i termini complessivi del discorso: il senso comune157 pare continuare a essere
151
Ciò vale in quanto l’entimema consiste in un sillogismo che non è fondato
su una premessa necessaria (cfr. ABBAGNANO N., s.v. Entimema, in ID., op. cit.,
p. 305).
152
Vd. infra nt. 165.
153
MORTARA GARAVELLI B., op. cit., pp. 78-80.
154
SORRENTINO C., Tutto fa notizia. Leggere il giornale, capire il giornalismo, Carocci,
Roma 2010, p. 134.
155
Cfr. ad es. PIVATO S., op. cit., pp. 87-88.
156
LUPERINI R.-CATALDI P.-MARCHIANI L.-MARCHESE F., Il Nuovo la scrittura e
l’interpretazione. Storia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea secondo
i nuovi programmi, 1, Dalle origini al Medioevo (dalle origini al 1380), Palumbo,
Palermo 2011, p. 4.
157
Cfr. anche ibidem.
69
Franz Brandmayr
informato dal consueto pregiudizio, al quale – a livello di
manualistica – vengono portate appena in questi anni le prime
critiche serie e argomentate.
A questo punto, va messo ancora in evidenza un altro aspetto della questione del pregiudizio antimedievale; finora ho creduto opportuno rimarcare soprattutto gli aspetti individuali e
psicologici del rapporto che lo storico, il docente e lo studente
potrebbero intessere con la materia medievalistica in cui si dovessero imbattere; va tuttavia ribadita anche la componente sociale dei loro eventuali comportamenti valutativi, stigmatizzanti
e anacronistici. Questi comportamenti, che scaturiscono da sentimenti e valutazioni personali,158 si inseriscono – infatti – in un
contesto collettivo e condiviso, da questa cornice olistica ricevono un rinforzo ed essi stessi, a loro volta, la corroborano,
instaurando con essa una prassi reciproca.159
Ciò accade, va detto, nonostante il soggetto, si tratti di uno
storico, di un docente o di uno studente, non sia sempre avvertito delle dinamiche psico-sociali, discorsive e interetniche, che
rendono attivi i suoi criteri valutativi e di quanto il proprio ethos
sia condizionato dall’ambiente sociale.160
In realtà non esiste solo un etnocentrismo legato ai grandi
insiemi sociali, alle grandi civiltà e alle entità nazionali; questo
concetto, se preso nel suo significato tecnico di erezione degli
schemi culturali di una «collettività» a criterio assoluto di valuta-
158
Sentimenti, valutazioni e comportamenti degli informatori costituiscono, in buona sintesi, l’oggetto della ricerca etnoantropologica [BIANCO C.,
op. cit., pp. 162-163; cfr. TURNER V., Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna
1986 (1982), p. 120].
159
Mi rifaccio al concetto marxiano di umwälzende Praxis (condizionamento
vicendevole).
160
Per un’introduzione a queste dinamiche vd. DUBAR C., La socializzazione.
Come si costruisce l’identità sociale, Il Mulino, Bologna 2004 (2000), passim.
70
Medioevo: un pregiudizio secolare
zione: a) della realtà; b) degli altri gruppi,161 può esprimere l’identificazione del soggetto con gli schemi culturali di una
subcultura,162 di una classe sociale,163 di un gruppo religioso, di
un partito politico e via discorrendo.164
Secondo gli antropologi esiste una versione «spontanea»165
dell’etnocentrismo. Senza una certa dose di etnocentrismo l’individuo non avrebbe punti di riferimento, non disporrebbe di
una “mappa” interpretativa della realtà che lo circonda e si troverebbe esposto al disorientamento culturale e, forse, a
un’“anomia”166 psicologicamente destrutturante e pericolosa per
l’equilibrio personale.
La collettività in cui il soggetto è inserito, dunque, codifica e
veicola i contenuti e le articolazioni dei propri schemi attraverso una serie di linguaggi verbali, gestuali e simbolici, che solo in
parte possono venire condivisi anche da altre collettività. All’interno del gruppo ogni individuo coordina i propri comportamenti con quelli degli altri membri, in una tensione alla reciproca conferma della validità dei comuni schemi di valutazione,
emozionali ed etici. È a questo punto che si può parlare di un
“senso comune”:
161
BERNARDI B., op. cit., p. 44.
CUCHE D., La nozione di cultura nelle scienze sociali, Il Mulino, Bologna 2003
(1996), p. 58.
163
Si veda il concetto di classicentrismo in LOMBARDI SATRIANI L.M., Antropologia culturale ed analisi della cultura subalterna, Guaraldi, Firenze 1976, p. 104.
164
Per la nozione di esclusivismo culturale, una specie di etnocentrismo che
non concerne necessariamente un gruppo etnico, cfr. CIRESE A.M., Cultura,
cit., p. 7.
165
TULLIO-ALTAN C., Antropologia, cit., p. 70.
166
Si tratta, in buona sostanza, del disagio che può pervadere singoli o gruppi
a causa della «inadeguatezza delle norme» della convivenza sociale durante le
fasi di mutamento [MILANESI G., s.v. Anomia, in DEMARCHI F.-ELLENA A.CATTARINUSSI B. (a cura di), op. cit., p. 140].
162
71
Franz Brandmayr
Il senso comune non è ciò che la mente comprende spontaneamente, (una volta) liberata dal ciarpame; è quello che la mente
riempita di presupposti [(socio-culturali) …] conclude […] Come
struttura del pensiero e suo esemplare il senso comune è totalizzante come ogni altro: nessuna religione è più dogmatica, nessuna scienza più ambiziosa, nessuna filosofia più generale [… (esso)]
pretende di raggiungere la realtà oltre l’illusione, le cose come
sono [… (ciò che è)] “realmente reale”.167
Il senso comune si esprime e si nutre mediante il discorso
comune, tutto strutturato attorno agli schemi che fondano e
danno consistenza alla cultura del gruppo o di una società. Esso
si sviluppa dalla bottega alla piazza, passa attraverso l’aula scolastica, ma – come abbiamo già costatato – arriva nondimeno
nei salotti che si presumono “buoni”168, informa gran parte dei
media e, conseguentemente, viene rilanciato nuovamente ai
fruitori degli stessi mezzi di comunicazione, in uno scambio
quotidiano continuo.169 Le sue «semiqualità» sarebbero, secondo Geertz, la «naturalezza», la «praticità», la «leggerezza», la
«mancanza di metodo», una facile «accessibilità»170 per chiunque: in buona sostanza, in questa quasi-filosofia (o filosofia spicciola) i contenuti sembrerebbero presentare i caratteri di un’ovvietà priva di ogni senso di meraviglia171 e di scoperta. All’interno di questo complesso di narrazioni il Medioevo potrebbe ri-
167
GEERTZ C., Antropologia, cit., pp. 105-106; parentesi rotonde mie.
Cfr. supra nt. 9.
169
Vd. ad es. GOFFMAN E., La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino,
Bologna 1969 (1959), passim.
170
GEERTZ C., Antropologia, cit., p. 107.
171
Geertz (ivi, p. 104) mi induce a richiamare il di¦ g¦r tÕ qaum£zein oƒ
¥nqropoi [...] ½rxanto filosofe‹n [gli uomini hanno incominciato a
filosofare a causa della (capacità di provare) meraviglia (ARISTOTELE, Metafisica, 2, 12-13); trad. di Giovanni Reale; parentesi rotonda mia].
168
72
Medioevo: un pregiudizio secolare
sultare configurato (è quanto un’analisi antropologica dovrebbe
accertare) alla stregua dei divertenti luoghi comuni tanto spiritosamente descritti da Régine Pernoud nella raccolta di saggi
che ho ripetutamente citato.
L’etnocentrismo (quello cosiddetto spontaneo, perlomeno),
dunque, è un atteggiamento insito nella condizione umana, abbiamo detto e ciò, a scanso di idealismi fuorvianti, non va mai
dimenticato.172 Esistono, però, due reazioni tipiche a una constatazione di questo genere: una, la prima, configura una sorta di
nichilismo antiscientifico,173 che porta a negare al ricercatore ogni
competenza a proferire qualsivoglia contenuto sull’“Altro”, che
non sia una mera proiezione del sé. La seconda reazione, simmetrica alla prima, parte dalla identica considerazione dell’impossibilità di evitare l’etnocentrismo, ma ne ricava una conclusione
opposta e propone una “scienza” consapevolmente etnocentrica
(una sorta di ossimoro, direi) e tetragona ad accogliere contributi
dagli out-groups, a meno che non siano consonanti174 con la propria concezione della realtà. Questa seconda posizione risulta,
probabilmente, presente sia al livello del discorso comune175 che a
quello accademico176 e si caratterizza per la confusione che tende
a operare fra i concetti di storiografia e di memoria storica.177 Si
172
Cfr. ad es. MALIGHETTI R., s.v. Etnocentrismo critico, in FABIETTI U.-REMOTTI
F. (a cura di), op. cit., p. 274.
173
Cfr., ad es., GEERTZ C., L’io testimoniante. I figli di Malinowsky, in ID., Opere e
vite L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna 1995 (1992), pp. 101-102. Vd.
anche supra nt. 31.
174
Cfr. TRENTIN R., Gli atteggiamenti sociali, in ARCURI L. (a cura di), op. cit., pp.
274-281, soprattutto a p. 276.
175
Vd. ad es. DAWSON CH., op. cit., p. 17.
176
La Pernoud scriveva che «per la Sorbona, tra Plotino e Cartesio non c’è
niente» (EAD., op. cit., pp. 49 e 153).
177
Vd. supra nt. 124.
73
Franz Brandmayr
tratta di un salto di qualità che, sempre a detta degli antropologi,
può provocare il passaggio a una versione «ideologica» dell’etnocentrismo; è quanto si verificherebbe allorché venisse teorizzata
consapevolmente una presunta superiorità della propria cultura
di appartenenza rispetto alle culture “altre”178. A un etnocentrismo spontaneo si sostituirebbe, allora, una costruzione sociale
più dottrinaria, solitamente pianificata e promossa da agenzie e
da gruppi di interesse,179 che intendono porsi a capo o – comunque – concorrere all’elaborazione di un processo di autoaffermazione o addirittura di egemonizzazione180 rispetto a culture o subculture altre percepite come antagonistiche.181
Esiste, però, una terza via, quella dell’“etnocentrismo critico” prefigurato da Ernesto de Martino182 e rielaborato da Vittorio Lanternari183. In poche parole, partendo dal dato inevitabile
dell’etnocentrismo, si tratterebbe di operare delle concettualizzazioni che consentano, tanto allo storico quanto allo studente,
di «defamiliarizzarsi»184 rispetto ai propri paradigmi valutativi e
di simpatizzare185 con quelli altrui, dopo averli conosciuti attraverso lo spoglio documentario e i testi specialistici (lo storico o,
178
TULLIO-ALTAN C., Antropologia, cit., p. 70.
Cfr. COLOMBO E., Le società multiculturali, Carocci, Roma 2002, pp. 53-57;
FABIETTI U., L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Carocci, Roma
19982 (1995), pp. 33-34.
180
AIME M., s.v. Egemonia, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), op. cit., pp. 256-257.
181
Cfr. il concetto di “acculturazione” in CUCHE D., op. cit., pp. 63-83.
182
DE MARTINO E., La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali,
Einaudi, Torino 1977, pp. 396-397.
183
LANTERNARI V., Ernesto De Martino, etnologo meridionalista: vent’anni dopo, in
“L’Uomo”, 1, 1977, pp. 29-56.
184
Cfr. CLEMENTE P., Lontananze vicine: sui modi di pensare e insegnare l’antropologia
nel mondo globale, in PASQUINELLI C., (a cura di), op. cit., p. 167.
185
Vd. infra paragrafo 3.
179
74
Medioevo: un pregiudizio secolare
eventualmente, il docente) o, più modestamente, attraverso i
manuali (lo studente).
2.3. Effetto alone, selettività, tautologia ed etnicità
Per le cause già accennate sopra186 il Medioevo costituisce un
complesso di contenuti didattici che si presta in modo particolare a subire l’azione dell’effetto alone, cioè la tendenza del soggetto inquirente a «lasciarsi guidare da un’impressione generale
o da un tratto emergente»187 invece che da una totalità di fatti
rilevati empiricamente e analizzati nei loro rapporti reciproci.
Nei dialoghi didattici in aula – come ogni insegnante sa bene –
è molto frequente emergano dagli studenti (solo da loro?) “sintesi” piuttosto stereotipate su tematiche che abbisognerebbero
di trattazioni ben più articolate, più ricche di sfumature e, soprattutto, con un riferimento più preciso alla documentazione
relativa all’oggetto di studio.188
Quando si spiega, ad esempio, che le critiche più risolute all’azione dei tribunali dell’Inquisizione durante la “crociata degli
albigesi”189 provengono dall’interno della Chiesa, gli studenti perplessi – almeno all’inizio – scoprono essere la Chiesa un organismo piuttosto complesso e multivoco, dove – nella fattispecie –
gli inquisitori domenicani incontravano una forte opposizione da
parte dei vescovi nelle diocesi dei quali si trovavano a operare,190
186
Cfr. supra paragrafo 1.
MANDL H., s.v. Alone/effetto, in ARNOLD W.-EYSENCK H.J.-MEILI R. (a cura
di), op. cit., p. 61.
188
PERNOUD R., op. cit., pp. 144 e 173.
189
Metto fra virgolette l’espressione, perché il termine “crociata” è moderno
(ivi, p. 141, nt. 13).
190
CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., pp. 36 e 40; DEDIEU J.-P., op. cit., pp. 1416 et alibi.
187
75
Franz Brandmayr
in cui Domenico di Guzmàn stesso «non era favorevole all’uso
della forza» e nel quale «anche la popolazione cattolica (della
Linguadoca) detestava l’istituzione inquisitoria, perché simboleggiava un’occupazione mal sopportata»191. All’interno della Chiesa, del resto, non si era mai inaridita nei secoli una corrente di
pensiero192, spesso perdente, ma mai priva di influenza, che caldeggiava linee d’azione missionaria non-violente direttamente
improntate al vangelo, piuttosto che alla Realpolitik ritenuta funzionale al governo della societas christiana.
Francesco d’Assisi e Domenico, personaggi carismatici personalmente propensi alla predicazione pacifica,193 la popolazione cattolica del Mezzogiorno francese insofferente nei confronti
degli eserciti del re e dei grandi feudatari del Nord (a loro volta
cattolici), veri vincitori politico-militari della crociata degli
albigesi,194 le gerarchie ecclesiastiche e civili locali sovente vicine ai borghesi catari195 e ostili ai domenicani forestieri, le indicazioni – spesso mitigatrici nei toni196 – provenienti dai papi di
Roma… Si fa presto a dire: “Chiesa”. Dov’è la Chiesa qui? È la
Chiesa gerarchica? Ma, in questo modo, il concetto risulta
pregiudizialmente valutativo, come ora cercherò di chiarire. È la
191
Ivi, p. 18 (parentesi mia).
Cfr. ad es. CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p. 65; DEDIEU J.-P., op. cit., p.
12. FLORI J., Le crociate, cit., pp. 13-16 preferisce, invece, mettere in evidenza
il processo di «sacralizzazione della guerra» interno alla Chiesa, completatosi
dopo l’anno Mille in seguito al processo di acculturazione verificatosi nel
plurisecolare contatto fra la Chiesa stessa e le popolazioni germaniche.
193
DEDIEU J.-P., op. cit., p. 12.
194
CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p. 32; DEDIEU J.-P., op. cit., p. 17. Al di là
della crociata degli albigesi, sul rapporto potere politico/Inquisizione e
sull’egemonizzazione di questa ad opera degli Stati, vd. CARDINI F.-MONTESANO
M., op. cit., pp. 36, 49, 81-98 e 159; DEDIEU J.-P., op. cit., pp. 12-27.
195
Ivi, p. 19 et alibi.
196
Cfr. CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p. 32; DEDIEU J.-P., op. cit., p. 18.
192
76
Medioevo: un pregiudizio secolare
“Chiesa spirituale”197 dei santi succitati? Oppure dobbiamo espellerne Domenico, come fa qualcuno, per le nefandezze ascritte
al suo ordine? Eppure non è infrequente il caso dei domenicani
che, proprio perché giudicano in favore del presunto eretico, si
inimicano l’autorità civile e la popolazione locale propense all’esecuzione.198 Ciò sembra confermare ulteriormente l’opportunità che l’evento storico della cosiddetta “crociata” venga letto con una serie più articolata di chiavi di lettura. Infatti, non
sempre vengono considerate, accanto alle istanze omologatrici199
della Chiesa, che certo sussistono, anche le dinamiche locali (conflitti di potere, la concorrenza economica interna a una classe
mercantile in espansione, risentimenti personali, vendette politiche200 ecc.), oltre alle mire espansionistiche del re di Francia e
dei suoi feudatari settentrionali.
Ma, se identifichiamo la Chiesa con le sue élites dove collochiamo, in questo caso, la Chiesa della religione popolare, tanto
rivalutata dalla più matura storiografia degli ultimi decenni201 e
che coinvolge la gran parte delle popolazioni europee di allora?
Che cosa intendono gli autori dei manuali designando l’istituzione ecclesiale? E il docente? E che cosa coglie, in tutto ciò, lo
studente? Si tratta, direi, di uno dei numerosi casi in cui un’etichetta categoriale, il vocabolo “Chiesa”, che viene ingiustificatamente a designare le generiche “gerarchie” (quali poi? quelle
del clero regolare o di quello secolare? tutte e due?), si estende a
197
Mi riferisco al noto concetto della tradizione gioachimita (cfr. POTESTÀ
G.L., s.v. Gioacchino da Fiore, in AA.VV., Enciclopedia Garzanti, cit., p. 357).
198
CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p. 54.
199
Ivi, p. 160.
200
Ivi, p. 35.
201
Per una bibliografia introduttiva vd., ad es., GUREVIČ A.J., op. cit., passim;
MANSELLI R., op. cit., passim e SCHMITT J.C., Religione folklore e società nell’Occidente
medievale, Laterza, Bari 1988 (anno), passim.
77
Franz Brandmayr
coprire semanticamente un’ampia serie di altri sottoinsiemi (dei
quali ho elencato una parte) compresi nella societas ecclesiale.
Non si tratta, tuttavia, di un’estensione semantica dalle conseguenze meramente teoriche e oziose: se ne può ricavare una
generica impressione di monolitismo ecclesiale che, storicamente, non si è assolutamente dato. L’effetto alone, in questo
modo, pare assicurato: i «tratti (che si vorrebbero) emergenti»
del potere e della violenza assorbono in un unico lemma omologante tutta una pluralità di diverse componenti sociali, culturali e politico-militari (clero/popolo, clero regolare/clero
secolare, clerici/bellatores, borghesi/popolo, alto clero/basso
clero, monarchia francese/papato, re e grandi feudatari del
Nord della Francia/feudatari meridionali, inquisitori/non-inquisitori ecc.), nessuna delle quali, fatte salve le élites più consapevoli dei catari,202 avrebbe mai rinunciato alla propria prerogativa di appartenere alla cristianità.
Pertanto, applicando il concetto di Chiesa senza una definizione precisa dei suoi contorni sociologici, non è impossibile
che esso perda di consistenza e si riduca a una mera etichetta
categoriale. In questo modo il ricercatore, il docente o lo studente sono esposti a una serie di rischi teoretici: a) il riduzionismo
della comunità ecclesiale a una sua parte: la gerarchia, e ciò – di
solito – senza un’adeguata motivazione metodologica; b)
l’anacronismo di un dualismo radicale203 clero/laicato,204 la cui
radice socio-culturale è decisamente moderna, viene proiettato
202
Nel catarismo «strutturatosi in modo mimetico rispetto all’organismo ecclesiastico egemone» (MERLO G.G., op. cit., p. 45) i simpatizzanti tendevano a
riconoscere nei «perfetti» semplicemente dei «buoni cristiani», senza rendersi sempre conto del fatto che si trattasse di una religione dualistica e diversa
dal cristianesimo.
203
Cioè l’antitesi inconciliabile di due entità concepite come opposte (VIGLINO
U., s.v. Dualismo, in AA.VV., Enciclopedia Cattolica, cit., vol. IV, c. 1942).
204
Cfr. GRAFF H.J., op. cit., pp. 104, 111 e 113.
78
Medioevo: un pregiudizio secolare
nel XIII secolo,205 epoca nella quale era – al contrario – nettamente dominante una concezione ecclesiale sì dialettica,206 ma
anche fortemente unitaria;207 c) l’affermazione di una sorta di
univocità del gruppo-Chiesa e la complementare obliterazione
dell’esistenza di un pluralismo di culture e subculture ecclesiali,
di cui la storiografia dà abbondante testimonianza; d) la perdita
di concretezza storica dovuta al misconoscimento della
microstoria e della storia locale, che – della crociata – offrono
molte varianti contraddittorie rispetto alla «leggenda nera».208
205
TORTAROLO E., Laicismo, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 11-13.
Cfr. REINHARD W., Storia dello stato moderno, Il Mulino, Bologna 2010 (2007),
p. 58.
207
Cfr. il concetto di «unipolarità» del «corpo della Chiesa» (ULLMANN W., op.
cit., p. 24).
208
DEDIEU J.-P., op. cit., p. 6. Trattare a fondo la questione dell’Inquisizione e
dei diritti umani (cfr. supra paragrafo 1.1.) non fa parte degli scopi di questo
saggio, pertanto mi limito a una brevissima serie di riferimenti forse indicativi di un certo uso della storia poi concretizzatosi nella “leggenda nera”.
Può essere interessante rilevare, ad esempio, la comminazione della condanna a morte al “solo” (non si tratta comunque di una vittoria della civiltà…)
1% degli imputati da parte del tribunale dell’Inquisizione di Tolosa nella
seconda metà del Duecento (DEDIEU J.-P., op. cit., p. 18); questo 1 % va ridotto ulteriormente, in quanto è certo che la condanna spesso si risolveva in un
pentimento dell’ultima ora davanti al patibolo. La «moderazione» degli inquisitori si concretizzava, inoltre, anche con la risoluzione pro reo in dubiis
(CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p. 57), con una pratica della tortura che –
a differenza da quella esercitata dai poteri laici – non doveva portare alla
morte (ivi, p. 61), né alle mutilazioni (ivi, p. 55), che era sottoposta a limitazioni e controlli (ivi, pp. 63 e 65), a sospensioni e annullamenti (ivi, p. 62). La
tortura – ancora – praticata dagli Stati fino al XVIII secolo, secondo alcuni
autori fu «forse» poco usata, «perché raramente documentata» [PAOLINI L., Il
modello italiano nella manualistica, in AA.VV., L’Inquisizione, Atti del Simposio
internazionale (29-31 ottobre 1998) Città del Vaticano, Roma 2003, p. 101].
Senza misconoscere l’esistenza di una certa letteratura che tende a minimizzare la portata delle vicende delle Inquisizioni, Cardini ricorda che il confronto sulla tortura va fatto con i contemporanei [ivi, p. 64; cfr. anche LE
206
79
Franz Brandmayr
Può essere di qualche utilità notare come di tutti questi aspetti
descrittivi, che rendono problematica l’interpretazione della crociata degli albigesi e dell’Inquisizione, il già citato manuale di
Giardina, Sabbatucci e Vidotto non riporti praticamente nulla.209
Una consapevolezza più profonda della matrice etnicoidentitaria del conflitto e della strumentalità dell’alibi religioso
dei «Franchi», portatori della cultura feudale del Nord francese e lanciati alla conquista della civiltà urbana «romana» della
Linguadoca, traspare – invece – in un testo recente,210 nel quale si afferma a chiare lettere che «la crociata contro gli albigesi
appare un momento significativo nel processo di consolidamento territoriale della monarchia francese»211. Per il resto,
però, neanche De Bernardi e Guarracino consentono allo studente del XXI secolo, a mio avviso, di comprendere come mai,
in una istituzione che si proclamava fondata sul Vangelo, una
consistente parte delle gerarchie e degli intellettuali potesse
non trovare abominevole l’impiego della coercizione violenta
e di massa nella propria pratica pastorale.212 Non vi si trova
alcun riferimento al Decretum Gratiani,213 uno dei documenti
fondamentali del Medioevo, nessun richiamo al concetto di
GOFF J., La nascita del Purgatorio, Einaudi, Torino 19962 (1981), p. 248; vd.
supra al paragrafo 2.2. le osservazioni sugli anacronismi] e che i dati quantitativi
sull’Inquisizione sono ancora carenti (CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p.
158) e, pertanto, anche gli storici rischiano di subire l’influenza dell’effetto
alone (cfr. DEDIEU J.-P., op. cit., p. 76).
209
Cfr. GIARDINA A.-SABBATUCCI G.-VIDOTTO V., Uomini, cit., pp. 89-94.
210
DE BERNARDI A.-GUARRACINO S., I saperi della storia. 1. Dalla società feudale alla crisi
del Seicento, Paravia Bruno Mondadori, Milano 2006, p. 72; gli Autori evitano,
peraltro, di menzionare le numerose vittime cattoliche delle stragi perpetrate dai
Franchi (cfr. DE ROSA G., Storia medioevale, Minerva Italica, s.l., 19823, p. 187).
211
DE BERNARDI A.-GUARRACINO S., op. cit., p. 73.
212
Ivi, pp. 70-73.
213
DE ROSA G., op. cit., pp. 188-189.
80
Medioevo: un pregiudizio secolare
società olistica214 né al delitto di lesa maestà,215 nessuna vera
esplorazione della mentalità medievale, nessuno sforzo
ermeneutico: l’“Altro” rimane distante e fissato nella sua riprovevole estraneità, resa in maniera quasi caricaturale.
Eppure già il De Rosa, ad esempio, nel suo vecchio manuale
aveva proposto un’interpretazione che non sembrava affatto una
giustificazione.216 Che l’avesse fatto con spirito apologetico, in
quanto studioso di matrice cattolica? La storiografia si ridurrebbe, allora, a una noiosa sequenza di polemiche da quotidiano sportivo, con la “curva nord” a disputare con la “curva sud” intorno
al comportamento arbitrale? Comprendere significa forse giustificare? Un approccio ermeneutico comporta necessariamente il
condividere i valori e le scelte dell’“avversario”? Domande
senz’altro retoriche, ma la cui riproposizione pare essere tutt’altro
che fuori luogo in una temperie culturale nella quale vengono
giustamente denunciati tanto gli usi e abusi della storia quanto il
dilettantismo. Perciò su quest’argomento dovrò ancora insistere
più avanti, ma – nel frattempo – possiamo rilevare anche nei casi
ora richiamati il persistente riprodursi delle dinamiche
etnocentriche e psicosociali che andiamo analizzando.
Certo, le esigenze di sintesi didattica richiedono inevitabilmente il ricorso a espedienti, che scoprono il fianco a questo
genere di difetto: con gli studenti – si dice – non sempre si può
entrare in un dettaglio troppo analitico. L’effetto alone, in ogni
caso, rivela meglio la sua qualità affabulatoria se esaminato
unitamente a un’altra caratteristica che, non di rado, accompa-
214
MATERA V., s.v. Olismo/individualismo, in FABIETTI U.-REMOTTI F., op. cit., pp.
531-532.
215
CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p. 9.
216
DE ROSA G., op. cit., pp. 188-189; certo, lo storico siciliano mi dà talvolta
l’impressione di non volere scendere troppo nei particolari di questo nodo
storico scabroso.
81
Franz Brandmayr
gna le narrazioni sul Medioevo: si tratta dell’«esposizione
selettiva»217. Essa consiste nella
tendenza delle persone a cercare informazioni congruenti con i
loro sentimenti, credenze e comportamenti passati e ad evitare
attivamente quelle incoerenti o dissonanti.218
Alla reticenza ad ascoltare ciò che non collima con le proprie
idee si associa, in maniera complementare, l’«aspettativa
stereotipica»219, che induce il soggetto a rilevare nell’oggetto del
suo studio solo ed esclusivamente i tratti culturali, che sarebbe
stato disposto a reperire fin dal principio.
Vediamo ancora qualche esempio.
Caprara scrive ancora del “triste panorama” offerto dalle
scienze astronomiche di allora. «Ne era responsabile la diffusione del cristianesimo che […] imponeva la descrizione (sic)
della Bibbia e del capitolo (sic) della Genesi»220. A prescindere
dall’incompetenza circa gli aspetti esegetico-biblici e dal grave
errore cronologico dell’attribuzione di un potere impositivo
alla Chiesa del Terzo secolo (notoriamente oppressa dalle au-
217
GILI G., op. cit., pp. 42 ss. ne scrive collegando l’esposizione con gli altri
due meccanismi selettivi della percezione e della memorizzazione.
218
TRENTIN R., Gli atteggiamenti sociali, in ARCURI L. (a cura di), op. cit., p. 276.
219
ID., Percezione e cognizione sociale, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 127.
220
CAPRARA G., op. cit., p. 42. Non è qui possibile esplicitare nei dettagli
l’erroneità del linguaggio del Caprara: basti ricordare che, in un’opera di divulgazione scientifica, risulta quantomeno equivoco riferirsi a una narrazione cosmogonica con il termine di «descrizione» (cfr. ABBAGNANO N., s.v. Descrittivo, in ID., op. cit., p. 218), che risulta certamente inadeguato per esprimere il significato [BONORA A., s.v. Cosmo, in ROSSANO P.-RAVASI G.-GIRLANDA
A. (a cura di), Nuovo dizionario di teologia biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 20017 (1988), pp. 327-328] dei due “racconti della creazione” compresi
nei primi tre capitoli della Bibbia.
82
Medioevo: un pregiudizio secolare
torità imperiali)221, risalta fin dal primo impatto con il testo la
selezione operata dall’Autore, che – fra tutte le dottrine soteriologiche orientali, coinvolgenti e ricche di cosmogonie e di
riferimenti cosmologico-escatologici i più immaginifici,222 di
cui la civiltà romana (ormai priva di riferimenti valoriali significativi)223 è assetata – sceglie il cristianesimo ed esso soltanto
come causa dell’oscurantismo anti-astronomico. A una contestualizzazione (è la soluzione migliore?) o a una attenuazione
dei toni [es.: la Chiesa (ovviamente quella teodosiana e postteodosiana, dal 391 in poi) «concorre a promuovere una concezione creazionistica» (e chi non lo faceva, allora?)] o a una
estensione delle corresponsabilità (se proprio si deve studiare
il passato per cercare dei colpevoli, non è meglio trovarli tutti?), il Caprara preferisce forse «dare informazioni congruenti
con i propri sentimenti ed evitare quelle incoerenti o dissonanti» rispetto agli stessi? In un eventuale sviluppo di questa
indagine sarebbe opportuno riprendere questo quesito, per riconnetterlo agli attuali usi e abusi della storia finalizzati a possibili strumentalizzazioni nella sfera pubblica. Questa argomentazione iniziale dell’Autore sembra essere il preludio interpretativo di più di un millennio di scienza e tecnica e, infatti, il Medioevo narrato dal nostro si caratterizzerà per una serie di carenze, o di “oscuramenti”, frutto di operazioni che
noi, fino a prova contraria, non vogliamo pensare come dolosamente falsificanti bensì come inconsapevolmente selettive.
221
È il secolo delle dure persecuzioni di Simplicio Severo, di Decio e Valeriano
[FRANZEN A., Breve storia della Chiesa, Queriniana, Brescia 19825 (1965), pp. 57-61].
222
CUMONT F., Le religioni orientali nel paganesimo romano, Laterza, Bari 1967
(1913), pp. 56-58; vd. anche ELIADE M., Paganesimo, cristianesimo e gnosi all’epoca
imperiale, in ID., Storia delle credenze e delle idee religiose, II, Da Gautama Buddha al
trionfo del Cristianesimo, Sansoni, Firenze 1980 (1978), pp. 363-394.
223
CUMONT F., op. cit., p. 54.
83
Franz Brandmayr
Ad esempio, nel suo volume non vi è alcuna menzione del
fatto che il Medioevo riconobbe il valore delle arti meccaniche224
e che lo fece «investendo le arti pratiche di un significato spirituale»225, per il quale «venne loro conferita una nuova dignità»226. Né
il Caprara scrive che a compiere questo passo sotto il profilo
teorico è l’abate-filosofo Giovanni Scoto Eriugena, che nel IX
secolo equipara il lavoro manuale a quello intellettuale227 e opera – con ciò – una netta rottura epistemologica sia nei confronti
della civiltà classica che rispetto al pensiero di Agostino
d’Ippona.228 Nella società «ecclesiologica»229 dell’alto Medioevo,
infatti, il fine di ogni vita, che non può essere altro che vita
cristiana, è: divenire “immagine e somiglianza di Dio”, e ciò si
realizza anche attraverso il lavoro.230 Già a partire dal VI secolo
224
Associandole per dignità a quelle liberali (LE GOFF J., Il Medioevo, cit., p. 71).
NOBLE D.F., op. cit., p. 17.
226
DOLZA L., op. cit., p. 52.
227
NOBLE D.F., op. cit., p. 20; Dolza, invece, sembra situare nel secolo XII,
quello della Rinascenza, questo passaggio assai importante sotto il profilo
teorico-filosofico: secondo la storica sarebbe stato Ugo da San Vittore a
«colloca[re] le arti meccaniche nell’ambito del sapere» nelle sue opere intitolate Didascalicon ed Epitome Dindimi in philosophiam (DOLZA L., op. cit., p. 57;
parentesi quadrata mia). In Noble (ivi, pp. 24-26) gli scritti di Ugo sembrano
avere piuttosto un valore di rinforzo e di amplificazione, nella mutata temperie
culturale, dei contenuti elaborati da Giovanni Scoto. Cfr. anche LE GOFF J.,
Lavoro, tecniche e artigiani nei sistemi di valore dell’alto Medioevo (V-X secolo), in ID.,
Tempo, cit., (1971), p. 90, che avvalora la posizione di Noble.
228
NOBLE D.F., op. cit., p. 21. Come è noto, Agostino, già manicheo e – comunque – neoplatonico anche dopo la conversione, manifesta un atteggiamento non particolarmente positivo verso la materia in generale e il lavoro
manuale in particolare (DOLZA L., op. cit., pp. 47-48; cfr. NOBLE D.F., op. cit.,
14-15 ); in definitiva egli non sembra discostarsi dalla posizione classica, che
fa prevalere le arti liberali su ogni altra forma di attività umana.
229
ULLMANN W., op. cit., p. 12 et passim.
230
DOLZA L., op. cit., p. 51. Cfr. infra le nt. 314 e 321.
225
84
Medioevo: un pregiudizio secolare
le comunità benedettine, con il loro celebre motto ora et labora,
si sforzano di tradurre questa concezione del mondo in comportamenti conseguenti, con la ferma convinzione che l’attività
pratica e la tecnica servano i disegni divini, oltre che la stessa
comunità monastica.231 In questo modo
l’ideologia del lavoro viene riscattata positivamente dal cristianesimo e sarà determinante anche per la nascita e la diffusione […]
dei mestieri;
sarà dunque la progressiva evangelizzazione dell’Europa a modificare l’attitudine dell’uomo medievale verso il lavoro manuale,232 il quale assumerà – in questo modo – un «significato spirituale»233 in tutta l’area cristianizzata. Persino gli attrezzi da lavoro, in particolare quelli prodotti con il ferro o con parti in ferro,234 vengono assimilati dalla Regola benedettina agli stessi vasi
sacri.235 Marc Bloch non teme di scrivere che le
acquisizioni e invenzioni (medievali) portano, a ben vedere, la
stessa testimonianza: quella di una notevole agilità delle mani,
dello sguardo e dello spirito. In questa capacità di rinnovamento,
diffusa sin nelle masse degli artigiani, come non riconoscere una
delle fonti di quella grandezza europea che fu vista sorgere, con
231
DOLZA L., op. cit., p. 50.
Ivi, p. 51; sull’importanza del lavoro già agli inizi del monachesimo copto
vd. LAWRENCE C.H., op. cit., pp. 35 e 64.
233
NOBLE D.F., op. cit., p. 17; sarà l’umanista Petrarca a manifestare un rinnovato disprezzo verso il lavoro manuale (FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI M.,
op. cit., p. 230).
234
Nella storia delle religioni sono conosciuti i significati simbolici attribuiti
alla figura del fabbro [ELIADE M., Storia delle credenze e delle idee religiose, I, Dall’età della pietra ai misteri eleusini, Sansoni, Firenze 1996 (1975), pp. 65-68].
235
LE GOFF J., Lavoro, cit., p. 86.
232
85
Franz Brandmayr
uno slancio così prodigioso, dal seno dei torbidi più gravi? L’homo europaeus, in altri termini, fu per eccellenza un homo faber.236
Il «gusto dell’esperimento»237, la sete di scoperta e di ricerca
che porterà gli europei alla conquista del mondo,238 l’ingegno e
l’abilità meccanica tali da raggiungere «risultati tecnici moderni»239 non sembrano giustificare l’appellativo di “zotico e incolto”240 attribuito all’uomo medievale. Si può giustamente porre
l’obiezione che i riferimenti dei nostri storici sembrano calcare
l’accento sulla dimensione della tecnica più che su quella della
scienza, tuttavia già nel 1959 Butterfield osservava che
si comincia ora a comprendere che la storia della tecnica ha, nello sviluppo del movimento scientifico, una parte più importante
di quanto si reputasse un tempo.241
Ancora, a un uomo medievale esageratamente rappresentato come alienato e proiettato verso attese ultraterrene,242 Garin
236
BLOCH M., Le “invenzioni” medievali, in ID., Lavoro, cit., p. 210; parentesi mia.
ID., Le “invenzioni”, cit., pp. 204-205.
238
DOLZA L., op. cit., p. 83.
239
BUTTERFIELD H., Le origini della scienza moderna, Il Mulino, Bologna 1998
(1958), p. 110.
240
Cfr. PERNOUD R., op. cit., p. 45.
241
BUTTERFIELD H., op. cit., p. 110.
242
Sul «dualismo tra l’“aldilà” e l’“aldiquà” che la maggior parte degli storici attuali riduce sbrigativamente a evasione dal mondo» (CARMO FELICIANI
S., Introduzione, cit., p. 8) pare concentrarsi con una certa insistenza forse
anche Le Goff (cfr., ad es., ID., Lavoro, cit., pp. 75 e 85 e ID., Medioevo, cit.,
p. 23), che – in quei casi – sembra tenere in scarso conto il giovanneo
Verbum caro factum est e le conseguenze storiche che ne sono derivate; eppure sul cattolicesimo inteso come fomite della «religione della tecnologia»
(cfr. NOBLE D.F., op. cit., passim) e «del lavoro» (cfr. infra nt. 354) pare concordare anche lo storico francese.
237
86
Medioevo: un pregiudizio secolare
sembra restituire il suo spirito d’invenzione e la sua attitudine
alla ricerca, a perseguire la conoscenza e ad aderire alla realtà
concreta.
Quando, liberati da una pericolosa eredità illuministica, gli storici della filosofia avranno imparato a valutare in pieno, nel suo
reale significato, l’enorme produzione medievale medico-magica, astrologica, alchimistica, ci renderemo, credo, conto di una
esigenza di congiungere la cognizione […] delle cose con la trasformazione di esse secondo i bisogni umani: di far convergere
continuamente teoria e pratica, tecnica e scienza: di afferrare un
ordine esistente, ma per modificarlo.243
Prendiamo ora in esame un altro aspetto della cultura diffusa: l’alfabetizzazione, senza la quale, sottolineano due fra i massimi studiosi della tradizione orale, non avrebbe potuto sussistere una logica lineare,244 quella stessa che ha contribuito al
decollo culturale, sociale ed economico dell’Europa.245 In relazione a questo vasto campo voglio qui richiamare la rilevanza,
anche a giudizio di Le Goff,246 dell’estendersi dell’istruzione
commerciale e giuridica nel periodo che va dall’XI al XIII secolo. Laici appartenenti alla nascente classe media dei commercianti, dei notai e degli avvocati fondarono scuole con curricula
propri.247 L’offerta formativa, come la si chiamerebbe oggi con
243
GARIN E., op. cit., p. 25; cfr. anche PERNOUD R., op. cit., p. 30.
GOODY J., Il potere della tradizione scritta, Bollati Boringhieri, Torino 2002
(2000), pp. 88-94; cfr. ONG W.J., op. cit., p. 89.
245
Cfr. CIPOLLA C.M., Vele e cannoni, Il Mulino, Bologna 19993 (1965), p. 87;
DAWSON CH., op. cit., p. 20; LE GOFF J., Il Medioevo, cit., p. 69.
246
Vd. infra nt. 253.
247
CIPOLLA C.M., Istruzione e sviluppo. Il declino dell’analfabetismo nel mondo occidentale, Il Mulino, Bologna 2002 (1969), pp. 51ss; GRAFF H.J., op. cit., pp. 110
e 125-126.
244
87
Franz Brandmayr
espressione mercantile, aumentò la propria diversificazione in
svariate zone geografiche europee toccate dal fenomeno dell’urbanesimo e ciò al punto di determinare nel XII secolo una
sorta di competizione fra le scuole monastiche e quelle secolari.248 Graff riporta l’esempio inglese del secolo XIII, quando
esisteva una vasta gamma di istituti: Grammar Schools, scuole cattedrali, scuole di monastero, scuole di chiese collegiate,249 Hospital
Schools, scuole di gilda, scuole comunali, cappellanie, scuole parrocchiali primarie, oltre a varie scuole specialistiche (di canto, di
scrittura, di lettura) e ad altre opportunità informali.250 Oramai
nell’Inghilterra del XIII secolo
reali, nobili, cavalieri, mercanti ed ecclesiastici erano nella stragrande maggioranza in grado di leggere e scrivere. Fra gli artigiani l’alfabetizzazione era divenuta più diffusa, ma restava molto
lontano dall’essere universale. Fra i contadini dovette rimanere
cosa rara, ma non del tutto impossibile.251
Il fatto può lasciare freddo l’osservatore contemporaneo,
abituato all’attuale velocità del mutamento sociale, ma non è
certo questo sguardo assuefatto quello che permette di cogliere
lo specifico medievale; all’occhio incapace di guardare con partecipazione252 il fenomeno storico del deciso ampliamento delle
percentuali di alfabetismo rischia di sfuggire la rivoluzione cul-
248
LAWRENCE C.H., op. cit., pp. 193-195.
«Dal latino collegium, “associazione”. Chiesa che possiede un capitolo di
canonici, di solito regolari, pur senza essere la sede di un vescovato»
[BARBERO A.-FRUGONI C., Dizionario del Medioevo, Laterza, Roma-Bari 20022
(1994), p. 78].
250
GRAFF H.J., op. cit., pp. 136-137.
251
Ivi, p. 133.
252
Vd. infra paragrafo 3.
249
88
Medioevo: un pregiudizio secolare
turale, che – secondo Graff – si sarebbe verificata fra il X e il
XIII secolo: «una cosa molto più nuova di quanto non sarebbe
diventata più tardi»253. Viene compresa – per la prima volta a un
livello massivo – l’utilità dell’istruzione «per la partecipazione, il
servizio, il potere»254. Persino la cultura cavalleresca non è più
ostile255 alle lettere e all’alfabetizzazione256.
A questo proposito Ullmann scrive del riuscito amalgama
degli elementi cristiani, romani e germanici, anche se questi ultimi «dovettero cedere alla autorità della dottrina e del dogma»257.
Parafrasando la celebre battuta di Stalin, secondo il quale lo Stato del Vaticano disponeva di troppo poche divisioni per impensierirlo, gli storici solitamente sono propensi a credere che – più
che imporre la dottrina e il dogma – la Chiesa abbia piuttosto
esercitato una costante pressione culturale e sociale sulle aristocrazie germaniche e che lo abbia fatto soprattutto per mezzo
del “cavallo di Troia” rappresentato dai numerosi membri della
nobiltà, che nel corso di tutto l’alto Medioevo ingrossarono le
file di quelli che furono alfine chiamati gli oratores e, in questo
253
GRAFF H.J., op. cit., p. 107. «La lettura si diffonde ben prima della galassia
Gutenberg e l’alfabetizzazione – è il fenomeno culturale che più conta – non
attende l’invenzione della stampa» (LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., p. XX).
254
GRAFF H.J., op. cit., p. 107.
255
Per una serie di indicazioni introduttive circa il lento evolvere delle culture
germaniche da una tradizione orale alla loro «romanizzazione» (cfr. ULLMANN
W., op. cit., p. 29) vd., ad es., BARBERO A., Santi laici e guerrieri. Le trasformazioni
di un modello nell’agiografia altomedievale, in BARONE G.-CAFFIERO M.-SCORZA
BARCELLONA F. (a cura di), Modelli di santità e modelli di comportamento, Rosenberg
& Sellier, Torino 1994, p. 127; CHABOD F., op. cit., p. 38; CIPOLLA C.M., Istruzione, cit., pp. 47-48; DAWSON CH., op. cit., pp. 89-131; ELIADE M., La nascita
mistica, Morcelliana, Brescia 19883 (1958), pp. 125-130; ID., Storia, cit., pp.
164-166; cfr. anche PERNOUD R., op. cit., p. 55.
256
GRAFF H.J., op. cit., pp. 120, 122 e 128.
257
ULLMANN W., Radici, cit., p. 29.
89
Franz Brandmayr
modo, portando i bellatores a un grado di crescente mitigazione
dei loro costumi violenti.
A ciò contribuisce anche l’epoca aurea del monachesimo benedettino (secoli XI-XII), durante la quale si diffonde fra i cadetti
dell’aristocrazia una modalità culturale, fatta di preghiera e di studio (e non più soltanto guerresca) di affermazione del proprio
«onore».258 Questo nuovo atteggiamento della classe dei cavalieri
si manifesta anche nel crescente prestigio che la città e la classe
borghese sembrano assumere ai loro occhi ad esempio in alcune
opere della giovane letteratura volgare in lingua d’oil.259
Nell’Occidente europeo lettere e alfabetizzazione riacquistano
finalmente, abbiamo visto, un prestigio sociale oramai da lungo
tempo perduto e che rimarrà un’acquisizione definitiva della
cultura occidentale:
La gente incominciò ad attribuire un connotato negativo all’analfabetismo e in prosieguo di tempo gli analfabeti furono sempre
più considerati inadatti ad un numero sempre crescente di attività sociali ed economiche.260
Con l’alfabetizzazione aumentano la coerenza dottrinale cristiana e, ad un tempo, lo spirito critico,261 mentre
con il secolo XI la Chiesa perse progressivamente il monopolio
dell’istruzione specie in quelle aree dove […] i benestanti […]
solevano assumere tutori privati per […] i loro figli;262
in questo modo, conclude Cipolla, il «principio morale» del-
258
Cfr. MICCOLI G., op. cit., p. 71; GRAFF H.J., op. cit., p. 128.
Vd. LE GOFF J., Guerrieri, cit., passim.
260
GRAFF H.J., op. cit., p. 49.
261
Ivi, p. 126; vd. anche infra le nt. 269, 307-313 e 321-326.
262
CIPOLLA C.M., Istruzione, cit., p. 51; LAWRENCE C.H., op. cit., p. 308.
259
90
Medioevo: un pregiudizio secolare
l’istruzione, fino ad allora «proclamato da uno sparuto gruppo di clerici illuminati, divenne un’idea corrente»263, della quale le istituzioni religiose continuarono a farsi promotrici investendo gran parte delle risorse disponibili264 e con una speciale
attenzione alle classi sociali svantaggiate.265 Se è vero, dunque,
che nei secoli X-XIII «senza la chiesa l’offerta d’istruzione e
alfabetizzazione in Occidente sarebbe stata incredibilmente limitata»266 e se è parimenti vero che fosse quello del clero il
gruppo sociale più colto,267 sembra tuttavia di poter dire con
una certa sicurezza che il basso Medioevo vide in svariate zone
d’Europa268 un laicato autonomo e critico,269 capace di produrre iniziative culturali significative sia all’interno che all’esterno dell’istituzione ecclesiale.
In effetti, soprattutto dopo l’opera fondamentale di
Grundmann,270 gli studi eresiologici di quasi tutte le impostazioni
sottolineano gli aspetti di omogeneità fra le esperienze carismatiche ortodosse (come – ad esempio – il francescanesimo) ed
263
CIPOLLA C.M., Istruzione, cit., p. 50.
GRAFF H.J., op. cit., pp. 113-115.
265
CIPOLLA C.M., Istruzione, cit., p. 50; GRAFF H.J., op. cit., p. 117.
266
Ivi, p. 113.
267
Per la situazione dell’Inghilterra dei secoli XIV e XV, che è fra quelle più
accuratamente studiate, vd. ivi, p. 205. È probabile che l’osservazione possa
venire estesa anche ad altre parti dell’Europa. È opportuno, tuttavia, non
omologare il clero in un’unica categoria socio-culturale: vi è, ad es., chi lo
divide in due (per l’alto Medioevo vd. MANSELLI R., op. cit., pp. 12-13) o quattro gruppi (BURKE P., op. cit., pp. 265-268). Vd. anche supra nt. 98.
268
Probabilmente soprattutto nelle zone più urbanizzate d’Europa, che – nel
periodo dal 1440 al 1492 – erano i Paesi Bassi e l’Italia (BURKE P., op. cit., p. 56).
269
Ad es. MANSELLI R., op. cit., pp. 80-85 scrive di «anticlericalismo» già nei
secoli XI-XIII.
270
GRUNDMANN H., Movimenti religiosi nel medioevo, Il Mulino, Bologna 1980
(1935), passim.
264
91
Franz Brandmayr
eterodosse, colte nel loro insieme come grande e creativa stagione dei movimenti spirituali medievali.271
Appare perciò dai contributi di autori di varia impostazione
un’immagine del Medioevo assai più luminosa e, soprattutto,
differenziata e ricca di sfumature rispetto alle stereotipie di certa manualistica. Di questi (come di altri) importanti passaggi
teorici e descrittivi fondamentali272 nel volume di Caprara non
si trova invece traccia. La Weltanschauung del nostro narratore
sembra sottendere una concezione aprioristicamente e
irreversibilmente antagonistica fra scienza e fede del tutto lecita, naturalmente, nella dimensione noetica personale, ma i cui
presupposti non vengono tematizzati e – tantomeno – discussi
neanche sotto forma di abbozzo larvato.273 Conseguentemente,
in questa prospettiva la religione e la Chiesa sembrano ricoprire
un ruolo esclusivamente oscurantista e retrivo, anche in questo
caso senza che appaia argomentazione di sorta né disamina dialettica in merito; l’assioma sembra innervare la trama della narrazione “in punta di piedi”, come un implicito del discorso, che
poggia sulla sua stessa “ovvietà”, “costruita” con etichette ed
espressioni ritenute familiari e scontate per il lettore.274
La selettività, però, non consiste soltanto nell’eliminare radicalmente tutto ciò che non risulta congruente con il sentire dello scrittore. Vi sono, infatti, nomi ed eventi che – per la loro
271
Vd. ad es. MERLO G.G., op. cit., pp. 16-19 et passim; PERETTO E., Movimenti
spirituali laicali del Medioevo. Tra ortodossia ed eresia, Studium, Roma, 1985, p. 18
et passim. Cfr. anche supra nt. 261 e infra nt. 323.
272
Per i quali rimando alla bibliografia delle note precedenti e a quella contenuta all’interno delle opere indicate stesse.
273
NOBLE D.F., op. cit., p. 5. Per una introduzione filosofica al problema vd.,
ad es., BOGDANOV G.- BOGDANOV I.-GUITTON J., Dio e la scienza. Verso il
metarealismo, Bompiani, Milano 1998 (1991), passim, in cui si propone il dialogo fra un fisico teorico, un astrofisico e un filosofo; cfr. infra anche nt. 280.
274
Vd. supra paragrafo 2.1.
92
Medioevo: un pregiudizio secolare
importanza – non si possono cancellare del tutto. In questo caso
la menzione risulta – in qualche modo – come l’esito di una
selezione effettuata per mezzo di una riduzione dell’alterità alle
categorie proprie della visione del mondo del narratore o,
quantomeno, ad attribuzioni apparentemente “neutre”.
Il britannico Ruggero Bacone inventava gli occhiali.275
Chi non vuole scadere a sua volta nel pregiudizio e nell’errore, che abbiamo definito effetto alone, non può ricavare certo
da un unico indizio la tendenza a celare l’appartenenza al clero
di Roger Bacon e la sua identità squisitamente francescana. Allora insistiamo e più sotto troviamo che
Nel XIII secolo [… (il)] filosofo inglese Ruggero Bacone […]
professava la “scienza come esperimento” e rilevava i gravi errori scientifici contenuti nelle Sacre Scritture, (e) cominciava a porre la “questione del metodo” che è alla base della ricerca.276
Ci accorgiamo, del resto, che qui è in gioco un complesso di
fattori di grande rilievo storico. Si tratta nientemeno che della
genesi remota della scienza sperimentale moderna:277 possibile
che a farsene iniziatore e promotore sia un frate dal cervello
fino? Ciò sembra contravvenire a un certo senso comune, che si
affermerà con decisione molti secoli dopo, secondo il quale i
frati – probabilmente – potrebbero avere altre qualità, ma certamente non quella del raziocinio innovatore. O forse l’Autore
ritiene che l’Opus maius sia frutto solo del Bacone-filosofo, per
cui non occorre mettere in rilievo la (disdicevole?) appartenen-
275
CAPRARA G., op. cit., p. 54.
Ivi, p. 56 (parentesi rotonde mie).
277
DAWSON CH., op. cit., pp. 23 e 285-286.
276
93
Franz Brandmayr
za religiosa del pensatore. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento destabilizzante: pare che a evidenziare «i gravi errori scientifici contenuti nelle Sacre Scritture» sia proprio un soggetto
ben inserito nella Chiesa; in questo modo la compagine ecclesiale sembrerebbe essere composta anche da soggetti capaci non
solo di prescindere dalle auctoritates,278 ma inoltre di innovare, di
pensare criticamente279 (persino sulla Sacra Scrittura!) e di anticipare i tempi proprio sotto il profilo della riflessione intorno
all’ambito scientifico-sperimentale, “notoriamente” appannaggio
del “pensiero laico”.280 Offrire anche questa immagine della società ecclesiale, pertanto, risulta troppo dissonante rispetto a un
copione che pare venga rispettato fedelmente attraverso la semplice omissione di qualche termine identificativo (il “teologo”?
il “filosofo francescano”?). Sottacendo qualche particolare, pertanto, l’Autore ottiene l’effetto di riordinare la trama della propria narrazione secondo uno schema selettivo e consonante281
con la propria pregiudiziale di fondo, ancorata all’idea di una
Chiesa retriva e chiusa al novum.282
278
Cfr. infra nt. 313.
Cfr. supra nt. 261.
280
Uso l’espressione fra virgolette, in quanto topos «della quantità», che richiederebbe un’analisi molto approfondita, per il suo radicamento nel discorso
comune (cfr. supra nt. 151). In mancanza di spazio, invito il lettore alla lettura di
EINSTEIN A., Idee e opinioni. Come io vedo il mondo, Fabbri, Milano 1996 (1957), pp.
187-193. Intorno alle stereotipie connesse al termine “laico” vd. POSSENTI V.,
Le ragioni della laicità, Rubbettino, Soveria Mannelli (CT) 2007, pp. 14-15, che
sottolinea il riduzionismo dell’odierna interpretazione dominante del concetto
a fronte delle sue possibili cinque accezioni. Per rinvenire ancora alcune indicazioni circa questo specifico anacronismo cfr. supra le nt. 204-207.
281
Cfr. supra nt. 174.
282
Se esco dall’ambito medievistico rilevo la menzione selettiva del fisico
belga Georges-Henri Lemaitre, che negli anni Venti del Novecento elabora
per primo l’ipotesi del Big Bang e del quale il Caprara omette di indicare la
confessione cattolica e lo stato di vita sacerdotale (ID., op. cit., p. 247).
279
94
Medioevo: un pregiudizio secolare
Se procediamo nell’analisi, ancora più sotto troviamo che,
con quasi duecento anni di ritardo rispetto ai presbiti, soccorsi
dall’inventività di Bacone,
ai miopi, invece, penserà lo studioso tedesco Niccolò Cusano
nel 1451.283
In questo caso si tratta del celebre filosofo neoplatonico,
astronomo e matematico illustre,284 che ha però il grave difetto di essere addirittura un cardinale, per cui forse sembra più
opportuno celare il suo stigma vergognoso sotto le generiche
e pudiche espressioni di «studioso» e di «tedesco», certamente
più neutre rispetto alla pretesa antinomia scienza/religione.
Perciò possiamo concludere che quando l’inventore è un uomo
di Chiesa e inoltre, come nel caso di Bacone e di Cusano, filosofo di prima grandezza, la tendenza è quella di lasciare emergere solo ed esclusivamente gli elementi che possano favorire
l’ipotesi di partenza (cioè: il Medioevo come età oscura, barbara, di fanatismo religioso e di superstizione, tutte qualità
negative determinate dall’influenza della Chiesa cattolica), occultando o minimizzando, dall’altro lato, i fatti storici che potrebbero indebolirla.
A volte il discorso comune ma, come vedremo, nondimeno
anche la pubblicistica divulgativa, ricorrono a delle false spiegazioni, in cui il pregiudizio lascia intravedere una sclerotizzazione
oltremodo evidente del suo nucleo cognitivo, cioè dello
stereotipo.285 Ne riporto un esempio ricavato dallo stesso manuale del Caprara:
283
Ivi, p. 58.
Cfr. ad es. VANNINI M., Mistica e filosofia, Piemme, Casale Monferrato 1996,
pp. 62-70 e 79.
285
MAZZARA B.M., Stereotipi e pregiudizi, Il Mulino, Bologna 1997, p. 16.
284
95
Franz Brandmayr
Fibonacci (1170-1240?) […] proponeva miglioramenti alle dimostrazioni ottenute dai grandi classici come Archimede. E anche questo era un segno del nuovo spirito innovatore che stava
portando ormai il Medioevo verso il tramonto.286
Il concetto di Medioevo sembra oramai reificato287 e lo stigma
dell’ignoranza oscurantista lo penetra e lo pervade fino alla saturazione. Il fatto di reperirvi qualche prodotto culturale innovativo
non induce l’Autore a porre in dubbio le sue sicurezze o ad attenuarne e sfumarne i toni: tale progresso, infatti, non può (“per
definizione”…) essere un frutto della civiltà medievale e rappresenta con ogni certezza, perciò, un anticipo della fervida e feconda età rinascimentale… Abbiamo qui un esempio di pseudo-eziologia, una proposizione di chiara natura tautologica,288 nella quale, per giustificare il verificarsi di un progresso matematico nel
Medioevo si ribadisce il Leitmotiv dell’opera in questione: evidentemente non si tratta più di Medioevo…
L’ultimo concetto che mi propongo di richiamare in questo
paragrafo porta il discorso a stretto contatto con uno dei fattori
causali nodali del pregiudizio antimedievale, fattore che, a mio
avviso, potrebbe rivelarsi forse il più importante: si tratta del processo dell’“etnicità”. Attraverso questo complesso di dinamiche
interculturali trovano espressione la «classificazione, l’organizzazione e la comunicazione della differenza culturale tra i gruppi»,
che polarizza le relazioni diadiche noi/loro in una dialettica di
contatto-somiglianza e, al contrario, di differenziazione.289
286
CAPRARA G., op. cit., p. 53.
ABBAGNANO N., s.v. Reificazione, in ID., op. cit., p. 738.
288
Cioè un «discorso […] ripetente nella conseguenza, o nel predicato […] il
concetto già contenuto nel primo membro» (ABBAGNANO N., s.v. Tautologia,
in ID., op. cit., p. 857).
289
SACCHI P., s.v. Etnicità, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), op. cit., p. 271.
287
96
Medioevo: un pregiudizio secolare
Faccio di seguito l’esempio, credo assai chiaro, della contrapposizione fra Medioevo e Rinascimento. È probabile che – alla
stregua dei processi dell’etnicità che pure oggi vediamo instaurarsi fra culture che si confrontano e si scontrano nel mondo
contemporaneo (ad es. l’Occidente e il mondo islamico)290 –
parimenti, ai fini della promozione e della celebrazione del Rinascimento, la denigrazione del Medioevo abbia costituito una
sorta di punto d’appoggio archimedeo sul quale è stato possibile fare leva per lo meno fino al celebre studio di Burckhardt.
Come si è già evidenziato sopra, inoltre, al di fuori dell’ambito
ristretto degli specialisti, questa ricostruzione storiografica oramai superata sembrerebbe perdurare e riprodursi, come per inerzia, nel senso comune, nella produzione “storica” non specialistica e persino in un certo genere di manualistica.291
La connotazione negativa dell’immagine del Medioevo, pertanto, è stata fin dal principio resa funzionale alla costruzione
culturale di un Rinascimento colto e interpretato come una sorta di riemersione dall’abisso della barbarie. Nel suo corso le arti
290
Svariati studiosi come, ad es., il sociologo ALLIEVI S., Parole dell’islam, parole
sull’islam. Formazione culturale, comunicazione e ruolo dei mass media, in SIGGILLINO
I. (a cura di), I media e l’islam. L’informazione e la sfida del pluralismo religioso,
E.M.I., Bologna 2001, p. 41, attribuiscono al testo di HUNTINGDON S.P., Lo
scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 1997 (1996), passim
un intento politico strumentale; in esso si fomenterebbe, infatti, una
contrapposizione frontale tra Occidente e Civiltà islamica funzionale a una
riaggregazione degli Stati occidentali intorno agli Stati Uniti d’America, visti
come vessilliferi del mondo “civile”. Questa lettura sembrerebbe sostanzialmente condivisa anche da CARDINI F., Astrea e i Titani. Le lobbies americane alla
conquista del mondo, Laterza, Roma-Bari 2005 (2003), passim.
291
VASOLI C., Prefazione, in BURDACH K., Riforma Rinascimento Umanesimo. Due
dissertazioni sui fondamenti della cultura e dell’arte della parola moderne, Sansoni,
Firenze 19862 (1918), p. VII scrive della «volgarizzazione» del «grande affresco storiografico del Burckhardt», trasformato troppo spesso in «un facile
cliché» da «mediocri storici, pubblicisti e banali giornalisti».
97
Franz Brandmayr
sarebbero rifiorite, avrebbero assunto nuovi valenze e significati – in certo modo più moderni – e avrebbero espresso «determinate tendenze prevalenti, cioè il realismo, la secolarizzazione
e l’individualismo»292. Ancora, va evidenziato – in prima approssimazione – il fatto che, di questo genere di ermeneutica della
civiltà medievale europea, si siano fatti imprenditori in modo
particolare la storiografia di matrice riformata293 e, in seguito,
gran parte degli esponenti della corrente illuministica:
Oggi sappiamo che il mito del Medioevo, come epoca di barbarie, era, appunto, un mito, costruito dalla cultura degli umanisti e
dai padri fondatori della modernità.294
2.4. Rinascimento vs. Medioevo: la revisione di un dualismo storiografico
La contrapposizione fra le due epoche, come si sa, si è progressivamente attenuata nel mondo accademico europeo, fino a determinare un cambiamento di rotta particolarmente avvertibile
negli ultimi decenni.295 La concezione di Jakob Burckhardt, che
colse nel Rinascimento un fenomeno culturale moderno creato
da una società moderna, negli anni Ottanta del XX secolo ormai «non appare più in questa luce»296 e viene attaccata in vari
modi dagli storici. Secondo una parte di costoro andrebbero
invece messi in maggiore risalto gli elementi di continuità fra le
292
BURKE P., op. cit., p. 29.
Cfr. supra nt. 36.
294
ROSSI P., Introduzione, in ID., La nascita della scienza moderna in Europa, Laterza,
Roma-Bari 20075 (1997), p. XIV. Cfr. supra nt. 133. Vd. anche BURKE P., op.
cit., pp. 16-17 e 32; DAWSON CH., op. cit., pp. 23 e 31; GARIN E., op. cit., p. 25; LE
GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., p. XVI.
295
Ivi, p. XVII.
296
BURKE P., op. cit., p. 4.
293
98
Medioevo: un pregiudizio secolare
due epoche e ciò va inteso in un duplice senso: nel senso del
reperimento di elementi documentari che impongono di anticipare al Medioevo fenomeni che si ritenevano essere caratteristici del Rinascimento e, per converso, nel senso dell’individuazione
di numerose persistenze e prolungamenti di “tratti culturali”297,
che si presumevano essere “medievali”, ben addentro alla cronologia rinascimentale.
Nel primo gruppo di fenomeni va senz’altro inserita la crescita dell’alfabetismo;298 Graff, come abbiamo già visto sopra,299
scrive di una «discreta alfabetizzazione»300 già nell’uomo medievale e osserva anche che
gli studi sul Rinascimento spesso associano i “decolli” intellettuali e culturali a risultati nel campo dell’istruzione e della stampa […] su di essi si è in genere esagerato. Le attività del Rinascimento erano già ben evolute prima dell’invenzione della tipografia a caratteri mobili […] La presenza dell’alfabetizzazione è costante anche se contraddittoria,301
e – perciò – non si può parlare di salti improvvisi. La percentuale di alfabetizzazione del 5-10% nel secolo XV, pertanto, sarebbe – secondo lo storico inglese – una «base per il futuro» e
un «traguardo fondamentale»302. Ciò si sarebbe verificato, per di
più, nonostante la stabilità e il benessere fossero stati “spazzati
via” in tante parti d’Europa da una serie di calamità e di eventi
negativi verificatisi fra il 1270 e il 1470303 e le condizioni stori297
MERCIER P., Storia dell’antropologia, Il Mulino, Bologna 19962 (1966), pp. 83 ss.
298
GRAFF H.J., op. cit., p. 150 et alibi.
299
Vd. supra paragrafo 2.3.
300
GRAFF H.J., op. cit., p. 71.
301
Ivi, p. 163.
302
Ivi, p. 209.
303
Ivi, p. 147.
99
Franz Brandmayr
che favorevoli per una ripresa si fossero presentate appena verso la fine del XV secolo.304
Questo discorso sarebbe valido anche qualora si volesse considerare soltanto la cultura dotta sotto il profilo della sua creatività, della quale scrive, ad esempio, Le Goff nel suo celebre La
nascita del Purgatorio:
Certo, la cristianità medievale – questo libro spera di dimostrarlo –
non è stata né immobile né sterile, ma anzi estremamente creativa.305
Infatti, se – come abbiamo visto sopra – nel Medioevo le
arti hanno prodotto molte innovazioni, 306 anche al livello
dell’intelligencija la capacità di innovare non è mancata affatto
e, al contrario di quanto comunemente si crede,307 proprio in
virtù delle doti inventive di un certo numero di intellettuali
combattivi, di uomini d’azione e di pensiero,308 di uomini il cui
«prestigio», il cui «fascino» e la cui «autorevolezza» fanno comprendere come si sia resa possibile l’egemonia culturale309 da
loro stessi esercitata fra i contemporanei. Questa creatività si
dipana attraverso percorsi di ricerca spesso travagliati (come –
ad esempio – in Wycliff, Hus e Gerson), lungo i quali dissenso
e conservazione convivono con diversa intensità, alternanza e
304
Ivi, p. 148.
LE GOFF J., La nascita, cit., p. 256.
306
Cfr. supra le nt. 224-241.
307
La teoria della creatività rinascimentale, esposta con grande ricchezza di
sfumature e con molti distinguo da BURKE P., op. cit., passim (cfr. ad es. infra le
note relative all’Autore in questione), fornisce talvolta l’estro per
generalizzazioni piuttosto grossolane circa la presunta incapacità innovativa
dell’intellettuale medievale (colloquio 2.1.13.12.2009).
308
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI M., op. cit., p. 213.
309
MICCOLI G., op. cit., pp. 65-67.
305
100
Medioevo: un pregiudizio secolare
dosaggio,310 mentre vengono anticipati sensibilmente luoghi
comuni che si presumono “moderni”, come il «teismo della
religione universale e l’idea di tolleranza»311 e precoci «tendenze illuministiche»312. Tutto ciò fa concludere alla Fumagalli che
la cosiddetta subordinazione alle auctoritates da parte dell’intellettuale medievale possa configurarsi come un vero e proprio
pregiudizio.313
Come è noto, poi, Ullmann si fa portatore di una tesi ancor
meno conforme al discorso comune, secondo la quale la stessa
idea di Rinascimento, inteso in particolare modo come sviluppo della humanitas dell’individuo come della collettività, non sia
comprensibile se non alla luce del concetto di «rinascita battesimale», contenuto teologico che – lungo tutto l’arco temporale
del Medioevo – sta alla base della dottrina della “deificazione”
dell’uomo, di cui ho già fatto menzione.314
La rinascita battesimale era l’assunto esplicito e implicito su cui
poggiava tutt’intera la concezione del mondo del Medioevo: i
suoi effetti globali toccavano l’uomo dalla culla alla tomba, in
ogni sfera della sua vita privata e pubblica e in tutti gli aspetti
socialmente e costituzionalmente rilevanti.315
Con queste considerazioni Ullmann riprende e approfondisce la tesi – già avanzata da Burdach316 – della matrice squisita-
310
Cfr. FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI M., op. cit., pp. 221-225.
STADELMANN R., Il declino del Medioevo. Una crisi di valori, Il Mulino, Bologna,
1978 (1929), pp. 211-254.
312
Ivi, pp. 255-291.
313
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI M., op. cit., pp. 231-232.
314
Cfr. supra nt. 230 e infra nt. 321.
315
ULLMANN W., Prefazione, cit., p. IX.
316
BURDACH K., Significato ed origine dei termini Rinascimento e Riforma, in ID.,
Riforma, cit., p. 8 et passim.
311
101
Franz Brandmayr
mente religiosa che soggiacerebbe al Rinascimento; ciò lo porta
a concludere che «il rinascimento umanistico fu in sostanza
un’espansione di questo tema ecclesiologico»317 della rinascita
battesimale. Infine altri ancora – sia pure con minore convinzione – riconoscono la possibilità di una genesi rinascimentale
in eventuale dipendenza teoretica dalla apocalittica renovatio mundi,
a suo tempo fatta oggetto di riflessione da parte di Gioacchino
da Fiore318 e riattualizzata319 da una congerie di autori e correnti
di pensiero basso-medievali fino al Rinascimento e oltre.320
Fa loro eco Le Goff, che sostiene essere il tema dell’uomoimago Dei a ispirare, animare «lo sviluppo dell’umanesimo medievale. Un umanesimo all’opera in tutte le attività della società
medievale, dalle imprese economiche fino alle più alte creazioni
culturali e spirituali»321, mentre lo stesso storico francese ricorda
ai sostenitori della teoria della creatività rinascimentale322 che ci
fu maggiore innovazione religiosa nel periodo della nascita degli Ordini mendicanti e – possiamo aggiungere noi – degli
eresiarchi medievali,323 rispetto a quanto realizzò più tardi il
Concilio di Trento.324 Analogamente, Manselli sostiene esservi
317
ULLMANN W., Radici, cit., pp. 12 e 28.
BURKE P., op. cit., pp. 237-238.
319
PANOFF M.-PERRIN M., Dizionario di etnologia, Newton Compton, Roma
1975, pp. 184-185.
320
NOBLE D.F., op. cit., pp. 27-50. Per una penetrante sintesi intorno al prolungamento in piena Età Moderna e Contemporanea dell’escatologismo medievale vd., dal punto di vista della Storia delle Religioni, ELIADE M., Paradiso e
utopia: geografia mitica ed escatologia, in ID., La nostalgia delle origini. Storia e significato nella religione, Morcelliana, Brescia 20003 (1969), pp. 103-127.
321
LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., p. XV. Cfr. supra le nt. 230
e 314.
322
BURKE P., op. cit., passim.
323
Cfr. supra le nt. 261 e 269-271.
324
LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., p. XX.
318
102
Medioevo: un pregiudizio secolare
stata una maggiore lungimiranza e una più profonda comprensione dei movimenti popolari – ereticali e ortodossi – in
Innocenzo III nel Duecento di quanto si sia in seguito verificato fra i papi dell’inizio dell’Età moderna.325
È ancora Manselli a farci presente che l’anticlericalismo non
è un prodotto tardo-medievale o rinascimentale, bensì un sentire comune a svariati gruppi e aree geografiche fra l’XI e il XIII
secolo.326 Fra i mecenati pare essere la Chiesa il protettore dei
letterati più tollerante (anche con riferimento alla condotta
morale), mentre dal Quattrocento la libertà per gli intellettuali
di corte sarà sempre più limitata, in quanto essi si vedranno
progressivamente costretti a uno sdoppiamento delle loro funzioni pubbliche e private, fino a dovere cercare un rifugio più
sicuro nell’intimità della loro coscienza.327 Ancora a proposito
della cosiddetta “tolleranza”, inoltre, il Medioevo cristiano riesce a inculcare nell’uomo europeo il messaggio universalistico,328
per il quale, dal momento che gli attributi naturali
non giocavano alcun ruolo all’interno della realtà ecclesiologica,
i suoi princìpi, i suoi dommi e le sue mete […] erano di fatto
universali. Regionalismo, provincialismo, tribalismo, e tutte le tante
altre varietà di aggregazione sociale naturale, non avevano alcuna incidenza concreta. Non c’era che una sola società – la società
ecclesiologica universale, che programmaticamente metteva da
parte le peculiarità biologiche, etniche, linguistiche e geografiche
e le riduceva ad un ruolo secondario.329
325
MANSELLI R., op. cit., p. 129.
Cfr. supra nt. 269.
327
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI M., op. cit., pp. 228-229.
328
LE GOFF J., L’uomo medievale, in ID. (a cura di), L’uomo, cit., p. 9.
329
ULLMANN W., Radici, cit., p. 12; cfr. anche DAWSON CH., op. cit., pp. 150 e 152.
326
103
Franz Brandmayr
Al ridimensionamento storiografico del concetto di discontinuità e rottura applicato alla diade ideal-tipica330 Medioevo/Rinascimento e alla fragilità concettuale che oramai vi viene attribuita
contribuiscono anche i motivi di continuità, che il Rinascimento
sembra mostrare rispetto a certe caratteristiche medievali. Su questa
linea sembra porsi anche il notevole lavoro di Burke,331 che prende in esame gli anni fra il 1440 e il 1520 e che – perciò – coglie in
pieno il periodo che ci interessa, quasi una sorta di sutura fra le
due epoche. In queste pagine lo storico inglese sostiene che la
fioritura artistica e le ipotetiche caratteristiche rinascimentali della
modernità, del realismo, della secolarizzazione e dell’individualismo non costituiscono affatto dei dati storici sicuri: «se pure è
possibile salvarle, lo si potrà fare solo a costo di notevoli riformulazioni», in quanto «tutte queste certezze si sono andate dissolvendo» nel corso della sua ricerca,332 mentre – in realtà – nell’«umanesimo rinascimentale […] sono ancora operanti un buon
numero di elementi medievali»333. Il fenomeno rinascimentale italiano è reso infatti possibile da un laicato colto334 – sulla cui matrice squisitamente medievale ci siamo già soffermati335 – e dalla
«vita ecclesiastica», che «in nessun altro paese d’Europa […] aveva uguale portata»336. Anche Lucien Febvre mette in evidenza come
lo spirito religioso del Medioevo sia «ben vivo […] in quel genio
che più d’ogni altro a quel tempo aveva rivendicato la modernità
del suo secolo»337, cioè in Rabelais, mentre altri insistono sul fatto
330
WEBER M., Il metodo, cit., pp. 107-120.
BURKE P., op. cit., pp. 29, 36-37, 39, 71, 214 e 223.
332
Ivi, p. 29.
333
BURKE P., Prefazione, in ID., Cultura, cit., p. X.
334
Ivi, pp. 36-37.
335
Vd. supra paragrafo 2.3.
336
ULLMANN W., Radici, cit., p. 16.
337
LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., pp. XX-XXI; l’A. si riferi331
104
Medioevo: un pregiudizio secolare
che la secolarizzazione del Rinascimento è relativa,338 che «la maggior parte dei quadri aveva soggetto religioso»339 e che «Dio è
ovunque nella letteratura dell’epoca»340.
Si è visto sopra che gli intellettuali e gli “artisti” del Medioevo sono stati capaci anche di creatività, mentre – contro ogni
“aspettativa stereotipica”341 –
è paradossale che in un’epoca in cui la cultura italiana fu contrassegnata da quella che potremmo definire “propensione al nuovo”, l’innovazione fosse considerata in modo negativo.342
In effetti, l’ideale rinascimentale è quello di considerare «le opere
antiche come altrettanti modelli da imitare»343 e anche Burke riconosce che gli italiani del Rinascimento, con Guicciardini in testa,
sono contrari alle novità,344 che la creatività sia per loro qualche
cosa di strano345 e che, in ogni caso, anche i cosiddetti “creativi”
attingono sia alla tradizione che all’innovazione.346
A proposito dell’ultimo elemento innovativo considerato,
infine, quello del presunto individualismo rinascimentale, Burke
osserva che gli artisti del periodo da lui esaminato sono formati
sce al celebre studio di FEBVRE L., Il problema dell’incredulità nel secolo XVI. La
religione di Rabelais, Einaudi, Torino 1978 (1942), passim.
338
BURKE P., Cultura, cit., p. 3.
339
Ivi, p. 214.
340
Ivi, p. 223; ULLMANN W., Radici, cit., p. 6.
341
Vd. supra nt. 219.
342
BURKE P., Cultura, cit., p. 237.
343
PERNOUD R., op. cit., p. 22.
344
BURKE P., Cultura, cit., pp. 236-237.
345
Ivi, p. 377.
346
Ivi, p. 32.
105
Franz Brandmayr
a una collaborazione intensa e costante decisamente «contraria
allo sviluppo dell’individualismo»347.
È opinione di svariati studiosi, perciò, che vi sia un certo accanimento nel ricorso alle suddivisioni e una sottolineatura esagerata delle cesure che separerebbero il Medioevo dal Rinascimento.
Ullmann – ad esempio – non nutre dubbi sul fatto che sia
insostenibile la posizione, comunemente accettata,348 di chi parla
di una “nuova era” o di una “frattura (del Rinascimento) nei
confronti del passato medievale”.349
Molti elementi documentari raccolti dagli studiosi sembrerebbero perciò suffragare la posizione della continuità storica
fra le due epoche, ma Pietro Rossi mette in guardia da
omologazioni eccessive: quando si parla di scienza medievale e
di scienza moderna
il continuismo è solo una mediocre filosofia della storia sovrapposta alla storia reale.350
Almeno sotto il profilo scientifico, sostiene l’Autore, va confermata l’esistenza di una sorta di discontinuità. Anche Butterfield,
pur nutrendo – come abbiamo già visto351 – una considerevole
opinione sulla capacità d’invenzione medievale, sembra incoraggiare una posizione di non-omologazione fra le due epoche, quando argomenta che l’Età di Mezzo pare esprimere una serie di
conati in direzione di una scienza empirica, ma
347
Ivi, p. 71.
L’Autore pubblicava l’opera nel 1977.
349
ULLMANN W., Radici, cit., p. 261; parentesi mia. Vd. anche ivi, p. 10 et alibi.
Cfr. infra anche nt. 354.
350
ROSSI P., Introduzione, cit., p. XIX.
351
Vd. supra nt. 239 e 241.
348
106
Medioevo: un pregiudizio secolare
l’uso degli esperimenti non venne tuttavia, per così dire, addomesticato e bardato prima del diciassettesimo secolo, quando gli
si dette un ordine interno, così che esso divenne come una grande macchina in movimento.352
Osserviamo, pertanto, che – com’è comprensibile – le differenze diventano più nette soprattutto mano a mano che ci si
addentra nell’Età moderna e si attraversa la stessa età rinascimentale. In definitiva, mi sembra che la posizione teorica più
prossima a una visione d’insieme abbastanza equilibrata è forse
quella che proviene dagli studi sull’alfabetizzazione di Graff:
Quando si descrivono circostanze in cui sviluppo e mutamento
tendono ad essere graduali piuttosto che rapidi, come nel caso
dell’alfabetizzazione del Continente, è più efficace ricorrere ai
concetti di “continuità” e “contraddizione”.353
Non pare trattarsi più di un aut aut, quindi, bensì di un et et,
che può sinteticamente rendere ragione di un polimorfismo di
esperienze e di situazioni particolari assai mutevoli a seconda
delle classi sociali, delle aree geografiche, delle subculture e degli aspetti o tratti culturali considerati.
Ho voluto dare spazio, per quanto possibile in un contributo
di queste dimensioni, ad angolature prospettiche diversificate per
oggetto di studi e per la sensibilità degli autori rispetto al tema del
rapporto fra il Medioevo e il Rinascimento. Non mi sembra inutile, però, lasciare concludere questa argomentazione a Le Goff,
che non mostra reticenze di sorta quando afferma che
la maggior parte dei segni caratteristici per mezzo dei quali si è
voluto riconoscerlo [il Rinascimento] sono apparsi ben prima del-
352
353
BUTTERFIELD H., op. cit., p. 110.
GRAFF H.J.., op. cit., pp. 19-20.
107
Franz Brandmayr
l’epoca (secoli XV-XVI) in cui il Rinascimento viene collocato. Il
“ritorno all’antico” si manifesta fin dal secolo XIII […] lo stato
“machiavellico” è già presente nella Francia di Filippo il Bello. La
prospettiva entra nell’ottica e nella pittura già alla fine del secolo
XIII. La lettura si diffonde ben prima della galassia Gutenberg e
l’alfabetizzazione – è il fenomeno culturale che più conta – non
attende l’invenzione della stampa. Fra la fine del secolo XII e gli
inizi del XIII l’individuo si afferma con altrettanta forza che nell’Italia del Quattrocento […] Non sono d’accordo con Max Weber e Robert Tawney quando collegano la “religione” del lavoro al
protestantesimo. Questa esiste fin dal secolo XIII.354
3. Verstehen, empatia, osservazione partecipante
Condannare o assolvere il passato non dovrebbe rientrare
fra i compiti dello storico ma, in generale, neppure delle società contemporanee: il Novecento e gli inizi del nuovo millennio hanno registrato sufficienti crimini perché nessuno fra
i contemporanei si possa sentire giudice del passato.355
Quando si tratta di mettere in rilievo gli errori o i limiti altrui il
lavoro del critico risulta sempre facilitato, perché distruggere è
più facile che costruire. Il soggetto sottoposto a valutazione critica ha lavorato, ha indagato, ha esercitato uno sforzo di analisi
e di scelta e si è – con ciò – caricato di una serie di atti di responsabilità. Chi lo giudica, invece, dispone del vantaggio di costruire il proprio edificio teorico sul fondamento del travaglio al-
354
LE GOFF J., Prefazione, in ID., L’immaginario, cit., pp. XIX e XX; parentesi
quadrata mia. Per quanto attiene alla nascita dello stato si veda anche REINHARD
W., op. cit., pp. 34-35. Dal punto di vista della sociologia delle religioni si
evince un considerevole rinforzo a questa visione positiva del Medioevo anche dai primi cinque capitoli di STARK R., La vittoria della Ragione. Come il
cristianesimo ha prodotto libertà, progresso e ricchezza, Lindau, Torino 2006 (2005).
355
CARDINI F.-MONTESANO M., op. cit., p. 164.
108
Medioevo: un pregiudizio secolare
trui. È con questa consapevolezza e con questo atteggiamento
di rispetto che cerco di fornire qualche spunto in direzione di
un approccio più efficace alla storia medievale.
È possibile che la carenza principale che denotano certe trattazioni del tema di cui ci occupiamo possa riguardare la sua problematica comprensione da parte dei suoi volgarizzatori, (così
potremmo essere considerati noi insegnanti quando non siamo
anche storici), ma talvolta – perché negarlo? – forse anche da
parte di qualche storico. Come si sa, il termine “comprensione”,
reso dal tedesco Verstehen356 a partire dal dibattito epistemologico
– svoltosi a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento357 – chiamato
Methodenstreit358, non ha soltanto un generico significato legato
semplicemente al “capire”. Fin dalla sua radice latina (capere) il
verbo capire dà l’idea di «afferrare»359, di «prendere», perciò, un
qualche cosa di estrinseco, di esterno rispetto al soggetto che “coglie”. Il con-prehendere del latino360 sembra invece rinviare a un significato più inclusivo e a un coinvolgimento tale da permettere
una Einfühlung 361 , un sentire dentro 362 e, al contempo,
un’«immedesimazione»363. Si tratta, perciò, come si può constatare, della stessa etimologia, ma – soprattutto – dello stesso atteg-
356
MARROU H.-I., op. cit., p. 73.
ABBAGNANO N., s.v. Comprendere, in ID., op. cit., pp. 141-142.
358
TULLIO-ALTAN C., Antropologia, cit., p. 287.
359
LIOTTA G.-ROSSI L.-GAFFIOT F., s.v. Capio, in IID., Dizionario della lingua latina.
Latino-italiano, il capitello, Torino 2010; il complesso greifen – Begriff – begreifen =
«prendere, pigliare» – «concetto» – «capire, comprendere» (MACCHI V., s.vv., in
ID., op. cit.) sembra rinviare a rapporti di significato abbastanza simili.
360
DEVOTO G.-OLI G.C., s.v. Comprendere, in IID., Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 1995.
361
MALIGHETTI R., s.v. Verstehen, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), op. cit., p. 790.
362
MACCHI V., s.vv. Ein e Fühlen, in ID., op. cit.
363
Ivi, s.v. Einfühlung.
357
109
Franz Brandmayr
giamento364 di empatia metodologica, che gli antropologi cercano
di porre in atto nella loro ricerca sul campo.365 Ciò non consiste,
come il lettore capisce, in una mera concessione al sentimentalismo, bensì in un percorso metodologico che, a partire da svariati
autori che hanno fondato le scienze sociali,366 ha dato i suoi buoni
frutti fino a pervenire – in tempi a noi più vicini – all’elaborazione originale del metodo dell’antropologia interpretativa affinato
da Clifford Geertz.367 In questa sede non è possibile neanche accennare ai passaggi più significativi che portano a questi esiti teorici; è sufficiente proporre all’attenzione di chiunque si occupi di
divulgare i contenuti della civiltà medievale l’opportunità di un
approccio dall’interno ai singoli dati, come alle epoche e alle culture fatte oggetto di studio. Ciò si può realizzare in maniera in
qualche modo analoga a quella attuata dall’antropologo che ricorre all’«osservazione partecipante»368 quando si trova a indagare “sul campo” intorno a una qualche cultura specifica.
364
Sotto il profilo psicologico si tratta del «tentativo di riprodurre in proprio
i sentimenti altrui, al fine di comprendere l’altra persona» [STECK P., s.v.
Empatia, in ARNOLD W.-EYSENCK H.J.-MEILI R. (a cura di), op. cit., p. 354].
365
Cfr. ad es. il riferimento alla «simpatia» dell’antropologo per l’oggetto di
studio (FIRTH R., I simboli e le mode, Laterza, Bari 1977, p. 40); a sua volta TULLIOALTAN C., Soggetto, cit., pp. 210-222 scrive dell’«empatia» richiesta nella ricerca
intorno alle varie tematiche inerenti l’ambito del simbolico. Sono espressioni,
comunque, che non vanno intese in senso «emotivo», né confuse con opzioni
teoriche che rifiutino a priori il tentativo di una «comprensione» oggettiva della
cultura studiata (cfr. TULLIO-ALTAN C., Manuale, cit., p. 543).
366
Si tratta, ad es., di Weber, di Simmel, di Talcott Parsons e di Wright Mills
(MALIGHETTI R., s.v. Verstehen, cit., p. 790).
367
ID., s.v. Antropologia interpretativa, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), op.
cit., p. 71; va tuttavia notato che – rispetto al Verstehen – la prospettiva geertziana
non contempla la nozione di empatia (MALIGHETTI R., s.v. Verstehen, cit., ib.).
368
BERNARDI B., op. cit., pp. 114 e 249-250; CIRESE A.M., Cultura, cit., pp. 249250, dove l’Autore rende il medesimo concetto con l’espressione «integrazione mentale»; TULLIO-ALTAN C., Manuale, cit., pp. 515-516 e 542-545.
110
Medioevo: un pregiudizio secolare
Ma non occorre uscire dall’ambito degli studi storici per rinvenire indicazioni metodologiche – espresse con grande autorevolezza – sui temi della comprensione e della simpatia metodologica:
Storico è colui che, attraverso l’epokhè, sa uscire da se stesso
per incontrarsi con gli altri. A tale virtù possiamo dare un
nome: “simpatia”.369
I «vecchi maestri positivisti», continua Marrou, ritenevano
essere lo spirito critico la migliore virtù dello storico: il dubbio
metodologico di ispirazione cartesiana – peraltro imprescindibile in ogni scienza – veniva da loro esasperato fino a diventare una «diffidenza programmatica», che – eretta a sistema370
– «dovrà considerarsi come una delle più gravi deficienze dello storico»371.
In assenza di simpatia metodologica, addirittura di una sorta
di amicizia372 con l’autore del documento, con il suo mondo fatto
di sentimenti, di passioni da occultare, di interessi materiali e simbolici da difendere, di tragedie rimosse e di sofferenze forse amplificate, difficilmente la fonte potrà venire “sfruttata” appieno e
solo con difficoltà essa potrà esprimere ogni sua potenzialità. Se
l’Altro non viene, in qualche modo, guardato con “partecipazione” (è il termine – forse meno enfatico dell’“amicizia” di Marrou
– che preferisco attingere dalla letteratura antropologica), egli –
l’Altro – rischierà di diventare «una creatura della ragione, un
fantasma che la mia immaginazione si compiace di alimenta-
369
MARROU H.-I., op. cit., p. 85.
Per una serie di argomentazioni sulla differenza fra “metodo” e “sistema”
e sulla loro articolazione speculare rispetto alla diade concettuale “apertura”/”chiusura” si veda ad es. GUITTON J., op. cit., pp. 119-120.
371
MARROU H.-I., op. cit., p. 85. Cfr. supra anche nt. 131.
372
ID., op. cit., p. 86.
370
111
Franz Brandmayr
re»373 o, se vogliamo adoperare un termine che abbiamo già incontrato, un concentrato di etichettazioni al quale la ricerca d’archivio o sul terreno non potrà aggiungere niente di nuovo. Si
configurerà – in questo modo – ciò che gli psicologi sociali definiscono aspettativa stereotipica, cioè la supposta conferma – ottenuta dai cosiddetti “fatti documentati” – di ciò che già si era
fissato a priori nella memoria selettiva del ricercatore, l’unica evidenza che – fin dal principio – egli sarebbe stato disposto a rilevare sul terreno dell’indagine. In questi casi ogni dissonanza cognitiva
rispetto all’ipotesi di partenza tenderà a venire obliterata, in quanto non suffragherà l’ipotesi di partenza del ricercatore e si perverrà, come abbiamo già visto sopra, a una sorta di pseudo-conoscenza di natura tautologica. Mi piace concludere il paragrafo con
una citazione ricavata da uno studio di un importante sociologo
della comunicazione, mentre tratta il delicato tema della percezione delle culture islamiche ad opera degli occidentali:
Comprendere i valori degli altri […] non significa […] necessariamente condividerli, anche se generalmente il risultato del procedimento è quello di un arricchimento della propria sensibilità etica.374
3.1. Per una conclusione aperta…
Abbiamo già accennato alla reticenza e finanche alla diffidenza
che certe espressioni (sospensione del giudizio, simpatia, partecipazione) suscitano in una parte dei ricercatori dei Cultural
Studies, fino a portarli talora a esiti nichilistici375 rispetto alla pos-
373
Ibidem.
MARLETTI C., Le immagini dell’islam nella narrazione di eventi e nel dibattito su temi.
Analisi qualitativa dei testi e dei generi, in ID. (a cura di), Televisione e Islam. Immagini e
stereotipi dell’islam nella comunicazione italiana, RAI-Nuova ERI, Roma 1995, p. 157.
375
Vd. supra nt. 173.
374
112
Medioevo: un pregiudizio secolare
sibilità di fare ricerca su culture e civiltà altre. Credo – del resto
– che anche certi storici non siano disposti a offrire uno spazio
eccessivo a questi atteggiamenti, che ben si presterebbero a essere resi funzionali a un irenismo accomodante. Ma non è certamente a questo che allude Marrou, il quale infatti precisa che
al progresso della nostra scienza (la storia) non nuoce che una
critica esigente, a volte ingiusta, possa scuotere una pigra simpatia pronta a scivolare nell’indulgenza e nella facilità.376
La sfida è certamente aperta e i risultati, sempre se arrivano,
non sono affatto scontati. Credo fosse, in ogni caso, importante
tornare a sollevare il problema del pregiudizio antimedievale e
cercare di mettere in ulteriore evidenza quanto esso sia compenetrato con il senso comune: dalla messa in luce delle modalità
riproduttive377 del pregiudizio che abbiamo cercato di esaminare, il docente, lo studente, forse lo storico stesso, potrebbero
attingere spunti per l’autoanalisi e per l’affinamento degli strumenti concettuali necessari per la comprensione del Medioevo.
Si tratterebbe, inoltre, di un esercizio utile anche per la comprensione di realtà socio-culturali “altre”, con le quali siamo
chiamati a misurarci nella concretezza dell’oggi.378
Restano aperte, a mio avviso, ancora due questioni, alle quali
ho accennato nel corso del saggio. In primo luogo, credo sia
opportuno un futuro approfondimento, complementare a queste riflessioni, della matrice occidentalista del pregiudizio antimedievale: potrebbe derivarne una visione nuova e, forse,
meno dogmatica di alcuni assiomi della civiltà euroamericana.
376
MARROU H.-I., op. cit., p. 87.
MAZZARA B.M., op. cit., p. 16.
378
Cfr., ad es., supra nt. 290.
377
113
Franz Brandmayr
“Sacralizzati”379 e divenuti un tutt’uno con il discorso comune, i
valori e i paradigmi dell’Occidente (ad es.: «la visione universale
e secolare di ciò che è {autenticamente} umano», i «diritti umani», il pensiero marxista e liberale e le «scienze umane»380, l’idea
del «soggetto-cittadino», «le concezioni della società civile […],
le diverse distinzioni fra pubblico e privato […], il tempo storico {lineare}» 381, l’«individualismo», l’«intellettualismo»,
l’«antitradizionalismo» e l’idea di «nazione» ecc.) hanno rappresentato un saldo supporto teorico funzionale alla tesi della
missione «civilizzatrice» dell’Occidente nei confronti del resto
del mondo.382 Essi potrebbero conferire – secondo alcuni –
una connotazione addirittura “religiosa” alla modernizzazione,383 all’interno della quale dette nozioni rischiano di assumere significati imperituri e sottratti alla critica storica.384 Altri
ancora, come – ad esempio – Jürgen Habermas, non esitano a
cogliere nella stessa storia della filosofia occidentale un «tentativo delle società democratiche di rassicurare se stesse» circa
379
Sul processo di “sacralizzazione dei simboli” cfr. REMOTTI F., Noi primitivi.
Lo specchio dell’antropologia, Boringhieri, Torino 1990, p. 157.
380
CHAKRABARTY D., Provincializzare, cit., pp. 16-17; parentesi mia. Qualche
“impressionista” è portato a credere che il pensiero marxista sia stato abbattuto con il Muro di Berlino; Chakrabarty opportunamente ci ricorda la sua
persistenza e vitalità. In questo senso credo che il volume di MASSET P., Il
marxismo nella coscienza moderna, Città Nuova, Roma 19772 (s.d. orig.), passim,
pur superato dagli eventi, rappresenti ancora un’utile introduzione.
381
CHAKRABARTY D., Provincializzare, cit., p. 38; parentesi graffe mie.
382
Cfr. ad es. BASTIDE R., Noi e gli altri. I luoghi di incontro e di separazione culturali
e razziali, Jaca Book, Milano 19902 (1970), pp. 27-28; CHAKRABARTY D.,
Provincializzare, cit., p. 21; TRIULZI A., Lo sguardo coloniale, in PASQUINELLI C. (a
cura di), op. cit., p. 106.
383
Cfr. ad es. KIPPENBERG H.G., La scoperta della storia delle religioni. Scienze delle
religioni e modernità, Brescia, Morcelliana 2002 (1997), pp. 196-197, 253 e 256-257.
384
Cfr. REMOTTI F., op. cit., p. 157.
114
Medioevo: un pregiudizio secolare
la bontà del proprio progetto modernistico385 da estendere al
mondo intero.
Rimanderei, pertanto, a un ipotetico lavoro futuro l’analisi di
questa particolare tipologia di precomprensioni, le quali – per
quanto a noi care – fondano, sostengono e rendono eurocentriche – oltre alla storiografia che si occupa delle aree extraeuropee
– anche le narrazioni moderne del Medioevo europeo. Questa
seconda fase del nostro esercizio decostruttivo potrebbe consentirci di portare a compimento quel lavoro di defamiliarizzazione386 rispetto alle prospettive moderne e postmoderne, che avevamo posto come nostro obiettivo critico.
Da ultimo, si pone la necessità della ricerca delle cause
dell’«ostilità simbolica»387 contro il Medioevo. Vi è chi la attribuisce non tanto alla malignità, quanto – piuttosto – all’incompetenza e alla mancanza di curiosità;388 vi è anche chi sosteneva già
alla metà del secolo scorso che
fuori del mondo accademico si sono affermate nuove forze sociali che si servono della storia o d’una versione particolare della
storia per fini sociali, come un mezzo per trasformare la vita e le
azioni degli uomini.389
È compito degli storici l’ipotizzare e il verificare se nella seconda metà del Novecento vi sia stata una manipolazione della
narrazione medievalistica ad opera di agenzie culturali, che non
385
Cfr. anche le argomentazioni di CHAKRABARTY D., Provincializzare, cit., pp. 62-63.
Vd. supra nt. 184.
387
È un concetto che attingo da DAL LAGO A., Non-persone. L’esclusione dei
migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano 20042 (1999), p. 50; in COLOMBO E., op. cit., p. 37 trovo la nozione affine di «violenza simbolica».
388
PERNOUD R., op. cit., p. 152.
389
DAWSON CH., op. cit., p. 17.
386
115
Franz Brandmayr
abbiano tenuto che in scarso conto gli sviluppi della ricerca
storiografica meno condizionata da istanze extrascientifiche.
Per quanto mi riguarda sarei più interessato per formazione
a un rilevamento in ambito sincronico, da effettuarsi all’interno
di qualche collettività (alcune classi di studenti? un gruppo di
colleghi?) o su una certa tipologia di prodotti culturali (un semestre di osservazione e controllo della produzione scritta di
una o più testate giornalistiche? una disamina sistematica dei
manuali in commercio nell’arco di un periodo determinato?): il
lavoro di registrazione e di analisi dei sentimenti, delle valutazioni e delle scelte390 degli individui e delle comunità riguardo al
Medioevo potrebbe anche essere molto significativo rispetto sia
alla conoscenza del processo di individuazione391 dei singoli attori sociali sia alla costruzione dell’identità negli specifici gruppi
di appartenenza.
390
Cfr. supra nt. 158.
JUNG C.G., s.v. Individuazione, in ID., Dizionario di psicologia analitica,
Boringhieri, Torino 1977 (1921), pp. 82-85.
391
116
Nessuno è ciò che sembra. Breve incursione
nella letteratura migrante
di Brigitta Bianchi *
Fervono i dibattiti sulla vitalità della lingua italiana connessi a quelli
sull’unità del Paese. Segnalo, soltanto per citare gli ultimi contributi,
il recente volumetto di Gian Luigi Beccaria Mia lingua italiana,1 le
conferenze all’ultimo Salone del libro di Torino, l’articolo La lingua
doc apparso su “Focus” di maggio2 e la simpatica e spumeggiante
trasmissione radiofonica Salva con nome condotta settimanalmente
da Lucia Cosmetico dagli studi regionali FVG della Rai.
È ancora attuale, per certi versi, il distico conclusivo della
quarta strofa dell’ode manzoniana Marzo 1821 (vv. 31-32) riferito alla nazione: «una d’arme, di lingua, d’altare, / di memorie, di
sangue, di cor».
Intanto la “letteratura migrante” forse apporta nuova linfa
alla comunque rigogliosa pianta della narrativa italiana. Si tratta
di testi prodotti in lingua italiana da migranti, non di lingua madre
italiana. Convenzionalmente si fa iniziare questa produzione con
il racconto Villa Literno scritto in italiano da Tahar Ben Jelloun a
quattro mani con quello che poi sarebbe diventato il suo traduttore ufficiale, Egi Volterrani. Nei primi anni Novanta interessa-
* Docente di italiano e latino.
1
Einaudi 2011.
2
N. 223, pp. 78-84, a firma di Sabina Berra.
117
Brigitta Bianchi
va alle case editrici rinnovare i propri cataloghi con storie “strane” e di denuncia. Molta strada si è percorsa da allora nel campo dell’editoria.3 Proporrò, a testimonianza della vitalità del filone, due esempi recenti di romanzi scritti in italiano da autori
non di lingua madre italiana.
A Trieste è ambientato Amiche per la pelle dell’indiana Laila
Wadia.4 In un fatiscente stabile della centrale via Ungaretti, strada di fantasia, ma verisimile, abitano quattro famiglie extracomunitarie (una indiana, una cinese, una bosniaca e una albanese) e un burbero anziano triestino, il signor Rosso, per il quale
tutti gli stranieri sono “negri”. La voce narrante è quella di Shanti
Kumar, una trentenne indiana, che si definisce «tenera ma tenace» e osserva: «Sono diventata una specie di ibrido culturale e
linguistico, ma il mio cuore è sempre rimasto in un sari: devi
srotolare le cinque iarde di soffice e luccicante patina occidentale per sentire il suo vero battito.»5 Moglie di Ashok e madre di
Kamla, italianizzata in Camilla, di cinque anni, la donna ha instaurato un rapporto vivace e solidale con la signora Fong, detta
Bocciolo di rosa, con Marinka Zigović, moglie del bosniaco Bobo
e mamma di due gemelli, e con Lule, moglie dell’ingegnere albanese Besim Dardani. «Lule è sempre elegantissima – con i
corti capelli biondo scuro sempre a posto come se andasse dalla
parrucchiera ogni mattina. È alta e slanciata e cammina con la
sicurezza di un’attrice. Assomiglia vagamente a Virna Lisi.»6 Con
orgoglio Shanti racconta della comune decisione di prendere
lezioni di italiano dalla signora Laura, ex insegnante di scuola
media. «È una donna alta e magra, e ha lunghi capelli argentati
3
In merito, segnalo il recente e sintetico contributo a firma di Filippo La
Porta, L’italiano come scelta, “Domenicale del Sole 24 Ore”, 21 agosto 2011.
4
Edizioni e/o 2009 (orig. 2007).
5
Ivi, p. 140.
6
Ivi, p. 36.
118
Nessuno è ciò che sembra
che porta sciolti come una quindicenne. Profonde rughe si irradiano dai suoi occhi grigioverdi, ma sono rughe di una donna
appagata, che ha vissuto la sua vita come voleva. Assieme ai
verbi irregolari e alla “s” impura, cerca di inculcarci l’importanza di questa libertà, e spesso ci parla di quello che l’emancipazione femminile ha significato per la sua città natale»7. Laura le
porta una volta a fare lezione al caffè San Marco, un’altra a un
concerto al Ridotto del teatro Verdi,8 un’altra ancora assegna
loro il compito di andare a visitare il castello di Miramare per
scrivere poi le loro impressioni. Le quattro donne ci vanno in
autobus con le loro famiglie e durante questa piacevole gita hanno
modo di entrare in contatto diretto, soprattutto linguistico, con
una tipica anziana triestina chiacchierona, che ovviamente comunica in dialetto, pur avendo ben capito di aver di fronte degli
stranieri (chi non conosce questo tipo di donna, qui a Trieste?!).
«Gli anziani – e soprattutto le anziane – di questa città sono
assai eccentrici. Hanno un’energia e una grinta da far invidia ai
ventenni, e sugli autobus spingono e imprecano come gli adolescenti con i loro enormi zaini sulle spalle. Tanti si sentono molto soli. Alla fermata ti raccontano tutta la loro vita – figli, malattie, disgrazie delle loro vicine di casa – quasi foste vecchi amici.
Poi salgono sull’autobus e fanno finta di non averti mai visto
prima, mentre ti strattonano per accaparrarsi un posto.»9 Anche
il signor Rosso appartiene a questa categoria di energici e scontrosi triestini, ma la piccola Kamla riesce a far breccia in un
temperamento che la Wadia definisce con gusto «da pentola a
pressione con la valvola difettosa»10 e gli fa sgorgare dal petto
7
Ivi, p. 54.
Ivi, p. 71. Gustosi i fraintendimenti delle quattro amiche su che cosa possa
essere un quartetto d’archi.
9
Ivi, p. 90.
10
Ivi, p. 17.
8
119
Brigitta Bianchi
«una risata che aveva soffocato per decenni. Come il tappo di
una bottiglia di spumante»11. Si scopre che il vecchio è una persona colta, che insegna a memoria alla bambina poesie di Ungaretti e di Saba tra lo stupore e il compiacimento dei genitori.
Inizialmente scettico è il padre Ashok, che sbotta: «Ungaretti?
È una persona? Pensavo che fosse un posto, come Fernetti»12.
La vita quotidiana dei condomini scorre veloce tra routine, animate discussioni, condivisioni di cibo, che possono anche generare incomprensioni e amarezze. Percependo la diffidenza delle
amiche nei confronti della sua jota, la bosniaca Marinka esplode:
«”Voi volete essere diversi. Vi crogiolate nel vostro stato di miserevoli stranieri! Vi ostinate ad aggrapparvi al vostro passato, a
un tempo e un paese che non esistono più al di fuori della vostra fantasia. Che senso ha prendere lezioni d’italiano? Spaccarvi la testa per imparare la coniugazione dei verbi? Sforzarvi di
leggere I promessi sposi e andare al cinema a vedere Il postino? Se
rifiutate le basi di una cultura, la sua cucina, cioè, se non riuscite
a mandare giù nemmeno un boccone di jota, come intendete
digerire la vita in questo paese?” E ha sbattuto la porta a mo’ di
punto esclamativo alla sua arringa.»13 Arriva il giorno in cui gli
inquilini ricevono dal padrone di casa una lettera, che ingiunge
loro di lasciare lo stabile entro sessanta giorni in quanto l’edificio, risultato pericolante, deve essere sottoposto a manutenzione straordinaria. Le famiglie sgomente devono innanzitutto cimentarsi con l’incomprensibile linguaggio burocratico. «Chi diavolo era S.V. ad esempio? Io sono S.K., Shanti Kumar.»14 Affrontano poi l’affannosa ricerca di una sistemazione alternativa
e di un’occupazione per le donne, che consentirebbe loro una
11
Ivi, p. 28.
Ivi, p. 31.
13
Ivi, p. 51.
14
Ivi, p. 98.
12
120
Nessuno è ciò che sembra
maggiore disponibilità di denaro. Marinka trova lavoro come
donna delle pulizie, Shanti come babysitter. È in questa occasione che l’eleganza e il benessere di Lule vengono drasticamente ridimensionati con curiosità e sollievo delle altre. Ma anche la soluzione che giunge inaspettata da parte della famiglia
Fong, e poi pure dal signor Rosso («Nemmeno in un film indiano ho sentito una storia così incredibile, penso», commenta
Shanti)15, ridimensiona (in positivo) la percezione dell’altro che
si ha in questo condominio.
La lingua di Laila Wadia è piana e scorrevole, lo stile denota
acutezza e capacità di cogliere anche nel particolare le caratteristiche espressive di vari gruppi linguistici. «Due persone che
vogliono abbattere il muro linguistico tra di loro sono due esseri
ansiosi di costruire un mondo migliore. E noi, armate di mattoni – libri di grammatica e di esercizi, vocabolari e audiocassette
– e con tanto cemento di buona volontà, stiamo tirando su con
non poco sacrificio l’impalcatura del nostro futuro. […] Lule ha
detto che sarebbe stato più produttivo trovarci un’insegnante
privata. Avremmo avuto più tempo per risolvere i nostri problemi individuali con la lingua. La “r” di Bocciolo di rosa, kvindi
la “kv” di Marinka, la mia eterna lotta con i generi e gli accenti.
Lule, chiaramente, doveva solo ampliare il suo lessico già notevole.»16 I mariti non capiscono il bisogno delle loro mogli di
imparare bene l’italiano. «Ai loro occhi spendere tre euro a testa
all’ora e passare settimane intere a declinare verbi è uno spreco,
un delitto, quasi. A Bobo non importa parlare spruzzando l’italiano con parole nella sua lingua e in triestino, Ashok sbaglia
spesso accento, e Besim e il signor Fong sono così parchi di
parole che i loro sbagli passano quasi inosservati.»17 Spicca, come
15
Ivi, p. 153.
Ivi, p. 53.
17
Ivi, p. 59.
16
121
Brigitta Bianchi
si è già accennato in precedenza, la capacità della Wadia di creare paragoni icastici. Il vecchio proprietario dello stabile, il signor Zacchigna, aveva una voce «da sturalavandino»18 e, se stringeva la mano, «la stritolava come uno spicchio d’aglio nel mixer»19.
Marinka si esprime «con un singhiozzo che la fa tremare come
un budino», «ha il cuore fatto di mozzarella, basta un niente e si
scioglie»20; una domanda le esce dalla bocca «come il fuoco da
una mitragliatrice al rallentatore»21; ancora, con dei tacchi alti
insoliti per lei, muove i passi «un po’ incerti, come se fosse un
pianoforte a coda che qualcuno spingeva da dietro»22; «suda come
una fetta di melanzana sotto sale»23. Il signor Rosso «bussa alla
porta come un martello pneumatico» e «aveva il riporto grigio
che gli penzolava dalla parte sbagliata come un topo morto»24.
Kamla ha una «vocina dolce come lo zucchero filato»25. I mobili, dice Shanti, «li abbiamo messi insieme come dei trovatelli in
un orfanotrofio»26. Bocciolo di rosa «ha la pelle liscia come l’interno di una conchiglia di madreperla»27. Laura sbatte le ciglia
«come un ventaglio a ferragosto»28.
18
Ivi, p. 10.
Ivi, p. 11.
20
Ivi, p. 14.
21
Ivi, p. 49.
22
Ivi, p. 68.
23
Ivi, p. 131.
24
Ivi, p. 20.
25
Ivi, p. 27.
26
Ivi, p. 38.
27
Ivi, p. 52.
28
Ivi, p. 56.
19
122
Nessuno è ciò che sembra
Roma è lo sfondo del romanzo dell’algerino Amara Lakhous
Divorzio all’islamica a viale Marconi.29 Due voci si rincorrono e si
intrecciano durante tutta la storia: quella del tunisino Issa (il
corrispettivo di Gesù per i musulmani), al secolo Christian Mazzari, giovane siciliano che parla perfettamente l’arabo, in missione per il Sismi; e quella di Sofia, l’egiziana Safia, madre di
Aida e moglie dell’architetto Said, che a Roma lavora come pizzaiolo e si fa chiamare Felice.
È la primavera del 2005 e sembra che i servizi segreti italiani abbiano ricevuto la notizia che un gruppo di immigrati
musulmani sta preparando un attentato nella zona di viale
Marconi, vicino all’università Roma Tre. Si rende necessario
quindi infiltrare una persona, Christian appunto, nella comunità araba musulmana a Roma, che gravita intorno al call center chiamato Little Cairo gestito dall’egiziano Akram. Questi
propone a Issa prima un posto letto con altri undici immigrati
nell’appartamento della sessantenne Teresa, soprannominata
Vacanza, e poi un impiego come lavapiatti proprio nella pizzeria dove lavora Felice. Christian deve calarsi nel suo personaggio, sembrare ciò che non è, ma che gli riesce facile essere,
salvo in alcuni frangenti. «Mi accorgo di un problema che avevo completamente sottovalutato: per sembrare credibile devo
parlare un italiano stentato, e pure un po’ sgrammaticato. A
volte mi capita di dimenticare la parte che sto interpretando.
Mi devo identificare nel personaggio Issa, un immigrato tunisino. Cerco di ricordare la parlata dei miei conoscenti arabi,
soprattutto di quelli tunisini. Devo imitare anche il loro accento. L’ideale è parlare un italiano con una doppia cadenza:
araba, perché sono tunisino, e siciliana, perché sono un immigrato che ha vissuto in Sicilia. Forse meno italiano parlo meglio sarà. Decido senza esitazione di sospendere momentane-
29
Edizioni e/o 2010.
123
Brigitta Bianchi
amente molte regole grammaticali, quindi via il congiuntivo e
il passato remoto.»30
È il bengalese Omar a iniziare Christian/Issa alla vita dell’appartamento e anche a fornirgli spiegazioni su che cosa significhi essere immigrato. Issa si adatta con qualche difficoltà alla
convivenza forzata, ma impara a conoscere i suoi vicini di letto
e riesce pure ad aiutarne qualcuno, mandando in bestia Giuda,
cioè il capitano Tassarotti del Sismi, il suo superiore che lo guida da un appartamento in via Nazionale, dove Issa può anche
tornare per qualche attimo alla sua vita precedente, facendosi
una doccia o leggendo le e-mail.
Su un binario parallelo scorre la narrazione di Sofia, laureata
in lingue, parrucchiera di nascosto dal marito, che le ha imposto
l’uso del velo. «Mettere il velo? Forse non avevo capito bene.
Ma noi saremmo andati a vivere in Italia o in Iran? Il velo è per
caso obbligatorio a Roma? Felice non scherzava affatto. Un vero
colpo basso. Un pugno sotto la cintura. Se fossimo stati sul ring
l’arbitro l’avrebbe subito ammonito e io avrei guadagnato dei
punti. Forse avrei pure vinto, alla fine. Ci sono delle regole del
gioco da rispettare, o sbaglio? Il vero problema è che viviamo in
una società nella quale il maschio fa contemporaneamente l’avversario e l’arbitro. Noi donne che dobbiamo fare? Potremmo
mai vincere in questa situazione?»31
Se il racconto di Issa è fortemente incentrato sulla sua integrazione, quello di Sofia ci ragguaglia sul suo passato e ci svela i
suoi pensieri e i suoi dubbi di giovane donna immigrata. «Vogliamo parlare della poligamia nel Corano? Non ho paura. Sono
pronta. Non ho fatto studi all’università religiosa di Al-Azhar,
però ho letto un sacco di libri sull’argomento. Dunque, i versetti
dedicati alla poligamia sono soltanto tre e si trovano nel capito-
30
31
Ivi, p. 45.
Ivi, p. 39.
124
Nessuno è ciò che sembra
lo intitolato “Le donne”. Ecco cosa dicono esattamente: “Sposate allora fra le donne che vi piacciono due o tre o quattro, e se
temete di non essere giusti con loro, allora una sola”. Fine della
citazione. Secondo il mio modesto parere, la poligamia è vincolata a condizioni impossibili da rispettare. Voglio proprio vedere come farà il signor poligamo a essere giusto con quattro mogli!
Infatti, dovrà dividere in maniera precisa tutto in quattro: il tempo, i soldi, i baci, i regali eccetera eccetera. È più facile vedere la
luna a mezzogiorno che trattare quattro mogli in modo identico! È una roba infernale che porta direttamente in manicomio.
Povero poligamo? Povero un corno! Peggio per lui.»32
Sofia è una donna colta (frequenta la biblioteca) e socievole:
la sua amica del cuore, l’algerina Samira, abita nel suo stesso
palazzo, ma sovente Sofia incontra anche l’italiana Giulia e l’albanese Dorina al giardino di piazza Meucci. Queste forse non
sono amiche per la pelle, come le donne di Laila Wadia, ma si
confrontano e crescono insieme. Parlano di maternità, di divorzio, di chirurgia estetica. «La mia teoria è semplice: il velo non è
sempre di stoffa, ci sono altri trucchi, paragonabili al nostro
velo, che nascondono altre parti del corpo. E allora? Allora niente.
Insomma, il seno rifatto nasconde il seno originale, il naso rifatto nasconde il naso originale, le labbra rifatte nascondono le
labbra originali e così via.»33 Anche con queste amiche c’è l’anziano burbero, il signor Giovanni, a cui Dorina fa da badante.
Egli legge La Padania, Libero e Il Giornale, ma, quando è triste,
per sfogarsi prendendosela con i partigiani, legge Il Manifesto!
Per un pianto di Sofia al call center e un provvidenziale fazzoletto porto da Issa, le due storie si intrecciano e gli stessi episodi
vengono narrati dai due punti di vista. All’inizio lui per lei è solo
un ragazzo con i baffi che le offre un fazzoletto, ma poi diventa
32
33
Ivi, pp. 60-61.
Ivi, p. 101.
125
Brigitta Bianchi
“il Marcello arabo”34 dopo un sogno sulla Dolce vita. Sì, perché ad
entrambe le voci il cinema italiano è molto familiare: se Sofia
dimostra spiccate preferenze per i film con Marcello Mastroianni, Issa spazia da Nanni Moretti a Federico Fellini, da Anna Magnani ad Alberto Sordi. I due si rivedono in biblioteca e poi al
mercato dove Issa rischia di far saltare la sua copertura prendendo le difese di Sofia, che è stata spinta da un arrogante cinquantenne. Lei commenta: «Da quando vivo in Italia non ho mai sentito un arabo, un immigrato, uno straniero parlare un italiano così
perfetto.»35 L’assimilazione di Issa continua e il capitano Giuda gli
chiede di infiltrarsi nella moschea della Pace. Dopo un’iniziale
ritrosia Issa riflette: «Ma perché lamentarmi? Questa è una vera
occasione. Potrebbe essere un’esperienza unica che arricchirebbe
il mio curriculum di orientalista, o meglio di arabista, come si usa
dire in ambito accademico. Ho sempre guardato con diffidenza a
quegli occidentali che vivono nei paesi arabi per anni senza sforzarsi minimamente di imparare l’arabo, e rimangono sempre dei
turisti odiosi, superficiali e viziati, insopportabili! Credono di conoscere il paese in cui vivono, e invece non sanno una minchia!»36
Bisogna specificare che Christian, la sua famiglia e la sua ragazza
Marta vivono in Sicilia, a Mazara del Vallo, e fin dalle prime pagine del libro la lingua di Issa riflette questo dato sia sul piano lessicale che su quello sintattico. Sono soprattutto i suoi proverbi a
portarci in Sicilia: «Cu’ parra picca campa cent’anni!»37 Ma proverbi ce ne sono anche in arabo e in francese e sono perle di
saggezza come quelle di padron ’Ntoni ne I Malavoglia.
Sofia, dal canto suo, confessa con orgoglio di parlare bene
l’italiano: «Mi è capitato di essere scambiata per un’italiana con34
Ivi, p. 100.
Ivi, p. 105.
36
Ivi, p. 140.
37
Ivi, p. 46.
35
126
Nessuno è ciò che sembra
vertita all’Islam oppure per una nata o arrivata da piccola in Italia.»38 Sottolinea invece che il marito, come tanti egiziani, non riesce a pronunciare la “p” e immagina un’esilarante scenetta in cui
Felice e «un altro orfano della lettera p» dialoghino in italiano al
Little Cairo.
A questo punto la vicenda si complica, come in Amiche per la
pelle, e avvengono due colpi di scena, che coinvolgono entrambi
Issa, con i quali il romanzo si conclude.
La narrazione scorrevole, la lingua particolare e gli interessanti punti di vista di immigrati sull’Italia e anche sui loro Paesi
d’origine mi hanno indotto a proporre i due romanzi a studenti
di una quinta ginnasiale in cui ho avuto la ventura di insegnare
geografia. Gli alunni hanno accolto di buon grado il suggerimento e quasi tutti hanno letto un romanzo o l’altro e ne hanno
vivacemente discusso in classe.
Del libro di Lakhous hanno messo in evidenza l’attualità della
tematica e il contributo che fornisce all’abbattimento di pregiudizi sul mondo arabo. Sono rimasti colpiti dal fatto che gli immigrati arrivano in Italia carichi di aspettative e lì si accorgono
che gli italiani, scontenti, abbandonano il loro Paese. I ragazzi
hanno espresso qualche riserva sullo stile: non hanno gradito
stilemi che caratterizzassero anche linguisticamente un personaggio e si sono trovati a disagio davanti al siciliano o al
romanesco, che talvolta compaiono nel testo.
Comicità, ironia e triestinità sono stati gli elementi del gradimento di Amiche per la pelle. Gli alunni sono rimasti colpiti dal
senso del passato, che dimostrano le quattro donne. Hanno imparato che non bisogna fidarsi delle apparenze. Chiave portante
di tutta la storia è, secondo loro, la condizione della donna.
Entrambi i libri sono calorosamente consigliati dai ragazzi.
38
Ivi, p. 81.
127
Dal “sapere” letterario al “saper essere”:
sviluppare una competenza interpretativa
di Raffaela Cosimi*
L’insegnamento della letteratura in lingua straniera
Se è vero che la letteratura è soltanto uno delle molteplici espressioni della cultura di un popolo che l’insegnante di lingua straniera deve prendere in considerazione nella sua pratica quotidiana, accanto al cinema, al patrimonio artistico, alle tradizioni
e ai fenomeni di costume, alle conquiste tecnologiche e scientifiche, non dimentichiamo che essa ricopre un ruolo assolutamente preponderante nell’indirizzo linguistico direttamente
correlato alla prova dell’Esame di Stato.
È bene altresì ricordare che il QCER (Quadro Comune di
Riferimento Europeo), ha reintegrato la letteratura all’interno
dell’approccio “per azioni-compiti”1, conferendole un’importan-
*
Docente di lingua e civiltà francese.
Il termine comunemente usato in francese per il metodo che ha superato
quello comunicativo, integrandolo, negli anni ’90 è “approche actionnelle”
ed è chiaramente definito da Rémi Thibert nel Dossier d’actualité n. 58 (novembre 2010) – Pour des langues plus vivantes à l’école [Per delle lingue più vive a
scuola] in questo modo: «L’approccio comunicativo ha ceduto il posto alla
didattica per azioni-compiti con il QCER, rendendo centrale il concetto di compito: i compiti sono dei progetti con reali obiettivi sociali in cui l’apprendente deve cercare, selezionare e analizzare le informazioni in funzione di ciò
1
129
Raffaela Cosimi
za etica e politica (benché limitata all’ambito educativo), che
costituisce un grande passo avanti rispetto ai precedenti documenti (Français Fondamental e Niveau Seuil)2 nei quali non
compariva affatto.3
Partirò dal presupposto che gli obiettivi dell’insegnamento
della letteratura in Lingua Straniera sono gli stessi che riguardano la Lingua Materna,4 e solo successivamente prenderò in esame le differenze e le eventuali difficoltà che l’uso di una lingua
diversa comporta nella lettura e interpretazione dei testi.
Ma già la definizione degli obiettivi didattici ed educativi non
è impresa facile, perché il concetto di letteratura si declina nei
due aspetti fondamentali di storia letteraria e di testo. Ad esempio secondo C. Bemporad (Università di Losanna), per letteratura si intende «l’insieme costituito dall’oggetto letterario [il testo, NdT] e da tutti i discorsi su questo testo, come anche tutti
gli elementi, le pratiche, le attività attorno a questo oggetto: le
critiche letterarie rivolte agli specialisti, le riviste, le trasmissioni
(…) i battage pubblicitari (…) le dissertazioni e naturalmente le
attività scolastiche»5.
che vuole realizzare utilizzando la lingua con uno scopo specifico. Tale prospettiva si adatta all’approccio per competenze, nella misura in cui una competenza si realizza sempre in un contesto sociale dato, anche se si misura
sempre a livello individuale» (la traduzione è della scrivente).
2
Si tratta dei primi modelli, elaborati negli anni Sessanta e Settanta, per definire rispettivamente il lessico di base necessario per esprimersi in modo efficace e il livello di autonomia linguistica dell’apprendente, in pratica i primi
tentativi di classificare le competenze in lingua francese.
3
Cfr. BEMPORAD C., Le cadre et la littérature. Proposition d’une articulation possible,
in 11èmes Rencontres des chercheurs en didactique des littératures, Ginevra, marzo
2010, p. 19, consultabile sul sito: http://www.unige.ch/litteratures2010/
contributions_files/Bemporad%202010.pdf
4
Per semplificare da qui in avanti userò le sigle LM e LS.
5
Ivi, p. 2
130
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
Questa doppia valenza rende già difficile operare una scelta/
integrazione tra storia letteraria e analisi testuale e il rischio che
si corre, sollecitati dalla necessità di sintesi e di semplificazione
imposta dalla tirannia del tempo, è quello di dare maggior spazio a uno dei due aspetti, a scapito dell’altro.
Valorizzando troppo l’aspetto cognitivo e dei contenuti, si
incorre nell’errore che condannava nel lontano 1894 Gustave
Lanson, il fondatore della storia letteraria come disciplina in LM:
Ultimamente hanno travisato l’insegnamento e lo studio della
letteratura. L’hanno presa per materia di programma, che bisogna aver scorso, sfiorato, ingoiato, alla bell’e meglio, il più velocemente possibile, per non essere bocciati: salvo poi, come tutto
il resto, non pensarci più per il resto della vita.6
Nell’ansia di voler insegnare tutto, la letteratura si riduce a
un’arida collezione di fatti e di formule, che finiscono per allontanare i giovani dalle opere, le vere depositarie e rivelatrici dell’individualità, per lasciare il posto a una conoscenza sterile e priva di
valore, un sapere “letterale” senza “virtù letteraria” e senza assimilazione critica. È invece importante rivalutare le opere:
In letteratura, come in arte, non si può perdere di vista le opere,
infinitamente e indefinitamente ricettive e di cui mai nessuno
può affermare di aver esaurito il contenuto né fissato la formula.
Vale a dire che la letteratura non è l’oggetto di un sapere: è esercizio, gusto, piacere. Non la si sa, non la si impara: la si pratica, la
si coltiva, la si ama.7
Oltre ad abbandonare la pretesa di esaustività, è bene anche
6
LANSON G., Histoire de la littérature française. Avant-propos, 1894, rist. Hachette,
Paris 1920, p. VI (traduzione della scrivente).
7
Ivi, p. VIII (traduzione della scrivente).
131
Raffaela Cosimi
non dimenticare che la letteratura nella Secondaria Superiore
non è critica letteraria, ma materia di studio da definire in termini di obiettivi didattici8 e che pertanto va considerata come una
tappa in un processo di crescita, una fase temporanea in vista di
un ulteriore sviluppo che, si auspica, non venga interrotto al
termine del ciclo, ma continui anche dopo in forma autonoma.
Tuttavia la quantità di obiettivi assegnati all’insegnamento/
apprendimento della letteratura è a dir poco impressionante; ad
esempio, per citare il Reuter:
Sviluppare lo spirito di analisi, sviluppare le competenze linguistiche, sviluppare le competenze di lettura e scrittura, sviluppare
i saperi letterari, il bagaglio culturale dell’allievo, il suo spirito
critico, permettergli di appropriarsi un patrimonio, sviluppare il
suo senso estetico e la sua sensibilità, procurargli piacere, contribuire alla formazione della sua personalità…9
Finalità così vaste e ambiziose difficilmente possono essere
acquisite affrontando la materia soltanto a partire dal quarto,
quinto anno di studio, soprattutto se devono essere sviluppate
attraverso dei contenuti cognitivi che abbracciano alcuni secoli
di storia della letteratura, e compresse in un monte ore annuale
piuttosto esiguo, all’interno del quale non vanno dimenticate
altre competenze, in primo luogo quella di scrittura.
Alla difficoltà di definire e collocare l’apprendimento/insegnamento della letteratura nel curricolo scolastico ed educativo,
8
Per la distinzione tra letteratura come disciplina e come materia di studio a
scuola vd. WIDDOWSON H.G., Stylistics and the Teaching of Literature, Longman
1975, citato in Insegnare letteratura in lingua straniera, a cura di STAGI SCARPA M.,
collana Scuolafacendo, Carocci Faber, Roma 2005, p. 18.
9
REUTER Y., L’enseignement apprentissage de la littérature en question, Enjeux 43-44,
Namur, p. 197 (traduzione della scrivente). Yves Reuter è professore di didattica del francese all’Università Charles de Gaulle - Lille 3, fondatore e direttore
dell’équipe di ricerca THEODILE, la più importante nella didattica del francese.
132
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
si aggiunge negli ultimi tempi un’esigenza che diventa sempre
più pressante, in presenza di un pubblico di studenti le cui coordinate culturali e sociali cambiano in modo assai rapido; quella
di essere motivati, «cioè aiutati a cogliere significato (per la costruzione di sé e della loro immagine del mondo) in ciò che
stanno studiando».10
Si pone cioè un problema di attualizzazione degli argomenti
di studio, che appaiono sempre più distanti dall’esperienza di
vita dei nostri giovani soprattutto nel linguaggio, ma spesso
anche nelle tematiche, e lontani dalle loro esigenze e dai loro
bisogni, pericolosamente soppiantati da modelli banalizzati e
culturalmente poveri sia nel messaggio che nello strumento
linguistico.
Se per rivitalizzare il patrimonio letterario è utile ricorrere a
linguaggi diversi (visivi, musicali, teatrali), è altresì importante
conservare il ruolo preponderante del testo scritto, proprio perché ci aiuta a contrastare i pericoli insiti nell’eccesso di comunicazione mediatica:
Appare quasi superfluo sottolineare quanto la parola scritta possa
indurre alla riflessione un universo giovanile che vive in una vera e
propria full immersion di comunicazione audiovisiva caratterizzata
da immediatezza ma allo steso tempo da pericolosa labilità.11
È quindi uno strumento importante che bisogna rinnovare e
valorizzare.
10
Cfr. CAROTTI L.-SCLARANDIS C., La storia letteraria nella didattica del triennio
(Griselda on-line, rivista letteraria), http://www.griseldaonline.it/adi/
carotti_sclarandis_print.htm.
11
Cfr. Insegnare letteratura in lingua straniera, cit., p. 15.
133
Raffaela Cosimi
Il testo letterario: una preziosa risorsa di apprendimento
linguistico
Il merito di aver restituito alla letteratura un ruolo primario nell’insegnamento della lingua straniera, e anche ai livelli elementari,
è di Daniel Coste, Jean Peytard e Henri Besse, che ne hanno sottolineato i vantaggi, tra i quali ci limitiamo a citare i seguenti: «(Il
testo letterario) è il miglior rivelatore dei fatti linguistici» secondo
la formula di Eliane Papo; esso risponde al desiderio degli insegnanti di condividere i loro saperi; soddisfa insieme la richiesta di
formazione linguistica (o di strumento di comunicazione) e culturale (o umanistica, di sviluppo della personalità individuale).12
Appare quindi ormai superata la visione di stampo struttural-funzionalistico che, identificando nell’uso “connotativo”
della lingua la specificità del testo letterario, elaborava una “stilistica dello scarto” rispetto alla “norma linguistica” imponendo di affrontarlo solo dopo che lo studente avesse raggiunto
la piena padronanza di quest’ultima, cioè della lingua di uso
quotidiano.
Perciò è auspicabile che essa non venga sminuita o addirittura eliminata, sulla scia dell’attuale orientamento verso una formazione strettamente professionalizzante, sempre più ancorata
alle necessità del mercato del lavoro, nell’ottica di una tecnicizzazione dilagante nelle società occidentali,13 ma anzi valorizzata
nella sua valenza educativa anche in settori non prettamente
umanistici, poiché la scuola ha il dovere di fornire il suo soste12
Cfr. SEOUD A., Des soucis pour la langue? Mais quelle langue, et quels soucis?, in
11èmes Rencontres… cit., Ginevra, marzo 2010; inoltre si può consultare PAPO
E.-PEYTARD J.-BOUGAIN D., Littérature et classe de langue, collection “Langue
et Apprentissage des Langues”, sotto la direzione di COSTE D., Crédif, ed
Hatier-Didier 1982.
13
Su questo argomento cfr. l’introduzione di BRANDMAYR F., A mo’ di prefazione. Il significato di queste pagine, in “Dialoghi al Liceo Dante”, Trieste 2010.
134
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
gno soprattutto a chi non dispone di determinati strumenti culturali in ambito familiare e perché, infine, la letteratura è anche
veicolo di idee e valori civili ed etici, oltre che estetici.
Anzi, è importante che la letteratura diventi una delle tante
risorse, e non soltanto nei Licei Linguistici, in quanto offre agli
studenti un’occasione di arricchimento attraverso testi che veicolano messaggi interessanti, ma soprattutto perché fa della lingua un uso specialissimo, sfruttandone tutte le possibilità espressive, rinnovandola e arricchendola continuamente.14
Senza contare che i testi letterari raccontano storie, descrivono esperienze umane, rivelano mondi diversi, talvolta lontani da
quelli dell’esperienza quotidiana aprendo nuovi orizzonti e fornendo messaggi interessanti, non effimeri e soggetti all’invecchiamento come le letture prese dai giornali o dall’attualità. E
ancora hanno un carattere di permanenza collettiva (prova ne
sia che i “grandi testi” vengono letti e studiati anche a distanza
di centinaia d’anni), ma anche individuale (si possono rileggere
più volte a distanza di tempo ritrovando lo stesso piacere o scoprendovi una sollecitazione diversa, correlata al vissuto individuale che è in continuo divenire).
Il testo letterario: un obiettivo di livello avanzato?
La lettura del testo letterario comporta tuttavia una serie di difficoltà quando sia affrontata nell’ambito di un LS.
In primo luogo presuppone un livello di competenza linguistica elevato, che le nuove generazioni di studenti hanno sempre più difficoltà a raggiungere anche nella lingua materna; senza contare che, malgrado gli sforzi degli insegnanti, il testo letterario è in genere percepito dal discente di difficile accesso e
14
Cfr. Insegnare letteratura in lingua straniera, cit., p. 13.
135
Raffaela Cosimi
piuttosto lontano dalla pratica quotidiana. Inoltre, perché esso
possa acquisire quella valenza sociale ed esistenziale che auspichiamo, deve essere forte e significativo per agganciare in qualche modo i bisogni impliciti – anche intellettuali, dei giovani.15
Infine, la lettura del testo deve essere supportata da conoscenze
di tipo culturale abbastanza approfondite, senza le quali è impossibile comprenderlo, apprezzarlo e interpretarlo.
La complessità del testo letterario richiede dunque un’educazione alla lettura che dovrebbe iniziare praticamente dai primi livelli (A1/A2) tramite le letture facilitate che si trovano comunemente in commercio, per proseguire con testi di autori
contemporanei che presentino situazioni vicine all’esperienza
degli apprendenti e per loro più significative, opportunamente
graduate nella difficoltà linguistica oltre che nella scelta dei temi.
Perché lo scopo dell’educazione letteraria è innanzitutto di renderli consapevoli dei cambiamenti culturali e sociali che stanno
avvenendo ora attorno a loro, ma anche di aiutarli ad «acquisire
strumenti critici di valutazione personale non offrendo alla loro
passiva accettazione gerarchie preordinate di valori e fama, ma
stimolandoli a prestare occhi, orecchie e intelligenza critica a
tutto ciò che si presenta alla loro attenzione»16.
Affrontare i grandi autori del “canone” letterario senza aver
prima costruito una competenza interpretativa individuale, rischia di inaridire lo studio della letteratura riducendolo a una
lista di contenuti che resteranno estranei al vissuto degli apprendenti; questi ultimi si avvicineranno ai “sacri testi” con timore
reverenziale e sentimento di inadeguatezza culturale che scoraggeranno la libera espressione delle loro reazioni emotive.
Infatti tutto il corredo di domande, che in genere accompagnano la lettura dei testi letterari e che hanno lo scopo di verificar-
15
16
Cfr. CAROTTI L.-SCLARANDIS C., op. cit.
Ivi.
136
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
ne la comprensione ma anche di orientarne l’interpretazione
all’interno di un contesto, tende a instaurare un meccanismo
domanda/risposta e un concetto di giusto/sbagliato che rischia
di inibire le risposte autentiche degli apprendenti.
La centralità del lettore
Per ottenere invece un’educazione stabile bisogna mettere in
moto i meccanismi di acquisizione profonda, non soltanto quelli
di apprendimento temporaneo, e fare in modo che gli studenti
interiorizzino gli elementi nuovi appropriandosene: fondamentale in questo processo cognitivo è il ruolo dell’emozione.17
Ora se riflettiamo all’uso che normalmente si fa in classe dei
testi letterari, osserviamo che le letture:
- non sono quasi mai integrali e la frammentazione in
piccoli estratti non permette al lettore di “entrare” nell’intreccio, né di familiarizzare con lo stile narrativo;
- sono imposte dall’insegnante in quanto devono rispondere agli obiettivi cognitivi che si è prefissato;
- sono scandite dai tempi e dalle necessità scolastiche;
- necessitano in genere di un intenso lavoro di interpretazione linguistica con il supporto dell’insegnante, delle
note o di un dizionario, che rallentano la lettura;
- sono appesantite da una quantità talvolta eccessiva di
richieste di tipo tecnico che la interrompono rischiando di scoraggiare la curiosità naturale a leggere.
17
In Insegnare la letteratura italiana per stranieri, Guerra, Perugia 2006, a p. 9 il
prof. P.E. BALBONI fa riferimento agli studi di SCHUMANN (1997) sul funzionamento cerebrale, riportando i cinque criteri utilizzati dal cervello per selezionare ciò che vuole acquisire: novità, attrattiva, funzionalità, realizzabilità,
sicurezza psicologica e sociale.
137
Raffaela Cosimi
Privilegiano dunque l’aspetto cognitivo, in quanto scelte perché
veicolano determinati contenuti (relativi al periodo storico, alle tematiche, al movimento in cui si inseriscono, o al contesto dell’opera dell’autore) e l’aspetto del testo, di cui si tendono a evidenziare i
tratti stilistici e le implicazioni linguistiche, trascurando invece il terzo fattore, la ricezione del testo da parte del lettore.
Infatti, solo superando la percezione di un’educazione letteraria concepita come “dovere”, facendo scoprire agli studenti che
hanno bisogno della letteratura e che da questa possono trarre
piaceri straordinari,18 riusciremo a incrementare la loro motivazione che si va facendo sempre più debole; constatiamo tutti infatti che i giovani leggono sempre meno, anche in lingua materna
e, una volta esaurito il compito imposto dall’insegnante, difficilmente si accostano in piena autonomia a un’opera letteraria.
Per raggiungere questo obiettivo, potrebbe essere utile recuperare l’aspetto socio-affettivo e soggettivo della lettura utilizzando pertanto come modello quella silenziosa in LM, chiamata anche “empirica” (in quanto legata all’esperienza personale) e “autentica” (in quanto motivata da bisogni e interessi reali), e che:
- è individuale, solitaria, autonoma;
- è liberamente scelta, e praticata in condizioni e in
momenti anch’essi liberamente scelti;
- è solitamente di un testo narrativo;
- è integrale;
- ha l’obiettivo di trovare piacere.
Questo piacere scaturisce spesso dal fatto che il testo incontra delle necessità emotive o riflessive del soggetto, sollecita la
sua curiosità di scoprire le azioni e i personaggi con i quali più o
meno si identifica, fornisce delle risposte a certi suoi interroga-
18
Ivi, a p. 10 il prof. P.E. BALBONI definisce in modo dettagliato l’educazione
letteraria come “risposta ad un bisogno” e “chiave per un piacere”.
138
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
tivi o in ogni modo si allinea con il suo sentire.19 Il ruolo dell’insegnante è allora quello di creare nuovi lettori, stimolando il
desiderio di capire, partendo da letture che presentino temi vicini alle esperienze del presente, aumentando il piacere di leggere e la capacità di ciascuno di attingere alle molteplici ricchezze del testo in modo sempre più articolato e profondo, rinnovandolo (perché no) nelle diverse fasi della vita alla luce delle
singole esperienze individuali.
Si tratta quindi di sviluppare una competenza trasversale tra
LM e le diverse LS, spesso sottintesa ma raramente esplicitata,
che chiameremo “di saper apprezzare le opere letterarie”, o più
semplicemente “competenza letteraria”, definita come «una
specie di direttore d’orchestra che attiva ed integra, completandole, tutte le altre competenze, e che si sviluppa mediante una
pratica quotidiana di condivisione culturale attorno ai libri»20.
Essa è da considerare nella sua doppia valenza di strumento,
in quanto permetterebbe all’apprendente di sviluppare delle strategie sempre più valide per affrontare testi via via più difficili e
complessi; e un obiettivo, perché gli permetterà di mantenere e
perfezionare la sua competenza linguistica e culturale, anche una
volta terminato il ciclo formativo della Secondaria Superiore.
L’autonomia è in effetti lo scopo principale dell’apprendimento, che «deve realizzarsi nell’arco di tutta la vita e va promosso e
facilitato in tutto il precorso educativo, dalla scuola dell’infanzia
19
Cfr. RIQUOIS E., Exploitation pédagogique du texte littéraire et lecture littéraire en
FLE: un équilibre fragile, ATER, Université de Rouen. In 11ème Rencontres…
cit., p. 250.
20
A proposito di questa competenza, che in Québec viene valorizzata e sviluppata a partire dal ciclo elementare nella lingua materna, è utile leggere il
progetto “Les oeuvres littéraires: projet du sous-comité de français de la
Montérégie”, giugno 2003, http://clindoeilpedagogique.net/IMG/apprecierNicole_1_.pdf. Il testo riporta anche una suddivisione interessante in
sottocompetenze (comprendere, reagire, interpretare, apprezzare).
139
Raffaela Cosimi
fino all’educazione degli adulti»21, e la lettura di un testo letterario
(strumento sempre disponibile) è praticabile individualmente in
qualsiasi momento, ed è fonte inesauribile di materiale che ha il
vantaggio, rispetto agli articoli di attualità reperibili sulla stampa e
in Internet, di non “invecchiare”: un libro è immutabile, sarà eventualmente il lettore, in relazione al momento e alle esperienze
personali, a riempirlo di significati diversi.
È evidente che questo approccio scardina i ruoli tradizionali;
l’insegnante allora, più che depositario di un sapere da trasmettere o di una chiave interpretativa preordinata, diventa una specie di “mentore” che legge e rilegge con gli studenti dei libri che
ha scelto (evidentemente) per loro, condividendo con loro il
piacere e la scoperta delle varie pieghe interpretative dell’opera.
Strategie e proposte
Benché il contesto scolastico e le difficoltà linguistiche, oltre
che culturali, modifichino inevitabilmente la ricezione di qualsiasi documento, lo scopo è di restituire il più possibile la modalità di lettura “autentica” in LM mediante delle pratiche opportune. In fondo a questo articolo riporto alcune proposte di lettura
e tre schede a uso dell’insegnante che ho selezionato e sperimentato in classe in base ai seguenti criteri:
- lunghezza: sono da preferire novelle, romanzi brevi
o racconti lunghi, che, pur consentendo al lettore
di familiarizzare con luoghi, eventi e personaggi,
non ne mettono a dura prova la resistenza;
21
Cfr. punto 2 dei documenti del Simposio intergovernativo di Rüschlikon, novembre 1991, citato in Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, La Nuova Italia, Oxford, p. 6.
140
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
- gradualità: essa riguarda le difficoltà lessicali e grammaticali costituite soprattutto dall’uso letterario del
“passé simple” (passato remoto) in francese;
- centralità del lettore: le tematiche proposte dovrebbero essere vicine all’apprendente, in quanto il narratore o il protagonista è quasi sempre un bambino o
un giovane;
- interesse culturale e sociale: i temi proposti sono utili a
comprendere la realtà sociale e culturale della Francia e del mondo francofono;
- attualità: sono da preferire gli autori contemporanei
perché presentano situazioni e linguaggi in cui i giovani meglio possono identificarsi, agganciandosi alla
realtà in cui vivono;
- diversità culturale: è bene proporre autori non strettamente francesi, ma appartenenti alle diverse realtà
culturali e religiose integrate sempre più alla realtà
sociale occidentale.
Altro elemento importante per sostenere e incrementare la
motivazione, è dare allo studente l’opportunità di confrontarsi
con i suoi pari, favorendo innanzitutto lo scambio di emozioni,
percezioni e giudizi, affinché ciascuno sia stimolato ad ampliare
il suo spirito critico, ad arricchire la sua identità personale e il
suo bagaglio culturale.
Dalla lettura empirica alla competenza letteraria:
definizione, metodi, strumenti didattici
Le nuove tendenze didattiche hanno evidenziato come la lettura
autentica può rivelarsi uno strumento importante nella pratica
della lettura analitica (o metodica) dei testi letterari, più oggettiva
e supportata da elementi linguistici e socio-culturali, per condurre l’apprendente a una lettura che chiameremo “soggettiva argo141
Raffaela Cosimi
mentata”, in cui i due precedenti aspetti, cioè i poli rispettivamente del soggetto cognitivo e del testo (lettura metodica) e del soggetto lettore (lettura empirica), assumano un ruolo complementare e si integrino. Tale lettura viene definita nella nuova didattica
della letteratura insieme “partecipativa” e “distanziata”22.
Infatti, ogni lettura interpretativa è un processo dialettico che
richiede implicazione e distanziazione da parte dei soggetti lettori (Dufay 2007), partendo però sempre da un approccio intuitivo che poggia sulle reazioni spontanee della classe per andare
verso una interpretazione ragionata dei testi letterari.
La sperimentazione messa in atto negli ultimi anni sia nelle
Suole medie (Collège) che nei Licei francesi prevede due strumenti innovativi: il “carnet de lecture” (quaderno di lettura) e il
“débat en classe” (dibattito in classe).
Il primo è una specie di diario in cui l’alunno annota le sue
reazioni in modo istintivo, disordinato e individuale durante o
immediatamente dopo la lettura, e rientra in un tipo di lettura
detta “implicata”23, connotata da un coinvolgimento psico-affettivo o intellettuale del soggetto lettore.
Nella seconda fase, il dibattito costituisce la messa in comune delle impressioni soggettive e individuali, e dunque un momento di confronto e di scambio che permette un certo grado
di oggettivazione, in quanto osservazioni o interpretazioni diverse spingono a rivedere le proprie posizioni. È bene tener
presente che non si tratta di parlare del testo letto, né di discutere attorno a un testo, e tanto meno di chiarirne il senso, ma di
22
Il concetto è sviluppato da ANNIE ROUXEL et GERARD LANGLADE in occasione del convegno intitolato Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la
littérature. Il concetto del triplo lettore è teorizzato da MICHEL PICARD e poi
ripreso da VINCENT JOUVE. Cfr. AHR S., D’une lecture empirique à une lecture subjective
argumentée: quels processus cognitifs et langagiers mobilise?, in 11ème Rencontres… cit.
23
Il termine francese “impliqué” è di difficile traduzione e indica un
coinvolgimento anche emotivo.
142
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
imparare a sviluppare, arricchire e organizzare il proprio pensiero e la propria lettura interagendo con i propri pari e con
l’insegnante. Inutile evidenziare quanto entrambe le pratiche
(quella scritta del quaderno e quella orale del dibattito), elaborate in un contesto di lingua materna, implichino in termini di
apprendimento linguistico, favorendo la verbalizzazione del processo attraverso il quale il lettore reale si appropria del testo
ricorrendo al proprio vissuto e alla sua cultura personale, integrando obiettivi linguistici, culturali e formativi.
In una terza fase il “carnet” viene ripreso e rielaborato, per
incoraggiare un atteggiamento riflessivo, e permettere al lettore
di incamerare gli elementi scaturiti dal dibattito, farli propri e inglobarli nella sua interpretazione, passando dalla lettura implicata
a quella distanziata e completando così il processo dialettico.
In tal modo si fa prevalere la ricezione empirica dei testi da parte
del soggetto lettore a scapito dell’oggetto della lettura (il testo) e
dell’effetto programmato di questo sul lettore; ma contemporaneamente si stimola quest’ultimo alla pratica linguistica e a un’attività
cognitiva che lo porteranno a una lettura soggettiva argomentata.
Insomma, una vera rivoluzione che mette i lettori singoli in contatto diretto con il testo: il percorso non si fonda più sul meccanismo domanda/risposta costruito da un discorso comune istituzionalizzato sull’opera letteraria, quella del lettore esperto rappresentato dall’insegnante o dal redattore del manuale, ma sono i
singoli lettori/studenti che conducono il gioco e imparano così a
costruire il loro percorso interpretativo del testo. Nulla impedisce
poi all’insegnante di riprendere le nozioni introdotte dal dibattito
che ritiene più valide o interessanti in una lezione di approfondimento di tipo più “magistrale”. In questo modo «la co-attività interpretativa non parte dai contenuti di saperi ma vi ci conduce»24.
24
«La co-activité interprétative ne part pas des contenus de savoirs mais elle
y conduit (Jorro 2009)» in AHR S., op. cit.
143
Raffaela Cosimi
Tuttavia è necessario guidare gli apprendenti nella verbalizzazione del processo di appropriazione del testo, perché tanta
libertà, alla quale questi ultimi sono poco abituati, genera spesso
risposte laconiche e insoddisfacenti. Si possono ad esempio
sollecitare le immagini mentali che ogni lettore si costruisce
durante la lettura, e nelle quali fa confluire il suo vissuto e la
sua cultura personale per riempire l’incompletezza del testo.
Oppure chiedere di annotare i tempi e i ritmi della lettura per
aiutarli a prendere consapevolezza delle strategie di scrittura
(come le tecniche narrative) e delle loro preferenze estetiche
(parti descrittive che sollecitano l’immaginazione, parti narrative che risvegliano la curiosità). Infine, spingerli a selezionare
una parte del testo giustificando la loro scelta, il che equivale
già a una forma di interpretazione, poiché ogni selezione si
fonda su una sensibilità individuale che può essere di ordine
intellettuale, ma anche estetico.
Conclusione
Appare necessario sperimentare nuove formule per avvicinare i
giovani alla lettura, ponendoli al centro del processo e aiutandoli a sviluppare le loro potenzialità interpretative in piena libertà.
La lettura dei testi letterari, dapprima in forma semplificata, poi
integrale, di autori contemporanei, può diventare una palestra
importante per accrescere la competenza letteraria necessaria
ad avvicinare lo studente ai grandi autori del passato, e costituirà uno strumento sempre disponibile e accessibile in forma autonoma per migliorare e mantenere la competenza linguistica,
oltre che una risorsa importante sia per l’arricchimento culturale individuale, che per l’interpretazione critica della complessità
del mondo attuale in continuo mutamento.
144
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
SCHEDE PRATICHE
Nella mia ventennale esperienza didattica ho avuto modo di
selezionare e sperimentare in classe alcuni testi che hanno riscosso un buon successo e un diffuso interesse. Si tratta in genere di racconti di formazione i cui protagonisti sono ragazzi o
giovani che si misurano con la realtà, vivono esperienze anche
difficili, o attraversano una fase di crescita. Dei primi tre ho
redatto una scheda per orientare l’insegnante nella sua scelta, le
altre sono semplici indicazioni.
J.M.G. LE CLÉZIO, Mondo, in Mondo et autres histoires, Gallimard 1996, corredato da un dossier cui ho in parte attinto per la formulazione della scheda
Pertinenza della
scelta e centri di
interesse
Destinatari: studenti in possesso di un livello A2
(250 ore di apprendimento circa), orientativamente
3°/4° anno di studio, a partire dai 16 anni.
Lingua e stile
La lingua, pur essendo letteraria, presenta la singolarità di un uso assai frequente dell’imperfetto, che rende il racconto accessibile anche con
un livello intermedio. La presenza di un esiguo
numero di verbi al passato remoto consente una
certa fluidità della lettura, che presenta invece
qualche complessità a livello lessicale, per la quale
si suggerisce un approccio propedeutico all’uso
del dizionario.
La forma e il
genere letterario
Racconto lungo (una settantina di pagine nell’edizione citata) alla terza persona, la cui voce narrante
si determina solo all’inizio e alla fine come testimone-personaggio degli avvenimenti entro i limiti temporali dell’arrivo di Mondo nella imprecisata città e
la sua partenza verso una meta sconosciuta. Verosimile e realistico nella struttura e nell’intreccio, il
racconto si colora nello stile di un’aurea magica che
lo avvicina al genere della favola.
145
Raffaela Cosimi
I temi
La libertà dai legami affettivi (Mondo è un orfano) e dagli obblighi sociali (non frequenta la scuola e dispone di tutto il suo tempo), la solitudine e
il desiderio di essere accudito (Mondo chiede
continuamente alle persone che incontra di essere adottato), la necessità di fare i conti con le
regole sociali, il viaggio iniziatico e l’incontro che
trasforma il protagonista che ne trae un insegnamento, il sentimento di una natura affascinante
ed ambivalente che attrae e spaventa allo stesso
tempo, la fusione in una visione sincretica di elementi di culture diverse (i personaggi che incontra già nei nomi evocano paesi diversi – Ciapacan, Thi Chin, il Cosacco, il Gitano), la sofferenza e la necessità della separazione, il potere magico delle parole e la capacità dello sguardo infantile di ingentilire un mondo banale e perfino
brutto e crudele.
La storia
In una città della Francia del sud non meglio
determinata un giorno arriva Mondo, un bambino di cui nessuno sa nulla, nemmeno il narratore, che segue i suoi movimenti quotidiani, i
suoi giochi infantili, i suoi approcci diretti e talvolta ingenui con il mondo e le persone che lo
circondano. Qui il ragazzino farà una serie di
incontri e di esperienze che lo matureranno: due
avventurieri che si guadagnano il pane con giochi di prestigio che si prendono cura di lui, la
piccola vietnamita Thi Chin, silenziosa e accogliente come la sua casa e il suo giardino, ma
sperimenterà anche la paura di essere catturato
come un cane randagio e infilato nella
camionetta di Ciapacan, e infine la gioia di imparare a scrivere il proprio nome nell’illusione
di poter cogliere la bellezza del mondo. Ma l’incanto della bella favola si spezzerà e Mondo sarà
costretto a ripartire per evitare di finire in un
istituto dell’assistenza pubblica e perdere così
la sua libertà.
146
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
ERIC-EMMANUEL SCHMITT, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Albin Michel
2001; collection “Classiques & contemporains”, Magnard 2004 per il dossier
Pertinenza della
scelta e centri di
interesse
Destinatari: studenti in possesso di un livello A2/
B1 (200 ore di apprendimento circa), vale a dire
3°/4° anno di liceo, a partire dai 15 anni.
Lingua e stile
Accessibile sia per la sintassi lineare e semplice (il
racconto viene fatto da un bambino), sia per l’uso
molto frequente del dialogo; stile spesso poetico
con l’uso di metafore che potrebbero richiedere
un intervento dell’insegnante. L’uso ridotto del
passato remoto non condiziona la comprensione.
Potrebbe essere consigliabile un’edizione con un
supporto di note (soprattutto per il lessico) come
ad esempio l’Edizione sopra indicata, corredata
da un dossier che l’insegnante può scegliere di
utilizzare anche solo in parte.
La forma e il
genere letterario
Racconto lungo/romanzo breve vagamente fiabesco, raccontato in forma di “ricordi d’infanzia”
da un narratore adulto che si alterna con il narratore bambino, scaturito da uno spettacolo che l’autore ha scritto per Bruno Abraham-Kremer e parzialmente ispirato alla sua storia. François Dupeyron ne ha tratto un film presentato a Cannes
nel 2004, che ha valso ad Omar Sharif nel ruolo
di M. Ibrahim il César per il miglior attore.
I temi
Gli stereotipi culturali e l’incontro delle culture e
delle religioni, la tolleranza religiosa, la ricerca della
felicità, il rapporto padre/figlio, l’amicizia e il modello adulto nella crescita e nella formazione della
personalità, l’iniziazione all’età adulta, l’indifferenza, la solitudine e l’abbandono, la depressione. Fra
i contenuti culturali si può anche proporre un approfondimento del quartiere di Parigi della rue du
Faubourg Poissonnière.
La storia
Siamo negli anni ’60 e Moïse, soprannominato
147
Raffaela Cosimi
Momo, è un ragazzino di undici anni trascurato
dal padre, avvocato depresso da quando la moglie
lo ha lasciato. A poco a poco la sua figura di riferimento diventa M. Ibrahim, un turco che tutti
chiamano “l’arabe du coin” (l’arabo dell’angolo)
perché tiene aperta la sua bottega della rue Bleu
tutti i giorni, che fra piccole trasgressioni e semplici riflessioni sulla religione, gli indicherà i segreti della felicità e lo accompagnerà, insieme alle
prostitute del quartiere, nel difficile cammino verso
l’età adulta. Momo, a sua volta, accompagnerà M.
Ibrahim nel suo viaggio di ritorno al paese natale,
per vederlo un’ultima volta….Molti elementi della storia lo avvicinano al romanzo di Romain Gary
La vie devant soi, pubblicato con lo pseudonimo
Emile Ajar, Gallimard, Paris 1982
FAIZA GUÈNE, Kiffe kiffe demain, Hachette littératures 2004 Paris, collection
“Le Livre de Poche”
Pertinenza della
scelta e centri di
interesse
Destinatari: studenti in possesso di un livello A2
(200 ore di apprendimento circa), orientativamente
3° anno di studio, a partire dai 15 anni.
Lingua e stile
Lo stile è quello della lingua orale sia dal punto di
vista morfo-sintattico, che delle scelte lessicali e
dell’uso dei tempi verbali, il che lo rende accessibile anche a discenti con nozioni di grammatica
non avanzate (in particolare l’uso del passato prossimo nella narrazione). Tuttavia bisogna prevedere qualche lezione propedeutica sulle varie forme
del linguaggio familiare (“argot”, “verlan”, espressioni idiomatiche) ampiamente utilizzato nel romanzo, o un glossario elaborato dall’insegnante
per accelerare i tempi di lettura.
La forma e il
genere letterario
Romanzo di formazione al limite del diario intimo, realistico nell’intreccio ma estremamente
148
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
gettivo nella presentazione dei fatti. Si tratta infatti
del racconto in prima persona, in forma di diario
personale, di un’adolescente di origine marocchina
con difficoltà a integrarsi e scarso rendimento scolastico; lo sguardo estremamente critico che porta
sulla realtà è l’espressione della sua sofferenza interiore, sofferenza che via via, grazie agli incontri e
agli eventi che si susseguono nella sua vita, riuscirà
a superare per acquisire maggior fiducia nel futuro.
La narrazione si divide in brevi capitoli non numerati ma separati da semplici spazi tipografici, a loro
volta suddivisi in parti seguendo un criterio tematico o le esigenze del racconto intimo più che i ritmi
di una progressione narrativa esterna.
I temi
La difficoltà di integrazione delle culture
(marocchina e francese), l’analfabetismo, gli
stereotipi sugli immigrati e il razzismo, i rischi legati allo statuto di immigrato (fallimento scolastico, uso di sostanze stupefacenti, piccola delinquenza), la povertà e la vergogna che ne derivano, l’importanza dell’istruzione per l’emancipazione sociale, la ribellione e la crisi adolescenziale, il ruolo
svolto dalla televisione nell’analisi della realtà, la
possibilità di trovare nella letteratura un sollievo e
una risposta alla sofferenza umana.
La storia
Un mattino il padre di Doria è tornato al paese
natale, il Marocco, per sposare una donna più giovane e in grado di dargli dei figli (possibilmente
maschi). La quindicenne attraversa allora un periodo non facile: la madre analfabeta è depressa e
costretta a lavorare come donna delle pulizie per
sbarcare il lunario; lo scarso rendimento scolastico dà luogo a una sfilata di assistenti sociali mal
sopportate; l’amicizia con un magrebino più grande di lei, del quale è forse un po’ innamorata, la fa
soffrire di gelosia nei confronti delle donne che
frequenta. Sullo sfondo, la realtà sociale degradata di una delle tante “cité” dove si muove, soffre e
149
Raffaela Cosimi
si arrabatta per sbarcare il lunario tutta una folla
variopinta di persone, ciascuna con la sua cultura,
i suoi limiti, le sue speranze. E su tutto, lo sguardo
critico e talvolta feroce ma sempre ricco di humour, di un’adolescente che cerca di decifrare il
mondo con i mezzi che ha (una conoscenza enciclopedica dei programmi televisivi), sforzandosi
di integrare la sua cultura di origine, con i suoi
rituali e le sue tradizioni, a una realtà dinamica ma
spesso crudele e poco accogliente. Un po’ alla volta
i vari nodi si sciolgono, i rapporti cambiano e nuovi
spiragli si aprono, lasciando sperare in un futuro
migliore.
Elementi
di analisi
dell’opera
La forma narrativa alla prima persona (diario); il
linguaggio parlato (scelte lessicali, strutture
sintattiche, forme idiomatiche); la soggettività del
racconto e le informazioni che si ricavano dall’analisi della voce narrante; i riferimenti socio-culturali (numerosissimi) a tradizioni marocchine, trasmissioni televisive e testi letterari.
Altre proposte di lettura
Joseph Joffo, Un sac de billes, Hachette 1998, collection “Le Livre de Poche”
Amélie Nothomb, Robert des noms propres, Albin Michel 2003, collection “Le
Livre de Poche”
Delphine de Vigan, No et moi, Lattès 2007, collection “Le Livre de Poche”
Tahar Ben Jelloun, Les raisins de la Galère, Fayard 1996
M. Pagnol, La gloire de mon père, Flammarion 1974 (esiste anche il film diretto
da Yves Robert, 2002 TF1 VIDEO)
A. de Saint Exupéry, Le petit Prince, Gallimard 1987, collection “Folio Junior”
Per altri suggerimenti si può consultare il sito http://takalirsa.pagespersoorange.fr/index.html, ricco di idee e sollecitazioni.
Bibliografia e sitografia
Aa. Vv., Littérature et classe de langue. Français langue étrangère, Hatier et CREDIF 1982
DUFAY J.L., Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens,
utilité, évaluation, Presses Universitaires de Louvain 2007.
150
Dal “sapere” letterario al “saper essere”
PAPO E., Littérature et communication en classe de langue, Hatier-Didier 1990
ROUXEL A., Enseigner la lecture littéraire, Presses Universitaires de Rennes, 1996
THIBERT R., Dossier d’actualité n. 58 (novembre 2010) – Pour des langues plus
vivantes à l’école
DUFAYS J.-L., GEMENNE L., LEDUR D., Pour une lecture littéraire. Histoire, théories,
pistes pour la classe, 2e édition, De Boeck 2005.
Riviste
LIDIL, revue de linguistique, http://lidil.revues.org/index60.html
LE MAGAZINE LITTÉRAIRE, http://www.magazine-litteraire.com/
TDC. La revue des enseignants, http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/
le-roman-francais-contemporain/sequences-pedagogiques/lire-le-romancontemporain-a-lecole.html.
151
Diario di una settimana di scuola
diversa dal solito
di Marco Zocchi*
La settimana verde delle classi 5A e 5B a Piano d’Arta
(10-15 maggio 2010)
Tra le attività educative e didattiche che vengono proposte agli
studenti del secondo anno un posto di un certo rilievo è riservato al viaggio d’istruzione. Da alcuni anni si è deciso di proporre
alle classi interessate la settimana verde. La località scelta è Piano d’Arta, punto di partenza per escursioni che portano alla
scoperta degli ambienti naturali, dei tesori d’arte e delle tracce
della storia in tutta la Valle del But. La meta è stata scelta proprio perché offre la possibilità di svolgere attività molto varie,
ma sempre legate alla programmazione educativa e didattica, in
particolare alla storia, alla geografia, alle scienze naturali, alla
storia dell’arte e all’educazione fisica.
La “ricaduta” è stata sempre positiva, non tanto perché gli
studenti si divertono (naturalmente non è questo l’obiettivo più
importante), ma soprattutto perché hanno l’occasione di vivere
esperienze umane e culturali nuove e stimolanti.
Al termine della settimana verde del 2010, nel ripensare con
gli studenti della classe 5A ai momenti più formativi del viaggio,
è emersa la volontà di far conoscere anche ad altri le esperienze
vissute. Da questa esigenza è nata la decisione di riprendere in
mano e di pubblicare gli “appunti di viaggio” presi di giorno in
153
Marco Zocchi
giorno, redigendo una sorta di diario. Quello che segue è l’esito
di questo lavoro.
Lunedì 10 maggio
L’inizio è tranquillo e leggero. Il simpatico Mauro, albergatore e
accompagnatore in tutte le gite, ci porta a visitare lo stabilimento termale e ci spiega le miracolose proprietà curative delle acque sulfuree, che erano sfruttate già dagli antichi Romani e che
molti secoli dopo hanno fatto venire da queste parti anche un
certo Giosué Carducci. Poi un primo “assaggio” di natura tra
boschi, prati e ruscelli.
Nel pomeriggio Tiziana, l’esperta di botanica, ci porta, ancora tra boschi e prati, a scoprire le piante della Carnia (le conosce proprio tutte!). Quelle che a uno sguardo superficiale sembrano solo erbacce tutte uguali rivelano una straordinaria
biodiversità. Impariamo a distinguere erbe curative, saporiti aromi
per le nostre pietanze e letali veleni, e riflettiamo sull’uso sapiente che gli antichi facevano delle semplici e preziose risorse
che la natura ci offre.
Martedì 11 maggio
A vederla dal paese, arroccata sulla cima di un’impervia montagna, la Pieve di San Pietro sembra inaccessibile; eppure è proprio quella la meta della nostra gita. Dopo la dura salita lungo il
ripido costone boscoso, con sorpresa ci troviamo all’improvviso tra le case del paesino semi-spopolato di Fielis. Con altrettanta sorpresa scopriamo che qui un coraggioso gruppo di volontari ha fondato un’istituzione unica, dal nome curioso, la
“Polse di Cougnes”: centro culturale, luogo di incontro e di dialogo interreligioso, foresteria, biblioteca, orto botanico, laboratorio artistico, musicale e scientifico, persino osservatorio astronomico. Quindi ci dirigiamo all’antica Pieve. Risalente agli albori
del Medioevo e più volte ristrutturata e ampliata nel corso dei
secoli, si erge in posizione dominante su tutta la valle del But;
154
Una settimana di scuola diversa dal solito
nel Medioevo fu sede episcopale e la sua giurisdizione si estendeva sulla Carnia e su parte del Cadore. Da lì scendiamo per un
altro ripido sentiero a Zuglio, l’antica Iulium Carnicum. In epoca romana la città, situata lungo l’importante via che attraverso il Passo di Monte Croce Carnico collegava Aquileia con
l’area germanica, era il centro più importante della zona. Dopo
una rapida occhiata all’area archeologica, corrispondente all’antico foro, visitiamo il Museo, che conserva interessanti reperti dell’epoca celtica (armi e corredi funerari) e del periodo
romano (mosaici, sculture, frammenti architettonici, oggetti
di vita quotidiana).
Mercoledì 12 maggio
Dopo la fatica di ieri, oggi è un giorno di riposo. Al mattino
visitiamo la fattoria didattica di Bosco Museis, presso Cercivento.
Il posto è ameno e bucolico. Il “padrone di casa”, Renato
Garibaldi, un pronipote dell’eroe dei due mondi, ci spiega come
si possa e si debba conciliare lo sviluppo e il progresso con il
rispetto dell’ambiente.
Nel pomeriggio ecco un’esperienza nuova per i più e divertente: la gara di orienteering. Dotati di carta topografica e di
bussola, dobbiamo trovare nel minor tempo possibile i punti in
cui sono posizionate le cosiddette “lanterne”, ben nascoste nel
bosco e tra le case. Il record stabilito lo scorso anno proprio da
una squadra del Dante resiste, ma i tempi dei primi classificati
sono molto buoni.
Siccome è venuta fame, molti accettano la proposta di recarsi in cucina per imparare dalla cuoca Benedetta i segreti della
sua arte e, naturalmente, per assaggiare le pietanze.
Giovedì 13 maggio
La camminata di oggi ci porta in un ambiente di alta montagna,
sulle cime che costituiscono il confine naturale tra l’Italia e l’Austria. La mano ferma di Mauro aiuta chi ha poca dimestichezza
155
Marco Zocchi
con la montagna. Ci fa da guida Bruno; una vita, la sua, dedicata alla scuola e alla montagna. L’interesse dell’escursione non è
solo naturalistico, ma anche storico. In questi luoghi, infatti, si
possono vedere ancora le tracce lasciate dalla Grande Guerra
’15-’18. Le cime che sovrastano il Passo di Monte Croce Carnico
furono teatro di sanguinosi combattimenti; la guerra in alta
montagna era resa ancora più dura dalle difficili condizioni ambientali e vi persero la vita moltissimi giovani da entrambe le
parti. Sulle cime e lungo le creste, le trincee degli opposti schieramenti correvano a poche decine di metri di distanza; la guerra
fu un susseguirsi di sanguinosi attacchi e contrattacchi per contendersi pochi metri di territorio e i punti più strategici passarono ripetutamente da un contendente all’altro. Salendo lungo i
sassosi sentieri che portano al Pal Piccolo passiamo in mezzo ai
resti delle trincee e delle postazioni, muti testimoni di una grande tragedia. Ma per noi non mancano le gradite sorprese. La
prima è la neve, che a metà maggio resiste ancora abbondante
in quota; a chi crede di essere arrivato dove inizia la neve perenne, Mauro fa notare che anche a Trieste la neve inizia “per
enne”… Girato lo spigolo della montagna, ecco un’altra sorpresa: dopo lunghe ore di preparazione tecnica sulla parete attrezzata della palestra, finalmente l’ebbrezza di una vera ferrata; la affrontiamo in sicurezza sotto la guida esperta di Bruno. Tutto è
molto divertente, ma il nostro pensiero va anche ai giovani che
sono saliti lungo questi sentieri con la certezza di andare a morire.
Venerdì 14 maggio
Oggi ci dividiamo in due gruppi: chi è interessato all’arte va da
una parte, chi preferisce camminare in montagna dall’altra.
Il primo gruppo si reca a Illegio. In questo piccolo borgo,
lontano dai flussi turistici e dalle grandi vie di comunicazione,
già da alcuni anni l’intraprendenza del Comitato di San Floriano
permette di allestire importanti mostre d’arte con opere provenienti dai musei di tutta Europa. La mostra di quest’anno è de156
Una settimana di scuola diversa dal solito
dicata alla raffigurazione degli angeli e attraverso le opere esposte ci permette di gettare uno sguardo sulle varie correnti artistiche che si sono susseguite a partire dal Medioevo. Ma a Illegio
non c’è solo la mostra. Si possono vedere il caseificio, che produce il genuino formaggio di montagna con tecniche tradizionali, i mulini azionati dall’acqua del torrente, e l’antica Pieve di
S. Floriano, isolata sulla panoramica cima di una collina e raggiungibile dal paese con una comoda passeggiata.
Per gli “irriducibili” invece la meta è il Lander. Dopo una
lunga salita nel bosco arriviamo al bivacco e, percorsi ancora
pochi metri, ci affacciamo da un lato sul lontano fondovalle,
dall’altro sugli imponenti scoscendimenti franosi, formatisi circa 10.000 anni fa, che costituiscono i versanti meridionali del
Monte di Rivo e del Monte Cucco. Il ritiro del ghiacciaio, che
prima tratteneva i versanti, ha lasciato questi ultimi in condizione di instabilità, con la conseguente formazione di frane e fenomeni di erosione, con creste, guglie e pinnacoli. Sulla cima per
un attimo la nostra attenzione è attratta dal volo di un falco, che
volteggia libero sopra di noi tra il bosco e i brulli dirupi e subito
scompare tra le nubi. Un insperato squarcio tra le nuvole permette un ultimo sguardo al panorama da una radura prativa, poi
bisogna scendere rapidamente. È stata un’escursione impegnativa, ma ha offerto piccole grandi soddisfazioni: trovare con la
mappa il sentiero giusto nel cuore della foresta di abeti, ripararsi
dalla pioggia in una baracca di legno in mezzo al bosco, sedersi
in compagnia accanto al fuoco, arrampicarsi sui faggi secolari,
correre a perdifiato giù per i prati in pendio, balzare da un sasso
a un altro per attraversare un torrente senza bagnarsi. Siamo in
Carnia, ma potremmo essere anche tra le Montagne Rocciose:
l’avventura è assicurata; e tutto questo in un giorno di scuola!
Dopo una camminata così impegnativa che cosa c’è di meglio per ritemprare le energie che una corroborante partita di
calcio? E allora, il tempo di cambiarsi e via verso il campo sportivo di Arta. Non sarà il Bernabeu, ma va bene lo stesso… La
157
Marco Zocchi
partita è spettacolare e combattuta, nonostante la pioggia; al
fischio finale abbracci e strette di mano: bell’esempio di fair play.
Alla sera Mauro ci intrattiene cantando e suonando. Darko,
il factotum dell’albergo, ci stupisce con la sua inesauribile allegria.
Sabato 15 maggio
È già arrivato l’ultimo giorno! Visitiamo le chiesette medievali
di Arta, S. Spirito di Chiusini e S. Nicolò degli Alzeri, due piccoli gioielli d’arte e di storia. Mauro ci racconta affascinanti storie
medievali di dame e di cavalieri; come in tutte le storie medievali, non manca il mistero: il miracolo della salvia e il cunicolo
segreto sotto la chiesa dei Templari.
Dopo pranzo, in attesa della corriera, Mauro ci intrattiene
con strani e bizzarri giochi di abilità; i giochi con cui nelle miniere del Belgio i minatori emigrati dalla Carnia passavano il
tempo tra un turno di lavoro e l’altro, quando nemmeno nei
momenti di riposo avevano la possibilità di uscire all’aria aperta.
Ma ora è proprio giunto il momento di partire.
Le montagne sono ormai alle spalle. Si torna alla normalità,
da lunedì si torna a fare lezione in aula anziché all’aria aperta.
Ma questa settimana di scuola diversa dal solito rimarrà a lungo
nel nostro ricordo.
158
Finito di stampare
nel mese di novembre 2011
presso lo stabilimento tipografico
Globalprint srl di Gorgonzola (MI)
per conto della casa editrice
LINT Editoriale srl di Trieste