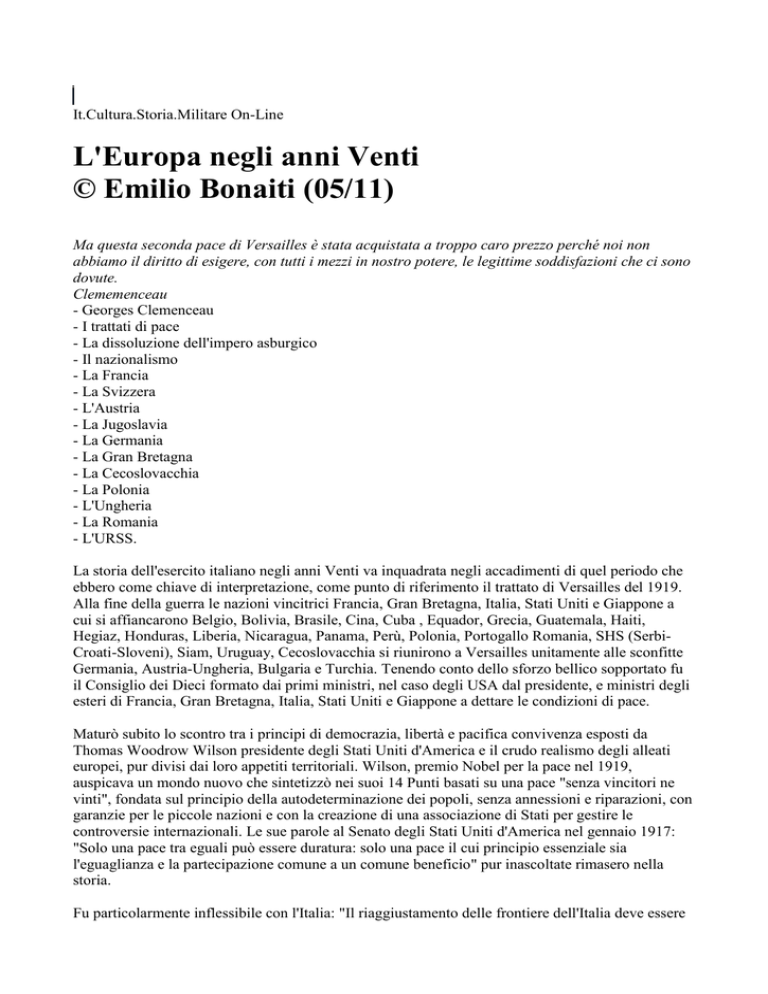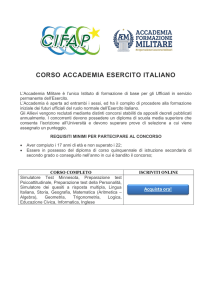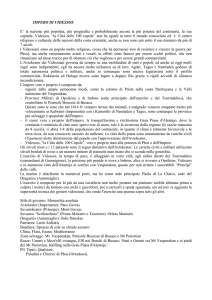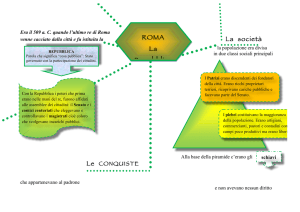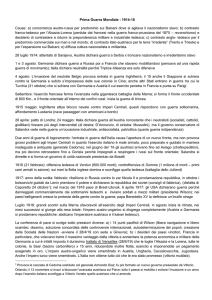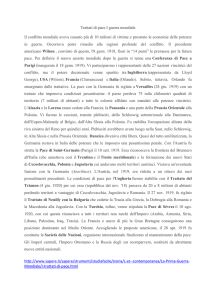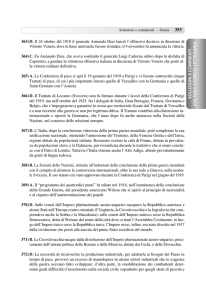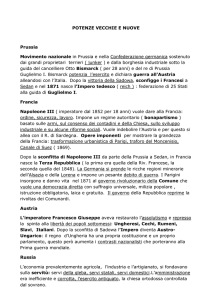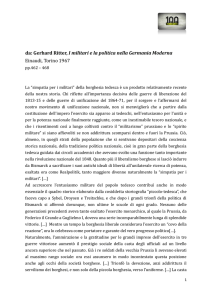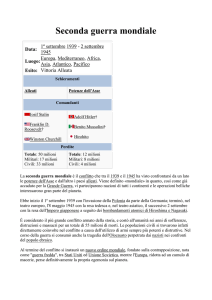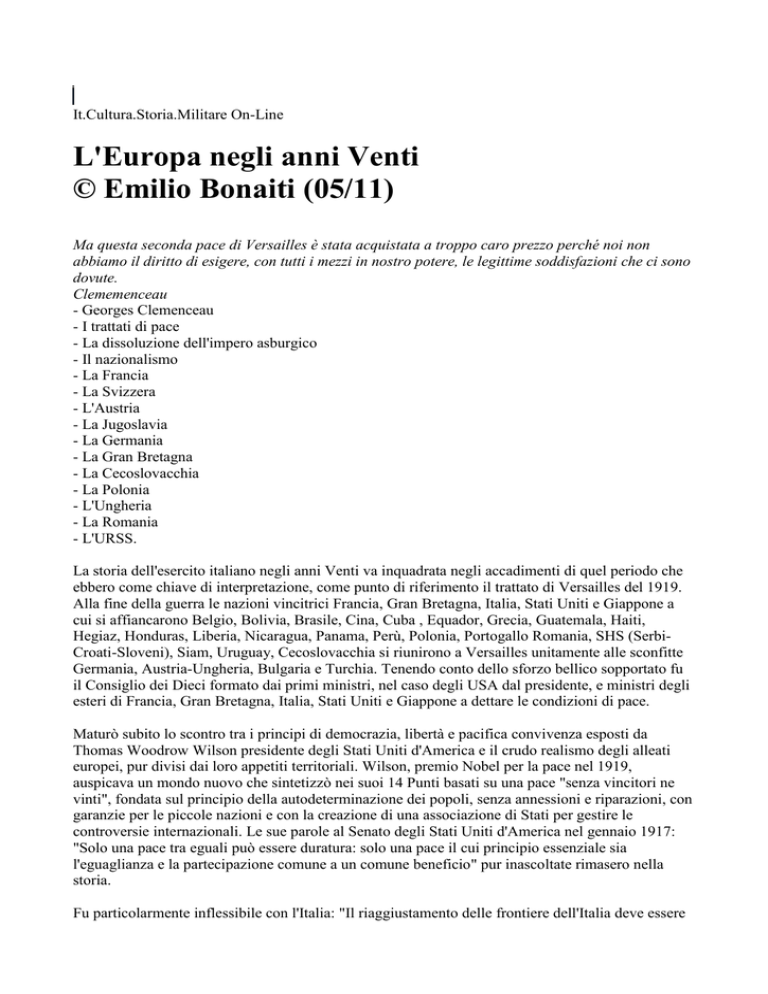
It.Cultura.Storia.Militare On-Line
L'Europa negli anni Venti
© Emilio Bonaiti (05/11)
Ma questa seconda pace di Versailles è stata acquistata a troppo caro prezzo perché noi non
abbiamo il diritto di esigere, con tutti i mezzi in nostro potere, le legittime soddisfazioni che ci sono
dovute.
Clememenceau
- Georges Clemenceau
- I trattati di pace
- La dissoluzione dell'impero asburgico
- Il nazionalismo
- La Francia
- La Svizzera
- L'Austria
- La Jugoslavia
- La Germania
- La Gran Bretagna
- La Cecoslovacchia
- La Polonia
- L'Ungheria
- La Romania
- L'URSS.
La storia dell'esercito italiano negli anni Venti va inquadrata negli accadimenti di quel periodo che
ebbero come chiave di interpretazione, come punto di riferimento il trattato di Versailles del 1919.
Alla fine della guerra le nazioni vincitrici Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e Giappone a
cui si affiancarono Belgio, Bolivia, Brasile, Cina, Cuba , Equador, Grecia, Guatemala, Haiti,
Hegiaz, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, Perù, Polonia, Portogallo Romania, SHS (SerbiCroati-Sloveni), Siam, Uruguay, Cecoslovacchia si riunirono a Versailles unitamente alle sconfitte
Germania, Austria-Ungheria, Bulgaria e Turchia. Tenendo conto dello sforzo bellico sopportato fu
il Consiglio dei Dieci formato dai primi ministri, nel caso degli USA dal presidente, e ministri degli
esteri di Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e Giappone a dettare le condizioni di pace.
Maturò subito lo scontro tra i principi di democrazia, libertà e pacifica convivenza esposti da
Thomas Woodrow Wilson presidente degli Stati Uniti d'America e il crudo realismo degli alleati
europei, pur divisi dai loro appetiti territoriali. Wilson, premio Nobel per la pace nel 1919,
auspicava un mondo nuovo che sintetizzò nei suoi 14 Punti basati su una pace "senza vincitori ne
vinti", fondata sul principio della autodeterminazione dei popoli, senza annessioni e riparazioni, con
garanzie per le piccole nazioni e con la creazione di una associazione di Stati per gestire le
controversie internazionali. Le sue parole al Senato degli Stati Uniti d'America nel gennaio 1917:
"Solo una pace tra eguali può essere duratura: solo una pace il cui principio essenziale sia
l'eguaglianza e la partecipazione comune a un comune beneficio" pur inascoltate rimasero nella
storia.
Fu particolarmente inflessibile con l'Italia: "Il riaggiustamento delle frontiere dell'Italia deve essere
effettuato lungo linee di nazionalità chiaramente riconoscibili. Il presidente americano, che
D'Annunzio icasticamente definì: "Triste quacquero incroato" scarso conoscitore della geopolitica
europea trovò una non troppo larvata opposizione da parte dei paesi vincitori dominati dai propri
egoismi e consci dei problemi che la creazione di una miriade di piccoli Stati in eterna conflittualità
avrebbe creato. Clemenceau causticamente definì i 14 Punti i 14 Comandamenti osservando che
Dio ne aveva fatti solo dieci, Lloyd George sosteneva che stando a tavola con Wilson e Clemenceau
gli sembrava di stare tra Gesù Cristo e Napoleone.
Dalla Conferenza per la pace di Parigi nacque la Società delle Nazioni sulla spinta di un
insopprimibile bisogno di pace che i sanguinosi eventi bellici avevano fatto maturare. La sede fu
stabilita a Ginevra nel 1920. Suo obiettivo la composizione dei contrasti tra gli Stati anche con l'uso
di sanzioni economiche e militari, sanzioni quest'ultime che rimasero sempre sulla carta.
GEORGES CLEMENCEAU
Avendo alle spalle un milione e seicentomila morti, il premier francese precisò il suo obiettivo, la
neutralizzazione della potenza germanica per gli anni a venire, la neutralizzazione della potenza che
dal 1814 aveva invaso per tre volte la Francia.
Tra i due paesi vi era troppa storia, troppa ossessione di cattive memorie: "In piedi, di mezzana
statura" si legge nella vivida descrizione che Aldrovandi Marescotti, segretario generale per l'Italia
alla Conferenza della pace a Parigi ne fa: "ma eretto, massiccio, con un volto severo, quasi avesse
innanzi agli occhi le atrocità e i sacrifici della lunga guerra, parla Clemenceau. Parla come di
consueto, chiaro, preciso, senza incertezze, senza indugi, senza una parola retorica, senza un gesto,
mantenendo i pugni chiusi lungo i fianchi, con un tono di voce che trae la sua forza dalla interna
coscienza. Parla di guerra imposta, crudelmente imposta. Ci avete imposto la guerra; prenderemo
misure perché una seconda aggressione, come questa non possa più ripetersi. E' giunta l'ora di una
pesante resa dei conti. Ci avete domandato la pace: siamo a vostra disposizione per accordarvela.
Riceverete il volume che contiene le condizioni di pace […] Ci troverete pronti a secondarvi nel
vostro compito; ma questa seconda pace di Versailles è stata acquistata a troppo caro prezzo perché
noi non abbiamo il diritto di esigere, con tutti i mezzi in nostro potere, le legittime soddisfazioni che
ci sono dovute" ().
Queste parole rivolte il 7 maggio 1919 nel Trianon Palace di Versailles, alla delegazione germanica,
alla presenza dell'americano Wilson, dell'inglese Lloyd George, dell'italiano Orlando, costituirono
la piattaforma della politica francese per tutti gli anni Venti e determinarono quella dei paesi che
alla Francia si unirono in alleanza.
Di questa politica Brockdorff-Rantzau, capo della delegazione tedesca, era ben consapevole quando
nella stessa seduta rispose: "Noi non disconosciamo la grandezza della nostra impotenza e
l'estensione della nostra disfatta. Noi sappiamo che la forza delle armi tedesche è spezzata. Noi
sappiamo la potenza dell'odio che ci viene incontro, e noi abbiamo sentita la volontà appassionata
con cui i vincitori vogliono farci pagare come vinti e colpevoli […]".
L'abisso di odio che divideva i due paesi ebbe una ulteriore rappresentazione nella seduta per la
firma del trattato. Clemenceau fece sedere ben in vista tre soldati francesi grandi invalidi, sconciati
nei corpi e nei volti. Così lo statista francese descrive l'episodio: "Sur un banc de velours, entre deus
fenétres, on venait de placer, bien en vue, trois grimacantes figures de l'infernale tragédie, yeux
exorbités, machoires tordues, visages ravinès de toutes les balafres: trois grands blessés de guerre,
invités a la place d'honneur, […]" (2).
I TRATTATI DI PACE
Con i trattati di pace gli Stati europei erano saliti a 28 e l'aspetto geopolitico si era precariamente
assestato dando origine a un conto alla rovescia di un nuovo conflitto di cui il 1939 fu la scadenza
inevitabile. I trattati imposti dai vincitori: nel 1919 Versailles con la Germania, Saint Germain con
l'Austria, Neully con la Bulgaria; nel 1920 Trianon con l'Ungheria e Sèvres con la Turchia avevano
dovuto tenere conto degli obiettivi territoriali, dello spirito di rancore e di vendetta della Francia,
delle ambizioni degli Stati minori alleati con i vincitori e di quelli sorti dalle rovine degli imperi
austroungarico, russo e ottomano.
Il giudizio della Santa Sede, che già aveva definita nell'agosto 1917 la guerra "inutile strage"
sollevando le fiere rimostranze di tutti i belligeranti, fu inequivocabile "un assurdo internazionale".
L'atteggiamento delle piccole potenze verso gli sconfitti ricordava quello stigmatizzato dal ministro
degli Esteri inglese lord Castlereagh al congresso di Vienna del 1815 dopo il crollo napoleonico:
"L'insaziabile spirito di prendere qualcosa senza alcun pensiero di come possa essere conservato", le
piccole potenze erano: "sufficientemente folli da supporre che le grandi potenze d'Europa debbano
essere sempre pronte per proteggerle nel godimento di queste spoglie meschine". Tutti
dimenticarono le parole dello svizzero Emmer de Vattel, padre del diritto internazionale moderno,
che nel secolo dei lumi scriveva: "Un trattato di pace non è che un compromesso […] Poiché
dunque sarebbe una cosa terribile rendere la guerra perpetua, o condurla fino alla totale rovina di
una delle parti".
LA DISSOLUZIONE DELL'IMPERO ASBURGICO.
La disgregazione dell'impero asburgico fu fortemente voluta da Clemenceau le Tigre il quale rifiutò
le profferte di pace avanzate da Carlo I, successore di Francesco. Rimasero famose le sue parole: "Il
fau chasser les Habsbourg, cette monarchie papiste".
Sulla sua linea erano in molti a concordare. Bissolati, nella commemorazione del sacrificio di
Cesare Battisti del 29 ottobre 1916, sostenne: "Sinché esista quella compagine mostruosa [l'impero
asburgico] quello Stato che è la negazione e la compressione di tutte le nazionalità che non siano la
tedesca e la magiara, la Germania imperiale potrà sempre allungare su di esso la mano per farsene
arma, e valersi della sua enorme potenza per tornare alla riscossa. Bisogna che il mostro dalle molte
teste sia ucciso. E dal suo corpo morto balzino vive tutte le stirpi che stanno dolorosamente
compresse nella sua artificiosa unità". Uno scrittore satirico austriaco, Karl Kraus fu più caustico:
"una stazione sperimentale per lo studio della fine del mondo".
L'Austria-Ungheria non era però solo "una prigione di popoli" ma un grande Stato, che esisteva da
600 anni, con una società civile estremamente evoluta, con 57 milioni di sudditi di razze diverse,
Tedeschi, Ungheresi, Cechi, Slovacchi, Polacchi, Ruteni, Rumeni, Serbi, Croati, Sloveni, Italiani,
Ebrei ai quali tutti era riconosciuto il diritto ad essere educati nella loro lingua, era "ein geistiger
Begriff" (un concetto spirituale) sosteneva il poeta Hugo von Hofmannsthal, una "maison
commune" secondo Francesco Giuseppe con una capitale, Vienna tra le prime cinque città del
mondo. Aggiungeva profeticamente il vecchio sovrano: "Qui le piccole nazioni dell'Europa
Centrale trovano un rifugio. Senza questa casa comune, la loro sorte sarà miserabile. Esse
diventeranno la preda dei potenti vicini". Era l'Austria Felix, un conglomerato ch resistette per
quattro anni di una durissima guerra, con una fiorente economia, una vita intellettuale di
prim'ordine, una burocrazia scrupolosa e imparziale, afflitta però da un regime illiberale e da
militari ottusi come il feldmaresciallo Conrad von Hotzendorf, capo di stato maggiore, che nel 1909
propugnò una guerra preventiva contro l'Italia prostrata dal terremoto di Messina. Di certo
l'adesione degli Ebrei fu totale e li portava a menzionare Francesco Giuseppe nei libri di preghiere,
affinché Dio vegliasse sulla salute del landesvater, del padre della patria, garante della loro
legittimazione, tra le altre componenti dell'impero. Va sottolineato che la costituzione non
prevedeva una nazionalità ebraica ma solo una confessione religiosa ed altresì che contro di loro si
scateneranno negli anni a venire tutte le frustrazioni delle altre nazionalità.
Fu condannata dalla miserabile incapacità della sua classe dirigente di rinnovarsi, dall'immobilismo,
dal rifiuto alla costituzione di uno stato federale nel quale tutte le componenti avessero avuto un
peso proporzionato alla loro entità, in massima parte dovuto all'Ungheria che applicò un programma
di "magiarizzazione" delle nazionalità sotto il suo controllo. Il sigillo funebre fu del conte Czernin,
ultimo ministro degli Esteri dell'impero, il quale nel 1919, volgendosi indietro, commentava: "Era
inevitabile che morissimo. Ma avevamo la possibilità di scegliere la maniera della nostra morte e
scegliemmo la più terribile" ossia la guerra, che aveva a base un assassinio politico, l'aiuto della
Germania, la decisa volontà dell'Ungheria, la presunta debolezza della Russia.
"Comunanza di vita, vantaggi commerciali e sicurezza a un gran numero di popoli, nessuno dei
quali ebbe più tardi la forza o la vitalità di resistere isolato alla pressione della risorta Germania o
della Russia. Un mosaico etnico nel quale la convivenza aveva reso più vivace e tollerante la vita di
piccoli popoli, che meglio si potevano integrare tra loro", così si esprimeva Churchill, una delle
poche teste pensanti del "secolo breve": La scomparsa dell'impero, che lo statista considerò come
una iattura per la creazione di numerosi focolai di conflittualità nell'Europa Centrorientale e
Balcanica, diede origine alla nascita, all'indebolimento o all'accrescimento di formazioni statali in
paesi incapaci di difendersi, che vivevano in condizioni di mescolanza etnica spesso inestricabili e
sempre accompagnate da economie precarie. I gruppi minoritari, già stretti nella fedeltà
all'imperatore arbitro imparziale dal quale ricevevano parità di diritti e di doveri, furono sottoposti a
vessazioni, a volte sanguinose, da parte degli Stati dominanti.
Francois Fejto affermò che l'impero asburgico annoverava otto nazionalità: tedesca, ceca, polacca,
ucraina, slovena, serbo-croata, italiana, rumena. Degli Stati che nacquero dall'impero, la Jugoslavia
ne annoverava nove e la Cecoslovacchia sette. Forse nessuno meglio di Roth seppe descrivere il
clima dell'epoca nel suo "La marcia di Radetszky". Alla notizia dell'assassinio dell'erede al trono
Francesco Ferdinando, promotore della riorganizzazione della dualistica monarchia su basi
trialistiche (austriaca, ungherese e slava) arrivata durante una festa reggimentale, gli ufficiali
ungheresi di una sperduta guarnigione dell'impero si riunirono a commentarla esultando nella loro
lingua; richiamati dal comandante di nazionalità slovena ripeterono le ingiurie in tedesco, mentre il
comandante essendo slavo come l'assassino, si trovava in forte difficoltà nel difenderne la memoria.
La pace era stata il risultato di un bilanciamento di interessi tra la Francia e la Gran Bretagna con la
neutralizzazione della Germania, pesantemente penalizzata e dell'Unione Sovietica, ammirato
modello per le Sinistre europee, circondata da un cordone sanitario di piccoli Stati,
I due vincitori, oltre alle pesanti condizioni economiche imposte alla Germania, si impadronirono
delle sue colonie con la formula dei mandati internazionali e in questo modo l'impero albionico, con
colonie, protettorati e mandati, andava da Città del Capo a Rangoon passando per Il Cairo e
Bombay.
La genesi dei mandati fu così farisaicamente spiegata: "à la suite de la guerre, ont cessé d'etre sous
la souverainetè des Etats qui les gouvernaient précédemment, et qui sont habités par des peuples
non encore capables de se diriger eux-memes dans les conditions particulièrement difficiles du
monde moderne". Si codificava il diritto-dovere dei popoli bianchi, non tutti, di portare civiltà e
ordine nei paesi ‘incivili'. Era una riedizione del "The white man's burden" di Kipling, "fardello" dal
quale l'Italia veniva esclusa. I territori coloniali furono divisi il 6 maggio 1919, il giorno prima del
ritorno dell'Italia alla conferenza della pace.
Il principio dell'autodeterminazione fu applicato solo a favore dei paesi vincitori e di quelli nati a
Versailles. Non ne furono codificati i limiti e le norme per gli sconfitti. E così sette milioni e mezzo
di Tedeschi, Lituani e Ruteni passarono alla Polonia, quattro milioni e mezzo di Tedeschi,
Ungheresi e Ruteni alla Cecoslovacchia, tre milioni e mezzo di Tedeschi, Ungheresi, Ruteni e
Bulgari alla Romania.
IL NAZIONALISMO
"Il principio del diritto di nazioni e nazionalità di disporre del loro destino e di costituire un proprio
Stato era pericoloso per la libertà" scriveva Jozsef Eotvos liberale ungherese cento anni prima,
aggiungeva Giolitti, col suo caratteristico ben pensare, di essere contrario al nazionalismo,
pericolosa caricatura del patriottismo, ma lo spettro, che già aveva scatenato la carneficina del
passato conflitto, continuava ad aggirarsi per l'Europa. Il fenomeno era particolarmente grave
nell'Europa Centrorientale e nei Balcani ove dal 1908 al 1933 i confini furono modificati nove volte
e quattro sistemi politici si erano succeduti. Con l'esclusione della Polonia, le altre nazioni non
avevano alcun peso militare e politico, erano piccoli Stati che vivevano nel terrore di essere
fagocitati da paesi confinanti. Avevano o si opponevano a rivendicazioni territoriali, tentavano di
essere gli unici interlocutori delle grandi potenze, si alleavano per la difesa di comuni interessi.
"E' dal nord al sud, dal Baltico al Mar Nero al Mediterraneo tutti hanno le mani, senza rendersene
conto, piene di fiammiferi" (3) scriveva George Simenon, il grande scrittore di gialli nel 1933 dopo
un viaggio che lo portò in tutta l'Europa Centrale attraverso: "cette ligne malsaine qu'on appelle une
frontière" in paesi che vantavano passate grandezze e vivevano in presenti grandi miserie un
patriottismo esacerbato e presuntuoso. Vilnius strappata dai Polacchi ai Lituani, che la
consideravano loro capitale, era una città: "dove scivolavano slitte puzzolenti, e poveri, poveri ogni
dieci metri, poveri più poveri che in qualsiasi altro paese del mondo". I Lituani, due milioni,
giuravano fieramente che avrebbero ripreso la loro capitale, i Polacchi, trenta milioni,
proclamavano fieramente che era una città polacca e che non l'avrebbero mai lasciata.
La storia degli anni Venti in Europa, in un clima di tensioni e instabilità, fu un susseguirsi di
disordini, violenze etniche, putsch, rivoluzioni e guerre non dichiarate. Disordini sociali portarono,
in un clima di involuzione in senso autoritario, la Spagna al colpo di stato del generale Primo de
Rivera, alla presa del potere di Mussolini in Italia, di elementi militari e dell'estrema destra in
Polonia, Ungheria, Romania, Lituania e Jugoslavia. In Germania si susseguirono putsch
dell'estrema Destra e tentativi di rivoluzione comunista contro la debole repubblica di Weimar,
violenti scontri di frontiera con la Polonia, che nello stesso tempo combatteva una guerra a fondo
contro l'Armata Rossa negli anni 1919-1920.
Il sanguinoso conflitto fra Grecia e Turchia si concluse con la vittoria turca e un doloroso scambio
di popolazioni, 1.400.000 dall'Asia minore e 400.000 dalla Grecia. L'esodo sarà il prodromo a
quello che avverrà dopo il secondo conflitto mondiale quando 3.300.000 Tedeschi verranno cacciati
da regioni passate alla Polonia, sostituiti da 2.300.000 Polacchi che abbandonarono quelle passate
all'URSS e 350.000 Italiani saranno costretti a lasciare l'Istria sotto minacce di ogni specie.
L'iniqua politica dei vincitori il 20 novembre 1945 al processo di Norimberga verrà così ricordata
da Robert Jackson, rappresentante dell'accusa per gli Stati Uniti: "Non assolvo gli Stati Uniti e
qualsiasi altro paese da ogni colpa nei fatti che fecero del popolo tedesco una facile preda alle
lusinghe e alle minacce dei congiurati nazisti" (4). Lo spirito di rivincita della Germania
pesantemente umiliata, il revanscismo di Ungheria, Bulgaria e Turchia mutilate nei loro territori,
l'ossessione di invasioni dall'ovest dell'Unione Sovietica, le frustrazioni di vincitori come l'Italia e il
Giappone che dalla vittoria avevano ricevuto mediocri compensi se rapportati a quelli della Gran
Bretagna e della Francia fecero nasceree e maturare le premesse per una revisione dei trattati che
porterà alla seconda guerra mondiale.
Per completezza e organicità di trattazione, per meglio inquadrare la situazione del continente alla
fine del decennio, un continente che si avviava al collasso morale, occorre tracciare un non breve
excursus dei paesi più importanti, senza nessuna pretesa di esaustività.
LA FRANCIA
Ho d'istinto l'impressione che la Provvidenza l'abbia creata per dei successi assoluti o delle
sciagure esemplari.
Charles De Gaulle
La Francia nel vuoto di potere creatosi in Europa dopo la sconfitta degli Imperi Centrali e la
dissoluzione della Russia zarista, costituiva la prima potenza militare del mondo. Nel 1927, secondo
uno studio di Aldo Valori (5), era in grado di mettere in campo con le truppe coloniali 739.0000
uomini, di cui 76.000 soldati di carriera e 35.000 ufficiali. La società civile era però attanagliata da
una profonda crisi morale ed economica e risentiva pesantemente dei sanguinosi sacrifici sopportati
nella Grande Guerra. Il 70% dei mobilitati era "mort au champ d'honneur" (1.358.000) o era rimasto
ferito (4.266.000) sui campi di battaglia.
Se è di tutti i dopoguerra la disaffezione dell'opinione pubblica per le forze armate: "Questa schiatta
di uomini sempre dispregiata o onorata fuori misura, a seconda che le nazioni la trovino inutile o
necessaria", il fenomeno in Francia era più profondo. Il raggiungimento degli obiettivi, l'avvenuta
eliminazione del pericolo germanico che in cento anni dal 1814 al 1914 aveva invaso tre volte la
Francia, la memoria delle fangose trincee dalle quali si sortiva per andare a morte quasi certa,
l'affermarsi delle dottrine pacifiste avevano distaccato i Francesi dal loro esercito che non aveva più
la grande missione, la "revanche", la liberazione dell'Alsazia e della Lorena.
Conseguenza di tutto questo fu una ondata di dimissioni, dal 1919 al 1927 ben 12.000 quadri
abbandonarono l'Armée nella quale restarono in maggioranza ufficiali in preda a una profonda
frustrazione che non avevano le capacità di reinserirsi nella vita civile e Painlevé, ministro della
Guerra nel 1926, riconosceva la gravità della crisi: "L'Esercito si trova attualmente in preda a un
profondo malessere. I suoi quadri sono scoraggiati e cercano ogni occasione per abbandonare il
servizio. La migliore gioventù si allontana dalle nostre scuole militari (6).
Fu in questa atmosfera che maturò la nuova dottrina militare basata sulla sicurezza innanzitutto.
Nacque il progetto di una "muraglia cinese", un sistema fortificato dietro il quale i figli dei
sopravvissuti della Grande Guerra avrebbero atteso l'arrivo degli alleati.
La linea Maginot fu l'espressione del pensiero militare francese, espressione dei vertici dell'esercito
rimasti sostanzialmente immutati fra i due conflitti mondiali e il cui conservatorismo, proprio
dell'età avanzata, nel maggio 1926 tutti i marescialli di Francia avevano più di 70 anni, era
coniugato con la presunzione dei vincitori, mentre in Germania i giovani ufficiali del 1914
arrivarono alle alte cariche nel 1939 avendo vissuto le trasformazioni tecnologiche che il progresso
aveva creato.
Va ricordato che anche un uomo d'armi come il maresciallo Caviglia, considerato il migliore tra i
generali italiani della prima guerra mondiale, sosteneva che la Maginot era insuperabile:
"L'esperienza del conflitto mondiale ha mostrato l'importanza dei vantaggi che le armi e i materiali
moderni accordano alla difensiva nella guerra terrestre. Allora fu creata la linea Maginot, a cui
seguì quella Siegfried. Sono linee profonde varie decine di chilometri ed appoggiate ad ostacoli
invulnerabili. Allo stato attuale dei mezzi d'offesa conosciuti, esse sono intransitabili".
A questa politica si associarono l'opinione pubblica, gli intellettuali, la classe politica, il
proletariato, gli influenti pacifisti che rifiutavano un nuovo bagno di sangue, consapevoli del
tracollo demografico che avrebbe portato nel 1935 a un contingente di leva ridotto da 240.000 a
170.000 unità. Questo complesso di circostanze influirà profondamente sull'Armée che andrà alla
guerra senza paura ma senza entusiasmo.
Nei confronti della "sorella latina" e del Regio Esercito esisteva un tranquillo senso di superiorità
che portava a guardare con sufficienza all'Italia. La sufficienza confinava con lo spregio quando il
generale Foch, comandante supremo delle forze alleate sul fronte occidentale, nel discorso
commemorativo del 2 dicembre 1918 non indicava le truppe italiane fra quelle che avevano
combattuto in Francia, eppure 4375 soldati erano morti sul fronte francese, il triplo dei soldati di
Napoleone III a Solferino.
Il generale Herr, ispettore dell'arma di artiglieria, con sufficienza scriveva nel 1923: "Les officiers
italiens paraissent c'envisager que la bataille défènsive, en pays de montagne et sur des positions
fortement organisèes". Sul soldato il giudizio era riduttivo, sosteneva nel 1931 C.Vidal: "Le
fantassin italien possède d'indeniables qualités d'endurance, de sobrietè; c'est un remarquable –
remeur de terre- mais, en général, il est emotif et nerveux, d'ou le besoin de l'encadrer solidement, il
vau ce que valent ses cadres […] Le fantassin italien n'est pas apte a se passer de chefs, ses qualités
combatives refleront celles de ceux qui le conduiront au feu" (7).
L'emotività e il nervosismo erano già stati rilevati nel 1878 da Niccola Marselli considerato uno dei
maestri del pensiero militare italiano il quale parlando dell'addestramento "al tiro di combattimento"
che veniva effettuato dalle brigate durante i campi estivi criticava "il sistema frettoloso" che "[…]
invece di educarlo alla disciplina del fuoco accelerato, aumentava i suoi vizi nervosi che lo rendono
meno adatto dei popoli nordici all'uso dell'odierno fucile" (8). La rotta del 1940 sarà particolarmente
umiliante per gli ufficiali costretti ad arrendersi ai "ritals" come venivano spregiosamente chiamati
gli italiani.
LA SVIZZERA
La neutralità è possibile quando un Paese è capace di resistere duramente, tanto da fare pensare al
nemico che il costo dell'invasione risulterebbe superiore ai benefici che potrebbe trarne.
Basil Liddell Hart
"I nostri rapporti con la repubblica svizzera sono veramente cordiali, profondamente amichevoli"
dichiarò Mussolini al Senato il 15 giugno 1928 e continuò: "L'Italia ha un interesse fondamentale
all'esistenza di una libera, indipendente, neutrale Svizzera e per quanto concerne il Canton Ticino,
di lingua, razza, costumi italiani, l'interesse fondamentale italiano è che esso resti elemento
integrante e integratore della Confederazione elvetica. Quei pochi che entro o oltre il Gottardo
hanno ancora la non peregrina abitudine di dare corpo ad ombre evanescenti, prendano atto di
questa chiara e solenne dichiarazione". Queste dichiarazioni, precedute da altre nel 1923 e nel 1924,
furono rinnovate negli anni trenta, malgrado l'esistenza di una stampa largamente antifascista e il
rifugio offerto ai fuoriusciti in sintonia con la tradizionale politica di ospitalità agli esuli stranieri.
Nel corso della guerra passata, anche alla luce dell'invasione del Belgio, lo stato maggiore era stato
grandemente assillato dal pericolo di una invasione tedesca attraverso il territorio elvetico,
eventualità che Cadorna, in una lettera al ministro della Guerra del 13 agosto 1914 definì
"disastrosa" aggiungendo: "la situazione diverrebbe di una gravità incalcolabile qualora una
qualunque minaccia si preannunziasse attraverso il saliente ticinese che pretende la punta del suo
cuneo formidabile nel cuore stesso del piano lombardo a sole due tappe da Milano, e cadendo alle
spalle del nostri esercito eventualmente schierato di fronte all'Austria, ne sconvolgerebbe e ne
paralizzerebbe l'azione" (9). La vittoria sollevò il nostro stato maggiore da quello che Cadorna definì
un "incubo". Per parare una eventuale invasione negli anni 1916-1917 si procedette alla
sistemazione difensiva della frontiera con una linea fortificata presidiata da sette divisioni.
Ma le parole dell'ex presidente federale Motta furono rassicuranti: "L'ipotesi di una violazione del
territorio svizzero da parte della Germania per gettarsi contro l'Italia era improbabilissima. La
Germania sapeva che la Svizzera era un osso duro, ben altra cosa che il Belgio". Le preoccupazioni
erano aggravate dalla ostilità dell'opinione pubblica svizzera nei confronti dell'Italia della quale si
temevano le mire sul Canton Ticino e dalle simpatie delle popolazioni svizzerotedesche e dei quadri
per le potenze centrali. Cordialissimi erano i rapporti del capo di stato maggiore dell'esercito
colonnello di corpo d'armata von Sprecher e del sottocapo di stato maggiore colonnello Egli con
l'alto comando tedesco. Egli, unitamente al capo dell'Ufficio informazioni, fu sottoposto a processo
per aver fornito all'Austria documenti dello stato maggiore contenenti valutazioni degli eserciti
dell'Intesa. La volontà della Svizzera , che proclamava la "neutralità permanente armata", di
resistere risolutamente a un invasione era fermissima, fidando anche sull'aiuto portato dagli eserciti
dei paesi vicini sul quale faceva grande affidamento lo stato maggiore nei suoi piani di difesa.
La prudente politica di neutralità della Confederazione fu comprovata nell'immediato dopoguerra
quando il Consiglio Federale rifiutò l'annessione del Voralberg, regione austriaca la cui popolazione
aveva avanzato la richiesta di secessione dall'Austria. La preoccupazione di future contestazioni
dovute a cambiamenti politici erano alla base della decisione.
Se il fenomeno Svizzera, una nazione priva di unità etnografica nella quale convivevano
pacificamente etnie diverse anche per lingua e religione, era unico in Europa, l'esercito confederale
nelle sue strutture era unico al mondo. Il paese non aveva un esercito permanente e le unità previste
si costituivano solo in caso di mobilitazione generale o nei periodi di istruzione. Il servizio era
obbligatorio per tutti e veniva eventualmente sostituito per gli esenti dal pagamento di una tassa
proporzionata al reddito. La Nazione Armata era il modello, il cittadino-soldato né costituiva la
base. Dopo un periodo iniziale di addestramento da 65 a 90 giorni, secondo l'arma di appartenenza,
il soldato veniva assegnato a un reparto e subito dopo congedato con successivi brevi richiami per
corsi annuali di 11 giorni. A 32 anni passava nella Landwher (milizia mobile) fino ai 40 e poi nella
Landsturm (milizia territoriale) sino a 48. I quadri non venivano preparati nelle accademie ma
selezionati tra i sottufficiali a loro volta scelti tra la truppa. In entrambi i casi la scelta era a giudizio
dei superiori e il grado non poteva essere rifiutato. Dopo aver frequentato scuole per le varie armi,
le scuole centrali per l'avanzamento a capitano e ai gradi superiori si arrivava per gli ufficiali di
stato maggiore a una scuola speciale secondo l'arma. Il grado di colonnello era quello più elevato
della gerarchia militare con differenzazione secondo il comando assegnato: Colonnello di
reggimento, colonnello di brigata, colonnello di divisione e colonnello di corpo d'armata. Il grado di
generale veniva assegnato dall'Assemblea Federale, il parlamento elvetico, solo quando l'esercito
veniva mobilitato "in servizio attivo". La mobilitazione avveniva in relazione a conflitti tra paesi
vicini e si ebbe nel 1847, 1849, 1856-57, 1859, 1870-71, e 1914-1918.
L'altissimo spirito civico del soldato-cittadino veniva evidenziato dalla cura con la quale venivano
conservati nelle abitazioni dei militari l'uniforme, l'equipaggiamento, l'arma individuale e le
dotazioni di prima linea, cosa che permetteva di schierare in sette giorni 500.000 uomini dai 20 ai
48 anni.
L'AUSTRIA
Così ci accingevamo, animati dalla migliore e più cosciente volontà e di tutta la nostra fede, a
custodire l'eredità austriaca.
Kurt von Schuschnigg
L'Austria, della quale Clemenceau aveva sostenuto: "L'Austriche c'est ce que reste", con il trattato
di Saint Germain fu ridotta geograficamente, politicamente e industrialmente a potenza di terzo
ordine, con una popolazione di sette milioni di abitanti. Le perdite territoriali furono gravissime. Il
Trentino, l'Alto Adige e l'Istria furono riuniti all'Italia, il Banato di Timisoara e la Transilvania alla
Romania, la Galizia alla Polonia. Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina si associarono alla Serbia e
formarono il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni.
Nello sbandamento generale, nella profondissima crisi morale creatasi, l'Assemblea Nazionale
proclamò il 12 novembre 1919 l'Anschluss, l'unione alla Germania, ma i vincitori lo vietarono con il
trattato di pace, vincolandolo al consenso, assolutamente ipotetico, di tutti i membri del consiglio
della Società della Nazioni. Aristide Brian sostenne ancora nel 1928: "L'Anschluss c'est la guerre".
Sul problema Mussolini fu tassativo: "L'unione dell'Austria alla Germania rappresenterebbe quasi
certamente la ripresa della guerra […] é assiomatico che la Germania con l'unione dell'Austria
giungerebbe in breve tempo a un potenziale maggiore di quello che aveva prima della guerra,
dominando nell'Europa continentale" (10). Il futuro alleato della Germania nazista si rendeva
lucidamente conto che il gravitare del colosso tedesco sulle frontiere era un evento da evitare. Uno
dei suoi più risoluti oppositori Antonio Gramsci nel 1926 arrivava alle stesse conclusioni in una
limpida analisi politica degli orizzonti internazionali: "L'Italia non può staccarsi dalla Gran
Bretagna per ragioni militari e navali e dagli Stati Uniti per ragioni economiche" e manifestava una
decisa opposizione all'unione dell'Austria con la Germania: "a) si confinerebbe con uno stato di 70
milioni di abitanti, capace di mobilitare il doppio delle nostre forze. b) Vienna unita alla Germania
riacquisterebbe la sua posizione economica nei Balcani".
Se i sentimenti della Francia verso la Germania erano improntati a odio e a vendetta, quelli
dell'Italia verso l'Austria erano di natura estremamente diversa. A fronte della catastrofica
situazione alimentare esistente a Vienna ci si preoccupò di inviare treni carichi di vettovaglie per
soccorrerne la popolazione che ammontava a un terzo di tutta l'Austria, la qual cosa ammorbidì il
complesso di superiorità e di frustrazione nei confronti dell'Italia. Silvio Gabrioli, che aveva
combattuto come ufficiale di complemento degli alpini, ha lasciato una colorita testimonianza sulla
crisi alimentare in cui si dibatteva il paese nel novembre 1918. Precedendo le truppe si spinse in
auto sino a Innsbruck che doveva essere occupata in esecuzione dell'armistizio. "Il nostro gruppo
era in albergo e, attendendo l'arrivo della delegazione civile austriaca, consumava il cibo portato
con se. La delegazione comparve. Erano quattro signori, vestiti da cerimonia, col cilindro. Ma alla
vista del nostro pane bianco, persero ogni ritegno e vi si avventarono al grido di "brot!", tanto era la
fame che li divorava sotto le redingotes" (11). La correttezza delle truppe a Innsbruck fu così
esemplare che in un convegno di storici italoaustriaci del 1973 fu portata a modello di
comportamento, rapportandola a quella delle truppe delle quattro potenze occupanti nel secondo
dopoguerra (12).
L'Italia garantiva all'Austria, stato cuscinetto con la Germania e cuneo tra i popoli slavi della
Jugoslavia e della Cecoslovacchia, l'indipendenza e l'integrità territoriale, ritenendola necessaria
alla sua politica di sicurezza. Si oppose quindi ai tentativi del premier cecoslovacco Benes di
attrarla nell'orbita della Piccola Intesa temendo l'unificazione politica dei paesi dell'area danubiana.
Con lo stesso spirito bloccò le mire jugoslave sulla Carinzia e sulla Stiria. Il trattato di Saint
Germain disponeva un referendum per Klagenfurt, città della Carinzia, che si concluse con 22.000
voti a favore dell'Austria e 15.000 alla Jugoslavia. L'esito favorevole, dovuto anche alla azione
energica e imparziale di reparti del Regio Esercito, accolti come liberatori e che lasceranno un grato
ricordo nella popolazione, provocò la successiva occupazione slava della città alla quale l'Italia e le
altre potenze occidentali si opposero con un ultimatum che ne portò allo sgombero. La netta
opposizione, che portò alla occupazione del tronco ferroviario Villaco-Sankt Veit Klagenfur nel
giugno 1919, nasceva anche dalla preoccupazione per la minaccia alle comunicazioni ferroviarie tra
il porto di Trieste e l'Europa Centrorientale. All'epoca il problema era molto sentito tanto che
Sonnino nel maggio 1919 scriveva: "Per dare alla Cecoslovacchia 60 chilometri di ferrovie, ed
assicurare comunicazioni ininterrotte tra Cecoslovacchia e Romania sono stati posti sotto sovranità
cecoslovacca circa 60.000 magiari. In Polonia per 100 chilometri di ferrovia sono stati trasferiti
sotto sovranità polacca circa 100.000 tedeschi". La protezione dell'integrità della vicina repubblica
si manifestò anche nella questione del Bungerland territorio conteso dall'Ungheria.
Una spina duratura nei rapporti tra l'Italia e l'Austria fu l'annessione dell'Alto Adige che portò alla
incorporazione di 224.000 alto atesini e 8150 chilometri quadrati. Il feldmaresciallo Franz Khun,
riorganizzatore dell'esercito austriaco dopo le gravi sconfitte del 1859 e del 1866, era stato esplicito
in proposito: "Se gli italiani vogliono difendere Venezia devono impadronirsi del Tirolo
meridionale fino al Brennero". In effetti la necessità militare di arrivare alla chiostra delle Alpi fu
messa in luce nella guerra passata dalle posizioni grandemente svantaggiate in cui il tracciato della
linea di confine voluta dagli austriaci nel 1866 poneva l'esercito italiano.
Il Brennero aveva anche un valore morale. Il Tricolore che vi sventolava era il segno, il simbolo
della compiuta unità nazionale. Era l'"insuperabilis finis" della strategia dell'impero romano, la linea
"segnata dalla mano di Dio" come scriveva Carlo Cattaneo, il "rigido confine" del Petrarca che
aggiungeva:
Ben provvide natura al nostro stato
Quando dell'Alpi schermo
Pose fra noi e la tedesca rabbia
Su di esso si escluse ogni trattativa sin dal primissimo dopoguerra.
Il ministro Della Torretta il 6 ottobre 1919 garantì il rispetto della minoranza ma aggiunse
gelidamente che quella garanzia: "costituiva l'ultima parola ed era l'ultima conversazione su tale
argomento". Mussolini fu più brutale. Scriveva su Il Popolo d'Italia dell'11 dicembre 1921: "Al
Brennero ci siamo e ci dobbiamo restare, anche a costo di dover spazzare via tutti i tedeschi da
Bolzano in su".
Su questo confine molti esponenti democratici non concordavano. Leonida Bissolati, espulso dal
Partito Socialista Italiano perché interventista, contrario alla politica di Sonnino, così si esprimeva:
"Quella (la linea del Brennero) è la linea strategica ottima, questa (la linea passante per le vette
dominanti l'Alto Adige e l'Eisach) è la buona. E allora, noi dobbiamo domandarci se per avere la
linea topograficamente perfetta, quando la buona coincide con la linea etnica, converrebbe all'Italia
deporre entro i propi confini il germe dell'irredentismo tedesco?".
Mussolini capo del governo, nel settembre 1923 ammise che i rapporti con l'Austria: "erano molto
buoni", ma nello stesso periodo iniziò una ottusa politica di assimilazione e snazionalizzazione delle
popolazioni allogene. Furono chiuse le scuole pubbliche tedesche e vietate quelle private, la lingua
italiana sostituì quella tedesca nei pubblici uffici e furono italianizzate le targhe, le insegne e le
tabelle, i cognomi tedeschi e le iscrizioni tombali, si procedette alla industrializzazione della
provincia di Bolzano con l'afflusso di popolazioni italiane: "Affogare gli allogeni in un mare di
popolazione regnicola" era il disegno governativo. Nel settembre 1938, quando si evidenziava
sempre di più la potenza tedesca, in una delle sue frequenti esternazioni al consiglio dei ministri il
duce sostenne: "Ci vuole più larga comprensione verso gli allogeni leali. Ma si sappia da tutti, di
qua e di là dal confine, che le frontiere sono intangibili. […] Per stedeschizzare l'Alto Adige non v'è
che un metodo: non isolare gli altoatesini, farli partecipare alla vita della nazione. Io ho fatto sapere
loro, che possono circolare nelle carriere del Regno. Possono diventare deputati, senatori, ministri.
Anche … capo del governo!", sulla qual cosa occorre aggiungere che le possibilità anche per gli
Italiani, erano molto ridotte.
L'aspirazione all'Anschluss era sempre viva nei circoli austriaci, sembrando l'ultima possibilità di
sopravvivenza. I partiti cristiano-sociale e popolare grande-tedesco che raccoglievano voti nella
borghesia ribadivano nel 1922, poco dopo il crollo economico: "Tenere fede alla politica
dell'Anschluss, mantenendo stretti contatti con il governo del reich tedesco, investimenti di capitali
tedeschi, protezione delle minoranze tedesche negli Stati vicini".
L'idea della riunione dei due paesi, l'incapacità di accettare la nuova realtà, si sviluppò negli anni
successivi. In Germania, specie in Baviera, il problema era oggetto di vivaci discussioni ed era uno
dei futuri obiettivi della politica estera, sollevando preoccupazioni e polemiche negli ambienti
italiani. In un articolo di Antonio Pavari "Alto Adige e Anschluss" pubblicato nel 1926 sulla
Rassegna Italiana, rivista accesamente nazionalistica, si riportò l'opinione di un professore tedesco
Herbert Schmidt espressa al Congresso geografico germanico tenutosi a Breslavia nell'anno
precedente: "L'unione viene proibita con il gesto di un poliziotto che crede di soffocare un
movimento come quando discioglie un assembramento". Tanto era sufficiente per provocare in
Mussolini una delle sue solite periodiche sfuriate. "[L'Italia] se sarà necessario porterà il tricolore
anche al di la del Brennero, ma non lo ammainerà mai sul Brennero".
Con il trattato di pace gli organici dell'esercito austriaco furono fissati in 30.000 unità, volontari
che, con l'abolizione della leva, avevano una ferma di dodici anni. Anche a quello austriaco era
imposto il divieto di mezzi corazzati e dell'aviazione ma a differenza di quello tedesco la volontà di
rivincita era inesistente. Nel 1929 l'esercito fu ridotte per problemi finanziari a 22.000 uomini e
l'ultimo cancelliere lo definì "povero e mercenario". Nella debolezza dello Stato i partiti politici
avevano creato delle milizie di parte. Republikaner Schutzbund (unione di difesa repubblicana) si
chiamavano i reparti armati del partito socialista formati da operai con una forza doppia di quella
dell'esercito, mentre le Heimwehren (Associazione per la difesa della patria) erano formazioni di
destra, nate, come i tedeschi Freiwilligen Korps (corpi franchi) per la difesa delle frontiere
minacciate dagli Jugoslavi e dagli Ungheresi. Pure le tradizioni militari non erano obliate se si
pensa che nelle Allgemeine Gefehisror Schrift (Norme generali per il combattimento) si dà spazio
alla guerriglia cui venivano riservati 18 su 148 articoli, con una previsione dell'antichissima forma
di lotta, ignorata nelle regolamentazioni italiane, che nella seconda guerra mondiale avrebbe usurato
nella sola Jugoslavia 17 divisioni italiane e 28 tedesche.
LA JUGOSLAVIA
Il cielo è blu, colore della Serbia e Dio che vive in cielo è serbo anche lui.
Canzone serba
In Jugoslavia tre etnie, i Serbi con sei milioni, i Croati con quattro e gli Sloveni con un milione e
mezzo di abitanti costituivano l'85 % della popolazione. Vi erano inoltre Tedeschi (500.000),
Ungheresi (250.000) Albanesi e Turchi (400.000), Romeni (200.000) oltre a Italiani, Montenegrini,
Zingari e Bulgari.
Il Regno dei SHS (Serbi-Croati-Sloveni) nacque il primo dicembre 1918 dalla unificazione delle
regioni slave soggette all'impero asburgico con la Serbia, regno al quale aderirono subito dopo la
Voivodina e il Montenegro. Si realizzava così il sogno secolare della piccola Serbia il cui governo
aveva proclamato il 7 dicembre 1914 che scopo della guerra era: "la lotta per la liberazione di tutti i
nostri fratelli irredenti Serbi, Croati e Sloveni".
L'assemblea nazionale, la Skupstina, costituitasi il primo marzo 1919 richiese che il Friuli con
Gorizia, Trieste, l'Istria, Fiume e tutta la Dalmazia fossero incorporate nel nuovo regno. Gli appetiti
territoriali dei serbi, su cui i vicini Ungheresi causticamente osservavano: "I serbi gente che passa il
tempo sulle rive del Danubio cantando inni guerreschi", non si limitavano all'Italia.
Truppe serbe al seguito di quelle francesi arrivarono nel dicembre 1918 nel Banato, regione
dell'impero austriaco, iniziando una politica di espulsione violenta delle popolazioni non serbe. Nel
successivo maggio 1919 occuparono Klagenfurt e Villach in territorio austriaco e ne furono
sgomberate solo dall'intervento dell'esercito italiano. Nel 1920 la Società delle Nazioni dovette
impiegare una missione composta da una diecina di ufficiali osservatori in Albania per sorvegliare il
ritiro delle truppe jugoslave il cui governo fu sottoposto a una pesante azione diplomatica anglofranco-italiana.
Sull'atteggiamento del governo iugoslavo, fu duro il giudizio del socialista giornale triestino Il
Lavoratore del 27 gennaio 1919: "Gli slavi si impossessano di località prettamente tedesche; è la
corsa sfrenata, pazza, alla fonte di nuovi irredentismi. Il governo ha l'aria di provare una vera
voluttà di attaccar briga con tutti i vicini, a nord e a sud, all'est e a ovest".
Il Regno si legò subito alla Francia, interessata ad impedire una espansione economica dell'Italia
verso i Balcani, "pour jouer un mauvais tour a l'Italie" sosteneva Clemenceau e patrocinò la
creazione della Piccola Intesa con accordi bilaterali con la Cecoslovacchia e la Romania, nazioni
tutte interessate alla conservazione dello statu quo.
Il paese era un mosaico di nazionalità, etnie, lingue, religioni e culture diverse e nel passato era
stato il confine tra il mondo cristiano e il mondo musulmano. Ben presto maturarono numerosi e
gravi problemi nella vita del giovane Stato, privo di una tradizione nazionale basata su una storia
comune. I contrasti tra il nazionalismo grande-serbo che tendeva a centralizzare la vita politica e le
tendenze federaliste prima e separatiste poi dei croati misero in luce la precarietà della coabitazione
tra gruppi etnici diversi, in un clima di arretratezza socioeconomica e culturale. Difficile era la
convivenza fra Serbi di religione ortodossa, Croati e Sloveni cattolici, Bosniaci musulmani.
Profonde erano le differenze culturali ed economiche tra Slovenia e a Croazia, già inserite in una
evoluta compagine politica quale era l'Austria-Ungheria, si pensi alla sostanziale differenza tra lo
stile di vita dell'Austria e un paese balcanico, e gli altri paesi reduci dal giogo ottomano, da cui
avevano ereditato una burocrazia ipertrofica, una popolazione in continuo aumento, una agricoltura
primitiva. Tutti questi elementi con l'aggiunta di minoranze che rappresentavano il 15% della
popolazione e alle quali erano negate i diritti più elementari, pur garantiti dalla costituzione del
1921, contribuivano a creare una miscela esplosiva che sarebbe deflagrata nell'avvenire. Se i
Balcani erano la polveriera d'Europa, la Jugoslavia era la polveriera dei Balcani.
Vanamente si tentò di dare al paese una coscienza unitaria e nazionale, la Jugoslavia finirà in un
mare di sangue di cui all'inizio del nuovo millennio non si vedeva la fine. In settanta anni di storia
fu tenuta unita solo da un autocrate come re Alessandro e da un dittatore come Tito, anni funestati
da attentati, regicidi, violenze, stragi e genocidi. Va riconosciuta a Mussolini l'immediata intuizione
"dell'artificialità" dello Stato creato a Versailles, uno Stato "senza anima".
La vita politica del paese fu precaria con frequentissime crisi, in due anni si succedettero sei
governi, con quattro elezioni generali dal 1920 al 1927, fino ad arrivare nel gennaio 1929 allo
scioglimento del parlamento e alla instaurazione di una dittatura da parte di Alessandro Primo che
nel successivo ottobre diede al paese il nuovo nome di Jugoslavia. All'origine della dittatura vi era
stata l'uccisione a colpi di pistola da parte di un deputato montenegrino in pieno parlamento nella
seduta del 20 giugno 1928 di due deputati del partito contadino croato e di Radic capo del partito
repubblicano croato. Alessandro pagò con la vita la sua politica anticroata. Nel 1934 in visita
ufficiale a Marsiglia fu assassinato da nazionalisti croati guidati da Ante Pavelic futuro capo dello
Stato croato sorto nel 1941 sotto la protezione dell'Italia.
La situazione che si venne a creare fu lucidamente prevista da uno studioso italiano Giorgio
Dainelli il quale nel 1929, dopo aver evidenziato le profonde differenze esistenti tra i popoli della
Jugoslavia, scriveva: "[i serbi] uniti ai loro fratelli di sangue della Bosnia e dell'Erzegovina adesso
cercano di prevalere sui croati , dei quali la formale e non completa unione politica non ha
cancellato i diversi caratteri linguistici, religiosi, culturali ed un antagonismo che spesso è
inimicizia e talora odio" e terminava con parole ancora oggi attuali "cercano di soffocare la
italianità superstite della Dalmazia […] Per un avvenire di pace […] le nazionalità minori siano
protette" (13).
Della Dalmazia un deputato serbo al parlamento austriaco, sicuramente dotato di humour, diceva
"Una provincia austriaca, dove si parla e si pensa in italiano, si comanda in tedesco e si obbedisce in
slavo" e un osservatore americano nel 1920 rilevava che: "Many Jugoslavs speak Italian in their
homes". Nella regione convivevano da secoli le due etnie. Gli Italiani costituivano il ceto dominante
anche per l'arretratezza dei contadini croati, ma restavano una minoranza. Nel censimento del 1910,
i cui dati furono violentemente contestati, su 634.855 abitanti erano 18.288; nessun deputato
dalmata di etnia italiana rappresentava la comunità a Vienna e alla dieta dalmata di Zara erano 6 su
45. L'unica amministrazione italiana era Fiume. Sulla Dalmazia, considerata indifendibile dalle alte
gerarchie militari dell'esercito, il marchese San Giuliano, ministro degli esteri all'epoca del Patto di
Londra, così si era espresso: "Sasonov [ministro degli Esteri zarista] ci ha offerto anche la Dalmazia
ma noi crediamo che non ci convenga estenderci sino alla Dalmazia che è fuori dei nostri confini
geografici". Nel 1915 l'intervento italiano era ritenuto così urgente che anche la Russia, naturale
protettrice degli Slavi del Sud, aveva offerto: "il completo dominio dell'Adriatico, con tutte le
condizioni a ciò necessarie, e salvo soltanto qualche concessione alla Serbia" (14).
Anche nella penisola istriana Italiani e Slavi avevano convissuto pacificamente sotto la repubblica
veneta e l'impero austriaco. Gli italiani, detentori del potere economico, vivevano lungo le coste e
nei centri cittadini, gli slavi nelle zone rurali. Con il diffondersi delle teorie nazionaliste cominciò a
manifestarsi una intolleranza sempre più estesa e che diventò irredentismo da parte di vasti strati
della popolazione slava dopo l'annessione dell'Istria all'Italia.
Unico elemento unificatore era un pervicace odio per l'Italia, che si era sostituito a quello contro i
turchi, che porterà alle foibe, tombe nelle quali giacciono un numero sconosciuto di morti, alla
violenta espulsione di 350.000 italiani e alle pretese del maresciallo Tito di portare i confini con
l'Italia al Tagliamento.
I rapporti politici fra i due paesi furono il paradigma di quelli che si svilupparono nell'Europa degli
anni Venti tra Stati divisi tra opposti nazionalismi e avvelenati da problemi etnici. L'immaginario
collettivo italiano era fortemente influenzato dal fatto di trovarsi di fronte a un vicino nel quale la
metà della popolazione era costituita da ex nemici. Inutilmente Sonnino nell'ultimo anno di guerra
annotava: "Le nostre rivendicazioni di fronte all'Austria-Ungheria rispondono al doppio concetto
etnico e della legittima sicurezza per terra e per mare. […] Laddove si tratta di popolazioni di
carattere misto, una equa delimitazione si può ottenere solamente mediante mutue concessioni e
reciprochi sacrifici, sotto pena di creare uno stato di cose, foriero di futuri conflitti".
I contrasti scoppiarono subito dopo la fine del conflitto quando l'Italia chiese la completa
applicazione del Patto di Londra del 1915 al quale i rappresentanti del nuovo Stato si opposero
strenuamente, appoggiandosi alle parole di Wilson, il quale aveva dichiarato che i confini italiani
dovevano essere fissati: "lungo linee chiaramente riconoscibili dalla nazionalità" e di Lloyd George
lo statista inglese che, dopo aver fatto parte del governo che negoziò gli accordi con l'Italia, dichiarò
nel gennaio 1918 che all'Italia dovevano andare solo: "Territori abitati da popolazioni di razza e
lingua italiana". Gli appetiti slavi furono ridimensionati quando il presidente americano, grande
protettore del nuovo paese, patì una sconfitta al Senato americano che non ratificò i trattati di pace,
provocandone il declino. I precedenti accordi di Londra furono ignorati.
Fu nel novembre 1920 che con il Trattato di Rapallo si arrivò a un primo accordo tra i due paesi.
L'Italia ebbe l'Istria in cui vivevano 400.000 slavi, Zara e le isole di Cherso, Lussino, Lagosta e
Pelagosa, con Fiume città libera e rinunciò alla Dalmazia, con grandi strepiti della Regia Marina,
dei nazionalisti e dei fascisti. Col successivo Patto di Roma del gennaio 1924 la Jugoslavia
riconobbe il passaggio di Fiume all'Italia ricevendone in cambio il Delta e Porto Barros. Nel
successivo 1925 con la Convenzione di Nettuno si regolarono i diritti della minoranza slava a
Fiume e di quella italiana in Dalmazia. La ratifica degli accordi provocò violentissime
dimostrazioni di piazza con assalti a consolati italiani e fu preceduta da accesissimi scontri nella
Skupstina che si susseguirono fino al 1928 quando finalmente passò. L'opposizione contro questi
trattati fu particolarmente violenta tra i croati e gli sloveni che, già sudditi fedeli di Francesco
Giuseppe, imperatore dell'Austria-Ungheria, avevano valorosamente combattuto nell'esercito
asburgico di cui costituivano, con i bosniaci, più del 50%. E croato era uno dei capi più illustri il
feldmaresciallo Svetozar von Boyna Boroevic che, dopo aver sconfitto più volte i russi a Grodeck, a
Przemysl e sui Carpazi, aveva guidato la 5° armata sull'Isonzo e sul Piave meritandosi l'appellativo
di "leone dell'Isonzo". Nel dopoguerra queste popolazioni avevano aderito con grande entusiasmo al
nuovo regno del quale erano stati nemici in guerra. Vengono alla mente le parole di Tom Wolfe:
"Nella guerra tra gli uccelli e le altre bestie, il pipistrello diceva di essere un uccello quando
vincevano i pennuti perché sapeva volare, ma di essere una bestia diversa nel caso contrario perché
aveva i denti".
Di certo la politica estera italiana fu irriducibilmente contro l'Jugoslavia e pieno era il sostegno alle
rivendicazioni dell'Austria, Bulgaria, Romania e Ungheria quando erano rivolte contro il vicino
orientale. Il nuovo corso fu vividamente tratteggiato da un ufficiale austriaco Fritz Weber che, dopo
aver combattuto sino all'ultimo contro gli Italiani, si ritirava al comando di una colonna austriaca
verso Vienna. "La nostra prima meta era Malburg (Maribor per gli jugoslavi) […] Davanti al ponte
della Drava, troviamo un ex ufficiaSerbia" (15)le austriaco con due prigionieri serbi che adesso sono
armati di fucile. […] La Drava segna il confine provvisorio e divide il nuovo regno di Jugoslavia
dalla nostra patria. L'uomo alza la mano, ci invita a scendere a terra: -Cavalli e armi rimangono quidice -voi invece potete passare (15). La minaccia di un bombardamento della città permise agli
austriaci di continuare la ritirata con armi e cavalli.
A questo fenomeno contribuì l'odiosa politica di assimilazione delle autorità fasciste che
applicarono le stesse direttive che avevano caratterizzato la politica italiana in Alto Adige. Il fine
ultimo era la distruzione dell'identità nazionale delle popolazioni annesse, con l'abolizione della
lingua e delle scuole ove si insegnava, la grottesca italianizzazione dei cognomi, la soppressione
delle associazioni slave. La situazione era tale che nel 1928 lo stato maggiore generale negli studi
su una eventuale guerra non faceva affidamento sui richiamati allogeni che dovevano essere inviati
in territori dell'interno, riuniti in battaglioni speciali e disarmati. Misure analoghe erano previste
dalle autorità jugoslave che prevedevano: "l'internamento nuclei uomini validi cittadini jugoslavi di
sentimenti ostili Jugoslavia abitanti in zone prossime […]".
Nei confronti degli slavi non furono però attuati provvedimenti di espulsione in massa, violenze o
stermini come avvenne nei confronti degli italiani negli anni successivi al 1942. Nessun Slavo fu
ucciso perché Slavo. La stampa jugoslava faceva da cassa di risonanza a tutti i soprusi e alle
associazioni nazionaliste tra cui primeggiava l'Istra, con sede a Zagabria, la quale riuniva tutti i
fuoriusciti dell'Istria. Dopo il Trattato di Rapallo il Novi List del 13 novembre 1920 commentava:
"Il trattato di Rapallo ha vivisezionato la giovane Jugoslavia […] però sappia l'Italia che anche i
morti si vendicano!". Il salvataggio dei resti dell'esercito serbo, sconfitto e messo in fuga dalle
armate austro ungheresi, ad opera della Regia Marina veniva minimizzato: "In seguito al deciso
intervento dello zar russo e del governo francese [l'Italia] fu costretta a cedere alcuni suoi vapori di
commercio per il trasporto dell'esercito". Alle falsificazioni storiche e alle minacce si univano il
dileggio per l'esercito italiano che pure aveva sconfitto l'oppressore austriaco e contribuito contro la
loro volontà alla liberazione dei croati e degli sloveni. Sul Novo Dobro di Spalato del 27 ottobre
1927 si legge: "Il 24 di questo mese si sono compiuti dieci anni dalla famosa e grande battaglia di
Caporetto. […] Lì i reggimenti sloveni, croati e bosniaci stritolarono nell'assalto austrogermanico il
migliore esercito italiano e lo cacciarono in fuga selvaggia oltre il Piave. Sebbene questa fosse una
vittoria delle armi austriache in cui i nostri uomini versarono il loro sangue, tuttavia essa suscita nel
nostro popolo tanta gioia quanto altrove" (16). La faziosità non è di pochi fogli di stampa.
L'Almanacco della "Jadronska straza" del 1929 sarcasticamente annotava: "Mussolini sa che
l'esercito non ha avuto nel passato una sola vittoria militare".
L'esercito, fortemente svantaggiato dalla penuria di ufficiali, nel 1926 era diviso in cinque armate su
16 divisioni di fanteria, più una divisione della Guardia con sede in Belgrado, due divisioni di
cavalleria, nove reggimenti di gendarmeria e 42 compagnie di truppe di frontiera. L'artiglieria
schierava 244 batterie campali leggere, 20 batterie pesanti campali e 20 batterie pesanti. I serbi
costituivano la maggioranza dei quadri con 3/5 degli ufficiali inferiori e il maggior numero di quelli
superiorialtrove" (17). Esisteva una forte conflittualità tra i quadri provenienti dall'esercito
austroungarico e quelli serbi anche per le diverse memorie storiche di cui erano depositari.
Caratteristica del clima esistente, gli ufficiali erano usi rivolgersi ai soldati chiamandoli "Junaci",
ossia eroi, in un esercito le cui tradizioni militari si erano forgiate nelle guerre contro gli ottomani e
i paesi vicini.
In un clima di retorica e di esaltazione nazionalistica si festeggiava ogni anno la sanguinosa
sconfitta di Kosovo Polje del 15 giugno 1389 quando i Turchi posero fine alla indipendenza serba:
una nenia racconta di una mamma che alla nascita del figlio lo accoglie con le parole: "Benvenuto
piccolo vendicatore del altrove" (17). A epitaffio del paese si raccontava negli ambienti diplomatici
di Belgrado che la Jugoslavia poteva essere riassunta in cifre: 6+5+4+3+2-1 = 0. Era composta da 6
repubbliche, 5 nazioni, 4 lingue, 3 religioni, 2 alfabeti e UN Tito. Scompare Tito scompare la
Jugoslavia.
LA GERMANIA
Non assolvo gli Stati Uniti e qualsiasi altro paese da ogni colpa nei fatti che fecero del popolo
tedesco una facile preda alle lusinghe e alle minacce dei congiurati nazisti.
Robert Jackson
Rappresentante dell'accusa americana a Norimberga
La Germania, considerata responsabile dello scoppio della guerra, ridotta a una potenza di
second'ordine dal trattato di Versailles, anche se non si poté arrivare al suo smembramento a
differenza dell'impero asburgico e di quello ottomano, pagò la sua colpa con sanzioni pecuniarie,
territori e popolazioni. Perse 70.579 kmq, 1/7 del territorio e 6.500.000 di abitanti, 1/10 della
popolazione. Alla Francia tornarono l'Alsazia e la Lorena col ripristino dei confini del 1870. Il
territorio della Saar, le cui miniere di carbone divennero proprietà della Francia a rimborso della
distruzione delle miniere del nord, venne affidato a una commissione di cinque membri della
Società delle Nazioni con la clausola di un plebiscito che, tenuto nel 1935, diede una forte
maggioranza alla Germania.
Il Belgio ebbe i distretti di Eupen e di Malmedy, la Danimarca a seguito di un plebiscito lo
Schleswig settentrionale. La Polonia, ricostituita nella sua entità nazionale, ebbe la Prussia
Occidentale e la Posnania quasi per intero, l'alta Slesia a seguito di un plebiscito del 1921 e un
"corridoio" che, tagliando parte della Prussia orientale, le apriva l'accesso al Baltico. Danzica
divenne città libera (Fraie Stadt Danzig) con 356.740 abitanti. Memel venne assegnato alla Lituania
pur contando una maggioranza di cittadini di lingua tedesca 72.000 contro i 68.000 di lingua
lituana, senza che si sentisse la necessità di un plebiscito. Il territorio di Hultschin (Hlvcin) con
48.000 abitanti fu assegnato alla Cecoslovacchia. La maggioranza di queste aree venne direttamente
annessa, per altre erano previsti plebisciti.
Tutti i fiumi tedeschi vennero internazionalizzati. Le colonie spartite tra Francia e Gran Bretagna
con qualche concessione al Giappone. Vi fu poi la cessione della flotta militare, di una grande parte
della flotta mercantile e pesantissime indennità finanziarie e industriali, oltre alla distruzione di 60
sistemi fortificati e di 7000 fabbriche di armamenti. Contro la Commissione di controllo del
disarmo vi fu una sorda opposizione, si cercò in ogni modo di intralciarne il lavoro in più casi
rifiutando informazioni e documentazioni, con una resistenza passiva o con azioni violente che
obbligarono le autorità a fare scortare gli ispettori alleati. L'esercito fu ridotto a 100.000 uomini con
l'abolizione della coscrizione obbligatoria, privato delle armi pesanti, dei corazzati e dell'aviazione.
L'articolo 160 del trattato di pace imponeva inoltre che: "Lo stato maggiore e tutte le organizzazioni
analoghe saranno sciolte e non potranno essere ricostituite sotto nessuna forma". Alla marina furono
lasciate sei navi da battaglia, sei incrociatori leggeri, dodici cacciatorpediniere e dodici cannoniere,
unità tutte estremamente obsolete, con un organico di 15.000 uomini.
Con questi provvedimenti si pensava di seppellire per sempre il militarismo tedesco. Le clausole
sugli armamenti a lungo andare si dimostrarono un vantaggio per l'esercito che, non appesantito da
enormi quantità di armamenti e munizioni rapidamente obsolete che riempivano gli arsenali delle
potenze vincitrici, poté dedicarsi in segreto allo studio e alla progettazione di armi, mezzi e
equipaggiamenti. Torna alla memoria il precedente del riarmo clandestino prussiano in epoca
napoleonica.
Il nuovo minuscolo esercito, un superbo modello di esercito professionale, fu affidato al generale
Hans von Seeckt che si era messo in luce sul fronte orientale e il cui nome va aggiunto negli annali
della storia militare a quelli di Scharnost e Gneisenau, autori della rinascita dell'esercito prussiano
dopo la débacle napoleonica, di von Roon che organizzò e di von Moltke che portò l'esercito alle
folgoranti vittorie del 1871. Il primo ordine di servizio emesso il primo gennaio 1921 era un grido
di riscossa: "Questa regolamentazione si fonda sulla forza, l'armamento e l'equipaggiamento
dell'esercito di una grande potenza militare moderna e non soltanto sull'esercito germanico dei
100.000 stabilita dal trattato di pace. L'esercito è il primo strumento della potenza del Reich.
Ciascuno dei suoi componenti deve penetrarsi dell'idea che, in servizio o fuori servizio, è il
rappresentante e l'agente esecutivo di tale potenza. La sua condotta e la sua attitudine in tutte le
circostanze della vita debbono provare che egli è pienamente cosciente della funzione che esercita e
delle responsabilità che ne derivano".
Seeckt, il quale non fece mai suo l'alibi della "pugnalata alla schiena", concepì il nuovo esercito,
sono parole sue: "[…] come un microcosmo capace di una illimitata espansione", un élite composta
da 4.000 ufficiali, selezionati dai 340.000 dell'esercito imperiale e 96.000 sottufficiali e soldati
scelti uno per uno con maniacale cura e che avrebbero formato la struttura, lo scheletro del futuro
esercito hitleriano. Di questa ufficialità Liddell Hart alla fine della seconda guerra mondiale scrisse:
"I generali tedeschi erano il miglior prodotto della loro professione, in assoluti rispetto ad ogni altro
paese".
Il paese alla fine degli anni Venti fu squassato da una profonda crisi economica e morale della quale
approfittò Hitler e il suo partito passato da 12 a 107 seggi nelle elezioni del 1930 e a 230 nel 1933.
La "vendemmia dei grappoli di odio" che maturarono in quegli anni avverrà dopo il 1938 quando
tutta l'Europa sarà sommersa in un mare di orrendi massacri, "pulizie etniche" e lutti senza fine.
LA GRAN BRETAGNA
We don't want to fight, but, by Jingo, if we'do,
We've got the ships, we've got the men, and we've got the money too!
Nel panorama europeo l'esercito britannico, difensore del più vasto impero del mondo degli ultimi
secoli, costituiva una anomalia. In passato si era detto che liberava il paese delle due classi più
oziose e dannose, la più alta e la più bassa. Era composto da ufficiali gentiluomini cui si inculcava il
dover essere prima gentiluomini e poi ufficiali e che venivano giudicati anche dalla correttezza
dell'accento e soldati di professione il cui addestramento individuale era curatissimo, con continue
esercitazioni basate sul fuoco mirato, tradizione che risaliva alle guerre napoleoniche.
La permanenza per tutta la durata del servizio nello stesso reggimento creava straordinari vincoli di
affratellamento, la dura vita nelle colonie con frequenti scontri di piccola intensità facevano dei
Tommy soldati coraggiosi, tetragoni nelle sconfitte. Di essi Kipling, con straordinario paternalismo,
scriveva "[…] che Dio nella sua infinita saggezza aveva dato ai soldati britannici il cuore tenero di
un fanciullo perché così potessero credere ai loro ufficiali e seguirli ovunque come cagnolini".
L'esercito era un piccolo Esercito di volontari, che si distingueva nella perfezione delle parate e
nella rigida etichetta reggimentale, guidato da ufficiali di buona famiglia, la cui professionalità ben
si coniugava con gli sport e la vita sociale, con generali sempre più anziani e sempre più soddisfatti
delle tradizionali dottrine che avevano portato alla passata vittoria. Più che un esercito era un
insieme di reggimenti rigidamente ordinati in prestigio, ciascuno compatto come una famiglia,
inadatto a combattere in formazioni complesse, incapace di assumere iniziative, mal visto da una
opinione pubblica pacifista.
Gli ufficiali costituivano una razza a parte, lontani dai problemi delle truppe affidate a capaci
sottufficiali, molti provenivano dalla "landed gentry", piccola nobiltà terriera e dall'aristocrazia.
Wellington nel 1845 sosteneva che dovevano avere: "Cultura, maniere, onore e altre qualità
acquistate mediante l'educazione che i gentiluomini inglesi ricevono". Nella guerra passata
dimostrarono il loro valore. Alla fine del 1914, dopo cinque mesi di sanguinosi combattimenti,
avevano lasciato sul campo sei pari, 16 baronetti, 95 figli di pari e 82 figli di baronetti. Dopo la
vittoria si calcolò che su otto ufficiali caduti uno era un nobile e nobili erano tre capi Alanbrooke,
Montgomery e Alexander che si misero in luce nella seconda guerra mondiale.
Missione dell'esercito era il presidio dell'India, dell'Egitto,dei nuovi mandati e di tutti i territori
(salvo quelli che si autogovernavano) e nel provvedere in patria il necessario sostegno al potere
civile. Lamentava il capo di stato maggiore nel maggio 1920: "Il nostro piccolo esercito è troppo
sparso non siamo abbastanza forti in alcun teatro: non in Irlanda, non in Inghilterra [era l'epoca dei
grandi scioperi], non sul Reno, non a Batum, non in Egitto, non in Palestina, non in Mesopotamia,
non in Persia, non in India".
Con l'esclusione dell'India, gli effettivi, con le truppe coloniali, la riserva (124.000) e l'armata
territoriale (180.227) ammontavano a 470.727 unità. I reparti stanziati in Gran Bretagna erano
limitati, la Manica costituiva il migliore baluardo contro gli invasori e nel futuro un insuperabile
ostacolo anticarro alle panzerdivisionen di Hitler. In India, perla della Corona, erano accasermati
59.987 effettivi, un numero superiore a quello di tutte le altre colonie (34.119). L'esercito indiano
era formato per un terzo da formazioni britanniche, la memoria del Mutiny del 1857 era sempre
presente, gli ufficiali superiori erano tutti britannici e quelli inferiori in maggioranza. La Gran
Bretagna schierava quattro battaglioni di carri sul territorio metropolitano, ogni battaglione era
composto da uno stato maggiore e 3 compagnie carri di tre sezioni ciascuna con un totale di 52
mezzi, di cui quattro con apparecchi telegrafici senza filo. Vi erano inoltre una compagnia
autoblindo in Gran Bretagna, una in Egitto, e otto in India. Va per inciso ricordato che lo stato
maggiore aveva cominciato ad esperimentare sistemi di comunicazione senza fili già negli anni
Venti e nello stesso periodo iniziò la trasformazione di reparti a cavallo in autoblindati.
Come tutti gli eserciti, era l'espressione della società che era chiamato a difendere, una società
classista, nella quale l'appartenenza alle classi sociali superiori era un potente viatico per tutte le
carriere. La differenza tra i quadri e i sottoposti era enorme, la mediocrità dei coraggiosissimi
ufficiali sarebbe stata impietosamente messa in luce nella guerra contro i Giapponesi e i Tedeschi,
unico popolo del quale rispettavano le qualità guerresche.
La politica estera britannica in Europa fu dettata dalla secolare esigenza di conservare la "balance of
power" tra i grandi Stati, evitando il predominio della Francia e, sugli oceani, dal "Two power
standards" ossia sul potere di disporre di una flotta superiore a quelle unite di altri due Stati. In un
clima di sostanziale debolezza, del quale l'inarrestabile decadenza era la matrice, si seguì una
politica di disarmo che avrebbe portato il paese alla seconda guerra mondiale con concetti operativi
e armamenti superati e antiquati. Vi è però una grande giustezza nel giudizio di uno statista
britannico, la Gran Bretagna era un pugile che combatteva al di sopra del proprio peso. Questa fu la
sua ineguagliabile grandezza.
LA CECOSLOVACCHIA
"La Cecoslovacchia era piccola, i suoi nemici grandi, gli amici lontani e distratti e poco disposti ad
affrontare i rischi e i dolori di una nuova guerra".
(Benedetto Croce)
La nuova nazione, risorta dopo 300 anni il 28 ottobre 1918, fu il paradigma degli Stati concepiti a
Versailles. Sotto la guida di Tomas Masarik e Edward Benes, uomini di valore internazionale e
strenui assertori dell'indipendenza, si fondò sulla spontanea, entusiastica unione di Cechi e
Slovacchi, ai quali furono aggregati Tedeschi, Ungheresi, Ruteni, Polacchi e altre esigue minoranze.
Al primo, Francois Fejto addebitò il grande errore di essere passato dal programma di una
trasformazione dell'impero asburgico in una federazione di stati a quello di una repubblica,
agglomerato di popoli diversi sotto la direzione egemonica dei cechi. Paradossalmente era
un'Austria in piccolo con un nucleo di boemi-moravi di 6.500.000 su 14 milioni, Slovacchi 3
milioni, Tedeschi 3 milioni, Ungheresi 700.000, Ucraini ribattezzati Ruteni 400.000, ai quali si
aggiungevano 100.000 Ebrei e 70.000 Polacchi.
Nel tempo, come per la vicina Jugoslavia, cominciarono a sorgere problemi non solo per le radicali
diversità culturali e storiche fra i Cechi e gli Slovacchi, due popoli separati dal decimo secolo uniti
solo dall'opposizione all'impero asburgico, ma anche per la politica di centralizzazione portata
avanti dalla dirigenza ceca. La Boemia, caratterizzata da un avanzato sistema industriale ereditato
dall'impero austriaco e la Moravia sulla quale l'influenza dell'Austria era stata fortissima, avevano
usufruito dell'istruzione obbligatoria negli ultimi 50 anni e il tasso di analfabetismo era del 2%. La
Slovacchia, fortemente cattolica, era una regione agricola soggetta dal decimo secolo all'Ungheria
con un sistema scolastico limitato alle scuole elementari, essendo le superiori in lingua ungherese.
La difficoltà di amalgamare popolazioni diverse per cultura, lingua e memorie storiche erano
enormi aggravate dalla arretratezza dei Ruteni e dall'insofferenza dei Tedeschi e degli Ungheresi
che nei secoli avevano esercitato il predominio politico e militare.
I Tedeschi della Boemia, tre milioni, aggruppati in due province, la Deutschbuhmen e la Sudenland,
comunemente conosciute come i Sudeti, aspiravano all'unione con la Germania, ancora prima della
fine della Grande Guerra. A Versailles il Consiglio dei Dieci diede mandato a una commissione di
risolvere il problema ma le sue conclusioni, la cessione alla Germania di una zona avente come
centro principale Karlovy Vary e Eger, fu respinto in base al principio che l'aggressore tedesco non
doveva essere premiato con concessioni territoriali.
I rapporti con l'Italia non furono mai cordiali e per le differenti forme politiche e per la politica
slavofila e francofila ceca. Non aumentarono quando i plenipotenziari cecoslovacchi esibirono nel
corso delle trattative a Versailles una carta geografica nella quale Trieste, Gorizia, l'Istria e Fiume
erano indicati come territori jugoslavi. La Francia ne fu il naturale referente, tutore e protettore
anche per il comune interesse a mantenere lo statu quo nell'Europa Centrale. Da questa posizione
era stata scalzata l'Italia che aveva costituito con prigionieri e disertori la Legione cecoslovacca che,
agli ordini del generale Piccioni, era stata la base del nascente esercito. La missione italiana terminò
le sue funzioni nel giugno 1919 quando il generale francese Pellé fu nominato capo dell'esercito
cecoslovacco col compito di riorganizzarlo.
Dei contrasti acutissimi fra popolazioni diverse si ha memoria nelle parole del generale dei
bersaglieri Giuseppe Boriani che, dopo aver valorosamente combattuto nella prima guerra
mondiale, fu inviato in Cecoslovacchia al comando della settima divisione cecoslovacca. In una
lettera diretta alla moglie nel gennaio 1919 scrive: "Non sono i soldati, poveri contadini semplici e
buoni, che hanno ideato il male, ma bensì le autorità civili slovacche che, messe ora in questi paesi
prettamente magiari, vogliono sfogare sulle popolazioni, come vendetta per i mali sofferti, tutte le
ingiustizie e le cattiverie che i magiari hanno inflitto loro […] Questa gente ritiene sia necessario
sottomettere brutalmente i magiari e questa sottomissione consisterebbe, per loro, nel rubare gli
averi, nel cacciarli via dai loro impieghi, nell'impedire loro di parlare le loro lingue, nel provocarli
in tutti i modi per far succedere disordini e procedere alla repressione con le armi" (18).
Con la vicina Polonia i rapporti furono turbati dalla questione di Teschen, città tedesca sul fiume
Olsa, appetita da entrambe le parti e salomonicamente divisa a metà. Il giudizio di Mussolini sulla
nuova entità statale fu espresso senza diplomazia: "Vi sono frontiere tracciate dal sangue: le nostre.
Altre tracciate dall'inchiostro: le cecoslovacche". Va però sottolineata la mancanza di risolutezza dei
capi cecoslovacchi. Pur avendo una potente linea fortificata ai confini, un esercito con moderni
armamenti, quadri pronti a combattere, la sicurezza che la Germania non era pronta alla guerra e
favorevole l'opinione pubblica delle grandi democrazie Edvard Benes cedette all'ultimatum, non
rispose alla forza con la forza, abbandonò la carica e lasciò il paese rifugiandosi a Londra dove: "si
diede al giardinaggio" (19).
Il sogno di Masaryk era di fare del paese "una specie di Svizzera", ma 70 anni dopo, passando per
eventi terribili, del sogno di Masaryk restavano solo la Boemia e la Moravia riunite nella
Repubblica Ceca.
LA POLONIA
"… un popolo capace di ogni eroica virtù, valoroso, affascinante nel suo complesso di individui
debba poi commettere inveterati errori in quasi ogni campo della sua vita di Governo. Splendido
nella ribellione e nella rovina, meschino, indegno nell'ora del trionfo! I più coraggiosi tra i
coraggiosi, troppo spesso guidati dai più vili dei vili".
Winston Churchill
Il paese dal 1795 al 1918 era stato diviso tra Russia, Germania e Austria, indipendente sino al 1939,
occupato da Tedeschi e Sovietici e, dal 1945, satellite sovietico. Alla fine della Grande Guerra la
raggiunta indipendenza evidenziò il problema della ricerca di una identità nazionale e culturale,
furono in molti a sostenere che non aveva una storia propria ma solo quella dei suoi potenti vicini,
dopo lunghissimi, tormentati anni di snazionalizzazione ad opera dei vicini occupanti, accomunati
da un totale dispregio per i Polacchi, di cui è traccia in Clausewitz: "A prima vista il fatto che uno
Stato [la Polonia] di otto milioni di abitanti abbia potuto scomparire, essendo suddiviso tra altri tre,
senza che nessuno degli altri Stati traesse la spada […] lo sfacelo della Polonia non è affatto tanto
incomprensibile quanto sembra essere […]. Da secoli questo Stato non ha più avuto in sostanza
alcun compito politico; esso era diventato soltanto il pomo della discordia per altri Stati. Esso non
poteva assolutamente mantenersi a lungo andare fra gli altri con la propria consistenza e
composizione: […] la loro vita statale disordinata e la loro incomparabile leggerezza andavano di
pari passo, e così essi andarono alla rovina" (21).
La delimitazione delle frontiere, aggravata da una posizione geostrategica infelice in un paese che
non aveva confini naturali, impegnò a lungo i vincitori. Ad occidente si tornò ai confini del 1772
con Danzica città libera. Ad oriente furono fissati su una linea proposta dal segretario agli Esteri
britannico Lord Curzon che correva in parte lungo il fiume Bug, dividendo la Russia Bianca tra
l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Polonia.
I Polacchi, in cui permaneva il ricordo del regno dei Jagelloni, animati da un fortissimo spirito
espansionistico, connaturato al contesto culturale e sociale dal quale scaturiva, legittimando le
rivendicazioni territoriali alla luce di un inventato passato, sognavano di tornare anche all'Est ai
confini del 1772 che comprendevano vaste zone dell'Ucraina e della Russia Bianca. Con questo
spirito invasero l'Ucraina raggiungendo Kiev ma furono ricacciati dall'Armata Rossa fino alle porte
di Varsavia. Solo con uno sforzo supremo, facendo appello a tutte le forze, fu imbastita una
controffensiva che arrivò fino ai fiumi Bug e Niemen. Col trattato di Riga del 1921 i confini furono
spostati a 200 chilometri ad Est della linea Curzon.
La ricostruzione del paese su basi democratiche fallì e nel 1926 il maresciallo Pilsudski, ritiratosi
dalla politica nel 1923, instaurò un regime autoritario appoggiato dai militari che andò inasprendosi
nel tempo, con una violenza culturale congenita, fino ad arrivare alla persecuzione delle minoranze
ucraine, biolorusse e tedesche che ammontavano al 30% della popolazione; pure nel 1919 era stato
firmato il trattato di protezione delle minoranze chiamato "le petit traité de Versailles" per
garantirne il trattamento politico e culturale.
Come Mussolini il maresciallo polacco era vittima di un complesso di inferiorità dovuto alla
secolare debolezza del paese e alla sua passata sottomissione allo straniero. "I nostri vicini, con i
quali desideriamo vivere in pace e in concordia, non vogliono dimenticare la secolare debolezza
della Polonia, che per tanto tempo era aperta alle aggressioni […] Non cederemo neppure un palmo
di terra polacca, e non permetteremo che i confini che ci spettano di diritto, vengano ristretti".
Ribadiva il suo pensiero: "La Polonia ha frontiere così estese e vicini così insidiosi e non dimentichi
della loro sete di conquista che, senza un forte esercito la sua esistenza non può essere garantita
ancora per molti anni". Nello stesso tempo accusava i Polacchi di avere perso: "il senso del diritto e
la fiducia nella propria forza […] mi sembra che per ogni polacco il servizio allo straniero fosse la
cosa più onorifica, più meritevole, più nazionale".
Il complesso di inferiorità emerge anche nelle parole di Dino Grandi al duce nel 1930: "L'anima
italiana non ha ancora acquistato quella libertà spirituale, che in mille anni di politica anti-unitaria
del Papato, politica femminea e servile verso lo straniero più potente del momento, le ha
appiccicato adosso, come una cappa di piombo". La questione di Vilnius, considerata dalla Lituania
come sua capitale, avvelenò i rapporti fra i due paesi. Il maresciallo, in un episodio che illustra
spirito e tensioni dell'epoca, dopo aver sostenuto che: "In linea di massima teniamo la Lituania in
pugno dall'esterno e dall'interno", fu sprezzante con il capo dello stato lituano: "Desta la mia
preoccupazione a causa dello stato della sua mente […] un irresponsabile […] è uno sfrontato",
affermazioni che destavano apprensioni e disagio negli ovattati ambienti diplomatici europei. Non
aveva parole diverse per la vicina Cecoslovacchia: "Lo stato cecoslovacco è un prodotto artificiale,
fatto con un ritaglio di terra che chiamerei "Niemandland" (terra di nessuno). Non vale la pena di
occuparci di questo stato né di basare su di esso il nostro programma d'azione". Dio fu
misericordioso con lui. Dopo aver assistito alla trionfale nascita, alla formazione e alla crescita della
nazione non ne vide la tragica fine e gli anni terribili che seguirono.
Lo storico Ernst Nolte rilevò un parallelo tra Fiume e Vilnus: entrambe le città avevano
rispettivamente una maggioranza italiana e polacca, erano circondate da regioni con maggioranze
jugoslave e lituane, furono conquistate da forze paramilitari strappandole agli jugoslavi e ai lituani
ed entrambe rimasero in mani italiane e polacche fino alla fine della seconda guerra mondiale. Il 25
aprile 1919 La Mission militaire française M.M.F., composta da un centinaio di ufficiali francesi al
comando del generale Paul Henrys venne inviata in Polonia per organizzare l'esercito. Forte
dell'alleanza con la Francia, massima potenza militare del continente, Pilsudski annotava: "Non
vedo la possibilità che i tedeschi di questa generazione, possano attaccare noi o chiunque altro",
comunque prudentemente nel gennaio 1934 fu firmato un patto di non aggressione con la Germania,
cui seguì nel maggio 1939 un accordo di assistenza con la Francia in caso di aggressione tedesca.
L'arroganza polacca, rappresentata dalle esternazioni del suo capo, trovò validi discepoli nella
politica dei colonnelli che lo seguirono. Di loro Liddell Hart scrisse "[…] avevano un'idea alquanto
esagerata della loro forza economica-militare". Pure in questo paese arretrato matematici di
altissimo valore riuscirono a decifrare nei successivi anni Trenta i messaggi trasmessi da Enigma la
macchina cifrante usata dalle forze armate tedesche per la trasmissione di messaggi.
Alla fine degli anni Venti, per proteggere 5.500 chilometri di confine di cui 2.200 con la Germania,
l'esercito allineava 265.000 uomini e costituiva sulla carta un complesso temibile. Allineava nel
1939 30 divisioni in servizio attivo, 10 di riserva e 12 brigate di cavalleria di cui solo una
motorizzata. Come quello italiano era un esercito di soldati che si muovevano a piedi, nel quale i
problemi della motorizzazione e della meccanizzazione non erano mai stati presi in esame. Dava
grande peso alla cavalleria ancora considerata un'arma di peso nelle battaglie moderne.
La guerra metterà in luce la pochezza delle strutture, sorprese ancora in corso di mobilitazione, dei
concetti operativi, della dottrina di impiego di fronte a una superiorità militare, che si manifestava
in proiezione, velocità e potenza di fuoco. Si dissolverà in un mese sotto i colpi della Wehrmacht
ma il motto "Honor i oiczyzna" (onore e patria) sarà ricordato dalla cavalleria che, lancia in resta,
attaccherà i carri armati. Nel suo "Ricordi di un soldato" Heinz Guderian gelidamente commenterà:
"La brigata polacca di cavalleria Pomorska, ignara del genere di costruzione e dell'effetto dei nostri
panzer aveva attaccato all'arma bianca e subito perdite enormi". Segno dei tempi un anno prima la
Polonia si era precipitata ad occupare le città di Teschen e Bohumin "con appetito da iena" (20)
mentre la Cecoslovacchia si dissolveva, aumentando la spiralizzazione della crisi che avrebbe
portato alla guerra. Immagini dell'epoca mostrano ufficiali ungheresi e polacchi che, radiosi ed
esultanti, si salutano sul comune confine raggiunto ai danni della sventurata nazione. 18 mesi dopo
saranno ufficiali russi e tedeschi, radiosi ed esultanti a stringersi la mano sul nuovo confine che
segna la sparizione della Polonia.
L'operetta si era trasformata in tragedia, la tragedia era stata prevista. Francesco Saverio Nitti,
presidente del Consiglio nel dopoguerra, si era interrogato sulla situazione che si sarebbe creata:
"Qualunque sia il suo sforzo potrà la Polonia resistere alla Russia e alla Germania, cioè ai due più
grandi gruppi etnici dell'Europa?".
La Polonia verrà messa in croce dalla Germania di Hitler e dalla Russia di Stalin. Perse il 20% della
popolazione, 6 milioni di cui 600.000 soldati, ma nella tragedia il popolo mostrerà il suo carattere,
sarà l'unico paese che non fornirà reclute ai reparti delle SS o ausiliari alla Wehrmacht.
L'UNGHERIA
Un paese di poeti e sognatori.
Lenin
L'Ungheria, che dal secolo XVI faceva parte dell'impero asburgico, con la riforma costituzionale
dell'Ausgleich del 1867 raggiunse una ampia autonomia assumendo la dignità di regno, avendo in
comune con l'impero austriaco solamente i ministeri della Guerra, degli Esteri e delle Finanze.
Francesco Giuseppe, che salito al trono imperiale regnerà per 68 anni, sottolineava che l'impero si
doveva appoggiare alle due nazionalità, la tedesca e l'ungherese, che ne rappresentavano le forze
più vitali. La classe dirigente ungherese si distinse per una politica di repressione nei confronti degli
slavi e di assoluta opposizione ai tentativi di allargamento della base costituzionale dell'impero,
gelosa dei suoi privilegi, pur essendo i Magiari una minoranza nel regno d'Ungheria come
d'altronde lo erano i Tedeschi in quello d'Austria.
Con la perdita del 70% del suo territorio, 700.000 Ungheresi passati alla Cecoslovacchia, 150.000
alla Jugoslavia e 250.000 alla Romania, con il confine che passava a 30 chilometri da Budapest, era
tra gli Stati più pesantemente penalizzati dai trattati di pace. Nel 1919, in un clima di disordini, un
moto insurrezionale porto alla creazione di una repubblica sovietica che fu spazzata via dalle truppe
romene che, entrate nel paese, occuparono Budapest. Successivamente l'ammiraglio Nicolas Horthy
assunse e tenne il potere fino al 1944.
Fu nel 1920 che si ebbe uno dei primi conati di antisionismo quando fu introdotta la norma del
"numerus clausus" che stabiliva che gli ebrei non potevano accedere alle università in numero
superiore alla incidenza percentuale della loro comunità. Fu necessario un deciso intervento della
Società delle Nazioni perché la norma venisse abolita.
Con l'Italia i rapporti furono sempre eccellenti, uniti nella comune avversione verso la Jugoslavia e
dall'interesse di non fare nascere un forte stato slavo nell'Europa orientale. Mussolini nel discorso al
Senato del 5 giugno 1928 si espresse con simpatia nei confronti della mutilata nazione: "[…]
tagliata troppo sul vivo nelle determinazioni territoriali del trattato del Trianon", aggiungendo: "i
trattati di pace non sono eterni". Si prese la sua parte di bottino territoriale della defunta
Cecoslovacchia. L'esercito ungherese si precipitò ad occupare la Rutenia, estrema propaggine
orientale e tentò vanamente di annettersi l'ormai indipendente Slovacchia di monsignore Tiso col
favore della Polonia.
LA ROMANIA
Viva il re, in pace e onore
Amante del paese e del paese difensore
La Romania, dopo molte esitazioni era entrata in guerra il 27 agosto 1916 affiancando le forze
dell'Intesa. Con un esercito antiquato, Liddell Hart lo definì: "un esercito di baionette" per la
gravissima penuria di armi automatiche e cattivi quadri era stato sconfitto in tre mesi e aveva
dovuto accettare il trattato di Bucarest del maggio 1918, perdendo la Dobrugia passata alla Bulgaria
e i distretti confinanti con la Transilvania passati all'Austria Ungheria. Con la vittoria alleata la
situazione si ribaltava, nasceva la Grande Romania dall'annessione della Transilvania, del Banato e
della Bessarabia. Ad esempio delle problematiche che nascevano dalla coabitazione di nazionalità
diverse basti pensare alla piccola Bessarabia ove convivevano Rumeni, Ucraini, Ruteni, Tedeschi,
Polacchi e Ebrei.
La maggioranza rumena in un territorio più che raddoppiato (da 130.000 a 295.000 chilometri
quadrati) rappresentava il 72 % della popolazione con forti minoranze di Ungheresi, Tedeschi,
Ucraini, Bulgari, Russi e Serbi. Ancora nell'anno 2000 gli ungheresi ammontavano a 2 milioni su
22.000.000. Come i paesi confinanti la vita politica fu condizionata dalla fragilità economica del
paese, dalla sorda opposizione delle minoranze e dallo sviluppo di movimenti nazionalistici e
antisemitici.
UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE
L'isola socialista non avrà mai pacifiche frontiere con lo stato borghese; ci sarà sempre un fronte,
sia pure in forma latente.
M.N.Tuchacevskij
L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS, nasce ufficialmente nel dicembre 1922.
Si basa sull'alleanza di 4 repubbliche: La repubblica federale socialista sovietica (RSFSR), la
repubblica ucraina, bielorussa, federale socialista transcaucasica, nata a sua volta dall'associazione,
avvenuta precedentemente, delle tre repubbliche transcaucasiche: Armenia, Georgia e Azerbaigian.
Solo in seguito verranno incorporate le repubbliche asiatiche. Malgrado la costituzione del luglio
1923 il potere si concentra nel Politibjuro. Carr sosteneva che: "Il Partito diventò il supremo organo
decisionale dell'URSS".
Al principio dell'autodeterminazione rese omaggio la Dichiarazione dei diritti dei popoli della
Russia del 15 novembre 1917 che affermava il diritto alla secessione, in pratica l'Armata Rossa
recuperò una parte delle province perdute (Ucraina, Bielorussia, paesi del Caucaso, Asia centrale e
Estremo Oriente) senza nessun plebiscito. I dirigenti sovietici facevano tesoro delle parole di Lenin,
fondatore di un nuovo ordine sociale in opposizione al capitalismo imperialista, che nel 1909
scriveva: "L'incondizionato riconoscimento della lotta per la libertà di autodecisione non ci impone
affatto ad appoggiare ogni richiesta di autodecisione da parte di una nazione". Il fondatore tuonando
contro lo zarismo "prigione dei popoli" incitò le numerose etnie dell'impero alla ribellione in difesa
dei propri diritti, che poi furono conculcati con la formula della società socialista e internazionalista.
Si passò dall'unione di repubbliche sovietizzate con la valorizzazione delle nazionalità a una
crescente centralizzazione russa. L'Armata Rossa degli Operai e dei Contadini era stata creata nel
febbraio 1918, agli ordini di Trotzkij nominato Commissario del popolo alla guerra.
Nei primi anni Venti i quadri erano improvvisati e raffazzonati, solo una parte aveva avuto una
preparazione professionale nell'esercito zarista. Scriveva Trotskij: "Il passaggio psicologico dalla
distruzione del vecchio esercito alla creazione di uno nuovo si ottenne solo a prezzo di continui
attriti e conflitti". Furono necessari 30.000 ufficiali superiori zaristi sorvegliati dai politruk,
commissari politici, destinati al controllo politico e responsabili della difesa dell'ortodossia
comunista, che, inevitabilmente, si sovrapponevano ai comandi militari anche nelle questioni
operative. Si dovette arrivare al 1929 per poter affermare che: "lo strumento militare dello stato
proletario, prima e unica patria delle masse lavoratrici del mondo" era stato epurato da: "estranei,
politicamente inaccettabili e antisovietici". Sul modello di epurazione possono farsi poche ipotesi.
L'ortodossia politica dei quadri veniva certificata dalle note caratteristiche che indicava sempre la
loro origine sociale. L'avversione per le forze armate, ritenute per la loro natura baluardo del potere
borghese, sulla spinta della nuova ideologia trionfante si manifestò come in tutte le rivoluzioni
proletarie con l'abolizione dei gradi, la soppressione degli ufficiali e la nomina di comandanti
elettivi eufemisticamente definiti "specialisti militari". Come sempre si tornò in un secondo tempo a
tutte le liturgie che caratterizzano le forze armate: bandiere, decorazioni, spirito di corpo, appellativi
onorifici, differenziazioni tra i vari gradi e con l'eterno principio dell'obbedienza assoluta agli
ordini.
Principale artefice della strutturazione fu Michail Vasilievic Frunze che, dopo aver partecipato alla
guerra civile contro i "bianchi", divenne nel 1924 capo di stato maggiore generale e comandante
dell'accademia militare di Mosca, ove morì un anno dopo, a seguito di un intervento chirurgico in
circostanze che diedero origine a molte ipotesi. Nel 1925 l'Armata Rossa aveva una forza di
562.000 uomini alla quale andava aggiunta la milizia territoriale. Le forze corazzate nello stesso
anno erano poca cosa. Due battaglioni, uno su carri armati leggeri e uno su carri pesanti, ciascuno
su tre compagnie di dieci carri. Si dovrà arrivare al 1929, anche per la pochezza dell'industria
automobilistica e di trattori, perché venisse schierato il primo mezzo di progettazione sovietica
l'MS-1 chiamato anche T-18. Pesava 5 tonnellate e con un equipaggio di due uomini era armato di
un cannone da 37 mm. e una mitragliatrice. Finalmente nel 1933 Vorosilov, uno dei pochi generali
sopravvissuti allo stalinismo, poté dichiarare: "Un tempo l'Armata Rossa non possedeva neppure un
carro armato".
"L'Armata Rossa attribuisce la massima importanza alla collaborazione con la Reichswehr"
scriveva il generale von Blomberg nel 1928. La collaborazione era nata dal totale isolamento dei
due paesi circondati da "un cordone sanitario" di Stati confinanti ostili. Già nel 1922 a Rapallo era
stato firmato un trattato con la Germania che sollevò allarme nelle cancellerie europee. La Russia
rinunziò ai danni di guerra che vantava e si instaurarono fruttuosi rapporti anche di collaborazione
militare. I Tedeschi chiesero e ottennero basi militari segrete nelle quali poterono esperimentare e
collaudare nuove armi e procedere al relativo addestramento. Installarono fabbriche di trattori, di
munizioni e di motori per aerei e presso Kazan nel 1929 sorse nel più gran segreto una scuola
carrista. Gli accordi prevedevano che i sovietici dovevano essere messi a conoscenza di tutti gli
armamenti e le esperienze tattiche maturate, col diritto di acquistare materiali bellici.
Sergio Romano, stimato per la finezza delle sue indagini, acutamente osservava: "Germania e
Russia, indipendentemente dai regimi che le governano, non hanno altra scelta fuor che quella di
essere complici o nemiche" (22). L'Italia l'otto febbraio 1924, sei giorni dopo la Gran Bretagna,
riconobbe, secondo Stato in Europa, il governo sovietico. In precedenza vi erano già stati contatti.
Nitti, presidente del consiglio, abbisognando della collaborazione del partito socialista, fece votare
dalla maggioranza che lo sosteneva il 13 dicembre 1919 un ordine del giorno con il quale si
auspicava: "la fine del blocco economico e la ripresa dei rapporti con tutti i governi esistenti di fatto
in Russia", preceduto dal governo inglese che, nello stesso anno, riprese le relazioni commerciali
con la Russia, malgrado l‘opposizione di Clemenceau fautore del "cordone sanitario".
I rapporti, malgrado le opposte ideologie, furono buoni per tutto il ventennio. Così li commentò
Georgij Vasil'evic Cicerin, che successe a Trotzkij come commissario del popolo agli Affari Esteri:
"L'Italia è entrata sulla via dell'intesa e del riavvicinamento con la Russia. Russia e Italia su questa
via possono raggiungere migliori successi e risultati". Comune era l'aspirazione alla revisione dei
trattati di pace e nel 1929 il nuovo commissario del popolo agli Affari Esteri Litvinov aveva
dichiarato a Grandi che i due paesi facevano parte di un: "grande blocco revisionista". Giorgio
Petracchi così li riassunse: "Vantaggiosi scambi economici e favori diplomatici, e una sottile, ma
controllata polemica ideologica mai scivolata in aperta e violenta ostilità" (23).
Entrambi erano portati a giocare su due tavoli, quello anglofrancese e quello germanico che alla fine
degli anni Trenta fu da entrambi ritenuto preferibile. D'altronde sui rapporti italorussi era sempre
calzante il giudizio di Costantino Nigra, ambasciatore presso lo zar nel 1881: "I due stati non
potevano farsi né troppo bene né troppo male essendo troppo lontani". All'epoca al potenziale
militare si poteva adattare il giudizio di Churchill sull'Unione Sovietica: "un indovinello avvolto in
un mistero racchiusi in un enigma". Tutto era avvolto nella cortina di silenzio che nascondeva il
paese. Di certo si appoggiava a una vastissima rete esterna al paese, una massa di uomini
raggruppati nei partiti comunisti di canina fedeltà.
In tutti gli anni trenta si susseguirono "purghe" contro dirigenti politici e intellettuali, col pavido
consenso dei dirigenti stranieri in esilio a Mosca e di quelli che dirigevano i partiti comunisti
all'estero. Negli anni 1937-1938 fu la volta dei militari. Con le accuse più aberranti furono fucilati i
capi di stato maggiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei servizi segreti. Quasi tutti i
comandanti e i commissari politici dirigenti dei distretti. Tre dei cinque marescialli, tre dei quattro
comandanti di primo grado, i 12 comandanti di armata di secondo rango, 60 dei 67 comandanti di
corpo d'armata, 133 dei 199 comandanti di divisione, 221 dei 397 comandanti di brigata, metà dei
comandanti di reggimento e a migliaia di altri ufficiali. La strage si estese in misura forse superiore
ai commissari politici. Spiccò tra gli assassinati il maresciallo Tuchacevskij, di famiglia
aristocratica, giovane tenente nel 1914, che aveva avuto incarichi sempre più alti nell'Armata Rossa
diventandone uno dei massimi teorici.
Conseguenza di tutto questo fu l'incapacità dei capi sopravvissuti e degli ufficiali frettolosamente
promossi ai gradi superiori di guidare la guerra. Più terrorizzati da Stalin che dai Tedeschi, avendo a
disposizione un materiale umano quasi inesauribile, condussero una guerra di usura, documentata
da perdite umane spaventose. Nel discorso alla sessione segreta del XX congresso del PCUS del
febbraio 1956 così si espresse Chruscev: "E, come sapete, prima della guerra avevamo eccellenti
quadri militari, la cui lealtà nei confronti del partito e della patria era indiscutibile […] Non v'è
dubbio che i nostri progressi […] verso la preparazione della difesa del paese sarebbero stati molto
più rapidi senza le tremende perdite subite dai quadri in conseguenza delle infondate e irragionevoli
repressioni di massa del 1937-38".
Glatz David e House Jonathan che hanno avuto la fortuna di entrare negli archivi militari sovietici
nell'opera "La grande guerra patriottica dell'Armata Rossa" di recentissima pubblicazione calcolano
a 29 milioni i soldati morti. Anche se la storia non può essere controfattuale, lasciando libero corso
al pensiero ipotetico viene spontaneo domandarsi quale sarebbe stato il futuro del paese se gli alleati
avessero portato avanti con determinazione, malgrado la vivissima opposizione della Sinistra
europea, una politica di aiuti a Kerenski e alla Duma negli anni dell'immediato dopoguerra.
NOTE
1. Aldovrandi Marescotti Luigi. Guerra diplomatica (1914-1919), Milano 1938. [torna su]
2. Clemenceau Georges. Grandezza e miseria di una vittoria. Milano 1930. [torna su]
3. Simenon Georges. A la decouvert des autres. Paris 1989. [torna su]
4. Taylor Telford. Anatomia dei processi di Norimberga. Milano 1996. [torna su]
5. Valori Aldo. Gli eserciti esteri nei loro ordinamenti presenti. Firenze 1927. [torna su]
6. De La Gorge Paul-Marie. Le armi e il potere. La Francia da Sedan all'Algeria. Milano 1967.
[torna su]
7. Vidal C. Ce qui il faut savoir de l'armèe italienne. Paris 1931. [torna su]
8. Marselli Niccola. La vita del reggimento. Osservazioni e ricordi. Firenze 1983. [torna su]
9. Rovighi Nicola. Un secolo di relazioni militari tra Italia e Svizzera 1861-1961. Roma 1987.
[torna su]
10. Documenti diplomatici italiani. Serie III vol.IV n.21 8 giugno 1925. [torna su]
11. Ceva Lucio. Le forze armate. Torino 1981. [torna su]
12. Kramer Hans. Innsbruch 1918-1920. Storia politica 1973. [torna su]
13. Dainelli Giorgio. La regione balcanica. Sguardo d'insieme al paese e alla gente Firenze 1922.
[torna su]
14. Documenti Diplomatici Italiani. V serie: 1914-1918 vol. I Roma 1954. [torna su]
15. Weber Franz. Tappe della disfatta. Milano 1965. [torna su]
16. Novi dobro di Spalato. Nuova Antologia 1.1.1928. [torna su]
17. Gayda Virginio. La Jugoslavia contro l'Italia (Documenti e rivelazioni). Roma 1933. [torna su]
18. Boriani Giuseppe. L'ultima retroguardia. I bersaglieri dall'Isonzo al Piave. Udine 2001. [torna
su]
19. Bolton Glorney. La repubblica dei Masaryk. Milano 1968. [torna su]
20. Churchill Wilson. La seconda guerra mondiale. Milano 1948. [torna su]
21. Clausewitz Karl von. Della guerra. Milano 1970. [torna su]
22. Romano Sergio. Confessioni di un revisionista. Milano 1998. [torna su]
23. Petracchi Giorgio. Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana a Mosca. 1861-1941.
Roma 1993. [torna su]