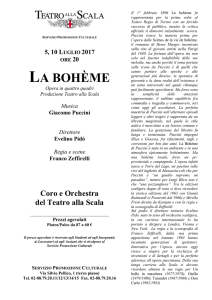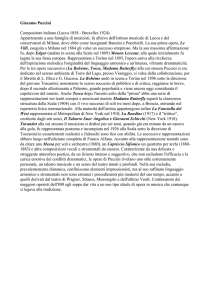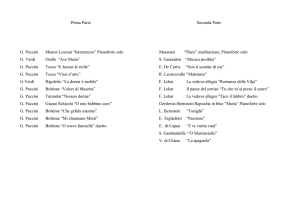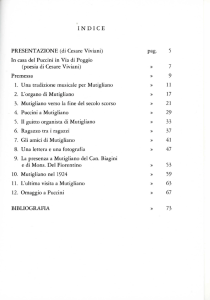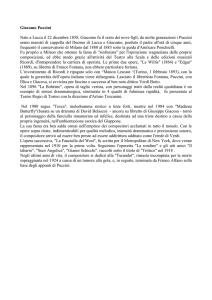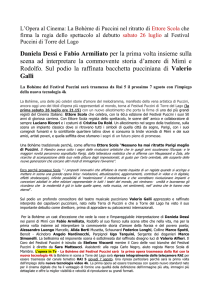Testi di Gianni Ruffin
W W W. T E AT R O U D I N E . I T
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016 - ORE 10.00
ANTEPRIMA PER GIOVANI E SCUOLE
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016 - ORE 20.00
LA BOHÈME
Musica di
graphic: anthes
storia che concerne vite comuni di giovani colti nella molteplicità di situazioni che la
quotidianità normalmente propone e, per converso, proprio perché piccole cose, i fatti
rappresentati si uniscono felicemente alla piccola modalità di conduzione del discorso
musicale.
La varietà degli eventi scenici non è poi solo quantitativa ma anche tipologica (ed
anche per questa ragione vi risulta convincente la scrittura in forma aperta): storia,
secondo Henri Murger, di «vita gaia e terribile», la vicenda di Bohème dà ampio spazio
alla commedia, ma v’insinua fattori eterogenei: in essa convivono la pubblica allegria
della festa al Quartier Latino e l’angoscia dissimulata per la salute di Mimì, la leggerezza
coquette di Musetta e l’ironia un po’ sadica per il perbenista Alcindoro, il divertito
distacco di Rodolfo verso il proprio «ardente dramma» (dato appunto alle fiamme)
ed il coinvolgimento emotivo dell’innamoramento, l’ironia di Colline per la «Vecchia
zimarra» e la tragedia d’una giovane vita troppo presto stroncata (una quarantina d’anni
dopo Violetta Valery, nell’immaginario italico Parigi rimane la capitale del divertimento,
dell’amore e della morte per tisi). All’occasione, inoltre, Puccini può anche scegliere
di contaminare tale eterogeneità: particolare sulle prime disorientante ma in fondo
rivelatore del suo magistero è la ripresa della medesima cadenza armonica della «vecchia
zimarra» nel momento più straziante dell’opera, il congedo di Mimì dal mondo. Come
spiega Michele Girardi: «questa ripresa trasmette un messaggio: comunicare il senso
di un distacco materiale, aldilà del fatto che si tratti di un oggetto o di una persona». Se
pensiamo che non si è data una sola rappresentazione della Bohème senza suscitare
copiose lacrimazioni fra il pubblico, Puccini vi si rivela un vero chimico delle emozioni:
non gl’importa il mezzo in sé, quello che conta è il precipitato espressivo, l’effetto.
Senza dubbio le giocose perfidie indirizzate da Puccini ad Illica e Giacosa implicano un
atteggiamento diverso, anzi opposto alla grandissima capacità di coinvolgimento della
sua musica, ma a ben vedere esse possono addirittura esser considerate testimonianze
emblematiche d’una necessità di distacco da parte del compositore, di uno “sguardo
dall’alto” che, allo stesso tempo, si traduce in calibrato controllo compositivo: in
attentissimo dosaggio degli effetti.
Chi accetti che proprio il distacco costituisca la cifra nascosta di Puccini, sarà meno
stupito dall’ammirazione testimoniata da un autore “freddo” come Igor Stravinskij. Non si
tratta solo del palese ascendente specifico esercitato dalla musica per la festa al Quartier
Latino sulla Fiera della settimana grassa di Petruška, bensì dell’ammirazione per l’intera
nostra opera dichiarata dal maestro russo nel 1956: «Più invecchio, più mi convinco che
La bohème è un capolavoro e che adoro Puccini, il quale mi sembra sempre più bello».
ph: Fabio Parenzan
prospettiva storica risalgono a due tipologie opposte ed alternative: la forma aperta
del recitativo e la forma chiusa dell’aria, del duetto e dei pezzi a più voci. Proprio di qui
promana l’impressione di scorrevole naturalezza: più agili delle vecchie forme chiuse,
grazie al loro interno cangiantismo questi brani ne evitano il senso temporale di durata
irrealisticamente espansa (storicamente motivata dalla necessità di dare adeguata
enfasi alla dimensione sentimentale). Se pensiamo a quanto significativo sia per la storia
del melodramma – specie italiano – il concetto di espansione lirica, comprenderemo
quanto innovativo sia stato il Puccini di Bohème, al quale espandere quasi non serve
più: qui le accensioni liriche sono perlopiù subitanei sfoghi di un’intensità emotiva che,
per trovare degna e piena espressione, non necessita – come per secoli s’era fatto –
d’allargarsi in ampie forme regolari, temporalmente espanse, ma non perciò risulta, al
paragone, meno espressivamente intensa (anzi!… se c’è una ragione fondamentale della
grande popolarità di Puccini essa risiede proprio nella grandissima potenza empatica
della sua musica).
Un breve accenno merita anche la discutibile accusa di resa al wagnerismo fomentata
da questa modalità di scrittura aperta, magari corroborata dal toccante richiamo alle
melodie delle succitate “arie” («Che gelida manina» e «Mi chiamano Mimì») nel tragico
finale di Bohème: modalità non dissimile da quella del Leitmotiv wagneriano. L’accusa non
solo è in sé difficile da comprendere (si stenta a capire dove stia il delitto nell’attingere
da uno dei più grandi compositori della storia del teatro musicale), ma è sostenibile solo
da un punto di vista piuttosto superficiale, limitato ad un approccio esteriore e generico,
incapace di decodificare il senso drammaturgico e formale degli elementi mobilitati.
Lontani da quelle polemiche pretestuose, avvelenate dal sentimento nazionalista, oggi
possiamo serenamente riconoscere che, ciascuno a modo proprio, Wagner, il Verdi del
Falstaff ed il Puccini di Bohème – con l’ottima ideale compagnia di Modest Musorgskij e
Claude Debussy – furono tra i primi a saper interpretare, con la scrittura aperta, l’epocale
tendenza all’informale che tutta l’arte europea andava a quei tempi manifestando.
È inoltre da sottolineare che, entro un genere per sua natura ibrido come l’opera lirica,
un capolavoro non può dirsi tale solo sulla base di astratte considerazioni stilisticomusicali: lo è, capolavoro, se lo stile musicale risulta convincente nel rapportarsi agli
specifici contenuti drammatici che l’azione porta in scena. L’affrettato giudizio talora
rivolto a Bohème (l’opera segnerebbe un passo indietro rispetto al “sinfonismo” di
Manon Lescaut) non è in grado di cogliere la perfetta funzionalità del modo di scrivere
prescelto da Puccini rispetto alla dimensione del dramma: un dramma concernente
non dèi ed eroi, non wagneriane cose ultime e nemmeno grandi personaggi storici; ma
neppure, come nel caso del Falstaff, contenuti buffi, che per loro stessa natura più si
prestano ad un tipo di scrittura radicalmente innovativa (ciò perché il riso, in quanto
segnale d’una dinamica psicologica d’alienazione – di presa di distanza dal suo oggetto
– si associa più facilmente a forme e contenuti trasgressivi rispetto a regole codificate
ed abitudini). Quella di Bohème è invece una storia piccola, immersa in una quotidianità
fatta di persone normali e di piccole cose, sulla quale si abbatte la tragedia con un
impatto emotivo dirompente poiché la dismisura della dimensione tragica è aliena alla
quotidiana normalità rappresentata. Proprio, insomma, per esser fatta di piccole cose
musicali – e non di grandiosità sinfoniche – la partitura di Bohème sa assecondare una
Giacomo Puccini
LA BOHÈME
Musica di Giacomo Puccini
Opera lirica in quattro atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa dal romanzo
Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger
Prima rappresentazione: Torino, Teatro Regio, 1° febbraio 1896
Mimì
Rodolfo, poeta
Musetta
Marcello, pittore
Colline, filosofo
Schaunard, musicista
Alcindoro / Benoît
Parpignol, venditore ambulante
Sergente dei doganieri
Doganiere
Venditore ambulante
Hye-Youn Lee
Ho-Yoon Chung
Marie Fajtova
Marcello Rosiello
Ivan Šarić
Vincenzo Nizzardo
Dario Giorgelè
Motoharu Takei
Hektor Leka
Giuliano Pelizon
Dax Velenich
con la partecipazione de “I Piccoli Cantori della Città di Trieste”
diretti da Cristina Semeraro
Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
direttore Renato Balsadonna
regia Marco Gandini
maestro del coro Fulvio Fogliazza
scene Italo Grassi
costumi Anna Biagiotti
allestimento scenico del Teatro del Giglio di Lucca
PRODUZIONE: FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE
Presentata da Arturo Toscanini al Teatro Regio di Torino il 1º febbraio 1896, La bohème è il
primo frutto, seguito da Tosca nel 1900 e Madama Butterfly nel 1904, della collaborazione
fra Giacomo Puccini ed uno dei più riusciti tandem letterarî della storia dell’opera
lirica: quello costituito dai due scrittori Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, che già avevano
collaborato al libretto di Manon Lescaut insieme a Marco Praga, Domenico Oliva, Ruggero
Leoncavallo e Giulio Ricordi. Ben più che semplici librettisti, Illica e Giacosa erano
personalità letterarie di spicco: il primo apportò diverse novità tematiche alla storia
della letteratura italiana, ancor oggi ingenerosamente attribuite a Gabriele D’Annunzio;
il secondo fu un fine letterato, particolarmente a proprio agio nella definizione di
atmosfere intime e dimesse – analoghe a quelle che tanto luogo hanno sulla scena
della Bohème –, ma chiamato a collaborare principalmente perché più esperto di Illica
nella versificazione (proprio sua è la nota ironica definizione «Illicasillabi» per i versi del
collega). La collaborazione di costoro con Puccini siglò un momento fra i più felici della
storia del melodramma, troncato nel 1906 dalla morte di Giacosa ma foriero dei tre
capolavori cui oggi, più ancora che a Manon Lescaut e Turandot, è assegnato il compito di
tramandare la memoria dell’ultimo operista italiano inseritosi stabilmente nel repertorio
internazionale.
La concezione di Bohème fu particolarmente sofferta, sia per ragioni di circostanza sia
per motivi attinenti allo specifico lavoro artistico. Si cominciò con la polemica che, fin
dal marzo 1893, oppose Puccini a Leoncavallo (affiancati dai rispettivi editori Ricordi e
Sonzogno) per la precedenza nella scelta del soggetto: polemica esplosa in coincidenza
col decadere dei diritti d’autore del fortunato romanzo Scènes de la vie de Bohème, che
lo scrittore francese Henri Murger aveva pubblicato sul periodico ''Le Corsaire'' fra il 1845
ed il 1849. Leoncavallo ci aveva pensato per primo, ma Puccini dichiarò d’aver conosciuto
troppo tardi le intenzioni dell’amico: nonostante il rammarico, protestò ragioni affini a
quelle che lo avevano visto in precedenza impegnato a difendere Manon dall’omonima
opera di Jules Massenet («la precedenza in arte non implica che si debba interpretare
il medesimo soggetto con uguali intendimenti artistici») e, per sua parte, concluse la
disputa con un tono di sfida: «Egli musichi. Io musicherò. Il pubblico giudicherà». Ben
sappiamo come sarebbe andata: il pubblico avrebbe sancito l’indiscussa vittoria di Puccini,
la cui Bohème spopola ancor oggi in tutto il mondo, mentre quella di Leoncavallo, giunta
in scena con più d’un anno di ritardo, è tutt’al più oggetto d’indagine sulla scrivania di
qualche studioso.
Quanto alla genesi di Bohème, essa (nonostante la fretta indotta dalla tenzone con
Leoncavallo) procedette faticosamente per le innumerevoli esigenze poste dal
compositore ai due librettisti. Esigenze ben riassunte dall’intimazione che, anni dopo,
Puccini avrebbe rivolto al librettista di Rondine, Tabarro e Turandot, Giuseppe Adami:
«Non si spaventi: i libretti si fanno così. Rifacendoli. Finché non raggiungeremo quella
forma definitiva che è necessaria a me per la musica, non le darò tregua. Verso, metrica,
situazione, parola… non mi guardi con quegli occhi attoniti… devono essere, fase per
fase, studiati, vagliati, approfonditi, secondo il desiderio mio e le mie personali esigenze».
Puccini, però, aveva fatto perdere la pazienza ad Illica ancor prima di coinvolgerlo
nel progetto-Bohème. Così lo scrittore a Giulio Ricordi nel gennaio 1893: «Puccini ha
confidato ad un amico che dei miei libretti ne fa anche senza e che nessuno sa capirlo,
perché egli vagheggia una cosa… una cosa… una cosa… che…! Capite che questa cosa,
esposta così, è assai difficile ad essere interpretata. Onde di fronte a questo buio pesto
dovrei io brancicare di qua e di là a cercare che cosa è la cosa che vagheggia il Puccini,
per poi sentirmi rispondere: “Un mi piasce!”?».
Nondimeno, Illica accettò di lavorare ancora con Puccini… ed anche questa volta il
lavoro al libretto fu un calvario; il testo poté dirsi ultimato solo nell’ottobre del 1895,
comportando un percorso assai accidentato per i librettisti, alle prese con disposizioni
del Maestro iperdettagliate e, in più d’un caso, provocatoriamente ironiche: oltre al
celebre stampo metrico «cocoricò-cocoricò-bistecca» – che i librettisti resero col verso
«Quando men vo soletta» (che in partitura diviene «Quando men vo, quando men vo
soletta») –, ricorderemo le disposizioni per «il coro che gavazza nell’osteria» all’inizio del
terzo quadro: «il coretto deve essere su questo metro: quinari tronchi. Quattro versi.
Per esempio: Noi non dormiam / sempre beviam / facciam l’amor / sgonfiam trattor».
Sono questi, con numerosi altri, gli aneddoti che ci tramandano la radicata immagine
del “toscanaccio” Puccini: simpatico, gaudente, burlone, un po’ attaccabrighe. Immagine
anche fondata, ma che rischia di metterne in secondo piano le serie motivazioni
artistiche, magnanimamente riconosciute, a fatiche concluse, dal pur tiranneggiato
Giacosa: «Puccini ha sorpassato ogni mia aspettativa!... e capisco adesso la sua tirannia
di versi e accenti».
Aldilà dei pittoreschi aneddoti, quest’affermazione ci mette sulla via della comprensione
del significato storico-artistico di Bohème. Con quest’opera Puccini mise a frutto
l’intenzione di farsi carico dell’eredità che costituiva al tempo stesso l’ultimo ed il più
originale (e frastornante) lascito del grande vecchio dell’opera italiana: la geniale e
recentissima partitura del Falstaff, che Giuseppe Verdi aveva presentato il 9 febbraio
1893 alla Scala di Milano. In quel suo ultimo capolavoro, Verdi aveva colto l’occasione per
sperimentare una scrittura musicale assai innovativa, tutta oscillante fra il recitativo e
l’arioso, ossia priva delle tradizionali grandi arcate liriche di struttura regolare (le forme
chiuse) ed intessuta tramite piccoli frammenti melodico-motivici, retta dal senso di
continuità garantito dal discorso sinfonico (pure questa una novità per l’Italia: patria del
principio secondo il quale la voce umana dev’essere il fulcro dell’invenzione sonora).
Anche nella partitura di Bohème il discorso musicale si articola in una forma aperta e
continua, costruita con un finissimo cesello operante su dettagli minimali, che per sua
natura impone un lavoro minuzioso agli stessi librettisti, cui non a caso Puccini impone
vincoli più di tipo metrico che espressivo. All’ascolto questa forma dà un’impressione
di sciolta scorrevolezza, di naturale semplicità ma, nell’atto compositivo, comporta
all’opposto uno strenuo impegno creativo, per la cangiante mobilità sonora richiesta
(aspetto che parallelamente chiama tutti gli esecutori, dal direttore ai cantanti a ciascun
singolo orchestrale, ad un arduo impegno di concertazione e coordinazione).
Siamo abituati a sentir definire – con una terminologia gravida di significato storico
– “arie” «Che gelida manina» e «Mi chiamano Mimì», e “duetto” il successivo «O soave
fanciulla» (non a caso tutte pagine del Primo quadro, che di Bohème è la parte più
idilliaca ossia la più adatta all’indugio lirico): brani che in verità sono caratterizzati da
imprevedibili fluttuazioni fra il declamato e la perlopiù effimera – e del pari intensa –
impennata melodica, ovvero che si situano a mezza via tra opzioni di scrittura che nella