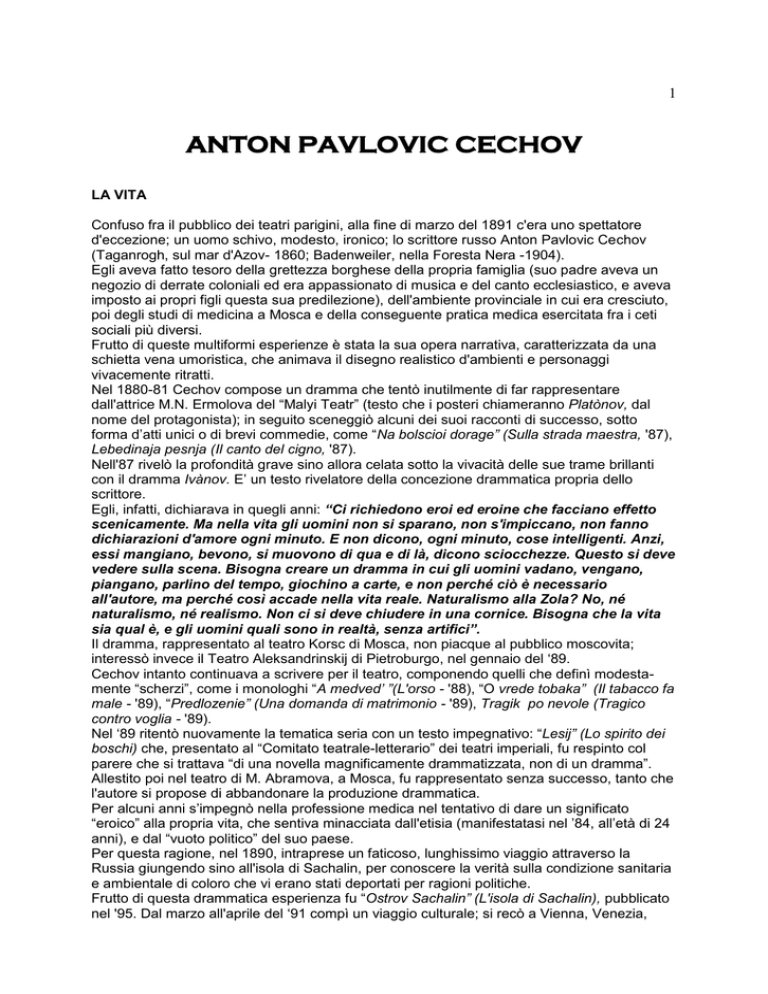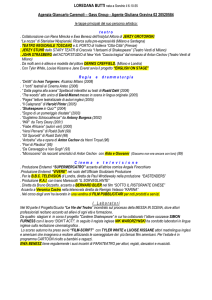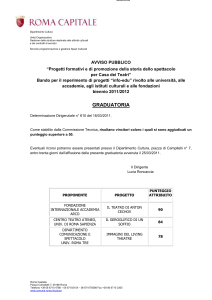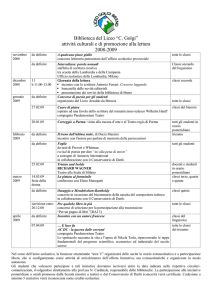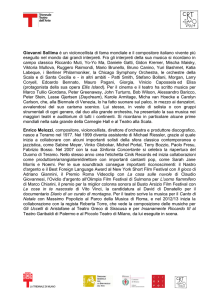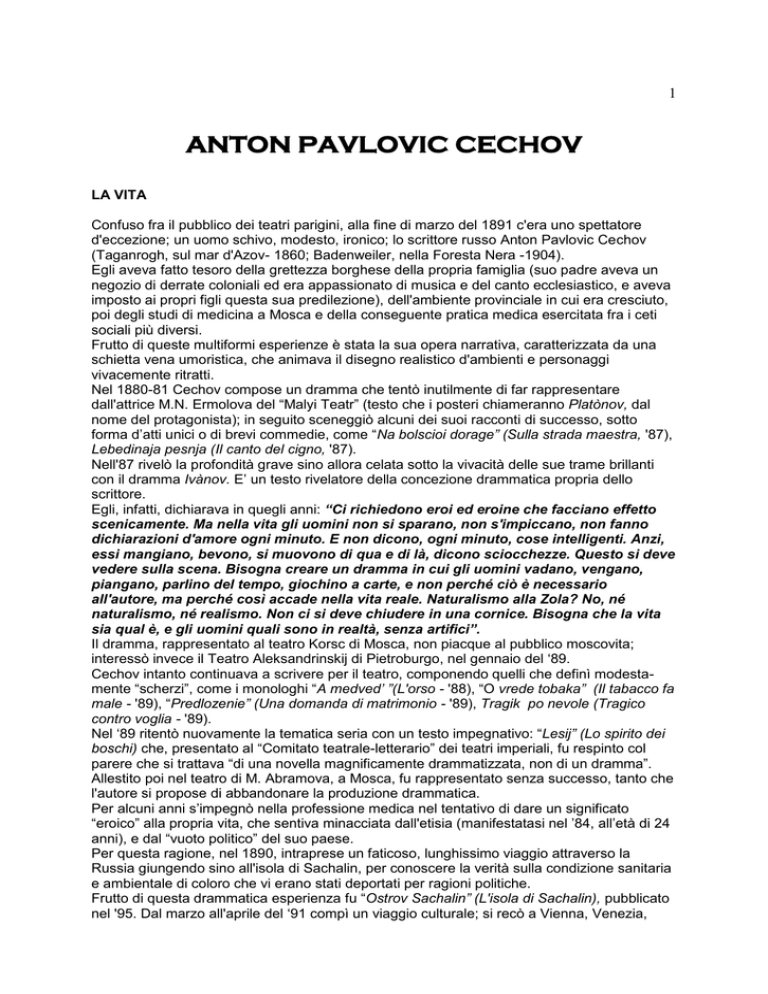
1
ANTON PAVLOVIC CECHOV
LA VITA
Confuso fra il pubblico dei teatri parigini, alla fine di marzo del 1891 c'era uno spettatore
d'eccezione; un uomo schivo, modesto, ironico; lo scrittore russo Anton Pavlovic Cechov
(Taganrogh, sul mar d'Azov- 1860; Badenweiler, nella Foresta Nera -1904).
Egli aveva fatto tesoro della grettezza borghese della propria famiglia (suo padre aveva un
negozio di derrate coloniali ed era appassionato di musica e del canto ecclesiastico, e aveva
imposto ai propri figli questa sua predilezione), dell'ambiente provinciale in cui era cresciuto,
poi degli studi di medicina a Mosca e della conseguente pratica medica esercitata fra i ceti
sociali più diversi.
Frutto di queste multiformi esperienze è stata la sua opera narrativa, caratterizzata da una
schietta vena umoristica, che animava il disegno realistico d'ambienti e personaggi
vivacemente ritratti.
Nel 1880-81 Cechov compose un dramma che tentò inutilmente di far rappresentare
dall'attrice M.N. Ermolova del “Malyi Teatr” (testo che i posteri chiameranno Platònov, dal
nome del protagonista); in seguito sceneggiò alcuni dei suoi racconti di successo, sotto
forma d’atti unici o di brevi commedie, come “Na bolscioi dorage” (Sulla strada maestra, '87),
Lebedinaja pesnja (Il canto del cigno, '87).
Nell'87 rivelò la profondità grave sino allora celata sotto la vivacità delle sue trame brillanti
con il dramma Ivànov. E’ un testo rivelatore della concezione drammatica propria dello
scrittore.
Egli, infatti, dichiarava in quegli anni: “Ci richiedono eroi ed eroine che facciano effetto
scenicamente. Ma nella vita gli uomini non si sparano, non s'impiccano, non fanno
dichiarazioni d'amore ogni minuto. E non dicono, ogni minuto, cose intelligenti. Anzi,
essi mangiano, bevono, si muovono di qua e di là, dicono sciocchezze. Questo si deve
vedere sulla scena. Bisogna creare un dramma in cui gli uomini vadano, vengano,
piangano, parlino del tempo, giochino a carte, e non perché ciò è necessario
all'autore, ma perché così accade nella vita reale. Naturalismo alla Zola? No, né
naturalismo, né realismo. Non ci si deve chiudere in una cornice. Bisogna che la vita
sia qual è, e gli uomini quali sono in realtà, senza artifici”.
Il dramma, rappresentato al teatro Korsc di Mosca, non piacque al pubblico moscovita;
interessò invece il Teatro Aleksandrinskij di Pietroburgo, nel gennaio del ‘89.
Cechov intanto continuava a scrivere per il teatro, componendo quelli che definì modestamente “scherzi”, come i monologhi “A medved’ ”(L'orso - '88), “O vrede tobaka” (Il tabacco fa
male - '89), “Predlozenie” (Una domanda di matrimonio - '89), Tragik po nevole (Tragico
contro voglia - '89).
Nel ‘89 ritentò nuovamente la tematica seria con un testo impegnativo: “Lesij” (Lo spirito dei
boschi) che, presentato al “Comitato teatrale-letterario” dei teatri imperiali, fu respinto col
parere che si trattava “di una novella magnificamente drammatizzata, non di un dramma”.
Allestito poi nel teatro di M. Abramova, a Mosca, fu rappresentato senza successo, tanto che
l'autore si propose di abbandonare la produzione drammatica.
Per alcuni anni s’impegnò nella professione medica nel tentativo di dare un significato
“eroico” alla propria vita, che sentiva minacciata dall'etisia (manifestatasi nel ’84, all’età di 24
anni), e dal “vuoto politico” del suo paese.
Per questa ragione, nel 1890, intraprese un faticoso, lunghissimo viaggio attraverso la
Russia giungendo sino all'isola di Sachalin, per conoscere la verità sulla condizione sanitaria
e ambientale di coloro che vi erano stati deportati per ragioni politiche.
Frutto di questa drammatica esperienza fu “Ostrov Sachalin” (L'isola di Sachalin), pubblicato
nel '95. Dal marzo all'aprile del ‘91 compì un viaggio culturale; si recò a Vienna, Venezia,
2
Firenze, Roma, Montecarlo e Parigi, dove prese contatto con gli ambienti artistici, letterari e
teatrali della metropoli.
Nel '92, acquistò la tenuta agricola di Melichovo, presso Mosca, dove risedette in seguito.
Negli anni seguenti ('92 -'94) s’impegnò attivamente nella lotta contro il colera e la fame che
tormentavano le popolazioni dei governatorati di Niznyj, Novgorod e Voronez.
Nel '94 Cechov compì un secondo viaggio in Italia, da Vienna ad Abazia, Milano, Genova,
Nizza.
In quei mesi lo scrittore lavorò alla composizione del nuovo testo drammatico “Cajka”
(Il gabbiano).
In quegli anni la conoscenza del teatro ibseniano cominciava a diffondersi in Russia, così
come quella del teatro simbolista; nel ’95 “Hannele” di Hauptmann veniva rappresentata da
Suvorin, critico e direttore del circolo “Piccolo Teatro” di Pietroburgo; nello stesso anno
Cechov suggerì all'amico di tentare la rappresentazione dei testi di Maeterlinck.
“Il gabbiano”, dunque, apparve in un momento in cui sembrava che il gusto del pubblico
russo delle grandi città cominciasse ad accogliere le proposte della drammaturgia postnaturalista.
In realtà, nonostante l'opera fosse allestita all'Aleksandrinskij di Pietroburgo, dove aveva
avuto successo Ivànov, e nonostante la presenza della grande attrice emergente del tempo,
Vera Fèdorovna Komissarzevskaja (Pietroburgo 1864-Taskent 1910), interprete nel ruolo di
Nina, il dramma cadde clamorosamente (17 novembre '96).
Il pubblico fu disturbato dalla soluzione tragica del dramma; quasi tutti i critici non
compresero né accettarono il linguaggio specifico dell'opera, che appariva loro tenue, fragile
e incoerente. In realtà
“Il gabbiano” rappresenta un’innovazione nel teatro drammatico russo, e precisamente la
fusione del dramma borghese occidentale con quello scandinavo simbolista d’Ibsen e di
Strindberg.
Ne risulta una forma teatrale verista e poetica nello stesso tempo: la realtà quotidiana, vista
dall'occhio di un poeta profondamente umano.
Dal punto di vista del linguaggio drammatico Cechov sapeva bene di tentare esperimenti
innovativi nel repertorio russo; tuttavia, l'insuccesso della rappresentazione e le critiche ostili
lo colpirono vivamente.
Ne risentì anche la sua salute, già molto fragile; dovette lasciare Melichovo per recarsi in
riviera, a Biarritz, e poi a Nizza, dove rimase fino alla primavera del '98. Negli stessi mesi in
cui aveva scritto Il gabbiano, rielaborava Lesij in un rifacimento che intitolò Djadja Vanja
(Lo zio Vanja).
Vita dunque di tutti i giorni e di gente comune ma solo apparentemente: né lo zio Vanja né
Sonja sono persone comuni, data l'eccezionale forza del loro animo, e soprattutto la
spiritualizzazione d’ogni loro azione più elementare.
Con Il gabbiano e Lo zio Vanja, il teatro “d'atmosfera” o, com’è stato anche definito, “degli
stati d'animo”, era nato.
Mentre Cechov era in riviera a curarsi, a Mosca, ci fu un incontro fra il drammaturgo e regista
V.I. Nemivòrié-Dàncenko (1858-1943), e il direttore di una compagnia di dilettanti di qualità,
K.S. Alekséév, (che diverrà famoso con lo pseudonimo di Konstantin Stanislàvskij; 18631938).
L’incontro, che durò diciotto ore, (22-23 giugno '97) pose le basi per la nascita del nuovo
teatro di prosa “Moskòvskij Chudòzestvennyj Teatr” (MCHT), cioè “Teatro d'Arte di Mosca”.
Stanislàvskij scriverà in seguito: “Noi protestavamo contro la vecchia tecnica della
recitazione, contro il falso pathos, la declamazione, contro gli eccessi personali degli attori,
contro la cattiva consuetudine della messa in scena, contro la regola del primo attore che
nuoceva al complesso, contro tutta la corruzione degli spettacoli, contro il repertorio scadente dei teatri. Nella nostra rivoluzione, in nome di un rinnovamento del teatro, noi
dichiarammo guerra ad ogni convenzionalismo”.
La conquista maggiore di questa battaglia fu lo spostamento del centro di gravità delle
rappresentazioni dall'eroe all'ambiente; se prima il successo dipendeva soprattutto
3
dall'attore, ora dipenderà soprattutto dal regista, capace di creare l'atmosfera e di dare
armonia al complesso.
La compagnia fu formata con attori della Filarmonica dove insegnava Nemiròvié-Dàncenko,
da allievi di Stanislàvskij e da attori di provincia; complessivamente 23 uomini e 16 donne.
Le prove del testo prescelto per il debutto, “Car' Fedor Ioannovic” (Lo zar F. Ivanovic; un
vecchio dramma storico di Aleksej Konstantinovic Tolstoj (1817-1875) che era stato vietato
dalla censura), cominciarono nel giugno del '98; lo spettacolo fu allestito da Stanislàvskij, che
tenne presente la lezione dei Meininger e lo realizzò, in puro stile naturalista, a Karetnyj riad,
il 14 ottobre '98.
Nonostante il successo conseguito, Dàncenko e Stanislàvskij vollero andare oltre ed osare
l'allestimento di testi assolutamente diversi dal precedente, e rappresentarono “La campana
sommersa” di Hauptmann, e Despoti, una commedia del '66 del romanziere e autore
drammatico russo Aleksej F. Pisemskij (1820-81).
Stimolati poi dal repertorio simbolista programmarono “Hannele”, che fu proibita dalla
censura.
Dàncenko allora convinse Stanislàvskij a tentare l'allestimento de “Il gabbiano” di Cechov su
una linea diversa dalla precedente e sfortunata rappresentazione del '96, una linea di ricerca
che, oltre il naturalismo e lo psicologismo, creasse un'autentica atmosfera di poesia.
Fu dall'incontro col “Teatro d'Arte” che derivò per Cechov la possibilità di essere interpretato
in modo rispondente ai motivi interiori della sua creazione scenica, così come per il Teatro il
modo di sperimentare i principi dell’opera di rinnovamento del teatro russo su un repertorio
nuovo.
Lo spettacolo (17 dicembre 1898) ebbe grande successo e decise delle sorti future del
Teatro d’Arte.
Cechov frattanto era stato costretto a trasferirsi nella stazione climatica di Jalta, in Crimea,
nella “Siberia calda” com'egli diceva, dove si logorava dalla nostalgia di Mosca, della vita
letteraria, del suo teatro.
Il 26 ottobre 1899 il Tetro d'Arte mise in scena Djadja Vania (Zio Vania), che già nel 1897
aveva avuto il battesimo in teatri provinciali, e nell’aprile 1900 fece una breve tournée a Jalta,
consolando così la solitudine di Cechov.
L’1l dicembre 1900 Cechov si recò a Nizza, dove lavorò a “Tri sestry” (Le tre sorelle),
rappresentata al Teatro d'Arte il 31 gennaio 1901. In quest’oppresso dolore Cechov vuol
mostrare il disagio profondo di tutta la Russia, ondeggiante fra la rassegnazione e il
presentimento di una non lontana tempesta.
Alcune frasi dei personaggi (il tenente Tuzenbach) danno a questo dramma l'importanza di
un documento storico: “È giunto il tempo in cui si avanza su di noi qualcosa di formidabile: si
prepara una forte, sana burrasca che spazzerà dalla nostra società la pigrizia, l'indifferenza,
la prevenzione contro il lavoro e la putrida noia... Lavorerò e fra trent'anni ogni uomo
lavorerà, ognuno!”
Il lavoro è, per Cechov, il segreto; espiare con un lavoro infaticabile secoli d’ignoranza,
d’ingiustizia e di miseria che hanno oppresso il popolo russo, creando un enorme divario fra
teoria e realtà.
Il 12 ottobre 1903 terminò, a Jalta, ”Visnevyj sad” (Il giardino dei ciliegi) che fu messo in
scena dal Teatro d'Arte il 17 gennaio 1904 con successo, ma non senza qualche perplessità
di pubblico e di critica.
Intanto Olga Knipper, la deliziosa attrice che lo aveva colpito alle prove de “Il gabbiano” (era
l’Arkadina) diventa amica della sorella; in un breve soggiorno moscovita di Anton i due si
vedono molto.
Di ritorno a Yalta, Anton pensa ad Olga: ”Mi sono abituato a voi, mi mancate e non riesco
proprio ad assuefarmi all’idea che non vi vedrò sino a primavera. Sono di pessimo
umore”.
La lontananza ha permesso ad Anton di rendersi conto dell’importanza assunta nella sua vita
dalla relazione con Olga e decide di sposarla, ed il matrimonio si celebra il 25 Maggio 1901.
Ad Anton rimangono solo tre anni di vita e la salute peggiora a vista d'occhio; scrive con
fatica, ha frequenti sbocchi di sangue, deve trascorrere lunghi periodi a Yalta lontano da
4
Olga. Anche ad Olga il distacco pesa: “Ho voglia di stare con te. Mi pento amaramente di
non aver abbandonato le scene. In realtà non so che cosa mi stia succedendo, e ciò m’irrita.
Non vedo chiaro in me. Mi fa impazzire il pensiero che tu sia solo laggiù, che tu sia infelice,
che tu ti annoi mentre io qui mi dedico ad un lavoro effimero, invece di abbandonarmi
interamente al mio amore”.
Il 15 febbraio tornò a Jalta ma, aggravandosi sempre più la sua malattia, i medici decisero di
mandarlo nel centro termale di Badenweiler, dove si spense.
Di lui Thomas Mann affermerà che “può stare alla pari con quanto vi è di più forte e di più
alto nella letteratura europea”.
LE OPERE (brevi riassunti)
Ivànov - Il protagonista, che avrebbe dovuto chiamarsi Ivan Ivanovic per essere, come disse
lo stesso Cechov a Korolenko: “il più comune degli uomini”, è un proprietario di campagna e
insieme un intellettuale in declino. Sua moglie Anna, che per lui si è convertita dall'ebraismo
all'ortodossia, è ammalata e si strugge al pensiero che il marito deluso della vita non l'ami più.
Ivànov frequenta, in effetti, la casa dei Lebedev, la cui figlia Sasha si è innamorata di lui ma,
quando Anna muore, il sospetto che il sentimento della fanciulla sia solo pietà e le accuse del
dottor L'vov (che lo ritiene colpevole della morte della moglie) lo spingono al suicidio. In una
precedente stesura Ivànov moriva per un collasso in seguito alle accuse di L'vov: la soluzione
del suicidio, che lo stesso Cechov riteneva “melodrammatica”, gli parve tuttavia la più logica
conseguenza dell'avvilimento spirituale di Ivànov. Il personaggio così finì col riassumere tutto
ciò che era stato detto da narratori e autori drammatici russi sugli uomini che, di fronte alla
politica dello zar Alessandro III, s'erano smarriti, disperando di avere ormai uno scopo nella
vita.
Il gabbiano - Costantino, figlio di una celebre attrice, vuoi diventare scrittore per avere la
gloria e con essa la mano di Nina, sua vicina di casa. In piena campagna è montato un
palcoscenico e Costantino vuol rappresentare un suo lavoro ma la madre Irene Arkadina, coi
suoi inopportuni commenti, interrompe la rappresentazione. In seguito a quest’insuccesso
Nina, che pure aspira agli allori dell’arte, si disamora di Costantino e finisce per andarsene a
Mosca con Trigorin, letterato alla moda e amante di Irene Arkadina. Come Costantino ha
ucciso per svago un gabbiano che volava sul lago, così Trigorin ucciderà moralmente per
svago Nina, seducendola e abbandonandola poco dopo. Colpirà a morte anche Costantino il
quale, non potendo ottenere Nina, sempre innamorata di Trigorin, e senza fiducia nel proprio
talento artistico, si uccide.
Zio Vania - Ivan Vojnickij, zio Vanja, è un uomo bonario e modesto che ha passato gran parte della vita amministrando la tenuta della nipote Sonja, figlia di una sorella defunta, e
dell'ambizioso prof. Serebrjakov, riammogliatosi con la bella Elena, una donna più giovane di
lui. Il professore vorrebbe la vendita della tenuta di sua figlia per procurarsi i mezzi necessari
ad un viaggio; zio Vanja, che si è reso conto di aver sacrificato la propria vita alla carriera di
un presuntuoso mediocre, si oppone. La tensione s'inasprisce a causa di Elena, della quale
s'innamorano zio Vanja e il dottor Astrov, del quale Sonja è segretamente innamorata ma
senza speranza. I conflitti sono violenti ma ad eccezione dei colpi di pistola a vuoto che zio
Vanja spara contro Serebrjakov in un impeto d'ira, tutto si svolge in tono minore, a
simboleggiare l'impossibilità di modificare l'ordine delle cose. Il professore e sua moglie,
delusi, ripartiranno per la città; il dottor Astrov, deluso, non verrà più tutti i giorni; zio Vanja e
Sonja ritorneranno alla loro monotona esistenza.
5
Le tre sorelle - Olga, Masha e Irina, tre sorelle orfane di un generale, lasciano bambine
Mosca per seppellirsi in una piccola città di provincia. Mosca rappresenta quindi il fascino di
una vita diversa, una promessa d’evasione. Olga, la più anziana, insegna al ginnasio; un
lavoro senza gioia che le permette di vivere. Masha, innamoratasi a diciotto anni del professor
Kuligin (un uomo gretto e meschino), lo sposa, convinta della sua intelligenza e abbagliata
dalla sua cultura. Irina è la più giovane, ancora ricca d’entusiasmi e di speranze. Accanto alle
tre sorelle, il fratello maggiore Andrej sogna di diventare uno scienziato famoso e nel
frattempo sposa Natasha, una piccola borghese avara e invadente.
Arriva una guarnigione e le tre sorelle, disprezzando il provincialismo dei cittadini, annodano
tenere relazioni con gli ufficiali, alla cui classe privilegiata appartenne anche il padre. Il
tenente e barone Tuzenbach s’innamora di Irina ma morirà in uno sciocco duello, e Masha si
consola del suo infelice matrimonio con l'amore per il comandante Versin. Ma “niente può
succedere”; il reggimento parte e le tre sorelle rimangono, dopo un momento di tragica
disperazione, a vivere la loro squallida vita. Il dramma si chiude con il grido angosciato di
Irina: “Adesso è autunno, presto verrà l'inverno che coprirà tutto di neve e io lavorerò,
lavorerò...”
Il giardino dei ciliegi - Ljubov'Andreevna Ranevskaja, proprietaria di una tenuta il cui
maggior ornamento è un ciliegeto, ritorna a casa dall'estero dopo esser stata economicamente
rovinata dal suo amante. La tenuta sta per essere venduta per pagare i debiti e tutti i membri
della famiglia, tra cui le due figlie di Ljubov'Andreevna (Ania, legittima; Varja, adottiva), ne
sono rattristati. Un conoscente, Lopachin, innamorato di Varja, consiglia di dividere la tenuta
in piccoli lotti ma ad un tal espediente si oppone l'incapacità di Ljubov'Andreevna e di tutti
coloro che la circondano. Messa all'asta la tenuta, lo stesso Lopachin l'acquista. Ognuno di
loro, costretto a lasciare la casa e il giardino dei ciliegi, s'avvia verso un nuovo destino
portando nel cuore il rimpianto di quel che avrebbe potuto essere: non solo
Ljubov'Andreevna, ma anche suo fratello Leonid Gaev, che continua la serie degli intellettuali
abulici e inetti della fine del secolo; Varja, che non è più al centro dei pensieri di Lopachin; la
dolce Anja, illusa dalle fantasie dell'eterno studente Trofimov, uno di quei personaggi
cechoviani che sognano un avvenire felice per l'umanità.
LA CRITICA
Si possono accennare soltanto alcuni degli spunti interpretativi che i drammi cechoviani
hanno suggerito ai maggiori studiosi del teatro moderno.
Osservando il suo originale linguaggio, uno di loro ha scritto: ”Un dialogo di Cechov è uno
spartito musicale per voce recitante. Vi si alternano accelerazioni e rallentamenti. Spesso il
tono e il timbro hanno la medesima importanza del senso esplicito.
Inoltre l'intreccio ha struttura polifonica e svolge contemporaneamente diverse azioni distinte,
a diversi livelli di coscienza.
Le tipiche riunioni, la “soirée” teatrale nel Gabbiano, la festa nella casa delle tre sorelle, la
scampagnata nel Giardino dei ciliegi sono altrettanti insieme dove le varie melodie si
combinano oppure si scontrano in dissonanze. Nel secondo atto del Giardino dei ciliegi le
voci di Madame Ranevskij, Lopachin, Gaev, Trofimov e Anja eseguono un quintetto.
Le linee melodiche si svolgono separatamente con apparente incongruenza.
6
Un altro ne ha colto una peculiarità: “Il linguaggio cechoviano deve il suo fascino a questo
continuo trapasso dalla conversazione alla lirica della solitudine. Ciò è possibile solo grazie
alla grande comunicatività del popolo russo e al lirismo della sua lingua.
Un altro ancora, riflettendo sul senso simbolico, sottolinea il valore della sua drammaturgia:
“La scena circostante del Giardino dei ciliegi corrisponde alla scena significativa della vita
umana e al solitario deserto al di là del piccolo salotto di Ibsen. Sviluppando ingegnosamente
i momenti di pathos con le dolorose intenzioni egli ha, nella piccola scena del realismo
moderno, una visione molto più larga di quanto non abbia Ibsen. Le cime nevose di Ibsen ci
scuotono piuttosto istericamente ma la “scena d'Europa” che noi indoviniamo dietro il
Giardino dei ciliegi è confermata da mille impressioni di diversa derivazione. E’ perché
Cechov dice così poco che rivela molto. Accettando così l'immediatezza e l'intelligibilità del
realismo moderno egli trascende, in un certo modo, le sue limitazioni e apre la strada ai
successivi sviluppi del teatro moderno”.
Il nostro massimo studioso del teatro russo infine, dopo aver ricordato il perdurante successo
internazionale del teatro cechoviano, ha offerto un'interpretazione sul significato filosoficoetico di quei drammi: “Non sono le vicende degli eroi russi a suscitare interesse in quei
drammi o commedie ma, per uno spostamento di prospettiva, gli spettatori di qualsiasi paese
vedono, o ritrovano, quella creatura umana che essi sanno in loro stessi, viva di quella
stessa allegria, o di quella stessa tristezza ed angoscia, di cui lo scrittore ha animato i suoi
eroi...”
De “Il gabbiano”, un critico russo dell’epoca ha scritto: “Il soggetto è quasi privo di movimento
esteriore; il movimento interiore è dato su un campo limitato e prevalentemente nei momenti
culminanti. Il soggetto non ha “principio”, nel senso che il corso scenico nelle forme del
dramma potrebbe cominciare in qualsiasi altro momento temporale. Non costruendo la
drammaticità dell'opera su degli “avvenimenti” ma solo su “esperienze di vita” dei personaggi,
l'autore si diffonde nella motivazione psicologica e quotidiana delle loro azioni... Costruito
così drammaticamente su di un'emozione non decisa da avvenimenti, l'opera in sostanza
non ha nemmeno una fine. Gli stati d'animo da cui deriva l'atmosfera dei drammi di Cechov
sono gli stessi che dominano nei suoi racconti e che hanno fatto dello scrittore uno dei più
profondi interpreti del suo tempo; scoraggiamento per la realtà ed insieme sogno di
redenzione, sia nel ricordo del passato sia nell'aspirazione dell'avvenire, dipinto come un'oasi
di serenità dopo la sofferenza e il tormento.
Lo spiraglio sull'avvenire, anche se non porta un vero e proprio superamento del
pessimismo, dà tuttavia il senso che nel fondo dell'animo dello scrittore vi fosse quasi il
rimorso di non riuscire a dare, oltre l'espressione dell'accorata rinunzia, anche quello della
fede.
Solo interpretate in questo modo a noi sembra che acquistino il loro vero valore la vaga
affermazione di fede in un avvenire migliore nel Giardino dei ciliegi, ne Le tre sorelle, e in Zio
Vanja.
Incoraggia quest’interpretazione anche quanto scrisse la Knipper-Cechova a proposito delle
difficoltà della rappresentazione dei drammi cechoviani: “Rappresentare Cechov è molto
difficile. Non basta esser buon attore e recitare la propria parte con maestria.
Bisogna amare, sentire Cechov, soprattutto bisogna amare la creatura umana come l'amava
Cechov, con tutte le sue debolezze e i suoi difetti. Soltanto quando l'anima si colma di questa
commozione, quando semplicemente, infantilmente si ha coscienza della gioia della vita, e
appassionatamente si voglia vivere e apprezzare tutto ciò che è dato da Dio, potrà apparir
facile affrontare le opere teatrali di Cechov e vivere la vita dei suoi personaggi”.
7
IL PENSIERO
Anton P. Cecov considera se stesso un medico di provincia trasferitosi a Mosca che scrive
più per divertimento che per vocazione, che racconta storie di tutti i giorni senza pretesa di
salvare l'umanità o lanciare messaggi ma con una precisa convinzione: la gente, per
migliorare, deve vedersi com’è fatta, come vive, non come dovrebbe essere o vivere.
“Non sopporto la menzogna e la costrizione, in ogni sua forma. Il fariseismo, la
stupidità, l'ingiustizia non regnano solo nelle case dei mercanti e nelle prigioni; le
vedo negli ambienti della scienza e delle lettere, tra i giovani” scriverà nel 1888, quando
si troverà conteso dai vari gruppi letterari di Pietroburgo, la capitale.
Anche nel lavoro letterario, come nel suo mestiere di medico, Anton privilegia la diagnosi alla
terapia, l'impostazione del problema alla soluzione. “Lo scrittore deve dare un quadro, il
più possibile obiettivo, della realtà, del personaggio, della vicenda presa in esame:
prediche, messaggi, prospettive lontane non fanno parte del suo mestiere.
Credo che i romanzieri non debbano risolvere problemi quali Dio, il pessimismo ecc.
Compito del romanziere è solo quello di rivelare come e in quali circostanze le
persone hanno parlato o meditato su Dio o sul pessimismo. L'artista non deve essere
il giudice dei suoi personaggi e di quanto essi dicono ma solo un testimone
imparziale... Ai giurati, ossia ai lettori, la valutazione. Io devo cercare solo d’avere
talento, cioè di saper distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è, per rendere
chiari i miei personaggi e parlare la loro lingua”. In una lettera all'amico Suvorin:
“In questo mondo è indispensabile l'indifferenza. Solo le persone indifferenti sono in
grado di vedere le cose chiaramente... In me il fuoco brucia uniforme e indolente,
senza improvvise vampate e senza scricchiolii... Ecco perché non commetto evidenti
sciocchezze né atti concretamente intelligenti... manco di passione”.
E a un'osservazione di Suvorin, che avrebbe voluto una più decisa condanna dei ladri nel
racconto omonimo, replica: “Voi mi rimproverate l'obiettività, chiamandola indifferenza
verso il bene o il male, mancanza di ideali ecc. Vorreste che quando dipingo i ladri di
cavalli dicessi: è male rubare cavalli. Ma lo sanno tutti che è male, senza che debba
dirlo io. Questo è affare dei giudici; il mio lavoro consiste nello spiegare che cosa essi
sono... Sarebbe indubbiamente piacevole combinare l'arte con la predicazione, ma per
me è estremamente difficile, anzi quasi impossibile, per motivi tecnici.
Nello scrivere mi affido al lettore, sperando che egli inserisca da solo gli elementi
soggettivi che mancano nel racconto”. Continua a pensare al teatro: “Dobbiamo lottare
con tutte le nostre forze affinché il teatro passi dalle mani dei bottegai a quelle dei
letterati, altrimenti è condannato”.
Nell'ottobre 1895 un annuncio gioioso all'amico Suvorin: “Pensate un po’: scrivo un lavoro
teatrale! Probabilmente non lo terminerò prima della fine di novembre.
Scrivo con piacere, andando contro le convenzioni teatrali in modo terribile.
E’ una commedia con tre ruoli femminili, sei ruoli maschili, quattro atti, un paesaggio
(vista sul lago), numerose discussioni letterarie, poca azione e cinque pud d’amore”.
E’ “Il gabbiano”. Lo finisce prima del previsto e lo manda a Suvorin con una nota di sconforto:
“Ho cominciato il dramma forte e l'ho terminato pianissimo. Sono più scontento che
soddisfatto; dopo averlo riletto mi rendo sempre più conto che non sono un
drammaturgo. Non fatelo leggere a nessuno”.
A proposito del suo teatro, Cechov confidò una volta a D.P.Gorodeckij: “Il pubblico vuole
che ci siano l'eroe, l'eroina, grandi effetti scenici. Ma nella vita ben raramente ci si
spara, ci s’impicca, si fanno dichiarazioni d'amore. E ben raramente si dicono cose
intelligenti. Per lo più si mangia, si beve, si bighellona, si dicono sciocchezze. Ecco
che cosa bisogna far vedere in scena. Bisogna scrivere un lavoro in cui i personaggi
entrano, escono, pranzano, parlano del tempo, giocano a vint... non perché questo sia
necessario all'autore, ma perché cosi avviene nella vita reale.
Ecco la gran lezione del teatro cechoviano: mostrare ciò che avviene nella vita reale.
8
“Il gabbiano”; i contenuti
Un dramma quasi senza trama: una madre attrice superficiale, possessiva con il figlio
Konstantin, (aspirante scrittore sensibile, inquieto) e un amante, Trigorin, scrittore di
successo ma volgare e presuntuoso.
Intorno a loro un gruppo di possidenti in vacanza tra cui Nina, che è amata da Konstantin ma
fugge con Trigorin inseguendo un sogno di successo in teatro.
Abbandonata dal vanitoso scrittore, fallisce anche come attrice: torna da Konstantin solo per
comunicargli la sua disperata decisione di continuare a vivere la vita randagia d’attrice di
terz'ordine.
Konstantin, ancora innamorato, sente crudelmente la fine del rapporto con Nina; non crede
più alla vocazione di scrittore che all'inizio l'aveva sostenuto e si uccide.
Come in tutte le opere di Cechov questi personaggi sono tormentati da grandi ideali sproporzionati alle loro forze (Nina, Costantino) o, pur incontrando successo nella vita, sono ugualmente afflitti dalla sensazione della propria inutilità, e indotti a cercar rifugio nelle piccole
soddisfazioni che offrono al corpo e all'anima la ricchezza e la stima del prossimo (Trigorin).
Sono questi gli uomini rappresentativi della Russia alla fine dell'Ottocento, inquieta e
anelante al nuovo ma incapace di realizzare i suoi sogni.
È stato osservato: nella commedia c'è più di un semplice intreccio di vicende amorose; i
discorsi sul valore dell'arte nella vita e sulla vocazione artistica vi occupano un posto rilevante, con tono a tratti polemico (erano gli anni in cui anche in Russia, come nel resto d'Europa,
si andavano affermando il decadentismo e il simbolismo).
Cechov, attraverso le parole di Kostantin, esprime le sue critiche e il suo modo di intendere il
teatro: “Per me il teatro d’oggi è un miscuglio di pregiudizi e di convenzionalismi.
Quando si alza il sipario questi grandi scrittori, questi sacerdoti dell’arte, con una luce
artificiale e una camera fatta di tre pareti vogliono farti vedere come gli uomini
mangiano, bevono, fanno all'amore, si mettono la giacca, ecc. ecc.; vogliono
dimostrarti, con parole e modi volgari, una morale meschina, utile e comprensibile alla
meschina vita borghese di tutti i giorni. Quando rifriggono in mille modi sempre la
stessa cosa, io devo andarmene... Occorrono forme nuove..
Alla fine, il giovane scrittore dirà: “La verità è che non è la forma quella che conta, ma
che l'artista scriva senza preoccuparsi di scuole o di tendenze, perché ne sente il bisogno, come uno sfogo dell'animo…”
Nina, dopo aver giocato e perduto la propria vita con Trigorin e aver straziato quella di
Kostantin, nell'ultima sua apparizione enuncerà, tuttavia, una tesi storico-cristiana che rivela
la ricchezza interiore dell'autore: ”Adesso, Costantino, io ho la sensazione che nella
nostra opera, sia di scrittore sia d’attore, quello che conta non è la gloria, non è quello
che si sognava, ma il saper soffrire. Portar la propria croce e avere fede.
Ora io ho fede, e non soffro più tanto. Se penso alla mia missione nella vita, non ho
più tanta paura”.
Il gabbiano viene accettato dal Teatro Aleksandrinskij, che ne annuncia la “prima” il 17
ottobre con un cast d'eccezione: Vera Fedorovna Komissartevskaja, la più grande rivelazione
di quegli anni, nella parte di Nina e accanto a lei tre star maschili: Apollonskij (Treplev),
Davydov (Sorin) e Varlamov (Scamraev).
Troppi mostri sacri per un lavoro che richiede invece attenzione, sobrietà, semplicità.
“Gli attori non sanno la parte” scriverà Anton dopo aver assistito ad una delle ultime
prove.
“Non hanno capito nulla. Recitano in modo orrendo. Solo la Komissarzeskaja è
brava”. Infatti non ce n'è uno che non declami in modo enfatico; tutti vogliono l'applauso,
esagerano toni e atteggiamenti. Il pubblico, inoltre, è venuto per divertirsi e vuole ridere: la
serata è in onore della Levkeeva, attrice comica popolarissima che recita in un breve
vaudeville presentato prima de Il gabbiano.
9
E’ sufficiente la richiesta di una presa di tabacco da parte di Masha nel primo atto, o
l'attacco del monologo di Nina: “Gli uomini, i leoni, le aquile, le pernici, i cervi dalle ramose
corna” per far scoppiare la platea in grandi risate, nonostante l'intensità e l'emozione della
Komissarzevskaja.
Disorientati e stravolti di fronte alle inattese reazioni del pubblico, gli attori perdono il controllo. Un disastro.
Anton fugge dal teatro senza salutare nessuno e vaga per ore nella Pietroburgo umida e
nebbiosa.
Alle due di notte arriva da Suvorin: “Vivessi ancora settecento anni, non scriverò mai più
per il teatro”.
Al fratello Michail scrive: “Il lavoro è stato un fiasco clamoroso. In sala c'era un'atmosfera tesa, imbarazzante, vergognosa. Gli attori hanno recitato da cani, da cretini.
Morale: non bisogna più scrivere lavori teatrali”.
Si rifugia nella casa di Melichovo, chiedendo tassativamente ai presenti: “Mai più una
parola su quello spettacolo”.
Sulla stampa recensioni durissime, stroncature feroci. La seconda rappresentazione va
meglio: il pubblico non si aspetta più risate, segue con attenzione, applaude.
La Komissarzevskaja scrive subito ad Anton: “Torno da teatro. Abbiamo vinto. Il successo è
pieno, unanime. Come vorrei vedervi qui ora e, ancor più, come vorrei che possiate udire il
grido di tutti: "l'autore!".
Piccola consolazione che non allevia l'amarezza profonda, e quando Suvorin gli propone la
pubblicazione a stampa accetta a malincuore.
“Per questo lavoro non sento altro che repulsione, ne leggo le bozze contro voglia.
Voi direte di nuovo che ciò non è intelligente, che si tratta d'amor proprio, d'orgoglio
ecc. Lo so, ma che farci? Non è a causa del fiasco del dramma.
Anche prima la maggior parte dei miei lavori aveva fatto fiasco e ogni volta n’ero
venuto fuori asciutto come un’anitra dall'acqua. Il 17 ottobre ha subito un insuccesso
non il mio dramma ma la mia persona.
Fin dal primo atto mi colpì una circostanza, vale a dire che gente che fino a quel
giorno avevo trattato a cuore aperto, familiarmente, amichevolmente, con cui avevo
pranzato in modo spensierato, in favore dei quali avevo spezzato una lancia (come, ad
esempio, Jasinskij), tutti costoro avevano una strana espressione, terribilmente
strana... Adesso sono tranquillo, del solito umore, ma non posso dimenticare quello
che è successo, come non potrei dimenticare se mi avessero dato uno schiaffo”.
Rientrato a Melikovo riceve una lettera dell’amico Vladimir Ilic Nemirovic Dancenco, anche lui
scrittore, drammaturgo e neo direttore del Teatro d’Arte di Mosca con il giovane regista
Stanislavskij.
Per la prima stagione del suo teatro Nemirovic vuole riallestire “Il gabbiano”.
Memore del fiasco pietroburghese, disgustato dalla faciloneria d’attori e registi, Anton rifiuta.
Nemirovic torna alla carica: gli assicura impegno e serietà degli interpreti, tutti giovani
entusiasti; un numero di prove dieci volte superiore agli altri teatri, massima attenzione ai
dettagli dell'allestimento.
Alla fine Anton cede, senza molta convinzione, e continua a scrivere racconti.
A Melichovo non riesce a concentrarsi, è assediato da amici e visitatori. Lascia Melichovo e
trascorre qualche giorno a Mosca, dove vede due o tre prove de Il gabbiano; è colpito
dell'impegno del regista e dalla bravura degli attori; è incantato soprattutto da una di loro,
Olga Knipper.
A Mosca è fissata per il l7 dicembre la prima de Il gabbiano.
Tutta la compagnia è in agitazione irrefrenabile. Un nuovo scacco avrebbe messo in serio
pericolo la reputazione del giovane teatro e avrebbe allontanato forse definitivamente Anton
dal Teatro.
Ecco come Nemerovic ricorda la fine del primo atto: “Successe ciò che in teatro succede
forse una volta ogni dieci anni: il silenzio, un profondo silenzio in sala e sul palcoscenico.
In platea tutti sembravano inchiodati, in palcoscenico non si capiva ancora niente... La cosa
durò a lungo. Giungemmo alla conclusione che il primo atto era caduto, caduto a tal punto
10
che non c'era neppure un amico pronto ad applaudire. Gli attori furono colti da un tremito
improvviso, prossimo all'isteria”.
Stanislavskij racconta il seguito: “Improvvisamente dal pubblico si levò un urlo, uno strepito,
un applauso frenetico. Il sipario si mosse, si aprì, si richiuse, e noi stavamo lì come storditi.
Poi di nuovo un urlo, poi di nuovo il sipario...
Noi stavamo sempre immobili, senza comprendere che dovevamo inchinarci. Finalmente
capimmo il successo e cominciammo ad abbracciarci l’un l'altro... Il successo cresceva ad
ogni atto e terminò con un trionfo”.
Un trionfo dell'autore, ma anche un trionfo del nuovo metodo di messinscena: rigoroso,
attento, orchestrato in tutti i movimenti e in tutti i registri.
Parte immediatamente un telegramma per Yalta: “Appena finita recita Gabbiano. Successo
colossale. Chiamate innumerevoli. Pazzi di gioia” cui ne seguì un altro, dopo gli esiti entusiastici delle prime recensioni.
Nel suo ultimo periodo ad Yalta Anton, solo, comincia a fare dei bilanci: la sua vita è segnata
da viaggi e racconti.
Di racconti ne ha scritti oltre duecentoquaranta. C'è una linea che li accomuna? Sì, secondo
Anton l'assenza di menzogna.
“Mai si deve mentire. L'arte ha questo di particolarmente grande: non tollera la
menzogna. Si può mentire in amore, in politica, in medicina; si può ingannare la gente,
persino Dio, ma nell'arte non si può mentire... Mi si rimprovera di scrivere solo
d’avvenimenti mediocri, di non avere eroi positivi... ma dove trovarli? Non chiederei di
meglio! Conduciamo una vita provinciale, le vie delle nostre città non sono neppure
lastricate, i nostri villaggi sono poveri, il nostro popolo è logorato. Tutti, finché siamo
giovani, cinguettiamo come passeri su un mucchio di letame; a quarant'anni siamo già
vecchi e cominciamo a pensare alla morte. Che specie di eroi siamo?... Volevo solo
dire alla gente in tutta onestà: guardate, guardate come vivete male, in quale maniera
noiosa. L'importante è che le persone comprendano questo: se lo comprendono
inventeranno una vita diversa e migliore. L’uomo diventerà migliore quando gli
avremo mostrato com’è”.
Il capolavoro di Cecov: “Il gabbiano”.
Per apparire giovane, l’Arkàdina porta camicette chiare.
Sebbene i traduttori trascurino questo particolare, esso è straordinariamente significativo,
perché indica l'anèlito di giovinezza che pervade l'attrice.
E poi quel “chiaro” appartiene al contrappunto cromatico delle vesti dei personaggi mulièbri.
Nina-gabbiano in bianco lunare; il bianco mesto del saio di Pierrot, nel teatrino sul lago.
E Masha in nero, in eterno nero: “E’ il lutto per la mia vita. Sono infelice”.
Ma nero e bianco rappresentano due aspetti reversibili dell'infelicità, e il bianco è tutto acini
neri, tutto fuliggini.
Cechov era molto sensibile a queste minuzie: si pensi all'abito rosa con cintura verde,
sintomo di banalità e di malgusto, che indossa Natascia nelle Tre sorelle.
C'è più cordoglio per la vita che fugge, più desolazione nel bianco di Nina che nell'immutabile
nero ossessivo di Masha.
Poiché annoda i destini di quattro artisti: Trepliòv, Trigòrin, l'Arkàdina, Nina Zarècnaja, la
commedia può intendersi anche come il compendio di quattro vocazioni diverse.
Si resta nel dubbio: chi dei quattro è davvero geniale? O forse gli esorcismi del genio
collimano col deserto del fallimento?
Per le riflessioni continue dei personaggi intorno al mestiere teatrale e ai trucchi della
narrativa, e inoltre per gli aneddoti di Sciamràev sugli attori, Il gabbiano vuol essere anche un
dialogo sull'arte scenica e sulla strategia dello scrivere.
Trigòrin, afferma Nina al quarto atto, “non credeva nel teatro”, nel teatro in genere.
11
Anche Trepliòv detesta e fugge il teatro, ma si riferisce alle recite istrioniche, alla trita
teatralità delle compagnie di provincia e forse anche ai vezzi delle scene imperiali. “Non c'è
bisogno di teatralità, colombelle...” Così Cechov implorava gli interpreti dell’Aleksandrinskij. “Occorre esser semplici... del tutto semplici...”
Eppure un inconscio teatralismo si annida nelle pieghe della commedia.
Essa conosce anche il gusto del travestimento: a Trepliòv, rifacendogli la fasciatura,
l'Arkàdina dice “Come se avessi il turbante”.
Quanto a Sciamràev, nella lotta contro il teatro banale, egli è in fondo un alleato di Trepliòv.
Se quest'ultimo attacca l'Arkàdina e la sua maniera da una prospettiva futura, per ansia di
nuove forme, Sciamràev la contrasta, lodando la generazione passata, gli attori-tromboni, le
“querce possenti” che, per l'Arkàdina, invece sono “antidiluviani”.
“Borghesuccio di Kiev! Parassita!” urla l'Arkàdina al figlio, spregiandolo come campione di
una corrente rinnovatrice che potrebbe scalzarla.
Ma Trigòrin, con più esattezza: “C'è in lui qualcosa di strano, d’indefinito, che a volte
assomiglia persino ad un delirio”.
Trepliòv, insofferente, nevrotico, ombroso, convinto di essere un drammaturgo fallito, un
inabile prosatore, vive a scatti, a singhiozzi, a colpi d'ala, sbandando come un gabbiano.
Sembra che tutto il suo cruccio, il suo rodimento, il suo grido di perdizione nascano dalla
mancanza di congegni pronti, ossia di quell'artifizio, di quel mestiere che sono propri di
Trigòrin il quale, con fredda perizia, sa trarre dallo spasimo di una ragazza invaghita un
“soggetto per un breve racconto”.
L'inchiostro circola come sangue nero negli scritti smaniosi di Trepliòv, ma in ciò che scrive
Trigòrin tutto è calmo e ben regolato secondo sicuri dettami e provati procedimenti.
“Sempre più e più mi pare”, asserisce Vasilij Ròzanov, che i letterati siano tutti dei
“brandeljàsy”. Il bello di questo fonema è che esprime e non indica nulla; appunto per questa
sua qualità si dimostra particolarmente applicabile ai letterati.
Trigòrin è un “brandeljàsy”. Nella vita: indeciso, abulico, inerte, molliccio, di facile rassegnazione e rinunzia, scalcagnato incantatore di fantasiose fanciulle.
Come romanziere: bramoso di prendere appunti, di far tesoro dei minimi accadimenti,
incalzato dalla consuetudine di imbrattar carta ad ogni costo, perché “non manchi una toga ai
pesci e non muoia di freddo il caviale”; schiavo di schemi, invischiato nel proprio mestiere
assillante.
Spaccarublo, vanèsia, iperbolicamente spilorcia l’Arkàdina ama il teatro soltanto perché le
fornisce occasione di mettersi in mostra.
Il successo l'attrae, non il testo che interpreta.
Ricordando le recite a Charkov, ciarla a sproposito dell'entusiasmo con cui l'hanno accolta e
della finezza dei suoi vestiti. Chiusa nel proprio egoismo può starsene a lungo a giocare a
tombola, mentre il disastro si addensa sul cielo della commedia.
Nina Zarècnaja è inquieta come un gabbiano nel vento.
Attonita e ansante, in perpetua fuga, arriva sempre improvvisa, con irruenza. “Sei entrata tu,
tagliente come un "eccomi!" “ potremmo dire con Majakovskij.
La commedia nella commedia, che ella declama nel teatrino lacustre, è intrisa del senso
d’indeterminazione di tutte le cechoviane tirate sulla felicità del futuro.
Qui tuttavia il futuro in parte si attua; non resta caliginosa promessa e stazione d'arrivo di
un'infinita traiettoria: si attua ed è desolante, afflittivo.
Trepliòv si toglierà la vita e Nina andrà a recitare in una pingue città di provincia, Ielièz, città
di mercanti, perdendosi nella morchia di un mondo triviale. Eppure il suo terminale monologo
affannato, rotto dal pianto, tutto iterazioni melodiche e stridori di gabbiano, non sbandisce la
speranza.
L'acerbità della vita e gli struggimenti hanno accresciuto la fede di Nina nella vocazione
d’attrice.
Masha non ha propensioni artistiche: ama la commedia di Trepliòv perché ama Trepliòv.
Ma in questo rompicapo d’amori incrociati c'è un momento, all'inizio del terzo atto, in cui il
destino di Masha sembra anch'esso sfiorare Trigòrin.
Un'improvvisa reciproca simpatia li avvicina.
12
Se Nina vede in Trigòrin un idolo inarrivabile, il romanziere è per Masha soltanto “un uomo
semplice”.
Nel quarto atto Trigòrin le chiederà, senza averne risposta, se è felice, ora che si è sposata.
D'altronde la stralunata che veste di nero, annusa tabacco e si esprime con frasi da romanza
straziante ha bisogno di consolare la propria malinconia, e perciò inclina verso Trigòrin,
perciò si confida con Dorn, il cui linguaggio è anch'esso intessuto di scampoli di lacrimose
romanze.
Se l'Arkàdina, nella sua vanità, si proclama giovane, i giovani come Masha e Trepliòv sono
stanchi, si sentono vecchi.
Masha ha la sensazione di essere nata già da tantissimo tempo e di trascinare la vita “come
un interminabile strascico”.
A Trepliòv pare di aver già novant'anni. Ma in genere tutti gli eroi del Gabbiano si lamentano
di non esser vissuti come volevano; sospirano perché il tempo fugge e la loro vita trascorre
feriale, monotona, senza furori; hanno malinconia del passato, rimpiangono amori infelici.
Insomma non fanno altro che “filosofare”.
Il Gabbiano è anche un'allegoria spietata di quel male inevitabile, di quel fumoso fuoco di
resina che è l'invaghimento di un quarantenne per una fanciulla, e dell'estatica infatuazione
di una fanciulla per un quarantenne.
Trigorin cerca evasioni e rifiorimento nell'amore di Nina che incarna la giovinezza, e la
giovinetta Nina disdegna il giovane Trepliòv innamorato per fuggir con Trigòrin, al quale
l'Arkàdìna, anch’ella quarantenne, si aggrappa disperatamente nella paura di perderlo,
assalendolo con un mare mellifluo di tenerezze e di scaltri vezzeggiativi.
La giovinezza ricusa i compromessi: Trepliòv sceglie la morte; Masha si avvolge in un
immutabile raggrinzito lutto; Nina trova la forza di rompere con la famiglia e di affrontare la
ruvidità della vita, le offese, i disinganni (non cesserà di voler bene a Trigòrin nemmeno
quando egli la avrà abbandonata).
Trigòrin invece, l'idolo quarantenne; la sua fastidiosa canna da pesca, la sua mollezza, la sua
facile rassegnazione, i suoi freddi fervori, il suo disvolere, la sua incapacità di risolversi: belle
parole e niente anima.
Tutta una serie di triangoli: Nina-Trigòrin-Trepliòv; Arkàdina-Nina-Trigòrin; Masha-TrepliòvMedvèdenko; Dorn-Polina-Sciamràev.
Persino Sòrin alla fine afferma di essere stato innamorato di Nina.
Questo carosello d'amore dà alla commedia un ritmo sospeso, ansimante, un'assidua
inquietudine.
Quando si trovano in due (Nina e Trepliòv; Nina e Trigòrin; Trigòrin e Arkàdina; Dorn e
Polina), i personaggi hanno sempre paura che all'improvviso qualcuno possa sorprenderli.
Ad accrescere la labilità e l'incertezza del tessuto drammatico concorre il motivo della
partenza continuamente rinviata.
L'Arkàdina vuole e non vuole; Trigòrin non vuole ma poi parte con gli altri; tutti partono:
anche Nina, e più tardi Trepliòv dietro a Nina.
Gli eroi cechoviani sono inclini a migrare come le renne. Una sorta d’immota partenza è il
disperato matrimonio di Masha con Medvèdenko.
Al quarto atto però tutti ritornano, anche Nina, sebbene ormai come un’estranea.
E vi saranno nuove partenze: Trigòrin correrà a Mosca, pungolato dall'ansia di scrivere; Nina
andrà in un teatro di terza classe a recitare, in una città di mercanti; Trepliòv scenderà nella
tomba.
Medvèdenko, col suo continuo ragionare sullo stipendio, sulla grama esistenza dei maestri, è
per Cechov un goffo, il campione di un praticismo che non conosce ideali.
Infervorandosi per i sognatori e i lunatici, Cechov tratta sempre con spregio i personaggi
della progènie di Medvèdenko, creature che, attente soltanto alla “saggezza del corpo”, non
sentono necessità d’assoluto, di Grandi Domande. Ecco perché nel quarto atto, mostrando
l'esitazione di Medvèdenko a tornarsene a casa nel fracasso della tempesta, mette con tanta
stizza in risalto il fastidio della sua presenza.
13
Nell'ultimo atto, con l'infittirsi del dramma, Cechov effigia tre momenti della banalità, tre
“stazioni” scurrili: la tombola, durante la quale l'Arkàdina blatera a vanvera dei propri successi
d’attrice; lo spuntino, cui Trepliòv si rifiuta di partecipare; di nuovo la tombola mentre Trepliòv,
lacerati i suoi manoscritti, va ad uccidersi.
Spuntino e tombola sono per Cechov indizi di quella trivialità inveterata, di quel trionfo del futile
e del commestibile che stroncano l'estro, gli impulsi, e canzonano la disperazione.
Ciò che è frivolo, viscerale, provoca sempre il suo astio.
La monotonia stralunata con cui Masha scandisce i numeri della tombola, come recitando un
rosario di lutto che si addice al suo abito nero, nerissimo; il malinconico valzer che Trepliòv
esegue al pianoforte due stanze in là; l'imperversare della tempesta sul lago; il fioco lume della
lampada a petrolio; le trafelate, incalzanti, apprensive battute di Nina; l'ambigua frase “corsa ad
ostacoli” che Dorn pronunzia alla fine, cercando di rimuovere la poltrona che sbarra la porta:
tutto questo fa del quarto atto una sorta di lamentosa “sonata di spettri”.
Roberto Lussignoli