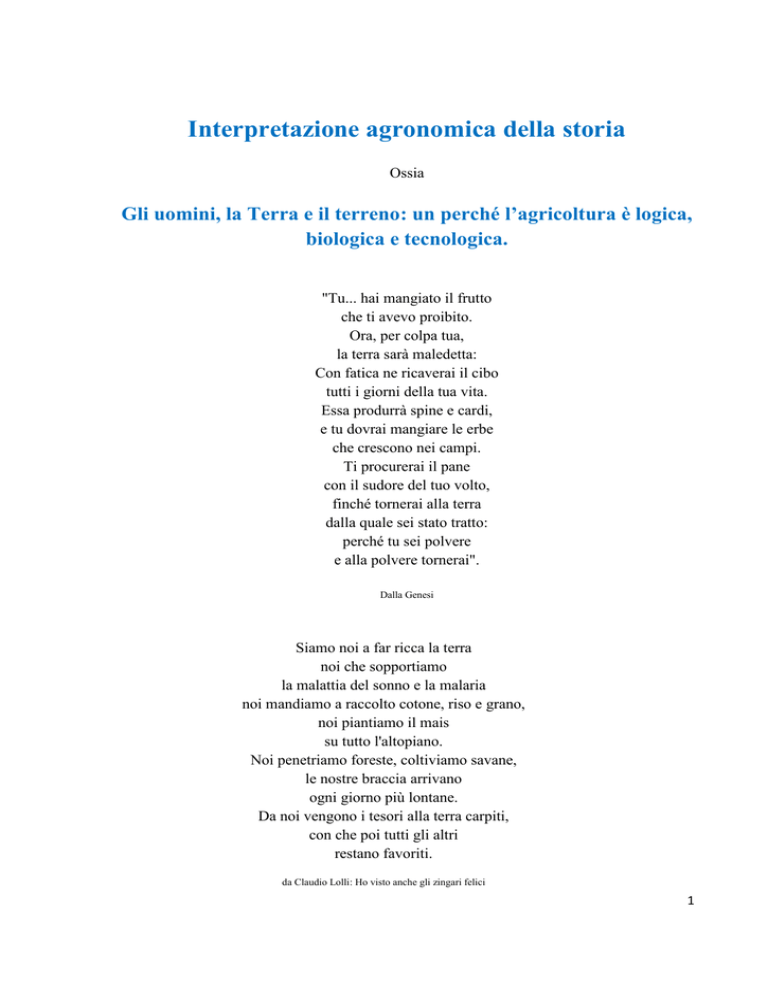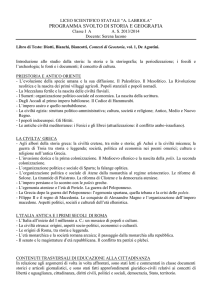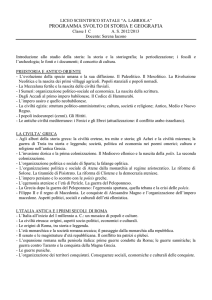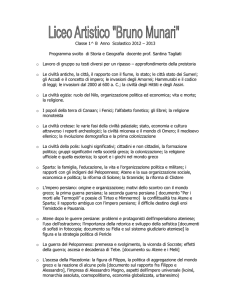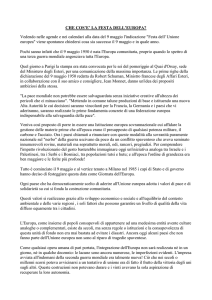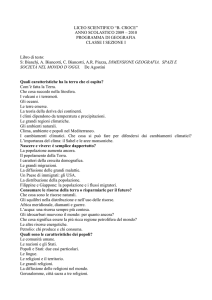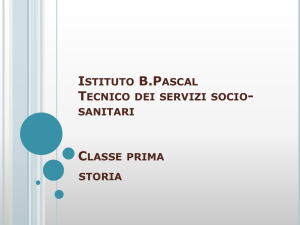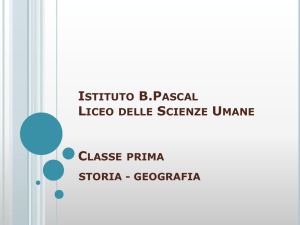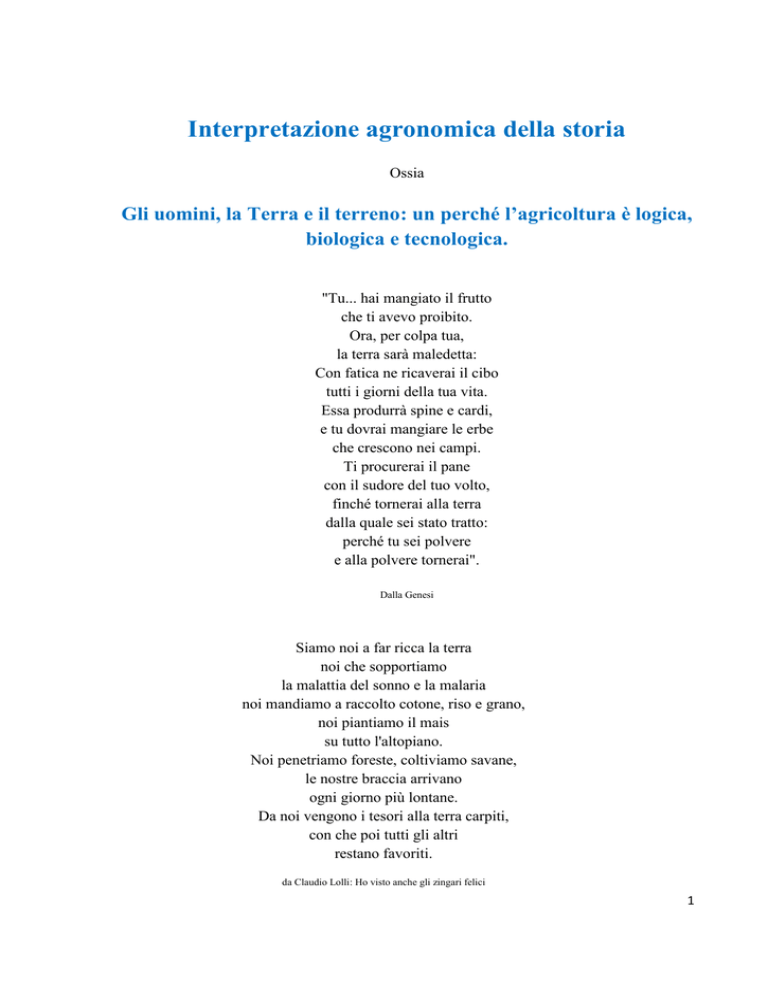
Interpretazione agronomica della storia
Ossia
Gli uomini, la Terra e il terreno: un perché l’agricoltura è logica,
biologica e tecnologica.
"Tu... hai mangiato il frutto
che ti avevo proibito.
Ora, per colpa tua,
la terra sarà maledetta:
Con fatica ne ricaverai il cibo
tutti i giorni della tua vita.
Essa produrrà spine e cardi,
e tu dovrai mangiare le erbe
che crescono nei campi.
Ti procurerai il pane
con il sudore del tuo volto,
finché tornerai alla terra
dalla quale sei stato tratto:
perché tu sei polvere
e alla polvere tornerai".
Dalla Genesi
Siamo noi a far ricca la terra
noi che sopportiamo
la malattia del sonno e la malaria
noi mandiamo a raccolto cotone, riso e grano,
noi piantiamo il mais
su tutto l'altopiano.
Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane,
le nostre braccia arrivano
ogni giorno più lontane.
Da noi vengono i tesori alla terra carpiti,
con che poi tutti gli altri
restano favoriti.
da Claudio Lolli: Ho visto anche gli zingari felici
1
Indice
Presentazione
3
Introduzione
8
Le Origini
11
Verso il Sapiens
12
Fuori dall'africa
18
L'uomo nuovo
29
La grande trasformazione
40
La prima alleanza
49
Verso l'agricoltura: la costruzione di una società mutualistica
59
La Terra, la terra e il terreno
73
Il nostro addomesticamento
76
Le piante Nutrici
83
La nascita delle Civiltà
92
La Terra coltivata
93
Il tempo delle biocenosi
105
L'Acqua e il Potere
113
Le civiltà fluviali
121
Regni e Imperi
139
Verso ovest
143
Roma
155
L'apice e il declino
167
Il tempo dei cavalli e dei cammelli
175
La genesi della civiltà del burro
191
L'orizzonte degli eventi
203
2
Presentazione
Questo è uno scritto che parla di noi uomini “sapientes” (ultima specie di Homo rimasta sulla Terra)
e di agricoltura; ossia quel sapere e quel saper fare che da circa 12-15.000 anni ci lega in forma
utilitaristica alla Natura e ci consente di indurre la Terra a produrre per noi il cibo che mangiamo, le
fibre e le pelli con cui ci copriamo ed altri prodotti d‟uso. E‟ un testo che si snoda lungo un percorso
tortuoso e complesso; inizia con l‟apparire sulla Terra dei primi individui della nostra specie,
prosegue fino al momento in cui i nostri antenati iniziarono a modificare coscientemente l‟ambiente
seminando e allevando, e arriva - seguendo le grandi trasformazioni vissute o indotte
dall‟agricoltura- fino ai giorni nostri. Produrre il cibo utile alla propria sopravvivenza? Che cosa
strana, in generale gli animali si alimentano del cibo che trovano –diventando, spesso, essi stessi
cibo - sotto l‟egida dominante delle leggi naturali che – condizionandone il numero- li commisurano
alle risorse alimentari disponibili. Gli uomini invece producono il loro cibo; così come fanno gli
insetti che gli entomologi chiamano: sociali (api, termiti, formiche). E non è chiaro se lo facciano
perché “sociali” o se “sociali” perché comunitariamente producono il loro cibo. Con una certezza:
lo fanno da alcuni milioni di anni, mentre noi abbiamo compreso come farlo solo da poche migliaia.
Prima eravamo una specie nomade, aggregata in piccoli gruppi che vivevano di caccia e di raccolta;
ora siamo una specie stanziale, capace di adattarsi ai mille e mille ambienti naturali del nostro
pianeta; tanto abile, nel modificarli a nostro vantaggio, da essere riusciti a colonizzare tutta la Terra.
Uomini e cibo, cioè il prodotto del coltivare, del pescare e dell‟allevare; un binomio che tra le
problematiche generali che riguardano le prospettive dell‟umanità dovrebbe essere al centro di tutte
le attenzioni (visto che nella storia mai siamo stati così tanti a mangiare) ma che nella realtà è
invece quasi ignorato. Viviamo in tempi di costante preoccupazione per la Natura; partecipi delle
giuste battaglie riguardanti i temi dell‟ambiente e delle mutazioni climatiche; turbati dalla futura
scarsità delle risorse idriche e dalla progressiva riduzione della biodiversità animale; allarmati
dell‟eccessiva impronta biologica che stiamo esercitando sull‟ambiente; con tutti i palinsesti
televisivi pieni di rubriche culinarie. Mentre i temi dell‟agricoltura vera e propria - ossia
quell‟attività che da alcuni millenni lega gli uomini, il cibo e l‟ambiente in una triade inscindibilequasi non si sente pronunciare parole, se non quelle che abbiano un taglio prettamente folkloristico
o nostalgico. Settore primario, viene chiamato sui testi di economia, ma nella realtà un ambito
produttivo che, dopo aver perso progressivamente d‟importanza economica, sembra essere scivolato
–nel dibattito sociale- tra le pieghe polverose del superfluo. Poco si parla di come il cibo si produce
e dei prodotti e delle forme che vengono usate per produrlo (pensate alle coltivazioni intensive degli
ortaggi in serra); dove lo si produce e rispondendo a quali logiche (pensate agli allevamenti in
batteria); e perché lo si produca in quel determinato modo e non in altri (pensate alla frutta e alle
verdure che non hanno più nessun sapore e che sono accessibili in tutte le stagioni o ai tanti alimenti
contaminati da antiparassitari, anticrittogamici o da ormoni). Si parla delle conseguenze che il
3
nostro modello agricolo induce sulla quotidianità della nostra vita e su quella dell‟ambiente naturale
solo nei momenti in cui –sui media- monta qualche scandalo alimentare; poi tutto tace di nuovo e
ritorna la nostra quotidiana anormalità. Abitanti di un mondo dove oltre la metà della popolazione
vive nelle aree urbane (è la prima volta nella nostra storia di uomini che succede in cosa del
genere), abbiamo perso la cognizione di quanto sia difficile e complessa l‟arte di prendersi cura
della Terra, affinché questa sia in grado di darci i suoi frutti; quasi immedesimando la produzione di
cibo a una delle tante attività industrializzate o all‟estrazione di risorse fossili dalla Terra. Ottusi,
forse, dal fatto di essere in grado di imbandire la tavola (quelli fortunati lo fanno tre volte al giorno)
per oltre sei miliardi di persone (più qualche decina di miliardi di animali chiusi negli allevamenti);
anche quando quella tavola è colma di cibo diventato solo merce, fonte costante di timore per i
consumatori più attenti e causa principale dell‟obesità che deturpa la vita di milioni di persone
collocati nelle fasce più deboli delle società ricche; colpevolmente incoscienti del fatto che la stessa
tavola è carente per più di un miliardo di persone che continuano a soffrire la fame o le carenze
alimentari. La fame! Una parola e un‟idea, che in questo tempo segnato dallo spreco, è oscena
anche solo da pronunciare, ma che per ragioni - da una parte economiche e ridistributive e dall‟altra
legate all‟ignavia sociale- gli uomini non sono stati in grado di relegare nel più profondo pozzo
della storia. Apparentemente dimentichi di quanto la storia umana sia segnata più dalla scarsità di
cibo che dalla sua abbondanza.
Questo perché -facendo salvi un numero crescente di agricoltori che si dedicano ad attente pratiche
agronomiche- l‟agricoltura di oggi è spesso una monocoltura di alta produttività e bassa qualità, che
induce la penuria in molti paesi non per inefficienza dei modelli alternativi, ma per il protezionismo
commerciale e il sostegno diretto e indiretto che i paesi ricchi fanno al loro modello produttivo e ai
prezzi dei propri prodotti agricoli.
Il vero e grande problema di questo modello d‟agricoltura: la sua sostenibilità! Legata come è
all‟uso massiccio delle risorse idriche, all‟utilizzo incondizionato di concimi chimiche e
antiparassitari, al depauperamento della naturale fertilità del terreno e alla totale insensibilità nei
confronti degli equilibri naturali; cosa sarà della produzione di cibo in un futuro prossimo quando
probabilmente verrà meno questa condizione di doping produttivo? E se non potrà essere questo,
quale sarà il modello dell‟agricoltura di domani? Come riusciremo ad affrontare i problemi
alimentari e ambientali di un mondo abitato da 10 miliardi di persone con le risorse fossili
(compresa la fertilità del terreno) declinanti? E a chi dovremmo demandare la discussione del
problema: ai tecnici? No, questa è una problematica di tale e complessa rilevanza che c‟è bisogno,
già ora, di trovargli un posto in prima fila nel dibattito sociale e politico e di coniugare i temi
produttivi con quelli etici e filosofici. E da dove può cominciare questo dibattito se non dallo
srotolarsi nel tempo della storia agronomica per capire come sia arrivati all‟oggi e immaginare
come potrà essere il domani?
Partendo proprio dalle domande su cui spesso sorvoliamo: perché ad un certo punto della nostra
storia evolutiva abbiamo scelto di arare la terra su cui per due milioni d‟anni abbiamo solo
camminato? Perché abbiamo cominciato a tenere vicino ai nostri rifugi gli animali a cui davamo la
caccia? Perché siamo gli unici mammiferi che lo fanno? Quanto l‟intensificazione della produttiva
agricola è legata alla nascita delle città (quindi alle civiltà)? E ancora: il declino delle grandi civiltà
4
è collegato al declino della loro agricoltura? Quanto potrà durare la guerra che da alcuni decenni gli
agricoltori hanno dichiarato alla Natura? Potranno, domani, i pochi agricoltori di oggi continuare a
sfamare il mondo? E‟ giusto continuare a sostenere questo modello ridistributivo apparentemente
“democratico” che scambia bassi prezzi alimentari con una bassa qualità dei prodotti?
Da parte mia, per cercare di dare alcune risposte a queste e a altre domande, proverò a raccontare
quale pensiero sta dietro la precisione ortogonale degli orti e dei filari, quali conseguenze ha indotto
il trasmigrare delle piante coltivate e degli animali da un continente all‟altro, come i modelli
agricoli si sono riorganizzati in base a questo girovagare; parlerò di cosa è successo all‟agricoltura
mondiale dopo la “scoperta” della chimica applicata all‟agricoltura, ma anche della logica illogica
che sta dietro l‟abitudine di irrorare di veleni i cibi che mangiamo. Parlando di questo in realtà
cercherò di parlare di quella strana e difficile relazione che ci lega alla parte più superficiale della
Terra: quella dove posiamo i piedi, quella dove l‟erba affonda le sue radici e dove siamo soliti
interrare i semi e far pascolare gli animali (quando pascolano!). Racconterò delle innovazioni che
l‟agricoltura ha introdotto nella nostra vita quotidiana e di come l‟uso di queste conoscenze abbia
influito sulla nascita e lo sviluppo delle diverse civiltà idrauliche, che – in fondo – altro non sono
che il frutto delle modifiche nel rapporto tra gli uomini che le hanno fondate e la Natura che le ha
accolte o sopportate. Proverò insomma a riflettere sulla nascita e sullo sviluppo di quest‟arte così
tipicamente umana che –al di là dei tanti problemi- ha regalato e regala alla Terra alcuni dei suoi
volti più belli.
L‟idea di questo scritto è nata molti anni fa, quando - leggendo libri che si occupavano di storia mi è parso di notare come spesso mancassero di una angolatura visuale che consentisse di leggere
un‟epoca, una civiltà, l‟identità di un popolo anche attraverso le forme e i sistemi di coltivazione e
di allevamento. Eppure quante civiltà sono fiorite (notate il rimando agronomico del termine) nel
corso della storia, e nessuna di queste avrebbe potuto farlo senza il contributo significativo di una
florida agricoltura. Certo sono esistiti anche imperi nomadi; ma come diceva Genghis Khan: “gli
imperi si conquistano a cavallo ma si governano seduti”. Seduti intorno a tavole dove non doveva
mancare il cibo, verrebbe da dire!
Così ho provato a immaginare come sarebbe stato il percorso della nostra storia di uomini se avessi
provato a leggerlo attraverso le lenti focali dell‟agronomia e, subito, si è aperto uno spettacolare
panorama di spunti e di interpretazioni originali; non perché nella storiografia mancassero studi
specifici, anzi! Questa però non voleva essere una ennesima storia dell‟agricoltura, ma una
“Interpretazione Agronomica della Storia”; ossia un modo originale di vedere e di raccontare la
storia umana.
Una storia dell‟agricoltura è seguire il pensiero attraverso i fatti; parla dell‟evoluzioni scientifiche e
tecnologiche e di come questi cambiamenti abbiano modificato il rapporto tra gli uomini e la Natura
che li circondava. Una interpretazione agronomica è seguire i fatti attraverso il pensiero; parla di
come è cambiato l‟uomo e di come questo cambiamento ha modificato il nostro stare nella Natura.
Parlare di storia agricola è guardare indietro con gli occhi di chi oggi la racconta, interpretare la
storia agricola è lo stesso, ma guardando indietro grazie a uno specchio, uno specchio dentro il
quale anche noi siamo riflessi. Capite cosa intendo con questo? Parlando di agricoltura noi parliamo
5
di Natura e noi non siamo estranei ad essa, noi siamo una parte del tutto. I nostri gesti cambiano le
cose intorno a noi, ma cambiano anche noi che li compiamo o li abbiamo compiuti. Perché noi
siamo interni all‟immagine che la storia ci riflette!
Facile a dirsi; ma mentre m‟immergevo in questa ricerca sentivo che il compito diventava sempre
più improbo e spigoloso, lievitava in temi che si contrapponevano o si sovrapponevano
sbarrandomi la strada con continue difficoltà. Cominciando dalla “conditio sine qua non”, il santo
Gral di tutte le domande: perché da nomadi cacciatori e raccoglitori siamo diventati agricoltori?
E‟ così che sono passati gli anni, anni condivisi con questo tarlo che silenziosamente continuava a
lavorare nel cervello, tanto che viene da chiedersi: ci possono volere più di trent‟anni per iniziare a
scrivere un libro? Certo che sì. A pensare che lo svolgersi del testo era lì, in bella mostra nella mia
testa, capitolo dopo capitolo, affermazione dopo affermazione. Ma come si fa a scrivere una storia
se non si sa come quella stessa storia ha avuto inizio? Così per anni ho percorso un labirinto di
specchi: trovavo uno spunto, magari da un articolo, facevo alcuni passi che sembravano significativi
ed – ecco- il percorso si bloccava, era solo un altro vicolo cieco che mi distoglieva e m‟illusionava,
un caleidoscopio di speranze che -a una breve analisi critica- svanivano miseramente o non
servirono ad andare oltre. Per anni ho cercato una porta, un chiarore nella foschia che mi ovattava la
mente, ho barcollato senza trovare risposte. Alcuni passaggi sul perché e sul come eravamo
diventati agricoltori li avevo già netti nella mente: già deframmentati, destrutturati, accumulati e
riorganizzati, già chiari nel loro svolgimento, ma per tanto tempo mi è sempre mancato l‟inizio: il
perché e il come abbiamo cominciato a asservire gli animali che prima cacciavamo e a lavorare la
terra per arrivare a trarne il cibo con il sudore e la fatica del lavoro? Noi: l‟unica specie di
mammiferi che lavorano per vivere e vivono per lavorare, era questo apparente non senso che
continuava a sfuggirmi.
Poi, lentamente la nebbia sembra essersi diradata, fino a permettermi di intravedere nella mia testa
degli appigli che non avevo mai notato, poi dei collegamenti, poi delle nuove elucubrazioni. Come
spesso succede non sono stati i testi scientifici ad aprire le finestre che hanno dissolto la nebbia. I
testi specializzati sono i tronchi e i rami di un‟idea, ma – per fare un albero – ci vogliono foglie e
fiori. Così le foglie e i fiori sono arrivati da articoli di giornale, da chiacchiere con gli amici e poi
dalla lettura di alcuni testi divulgativi o filosofici o, forse, dal penetrare a fondo in un‟età matura
dove gli orecchi ascoltano più di quanto gli occhi vedano.
E così eccomi a riprendere le fila di un‟idea che era nata trent‟anni fa da uno scritto di Josè Ortega y
Gasset che si chiamava: “L‟Interpretazione Bellica della Storia”. Fu dopo aver letto quel saggio che
pensai che sarebbe stato bello scrivere del percorso degli uomini sulla Terra visto attraverso la
nascita e lo sviluppo dell‟agricoltura, fino ad immaginare di poter scrivere un contrappunto
agronomico alle riflessioni che il filosofo spagnolo aveva fatto sulla lotta e sulla guerra.
Maledizione! Non sapevo ancora in quale ginepraio mi ero cacciato.
Così – da un po‟ di tempo- ho cominciato a delineare i primi capitoli di questo scritto e poi a
riempire i contenitori vuoti dei vari capitoli, ma ecco che questo lavoro grezzo si suddivideva nella
mia testa in una specie di blob in continua mutazione e trasformazione. Fino a che ho capito che
ogni capitolo stava diventato una storia, un testo nel testo. Allora mi sono rilassato; altro non c‟era
6
da fare che prendere il blocco d‟idee e trattarlo come si fa con l‟ammasso di acqua e farina quando
si vuole stendere una sfoglia: prenderlo, cominciare a impastarlo, manipolandolo in continuazione,
per poi lavorarlo come con il mattarello, tirarlo per un lato, avvolgerlo e passarlo di nuovo sotto il
cilindro di legno fino a farlo diventare più sottile, e ancora più sottile e elastico, flessibile e
malleabile. Fino ad arrivare a quel prodotto artistico e sublime che è una sfoglia fine e liscia stesa
sulla spianatoia. Quello che troverete è il risultato di questo difficile ma divertente lavoro.
Intramezzati alle cose che ho scritto (di cui mi assumo la piena e totale responsabilità) ho aggiunto
dei paragrafi che troverete colorati in rosso. Alcuni di questi –sempre trovati in rete- sono estratti
dagli scritti di altri autori (che spero di aver sempre correttamente citato), anche se la maggior parte
sono presi dalla versione italiana di Wikipedia e da me rielaborati in parte per adattarli a questo
scritto. A questa straordinaria esperienza enciclopedica va tutto il mio personale ringraziamento,
oltre alla piena condivisione degli intenti, perché sono dell‟idea che il sapere o è condivisione o non
è nulla e che il libero accesso alle informazioni e alla conoscenza è uno degli strumenti più
importanti di cui la nostra specie dispone.
7
Introduzione
Visto con gli occhi degli uomini comuni la storia dell‟evoluzione della nostra specie appare come
un tracciato vittorioso; un percorso lineare che va dal primitivo, dall‟arcaico, verso il complesso e il
moderno. Se lo stesso percorso lo guardiamo con gli occhi di un credente in questa linearità
possiamo vedere il progetto di una Mente superiore, capace di guidare una specie eletta attraverso le
difficoltà che gli sono frapposte dalla Natura, dopo che - per colpa del peccato originale- ha perso
l‟accesso ad un mitico giardino dell‟Eden. Questo è quello che gli uomini hanno creduto di se stessi
guardando alle gesta e al pensiero delle generazioni che li hanno preceduti.
Anche quando il grande dibattito ottocentesco sull‟evoluzione, seguito agli studi e alle
pubblicazioni delle grandi figure del positivismo scientifico, ha intaccato il principio del Massimo
Fattore come progettista e guida dei passi degli uomini (congiuntamente al concetto di averli creati
con il compito di controllare il mondo), mai si è messo in dubbio la linearità del nostro procedere.
Solo nell‟ultima metà del secolo scorso all‟idea di un percorso fatto di un susseguirsi di eventi
ordinati si è contrapposta un‟altra teoria, la cui rappresentazione grafica non è più un albero dal cui
tronco si sono staccano tanti rami, ma un cespuglio dal quale non si distingue la direzione
principale. Per gli uomini di fede non è difficile – anche in questo caso – vedere l‟opera della ferma
mano di Dio, mentre per i laici – portatori di concetti come la pressione selettiva o la selezione
naturale - la definizione di un percorso ha iniziato ad appoggiarsi su concetti sempre più complessi
fino ad arrivare ad oggi e allo studio della teoria del caos.
In questo labirinto di pensiero, in questo campo paludoso dove a ogni passo si corre il rischio di
essere bloccati nel fango, se non addirittura di scomparire nelle sabbie mobili di conoscenze in
continua ridefinizione, proverò a elaborare un mio personale contributo - non certo sull‟evoluzione
della nostra specie (quella la lascio ad altre e più alte menti accademiche) ma sulle ipotetiche
ragioni che hanno portato gli uomini a coltivare la stessa terra su cui avevano camminato per alcuni
milioni di anni, fino a trasformarsi - unico mammifero tra pochi insetti - in produttore del cibo con
cui si alimenta, nonché allevatore di altre specie. Cercherò – in definitiva – di ragionare sul tema
dell‟agricoltura e dell‟allevamento: probabilmente l‟attività più caratteristica della nostra specie;
quella che ci permette di sostenere un modello di vita “comunitario” basato su strette alleanze con
altre specie vegetali e animali.
Ovviamente molteplici e contrapposte sono le interpretazioni sul come e sul perché gli uomini siano
diventati agricoltori e abbiano reso “domestici” alcuni degli animali che avevano cacciato per tante
migliaia di anni. Ma su un punto tutte le opinioni concordano; questa grande trasformazione è
avvenuta più o meno contemporaneamente in diverse parti del mondo in un arco di tempo
relativamente ristretto che va dai 12 ai 10.000 anni fa, e che ciò ha rappresentato il passaggio più
importante della nostra storia evolutiva. Che spiegazioni si sono date a questo straordinario
fenomeno?
Alcune teorie affermano che tutto è legato alla necessità di rispondere agli aumentati bisogni
alimentari di una popolazione in continua crescita, ma i demografi possono spiegare che
difficilmente si riscontra una crescita se presupponiamo che la popolazione soffra di carenza
8
alimentare; altre ritengono che sono stati i cambiamenti climatici e condizionare la scelta di
abbandonare lo stile di vita nomade; altre che esisteva negli uomini una voglia innata di
sedentarizzazione. Tutte comunque –pur non essendo in grado si spiegare il perché- concordano che
l‟agricoltura e l‟allevamento sono state delle applicazioni – in forme, gesti e pensieri- di un progetto
umano di portata e valore straordinario! Un‟illuminazione folgorante che altro non è che la degna
risposta all‟imperativo del Dio biblico: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la Terra;
soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che
striscia sulla terra».
Se questo è quello che noi pensiamo che il Dio cristiano ci abbia detto o ordinato (occorre però
aggiungere che non tutte le religioni hanno un Dio così categorico), non è difficile capire il perché
la specie umana assegni alla nascita dell‟agricoltura uno altissimo valore simbolico positivo; il vero
snodo su cui si imperniarono la “civiltà” e la “civilizzazione”, in contrapposizione alla paura
dell‟occasionale, all‟oscurità enigmatica delle caverne, al vagare perpetuo per procacciarsi il cibo.
Solo negli ultimi decenni alcuni autori hanno iniziato a chiedersi se questa idea positivistica del
percorso degli uomini sulla Terra poggia su solidi riscontri scientifici. Si è appurato così che gli
uomini del paleolitico (quindi pre-agricoli) erano mediamente molto più alti di noi (li abbiamo
raggiunti in altezza solo nell‟ultimo secolo), che vivevano molto più a lungo di noi (anche in questo
siamo arrivati a uguagliarli da poco più di un centinaio di anni), che avevano un‟arte figurativa
strabiliante (torneremo su quest‟aspetto in seguito) e capacità cognitive insuperabili (vedremo –
invece – quest‟aspetto tra poco); che facevano del gioco e della socializzazione la base della loro
umanità, anche perché dedicavano all‟approvvigionamento alimentare (caccia e raccolta) solo
poche ore al giorno o pochi giorni all‟anno (in alcuni studi realizzati in Medio-oriente, si è visto che
un paio di settimane di mietitura del grano selvatico, erano sufficienti ad accumulare il fabbisogno
di cereali, quindi di energia, necessario a un nucleo famigliare per l‟intero anno).
Perché, in realtà, ripulendo questi argomenti dalle sovrapposizioni culturali che abbiamo aggiunto a
posteriori, coltivare la terra è fondamentalmente e imprescindibilmente un atto inusuale e
costrittivo; quasi una forma di aberrazione a cui i nostri antenati hanno piegato la nostra specie. Un
atto che probabilmente mai si sarebbe potuta affermare senza una serie sorprendente di concause
nelle quali – noi umani – siamo in parte protagonisti e in parte figuranti secondari.
Anche oggi tutti gli studiosi concordano che essere dei semplici raccoglitori e cacciatori è molto
più funzionale in termini di energia spesa per assicurare l‟esistenza della specie (che è il vero e
unico imperativo cui tutti gli animali –compreso noi - sono chiamati a sottostare). Per fare questo
basta inserirsi in una relazione di equilibrio con il bioma circostante e rimanere nella propria nicchia
ecologica, anche se quella nicchia sottintende, raccogliere, predare, cacciare con la consapevolezza
di poter essere anche prede. Questo è quello che fanno tutti gli esseri viventi di questo straordinario
insieme che noi chiamiamo ”Terra”, un posto regolato da leggi che solo ora cominciamo a
comprendere, un luogo dove la stabilità dinamica dell‟ambiente è al di sopra e al di fuori degli
individui che vi sono inseriti e all‟interno del quale svolgono la loro esistenza; un luogo dove tutte
le specie trovano un equilibrio (anch‟esso dinamico) e si riproducono in relazione a questo
equilibrio.
Ma in Natura non esiste solo questa forma di equilibrio basata sulla predazione, perché api, termiti o
formiche (quelli che vengono definiti insetti sociali), devono il loro successo biologico a complesse
forme di cooperazione anche interspecifiche. Infatti queste specie possiedono una raffinata arte
9
agronomica che li ha portate a stringere strette alleanze con diverse specie di funghi che coltivano
nei loro giardini sotterranei, o con altre specie di insetti (cocciniglie e afidi) che allevano e
mungono nei loro nidi. Questi insetti hanno strutture gerarchiche piramidali molto più rigide di
quelle umane, possiedono una ferrea divisione del lavoro e come gli uomini costruiscono
architetture mirabili (i nidi delle termiti), o perfette (le celle esagonali per allevamento delle pupe).
In questa loro opera faticosa e costante però niente sembra collidere con le leggi che regolano la
Natura, a differenza di noi uomini che siamo diventati quello che siamo proprio grazie alla capacità
di modificare la Natura a nostro vantaggio (questa –più o meno- è l‟idea che noi abbiamo avuto di
noi stessi prima che si manifestassero i “limiti” ambientali di questo nostro atteggiamento mentale e
comportamentale).
Con questo scritto proverò ad inserirmi in questo complesso dibattito portando all‟attenzione un
punto di vista nuovo, sostenendo cioè che questa nostra capacità di modificare l‟ambiente per
passare alla produzione programmata di cibo è la conseguenza di una agglutinazione comunitaria
del nostro modo di vivere (che come alcuni insetti ci ha trasformati in un animale “sociale”) e non
corrisponde ad un progetto elaborato grazie alla nostra fantasia, o legato ai nostri bisogni di specie
(ossia a carenze alimentari), né all‟ indole, né ad una innata capacità elucubrativa (tutti concetti che
fanno pensare ad un essere eletto, e che sono la conseguenza di una ascientifica forma di
antropocentrismo), ma è la risultanza di un insieme di eventi naturali particolarmente complessi che
ci hanno coinvolti e sconvolti e di cui noi Sapiens non siamo gli unici protagonisti!
Vederci come coprotagonisti e non attori solitari cambia l‟angolo visuale delle cose, supera il nostro
innato bisogno di essere al centro della scena (che è una lente focale che deforma da tanto tempo il
nostro sguardo) e ci consente di analizzare il problema dell‟addomesticamento vegetale, animale e
umano (perché l‟agricoltura –quindi la necessità di pianificazione- ha addomesticato noi per primi)
con una visione multifocale: quella più consona per cercare di capire gli eventi.
Questo è quello che mi prefiggo di fare con questo scritto e il farlo mi diverte, mi stimola e mi
spaventa. Spero di farlo con lucidità e senza noie e spero che voi lettori possiate trovare il mio
ragionare sensato e lineare, anche quando sarete in parziale o totale disaccordo con quello che
comincerò a raccontare.
10
Le Origini
Prima della storia, quante storie da raccontare
11
Verso il Sapiens
Nell‟iniziare questo percorso cronologico attraverso il nostro tempo umano sorvolo sulle varie
teorie che si sono succedute e su quelle che oggi si contrappongono nel tentativo di dare una
interpretazione risolutiva alla storia filogenetica del genere Homo; sono troppo complesse, troppo
soggette a cambiare repentinamente a seguito di nuovi ritrovamenti fossili e – in fondo – troppo
lontane da quello che vuol essere il nocciolo della questione: la nostra storia di agricoltori.
Inizieremo invece il nostro racconto dall‟apparire in Africa circa 200.000 anni fa di una nuova
specie del genere Homo: l‟Homo sapiens, a cui noi apparteniamo, ultima e unica specie di Homo
rimasta sulla Terra dopo l‟estinzione di diverse branche del suo cespuglio evolutivo e a oggi - più
o meno lontanamente- imparentata con alcune specie di grandi scimmie tuttora viventi.
Partiamo dalle certezze che non sono in discussione: circa 200.000 anni fa la Terra si trovava nel
pieno di una ennesima e imponente glaciazione, quella che chiamiamo del Riss (300.00 – 130.000
anni fa), che fu così vasta da coprire entrambi i poli di una imponente calotta glaciale e che si estese
con appendici significative sui Pirenei, le Alpi, i Balcani, il Caucaso e gli Urali (solo per parlare di
una parte dell‟Eurasia). Conseguenza di questa glaciazione fu il ritirarsi dei mari e il progressivo
inaridirsi del clima su tutte le terre emerse (una parte dell‟acqua era sequestrata in forma solida dai
ghiacci). Molti esseri viventi che avevano prosperato nel periodo precedente incontrarono severe
difficoltà a adattarsi al mutato regime climatico, tanto da essere costretti a ritirarsi, a mutare o a
sparire. L‟ampiezza del fenomeno e la continua fluttuazione degli eventi portarono alla formazione
di ampie ed instabili nicchie ecologiche che furono colonizzate da piante e da animali capaci di
adattarsi ai nuovi regimi climatici. Anche le varie specie di Homo che vivevano sulla Terra furono
coinvolte dal succedersi di questi eventi; così, collegate più o meno direttamente con la glaciazione,
apparvero (o si consolidarono) alcune mutazioni che rivoluzionarono il genere Homo: il neanderthal
(quel nostro cugino così tanto idealizzato), il sapiens (cioè noi), il floresiensis (il piccolo uomo i cui
resti fossili sono stati rinvenuti sull‟isola di Florens in Indonesia e che oggi appare come un
interessante enigma biologico) e l‟enigmatico Denisoviano (la cui esistenza è in attesa di nuove e
ulteriori conferme); uomini che per un periodo convissero tra loro e con le specie che li
precedettero, per poi gradatamente sostituirle ed essere a loro volta sostituiti.
Noi, uomini contemporanei, siamo comparsi in qualche parte dell‟Africa orientale intorno ai
200.000 anni fa (i primi ritrovamenti sono in Etiopia) più o meno negli stessi luoghi dove – secondo
le principali teorie filogenetiche- già due milioni e mezzo di anni prima si erano evoluti i primi
individui del genere Homo (l‟Homo habilis); come a ribadire, con un‟ulteriore conferma, che quella
parte dell‟Africa è stata la matrice del nostro genere e non solo della nostra specie (tesi comunque
non da tutti condivisa). La mutazione che ha portato alla comparsa del sapiens, in quell‟area
geografica coincise con la riduzione delle foreste, sostituite da un manto di piante erbacee perenni,
con il conseguente estendersi delle savane a danno della copertura forestale; l‟ambito naturale
perfetto per le grandi mandrie di erbivori, seguite dai carnivori necessari per mantenere un corretto
12
equilibrio ecologico, più tutti gli altri philum vegetali e animali: insetti, rettili, uccelli, fino ai
microbi che trovarono confacente quella nuova tipologia ambientale.
La riduzione del manto arboreo produsse anche un altra conseguenza: le foreste non sono un
ambiente unitario ma un insieme complesso e variegato di microambienti naturali in equilibrio e in
relazione tra loro (pensate quanta diversità biologica alberga in una foresta pluviale tra la volta
arborea e la vita a livello del suolo 40-50metri più in basso). Da questa pluralità di ambienti deriva
una ampia biodiversità: migliaia di specie ciascuna presente in un numero relativamente limitato di
individui e in ambiti ecologici ristretti. Nella savana la biodiversità è minore, ma la maggior
omogeneità biologica assicura uno spazio a un numero più alto di individui di ogni specie. Come
dire che un arbitro aveva facilitato alcuni dei presenti (sapiens compreso) espellendo un gran
numero di giocatori. Chiaramente ognuno è libero di farsi un‟idea sulla reale identità dell‟arbitro!
L‟ipotesi di far coincidere molte mutazioni genetiche con dei cambiamenti significativi dell‟habitat
è ad oggi un archetipo del pensiero legato alla selezione naturale e io a quel concetto mi attengo (
sebbene trovi che ci siano aspetti ancora da chiarire) anche se non posso fare a meno di pensare alle
tante mutazioni fallite prima che l‟insieme dei tratti che caratterizzano noi Sapiens sia stato
acquisito e consolidato nell‟Africa orientale di migliaia di anni fa.
Noi tendiamo a considerare la vita come un evento statico e ci preoccupiamo o sorprendiamo dei
cambiamenti, ma in Natura mutare non è un‟eccezione, è la norma. Nuove mutazioni si presentano
in ogni momento senza che si riesca ad avvertirle e senza che esse lascino tracce significative sulla
storia evolutiva. Le mutazioni sono individuali e quasi sempre vengono rigettate al momento della
scomparsa dell‟individuo stesso. Alcune possono essere acquisite all‟interno di un genere ma
codificate come espressioni minoritarie: possono essere morfologiche come il nanismo, l‟albinismo,
etc. o fisiologiche come il favismo. Alcune di queste le consideriamo benevolmente come la quarta
appendice del quadrifoglio, altre le chiamiamo “malattie genetiche” e come tali le consideriamo.
Ma in Natura non esiste il concetto di malattia genetica, casomai si potrebbe dire che esiste (in
alcuni casi) quello di strategia e non sempre una strategia naturale coincide con il nostro pensiero
limitatamente umano. Le persone affette da favismo sono molto più resistenti alla malaria e quindi
molto più attrezzate a vivere e colonizzare alcuni ambienti specifici. Se il clima diventasse più
umido e le zanzare proliferassero, indirettamente questa mutazione sarebbe favorita. Ugualmente se
il sole fosse offuscato per centinaia di anni da una spessa coltre di nubi (ammesso che la vita come
la conosciamo potesse sopravvivere) il mondo sarebbe il posto ideale per gli albini, i quali
sarebbero in grado di rispondere meglio all‟assioma: la mutazione propone, la Natura dispone! Che
poi è come dire che la Natura procede non lungo un solco prestabilito ma più semplicemente per
esclusione.
Questo è un discorso davvero complesso e che ci vede del tutto coinvolti - perché a ben guardarele mutazioni che hanno portato alla nostra affermazione erano piene di aspetti contorti e
contradditori. Il sapiens aveva ulteriormente perso la copertura di peli e questo lo esponeva
maggiormente a ferite e escoriazioni e alle intemperanze dei raggi del sole (ulteriore ragione del
perché noi sapiens siamo nati neri); aveva acquisito un portamento più eretto, ma a scapito della
capacità di arrampicarsi sugli alberi e districarsi sui rami per sfuggire ai suoi predatori (una delle
13
forme di difesa di molte scimmie); aveva ridotto la dentizione e l‟intestino cieco, che è la parte
dell‟intestino deputata alla digestione della cellulosa (diventato soltanto una “appendice”). Questo
aspetto costrinse il sapiens a modificare la sua dieta (o fu il contrario?), perché con la riduzione del
cieco molte foglie (non più presenti nella savana) erano diventate ormai indigeribili; ma in Natura
perdere la propria specializzazione alimentare –quindi trasformarsi in onnivori- non porta sempre
degli svantaggi!
Il sapiens aveva anche aumentato il volume del proprio cervello, una mutazione che comporta un
considerevole aumento del consumo energetico da destinare al funzionamento del cervello stesso.
Questo cambiamento così impegnativo ebbe sicuramente molte difficoltà fisiologiche ad affermarsi,
ma visto i risultati a posteriori, fu certamente favorito dall‟ampliarsi dell‟offerta alimentare sia
quantitativa che qualitativa che ne facilitò il consolidamento. A queste varianti c‟è da aggiungere
una trasformazione della laringe, conseguente alla modifica della postura del tronco e della testa.
Probabile e indiretta conseguenza di quest‟ultimo cambiamento funzionale è stata quella di una
migliore possibilità di fonazione; così che la vocalizzazione (conseguente all‟aumento di fonazione)
si è potuta unire all‟aumento dell‟elaborazione del pensiero (conseguente all‟aumento del volume
celebrale), arricchendo la specie di due aspetti che sono diventati anch‟essi un arma potenziale in
uso ai nostri antichi antenati.
A tutto questo va aggiunto un altro aspetto non legato alla fisiologia del corpo adulto ma a quella
della sviluppo infantile. Il sapiens è una specie che nasce prematura (tecnicamente siamo una specie
neotenica), non certo come un marsupiale che arriva al mondo come un piccolo feto del peso di
pochi grammi, ma comunque con caratteristiche distinte dalla maggior parte degli animali (specie di
quelli che sono delle potenziali prede) che sono in grado di arrivare all‟autonomia nel giro di pochi
giorni o di poche ore. Questa caratteristica, che deriva dalla riduzione del canale del parto per via di
una diversa disposizione delle ossa del bacino -conseguente alla postura eretta e all‟aumento del
volume del cranio dei neonati- ha molti risvolti, alcuni dei quali apparentemente negativi: il
cucciolo di uomo deve essere accudito e allattato dalla madre anche per anni, inizia a camminare
solo dopo dodici mesi, inizia a vocalizzare più o meno nello stesso periodo, ma parla (una volta
acquisita questo imprinting culturale) dopo quasi due anni, raggiunge la capacità riproduttiva dopo
l‟adolescenza e matura le sue potenzialità fisiche solo dopo i vent‟anni. Legato a questo lento
processo di crescita c‟è – in contrappunto – una marcata longevità, fenomeno che fa sì che l‟uomo
sia uno degli animali – dell‟intera sfera zoologica- che vive più a lungo.
Anche se all‟epoca della comparsa e consolidamento di tutte queste mutazioni fisiche - l‟arma più
efficace si dimostrò l‟aumento della facilità di enartrosi (il movimento rotatorio delle articolazioni
della spalla e dell'anca), una modifica che ci ha consentito di tirare sassi e lance con più forza e
all‟anca di correre più velocemente e di deambulare (camminare) con più facilità (da sempre la fuga
è il più diffuso sistema di difesa).
Glabri, longilinei, privi di pronazione e con una dentizione adatta ad una dieta onnivora questi
nostri antenati hanno saputo adattarsi con malleabilità a un ambiente dove la primogenitura della
catena alimentare era ancora contesa tra i felini (leoni, leopardi), i canidi (lupi, licaoni, sciacalli) o
gli orsi, e dove gli erbivori erano prede e le acque erano dominate dai grandi rettili o dagli
14
ippopotami. In quella complessa catena alimentare i nostri antenati si collocavano circa in mezzo,
forse in un mezzo superiore, anche se c‟è da dire che – visto il successo biologico a posteriori –
quella collocazione li metteva evidentemente in grado di utilizzare a pieno i prodotti della savana;
contrastando le iene e alcuni uccelli nella funzione di animali spazzini; cacciando nidi e piccole
prede; raccogliendo insetti, larve e prodotti vegetali e cacciando roditori e altri onnivori come i
cinghiali e i facoceri, predati da giovani, perché da adulti il discorso diventava più complesso. In
realtà l‟aver abbandonato una dieta quasi esclusivamente erbivora -che è quella dei gorilla- aveva
comportato l‟acquisizione di atteggiamenti aggressivi –legati alla predazione - che esulavano dalla
sola difesa del branco e del territorio.
In genere gli studiosi hanno visto nell‟aumento del cervello lo strumento principe dell‟affermazione
del sapiens, collegando l‟aumento del volume celebrale con l‟evoluzione della mano, ma pochi sono
quelli che hanno speso parole sui piedi, la nostra mutazione più complessa (tanto che i nostri parenti
scimmieschi hanno quattro arti prensili ma non hanno i piedi), più bistrattata e sottovalutata.
Chiaramente i piedi si erano già affermati con l‟emergere del genere Homo, ma con i sapiens sono
arrivati alla loro funzione anatomica attuale; quei piedi che sono il nostro tratto fisico più
caratteristico perché -senza rendercene ben conto- sono stati proprio loro a trasformarci in un
animale ibrido, mezzo arboricolo e mezzo terricolo e anche mezzo anfibio (siamo gli unici
discendenti delle grandi scimmie che hanno familiarità con l‟acqua). Queste caratteristiche di
animali ibridi fanno il paio con le nostre modalità alimentari: mezzi carnivori e mezzi erbivori.
Come dire: di tutto un po‟, che è il nostro tratto più particolare.
E‟quel “di tutto un po‟“che ci permette di salire sugli alberi quasi come fossero scimmie, di
camminare in terra meglio dei plantigradi e correre con una buona accelerazione iniziale, anche se
con poca resistenza, o di nuotare anche se in modo meno fluido di un delfino; cosa che ci ha
consentito di avventurarci sull‟acqua galleggiando su zattere e tronchi (siamo gli unici animali a
sangue caldo che scientemente usano il galleggiamento come navigazione). A questi tratti va poi
aggiunto la relativa poca paura del buio – pur non essendo noi animali notturni – che ci ha permesso
di esplorare caverne e grotte, ottime come rifuggi. Verrebbe quasi da dire: l‟uomo, un vero pout
pourrì biologico!
Certo il sapiens non veniva dal nulla. La sua attraversata nel tempo fino alla nostra
contemporaneità è stata scandita da diversi momenti topici. In primis avevamo trovato un grande
alleato: il fuoco (questo era avvenuto circa 400.000 anni fa), poi avevamo già elaborato tecnologie
complesse come picche e asce, lame in pietra, trasformando in utensili quello che la Natura ci
offriva: rami, pietra e ossa; mentre da generazioni costruivamo giacigli con le erbe della savana e
rifugi sugli alberi coperti con steli contro la pioggia, così come ancora fanno gli altri primati che
vivono nelle zone di foresta pluviale. Non sappiamo invece se già intrecciassimo gonnellini da
legare ai fianchi, perché è improbabile che ci fosse una percezione del pudore. Per 100.000 anni la
savana fu il nostro habitat naturale e all‟interno di essa avevamo trovato una equilibrata
collocazione: predati ogni tanto e predatori ogni volta che potevamo. In fondo – da come la storia
si stava sviluppando - una volta arrivati al massimo dell‟espansione numerica la savana poteva
diventare a suo modo la nostra prigione. Poteva, ma è successo esattamente il contrario. Perché!
15
Intorno ai 100.000 anni fa (dopo aver probabilmente occupato una buona parte del nostro areale
originario di riferimento) la nostra specie si trovò davanti ad un dubbio: fermarsi o andare oltre?
“Hic manebimus optime”, avrebbero potuto dire i nostri antenati, e forti e compiaciuti del loro
successo biologico accettare di diventare una specie endogena di quello specifico territorio che
tuttora è rappresentato dalle savane. Avrebbero potuto utilizzare la connessione tra testa e mani (che
come abbiamo detto per alcuni autori è alla base del pensiero umano e della comunicazione) per
incrementare ulteriormente la loro pressione ecologica e diventare una delle specie dominanti di
quella parte d‟Africa e lì fermarsi. Invece dalla savana siamo usciti; perché?
Gli animali migrano; lo fanno gli uccelli per spostarsi ad altre latitudini talvolta fino all‟altro
emisfero, lo fanno gli insetti e anche i mammiferi per cercare aree di pascoli freschi, e questo
migrare risponde a un progetto preciso e ciclico: cercare spazi adatti per nidificare o per partorire e
allevare i cuccioli. Oppure gli animali fuggono: da carestie, da cataclismi naturali, dal fuoco, ed è
uno spostarsi caotico, disperato e senza meta. Qualche volta ci si sposta perché si sono scoperte
nuove fonti di cibo, magari accessibili con un cambio della strategia alimentare (come hanno fatto i
gabbiani che in pochi decenni hanno conquistato gli spazi urbani e iniziato a saccheggiare gli avanzi
alimentari prodotti da noi umani); altre volte si migra solo per rispondere alla necessità zoologica di
ridurre la pressione ecologica sul territorio magari davanti a un temporaneo cambio della piovosità,
e in quel caso si è nomadi e senza una meta sicura.
Ma pochi sono gli animali che vanno, specie se il loro andare li porta ad uscire dalla loro nicchia
ecologica! Ecco i nostri antenati hanno fatto questo, sono andati! Rispondevano a input che
spingevano alla ricerca, alla esplorazione, al bisogno di confrontarsi con nuove sfide o sfide in
nuovi ambienti (ossia andavano per curiosità intellettuale)? In questo andare oltre possiamo
rintracciare un tratto già umano? Forse sì ! Forse andarono proprio solo per una innata attitudine nel
guardare un poco più in là, nel cercare un poco più oltre; perché la curiosità e il desiderio di dare un
senso alla nostra vita accumuna i sapiens di oggi già a quei primi individui della nostra specie
apparsi sulla terra 200.000 anni fa. O forse questo è quello che a noi piace pensare di questi lontani
antenati, come se da ciò derivasse un aspetto di nobiltà biologica acquisita che differenziava già
allora la nostra specie da tutte le altre, e in questo c‟è un ingenuo atto di presunzione che ha poco a
vedere con una attenta teoria scientifica.
Ma in fondo viene anche da pensare che anche questo sia solo un dubbio solo retorico; in fondo
perché e come avrebbe potuto fermarsi in una sola e specifica nicchia ecologica una specie di
primati il cui tratto più caratteristico sono i piedi? Sarebbe un venire meno alla sua stessa ragione
fisiologica di esistenza (in fondo non lo avevano già fatto gli ominidi precedenti il genere Homo? E
non lo avevano già fatto gli habilis due milioni d‟anni fa, prima ancora che il cervello raggiungesse
le dimensioni caratteristiche dei sapiens?). La nostra è una specie nomade per suggerimenti fisici e
comportamentali. Quindi esplora perché è nella sua natura farlo, perché come specie
intrinsecamente rigetta le barriere biologiche con cui la Natura irretisce la maggior parte delle altre
specie animali e vegetali; con quello stesso atteggiamento –evidentemente- con cui rifiuta confini
fisici e culturali! Va perché i suoi piedi comandano e sono in grado di piegare anche il suo intelletto
e di fargli superare anche le sue paure (potenti strumenti preventivi), anche quando il viaggio è
un‟incognita e il confine uno oscuro presagio.
16
C‟è comunque un‟altra realtà incontrovertibile: quella parte d‟Africa in cui il nostro genere è
apparso è stata - ed è anche oggi- quella che più resistenza ha fatto all‟evoluzione delle società
umane, tanto che i luoghi della nostra genesi sono quelli che abbiamo modificato di meno e quelli
dove l‟ambiente naturale è ancora oggi dominante.
Quasi a voler dire che siamo figli dell‟Africa orientale ma che quell‟ambiente era troppo difficile
per noi, piccoli animali glabri che - seppure dotati di pensiero- e conseguentemente di alcune
tecnologie, erano ben poca cosa nei confronti della grandiosità di quella Natura. Quello era un
ambiente troppo imponente, troppo resistente a cambiamenti apportati da un suo gruppo di membri;
un ambiente che schiacciava tutti gli esseri viventi con la sua enorme possenza e li obbligava e li
obbliga al rispetto dei ruoli. Da quell‟ambiente così difficile alcuni di noi hanno trovato la forza o la
possibilità d‟uscire, e proprio alcuni di quelli usciti sono quelli che hanno dato il via alla grande
trasformazione.
17
Fuori dall’Africa
Il passaggio che ha portato la nostra specie a vivere fuori della nostra originaria nicchia ecologica
(la savana) è stato un percorso particolarmente impegnativo, durato chissà quante generazioni e
costellato da chissà quanti tentativi e insuccessi. I nostri antenati si muovevano allora in piccoli
gruppi di una decina di individui, in pratica una enclave famigliare. Intorno l‟Africa si apriva con
tutti i suoi enormi spazi: il sud- preceduto dalla regione dei grandi laghi- era dominio incontrastato
della grande fauna selvatica. Spostandosi in questa direzione i sapiens colonizzarono la zona degli
altopiani per poi spingersi fino all‟arido deserto della fascia subtropicale (il Kalahari), dove ancora
vivono nomadi i San che comunicano tra loro con uno degli idiomi più antichi e complessi della
nostra umanità.
Le lingue khoisan sono note per la presenza delle cosiddette consonanti clic, prodotte facendo
schioccare la lingua contro il palato o contro i denti, con diversi movimenti. La lingua juǀ'hoan, per
esempio, ha circa 30 suoni "clic" e qualcosa come 90 diversi fonemi, incluse vocali stridenti e
faringealizzate e quattro tonalità. Le "consonanti clic" si trovano anche in altre lingue; le lingue
khoisan vengono infatti considerate parte di un più ampio gruppo detto informalmente "lingue clic".
In Africa meridionale, per esempio, ci sono suoni analoghi in diverse lingue bantu (xhosa, zulu,
sesotho) e in Kenya nella lingua dahalo. Si pensa che i clic bantu derivino da quelli khoisan, e che i
dahalo invece abbiano mantenuto questi suoni da un linguaggio storicamente antecedente al ceppo
khoisan. Suoni simili, comunque, si trovano persino in alcune lingue degli australiani aborigeni,
come la lingua cerimoniale Damin (ovviamente senza alcuna correlazione con i ceppi linguistici
africani). Rielaborato da Wikipedia alla voce: Lingue khoisan
All‟est c‟era un oceano che gli uomini non erano ancora in grado di navigare, anche se - nella punta
estrema dell‟Africa orientale- la glaciazione aveva drasticamente ridotto lo stretto passaggio che
oggi chiamiamo del Bab el- Mandeb; da qui – forse e chissà come– passarono alcuni nostri antenati
per poi dirigersi a nord e colonizzare le sponde arabiche dell‟Eurasia bypassando la valle del Nilo.
L‟ovest c‟era l‟immenso bacino del Congo, in gran parte coperto dalle grandi foreste pluviali,
ambito elettivo di quei nostri lontani cugini quadrumani con cui condividiamo oltre il 98 % del
patrimonio genetico ma ben poche tipologie comportamentali (quei cugini che sono rimasti a vivere
nel nostro ambiente primordiale che oggi ci appare come uno degli habitat naturale più difficili da
penetrare).
Infine il nord, con il grande spazio dove ora si estende in tutta la sua enormità il deserto del Sahara
(che negli anni della glaciazione era in gran parte coperto da vegetazione), irrorato da alcuni fiumi
oggi scomparsi che si perdevano nella sua vastità e attraversato dalla valle fluviale del Nilo che lo
tagliava come una lama. Così generazione dopo generazione, seguendo le orme dei nostri
predecessori più antichi, i nostri antenati andarono a colonizzare questo nuovo e inedito spazio
ecologico, fino a che -100.000 anni fa-, poco dopo l‟inizio dell‟ultima glaciazione (glaciazione di
18
Wurm 110.000-10.000 a.C.) iniziamo a trovare i loro primi insediamenti lungo le coste del
Mediterraneo e in Medio-oriente.
Non sappiamo e -con tutte probabilità- mai sapremo se nei 100.000 anni che vanno dalla sua prima
apparizione nell‟Africa orientale alla sua documentata presenza in Medio-oriente le circa 5000
generazioni che si sono succedute potessero parlare; forse esisteva già un abbozzo di linguaggio
comune; quell‟ipotetica “lingua-madre” che tutti i linguisti anelerebbero scoprire (purtroppo su
quest‟aspetto non abbiamo – e presumibilmente mai avremo- nessuna certezza e tanto meno
documentazione). Appare però facile immaginare che –seppure con una forma di comunicazione
primitiva legata alla vocalizzazione- i nostri antenati avessero già sviluppato la possibilità di
scambiare informazioni ed esperienze così come fanno la maggior parte degli animali (anche se
purtroppo siamo alieni alle tante forme di comunicazione che esistono nel mondo animale).
Ad oggi noi abbiamo solo un‟idea approssimativa del clima del Medio-oriente di 100.000 anni fa
perché il dibattito sull‟inizio e sulla fine dei vari cicli climatici è ancora aperto, senza poi
dimenticare che stiamo parlando di archi temporali talmente lunghi da racchiudere al proprio
interno ampi fenomeni di oscillazione. Di una cosa però -vista la latitudine- siamo certi: tutta l‟area
era libera dai ghiacci che coprivano molta parte dell‟Eurasia e dalla siccità che attanagliava le
savane africane, e che il clima temperato -probabilmente più piovoso di quello attuale- era
comunque soggetto a cambiamenti stagionali. Facendo salve queste premesse, possiamo affermare
che i sapiens avevano incontrato sul loro andare un bioma sicuramente più facile di quelli ricchi ma
terribili che avevano conosciuto fino allora; un habitat cerniera tra i tre grandi blocchi continentali
del mondo antico (Africa, Asia, Europa), caratterizzato da spazi aperti, pochi alberi e una fauna che
come noi era in parte di derivazione africana. Queste particolari condizioni (fatte le debite
differenze temporali) erano dovute al fatto che l‟ambiente dell‟Africa mediterranea, del Mediooriente aveva e ha una piovosità annuale paragonabile a quella della savana (circa 300-400 mm
annui).
La savana è un bioma terrestre caratterizzato da una vegetazione a prevalenza erbosa, con arbusti e
alberi abbastanza distanziati da non dar luogo a una volta chiusa. Le savane sono determinate
principalmente dalla scarsità delle precipitazioni. Precipitazioni inferiori ai 200 mm all'anno sono
infatti insufficienti allo sviluppo di alberi e arbusti, e determinano regioni di sola prateria erbosa,
quali si trovano tipicamente ai margini dei deserti subtropicali. Spostandosi gradualmente verso
latitudini più piovose (ovvero verso l'equatore) si osserva prima la comparsa di vegetazione
arbustiva (fino a 300 mm) e poi di alberi isolati (fra i 300 mm e i 400 mm). Il paesaggio è dominato
da enormi distese di erba. Le piante erbacee sono in genere perenni con radici profonde e ramificate
per intercettare ogni traccia di umidità. Gli alberi invece sorgono isolati e sono rappresentati da
acacie e baobab. L'erba della savana è fonte inesauribile di cibo per una numerosa fauna erbivora,
che riunita in branco, si sposta a seconda delle stagioni per cercare zone in cui il cibo e l'acqua sono
abbondanti. Gli erbivori rappresentano il primo anello di una catena alimentare che termina con i
carnivori.
Rielaborato da Wikipedia alla voce: Savana
19
L‟insieme di queste caratteristiche ha portato i biologi a definire l‟Africa mediterranea e il Mediooriente come un‟estensione della macro regione africana e questo è sicuramente vero per una parte
della fauna e per alcuni tipi di alberi, ma è sorprendente come gli studiosi di scienze naturali
abbiano voluto sottolineare le similitudini senza curarsi delle differenze; perché sono proprio le
macroscopiche differenze –molte delle quali concentrate nel regno vegetale- che hanno offerto ai
sapiens quelle opportunità che la nostra specie ha potuto poi sfruttare in modo straordinario.
Il fatto che la piovosità di queste regioni sia paragonabile non assimila il clima mediorientale a
quello della savana. Nell‟Africa equatoriale e sub-equatoriale il clima è binario, con il costante
alternarsi di un periodo secco e di uno piovoso e con temperature che permangono alte per tutto il
corso dell‟anno; mentre alle latitudini mediterranee l‟anno meteorologico si suddivide in cicli di
quattro stagioni: con le piogge generalmente concentrate in autunno e in primavera (periodi
tendenzialmente caratterizzati da un clima mite), inverni freddi e qualche volta nevosi ed estati
secche e calde. Questo significa che lungo la strada della sua irradiazione, per la prima volta, il
sapiens aveva incontrato l‟inverno!
Dall‟inverno deriva la sostanziale “scomparsa” della vegetazione durante il periodo freddo (il mito
di Cerere) e questa parziale assenza di vegetazione rende la regione non adatta a sostenere grandi
mandrie di erbivori gregari, fattore che si ripercuote sul numero dei loro grandi predatori. Un
fenomeno assente nella savana africana, dove anche nella stagione asciutta, c‟è sempre una prateria
(anche se fatta di erba secca) buona da pascolare e dove le mandrie dei ruminanti possono spostarsi
lungo delle direttrici di migrazioni cicliche.
C‟era poi un‟altro aspetto importante che era sempre collegato alla stagione invernale; in queste
zone le acque e dei fiumi, dei torrenti e delle paludi sono libere dai grandi rettili, i quali -essendo
animali a sangue freddo- non sono in grado di sopravvivere in aree dove la temperatura può
scendere anche di alcuni gradi al disotto dello zero; cosa che vale anche per alcuni mammiferi
sensibili alle basse temperature come gli ippopotami (come vedete non tutti gli animali sono in
grado di andare oltre la propria nicchia ecologica!). Senza dimenticare l‟efficienza dimostrata dal
freddo nel saper ridurre o interrompere l‟incidenza di molte malattie parassitare (bilhariosi, malaria,
tripanosomiasi, etc.).
Queste diverse condizioni aprirono ai nostri antenati delle straordinarie possibilità. Per centomila
anni, in Africa, i sapiens avevano potuto trovare gli alimenti solo sulla superficie della terra: l‟acqua
e gli ambienti umidi erano loro parzialmente preclusi. Non perché privi di offerte alimentari (anzi),
ma perché luoghi dove troppo facilmente si poteva correre il rischio di diventare prede o di
rimanere contagiati. Con l‟arrivo nel Medio-oriente la nostra specie trovò invece fiumi, lagune,
laghi e una grande acqua libera dalla maggior parte di questi pericoli, e questo le permise di
raccogliere e/o cacciare, pesci, anfibi, molluschi, e di introdurre queste ricche risorse alimentari
nella dieta quotidiana. In un primo tempo questo facile accesso fu limitato alla sola raccolta lungo le
rive o le spiagge, per poi dare vita alle prime forme rudimentali di pesca (che altro non è che una
caccia nell‟acqua).
L‟offerta alimentare si arricchì così di un vasto apporto proteico e calorico che si può ben definire: a
portata di mano; fatto per essere facilmente raccolto e utilizzato. Questo pieno utilizzo delle acque
20
dolci o di quelle costiere finì per incrementare notevolmente il numero d‟individui sostenibili dal
territorio. Di questo aspetto si ha un‟ampia documentazione nei siti paleolitici studiati in tutto il
Medio-oriente (e –in generale- dell‟emisfero nord), dove sono riscontrabili grossi depositi di scarti
alimentari provenienti proprio da molluschi o da lumache. Così che l‟accesso senza rischi a questa
nuova fonte alimentare significò una riduzione del territorio necessario al sostentamento di ogni
specifico gruppo di raccoglitori-cacciatori o (se volete) un numero più alto di gruppi per chilometro
quadrato. Infatti in tutta l‟area mediorientale (fenomeno che poi si estenderà progressivamente alle
altre aree temperate) riscontriamo un progressivo e costante aumento dei numero di siti paleolitici
che arrivano ad una densità che non si era mai vista fino allora. Cosa che ha generato un
obbligatorio adeguamento nelle forme di equilibrio sociale interno ed esterno ai vari gruppi
familiari.
Questo era il Medio-oriente agli occhi dei primi sapiens: niente grandi mandrie di ruminanti: quindi
pochi felini, pochi canidi, ma – soprattutto- corsi d‟acqua senza i grandi rettili e senza grossi rischi
di contagi infettivi; quindi acque “domestiche”. In altre parole un territorio dove degli individui
glabri e per natura privi di strumenti fisiologici di aggressione (né denti , né zanne, né artigli),
poterono – anche con l‟aiuto di strumenti prodotti dal loro intelletto- posizionarsi alla cima della
catena alimentare.
C‟era -è vero- in quei territori un altro genere di Homo: il neanderthal; un ramo collaterale derivante
da un predecessore comune dal quale ci eravamo divisi circa 500.000 anni fa. Il neanderthal era
apparso e poi si era consolidato in tutti i territori dell‟Europa e del Caucaso durante il corso della
glaciazione del Riss. Molto abile nella caccia – dalla quale traeva la maggior parte del suo
sostentamento- questo altro genere di Homo, con i suoi tratti morfologici così particolari (corpo
tozzo per non disperdere il calore, naso largo per riscaldare l‟aria inspirata, probabile colore bianco
della pelle per assorbite al massimo le vitamine A e D) si era dimostrato adatto ai climi rigidi
dell‟emisfero nord. Quando circa 100.000 anni fa il sapiens incontrò il neanderthal in Palestina,
questi era al bordo estremo del suo areale di diffusione, in un‟area geografica dove il ghiaccio non
aveva mai dominato la Natura ma in una fase climatica (inizio della nuova glaciazione di Wurm)
dove il freddo era in lento ma progressivo aumento. Forse è proprio l‟inizio di quest‟ultima
glaciazione che lo aveva portato ai margini del sua nicchia ecologica di riferimento.
Il neanderthal aveva affrontato millenni di sfide inenarrabili (da questa consapevolezza –forse- oggi
deriva un atteggiamento benevolo verso questo nostro cugino scomparso), sopportato un clima
infausto e inverni durissimi, combattuto contro i canidi e orsi per procacciarsi il cibo, cacciato prede
difficili come i grandi erbivori dell‟Europa settentrionale (alci, renne, uri ecc.) e –occasionalmente–
anche l‟unico proboscidato che viveva in quei tempi nell‟areale nordico: il mammut. Spesso aveva
dovuto contendere ai lupi le carcasse degli animali cacciati, ma mai aveva dovuto combattere – per
assicurarsi uno spazio nella sua nicchia ecologica – contro un nuovo esponente del genere Homo.
Eppure per 50.000 anni questi due branche del genere Homo condivisero gli spazi del Mediooriente, forse combattendosi, forse ignorandosi, forse incrociandosi geneticamente (da alcune
analisi recenti risulterebbe che una piccola parte del nostro corredo genetico deriva dal neanderthal
e questo- a rigor di logica- significa che i due generi intercorressero rapporti sessuali fecondi).
21
E‟ anche possibile che i due generi avessero una diversa dispensa alimentare così come accade ai
grandi carnivori africani, o forse una diversa tecnica di caccia o di raccolta, anche se dai manufatti
fossili che sono giunti fino a noi possiamo notare che entrambi i gruppi umani avevano un livello
tecnico di lavorazione della pietra paragonabile. Di certo trovando una forma elastica di equilibrio
biologico che con buona probabilità derivava anche dal fatto che il loro livello culturale fosse più o
meno lo stesso.
In archeologia preistorica, l'espressione industria litica (dal greco antico lithos, «pietra») indica
l'insieme degli oggetti di pietra realizzati dall'uomo a partire da ciottoli intenzionalmente modificati.
Nel paleolitico inferiore gli utensili sono realizzati con ciottoli scheggiati (cultura dei ciottoli, o
Pebble Culture") o manufatti a forma di mandorla (bifacciali o amigdale). Abbiamo testimonianza
di manufatti su ciottoli appena scheggiati ("choppers" e "chopping tools") associati a diversi
strumenti ricavati da schegge (raschiatoi e punte). Nel paleolitico medio si assiste ad una crescita
della varietà dei manufatti che sono in questa fase caratterizzati da un perfezionamento delle
tecniche di lavorazione (scheggiatura "levalloisiana" dal sito di Levallois). In questo periodo,
caratterizzato dalla diffusione in Europa dell'Homo sapiens, si perfeziona la tecnica di scheggiatura
a pressione, che consente di ottenere manufatti di grande raffinatezza. I manufatti litici sono ricavati
soprattutto da lame e micro lamine, mentre ha inizio la diffusione dei lavorazione dell'avorio. Tra le
realizzazioni caratteristiche del periodo troviamo bulini, punte ritoccate, manufatti di piccole
dimensioni ("microliti"). Nel Medio-oriente di 100.000 anni fa la tipologia dei ritrovamenti litici
appartiene a quella che chiamiamo: cultura musteriana, un nome associato principalmente con
l'Homo neanderthalensis. Prende nome dal sito di Le Moustier, nella regione francese della
Dordogna. Attrezzi in selce simili sono stati trovati in tutta l'Europa che non era interessata dalle
glaciazioni, oltre che nel Vicino Oriente e nel Nord Africa. Raschiatoi, denticolati e punte
costituiscono la maggior parte dell'industria.
Gli attrezzi musteriani erano prodotti dai Neandertaliani e risalgono a 300.000-30.000 anni fa.
Nell'Africa settentrionale e nel Vicino Oriente le opere dei Neandertaliani sono indistinguibili da
quelle prodotte dagli umani moderni. Generalmente, le pietre venivano lavorate in modo da
produrre una base di partenza adatta a più possibili attrezzi (nucleo), che veniva poi rifinito
rimuovendo schegge di selce con la tecnica Levallois o un'altra tecnica equivalente.
Lo studio delle tracce d'usura e l'osservazione al microscopio indicano che queste pietre potevano
essere associate a un manico di legno e che gli uomini del periodo Musteriano lavoravano, oltre alla
pietra, anche legno e pelli e che usavano, a volte, i loro attrezzi anche per tagliare materie vegetali.
Rielaborato da Wikipedia alla voce: Industria litica
Poi, passati 50.000 anni le testimonianze di questa coesistenza cominciano a diradarsi,
diminuiscono gli oggetti e i fossili riferibili ai neanderthal e appaiono strumenti litici prodotti dai
sapiens che iniziano a presentare caratteristiche tecniche nuove e raffinate. Uno strano fenomeno
che lascia molti interrogativi ancora aperti ai quali facciamo fatica a dare una risposta, perché –
possiamo confessarlo senza remore- pensiamo di conoscere i meccanismi che conducono verso
l‟estinzione di una specie ma ci sfuggono le ragioni che invece inducono all‟attivazione di quei
meccanismi. E qui tocchiamo uno dei punti più controversi di tutta questa narrazione: come mai è
sparito il neanderthal? E come e perché nello stesso periodo il sapiens –pur senza apparentemente
22
sottostare a mutazioni fisiche significative- ha cambiato il suo modo di essere e ha acquisito un
apparato cognitivo e comportamentale paragonabile a quello di noi uomini contemporanei; cioè
perché l‟uomo uscito dalla savana circa 50.000 anni prima dopo un lungo periodo di convivenza
con una specie cugina ha poi iniziato a mutare il suo modo di essere e si è trasformato in quello che
oggi noi siamo? E la scomparsa del neanderthal ha una incidenza su questo? O è vero il contrario?
Oppure dobbiamo considerare la scomparsa e la trasformazione come fenomeni sovrapponibili ma
distinti?
Dice Darwin; al quale a questo punto è doveroso fare riferimento:
«E‟ evidente che negli esseri viventi (vegetali ed animali), lungo il corso del tempo, si verificano,
sotto l‟influsso delle condizioni ambientali, piccole variazioni organiche. Esse sono funzionali
all‟adattamento individuo-ambiente e quindi vantaggiose per i soggetti che riescono a svilupparle.
Solo gli individui “adatti” o “forti”, cioè capaci di interagire con l‟ambiente e di trasformarsi,
possono, di conseguenza, sopravvivere al meccanismo della “selezione naturale”. Gli altri, invece, i
“non-adatti” o i “deboli” sono condannati all‟estinzione».
Charles Darwin, L'origine delle specie, 1859, p. 147
E questo ci porta a ragionare su uno dei concetti più importanti espressi da Darwin nelle sue
riflessioni sulle origine delle specie.
La selezione naturale, concetto introdotto da Charles Darwin nel 1859 è il meccanismo con cui
avviene l'evoluzione delle specie e secondo cui, nell'ambito della diversità genetica delle
popolazioni, si ha un progressivo (e cumulativo) aumento della frequenza degli individui con
caratteristiche ottimali (fitness) per l'ambiente di vita.
Gli individui di una stessa specie si differenziano l'uno dall'altro per caratteristiche genetiche (cioè
morfologiche e funzionali, frutto dell'interazione del genotipo con l'ambiente). La teoria della
selezione naturale prevede che all'interno di tale variabilità, derivante da mutazioni genetiche
casuali, nel corso delle generazioni successive al manifestarsi della mutazione, vengano favorite
("selezionate") quelle mutazioni che portano gli individui ad avere caratteristiche più vantaggiose in
date condizioni ambientali, determinandone, cioè, un vantaggio adattativo (migliore adattamento) in
termini di sopravvivenza e riproduzione. Gli individui meglio adattati ad un certo habitat si
procureranno più facilmente il cibo e si accoppieranno più facilmente degli altri individui della
stessa specie che non presentano tali caratteristiche. In altre parole, è l'ambiente a selezionare le
mutazioni secondo il criterio di vantaggiosità sopra descritto: i geni forieri di vantaggio adattativo
potranno così essere trasmessi, attraverso la riproduzione, alle generazioni successive e con il
susseguirsi delle generazioni si potrà avere una progressiva affermazione dei geni “buoni” a
discapito dei geni inutili o dannosi. La specie potrà evolversi progressivamente grazie allo sviluppo
di caratteristiche che la renderanno meglio adattata all'ambiente, sino ad una situazione di equilibrio
tra ambiente e popolazione che persisterà finché un cambiamento ambientale non innescherà un
nuovo fenomeno evolutivo.
Rielaborato da Wikipedia alla voce: Selezione naturale
23
Possiamo tradurre questi concetti in un modo riassuntivo: ogni specie è composta di un grande
numero d‟individui, questi individui presentano tra loro una ampia variabilità genetica (basti
pensare a quanta differenza morfologica c‟è tra noi sapiens) e tutti possono compartecipare alla
riproduzione e alla conseguenza evoluzione della specie. Ma le condizioni dell‟ambiente naturali e
le loro costanti fluttuazioni portano a setacciare gli individui più adatti (ossia quelli più dotati di
“fitness”), che grazie a queste caratteristiche si riproducono più facilmente e che quindi più
facilmente passano le loro caratteristiche genetiche alla generazione successiva.
Se nello studiare le ragioni che hanno portarono il neanderthal all‟estinzione diamo per scontato la
funzionalità del meccanismo della “selezione naturale” (fenomeno che peraltro ha coinvolto anche
molti altri animali del periodo glaciale) e nell‟assicurare ai sapiens la loro affermazione biologica
dobbiamo fare riferimento a due cambiamenti fondamentali su cui tutti gli studi mettono l‟accento:
la velocità del riscaldamento climatico che ha fatto seguito a uno dei culmini della glaciazione unita
ad una forte oscillazione climatica interna al periodo di glaciazione, e l‟accanita concorrenza
alimentare che i nostri progenitori fecero ai neanderthal (quindi un cambiamento delle strategie
comportamentali di un‟altra specie concorrente). E già con quest‟ultima affermazione abbiamo
introdotto già un concetto nuovo che esula dalle tematiche strettamente ambientali. Ma sorge
spontanea una domanda: perché quell‟equilibrio si alterò dopo 50.000 anni di convivenza? Perché
messo di fronte a un sapiens che forse aveva trovato strumenti più efficienti per adattarsi ai
cambiamenti naturali (anche se vi ricordo che l‟apice dell‟ultima glaciazione fu toccato 20.000 anni
fa) il neanderthal non seguì il ritirarsi della linea dei ghiacci? Perché da 30.000 anni non ci sono più
neanderthal neanche ai poli (a parte delle fantasie sugli Yeti del Tibet)?
A mio avviso occorre ritornare su alcuni temi trattati nell‟introduzione ribadendoli in forma di
postulato: le specie tendono alla conservazione non alla mutazione! Ogni individuo, ogni gruppo,
ogni specie è intrinsecamente conservativo. Poi ci sono le mutazioni, ma le mutazioni non sono
tutte uguali! Anzi il termine stesso di mutazione esprime un concetto fuorviante perché induce il
nostro pensiero verso l‟idea del cambiamento evolutivo. Ma si può cambiare per trasformarsi in
qualche altra cosa e cambiare per adattarsi, e questo non è la stessa cosa. La natura cambia; con cicli
climatici, stagioni, epoche, ere, circonvoluzioni, evoluzioni, rivoluzioni; le specie si adattano a
questi cambiamenti. Sono, siamo canne a vento della vita! Probabilmente è proprio quando
perdiamo la capacità di adattarci che andiamo incontro al declino e all‟estinzione.
Le mutazioni osservate da Darwin (ricordate i becchi degli uccelli delle Galapagos?), sono quindi
dei cambiamenti adattativi. Gli esseri viventi cambiano perché la specie rimanga simile: che non va
confuso con uguale! Uguale vuole dire conservazione, stasi; simile vuole dire mutazione,
cambiamento; e in Natura chi non si adatta scompare. Anche se nel mondo ci sono un certo numero
di specie – sia animali che vegetali- che nel corso dell‟evoluzione apparentemente non sono
cambiate – tanto che diciamo con sorpresa che alcuni animali e vegetali sono dei fossili viventi- in
realtà i loro individui sono simili a quelli di migliaia di anni fa, non uguali e la loro presenza rimane
come una reliquia del passato. Le specie devono giocare con la Natura un gioco di sponda:
rispondere a significativi cambiamenti naturali o all‟esplorazione di nuovi ambienti con dei
cambiamenti adattativi (questo è quello che diceva Darwin). Se devo colonizzare un nuovo spazio
ecologico adatto il becco (e fisso questo cambiamento nel mio corredo genetico) o cambio il colore
24
della pelle per adattarmi alla riduzione delle ore di esposizione al sole. Ma malgrado il mio colore di
pelle sia diverso da quello di popolazioni di altre latitudini noi siamo sempre un‟unica specie (in
realtà nel nostro caso specifico unica specie e unico genere, perché –aimè - di Homo ci siamo
rimasti solo noi).
Poi ci sono le mutazioni vere e proprie che per coerenza con il mio ragionamento comincerò a
chiamare “mutanze” ; ossia delle vere e proprie rivoluzioni genetiche, come lo sono tutte quelle che
portano alla formazione di una nuova specie. Le mutanze non inducono alla conservazione della
specie, ne generano una nuova! Sono eventi estremi e assolutamente naturali, conseguenti a
fenomenologie estreme. Noi – e parlo di noi uomini contemporanei votati allo studio e
all‟osservazione scientifica- non abbiamo ancora assistito alla nascita di una nuova specie. Abbiamo
visto e contribuito alla nascita di nuove razze animali e di nuovi cultivar vegetali, all‟estinzione di
precedenti specie, ma il momento dell‟apparire di un nuova specie ancora ci è ignoto.
L‟apparizione di una nuova specie non risponde al meccanismo narrato sopra della “fitness”, l‟atto
è in se troppo rivoluzionario per sottostare al meccanismo biologico del “potere del più adatto”.
Quello, come ho detto è adattativo. Una nuova specie appare dall‟aberrazione, dall‟anormalità: è –
anzi- la codificazione genetica della anormalità. Possono apparire in alcuni individui dalla
rielaborazione del codice genetico prodotta da epifenomeni mutogeni di origine esterna (radiazioni,
virus, sostanze chimiche, ecc.), oppure da devianze genetiche interiorizzate nella specie. Forse
esistevano all‟interno delle popolazioni che ci hanno preceduto delle occasionali apparizioni di
uomini glabri, o con il muso retratto, o con una dentizione da onnivoro, o con l„intestino cieco
ridotto. Erano individui marginali, espressioni di un codice genetico che aveva interiorizzato una o
più di queste mutanze ma che la faceva apparire casualmente, per combinazione occasionale di geni
recessivi. Individui probabilmente destinati a una vita più complessa e breve dei loro
contemporanei.
La Natura traccia un solco e a quello si attiene, giocando con gli adattamenti per consentire la
fitness della specie (non quella degli individui che sono una particella minore della specie), però –
accanto alla strada principale- tiene aperti dei piccoli sentieri e -con un‟insistenza sorprendente,
batte occasionalmente quei sentieri per non vederli chiudere dalla vegetazione. La logica naturale
rigetta sia il senso dell‟utilitaristico sia quello dell‟immediato. La Natura naturalmente fa quello che
un uomo saggio o una società saggia dovrebbe copiare da lei: traccia una strada maestra e –
contemporaneamente- tiene aperte tante altre opportunità. Poi ci sono momenti (nel nostro caso
“ere”) dove quel sentiero mantenuto aperto in un angolo recessivo del corredo genetico comincia ad
apparire utile. Gli individui portatori o acquisitori di quella mutanza si riproducono (anche tra loro,
consentendone così la fissazione in alleli dominanti) e la loro discendenza trova spazi progressivi in
un bioma nuovo o in trasformazione, e quello che era un sentiero stretto, battuto da pochi, si amplia
e si consolida, fino all‟apparizione di una massa critica d‟individui: una nuova specie.
Ma la complessità del quadro biologico non si ferma qui. C‟è un altro ambito non legato alle
mutazioni o alle mutanze (fenomeni codificati nel codice genetico) ma a significativi cambiamenti
degli aspetti comportamentali, questo può succedere quando una specie o un genere scopre una
nuova e abbondante fonte di cibo (quindi una nuova nicchia ecologica). In questo caso la specie trae
25
un enorme vantaggio nell‟aver cambiato le proprie basi alimentari o nell‟aver scoperto nuove e
accessibili risorse. La specie si fa più forte, più numerosa, più aggressiva; tende a competere con
più “fitness” contro altre specie per assicurarsi il controllo del nuovo territorio di caccia o di
raccolta (in questo caso possiamo anche parlare di raggiungimento di una massa critica
paragonabile a quella di un animale “composto”).
Questo è quello che penso sia successo ai sapiens in Medio-oriente quando trovarono una nuova e
ricca offerta alimentare derivante dallo sfruttamento dei fiumi, delle paludi e delle rive senza
antagonisti naturali che si frapponessero all‟utilizzo. Grazie a queste condizioni i nostri
predecessori poterono spostare il loro accampamenti nelle valli e lungo i corsi d‟acqua, cosa che
mai avevano potuto fare prima d‟allora. C‟era da condividere quelle risorse con i neanderthal, bene;
lottando per accaparrarsi il massimo per 50.000 anni quelle risorse si condivisero, elaborando forse
un obiettivo comune: l‟eliminazione di ogni altro concorrente che ci sovrastasse nella catena
alimentare! Fu un percorso lungo ma perseguibile perché- come abbiamo detto- quei territori non
erano fatti per sostenere un numero elevato di grandi predatori che ci contendessero il vertice della
catena alimentare.
Indubbiamente il freddo ha richiesto alla nostra specie un grande sforzo adattativo e ha imposto
significativi cambiamenti comportamentali, il cui superamento avrebbe potuto prevedere alcune
forme di retroazione (esempio il tornare a coprirci di peli così come fanno gli animali che durante
l‟inverno infittiscono la pelliccia); ma invece di tornare indietro il freddo è stato ragione di una
grande spinta evolutiva: ha infatti obbligato i nostri antenati a coprirsi (quindi ad uccidere gli
animali anche per le loro pelli) e ad imparare l‟arte della concia e della cucitura, e li ha portati ad
esplorare le caverne per avere un riparo stabile e ad utilizzare il fuoco per scaldarsi e non solo per
cucinare.
Ma l‟inverno non è stato solo un attivo strumento si stimolo intellettuale ha anche svolto una
importante funzione coagulante di percezione collettiva, portando i sapiens a delle più strette e
attente forme di collaborazione, favorendo direttamente quella che potremmo chiamare una forma
di condivisione comunitaria (torneremo in seguito su questo tema).
Diecimila anni prima dell‟inizio del paleolitico superiore (circa 40.000 anni fa) i gruppi umani di
neanderthal e sapiens avevano ormai portato a termine la prima vera modifica ambientale compiuta
perseguendo una strategia evolutiva, non c‟erano più grandi carnivori in grado di contendere le
riserve alimentari. E il territorio si apriva ad un intenso utilizzo di caccia e di raccolta: mai prima
d‟allora i gruppi umani erano stati così numerosi e così vicini.
Non penso che in questa azione i sapiens siano stati gli unici protagonisti. Non lo penso perché non
credo che i neanderthal si comportassero tanto diversamente dai nostri antenati. In realtà credo che
tra le due specie del genere Homo ci fosse una parziale condivisione di intenti. Non sto parlando di
un‟alleanza, non è questo il termine del mio pensiero. Sto dicendo che entrambe le specie avrebbero
potuto trarre un vantaggio biologico selettivo dall‟antagonismo verso gli altri predatori, fino a
portare a completa scomparsa le specie che si frapponevano al posizionamento del genere Homo al
vertice della catena alimentare.
26
Mai nella loro storia evolutiva gli uomini erano stati al vertice della catena, mai – da quando
avevano assunto la posizione eretta- avevano potuto andare in giro a testa alta ma con
atteggiamento rilassato nei confronti della terra su cui camminavano e non a testa alta per la paura
di essere attaccati. Questo in termini comportamentali non è una cosa da poco. Io credo che essere
sollevati dai problemi della fuga, del nascondersi, del camuffarsi possa essere un potente motore
evolutivo che i sapiens hanno saputo cogliere, mentre i neanderthal no. Cercheremo nel prossimo
capitolo di capire il perché!
Questi sono anche i millenni delle progressive espansioni in Europa, in Asia, nelle isole
dell‟arcipelago indonesiano, fino ad arrivare all‟Australia e alla Nuova Guinea. Mentre per la
colonizzazione delle Americhe bisognò aspettare che l‟accentuarsi della glaciazione creasse un
ponte di terra (ghiacci) attraverso quello che oggi è lo stretto di Bering.
Intanto a favorire quell‟incedere dei sapiens verso climi e latitudini più nordici o orientali erano
apparse delle piccole mutazioni adattative: il colore bianco della pelle in Europa, la piega mongola
degli occhi in Asia, un ampio polimorfismo (si erano ridotti di statura nelle aree, dove potevano
contare su un minimo apporto proteico mentre si erano alzati nelle aree dove la caccia e la raccolta
erano abbondante), e ancora delle variazioni endocrine nel sistema circolatorio, come i gruppi
sanguinei o il fattore rh negativo. Il sapiens si mostrava allora come una specie segnata da un
profondo cinetismo genetico, come una specie vincente che mutava con facilità per adattarsi alle
nuove condizioni ambientali. A conferma di questa tesi citiamo i mutamenti avvenuti nei gruppi
sanguinei, fattore sul quale torneremo anche in seguito.
L‟Homo sapiens era originariamente portatore del solo gruppo 0 caratteristico degli individui che
hanno un regime alimentare basato sulle proteine animali. Un tipo di uomo abituato a grandi sforzi
fisici (necessari per portare a termine lunghe battute di caccia) che -vivendo in piccoli gruppi- non
aveva bisogno di sviluppare sistemi per difendersi dalle infezioni trasmesse dai propri simili.
Queste caratteristiche si ritrovano ancora oggi negli appartenenti al gruppo 0, caratterizzati da un
apparato digerente robusto e da un sistema immunitario particolarmente attivo contro le infezioni
contraibili attraverso il cibo, ma debole contro quelle virali. Un sistema immunitario che inoltre
pecca di fragilità di fronte a radicali cambiamenti di alimentazione e favorisce l‟insorgenza di
allergie e malattie autoimmuni.
Il gruppo A apparve 20.000 anni fa, come risultato di un mutato regime alimentare in cui avevano
un peso crescente i prodotti di origine vegetale. Gli uomini inoltre si stavano organizzando in
comunità sempre più numerose, esponendosi a un rischio maggiore di contrarre malattie
trasmissibili dai propri simili.
Con un cambiamento enorme il processo evolutivo selezionò individui capaci di sfruttare al meglio
i nutrienti dei vegetali e di difendersi efficacemente contro le infezioni da contagio. Gli appartenenti
al gruppo A hanno una scarsa tolleranza delle proteine di origine animale, un sistema immunitario
efficace contro le infezioni virali e resistente alle variazioni climatiche, ma debole verso le malattie
di tipo batterico.
Il gruppo B ebbe origine nella zona dell‟Himalaia circa 15.000 anni fa. Il clima ostile e il territorio
inospitale indirizzarono alcuni uomini verso la pastorizia nomade e l‟allevamento, così i prodotti
27
caseari divennero la più importante fonte di sostentamento.
L‟uomo, che in origine non era strutturato per resistere né a lunghi periodi di carenza alimentare, né
alle infezioni procurate dal freddo, sopravvisse grazie a una dura selezione naturale che favorì
esemplari resistenti a queste condizioni di vita estreme.
Il gruppo AB è stato l‟ultimo adattamento del sangue umano. Ebbe origine circa 1.000 anni fa nella
zona del Caucaso dalla mescolanza tra le popolazioni nomadi (prevalentemente di gruppo B) e
quelle stanziali (prevalentemente di gruppo A).
I gruppo AB è un mix tra i due gruppi. Le sue caratteristiche immunitarie lo hanno protetto durante
le grandi epidemie medievali, come il tifo e la peste. E‟ invece maggiormente soggetto alle
infezioni batteriche delle vie respiratorie, alle infezioni da Candida e ai parassiti intestinali, mentre
risulta ben protetto dai virus del raffreddore.
Questo inserto è una rielaborazione da Wikipedia , da Sentirsibene.com e dal sito Dieta dei Gruppi Sanguinei
Cambiamenti fisiologici mica indifferenti, non credete?
28
L’uomo nuovo
Tra i tanti corridoi di quel maestoso palazzo di Cnosso che è la nostra storia evolutiva c‟è un
momento impalpabile, una soglia, oltrepassata la quale la nostra specie sembra affermarsi come
arricchita nella sua capacità di elaborare pensieri, sogni, fantasie e simboli. Come, quando e perché
è successo? E‟ un evento che viene al di fuori di noi? Una illuminazione, una “grazia, o è –inveceun cammino che si svolge per un percorso lungo, complesso e altalenante? E‟ stato qualcosa che
abbiamo cercato o qualcosa che ci è capitato? Qualcosa che era già scritta nel nostro codice
genetico o qualcosa che ci è accaduta per pura casualità? Ad oggi non lo sappiamo; ma questo – e
forse proprio questo- non impedisce di battagliarci sulle ipotesi!
L‟unico dato più o meno certo è che dalla diaspora che ci ha portati fuori dall‟Africa ad un certo
punto della nostra storia evolutiva emerge un altro modo di essere uomini; nasce o si espande quel
senso dell‟umano che ci porta – curiosi e interessati- a comunicare ad altri le notizie di quello che è
avvenuto vicino o lontano da noi; ad essere tristi o allegri, a pensare alla morte e immaginarne la
resurrezione, a ballare, a suonare, a tagliarci la barba e i capelli o dipingere sui muri o imbellettarci
il viso, a difendere un‟idea, a provare compassione per un dolore altri. Quel modo di essere uomo
che mi tiene in questo momento davanti a un computer pregustando il caffè che sento borbogliare in
cucina mentre la luce (che luce oggi) di una mattina di maggio mi entra dalla finestra. Secondo
molti studiosi quell‟uomo è apparso nell‟area che va dal Medio-oriente o degli altipiani siriaci
anatolici circa 40-50.000 anni, quando l‟Homo sapiens (ossia l‟uomo moderno nato 200.000 anni
fa in Africa e arrivato in quelle zone circa 50.000 anni prima) trasformò o vide trasformati i suoi
comportamenti e le sue percezioni in qualcosa di più complesso e contradditorio: l‟uomo
contemporaneo. Per correttezza bisogna però aggiungere che negli ultimi anni gli studiosi stanno
dando grande importanza ad alcuni ritrovamenti archeologici avvenuti nella grotta di Blombos
vicino a Città del Capo che suggerisco l‟opportunità di traslare in altri luoghi e di retrodatare e
alcuni aspetti della nostra “umanizzazione” di una decina di millenni. (probabilmente anche questa
datazione non ha niente di definitivo perché più si ampliano le ricerche e più vediamo consolidata
una tendenza alla retrodatazione ). Il fatto che il litorale sud-africano – un‟area geografica a clima
mediterraneo- possa essere un altro luogo di “umanizzazione” sposta ma non muta il contesto
ambientale dentro il quale essa può essere avvenuta.
Ma - prescindendo dal luogo e dal tempo - viene spontaneo domandarsi, perché e come questa
incredibile trasformazione può essersi attivata? Il momento è topico, perché stiamo parlando di noi.
Niente ci differenzia in termini di capacità di pensiero e di analisi – e in fondo anche di
comportamenti- da questi nostri avi. Se potessimo prendere un neonato di quella nostra lontanissima
stirpe e trasportarlo nel nostro tempo presente crescerebbe integrandosi perfettamente nei modi e
nel pensiero della nostra società contemporanea, perché lui e noi siamo la stessa cosa.
Secondo il pensiero scientifico prevalente questa trasformazione si è prodotta da piccole ma
significative mutazioni della struttura corporea dei nostri antenati che, interessando tessuti molli
29
non sono rintracciabili nei resti fossili. Sono citati come ipotesi una modifica delle sinapsi del
cervello o un abbassamento della laringe. Ossia delle possibili mutazioni fisiche che – influenzando
i meccanismi dei processi intellettivi e/o quelli della vocalizzazione- avrebbero prodotto le logiche
conseguenze che queste ipotesi sottintendono.
Certo non è facile sostenere tesi che non possono trovare riscontro, ma per chi non crede alla
“grazia” - cosa a cui credono molti rispettabili persone- questo arduo scoglio trova nell‟ipotesi di
mutazioni funzionali un vasto consenso, come quella dell‟abbassamento della laringe che è
relazionata alla nascita del linguaggio, cioè quella capacità tipicamente umana di poter trasmettere
sentimenti e informazioni ai nostri simili. Fatto che viene visto come il senso e l‟essenza
dell‟umanizzazione.
Per collegare il corpo alla psiche – passando dalla maggior capacità di vocalizzazione alla nascita
della parola - alcuni studiosi assegnano un contributo significativo all‟esaptazione di alcuni caratteri
fisici.
Questo termine definisce caratteri che insorgono in un contesto per poi essere sfruttati in un altro, o
il processo con il quale simili novità sono adottate nelle popolazioni. Il classico esempio di
esaptazione che diventa adattamento è fornito dalle penne degli uccelli. Se cerchiamo un fattore
capace di aprire la strada a capacità cognitive simboliche, l‟invenzione del linguaggio è il candidato
più ovvio. Anzi, è forse l‟unico plausibile. Che cosa potrebbe essere accaduto? Dobbiamo supporre
che in una popolazione sia avvenuto un cambiamento neurale che non aveva nulla a che fare con
l‟adattamento. Questa innovazione fu l‟elemento fisico ( come esempio la discesa della laringe
N.d.A.) che doveva essere introdotto per rendere possibile il linguaggio e il pensiero simbolico:
tutto il resto ne è derivato. Una volta generatasi, questa potenzialità poteva restare inespressa, senza
farsi avvertire fino al momento di essere liberata da uno stimolo culturale in una particolare
popolazione. Quasi certamente questo stimolo fu l‟invenzione del linguaggio. Il fatto che oggi tutti
gli esseri umani usino il linguaggio indica che fu un‟acquisizione vantaggiosa. E se davvero lo fu,
non sorprende che il linguaggio e gli schemi di comportamento simbolici associati siano stati in
grado di diffondersi rapidamente nelle popolazioni di tutto il mondo. Non c‟è modo di escogitare
uno scenario convincente sull‟origine di quegli straordinari organismi che sono gli esseri umani
senza chiamare in causa l‟umile processo dell‟esaptazione. È chiaro che non siamo il risultato di un
costante e accurato processo di perfezionamento, e che gran parte della nostra storia è stata il frutto
del caso e della fortuna. La natura non ha mai "inteso" che occupassimo la posizione dominante in
cui ci siamo trovati.
Dalla presentazione on line del 02-gennaio 2002 di un articolo delle Scienze
Non so a voi, ma a me questo articolo riporta alla mente il dottor Azzeccagarbugli di manzoniana
memoria. Non lo dico per contrastare l‟idea che il linguaggio sia stato il volano più significativo
della nostra umanizzazione -quella è una ipotesi portante, oltreché condivisibile- ma penso che gli
uccelli non siano uccelli solo perché cantano tanto quanto l‟uomo non è uomo solo perché parla.
Sicuramente noi siamo uomini perché parliamo, cantiamo e comunichiamo, ma siamo uomini anche
perché girovaghiamo (ecco che tornano i piedi); guardando, incontrando, conoscendo e sopra ogni
altra cosa: sperimentando e condividendo i nuovi risultati! Siamo animali percettivi e associativi;
30
sentiamo cose che sono dentro e attorno a noi e nel momento che “sentiamo” delle cose cerchiamo
di acquisirle e una volta acquisite tendiamo a comunizzarle. A pensarci bene per anni ho criticato
l‟italiano che con il verbo sentire accomuna le varie differenze di percezione dei nostri sensi:
l‟udito, il tatto, il gusto: sento il caldo e il freddo, sento la gioia e la noia. Poi ho capito che non
c‟era errore in questa accumulazione.
Dice il mio vecchio vocabolario alla voce sentire: “dal latino sensus; meditare, riflettere, ricevere
una impressione per mezzo dei sensi, percepire con la mente, intendere, conoscere, giudicare,
apprendere con l‟animo ricevendo impressioni dall‟esterno”. Ahi, potenza e poesia dei vecchi
vocabolari!
Anche io credo che l‟esaptazione possa spiegarci come una modifica della laringe avvenuta
200.000 anni fa - conseguenza di una miglior postura eretta acquisita dalla nostra specie- sia stata
essenziale 150.000 anni dopo per attivare i meccanismi fisici del linguaggio, ma penso anche che
questo non serva a capire perché quel meccanismo si è attivato, né perché quella mutazione –una
volta avvenuta- da sola sia stata in grado di consentirci quella “muta” intellettuale che ci ha fatto
perdere la nostra pelle animale che ci ha trasformato negli uomini di oggi. Faccio questo discorso
non per confutare le ipotesi auto evolutive (cioè cambiamenti prodotti da fattori autogeni), ma
perché ritengo che le mutazioni endogene vadano lette in un quadro più ampio di fenomeni
adattativi legati ai cambiamenti ambientali.
Penso invece che noi uomini nel leggere noi stessi attraverso noi stessi cadiamo spesso in una forma
d‟abbaglio, in una angolazione prospettica da cui riceviamo una percezione distorta della realtà. Io
credo che per meglio comprendere un fenomeno così complesso dovremmo rompere il nostro
canonico antropocentrismo e provare ad uscire dal Noi immaginandoci come una semplice tessera
all‟interno di un puzzle naturale ben più vasto (cosa molto facile a dirsi e molto difficile a farsi). Ma
se riteniamo che solo dopo aver superato quella “soglia” si sia diventati pienamente e
compostamente uomini (passaggio che alcuni autori stigmatizzano aggiungendo un doppio sapiens
alla nostra classificazione linneana, come a marcare una netta differenza tra il primitivo uomo
sapiente e l‟uomo due volte sapiente) non possiamo leggere i fatti che precedono quel momento con
gli occhi di noi uomini d‟oggi. Dobbiamo immedesimarci nella vita quotidiana di quei nostri
predecessori di mille e mille generazioni fa, provare a collocarci nel loro contesto fisico e
ambientale e tentare di “sentire” (nel senso latino del termine) il mondo con lo spirito di quei nostri
lontani antenati.
Per fare questo dovremmo provare a ragionare su alcuni aspetti esterni a noi, quali sono per
esempio, i cambiamenti climatici, le trasformazioni degli ambienti naturali che ne conseguono, la
competizione tra specie generate da queste trasformazioni e le conseguenze che a caduta sono
derivate sui comportamenti dei nostri antenati, scendendo mentalmente in quel mondo esterno a noi
che era scosso e sollecitato da una imponente trasformazione climatica.
Tentiamo di dare un senso a questo assunto appena formulato e proviamo a guardare il mondo di
50.000 anni fa .
31
Da quanto conosciamo fino ad ora (sia nell‟ipotesi Mediorientale che in quella Sud Africana)
appare in tutta evidenza che i cambiamenti comportamentali dei nostri progenitori sono avvenuti
proprio nella fascia climatica a “clima mediterraneo”, grosso modo nelle aree comprese tra i 30 e i
40 gradi di latitudine, tenendo a mente che a quell‟epoca il nostro areale di espansione era limitato
all‟Africa e all‟Eurasia perché le Americhe e l‟Australia erano ancora da raggiungere (in realtà
raggiungeremo l‟Australia proprio in quei millenni approfittando di un parziale ponte di terre
emerso grazie alle glaciazioni, e la marginalità di quei pochi “esploratori” e il successivo
isolamento legato alla fine delle glaciazioni ha di fatto comportato la straordinaria originalità della
flora e della fauna australiana).
Ma, che cosa ci potrebbe essere stato di così particolare nell‟ambiente di quelle zone da indurre
nella nostra specie cambiamenti tali da “umanizzarla”? Con molta probabilità altri cambiamenti!
Le fasce temperate - all‟interno delle quali vanno inserite quelle a clima “mediterraneo”, erano tra
gli ambienti naturali che stavano risentendo in modi particolari dell‟irrigidirsi progressivo del clima,
e la logica risposta di molte specie viventi a questi cambiamenti fu quella di mutare per adattarsi
alle nuove condizioni ambientali. Chiaramente questi tipi di adattamenti non sono sincronici ma
producono alterazioni anche significative negli equilibri tra le specie. Solo per fare un esempio: noi
(branca di Homo di relativamente recente derivazione africana) nella nostra espansione in Eurasia
siamo tra le specie che hanno saputo trarre vantaggi da questa recrudescenza del freddo a danno del
Neanderthal (che se era evoluto proprio con un adattamento naturale al freddo). Cosa davvero
sorprendente!
Ma come già visto il clima rigido invernale non è un nemico della genesi di nuove specie o della
crescita e adattamento di quelle già esistenti, anzi alcune risultarono decisamente avvantaggiate:
quali? Tutte quelle dotate o che si possano dotare di meccanismi di accumulo delle riserve
energetiche (generalmente oli e amidi per le piante, grassi per gli animali e zuccheri per gli insetti)
che consentano di superare con il minor sforzo possibile la stagione invernale che – nelle aree
temperate - si presenta con 4-5 mesi di temperature rigide, di piogge frequenti e di poche ore di
luce. Ovviamente non è il freddo in quanto tale ad avere una funzione positiva o negativa sulle
specie, sono l‟insieme dei cambiamenti climatici che favoriscono alcune specie e sfavorisce altre.
Torniamo quindi a svolgere questo tema con più dettagli.
Di certo gli inverni freddi e umidi rappresentarono per i Sapiens una barriera che i nostri antenati
poterono superare solo ricorrendo –in ambito comportamentale- a delle nuove strategie adattative.
Per prima cosa cercando rifugi nelle grotte o sotto grandi incavi di rocce (in Africa equatoriale non
c‟era bisogno), poi rivestendosi con pelli recuperate dagli animali uccisi nella caccia (riacquisendo
così artificiosamente quella dote di peli che avevamo perso con le antiche mutazioni) e utilizzando
il fuoco come supporto al riscaldamento e non solo come mezzo per cucinare o per tenere lontane le
fiere. Quello che i sapiens fecero culturalmente (cioè acquisendo nuovi comportamenti) le piante e
gli animali avevano già fatto geneticamente, si erano cioè adattate diversificandosi con nuovi
cultivar e nuove specie. La vegetazione era quella che aveva risposto ai mutamenti climatici con
gli strumenti più sorprendenti.
32
Nella savana africana la maggior parte delle piante erbacee sono graminacee perenni, piante
caratterizzate da grossi culmi rigettanti e profondi apparati radicali. Questo tipo di piante resiste
tranquillamente alla stagione asciutta facendo seccare la parte aerea e rigenerandosi velocemente
all‟arrivo delle prime piogge. Queste piante utilizzano per la riproduzione l‟impollinazione
anemofila (quella fatta dal vento), i loro semi sono di conseguenza piccoli e leggeri e non
rappresentano per gli uomini e per i grossi animali una fonte significativa di approvvigionamento
alimentare. Ci sono poi le piante perenni che come strategia adattativa hanno sviluppato un
apparato radicale modificato in tuberi o in rizomi, che consentono loro di immagazzinare sotto terra
preziose scorte alimentari. Queste piante sono una ottima fonte di sopravvivenza per gli uomini e
animali durante il periodo secco e sono a tutt‟oggi una importante fonte di cibo per alcune
popolazioni nomadi. Nella savana africana sono invece molto limitate le leguminose erbacee
(sostituite da quelle arboree come le acacie), eccellente fonte di alimentazione per molti erbivori,
ma di fatto poco utilizzabile dagli uomini. In generale il ciclo di vita della flora è comunque
pluriannuale, quasi a voler dire che quelli sono ambienti dove la flora non può sprecare troppe
energie per ricercare strategie riproduttive.
Nelle regioni a ciclicità tetra-stagionale come quelle temperate c‟è una forte presenza di piante
erbacee annuali e –mentre la flora perenne basa la sua strategia riproduttiva sui numeri- la flora
annuale deve applicare meccanismi riproduttivi molto più ingegnosi dotando i propri semi di
strutture biologiche più complesse. I semi di molte di queste piante nascono con le piogge
autunnali, sopravvivono durante l‟inverno, crescono con i primi caldi primaverili e spigano (ossia si
riproducono) all‟inizio dell‟estate. Questi semi caduti sul terreno restano dormienti durante il
periodo caldo e secco della fine estate per poi germinare con le piogge del successivo autunno o con
l‟arrivo dei primi freddi. A differenza dei semi delle piante perenni che si disperdono nei periodi
che precedono la stagione delle piogge questi semi devono rimanere sul terreno per tre - quattro
mesi fino alla fine dell‟estate. Per superare questo periodo i semi (specie delle graminacee) sono
dotati di un tegumento duro –quasi vitreo- che protegge la vitalità del germe rinchiuso al loro
interno, più glume e reste che fungono da protezione contro insetti e uccelli che vogliano cibarsene.
Altre piante erbacee hanno un ciclo ancora più corto (spesso sono leguminose): nascono in
primavera, crescono con l‟inizio dell‟estate e terminano il proprio ciclo vitale con l‟arrivo dei primi
caldi, lasciando cadere i semi sul suolo che rimangono indeiscenti per vari mesi. In entrambi i casi i
semi devono superare l‟estate che -essendo calda e secca- non rappresenta un problema per la loro
conservazione e sperare di arrivare senza essere predati all‟autunno-inverno. Per questo lungo
periodo di latenza i semi di queste piante annuali sono come delle piccole cassette di sicurezza che
la natura riempie di amidi e di oli in grado di garantire il giusto apporto di energia al germoglio nel
momento della germinazione; tutto questo li rende molto appetibili ai predatori in grado di
utilizzarli.
Ma non c‟è solo il problema della difesa e della deiscenza, questi semi devono anche assicurare che
il germe non marcisca con l‟umidità portata dall‟arrivo di una pioggia occasionale o di un primo
freddo autunnale. La giusta epoca di germinazione è infatti essenziale per assicurare la propria
discendenza. Ma proprio quel pericarpo rigido che serve a proteggerli dai fattori esterni può
rappresentare una barriera alla germinazione. Ecco allora che molte piante di clima mediterraneo
hanno adottato un complesso processo biologico che in agronomia si chiama “vernalizzazione”;
33
ossia la necessità –prima di germinare- di attraversare un periodo di basse temperature, segnale che
assicura che il seme non si trovi davanti all‟umidità portata da una pioggia occasionale ma che è
arrivato alla giusta epoca di germinazione. La vernalizzazione è uno dei meccanismi di adattamento
al clima più perfetti che si conosca, il freddo e l‟umidità invernale funzionano infatti come starter
per complessi meccanismi fisiologici e biochimici, attivando degli enzimi che hanno l‟effetto di
stimolare la crescita del germoglio. Non c‟è davvero ragione di dubitare dell‟ingegnosità della
Natura.
Come molte specie erbacee gli alberi e gli arbusti di queste zone fecero le stesso iniziando a
proteggere i loro semi o con esocarpi (mandorle, noci, ghiande) o con mesocarpi legnosi ( olive,
ciliegie, prugne). Anche questi sono meccanismi molto complessi perché per un lato la Natura deve
riempire i semi di sostane energetiche mentre in contemporanea deve organizzare strutture di
protezione legnose che ne scoraggino la predazione.
Per le stesse ragioni climatiche anche molti mammiferi presenti nell‟area avevano adottato strategie
particolari: molti ispessivano la pelliccia durante l‟inverno e la diradano in estate, altri
accumulavano riserve di grasso sottocutaneo o in punti specifici del corpo. Alcuni roditori
organizzavano “dispense” alimentari in luoghi protetti, altri -come le api- costruivano gli stessi
magazzini dove poi andavano a riporre il concentrato alimentare che sarebbe servito all‟intero
alveare per passare l‟inverno. Molti uccelli migravano; i piccoli animali a sangue freddo, come
lucertole, orbettini, serpenti, passavano l‟inverno nascosti dentro tane ricavate tra le pietre
adottando la strategia straordinaria del letargo. I grandi rettili –come abbiamo già visto- erano
assenti semplicemente perché non furono capaci ( o interessati) ad organizzarsi per passare li freddo
invernale.
C‟era poi un altro meccanismo adattativo strettamente fisiologico che riguarda le femmine partorite
e la loro prole. Per consentire ai neonati di fronteggiare i mesi di scarsità dell‟erba- sia invernali che
estivi- le puerpere avevano sviluppato in forma ipertrofica i loro apparati mammari e modificato la
loro attitudine all‟allattamento. Questo fenomeno non succede in Africa dove i parti coincidono con
l‟inizio della stagione delle piogge, quando le erbe sono sovrabbondanti e dove i cuccioli sono
indotti –dal contesto naturale- a una precoce autonomia. Ma nelle fasce temperate può succedere
che –mentre i pascoli stanno già regredendo per la siccità estiva- i cuccioli non siano ancora pronti
allo svezzamento. Ecco allora che la madre –ricorrendo alle riserve energetiche di grasso corporeopuò prolungare l‟allattamento e integrare la prima alimentazione verde dei cuccioli con un
significativo apporto di latte. Anche noi sapiens ci siamo adattati a questa priorità biologica, infatti
le popolazioni che vivono in clima rigidi o con scarse ore di luce invernale mantengono attiva la
lattasi, l‟enzima che consente di digerire il latte anche dopo lo svezzamento.
Nella Bibbia Jahvé ordina a Mosè di radunare il suo popolo e lasciare l‟Egitto affinché sotto la sua
guida siano in grado di superare il mare e il deserto ed arrivare alla terra dove scorre il latte e il
miele. Gli estensori della Bibbia sbagliarono solo per difetto immaginando che la terra che li
attendeva fosse quella che Mosè vide dall‟alto del monte Nebo, perché quasi tutti i territori della
fascia temperata sono caratterizzati da femmine di ruminanti buone allattatrici e alveari colmi di
miele, ottima riserva per superare l‟inverno.
34
I nostri antenati, che avevano colonizzato quelle aree già da migliaia di anni e che erano alla loro
terza colonizzazione come genere Homo, questa volta impararono dalla Natura che li circondava a
fare lo stesso. Non era una cosa scontata! Avrebbero potuto continuare a vivere solo della caccia e
della predazione delle risorse e/o raccogliendo quello che la stagione invernale aveva da offrire
come i tuberi e alcuni rari frutti invernali (erano quello che avevano sempre fatto e che facevano
ancora i Neanderthal). Ovviamente il loro numero sarebbe stato determinato proprio dall‟offerta di
cibo stagionale che avrebbe funzionato come fattore limitante.
Invece – sconvolgendo per l‟ennesima volta il loro modello alimentare, che cosa fecero?
Cominciarono a raccogliere quegli strani semi coperti da glume e i primi – ancora minuscolibaccelli di leguminose, iniziando a fare concorrenza non più e non soltanto ai grandi predatori, ma
anche ai piccoli roditori e agli uccelli. Aggiungendo i semi di cereali e di leguminose selvatiche alla
nostra base alimentare i nostri antenati stavano dando un considerevole contributo energetico alla
loro dieta, che si aggiungeva all‟apporto proteico legato all‟uso di molluschi, gasteropodi e anfibi e
pesci (gettando così le basi di quella che ancora oggi è la nostra base alimentare).
Non sappiamo di preciso da quanto tempo questi semi “maggiorati” fossero apparsi, ma è probabile
che alcune mutazioni adattative siano da far coincidere proprio con l‟affermarsi dell‟ultima
glaciazione. Alcuni studi sui pollini fossili dimostrano inconfutabilmente che durante il picco di
glaciazione le graminacee con queste caratteristiche fossero dominanti in tutte le aree mediterranee
e che ci sono buone tracce anche di leguminose. In alcune zone, quelle più fertili, più riparate dagli
eventi esterni, più umide, in una stagione normale le cariossidi erano più abbondanti e più grosse.
E‟ facile immaginare che i nostri antenati concentrassero in queste zone la loro raccolta casuale. Ma
per fare cosa? Cacciare da un beneficio immediato: si uccide la preda e la si consuma in alcuni
giorni. Anche raccogliere risponde alla stessa logica; camminando si incontrano frutti commestibili
o tuberi o germogli o foglie, li si raccoglie e li si mangia. Tuttalpiù li si lascia per la cena. Ma
raccogliere cariossidi e baccelli implica l‟idea di conservazione e di trasformazione. Si raccolgono i
semi ma per farne cosa? Non è sufficiente tenerli nella mano, per prima cosa li si deve mettere da
qualche parte. Le formiche li accumulano sottoterra, i topi di campagna nelle loro tane. I nostri
antenati avevano notato cosa facevano gli animali accumulatori? Certo che si! Avevano sicuramente
già notato cosa facevano le api con il miele, i ghiri e gli scoiattoli con le ghiande, le formiche con i
semi. L‟ambiente naturale a quelle latitudini è un mondo dove gli animali immagazzinano. Anche le
capre e le pecore selvatiche accumulavano il grasso nella loro coda, perché l‟inverno –a volte- può
essere anche inclemente e bisogna avere delle buone scorte alimentari per superarlo senza
problema. Non abbiamo trovato silos di 40 mila anni fa. Probabilmente ancora non c‟erano, forse
erano solo buche per ammassare i semi in una zona al riparo della pioggia, forse erano borse di
pelle da portare a spalla. Ma di sicuro i nostri antenati avevano cominciato ad organizzare le prime
dispense alimentari – magari ancora rozze- ma capaci di rispondere a quei primari bisogni.
Ma l‟utilizzo delle cariossidi e dei baccelli non è solo un problema di conservazione. Quei semi
vanno vagliati, ossia vanno liberati dalle glume e dalla pellicola che ricopre i baccelli. Per questo
molti uccelli non possono predarli. Come ho già detto la Natura difende quei semi come se fossero
delle piccole casseforti. Vagliarli è un lavoro paziente e faticoso, ma quello che i nostri
35
predecessori ricevevano in cambio di quel lavoro era oro. Piccoli chicchi pieni di amidi, di oli e di
proteine che ricompensavano qualsiasi fatica. E parlando di lavoro la fatica non finiva qui. Per
trasformare quei chicchi in alimento bisognava frantumarli, anzi più che frantumarli! La loro
ricchezza era all‟interno e per appropriarsene bisognava ridurli in polvere ( la farina). Così i nostri
antenati fregando i semi tra due pietre inventarono le prime mole (ne abbiamo alcune testimonianze
risalenti a circa 30.000 anni fa con pietre che sono servite a macinare i semi di alcune erbe palustri).
Quanti passaggi per utilizzare quei piccoli semi selvatici, ma la risorsa era abbondante e distribuita
in diversi mesi dell‟anno, la raccolta facile, specie se comparata con la caccia (da alcune prove
effettuate in Medio-oriente una quindicina di giorni di raccolta sono in grado di assicurare
l‟immagazzinamento dei cereali selvatici necessari per i consumi di un intero anno).
Poi era una fatica che si poteva condividere, fatta con dei tempi e dei modi programmabili. Si
potevano organizzare battute comuni di raccolta, si macinava insieme ad altri, lo potevano fare tutti
specialmente quelli o quelle che non erano occupati nella caccia e –cosa più importante- lo
potevano fare gli inabili alla caccia e infatti questo è quello che fecero (questo significa che la forza
e il coraggio dei cacciatori non erano più i fattori principali di successo di un gruppo di sapiens).
Ma quel cibo non era ancora pronto, non si mangia la farina! Bisognava amalgamarla con l‟acqua,
poi cucinarla e -badate bene- non era come cucinare la carne sul fuoco. Questo era un cibo che
andava manipolato, a cui bisognava dare una forma. Ma era una nuova fonte di cibo straordinaria,
tanto straordinaria che faremo quello che la Natura non aveva disposto che noi facessimo.
Modificare la nostra fisiologia per digerire questo nuovo cibo. Ricordate la nota di qualche pagina
fa? Io non avevo fatto commenti ma spero che tutti lo abbiate notato! Sulla nota riguardante le
mutazioni dei gruppi sanguinei c‟è scritto che l‟apparire del gruppo A è databile intorno ai 20.000
anni fa e si pensa che sia legato al cambiamento della razione alimentare a seguito
dell‟introduzione nella dieta dei cereali. Io non ho idea se la datazione sia giusta, anzi penso che
andrebbe retrodatata. Ma di sicuro l‟introduzione volontaria di quei semi (quindi del glutine e degli
amidi) nella nostra dieta è un atto che sovverte molti equilibri perché pone la nostra specie oltre il
determinismo della Natura che colloca ogni gruppo animale all‟interno di un recinto
comportamentale prefissato.
Questi nuovi comportamenti acquisiti ci inseriscono poi in una dimensione temporale diversa. Una
cosa è vivere alla giornata (scherzando sul modo di dire) altra cosa è pianificare il futuro, come fa
chi accumula derrate alimentari per poterle utilizzare in un momento di carenza. Certo altri animali
lo facevano ma noi no, Noi eravamo nati come animali spazzini e raccoglitori e cacciatori
occasionali. Studiare, capire e riprodurre quello che facevano altri animali è stato un atto
rivoluzionario compiuto verso la Natura e verso noi stessi. Gli uomini e le donne che hanno
cominciato a spigolare sono passati da una economia legata alla logica predatoria a quella della
programmazione, e per programmare bisogna pensare, organizzare, bisogna contare e comunicare.
Ma c‟è un altro aspetto essenziale che è doveroso sottolineare: l‟accumulazione dei semi porta
all‟acquisizione di comportamenti relazionali paragonabili a quelli degli animali sociali e tutti gli
animali sociali hanno forme complesse di comunicazione, hanno il lavoro come un intrinseco valore
e hanno delle forme di gerarchia per gestire le complessità relazionali. Noi uomini abbiamo trovato
36
la comunicazione attraverso la voce, ma sarà l‟accumulazione di un “bene” il gesto che ci imporrà
la parola?
Dopo tanto riflettere io penso che è stato questo il passaggio che ci ha portato ad elaborare una
forma comunicativa più complessa. Fino a quando siamo rimasti chiusi nel recinto di una economia
predatoria (sia di caccia che di raccolta) i suoni emessi, la gestualità delle mani e del corpo e la
mimica maxillofacciale sono stati sufficienti ad esprimere la gamma dei nostri bisogni. Con la
spigolatura, l‟immagazzinamento e la lavorazione dei semi e con la trasformazione di quei semi in
cibo servivano nuove e più complesse forme di scambio comunicativo. In altre parole possiamo dire
che dopo l‟ausiliare “essere” stava nascendo l‟ausiliare “avere” con tutte le forme verbali
accessorie: tenere, possedere, conservare, organizzare; così la voce – strutturata in pensieri espressi
- si è dimostrata lo strumento più idoneo ad accompagnare tutti questi cambiamenti e non solo lo
stroma su cui si sono costruite quelle protolingue in uso tra i nostri antenati.
Della stessa portata rivoluzionaria è stato il sommovimento all‟interno delle relazioni sociali. Dove
prima c‟era la sola gerarchia dei cacciatori a sostenere in termini alimentari l‟intero gruppo
famigliare (con una struttura di potere molto verticale) ora la struttura sociale si era ampliata
considerevolmente, perché i bisogni alimentari erano assicurati anche dalle figure più marginali: i
bambini –che erano i più veloci a cogliere le piccole spighe, le donne che pure puerpere avevano il
tempo e la forza per battere i grani, pulirli dalle reste e dalle glume, per poi macinarli e a farne
focacce, fino agli anziani a cui l‟aumento e la diversificazione dell‟offerta alimentare consentiva per
la prima volta di trovare una loro collocazione produttiva (occupandosi anch‟essi del lavoro), o
indirettamente produttiva, badando al focolare, custodendo le scorte o accudendo i cuccioli di uomo
mentre le madri erano occupate in altri lavori.
Sono questi i millenni in cui immaginiamo l‟affermarsi di una vera e propria economia di
prossimità, legata all‟aumento delle nascite in una rapporto maltusiano tra offerta alimentare e
popolazione e all‟innalzamento significativo dell‟età media che passa dai 25 ai circa 40 anni; un
prolungamento che consente la “comparsa” dei nonni, e che sarà uno strumento straordinario per
l‟affermazione di noi Sapiens. Questi sono infatti i millenni dove si produce una frattura definitiva
tra noi, raccoglitori e mangiatori di semi e i Neanderthal semplici cacciatori. La fine la conosciamo!
Semi: abbondanti, disponibili, accumulabili e manipolabili! Con l‟utilizzo dei semi gli uomini non
hanno trovato soli una fonte energetica straordinaria e pressoché illimitata e una nuova nicchia
alimentare da utilizzare senza concorrenti pericolosi, ma hanno anche gettato le basi per la conta e
per il tempo, e il fare diventa cultura materiale, e la parola la trasmette, e la cultura materiale
diventa cultura simbolica, così -quando il suono diventa verbo- diventa capace di esprimere atti e
sentimenti e l‟Homo diventa uomo.
Aggiungo solo alcuni altri pezzi di pensiero a questo ragionamento. Ho detto prima che una volta
raccolti i semi bisognava macinarli e poi impastarli con l‟acqua per poi dare una forma alla massa
così ottenuta prima di cucinarla. Ma c‟è un altro uso possibile di quei semi un uso insolito e per
alcuni versi “sconvolgente”. Se lasciamo quei semi di cereali nell‟acqua per alcuni giorni questi
cominciano a fermentare attivati da un processo naturale che trasforma gli amidi e gli zuccheri in
alcol. Abbiamo così ottenuto la prima birra. Conosciamo il potere trascendente di questa e di
37
qualunque altra bevanda fermentata e sappiamo che è tale da alterare il normale stato di coscienza,
siamo quindi tenuti a riflettere sul potere comunicativo e creativo di quello stato. Capisco che
l‟affermazione è pesante e che si presta a molte critiche “morali” , ma questo non mi esime dal
suggerire e consigliare – di valutare pacatamente- l‟ipotesi che i primitivi usi delle sostanze
psicotrope o inebrianti possono aver influito – insieme agli altri aspetti sopradescritti - sui
meccanismi che hanno portato i nostri antenati a quella “muta” che ci ha trasformato in uomini.
Ma prima di chiudere questo capitolo e continuare il sentiero mentale che ci porterà ai temi più
specifici dell‟agricoltura penso abbia senso soffermarci ancora un poco su questo nostro
comportamento acquisito.
Come abbiamo visto ci sono ambienti naturali dove non c‟è bisogno di immagazzinare risorse. Non
lo fanno né le piante né gli animali perché è inutile o controproducente farlo. Cito un aneddoto
ascoltato qualche tempo fa: la scelta varietale e la cura con cui vengono accuditi i fiori lungo gli
argini dell‟autostrada che unisce l‟aeroporto alla città di Singapore induce le api a non accumulare
più il miele, visto che la fioritura continua comporta l‟inutilità delle scorte.
Ci sono invece regioni della terra che obbligano le piante e gli animali o a migrare durante
l‟inverno, o ad andare in letargo, o ad accumulare riserve alimentari, e queste devono essere più
consistenti man mano che per latitudine diminuiscono le ore di luce invernale. Solo i predatori
possono ignorare questa legge biologica, ma allora la natura relaziona il loro numero in base alla
quantità di prede cacciabili nei periodi invernali. L‟uomo è stato l‟unico animale capace di superare
questo determinismo biologico, non tanto perché omnivoro (tra i mammiferi anche altri animali lo
sono), ma perché grazie alle dita (che si sono rivelate perfette per la raccolta dei semi) e alle mani (
capaci di utilizzare le pietre stondate per la molitura) ha potuto integrare il suo approvvigionamento
alimentare anche con la raccolta dei semi, attingendo così a una riserva che prima era utilizzata solo
dai piccoli roditori, da alcuni insetti e alcuni uccelli.
Ovviamente si accumula, dove si può accumulare, dove ci sono le condizioni per dare seguito a
questa necessità comportamentale. Nell‟Africa orientale dove siamo nati quelle condizioni non
c‟erano! Ve lì immaginate i nostri progenitori pingui di grasso ben immagazzinato sui fianchi, sulla
pancia e sulle natiche arrampicarsi sugli alberi o correre veloci per salvarsi da qualche predatore? O
–ve li immaginate- immagazzinare qualche manciata i semi o un pezzo di carcassa per poi vedersela
assalire da una scia d‟insetti o fungere da richiamo per qualche altro animale predatore? Forse nella
mutazione che ci ha portato al Sapiens c‟era già questo intrinseco comportamento di specie, solo
che nell‟Africa orientale era inutile o inopportuno estrinsecare a pieno questo comportamento. Per
questo ho citato l‟aneddoto delle api. Ammesso che l‟aneddoto sia vero solleva un tema
interessante: dove mai s‟erano viste le api che non riempiono di miele il loro alveare? Ma – anchedove mai s‟era visto un ambiente naturale che fosse fiorito 12 mesi all‟anno. Appare evidente che i
cambiamenti ambientali sono in grado di generare mutazioni fisiche e anche cambiamenti
comportamentali.
Il problema è però un altro! Dove i comportamenti sono condizionati dall‟istinto l‟arbitrio è
marginale. Gli animali fanno quello che il loro istinto dice di fare: le api accumulano il miele, le
formiche i semi e gli orsi il grasso sottocutaneo. C‟è un limite? Ci sono parametri? Ancora non lo
38
sappiamo! Può una colonia di formiche estinguersi per non aver lavorato quanto bastava per
assicurarsi la sopravvivenza davanti a un inverno particolarmente lungo e rigido? Non lo sappiamo,
perché non sappiamo da dove deriva la loro “saggezza”! Cioè non sappiamo valutare quali solo gli
input istintuali che governano sia i singoli individui sia una colonia nella costruzione di una
dispensa alimentare: fanno il massimo del lavoro possibile (ossia lavorano a cottimo) per tutta
l‟estate seguendo un input standard? O lo fanno relazionandolo ai loro consumi e programmando le
loro riserve in relazione al clima che verrà nell‟inverno successivo? Per quanto sia assurdo noi non
sappiamo come gli altri animali sociali riescano a programmare e gestire le loro riserve e – in
contemporanea- trovare un corretto equilibrio tra i loro bisogni di specie e il loro ambiente naturale.
Eppure questo è un punto fondamentale, perché gli altri animali sociali non condizionano
l‟ambiente dal quale traggono gli alimenti ma sono dall‟ambiente condizionati.
Mentre noi animali (o eravamo animali?) privi di quell‟input naturale il comportamento
accumulatorio lo abbiamo acquisito per analisi, elaborazione e emulazione. Quindi il nostro
accumulare non è naturale ma culturale. Il problema sorge dal fatto che abbiamo acquisito il
comportamento senza acquisirne quei contorni e quei limiti che ci possano suggerire dove sarebbe
meglio fermarsi prima di mettere a repentaglio gli equilibri dei singoli individui e dei biomi.
Si potrebbe rispondere, ma se noi fossimo una specie condizionata dagli input comportamentali
saremmo ancora Homini e non uomini. Forse si; ma guardate quanti obesi ci sono oggi nei paesi
produttori di surplus alimentari (capite: surplus alimentari! Una bestemmia nei confronti della
Natura). Messi di fronte all‟abbondanza molti uomini continuano a comportarsi come se fossero in
carenza di cibo, mangiano senza un reale bisogno e senza un corretto limite. Guardate quanto è
iniqua la distribuzione del cibo sulla terra con oltre un miliardo di persone che vivono in aree di
sottoalimentazione e non certo perché il loro territori siano poco produttivi.
Guardate quanti disastri ecologici abbiamo provocato per questo nostro modo compulsivo di dare
valore alla produzione di beni qualche volta anche superflui. Ma che cosa volete? Gli animali non
accumulano per aver sviluppato un desiderio di possessione ma solo come strategia per assicurare la
sopravvivenza della specie. Il piacere di possedere (o peggio ancora il bisogno) è una drammatica
deriva che solo gli uomini conoscono. Fino ad arrivare all‟oggi dove misuriamo il valore delle
persone o delle loro società in base alla capacità di accumulare prescindendo da cosa e da come.
Possedere le cose è ciò che rende gli individui ricchi agli occhi di molti uomini, e pensare che tutto
è nato mutuando i comportamenti istintivi di alcuni animali. Ma prima di arrivare a queste forme di
aberrazione dei comportamenti accumulatori ( pensate abbiamo riserve anche di gas nervino e di
armi nucleari) devono passare ancora vari migliaia di anni, per adesso dedichiamo la nostra
attenzione a questi millenni magici della storia umana (forse i più importanti della nostra storia
evolutiva) e cerchiamo di seguirne gli sviluppi.
39
La grande trasformazione
Sono giorni che sto fermo su questo capitolo, forse perché in questo mese di agosto il caldo non è di
grande aiuto alla scrittura o forse perché siamo arrivati a un ennesimo nodo gordiano, per sciogliere
il quale dovrei essere capace di trovare le parole efficaci per descriverlo e idee lucide e lineari per
affrontarlo, mentre invece tutto sembra cospirare perché la mia personale comprensione si ritrovi in
piena aporia.
Quella “muta” che ci ha portato a essere uomini (e quindi anche a lavorare coattamente per produrre
cibo) è in se stessa un atto tanto incredibile che rifugge dalle normali analisi e dalle consuete
interpretazioni. In verità potrei sorvolare il problema, scantonarlo come fanno molti di coloro che
non trovano risposte, dare per scontato che questi sono i millenni della nostra “umanizzazione”,
continuare il nostro racconto e andare oltre. Ma di questo non sono capace, o per meglio dire: non
sono capace di andare avanti aggirando questo ostacolo, perché -se l‟intento di questo scritto è
quello di raccontare il nostro percorso di uomini coltivatori, la vera narrazione – formalmentecomincia proprio da qui, da quando siamo diventati “completamente” uomini.
Che cosa può essere successo alla nostra specie 40-50.000 anni fa in Medioriente (o forse 10-15.000
anni prima in Sud Africa)? Quale sommovimento profondo del nostro modo di essere ci potrebbe
aver portati a modificare così profondamente i nostri comportamenti fino a spingerci a superare
quella soglia che ha portato alcuni studiosi ad aggiungere un secondo sapiens alla nostra tassonomia
ed altri studiosi a dividerci in sapiens moderno e sapiens contemporaneo? Come abbiamo visto
sono in molti a ritenere che questo passaggio sia legato all‟acquisizione del linguaggio, come a dire
che è la parola che ha fatto l‟uomo; ricordate: al principio era il Verbo! Eppure siamo Homini da
quasi due milioni di anni, certo prima eravamo solo abili, solo più tardi siamo diventati sapientes.
Può essere la parola il germe di questa sapienza o è l‟acquisizione della “sapientia” che indusse gli
uomini a comunicarla tra loro? Un pensatore come Origene, vissuto all‟epoca del tramonto dell‟età
classica, quando i pensieri sugli uomini si erano fatti più introspettici, riteneva che nell‟uomo
coesistesse una seconda natura che andava oltre a quella prefigurata dalle leggi zoologiche. Una
seconda natura che l‟ha portato a scegliere “non in obbedienza a una struttura preesistente, ma solo
per decisione propria, facendosi egli stesso Natura”. Origene postulò che alla base del nostro essere
uomini c‟è la ricerca e pure il tentativo, c‟è quel cogliere il frutto nel giardino dell‟eden che ci ha
gettato nel purgatorio del pensiero ma che ci ha fatto autonomi del nostro destino. Pensieri possenti
che gli costarono la condanna come eretico, che però non affrontano la domanda: perché? Origine
1500 anni fa suggeriva che fosse la curiosità a dettare i contorni della nostra storia evolutiva. Ecco
allora che insieme alla bocca ritornano i piedi- questa parte anatomica così unicamente umanaritorna questo nostro andare, questo uscire dagli ambienti naturali per esplorarne altri, con gli occhi
vigili e i sensi pronti, non per paura ma per desiderio di vedere, agire, capire. E torna l‟idea che i
contatti, gli incontri, gli scambi di oggetti e di idee e di parole abbiano potuto funzionare come
sinapsi capaci di rompere l‟isolamento dei piccoli gruppi ed inserirci nel ristretto novero delle
40
specie eusociali, dove le relazioni zoologiche sono basate sul lavoro, sulla cooperazione e sullo
scambio d‟informazioni (e sulla gerarchia).
Ovviamente ci saranno nuovi studi della nostra storia evolutiva e della nostra umanizzazione, nuove
scoperte che porteranno a negazioni e nuove interpretazioni, ma io penso che il momento in cui
l‟uomo si è dato una meta non potrà mai appartenere alla sola categoria della scienza ma anche a
quella dello spirito, un po‟ come quando parliamo dell‟origine dell‟universo. Inoltre - se diamo un
senso al nostro camminare- allora l‟uomo è uomo fin da quando è apparso in Africa 200.000 anni
fa. Già quell‟uomo guardava le stelle e cercava di capire cosa quel cielo notturno potesse suggerire
o quello che potevano dirgli il vento e le nubi che si ammassavano all‟orizzonte, già quell‟uomo
guardava la Terra e cercava i segni per capire quale era la direzione da prendere, quali le orme da
seguire. Non era il pensiero che mancava a quell‟uomo, erano gli strumenti ancora scollegati a quei
pensieri. L‟uomo era –forse- già uomo al momento del suo apparire. Noi eravamo in nuce quello
che ora siamo, ma la nostra dipendenza dall‟ambiente naturale e il nostro relativo isolamento era
tale che dovevamo attendere che si sovrapponessero e incastrassero alcune condizioni come in un
cubo di rubrick perché la nostra “humanitas” avesse il predominio sulla bestia.
Fattori endogeni (cioè interni a noi), fattori esogeni ( ossia esterni a noi), c‟è qualcosa di altro a cui
si possa pensare per lacerare queste tenebre? Forse si! Forse ci sono cose fatte da nostri antenati
sapiens – gesti e opere da Homo faber che potrebbe avere avuto sull‟evoluzione dell‟Homo
sapiens. Per questo nel precedente capitolo mi sono dilungato sulle conseguenze di quel nostro
essere diventati granicoli, ossia sulle ricadute evolutive di quel cambio di strategia alimentare legato
alla raccolta, l‟immagazzinamento, la lavorazione dei semi, per finire con la cottura.
Ho anche accennato al ruolo che potrebbe aver avuto la produzione casuale delle prime bevande
alcoliche come strumento di affabulazione (il valore del “perdersi” per “trovarsi”) perché penso che
gli effetti disinibitori dell‟ebbrezza sulla comunicazione – quell‟ebbrezza che suggestiona il
cervello, libera la parola e induce il riso (siamo gli unici animali che ridiamo)- potrebbe essere un
altro cofattore dell‟umanizzazione.
A questo potrebbe (e credo dovrebbe) essere aggiunto l‟uso di alcune sostanze psicotrope di origine
vegetale che- proprio in quei millenni- i nostri antenati avevano cominciato a consumare
aspirandone il fumo attraverso le prime pipe. Anche in questo caso vale il discorso appena fatto:
sapiens e animali conoscevano il potere di molte piante psicotrope ma –probabilmente fino ad
allora- nessuno le aveva ancora fumate (forma molto più potente d‟uso). E‟ opportuno però fare le
dovute distinzioni. Mentre l‟alcol è stato ipoteticamente utilizzato con una funzione sociale e
collettiva le varie droghe no! Per i loro evidenti stadi di alterazione della coscienza il consumo di
queste sostanze è stato tradizionalmente circoscritto a una elite che si è fatta carico della funzione di
sperimentazione e che da questo ne ha ricavato un potere di influenza e d‟indirizzo all‟interno delle
società famigliari dei sapiens.
Per sola comodità chiameremo questi uomini: sciamani, benché in realtà ben poco sappiamo del
loro ruolo e delle loro funzioni. Cosa ci potrebbe raccontare la nascita di questo “sciamanesimo”?
Ci potrebbe raccontare che stiamo attraversando millenni d‟intensa sperimentazione non solo legata
agli aspetti alimentari delle erbe (la fitoalimurgia), ma anche alle loro proprietà curative, sapendo
41
che se le piante con proprietà medicinali sono normalmente utilizzate dagli animali nei momenti di
bisogno, in questo caso non stiamo parlando del consumo in quanto tale ma delle prime
sperimentazioni sugli effetti di assunzione dei prodotti fitoterapici attraverso macerazione e
infusione) e poi ci può raccontare l‟inizio della prima stratificazione sociale all‟interno della società
paleolitica, dove una ampliata dispensa alimentare cominciava a consentire il sostentamento di
figure non direttamente occupate nella caccia o nella raccolta, ma anche nell‟artigianato e nella
medicina.
Penso comunque che non abbia senso allungare troppo il discorso a sostegno di queste ipotesi,
perché - pur convinto che le sostanze psicotrope siano state un ulteriore cofattore del nostro
percorso di umanizzazione- lo ritengo un cofattore importante ma non quello codificante. Questo
ruolo lo riservo all‟organizzazione dei primi schemi comportamentali, ossia alla nascita di quei
modelli culturali e morali attraverso i quali i nostri antenati hanno iniziato a separare quello che
avremmo potuto fare come individui e come gruppi sociali da quello che abbiamo scelto o che ci
siamo concessi di fare; espellendo o isolando da Noi alcuni comportamenti che abbiamo ritenuto
inadeguati o inopportuni al mantenimento di un stabilità sociale all‟interno dei gruppi famigliari in
progressiva espansione.
Penso che l‟umanizzazione sia questo: un equilibrio altalenante tra sperimentazione (ossia risposta
fattiva alla tentazione, presa dalla sua radice etimologica che la unisce a “tentativo”) e
regolamentazione.
Questi sono i millenni legati alla nascita di quei tabù che ancora indirizzano e influenzano molti
atteggiamenti umani. Pensate ai comportamenti sessuali, alle barriere culturali e morali con cui noi
controlliamo e restringiamo la sessualità giovanile o regoliamo il sesso all‟interno dei nuclei
famigliari. Certo l‟omozigosi (ossia il sesso tra consanguinei) è un comportamento negativo tra tutti
i mammiferi superiori e a prevenire i danni di quel comportamento ci ha pensato la Natura
espellendo dal gruppo gli animali che hanno raggiunto l‟età della riproduzione. La particolarità è
che noi – da quei millenni– abbiamo smesso di espellere gli adolescenti e – cosa strana - abbiamo
iniziato a integrarli per aumentare il numero dei componenti dei gruppi famigliari, oppure a
facilitarne l‟uscita attraverso scambi con altri gruppi famigliari per cercare o cementare alleanze (a
dimostrazione che avevamo appreso come procurarci il cibo con più facilità). Ma non ci sono solo
regole ai comportamenti sessuali. Pensate alla sindrome di Crono, al fatto - cioè - che tra gli animali
i maschi dominanti tendano ad uccidere i figli (loro e di altri padri) per non subire una futura
concorrenza per il predominio sessuale e (nel nostro caso, “politico”) o pensate ai tabù alimentari
(tra cui quelli che delineano i contorni del consumo delle sostanze psicotiche).
In realtà, come dice Pico della Mirandola, che durante l‟umanesimo ripropose e elaborò il pensiero
di Origene: “l‟uomo è animale di natura varia, multiforme e cangiante, solo a lui è concesso di
ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole”. Anche il giovane Pico, per queste riflessioni, finì
“giustamente” richiamato dalla Santa Inquisizione. “Giustamente” non perché il richiamo fosse
eticamente giusto! Ma perché – visto con gli occhi di chi crede nella genesi Divina dell‟uomo- era
sicuramente giusto richiamarlo, perché: se la Santa Inquisizione non richiamava Pico per questa sua
eretica affermazione, che senso aveva la sua funzione e la sua stessa esistenza?
42
L'‟uomo è animale di natura varia? Certo che sì, tutti noi che pure ci sentiamo lontanissimi dalle
“bestie” sappiamo e avvertiamo che nell‟uomo vive sopito uno spirito animale; pensate a quando si
scatenano quelle pulsioni sessuale collettive che noi definiamo: l‟istinto del branco! Sappiamo
anche che quell‟istinto è regimentato (o soffocato) da tutta una serie di prescrizioni morali e regole
comportamentali. Questo ci porta alla costatazione che l‟umanizzazione ha un‟incredibile ricaduta
sul nostro processo evolutivo e questo ci obbliga a leggere gli avvenimenti con un atteggiamento
duale, non più soltanto come un‟evoluzione dei nostri comportamenti legati alla selezione naturale
ma iniziando a dare un giusto peso anche ai nostri comportamenti culturali. Prendete il fenomeno
dell‟allungamento della vita media e l‟apparire degli anziani nei gruppi parentali degli Homini
sapientes. La cura e la familiarizzazione degli anziani non sono legate solo alle condizioni
ecologiche favorevoli, perché non sono solo una questione di possibilità, ma una scelta tra “quello
che avremmo potuto fare e quello che abbiamo deciso di fare”, ossia tra quello che riteniamo giusto
e quello che classifichiamo come sbagliato. In quella scelta c‟è una strategia. Gli animali hanno
questa scelta? Forse si! Ci sono alcuni esempi tra i mammiferi superiori di comportamenti
paragonabili (per esempio la cura o il dolore per la perdita di un congiunto) ma –presumibilmentenon ci sono regole sociali a codificarla e –di conseguenza- non dovrebbe esistere tra gli animali una
morale comune che ne sancisca i comportamenti.
D‟ora in avanti i nostri passi non seguiranno più il solo sentiero tracciato dalla Natura, ma ci sarà
spazio per i sentimenti e per le regole decise dagli uomini, e - l‟uso della parola- sarà capace di dare
a tutto questo un vasto livello di compartecipazione e condivisione. Che sia stato poi il linguaggio a
far nascere la compartecipazione o la compartecipazione a far nascere il linguaggio per avere un
mezzo per veicolarla è un quesito che lascio ad altri.
Siamo diventati uomini e come uomini siamo capaci di realizzare progetti o di pianificare strategie
che non rispondono automaticamente ai soli input naturali, ma valutiamo, soppesiamo, elaboriamo
ed infine operiamo delle scelte e le indirizziamo verso un obiettivo che può essere individuale o
comunitario. Non sappiamo quanto questi comportamenti “umani” fossero presenti nei nostri
antenati sapiens (come detto sopra sono tentato a credere che seppur parzialmente alcuni
comportamenti “umani” siano legati proprio alla comparsa del sapiens) ma di sicuro lo sono stati
compostamente da questa soglia in poi: la delusione per un patto tradito o per una ipotesi non
corrisposta, la tendenziale tenerezza verso creature innocenti, la gelosia possessiva, la gioia per un
risultato, la serenità per una fiducia ritrovata, la melanconia o la tristezza, oppure il senso di
inadeguatezza davanti a certe sfide, l‟ammirazione della bellezza; quanti sono i comportamenti che
ci fanno uomini? Tanti e distinti. Quando troveremo il modo di comunicare con gli animali
capiremo come e quanto questi sentimenti siano ad appannaggio dei soli uomini o se invece
appartengano alla vita in quanto tale. Ma dobbiamo presumere che una differenza di sentimenti e
sensazioni tra noi e gli animali ci sia per lo meno nella gamma nella intensità. E se è questa intensità
di sentimenti che ci fa uomini allora questa è la “muta” che andavamo cercando di spiegare e questa
“muta” è intrinsecamente legata all‟aver diviso quello che abbiamo cominciato a ritenere “bene” da
quello che abbiamo valutato come “male”.
Ma mentre i nostri antenati di quei lontani millenni erano presi dal definire i contorni (le leggi) che
limitavano e regolavano la nostra fisicità (sesso, cibo, potere individuale derivante dalla sola forza
43
fisica) per assicurare un equilibrio all‟interno dei vari contesti sociali, dall‟altra liberavano la mente
da quei sedimenti che ne incatenavano la loquacità creativa.
Quei millenni sono stupefacenti! Le dita sembrano aver trovato un‟armonia di movimenti e di
coordinazione che non si era mai vista prima d‟allora, a riprova che le sinapsi del cervello aveva
iniziato a elaborare percorsi completamente nuovi e liberi. Troviamo così i primi strumenti musicali
a fiato ricavati dalle ossa lunghe di alcune prede e collegata alla musica ecco quindi la danza (non
abbiamo testimonianze di altri strumenti a corda o a percussione, ma è possibile che ci fossero e che
non si siano conservati). Ma la gamma dei nuovi comportamenti appare infinita. Ci sono i primi
aghi e quindi i primi abiti cuciti con tendini o fibre, i primi ornamenti complessi a dimostrazione
che la vanità e la ricerca della bellezza sono altre componenti intrinseche della nostra specie. Certo
anche gli animali si ammantano di livree spettacolari e sappiamo perfettamente che tutto questo è
legato all‟accoppiamento. Ma negli uomini c‟è anche una ricerca della bellezza che trascende dalla
sola funzione riproduttiva; guardate le incisioni rupestri che ci hanno lascito quei lontani antenati o
le pitture che sono state ritrovate in alcune zone della regione franco-cantabrica.
"Da Altamira in poi tutto è decadenza ", avrà a dire Pablo Picasso.
Il "cavallo cinese" di Lascaux. 19.000-15.000 a.C.
Grotta di Chauvet, Francia 30.000 a.C.
L‟arte del Paleolitico europeo è l‟arte rupestre per eccellenza, quella delle caverne di Chauvet
(33.000-29.000 anni fa), Cosquer (25.000-20.000 anni fa), Lascaux (19.000-15.000 anni fa) e
Altamira (15.000- 11.000 anni fa). In Europa la documentazione dell'arte delle caverne, appare
singolarmente concentrata nell'area Franco-Cantabrica, con poche testimonianze in Italia e nel resto
della Penisola Iberica. Altri esempi di arte parietale paleolitica in grotta, li troviamo negli Urali,
nella Valle di Bielaya in Moravia, in Ungheria e in Romania. La conservazione eccezionale
dell‟arte paleolitica dell‟area Franco-Cantabrica si deve a una serie di fattori fortunati di carattere
geologico e climatico che hanno sigillato le grotte con l‟accumulo di detriti e pietrisco che ne ha
ostruito gli ingressi alla fine del Pleistocene, mantenendo all' interno condizioni stabili di
temperatura e di umidità. Di conseguenza solo nell‟Europa Occidentale è possibile avere un
panorama abbastanza completo e articolato dell‟arte preistorica. Nell‟arte del Paleolitico, si
distinguono due categorie fondamentali di opere:
44
L‟arte rupestre o parietale. Comprende incisioni, pitture e rilievi eseguiti sulle pareti o sui soffitti
delle caverne, molto raramente sulle pareti sotto le rocce o su superfici rocciose all‟aperto.
L‟arte mobiliare, che comprende piccoli oggetti e manufatti raggruppabili in quattro categorie
principali: ornamenti (pendagli, rondelle, figure intagliate nell‟osso e nel corno di renna); armi e
utensili (arpioni, propulsori, zagaglie, bastoni forati, decorati con incisioni, rilievi o piccole figure di
animali scolpite a tutto tondo); placchette in pietra o in osso con figure incise; statuette di animali o
umane in pietra, in osso, corno, avorio e argilla. A differenza dell‟arte parietale, l'arte mobiliare è
presente in tutta Europa e in Siberia Meridionale.
Dal sito: Paleo Natura.org, come estratto di un articolo di Loana Riboli
La bellezza di quest‟arte prescinde dalle funzioni per la quale era stata concepita e le sue
manifestazioni sono l‟espressione lampante di come in quegl‟uomini si fosse instillata una nuova
sensibilità percettiva e creativa. In quelli millenni assistiamo anche ad uno sviluppo tecnologico che
arriva alla perfezione estetica come nel caso dei “microliti”(punte di freccia, asce, arpioni, zagaglie)
di stupefacente perfezione formale.
Da:Collezioni Paleontologia Umana e Preistoria del Museo Piero Leonardi. Immagini prese dal sito: La mia Preistoria, di Claudio Nucci
I microliti sono dei manufatti di pietra di piccole dimensioni e di forma geometrica che venivano
ottenuti dalla frammentazione di piccole schegge o lame tramite una particolare tecnica denominata
"tecnica del microbulino". I bordi erano poi successivamente regolarizzati tramite ritocchi.
Utilizzati come "armature" per la costruzione di frecce e giavellotti per la caccia o per confezionare
strumenti compositi, la loro forma standardizzata permetteva una facile sostituzione degli elementi
rotti sulle asticelle, alle quali erano fissati tramite fibre vegetali o animali e/o colle naturali.
La tendenza alla microlitizzazione si manifesta nei complessi europei già dalle fasi terminali del
Paleolitico superiore e raggiunge il massimo sviluppo nel Mesolitico.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Microliti
Non parlo a caso della perfezione formale perché – con queste nuove tecniche di lavorazione - i
nostri progenitori furono in grado di costruire dei manufatti che per la prima volta presentavano
una perfetta simmetria assiale
45
In natura la maggior parte degli esseri viventi presentano una loro simmetria. Questo è tanto più
vero quando parliamo di esseri in movimento. Se un‟ala di farfalla fosse più piccola di quella
corrispondente all‟altro lato dell‟asse il suo volo sarebbe compromesso, la stessa cosa succede alla
locomozione di un bipede, perché la simmetria svolge un ruolo determinante nella coordinazione
dei movimenti. Riprodurre questa simmetria nei manufatti del tardo paleolitico consentì agli uomini
di fare un altro passaggio incredibile: appropriarsi – con tutta la precisione che può derivare da una
attenta mira -dell‟energia cinetica, ossia di quella forza viva e guizzante che si sviluppa con il
lancio. La funzione di lancio può essere assicurata dalla leva del braccio come nel caso di lance,
asce o coltelli (questo vale anche per i propulsori che sono strumenti che si usano per potenziare la
forza di lancio di un giavellotto), oppure da corde portate in tensione come nella fionda o nell‟arco.
In qualsiasi caso la simmetria dell‟oggetto lanciato è essenziale perchè nessuna lancia storta arriva
lontano e nessuna freccia colpisce il bersaglio. Dove furono prodotti per la prima volta e quando
furono prodotti alcuni di questi utensili (30-40.000 anni fa in Medioriente o qualche migliaio di anni
prima in Africa australe) è un aspetto secondario del nostro ragionamento. L‟unica eccezione
(perché la Natura è piena di eccezioni) che conferma questa regola è il boomerang che, proprio
perché dotato di ali assimetriche, è portato a ruotare nell‟aria (una tecnica di volo che neutralizza il
sonar dei pipistrelli) e - svolgendo una parabola ellittica- a tornare al suo punto di lancio. Penso che
pochi oggetti al mondo siano una così chiara dimostrazione delle capacità intellettive, estetiche e
creative di quei nostri lontani antenati.
Con la scoperta dell‟arco e delle altre armi da lancio gli ambiti di caccia dei sapiens si estesero
anche ai pesci nell‟acqua e agli uccelli nell‟aria come nessun altro predatore aveva mai potuto fare.
Con l‟acquisizione di queste armi gli uomini si erano dotati – metaforicamente- di potenti zanne e
affilati artigli e, cacciando in gruppo, si trasformarono in un meganimale composito dedito alla
caccia d‟assalto a cui non faceva concorrenza o paura nessun altro predatore o preda.
C‟è molta ideologia nell‟immaginarci come antichi cacciatori dell‟età della pietra; è costante l‟idea
di antenati intrepidi che sfidavano le fiere con il solo uso delle lance fatte di legno acuminato o di
rozze asce ammanicate sommariamente, ma questa immagine è in gran parte frutto di semplice
fantasia. Nessun essere senziente – anche in gruppo- assale un animale molto più grande o
aggressivo di lui. Per farlo bisogna avere forti motivazioni, buone armi d‟attacco e un coordinato
lavorio di gruppo per fiaccarne la resistenza. I nostri antenati - in genere- si assicuravano un
occasionale consumo di carne cacciando uccelli in cova, uccidendo i piccoli mammiferi che si
muovevano lenti sul terreno, oppure usando vari tipi di trappole per catturare gli animali più
pericolosi o elusivi. Le prime armi furono essenzialmente di difesa o furono usate per abbattere gli
animali intrappolati.
Le armi da lancio cambiarono completamente queste condizione. Una freccia o un giavellotto
scagliato a decine di metri di distanza sono un‟arma d‟offesa impressionante, perché possono
colpire le prede a distanza di totale sicurezza e senza che queste avvertano alcuna presenza
ravvicinata. Questo ovviamente aumentò il numero e la tipologia degli animali catturati per unità di
superficie. Questa potenziata capacità predatoria non avrebbe avuto le stesse importanti
conseguenze sulla nostra storia evolutiva se non fosse stata accompagnata da tutta una serie di altre
innovazioni, che modificarono completamente il nostro modo di essere homini e che dettero inizio
46
al nostro modo di essere uomini. Una e vera e propria rivoluzione tecnologica che ampliò e
completò un vero e proprio rinascimento della nostra specie. E‟ in questo alveo di sorprendenti
innovazioni che va inteso anche lo sviluppo delle tecnologie per la conservazione dei cibi freschi.
Abbiamo già parlato della nuova attitudine di raccogliere o mietere e poi conservare le sementi; ma
i semi sono secchi e -per questo- non presentano delle grosse difficoltà nella conservazione. In
questo caso invece vediamo come i nostri antenati affrontarono e risolsero il problema di conservare
anche i cibi freschi e facilmente deperibili come la carne o i vegetali.
L‟ispirazione venne probabilmente osservando e reinventando il comportamento di altri animali. I
canidi sono soliti immagazzinare il cibo eccedente riponendolo sottoterra (più o meno come fa il
mio cane nascondendo le ossa in buche scavate nel giardino) o come fanno i grandi rettili
sotterrandolo nel fango. Altri (per esempio i roditori come i disneliani Cip e Ciop) organizzano
delle vere a proprie dispense alimentari più o meno come fanno tutti gli insetti sociali quali le api, le
termiti o le formiche.
Potremmo considerare questo comportamento accumulatorio - acquisito grazie allo studio,
all‟analisi e alla elaborazione- come una tappa intermedia tra il modello di predazione (legato alla
caccia e alla raccolta) e quello di produzione. Anzi potremmo e forse dovremmo fare una cosa in
più, potremmo ridisegnare i contorni dell‟età mesolitica (l'età della pietra di mezzo; da mesos = in
mezzo) ridefinendo l‟epoca proprio in base a questo nuovo comportamento umano. Sarebbe un
modo di coniugare la suddivisione del nostro tempo -oggi basata sull‟evoluzione dei manufatti in
pietra- con una pensata anche in funzione dei nostri comportamenti alimentari.
Mentre questo testo prende forma esistono sulla terra dei gruppi umani che vivono in ambienti
naturali così difficili da non aver possibilità di praticare ne‟ allevamento ne‟ agricoltura. Questi
uomini si spostano sul loro ampio territorio di sussistenza su percorsi che in genere seguono
itinerari stagionali - che possono essere considerati sommariamente ciclici- assicurandosi il
sostentamento con la caccia e la raccolta. Eppure accumulano e organizzano scorte, e -proprio
grazie a questo comportamento- riescono a superare i periodi di grave difficoltà di
approvvigionamento alimentare. Come abbiamo visto questa cultura dell‟accumulazione e della
tesaurizzazione non è solo umana, ma gli uomini del tardo Paleolitico (secondo il mio suggerimento
sarebbe invece opportuno parlare di uomini del primo Mesolitico) l‟hanno razionalizzata, estesa e
adattata alle proprie esigenze e esistenze.
Sono molte le tecniche di conservazione e molte di queste sono state sperimentate proprio in questo
periodo. La carne può essere tagliata a strisce sottili e fatta essiccare e la stessa cosa si può fare con
i pesci privati della lisca. Nelle zone dove l‟ambiente è troppo umido per consentire l‟essicazione si
possono ottenere gli stessi risultati conservativi esponendo la carne al fumo di fuochi da campo. I
vegetali stessi si possono essiccare e in questo modo i nostri antenati conservarono funghi, alghe e
licheni e piante medicinali. Poi c‟è la tecnica più complessa dello stoccaggio in otri fatti di pelle o
corteccia, realizzati in modo da impedire lo scambio con l‟ossigeno atmosferico. Questo sistema
sottintende un gradiente tecnico e tecnologico molto complesso. La fermentazione anaerobica (ossia
senza ossigeno) favorisce la trasformazione degli zuccheri in acido lattico e la conservazione è
assicurata proprio dall‟acidificazione della massa vegetale, esattamente come avviene con i crauti.
47
Questa tecnica – fino a qualche decennio fa – era ancora in uso presso alcune popolazioni nomadi
siberiane e assicurava – a questi popoli che vivevano nella cultura della renna – il corretto apporto
di vitamine vegetali durante i lunghi inverni polari. Dopo la fermentazione per produrre birra
l‟acidificazione è stata un‟altra dimostrazione d‟uso dei primi procedimenti biotecnologici.
Non ci sono riscontri archeologici che testimonino – già a quell‟epoca - l‟uso di questa tecnologia,
come non ce ne sono per quanto riguarda la conservazione sotto sale e neanche sotto ghiaccio, ma
non sarei sorpreso di sapere che i nostri lontani antenati, nelle aree dove l‟ambiente e le stagioni lo
consentivano, fossero soliti utilizzare gli alimenti surgelati.
Raccogliere semi facendo concorrenza ai roditori e agli uccelli, utilizzare trappole per catturare gli
animali notturni o schivi, tessere reti per imbrigliare pesci nell‟acqua, abbattere uccelli intenti nel
volo, colpire da lontano animali intenti al pascolo, fare concorrenza agli altri predatori grazie alla
supremazia assicurata dalle nuove armi e soprattutto razionalizzare i consumi suddividendo le prede
in razioni giornaliere e pianificando delle vere e proprie dispense alimentari per sopperire alle
stagioni della carenza, sono tutte cose che ampliano a dismisura la pressione esercitata dai sapiens
sul loro habitat. Nel giro di qualche millennio dalla gran parte delle aree temperate sparisce o si
rintana nei luoghi meno accessibili la fauna che dell‟uomo è antagonista e con essa spariscono
anche le ultime testimonianze degli altri generi ancora viventi di Homo (quello di Florens e quello
di Neanderthal) e i nostri antenati rimangono l‟unico genere dell‟unica specie di Homo vivente sulla
Terra. Eppure quell‟uomo, che tanto assomiglia all‟Übermensch di nicciana memoria, fa in quei
millenni uno dei gesti più sorprendenti, innaturali e gravidi di conseguenze di tutta la nostra storia
evolutiva, le cui ricadute avranno una portata rivoluzionaria; cerca, trova e accetta un‟alleanza con
un altro animale: il cane.
48
La prima alleanza
Abbiamo appena visto come lo sviluppo delle nuove armi consentì ai nostri antenati di poter
cacciare e uccidere le prede (e nemici) attraverso lanci. Noi, che pure da bambini e da adolescenti
siamo cresciuti giocando con la fionda e che viviamo in un mondo dove alcuni paesi possiedono
testate nucleari montate su missili intercontinentali, quasi non consideriamo quello che lanciare ha
significato nella storia dei nostri antenati: un gesto che permise di ampliare il raggio di predazione
fino alla gittata massima dei lanci stessi e che frappose una distanza di relativa sicurezza tra i
lanciatori e le prede. Con quel gesto i nostri antenati si sottrassero alla lotta, introducendo nella
caccia reti e trappole come ragni e attacchi da lontano come cobra sputatori. Cacciando nell‟acqua e
nell‟aria, cacciando in terra con acuminati e affilati strumenti di morte, gli uomini si sono
trasformati nei predatori più rapidi, pericolosi ed elusivi del mondo animale. Ovviamente questo
produsse un cambiamento significativo dei modelli di organizzazione sociale e di quelli legati
all‟approvvigionamento alimentare. In Natura si caccia per assicurarsi il bisogno giornaliero: la
carne è un alimento che si deteriora rapidamente e, senza conservazione, può essere usata solo per
pochi giorni. Non ha senso affrontare uno scontro con una grande preda per poi doverla
abbandonare ad altri utilizzatori e ha ancora meno senso uccidere più prede di quelle che si possono
consumare. Si cacciava per assicurarsi la carne per l‟oggi e per il domani, dopo pochi giorni si
tornava a cacciare con la speranza di trovare nuova selvaggina. Ma l‟essiccazione della carne con il
gelo, con il sole e con il fuoco e -forse con il sale- cambiò completamente questo stato di cose,
accrescendo le riserve disponibili e incrementandone i consumi. In questi millenni infatti i nostri
antenati cominciarono a organizzare delle vere e proprie battute di caccia per assicurarsi delle
uccisioni multiple: lo facevano durante la stagione delle migrazioni quando c‟erano molti animali di
passo, in quella dei parti primaverili o prima dell‟inverno quando gli animali avevano accumulato il
massimo di riserve di grasso ed erano meno pronti alla fuga. Raccogliere, uccidere e conservare!
Pianificando, condividendo, organizzando i modi e le forme della ridistribuzione. Conseguenza o
causa di questa marcia -trionfale per la nostra specie ma macabra per i nostri antagonisti- fu la
fondazione di quella che può essere definita una ”ecumene mesolitica”; un vasto spazio di terre
emerse su cui il genere umano si stava progressivamente estendendo, segnato dalle prime forme
rudimentali di commercio (per esempio le pietre per ricavare utensili e le conchiglie per i monili) e
dalla nascita delle “vie dei canti” (cito il titolo di un libro di Chatwin sugli aborigeni australiani),
quei percorsi di oralità attraverso i quali – gruppi umani anche non contigui e senza una lingua
comune – erano in grado di trasmettersi notizie, nuovi saperi e le nuove norme che codificavano
nuovi comportamenti; consentendo alla conoscenza di diventare “cultura” e alla cultura di diventate
essa stessa una forma di scambio o d‟influenza. Un vero e proprio rete di contatti e comunicazioni
che era pienamente attiva prima ancora che arrivasse il tempo della scrittura e che da allora non ha
mai smesso di funzionare.
Questa immensa rivoluzione di mente, di gesta e di modi (effetto e causa della nostra
umanizzazione), insieme alla contemporanea scomparsa o contenimento dei nostri antagonisti,
49
comportò –come già visto- un aumento significativo della popolazione che espandendosi in
direzioni divergenti arrivò – in quegli anni - a colonizzare quasi tutte le terre emerse.
Parlando di popolazione parliamo di numeri e, parlando di numeri, parliamo di stime (cosa che fino
ad adesso non abbiamo mai fatto), con la consapevolezza che stiamo riferendoci a un‟epoca molto
lontana e a tempi cronologici che continuiamo a misurare in millenni, cosa che ci porta a costruire
ipotesi complesse partendo da pochi e incompleti elementi probanti. In queste condizioni i limiti
soggettivi delle nostre menti spesso tendono a semplificare grossolanamente la qualità e la quantità
d‟informazioni che oggi abbiamo a disposizione, in attesa che nuove fonti confermino o aprano
nuovi sentieri di studio o di riflessione.
Da tutto questo discende che una stima complessiva della popolazione di sapiens appare un
tentativo complesso, in un quadro dinamico in costante ridefinizione. Quest‟aumento di numero e di
numeri ha un riscontro nel lavoro degli archeologi che proprio in questo periodo cominciano a
trovare testimonianze di rifugi presumibilmente costruiti con pietre, pali di legno, corde, pelli e –
nelle zone soggette ai ghiacci invernali –con zanne e ossa di grandi animali. Riprova del fatto che i
ripari naturali (come falesie e grotte) non erano più sufficienti ad alloggiare l‟intera popolazione o
che –forse- gli uomini erano già alla ricerca di standard abitativi più confortevoli e pratici. In alcune
aree questi insediamenti sembrano costituirsi intorno ad un nucleo che può essere quasi considerato
come una specie di campo base, al quale erano collegati degli spazi utilizzati in occasione di battute
di caccia o di raccolta. Se stimassimo la popolazione mondiale di 30.000 anni fa intorno ai due
milioni di persone e i gruppi famigliari formati da nuclei di una trentina d‟individui, dovremmo
supporre l‟esistenza di circa 60-70.000 “villaggi” mesolitici sparsi per il mondo (ho desunto questo
numero dai vari dati demografici che si trovano in rete). Un numero irrisorio confrontato con l‟oggi,
comunque un numero significativo, perché in Natura i grandi mammiferi predatori non raggiungono
questi numeri di popolazione. Queste decine di migliaia di aggregati, abitati anche solo
stagionalmente, ci portano a riflettere sul fatto che per la prima volta la nostra specie aveva iniziato
a creare intorno a se degli habitat artificiali (dove per artificiali s‟intendono gli habitat prodotti
attraverso bisogni o comportamenti acquisiti). Gli habitat artificiali erano riconoscibili dagli scarti
lasciati dagli uomini sulla terra, e questo generò una serie di problematiche a cui la Natura pose
rimedio attraverso innovative soluzioni.
Non parlo delle feci – che sono un problema minimo perché facilmente metabolizzabili, parlo –per
esempio- delle ossa e degli altri scarti animali che restavano sul campo dopo la macellazione. In età
mesolitica solo una piccola parte di quelle ossa poteva essere usata a scopo utilitaristico (ami, armi,
strumenti musicali), la maggior parte era abbandonata sul posto dopo essere stata spolpata della
carne e del midollo. Dovranno passare alcuni millenni prima che gli uomini trovino delle
applicazioni – come la saponificazione- che consentano loro il totale riutilizzo delle ossa animali.
Fino a che i gruppi umani furono limitati nei numeri e vaganti nella forma di utilizzo del territorio,
la dispersione degli scarti alimentari era assolutamente casuale e questo non comportava problemi.
Il discorso iniziò a cambiare davanti a qualche migliaia d‟insediamenti anche solo stagionali.
L‟importanza di questo passaggio appare evidente: in Natura non esistono spazi vergini o vuoti ma
ambiti che vanno felicemente e velocemente colonizzati. Prendiamo il caso di un luogo dove si
50
eseguivano le varie fasi del processo di macellazione e essiccazione della carne. Ovviamente i primi
colonizzatori sono i batteri e le muffe e tutto quello che riguarda il microcosmo, ma il processo di
colonizzazione non si ferma a questi. Le stagioni di sedentarizzazione sono accompagnate dalla
presenza d‟insetti opportunistici come le mosche carnaie, i tafani e le vespe per quanto riguarda la
carne o calandre e tignole per quanto riguarda i semi. Sia nell‟uno sia nell‟altro caso assistiamo a un
conseguente aumento dei piccoli mammiferi, uccelli o rettili insettivori, e mai mancano i necrofagi,
tanto che i fumetti che raccontano le saghe preistoriche non si allontanano dal vero quando
riempiono le strip di neri corvi e voraci avvoltoi.
Lo stesso discorso vale per i piccoli roditori come arvicole e topi campagnoli, ma anche per ratti o
per gli altri predatori delle derrate alimentari. Per tutti questi animali la relativa approssimazione
delle difese messe a tutela delle scorte alimentari era ragione di facilità di accesso e di aumenti
demografici esponenziali. Il controllo di questi concorrenti è stato un problema che deve aver
assillato i nostri progenitori, che – avendo pochi strumenti di contrasto- dovettero accettare che
fosse la Natura a riequilibrarne i numeri; a differenza dei grandi mammiferi come orsi e felini, più
pericolosi per gli uomini, ma- per assurdo- più facili da controllare.
Una riflessione a parte meritano i canidi: lupi e volpi nelle regioni a clima continentale
dell‟emisfero nord, coyote dell‟America settentrionale e centrale, sciacalli nelle zone predesertiche,
o i licaoni africani. I canidi -in particolare i lupi- con cui condividevamo la stessa nicchia
predatoria, sono stati per millenni i nostri più temibili concorrenti. Dotati per natura di mezzi molto
efficienti, possono correre velocemente e per lunghe distanze, balzare dopo un agguato silenzioso o
aggredire in gruppo gettando panico tra le prede per poi azzannare con forza e con grande apertura
buccale: la loro arma letale. I lupi sono anche dotati di sensi molto sviluppati: un udito acuto, una
vista anche notturna e un olfatto sensibilissimo con il quale fiutare le uste e seguirle per chilometri.
Per migliaia d‟anni queste performance hanno permesso ai canidi di superarci nell‟efficienza della
caccia e nella capacità predatoria. Solo il nostro essere onnivori ci ha consentito di competere
paritariamente, di rintuzzare la conflittualità sullo stesso ambiente naturale e, malgrado la loro
concorrenza, di aumentare costantemente la popolazione. In più gli uomini hanno goduto del
vantaggio di compensare il loro scarso olfatto e udito, la loro totale assenza di visione notturna, il
loro essere privi di una naturale arma letale, con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni
sociali.
Fu il procedere dell‟umanizzazione che spostò nettamente a nostro vantaggio l‟antagonismo tra le
due specie, fu lo sviluppo delle armi da lancio che dotò il branco degli uomini dei più aggressivi e
spietati strumenti di caccia. Una rivoluzione tecnica e comportamentale che aveva portando
all‟estinzione gli altri generi di Homo e che – in certe zone della Terra- poteva esporre i canidi allo
stesso rischio.
Ma l‟ampia capacità di adattamento non è una caratteristica solo umana; quando - con lo sviluppo
delle tecniche di conservazione- gli uomini iniziarono ad abbandonare scarti di macellazione,
furono proprio i lupi che -razzolando nelle nostre discariche- trovarono un modo di recuperare
alimenti senza lo sforzo e i rischi della caccia, solo vivendo collateralmente agli uomini. Le ossa, gli
intestini, le parti scartate della pelle, i polmoni, formano un insieme di tessuti e di organi che
51
assommano a circa la metà del peso totale della preda, tutte parti del corpo per noi poco utilizzabili
ma che per i lupi rappresentavano un ricco banchetto. Una suddivisione a metà che caricava i nostri
progenitori di tutti gli oneri e lasciava ai lupi cibo gratis e senza rischi.
Uno scenario decisamente insolito che probabilmente accentuò l‟antagonismo tra le due specie,
perché i branchi stazionanti nei dintorni degli accampamenti erano in grado di predare anche gli
individui poco difesi, come i bambini non sorvegliati o le persone deboli o indebolite. Forse a
questo tempo è ascrivibile la nostra paura atavica nei confronti dei lupi e –forse- è anche questa la
ragione del perché gli uomini iniziarono (compresi i neanderthal) a coprire di terra e pietre i corpi
dei congiunti, caricando anche di gesti un antagonismo radicale di pensiero. Ma la Natura gioca la
sua partita a tutto campo e le specie si muovono al suo interno come la palla di un biliardo, mossi da
una mano invisibile e onnisciente che li sposta e li rotea per volontà o per bisogno di giungere a
nuovi goal.
Noi –che per deformazione mentale- pensiamo che l‟antagonismo tra le specie conduca sempre alla
scoperta di nuove armi, all‟evoluzione di nuove tattiche di lotta e contrapposizione, assistiamo
sorpresi al meccanismo messo in atto dai canidi per rispondere alle nuove sfide aperte nel loro
cammino adattativo, a ferma riprova che la selezione naturale è un gioco di specchi, fatta anche di
ritirate e fughe, e di camuffamenti e trasformazioni che possono portare a svolte sorprendenti.
Ecco, infatti, che tra noi e i canidi si produsse un fatto imprevedibile, un cambiamento che avrà
ripercussioni enormi nello sviluppo delle società umane, il perno su cui si poggia tutta la nostra
successiva evoluzione neolitica.
Ricordate quanto avevo affermato in un capitolo precedente? Si cambia per rimanere; chi non muta
sottoscrive la sua marginalizzazione o la sua scomparsa! E i canidi erano una specie dinamica,
attiva; malleabile e viva, non erano dei Dodo delle Mauritius; nel loro scenario evolutivo non era
contemplata una estinzione per mano di un‟altra specie antagonista e neppure il totale ripiegamento
nelle aree più impervie del pianeta.
La situazione era strana! Una legge naturale (che faremo bene ad inserire nelle nostre tavole
mentali) dice che la Natura rifiuta il concetto di rifiuto; non solo perché i rifiuti biologici sono
pericolosi, ma anche perché quello che non serve ad alcuni può servire ad altri. I nostri antenati
avevano bisogno che qualche specie eliminasse i loro “rifiuti”, nello stesso tempo contrastavano il
fatto che quegli scarti richiamassero e favorissero i canidi. Ma nelle zone temperate, dove il senso
dell‟accumulazione si era più sviluppato, i lupi avevano tutte le chance biologiche per assicurarsi
l‟uso –quasi esclusivo- di una dispensa così facile e abbondante. E, se la conflittualità innata tra le
due specie non era cosa da poco, neanche da poco fu la risposta. Nel genere Canis si presentò una
mutazione: dal lupo apparve il cane primitivo (sulla filogenesi del canis lupus familiaris ci sono
chiaramente posizioni diverse), un cambiamento che si evidenziò in diverse aree del globo e in
epoche più o meno corrispondenti.
Non sono un panteista, non sono solito pensare alla Natura come un‟entità senziente capace di
indirizzare le sue decisioni. L‟evoluzione procede a tentativi –alcuni rigettati, altri di successo- batte
52
molti sentieri, anche quelli più imprevedibili. Di questa strategia conosciamo i risultati finali,
mentre spesso ignoriamo i tentativi falliti, spesso sorprendenti.
In questo caso la strada battuta fu quella di inserire tra il genere Canis e il genere Homo, una nuova
specie che potesse occupare quella nicchia biologica prodotta dagli uni e utilizzabile dagli altri.
E‟così che apparve il cane, una specie insolita, una specie ponte, che a una valutazione superficiale
sembrava dotata solo di mutazioni disfunzionali. Il cane primitivo non possedeva la resistenza alla
corsa dei suoi predecessori, né l‟aggressività e l‟irrequietezza, neppure la straordinaria pressione
alle mascelle o la sfuggevolezza. Una mutazione (come già quella umana) apparentemente destinata
a non consolidarsi; ma i cani avevano una caratteristica (che troveremo in seguito anche in altre
specie) che è stata la loro arma vincente, erano portatore di un‟accentuata neotemia.
È definita neotenia il fenomeno evolutivo per cui negli individui adulti di una specie permangono le
caratteristiche morfologiche e fisiologiche tipiche delle forme giovanili come il muso meno
allungato e i denti meno sporgenti. Anche l'uomo viene considerato un esempio di neotenia, nella
postulazione dell'anatomofisiologo olandese Lodewijk Bolk. Caratteristica neotenica nell'uomo, per
esempio, è la capacità di digerire il latte da adulto (che tra l'altro non è tipica di tutte le
popolazioni). Gli adulti umani presentano inoltre proporzioni corporee più simili a quelle giovanili
rispetto agli altri primati e una scarsità di pelo corporeo. La neotenia può essere importante per
fornire un più ampio spettro di adattabilità ambientale rispetto alla specie ancestrale più
specializzata.
Rielaborato da Wikipedia alla voce: Neotenia
Capite quest‟ultimo passaggio preso da Wikipedia? Una specie meno specializzata e con accentuati
tratti infantili può trarre dalla Natura alcune chance che si contrappongono all‟idea della
specializzazione e della lotta. Infatti per eludere le nostre difese e i nostri antagonismi la Natura ci
presentò non un cavallo di Troia, ma un piccolo e indifeso cavalluccio a dondolo. I cuccioli –specie
quelli abbandonati dalla madre perché privi di alcune delle prerogative di specie- incutono poca
paura, in più gli uomini sono sensibili alla vulnerabilità degli individui. I cuccioli delle specie
neoteniche accentuano entrambi queste caratteristiche. Sono belli (e –come visto- già i primi
sapiens erano sensibili alla bellezza), sono indifesi (e gli uomini sono sensibili alla debolezza), sono
socievoli (e gli uomini sono sensibili alla socievolezza). Sono gioiosi e lieti, giocano volentieri con i
cuccioli di uomini, e i loro gioghi sono una gioia per gli occhi e una felicità per il cuore. Il bisogno
di equilibrio della Natura o l‟acuto protagonismo del genere Canis aveva trovato la strategia perfetta
per assicurare alla specie la sua sopravvivenza; la mossa del cavallo che spiazzava tutte le strategie
ortogonali di antagonismo frontale tra le nostre due specie: farsi adottare!
O furono gli uomini che sentirono il bisogno di stringere un‟alleanza? Quell‟Homo diventato Uomo
che aveva cominciato a interrogarsi sul suo destino e sulla sua posizione in quel mondo su cui
camminava portando il senso della sua solitudine di specie? Quegli uomini che da qualche tempo (o
da tempo immemore?), ansiosamente, cercano conferme ai loro dubbi e alle loro paure in
un‟alleanza con i loro Dei, ma che spesso sono capaci di trovare certezze solo nelle alleanze che la
Natura ha offerto loro.
53
“L‟antropologa americana Pat Shipman ritiene che i nostri antenati si siano affermati sul
Neanderthal – e su tutto l‟ambiente circostante- quando hanno iniziato ad addomesticare i cani. In
sostanza, l‟antropologa è convinta che i cani possano essere stati una primaria forma di “tecnologia”
che ha permesso ai Sapiens di crescere per numero e per capacità, eliminando
progressivamente tutti gli altri. Shipman è partita dall‟analisi dei resti di canidi trovati nelle grotte o
nelle sepolture risalenti all‟epoca in cui le due specie umane vivevano in contemporanea. Si è così
accorta che, a differenza dei Neanderthal, i nostri antenati avevano una sorta di culto per i cani.
Scheletri canini sono stati ad esempio trovati in un sito antico di 27 mila anni, a Předmostí, nella
Repubblica Ceca, collocati all‟interno di una tomba secondo un preciso rituale. Denti di cane erano
utilizzati come ornamenti. Questo, secondo Shipman, testimonia che l‟animale era tenuto in grande
considerazione: non era una preda da macellare, ma una creatura degna di rispetto e di onore. Non
solo. Proprio come gli esseri umani, raramente i cani appaiono dipinti nelle caverne dell‟Età
Paleolitica. Un elemento che suggerisce, forse, che essi non erano considerati animali alla stregua
degli altri- cavalli, cervi e così via- ma compagni di avventura. A unire uomini e cani, oggi come
allora, sarebbe stata la caccia. Shipman ipotizza la creazione di un circolo virtuoso di cooperazione:
gli uomini sfamavano e accudivano i cani che in cambio lavoravano per loro alla ricerca del cibo.
Entrambi ne traevano vantaggio, diventando più forti di giorno in giorno. Ma c‟è un altro aspetto
intrigante della teoria della ricercatrice: il cane, oltre ad essere la tecnologia che ha fatto affermare
l‟uomo, può essere stato anche l‟ elemento che ne ha condizionato l‟evoluzione, esattamente come
l‟addomesticamento del bestiame ha fatto sì che l‟umanità- o almeno, gran parte di essa-sviluppasse
l‟enzima adatto a digerire il latte.
Shipman ha elaborato l‟ipotesi dello “sguardo cooperativo” che parte da una costatazione: l‟uomo,
rispetto agli altri primati, ha un occhio dotato di una sclera (la parte bianca) molto più ampia.
Elemento che non lo favorisce nella caccia notturna: i suoi occhi sono visibili a distanza e la preda
capisce la direzione in cui guardano. Questa caratteristica solo apparentemente svantaggiosa
potrebbe essersi sviluppata proprio grazie al rapporto con i cani, anche i cani- ricorda Shipman conoscono il potere dello sguardo: i sottomessi lo abbassano davanti al capobranco, loro simile od
umano poco cambia, e con gli occhi esprimono vari stati d‟animo che i padroni sanno ben
comprendere. In uno studio sperimentale, poi, l‟antropologa ha dimostrato che neonati e cuccioli di
cane sono in grado di individuare, con lo sguardo, la fonte dalla quale si propaga una voce. Dunque
è questo un elemento in comune, tra noi e i nostri fedeli compagni a quattro zampe.
Un‟affinità magicamente unica che ci permette di “lavorare” insieme, di comunicare, di capirci
senza bisogno di parole e che forse- pensa la studiosa- non si è sviluppata in modo indipendente.
“Finora nessuno studio genetico ha confermato la prevalenza di sclera negli uomini paleolitici
rispetto ai Neanderthal - ma se la mutazione che l‟ha portata, ad aumentare nei nostri predecessori
fosse confermata, essa avrebbe sicuramente favorito la comunicazione umani - cani e promosso
l‟addomesticamento.” Come dire, che i cani possono aver influito sulla nostra evoluzione aiutandoci
a cambiare in meglio. L‟aforisma del sociologo Mashall McLuhan che recita “Noi formiamo i nostri
strumenti e poi i nostri strumenti formano noi” potrebbe essere vecchio quanto l‟Umanità”.
Note tratte e rielaborate dal blog: Estremamente, nella sezione “Archeologia & Storia”, postato il 18 aprile 2012 da Sabrina Pieragostini
54
Riporto quasi per intero questo passo incontrato in internet e ringrazio Sabrina Pieragostini per aver
trasferito in prosa questi concetti così interessanti, ma coltivo l‟idea di poter andare oltre. A
differenza della Shipman io non credo che il cane sia una nostra “tecnologia”, perché vedo in questa
ipotesi l‟angolatura di uno sguardo sommariamente antropocentrico. Io credo invece che
inconsapevolmente i nostri antenati abbiano accettato una proposta che veniva dalla logica delle
cose. C‟era uno spazio da occupare e quello spazio poteva essere condiviso da un interesse
biologico duale. Come ho già detto la mano dell‟evoluzione ha mosso i giocatori in campo e la
Natura ha fatto il suo goal. Dirò di più: la Natura ha suggerito un patto tra diversi e, con il cane, ha
presentato l‟offerta. Nel momento che i nostri antenati, consapevolmente o inconsciamente, l‟hanno
accettata, hanno ascritto nel loro codice comportamentale un “patto mutualistico” dal quale mai
siamo venuti meno.
Oggi il lupo (Canis lupus) è praticamente scomparso da molti territori o si è –lui si - rintanato negli
angoli meno accessibili della terra; ma i suoi discendenti indiretti sono milioni, a dimostrazione che
si può vincere anche ritirandosi. I cani (canis lupus familiaris) vivono dentro le nostre case o intorno
ad esse, accudiscono ai nostri beni, sono di sostegno ai bisogni di molte persone e riempiono le
solitudini di molte altre, e – seppure soggetti a forme immonde di sfruttamento- nelle società
opulente fanno una “vita da cani” più per eccesso che per negligenza, perché spesso gli uomini
contemporanei assimilano i comportamenti e le necessità dei cani alle loro, tanto che potrebbe
essere interessante cominciare a studiare il significato recondito della progressiva e costante
antropizzazione di quelli che definiamo: animali da “compagnia”!
Ci sono moltissimi essere viventi che ricorrono a patti mutualistici, anzi – a ben vedere – pare
proprio che per la Natura ricorrere a questi accordi tra diversi sia assolutamente normale, ma il
gesto in se è così particolare che è opportuno ricorrere alla biologia.
Il Mutualismo, in biologia detto anche simbiosi mutualistica, è una stretta relazione da cui deriva un
beneficio reciproco. Il termine fu coniato da Heinrich Anton de Bary nel 1879 per qualificare la
natura dei licheni, ch'egli dimostrò essere un'associazione fra un'alga e un fungo. Fu poi adoperato
per indicare associazioni simili tra due organismi di diversa specie. Il mutualismo è una condizione
estremamente diffusa e coinvolge organismi appartenenti a tutti i regni del vivente. Si va da quello
molto famoso tra i pesci pagliaccio e gli anemoni di mare a quelli meno conosciuti tra gli afidi e
alcuni batteri o tra piante e funghi o piante e batteri. La Simbiosi è invece un concetto che indica
varî modi di convivenza tra organismi di specie diversa. In base al tipo di relazione che tra essi
intercorre, sono definite diverse modalità di simbiosi: mutualismo, quando l‟associazione è
vantaggiosa per ambedue i simbionti; commensalismo, quando si ha l‟utilizzazione comune di
risorse alimentari, con vantaggio di uno solo dei simbionti, ma senza danno diretto per l‟altro;
inquilinismo, quando uno dei due simbionti (l‟inquilino) vive all‟interno o sopra l‟altro e ne occupa
la tana o il nido senza che ciò provochi alcun danno. La biologa Lynn Margulis, famosa per la
ricerca sull'endosimbiosi, ipotizza che le simbiosi possano costituire un'importante componente
dell'evoluzione. Considera infatti la nozione darwiniana dell'evoluzione, guidata dalla
competizione, come incompleta, e afferma che l'evoluzione è fortemente basata sulla cooperazione,
interazione, e dipendenza mutuale tra organismi. Secondo Margulis e Sagan (1986), "la Vita non
55
colonizzò il mondo attraverso il combattimento, ma per mezzo dell'interconnessione". Come negli
umani, gli organismi che cooperano con altri della loro specie o di specie differenti, spesso
sopravvivono di più rispetto ad altri che non lo fanno.
Rielaborato da Wikipedia alla voce: Mutualismo
Le ipotesi di una vita basata anche sulla collaborazione continuano a incontrare una certa difficoltà
ad affermarsi specie in quegli ambienti culturali e sociali permeati dall‟idea dell‟affermazione
individualistica, negli ambiti economici basati su approcci liberisti e negli ambienti scientifici
fortemente condizionati da approcci acritici del pensiero darwinista.
Nel libro “L'origine delle specie”- pubblicato nel novembre del 1859 - Charles Darwin rese
pubblica la sua teoria secondo cui gli organismi si evolvono attraverso un processo che egli chiamò
di “selezione naturale”. Notate bene i concetti intrinseci della teoria: Darwin parla di origine e di
evoluzione, sottintendendo che la vita non è caratterizzata da una riproduzione simile di se stessa,
ma da continui adattamenti dovuti alla “selezione” degli individui che egli definì “naturale”, ossia
legata alle leggi della Natura. Come spesso accade le parole hanno un senso: evoluzione viene dal
latino “evolutio-onis”, che etimologicamente vuol dire lo svolgersi di una cosa come quando si
srotola un papiro; mentre selezione viene da “selicere”, ossia: scegliere. Adattamenti (quindi
intrinsecamente passivi) che dipendono da una forza esterna ad essi, quella Natura, che Darwin
nella sua teoria inserì come aggettivo. Dopo aver affermato questa idea – che all‟epoca aveva quasi
il valore di un‟eresia- Darwin suggerì che le ragioni di questi cambiamenti fossero legate a due
presupposti (logicamente naturali): il fatto che in qualsiasi popolazione fosse riconoscibile
un‟ampia variabilità d‟individui e che la vita fosse condizionata dalla scarsità delle risorse
ambientali e alimentari. Darwin ritenne che questi due condizioni favorissero quella che egli definì:
la “sopravvivenza del più idoneo” (survival of the fittest), in un agone caratterizzato da una costante
” lotta per la sopravvivenza” (struggle for existence). La teoria di Darwin si poggia quindi sul
presupposto che la vita di tutti gli organismi viventi (individui, colonie o gruppi famigliari o specie)
sia in costante srotolamento (evoluzione) attraverso il processo della selezione naturale e che tutto
questo si attua grazie ai requisiti di varianza genetica e limitatezza alimentare che “dinamizzano” il
processo. O detto in parole più semplici: tutta la vita è una costante competizione tra individui, gli
individui non sono tutti uguali, e alcune condizioni naturali (come la scarsità delle risorse
alimentari) funzionano da griglia per favorire la selezione dei più adatti.
Definire così accuratamente il contesto fu essenziale per Darwin perché - quando scelse di rendere
pubbliche le sue tesi- esistevano ben pochi supporti scientifici a sostegno delle sue idee, che invece
arrivarono abbondanti dopo l‟apertura di questo nuovo e straordinario campo di studi. Non si
conoscevano i fossili (non perché non si fossero trovati, ma perché nessuno aveva ancora pensato di
collegare al passato quello che si era trovato), Mendel non aveva ancora scoperto le leggi
dell‟ereditarietà e mancava ancora un secolo alla scoperta della struttura del Dna. La pubblicazione
della teoria fa una bomba gettata nel negozio di cristalli della società “borghese” dell‟milleottocento
e il dibattito sociale e culturale che suscitò fu impressionante. D‟altro canto la teoria di Darwin
rappresentava una radicale cesura di pensiero per una società ancora inconsciamente convinta che la
vita dipendesse dalla creazione divina (nel XVII secolo il vescovo anglicano Ussher – tentando di
calcolare l‟età della Terra- dedusse dalla lettura della Bibbia che il primo giorno della Creazione
56
era iniziato al tramonto precedente la domenica 23 ottobre del 4004 a.C. e i suoi calcoli trovarono
entusiastico sostegno). Quindi la vita come un dono e non come un percorso. Una vita statica, che si
riproduceva perennemente simile a se stessa e non una vita caratterizzata da addendi in continuo
aggiustamento, che di generazione in generazione- interagendo con l‟ambiente che li circonda e
adattandosi alle forze che ne indirizzano il cambiamento- veniva setacciata permettendo solo ai più
adatti di andare oltre.
In quel secolo che mischiava le pulsioni intellettuali provenienti dall‟illuminismo con le aspirazioni
al più statico conformismo, in un momento politico e sociale europeo sospeso tra i moti
rivoluzionari del 1848 e la “Comune di Parigi”, in una società fortemente divisa in classi sociali - le
tesi di Darwin – che arretravano indicibilmente il tempo delle origini fino a portarci a un antenato
comune con le scimmie e che postulavano una evoluzione intrinsecamente legata alla competizionedovevano apparire a dir poco come pericolose per i garanti delle status quo e blasfeme per i
religiosi.
La teoria della selezione naturale si basa sul principio che gli esseri viventi appartenenti a una stessa
specie tendono a differenziarsi l'uno dall'altro per alcune caratteristiche fisiologiche o
comportamentali. Queste diversità sono casuali e conferiscono agli individui dei vantaggi o degli
handicap nell‟ambiente in cui vivono. Secondo la teoria proposta dal naturalista Charles Darwin è
l'ambiente a selezionare le specie, premiando gli individui con caratteristiche più adatte alle
condizioni dell'ambiente stesso. Questi ultimi si procurano il cibo con più facilità e sono favoriti
nell'accoppiamento rispetto a quelli con caratteristiche meno adatte all‟ambiente, pertanto hanno
una maggiore probabilità di trasmettere i propri geni alle generazioni successive. Col passare delle
generazioni la popolazione tende a essere composta soltanto dagli individui con caratteristiche
migliori mentre tutti gli altri scompaiono dalla scena. E' la selezione naturale. In questo modo la
natura porta avanti i geni migliori e causa la scomparsa di quelli meno utili. Il processo della
selezione naturale determina l'evoluzione della specie.
Rielaborato da Wikipedia alla voce: Selezione naturale
A distanza di centocinquanta anni dalla sua pubblicazione solo pochi gruppi legati ai movimenti
religiosi continuano a pensare alla creazione come a un complesso, ma unitario, atto divino. Mentre
– si può facilmente affermare- che l‟idea della vita in continua evoluzione (unita a quella di una
discendenza comune con le scimmie) sia entrata completamente nella mentalità collettiva. Ma i veri
problemi teorici alle tesi di Darwin non sono venuti dai detrattori ma da alcuni dei suoi più accesi
sostenitori (ricordate il detto: dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io?), ossia da tutti
coloro che hanno fatto una trasposizione sociologica e – implicitamente- politica dei concetti di
“adatto” e di “lotta”. Parlo di coloro che hanno creduto di trovare – nell‟idee darwiniane- un
sostegno implicito alle tesi dell‟eugenetica e del darwinismo sociale. Oltre a questo aspetto
(pericoloso, ma marginale) c‟è però un altro punto a mio avviso ben più problematico! Con il tempo
e con i suoi “successi” antropici, l‟uomo contemporaneo ha permeato il concetto di evoluzione di un
“motu proprio” che sembra staccarsi dal fatto che questo dipenda dalla Natura (la forza che
svolgeva il papiro) per sostituirvisi. Non sto parlando solo della selezione artificiale (quella fatta
dall‟uomo), ma del fatto che oggi gli uomini si sentano garanti o guide della Natura, cosa che a mio
57
avviso è una delle espressioni più errate dell‟antropocentrismo (questo tema apre delle complesse
riflessioni che affronteremo negli ultimi capitoli).
Darwin basò la sua teoria sulle idee malthusiana che la vita fosse condizionata dalla scarsità delle
risorse ambientali e alimentari, e che fosse questa limitazione a generare un perenne stato di
competizioni e lotte. Quelle stesse idee che Karl Marx, ne “Il Capitale”, definì «stupidaggini
infantili e superficiali plagi», immaginando invece che il progresso nella scienza e nella tecnologia
avrebbe consentito una costante crescita della popolazione e che il problema della penuria fosse da
imputare essenzialmente alla ingiusta distribuzione delle risorse (a sua volta Marx è criticato per
aver sottovalutato il problema dei limiti ambientali allo sviluppo). Come vedete problemi complessi
che esulano dalla traccia principale di questo scritto.
Ma le tesi della Margulis possono funzionare da sostegno a quelle darwiniane, contribuendo a dare
al carro teorico dell‟evoluzione la stabilità di cui ha bisogno. C‟è il più adatto, ma c‟è anche il più
adattabile e la lotta non è l‟unica strategia per assicurarsi la sopravvivenza, perché esiste anche la
condivisione d‟intenti e la cooperazione, sia tra simili che tra diversi. I suggerimenti della Margulis
mutano profondamente il panorama delle strategie evolutive; lo ampliano, lo diversificano, lo
rendono più complesso e meno schematico e la simbiosi mutualistica tra noi e i cani ne è un buon
esempio (tanto per citare uno degli innumerevoli casi di mutualismo). Così circa 30.000 anni
l‟uomo e il cane iniziarono a camminare insieme sulla Terra (forse quel percorso fu interrotto
alcune volte, ma poi sempre ripreso), dando vita al predatore più perfetto che mai la Natura avesse
conosciuto. Una relazione mutualistica così stretta e sorprendente da caratterizzarsi come una vera
forma coevolutiva. Molti rideranno all‟idea di una forma di coevoluzione e continueranno a pensare
che il cane è solo un animale che si lascia dormire sull‟uscio di casa, ma nessuno è cieco quanto chi
non vuole vedere.
Per mille e mille anni il cane è stato il nostro naso e il nostro orecchio, colui che ci ha aiutato a
scovare le prede, a stanarle, e – a guaiti- riportarle verso di noi, consentendoci di applicare una
strategia di caccia che ha pochi uguali nel mondo animale. Il primo animale disposto ad accettare
l‟uomo all‟interno della logica di branco (e viceversa), spesso considerandolo come il capo e non un
semplice gregario. Quello che ha piacere di dormirci a fianco, sentendosi addirittura rassicurato
dalla nostra vicinanza, quello cui – spesso –demandiamo la difesa dei nostri beni (che per molto
tempo furono i greggi) e/o dei nostri affetti. Cave Canem scrivevano i romani su l‟uscio delle loro
case e questo ci porta ad affermare che questa relazione simbiotica ha dato un contributo
significativo allo sviluppo di quel bisogno di “avere” una casa (la domus) che da qualche millennio
è uno degli atteggiamenti acquisiti più caratteristici della nostra specie. Controprova del fatto che i
cani sono stati il perno della nostra “domesticazione”. Ma per capire meglio il senso di questa
affermazione occorre passare al prossimo capitolo.
58
Verso l’agricoltura: la costruzione di una società mutualistica
Circa ventimila anni fa l‟ultima glaciazione raggiunse il suo apice, coprendo di ghiaccio una parte
significativa dei due emisferi e modificando pesantemente il clima delle terre restanti, ma per
l‟ennesima volta i nostri antenati furono in grado di superare questo sferzante colpo di coda del
freddo e del gelo. Eravamo ormai ben attrezzati per farlo: non avevamo più soltanto il fuoco, ma
anche le prime rudimentali abitazioni; avevamo abiti fatti con pelli conciate e cucite in modo di
aderire al corpo; avevamo armi di offesa efficienti e –cosa più sorprendente- avevamo sviluppato
degli adattamenti fisico-biologici ai nuovi climi e ai nuovi regimi alimentari e avevamo stretto una
ferrea e mutua alleanza con il cane, così da non avere concorrenza ma assistenza
nell‟approvvigionamento della carne e sul controllo delle scorte con la specie nostra più diretta
antagonista. Tutto questo (ossia: piccoli ma significativi cambiamenti endogeni, applicazioni di
nuove tecnologie e un diverso modello relazionale con il mondo animale) stava permettendo una
crescita –lenta ma progressiva- degli insediamenti umani. Lo sappiamo sia dal numero crescente dei
siti mesolitici che dalla progressiva capacità dei nostri antenati di modificare l‟ambiente naturale.
Questo perché sappiamo (o presumiamo di sapere) che i nostri antenati usassero il fuoco per creare
delle radure artificiali all‟interno di quella foresta primordiale che allora copriva gran parte
dell‟Europa, in modo da creare delle piccole isole di ricco e facile pascolo, create al fine di cacciare
–più facilmente- cervi e altri ungulati. Ma le modifiche dell‟ambiente naturale non si limitava solo
a distruggere qualcosa, perché nelle aree a prateria -tipiche allora delle aree mediorientali – ricche
della presenza di cereali selvatici- assistiamo per la prima volta all‟uso studiato dell‟irrigazione
(così almeno alcuni studiosi interpretano alcuni canaletti scavati nelle rocce) accompagnata dalla
costruzione di probabili piccole dighe lungo il corso dei torrenti; tutto questo per sostenere
occasionalmente il ciclo vegetativo delle piante nei momenti critici del loro ciclo riproduttivo (in
autunno al momento della nascita e in primavera nel momento della fioritura).
E questo non deve sorprenderci perché anche presso i Paiute del Nord America (una delle tante
popolazioni che aveva elaborato un modello più complesso di quello della semplice caccia e
raccolta, ma ancora non agricolo) queste pratiche furono normalmente applicate fino all‟invasione
europea (devo queste ultime notizie ad un bel libro sulla storia dell‟agricoltura scritto da Teresa
Rojas Rabiera e da William T. Sander).
L‟uso di questa pratica -apparentemente già agronomica- in regioni caratterizzate da consistenti
fluttuazioni pluviometriche annuali, si dimostrò molto efficace nello stabilizzare e/o incrementare la
produzione annua di granaglie, facendo in modo che ogni raccolto annuale fosse sottratto dalla
normali oscillazioni climatiche e che ogni ciclo vegetativo si trasformasse in una “ ottima annata”.
Consentendo quindi che il ciclo riproduttivo delle piante potesse trasformarsi costantemente in un
ciclo produttivo per gli umani, proprio in virtù del surplus che da occasionale veniva stabilizzato
senza alterare l‟equilibrio naturale.
59
Voglio dire con questo che “aiutare” la Natura a fare un buon raccolto danneggiava solo
parzialmente gli altri animali granivori, il cui equilibrio ecologico si atteneva alla legge del minimo
(tanti animali quanti si potevano mantenere in un anno di scarsa produzione granicola), ma
avvantaggiava considerevolmente i nostri antenati che, proprio grazie al lavoro di sostegno alla
produzione, cominciarono a condeterminare le quantità di granaglie raccoglibili.
Non ci sono invece testimonianze documentate di concimazioni (e come potremmo trovarle?),
anche se si può supporre che quei nostri antenati mesolitici avessero già constatato gli effetti
benefici della pratica del debbio (la bruciatura dei boschi o delle stoppie estive) che è una tecnica
conosciuta a molte popolazioni pre-agricole, o quella della dispersione delle ceneri domestiche e
l‟utilizzo degli scarti organici prodotti negli accampamenti. Non abbiamo neanche (né potremmo
avere) testimonianze di sarchiatura o di mondatura dei terreni, tecniche che sono utili per diminuire
la concorrenza che le altre specie selvatiche fanno a quelle che si vogliono raccogliere. L‟utilizzo
anche solo di una di queste pratiche, che a dovere dobbiamo considerare “agronomiche”,
corrisponde a uno di quei momenti importanti della nostra evoluzione culturale, quando gli uomini
iniziarono a “prendersi cura” di alcune specie vegetali (così come avevano già fatto con il cane) al
fine di indurre l‟incremento della produzione delle granaglie che è il preludio di forme nuove di
stabilizzazione (anche se all‟inizio solo stagionali).
Di questo modo nuovo di vivere il territorio abbiamo significative testimonianze in tutta l‟area della
che siamo soliti chiamare: Mezzaluna Fertile e dai sorprendenti ritrovamenti di Göbekli Tepe.
Immagine presa da Wikipedia alla voce: Göbekli Tepe. Autore Teomancimit
60
Göbekli Tepe è un sito archeologico della Turchia, situato presso il confine con la Siria dove è stato
rinvenuto il più antico esempio di santuario in pietra databile attorno al 9500 a.C. e la cui erezione
occupò centinaia di persone nell'arco di quattro o cinque secoli. Intorno all'8000 a.C. il sito – che si
trova su una collina artificiale alta circa 15 m e con un diametro di circa 300 mq- venne
deliberatamente abbandonato e volontariamente seppellito con terra da riporto.
Gli scavi furono iniziati nel 1995 e rimisero in luce un monumentale santuario megalitico, costituito
da muri in pietra grezza a secco. Sono inoltre stati rinvenuti quattro recinti circolari, delimitati da
enormi pilastri in calcare pesanti oltre 15 tonnellate ciascuno. Sono state riportate in luce circa 40
pietre a forma di T, che raggiungono i 3 m di altezza, per la maggior parte incise con raffigurazioni
di diversi animali (serpenti, anatre, gru, tori, volpi, leoni, cinghiali, vacche, scorpioni, formiche).
Indagini geomagnetiche hanno indicato la presenza di altre 250 pietre ancora sepolte nel terreno,
mentre un'altra pietra a forma di T, estratta solo a metà dalla cava, è stata rinvenuta a circa 1 km dal
sito. Ha la lunghezza di circa 9 m ed era probabilmente destinata al santuario, ma una rottura
costrinse ad abbandonare il lavoro.
Per molti studiosi queste raffigurazioni di animali permetterebbero di ipotizzare un culto di tipo
sciamanico, antecedente ai culti delle civiltà sumera e mesopotamiche. Uno studio degli strati di
detriti accumulati sul fondo del lago di Van in Anatolia ha consentito di individuare una consistente
crescita della temperatura proprio intorno al 9500 a.C. e alcuni studiosi vedono – proprio in questo
cambiamento climatico– una delle ragioni determinanti della progressiva sedentarizzazione delle
genti che costruirono il sito. La presenza di una struttura monumentale dimostra che anche in una
economia di caccia e di raccolta (a questa affermazione aggiungerei: specializzata!), gli uomini
possedevano mezzi tecnici e culturali sufficienti per erigere strutture monumentali e forme
di'organizzazione sociale adeguate a favorire uno sfruttamento pianificato delle risorse alimentari,
essenziale per il successivo sviluppo delle prime pratiche agricole.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Göbekli Tepe.
Secondo diversi storici dell‟agricoltura alcune aree dell‟attuale Turchia presentavano delle
situazioni particolarmente favorevoli alla crescita dei cereali selvatici la cui produttività per unità di
superficie praticamente uguagliava quella odierna dei campi coltivati. Ma a mio modo di vedere, un
luogo come Göbekli Tepe, suggerisce che i primi approcci utili ad incrementare e stabilizzare i
raccolti stagionali – come l‟ uso di sistemi capaci di concimare la terra, la mondatura dei campi,
l‟interdizione al pascolo degli animali che potevano danneggiare le erbe, l‟occasionale irrigazionedovevano essere in uso anche a prescindere dalle prime vere pratiche di semine programmate.
Questo perché uno sforzo collettivo tanto grande e protratto per così tanto tempo, come quello
necessario a costruire un tale santuario anche su di un territorio particolarmente fertile, non sarebbe
stato possibile contando solo sui prodotti alimentari derivati dalla semplice raccolta e dalla caccia
nei territori circostanti.
Siamo quindi di fronte a una particolare forma di “raccolta assistita e/o specializzata”, una
evoluzione significativa del rapporto tra la nostra specie e la Natura circostante, ma ancora lontana
da una vera e propria agricoltura programmata.
61
Quello che mancava per arrivare alla nascita dell‟agricoltura vera e propria (cosa per la quale si
dovrà attendere ancora alcuni millenni di evoluzione tecnica e culturale (ammesso che la datazione
attuale sia corretta) apparentemente era solo il gesto della preparazione del letto di semina (cosa che
ai primordi era una pratica effettuata con la zappa e per questo molto simile alla sarchiatura) e poi la
semina vera e propria. Un passo apparentemente breve ma carico di un profondo significato
ontologico, perché paradigma -non già e non più- dell‟applicazione di una nuova “tecnica”, ma di
una nuova “funzione”. Un modo diverso di vedere, percepire, sentire e collocare noi stessi (noi,
come specie) nel più vasto proscenio del contesto naturale; legandoci a quel contesto non più da
nomadi, quindi saltuariamente e occasionalmente, ma come popolazione stanziale. Un passo che ci
ha portato a diventare una delle specie più vincolate all‟idea della “domus”, quindi domestica, e da
prestatori d‟impegno occasionale a una di quelle specie sociali che fanno del lavoro un intrinseco
valore, oltreché uno dei perni intorno al quale organizzare il complesso sistema delle interrelazioni
sociali.
Sul perché io ritenga che gli uomini l‟abbiano fatto questo passo ho già parlato in precedenza! Non
a seguito di un progetto disegnato dalla nostra intelligenza, ma – in modo molto più “naturale” –
accettando dei meccanismi di bio-alleanze (difensive, o per meglio dire: precauzionali) al fine di
acquisire per noi e distribuire per altri dei vantaggi reciproci nei confronti della normale ciclicità ed
imprevedibilità della Natura. In termini di specie coinvolte i vantaggi sono evidenti (la nostra, e le
specie a noi associate, sono oggi dominanti sia nel mondo vegetale che in quello animale e – là
dove sono insediate con i loro modelli di approvvigionamento alimentare- hanno reso “marginali”
quasi tutte le altre specie viventi.
Poi intorno ai 10.000 anni a. C. il lungo periodo di glaciazione terminò. Lo fece in un modo così
repentino (sempre parlando di epoche climatiche) che in qualche centinaio di anni i ghiacci che
coprivano molta parte della Terra si sciolsero, ritirandosi verso i poli e verso le valli montane,
innescando una serie di cambiamenti, climatici, geografici e ambientali impressionanti (questa –per
lo meno- è oggi la tesi corrente). Di questi fenomeni c‟è rimasta un‟eco che pervade quasi tutte le
culture umane: il Diluvio, che narrato a posteriori in diversi cicli evocativi, può essere considerato
come lo iato attraverso il quale la nostra specie è entrata nell‟epoca storica. Nel nostro percorso
evolutivo non ci sono infatti molti altri fatti capaci di richiamare con tanta forza il senso generale di
caos e distruzione e quello successivo rinnovamento, e credo che il latino Diluvium (da cui deriva la
parola italiana) sia stato capace di rendere tutta l‟intrinseca drammaticità dell‟evento.
Da quest‟accadimento lontano parte davvero la nostra narrazione sui temi dell‟agricoltura di cui
fino a ora abbiamo avuto solo un approccio propedeutico, perché la fine dell‟ultima glaciazione è il
vero spartiacque tra il tempo della sola caccia e raccolta e quello delle prime attenzioni prestate a
quelle specie vegetali che oggi rappresentano la base della produzione agricola, come lo è tra il
mondo muto del passato e quel tempo della memoria che ci proietta in quella storia raccontata che
porta a noi uomini contemporanei.
Questa idea di far coincidere l‟inizio del mondo coltivato con la fine della glaciazione sposta a
ritroso il tempo della terra coltivata di alcuni millenni rispetto l‟opinione comune degli studiosi che
62
– in generale- ritengono le pratiche agricole iniziate intorno agli 8.000 anni a.C. (una datazione che
corrisponde alla nascita del periodo della storia umana che siamo soliti chiamare “ Neolitico”).
Penso che in termini teorici abbia un senso collegare un evento così “rivoluzionario” della storia
umana con un altro evento altrettanto significativo della storia della Terra, specie considerando che
da alcuni anni c‟è una tendenza generale a retrodatare gli avvenimenti umani mano a mano che si
ampliano le ricerche e si aggiungono nuove scoperte. Anche perché – sempre parlando di concetti
teorici- un ritrovamento archeologico è la conferma e non l‟attestato di nascita di un determinato
evento, che va collocato in un punto più a monte delle prime testimonianze dell‟evento stesso.
Ma ammettendo che la fine dell‟ultima glaciazione possa rappresentare l‟incipit dell‟uomo
agricoltore, sorge imponente la domanda: cosa può aver portato gli uomini a coltivare la terra e a
allevare gli stessi animali che prima cacciavano? Quale profondo sommovimento dell‟io e del noi
ha generato – dopo due milioni di anni di storia evolutiva- l‟idea che il cibo non era più solamente
quello che si incontrava ma anche quello che si pianificava e si produceva e riproduceva? Quale
complessa elaborazione del pensiero ha fatto si che gli uomini pensassero che una dispensa
abbondante si potesse ottenere programmando dei futuri benefici da realizzarsi attraverso la
programmazione delle semine e dei parti, la pianificazione dei cicli climatici e il lavoro delle
braccia! Detto in termini scherzosi, come mai a un certo punto della loro esistenza i nostri antenati
hanno deciso che invece dell‟uovo raccolto occasionalmente fosse meglio aspettare e allevare la
gallina? Domanda messa in forma scherzosa che però sottintende una serie complessa di scelte mai
prese fino allora; decisioni che cambiarono radicalmente il rapporto tra la nostra specie e l‟ambiente
naturale; passaggio complesso e rivoluzionario, quanto lo è smuovere la terra con una zappa per poi
lasciare incustodito un seme, che – forse – sarà una spiga dopo mesi di attesa, o risparmiare alla
morte un giovane animale perché una volta cresciuto ci possa dare latte e lana.
Perché siamo diventati agricoltori e abbiamo iniziato ad allevare animali? Domanda che da secoli
assilla le menti degli uomini di scienza, di fede e di pensiero e che tuttora rimane un quesito al quale
non si riesce a trovare risposta adeguata. Perché diventare agricoltori ha significato pianificare la
produzione di cibo e organizzare la biologia del suolo in modo tale da poter produrre dei surplus
alimentari, cosa che a loro volta hanno permesso le suddivisioni sociali e le aggregazioni nei
villaggi, che nel tempo sono potuti diventare città, e le civitas sono state il fulcro su cui si sono
sviluppate le nostre “civiltà”; che hanno prodotto il calcolo, la scrittura, le leggi, l‟etica, la fisica e la
metafisica. Pensieri e opere che hanno portato l‟uomo a un punto sorprendente della sua storia
evolutiva, dove la mente è stata capace di sviluppare l‟idea della pietà e del rispetto, che sono i
sentimenti base della cultura della convivenza e della democrazia. Forme di comportamento che –
anche se a fatica- consentono di far convivere sulla Terra oltre sei miliardi di persone. Eppure,
malgrado le tante cose che fanno apparire straordinario il processo iniziato alcune migliaia di anni
fa, è altrettanto vero che- una valutazione critica- evidenzia così tanti risvolti negativi da far
affermare a Jared Diamond: “essere diventati agricoltori è la peggiore disgrazia che è toccata alla
nostra specie e una infelice scelta dalla quale ancora non ci siamo ripresi”.
La vita media degli uomini convertiti all‟agricoltura – se confrontata con quella degli uomini del
paleolitico - si è quasi dimezzata, ed è tornata agli stessi livelli solo agli inizi del secolo scorso e
63
solo in alcune regioni della Terra; la statura si è ridotta di quasi venti centimetri (anche questa è
tornata ai livelli del paleolitico solo un centinaio di anni fa); sono esplose le malattie contagiose
(perché la contiguità abitativa e lo scarso igiene nei villaggi e nelle città è stato il perfetto terreno di
cultura di parassiti, batteri e virus); la popolazione è aumentata, ma la fame è diventata l‟incubo
ricorrente di ogni civilizzazione che si è succeduta sulla Terra, tanto che ancora oggi un sesto della
popolazione mondiale soffre di sottoalimentazione, senza poi escludere la possibilità di un
peggioramento futuro; che le nostre civiltà si sono basate per millenni su un ordine gerarchico
piramidale che ha una intrinseca radice dis-umana; che l‟uomo – e più ancora le donne- hanno
dovuto impegnare ore e ore del loro tempo, sottraendolo ad attività ludiche, riflessive o ricreative,
per destinarlo a un lavoro tal volta massacrante, che consente di produrre del cibo spesso appena
sufficiente per la sopravvivenza; che ci sono state le guerre per accaparrarsi i beni prodotti dal
lavoro o dalla parsimonia di altri; mentre alcuni uomini rendevano schiavi altri uomini per asservirli
ai loro progetti di accumulazione; e che- una volta messo fine a questo lavoro coattivo – ha
prevalso il binomio lavoro-moneta, mezzo di scambio essenziale per comprare cibo o altri beni
spesso voluttuari e alcune volte inutili. Cosa, che a pensarci bene, è un comportamento
sconvolgente per quello che era l‟ordine naturale delle cose umane prima dell‟avvento
dell‟agricoltura. Tanto più che la triade lavoro, moneta, beni vendibili o acquistabili è basata – come
diceva un signore un po‟ di tempo fa - su uno scambio intrinsecamente diseguale-, dal quale alcuni
traggono un plusvalore a danno di molti (e oggi nel mondo ci sono dei ricchi così tanto ricchi che la
loro ricchezza non dovrebbe essere considerata un valore, ma un orrida vergogna nei confronti delle
moltitudini che soffrono di fame o di sottalimentazione, così come lo è l‟idea che esistano dei
“meriti” individuali che la possano giustificare).
Per alcune religioni la risposta a questa domanda è semplice: produrre cibo con il lavoro è la
conseguenza della perdita di uno stato di “grazia” in cui l‟uomo è caduto per aver peccato di
superbia e insubordinazione. E‟ l‟idea dell‟Eden perduto, di quell‟alterazione dello status naturale
che l‟uomo ha provocato per avere voluto paragonarsi a Dio acquisendone la conoscenza. E‟
chiaramente un‟idea affascinante non tanto per il racconto biblico in se stesso (che chiaramente è un
racconto mitopoietico) ma perché pone prepotentemente il tema dei limiti alla nostra presunta
intelligenza e alla correttezza dei nostri comportamenti; due cose che mai come ora -nel secolo che
sarà della mappatura e della manipolazione genetica, dell‟intelligenza artificiale, e del connubio tra
l‟uomo e le sue macchine- fanno diventare stringente il modo con cui valutare comportamenti e
decisioni, nell‟alveo di scelte da assumere che saranno determinanti per il futuro dell‟umanità.
A queste riflessioni impostate sul concetto di peccato e sul successivo bisogno di redenzione molti
studiosi –partendo dagli albori del positivismo scientifico ottocentesco- hanno contrapposto l‟idea
della “scoperta” dell‟agricoltura e dell‟allevamento come la prova più alta dell‟ingegno umano.
Unica specie tra migliaia capace di risolvere – grazie all‟intelletto e alla comunicazione- i problemi
e le sfide che il processo evolutivo ha messo sul suo cammino. Visti con gli occhi di società
coloniali in tumultuoso sviluppo economico i risultati erano inequivocabili e, nel cercare le ragioni
che hanno portato gli uomini a quel salto comportamentale, gli scienziati (quelli del secolo scorso)
hanno elaborato una serie di pensieri e riflessioni tra le quali emergono due teorie predominanti: la
prima suggerisce che la nascita dell‟agricoltura è da collegarsi a una “rivoluzione” concepita e
prodotta dagli uomini come risposta alle profonde e sconvolgenti trasformazioni climatiche che la
64
Terra stava vivendo, la seconda sostiene che l‟eccessiva pressione sull‟ambiente naturale ci ha
obbligati a cercare una risposta alternativa (e produttivistica) alla progressiva erosione del terreni e
alla diminuzione degli animali cacciati (e qui appare per la seconda volta la teoria della limitatezza
delle risorse che come già visto tanto peso ha avuto sulle teorie di Darwin).
Così, mentre gli uomini di fede vedono l‟uomo precipitato dal giardino dell‟Eden nella tribolazione
dei fatti quotidiani per via di un atteggiamento che sottintende una colpa (quindi l‟oggi come una
perdita), la quasi totalità degli scienziati intravede nei fenomeni esterni la causa o la ragione che
hanno portato la nostra specie a “inventare” soluzioni tecniche per rispondere o arginare il problema
del reperimento delle risorse alimentari (quindi l‟oggi come un‟acquisizione). Questo punto di vista
sottintende – anche se indirettamente- che la capacità di “inventare” corrisponda al genio di una
specie che, unica tra tutte quelle che popolano la Terra, è stata capace di affrontare le sfide e di
trovare quelle soluzioni. Soluzioni che - nel solco del lavoro e dell‟accumulazione- hanno tracciato
un sentiero che dagli albori dell‟agricoltura porta all‟Homo oeconomicus delle società industriali.
Quasi a voler dire: sono – perché penso e parlo - ma anche perché produco e posseggo!
Un passaggio elaborato grazie all‟intelligenza, per rendersi indipendente dai condizionamenti
imposti dalla Natura, realizzato attraverso scelte fatte da una specie che era giunta al punto di far
valere la sua capacità creativa per imporre una forma di imperium sul resto della sfera vivente.
E‟ in questo contesto che - lasciando gli uomini di fede al loro alto pensiero- vorrei provare a dare
un contributo al dibattito più prosaicamente scientifico, che è così poco convincente da rimandare
alla mente a un tipico detto romanesco: se la cantano e se la sònano! A voler dire: spesso gli uomini
cercano gli strumenti e le forme per convincere se stessi della giustezza di quello che loro stessi
hanno pensato. Ci scherzo su per allentare la tensione, perché -in realtà- siamo arrivati a un
momento dove le parole vanno valutate con il bilancino.
Per prima cosa penso che sia opportuno cancellare una serie di falsi miti o di evidenti errori di
valutazione, come l‟idea che gli uomini si siano messi a coltivare la terra e ad allevare gli animali
per rispondere al problema dell‟esaurimento delle risorse. Non perché il problema della limitatezza
delle risorse non esista, ma perché è sbagliato l‟angolo prospettico con cui si guarda il problema
stesso. In Natura gli habitat tendono all‟equilibrio e –normalmente- qualsiasi specie – di fronte
all‟assottigliamento delle risorse si auto-limita nelle nascite o si riduce di numero per aumento della
mortalità o per migrazioni forzate. Cercare di spiegare che di fronte ai limiti del proprio
approvvigionamento alimentare gli uomini, invece di adattarsi, siano stati capaci di progettare
soluzioni che tra l‟altro posticipano nel tempo i benefici del progetto, è l‟ennesimo peccato di
sovrastima che abbiamo fatto di noi stessi e che ci ha condotti ad un errore di valutazione.
Rimangono però le imponenti trasformazioni climatiche generate dalla fase post-glaciale! Possiamo
immaginare queste trasformazioni come l‟evento scatenante? Possiamo vedere nel Diluvio (in senso
metaforico) il catalizzatore capace di innescare un rimescolamento tale dei fenomeni naturali da
finire per coinvolgere anche la nostra specie?
Ci vengono in aiuto - in questo senso- alcune teorie elaborate dagli ultimi decenni del secolo scorso,
incentrate sul concetto di complessità. Mi permetto a questo proposito di trascrivere – seppure
65
adattata al discorso che stiamo facendo – una lunga riflessione (comprese le citazioni riportate in
corsivo) presa da un interessante articolo di Mirko Di Bernardo dal titolo: Complessità e significato
nei sistemi biologici, pubblicato in internet sul sito; Dialegesthai: Rivista telematica di filosofia.
Negli anni 60 e settanta del secolo scorso nascono nuovi linguaggi adatti a rappresentare le
proprietà dei sistemi caratterizzati da una complessità funzionale e strutturale. Essi si basano
sull'insufficienza del riduzionismo come unico metodo scientifico valido, accettando l'irriducibilità
dei diversi livelli di organizzazione di tali sistemi e l'impossibilità di trovare spiegazioni esaurienti
delle loro proprietà, senza ricorrere a categorie storico-evolutive (gli organismi biologici, la mente,
l'organizzazione sociale, le economie). Questo nuovo modo di indagare la realtà che è stato definito
da alcuni studiosi la «sfida della complessità» porta a ritenere che la maggioranza dei fenomeni
chimici, fisici e biologici non si spiegano in termini di «leggi» ma di «processi», in cui il tempo è
continuamente apportatore di nuove informazioni, poiché nel tempo si determinano le «scelte» del
sistema, che vanno a costituire la sua «storia», secondo una evoluzione non predicibile a partire
dalle condizioni iniziali. A Ilya Prigogine, premio Nobel nel 1977, si deve l'applicazione dei sistemi
complessi in ambito biologico. A partire dagli studi di Prigogine ha inizio quella che alcuni studiosi
chiamano la scienza della complessità, la quale, in ambito biologico, si svilupperà negli anni
novanta grazie anche al notevole contributo offerto dalle ricerche portate avanti dal biochimico S.
Kauffman, che nel volume dal titolo “A casa nell'universo. Le leggi del caos e della complessità”
così scrive:
“Proprio in mezzo, proprio vicino alla transizione di fase, proprio ai confini del caos, possono
verificarsi i comportamenti più complessi: abbastanza ordinati da assicurare una stabilità, ma pieni
di flessibilità e sorprese”…“Se questo è vero, allora la vita non si trova nelle proprietà individuali
dei singoli (nei dettagli) ma è una proprietà collettiva di sistemi interagenti tra loro. In quest'ottica,
la vita non deve essere ricercata nelle sue parti, ma nel complesso delle proprietà emergenti che
creano il tutto. Nel tutto che emerge e si auto-riproduce non è presente alcuna forza vitale o
sostanza estranea. E tuttavia, il sistema complessivo possiede una sorprendente proprietà che è
assente in ognuna delle sue parti: può riprodurre se stesso ed evolversi”.
Alla luce di tutto ciò, dunque, possiamo affermare che i sistemi biologici sono sistemi complessi,
non lineari (impredicibili), dissipativi (che scambiano energia con l'esterno), capaci di generare
informazione (dal caos si genera l'ordine). La vita, allora può essere «interpretata» come un ordine
che, emergendo dal caos, è in grado di auto-assemblarsi in modi sempre diversi, o –come meglio
dice H. Atlan, in “Complessità, disordine e auto-creazione del significato”: “Evidentemente questo
stato intermedio non è fisso, ma consente di reagire a perturbazioni casuali attraverso mutamenti di
organizzazione che non siano una semplice distruzione dell'organizzazione preesistente, bensì una
ri-organizzazione che consenta l'emergenza di nuove proprietà …… l'aspetto più importante dei
fenomeni di auto-organizzazione è l'auto-creazione del senso, cioè la creazione di nuovi significati
nell'informazione trasmessa da un livello di organizzazione a un altro livello di organizzazione.
Perché dunque una disorganizzazione sia in grado di produrre una riorganizzazione, è necessario
che si trasformi il significato delle relazioni fra le parti. È questo il motivo per cui la questione della
creazione dei significati si trova al centro dei fenomeni di auto-organizzazione”.
66
L‟imprevedibilità delle riorganizzazioni- così come è formulata nella teoria dei sistemi complessi- è
in grado di rispondere alle domande: perché gli uomini lo hanno fatto (coltivare la terra)? Come mai
hanno deciso di farlo? Chi e che cosa glielo ha fatto fare? Quella riorganizzazione, nel suo cambiare
le relazioni fra le parti, può spiegare come mai siamo arrivati a intrecciare relazioni di do ut des con
piante e animali e ad accentuare la tendenza (presente da alcuni millenni) all‟accumulazione e
immagazzinamento dei beni alimentari?
Per rispondere conviene prima porci un‟altra domanda: la fine veloce dell‟ultima glaciazione può
essere definita come un periodo di caos creativo? Lo scambio di tanta energia in un periodo tanto
breve, gli sconvolgimenti ambientali e –in fondo- anche la traccia indelebile impressa dalla sola
parola, credo consenta di rispondere di si! Non sto parlando di un cataclisma come quelli seguiti
all‟impatto con un grande asteroide che provocarono imponenti estinzioni di massa, ma di un
periodo climatico così turbolento da essere in grado di generare un profondo subbuglio e un
successivo rimescolio ecologico. In pochi secoli cambiarono i profili delle coste e il mare invase di
nuovo quelle che per un tempo erano state pianure litoranee, si allagò di nuovo il Baltico, e
sorpassando lo stretto del Bosforo, tornò a riempirsi l‟invaso del Mar Nero; in alcune zone aumentò
enormemente la piovosità, mentre altre parti della terra andarono incontro a una veloce
desertificazione; negli oceani si ridisegnarono le direzioni e la portata delle grandi correnti marine
con imponenti conseguenze sulle terre lambite dalle stesse e sul clima terrestre in generale.
La riorganizzazione dei movimenti dei fluidi -siano essi stati acqua o aria- produsse una forte
ricaduta sulla totalità della flora e della fauna. Tra le piante le angiosperme ripresero l‟avvento sulle
gymnosperme (detto in parole più semplici le piante con i fiori – forti del ritorno pieno delle
primavere- presero di nuovo il posto delle conifere) e molte di queste si ritirarono sui dorsali delle
montagne o nei territori a clima continentale; lo stesso fecero i licheni, seguiti dalle renne -loro
utilizzatrici principali- e il loro posto fu preso dalle praterie, presto colonizzate da altre famiglie di
erbivori, ma anche da boschi di caducifoglie. Alcuni animali scomparvero, altri mutarono
fisicamente o cambiarono i loro comportamenti. Il clima più mite portò a un notevole aumento degli
insetti - specie quelli pronubi, importanti per l‟impollinazione- e insieme con essi aumentarono tutti
gli animali insettivori: uccelli, rettili, anfibi, fino ai pipistrelli; ripresero le migrazioni- che anche
oggi segnano le stagioni intermedie- e molti animali tornarono a riprodursi nelle aree liberate dai
ghiacci o dalla neve. Ma tra tutte le sorprendenti e variegate strategie, messe in campo per
avvantaggiarsi del ritorno ad un clima temperato, niente è paragonabile alla tattica adottata ( o alla
proposta accettata) dai nostri antenati; quella di aprirsi ad una alleanza con un variegato gruppo di
piante e di animali.
Ecco allora che – visto con quest‟angolo prospettico - il quadro teorico che potrebbe definire i
comportamenti dei nostri antenati si fa più chiaro. Tutto rientra nell‟ambito di quel «processo» che
ha comportato una nuova «scelta» di sistema; un‟evoluzione non predicibile che ha fatto seguito al
caos fecondo. L‟affermazione di un nuovo comportamento complesso, abbastanza ordinato da
assicurare una futura stabilità, ma portatore di flessibilità e sorprese. In fondo lo sconvolgimento
climatico fu così veloce e profondo che dovette sorprendere e spiazzare tutta una serie di
adattamenti biologici che erano stati acquisiti da un vasto gruppo di piante e di animali (pensate ad
alcuni cereali che avevano ingrossato i semi per meglio sopravvivere all‟inverno o ad alcuni
67
mammiferi che avevano aumentato la secrezione lattea per poter allattare più a lungo la loro prole e
consentirgli si meglio superare la stagione fredda)
In fondo stiamo parlando di un accordo che portava vantaggi reciproci, sulla scia di un modello che
avevamo già sperimentato quando stringemmo il patto- tuttora vigente- con il cane. Una risposta
biologica ed ecologica sorprendente, che ci consentiva di non modificare per l‟ennesima volta i
nostri bioritmi, non ci obbligava di nuovo a migrare o trasmigrare, né comportava ulteriori e
drastiche mutazioni fisiche; ma induceva –quelli si- significativi cambiamenti nei comportamenti e
nella nostra maniera di vedere e di vederci in relazione con il mondo. Perché allearsi voleva dire
aumentare la pressione ecologica sul territorio, intensificandone la capacità di estrarne alimenti; ma
voleva dire anche cercare di capire e di vedersi in un diverso contesto ambientale e di trovare le
ragioni per questa nuova collocazione; significava essere capaci di valutare i benefici che potevano
derivare nella media e nella lunga distanza e – soprattutto – avere le giuste motivazioni per
intraprendere una strada senza ritorno.
Perché l‟alleanza è vincolante tanto per gli uni quanto per gli altri! Tanto vincolante che, se è vero
che oggi gli uomini “dominano” la biosfera, è altrettanto vero che mai sarebbero arrivati a tanto
senza lo scambio mutualistico con quelle specie che oggi sono il grano, il mais, il riso, i ruminanti e
altri animali (ma di queste cose parleremo più ampliamente in un prossimo capitolo). Perché noi,
senza di loro, torneremmo precipitosamente all‟età della Terra non coltivata. E non sto scherzando
facendo quest‟affermazione: quel patto stipulato qualche migliaio di anni fa non si può sciogliere,
pena il precipitare nella situazione dei tempi precedenti il diluvio. E‟ vero che ci sono dei popoli –
attraverso dei tabù indotti dalle loro religioni- che hanno rifiutato uno o l‟altro di questi legami (il
mondo mussulmano e quello ebraico i suini e altri animali; gli induisti i bovini) e che ci sono
sempre più uomini che rigettano l‟idea di mangiare la carne degli animali uccisi o di utilizzarne i
prodotti; ma nessuna cultura ha mai rifiutato il patto con i vegetali, né potrebbe farlo. Perché in tutte
le società (tranne i popoli dell‟estremo nord che seguono una dieta che si potrebbe definire
paleoartica) i vegetali sono alla base dell‟apporto calorico di cui abbiamo bisogno per far funzionare
il nostro corpo che, per Natura, è costretto a mantenersi a una temperatura più alta di diversi gradi di
quella media terrestre. Senza quel patto con i vegetali apportatori di calorie è evidente che mai la
popolazione attuale della Terra potrebbe vivere di sola raccolta.
Tutte queste riflessioni porterebbero ad affermare che la teoria del caos –anche se per linee
generali- può essere la giusta chiave interpretativa sul perché gli uomini siano diventati agricoltori e
allevatori. Una teoria che rigetta l‟idea di un progetto pensato e sviluppato da un animale superiore
(un post-animale), e che sostituisce l‟immagine dell‟uomo architetto e muratore con quella di una
specie che – arrivata a un punto del suo cammino evolutivo e sottoposta ad un periodo di “caos”
climatico– si è resa disponibile a farsi coinvolgere da una proposta, forse fatta o forse ricevuta,
comunque accettata.
Possiamo quindi affermare che tutte le tessere del puzzle hanno trovato la giusta collocazione? Con
sorpresa e anche con un poco di riluttanza (perché questo rimette tutto in discussione) devo dire di
no! La teoria dei sistemi complessi è sicuramente valida per i tutti i fluidi, come lo è per tante altre
68
problematiche cui prima non eravamo in grado di dare spiegazioni, ma solo parzialmente si adatta
alla nostra specifica problematica biologica.
Non lo è perché inciampa su un problema insuperabile; l‟assioma della impredicibilità della
risposta, che sottintende ed impone, che nelle forme di auto-organizzazione casuali non ci possano
essere risposte uguali o simili; mentre – con curiosità scopriamo- che in Natura lo schema delle
alleanze è già stato utilizzato altre volte e da altri animali e molto prima che lo usassimo anche noi
uomini.
Le api, le formiche, le termiti vengono definite insetti eusociali perché sono capaci di costruire delle
macro società caratterizzate dalla condivisione d‟intenti, dal lavoro e dal modello di divisione della
società in caste. Si è sempre ritenuto che queste caratteristiche abbiano potuto svilupparsi grazie alla
capacità di questi insetti di comunicare in varie forme e maniere: suoni, tocchi, danze, segni, scie
olfattive; modi diversi in grado di coinvolgere organi diversi degli apparati percettivi con il fine di
consentire lo scambio di notizie e informazioni e anche di quelli che potremmo chiamare “ordini”.
Come dire: è il Verbo (nelle sue varie forme espressive) che getta le basi della socialità e una
società è tanto più vasta e forte tanto più è in grado di ampliare la comunicazione e lo scambio di
informazioni. Ma questi insetti non sono gli unici esseri viventi che comunicano, ci sono gli uccelli
che lo fanno con il canto e con il loro cinguettio, ci sono gli anfibi che gracidano, e tantissimi altri
animali che adottano le forme più varie sofisticate, come quelli che comunicano grazie alla tecnica
degli ultrasuoni.
Se la comunicazione complessa è un appannaggio condiviso da molti altri animali perché nessun
uccello, nessun anfibio, nessun altro mammifero tranne l‟uomo, sono strutturati in società? (per
dovere di cronaca occorre dire che un particolare tipo di talpa africana viene ritenuta capace di
organizzarsi su basi sociali). Questa riflessione condurrebbe a pensare che questi insetti sono
eusociali (ma alcuni studiosi preferiscono definirli anche: politici) non solo perché comunicano, ma
anche perché usano (si potrebbe anche dire sfruttano, dal concetto: mettere a frutto) lo scambio con
altri esseri viventi a loro proprio beneficio, appropriandosi di cose che per loro diventano “beni”
con i quali edificano, mantengono o ampliano le loro società.
Lo fanno le api, che in aree caratterizzate da fioriture limitate (esempio un bosco di abeti), invece di
raccogliere il polline dei fiori si sono adattate a “mungere” la melata (una particolare deiezione
zuccherina) prodotta dagli afidi che suggono la linfa dei germogli. Lo fanno le termiti e soprattutto
le fanno le formiche che sono allevatrici e coltivatrici straordinarie. Le formiche taglia-foglie
praticano nel loro mondo ipogeo una speciale orticultura basata sulla coltivazione di un fungo –
presente in Natura solo in queste camere sotterranee- che fanno crescere su un particolare terreno di
coltura composto di foglie e ramoscelli sminuzzati, masticati e impastati con la saliva, poi
fertilizzati con le feci della colonia. Alcune specie praticano invece una pastorizia transumante,
spostando gli afidi – troppo grossi per muoversi da soli- da germoglio a germoglio e sono sempre
pronte a proteggerli da eventuali predatori, esattamente come fanno i pastori con le greggi di
pecore. Altre organizzano delle vere e proprie stalle, dove le operaie si prendono cura degli afidi adattati a vivere nel buio dei loro formicai- li nutrono, li abbeverano, li fanno riprodurre
selezionandoli e tengono i ricoveri puliti. Quando il gregge aumenta troppo procedono alla
macellazione selettiva per destinare gli individui in esubero all'alimentazione delle larve della
69
colonia. Tra i vari adattamenti funzionali questi afidi domestici si sono specializzati a produrre la
melata in forma di piccole gocce, permettendo così alle formiche di raccoglierla facilmente.
Qualcuno potrebbe dire: ma sono solo formiche! Niente di più sbagliato! E‟ stato calcolato che il
peso di tutti gli uomini presenti sulla Terra e quello di tutte le formiche sia pressoché equivalente;
ma con una differenza sostanziale. L‟impronta ecologica delle formiche è nulla, perché le cose da
loro utilizzate tornano nel ciclo della natura come riutilizzabili, mentre noi siamo diventati dei
campioni nella produzione di “scarti”.
L'impronta ecologica è un indicatore utilizzato per valutare il consumo di risorse naturali rispetto
alla capacità della Terra di rigenerarle. L'impronta misura la superficie necessaria per rigenerare le
risorse consumate da una popolazione e per assorbirne i rifiuti prodotti. Utilizzando l'impronta
ecologica, è possibile stimare quanti "pianeta Terra" servirebbero per sostenere l'umanità, qualora
tutti vivessero secondo un determinato stile di vita.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Impronta ecologica
Arrivati a questo punto, e sapendo che ci sono altre specie che adottano comportamenti che
ritenevamo tipicamente umani, si ripropone la domanda: allora cos‟è questa benedetta agricoltura?
Nell‟alveo di un particolare modello che la Natura ha adottato per quei pochi animali che vengono
definiti ”eusociali”, l‟agricoltura altro non è che un particolare tipo di biocenosi che potremmo
definire: dinamica! Dove il concetto di “dinamica” sottintende che questa particolare biocenosi non
si organizza solo dove le condizione ambientali lo consentono, ma che è in grado di organizzarsi in
vari ambiti grazie alla sua capacità di influenzare e modificare gli habitat naturali su cui intende
insistere (tra qualche capitolo parleremo poi della sua evoluzione).
L‟agricoltura è quindi un ecosistema naturale integrato e in costante adattamento, dove ognuna delle
parti concorre ad assicurare la funzionalità e la stabilità del sistema stesso. La prima è l‟alleanza
mutualistica tra alcune piante e alcuni animali interconnessi tra loro (leguminose che fertilizzano il
terreno, graminacee che usano questa fertilizzazione, piante che lo rinnovano, altre che lo
emendano, animali che lo pascolano impedendone la crescita di alcune erbe concorrenti e che
pascolando lo fertilizzano); la seconda è il lavoro e la cura che un simbionte principale mette a
disposizione delle altre specie nel predisporre e organizzare tutta la complessa artificiosità del
sistema (ricevendone in cambio dei surplus di prodotti naturali); una spettacolare complessità da cui
deriva la capacità di penetrare vati tipi di habitat integrandosi o sostituendosi. Perché coltivare e
allevare vuol dire: prima adattarsi all‟ambiente, poi adattare l‟ambiente, ed infine crescere in uno
specifico ambito contenendo o escludendo le specie antagoniste.
In ecologia il termine biocenosi (o comunità) deriva dalle parole di lingua greca βιος (bios = vita) e
κοινος (koinosis = comune) ed indica la comunità delle specie di un ecosistema che vive in un
determinato ambiente, o, meglio, in un determinato biotopo (dal greco βιος = vita e τοπος = luogo),
cioè un'area in cui le condizioni fisico-chimiche ed ambientali sono costanti. Il biotopo, per le sue
caratteristiche, può essere definito come l'unità fondamentale dell'ambiente. L'ecosistema è formato
quindi da biocenosi e da biotopi. Meno usato è il termine biota per descrivere l'insieme della vita
70
vegetale e animale che caratterizzano una certa regione o area (ad esempio biota europeo). Il biota
della Terra, nel suo insieme, occupa lo spazio definito biosfera. La biocenosi, come detto, è l'unità
biotica fondamentale dell'ecosistema. I principali biomi (come ad esempio tundra, taiga, foresta
temperata, prateria, deserto e foresta tropicale) che ricoprono la superficie terrestre sono
caratterizzati da un'associazione biocenosica dominante e caratterizzante il paesaggio. Tutti i biomi
terrestri, con tutti gli organismi che li abitano e l'ambiente nel quale vivono compongono la
biosfera. Da questo punto di vista tutta la biosfera può essere considerata un'unica grande biocenosi.
La biocenosi è dunque un insieme di popolazioni di specie diversa che vivono in uno stesso
ambiente naturale e fra le quali si vengono a creare dei rapporti di interrelazione e interdipendenza.
La comunità ecologica ha delle caratteristiche proprie dette proprietà emergenti, che non si
riscontrano a livelli di organizzazione biologica gerarchicamente inferiori (singolo individuo e
popolazione). Tali proprietà sono la diversità specifica, i rapporti di distribuzione delle varie
popolazioni e l'organizzazione trofica (rete alimentare e catena alimentare). Come già detto, la
natura di una comunità è strettamente legata all'ambiente in cui vive e poiché l'ambiente è spesso
disomogeneo, anche la comunità presenta variazioni nello spazio e nel tempo. La zonazione
spaziale è la distinzione tra comunità contigue causata dalle variazioni delle condizioni ambientali
nello spazio (ad esempio temperatura ed umidità). In genere le condizioni variano gradualmente e
quindi non è quasi mai possibile definire confini netti. Inoltre molto spesso due comunità sono
separate da un ecotono, cioè da una comunità di transizione formata da un popolamento misto di
specie appartenenti alle due. Più le condizioni ambientali variano bruscamente e più sono netti i
confini tra due comunità. La zonazione temporale è la distinzione tra comunità determinata da
variazioni temporali delle condizioni in uno stesso sito. Questo tipo di zonazione è legata al
fenomeno della successione: il susseguirsi della componente biotica nell'ecosistema tramite processi
di colonizzazione- estinzione-sostituzione. Alla fine del processo si arriva ad una biocenosi stabile,
omeostaticamente regolata, chiamata Climax. Sono esempi di biocenosi la barriera corallina, le
zone umide, le aree urbane, le biocenosi bentoniche.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Biocenosi
Per rendere più semplice il quadro appena descritto guardiamo cosa fanno su un terreno incolto dei
bonificatori: abbattono alberi e arbusti (che vengono estirpati e bruciati), eliminano le erbe naturali
(che vengono sarchiate e oggi diserbate), escludono gli animali concorrenti (che vengono cacciati o
scacciati), scartano i semi e gli animali più deboli e si assicurano la riproduzione dei più forti, più
sani e più docili. L‟effetto di tutto questo? Semplice! Sui territori toccati da questa particolare forma
di biocenosi che vede l‟uomo assumere il ruolo di simbionte principale si vede aumentare
esponenzialmente la presenza delle specie coinvolte a danno della biodiversità naturale. Perché
l‟agricoltura non aumenta la possibilità assoluta di un territorio di sostenere un ricco e variegato
bioma, ma aumenta quella relativa dei contraenti il patto. Ci sono voluti diversi millenni perché gli
uomini imparassero a modificare il suolo con emendanti e concimazioni e bonifiche e il clima con
delle irrigazioni. L‟applicazione di queste tecniche ha effettivamente prodotto un significativo
aumento della produttività agronomica, ma solo perché a questo scopo le tecniche sono state
indirizzate. Una sorgente che irriga quello che prima era un deserto permetterebbe di produrre una
71
grande massa vegetale, se l‟acqua non fosse finalizzata alla produzione di soli bisogni destinati agli
uomini e agli animali suoi alleati.
C‟è poi un altro aspetto tanto importante quanto lo è stato l‟acquisizione di questa “funzione”, ed è
la ripetizione nel tempo della stessa. Ci sono dei popoli – specie quelli che abitano nelle foreste
amazzoniche - che praticano l‟agricoltura temporanea. Coltivano per un certo numero d‟anni e poi
si spostano per cercare nuovi terreni da coltivare. Questi popoli – per ragioni che dipendono da
particolari condizioni naturali – non riescono a preservare la fertilità dei terreni e sono quindi
obbligati a spostarsi dopo alcuni anni di coltivazione. La quasi totalità dei terreni coltivati invece lo
sono da generazioni; questo è successo quando l‟uomo, trasformatosi in agricoltore, è riuscito a
cooptare intorno a se una biocenosi complessa, che con alternanza di specie, con giuste rotazioni e
consociazioni, ma anche con gli opportuni riposi, è stata in grado di produrre quei surplus di
granaglie di cui noi stanziali abbiamo bisogno senza diminuire l‟humus del terreno. Anzi, di
riuscire nell‟incredibile risultato di asportare nei millenni dei surplus produttivi annui e nello stesso
tempo di aumentare poco alla volta la fertilità stessa del terreno. Prendere senza togliere, anzi:
togliere aggiungendo! Questa è l‟agricoltura (quella vera), l‟unica attività umana dove la nostra
specie si dimostra capace di prelevare cibo in ogni ciclo produttivo stagionale ma, nello stesso
tempo, di chiudere un ciclo poliennale aumentando, anche se di poco, la fertilità della terra
coltivata. Su questo “miracolo” biologico si è basata, fino a ieri, tutta l‟essenza del nostro vivere su
questa pianeta.
Ma per capire tutto questo abbiamo bisogno di aprire il prossimo e breve capitolo.
72
La Terra, la terra e il terreno
Quanto lavoro per fare della terra un campo coltivato
C‟è la Terra, il pianeta che noi popoliamo, quella che girando sul suo asse fa il giorno e la notte e
che, ruotando intorno al sole con un orbita ellittica, fa le stagioni. Corpo celeste che da oltre quattro
miliardi di anni porta a guinzaglio il suo unico satellite: la luna. Il più grande tra i pianeti tellurici
del sistema solare; composto di rocce e metalli, circondato da un atmosfera di gas, irradiato dai
raggi solari sotto forma di luce. Sfera geoide in gran parte coperta di acque che riverbera azzurra nel
cosmo infinito. Studiata dall‟astronomia e dall‟astrofisica.
Poi c‟è la terra, quella nuova cercata dagli esploratori - che spesso la coniugano al plurale – Quelle
esplorate da Ulisse e da Giasone o da Sinbad il marinaio, quella acclamata da Cristoforo Colombo
alla fine del suo viaggio su un mare sconosciuto. La parte emergente dalle acque di quella corazza
di rocce solidificate che ricopre la Terra per lo spessore di alcuni chilometri, quella su cui posiamo i
nostri piedi. Studiata dalla geologia, la geografia o la climatologia.
Poi c‟è la terra, quella che possiamo prendere in un pugno della mano. Quella che l‟azione del
tempo e degli elementi ha sbriciolato e che la vita ha colonizzato sopra e sotto il suo manto.
Delicata epidermide, punto di scambio tra l‟atmosfera e il mondo sotterraneo. Sottile pellicola dove
luce, liquidi e fluidi gassosi si incontrano e si compenetrano. Studiata dalla mineralogia, dalla
pedologia, ma anche dalla biologia e ecologia e – in generale – dalle scienze naturali.
Terra fatta di rocce sminuzzate dal tempo e dal clima: pietre, ghiaia, sabbia, limo, argilla. Uno
stroma minerale con tessitura e struttura diversa a secondo delle varie percentuali dei suoi
componenti, su cui camminano, strisciano, volano e – in alcuni casi - nuotano varie forme della vita
animale; dove trovano alloggio batteri, licheni e funghi, più una varietà sorprendente di animali
specializzati nella vita ipogea, dove le erbe e gli alberi affondano le loro radici e dove da milioni e
milioni d‟anni tutta la vita trova la sua bara.
Vita passata - seppellita nel profondo- che ha dato luogo a imponenti depositi di sostanze fossili.
Antica luce nascosta nel buio della Terra che oggi noi sfruttiamo per estrarne la sua originaria
energia. A questa vita sottratta e inerte si contrappongono le cose morte che ogni giorno cadono sul
suolo (o che vivevano in esso) e che in presenza di ossigeno e delle giuste condizioni di umidità e di
temperatura – attraverso trasformazioni lunghe e complesse- danno origine a un substrato vivo e
vitale chiamato ”humus” (che in latino vuol sempre dire: terra).
Una materia scura e plastica, grassa al tatto e odorosa di muschio. L‟humus, un colloide che attrae e
lega a se le molecole d‟acqua e gli elementi minerali in essa diluiti e, in questo modo, ne contrasta
il percolamento e la lisciviazione nel profondo. Un effetto spugna che lo fa assomigliare a un
deposito logistico e lo fa funzionare come il perno della bilancia tra eccessi e bisogni osmotici della
73
vita vegetale. Humus, di cui siamo in grado di quantificare la quantità presente nel terreno, di cui
conosciamo nella struttura fisica e le funzioni, ma che non siamo ancora in grado di definire se non
sommariamente. Perché l‟humus è metonimico, una parte che rappresenta il tutto. C‟è più vita in
una sola manciata di humus che uomini sulla terra.
La terra è fertile perché l‟humus è fecondo, ed è questa sua capacità che ha consentito alla nostra
specie di trovare alloggio stabile sulla Terra. Perché dove il suolo è povero di humus: per il clima
(ghiacci), per l‟altitudine (rarefazione dell‟aria), o la struttura stessa del suolo (deserti di roccia e
sabbie), o peggio ancora perché l‟humus è stato distrutto da azioni traumatiche, gli uomini sono
costretti a vivere da nomadi. E‟ il ciclo di formazione e asportazione dell‟humus che getta le basi
della vita vegetale e animale, ma questo processo è incostante! Il freddo riduce l‟attività dei miliardi
di organismi coinvolti e favorisce la fossilizzazione della sostanza organica, il caldo asciutto la sua
vaporizzazione. Stessi problemi emergono in suoli troppo umidi o troppo acidi, o troppo basici. Lo
spettro pedoclimatico dove i processi di umificazione sono massimizzati ha un rank ristretto. Questo
è quello che è successo alla fine della glaciazione, quando -per diverse centinaia d‟anni- le
condizioni ambientali sono state in grado di incrementare significativamente la presenza di humus
nella terra.
E‟ stata questa maggiore presenza e vitalità dell‟humus, legata al clima mite, che ha favorito
l‟ubertosità della terra e questo ha avvantaggiato i vegetali granicoli e in particolar modo le
graminacee che non hanno batteri fissatori d‟azoto che vivono sulle loro radici. A questo si sono poi
aggiunte le attenzioni che i nostri antenati dedicarono nel costruire le migliori condizioni possibili
alla crescita di quelle piante con cui cercavano alleanze: mondando i prati dalle specie concorrenti e
cominciando a dissodare la terra da pietre e radici, per poi arieggiarla con varie lavorazioni. Tutto
questo ha permesso – nel tempo - di trasformare la terra in quello che si chiama: terreno agrario.
Perché terra e terreno non sono sinonimi. La terra è il suolo come la Natura lo ha fatto, ossia una
terra vergine; mentre il terreno è il suolo modificato dal lavoro (prima dei soli uomini, poi degli
uomini coadiuvati dagli animali da tiro e ora delle macchine). Il terreno in Natura non esiste, quello
che oggi coltiviamo è quindi il risultato di un processo iniziato circa 10-12.000 anni fa e studiato
dall‟agronomia e più in generale dalle scienze agrarie.
La maggior parte delle persone pensano che dove c‟è terra ci può essere agricoltura. In realtà, nel
mondo, le aree facilmente e immediatamente coltivabili sono state solo alcune praterie a clima
temperato e altre piccole aree sparse per i vari continenti. La quasi totalità degli terreni agricoli
attuali sono invece il frutto del lavoro, pesante, improbo, di generazioni e generazioni di donne e di
uomini e del loro costante impegno nel renderli coltivabili. Di tutto questo – noi, lontani discendenti
– abbiamo purtroppo perso memoria. Come abbiamo perso coscienza del fatto che tutta la vita
animale presente sulla Terra deriva da quel sottile strato di 20-30 centimetri dove alberga l‟humus,
quel sottile stato che noi uomini moderni oltraggiamo in forme e modi più fantasiosi e disparati.
Quello strato che in Natura è reso ricco dalle foglie cadute, l‟organo più perfetto del mondo
vegetale. Una lamina sottile, flessibile al vento, che sul lato esposto riceve la luce. Energia solare
che permette di coniugare anidride carbonica dell‟aria e acqua tissutale per produrre quell‟energia
organica (zuccheri, amidi, cellulose) rilasciando l‟ossigeno che tutti consumiamo e senza il quale
74
non potremmo respirare. Guardate le foglie che cadono in autunno, un tappeto morbido che in pochi
giorni viene riassorbito senza lasciare tracce e che apporta concime alla terra. O pensate ai corpi
morti che se insepolti ammorbano l‟aria e sono potenziali veicoli di contagio e malattie. Riponete
quei corpi nella terra e i pericoli scompaiono, perché la terra funge da bara e –in presenza di humussanifica la morte anche quando è un eccidio. Questo è l‟immane potere dell‟humus, quello che agli
uomini piacerebbe avocare a se e che invocano ai loro Dei, quello della transustazione. Ossia il
potere di portare le cose morte a nuova vita.
75
Il nostro addomesticamento
Da migliaia d‟anni l‟uomo aveva preso una pietra nella mano, l‟aveva osservata, immaginata adatta
ad un uso; per fare questo l‟aveva scheggiata, lavorata fino a darle la forma desiderata, infine –
unico tra tutti i primati- l‟aveva ammanicata per poterla meglio impugnare e trasformare in
un‟arma. Quella pietra diventata ascia è stata lo strumento più significativo della sua affermazione,
quella con cui ha scacciato nemici e cacciato prede. Poi, in un giorno imprecisato del dopo
glaciazione, qualcuno a quell‟arma aveva aggiunto un manico lungo più delle sue braccia – che la
terra era bassa sotto i suoi piedi - aveva ruotato la pietra di 90 gradi rispetto all‟ascia, angolandola
rispetto al manico, poi - con entrambi le mani- aveva impugnato questo nuovo strumento, lo aveva
sollevato sopra la testa e, con slancio e ampia roteazione, l‟aveva piantato nel terreno. Non era
ancora un solco, ma una semplice scalfittura sulla crosta della terra, una piccola culla fatta di
terreno smosso. In quella culla – colui o colei che aveva inventato la zappa - aveva lasciato
volutamente cadere alcuni semi, preoccupandosi di coprirli per fare in modo che fosse facile per
loro tornare alla terra e nutrirsi di essa. Con quel gesto quell‟uomo (chiaramente parlo di “uomo” in
senso corale) aveva prodotto una cesura con tutta la storia di tutti i suoi antenati e rivoluzionato per
sempre le vite della sua figliolanza. Perché - in un tempo così pieno di cambiamenti - oltre
all‟adattarsi all‟ambiente circostante o migrare alla ricerca di nuovi spazi abitativi, quel gesto (che
come avrete capito ho romanzato nei suoi molti passaggi) ha trasformato l‟uomo in un fulcro capace
di aggregare intorno a se piante e animali alla ricerca di nuovi habitat fruibili nell‟ecologia postglaciale. Nicchie che nel tempo si sono dimostrate così funzionali e adattabili da arrivare fino ad
oggi, anche perché rinsaldate da fenomeni coevolutivi che hanno interessato tutte le specie
coinvolte. Tutto questo reso possibile dalla capacità di questi nuovi aggregati biologici di incidere,
fino a modificare, gli ambienti naturali nei quali si andarono a inserire.
Questo complesso e stupefacente momento in cui alcuni micro sistemi coesi si organizzarono
all‟interno di macro sistemi aperti è stato ed è uno dei temi più discussi e dibattuti della storia
dell‟umanità. Come già detto non credo che in quel gesto ci sia stata una predestinazione biologica
o sopranaturale, ma neppure una condizione inducente come quella della scarsità delle risorse;
perché non vedo l‟agricoltura nascere da un progetto ma – più semplicemente- dall‟accettazione di
una proposta. Un accordo tra le parti normato da leggi tutte interne alla Natura, prima labile e
fugace (e ristretto a poche specie), poi pian piano evolutosi fino a divenire un legame ferreo e
imperituro ed esteso a un numero relativamente ampio di specie vegetali e animali.
Questo mio modo di pensare sottintende che l‟agricoltura sia nata nel segno di preordinate leggi
biologiche, le stesse che avevano indotto e normato i modelli comportamentali degli insetti sociali,
mentre il suo sviluppo – influenzato dall‟imprevedibilità - è dipeso da tentativi che mischiarono
impegno, pazienza, tenacia e piena disponibilità alla comprensione e all‟adattamento di tutte le parti
contraenti. Attenzioni e comportamenti non molto dissimili da quelli che la nostra specie presta
normalmente alla crescita dei figli. Perché – forse- è proprio in quel tempo dilatato dello sviluppo
dei piccoli umani che si può trovare una chiave utile per capire gli atteggiamenti che sono stati
76
necessari per legare a noi (e per legarci) altri esseri viventi. Non è un caso che alcuni autori abbiano
voluto vedere nell‟inizio dell‟agricoltura e dell‟allevamento un‟impronta tipicamente femminile.
Idea suggestiva che lascio al campo delle ipotesi, non senza aver fatto notare che oltre ai
comportamenti accumulatori delle derrate alimentari (che gli uomini avevano acquisito da alcuni
millenni) questa potrebbe essere l‟ennesima similitudine che ci accomuna con gli insetti sociali (un
mondo governato dalle regine).
Ho voluto puntualizzare questi passaggi perché penso che l‟uomo del post mesolitico non avesse
strumenti per esulare dalle leggi che regolavano e regolano gli equilibri naturali. L‟idea dell‟uomo
guidato dall‟ingegno o dal volere divino e portato da questi verso forme di organizzazione della
Natura a fini produttivistici è un‟offesa alla nostra intelligenza e all‟ineludibilità delle leggi
biologiche, cui nessun essere vivente – fino a pochi anni fa – è potuto sfuggire (torneremo su questo
importante argomento in uno dei capitoli di chiusura). L‟intelligenza deduttiva e intuitiva della
nostra specie, il suo ingegno e abilità manuale (cui è legato lo sviluppo delle tecnologie), la sua
facilità di comunicazione e di socializzazione, la sua indole (per un lato materialista e pragmatica,
ma per l‟altro portata a speculare sull‟inconosciuto e l‟irrazionale), che ci fa ridere e piangere per
gli affetti e le emozioni, cantare o fischiettare per la gioia, pregare o scongiurare o ammirare
stupefatti o sgomenti i fenomeni della Natura, sono stati invece il volano che abbiamo utilizzato per
“dinamizzare” le varie biocenosi; fino a portarle ai sorprendenti risultati produttivi degli ultimi due
secoli, che - nei paesi ad agricoltura intensiva - consentono a pochi milioni di persone di produrre
cibo in abbondanza per tutto il resto della popolazione. Ineludibilità che non sembra applicarsi ai
complessi sistemi relazionali che attualmente regolano il nostro vivere sociale e civile; visto che dopo le grandi civiltà idrauliche - che ricalcavano il modello comportamentale preso in prestito dal
mondo degli insetti sociali, si è evidenziata nella nostra specie una capacità “politica” che ci ha
permesso di gestire - in forma parzialmente compartecipata - le nostre complesse relazioni sociali
(argomento affascinante e complesso che però esula dalla traccia principale di questo scritto).
Possiamo però essere certi di una cosa: che tutto questo modello ha avuto un inizio solo poche
migliaia di anni fa, e possiamo anche presumere che il primo atto dell‟alleanza fu quello di allestire
per i nostri futuri partner dei ricoveri accoglienti; adatti a ospitare quelle piante e quegli animali che
cercavano un nuovo spazio ecologico nel caos creativo della post-glaciazione. Un ricovero per i
semi, prima asciutto per conservarli e poi – una volta interrati - umido e soffice per favorirne la
germinazione, e un ricovero per gli animali, solido e sicuro quanto bastava per tenere lontano le
fiere. Non è un passaggio difficile da capire: un‟alleanza simbiotica si basa su un dare qualcosa in
cambio di altro. Nel nostro caso specifico, dare sicurezza alla progenie dei nostri alleati (favorendo
così la soprariproduzione di quelle mutazioni che si erano evidenziate durante l‟ultima glaciazione e
che forse “avvertivano” il pericolo della fine della stessa) in cambio di un surplus d‟individui o di
prodotti che poteva essere considerato eccedente rispetto alle necessità dell‟ecosistema che si stava
organizzando.
Chiaramente bisogna intendersi riguardo al concetto di eccedenza. In un ambito esclusivamente
naturale la dispersione dei semi è una legge assoluta. Le piante “sanno” che molto del germoplasma
che producono, andrà perduto prima della stagione della germinazione. Le cause possono essere le
più svariate. I semi possono essere predati dagli uccelli o da altri animali granivori, possono perdere
77
la loro capacità germinativa a causa di una stagione sfavorevole, o – nei casi limiti possono
germinare e poi morire sempre per cause climatiche infauste. La Natura si tutela da questi eventi
producendo una sovrabbondanza di semi in relazione al fabbisogno di autoriproduzione della specie
(questo discorso vale anche per il seme degli animali tenendo però a mente che il “seme” dei
vegetali è diploide perché è il risultato di un accoppiamento, mentre il “seme” -ossia lo spermadegli animali è aploide e corrisponde a tentativi di accoppiamento). Questa dispersione “ad
abundantiam” favorisce direttamente sia la specie sia tutti coloro che ne possono trarre vantaggio.
Più o meno lo stesso succede nel regno animale se parliamo di pesci o di anfibi, mentre tra
mammiferi le leggi della riproduzione seguono altre regole: quasi tutte le femmine diventate puberi
entrano nel ciclo riproduttivo, dal quale sono esclusi una percentuale considerevole dei maschi.
Infatti, oltre agli animali malati, a quelli vecchi o ai giovani e inesperti, anche i maschi allontanati
dalla protezione del branco - dopo gli scontri che li hanno visti perdenti- diventano un obiettivo di
caccia per i predatori. Questo perché il numero dei maschi necessari per assicurare la riproduzione e
il ricambio genetico di una popolazione è spesso significativamente più basso del numero delle
femmine. Non amo particolarmente cibarmi di carne e penso che la ragione, i bisogni generali
dell‟ecosistema terrestre, gli affetti, ci porteranno in un prossimo futuro ad abbandonare sempre di
più l‟idea di mangiare gli animali (già solo il dirlo dà all‟idea un‟immagine sanguinolenta); ma
vorrei far notare che ancora oggi – nell‟età degli allevamenti intensivi - a parte i panini con la carne
macinata, che sono la destinazione tipica delle bovine da latte al termine del loro ciclo produttivo noi continuiamo a mangiare: manzi, vitelli, agnelli, capretti, polli, ossia solo giovani maschi che la
Natura avrebbe tendenzialmente escluso dal ruolo di riproduttori. Pensiamo di controllare il mondo
e abbiamo sempre più strumenti per farlo, ma nello stesso tempo siamo governati da leggi archetipe
alle quali sottostare.
E‟proprio in questo contesto di leggi naturali che iniziarono a organizzarsi quelle biocenosi che ci
videro precocemente assumere il ruolo di simbionti principali, posizione assunta quando i nostri
antenati iniziarono a favorire la riproduzione delle specie a noi legate (cosa che si poteva ottenere
anche grazie all‟esclusione di quelle concorrenti) con il fine di assicurarsi l‟unicità della funzione di
predatore naturale. Siamo di fronte ad un modello specifico, dove la protezione è barattata con una
predazione controllata; un sistema ecologico capace di sostenersi solo trovando il punto di
equilibrio tra quello che si preleva e quello che deve essere lasciato alla Natura in modo ché non si
producano svantaggi alle specie coinvolte. Cosa possibile asportando solo quel plus di piante e
animali generati proprio dalle leggi naturali dell‟”abundantiam”. Risulta però evidente come, con
l‟applicazione e poi con l‟estensione di questo modello, gli uomini abbiano iniziato a muovere i
primi passi verso quell‟idea di costruito (o per meglio dire: di artificiale) sottinteso nel concetto di
biocenosi dinamica. Ma questo tema lo affronteremo più ampliamente quando arriveremo a parlare
delle civiltà idrauliche - per ora, e per altri cinque, sei millenni - non si manifesteranno cambiamenti
significativi o frizioni evidenti all‟interno degli habitat naturali che ci vedranno compresenti nella
funzione talvolta duplice di fruitori naturali, in qualità di cacciatori - raccoglitori, e in quella di
fruitori organizzati, sotto la forma, ancora labile, di agricoltori-allevatori.
Come già visto in Natura non siamo i soli ad adottare questi comportamenti, alcuni insetti sociali
fanno più o meno lo stesso. Solo che lo fanno da così tanti milioni di anni che, fino ad oggi, non
siamo riusciti a capire come abbiano potuto stringere le loro alleanze, come abbiano immaginato,
78
progettato e organizzato quei ricoveri dove alloggiano i loro produttori di melata, o i campi
sotterranei dove coltivano i loro funghi. Abbiamo comunque la certezza che senza gli apporti
produttivi, che varie specie d‟insetti e di funghi assicurano loro, verrebbero meno gli architravi su
cui gli insetti sociali hanno costruito le loro società complesse, piramidali e classiste. Questo perché
il mantenimento di una società vasta e stratificata è legato alla piena fruizione della capacità
produttiva del territorio su cui essa insiste; ciò comporta che le società complesse devono piegare ai
propri interessi, e ai bisogni comuni tra alleati, gli equilibri che reggono gli habitat naturali
circostanti. Questo si ottiene inserendosi all‟interno del sistema naturale – composto da mille e
mille interconnessioni diverse- con il proprio sistema coeso e facendo in modo di espellere e
sostituire le specie concorrenti (detto in altre parole: riducendo la biodiversità del bioma) in modo
di addurre verso di se una maggior quota delle risorse e della produttività naturale del bioma stesso.
Comunque, mancando a oggi un‟esauriente storia evolutiva dei insetti sociali, manca anche una
storia comparativa capace di assimilare i nostri comportamenti ai loro; per questa ragione è ancora
più importante seguire le flebili tracce che emergono dal nostro passato, tracce utili per capire quali
sono stati i percorsi che ci hanno portato alla nascita di quelle particolari forme di collaborazione
che con non poca approssimazione siamo soliti considerare come espressioni culturali tipiche della
nostra specie.
Diversi sono i gradienti relazionali che ci legano a piante ed animali; e dato che siamo una società
che ritiene la carcerazione un metodo educativo, non deve sorprendere che la vulgata comune veda
nella cattività (dal latino captivus; prigioniero) lo strumento adeguato per favorire all‟asservimento
degli animali; immaginando che costringendoli a vivere e in spazi circoscritti si riesca ad
ammansire la loro indole, fino ad ottenere individui proni ai nostri desideri e ai nostri bisogni (una
cosa analoga vale sommariamente anche per i semi). E‟ vero che la cattività è stata ampliamente
utilizzata dagli uomini per scopi ludici e/o sacrificali e che anche oggi ne facciamo largo uso; ma
penso che questa restrizione della libertà non abbia mai prodotto i cambiamenti di morfologia e di
comportamento che sono tipici delle specie “domestiche”. Questo perché la domesticazione non
discende né dalla reclusione né dalle privazioni, ma da una scelta che corrisponde a precisa strategia
di specie. La differenza tra gli animali prigionieri e quelli domestici la possiamo misurare nel
momento in cui i primi riacquistano la libertà e, senza problemi, tornano alla loro piena dimensione
animale; quasi a dimostrazione che la cattività, anche dopo generazioni, altro non è che una
prigionia temporanea che nulla ha che vedere con l‟inizio di una domesticazione.
A misurare il grado d‟integrazione del sistema simbiotico non è quindi il livello di ammansimento,
perché gli animali e le piante possono arrivare a fare esattamente quello che noi vogliamo senza per
questo essere integrati in una simbiosi. Ne è prova tangibile il loro addomesticamento (dal latino
domus che significa casa), uno status che comporta l‟abbandono più o meno forzato dello stato
selvatico del singolo animale o di un gruppo. Gli animali addomesticati (quelli dei circhi, per
intenderci) possono in alcuni casi anche aiutare l‟uomo in particolari attività lavorative (come nel
caso degli elefanti), ma, anch‟essi lasciati a se stessi, riprendono immediatamente il loro normale
comportamento di specie.
79
Più complesso è il discorso relativo alla relazione tra animali e l'uomo (concetto esteso anche alle
piante) se parliamo di domesticazione; questo è lo stadio cui si trovano quelle piante e quegli
animali che insieme all‟uomo hanno sviluppato quelle particolari forme di biocenosi che siamo
soliti chiamare agricoltura e allevamento. Queste complesse forme relazionali sono il frutto (sembra
proprio il caso di dirlo) di significativi cambiamenti morfologici, fisiologici e comportamentali di
tutti i soggetti coinvolti; cambiamenti legati o indotti dalla comparsa di specifiche mutazioni
genetiche e segnati da un percorso coevolutivo più che coercitivo. La vasta gamma di pratiche
agronomiche come il dissodamento, la concimazione o l‟irrigazione del terreno, il controllo
dell‟alimentazione, la convivenza spaziale con individui della stessa specie o tra specie diverse,
altro non sono che strumenti accessori che l‟uomo ha utilizzato per consolidare e ampliare nel
tempo e nello spazio le varie relazioni simbiotiche. Gli stessi incroci etero o omozigoti, usati in
agricoltura da un paio di millenni, sono ipotetiche proposte che per affermarsi hanno necessitato il
vaglio della Natura; setaccio di ultima istanza anche dei sistemi coesi (torneremo a parlare
dell‟evoluzione dalla selezione naturale a quella artificiale verso la fine di questo scritto). Una cosa
però è acclarata: se mai dovesse succedere un qualche fenomeno che imponesse il ritorno allo stato
selvatico, le specie domesticate subirebbero un così profondo processo di riadattamento da portarle,
probabilmente, all‟estinzione o alla marginalità biologica.
Un ritorno alle origini che potrebbe avere anche sulle società umane conseguenze paragonabili alla
più terrificante scenografia horror hollywoodiana. Provate a immaginare quali sarebbero gli effetti
di una pandemia che eliminasse l‟ottanta per cento del pollame allevato sulla terra, con la
conseguente interruzione di tutta la filiera della carne, delle uova e dei prodotti a esse legati.
L‟impatto sulla popolazione umana sarebbe pesantissimo (basti ricordare cosa è successo in Irlanda
tra il 1845-49 con la peronospora della patata che dette il via alla tragedia conosciuta come: the
Great Famine). Diventerebbe poi drammatico se una cosa del genere dovesse toccare alle
graminacee (grano, riso, mais, orzo, miglio) che sono alla base di quasi tutti i modelli alimentari
dell‟umanità. Senza l‟apporto calorico assicurato dalle graminacee, gli uomini sprofonderebbero in
un abisso biologico dal quale solo con enormi difficoltà e con immani perdite potrebbero, forse,
rivedere la luce (è opportuno però specificare gli uomini che vivono nella fascia equatoriale hanno
forme di approvvigionamento alimentare che non vertono sui cereali). Credo che non sarebbe
azzardato stimare che senza il contributo alimentare dato dalle graminacee, la popolazione umana
tornerebbe ai numeri e ai comportamenti del tardo mesolitico. Questo perché la specie più coinvolta
dal processo di domesticazione sia per le mutazioni genetiche (i gruppi sanguinei, il colore della
pelle, la plica degli occhi, il perdurare anche da adulti dell‟enzima della lattasi etc. etc.) che per i
cambiamenti comportamentali siamo proprio noi. Noi che per due milioni di anni abbiamo vissuto
nomadi e in piccoli gruppi parentali e che siamo diventati una specie stanziale che vive -per una
buona metà- in agglomerati urbani abitati da milioni d‟individui. Noi che demandiamo a una
percentuale sempre minore di persone d‟assicurarci della piena sovranità alimentare. Noi che
basiamo oggi questa sovranità su un modello agricolo che per industrializzare il processo utilizza
sempre meno specie a noi simbiotiche. Noi, che abbiamo fatto della “domus”, ossia della casa, il
centro di un‟idea di “proprietà” (comportamento insolito per una specie animale) che va oltre il
desiderio di “nido” dove riporre gli affetti e i desideri. Noi che abbiamo seguito e/o subìto un
processo di domesticazione che non ha uguali nel mondo animale, che ci ha portato a dipendere
80
totalmente da un gruppo assai limitato di piante e animali di cui siamo sicuramente dominus e
inconsciamente schiavi.
Potremmo tracciare una mappa dei centri di origine della domesticazione (i centri Vavilov, dal
nome del botanico russo che negli anni venti del secolo scorso rilevò per primo la loro esistenza,
postulando che lì dove più ampia è la varietà catalogabile di predecessori selvatici, lì c‟è il centro di
origine della specie) e i conseguenti percorsi di diffusione lungo i millenni della preistoria, ma da
quando la teoria policentrica ha preso il sopravvento sulle prime ipotesi che davano l‟agricoltura
nata nella Mezzaluna fertile, abbiamo assistito a così tanti aggiornamenti sulla datazione e sui
luoghi di ritrovamento dei primi reperti, che si corre il rischio di perderne il senso per un florilegio
di studi che a volte sembrano rispondere a nazionalismi e localismi da cui preferisco tenermi
lontano.
Dopo aver specificato che alcune piante e animali hanno avuto un‟origine policentrica, si può
comunque dire che i principali centri di domesticazione sono da collocarsi in diversi ambienti
naturali e climatici dei vari continenti: nelle grandi pianure degli Stati Uniti orientali, dove circa nel
3000 anni a.C. si domesticarono il girasole, il chenopodio e il tacchino; nella Mesoamerica, dove
dal 8000 a.C. assistiamo alla domesticazione del mais, dei fagioli e delle zucche, del tabacco e del
cacao; nelle Ande centrosettentrionali (8000 a.C.) area di domesticazione dell‟arachide, pomodoro,
patata, manioca, lama e cavia e della coca; nell‟Africa Sub-sahariana e nell‟Etiopia (7000 a.C.)
luogo di domesticazione del caffè, sorgo, del riso africano e del miglio; nella Mezzaluna fertile,
dove circa 9.000 a.C. iniziarono i percorsi di domesticazione del grano, orzo, ceci, lenticchie,
pecore, capre, lino e poi dell‟olivo e della palma da datteri; dell‟Asia centrale da cui vengono la
carota, la cipolla, i piselli, il mandorlo e la vite; nei bacini dello Yangtze e del Fiume Giallo, dove
circa 9.0000 a.C. troviamo le prime testimonianze della domesticazione di molte piante da frutto
come gli agrumi, l‟albicocco, il pesco, il melo, e poi del riso, miglio, maiale, il baco da seta, la soia
e il papavero da oppio; negli altipiani della Nuova Guinea (circa 8000 a.C.) da dove abbiamo
testimonianze del cocco, taro, igname, canna da zucchero e più tardi della patata dolce. Ci sono
anche studi che attestano di un centro di origine mai chiaramente delineato in Amazzonia, mentre si
considera solo un sotto centro quello nella valle dell‟Indo, da dove pure derivano i bovini, la
melanzana, il cotone e la canapa. Ma il discorso si potrebbe estendere al sud est asiatico da dove
dovrebbero originare i polli e il bufalo o al Tibet dove si sono domesticati gli yak. Un centro minore
di domesticazione è stata l‟Europa, tardo luogo di origine di alcuni cereali adattati a climi rigidi
come l‟avena e la segale (per altri autori già domesticati in Asia Centrale), mentre l‟Australia, con il
suo clima desertico e i suoi particolari endemismi, appare come l‟unico continente dove la
popolazione è stata refrattaria ad iniziare i processi di co-domesticazione. Sembra incredibile da
dire e da pensare ma fino alla scoperta del grande continente australe (due secoli e mezzo fa) gli
uomini che lo abitavano da 50.000 anni avevano continuato a vivere con modelli produttivi e
culturali simili a quelli del mesolitico. Una società senza stato, senza legge, senza Dio e senza re,
commentarono stupefatti i primi viaggiatori europei. Eppure quale perdita sapienziale immane è
stata la scomparsa o l‟ottundimento di quella cultura ad opera dell‟invasione inglese, quale tragedia
per un‟umanità se questa fosse cosciente del valore della diversità comportamentale e culturale.
Pensiamo ai livelli spettacolari della pittura e della musica, ai particolari modelli di caccia e raccolta
(il boomerang) o al canto usato come strumento di trasmissione della storia e del sapere. Vengono
81
in mente le parole di Vico: “Il più sublime lavoro della poesia è dare alle cose insensate senso e
passione, ed è proprietà dei fanciulli di prender cose inanimate tra mani e, trastullandosi, favellarvi
come se fossero quelle persone vive. Questa dignità filologica e filosofica ne approva che gli
uomini del mondo fanciullo, per Natura, furono sublimi poeti”. (Principi di scienza nuova).
Non sono un nostalgico e neppure un amante del trascendentale, né sono solito farmi prendere dalle
mode alternative, ma penso che aver marginalizzato o azzerato gli apporti che potevano venire da
culture tanto diverse (penso a quelle di tanti popoli ormai scomparsi) e averli sostituiti con
l‟andamento giornaliero dell‟indice borsistico sia un profondo disvalore delle nostre società di cui .
prima o poi, pagheremo il conto.
Eppure, questa nostra società che dà al denaro più valore che alla poesia, nasce solo 10.000 anni fa
(secolo più o secolo meno) quando i nostri alleati stipularono le quattro alleanze simbiotiche che
tuttora fungono da architrave dei nostri aggregati sociali: tre sono con le graminacee: il grano, il riso
e il mais; la quarta con una solanacea, la patata, di cui parleremo in seguito. Sono però diversi i
luoghi della domesticazione e le specificità botaniche di queste piante archetipe cui è opportuno
dedicare uno specifico capitolo.
82
Le Piante Nutrici
Siamo animali onnivori e come tali viviamo nutrendoci di molti tipi di alimenti; questa caratteristica
- insieme alla capacità di isolarci termicamente dall‟ambiente grazie agli abiti e alloggiamenti- ci ha
consentito di esplorare e colonizzare quasi tutti gli ambienti naturali presenti sulla Terra. Esistono
dei gruppi umani –come quelli che abitano nelle zone artiche- che devono basare la loro
alimentazione solo sulla carne e bilanciano la loro dieta assimilando i necessari apporti di vitamine
e minerali dal fegato, dalla pelle e dai grassi dai pesci e dagli animali uccisi. Anche gli uomini che
vivono nella taiga o nelle tundre contano sulla caccia, ma la base della loro alimentazione è
rappresentata dal latte e la carne delle loro mandrie di renne (così come fanno i tibetani allevatori di
yak). Questi popoli riescono però ad integrare la loro base alimentare con la raccolta dei vegetali
selvatici che consumano freschi o conservati. Ma non c‟è solo il freddo a funzionare da fattore
limitante: i popoli che abitano le foreste tropicali, per le difficoltà legate alla caccia, scontano una
tendenziale carenza proteica, un poco come quello che accade agli abitanti dell‟outback australiano.
Non stiamo parlando dei comportamenti alimentari d‟interdizione, prescritti da alcune religioni, o di
quelli di rifiuto che sono scelti da molte persone nella nostra società dell‟iperconsumo. Stiamo
parlando di popolazioni che vivono nei posti più impervi e difficili del nostro pianeta, dove il cibo è
intrinsecamente difficile da reperire e dove per sopravvivere bisogna essere totalmente e
completamente inseriti all‟interno del corrispettivo contesto naturale e/o possedere una perfetta
conoscenza dei prodotti commestibili che quegli ambienti offrono.
Ci sono poi i popoli che vivono nelle zone desertiche, dove i limiti di piovosità impediscono la
coltivazione, e dove la sopravvivenza dei gruppi umani e mediata dagli animali allevati che -come
gli uomini- possono ricavare l‟indispensabile acqua per l‟abbeveraggio dalle sorgenti naturali o da
pozzi profondi e possono trovare della pastura dai radi pascoli presenti in questi territori. Il
nomadismo di questi allevatori è molto diverso da quello delle popolazioni che abbiamo descritto
prima; i primi sono popoli che basano la propria alimentazione sull‟autosufficienza, questi ultimi
invece spesso commerciano carne e pelli dei loro animali con i cereali e il sale prodotti nelle aree
limitrofe. Se allevo, lavoro per ottenere proteine (un prodotto secondario ottenuto dai vegetali) se
coltivo, lavoro essenzialmente per avere energia. Per questa ragione coltivare la terra significa fare
in modo che le piante possano avere le migliori condizioni possibili per catturare la luce del sole.
Sono le onde elettromagnetiche prodotte dal sole che irradiando la Terra permettono alle piante di
trasformare la luce in depositi di amidi e di grassi vegetali; una forma di energia conservata sotto
forma organica e per questo utilizzabile dagli animali. Questa è la logica primaria del nostro
coltivare: consentire alla luce di diventare vita, tanto che dove non c‟è luce non c‟è agricoltura.
Quest‟assunto è alla base delle mille e mille forme con cui gli uomini hanno reso grazie al sole.
Diverse specie vegetali hanno così raffinato le loro tecniche per catturare ed immagazzinare la luce
che si sono trasformate in veri e propri depositi energetici. Alcune di queste come l‟albero del pane,
il taro, la manioca e la tapioca o il platano verde o il banano, sono importanti per gli uomini che
vivono nelle aree tropicali della Terra, così come lo sono il sorgo e il miglio per tutti quei popoli
83
che vivono nelle aree dei predeserti caldi, ma quattro sono quelle che hanno avuto un peso e
un‟influenza determinante per lo sviluppo delle società umane: il grano, il riso, il mais e la patata.
Queste sono piante che hanno oltrepassato i vincoli ambientali e fisiologici che le caratterizzavano
nei loro territori d‟origine e, nel traslatarsi e colonizzare in modo prepotente molti altri ambiente
naturali della Terra (sono coltivate in tutti e cinque i continenti), sono arrivate ad acquisire una
funzione ecumenica che ci suggerisce di assegnare loro il titolo di “piante nutrici”, in quanto base
nutritiva di molti di quei popoli che hanno dato vita alle grandi civiltà umane.
Cominciamo a parlarne partendo dalla prima di esse: il grano. (Non credo che l‟ordine di questa
lista sarebbe stato lo stesso se io fossi nato in Asia orientale, Perù o Messico).
Risalire nel tempo e nello spazio la linea filogenetica di quello che noi semplificando chiamiamo
“grano” (tra questi per comodità mettiamo anche l‟orzo) è come vagare nel labirinto del palazzo di
Cnosso, tanto questo cereale è rappresentato da cultivar e specie diverse. Lascio che siano più
attenti e specializzati studiosi a percorrere i meandri della sua complessa evoluzione, perché questo
ci distoglierebbe dal nostro raccontare, e mi concentro su alcuni degli aspetti più significativi per
questo scritto. Il grano è una pianta capace di mutazioni sorprendenti: i suoi progenitori si trovano
ancora in forme selvatiche sulle pendici collinose e montane della Mezzaluna Fertile; piante che i
nostri antenati avevano iniziato a mietere grazie a file di micro lamine taglienti montate su legni
ricurvi o su mandibole di animali. Una piccola alterazione della saldatura tra il chicco e la rachide
dette vita all‟einkorn, un tipo di grano che si rivelò straordinario nelle mani dei nostri antenati, dato
che al momento della raccolta i suoi chicchi non cadevano dalla spiga ma rimanevano attaccati
proprio a quella rachide modificata. Era una mutazione potenzialmente nefasta per la sopravvivenza
della specie, che riuscì a sopravvivere anche grazie alle attenzioni prestate dai nostri progenitori che
per la prima volta potevano mietere senza preoccuparsi della dispersione delle sementi. L‟einkorn
ha una spiga piccola, con due sole file di spighette collocate ai lati della rachide, ogni spighetta
porta un solo seme di alto valore nutritivo: meno di duecento chilogrammi di granaglie coprono il
fabbisogno energetico annuo di un uomo adulto e, con i falcetti di nuova concezione (il senso del
nuovo è comune a ogni epoca), tutti i membri del clan potevano raccoglierlo senza difficoltà. Il
grano (nelle sue svariate forme: farro piccolo, medio, grande, grano duro e grano tenero) ha però un
grave difetto, asporta molte sostanze nutritive dal terreno e questo rende impossibile per le piante
continuare a dare buone produzioni dopo appena un biennio. Il bisogno di equilibrio della Natura
trovò la soluzione a questo limite biologico con una semplice forma di associazione: la
consociazione tra le due famiglie complementari delle graminacee e delle leguminose; in pratica
una bio-alleanza! Questa è la ragione del perché, in tutta la Mezzaluna Fertile, sono
abbondantemente presenti anche le specie ancestrali di ceci, lenticchie, fave e molte altre varietà di
leguminose erbacee. L‟azione biologica esercitata dalle leguminose è di integrare la fertilità dei
terreni che altrimenti sarebbe diminuita dalla presenza di specie solo “consumatrici”. Questa
famiglia botanica è, infatti, in grado di trasferire l‟azoto atmosferico nelle profondità del terreno
grazie all‟attività di particolari colonie di batteri che vivono sulla superficie dei suoi apparati
radicali, vere e proprie popolazioni saprofite che in virtù di questa funzione sono chiamate: azoto
fissatori. Quest‟attività, la cui funzione è rendere organico l‟inerte azoto atmosferico, è essenziale
alle graminacee che in assenza di quest‟apporto azotato non potrebbero far crescere e maturare
84
spighe numerose e piene. I nostri antenati non dovettero fare altro che inserirsi in questo contesto
ecologico e indirizzare la loro presenza verso dei reciproci vantaggi.
Una volta stretti i primi legami e messe le nostre braccia, la nostra intelligenza, l‟abilità manuale e
le nostre prospettive di specie a servizio di questa strategia, la nascita di una serie di vere e proprie
biocenosi è diventata più semplice, proprio perché questo progetto cooptava molte altre specie
interessate. Mutazioni di pecore e capre selvatiche, le cui più prolungate lattazioni erano spesso
correlate con una maggior mansuetudine e –a volte- con l‟assenza di corna, si sono avvicinate a
pascolare i campi naturali che gli uomini, curavano per mietere. Siccome il pascolo invernale è
un‟altra pratica agricola utile a tenere sotto controllo le specie vegetali antagoniste e che in più
concima i campi, queste specie non hanno avuto problemi a trovare una nuova forma cointeressata
di associazione. Il cane – a questo punto – da elemento di esclusione si è adattato a divenire uno
strumento utile all‟inclusione di questi nuovi animali “domestici”, proteggendo loro e i loro cuccioli
da predatori esterni. Anche altri animali si sono potuti pian piano inserire all‟interno di un sistema
così articolato: suini meno aggressivi di quelli selvatici, alcuni volatili -che essendo onnivori- erano
capaci di fruire degli scarti alimentari prodotti da agglomerati umani sempre più grandi e non
utilizzabili dai carnivori. Poi altre specie vegetali; alcune utili a produrre le fibre tessili (per esempio
il lino) che cresceva spontaneo nei campi di cereali; poi piante che possedevano radici e tuberi
commestibili, o verdure a foglie larghe o semi di altre famiglie botaniche; poi le api che hanno
iniziato a gradire le attenzioni degli uomini, fino ad arrivare- una volta che la stabilizzazione aveva
messo vere e proprie “radici” – a quegli alberi che oggi noi conosciamo come “da frutto”, lontani
parenti delle forme selvatiche di albicocchi, ciliegi, olivi, fichi o viti. Le società che si sono
sviluppate nella zona della Mezzaluna fertile hanno goduto poi – insieme alla birra e all‟idromele –
del vino prodotto da quest‟ultimo frutto per i bisogni psicotropi che – a quanto pare – sono uno
degli elementi comportamentali tipici delle società umane.
Non è questo il posto dove fare un elenco delle specie e di come si sono collegate tra loro
all‟interno del complesso bioma mediorientale (sarebbe ragione di un altro scritto), ma solo ribadire
il concetto: in quei secoli di transizione i nostri antenati hanno assunto una nuova funzione che ha
cambiato la loro contestualizzazione naturale e questo è stato reso possibile dall‟interazione di una
complessa polifonia di voci su cui spiccava l‟uomo per la sua “funzione” particolare. L‟unica
immagine che mi viene in mente per descrivere questa situazione è quella del nostro sistema solare (
scusate questa caduta eliocentrica), con il sole e tutti i pianeti che a lui sono collegati; un insieme
dinamico dove ogni presenza è dotata di un suo moto proprio, dove però tutti sono obbligati a
rapportarsi costantemente tra loro, mentre – in contemporanea - sono tenuti a rispettare gli equilibri
che li connettono allo sterminato universo della vita terrestre (sul delicato rapporto tra l‟interno e
l‟esterno di ogni biocenosi, ossia tra il mondo coltivato e quello naturale – che è il vero grande tema
della nostra epoca – conto di parlare nell‟ultimo capitolo).
Ecco allora il grano ritornare protagonista: da una specie selvatica affine al piccolo farro ( secondo
alcuni studiosi dal farro medio) ecco apparire l‟antesignano del grano duro. Questa nuova specie –
85
secondo alcuni studiosi - è il frutto di un incrocio naturale tra un altro grano selvatico (si pensa il
Triticum Urartu, un piccolo grano diploide rustico ma di scarsa produttività) e un‟altra graminacea
del genere Aegilops, dotata di piccole spighe che però nascevano numerose da un grosso cespo. Il
risultato di quest‟incrocio sarà sorprendente! Un nuovo tipo di grano – che la cura degli uomini ha
poi reso sempre più domestico- con un numero molto più alto di spighette portate su più file, con
lunghe reste ma semi liberi dalle glume e con cariossidi vetrose, capace di arrivare a produrre
alcune volte la sementa necessaria per riseminarlo.
Come hanno potuto due specie così semplici dare questo risultato sorprendente? I genetisti
direbbero: grazie all‟incrocio! La risposta è corretta, ma non risponde al vero senso della domanda.
Il problema non è come sia apparso il grano duro (e suo cugino; il farro grande), ma come abbia
potuto affermarsi in un contesto così competitivo e difficile un tipo di grano con quelle capacità
produttive? La vera risposta è: proprio grazie alla cura che gli uomini hanno prestato alla
conservazione di questo super seme (ossia una bio-alleanza). Un grano così produttivo è –
obbligatoriamente – anche una pianta intrinsecamente meno rustica e competitiva (quindi portatore
di un handicap naturale). Ma quel super grano -che non era capace di stare in mezzo agli altri- è
stato invece ottimo per noi. Sono i nostri antenati che l‟hanno accudito, protetto e incoraggiato, con
la stessa summa di attenzioni prestate anche alle altre specie animali e vegetali. Quelle spighe che
apparivano occasionalmente sono diventate le nostre spighe, quelle su cui i popoli mediorientali
hanno intrapreso un nuovo cammino.
Quei grani che poi, insieme all‟olivo e alla vite, una volta lasciate le pendici dei loro monti e portati
verso ovest dalle antiche migrazioni, hanno dato vita a quella che è conosciuta come la triade
mediterranea (anche se a queste aggiungerei: il fico, le capre e le pecore); quella particolare
interconnessione agronomica che ha caratterizzato, e caratterizza ancora oggi, l‟agricoltura dei paesi
che si affacciano sulle rive dell‟ importante mare di mezzo, vero e proprio utero raccoglitore di
mille forme di biodiversità agronomiche. Una triade che è stata alla base della grande cultura grecoromana che con forme disparate e spurie è arrivata a lambire la nostra epoca.
Il grano duro, come tutte le specie viventi, ha degli stringenti limiti biologici; la scarsa resistenza al
freddo e, più ancora, la facilità di subire attacchi fungini alla presenza di primavere ed estati umide
e piovose. Ecco perché il suo areale di diffusione è limitato solo alle regioni costiere e a poche aree
interne dei paesi di clima mediterraneo. Ma il cammino del grano non aveva ancora finito di
sorprenderci: dal grano duro, sempre attraverso l‟incrocio con un'altra specie ( probabilmente
l‟Aegilops tauschii) nacque molto più tardi il grano tenero; quello senza reste, quello con i chicchi
pieni di glutine con cui si fa la farina per il pane bianco, caratterizzato da ancora maggiore
produttività e da un ben più alta capacità di adattamento ai climi umidi; quello con cui i romani
colonizzarono la Gallia e le regioni non mediterranee del loro grande impero (le caratteristiche di
questo frumento e la sua influenza le vedremo però quando parleremo dell‟agricoltura romana).
Questi discorsi fatti per il grano valgono, come modello, anche per le altre piante nutrici che ci
apprestiamo a descrivere.
86
Dalle terre toccate dai monsoni, dalle umide pendici dell‟Himalaya, dai delta alluvionali dei grandi
fiumi che scendono dal Tibet e dal Pamir viene un‟altra pianta nutrice: il riso (Oryza sativa)! Che
dal suo areale d‟origine del sud est asiatico trasmigrò poi verso la Persia e la Mesopotamia e
l‟Egitto, da dove gli arabi lo portarono in Europa e gli europei nelle Americhe e in Oceania. Una
pianta che per un lungo periodo del suo pur breve ciclo riproduttivo vive nell‟acqua, per poi
maturare ed essere mietuta su campi asciutti; perfetto adattamento biologico ai cicli monsonici che
caratterizzano le calde stagioni nel Sud Est Asiatico. Il riso: una pianta sorprendente, capace in
alcuni luoghi di dare anche tre raccolti l‟anno e con una quantità totale di sementa prodotta in
rapporto a quella necessaria per la risemina che non aveva uguali tra le graminacee del vecchio
mondo. Alimento base (anche grazie alle sue caratteristiche organolettiche) di circa la metà della
popolazione mondiale. Ed è facile capire le ragioni di questa sua straordinaria “produttività”! Il riso
non “stanca” la terra per la semplice ragione che dalla terra prende ben poco, traendo le sostanze di
cui ha bisogno dalle ricche acque dei fiumi, delle rogge e dei torrenti, che a loro volta li sottraggono
ai terreni a monte.
Coltivare il riso vuol dire gestire i cicli delle acque piovane e/o regolarne i flussi; facendo in modo
che quelle acque facciano quello che le piante chiedono per ben produrre e non solo riprodurre:
concimare. Per il resto le pratiche agronomiche che sono alla base della coltivazione sono le stesse:
favorirne la nascita (per questo da tempi immemori si fanno i semenzai, per poi trapiantare le
giovani piantine) e diminuire il più possibile la concorrenza (per questo si mondano i campi).
Grazie alle sue caratteristiche il riso non ha bisogno di consociazioni di sostegno con le leguminose,
anche se esiste una leguminosa tipica delle biocenosi orientali: la soia, che era coltivata per
arricchire i campi non adattati a risaia. Le bio-alleanze non si fermano solo a questo: ci sono le
carpe allevate nei campi allagati, diversi tipi di anatidi (e in Indocina, polli e galline), i suini, molti
tipi di ortaggi che crescono ubertosi su quelle terre ricche e umide. Poi molti frutti come pesche,
agrumi (anch‟essi portati dagli arabi in Sicilia), gelsi e tutte le pomacee. Una importante coltura
psicotropa è la canapa (contrariamente a quanto si crede il papavero è originario del Medioriente);
canapa che insieme al cotone è anche una pianta da fibra tipica di quella parte di continente. Anche
se il tessuto più straordinario, quello che da sempre ha affascinato la fantasia degli uomini e delle
donne, non viene da una pianta ma deriva dal sottilissimo filo prodotto dal bruco di una farfalla: la
seta.
Si, non c‟è stata nell‟antichità del vecchio mondo pianta più produttiva del riso, la base alimentare
delle grandi culture fluviali della Cina meridionale (la pianta nutrice tipica della Cina del nord è
stata il miglio), del‟India e dei vari regni del Sud Est asiatico, ma neppure c‟è stata pianta che ha
richiesto agli uomini così tanta attenzioni: perché per produrre riso ci vuole l‟acqua, e l‟acqua
rimane sui campi solo se questi sono livellati, quindi, perfettamente piani. Questo ha comportato
che moltitudini di uomini, donne e bambini -generazione dopo generazione- hanno passato il loro
tempo a spostare terra, ad alzare argini e scavare canali, spesso con il fango fino ai polpacci, per
prendersi cura di una pianta che li sfamava mentre li rendeva schiavi.
Forse è per questo che i popoli orientali hanno stretto un‟alleanza con i bufali, un po‟ come i primi
agricoltori del medioriente hanno fatto con il genere Bos ( vacche e tori). Hanno cercato in questi
87
animali potenti un aiuto per il duro lavoro sui campi. Mi sono sempre chiesto come e perché i nostri
antenati abbiano stretto un‟alleanza con questi animali. L‟unica risposta che riesco a darmi è
proprio questa: non per il latte, né per la carne (che sono prodotti derivati), ma per cercare un aiuto
per il lavoro. In oriente si portavano (e si portano ancora) i bufali a calpestare le risaie prima del
trapianto del riso, e –forse- qualcosa del genere si faceva anche nella Mezzaluna Fertile per
preparare il terreno alla semina al posto della zappa e ben prima che fosse inventato l‟aratro.
Un‟alleanza che ha dell‟incredibile, qualcosa che va oltre ben oltre quella pure difficile con ex lupi
o ex cinghiali, perché un bufalo o un toro sono animali ben più temibili e difficili da gestire. Non
tanto per le femmine che generalmente sono più mansuete (tranne quando sono puerpere), ma per i
maschi adulti, la cui ombrosità e irrequietezza rappresenta sempre un grave problema, tanto da
portare gli uomini ad adottare la pratica della castratura per ottenere una forma di sottomissione
coatta. Credo sia per la difficoltà e particolarità intrinseca di quest‟alleanza che gli uomini hanno
mitizzato il ruolo di questi animali che sono stati sacri in tutte le culture del vecchio mondo. Cosa
che invece non è mai avvenuta per i cavalli e i cammelli domesticati alcuni millenni più tardi. Non
sorprende quindi se nel sub continente indiano – territorio d‟origine dei paleo-bovini- la vacca sia
un animale sacro per la religione induista.
Graminacea di straordinario vigore e versatilità il mais ( Zea mais) divenne la pianta nutrice degli
uomini della Mesoamerica più o meno in contemporanea con quelle del vecchio mondo. Il suo
precursore è probabilmente una specie originaria degli asciutti altopiani messicani conosciuta come
teosinte. Graminacea senza cespo (dal suo seme nasce un unico culmo), di rapida crescita e di
straordinario vigore, la pianta sostiene diverse spighe (pannocchie) cariche di più file di semi. La
sua adattabilità e rusticità sono straordinarie e, dove le condizioni pedoclimatiche lo consentono, lo
è anche la sua produttività, visto che è capace di rendere cento e più volte la sementa (oggi –come
vedremo più avanti parlando di agricoltura industriale – molto di più). Queste performance sono
dovute al fatto che il mais è l‟unica pianta C4 dello stretto novero delle piante nutrici.
Si definiscono piante C4 alcune specie vegetali che sono caratterizzate da un particolare processo
biologico per la fissazione dell‟anidride carbonica diverso dal ciclo C3 o ciclo di Krebs. Le piante
C4 sono capaci - sia anatomicamente che biochimicamente - di ridurre la perdita di acqua che
avviene durante la fotosintesi, una caratteristica che rende alcune specie coltivabili anche in
ambienti asciutti ( il sorgo e alcuni cultivar di mais). Mentre altre dimostrano una sorprendente
capacità di adattarsi ai climi caldi e umidi ( la canna comune e quella da zucchero ). Conosciute per
la particolare efficienza fotosintetica e per la loro spiccata velocità di accrescimento, queste piante,
in particolari condizioni, possono dare così eclatanti performance produttive da essere oggi alla base
dei modelli di coltivazione industriale per produrre zuccheri, amidi e etanolo.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Piante c4
Il mais è una pianta che richiede molte sostanze nutritive, ha, però ha la caratteristica che cresce
senza “stancare” la terra e può essere riseminata nello stesso luogo anno dopo anno. Questo è
probabilmente dovuto al suo corto ciclo biologico (quattro - cinque mesi a differenza del grano che
arriva a maturazione in circa otto mesi) che lascia alla terra il tempo di rigenerarsi grazie all‟azione
di altre colture da “rinnovo” (sono piante da rinnovo quelle specie vegetali a ciclo corto come le
88
verdure o le piante da fibre). Questa è anche una delle ragioni del perché quando il mais si espanse
nelle fertili valli vulcaniche (come la laguna di Teotihuacan) dette vita a una biocenosi basata
essenzialmente sull‟orticoltura (melanzane, pomidoro, peperoni, il cuore di quelle che oggi vengono
considerate dei veri cultivar mediterranei), con alla base la triplice alleanza tra il mais, il fagiolo
(una leguminosa) e la zucca e l‟integrazione con diversi alberi da frutta (guava, avocado, papaya). A
questa si aggiunse come fibra tessile il cotone (domesticato in contemporanea di quello del subcontinente indiano) e con il tabacco come pianta psicotropa (anche se le vere funzioni trascendentali
furono demandate alla raccolta e all‟uso dei funghi). Stranamente questa biocenosi conta su
pochissime alleanze con degli animali; tra questi il cane (che era allevato anche per essere
mangiato) il tacchino (che fu introdotto precocemente dal nord America) e le quaglie. Mancò quindi
a questo modello produttivo la forza lavoro animale, il latte e i suoi derivati, e quasi tutto il
consumo di carne continuò a dipendere dalla caccia. C‟era però un ampio consumo d‟insetti e la
raccolta del miele fatta da api senza pungiglione. Su questa biocenosi si basarono tutte le culture del
centro America come quelle Olmeche, Tolteche, per arrivare agli Atzechi e ai Maya. Per uno strano
scherzo del destino il mais dopo essere arrivato in Europa tornò nei paesi del nord America dando
vita a nuove bio-alleanze (essenzialmente con la soia, e insieme a questa con bovini e maiali), che
sono il fulcro dell‟attuale modello di agricoltura industriale nord americano (parleremo di questo in
seguito).
Completamente diversa dalle altre piante nutrici è invece la patata (Solanum tuberosum), base
alimentare delle popolazioni andine del sud America. Diversa non solo perché è l‟unica di questo
gruppo a non appartenere alla famiglia delle graminacee, ma anche perché immagazzina la riserva
di carboidrati nei suoi tuberi sotterranei e non nei semi. Diversa perché viene da un territorio di alta
montagna dove fare agricoltura è ancora oggi particolarmente difficile. Eppure questa piccola pianta
dal comportamento quasi sarmentoso in millenni di adattamenti è diventata capace di sintetizzare
una quantità incredibile di amidi (oggi si arriva a fare produzioni di 1000 q. li di patate ad ettaro),
mantenendo la caratteristica che per riprodursi non ha bisogno dell‟intero tubero ma solo di uno dei
suoi vari occhi germinali. Queste performance produttive ovviamente stancano molto il terreno che
può essere rimesso in produzione solo dopo un ciclo di riposo o di rinnovo. Questa precondizione
ha favorito la nascita di associazioni con altre specie vegetali come i fagioli comuni, quelli di Lima
o le arachidi (tutte appartenenti alla famiglia delle leguminose), poi zucche, quinoa e altre specie
vegetali. Nella originale biocenosi sud americana – per evidenti ragioni climatiche - mancano alberi
da frutta, mentre sono associati molti animali come i porcellini d‟india, i lama e gli alpaca ( i
guanachi e la vigogna sono stati pure integrati senza essere mai stati realmente domesticati). Da
questi camelidi domestici gli uomini andini traevano carne, latte, lavoro, pelli per il cuoio e lana
con cui si tessono i loro caldi indumenti. Le funzioni psicotrope sono state invece essenzialmente
demandate alle foglie di coca, considerate sacre da molte popolazioni locali. Questa biocenosi
costituì il regime alimentare di questi popoli di montagna e anche del grande impero fondato dagli
Incas. Con l‟arrivo degli spagnoli la patata passò nell‟Europa mediterranea dove si espanse molto
lentamente, non trovando molti territori adatti alla sua coltura. Qui divento un cultivar invernale e
finì per essere coltivata essenzialmente nelle regioni montane (pirenei, appennini, alpi e zone
balcaniche) dando un importante contributo alimentare a popoli che prima contavano sulla
produttività del bosco (ghiande e castagne) e sul grano saraceno. Invece si adattò perfettamente
89
come coltura primaverile estiva dei terreni umidi e tendenzialmente acidi del nord Europa, dove
andò a sostituire o integrare (con ben altri risultati) le colture invernali dell‟avena e della segale e
dello stesso grano saraceno. Qui -grazie alla sua produttività e alla sua facile conservabilitàdivenne in pochi secoli la vera base alimentare dei popoli germanici, scandinavi, slavi e anglo
sassoni, decuplicando all‟infinito le chilocalorie ottenibili dalla coltivazione di quei terreni. In
Irlanda arrivò ad assumere un ruolo paragonabile a una monocoltura dominante, con le tragiche
conseguenze di cui abbiamo già parlato precedentemente, quando una malattia fungina attaccò –
distruggendo – i campi.
Quello appena descritto non è che un rapido resoconto dell‟epoca delle domesticazioni e del loro
progressivo strutturarsi in organizzazioni complesse. In realtà le piante e gli animali domesticati
sono molti di più di quelli descritti e si stimano nell‟ordine di diverse centinaia di specie, decine e
decine per ogni ambiente naturale coinvolto. Di questo incredibile fenomeno abbiamo oggi un‟idea
solo parziale, in primo luogo perché da tempo abbiamo progressivamente ridotto la variabilità del
nostro regime alimentare, ma anche perché mai le nostre società – parlo di quelle dei paesi ricchi –
sono state così lontane dai problemi dell‟approvvigionamento del cibo. C‟è certo una cosa che non
può fare a meno di sorprenderci: in tutto il mondo la domesticazione si è svolta in un periodo
circoscritto di poche migliaia d‟anni e i tentativi fatti in seguito non sono mai più andati a buon fine.
Secondo alcuni autori questo è dovuto al fatto che in quel periodo furono domesticati tutti gli
animali potenzialmente domesticabili (per le piante il discorso è più complesso) e che la ferinità di
quelli rimanenti ha impedito nuove alleanze. Con onestà non credo che questo discorso sia vero.
Non penso che è agli altri che si debba guardare, ma a noi stessi! A quanto è diverso il nostro modo
di stare e di guardare la vita sulla Terra dopo che siamo diventati agricoltori, alla perdita di quello
“stupor mundi” che c‟era negli occhi dei nostri antenati (in quelli che dipingevano le caverne di
Lascaux), sostituito da quel “terror mundi” in cui ci siamo trasformati in questi ultimi secoli. E se in
un ipotetico futuro, delle nuove necessità o delle diverse opportunità ci conducessero a nuovi
bisogni, chissà se avremo ancora la possibilità di scrivere nuove e diverse alleanze? Lasciamo per
ora che questa sia solo una domanda retorica.
Intanto la coltivazione e l‟allevamento –nate in piccole e occasionali enclaves- andarono pian piano
espandendosi in altri e vari ambienti naturali, sia per contiguità territoriale, sia per trasmissione
delle conoscenze acquisite, così da diventare cultura condivisa tra le varie genti che popolavano la
Terra. Cultura che appropriatamente viene dalla stessa radice linguistica della parola coltivazione,
perché mai prima d‟allora i nostri antenati avevano affrontato un problematica così complessa come
quella di maneggiare i delicati equilibri delle tante biocenosi agricole sparse per il mondo:
Apprendendo i tempi biologici delle semine, quelli della crescita e della fruttificazione, imparando
a leggere il tempo che scorre e contemporaneamente a prevedere il tempo meteorologico che sta per
venire, sapendo gestire gli umori degli animali custoditi, e compiacendoli per farli produrre e
riprodurre. Mantenendoli sani e risanandoli quando malati. Un processo di accumulo di saperi e di
conoscenze che ha richiesto ai nostri antenati millenni di attente osservazioni, premurose cure e
benevole condivisioni.
90
Con questo senso corale di compartecipazione ( che comunque la si voglia vedere ha prevalso su gli
egoismi e le divisioni) gli uomini hanno gettato le basi di quelle culture agricole le cui
testimonianze affronteremo nel prossimo capitolo.
91
La nascita delle Civiltà
Dopo l’inizio della storia, quante storie da raccontare
92
La Terra coltivata
Prima di passare a quel particolare periodo dell‟evoluzione umana che è contrassegnato
dall‟acquisizione e dallo sviluppo delle tecniche di coltivazione e di allevamento (che nel giro di
alcune centinaia d‟anni produrranno un apparato culturale molto più complesso e sfaccettato di
quello che i nostri antenati avevano sviluppato fino ad allora e –cosa interessante- una apparato
tutto incentrato sullo studio delle relazioni e dei fenomeni della Natura), vorrei tornare a rimarcare
un punto decisivo: se immaginiamo l‟agricoltura come una particolare forma biocenosi, allora -per
assimilazione- dobbiamo considerarla come un microcosmo coeso inserito nel più vasto
macrocosmo naturale. Una biocenosi appena formata è quindi un nuovo microcosmo e corrisponde
a un ecosistema più o meno esteso sul territorio e partecipato da un numero più o meno ampio di
specie, caratterizzato da un flusso coesivo verso interno e da un costante scambio di input verso
l‟esterno. Di certo un ecosistema particolare, basato come è su di una serie di patti biologici che
vedono l‟uomo ricoprire la funzione di simbionte principale; patti incernierati dal lavoro e le cure
che gli uomini assicurano alle altre specie che lo hanno stipulato e sull‟impegno comune
all‟esclusione o al contenimento di quelle che sono esterne al patto stesso. Questo comportamento –
insolito ma non unico- ha come risvolto significativo quello di aumentare la produttività relativa
dell‟ambiente naturale (la produttività come surplus indotto) dentro del quale il sistema sta inserito
(questo a vantaggio principalmente del simbionte principale) e quella riproduttiva di tutte le specie
coinvolte. Sono questi vantaggi la base dei legami biologici che durano ormai da 10.000 anni; il
venir meno di quei vantaggi inficerebbe il senso stesso dell‟unione. L‟idea dell‟agricoltura come
una particolare forma di biocenosi (più avanti torneremo sul concetto di dinamica) consente di
mantenere le gesta dei nostri antenati all‟interno delle leggi che regolano la vita dell‟universo e
supera l‟immagine dell‟uomo che, con decisione autonoma e fuori dal quadro delle leggi naturali,
trasforma in beni alcune piante e alcuni animali a suo uso e piacimento. Fatta questa debita
premessa, passiamo ora a parlare dell‟argomento del paragrafo.
Assicurare le cure alle specie con cui avevamo stipulato il patto non è semplice; non stiamo
parlando di specie avvezze a difendere i loro spazi ecologici e la loro presenza biologica in una
costante battaglia per la sopravvivenza; stiamo parlando di specie apparse da mutazioni spesso
portatrici di un‟intrinseca fragilità, che -per consolidare la loro presenza nell‟ambiente che le
circondava- avevano bisogno di un soccorso mutualistico senza il quale sarebbero state espunte o
fortemente ridimensionate dal contesto naturale. Queste specie erano (e sono) particolarmente
esigenti nelle attenzioni che richiedono: alcune devono essere difese dalla predazione degli uccelli,
altre dai lupi; tutte tendono ad essere costituzionalmente più deboli di fronte ad attacchi fungini o
parassitari, e tutte – in generale- sono prodighe nell‟accumulare risorse o nel distribuirle solo se il
lavoro e le cure degli uomini le mettono nelle giuste condizioni per farlo: lavori e cure pesanti e
improbi! Non guardate la Terra come noi oggi la vediamo, tutta modificata da millenni di
adattamenti e di trasformazioni: spianata, frazionata, arata nel profondo, con gli argini dei fiumi
elevati e rafforzati e i canali d‟irrigazione scavati. La terra vergine è un‟altra cosa rispetto a quella
coltivata a cui noi siamo portati a fare mentalmente riferimento. La terra vergine, inoltre, è spesso
93
improduttiva e fare in modo che la terra diventi terreno è stato il procedimento colturale e culturale
più complesso che gli uomini abbiano mai acquisito e attuato: altro che imparare ad accendere il
fuoco e inventare la ruota! Per piantare grano, mais, patate o altre colture alimentari la terra va
prima dissodata e poi resa feconda. L‟opera è difficile ancora oggi, anche quando è fatta con potenti
macchine agricole e con concimazioni illimitate; immaginate farlo con i mezzi a disposizione dei
primi coltivatori! Non c‟erano aratri (chi avrebbe potuto tirarli?), ma non c‟erano neanche pale o
vanghe, perché la tecnologia litica che avrebbe consentito di produrne la forma non era però in
grado di dare a quella forma la giusta funzione; c‟erano solo bastoni di legno, zappe e asce fatte di
pietra o di osso. Con questi semplici strumenti bisognava tagliare gli alberi, estirpare gli arbusti,
divellere le radici (il lavoro più faticoso e difficile) e i ceppi (i più improbi): poi – una volta
eliminato il manto arboreo e vegetale – bisognava che il piccolo campo avesse una pendenza più o
meno costante o un piano di calpestio a livello (questo era essenziale per i popoli che avevano
iniziato a coltivare il riso); bisognava cioè fare un modo che l‟acqua non ristagnasse o che lo
inondasse senza via di fuga. Per fortuna i nostri antenati -viste le dimensioni ridotte dei campi
coltivati e la semplicità degli attrezzi agricoli usati- non c‟era bisogno di togliere le pietre più
grosse, perché si poteva seminare intorno ad esse. Questo faticosissimo lavoro diventerà però
indispensabile al momento dell‟introduzione dell‟aratro, che chiaramente non avrebbe potuto
avanzare in un campo con molte pietre emergenti; trovando poi il modo di utilizzarle le pietre
asportate per uno scopo utile allo spazio coltivato (alcuni muri frangivento sono vecchi di millenni).
L‟opera della messa in coltura della Terra è l‟opera più ciclopica, lunga e faticante mai realizzata
dall‟uomo: piramidi, rete viaria romana, grande muraglia, niente è neppure lontanamente
paragonabile al lavoro che milioni di donne e uomini per centinaia di generazioni hanno fatto per
fare in modo che la Terra acquisisse la sua veste coltivata (viene da chiedersi se noi uomini
contemporanei –che ne siamo eredi- siamo coscienti di tutto questo e se ce lo meritiamo) . Quando
tra le alleanze l‟uomo stipulò un patto con i buoi, gli yak o i bufali, e dopo che essi furono aggiogati
(forse intorno al 6000 a. C.), più tardi con i cavalli (circa il 3000 a. C) e poi con i cammelli, il
contributo che questi animali diedero al lavoro di dissodamento fu solo parziale, perché gli aratri di
legno non erano strumenti utili per divellere radici e pietre, ma solo per scalfire la terra già
dissodata. Così che questi animali furono utilizzati per le lavorazioni superficiali (arature leggere ed
erpicature) e per il trasporto (in quest‟ultimo caso furono così risolutivi che ancor oggi - a duecento
anni dalla nascita delle prime macchine motrici- siamo soliti valutare il loro lavoro o la loro potenza
in cavalli motore). Anche dove gli uomini si trovarono alla presenza di estese praterie il lavoro di
messa a coltura non fu meno improbo. E‟ vero, si poteva usare il fuoco! Ma molte graminacee da
prateria si erano adattate proprio a questo: bruciano nella loro parte aerea senza rovinare il cespo (e
con esso le radici), così da essere pronte a riprodurre immediatamente nuova vegetazione, come ben
sanno gli aborigeni australiani, che da migliaia d‟anni usano il fuoco proprio per mantenere sano il
manto vegetale. Ben venga l‟aiuto dei piccoli ruminanti come capre e pecore (altrimenti dove
sarebbe la reciprocità della biocenosi?) che con il loro incessante brucare fanno al manto vegetale
un danno ben maggiore che un intero gruppo di uomini e donne zappando, e in più mangiando,
concimano! Tutto questo per dire che, fino a quando non si sono trovati strumenti adeguati (aratri e
utensili in metallo) e forza lavoro accessoria (la castrazione dei giovenchi per farne dei buoi e la
scoperta del giogo per favorire il tiro), la terra coltivabile è rimasta una minima parte di quella che
94
“potenzialmente” si sarebbe potuta mettere a coltura. I nostri antenati dovettero quindi accontentarsi
di coltivare le radure nei boschi o i piccoli spazi aperti nelle sterpaie, aiutati in quest‟opera proprio
dal lavoro di ripulitura fatto dalle greggi. Non era ancora volontà degli uomini decidere dove e
come coltivare la Terra, perché la “coltivabilità” era un “dono” legato alle caratteristiche ambientali
e pedologiche dei vari territori, e a questa condizione gli uomini non potevano fare altro che
adattarsi. Così per cinquemila anni dall‟inizio della coltivazione non abbiamo nessuna
testimonianza di un ridisegno generale dell‟ambiente in funzione produttiva (cosa che condiziona
anche l‟aspetto abitativo), e –diversi millenni mancavano ancora- a che il paesaggio agrario
cominciasse ad essere disegnato.
Malgrado tutto questo la produzione di cibo aumentò considerevolmente; perché delle zone
potenzialmente coltivabili -circondate dai pascoli e inserite in più vaste aree di caccia e raccoltanon erano difficili da trovare in un pianeta abitato da pochi milioni di essere umani, e con l‟aumento
del cibo si poté assistere a un incremento significativo delle nascite (un potere generativo che darà
al corpo femminile, specie nei suoi organi riproduttivi, una funzione mitopoietica; base della sua
trasformazione immaginifica in Dea nutrice), solo in parte ridimensionato dall‟accorciamento della
vita media dovuto al peggioramento delle condizioni igieniche. Un fenomeno demografico ben
conosciuto, che sempre avviene quando le specie trovano una nuova fonte di approvvigionamento
alimentare. Così che i nostri progenitori cominciarono a crescere di numero e a espandersi, con un
crescendo lento ma significativo.
Immagine presa da Wikipedia alla voce: Esplosione demografica. Autore El T
Quando l‟uomo fece il passaggio da cacciatore nomade ad agricoltore la popolazione incominciò ad
aumentare. Questo fu dovuto in parte a un‟aumentata disponibilità di cibo e al fatto che, per la
95
prima volta nella storia, i tassi di natalità aumentarono in modo significativo. Infatti, le società
basate sulla caccia e raccolta tendono ad avere pochi figli; in una società di questo genere una
donna, nei continui spostamenti della sua comunità, riesce a trasportare un solo figlio: gli altri figli
devono quindi essere abbastanza grandi da seguire la tribù in modo autonomo. Per questa ragione
una donna poteva avere un figlio ogni tre o quattro anni, cosa che era ottenuta attraverso l'astinenza
sessuale, l'allattamento prolungato, l'aborto o l'infanticidio. Le società agricole, al contrario, restano
sempre nello stesso posto a sorvegliare i loro raccolti; quindi, la mobilità dei bambini non
rappresenta un problema, e invece essi possono contribuire alla produzione di cibo già in tenera età.
Per questa ragioni, il tasso di fertilità nelle società di agricoltori è molto maggiore, spesso con una
media di una nascita ogni due anni. Tutti questi fattori contribuirono a un innalzamento della
densità della popolazione nel momento del passaggio da vita nomade a vita sedentaria
Questo scritto è inserito nel sito web di un gruppo di studenti e insegnanti del Liceo Linguistico "Veronese" di Montebelluna (Treviso, Italia), che io
ho ripreso adattandolo leggermente.
Intanto la nostra specie cambiava e si diversificava nell‟essere, nello stare e nell‟apparire. Per circa
un paio di milioni d‟anni gli uomini si erano associati in gruppi famigliari composti di poche decine
d‟individui (così come fanno ancora oggi i gorilla o gli oranghi: specie a noi vicine in linea
filogenetica); poi con l‟introduzione di nuovi strumenti di caccia e di pesca, l‟alleanza con il cane e
la scoperta di nuove tecniche per raccolta e l‟immagazzinamento, i gruppi umani divennero più
grandi, tanto da formare dei veri e propri clan composti dall‟unione di alcuni gruppi famigliari, e si
moltiplicarono nel numero e nello spazio, iniziando a colonizzare i territori limitrofi; così come
fanno le colonie di batteri su di una piastra di Petri. Con il passaggio alla coltivazione e
all‟allevamento la struttura sociale s‟ingrandì ulteriormente, allentando i legami familiari e clanici e
dando vita a strutture sociali più complesse aggregate in veri e propri villaggi; una grande sfida per
le società umane che dovettero trovare nuovi strumenti per regolare la coesione interna ai gruppi,
presupposto essenziale di una convivenza il più possibile pacifica. Gli uomini portatori di questo
nuovo input culturale furono vincenti all‟interno dei meccanismi selettivi di specie, anche perché
sostenuti da tanti silenziosi alleati che stavano vincendo insieme a loro. Così i nuovi gruppi di
agricoltori e allevatori, moltiplicandosi, cominciarono a esportare le tecniche agricole al di fuori
degli ambienti naturali in cui erano nate, sostituendosi a quello che incontravano sul loro cammino e
legando per sempre gli umori e le fortune della nostra specie alla terra coltivata. Con una
sostanziale differenza semantica: non c‟è il tempo del neolitico – perche la pietra è solo una
sineddoche- c‟è il tempo di uomini con idee nuove che fanno cose nuove.
Acquisizione di comportamenti nuovi per una specie diventata stanziale; apprendere come vivere
tutti insieme in piccoli spazi definiti da mura e tetti, imparare a custodire le più ampie riserve di
cibo, trovare nuovi modi per distribuirlo anche a costo di allontanandosi dall‟economia del dono e
da quella comunitaria che erano state per migliaia d‟anni la base delle culture ancestrali. Una specie
che stava iniziando a sperimentare dei nuovi codici che consentissero la gestione della conflittualità
interna e nuove “regole” che favorissero la convivenza e la rappresentanza, perché la “rivoluzione”
produttiva era diventa una “rivoluzione sociale” e l‟uomo nuovo doveva trovare un nuovo
equilibrio interiore e esteriore. Questi cambiamenti sono ampliamente documentati; infatti
dall‟ottavo millennio a.C. le campagne di studi effettuate testimoniano una vasta presenza di ossa e
sementi di piante e di animali domesticati anche nei villaggi situati nei territori limitrofi ai primitivi
96
centri principali di domesticazione. Dall‟area della mezzaluna fertile -quella più vasta e complessa,
quella dove più numerose furono le specie cointeressate, e proprio per questo la meno coesa- la
biocenosi primitiva si suddivise irradiandosi in diverse direzioni (ma è anche possibile immaginare
che all‟interno della Mezzaluna fertile ci siano formati più modelli specifici). Quello che aveva
come base energetica il grano tenero e l‟orzo– risalì verso i Caucaso e da qui verso le pianure russe
e ucraine, per poi espandersi lentamente verso l‟Europa centrale, quella balcanica, e
successivamente verso quella nordica. Questa biocenosi si costruì intorno a quelle specie vegetali e
animali (o a quei cultivar) che possedevano un sufficiente grado di adattabilità alle condizioni di
clima continentale. Così nel corso della sua espansione verso i climi freddi e le latitudini più elevate
assistiamo alla progressiva affermazione di verdure a ciclo solo estivo, oppure con grosse radici o
tuberi invernali, mentre le pecore si coprirono di uno strato di grasso e di un folto vello, i bovini
aumentarono di taglia e si orientarono verso la produzione lattifera (alimento principe per assicurare
ai vitelli una facile fonte di cibo e un grande apporto di vitamina D durante i periodi invernali) e gli
alberi da frutto si adattarono ai lunghi cicli di riposo invernali e le corte e calde estati; nel lento
espandersi verso il nord e in ragione del bisogno crescente di alimenti energetici successivamente si
integrarono al suo interno le forme domesticate della segale e dell‟avena. Grossolanamente
possiamo dire che si andò costituendo una biocenosi che verteva sulla carne, ma ancora di più sul
latte e sul burro, alimenti essenziali per popolazioni dalla pelle sempre più bianca, i capelli sempre
più biondi e gli occhi sempre più azzurri.
Un altro troncone che si distaccò dalla Mezzaluna fertile fu quello dei grani duri, ma anche della
vite e dell‟olivo, delle pecore da latte e delle capre (animali di rustico aspetto e di piccoli bisogni,
perfette per dei territori dove nel corso delle lunghe estati non piove mai), delle mandorle e dei
fichi. Un‟alleanza che si espanse verso l‟attuale Turchia e da lì verso Creta, la Grecia e le sue isole e
le coste nord del Mediterraneo. Le terre dell‟olio e del vino, dei legumi a ciclo invernale e del latte e
formaggi di pecore e capre, delle vacche dalle grandi corna adatte a sopportate le stagioni secche,
poco propizie per la produzione del latte, ma ottime per i lavori nei campi.
Una branca della primitiva biocenosi mediorientale s‟indirizzò invece verso il nord-est e,
oltrepassando qualche migliaio di chilometri di terre poco adatte alla coltivazione (se si escludono
la depressione caspica, le valli e le oasi dell‟Iran), trovò un suo punto di elezione nelle terre
pianeggianti situate tra l‟Amu Darya e il Syr Darya; qui la sua spinta si fermò di fronte alle
imponenti muraglie dell‟Hindu Kush, del Pamir, del Karakorum e all‟inospitalità del deserto del
Gobi che segnarono una linea di confine tra questa biocenosi di origine mediorientale e quelle delle
pianure indo-gangetiche e cinesi. Ma la sua presenza, al centro della steppa euroasiatica (unita al
corollario di oasi lungo la sua scia) rappresentò uno ganglio pulsante che permise un costante
movimento circolatorio a uomini, piante e animali; una frontiera permeabile, come una vera
membrana osmotica che filtrò gli scambi biologici (alcuni li permise, altri li bloccò) lungo le
direttrici est, sud-est e ovest e viceversa. Da questa enclave passarono alcune specie verso la Cina e
quelle cinesi che divennero patrimonio delle biocenosi occidentali; da qui probabilmente
transitarono le specie provenienti dall‟India.
Nel resto dell‟ Asia centrale e in tutta quella settentrionale – a nord dell‟Amu Darya, a cavallo della
catena dell‟Altai, tra le grandi steppe siberiane, mongole e il deserto del Gobi -dove la piovosità e/o
97
il clima non consentivano vaste coltivazioni- si svilupparono invece delle biocenosi solo
faunistiche. Alcune di queste furono inizialmente basate sull‟allevamento delle pecore e delle capre
(domesticatesi nella Mezzaluna fertile) e in misura minore sui bovini (domesticatisi in India);
modelli pastorali poi integrati con l‟allevamento dei cavalli (presumibilmente domesticatisi nelle
steppe kazakhe tra 4-5.000 anni fa) e dei cammelli (di domesticamento quasi coevo). Una biocenosi
animale in costante correlazione con quelle agricole della Cina, dell‟Oxus e dell‟Iran del nord.
Dentro questi modelli pastorali vanno inseriti anche quelli dei popoli tibetani che allevavano yak e
quelli dei popoli artici che continuarono ad allevare le renne (come –forse- facevano già gli uomini
del mesolitico). Enormi aree a steppa che ancora oggi rappresentano le terre elettive di mandrie e
greggi, e dove vivevano e vivono dei popoli obbligatoriamente nomadi, la cui sussistenza era e è
demandata alla costante mobilità e alle straordinarie capacità adattative. Un mondo in equilibrio
precario, soggetto pesantemente alle fluttuazioni climatiche e che scontava un problema di fondo
che occasionalmente si rinnovava: alcuni lustri di clima favorevole consentivano agli uomini un
aumento della natalità (per riduzione del tempo di interparto e per minore mortalità infantile); un
lasso di tempo sufficientemente lungo perché le greggi (che hanno cicli riproduttivi più brevi e/o
che non attuano forme di controllo delle nascite) andassero incontro ad un aumento
esponenzialmente (nessun nomade attua una politica di controllo delle nascite animali se il clima è
favorevole e i pascoli abbondanti). Ma -quando dopo un periodo di stagioni favorevoli- il ciclo si
invertiva, queste società nomadi erano obbligate (per varie problematiche, tra cui quelle relative alla
coesione interna) ad espellere una parte più o meno significativa di uomini e di animali. Cessavano
allora gli scambi pacifici con i popoli di agricoli confinanti e da quelle immense lande uscivano
ondate successive di espulsi o di avventurosi che potevano da vita a grandi migrazioni di massa o a
saccheggi, predazioni e razzie; un riproporsi casuale ma ciclico dell‟antico conflitto “Abele contro
Caino” che tanta importanza ha avuto nelle storia sociale, politica, economica, linguistica e
culturale dell‟intera Eurasia.
L‟ultima biocenosi riconducibile alla Mezzaluna fertile fu quella che si consolidò nella parte più
meridionale della stessa, nell‟area che possiamo definire: siro-palestinese. Di questa zona abbiamo
un‟ampia gamma di studi intrapresi negli ultimi anni che ci aiutano a fare luce su di una
popolazione pre-agricola locale particolarmente interessante.
La Cultura natufiana fu una cultura mesolitica diffusa sulle coste orientali del Mar Mediterraneo
nella regione del Levante. La datazione con il metodo del radiocarbonio colloca questa cultura alla
fine del Pleistocene (tra 12.500 e 10.200 anni fa). È caratterizzata dalla creazione di insediamenti
stabili prima dell'introduzione dell'agricoltura e fu probabilmente l'antenata delle culture neolitiche
della regione. Alcuni elementi permettono forse di riconoscervi il primo caso di coltivazione
deliberata di cereali e certamente faceva uso di cereali selvatici. I villaggi natufiti coprivano circa
1.000 m2 di terreno e ciascun insediamento ospitava dai 100 ai 150 individui, mentre insediamenti
più piccoli sono stati interpretati come ripari temporanei. Negli insediamenti le case erano semisotterranee a pianta rotonda (diametro tra i 3 e i 6 m), spesso con fondazioni in pietrame a secco,
mentre la sovrastruttura doveva essere realizzata in legno leggero. Al centro della casa un focolare
rotondo o con angoli arrotondati. Gli insediamenti stabili sono probabilmente stati resi possibili da
abbondanti risorse alimentari, dovute al clima favorevole all'epoca. La vita si basava sulla caccia, la
98
pesca e la raccolta, compresi i cereali selvatici. Sono presenti strumenti legati alla lavorazione e al
consumo dei cereali.
Le lame di falce, con la caratteristica lucidatura data dall'uso, testimoniano l'utilizzo per il taglio
degli steli e forniscono una prova indiretta di un inizio di agricoltura. Raddrizzatori di pietra
testimoniano l'utilizzo dell'arco. Esistono inoltre recipienti e mortai. Compare una ricca industria
dell'osso, che comprende arpioni e ami per la pesca. Sono lavorati pendagli in pietra e in osso,
utilizzati come ornamenti ed esistono alcune figurine umane scolpite nel calcare, ma il tema
figurativo preferito sembra essere stato la gazzella. I resti botanici rinvenuti testimoniano la raccolta
di cereali selvatici, legumi, mandorle, ghiande e pistacchi. Le ossa rinvenute mostrano che la preda
principale era proprio la gazzella. Inoltre erano cacciati occasionalmente anche cervi, cinghiali e
nelle zone a steppa, onagri e caprini. Uccelli acquatici e pesci d'acqua dolce fornivano parte della
dieta nella valle del Giordano. Alcune tracce sulle ossa animali sono state interpretate come prove
di una caccia comunitaria con le reti.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Cultura natufiana
Da quest‟area discendono più o meno gli stessi modelli di alleanze di quella che abbiamo definito
come: “biocenosi mediterranea”, ma con cultivar più adatti (o che si sono adattati) alle condizioni
predesertiche tipiche dell‟agricoltura siriaca, di quella della penisola arabica (specie nella sua parte
meridionale) e dei paesi del nord Africa. A caratterizzare ulteriormente questo particolare insieme
di alleanze adatte alle aree predesertiche furono – successivamente- i cammelli e la palma da dattero
e l‟esclusione -tramite un input culturale e religioso- dei suini; mentre lo Yemen e l‟Oman
divennero le terre del caffè e delle spezie profumate.
Una simile dispersione biologica avvenne nei centri di domesticazione dell‟Estremo oriente. La
biocenosi che si costituì nel nord della Cina e che si aggregò inizialmente intorno al miglio e al
panico (e che più tardi integrò il grano tenero grazie a un trasferimento biologico ovest est), migrò
verso nord e colonizzò la Corea, la Manciuria e successivamente il Giappone; avendo la strada ad
occidente sbarrata dalle grandi steppe mongole con cui però mantenne una relazione di scambi non
solo alimentari. Quella complessa e vasta che si formò nel sud della Cina, costruita intorno alla
domesticazione del riso e molte altre specie vegetali e animali, trasmigrò verso sud colonizzando
tutti i paesi dell‟Indocina e l‟Assam, più i grandi arcipelaghi del Pacifico (non la Nuova Guinea e il
Borneo che furono centri di domesticazione secondaria di quelle specie che depositano la loro
componente energetica nei tuberi o nei fusti, che poi si estese verso i piccoli arcipelaghi del
Pacifico).
Un discorso analogo vale per le biocenosi Americane: quella messicana -costituitasi intorno al
mais- si estese per la Mesoamerica (compresi alcune aree meridionali degli Stati Uniti) e toccò la
parte caraibica del centro e del sud America ma non riuscì mai a colonizzare le vaste pianure nord
americane, che fino all‟arrivo degli europei rimasero territori di caccia e di nomadismo (simile in
questo alle steppe euroasiatiche). Quella peruviana non fu mai in grado di scendere le pendici
andine e non si estese mai all‟Amazzonia (centro di una biocenosi secondaria) e alle vaste praterie
delle Pampas (che furono poi colonizzate sempre dagli europei). Un discorso simile vale per gli altri
centri di domesticazione secondari sparsi in giro per il mondo, come quello costituitosi intorno al
99
fiume Niger o quello dell‟Etiopia. Un discorso a parte bisogna fare per il sub continente indiano, da
cui discende la domesticazione dei bovini, dei bufali d‟acqua, delle galline, del cotone, della canapa
e del tè; specie essenziali per lo sviluppo delle biocenosi limitrofe e che oggi sono alla base
dell‟agricoltura mondiale. Malgrado tutte queste esternazioni – di cui siamo in grado di tratteggiare
solo grossolanamente i percorsi e le ragioni- l‟India sembra un paese d‟invasioni e non un paese di
invasori, tanto che anche le sue grandi civiltà agricole (Harappa e Mohenjo-daro) sono ancora un
enigma per gli storici.
Di questo percorso di diffusione dell‟agricoltura abbiamo una traccia precisa nell‟Europa
preistorica, dove il numero dei siti rilevati e studiati è più alto che non negli altri territori dove si
sono sviluppate le primitive agricolture. Scrivono Albert J. Ammerman e Luigi Cavalli Sforza sul
libro “La transizione neolitica e la genetica della popolazione europea”:
“Come abbiamo già ricordato, possiamo considerare l'espansione delle prime fasi dell'agricoltura
come un processo di diffusione spiegabile in due modi sostanzialmente diversi, che occorre
distinguere nettamente a livello concettuale. Secondo uno di questi, si può considerare il processo
come risultato di una diffusione culturale: cereali e tecniche agricole in questo caso sarebbero
passate da un gruppo all'altro senza richiedere il movimento o lo spostamento geografico delle
persone. Alternativamente, si può vedere l'espansione come un processo di diffusione causato dalla
crescita e dallo spostamento di una popolazione: secondo quest'ultima spiegazione, per la quale si
parla di diffusione demica, non è l'idea dell'agricoltura a diffondersi ma gli agricoltori stessi, e con
questi la loro cultura. La diffusione assumerà un carattere demico essenzialmente in situazioni in
cui un cambiamento considerevole della struttura della popolazione segue alla nuova forma di
sussistenza. Si può dimostrare matematicamente che se un aumento della popolazione coincide con
una modesta attività migratoria locale, ne deriverà un'onda di espansione della popolazione che
avanzerà a velocità radiale costante. E‟ esattamente la forma di espansione che osserviamo nel caso
del calcolo della velocità ottenuto dai dati europei. Il modello di un'onda di avanzamento di
popolazioni corrisponderebbe ad un'espansione lenta e continua, che comporterebbe la formazione
frequente di nuovi insediamenti a brevi distanze dai luoghi precedentemente occupati”.
E ancora: “è possibile misurare la velocità di diffusione dell'agricoltura in Europa; si tratta di un
risultato che è stato ottenuto in parte grazie allo sviluppo di metodi semplici ma adeguati a
intraprendere tale misurazione e in parte all'esistenza di un gran numero di datazioni C-14
provenienti dai primi siti neolitici dell'Europa e del Vicino Oriente. Misurando la velocità di
diffusione, si ottiene un valore medio di circa un chilometro all'anno; se confrontato con eventi
storici a noi più familiari, questo valore sembra molto basso ….., ma in effetti 25 chilometri per
generazione non sono pochi, specialmente pensando ai mezzi di trasporto disponibili nell'epoca
neolitica”.
Di questa espansione il team di Cavalli Sforza ha tracciato delle mappe isocrone che toccano tutta
l‟Europa, da dove si evidenzia che l‟agricoltura impegnò quattromila anni per passare dalla
Mezzaluna fertile alla Scandinavia e alla Scozia e tremila anni per arrivare nella penisola Iberica.
Parlando di agricoltura (ossia di quel particolare modo che gli uomini hanno di rapportarsi alla
Natura) alle tipologie di diffusione demica e culturale (forme centrate sugli uomini) sarebbe
100
opportuno aggiungerne un‟altra tipologia legata alle condizioni ambientali. Pare evidente (e i dati lo
confermano) che, dove la diffusione si è mossa sullo stesso parallelo (Mezzaluna fertile – penisola
Iberica) la sua onda di avanzamento è stata più veloce, questo probabilmente perché le specie non
dovettero affrontare grossi adattamenti climatici; dove la direttrice è stata sud-nord (oltre che estovest) la progressione risultò più lenta, perché tra le specie coltivate e allevate si dovettero
selezionare nuovi cultivar e/o nuove razze animali in grado di competere e/o sostituire le specie
autoctone. E anche nuovi comportamenti e nuovi adattamenti umani, perché vivere e lavorare i
campi in Medioriente non è la stessa cosa che farlo in Scandinavia.
Intanto, mentre avanzava adattandosi a territori sempre nuovi e sempre più ampi, l‟agricoltura delle
biocenosi primarie cambiava al suo interno grazie a processi di adeguamento e perfezionamento
delle alleanza biologiche. Qui iniziamo a toccare il tema della “dinamicità” che per tanto tempo
abbiamo tenuto in surplace e che sarà centrale del prossimo capitolo. Grazie ad un processo di
acquisizione culturale - avvenuto in secoli di attente osservazioni- gli uomini appresero come
“prendersi cura” delle altre specie per ottimizzare i benefici reciproci: come selezionare i semi per
loro migliori e come gestire con profitto reciproco le mandrie; imparando come dal succedersi delle
stagioni derivi il tempo del riposo e quello del risveglio vegetativo e degli amori animali;
acquisendo conoscenze sulla variabilità del clima (fatto che permise loro di prevedere il periodo
delle piogge e quello della siccità); apprendendo a gestire il benessere e a contrastare le malattie dei
campi e delle greggi; fino a comprendere che per assicurarsi i giusti raccolti la terra andava nutrita e
abbeverata come si fa con le mandrie. Nello stesso tempo le mandrie si affidarono agli uomini con
meno timore e gli uomini ne espunsero gli individui più feraci e indisciplinati, facendo la stessa
cosa con i semi nei campi coltivati, dando quindi vita a popolazioni più omogenee e maggiormente
in grado di rispondere alla sollecitazioni di maggior produttività (perché un‟alleanza - e questo vale
anche per gli umani- è fatta di individui più accondiscendenti al modello). Così per alcuni uomini
(con un crescendo che non si più interrotto fino ad ora) venne meno il bisogno di impegnarsi
quotidianamente nella ricerca del cibo (l‟unico impegno a cui nessun essere vivente può sottrarsi) e
si aprirono spazi affinché il loro tempo si rivolgesse a interessi nuovi: alcuni diventarono artigiani
specializzati nel produrre oggetti di cui gli agricoltori avevano bisogno, altri capirono il
funzionamento delle fornaci e con la palta impastata o le terre arrivarono a produrre ceramiche e
metalli, tra loro alcuni capirono che la bellezza dei segni, dei suoni e dei gesti trasmetteva benessere
alla comunità e iniziarono a vivere di quella; altri divennero guerrieri a difesa dei beni accumulati e
delle persone che vivevano nei villaggi; altri ancora raccontavano idee e fatti che –a loro dire- erano
stati suggeriti da entità esterne al convivio quotidiano; alcuni pensarono che quello era il tempo
giusto per gestire e indirizzare il lavoro di altri. Di certo nei villaggi nacquero società più
complesse, organizzate su basi meno comunitarie, e per la prima volta nella storia della nostra
specie in molti dovettero andare da chi coltivava per scambiare cose in cambio di cibo. Così che
dopo milioni d‟anni di storia evolutiva non solo i bambini e i vecchi iniziarono a dipendere da altri
per il loro mantenimento.
Dove le condizioni pedoclimatiche, sociali e culturali lo consentirono, il numero delle persone che
abitavano in quei villaggi aumentò; ne abbiamo un esempio nell‟agglomerato di Gerico (da molti
considerato la prima “città “) o in quello di Çatal Hüyük, già esterno al territorio della Mezzaluna
fertile.
101
Çatal hüyük è un importante centro abitato di epoca neolitica situato in Anatolia vicino alla città di
Konia. Il sito presenta una sequenza di 18 livelli stratigrafici che vanno dal 7400 al 5700 a.C. e
occupa una superficie di 13,5 ettari, dei quali solo un 5% è stato indagato con scavi archeologi. È
stato scoperto alla fine degli anni cinquanta da James Mellaart che vi ha condotto campagne di scavi
tra il 1961 ed il 1965. Dal 1993, ulteriori ricerche sono condotte da Ian Hodder. Il villaggio era
costruito secondo una logica completamente diversa da quella moderna: le case erano monocellulari
e addossate l'una all'altra; essendo poi di altezze diverse, ci si spostava passando da un tetto a un
altro e per molte case l'ingresso su quest'ultimo era l'unica apertura. La circolazione e gran parte
delle attività domestiche avveniva dunque al livello delle terrazze. L'assenza di aperture verso
l'esterno, nonché di porte a livello del terreno, difendeva la comunità dagli animali selvatici e da
eventuali incursioni di popolazioni confinanti, anche se resta oscuro il livello di conflittualità tra le
diverse comunità dell'epoca. L'unica via d'accesso all'intero complesso erano scale che potevano
facilmente essere ritirate in caso di pericolo. A Çatal Hüyük ogni abitazione era divisa in due
stanze. Quella più grande aveva al centro un focolare rotondo ed intorno dei sedili e delle
piattaforme elevate per dormire; in un angolo c'era un forno per cuocere il pane. La stanza più
piccola era una dispensa per conservare il cibo: tra una casa e l'altra c'erano dei cortili usati come
stalle per capre e pecore. Circa un terzo delle case presenta stanze decorate e arredate
apparentemente per scopi cultuali: sulle pareti, infatti, sono state rinvenute pitture e sculture di
argilla che raffigurano teste di animali (specie di tori, qualcosa di analogo ai bucrani) e divinità
(specialmente femminili, legate al culto domestico della fertilità e della generazione). Gli abitanti
della città seppellivano i propri morti, divisi per sesso, sotto il letto. Questi, prima di essere
sistemati sotto i letti, erano esposti all‟aperto in attesa che gli avvoltoi procedessero a una completa
escarnazione. I ritrovamenti relativi alla cultura materiale sono da segnalare l'abbondante
produzione ceramica e una raffinata industria litica, realizzata per il 90% in ossidiana, pietra
vulcanica vetrosa di cui la regione è ricca e di cui è attestato un intenso commercio locale fin
dall'epoca protostorica. Lo schema economico di base è quello tipicamente agro-pastorale, ma si
segnalano scelte ardite, quali quella di coltivare frumento invece che orzo e quella di allevare bovini
oltre che ovini e caprini.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Çatal hüyük
Si stima che gli abitanti di alcuni villaggi superassero il numero di diecimila persone e questo lascia
immaginare il grado di stratificazione sociale di quella realtà protostorica. La cosa sorprendente è la
similitudine del modello abitativo con quello degli insetti sociali; moduli addossati l‟uno agli altri
senza discontinuità e con un solo accesso superiore, come una semplice cella per l‟allevamento
delle pupe. Sorprendente è invece il numero degli spazi ritenuti luoghi di culto, chiara
dimostrazione che il legame tra gli uomini e quelle entità immateriali che possiamo cominciare a
definire “divine” fosse molto forte. Queste stanze sono del tutto simili a quelle abitate ma con
raffinati affreschi parietali incentrati sul tema della morte (affreschi di avvoltoi volteggianti insieme
a molti segni grafici) e un numero sorprendente di sculture. La maggior parte di queste sculture
rappresenta teste di tori con grandi corna. Come e perché i tori – una specie domesticata in India
intorno al 9000 a.C. – abbiano un tale ruolo nell‟Anatolia è un mistero (lascia perplessi l‟idea
sostenuta da alcuni di una similitudine tra le corna bovine e l‟utero materno), ma consente di
immaginare dei circuiti culturali e agronomici di ampia mobilità che coinvolgevano tutta l‟Eurasia.
102
Questo ci porta all‟ultimo argomento di questo capitolo, quello su cui non possedendo delle
conoscenze specifiche avrei preferito sorvolare, ma che affronto per ribadire la visione centrata
sull‟agronomia che è l‟assioma di tutto lo scritto. Per i linguisti queste migrazioni preistoriche sono
state e sono tuttora ragione di grandi discussioni e diatribe, secondo Colin Renfrew è proprio dalla
Mezzaluna fertile che hanno avuto origine gli antenati dei popoli indoeuropei, i quali -grazie
all‟affermazione delle tecniche agricole- si espansero in Europa, in Iran e nel sub continente
indiano. Marija Gimbutas rigetta completamente questa ipotesi e lega invece l‟arrivo degli
indoeuropei (a suo avviso avvenuto nel corso del quarto millennio a. C.) a un susseguirsi
d‟invasioni che ebbero origine nelle steppe situate tra il mar Nero e il mar Caspio e collegate alle
migrazioni di tribù nomadi portatrici della cultura dei Kurgan (il tema della diatriba è da quale
oriente venivano i popoli indoeuropei).
Il termine Cultura kurgan indica l'insieme di culture preistoriche e protostoriche dell'Eurasia
(Europa orientale, Asia centrale e Siberia) (fino ai Monti Altai e alla Mongolia occidentale), che
utilizzavano seppellire i morti di alto rango in tumuli funerari, edificati a partire dal 4000 a.C. circa
e particolarmente nell'Età del Bronzo. I kurgan più antichi pare siano comparsi tra le popolazioni
del Caucaso e poco dopo nella steppa russa meridionale e in Ucraina. Subito dopo l'influenza delle
Culture kurgan si propaga nella maggior parte dell'Europa orientale, centrale e settentrionale.
L'ipotesi correntemente più accettata è che i popoli indoeuropei abitassero alcune regioni della
Russia meridionale attorno al mar Nero proposta da Marija Gimbutas. Questa ipotesi è anche
supportata dai risultati delle moderne indagini genetiche di Luigi Cavalli-Sforza (picco in Russia
meridionale della III componente principale della composizione genetica delle popolazioni europee
moderne).
Elaborato da Wikipedia alla voce: Cultura Kurgan
Ma nella mia testa c‟è l‟idea che per capire il fenomeno degli indoeuropei bisogna andare indietro
di qualche millennio ed arrivare alla primitiva irradiazione originatasi nella Mezzaluna fertile di cui
ho parlato pocanzi.
Faccio però notare che non possiamo leggere la storia delle migrazioni solo in funzione dei
comportamenti umani è estremamente fuorviante, perché sulla vita dei popoli e sulle loro
migrazioni gli eventi climatici hanno un peso decisivo. E‟ vero che gli uomini sono una specie
vagabonda (altrimenti perché avremmo i piedi?) ma il girovagare è il comportamento dei singoli
non dei popoli e quando i popoli si spostano, non girovagano, ma si muovono rispondendo a cause
ben precise. Nessun popolo lascia i pascoli che ben conosce o le proprie case o tende, senza una
precisa causa scatenante o un‟opportuna ragione. I popoli possono essere spinti a partire per nuovi
orizzonti colturali e culturali dopo che il loro numero è considerevolmente aumentato (in virtù di
una prolificità conseguente all‟abbondanza), oppure per carestia. Il primo caso va compresa anche
la migrazione “demica” legata alla nascita dell‟agricoltura e alle nuove tecniche di conservazione
degli alimenti. Allora le migrazioni sono radiali e si prolungano per un periodo tanto lungo da
sostituire le cose e le genti che incontrano sul loro cammino; mentre sono fulminee e disperate in
caso di carestia. Queste migrazioni legate alla penuria possono occupare territori nuovi o sostituire
popoli, dando vita a nuove società e culture (ne abbiamo ampia testimonianza), ma difficilmente
103
sono ampie a punto di occupare un intero continente. Quando raramente avviene (penso ai
mongoli), tendono a essere effimere; nel senso che sono capaci di sostituire per un tempo i centri di
potere politico, ma sono portate ad accettare lo status religioso e culturale dei popoli assoggettati.
Abbiamo però anche l‟esempio di progetti attuati tramite a una campagna militare (le
colonizzazioni) che hanno portato all‟occupazione e in una sostituzione parziale o totale dei modelli
produttivi, della lingua e della religione.
104
Il tempo delle biocenosi
Così in sette-otto mila anni le biocenosi agricole si sparsero per il mondo. Non con il passo lento e
cadenzato tipico dei nomadi e delle loro mandrie, neppure con quello accorto e silenzioso dei
cacciatori, ma con il passo fermo e motivato degli uomini che si spostavano con i loro attrezzi
agricoli; scortando animali da cortile e greggi, trasportando bisacce piene di semi e talee di alberi da
trapiantare; ma –soprattutto- facendosi essi stessi veicoli di nuove conoscenze e di nuovi modelli di
comportamento: perché le idee sono leggere da trasportare anche quando risultano “pesanti”; perché
vanno più veloci delle cose e passano da una testa all‟altra più facilmente di quanto le cose passino
da mano in mano; perché le idee contaminano le persone mentre le cose possedute rendono
diffidenti. Uomini che guardavano la Terra con uno diverso sguardo utilitaristico; cercando terra
fertile da coltivare, acqua accessibile per irrigare, pendii assolati e suoli drenati e profondi dove le
messi e i frutti potessero maturare abbondanti; luoghi dove loro e i loro figli potessero crescere e
moltiplicarsi non vivendo dei beni che la Terra offriva loro ma di quelli del frutto del loro lavoro.
Adattando e adattandosi in mille e mille forme (a volte sorprendenti) ai vari ambienti naturali e qualche volta- ricorrendo anche alla stipula di nuove e più tardive alleanze con le specie locali che
incontrarono sul loro cammino (ne sono un esempio il cavallo e il cammello, la palma; ma anche il
coniglio, il carciofo, il finocchio e l‟asparago, l‟avena e la segale, etc.). Dando così vita a un
universo di biodiversità coltivata che si è sviluppato parallelamente alla diminuzione indotta della
biodiversità generale dei territori dove si insediavano e facendone – in parte- da contrappunto.
Perché l‟inizio della coltivazione e dell‟allevamento segna anche l‟affermazione all‟interno della
Natura dei nuovi biotopi formati dalle varietà e dalle specie coltivate (compresi gli uomini portatori
di mutazioni adattative come la lattasi); con una evidente sovrapposizione a quella che fino allora
era stata la logica selettiva della sola Natura. Perché i sistemi agricoli sono anch‟essi dei naturali
promotori della diversità biologica, basata però su finalità opportunistiche come la velocità di
accrescimento e fruttificazione, l‟incremento della produttività utilizzabile, l‟adattamento alla
contiguità e –soprattutto- la valorizzazione di quelle caratteristiche percettive di gustosità e di
bellezza che sono i principi fondamentali di ogni selezione (dal latino selicere, che vuol dire:
scegliere), quindi –in ultima istanza- snodo collaterale di biodiversificazione. Punto d‟affermazione
di una biodiversità motivata, figlia d‟interessi interni ai sistemi agricoli che rispondono a scelte
produttive e sensoriali (i già citati gusto e bellezza), egualmente capaci –se assistiti- di
compenetrarsi alle tante e varie condizioni pedoclimatiche presenti in Natura. Ho detto “ai bisogni
interni dei sistemi agricoli” e non ai bisogni degli uomini perché sarebbe un errore pensare che la
scelta dei cultivar o delle specie dipenda solo dalla nostra volontà, infatti anche gli altri protagonisti
delle biocenosi dinamiche sono in grado di influenzare e incrementare la biodiversità dei sistemi
agricoli, basti pensare agli animali che con il loro brucare selezionano le erbe dei campi.
Questo passaggio è essenziale per sostenere che la complessità delle relazioni interne alle biocenosi
è più ampia e profonda del solo interesse e volere umano e che è proprio questa complessità
relazionale che ha consentito ai sistemi agricoli di collocarsi senza artificiosità e senza attrito nel
contesto ambientale, apportando in biodiversità motivata una parte di quello che intrinsecamente
105
sottraevano in diversità naturale (la semplificazione tipica dell‟agricoltura industriale -che oggi
porta spesso alla monocultura varietale- è una forma degenerativa di quella che ho appena definito:
biodiversità motivata). Tutto questo perché le biocenosi agricole sono un affresco vitale che assume
forme e colori diversi a secondo dei vari ambienti naturali presenti sul Terra; capaci di essere
ubiquitarie e proteiformi, plastiche e progettuali. Da queste caratteristiche discende la loro natura
espansiva, la loro attitudine a penetrare gli ambienti naturali che incontrano sul loro cammino, la
loro capacità di avanzare sostituendo. Da ciò deriva l‟idea della loro dinamicità: qualcosa che
avanza trasformandosi costantemente, con la forza di trasformare anche l‟ambiente intorno a se.
Prendo come riferimento “ La conquista sociale della Terra”, il titolo del libro che Eduard Wilson
ha dedicato alle formiche e alludo all‟incredibile capacità (comune anche a questi insetti sociali) di
infiltrare – modificando- molti dei territori naturali presenti sulla Terra. Faccio queste asserzioni, in
piena coscienza, anche se sostenere l‟esistenza di biocenosi dinamiche apparentemente è un
ossimoro biologico. Le biocenosi naturali –come tutti i sistemi biologici- tendono a essere stabili e quando cambiano-, lo fanno solo in forza di sollecitazioni o aggressioni che vengono dall‟esterno:
un agente infettante, una forte siccità, una catastrofe ambientale o l‟arrivo di un nuovo o di nuovi
predatori. Cambiamenti che sono in ogni modo condizionati dalla tendenza della Natura ad una
pronta restaurazione dello status quo e che –qualora confermati- sottostanno alla costante logica
d‟equilibrio o riequilibrio.
Le biocenosi dinamiche (e tra queste vanno comprese anche quelli degli insetti sociali) sono invece
caratterizzate da cambiamenti continui che non sono esclusivamente risposte ad agenti esterni, ma
vengono generati dall‟interno con un motu proprio che ha l‟incredibile capacità di emergere da se
stesso e di estendersi nell‟ambiente circostante; compenetrandolo fino al punto da contrastare ed
espellere le situazioni antagoniste. Non è quindi il “generale” che condiziona il “particolare”, ma
esattamente il contrario. Questa “forza cinetica” che consente alle biocenosi dinamiche di
affermarsi e vincere altro non è che il classico meccanismo evolutivo (che ha nella crescita
numerica e nel consolidamento ambientale l‟obiettivo di ogni singola specie), in questo caso però
perseguito e messo in atto da tutte le specie coinvolte in un costante rapporto di collaborazione e di
integrazione le une con le altre. Le specie partecipi di queste biocenosi non si muovono
autonomamente, ma tutte avanzano con un movimento sincronico che, tanto più è coordinato, tanto
più risulta vincente nel contesto ambientale, oltre che tendente alla diffusione territoriale.
Chiaramente questa dinamicità può essere ritardata o accentuata dalla molteplicità dei fattori
esterni, come le condizioni ambientali, quelle climatiche o la qualità del terreno; oppure legati
all‟intensità delle relazioni tra i vari simbionti e/o al ruolo e alla funzione del simbionte principale.
Una cosa, infatti, caratterizza le biocenosi dinamiche: in tutte si evidenzia la presenza di una specie
che ha funzione di simbionte principale. Stiamo parlando di una specie sociale che vive in nuclei
che vanno dalla famiglia umana alle grandi colonie di termiti (partecipate da milioni di individui),
organizzata su basi parentali e/o comunitarie e gestita in forme di gerarchia più o meno partecipata,
che ha nell‟abnegazione individuale, nella comunicazione tra i partecipanti e nell‟intrinseco valore
assegnato al lavoro il suo collante. Nelle biocenosi più antiche (parlo di quelle degli insetti sociali
che sono strutturate da alcuni milioni d‟anni) la presenza di questa specie assurge a forme
parossistiche: una sola femmina (la regina) assicura alla specie l‟esclusiva funzione riproduttiva, la
società è rigidamente divisa in caste e le specie alleate sono –di fatto- sequestrate e schiavizzate per
106
essere poste al lavoro coatto. Purtroppo abbiamo idee solamente approssimative di come questo
modello evolutivo si sia affermato, conosciamo però forme di socialità intermedie (pur non sapendo
se sono in un divenire) dove le relazioni sociali sono più elastiche; tra queste –credo- possiamo
collocarci anche noi: gli ultimi arrivati di questo ristretto gruppo di animali eusociali.
La condizione di simbionte principale comporta impegni non indifferenti: una alta e costante
capacità di relazione con gli altri coprotagonisti, una profonda conoscenza dei loro bisogni, una
raffinata capacità elaborativa e progettuale, oltre che una abile manualità applicata sia internamente
che esternamente alla biocenosi stessa. Tutto questo unito alla capacità acquisita (anche dalla nostra
specie) di dedizione e di servizio: tentando di gestire i cambiamenti climatici, ambientali e genetici;
prendendosi cura della salute vegetale e animale; cercando di mettere il sistema nelle migliori
condizioni produttive e riproduttive possibili; consci che il bene generale si tramuta
imprescindibilmente nel bene individuale e collettivo.
E‟ incredibile come l‟assunzione di questo nuovo ruolo biologico abbia cambiato definitivamente la
nostra prospettiva di specie,ed è incredibile che questo sia avvenuto e il come è avvenuto. Quanto è
mutato il nostro modo di stare nel mondo e la stessa percezione dello stesso mondo dopo che le
pietre tolte dai campi sono diventate fondamenta e muri di case e di magazzini, dopo che
l‟accumulare derrate alimentari (che rapidamente si sono tramutate in beni secondari) è diventata la
nostra preoccupazione principale, dopo che –guardando il cielo con occhi nuovi-abbiamo iniziato a
maledire la siccità, la gelata tardiva, la pioggia eccessiva perché più interessati ai fenomeni
meteorologici che al cielo in quanto tale. Tutti sentimenti che gli uomini hanno cominciato ad
avvertire solo dopo che i loro piedi hanno iniziato a calpestare terra arata.
Un ruolo che è la conseguenza del baratto tra minore libertà in cambio di una stabilità da molti
vissuta come maggiore sicurezza; uno scambio da alcuni ritenuto doloroso, ma sicuramente
vincente (parlo in termini di specie), che ha consentito a noi e ai nostri alleati di espanderci a
macchia d‟olio per il mondo. Insolita prova che non sempre le cose si sviluppano per addizione, ma
che esistono cose che crescono anche per negazione o sottrazione; ne sono un esempio gli animali
allevati a cui è impedito riprodursi secondo i cicli naturali, oppure la potatura o la castrazione (altri
esempi canonici di sottrazione). Mentre tutte le femmine nate servono alle mandrie, ai greggi o ai
pollai, di maschi ne basta uno su dieci, su venti, su cinquanta. Quei pochi maschi riproduttori
rispondono a valutazioni che variano nel tempo e nei luoghi; gli altri (quelli esclusi dalla
competizione riproduttiva per mantenere una pace all‟interno dei gruppi e per assicurare una ricca
macellazione futura ) sono castrati. Lo stesso si fa con gli alberi da frutto! Se gli uomini non
intervenissero con le potature (un‟altra forma di castrazione) gli alberi fruttiferi tenderebbero a
crescere e riprodursi in modo naturale; ma gli uomini coltivatori non sono cinghiali che sfruttano
l‟abbondanza dei frutti selvatici (come facevano i loro antenati); l‟uomo agricoltore taglia e
costringe e l‟albero cresce secondo la volontà di chi lo cura; dà meno frutti ma più grossi e saporiti,
frutti che in Natura mai crescerebbero così grandi e succosi (è così che l‟albero potato e, accudito
per i suoi frutti, emerge dal contesto naturale dove vive). Perché questa è l‟essenza dell‟agricoltura
vista come biocenosi dinamica; un sistema biologico che lega e che costringe, obbliga, induce e
sostituisce; ma anche una enclave biologica che si adatta e si trasforma in mille e mille endemismi,
localismi, fatti di varietà e razze l‟una diversa dalle altre; arricchendo il mondo di specie e di
107
cultivar relazionati alla più alta capacità produttiva motivata estrinsecabile da quel territorio, oltre
che ai piaceri visivi e sensoriali; facendo in modo che il gusto e la bellezza (quindi un modello di
selezione culturale oltre che colturale) ripiani in parte la perdita della varianza naturale.
Chiaramente questa nuova funzione culturale non ridimensiona il fatto che anche gli uomini
coltivatori nascessero da una particolare forma di castrazione. Provate solo a immaginare cosa può
pensare di noi, del nostro stile di vita, del nostro concetto del tempo e più ancora della nostra
“padronanza” del tempo un nomade o un eremita (la non padronanza del tempo è una delle forme di
deprivazioni più violenta che si può immaginare). Può essere che le nostre rinunce abbiano un
senso, e che quello che abbiamo perso in leggerezza e libertà sia ampliamente giustificato dalla
quantità d‟opzioni e di beni con cui riempiamo la nostra vita (visto il senso che attribuiamo a quei
beni); ma non è di questo che voglio parlare -perché su questo ognuno è libero di avere la propria
opinione- ma è della perdita in quanto tale. Diventare una specie stabile e accumulatrice ha
comportato dei cambiamenti dell‟Io e dei rapporti sociali incredibili a cui -qualcuno – anche a
distanza di mille generazioni- ancora si rifiuta di adeguarsi. Guardate quanto è difficile per i ragazzi
il momento dell‟adolescenza, quante fughe, quanti rigetti del cursus formativo, quanto rifiuto della
logica del lavoro, fino a che le consuetudini sociali e la morale comune non prendono il
sopravvento, riportando le resistenze individuali nell‟ambito del comportamento collettivo. Sono
convinto che molto di questo non sarebbe potuto succedere, se quei sei-settemila anni che dividono
la nascita dell‟agricoltura dalla nascita della storia non avessero disegnato un tipo di uomo
completamente nuovo: l‟uomo che trae sicurezza dal possedere le cose (perché la libera fruizione
delle cose lo sottrae al senso di precarietà insito nella Natura); ma anche l‟uomo che trova
compiacimento nel trasformare le cose possedute in base ai propri gusti sensoriali (perché la
manipolazione delle cose naturali dà all‟uomo il senso di onniscienza). Ricordate Origene e l‟uomo
che si fa Natura?
Infatti, nei millenni successivi all‟affermarsi del mondo coltivato (tra il V e il IV millennio a.C.)
l‟apporto culturale di gusto e di bellezza va oltre gli aspetti della produzione e si estende alla
preparazione e elaborazione dei cibi; anzi –si può dire senza paura di essere smentiti- che è proprio
questo il campo dove le percezioni sensoriali hanno dato agli uomini il massimo grado di
compiacimento. Sono questi i millenni che l‟archeologo inglese Andrew Sherrat definisce come
quelli della: “rivoluzione dei prodotti secondari”, quelli che videro, nei campi, l‟introduzione di
alcune innovazioni fondamentali come l‟aratro e il concime (che daranno all‟agricoltura un
contributo produttivo determinante), ma anche i millenni che videro il latte trasformarsi in
formaggio e yogurt, l‟uva diventare vino, la farina lievitare in soffice pane, il malto diventare birra,
etc. Un tale ampliamento del gusto alimentare che ha paragoni solo con l‟introduzione del fuoco e
la conseguente cottura dei cibi. Ho inserito la lista sottostante per il piacere di dare, anche nella sua
parzialità, il senso della varianza e eterogeneità del gusto alimentare che da allora caratterizza le
società umane e che –a mio avviso- è stato uno degli strumenti più forti con cui gli uomini si sono
“abboniti”.
È doveroso notare che le fermentazioni conosciute nel mondo occidentale sono relativamente
poche, e sono dedicate soprattutto a svolgere un ruolo preminente nella sterilizzazione e
conservazione dei cibi e delle bevande, ma anche a produrre un considerevole miglioramento
108
gustativo dei cibi e della loro digeribilità. Nel resto del mondo (Asia, America, Africa) sono invece
diffusi molti altri tipi di fermentazioni che utilizzano, sia gli stessi agenti di fermentazione per
sostanze diverse (sorgo, durrha, mais), sia tipi e agenti di fermentazione diversi per sostanze diverse
(legumi, vegetali, pesci, carni, ma soprattutto cereali come: sesamo, miglio, riso, soia, teff). Queste
fermentazioni sono usate prevalentemente per migliorare il contenuto nutrizionale, ma anche per
produrre cibi batteriologicamente puri (in termini di commestibilità), oltre che di sapore gradevole e
conservabili nel tempo:
Africa: l‟Ogi (Sudafrica), una crema poco densa da mais e sorgo; il Mahewu (Sudafrica), crema
densa da mais e farina di frumento; il Mawe (Africa occidendale ), pasta acida di farina di mais;
l‟Injera (Eritrea ed Etiopia), focaccina spugnosa ed acida di farine di teff e frumento; il Kishk
(Egitto), pasta acida da frumento e latte con un altissimo contenuto proteico e vitaminico; la Kiska
(Sudan), pane acido da farina di sorgo; il Banku (Ghana), pane acido da mais e cassava; il Kenkei
(Ghana), panetti di pasta di mais fermentati e cotti al vapore.
America: la Chicha (in tutta la zona andina), bevanda acida e nutriente a basso o medio livello
alcolico; il Pozol (Messico ed America centrale), panetti fermentati di farina di mais; il Tesguino
(America centrale), bevanda sciropposa e alcolica prodotta dal mais; l‟Atole (Messico), crema acida
da granella umida di mais; l‟Agua agria (Messico), bevanda acida non alcolica da fermentazione
lattica; la Zambumbia, bevanda messicana alcolica da orzo e zucchero di canna.
Asia: In Cina il termine chu è individuato come sinonimo di "agente fermentante", quindi esistono
diversi tipi di "chu", a seconda di questo, ma anche di cosa, e di come si fermenta. Il Ping chu,
pastone cremoso. Il San chu, un composto granuloso. Il Huang chu, un chu giallo a fermentazione
alcolica, normalmente di riso o soia. L‟Huang cheng, un chu giallo di grano (nord della Cina) dove
non cresce il riso. Il Na chu, un chu tipico di riso (Cina meridionale e Corea). In Corea esiste anche
il Nuruk; un pastone di riso, grano, orzo fermentato e il Meju; pastone di granella di soia
fermentata. Nelle Filippine il Bubod; un pastone fermentato di riso da granella o farina. In
Thailandia lo Loopang; un pastone da fermentazione micetica, di farina e crusca di riso. In
Indonesia e Malesia il Ragi; ossia dei panetti compatti di riso a fermentazione micetica. In India la
Marchaa: torta bassa di riso, fermentazione micetica. In Giappone il Koji; un pastone tipo polenta
da granella o farina di riso o grano; il Funazushi (in giapponese: 鮒寿司 che significa sushi di
Carassio), un prodotto tipico della zona del lago Biwa fatto di pesce fermentato per quattro anni con
il riso e poi essiccato per altri quattro.
In Groenlandia: il Kiviaq, un piatto tipico degli Inuit a base di piccoli Auk (uccelli marini simili ai
pinguini) fermentati dentro una sacca di pelle di foca e consumati crudi, dal sapore misto tra
liquirizia e formaggio. In Islanda; il kæstur hákarl, squalo fermentato in fossa dal caratteristico
odore ammoniacale. Senza dimenticare il più famoso di questi prodotti: il garum; una salsa liquida
di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani aggiungevano come condimento a molti
primi piatti e secondi piatti. Una salsa di cui non conosciamo più la ricetta ma che si presume si
avvicini al Nuoc Mam, originario del Vietnam ed abbastanza diffuso in Estremo Oriente.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Fermentazioni
109
Noi consideriamo i prodotti derivati dalla trasformazione e manipolazione delle derrate alimentari
come una delle opere tipicamente umane, come se le api non scegliessero i pollini con cui fare il
miele e i mieli fossero tutti uguali, o come se le formiche non decidessero le qualità organolettiche
dei funghi che coltivano e non selezionassero gli afidi per produrre una melata più dolce e
abbondante. Ma a prescindere dall‟ipertrofia del nostro Io, viene spontanea la domanda: come tutto
questo è potuto succedere? Grazie a quali meccanismi gli uomini hanno potuto attuare un
cambiamento così significativo nella dispensa dei prodotti commestibili e dei propri gusti
alimentari? Qui non stiamo parlando del fuoco e dei prodotti cucinati (quelli si che sono il risultato
di un‟elaborazione esclusivamente umana!); qui stiamo parlando di cibi ottenuti attraverso processi
fermentativi e enzimatici, o grazie a particolari processi di conservazione, che –spesso- escludono
l‟atto della cottura: formaggi, insaccati di carne, vino, birra, che relegano la divisione binaria tra il
crudo e il cotto ad un approccio semplificato di una tematica ben più complessa.
E allora? Come hanno potuto gli uomini far lievitare il grano macinato o ottenere da una pappa di
cereali la spumosità di una birra o la spugnosità dell‟Injera? Cosa ci ha permesso di far nascere e
poi elaborare questi risvolti di gusto così particolari? Anche in questo caso la risposta è: grazie a un
sistema d‟alleanze! Non con quegli organismi superiori (piante e animali) con cui abbiamo dato vita
all‟agricoltura, ma con quegli esseri del microcosmo (famiglie di funghi con capacità lievitante e
quei ceppi di batteri con capacità fermentante) capaci -se assistiti- di trasformare i prodotti base
derivati dalla coltivazione, dall‟allevamento e dalla caccia, in cibi elaborati. Minuscole entità che,
messe nelle loro condizioni ideali d‟ambiente, si sviluppano rapidamente in colonie, capaci di
attivare impressionanti trasformazioni biochimiche (avete mai visto “bollire” il mosto?) e di dare
nuove forme e nuovi sapori ai prodotti della terra e del mare.
I lieviti sono un gruppo di funghi formati da un unico tipo di cellula. Il più comune è il
saccharomyces cereviciae o lievito di birra, "domesticato" da alcune migliaia di anni e utilizzato per
la produzione di vino, pane e birra. Esiste poi il lievito madre (o lievito acido), un amalgama fatto di
lieviti e batteri lattici (quelli che servono anche per la produzione dello yogurt o degli altri derivati
del latte), che induce una lievitazione più lenta ma con una maggiore crescita della massa, oltre che
una maggiore digeribilità e conservabilità del prodotto. Il lievito chimico è invece un mix composto
da una base debole (solitamente bicarbonato di sodio), un acido debole (in genere l'acido tartarico) e
da un amido inerte (amido di mais). Si usa questa miscela per aumentare il volume e per alleggerire
la consistenza del prodotto grazie a una reazione acido-base che rilascia bolle di anidride carbonica.
Questa reazione non biologica induce una lievitazione più rapida e standardizzata.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Lieviti
Si pensa che il primo prodotto ottenuto dalla fermentazione sia stato il vino, perché gli acini rotti
dell‟uva sono naturalmente contaminati dai lieviti trasportati da vespe e api; secondo altri invece il
primo prodotto fermentato è stato l‟idromele, la bevanda leggermente alcolica derivata dal miele
delle api. Ma prescindendo dalla primogenitura una cosa è certa: i lieviti e alcuni batteri da oltre seisettemila anni –rivoluzionando la nostra tavola- hanno rivoluzionato la nostra vita.
110
Millenni incredibili, che - dopo il vino e l‟idromele (prodotti con fermentazioni autoindotte)- hanno
visto gli uomini apprendere come e quando addizionare i lieviti alle pappe di cereali per ottenere
birra o pane, aggiungere fichi o datteri (ricchi anch‟essi di lieviti naturali) all‟acqua o al latte per
produrre kefir, inoculare batteri al latte per ottenere yogurt o kumis, fare l‟aceto per “cuocere” le
verdure crude o cagliare in formaggio grazie all‟uso di speciali agenti acidificanti. La vastità e la
complessità di queste opere è paragonabile solo all‟impegno che gli uomini (mai come in questo
caso persiste nella mia lingua un gap linguistico a danno delle donne) hanno profuso nel mantenere
“vive” le alleanze con lieviti e batteri. Da sei-settemila anni, infatti, la nostra specie presta la
massima attenzione (come se fosse prometeica) alla “madre” del pane e non c‟è stata (fino all‟arrivo
dei lieviti industriali) comunità che non si sia impegnata quasi con maniacalità alla sua
conservazione. Far morire una “madre” era un‟onta per la famiglia! Sei-settemila anni di cure quasi
quotidiane in un susseguirsi di gesti che hanno trasferito le attenzioni che gli uomini dedicano alle
biocenosi dal mondo esterno all‟interno delle case e delle cantine, con una intensità che si è incisa
nella carne viva della nostra specie, visto che abbiamo acquisito un adattamento selettivo per poter
meglio assimilare alcuni dei prodotto lievitati (e che oggi in molti hanno perso anche a causa dalla
scarsa qualità dei prodotti stessi).
Per questa ragione molti studiosi parlano di una coevoluzione tra l‟uomo e i saccaromiceti e
ritengono il rapporto con i lieviti come uno dei più stretti legami simbiotici intrecciati dalla nostra
specie.
La coevoluzione è il processo di evoluzione congiunto di due o più specie appartenenti alla stessa
comunità che interagiscono tra loro tanto strettamente al punto da costituire ciascuna un forte fattore
selettivo per l'altra (o le altre), col risultato di influenzarsi vicendevolmente. Il rapporto che lega le
specie in coevoluzione può essere sia predatorio (preda e predatore), che parassitico (ospite e
parassita), che simbiotico (ospite e simbionte). Talvolta tale concetto può essere utilizzato in
un'accezione analoga ma differente: si parla di coevoluzione anche nel caso d‟evoluzione d‟aspetti
culturali in stretta relazione interdipendente con l'evoluzione biologica. Ad esempio dal momento in
cui i primi ominidi hanno iniziato a padroneggiare l'uso del fuoco per cuocere il cibo (evoluzione
culturale) la struttura ossea si è coevoluta con una riduzione delle dimensioni e dell'inclinazione
della mascella (aspetto biologico); di pari passo la cassa cranica ha avuto modo di evolversi verso
una maggiore ampiezza, con conseguente ampliamento delle capacità cerebrali e culturali.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Coevoluzione
A questo punto sorge spontanea la domanda: dobbiamo considerare i microrganismi alla stessa
stregua dei macrorganismi? Trasformare i cibi è relazionabile ad allevare e coltivare? E, se si, l‟idea
della coevoluzione è un principio estendibile anche al macrocosmo? Ha quindi ragione David
Rindos che suggerisce di applicare il concetto di coevoluzione all‟agricoltura? Oppure l‟attività dei
microrganismi e la loro coevoluzione con gli uomini (trasformazione dei cibi) sono una cosa
separata dall‟agricoltura (produzione dei cibi)? Questa ultima asserzione è un postulato o è solo una
conseguenza del nostro modo attuale di vedere l‟agricoltura? Wendell Berry ci ricorda che:
mangiare è un atto agricolo! Ce lo ricorda perché, oggi, con la filiera dell‟industria alimentare in
grado di portare sulle tavole cibi sempre più lontani dai prodotti agricoli, sono molte le persone che
111
hanno scisso la relazione tra cibo e mondo coltivato. Oppure anche le funzioni del microcosmo
vanno inserite all‟interno del complesso sistema delle biocenosi dinamiche di cui l‟agricoltura
diventa la componente principale ma non unica? La domanda non è retorica, perché la differenza è
sostanziale. Io infatti concordo con la teoria di Rindos sulla coevoluzione, e penso che tutti noi ( e
per noi intendo: uomini, animali e batteri allevati, piante e lieviti coltivati) siamo coevoluti in una
rapporto costante e continuativo dell‟uno con gli altri, solo che inserisco questa idea –di per se già
suggestiva- in un quadro ancora più vasto e complesso. Perché, se pure il concetto di coevoluzione
sottintende il principio di una costante rimodulazione e adattamento dei rapporti tra simbionti, lascia
immaginare il sistema come chiuso su se stesso, autonomo e autosufficiente. Un sistema che evolve
senza espandersi. Io penso invece che i sistemi agricoli (anche nella loro componente alimentare)
posseggano una forza autoinduttiva che li porta ad essere espansivi e sostitutivi; quindi “dinamici”.
Questo straordinario periodo di alleanze simbiotiche ebbe praticamente fine quando si avvicinarono
i tempi della storia. Per cui, da qualche migliaio d‟anni, nessuna nuova pianta, nessun nuovo battere
e nessun nuovo animale ha più mostrato interesse a dare vita –insieme agli uomini- ad un progetto
condiviso. Conosciamo vari tentativi che hanno dato scarsi risultati (non c‟è da confondere
l‟allevamento domestico con il domesticamento: i criceti sono simpatici animali domestici, ma non
sono domesticati. Per questo, una volta liberi, riprendono immediatamente i loro comportamenti
naturali). Delle ragioni che hanno prodotto questa cesura sappiamo ben poco, così non siamo in
grado di dire se siano le specie nostre alleate a fare schermo all‟ingresso di loro potenziali
concorrenti, o se il fenomeno non dipenda dagli uomini che hanno smesso di sentirsi come un
“primus inter pares”, acquisendo invece un comportamento sprezzante e oppressivo verso le altre
specie nella loro funzione di simbionte principale. Sappiamo però che la stessa cosa è successa
anche agli altri insetti sociali, come se una volta acquisito un modello il modello sia replicabile ma
non ammendabile.. Non sappiamo neanche se tutto questo può discendere da un difetto del sistema,
oppure da un eccesso di funzionalità del sistema stesso. Personalmente sono portato a credere che il
sistema delle alleanze abbia smesso di inglobare altri attori perché compiaciuto dei propri risultati
funzionali, quindi –-nella scia delle leggi naturali- pur mantenendo la sua espansività verso
l‟esterno- abbia acquisito forme interne di autoconservazione.
112
L’Acqua e il Potere
L‟espansione delle biocenosi dinamiche, che si è tradotta in occupazione di nuovi territori naturali e
si è attuata attraverso la trasformazione dei suoli vergini in terreni agrari, è stata -come visto- un
percorso impegnativo e complesso che ha necessitato di una mole impressionante di lavoro. Come
ho già sostenuto aver fatto questo con la forza delle sole braccia (per lo meno fino a quando non
abbiamo potuto cantare sui vari livelli di lavoro animale) è stata l‟opera più titanica compiuta dalla
nostra specie. Chiaramente questa tendenza espansionistica si è sempre scontrata con tutta una
serie di fattori limitanti. Alcuni sono ambientali come le condizioni climatiche rappresentate dalla
piovosità, temperature e venti, o dalla disponibilità e accessibilità delle risorse idriche, ma anche da
specifiche condizioni pedologiche dei terreni.
In pedologia la tessitura è la proprietà fisica del terreno che lo identifica in base alla composizione
delle sue particelle solide. Esiste una tessitura grossolana (sabbia e scheletro), fine (limo) e
finissima (argilla). L‟argilla ha struttura lamellare con particelle di dimensioni inferiori ai 2 micron
ed elevate proprietà colloidali; la sua presenza conferisce al terreno la capacità di trattiene
l‟umidità e di adsorbire le sostanze concimanti, il suo eccesso comporta la tendenza al ristagno
dell‟acqua (che provoca asfissia), una forte coesione allo stato asciutto e una accentuata plasticità
allo stato umido. Si definiscono terreni argillosi quelli che hanno una percentuale di argilla
superiore al 15% (oltre il 20% i terreni sono compatti o pesanti); se la percentuale d‟argilla
oltrepassa il 35-37% il terreno diviene inadatto alla coltura. Il limo (dal latino limus: “fango, o
mota”) ha struttura intermedia tra la sabbia e l'argilla ( secondo la classificazione USDA le sue
particelle variano dai 2 ai 50 micron); limose sono le particelle depositate dalle piene dei fiumi
oppure trasportare dai venti. Il limo a differenza dell‟argilla non ha proprietà colloidali, né di
coesione e né di plasticità, suoi tenori troppo elevati pongono ai terreni problemi meccanici e di
fertilità chimica. La sabbia, con particelle che vanno dai 50 micron ai 2 millimetri, è frazione
sostanzialmente inerte del terreno da cui deriva macroporosità e scarsa capacità di ritenzione idrica.
Gli elevati tenori di sabbia comportano uno sgrondo troppo rapido dell'acqua, ma migliorano le
proprietà meccaniche, rendendo i terreni sciolti e facili alla lavorazione. Lo scheletro (sassi e pietre)
ha proprietà fisico-chimiche analoghe a quelle della sabbia ma ne accentua i difetti. Alla struttura
fisica si deve aggiungere la piccola percentuale di humus, che nei terreni di media fertilità varia
dall‟1,5 al 3%, e che rappresenta la componente viva e riproducibile (o perdibile) dei terreni agrari.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Tessitura (terreno)
Computando questi vari gradienti di limitazione ambientale si può andare dai ghiacci perenni e dai
deserti (dove gli uomini possono sopravvivere solo grazie a un‟economia basata sulla caccia), a
quelle aree di pascolo nomade dove gli uomini utilizzano forme di associazionismo binario (tundrerenne, deserti-dromedari) o trinomiale (steppe fredde-cavalli-pecore o steppe calde-cammellicapre); fino ad arrivare a quei territori coltivabili solo ricorrendo a impegnative opere manuali e
ingegneristiche, come i terreni terrazzati o quelli protetti da muretti elevati a secco (capaci di
113
frangere i venti, di catturare e ridistribuire il calore), o quelli resi coltivi da quei complessi sistemi
di canalizzazione che sono tipici delle oasi e di alcune aree predesertiche.
I qanat (dall'arabo )ق ناتo kariz (dal persiano )ك اري زsono un sistema di trasporto idrico usato per
fornire una fonte affidabile d'approvvigionamento d'acqua per insediamenti umani e per
l'irrigazione in ambienti caldi e aridi. La tecnologia su cui si basano fu sviluppata nell'antica Persia
e quindi diffusa ad altre culture: ad est fino in Cina, ad ovest fino al Marocco e alla penisola iberica.
Localmente sono noti come foggara (Libia ed Algeria), khettara (Marocco), kārīz o kārēz (Iran,
Afghanistan, Pakistan, Asia centrale). I qanat sono costituiti da una serie di cunicoli verticali simili
a pozzi, collegati da un canale sotterraneo in lieve pendenza. Questa tecnica permette all‟acqua di
falda posta a monte di arrivare in superficie senza necessità di pompaggio e senza la dispersione
dovuta all'evaporazione. La maggior parte dei qanat hanno percorsi di pochi chilometri e servono ad
irrigare delle valli limitrofe, ma alcuni trasportano l‟acqua per decine di chilometri fino a creare
delle oasi nel pieno deserto. I pozzi verticali di solito variano da 20 a 200 metri di profondità, anche
se in alcuni qanat nella provincia di Khorasan sono state realizzati pozzi verticali di 275 m. di
profondità. I pozzi sono utilizzati durante la costruzione per asportare il materiale di scavo, ma
consentono anche l‟aereazione per le necessarie opere di manutenzione. In Pakistan si stima che
fino al 20° secolo ci fossero più di 20.000 karizes. In Cina si è calcolato che la lunghezza totale dei
canali superasse i 5000 chilometri, ampissime erano anche le aree servite dalle foggare nei paesi del
Magreb, dove –da alcuni anni – sono in corso dei progetti di recupero. La parte antica di Palermo,
in Sicilia, era dotata di un sistema di qanat costruito durante il periodo arabo (827-1072) utile per
irrigare gli aranceti urbani. Molti di quei qanat sono ora mappati e alcuni possono essere visitati.
Nelle Americhe i qanat sono stati utilizzati nella regione Nazca in Perù e nel Cile settentrionale.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Qanat
Ci sono poi i fattori limitanti non ambientali; essi sono rappresentati dalle malattie, che in forma
pandemica possono colpire uomini, piante e animali, o la forte riduzione delle necessità alimentari
conseguente alla mortalità provocata dalle catastrofi naturali o dagli eccidi prodotti dalle guerre.
L‟insieme di questi fattori regressivi ha però solo frenato ma mai interrotto quel processo di
espansione agricola che si è iscritto nel codice comportamentale della parte stanziale (ormai
preponderante) della popolazione umana e che è tuttora in atto (oggi è il continente africano –dove
ancora sopravvivono terreni potenzialmente agricoli sfruttati in forme occasionali o tradizionali- ad
essere interessato da processi di trasformazione fondiaria spesso gestiti dalle multinazionali
dell‟agroindustria che, solitamente, fanno un‟agricoltura semplificata monocolturale). Vista in
questa ottica la ricerca di nuove terre da colonizzare non è quindi legata all‟aumento demografico
della popolazione (che casomai consegue e non precede), ma a una codificata norma di
comportamento acquisito.
Non ci sono, però, solo i limiti che derivano dalla scarsità ma anche quelli che dipendono dagli
eccessi. Le grandi aree pianeggianti situate a cavallo dell‟equatore (il bacino del Rio delle
Amazzoni e quello del fiume Congo, le zone pianeggianti di Sumatra o del Borneo) sono a tutt‟oggi
coperte da vaste e intrigate foreste perché le condizioni ambientali rendono queste aree, di fatto,
incoltivabili. In queste zone l‟alto livello di piovosità, coniugato con le elevate e costanti
114
temperature, assicura un tale lussureggiamento vegetale che, l‟impegno degli uomini e degli animali
domesticati per contrastarne la crescita e trasformare il suolo in terreno agrario, ne è risultato finora
inibito. Così che oggi (un tempo storico segnato dal primo significativo declino della nostra attuale
civiltà), distruggiamo le foreste senza neppure l‟attenuante di farlo per sostituirle con dei campi
coltivati o di pianificarne il recupero arboreo. Il riferimento ai campi coltivati e non ai pascoli per
allevamenti non è casuale, perché c‟è una differenza sostanziale di impegno e di progettualità
complessiva tra il primo e il secondo caso (sempre ammesso che questa azione abbia oggi un
senso). Per fare un pascolo è sufficiente tagliare gli alberi, bruciare il sottobosco, e poi lasciare ai
bovini o alle greggi di pecore o capre di fare il lavoro di contrasto al recupero forestale; per fare un
terreno agrario stabilizzato (dove la percentuale di humus sia autoriproducibile ) ci vogliono anni e
anni (gli agronomi ritengono adatto un periodo di un centinaio d‟anni) di attente e continuative
pratiche agricole. E il nostro è un tempo che purtroppo mostra di non avere tempo.
Diverso è il discorso dei limiti quando prendiamo in considerazione quei grandi sistemi fluviali che
si collocano a cavallo o a nord del Tropico del Cancro, come il corso superiore del Nilo, la pianura
tra il Tigri e l‟Eufrate, il corso inferiore dell‟Indo (tutti grandi fiumi che attraversano vaste aree
desertiche dove la pioggia e la vegetazione sono ridotti a minimi termini) e il vasto territorio situato
tra lo Yang Tze Kiang (Fiume Azzurro) e il Huang He (Fiume Giallo). Aree dove, per ragioni
climatiche e pedologiche, gli alberi erano quasi assenti, ma dove -prima che il lavoro degli uomini
ne modificasse l‟ambiente naturale disegnando i primi paesaggi agrari della storia- nelle zone umide
contigue a questi grandi fiumi, esisteva una folta vegetazione ripariale e palustre fatta di salici,
giunchi, fitti canneti e, in alcuni casi, papiri e palme non ancora domesticate. Questi erano territori
aperti, di clima temperato-caldo anche durante gli inverni e bagnati dall‟acqua di questi fiumi
(quindi non condizionati negativamente dalla variazione di temperature e piovosità stagionali);
straordinariamente fertili perché formati e costantemente arricchiti dagli apporti di limo fluviale;
coperti da un folto e intricato manto vegetale, a volte quasi impenetrabile, (si può vedere quello che
resta di quella tipica vegetazione in alcune zone dello Shatt al Arab, il fiume formato dalla
confluenza del Tigri con l‟Eufrate), ma non naturalmente ostili come quelli delle foreste equatoriali
(non c‟erano parassiti così pericolosi e neppure animali fluviali che potessero contendere all‟uomo
il vertice della catena alimentare (in Mesopotamia e nel corso superiore del Nilo non vivevano
coccodrilli e ippopotami e il gaviale indiano e il coccodrillo cinese non solo soliti attaccare l‟uomo)
e – in fondo- limitati (ossia vasti non più di quanto un ipotesi di colonizzazione potesse concepire).
Questi alluvi pianeggianti e fertili erano confinanti con quelle grandi aree collinose e montuose e di
accentuata biodiversità della Mezzaluna Fertile, del Belucistan indo-pakistano, degli altopiani del
Loess in Cina, dove - non per casualità- gli uomini da alcuni millenni avevano dato vita a quel
sistema di alleanze che aveva loro permesso di integrare l‟economia basata sulla sola caccia, pesca e
raccolta, con le prime esperienze di coltivazione e d‟allevamento. Ma quelli erano anche i territori
dove , nelle oasi bagnate da ricche fonti sorgive ricche di minerali disciolti nell‟acqua come Gerico
in Palestina, Al-Fayyum in Egitto, Jarmo nel Kurdistan iracheno o Mehrgarh in Pakistan, gli uomini
avevano iniziato a coltivare stabilmente la terra, dando vita ai primi insediamenti urbani della storia.
Perché quegli uomini –per loro esperienza diretta- avevano capito la legge più importante
dell‟agronomia: che l‟acqua –con le sue sostanze minerali dissolte in essa- è per le piante cibo che
nutre mentre le disseta.
115
Trasferire questo modello, nato sulle pendici delle arre collinose e sugli altopiani, confermato e
consolidato nelle oasi e nelle valli di acque sorgive, a quelle ampie terre limitrofe formate e
rifocillate dal costante fluire dei grandi fiumi, formate da estesi spazi incolti e disabitati, con terreni
profondi e piani, straordinari per procacità e ricchezza, era quindi una irrefrenabile tentazione
biologica (come specie); culturale (come esseri capaci di un pensiero e di una progettualità propria);
e colturale (come protagonisti di un‟alleanza simbiotica con quelle piante e quegli animali con cui
avevamo intrapreso un percorso comune di domesticazione e con gli schemi sociali già acquisiti). E
questo fecero gli uomini nel giro di alcuni secoli, segno evidente che gli strumenti e le forme di cui
si erano dotati sono stati particolarmente efficaci.
Specie se consideriamo i non pochi problemi agronomici che bisognava risolvere e la poca forza
lavoro su cui, all‟inizio, poteva contare la rete dei villaggi semistanziali (gli uomini non sapeva
ancora come reintegrare la fertilità della terra e quindi erano obbligati a coltivarla a rotazione) e i
relativamente pochi insediamenti “urbani” (quelli nati nelle oasi) legati a queste specifiche e
limitate condizioni ambientali. Il primo e più grave problema era l‟eccesso d‟acqua palustre e la
pericolosa aleatorietà ed irrequietezza dell‟acqua fluviale. Perché per colonizzare e rendere
coltivabili delle terre alluvionali bisogna prima risanare i terreni togliendo l‟acqua in eccesso, poi
irreggimentare i flussi dei fiumi (varianti a secondo delle stagioni) e infine essere capaci di far fluire
l‟acqua sui campi per irrigarli nelle stagioni del bisogno. C‟era, cioè, la necessità di costruire un
sistema doppio di canali che scorressero su piani sfalsati; perché –ovviamente- i canali di portata e
di sgrondo non possono essere gli stessi! Un sistema idrico è infatti come un sistema circolatorio
che si divide in arterioso e venoso, come un sistema respiratorio fatto di aria ossigenata che entra
nel corpo e aria carica di carbonio che ne esce. I sistemi circolatori sono per loro natura doppi e,
quindi, doppio è l‟impegno che gli uomini devono prestare per costruirli. Tutto questo nei primi
millenni legato al lavoro collettivo e volontaristico delle comunità, poi (dopo che la terra stessa era
diventato un “bene”) sotto le direttive di una figura nuova: l‟agrimensore (colui che è capace di fare
i calcoli, di misurare i piani di livello e di soprassedere i lavori di scavo), coadiuvato da una schiera
di braccianti (o di schiavi) disposti a realizzare quel duro lavoro (bisognava attendere ancora
qualche millennio prima che la carriola fosse inventata) con l‟aiuto di quegli animali adibiti a soma
(asini, onagri e bufali) e che si dimostrarono determinanti per trasportare la terra tolta dagli scavi e
usata per livellare i campi (che nessuna terra è piana come dovrebbe essere un campo coltivato e
deve essere una risaia). Un secondo fattore limitante era poi rappresentato dalla disponibilità di
attrezzi specifici, perché senza pale e vanghe (strumenti di taglio e di leva che permettono di
scavare e di caricare con un unico movimento) e senza buoni picconi (nei luoghi dove erano
necessari) il lavoro di scavo non è facile da realizzare. In questo caso l‟aiuto venne dai progressi
fatti per fare respirare più profondamente il fuoco, che -dopo essere stato utilizzato per trasformare
il fango in forme solide e contenitrici - cominciava ad essere utilizzato anche per la fusione delle
rocce contenenti metalli. Con questa nuova tecnologia gli uomini cominciarono a produrre quegli
strumenti in rame (poi in bronzo e poi in ferro) che furono determinanti per aumentare l‟efficienza
del lavoro e il cui primo utilizzo coincide con i primi processi di urbanizzazione. La colonizzazione
quindi marciò in contemporanea all‟elaborazione di una capacità di calcolo da applicare
all‟idraulica, all‟introduzione di importanti innovazioni tecnologiche (metallurgia e macchine per il
sollevamento idrico) e alla stipula di nuovi patti biologici con quegli animali che da allora si sono
116
abituati a portare il basto poggiato sulla schiena ( per un erbivoro non c‟è cosa più difficile da
accettare che un basto o un peso sulla schiena, perché l‟azione corrisponde all‟assalto di uno dei
suoi naturali predatori).
Così che le prime opere di colonizzazione furono realizzate completamente a braccia e bisognò
attendere ancora diversi secoli prima che gli agricoltori della Mesopotamia sperimentassero il giogo
frontale (applicato alla fronte e/o alle corna di un unico bue) e il giogo da garrese (formato da una
trave di legno arcuata ai due lati), che consente ad una coppia di buoi di esercitare il traino; e circa
tremila anni prima che gli uomini (gli etruschi?) sperimentassero la forma del giogo a collare da
applicare sopra le spalle e al petto dei cavalli (i cavalli con il giogo al garrese tendono a soffocare) e
prima che gli stessi cavalli fossero tanto robusti da poter essere aggiogati per tirare un aratro, che
altro non è che una elaborazione della forma del piccone su cui torneremo in seguito (il tiro del
carro montato su ruote è una cosa completamente diversa del tiro dell‟aratro piantato nel terreno).
Ora, apparentemente, quasi tutto era pronto per il grande “balzo in avanti”, quel passaggio epocale
con cui gli uomini e i loro alleati stavano per aprire le gabbie dei limiti biologici, estendere i propri
confini naturali, dare un nuovo e geometrico disegno visivo e biologico agli ambienti spontanei
della Terra. Quel “passaggio del Rubicone” che ci ha traghettato nell‟epoca delle città e
dell‟urbanizzazione, delle prime divinità antropomorfe, dei codici e della contabilità tenuta su
tavolette d‟argilla, del calcolo e interpretazione delle stelle, della letteratura e della matematica,
delle ziggurat e delle piramidi innalzate verso il cielo; quei tempi di imperi e di re, di processioni
sacerdotali e marce cadenzate di guerrieri, di contadini curvi sui campi, di artigiani seduti ai torni o
al lavoro sui magli, di donne chine sui telai o recluse nei loro lavori domestici, quei tempi di
schiavi, che siamo soliti chiamare: civiltà!
In realtà, niente di tutto quello che è successo si sarebbe potuto realizzare senza che la
domesticazione dell‟uomo non avesse portato, anche la nostra specie, a rivoluzionare il suo modo di
essere e il suo modo di vedere e di vedersi nel mondo. Un cambiamento così radicale da costruire
nuovi archetipi concettuali e comportamentali che sarebbero apparsi incomprensibili per le
generazioni precedenti: come l‟idea che il lavoro è un mezzo di scambio (quindi che si compra o si
vende), o che si possono disumanizzare le persone fino a costringerle a fare cose o lavori che altri
comandano loro di fare, o che lo status economico è ragione di divisione interna alla comunità (le
società precedenti erano generalmente più egualitarie e le divisioni non erano basate sul censo).
Ovviamente questi presupposti portarono gli uomini a dover rimodulare l‟organizzazione interna di
società che andavano sempre più ampliandosi e stratificandosi, compresi i sistemi relazionali e le
forme di rappresentanza. Il che conduce ad affermare che niente di tutto questo si sarebbe potuto
fare senza la nascita di quell‟entità economico-sociale, di quella specifica forma di ordinamento
giuridico-politico, che è lo Stato nelle sue varie espressioni (nel nostro caso: città stato e imperi); e
senza che gli uomini accettassero, ritenendola opportuna, questa grande trasformazione (che
evidentemente dovette apparire più appagante che il piatto di lenticchie scambiato da Esaù).
Perché gli uomini lo fecero? Sicuramente perché si erano create le giuste condizioni biologiche,
culturali e colturali. E perché accettarono di farlo senza scontri e contraddizioni apparenti?
(perlomeno quelli che si trovarono collocati negli strati sociali più bassi). Non sono un romantico
117
della vita pastorale, neppure credo nelle segrete virtù della vita nomade o randagia, ma passare dalla
società semistanziale dei villaggi con la proprietà collettiva, la sostanziale autonomia economica e
un sistema aperto di rappresentanza politica, alla rigidità sociale delle civiltà urbane ha comportato
una così significativa sottrazione dei mezzi e degli strumenti di autoproduzione, e quindi una tale
perdita della libertà individuale e/o famigliare, che c‟è ragione di chiedersi come tutto questo sia
stato possibile (in realtà abbiamo ben poche informazioni su questo determinante passaggio della
nostra storia). Evidentemente ci devono essere stati dei straordinari ed innovativi meccanismi di
cooptazione: la nascita di un grande apparato simbolico legato all‟idea dello Stato (capace di
trasmettere un forte senso d‟appartenenza); un epoca di guerre costanti e di bassa intensità
indirizzate verso i popoli limitrofi (capaci di assicurare un bottino di schiavi e di delineare
nell‟altro, nello “straniero”, il vero nemico da combattere e l‟apparente soggetto da indirizzare al
lavoro coatto); la nascita di nuove concezioni religiose che trasferissero il senso del “sacro” dalle
divinità ctonie e naturali alla figura del re o dell‟imperatore (capaci cioè di legittimare la forma
gerarchica dello Stato e nello stesso tempo di far pensare a tutti che tutti potessero appartenere al
suo “corpo mistico”, accedendone se se ne aveva vocazione o voglia).
Come gli uomini riuscirono a fare tutto questo? Qui la risposta è ancora più sfaccettata e complessa:
lo fecero estendendo i modelli agricoli già sperimentati su quei nuovi territori fluviali, tanto fecondi
in termini di produttività da consentire un sorprendente aumento dei surplus alimentari e quindi
della popolazione; lo fecero elaborando un sistema punitivo o coercitivo (che non a caso è una
delle funzioni principali delle Stato) o premiale (dove dei comportamenti consoni consentivano di
aspirare all‟elevazione di ceto economico e sociale); lo fecero, immaginando (o facendo
immaginare) una vita dopo la morte (l‟idea del paradiso e dell‟inferno è contemporanea a quella
dello Stato) che spostasse l‟orizzonte temporale dell‟esistenza e che facesse accettare agli uomini
cose altrimenti inaccettabili. Ed -essendo agli albori della nostra storia di società strutturate e
fondamentalmente moderne- lo fecero copiando il modello prefissato dalla Natura (meglio sarebbe
dire: adeguandosi alla). Adeguando cioè le società umane a quelle già sperimentate degli insetti
sociali (non per caso chiamati anche “politici”): con una prefissata struttura gerarchica, una
divisione in caste e una tendenziale rigidità del sistema, che sono forme di autotutela del modello.
In un insieme contestuale di atti e di pensieri da cui si evince che l‟idea dello Stato non è
conseguente alla nascita delle civiltà ma è funzione delle stesse. A questo modello archetipo
rimanda il fatto che molte strutture statuali fossero organizzate intorno a dei “fuchi”; come erano le
strutture palaziali incentrate sugli eunuchi o come sono ancora oggi alcune delle più importanti
religioni mondiali.
Tutto questo perché, vista la complessità insita nel passaggio, ritenere che esso sia avvenuto solo
grazie alle nostre capacità di elaborazione culturale, non è solamente fuorviante, è un grave errore
interpretativo. Diverso è il discorso se immaginiamo il passaggio come un percorso evolutivo, a cui
cultura e compartecipazione hanno apportato adattamenti e modifiche. Da qui il bisogno di
integrare il nostro comportamento di esseri pensanti a quello biologico di specie. Una specie che
avendo trovato un fertile pabulum di coltura, una ricca pastura, li ha considerati come un ambito
naturale di espansione e - in assenza di altri competitori naturali- li ha colonizzati adeguando se
stessa alle costanti leggi della vita. Acquisendo quella praxis biologica che tiene uniti gli insetti
sociali, ma aggiungendo a questa significative modifiche; grazie all‟apporto specificatamente
118
culturale, all‟accumulo di conoscenze acquisite, all‟ingegnosità e alla perspicacia tipicamente
umane, e –sopra a ogni cosa- ad un senso di “pietas” che integra l‟idea di comune
compartecipazione. Applicando poi tutto questo a uno schema di colonizzazione ambientale reso
fattibile da quelle alleanze simbiotiche già sperimentate insieme ai nostri alleati.
E‟ grazie a questo insieme di fattori che gli uomini (e i loro alleati) hanno potuto aprire i limiti di
specie e muovere alla colonizzazione di quelle terre ricche e vergini, progettando e arrivando a
realizzare la trasformazione completa (si può dire:rivoluzionaria) di quei ricchi ambienti naturali e
dello stesso modo di essere uomini. Suddividendo la Terra in appezzamenti commisurati alle
caratteristiche e alle necessità del lavoro (uno iugero romano corrispondeva ad una giornata di
aratura di una coppia di buoi): costruendo case (dove la famiglia di sangue ha sostituito la famiglia
allargata), ma anche stalle e magazzini (dove alloggiare gli strumenti o depositare i frutti del
lavoro); in un progressivo abbandono del concetto d‟uso condiviso a vantaggio dell‟idea di
proprietà, individuale, reale o ecclesiastica, dei mezzi di produzione (arrivando a premiare chi più
ne possedeva). Innalzando templi fatti per sfidare i secoli, spazi fisici che hanno sostituito quelli
naturali e che hanno sottratto, a favore di una casta sacerdotale, l‟idea della rappresentanza nella
sfera religiosa (non è il popolo il gregge di Dio e non sono i religiosi i loro pastori?); fondando
regni che altro non sono che la privatizzazione della sfera di rappresentanza politica a favore di una
aristocrazia, e dove spesso la figura del re e del grande sacerdote si sovrapponevano (l‟idea
monarchica è trasferita anche al post-umano: non è il Paradiso il regno dei cieli? E non è l‟inferno –
nella sue tante forme- il regno del peccato?). Un insieme di concetti e di opere tanto profonde ed
incisive da aver cambiato per sempre la nostra collocazione nel mondo naturale, con un
cambiamento così radicale da condurci a percepire noi stessi come una specie superiore alla Natura,
una specie immanente che è poi arrivata ad immaginare Dio (inteso in questo caso come una Entità
Creatrice) a sua immagine e somiglianza.
Società complesse che quando nacquero, nacquero già divise in caste di schiavi, operai
specializzati, guerrieri, dirigenti, giudici, sacerdoti e re. Dove i re avevano una funzione
trascendente che solo il “divino” poteva garantire e che solo i sacerdoti potevano assicurare, mentre
la gestioni dei conflitti esterni era demandata all‟esercito e quelli interni all‟applicazione della
“legge”. Tutto questo coniugato tendenzialmente solo al maschile, perché nella nostra specie solo il
maschio è in grado di assicurare una discendenza reale o divina “potenzialmente” illimitata. Solo il
maschio (ad imitazione delle regine degli emitteri e degli imenotteri) è in grado di produrre milioni
di gameti. Alla Dea Madre, la Terra, rimase demandata la rappresentazione della fecondità, che
l‟uomo –con i suo lavoro e in virtù dei suoi attrezzi agricoli- fertilizzava.
Un percorso che si è mosso con un movimento spiraloide, in circomvoluzioni paragonabili a quelle
di un viticcio vegetale, dove la produzione progressiva di surplus alimentari ha funzionato da
volano per un significativo incremento demografico, che a sua volta ha creato le fondamenta dei
processi d‟urbanizzazione, che sono stati la ragione e/o la conseguenza della prima consolidata
stratificazione sociale; in un processo complesso e poligenico che è sfociato nella nascita di quelle
prime civiltà che noi siamo soliti definire: “idrauliche” perché sorte proprio in virtù della volontà,
capacità e abilità degli uomini nel gestire l‟acqua (da qui il titolo del capitolo: acqua e potere).
119
Consentendo così al nuovo modello di occupazione d‟espandersi e trasformare quelle terre basse di
rive e di paludi in campi e giardini.
Ma queste similitudini non devono trarci in inganno, perché -in realtà- a parte l‟aggettivo
“idrauliche”, che sembra assimilarle, l‟ontogenesi agraria ( perché di questo parleremo d‟ora in poi:
non più di coltivazione o allevamento, ma di vero e proprio sistema agricolo) di queste civiltà è
stata profondamente diversa. Diversa non per gli aspetti sensoriali percepibili (il clima e i venti sono
grossolanamente paragonabili), o per l‟acqua d‟irrigazione (che una volta irreggimentata non ha in
nessuna di queste terre vallive una funzione limitante); neppure per la fertilità dei suoli, che è ricca
e abbondante; ma per la struttura stessa di quei suoli (come visto in agronomia la tessitura dei suoli
ha una funzione determinante) e nell‟utilizzo di differenti schemi d‟alleanze, portatori di capacità
specifiche nell‟adattarsi e sfruttare le diverse realtà ambientali.
Perché una cosa importante da notare di questo processo è come, partendo da sistemi agrari
tendenzialmente dissimili- le società degli uomini abbiano prodotto modelli e raggiunto obiettivi di
evoluzione dei sistemi economico-culturali, nonché socio-politici, pressoché paragonabili. Questo,
perlomeno, è‟ quello che è successo nelle quattro aree che possiamo considerare come principali
“madrine” della storia umana: quella cinese e quella indiana, quella l‟egiziana e quella
mesopotamica. Cercheremo ora di capire come e perché!
120
Le civiltà fluviali
Gli uomini hanno consegnato alla storia un‟infinità di tracce, molte delle quali perdute per sempre,
alcune considerate minori per il semplice fatto di aver lasciato sulla terra un‟impronta ecologica più
leggera di altre. All‟opposto, là dove gli uomini e i loro alleati hanno realizzato le grandi
trasformazioni, lì sono nate le civiltà che abbiamo ascritto alla nostra storia collettiva, tanto pesanti
da essere ancora capaci d‟influenzare il nostro vivere quotidiano. Cosa che equivale a dire che
culturalmente e colturalmente siamo figli di coloro che più sono stati capaci di manipolare a proprio
uso l‟ambiente naturale: paradigma che ha ben funzionato fino ad oggi (siamo più di sei miliardi, e
questo per una specie è un eccellente risultato), ma che in futuro saremo quasi sicuramente costretti
a riconsiderare. Nel raccontare l‟inizio di tutto questo c‟è bisogno però di fare alcune cesure:
tralasciando per il momento le culture del centro e sud America (le prime figlie di un ambiente
lacustre o tropicale, le seconde tipicamente andine, e tutte annichilite dall‟occupazione europea) e
soprassedendo anche su quelle nate nelle vaste pianure gangetiche, su quelle che si sono formate
lungo il corso del Mekong o sugli altipiani etiopici o lungo il bacino del fiume Niger –non per
sottostima, ma perché, altrimenti, i confini di questo scritto si allargherebbero a dismisura come
fanno i delta di alcuni fiumi- e provando a concentrare le attenzioni sul bacino dell‟Indo, sulla vasta
pianura cinese, sulla valle del Nilo ed su quelle terre iscritte dal corso del Tigri e quello
dell‟Eufrate; unanimemente considerate le più importanti fucine della nostra storia e del nostro
attuale modello produttivo e comportamentale (La nostra attuale situazione politica di democrazia
rappresentativa - definita dopo la prima guerra mondiale con la fine degli imperi centrali europei, e
consolidata dopo la seconda con la fase del post-colonialismo- ha invece altre matrici).
Per il tanto che si è scritto di questi ambiti sembra quasi velleitario che si possa aggiungere altre
parole, ma essendo questa una lettura agronomica degli eventi, cercherò di raccontare come – visto
da questo specifico angolo visuale- le storie degli uomini si aprano a nuove e curiose prospettive.
La civiltà cinese
Comincerò dalla civiltà cinese, quella più complessa e per alcuni versi intrigante, l‟unica che,
attraversando un corollario di quattro millenni, è stata capace di arrivare fino agli anni settanta del
secolo scorso praticamente invariata nei suoi architravi portanti. Anche l‟unica che discenda dalla
sovrapposizione e in parte dalla fusione di due distinti modelli agronomici generati da due distinte
biocenosi: la prima sviluppatasi lungo il corso medio ed inferiore del Fiume Giallo e basata sulla
coltivazione del miglio come simbionte principale (solo più tardi sostituito o integrato dal grano
arrivato dall‟Asia Centrale); l‟altra, più meridionale e anche più originale e autoctona, - nata lungo
il bacino del Fiume Azzurro- e basata sulla coltura del riso (di cui questa area è stata una dei
principali centri di domesticazione).
121
Sarà da questa biocenosi che partirò per questa descrizione, non perché la coltivazione del grano
sia meno importante (oggi la Cina –oltre a essere il più grande produttore mondiale di riso- lo è
anche di grano), ma perché il riso è la vera pianta madre della società cinese, quella che ne ha
forgiato i tratti sociali e culturali, quella che da questa parte dell‟Asia si è irradiata a tutte le terre
umide, calde o temperate, del mondo.
Questo racconto prende quindi inizio lungo il corso medio inferiore dello Yangtze Kiang (o Fiume
Azzurro nelle lingue latine), uno dei più imponenti fiumi del mondo (terzo o quarto per lunghezza a
seconda dei metodi di calcolo e dei vari nazionalismi), famoso per la sua irrequietezza, per le sue
piene irruenti e per le sue drammatiche inondazioni che, nel corso della storia millenaria della Cina,
hanno sparso morte e provocato spaventose distruzioni. Un problema che l‟attuale sistema politico
cinese ritiene di aver affrontato e/o risolto sbarrandone il corso con la costruzione dell‟imponente
diga delle Tre Gole (per le dimensioni e le difficoltà tecniche da superare, per il numero di persone
e di attività economiche da spostare, per l‟espansione agricola che la diga può garantire, per la
quantità di energia idroelettrica che la diga può fornire, c‟è in quest‟opera una determinazione
concettuale che solo una cultura politica “imperiale” era in grado da concepire).
Prima che gli uomini cercassero d‟irretirlo e di renderlo “utile” (un aggettivo che nessun fiume
contempla nel suo scorrere) il grande fiume scendeva dall‟altopiano del Tibet per dare vita ad un
continuum di grandi pianure alluvionali, caratterizzate da una quantità incredibile di laghi e di
paludi, che rappresentavano la sua naturale area di esondazione; per poi sfociare a mare con un
vasto e fertilissimo delta che oggi –da solo- è capace di generare una significativa percentuale del
Pil agricolo cinese. In questi antichi ambienti palustri e lacunari viveva la pianta originale del riso:
la generatrice; quella che -di questo particolare connubio tra acque e terra- aveva fatto il suo
ambiente naturale (alcuni studiosi ritengono che il riso ancestrale vivesse anche in Cambogia e
Thailandia).
E‟ però opportuno precisare che il riso non è una pianta lacustre, ma una pianta che può adattare
una parte del suo ciclo vitale in acque basse e temperate, perché ben sopporta la normale carenza
d‟ossigeno dei terreni temporaneamente inondati. Nelle zone del mondo caratterizzate da forti
precipitazioni stagionali il riso può nascere e crescere anche su terreni non sistemati a risaia e lo
stesso accade dove ci sono falde acquifere poco profonde; matura poi su terreni asciutti, seguendo
così -in modo artificioso- i cicli naturali delle piogge e delle piene dei fiumi. E‟ una graminacea a
ciclo breve: nasce, cresce e spiga nel giro di pochi mesi. Così nelle zone equatoriali il riso può
produrre anche tre raccolti all‟anno e questo per anni e anni di seguito, senza che il terreno si
stanchi di esserne coltivato. Un particolare effetto agronomico che dipende dal ciclo della acque
che, inondando, “mondano” e rigenerano il terreno. Una cosa che consente agli uomini di rendere
continuo il complesso lavoro di gestione delle risaie e –indirettamente- ne ammortizza i costi e la
fatica; rinserrando un legame tra lavoro e terra che non ha paragoni con nessuna altra coltura del
mondo.
Per questo la sfida lanciata dal riso per favorire la sua domesticazione presentava per i primi
agricoltori cinesi (e per gli altri popoli orientali) molti aspetti accattivanti! Come appena detto il riso
122
è una pianta che cresce anche senza l‟apporto di concimazioni (visto che l‟acqua trasportata dai
fiumi reintegra la fertilità dei terreni); una pianta che non stanca la terra dove la si coltiva e che
quindi può essere gestita anche a monocoltura ripetuta nel tempo; una pianta che produceva
cinquanta, settanta volte (oggi più di cento) il seme necessario per riseminarla (quindi una pianta
che ha una capacità produttiva quasi ineguagliata e un limitato bisogno di scorte sementiere); una
pianta con una capacità di fotosintetizzare energia come poche altre piante al mondo (due pugni di
riso a persona -50-70 grammi- sono il quantitativo necessario per preparare la base di un pasto); una
quantità che –seppur con gravi carenze aminoacidiche - assicura agli uomini un ottimo apporto di
calorie e di sostanze alimentari.
Non c‟è per produttività, adattamento e frugalità un altro cereale (più avanti parleremo della patata,
che però non è un cereale) al mondo che possa eguagliarlo, e –pare- che il riso sia ben cosciente di
queste sue caratteristiche virtù! I popoli che lo coltivano si sono piegati al giogo del suo potere:
hanno innalzato dighe per formare bacini da cui attingere risorse idriche per tutto l‟anno; hanno
scavato canali fino ad adagiare sulla terra con un sistema capillare di smistamento delle acque;
hanno terrazzato montagne e asciugato paludi, coprendo la terra di tanti piccoli laghi stagionali da
adibire alla sua coltivazione. Gli uomini, per risparmiare semi preziosi, hanno adottato la tecnica dei
semenzai che permette di ridurre di un decimo il fabbisogno della semina (in genere una ventina di
chili ad ettaro invece dei duecento), questo però comporta il trapianto delle piantine, fatto da curvi e
con l‟acqua fino alle ginocchia (e -come dicono i contadini a terra- la terra è bassa sotto i piedi);
hanno obbligato gli uomini e le donne al diserbo manuale, anch‟esso fatto nelle risaie allagate, che a
fine giornata lascia le persone distrutte e sporche. Per arrivare infine al momento della raccolta che
è in se uno dei più faticosi e difficili lavori agrari: perché la paglia del riso è dura, silicea, con foglie
come lamine taglienti, con un chicco iperprotetto rivestito di lolla coriacea e di pula difficile da
staccare. Per questo il riso –dopo essere stato mietuto e trebbiato (e la polvere di riso è
estremamente irritante)- va sbramato prima di essere pronto per cucinare. Chi produce manualmente
riso era ed è un popolo piegato sul fango della terra, un popolo che come pochi conosce il senso
della fatica, perché il riso è una pianta che richiede una dedizione assoluta, che non lascia tempi
morti, ma che ripaga con abbondanza questa dedizione. Se all‟epoca il prodotto di un ettaro di grano
bastava ai fabbisogni annuale di una famiglia, il prodotto di un ettaro di riso bastava a sfamare un
intero villaggio. Forse è questo potenziale produttivo in pectore che catturò l‟attenzione delle
popolazioni semistanziali che frequentavano quei paduli per le loro battute di caccia e pesca e per la
raccolta stagionale dei cereali selvatici; perché la pianta del riso (come pure le zizzanie – che altro
non sono che particolari specie di riso selvatico) hanno semi di una certo volume, cespi con tante
spighe, chicchi numerosi e di alto valore nutritivo; una ricchezza che poteva aumentare con un
semplice sforzo aggiuntivo, per esempio eliminando manualmente le piante sue concorrenti (è o non
è l‟agricoltura una intrinseca riduzione della biodiversità naturale?). Da qui alla coltivazione i passo
è facile da intuire, bisognava solo riprodurre artificialmente le condizioni di sommersione
temporanea e il gioco era fatto! Perché un tratto caratteristico della nostra specie è di non
accontentarsi di quello che ha, ma volere altre e più cose ed il riso in fase di domesticazione è stato
ben contento di solleticare questo nostro punto debole a suo vantaggio selettivo (oggi il riso
domestico è uno dei cereali egemoni dell‟agricoltura mondiale).
123
Questo desiderio congiunto si scontrava però con i vincoli pedologici, perché non tutti i terreni sono
adatti alla coltivazione del riso: non lo sono i terreni sabbiosi, dove l‟acqua percola; non lo sono
quelli troppo argillosi, dove il fango s‟agglomera e impantana (da questo deriva il vantaggio nel
bazzicare le risaie degli animali dalle unghie fesse come i bufali d‟acqua e i maiali o degli uccelli
con i piedi palmati). Lo sono i terreni alluvionali e profondi, ma questi terreni sono una parte
minimale della terra coltivabile. Lo possono essere i terreni limosi, sia d‟origine fluviale che eolica,
purché coltivati con le dovute attenzioni. Questi terreni sono ampliamente presenti nelle piane
alluvionali spesso mischiati con percentuali considerevoli d‟argilla (e sono quelli precocemente
coltivati). Questa tipologia di terreni la si riscontra anche nella Cina centrale, dove ci sono centinaia
di migliaia di ettari formati dalle particelle di loess trasportate dal vento. La colonizzazione di questi
terreni è stato il vero campo di sfida dell‟agricoltura cinese.
Il löss o loess (la parola è di origine tedesca) è un tipo di sedimento che viene raccolto e trasportato
dal vento e che ha dimensioni granulometriche simili a quelle del limo fluviale. Le aree di origine
del sedimento possono essere diverse e sono rappresentate dai deserti o dai terreni instabili di
origine glaciale. Ci sono depositi di löss che arrivano a coprire centinaia di chilometri quadrati di
superficie e che s‟innalzano sulle pianure con spessori fino a qualche centinaia di metri (come nel
caso del vasto Altopiano del Loess nella Cina centro-settentrionale, e sembra incredibile che il
vento abbia potuto fare tutto questo). Questi estesi depositi inconsolidati sono soggetti a una forte
erosione pluviale e fluviale ( il Fiume Giallo prende il nome dall‟aver attraversato e eroso
l‟Altopiano). Ci sono anche altri depositi famosi, come i suoli neri di steppa (Chernozem, Mollisol)
della Russia europea meridionale, quelli della Siberia sudoccidentale e quelli delle Grandi Pianure
nordamericane; questi sono terreni estremamente fertili perché alternano gli strati di löss a veri e
propri e suoli. I primi si accumulano durante i periodi glaciali, secchi e ventosi, i secondi si
sviluppano durante i periodi interglaciali con clima caldo e umido. La variabilità di questi suoli (che
vanno da quelli neri ucraini e quelli gialli cinesi) dipende da quest‟alternanza, dall‟area di asporto
delle particelle, dalla loro granulometria che varia tra un minimo paragonabile a quello dell‟argilla
fino ad un massimo quasi sabbioso, e dalla forza e capacità dei venti nel trasportare le particelle.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Löss
La tessitura e la granulometria sono però solo uno degli aspetti dei terreni agrari, c‟è da considerare
anche la porosità (tanto più piccole sono le particelle e tanto più alta risulta la quota di spazi liberi
per unità di volume; la sabbia ha il 30% di vuoto, il limo oltre il 40%, l‟argilla oltre il 50%, il che
cambia il peso dei suoli); la plasticità (ossia la proprietà di lasciarsi modellare, che nella sabbia è
nulla e nel limo bassa); la coesione (che vuol dire la capacità delle particelle del terreno di restare
unite per azione di forze interne); la permeabilità; l‟evaporabilità, la capacità di imbibizione e la
capillarità. Tutto un‟insieme di cose che danno il senso di quanto sia complesso un terreno agrario e
difficile la sua gestione.
Tutto questo per dire che un terreno limoso è un terreno potenzialmente fertile solo se pianeggiante
(perché se inclinato, a causa della sua scarsa coesione e della sua instabilità, l‟acqua lo incide
profondamente in grossi calanchi) e se situato in zone di alta e/o costante piovosità (perché ha una
bassa capacità di trattenere l‟acqua capillare e una volta asciutto forma una crosta sulla superficie
124
come fa il fango – ossia il limo- delle pozzanghere). Un terreno che quindi si sarebbe prestato
ottimamente per lo sviluppo della coltivazione del riso solo con l‟ausilio di una vera e propria
scienza idraulica.
E questo hanno fatto i contadini cinesi e dell‟estremo oriente: hanno imbrigliato l‟acqua per portarla
alle risaie e hanno terrazzato i pendii per risalire le curve di livello, organizzando un sistema
spettacolare di impluvio e di sgrondo; disegnando così alcuni dei paesaggi agrari più straordinari
della Terra (per stupirsi basta digitare: terrazzamenti a risaia, ed ammirare questi geniali opere delle
civiltà contadine orientali).
Questi accorgimenti hanno consentito al riso di estendere il suo areale di coltivazione verso i paesi
meridionali del continente asiatico (tutta la parte continentale dell‟Estremo Oriente compresa
l‟India, tutte le grandi isole del Pacifico e quelle degli arcipelaghi delle Filippine e dell‟Indonesia) e
di risalire di diversi gradi di latitudine verso i paesi del nord (Corea e Giappone): per seguire poi le
armate di Alessandro fino alla Mesopotamia e all‟Egitto, arrivando a colonizzare le zone umide e
temperate del sud Europa (valle del Po, del Rodano, dei fiumi spagnoli e alcune di quelli balcanici,
dove il riso è giunto dopo all‟anno mille), e dall‟Europa partire alla conquista di tutto il mondo.
Nelle aree temperate il riso viene però coltivato solo nei mesi estivi: seminato a primavera inoltrata
–quando le temperature si sono ormai stabilizzate - e raccolto alla fine dell‟estate (giusto in tempo
perché alcuni campi possano essere seminati a grano). Queste sono zone dove l‟areale del riso e
quello del grano si sovrappongono e questo permette di aumentare e diversificare i raccolti di
cereali. Ovviamente lo stesso avviene specularmente nell‟emisfero sud.
A funzionare da anello di congiunzione tra le due diverse biocenosi cinesi furono le provincie
contigue dell‟Hubei –nella parte situata a nord del Fiume Azzurro- e dell‟Henan – nella parte che si
trova a sud del Fiume Giallo -dopo che questi ha ricevuto le acque del Wei e ha terminato di
attraversare gli Altopiani del Loess (luogo d‟origine delle popolazioni neolitiche dedite alla
coltivazione del miglio). Terre con un‟enorme potenziale che per manifestarsi aveva bisogno di una
nuova sovrastruttura politica. Un‟entità capace di realizzare le infrastrutture necessarie per
controllare l‟acqua in eccesso (un prerequisito), e farla arrivare costante nei mesi asciutti (che è il
requisito obbligatori per mettere a coltura delle risaie). Non è quindi un caso se in queste provincie
nacque il primo centro di potere politico e amministrativo; quella dinastia Xia che fu la prima
monarchia ereditaria cinese e che regnò grossomodo tra il 2200 e il 1700 avanti Cristo. Una
monarchia che negli annali successivi fu preceduta da un epoca immaginifica chiamata: dei Tre
Augusti e dei Cinque Imperatori; sovrani mitologici e mitopoietici (forse derivati dalla fusione tra
mito e realtà storica) a cui fu attribuita la nascita dell‟agricoltura, dell‟allevamento, della
metallurgia, del calcolo, etc. .
E qui entro in punta di piedi in un campo lontano dai miei studi che ritengo però vada –anche se
superficialmente- esplorato (altrimenti a cosa vale l‟aver sostenuto che nella nostra elaborazione
culturale e nei nostri comportamenti aggregativi e organizzativi c‟è anche una componente
evoluzionistica che ci accomuna agli insetti sociali?). Perché se la società cinese voleva ampliare la
sua base produttiva –e sfruttare quello che potenzialmente era sfruttabile- doveva superare i limiti
dei localismi che generano endemismi, e dotarsi di una sovrastruttura capace di pianificare un
125
ampio ridisegno territoriale, e –visto che nella società cinese il ricorso alla schiavitù è sempre stato
limitato- doveva fare tutto questo dotandosi di operai da mettere a corvée stagionali (probabilmente
scambiando il loro lavoro con l‟abbattimento di una tassazione fondiaria …. le tasse !!! aspetto
intrinsecamente legato all‟idea della Stato). Questo sviluppo delle funzioni statuali fu reso possibile
dall‟organizzarsi di regni che dopo essersi contrapposti per oltre 1500 anni furono riuniti nel 221
a.C. da Qin Shi Huang (letteralmente "Primo Imperatore della dinastia Qin") che fu il primo
sovrano storico a fregiarsi del titolo di imperatore. Sempre successivamente anche la sua figura
storica fu ammantata da valori simbolici, tanto che la stessa parola "Cina" viene fatta generalmente
risalire a "Qin" o "Ch'in". (Solo per tratteggiare meglio il personaggio occorre dire che fu lui a
commissionare l'imponente esercito di terracotta per la sua tomba e a dare inizio alla costruzione
della muraglia cinese).
Al vertice dello Stato c‟era ora una figura a cui atteneva la funzione di tramite tra la sfera
dell‟immanente e la realtà terrena; figura compenetrata profondamente con la società cinese, dove
il trascendente non ha mai avuto lo stesso peso di altre civiltà e dove non si aspettava la piena
“benefica” che rifocillava le campagne, ma si faceva ogni cosa si potesse fare per pianificarla (il
Gran Canale Jing-Hang o Canale Imperiale con i suoi 1.794 chilometri è il canale o fiume artificiale
più lungo del mondo e il manufatto più imponente mai realizzato dagli uomini). Un vertice
semidivino che governava una società che non ha mai elaborato l‟idea di un Dio creatore esterno
alla Terra, così come non ha mai elaborato il pensiero di una vita dopo la morte e la conseguente
l‟idea punitiva o premiale dell‟inferno ed del paradiso extraterreni (questo fino all‟arrivo del
Buddismo).
Nel suo “Sociologia della Religione, il Confucianesimo e il Taoismo” Max Weber ha scritto: « In
luogo di un Dio creatore sopramondano si considerava come immagine ultima e suprema quella di
un essere sopradivino, impersonale, sempre identico a se stesso, eterno nel tempo …. La potenza
celeste "non parlava" agli uomini, ma si rivelava attraverso il governo terreno, e quindi nell'ordine
stabile della natura e della tradizione, che era parte dell'ordine cosmico …. ».
Così nella sua originale ontogenesi la società cinese si è costituita mettendo al suo apice una figura
semidivina che governava una società fatta essenzialmente di contadini e di piccoli artigiani tramite
un esteso apparato amministrativo (una presenza strutturata su vari livelli, la cui esistenza era
giustificata dalla complessità nel regolare l‟alta produttività intrinseca dei territori legata alla ottima
fertilità degli stessi e la densità abitativa che di conseguenza ne derivava). Una burocrazia
ubiquitaria così potente da contrastare e limitare i poteri del ceto sacerdotale e di quello militare
(non è per caso se in epoca storica un solo generale vittorioso sia stato nominato imperatore).
Ecco allora il “Figlio del Cielo”, ammantato di un aurea trans-umana, forzato a vivere in una “Città
Proibita” (un modo per trasmette il senso del vuoto “pneumatico” che doveva circondare la sua
figura), accudito e controllato da una corte di eunuchi (verso la fine della dinastia Ming sembra che
gli eunuchi cinesi fossero più di 100.000), governare l‟Impero Celeste tramite un vasto apparato
burocratico autoreferenziale, principale custode di un‟etica comportamentale che si richiamava alle
dottrine di Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) e dei suoi seguaci (la sua principale forma di
legittimazione).
126
La civiltà dell’Indo
Esattamente l‟opposto di quanto successe alla civiltà cinese quella indiana (ossia quella nata nella
pianura formata dall‟Indo e dei suoi poderosi affluenti e che ha raggiunto il suo apogeo tra il 2600
a.C. e il 1500 a. C.) è forse -delle quattro che stiamo prendendo in considerazione- la civiltà più
emblematica; non fosse altro per il fatto che è scomparsa dalla storia per oltre tremila anni e che le
sue tracce sepolte sono state rinvenute meno di un secolo fa.
Di certo non deve essere stato facile far nascere una civiltà lungo il corso dell‟Indo; il grande fiume
è irruento, indomito, ha un flusso che -sotto l‟influenza dei monsoni- è anarchico e con piene
feroci. Sfocia al mare con un grande delta che ha molti rami chiusi; questo perché la portata delle
sue acque si riduce lungo la via in ragione della forte evaporazione e a causa dei prelievi fatti
attualmente per irrigare i campi.
Eppure il fiume con i suoi affluenti forma una delle pianure alluvionali più fertili della Terra, madre
della civiltà più vasta territorialmente tra le quattro che stiamo esaminando. Questo potenziale lo
avevano capito, intorno alla metà del VII millennio a.C., le popolazioni che in forma semistanziale
vivevano nel Belucistan (ad ovest della valle dell'Indo), coltivando in forma seminomade grano e
leguminose, allevando bovini e ovi-caprini, raccogliendo la bambagia delle piante selvatiche del
cotone.
Lasciare le colline e discendere verso le grandi pianure, dando vita ad una agricoltura stanziale, per
quelle popolazioni ha comportato un cambiamento radicale degli stili di vita e un conseguente
aumento produttivo e demografico. Da questo nacque il vasto tessuto abitativo di questa civiltà (ad
oggi conosciamo più di mille siti archeologici), fatto di piccoli villaggi agricoli dove gli abitanti
vivevano coltivando un gran numero di specie vegetali (piselli, sesamo, datteri, ceci, lenticchie) e
allevavano animali (zebù e bufali e galline). Intorno al 4000 a.C. si formarono i primi agglomerati
proto urbani, poi - intorno al 2600 a.C. – da alcuni di questi- nacquero vere e proprie città (le più
importanti sono Harappa e Mohenjo-daro con una popolazione di 30-40.000 abitanti), arricchite da
una florida agricoltura, da un vivace artigianato e da ampi scambi commerciali con i paesi che si
affacciavano sull‟Oceano Indiano e con le altre potenze economiche del mondo antico.
Se la situazione pedologica era favorevole: il suolo quasi sempre sabbioso -morbido e profondo-,
concimato dal limo sottratto a monte; lo era meno la situazione climatica, perché in alcune stagioni
le temperature arrivavano a picchi molto elevati. Questo però voleva dire che, avendo sempre a
disposizione l‟acqua di irrigazione, quelle terre semidesertiche si potevano trasformare in giardini
tropicali.
In questo c‟è tutta la differenza con la situazione cinese: nella grande pianura tra i due fiumi i
terreni limosi e argillosi erano pedologicamente predisposti a trattenere l‟acqua, il vero problema
era –casomai- controllarne le occasionali inondazioni (non è un caso che l‟animale totemico cinese
sia il drago: visto come un fiume che scorre). Nella valle dell‟Indo i terreni erano tendenzialmente
sabbiosi e gli apporti limosi erano in grado solo in parte di correggerne la struttura. Questo aspetto
127
complicava non poco la situazione agricola, perché rendeva difficile predisporre un efficace sistema
d‟irrigazione: infatti se è vero che nei terreni sabbiosi è facile scavare canali, è pur vero che questi
canali disperdono troppa acqua lungo il loro percorso; che la sabbia non serve per costruire piccoli
sbarramenti o solide dighe (non la si può compattare), e che il terreno sabbioso consente
l‟irrigazione a scorrimento (l‟unica allora possibile) solo per tratti brevi, visto che l‟acqua percola
troppo velocemente (provate ad irrigare a scorrimento un terreno tendenzialmente sabbioso e ne
vedrete gli effetti). Programmare poi un sistema di costante captazione dell‟acqua, da fiumi con un
flusso influenzato dai monsoni, era (ed è) molto complesso, perché la portata di quei fiumi può
fluttuare considerevolmente di anno in anno. Quindi dove era opportuno tracciare il confine tra il
tendenziale e il potenziale? Fino a dove spingere il progetto di ridisegno territoriale? Di quale
ampiezza e di quale lunghezza doveva essere il canale? Decisioni difficili da prendere e progetti
difficili da realizzare. Ci troviamo quindi di fronte a terre potenzialmente fertilissime ma la cui
produttività è stata limitata dalla difficoltà di pianificare il costante ricorso alla necessaria acqua
d‟irrigazione.
Per questo la civiltà dell‟Indo era spalmata su un ampio territorio, perché i limiti pedo-climatici la
obbligavano a svilupparsi solo sulle aree limitrofe ai fiumi. Dice Vandhana Shiva che i canali del
Pungiab portassero l‟acqua solo per quattro o cinque mesi all‟anno e che per i restanti mesi fossero
asciutti, e –date le condizioni- questo non sorprende (solo dopo la loro impermeabilizzazione si
sono potuti progettare e realizzare canali più ampi e più lunghi, riforniti costantemente grazie a
sistemi di pompaggio). A questo c‟è da aggiungere che probabilmente la civiltà dell‟Indo poteva
contare su strumenti di sollevamento idraulico molto semplici, perché la gestione e
l‟ammortamento di quelli più complessi (tipo le norie) era troppo onerosa o troppo complicata,
come complicata era la colonizzazione del delta (per gli strumenti tecnici allora a disposizione).
Questi aspetti condizionavano non poco la produzione agricola; c‟era –probabilmenteun‟agricoltura intensiva dove era possibile un facile accesso all‟acqua, mentre sul resto del territorio
si provvedeva alla semina nel periodo delle piogge e quindi a una sola raccolta stagionale. Possiamo
immaginare un‟agricoltura ripale dove si coltivava il riso (arrivato probabilmente dalla Cina intorno
al tremila a.C. ), le verdure e la canna da zucchero (che è una pianta poliennale); poi un‟agricoltura
stagionale con i campi a orzo e grano (la cui produttività era condizionata negativamente dalla
temperature), sorgo e cotone (la pianta tessile più importante del mondo). Queste specie però
dovevano essere coltivate mettendo le terre a riposo biennale, perché tutte -per ragioni diverseesauriscono rapidamente la fertilità dei terreni. La loro coltivazione dava un significativo contributo
nel soddisfare i fabbisogni alimentari (anche se il sorgo –che è un cereale che ben si adatta ai climi
caldi asciutti- ha un uso limitato per l‟alimentazione umana) ma era anche la base di una “industria”
di trasformazione. Stiamo quindi parlando di una civiltà basata in parte su di agricoltura intensiva e
in parte su un‟agricoltura semiestensiva stagionale, poi sulla lavorazione, trasformazione e vendita
di alcuni beni derivati dai prodotti agricoli come il tessuto di cotone o lo zucchero raffinato (a cui va
aggiunta la lavorazione e commercializzazione delle pietre dure e dei metalli scavati nelle miniere
afgane). Le ricadute sociali e economiche di questo modello sono evidenti, perché è probabile che
questa manodopera stagionale venisse proprio da coloro che si occupavano della produzione
artigianale; il che suggerisce l‟esistenza una piccola-media proprietà -dove la famiglia contadina
assommava varie funzioni- e/o una certa mobilità sociale.
128
Queste ipotesi sono però difficili da verificare non fosse altro perché molti siti sono completamente
coperti di fango (a Mohenjo-daro in alcuni punti lo spessore supera i sette metri di altezza). In realtà
ci mancano molti aspetti essenziali della cultura materiale, della tipologia della proprietà terriera,
della stratificazione sociale, per avere idee esaustive della situazione. Una mancanza di conoscenze
che dipende anche dal fatto che la scrittura non sia stata ancora decifrata e che i testi pervenutici –
forse- non rappresentano neanche una forma di scrittura ma solo segni simbolici. L‟unica cosa certa
è che ci rimane una mole incredibili di sigilli e una cultura immateriale che –forse- ha lasciato in
dote alle popolazioni successive una complessa cosmogonia, una separazione in caste e –ipotesi
azzardata- un particolare atteggiamento favorevole al matriarcato politico (cosa che ha permesso ai
paesi del subcontinente indiano di eleggere -in questi ultimi decenni democratici- varie donne ai
vertici di governo).
Intanto nella valle dell‟Indo dal 1800 a.C. cominciarono ad avvertirsi i primi cenni di una crisi
urbana che porterà ad un progressivo abbandono delle città, ad un graduale processo di
riruralizzazione e poi al totale decadimento di questa civiltà. Per alcuni studiosi questo è dipeso da
un radicale cambiamento climatico che modificò la portata e l‟ampiezza del Ghaggar-Hakra (il
Ghaggar-Hakra è oggi un fiume stagionale che scorre a destra dell‟Indo e che porta acqua solo nei
mesi del monsone, identificabile con il mitico fiume Sarasvati citato nel Rig Veda); per altri studiosi
la colpa va invece ricercata in un violento terremoto che deviò verso il Gange una parte degli
affluenti che prima s‟immettevano nell‟Indo.
Gli storici che preferiscono il catastrofismo umano a quello ambientale pensano invece che la civiltà
dell‟Indo collassò per colpa dell'invasione degli Arii (la immaginifica popolazione nomade
indoeuropea proveniente dai rilievi dell‟Asia Centrale) che occupando la regione e distruggendo le
strutture idrauliche e sociali portò al collasso –violento- dell‟intera società (come se anche la loro
invasione non possa essere dipesa da un mutamento climatico che potrebbe aver modificato le
tradizionali aree di pascolo di questi popoli).
Sono però convinto che le civiltà siano le vere artefici delle loro vittorie e delle loro sconfitte: una
società giovane e vivace è in grado di affrontare e superare molte sfide, tanto quanto una società in
senescenza o indebolita è portata, irrimediabilmente, a decadere. Quindi sono più propenso a
credere che il collasso politico, economico, sociale e culturale della civiltà dell‟Indo sia da cercare
in una serie di gravi problematiche interne a cui le problematiche esterne hanno fatto da detonatore.
Tra le tante ipotesi che possiamo formulare ne individuo una, che ritengo sia la più sospettabile:
quelle società non sono state in grado di dotarsi di un potere decisionale che fosse legittimato dalla
popolazione a prendere decisioni sovra territoriali (il che equivale a dire che l‟oblio è arrivato per
eccesso di localismo). Da Wikipedia prendo questo scritto che mi sembra indicativo: al contrario
delle contemporanee civiltà della Mesopotamia e dell'Egitto, non sembrano esistere tracce di un
potere centrale di tipo regale o sacerdotale e sembrano mancare tracce di eserciti o di opere
difensive: le mura presenti in alcuni casi e la sopraelevazione della cosiddetta cittadella sembrano
dovuti alla necessità di proteggersi dalle alluvioni dei fiumi piuttosto che dai nemici esterni.
Estratto dalla voce: La civiltà dell‟Indo
129
Credo che questo sia un aspetto importante da mettere a fuoco. E‟ quindi l‟assenza di una forma
statuale centralista che ha portato al dissolvimento di questa civiltà? In realtà penso che esistano
molte forme statuali, così come esistono molti modelli produttivi che riflettono le condizioni
ambientali, pedologiche e agronomiche dei vari territori; nel nostro caso specifico stiamo
probabilmente parlando di una società di artigiani e piccoli produttori agricoli –aggregati in villaggi
o piccole città, in grado di produrre surplus specie nei settori alimentari, con un modello agricolo
“leggero”. Villaggi o piccoli agglomerati urbani –forse- usi a prendere decisioni nell‟agorà
comunitaria (deve essere intesa in questo modo la “cittadella” di queste “città” che contavano solo
30-40.000 abitanti?). Un ambiente dove, visto le condizione pedoclimatiche progettare e realizzare
grandi opere strutturali era difficile, come lo era reintegrare la fertilità dei terreni. Se poi il collasso
sia stato provocato da un‟ingorda pressione produttiva, con semine ripetute che hanno colpito la
fertilità dei terreni e quindi diminuito le rese, oppure da una crisi climatica; da una situazione di
disordini interni per mancanza di un potere centralistico o da un‟invasione distruttiva proveniente
dall‟esterno, ad oggi non siamo in grado di saperlo. Una cosa sembra però probabile: la civiltà
dell‟Indo è stata in grado di brillare per oltre mille anni senza re, senza imperatori e senza grandi
sacerdoti, e anche senza graffi insostenibili a un ambiente naturale che da più di un secolo è tornato
a svolgere le sue funzioni di “granaio” del subcontinente indiano (le pompe elettriche di
sollevamento e i canali realizzati in cemento hanno indubbiamente favorito questa rinascita
produttiva).
La civiltà egizia
A questa civiltà “leggera” e scomparsa da secoli si contrappone la civiltà più longeva della storia
umana: quella egizia; capace di lasciare -a sua indelebile memoria- alcuni dei manufatti più
sorprendenti mai realizzati dalla nostra specie e capace di immaginare un mondo binario dove la
vita e la morte si sovrapponevano, compenetrandosi, e dove un essere divino di una dinastia divina
ne governava le sorti. Nata lungo i mille e più chilometri della stretta valle del Nilo –nella parte che
dall‟ultima cataratta del fiume arriva fino al mare Mediterraneo- tagliando in perpendicolare uno dei
deserti meno ospitali della Terra, la civiltà egiziana è frutto del lavoro costante e continuo di 250300 generazioni di contadini, capaci di costruire un ambiente dove nulla è naturale e tutto quello
che si vede – a parte il deserto e il fiume- è colturale e culturale: ossia frutto del lavoro e del
pensiero umano.
"Salute a te, o Nilo che sei uscito dalla terra, che sei venuto per far vivere l‟Egitto... Quando la
piena comincia ad innalzarsi, il paese è in giubilo e tutti attendono con gioia." Questo era un inno
dedicato al Nilo quando intorno alla metà di luglio la stella Sothis o Sirio cominciava ad apparire
bassa sull‟orizzonte del deserto orientale. L‟invocazione non era un appello affinché avvenisse di
nuovo questo straordinario fenomeno naturale (cosa su cui -pur non conoscendone le cause- non si
dubitava), quanto una preghiera alla sua entità e alla sua auspicata pacatezza (la piena, che
raggiungeva il massimo livello nei primi giorni di settembre, poteva anche essere distruttiva). Se le
130
acque si fossero innalzate copiose molta terra poteva esser messa a coltura, se l‟inondazione fosse
stata scarsa la siccità si sarebbe potuta trasformare in carestia.
Nilometro è il nome dato alle strutture – solitamente scale o pozzi – usate nell'antico Egitto per
misurare l'altezza delle piene del fiume Nilo e poter così prevedere gli andamenti dei raccolti.
Lo scopo originario era ricavare informazioni sul reddito delle attività agricole – che si supponeva
fosse proporzionato all'entità delle piene – in modo da operare una tassazione adeguata. Visto
questo scopo, si può affermare che il nilometro sia l'antesignano del moderno redditometro. I
nilometri più famosi si trovano nell'isola Elefantina (presso Assuan), e nell'isola della Roda (Il
Cairo).
Elaborato da Wikipedia alla voce: Nilometro
Verrebbe da dire che dall‟acqua e dal fango veniva il benessere del popolo e la ricchezza della
nazione!
La civiltà egizia mosse i suoi primi passi intorno al quattromila a.C. quando le popolazioni locali
iniziarono a coltivare e allevare -in quella che allora era una valle selvaggia e paludosa- i semi e gli
animali domesticati nei millenni precedenti dai natufiani della limitrofa Mezzaluna Fertile ( in un
precedente capitolo avevo diviso questa biocenosi in una parte settentrionale e in una meridionale:
la nostra!). Era un transfert culturale e colturale facile da realizzare: i terreni leggeri e sabbiosi
erano simili e l‟ambiente naturale e il clima paragonabili a quelli della valle del Giordano, dove
quel modello di biocenosi era probabilmente nato. Solo che nella valle del Nilo le popolazioni locali
(o forse arrivate dalla Palestina) avevano di fronte una Gerico all‟ennesima potenza. Probabilmente
fu questa sfida - che richiedeva strutture organizzative e di pianificazione territoriale più complesse
di quelli in uso ai villaggi seminomadi o nelle proto-città - che portò queste popolazioni ad
associarsi in gruppi più consistenti, divenuti nel tempo dei veri e propri piccoli regni. Questi piccoli
regni si combatterono e si allearono tra loro per oltre mille anni; da queste incessanti lotte
sopravvissero due sole entità (l‟Alto e il Basso Egitto) che Narmer (il re dell‟Alto Egitto e primo
Faraone della prima dinastia) unificò intorno al 3100 a.C. sotto il suo controllo. È anche possibile
che il mitico Re Scorpione (tanto per dare al faraone un‟ascendenza trans-umana) sia da identificare
con Narmer.
Le forme di aggregazione sono simili a quelle descritte per la società cinese, ma con una differenza
sostanziale: mentre la società cinese era governata da una complessa burocrazia in quella egizia
(che la precedette di mille anni) era la religione ad avere un ruolo preponderante (il Faraone –come
essere divino- ne era l‟espressione più alta). Eccoci allora di fronte ad una società dove il divino e
l‟umano si intersecavano costantemente, con grandi pulsioni escatologiche, e un intenso politeismo
basato su un pantheon zoomorfo o chimere zoo-antropomorfe; mentre il mondo vegetale ricorreva
potente nel disegno architettonico degli edifici (le colonne come palme o come fasci di papiri, i
capitelli come loto). Un‟altra similitudine con la civiltà cinese era il lavoro di corvè che i contadini
avevano l‟obbligo di prestare. E‟ un aspetto interessante e relativamente poco studiato; è infatti
probabile che questo lavoro coatto coincidesse con i mesi dell‟inondazione e che fosse utilizzato per
realizzare delle opere di servizio pubblico (anche le piramidi?). Questo potrebbe spiegare come la
131
società egizia trovasse la forza lavoro necessaria: durante i mesi dell‟inondazione si lasciava il
lavoro sui campi e si organizzavano campi di lavoro.
Non è questo il contesto per discutere di religione egizia, certo è che tra le civiltà antiche poche
sembrano eguagliare con tanta intensità l‟idea di accompagnare la morte di uomini e animali verso
una nuova vita, verso un oltre enigmatico e sconosciuto.
In un territorio dove la pioggia è un evento assai raro, e dove la sua quantità è irrisoria, una cosa è
però certa: la sola inondazione estiva non era sufficiente ad assicurare degli abbondanti raccolti. La
piena del Nilo –che andava dalla fine di giugno a una buona parte di settembre- svolgeva la sua
principale funzione nel rinnovare la fertilità dei terreni non nell‟irrigare i campi. Il grano, l‟orzo, le
leguminose invernali - seminati in autunno subito dopo la piena e dopo aver mandato le greggi ad
erpicare i campi con i loro zoccoli- a giugno erano già trebbiati e ammassati nei granai; così come le
leguminose primaverili e il lino per la tessitura. Il grande calore estivo e la piena del fiume
trovavano dei campi in riposo colturale e in attesa di essere rifocillati. Questo significa che per gli
altri mesi (specie con quella tipologia di terreni sabbiosi) c‟era il problema di poter disporre di
sistemi d‟irrigazione.
Nell'antichità, per abbeverare gli animali e irrigare i campi si rese necessario mettere a punto delle
tecniche per il sollevamento dell'acqua dal sottosuolo o da fiumi e torrenti che si trovavano ad un
livello inferiore rispetto a quello di utilizzo. Alcune di queste macchine, pur avendo una storia
millenaria, sono ancora oggi in uso in molti paesi del terzo mondo.
Lo shaduf è uno strumento semplice e ingegnoso, adottato a partire dal II millennio a.C. dalle
popolazioni egiziane per innalzare l‟acqua da fiumi e laghi e alimentare dei canali sopraelevati.
Nell'antico Egitto sono molte le raffigurazioni che ne evidenziano l'uso per scopo irriguo. Si tratta
essenzialmente di una trave posta su un fulcro asimmetrico, all'estremità del braccio più lungo si
trova un secchio, mentre dalla parte opposta un contrappeso (pietra) per bilanciare il carico. Questo
permetteva anche ad un singolo uomo di sollevare, con pochissimo sforzo, secchi pesanti ad alcuni
metri dal livello a cui si trovava. Se il dislivello da superare è grande si potevano usare intere
batterie di shaduf , posizionate su livelli diversi, in modo da passare l‟acqua dall‟una all‟altra.
La saqiya probabilmente è stata inventata in Egitto ed è tutt‟ora molto diffusa nel mondo islamico.
Il dispositivo è costituito da una serie di secchi, oppure otri, legati a una corda, messi in movimento
dalla forza di un animale che ruota trascinando una ruota dentata. Una serie d‟ingranaggi consente
ai secchi di sollevare l'acqua e trasferirla in un canale o in una vasca di raccolta. Tutto il
meccanismo è azionato grazie alla pazienza di un asino, di un mulo o di un cavallo. Per evitare che
l'animale si fermasse si era soliti applicare alla cavezza dei paraocchi, questi impedivano che si
rendesse conto del movimento circolare.
La noria -descritta per la prima volta da Vitruvio- può essere considerata una variante della saqiya,
rispetto alla quale presenta il grosso vantaggio di essere azionata sfruttando l'energia del moto
dell'acqua stessa. Si tratta di una ruota di grande diametro, verticale, munita di raggi di legno che
terminano a forma di pala. L'acqua in movimento spinge le pale facendo girare la ruota la quale, con
132
i numerosi contenitori (otri, secchi, vasi.) collocati sulla circonferenza, solleva l'acqua. La parola
“noria” deriva dall'arabo na-urah che significa vociare, zampillare. Se la spinta dell'acqua è
considerevole si possono raggiungere grandi altezze: esistono norie con un diametro superiore ai 20
metri, alcune ancora operanti in Siria.
Preso e riadattato da: tecnorevelli.blogspot.com/2011/11/macchine-per-sollevare-lacqua.
Erano questi sistemi di sollevamento che consentivano la coltivazione continuativa degli orti e le
eventuali irrigazioni di soccorso in una primavera siccitosa. Vale comunque per l‟Egitto quello già
detto per la valle dell‟Indo: il fondo sabbioso facilitava lo scavo dei canali ma non la loro
funzionalità; così nella valle -a parte i canali paralleli al fiume e il Bahr Yusuf che riforniva la
grande oasi di Fayyum-, la risorsa principale erano i bacini che si riempivano con l‟inondazione e
che funzionavano come deposito.
Prima che gli uomini capissero il valore delle rotazioni agrarie, prima ancora che imparassero come
mantenere costante (o incrementare) la fertilità del terreno, l‟inondazione annuale regalava
all‟Egitto una terra benedetta, dove le messi crescevano costanti e dove gli sforzi degli uomini erano
ripagati da copiosi raccolti.
Di una cosa però siamo debitori all‟agricoltura egizia: l‟invenzione dei prati! Sembra una
sciocchezza da dire, ma in un ambiente tutto costruito dagli uomini per gli uomini, bisognava
pensare anche al cibo per gli animali!
Non sto parlando degli animali granicoli come i volatili -che spilucchiano quello che avanza dalla
macina o sono capaci di andarselo a cercare-, e neppure dei maiali -che come specie mal sopportano
il caldo asciutto di questa area, dalla quale attraverso dei tabù alimentari sono stati banditi-, sto
parlando dei ruminanti o degli equini che hanno bisogno di brucare l‟erba e quindi di terreni messi a
pascolo. In un‟agricoltura semiestensiva come quella della valle dell‟Indo o in quella cinese -la
mondatura delle risaie e il pascolo dei bordi delle strade e dei canali- assommato agli spazi
dell‟incolto o del non utilizzabile, erano più che sufficienti per i bisogni di questi animali, ma in
Egitto gli spazi d‟incolto non c‟erano e minime erano anche le erbe da scarto, così fu necessario
creare dei prati –sempre artificiali- per avere i foraggi utili per gli animali.
Chi ha avuto la fortuna di visitare l‟Egitto (ma lo stesso vale nelle oasi dei deserti) può ricordare i
piccoli campi coltivati a leguminose foraggere. Non è quindi per caso che uno dei trifogli principe
delle colture pratensi si chiami ”alessandrino”. Di questo aspetto agronomico apparentemente
minore torneremo a parlare più avanti quando i prati coltivati e le marcite faranno il loro ingresso
trionfale nell‟agricoltura medievale europea.
La civiltà sumerica
L‟ultimo posto di questa lista –posizione che corrisponde ad una logica geografica che sarà chiara
tra poco e non certo al livello d‟importanza- è lasciato alla civiltà sumerica: quella nata nella parte
meridionale della Mesopotamia, lì dove il Tigri e l‟Eufrate sfociavano nel golfo iranico insieme al
133
Karum, che con le sue acque fangose discende dall‟altopiano iranico (oggi i tre fiumi si uniscono a
formare lo Shatt el Arab, che ha una tale portata di sedimenti da fare avanzare la costa del Golfo
Persico di circa trenta metri all‟anno). La civiltà sumerica; la madre della civiltà, non foss‟altro
perché precedette le altre di molti o di moltissimi secoli. Se la civiltà egiziana era figlia del Nilo e
poi dei contadini che ne hanno lavorato la terra, la civiltà sumerica è figlia degli uomini che fecero
di quelle paludi di canne e giunchi, fangose e insalubri, il primo giardino dell‟umanità – l‟archetipo
del paradiso terrestre-: l‟Eden! In termini naturali una incredibile trasformazione alchemica che
pone imperiosamente una domanda: come hanno potuto farlo?
I Sumeri (gli uomini dalla testa nera) non erano un popolo semitico come molti altri popoli del
Medioriente, dobbiamo quindi supporre che provenissero da altri luoghi (come da norma esiste
anche la versione che ritiene fossero autoctoni e che ricevettero dall‟esterno solo influenze
culturali); probabilmente dall‟altopiano iranico o dalle pendici di quei monti Zagros (oggi
parleremo di Kurdistan iracheno), dove- già da alcuni millenni- avevano avuto origine le prime
forme di domesticazione di uomini, piante e animali. La piana alluvionale, con la sua incredibile
fertilità potenziale, era in grado –probabilmente- di stimolare su questi popoli limitrofi la più
dirompente tentazione agronomica, anche con delle condizioni pedoclimatiche proibitive: caldo
insopportabile, acque morte e argilla fangosa (il che –con quel clima- voleva dire canneti
inestricabili). In assoluto il peggior ambiente naturale che una popolazione di aspiranti coltivatori
potesse immaginare, sicuramente l‟ambiente originario più ostile tra quelli che abbiamo descritto
finora. Di sicuro in quell‟area c‟erano già popolazioni che vivevano di pesca, di caccia e di una
limitata agricoltura stagionale e occasionale del tipo: brucia e semina (chiaramente nelle zone non
ricoperte di canne); d‟altro canto che altro si poteva fare in un ambiente dominato da una fitta e
incredibile vegetazione palustre? (per chi voglia avere un‟idea approssimativa delle condizioni
originarie può leggere il libro "Marsh Arabs" -Gli arabi delle paludi- scritto da Sir Alfred Thesiger
nel 1964, che illustra con occhi attenti e indagatori le popolazioni arabe che vivevano in quei
territori e con cui l‟autore aveva convissuto sette anni). Eppure quei pantani insalubri sono il luogo
di nascita della nostra prima civiltà e -cosa sorprendente- questa nacque proprio dove la palude era
probabilmente più estesa. Stiamo parlando di quella che è nota come la cultura di Ubaid (che
partendo quasi dalla foce ebbe un‟ampia diffusione in tutta la regione). A questo periodo di
transizione tra la protostoria e la storia (4500-3500 a.C.) risalgono le prime opere di canalizzazione,
realizzate per sopperire a esigenze solo locali, e i primi significativi esempi di architettura templare
(segno evidente del definitivo superamento dei culti naturalistici e famigliaristici) con un risoluto
passaggio verso forme di religiosità collettiva (una tendenza di cui avevamo già dato testimonianza
parlando di Göbekli Tepe).
Proviamo a mettere a fuoco la problematica, altrimenti rischieremmo di non capire il senso di
questo discorso! In questa parte della bassa Mesopotamia le popolazioni dovettero affrontare degli
enormi problemi di risanamento ambientale (è probabile che l‟anofele fosse ampiamente presente) e
di bonifica agraria (due cose che spesso marciano insieme). Per risanare quelle terre paludose
bisognava drenarle (ossia consentire lo sgrondo dell‟acqua in eccesso), ma il drenaggio di una zona
pianeggiante non è cosa semplice da realizzare! Non c‟era la possibilità di scavare il normale
sistema circolatorio di canali per le acque alte (quelle afferenti) e di acque basse (defluenti), per la
134
semplice ragione che l‟acqua non poteva essere convogliata da nessuna parte (per mancanza di
dislivello) e neppure poteva essere sollevata (perché gli strumenti allora a disposizione non lo
consentivano). Ecco allora che il drenaggio di una zona totalmente pianeggiante (essenziale per
poter avere dei terreni con la superficie di semina asciutta) consistette nello scavare canali –ampi
quanto basta per fare da normale vaso di espansione alle piene stagionali- calcolandone l‟ampiezza
in modo da poter disporre di un quantitativo di metri cubi di terra da trasferire sulle prode (le prode
sono quegli spazi di terra che si vanno a formare tra il reticolo dei canali). In questo modo si
riescono ad ottenere dei campi regolari con il piano rialzato di diverse decine di centimetri
sull‟acqua di falda (in altre parole: se il dislivello non c‟è lo si crea scavando canali e innalzando
artificialmente i campi). Questa soprelevazione, per ottenere una piena funzione agronomica, deve
fare in modo che i semi possano nascere e le radici possano crescere su di un terreno non
perennemente bagnato (i semi dei cereali e dei legumi coltivati nell‟area se seminati su terreni
troppo umidi marciscono). Ritorna così prepotentemente la figura dell‟agrimensore: colui che sa
fare i calcoli idrologici, colui che è in grado di sapere di quanto bisogna alzare le prode di terra
perché queste potessero superare –senza essere inondate- la normale piena stagionale dei fiumi.
Canali –quindi- che avevano un doppio scopo: drenare i terreni da coltivo e consentire che la terra
spostata permettesse la formazione di campi coltivabili. Un conoscenza del territorio e una sapienza
agronomica incredibili (per coloro che fossero incuriositi da questo aspetto c‟è da ricordare che le
popolazioni precolombiane fecero le stesse cose negli llanos colombiani e venezuelani, e le fecero
su dimensioni ancora più ampie). Fu questa sapienza agraria e questa conoscenza delle esigenze
delle piante e degli animali nostri alleati che consenti alla cultura di Ubaid di estendere la sua
influenza su tutta la Mesopotamia, anche dove le condizioni erano meno problematiche e minori i
risultati produttivi.
Poi - intorno al quarto millennio a. C. dalla cultura di Ubaid cominciò ad emergere un agglomerato
urbano che, in un tempo relativamente breve, arrivò ad avere tutte le caratteristiche di una vera e
propria città: Uruk (ca. 3800-3000 a.C.), che nel suo momento di massimo splendore si pensa
contasse una popolazione di circa 80.000 abitanti e era rinchiusa in una doppia cinta di mura lunghe
più di dieci chilometri, fondate- secondo la tradizione- dal mitico Gilgamesh. Una popolazione
urbana che per l‟epoca era enorme e che comportava una divisione netta tra classi sociali e tra ceti
produttivi.
Ora, questo non è uno scritto sulla storia antica e - la storia della Mesopotamia è la più antica, più
complessa, più intrigante del mondo- quindi chi vuole ha centinaia di libri per leggere e per sapere
di Uruk, di Ur, di Ninive, Babilonia, dei fatti divenuti miti e dei miti diventati fatti che quella terra
ci ha lasciato. Quindi non passerò in rassegna la sua storia straordinaria, ma concentrerò le mie
attenzioni solo sugli aspetti agronomici. Non prima però di aver sottolineato una cosa: in nessuna
altra parte del mondo gli uomini hanno pensato di sfidare il Dio -che loro stessi avevano collocato
in una dimensione celeste- erigendo una torre che arrivasse a lambire il suo regno. O forse anche
questo è solo un mito, costruito da un popolo che ha di Dio l‟immagine del grande punitore, e che
ha utilizzato la parabola storica vissuta nella Mesopotamia per lanciare un grande monito alla
superbia umana.
135
La cosa sorprendente è che quella torre fosse stata costruita – o si volesse costruire- di mattoni di
fango. Come di fango era l‟impressionate quantità di testi scritti su tavolette d‟argilla che ci sono
pervenuti dagli scavi archeologici.
Nel Vicino Oriente Antico, le tavolette di argilla erano facili supporti per la scrittura. I caratteri
erano tracciati su una tavoletta umide con uno stilo spesso realizzato con un calamo di canna. Una
volta completato il testo, le tavolette erano essiccate al sole o all'aria, oppure cotte in forni per
renderle dure e durevoli. Le raccolte di questi documenti di argilla costituirono la base dei primi
archivi e delle prime biblioteche. Nel Medio Oriente, sono state ritrovate decine di migliaia di
tavolette scritte, molte delle quali in frammenti. Si tratta di una delle prime forme di scrittura
documentate nel Vicino Oriente, direttamente derivata dalla evoluzione e stilizzazione di una
precedente fase di scrittura fondamentalmente figurativa, a base di pittogrammi, creata a quanto
sembra dai Sumeri, primi abitanti storicamente documentati dell'antica Mesopotamia (oggi Iraq), fin
dalla fine del IV millennio. Attraverso i secoli la rappresentazione pittografica dei segni assunse
sempre più un aspetto stilizzato, e le stesse linee, originariamente disegnative e continue, furono
segmentate in una serie di tratti, o cunei – da qui il termine “cuneiforme”, che caratterizza questa
scrittura- divenendo sempre più indipendenti dalle forme originarie, e quindi sempre meno
riconoscibili. Con l'avvento delle popolazioni semitiche, agli inizi del II millennio a.C., e il
tramonto della civiltà sumerica, la scrittura cuneiforme divenne appannaggio della nuova cultura
babilonese e assira (detta globalmente accadica) e data la propria struttura fortemente sillabica poté
essere usata per esprimere altre lingue come l'elamita, l'ittita, l'urarteo, e il luvio cuneiforme. Essa
rappresentò anche la base e l'ispirazione da cui vennero create le scritture di Ugarit e quella
achemenide dell'Antico Persiano.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Scrittura cuneiforme
Si parla tanto di scrittura, ma sarebbe meglio parlare di contabilità (che è un insieme di scrittura e di
matematica), perché di questo parlano la stragrande maggioranza delle tavolette: di conti! Conti del
dare e dell‟avere, di prestiti e di tasse, di attestati di proprietà, di lasciti testamentari, di oneri messi
per iscritto. La nascita della civiltà non è legata alla letteratura (come ci piace pensare) ma alla
matematica dei numeri: dove i testi servivano a fare di conto e a calcolare l‟ammontare delle
imposte, e dove gli atti di proprietà testimoniavano che se qualcheduno aveva, era perché ad altri
era stato tolto.
Tutto questo chiacchiericcio non risponde però alla domanda lasciata in sospeso: come gli uomini di
quel paese di acqua e fango hanno potuto fare tutto questo? Dai dati contabili che gli studiosi hanno
potuto estrapolare dalla lettura degli archivi di tavolette appare evidente che la produttività di certi
territori era incredibile: ci troviamo di fronte a rese produttive dei campi seminati a grano e/o a orzo
di 40-50 quintali ad ettaro di granella raccolta (qualche volta anche di più!). Stiamo quindi parlando
di raccolti che rendevano 20-30 volte la sementa necessaria per seminarli. Queste sono rese medie
paragonabili a quelle che si ottengono dal secolo scorso, ma solo perché l‟agricoltura attuale usa un
quantitativo enorme di concimi chimici. Allora come potevano i popoli sumerici eguagliarci senza
utilizzare nitriti, nitrati o ammoniaca di sintesi? Queste antiche civiltà non conoscevano i principi
della concimazione e seppure l‟avessero conosciuti non avevano concimi da utilizzare per
136
migliorare la resa produttiva dei campi: la civiltà cinese si rimetteva all‟acqua che fertilizzava le
risaie, quella egizia alle piene benefiche del Nilo, quella indiana forse deve la sua decadenza
all‟incapacità di rispondere a questo problema, e quella sumerica? Come fece la più antica e la più
ricca civiltà della Terra a permettersi torri alte fino al cielo e giardini sospesi su tetti e terrazzi (mi
riferisco chiaramente ai giardini di Babilonia che in onor del vero furono costruiti molti secoli dopo
al periodo che stiamo prendendo in esame). Molti studiosi pensano che questo fosse possibile grazie
al ricorso al lavoro schiavile (anche in questo i sumeri -anticiparono i tempi- inventando nuovi
modelli comportamentali). Ma questa è una falsa risposta, perché il ricorso al lavoro degli schiavi ci
può dire con che forza lavoro hanno potuto farlo – ossia come, non cosa hanno fatto- . Mai
scambiare l‟azione di realizzazione con l‟idea!
Per dare una risposta a questa domanda c‟è bisogno di tirare fuori un coniglio dal cappello! In
agronomia esiste una pratica che - se applicata ai terreni argillosi (e solo a quelli)- riproduce
esattamente gli effetti di una concimazione: la calcificazione. La distribuzione di polvere di calce su
i terreni argillosi induce alcuni risultati sorprendenti: il primo è un fenomeno legato alla fisica del
terreno e corrisponde alla flocculazione delle molecole d‟argilla, che in questo modo si aggregano
tra di loro a formare molecole più grandi e più areate (questo è possibile grazie alla carica
fortemente positiva dello ione calcio e alla carica negativa delle molecole d‟argilla che si attraggono
tra loro), il secondo è strettamente legato alla chimica con una enorme quantità di ioni –quelli
precedentemente legati alle molecole d‟argilla e quindi indirettamente sequestrati alle piante- che
con questa pratica vengono sostituiti da quelli di calcio, cosa che rappresenta una forma di
concimazione indiretta. Una buona distribuzione di calce sui terreni argillosi rende –quindi- i terreni
più soffici e areabili (aumentando la percolazione dell‟acqua di superficie e diminuendo
l‟evatraspirazione), trasformandoli fisicamente in un substrato meno umido (quando c‟è presenza di
acqua) e più capace di trattenerla nei periodi di carenza idrica; consente poi una concimazione con
gli elementi chimici di carica positiva messi in circolazione (potassio, rame, molibdeno, selenio,
etc.) e aumenta la presenza di ioni con carica negativa ( azoto e fosforo), in virtù della miglior
circolazione d‟aria nell‟argilla flocculata. Insomma: distribuire calce spenta sui terreni argillosi è
come fare l‟apprendista stregone!
Ora la vera domanda è: i sumeri conoscevano i risultati della distribuzione della calce sui terreni?
Non lo sappiamo! E credo di poter dire che non lo sappiamo per la semplice ragione che nessuno ha
mai pensato di porsi questa domanda. Sappiamo però che i popoli della Mesopotamia facevano
grande uso della calce che serviva l‟edilizia (la calce era usata per tenere insieme i mattoni
d‟argilla), sappiamo anche che gli archeologi hanno trovato dei grandi depositi di pietre calcaree
(venivano trasportate da lontano discendendo i fiumi), sappiamo poi che a molte costruzioni –
ritenute templari- è stato assegnato il nome di “templi bianchi”, perché pieni di depositi di pietre
calcaree o di calce. Erano templi o magazzini?
Una cosa è però certa: l‟uso prolungato delle tecniche di calcificazione provoca dei gravi danni ai
terreni e ne inducono una diminuzione progressiva delle rese produttive. La calce spesso contiene
una grande quantità di ioni sodio (NA++ ha la stessa carica fortemente positiva della CA++) e
anche lo sodio è in grado di scacciare gli altri ioni positivi e di sostituirli, creando però un grave
137
problema di fondo: il sodio salinizza i terreni e li rende sterili (il sale da cucina è il normale cloruro
di sodio, e ricordare cosa fecero i romani dopo la conquista di Cartagine?).
Ora, tutti gli archeologi concordano sul fatto che i terreni della Mesopotamia si siano isteriliti per un
problema di salinizzazione, e questo logicamente avvenne per l‟infiltrazione nelle falde idriche
delle acque marine del Golfo Persico; ma gli uomini hanno dato un contributo a questo processo?
Sicuramente si! Lo hanno fatto non solo distribuendo calce per ammendare i terreni argillosi, ma
anche scavando canali (che consentirono all‟acqua di falda di risalire in superficie per capillarità),
irrigando molto in un ambiente di forte evaporazione e coltivando troppo intensamente. Risultato di
tutto questo: nei secoli a seguire i terreni coltivati hanno perso progressivamente la loro fertilità
(l‟humus viene ucciso dal sale) e quello che oggi rimane è una landa desolata e improduttiva.
La civiltà sumerica –che così tanta importanza ha avuto nelle vicende umane- fu sotto il punto di
vista della corretta gestione del territorio un vero disastro e –anche in ragione di questo- collassò
fragorosamente, finendo sostituita da altri popoli e da altre civiltà. Civiltà che – per quanto
splendide- furono incapaci di ricreare quell‟incredibile periodo in cui agli uomini sembrava di aver
trasformato per sempre quelle paludi in un grande giardino. Può essere allora che il peccato più
grande di presunzione, non sia stato l‟aver tentato di costruire una torre alta fino al cielo, ma aver
pensato che era possibile piegare le logiche della Natura, drogando e manipolando la Terra a nostro
uso e consumo. Pensando che questo si sarebbe potuto fare senza pagare pegno.
Purtroppo, non sembra che gli uomini abbiano appreso il valore di questo ammonimento.
138
Regni e Imperi
Le civiltà che abbiamo appena descritto (insieme alle altre che abbiamo tralasciato) sono edificate
sulle fondamenta di significativi e costanti surplus produttivi agricoli? Si, sicuramente si! Perché?
Perché da quando abbiamo smesso di essere cacciatori e raccoglitori e abbiamo cominciato a
coltivare la terra ed allevare animali il cibo è diventato l‟unico bisogno primario che, per essere
appagato, richiede un impegno molto più complesso che quello di cercare, raccogliere o cacciare!
E‟ quindi il lavoro (nostro, di alcuni animali e ora delle macchine) il collante interno alle varie
biocenosi, in un apporto di forza e d‟ingegno che aggiungendosi a quello dell‟energia solareaumenta l‟efficienza relativa dei sistemi agricoli. Attenti perché questo passaggio è determinante:
l‟agricoltura (ossia il mondo coltivato) non è più produttivo o più efficiente del mondo naturale, lo
è solo relativamente ai prodotti per noi d‟uso, perché i sistemi naturali -in termini di biomasse
prodotte- fino alla nascita dell‟agricoltura industriale hanno continuato ad essere molto più
produttivi delle nostre biocenosi. Dovrei qui parlare di Nicholas Georgescu-Roegen e del suo
approccio alla bioeconomia, ma credo che è opportuno rimandare questo argomento alla parte
conclusiva di questo studio. Quindi lasciamo le discussioni sull‟entropia del pianeta e torniamo alla
nostra più semplice trattazione.
Il sole e l‟aria sono democratici (ossia –per ora- disponibili a tutti gratuitamente), l‟acqua è un bene
da società di cacciatori e raccoglitori (nel senso che –se anche la paghiamo- non la produciamo, la
captiamo –sinonimo di catturiamo- o al massimo la recuperiamo); il cibo no! Per avere il nostro
cibo quotidiano dobbiamo lavorare e se non siamo noi a lavorare la terra (uso il termine “terra” in
senso lato, perché il cibo si produce anche nell‟acqua, come nell‟acqua si pesca) c‟è comunque
qualcun‟altro che lo ha fatto – o lo sta facendo- per noi. E‟quindi il lavoro che consente di poter
produrre, accumulare e ridistribuire i prodotti della terra, trasformando i prodotti agricoli in merci e
trasformando coloro che non lavorano la terra in dipendenti –in termini di prodotti primari- dal
lavoro altrui; da questo discende il concetto di surplus, che altro non è che la differenza tra prodotti
agricoli totali e i prodotti necessari al mantenimento di chi (uomini e degli animali) operano per
produrli (dove per mantenimento degli uomini si deve intendere il cibo, ma anche le fibre vegetali o
animali necessarie a tessere indumenti). Come già detto questo rapporto va dall‟85-90% delle
antiche società rurali al 5% delle moderne società basate su modelli di agricoltura industriale.
Così che, una volta modificato il rapporto che legava la nostra specie alla Natura (dove la nostra
esistenza era condizionata dall‟offerta alimentare disponibile), la fertilità del terreno, la disponibilità
d‟acqua per l‟irrigazione, coniugate all‟impegno di lavoro (umano o animale) e all‟ingegno (solo
umano) e agli obiettivi di espansione numerica condivisi tra gli attori compartecipi dei sistemi
agricoli, hanno contribuito a migliorare l‟efficienza delle varie biocenosi. Questo miglioramento
relativo ha portato ad aumento demografico e ad una riduzione del gravame di fatica e di tempo che
pesava sugli uomini. Questa seconda strada però non ha significato una riduzione proporzionale del
lavoro per tutti gli uomini, ma è stata utilizzata solo da quelli che si sono liberati dal gravame di
coltivare per poter mangiare, lasciando a coloro che sono rimasti sui campi tutto il peso della
produzione.
139
L‟essere sollevati dal soddisfacimento dell‟obbligo primario ha così consentito ad alcuni uomini di
fare altro o di pensare ad altro, e così –per la prima volta- la società degli uomini ha visto apparire
una più vasta gamma di “beni” disponibili, capaci di ampliare la sfera dei nostri piaceri e dei nostri
apparenti bisogni. Questi “beni”, le nuove capacità nel produrli, uniti al desiderio o il piacere di
possederli, sono stati un potente stimolo allo sviluppo di un‟economia più vasta e hanno gettato le
basi della monetizzazione dell‟economia (la prima moneta al mondo è stata utilizzata dai Sumeri e
era un soldo equivalente a uno staio di orzo; con questo soldo –il cui valore era determinato da un
peso- gli uomini superarono i vincoli del baratto).
Così –con un logica che potrebbe trasformarsi in una equazione matematica- meno sono le persone
occupate nel soddisfacimento dei bisogni alimentari, più la società è ricca (in termini monetari) e
complessa. Infatti la ricchezza monetaria non deriva dalla produzione e dall‟autoconsumo dei
prodotti alimentari, deriva dal plusvalore che si riesce ad attribuire loro con la trasformazione e la
commercializzazione. Molti hanno cercato ragioni razziali, altri hanno immaginato logiche culturali
e comportamentali, c‟è anche qualcuno che ha parlato di etica religiosa, ma la ricchezza (in termini
monetari e di beni materiali posseduti) di una popolazione risiede nell‟efficienza della sua
agricoltura –capace di liberare tempo e fantasie- e anche nel fatto che la stragrande maggioranza
della popolazione ignori questa banale verità, proprio perché è quotidianamente occupata a fare
altro. Capire come questo meccanismo assicura molti strumenti utili a capire il senso di questo
nostro raccontare.
Non è quindi per caso se – dopo la nascita dell‟agricoltura e dell‟allevamento- le civiltà fiorirono là
dove la terra fu generosa con le piante, gli animali e gli uomini uniti in alleanza. Perché le civiltà
vanno oltre i bisogni primari, sono fatte da uomini che svolgono mestieri più vari e disparati, ma
anche di uomini che ballano, che ridono e che conversano tra loro, così come sono fatte da uomini
che pregano, che scrivono, che giudicano, che organizzano e governano. Perché le civiltà sono
l‟espressione di un alto livello d‟umanizzazione e d‟organizzazione (detto parafrasando P.P.
Pasolini), ossia sono una sintesi tra l‟io e il noi, con rapporti complessi con il loro.
Le civiltà arrivano a vertici tanto più alti quanto più il verbo “governare” si allontana dal verbo
“comandare”, e tanto meno l‟obbedire è coercitivo e non volontario (torneremo tra poco sulle basi
dell‟obbedienza). Questo perché, anche se le civiltà sono gerarchiche nei loro vari livelli, partono da
presupposti di similitudine se non d‟uguaglianza. Le civiltà non nascono intorno ad un campo (dai
campi le civiltà traggono nutrimento per le loro radici), perché i frutti di ogni civiltà maturano
dentro una “piazza”, o comunque si voglia chiamare uno spazio di partecipazione comune. Le
civiltà non nascono verticistiche, lo possono diventare e quasi sempre lo sono diventate, ma la loro
genesi è comunitaria e compartecipativa. Per questo i poteri hanno bisogno di una legittimazione
“popolare”, per questo i poteri senza il consenso popolare altro non sono che occupazioni coercitive
destinate a collassare in un arco relativamente breve di tempo, per questo c‟è chi dedica così tanto
sforzo nel creare i meccanismi artificiali e artificiosi di consenso. Perché le civiltà prendono origine
da comunità più ampie di quella di un villaggio, perché l‟energia generatrice di una civiltà non
discende per via diretta dal lavoro (il surplus produttivo è un prerequisito) ma da un ampio incontro
di pensieri; dalla possibilità per la mente di divagare in dimensioni post o pre produttive, in circuiti
estranei ai bisogni e ai comportamenti quotidiani. Civiltà, socialità e socializzazione sono un
140
tutt‟uno (meglio sarebbe dire che: dovrebbero esserlo), perché civiltà vuol dire cultura,
comunicazione e organizzazione su forme più vaste di quelle famigliari o di villaggio. Questo non
vuol dire che la civiltà è legata alla “civitas”, come si dovrebbe desumere dal nome, ma comunque
discende da un‟ampia socialità condivisa, per questo è possibile che nasca anche in una socialità
collegata a rete (come era la cultura di villaggi o come è oggi la cultura internauta).
Nella storia della nostra specie sono esistite un‟infinità di culture (pensate a quella del paleolitico
con le sue meravigliose pitture rupestri e le straordinarie innovazioni tecnologiche che hanno
caratterizzato quel periodo) e ancora oggi persistono alcune culture nomadiche che hanno livelli
incredibili di conoscenza e di sapienza. Tutte queste culture sono legate alla diminuzione del tempo
necessario alla soddisfacimento dei bisogni primari e alla possibilità di attivare una fertile
elucubrazione delle menti e condivisione degli spiriti. Non è però una sorpresa che queste culture
utilizzino il tempo nella forma di ozio creativo o ricreativo - senza erigere santuari, senza scavare
canali-, perché non hanno potuto (per problemi ambientali) o desiderato costruire quel sistema
d‟alleanze che sono state alla base dei surplus produttivi capaci di sostenere delle forme più
complesse di organizzazione. E -senza organizzazione- ci sono le culture non le civiltà.
Ma là dove la terra è stata generosa, là dove l‟alleanza con gli altri artefici delle biocenosi è stata
fruttifera, noi abbiamo avuto il modo di diventare una specie stanziale, acquisendo un
comportamento che ci distingue dai nostri cugini primati. Loro vagano in piccolo gruppi parentali
per la giungla o nella savana costruendo dei semplici giacigli provvisori per passare una notte o per
ripararsi da una pioggia scrosciante, noi –come tutte le specie stanziali- costruiamo tane. E come
tutte le specie stanziali che sono anche sociali le nostre tane (che chiamiamo case) sono organizzate
in colonie tanto più grandi quanto più efficiente è il sistema che le rifornisce di prodotti. E se le
colonie crescono nei numeri e nelle varie funzioni arrivano ad un punto dove emerge la necessità di
una gerarchia interna che ne regoli i rapporti. Per gli altri animali eusociali quest‟ordine è codificato
nei loro geni e pianificato dalla funzione riproduttiva della regina (un formicaio o un termitaio ha un
ordine interno che non consente deroghe). Noi che siamo gli ultimi arrivati di quel ristretto gruppo
di animali sociali, non avendo codificato nei geni -né dei comportamenti prefissati, né l‟attitudine
al rispetto dell‟ordine gerarchico- abbiamo dovuto immaginare e costruire dei memi capaci di
riprodurne e legittimare lo stesso comportamento. Non dobbiamo quindi sorprenderci se nelle menti
dei bambini c‟è una oggettiva difficoltà a recepire il concetto di morale comune o d‟obbedienza
(cosa che vale anche per tanti uomini). Questo perché tutti i comportamenti che derivano da input
culturali sono passibili di rifiuti e riconsiderazioni. Anche per questo le nostre divisioni sociali non
sono rigide, ma si comportano come membrane organiche che consentono il passaggio da un livello
all‟altro (mi riferisco sia al benessere economico che al potere decisionale). Perché questo
meccanismo interiore di circolazione osmotica è un‟ulteriore forma di legittimazione culturale della
sovrastruttura gerarchica, lasciando immaginare che un prete possa diventare papa o un semplice
militare possa diventare re (in genere è la casta militare che rovescia e sostituisce una monarchia).
Riconosciuto però il valore del pensiero e del comportamento individuale emerge una domanda:
cosa potevano fare gli uomini –nei loro tentativi di darsi una forma d‟organizzazione- se non
adeguarsi alla forme fissate dalle leggi naturali che regolano i rapporti interni delle altre comunità
eusociali? Siamo una specie come tutte le altre, dove l‟appellativo di sapiens è una semplice
141
iperbole, e dove l‟attenersi è costume condiviso. Quali meccanismi mentali potevamo immaginare –
appena costruiti i primi agglomerati umani- se non un potere centralista regale e/o sacerdotale
legato alla figura di un “re” pianificatore che – obtorto collo- è paragonabile a quella che
soprassiede la scala gerarchica degli altri animali sociali? Era possibile ipotizzare la costruzione di
una società senza fuchi, senza tutori e senza operai? La gerarchia è la più banale forma di
organizzazione sociale perché risponde a logiche primarie, governate dalla Natura e facilmente
comprensibili dalla parte rettiliana del nostro cervello, con la non piccola differenza che la gerarchia
umana è obbligata a sottostare ad una complessa serie di sovrastrutture legittimatorie e forme
aleatorie d‟acquisizione del consenso, senza le quali non potrebbe sostenersi. E‟ questo –forse- il
punto dirimente: gli uomini sono una specie neotenica, necessitano di un lungo periodo formativo
che ci accompagna durante l‟infanzia e parte dell‟adolescenza. Obbedire è quindi un
comportamento innato perché essenziale allo sviluppo degli individui della nostra specie. Tutti
abbiamo obbedito alla autorità parentale, e tutti possiamo obbedire ad altre forme che abbiano in se
il germe dell‟autorità o dell‟autorevolezza. Su questo si è costruito il potere di alcuni (perché tutti
nella vita abbiamo “obbedito” e abbiamo dato “ordini”), non c‟era necessità di codificarlo nel
nostro patrimonio genetico, è bastato costruire delle strutture culturali di legittimazione.
Certo i memi culturali sono molto forti, omnipresenti, pervasivi, in grado di auto mantenersi e
capaci di mantenere un ordine sociale che altrimenti non avrebbe modo di sopravvivere. Per questo
può esistere una regalità senza moralità, una autorità senza integrità, un comando senza etica. Per
questo da quattromilatrecento anni (da quando Sargon l‟accadico fondò il primo impero sulle ceneri
dei regni sumerici) gli uomini vivono aggregati all‟interno di società organizzate in regni o imperi.
Di regni neanche a parlarne, nella storia sono stati così tanti che non si possono neanche catalogare,
ma anche gli imperi sono un presenza costante della storia dell‟umanità: l‟impero assiro babilonese,
impero achemenide, macedone, romano, bizantino, ottomano; ma anche han, jìn, qin, ming;
l‟impero maurya, xionglu, quello kushana o sassanide. L‟impero incas e quello azteco, quello etiope
e quello songhai, l‟impero del ghana, ma anche quello omayyade, e quello abbasside. Quello
spagnolo, portoghese, francese, inglese, olandese, austriaco, russo. Quello giapponese (che è –
formalmente- l‟ultimo impero rimasto). Imperi potenti che hanno sfidato i secoli e imperi
quindicennali come quello dei nazisti o di Napoleone o durati un semplice battito di ciglia nella
griglia del tempo, come il ridondante impero quinquennale dell‟Africa Orientale Italiana. E i tanti
altri imperi e imperialismi di cui non ho citato il nome per non rendere questa lista noiosissima.
Nessuno si senta escluso, da quando gli uomini si sono dati una socialità organizzata su livello
complessi, regni e imperi sono stati la forma gerarchica più ampliamente presente nel governo delle
società umane. Credo che si possa dire che lo sono stati e non hanno mai smesso di esserlo (faccio
mio il suggerimento di Michael Hart e Antonio Negri sul fatto che oggi tutti noi soggiacciamo ad
un impersonale impero universale dominato dalla finariarizzazione del denaro) grazie al fatto che
l‟impero è un concetto iperonimico fondato su stilemi agglutinati dalla fede. Così –se per alcuni
millenni abbiamo avuto fede nella sovranità di un Dio o di un imperatore/trice - ora sembra che tutti
siamo presi dalla fede in Mammona.
142
Verso ovest
Così come alcuni grandi eventi naturali -terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni o forti siccitàhanno segnano la storia naturale della Terra, le migrazioni (che spesso hanno fatto seguito ai grandi
eventi naturali) hanno segnano la storia della nostra specie. Non sto parlando delle migrazioni
stagionali (gli uccelli migrano, così come fanno gli uomini e le mandrie alla ricerca di pascoli
freschi) e neppure di quelle migrazioni occasionali fatte da singoli individui, ma di quegli
spostamenti che coinvolgono interi popoli (poco importa il numero) nel tentativo o nel bisogno di
cercare nuovi luoghi da colonizzare. Un comportamento naturale a tutti gli essere viventi, quando –
venendo meno, per ragioni più disparate, il poter vivere in un luogo determinato- se ne allontanano
cercando un posto per sostituirlo. Nel loro migrare da un posto a un altro gli uomini lasciano tracce,
alcune volte deboli come le briciole di pane di Pollicino, altre volte più visibili, come un vero e
proprio filo d‟Arianna nel labirinto. Sulla lettura di queste tracce (come detto più o meno flebili a
seconda del tempo e del luogo) discute la comunità degli studiosi, nel tentativo di ricostruirne il
senso e le ragioni e più ancora le ripercussioni che questi spostamenti hanno indotto nei luoghi di
nuova stabilizzazione.
Come già visto nei precedenti capitoli l‟uomo è portato ad essere -per struttura fisica- un animale
migrante, ma questo nostro spostarsi all‟interno di aree più o meno grandi alla ricerca di cibo è
cambiato negli ultimi 10-15.000 anni con l‟acquisizione di nuovi comportamenti - individuali e
collettivi – legati alla nascita dell‟agricoltura e dell‟allevamento a stabulazione fissa; una tale
rivoluzione nella strategia di sopravvivenza da marcare un significativo cambiamento del rapporto
tra gli uomini e l‟ambiente naturale, e da generare una forma di dualismo che occasionalmente ha
prodotto significative frizioni. Un comportamento ben stigmatizzato nella Bibbia con la narrazione
del fratricidio di Caino (l‟agricoltore stanziale, quindi uomo che trasforma il territorio dove vive) a
danno di Abele (l‟allevatore nomade che incide poco sull‟ambiente naturale). Questo nuovo migrare
di popoli con semi, piante e animali ha modificato i numeri e le forme di questo nostro andare per il
mondo, (perché ha aperto nuove geografie alle migrazioni, introducendo l‟idea di uno postarsi per
cercare nuove terre coltivabili, e perché ha aggiunto alle migrazioni per crisi -interne o esterne- le
migrazioni legate ai successi riproduttivi degli uomini coltivatori). Questi nuovi fenomeni migratori
hanno lasciato dietro di se un insieme di tracce ben più profonde e leggibili delle precedenti. Su
questi spostamenti collettivi è forse il caso di ritornare, anche perché il tema è strettamente
connesso all‟argomento che vorremmo trattare in questo capitolo, dove parleremo di quelle
migrazioni (di uomini e di idee) che hanno portato l‟agricoltura ad affacciarsi nel bacino del
Mediterraneo, gettando le basi di alcune delle civiltà più sorprendenti della storia umana.
I fatti succedutesi in questi millenni sono molto difficili da percepire e raccontare, e –giuro- che
sono giorni che rigiro le note e appunto le idee nel tentativo di trascriverne gli aspetti salienti in
modo lucido e ordinato. Ma le migrazioni sono così tante e sovrapposte che è quasi impossibile
seguirne un filo narratore; i luoghi dove si sono generate e le forme del loro insediamento sono così
complicate da determinare che tutto appare come un grande gioco di dama, dove le pedine si
143
spostano per mangiare o essere mangiate. (Sì; comunque lo si metta –non certo per colpa
dell‟argomento che in realtà appare d‟interesse straordinario, ma per le difficoltà nella descrizionequesto è un capitolo che mi sta antipatico da scrivere!)
Partiamo comunque dall‟ovvio presupposto che ognuno di noi è solito leggere gli eventi dal suo
specifico angolo visuale (io dall‟agronomia), e proviamo a dare un senso al flusso scadenzato e
costante delle tante e differenti migrazioni.
In quei millenni la nostra specie stava muovendosi in più direzioni (c‟era in atto il popolamento
delle Americhe e l‟Africa del nord viveva la progressiva desertificazione del Sahara, mentre alcune
popolazioni già agricole stavano andando a colonizzare le terre di quelle che successivamente
diventeranno le “civiltà fluviali”); un insieme variegato di fenomeni che noi tentiamo di
stigmatizzare delimitando e definendo all‟interno di specifici flussi, ma che in realtà è stata una
costante della storia della nostra specie. Ma questo capitolo si prefigge un obiettivo specifico: vuole
centrare le sue attenzioni sulle migrazioni che partendo dai centri principali di domesticazione
dell‟Asia sud-occidentale hanno puntato verso l‟Europa, trasferendo e estendendo gli spazi delle
nuove e conoscenze agronomo-zootecniche acquisite in quella parte del mondo, gettando le basi
delle grandi civiltà del Mediterraneo e di alcuni dei più grandi e longevi imperi della storia umana.
Fatte questa premessa, proviamo ora a definirne i fenomeni più importanti, tracciando le linee guida
dell‟espansionismo di quei migranti coltivatori e allevatori.
Secondo un filone di pensiero il fenomeno della colonizzazione agricola europea è legato a delle
migrazioni verso occidente di alcuni popoli proto-indoeuropei che lasciarono l‟Anatolia intorno al
settimo millennio a.C. (abbiamo già parlato di questa ipotesi in un precedente capitolo). Il prefisso
“proto” serve ad indicare che ci troviamo di fronte a popolazioni –ad oggi ancora sconosciute- che
si misero in viaggio, a causa o in virtù, del successo produttivo e riproduttivo legato all‟acquisizione
dell‟agricoltura in quella regione attigua alla Mezzaluna Fertile. Di queste migrazioni di agricoltori
primigeni abbiamo documenti riguardanti l‟espansione del loro corredo genetico, e una mappatura
dei loro insediamenti europei dediti all‟agricoltura stanziale. Setacciando poi tra le tante lingue
indoeuropee oggi in uso, abbiamo vari termini che rimandano ad una arcaica radice comune, e –
secondo alcuni – questo basta a connotare l‟evoluzione vissuta da quei popoli successivamente. Da
questo fenomeno deriverebbe, che grazie a queste antiche migrazioni, l‟agricoltura penetrò in
Europa utilizzando il ponte tracico, per poi - attraverso il corridoio danubiano- espandersi (sia
grazie agli spostamenti di popoli che in virtù di contaminazioni culturali) nelle varie direzioni: verso
ovest (fino a raggiungere la Gran Bretagna, l‟Irlanda), verso nord (fino a comprendere l‟intera
penisola scandinava e successivamente l‟Islanda) e verso sud, andando ad interessare le tre
estensioni che si affacciano nel mediterraneo (le penisole iberica, italica e balcanica con le
appendici isolane ad esse collegate). Applicando questa logica –ovviamente- la Tracia e i Balcani,
sono stati tra i primi territori coinvolti dalla grande trasformazione colturale e culturale che questi
popoli proto-indoeuropei portarono con loro.
Con una rilettura critica delle sue tesi Colin Renfrew modificò poi questa “ipotesi anatolica”,
proponendo proprio i Balcani come crogiuolo di una "Europa Antica" (nata tra il sesto e il quinto
144
millennio a.C.), da cui emersero quei popoli proto-indoeuropei (poi diventati indoeuropei) che
discendevano dai precedenti (VII millennio a.C.) pre-proto-indoeuropei (o proto-indoittiti).
Tra tutti questi pre e proto riuscite ora a capire perché questo capitolo mi stia antipatico da scrivere?
Comunque, -secondo questa tesi – quelle migrazioni si sovrapposero e/o sostituirono le genti che
abitavano l‟Europa dal tempo del paleolitico (quelli che a loro volta avevano sostituito i
Neanderthal); popoli che con la migrazione degli indoeuropei (anche di quelli proto) non avevano
nulla a che fare, perché qui abitavano ben prima dell‟arrivo di questi colonizzatori armati di semi e
di greggi.
Si pensa che alcuni etnonimi corrispondano a genti pre-indoeuropee, che si suppone siano i
discendenti di precedenti culture della Europa antica: i Sardi, i Pelasgi, i Minoici, i Lelegi, gli Iberi,
gli Etruschi e i Baschi. Due dei tre popoli che abitarono la Sicilia prima dei Greci, i Sicani e gli
Elimi, potrebbero essere stati di origine pre-indoeuropea. Il termine "pre-indoeuropeo" viene esteso
in alcuni casi fino a riferirsi all'Asia Minore, Asia Centrale e India, nel qual caso gli Urriti, gli
Urartiani, i Dravidi possono essere compresi in questo gruppo.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Europa antica
Come già visto Maria Gimbutas non contesta le migrazioni avvenute tra il VII e il IV millennio, ma
le ritiene prodotte da popoli pre e non proto-indoeuropei, mentre pensa che la vera immigrazione
indoeuropea sia da collocare all‟epoca del calcolitico e fu realizzata da popoli provenienti dalla
zona caspica (quindi non dall‟Anatolia), riconoscibili per la cultura dei Kurgan (una parola turcotartara che indica dei tumuli contenenti la sepoltura di una tomba a fossa), portatori delle tecniche
metallurgiche e del cavallo domesticato (quindi per la Gimbutas gli indoeuropei erano degli
allevatori nomadi e non degli agricoltori, simili –in parte- a quei popoli che alcuni millenni più tardi
penetrarono il limes orientale dell‟impero romano). La differenza non è da poco, perché mentre la
prima ipotesi suggerisce una flusso pacifico (pacifico?) e costante, nella seconda si immagina una
vera e propria invasione di popoli guerrieri, montanti a cavallo e in possesso di tecnologie militari,
che sostituirono il culto della Grande Madre con degli Dei maschili e modificarono la socialità
matrilineare con l‟idea di un virile potere mascolino. Ovviamente queste diverse teorie sulla
provenienza sono il basto su cui caricare un‟infinità di altre ipotesi riguardanti i diversi modelli
associativi, le differenze linguistiche, quelle culturali e i vari aspetti religiosi. Ma facendo lo slalom
attraverso queste tesi contrapposte io provo a continuare il mio viaggio tutto interno all‟agricoltura.
Ora, come avrete capito questi sono solo accenni veloci per dare il senso della vastità della
problematica, e sono fatti in modo da affrontare solo superficialmente il problema (sapendo poi che
molte altre tesi divergenti si contendono l‟essenza di questa discussione, come quella –pure degna
di considerazione- della continuità paleolitica). Per quanto siano accese e discordanti queste dispute
accademiche, una cosa però si può dire: l‟agricoltura si espanse per l‟Europa utilizzando il corridoio
danubiano (ma per alcuni studiosi la contaminazione fu molto più culturale che demica, e questo è
facile da intuire, visto che il seme del grano può viaggiare molto più veloce dei popoli che lo
coltivano). Vari studi hanno confermato questo tragitto, con ricerche tanto ampie e documentate da
arrivare a calcolarne la velocità stessa d‟irradiamento (che –approssimatamente - si può stimare in
145
circa un chilometro all‟anno). Ecco allora determinato e documentato che il grano, entrando in
Europa da est, impegnò circa quattromila anni per arrivare fino alla Scozia e alla Norvegia (che
erano allora tra i più lontani e più nordici areali radiali della sua coltivazione).
Personalmente non ho strumenti per eccepire e –nello sviluppare il mio ragionamento- cerco di
tenere la barra lontana dalle tante tesi contrapposte (che interessano più la genetica delle
popolazioni e la linguistica). Penso però che ci sia una cosa da sottolineare: tutti questi studi, fatti
nel tentativo di analizzare l‟Europa negli ultimi millenni prima dell‟inizio della storia, hanno come
base d‟analisi quella che possiamo definire come una biocenosi continentale; ossia una particolare
tipologia d‟alleanze basata sulla coltivazione delle specie che ben si adattano a certe specifiche
condizioni che possiamo definire “a clima freddo-temperato”: il grano tenero e gli ortaggi
primaverili-estivi, a cui si aggiungono l‟allevamento delle pecore da carne (quelle coperte da un
folto vello), dei bovini (quelli che daranno poi origine alle razze specializzate nel produrre latte) e
successivamente quello dei cavalli (sto solo citando le specie più importanti). Questa è una
biocenosi che –sostanzialmente- corrisponde ancora oggi alla base produttiva dell‟agricoltura
continentale europea, ma che ha il limite di essere solo parzialmente applicabile all‟agricoltura del
Mediterraneo. Questo perché -per sostanziali differenze climatologiche- le grandi civiltà
mediterranee si sono sviluppate partendo da un modello agronomico completamente diverso; un
modello nuovo rispetto a tutti quelli conosciuti fino ad allora, caratterizzato da una innovativa
tipologia d‟alleanze che si andò aggregando nell‟area mediorientale -compresa Cipro, che di
quell‟area è un‟estensione isolana-. Ora è facile intuire che seguendo il nostro modus pensandi è su
questa biocenosi mediterranea e sui popoli che contribuirono ad organizzarla che noi dobbiamo
concentrare le nostre attenzioni, perché fu quella che funzionò da base produttiva di alcune delle
grandi civiltà del mondo classico: cretese, minoica, fenicia.
Una biocenosi che, una volta formatasi, si mosse verso occidente seguendo migrazioni (demiche e/o
culturali) realizzate non grazie agli zoccoli delle greggi e neppure attraverso le ruote dei carri, ma
grazie alle vele che già dai tempi arcaici solcavano il Mediterraneo. Storie antichissime che noi
conosciamo per lo più attraverso i miti fondativi elaborati nelle terre del loro approdo.
Un tema che ha diverse similitudini con quanto abbiamo appena detto degli indoeuropei: migrazioni
di popoli antenati dei semiti (quindi proto) o di popoli semitici (esempio i Fenici –che tra i
colonizzatori semitici sono i più famosi, la cui migrazione fu –però- molto più tarda), e/o
migrazioni di popolazioni autoctone (quindi pre) che abitavano quelle zone prima dell‟arrivo dei
popoli semiti; che molti ritengono provenissero dalla penisola Arabica, o dalla Mesopotamia
(ricordo che con il regno di Akkad, si ha la prima cultura linguisticamente semitica).
Essendo queste migrazioni (e/o le relazioni culturali) avvenute per mare, è ovviamente impossibile
seguirne la scia, una situazione complicata anche dal fatto che la loro stabilizzazione lungo tutte le
coste del mediterraneo fu poi circoscritta e/o cancellata dalla sovrapposizione di altri imponenti
flussi migratori provenienti dal nord, quelli che portarono dei popoli indoeuropei a stanziarsi in
Grecia, Italia, e nella penisola Iberica. Bisogna però dire che intorno a queste migrazioni
intermediterranee c‟è una specie di “damnatio memoriae” (ricordo che ancora non siamo in grado di
146
interpretare molte delle loro lingue), dalla quale emergono però alcuni aspetti determinanti della
cultura e della socialità europea.
Un insieme d‟eventi che descrive l‟Europa come un continente in costante cambiamento, dove il
preesistente tessuto sociale neolitico è stato rimescolato dagli indoeuropei che hanno portato tra le
cose e pensieri: la struttura patrilineare, nuove forme nell‟organizzazione sociale, le lingue e un
modello agricolo basato su delle alleanze “continentali”; e da popoli di provenienza mediorientale
che hanno lasciato a loro testimonianza una boofilia con il toro come animale sacro o sacrale (un
atteggiamento che parte dai bucrani di Çatal Hüyük, tocca l‟epopea di Gilgamesh e poi tutta l‟area
semitica fino al Mitraismo, si sposa con la taurocatapsia cretese –così si chiama il rito del salto del
toro- e , attraversando nel tempo e nello spazio tutto il Mediterraneo, arriva ad oggi con le corride e
le corse dei tori in Spagna e Portogallo), con un culto ctonio per le pietre, un‟oralità che è diventata
mitologia, una grande innovazione nei modelli agricoli che vedremo tra poco, e degli aspetti
salienti della nostra religiosità occidentale, dove –ancora oggi- i culti della Grande Madre vengono
traslati nella venerazione per una Vergine Genitrice. Per non essere criptico vorrei però spiegare che
cosa intendo per “culto ctonio delle pietre”. Tutti sappiamo l‟importanza che la Ka‟ba della Mecca
riveste per i credenti mussulmani, o quella che hanno le pietre del Tempio di Salomone per
l‟ebraismo; ma c‟è anche da ricordare i Betili innalzati dai Sumeri o quelli dei Siro-palestinesi e
sacri ad Astarte. Questi culti furono in parte ripresi nel mito greco di Deucalione e Pirra –che
ripopolarono la terra desertificata dal Diluvio gettando dietro di se delle pietre che si trasformavano
in uomini e donne-, e la famosa allocuzione di Gesù di Nazareth: tu sei Pietro, e su questa pietra, Io
edificherò la mia chiesa! Ora il mondo è pieno di pietre sacre, Dolmen e Menhir, ma credo di non
sbagliare dicendo che questi culti nel Medioriente hanno particolari aspetti eucaristici.
Ma lasciamo questo racconto di rimescolii di popoli e concentriamoci invece sul nostro percorso,
perché siamo arrivati ad uno snodo dirimente: cosa c‟è di particolare in questo modello
mediorientale che abbiamo citato più volte senza averlo ancora affrontato? Avevamo già parlato di
una biocenosi nata a sud della Mezzaluna fertile; quella dove il grano duro (capace di resistere alla
siccità primaverile) funge da cereale basico; dove ci sono le leguminose e gli ortaggi (ma quelli a
ciclo autunno-vernino come i ceci o le fave e lenticchie, che nascono in autunno, crescono in
inverno e si raccolgono prima dei caldi estivi); dove c‟è una estesa zootecnia, che ha però per base
all‟allevamento dei bovini da carne con le grandi corna e non da latte, e pecore e capre da latte e
non da carne (sto solo definendo le caratteristiche zootecniche primarie, perché –ovviamente- le
bovine da carne fanno anche il latte –ma poco-, e le pecore da latte vengono macellate anche se
producono poca carne). Ma queste differenze, pur importanti, non sono certo sostanziali; la
differenza vera sta nel fatto che la biocenosi mediorientale introduce nel Mediterraneo, come sua
architrave portante, la coltivazione della più importante triade arborea di tutta l‟agricoltura
mondiale: l‟ulivo, la vite e il fico, a cui possiamo sommare anche il mandorlo e il carrubo e il
melograno. Un insieme arboreo che in forma selvatica era ed è presente in un areale assai vasto
dell‟Asia occidentale, ma che nel bacino del Mediterraneo ha potuto estrinsecare il suo massimo
potenziale produttivo. Anzi, una triade arborea che è diventata sinonimo stesso di Mediterraneo, e
che da sola è stata capace di far uscire il grande mare della classicità dai tempi oscuri della raccolta
147
di drupe e di ghiande, e di portare quei popoli –figli di un radicale rimescolio di geni e di tradizionia diventare protagonisti di alcune delle civiltà più spettacolari della storia umana.
Confrontiamo questa realtà con quello che erano le condizioni dell‟ecumene agricolo nei primi
secoli del II millennio prima dell‟era cristiana. La grande civiltà sumerica era già collassata e la
Mesopotamia era passata sotto il controllo di popolazioni di origine semitiche, la Cina stava
gettando le base della sua struttura imperiale, mentre in Egitto la IX dinastia stava riunificando il
paese riprendendo il controllo del delta del Nilo (che diventerà il nuovo centro produttivo del paese)
e la civiltà indiana si andava avviando verso il suo definitivo declino. Tutte queste civiltà avevano
in comune lo stesso substrato agricolo, perché si erano sviluppate avendo per base colture quasi
esclusivamente colture erbacee. Come abbiamo già visto erano stati i surplus produttivi derivati
proprio da queste piante erbacee a consentire la stabilizzazione di queste società, ma la loro
coltivazione era possibile solo grazie all‟utilizzo delle acque di falda o di quelle d‟irrigazione, e
grazie alla capacità di queste acque di rigenerare le terre messe a coltivazione continuativa (e in
diverse parti il modello stava mostrando i segni di una sua implosione); questo perché i limiti che
l‟ambiente naturale imponeva all‟agronomia di queste civiltà erano così stringenti e definiti da
determinare l‟incapacità di superarli. Le società fluviali non avevano quindi potenzialità espansive
per il semplice fatto che erano obbligatoriamente legate alle caratteristiche dei territori dove si erano
sviluppate. Società ricche ma fragili (perché bastava un perturbamento climatico per metterle
irrimediabilmente in crisi) e costrette a subire - nel corso dei secoli- ripetute invasioni, senza che
mai nel corso della loro lunga storia abbiano avuto la funzione o il ruolo di invaditrici. Potremmo
definirle – forzando un poco i termini- società saprofite delle terre su cui si erano sviluppate, e che
senza quel pabulum di coltura non avrebbero avuto modo di sviluppare diversa cultura.
All‟opposto di questo modello si collocavano i tanti e piccoli popoli che abitavano il vasto corpo
eurasiatico e africano. Queste erano società portate ad una obbligatoria mobilità, in parte perché
discendevano da culture pastorali nomadi, e in parte perché il loro modello agricolo non era in
grado di stabilizzare la produzione di surplus. Le costanti ondate migratorie che dalla parte interna
dell‟Asia si sono mosse verso le periferie vanno collegate a questa problematica; dove, se anche la
buona terra era una costante, il clima era una variante non normalizzabile. Quelle pre, proto, o
indoeuropee erano società che non padroneggiavano le tecniche agronomiche che avrebbero potuto
far in modo di stabilizzarle sulla terra, erano società che pure dopo aver abbandonato la sola pratica
pastorale erano obbligate ad una agricoltura transumante, perché non avevano strumenti per
reintegrare la fertilità dei terreni e renderne costanti i surplus Non c‟erano fiumi esondanti (fatto
salvo l‟area compresa tra il Sir Daria e l‟Amur Daria, di cui abbiamo già parlato e il bacino del lago
Ciad, che però si stava inaridendo), non c‟era un clima che consentisse rese produttive regolari e la
bi o tristagionalità delle colture. Erano piccoli popoli obbligati alla caccia, alla parziale raccolta,
all‟allevamento semi nomade e ad un‟agricoltura di sopravvivenza, popoli che anche dove vivevano
in accampamenti stabili, erano usi ad una stabilità precaria, che poteva durare solo qualche anno.
Era un‟agricoltura tributaria dalla foresta e dall‟incolto, che ancora svolgevano la funzione di
compensazione produttiva. Un‟agricoltura brucia e coltiva, simile a quelle ancora in uso presso le
ultime popolazioni amerinde del sud America e in alcune zone dell‟Africa o dell‟Australia.
148
Quelle mediterranee –nate da terre dove mancano i grandi fiumi, dove l‟acqua piovana scarseggia
e/o è concentrata solo in autunno e in inverno, dove la terra era spesso sassosa e l‟estate
implacabile- come hanno potuto competere e superare le società che le avevano precedute?
Fu proprio grazie alla coltivazione della triade arborea che le società del Mediterraneo trovarono il
modo di mettere “radici”, grazie alla stipula di queste nuove e particolari alleanze con degli alberi (
quindi con specie poliennali e non stagionali che per crescere non avevano bisogno di rinnovare la
fertilità della terra) e grazie all‟introduzione di nuove elaborazioni tecnologiche e scientifiche da
applicare alla relazione simbiotica con quegli alberi. Tanto da poter dire che se quelle precedenti
erano civiltà “fluviali” (ossia tributarie di quelle acque), quelle nate nel mondo mediterraneo sono
state civiltà partorite dalle sole capacità e intuizioni umane e dall‟atteggiamento espansionistico dei
nostri nuovi alleati. Civiltà che non hanno ridisegnato la terra con un graticcio idrico, ma che hanno
disegnato alleanze che sono esse stesse emblema di quelle nuove terre. C‟è infatti qualcosa di più
mediterraneo di una vecchia e contorta pianta d‟olivo, che pure non è di origine mediterranea?
Ecco allora che conoscere quali sono gli aspetti agronomici salienti ed innovativi di questa specifica
biocenosi e sapere grazie a quali tecniche di coltivazione si sia potuta espandere lungo tutte le coste
del Mediterraneo (condizionate non più dalla facilità d‟accesso all‟acqua, ma solo da specifiche
condizioni climatiche e quindi ripetibili in ogni luogo quelle condizioni si ripresentassero) ha –per
l‟epoca storica che stiamo prendendo in considerazione- molto più importanza che non conoscere i
modelli d‟espansione dell‟agricoltura continentale europea e dei popoli indoeuropei che ne furono
portatori!
Una triade arborea che in forma selvatica – in buone condizioni pedo-climatiche- è di per se stessa
esuberante: piante di fichi che si piegano sotto il peso dei frutti, olivastri carichi di drupe, e viti
selvatiche che come una liane s‟aggrappano agli alberi per andare a produrre i loro grappoli sul‟alto
delle cime. Ma anche piante che possono resistere e continuare a produrre nelle condizioni di clima
più estreme (come fa il fico nel pieno della stagione asciutta), o che dopo aver superato senza
problemi l‟estate più secca, gonfiano i frutti con le prime piogge dell‟autunno (come la vite o
l‟olivo), perché ben attrezzate a resistere alla sua ricorrente variabilità. Ecco allora l‟importanza
insita in questo scambio simbiotico (capace di valorizzare le mutazioni più interessanti) o il senso
da dare ad una manipolazione (come la potatura) capace di regolarne la produttività. Ecco il valore
del legame tra queste piante e gli uomini, che si sono fatti veicolo della loro propagazione, facendo
in modo che i nuovi cultivar fossero scelti in base all‟utilità relativa per la nostra specie e non a
quella naturale buona per i cinghiali e gli uccelli.
Perché questo fecero quei lontani popoli mediorientali: scelsero le mutazioni più interessanti, le
riprodussero per talea, e ne governarono la crescita e la riproduzione con potature attentamente
ponderate, così da fare in modo che le piante producessero frutti più grandi, più esposti ai raggi del
sole, più dolci e più sani. In altre parole più utili! Non aumentando, ma cambiando il modo di
trasformare i raggi del sole in preziose riserva energetiche sotto forma di zuccheri, oli e alcol. Un
apporto di energia concentrata; non utilizzabile nella nostra alimentazione come piatto base , ma
certamente utile a rendere il cibo più buono e l‟atto dell‟alimentarsi più gioioso. Su questi piaceri
149
della gola e dello spirito gli uomini del Mediterraneo orientale fecero la loro fortuna commerciale
(ed in fondo anche la nostra fortuna di interessati consumatori).
Sappiamo dai ritrovamenti archeologici che questa biocenosi ha cominciato ad aggregarsi nell‟area
compresa tra le coste mediorientali e il pianoro turco-siriaco, compresi Cipro e l‟area palestinese,
mutuando –in parte- le alleanze sperimentate nei millenni lontani della cultura natufiana e
consolidate nella depressione del Mar Morto e nelle aree limitrofe, ma aggiungendo a questa
biocenosi primigenia le prime coltivazioni arboree della storia dell‟umanità ( ho escluso da questo
discorso, ma non per dimenticanza, la coltivazione della palma da dattero: primo perché ha una
storia più tarda e secondo perché sento il bisogno di mettere dei limiti alla trattazione).
Presumibilmente una delle prime piante ad essere associata all‟agricoltura sia stata il fico, la cui
coltivazione potrebbe risalire ad oltre 11.000 anni fa, un tempo così precoce da precedere di quasi
5.000 anni qualsiasi altra pianta in Medio Oriente. Questo aspetto non ci deve sorprendere, perché il
fico –anche domestico- è una pianta che cresce bene anche in mezzo alle rocce (anzi si potrebbe
quasi dire, che viste le condizioni pedologiche estreme che è solito sfruttare, un terreno roccioso è
un ottimo medium su cui fare crescere il fico). La pianta poi richiede una gestione minima
(ovviamente non sto parlando della coltivazione industriale dei fichi), perché è quasi esente da
malattie e ha un‟ottima resistenza alla calura o alla siccità estiva (anzi un‟estate intensa rende i fichi
più dolci). Una pianta che non teme le gelate tardive o venti salmastri che ne brucino i fiori (se
improvvisamente vi venisse in mente di non aver mai visto i fiori del fico, sappiate che la pianta li
tiene nascosti all‟interno di quello che noi consideriamo il frutto). Un pianta che non va trattata, non
va irrigata e –soprattutto- non va potata (torneremo tra poco su questo). E‟ stata la prima pianta
domestica per il semplice fatto che era la pianta più portata alla domesticare, visto che –ancora
prima che si cominciasse a coltivarla- alcune piante selvatiche già riempivano le sporte dei nostri
antenati con morbidi frutti zuccherini. I fichi di Smirne sono ancora oggi famosi in tutto il mondo, e
forse proprio da questa area dell‟Asia minore –dopo essersi domesticata nella limitrofa zona
mediorientale- la pianta è partita per conquistare il suo attuale areale di distribuzione. Però non fate
l‟errore di pensare che i fichi siano una cosa da poco. Prima che iniziasse la loro coltivazione
massiva il gusto e il quantitativo zuccherino che essi hanno apportato alle paleo diete si poteva
trovare solo nel miele. I fichi poi erano un ottimo conservante e loro stessi –una volta seccati- si
potevano immagazzinare per tutto l‟inverno, sono utilizzati per preparare degli ottimi probiotici (il
kefir d‟acqua che è tipico del Caucaso e del Mar nero, un‟altra importante area di coltivazione del
fico) e alcuni distillati. Per le diete relativamente povere di sapori dei primi coltivatori i frutti del
fico –dolci e abbondanti- dovevano sembrare una vera benedizione.
Tanto semplice è stato apprendere le basi della coltivazione del fico quanto difficile è stato
elaborare le tecniche necessarie alla coltivazione dell‟uva e degli olivi. Perché mentre il primo
cresce naturalmente, si raccoglie e si consuma direttamente, la vite e l‟olivo sono il risultato di una
complessa gestione agronomica e di una elaborata manipolazione alimentare.
L‟olivo è una pianta ermafrodita portata all‟autoincompatibilità (cioè incapace di autofecondarsi)
presente in forma selvatica in un vasta area tra il Medioriente e l‟Iran. E‟ probabile che proprio
150
questa sua caratteristica sessuale abbia prodotto quegli incroci che avevano –per i primi agricoltoridelle caratteristiche particolarmente interessanti nel portamento e nei frutti.
Le prime testimonianze della sua domesticazione le troviamo in Siria, in Palestina, dove le scoperte
archeologiche hanno riportato alla luce degli orci per l‟immagazzinamento dell‟olio e macine
olearie che sono databili intorno al 5000 a.C. . Ad Ebla la sua coltivazione era così diffusa da farne
un prodotto d‟esportazione e già dal III millennio a.C. il commercio dell‟olio di oliva era così esteso
da essere regolato nel codice di Hammurabi. Questo perché – come racconta Erodoto- a Babilonia
non crescevano alberi di olivo e le popolazioni erano costrette a servirsi dell‟olio di semi di
sesamo. Un aspetto che non deve sorprenderci: l‟olivo è pianta che cresce su terreni asciutti e riesce
a fruttificare anche su terreni poveri, mentre rifugge le terre nere e umide, anche quando queste
sono straordinariamente fertili. La pianta che cresce su una terra austera e che ripaga gli uomini con
un prodotto profumato dal colore dei raggi del sole e che, come il sole, arde dando luce. Non
stupiamoci allora della sua funzione mitopoietica.
La mitologia narra che Atena contese a Poseidone il possesso dell‟Attica. A dirimere la questione fu
chiamato Giove che indicò vincitore chi tra i due contendenti avesse fatto agli uomini il dono più
utile (evidentemente a quei tempi il dono aveva ancora un valore economico). Poseidone, lanciando
il suo tridente, fece uscire dalla terra un cavallo; Atena, toccandola con la sua lancia, fece emergere
dalla terra una pianta d‟olivo. Giove rifletté attentamente e -proclamando Atena vincitrice- le diede
il possesso dell‟Attica. Gli uomini di quelle terre, riconoscenti, le dedicarono la più grande città di
quelle terre: Atene.
(Ho riportato questo mito perché nella sua ritualità fondativa sembra suggerire che i Greci
ritenessero la pianta dell‟olivo -immigrata dal medio oriente-, più importante del cavallo –di
importazione indoeuropea-). Ma continuare è superfluo, si sono riempiti libri e libri sui i miti e le
storie collegati all‟olivo e alla l‟olio derivato dalla sua coltivazione, e la sacralità per le grandi
religioni monoteiste attesta la particolarità di questo albero.
L'areale della vite silvestre era ed è più esteso di quello dell‟olivo, e questa capacità di adattamento
si riscontra anche nella vite domestica, che –non a caso- dall‟epoca dei romani ha abbandonato il
mediterraneo per andare a colonizzare, inebriare e confondere, i popoli della Gallia, della Belgica,
della Pannonia, e di tante altre terre lontane dal mare Mediterraneo. La vite silvestre è una specie
dioica (ossia esiste una pianta maschile e una femminile), con una piccola percentuale ermafrodita
(il termine botanico è: monoica). Da questa minoranza genetica potrebbero discendere le viti
coltivate (che sono tutte monoiche), domesticate da qualche parte dell‟areale della Mezzaluna
Fertile cinque o sei millenni a.C. . Il tempo e il luogo -dalla Georgia fino alla Giordania - sono per
questa trattazione di secondaria importanza e questo tipo di contesa appare troppo campanilistica
per suscitare ulteriori interessi; mentre appare certo che la sua coltivazione sia stata precoce, ma
lenta e complessa deve essere stata l‟acquisizione delle metodologie per fare del buon vino. Il
ritrovamento di alcune antiche giare, sembrerebbe dimostrare che l‟uso della resina per migliorarne
la conservazione fosse molto antico, e questo non deve sorprendere perché la vinificazione è un‟arte
che richiede un notevole accumulo di conoscenze tecniche, oltre all‟acquisizione di diverse pratiche
agronomiche: c‟è da spremere il mosto, regolarne la fermentazione (prima aerobica, poi
anaerobica), deciderne la durata, scegliere il contenitore appropriato perché tutto questo avvenga;
151
poi c‟è il periodo del riposo fermentativo (come un lungo ritorno invernale nel grembo della terra),
poi c‟è il filtraggio e (se necessario) la chiarificazione, la scelta del vitigno, il tipo di terreno su cui
coltivarlo e la giusta esposizione; c‟è da decidere la tipologia del suo portamento; c‟è da scegliere il
modello di potatura (che nessuna vite è coltivata senza essere anche potata) e c‟è da prevenire e
curare le eventuali malattie (e queste sono solo le pratiche principali). Un insieme complesso di
conoscenze tecniche e di accumulati saperi.
I primi riferimenti ad una viticoltura specializzata probabilmente precedono di poco il 2.000 a.C. e
li troviamo nell‟area egea, dove –per adattarla alle condizioni pedo-climatiche- la vite era già
coltivata ad alberello (è la forma canonica di coltivazione, ancora oggi in uso), intervenendo sulla
pianta con radicali potature (questa tipologia di conduzione era molto diversa da quella praticata
molto più tardi in Etruria dove la vite - poco potata- era coltivata “ad arbustum”, cioè maritata a
degli alberi che funzionavano da tutori). Questo ci riporta al tema della “potatura”, che avevamo già
trattato in un precedente capitolo. Il “togliere” per avere è un tema d‟indubbio interesse, perché
modifica i presupposti della produttività naturale e introduce un‟elaborazione concettuale che è una
delle basi della scienza agronomica. In questo caso non ci troviamo davanti solo ad una
domesticazione genetica, ma anche ad una domesticazione per coercizione, pensata e realizzata per
fare in modo che la pianta faccia esattamente quello che noi desideriamo.
Ma non bisogna credere che questo potere coercitivo sia unidirezionale (come spesso accade in
questo tipo di relazioni): la vite è si una schiava ubbidiente, una liana che acquisisce molteplici
forme, ma gli uomini cadono spesso succubi di questo suo essere malleabile, e le sovrastrutture che
governano le società degli uomini conoscono bene l‟ambigua relazione che ci lega a questa pianta e
spesso si sono appropriate della commercializzazione dei suoi prodotti derivati (alcol nelle varie
forme) in condizioni di monopolio.
Questo sottrarre come mezzo per arrivare al bene è tipico di tutto il bacino del Mediterraneo, dove
la terra soffre la durezza dell‟estate, e dove –per produrre frutti utili- le piante devono essere
allineate a questa legge del minimo (che io sappia soli i giapponesi –attraverso la potaturaarrivarono all‟orrido sublime dei bonsai). Ma il riferimento non è riservato alle sole piante, la
castrazione dei giovenchi altro non è che il corrispettivo animale della potatura. Senza la
castrazione non ci sarebbero i buoi, e senza buoi non ci sarebbero arature; quell‟atto di muovere la
terra che nel Mediterraneo è essenziale per poter seminare e per poter gestire al meglio
l‟evotraspirazione primaverile-estiva (il terreno arato assorbe in autunno molta più acqua piovana, e
la sua erpicatura primaverile diminuisce considerevolmente la traspirazione capillare dell‟acqua
trattenuta nel terreno). Questo raggiungere il bene con la “sottrazione” è anche diventato una forma
di pensiero, perché ad esso si lega l‟idea del “digiuno” dalle tentazioni della carne, uno dei concetti
fondamentali delle religioni monoteiste. Quella mediterranea –per aver domesticato dei possenti
bovini da carne (che castrati si potevano trasformare in ottimi buoi da lavoro) è stata una delle
prime agricolture ad utilizzare la forza lavoro animale. Tanto da poter dire che se le civiltà fluviali
hanno come tipico strumento di lavoro la pala e la zappa, quella mediterranea è veramente la civiltà
dei buoi e dell‟aratro.
Con l‟introduzione dell‟arboricoltura poi il concetto di biocenosi dinamica cambia radicalmente la
sua natura: non siamo più di fronte all‟occupazione dei limiti spaziali e al rispetto dei loro vincoli, si
supera il concetto “oasi”, che fa sì -come in Egitto - che si trasformi totalmente l‟ambiente naturale
152
ma non si proceda oltre per l‟impossibilità di modificarne le condizioni agrarie. Con l‟integrazione
dell‟arboricoltura (ovviamente poliennale) e delle potature (che la adattano ai vari ambienti) l‟allora
ecumene agricolo rompeva la dipendenza idrica e si preparava ad espandersi fin dove le condizioni
del clima, della temperatura e dell‟irradiazione solare lo avessero consentito ( nel Mediterraneo
questa espansione è stata facilitata dal fatto di essere un mare a latitudine orizzontale).
Queste sono le ragioni agronomiche, climatiche e ambientali che hanno consentito lo spostamento
verso occidente di questa biocenosi che aveva integrato nelle sue alleanze anche le coltivazioni
arboree. Il veicolo dell‟espansione invece sono state le tante migrazioni di popoli: le più arcaiche
avvenute forse per guerre o per crisi produttive (prima che le biocenosi acquisissero caratteri di
piena funzionalità), le più tarde –probabilmente- legate alle dinamiche di espansione demografica.
Una cosa però appare certa: queste biocenosi mediterranee non sono mai state capaci di produrre
quei significativi surplus cerealicoli che avevano e/o stavano caratterizzando le civiltà fluviali, e le
loro società dipesero dallo scambio di olio, vino e altri prodotti agricoli trasformati con i paesi forti
produttori di cereali; lucrando significativamente su questo scambio disuguale (come sempre
avviene acquistando materie prime in cambio di beni lavorati). Quanto questo aspetto produttivo
abbia inciso sulla struttura sociale e politica è difficile da dire, una cosa è però evidente: nei paesi
della biocenosi mediterranea (quella che sarà successivamente l‟area di espansione greca e fenicia)
non sono mai sorti dei grandi regni, ne tantomeno imperi, ma sono invece emerse delle straordinarie
civiltà nate dall‟aggregazione culturale di varie città stato (l‟impero macedone e poi l‟impero
romano non sono due eccezioni che confermano la regola ma due realtà agronomiche simili che
integreranno il loro modello produttivo –originariamente continentale- con quelli mediterranei; anzi
ne diventeranno i diffusori).
Un aspetto è però importante da sottolineare: l‟espansionismo agronomico della triade arborea non
è cosa semplice da maneggiare, specialmente per società che non hanno voluto o potuto capire le
pericolose ripercussioni ecologiche di questo fenomeno. Nell‟area Egea ne sono una prova
significativa la civiltà minoica e quella micenea; due civiltà che fecero dell‟esportazione di prodotti
agricoli lavorati (olio, vino e formaggi) una delle basi economiche della loro ricca talassocrazia
(società che basano la loro economia sul dominio marittimo) e che crollarono quasi
contemporaneamente per cause che lasciano ancora aperti molti interrogativi. Cretesi e micenei
furono tra i primi ad intuire il potenziale economico di questi nuovi prodotti agricoli e a prendere il
controllo dei loro commerci, caricando le loro navi di orci ripieni di olio e di vino, oltre che di
ceramiche, armi e gioielli. Le ceramiche e gli ori erano per pochi, ma l‟olio per il condimento o per
il funzionamento delle lampade, ed il vino, avevano il potenziale per diventare elementi di uso
comune, utili ad illuminare la notte e a trarre compiacimento. Questa fu la grande intuizione politica
consentita dalla biocenosi mediterranea, questo fu il cardine su cui si svilupparono i ricchi
commerci del Mediterraneo, che unirono tra loro genti e paesi diversi (dopo molti secoli un‟altra
decisione politica proibì il consumo di vino e la vite fu bandita da molte di quelle terre). Ho osato
dicendo che l‟eccessiva specializzazione produttiva, legata all‟intensificazione di quei commerci, fu
una delle concause del tracollo di quelle civiltà; non ho documenti storici per affermarlo, ma credo
nella logica delle cose e nell‟ingordigia irrazionale degli uomini. Comunque sia: quelle civiltà
crollarono repentinamente, e dopo ci fu un periodo di buio. Poi, in luoghi limitrofi, lentamente,
153
cominciarono ad emergere nuove colture, nuove aggregazioni urbane, che portarono i villaggi a
divenire nuove città. Nuovi popoli con una vita economica, sociale e culturale così attiva da far
emergere nuove civiltà. Civiltà straordinarie che si contesero il controllo marittimo del mondo
classico e debordarono oltre ad esso. I fenici colonizzarono molte coste dell‟Africa mediterranea e –
varcando le Colonne d‟Ercole- andarono a navigare per l‟oceano; i greci –colonizzando la sponda
europea del Mediterraneo, l‟Asia minore e il Ponto - non furono da meno!
Periplo in greco significa circumnavigazione. Di questi antichi viaggi per mare ci sono pervenuti
alcuni manoscritti contenenti la narrazione in forma più o meno schematica. Tra gli altri si
ricordano: il Periplo massaliota – un manuale mercantile forse degli inizi del VI secolo a.C., che
descrive le rotte mercantili lungo le coste atlantiche nell'Europa, con una descrizione di quella che
sarà conosciuta come la "via dello stagno"-; il periplo di Annone (VI secolo a.C.), che fu il viaggio
intrapreso dal questo grande navigatore fenicio sulla costa orientale dell'Africa con più di 60 navi,
dove si narra di incontri con mostri umanoidi e strani gorilla. Anche il greco Pitea di Massilia
(Marsiglia) ci ha lasciato una narrazione scritta del suo viaggio marittimo verso le coste dell'Europa
settentrionale, come pure il periplo di Scilace di Carianda o quello di Scimno. Per finire con il
Periplus Maris Erythraei (periplo del mare Eritreo o mar Rosso) e lo stadiasmo del Mare Magno, il
più importante portolano antico giunto fino a noi.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Periplo
Ecco il modello mediterraneo estendersi allora lungo tutte le coste, superare lo stretto di Gibilterra
(il Portogallo, il nord del Marocco atlantico, le Canarie, sono a tutti gli effetti regioni
“mediterranee”; così come lo sono le coste del Mar Nero), ecco i commerci estendersi in scambi
ampi di prodotti e d‟idee. Ecco nascere la prima economia mondo: dove le civiltà del Mediterraneo
facevano commercio con il nord dell‟Europa e – attraverso il Mar Rosso- con le grandi civiltà
asiatiche, e dove Cartagine e l‟Egitto fungevano da snodo commerciale per i regni sub-sahariani.
Vista questa realtà non c‟è da sorprendersi se Eratostene volle misurare la circonferenza del mondo;
una cosa che farà esclamare ad Archimede: datemi una leva per sollevarlo!
In agronomia quelli furono secoli di attenti studi e di perfezionamenti, il cui climax fu
probabilmente raggiunto dal trattato di ventotto volumi scritto nel III secolo a.C. da Magone il
cartaginese (il cui testo originale è andato perduto e di cui abbiamo piccoli frammenti nei testi greci
o latini) e dagli scritti di Teofrasto (Ereso, 371 a.C. – Atene, 287 a.C.), il filosofo che è considerato
il “padre della tassonomia” e che ha gettato le basi della botanica.
Poi venne Alessandro; venne greco da uno dei paesi cerniera tra il mondo mediterraneo e l‟Europa
continentale; venne non con l‟idea di sollevare il mondo ma di conquistarlo – giovane, sognatore e
arrogante, seguito da altri che gli assomigliavano- e il mondo greco arrivò fino alle pianure
dell‟India; finché la lontananza fece comprendere a quei giovani che il mondo era troppo grande per
essere governato da uno solo tra gli uomini.
Fu una meteora che illuminò la storia e dopo di lui rimasero i regni fondati dai suoi amici più vicini;
nella storia agraria rimase invece l‟arrivo nel Mediterraneo dei cultivar orientali dell‟albicocco,
della pesca e forse del susino. Poi venne Roma!
154
Roma
Non credo esista nella storia umana un altro luogo, fisico o mentale, paragonabile a Roma!
Qualcuno potrebbe pensare: pro domo sua! Come dicendo che poche persone sfuggono ai
condizionamenti delle proprie origini. E –forse- a questa critica dovrò prestare la giusta attenzione,
benché la mia nascita non abbia poi nulla a che fare con le radici della mia famiglia. Ma arrivato
alla metà di questa opera consentitemi un momento di tranquillo rilassamento, e se per questo breve
paragrafo introduttivo parlerò con quella che potreste trovare come una enfasi particolare,
perdonatemi questo comportamento da dilettante.
Sono però sinceramente convinto che nessuna altra città del mondo – non Città del Messico
(capitale indiscussa della Mesoamerica), non Gerusalemme e neppure Pechino (con la sua storia
straordinaria)- siano state capaci di istillare nel nostro condotta collettiva così tanti risvolti
comportamentali come Roma ha fatto in maniera così pregnante; mischiando insieme il sacro con il
profano, accompagnando con costante ingegno ed impegno la loro evoluzione nel corso della sua
storia millenaria. Pensate al diritto e alle forme di rappresentanza politica (mi riferisco all‟influenza
che Roma ha avuto sulla moderna concezione della giustizia e nell‟organizzazione del governo
delle cose pubbliche); alla determinazione con cui ha organizzato la più vasta rete di collegamenti
viari del mondo antico (da cui mutuiamo l‟importanza delle comunicazioni “libere” e veloci); al
concetto di salute pubblica e di distribuzione annonaria (due aspetti di quello che oggi chiamiamo lo
“Stato sociale”); all‟uso dello spettacolo per favorire politiche di consenso alle classi dirigenti o al
“vis pacem para bellum” (il presupposto ideologico che leggittimizza le funzioni “stabilizzatrici”
della forza pubblica e dell‟apparto militare), e capirete come il ruolo che Roma non è ascrivibile a
una delle tante città faro (quelle città capaci di influenzare il resto del mondo con il loro modo di
essere), ma a quello della più importante città “ponte” della storia umana. Una città, che avendo le
sua fondamenta gittate su diversi pilastri sostruttivi, è stata capace di assorbire e amalgamare
differenti influssi culturali, ricomponendoli in una malta così solida e possente da funzionare da
base per una parte significativa del nostro pensiero collettivo. Traslate questa riflessione nel campo
delle dottrine escatologiche e vedrete come la città abbia assorbito e rielaborato un culto
monoteistico di provenienza mediorientale (portatore dell‟idea di peccato, di perdono e di
redenzione), per coniugarlo con la sua “pietas” (l‟antica divinità preposta al compimento del
proprio dovere nei confronti dello Stato, della religione e della famiglia) e, soggiogando il tutto ad
una rigida forma di gerarchia mutuata dalla sue antiche forme statutarie, abbia gettato le basi
concettuali e millenaristiche della più importante “sovrastruttura” del nostro pianeta: la chiesa
cattolica romana. Quella che per secoli ha dettato i codici della morale occidentale (e non solo) e
anche quella che ha segnato il tempo con cui –tutto il mondo- misura la storia e lo scorrere delle
cose. Una presenza così pregnante che consentiva a Ignazio de Loyola di dire: lasciate agli uomini
la vita, ma la nascita e la morte sono cose nostre!
Non per niente parliamo di “civiltà romana” (cioè l‟espressione della città di Roma), invece di
parlare di civiltà cinese, egizia, greca (ossia espressione di ben più vasti territori).
155
Penso che questo derivi anche dal fatto che Roma è una città maternale, e –per logica conseguenzatotalmente femminile! Fecondata da molti, ma vera portatrice del concetto: “e plurimus unum”.
Questa Roma che giace, geograficamente e metaforicamente, su un vasto falsopiano che possiamo
intendere come un accogliente giaciglio. Non deve quindi sorprenderci se i suoi monumenti più
importanti, quelli per i quali è conosciuta in tutto il mondo, facciano riferimento proprio all‟idea di
grembo. I greci sceglievano delle collocazioni particolari dove poter costruire i loro teatri: delle
cavea naturali che poi incidevano affinché lo spettacolo umano e quello naturale si
sovrapponessero. I romani no! I romani edificavano i loro anfiteatri come se fossero grandi uteri
accoglienti: non è forse questo il senso del Colosseo e delle tante arene che i romani hanno sparso
per il mondo antico? E non è simile ad un gigantesco ovario l‟imponente costruzione del Pantheon
con il suo portico frontale e il grande oculo deiscente della cupola? E quando Bernini edificò il
grande colonnato di piazza S. Pietro, non rimanda la disposizione delle colonne a enormi labbra
vaginali che conducono al grembo mistico della basilica, con il tabernacolo che sovrasta l‟entrata
dei meandri della cripta e l‟obelisco esterno che assomiglia in modo di impressionante ad un
clitoride eretto?
Se non si capisce questa dimensione uterina di Roma, il peso e la funzione della sua componente
femminile, si perde la percezione di un aspetto importante del suo carattere. Roma è donna e madre;
una madre feconda, capace di amare di un amore possente i suoi figli (lo stereotipo insuperabile
rimane Cornelia -la figlia di quello Scipione, chiamato l‟Africano perché vincitore di Annibale- che
fu l‟espressione della più alta dell‟aristocrazia romana, ma che –in contemporanea- fu anche
l‟orgogliosa madre dei Gracchi, i tribuni estensori delle leggi agrarie favorevoli alla plebe; ma
questo mito archetipo attraversa i secoli e arriva fino all‟epoca recente, ad Anna Magnani e allo
straziante racconto pasoliniano di Mamma Roma). Nella sua dimensione maternale Roma è anche
un‟accogliente madre putativa, esattamente come il suo famoso animale totemico: la lupa
capitolina, trasposizione zoomorfa di Acca Laurentia, la prostituta sacra che con mammelle cariche
di latte adotta e allatta figli non suoi.
Esiste forse una relazione tra questa caratteristica maternale e la feracità naturale della sua terra, ma
esiste anche una componente culturale che con molta probabilità discende dalla precoce
commistione che i romani hanno avuto con gli etruschi (questo popolo che in parte discende da
un‟antica migrazione mediorientale), dove forte era il ruolo femminile e dove ricorrenti erano i
legami con le antiche divinità portatrici del culto della fertilità (tipicamente romana è Cerere, dea
madre del grano e della rinascita primaverile). E se Roma è famosa per i suoi generali, per i suoi
consoli e per i suoi papa re, non date troppo peso a questo aspetto; nella più importante città
sacerdotale del mondo (la città della sottrazione sessuale per motivi religiosi), gli uomini –specie
quelli più importanti- sono sempre figli o mariti di donne che li hanno spesso governati (ho sempre
pensato che sarebbe interessantissimo scrivere una storia di Roma vista attraverso il ruolo svolto
dalle sue donne). C‟è però un altro aspetto, anch‟esso di probabile derivazione mediorientale (una
componente che ha avuto un peso significativo nella formazione culturale della Roma arcaica) e che
è determinante per capire lo spirito romano: l‟attenzione maniacale per le fonti d‟acqua!
Conseguenza probabile di quella scrupolosità che i popoli mediorientali dovevano mettere sulla
gestione delle loro scarse risorse idriche, i romani (che come Latini erano di discendenza
156
indoeuropea e quindi portatori di un modello agrario continentale) acquisirono dagli etruschi (ossia
da input mediorientali) il senso e l‟importanza di gestire le fonti, le sorgenti ed i torrenti che –per
loro fortuna- sgorgano e scorrono copiosi dalla loro terra (nella religione romana Egeria –in un
interessante accostamento- è la dea delle fonti e dei parti a cui le donne incinte offrivano sacrifici
per invocarne il buon esito). Se non si capisce questo non si capisce il significato intrinseco degli
acquedotti (pur avendo i romani il fiume come facile risorsa idrica) e non si capisce l‟importanza
che i romani tributavano alle terme, che possono anch‟esse essere viste come un ventre caldo,
umido e accogliente. Io credo sia stata questa sacralità d‟acqua sorgiva e questa terra vista come
grembo -ossia l‟unione tra il principio maschile e quello femminile- che ha dato vita al concetto
tipicamente romano di Genius loci (lo spirito che anima i luoghi), che può essere considerato la vera
base concettuale su cui i romani – nel primo periodo della loro storia- costruirono il loro
straordinario modello agricolo, gettando una delle fondamenta della loro civiltà universale. Roma
infatti è stata la prima civiltà idraulica senza un fiume come fonte idrica d‟approvvigionamento,
proprio perché –ignorando il Tevere (a cui è stato dato il compito di congiunzione con il mare)- è
stata capace di gestire al meglio le mille piccole fonti idriche del suo territorio. Trovare e
valorizzare lo “spirito del luogo”, un atteggiamento che oggi sarebbe il caso di recuperare.
La riflessione non è retorica; in un precedente capitolo abbiamo sostenuto che sono stati i surplus
produttivi a permettere lo sviluppo delle civiltà. Abbiamo anche detto che quelle cerealicole –tutte
legate alla presenza di valli alluvionali bagnate da grandi fiumi- hanno poi dato vita a grandi imperi
centralizzati, mentre le civiltà commerciali –quelle caratterizzate da un‟attenta gestione di alcune
specie arboree (vite e olivo)- sono state l‟espressione economica e culturale di civiltà formate
dall‟aggregazione –spesso solo temporanea- di diverse città-stato. Se queste erano le condizioni
agronomiche del mondo conosciuto fino allora, come ha fatto Roma – città guida di un territorio
relativamente piccolo- a diventare la più grande metropoli del mondo classico? Come ha potuto la
sua agricoltura fungere da base economica per la costruzione del più vasto dominio territoriale
conosciuto fino allora? E quale modello agricolo ha potuto sostenere uno sviluppo demografico che
per alcuni secoli ha continuato ad offrire braccia armate alle sue tante legioni?
Fatte le premesse concettuali (che come tutte le cose concettuali sono ampiamente discutibili) e
sollevate queste domande, proviamo ora delineare il quadro degli approcci pratici e ideologici con
cui i romani hanno gestito il loro territorio, e proviamo a definire in cosa ha consistito l‟originalità
del loro modello agrario; cercando di capire come (e se) i temi relativi all‟agronomia abbiano dato
un contributo alla storia generale dell‟Urbe e se quel contributo è stato così significativo da
influenzare –indirettamente- anche la nostra storia collettiva.
Ma, prima di procedere oltre c‟è bisogno di un‟ulteriore preambolo, per essere sicuri di dare a
Cesare solo quello che è di Cesare.
Con il nome di popoli dell'Italia antica si indicano quelle popolazioni che abitavano la penisola
italiana durante l'Età del ferro e prima dell'ascesa di Roma. Questi popoli non erano tutti collegati
sul piano linguistico o su quello genetico. La conformazione dell'Italia, lunga penisola distesa nel
mar Mediterraneo, ne favorisce, infatti, i rapporti con le regioni circostanti, ma, al tempo stesso, la
sua natura prevalentemente montuosa tende a separare e isolarne le popolazioni entro aree
157
geografiche circoscritte. Sul piano linguistico, si può distinguere fra popoli parlanti lingue
indoeuropee e popoli parlanti lingue non indoeuropee. Al primo gruppo (popoli di lingua
indoeuropea) appartenevano in particolare i popoli italici propriamente detti, cioè parlanti lingue
italiche; a essi si aggiungevano dei popoli non del ramo italico. Indoeuropei non italici erano ad
esempio i colonizzatori di lingua greca. Altri popoli, infine, non erano affatto indoeuropei.
La classificazione di un certo numero di queste etnie non è stata ancora chiarita. Il celebre studioso
Giacomo Devoto ha affermato che le varietà indoeuropee che confluirono in Italia sono: "infinite".
A causa poi della forte influenza che gli etruschi (non indoeuropei) ebbero su tutti gli antichi popoli
italici, a volte si parla di una "civiltà etrusco-italica". Le antiche popolazioni dell'Italia nel loro
complesso si possono quindi classificare in: pre o non indoeuropee (popolazioni di origine dubbia o
di cui si hanno informazioni scarse o nulle riguardo alla loro lingua e religioni), rappresentate
principalmente da: Etruschi, Liguri, Sardi e Corsi. E indoeuropei italici (di questi popoli abbiamo
abbondanti informazioni riguardo alla natura indoeuropea della loro lingua e religione), come i
Latini (compresi i Falisci), Siculi, Sabini, Piceni, Umbri, Sanniti, Bruzi, più i Sabelli adriatici e
quelli tirrenici. A cui si devono aggiungere degli altri indoeuropei non italici, come gli Apuli
(provenienti dall‟Illiria), i Veneti e i Rutuli (la cui provenienza è dibattuta), i Celti e i coloni Greci
della Magna Grecia, che in Sicilia si sovrapposero ai Siculi.
Elaborato da wikipedia alla voce: Popoli dell‟Italia antica
Davanti ad un catalogo così complesso, si può comprendere come, ogni analisi storico-agronomica,
non possa prescindere dalla posizione stessa della città, che per il suo giacere su una linea di faglia
culturale e ambientale era –per logica conseguenza- situata anche su una linea di faglia
agronomica. L‟Italia a nord degli Appennini è un territorio a clima intrinsecamente continentale
(sono fatti salvi la parte costiera dell‟Adriatico, i suoi addentati interni e i limitati contorni dei laghi
lombardi). Un clima molto diverso da quello dell‟Italia peninsulare dove Roma è collocata. Ma
occorre tener presente che la catena degli Appennini -percorrendo tutta la penisola italiana come
una spina dorsale- porta con se un clima freddo d‟inverno e spesso arido in estate, capace
d‟influenzare un‟ampia parte della zona peninsulare in un modo che possiamo definire come
“continentale”. Roma è lì: appoggiata sui suoi colli a pochi chilometri dal mare, ma anche a pochi
chilometri da alte montagne (la cima del Gran Sasso – che con i suoi quasi tremila metri è la
montagna più alta degli Appennini – in linea d‟aria dista da Roma meno di cento chilometri).
Questa fa si che Roma non è –come la sua posizione potrebbe far pensare- una città a clima
mediterraneo. O meglio: lo è a modo suo; intendendo dire con questo che il suo clima risente di una
parziale sovrapposizione dei due ambiti climatici e che anche le sue caratteristiche agronomiche
sono una summa (anch‟essa parziale) dei due sistemi agrari di cui abbiamo già parlato. Credo sia
importante riflettere su questo aspetto, perché in questo stare in bilico, in questa funzione che
precedentemente ho definito di “città ponte”, c‟è un‟altra essenza caratteristica della romanità e
dell‟agricoltura romana. Una città al centro di una penisola che divide il mediterraneo tra oriente e
occidente, ma anche una città che divide l‟Italia (e non solo) tra il nord e il sud; una città abitata da
un popolo che non si è mai fatto scrupolo di copiare per apprendere, di emulare per poi poter
rielaborare; un popolo di identità ibrida e composita, aperto però all‟idea che tutti quelli che
158
venivano e che vengono nella sua orbita: “cives romani sunt”, perché serenamente cosciente che la
sua identità è costruita e non acquisita per via fattuale.
Se le caratteristiche geografiche le trasferiamo agli aspetti socio-culturali le cose sono grosso modo
paragonabili: lungo le coste tirreniche i Latini rappresentavano un cuneo di genti italiche (con il
pieno controllo del tratto finale e della foce del Tevere e delle sue saline) inserito tra territori
costieri di coltura e di lingua greca ed etrusca. Ossia: un popolo indoeuropeo italico (portatore di
una tradizione pastorale), posto tra un altro popolo d‟ascendenza indoeuropea (i greci), che da
alcuni secoli aveva però assorbito tutte le caratteristiche (anche quelle agronomiche) della civiltà
micenea mediterranea, e gli etruschi -che erano la probabile fusione tra popolazioni autoctone e
migranti pre-semitici mediorientali-. Così -mentre il resto dei popoli italici- erano rimasti
tendenzialmente legati alla loro economia pastorale e, con una certa difficoltà, scendevano dai
contrafforti degli Appennini, i Latini – pur avendo la capitale della loro confederazione collocata
sulle pendici dei Castelli Romani (gli alti colli vulcanici situati a pochi chilometri da Roma), e più
specificatamente i romani, sono stati l‟unico popolo italico affacciato saldamente sul Tirreno, dove
–controllando il Tevere - controllavano i commerci (specie di sale, essenziale per le greggi di coloro
che vivevano sugli Appennini) rivolti verso l‟interno della penisola. (Ovviamente non disconosco il
fatto che i Volsci o gli Aurunci avevano anch‟essi colonizzato il litorale sud del Lazio, ma cerco di
fare un discorso semplificativo).
Fatte queste ulteriori premesse –che servivano a definire il contesto- possiamo ora cominciare a
guardare meglio gli aspetti agronomici.
L‟Italia centrale è un territorio con funziona di cerniera, e –come visto- questa collocazione le
consente la sovrapposizione dei due modelli principali di biocenosi europee, che vi si intersecano
come i denti di una zip: quello continentale (le cui caratteristiche abbiamo definito nei precedenti
capitoli) e quello mediterraneo, arrivato: o direttamente dal Medioriente intorno al 1000 a.C. - (con
le antiche migrazioni che per semplicità potremmo definire: Pelasgiche, a cui dobbiamo, tra l‟altro,
la prima introduzione in Italia della vite e dell‟olivo e del grano duro), o in maniera indiretta intorno
al 500 a.C. dalla Grecia e/o dalla Fenicia. A questi due ultimi flussi migratori dobbiamo la
specializzazione produttiva del modello agronomico mediterraneo e l‟introduzione della parte
peninsulare e insulare dell‟Italia nell‟ecumene agricolo e commerciale di quell‟epoca.
Questa funzione “cerniera” è essenziale per capire l‟agronomia romana: per tradizione non si
coltiva grano duro a nord degli Appennini, tanto quanto non si coltiva grano tenero a sud della
Campania, ma l‟agro intorno a Roma permette la coltivazione sia dell‟uno che dell‟altro (ed è
opportuno ricordare che il grano tenero- già di suo più produttivo del grano duro- nelle campagne
intorno a Roma raggiungeva produzioni medie di 5 o 6 volte le sementa necessarie per la risemina;
produzioni che per l‟epoca erano eccellenti). Più o meno la stessa cosa che succede con l‟olivo.
L‟olivo generalmente non si può coltivare a nord degli appennini e l‟agro intorno a Roma non ha
una vocazione per questo coltivo, che invece è tipico delle colline limitrofe alla città, questo
significa che nell‟Italia centrale la coltivazione dell‟olivo ha lasciato la costa ed è progressivamente
penetrata verso le aree collinose interne (e questo è un altro probabile dono che, prima gli etruschi e
159
poi i sabino-romani, hanno fatto all‟agricoltura italiana). Visivamente possiamo immaginare il
territorio agricolo di Roma come un grande rettangolo collocato lungo la costa del mar Tirreno,
caratterizzato da terreni di origine vulcanica di ottima tessitura e fertilità, ricco di risorse sorgive e
di laghi, e con il Tevere che lo taglia tangentalmente. Un territorio lambito dal mare (con la pesca e
una ricca acquacoltura, e con quello che in agronomia significa questa collocazione, che attenua i
caldi estivi e protegge dai freddi invernali) e limitrofo ai monti (con la loro economia del pascolo e
dei boschi); un territorio caratterizzato da inverni relativamente miti e da lunghe estati senza
pioggia, dove la biocenosi entrata in Europa dal corridoio danubiano (e dall‟Epiro) e quella venuta
dal Mediterraneo si sono compenetrate e sommate, realizzando una fusione sorprendente.
I latini fondando Roma sui colli che sovrastavano l‟isola Tiberina (il miglior guado del basso
Tevere) hanno goduto di questo particolare ambiente. Un ambiente limitrofo a quello degli etruschi,
grandi “bonificatori” e agronomi impareggiabili nella gestione delle acque e di un territorio tutto
segnato da piccoli lavori di manutenzione: lì una condotta sotterranea per irrigare un campo, là un
tunnel per drenare un piccolo avvallamento, lì una piccola diga per sbarrare un torrente, là un pozzo
per captare la falda d‟acqua superficiale che nella campagna intorno a Roma scorre pochi metri
sotto la terra. Non lavori imponenti, ma lavori attenti alla migliore gestione agronomica possibile
(ancora oggi i territori etruschi – alto Lazio e Toscana in primis- sono zone dove la cura della terra
si unisce ad una maniacale cura del paesaggio). I romani furono pronti ad acquisire queste loro
caratteristiche e ad integrarle con il loro modo di essere: il loro territori agricoli erano perfettamente
curati e l‟uso delle risorse idriche attentamente programmato (i campi intorno a casa mia sono
ancora segnati dai loro insediamenti e da una vasta rete delle loro opere idrauliche). Questo
atteggiamento agronomico e culturale si coniugò perfettamente con l‟antica religiosità romana e il
Genius loci divenne un vero e proprio cardine del loro primitivo modello di agronomia. Voglio dire
con questo che i romani dei primi secoli furono maestri nel sovrapporre gli aspetti colturali alle
caratteristiche ambientali, valorizzando al massimo –a fini produttivi- quello che anche di piccolo la
Natura poteva offrire loro.
Ma la componente ambientale e agronomica non è che una parte del discorso che stiamo facendo,
perché -in realtà- il sistema agricolo romano è frutto di una precisa scelta politica e ideologica, la
stessa che portò all‟emanazione nel 367 a. C. delle leggi Licinio Sestie, che stabilirono che fosse
vietato possedere più di 500 iugeri di terreno privato o più di 500 iugeri d‟uso di ager publicus e di
far pascolare sui terreni pubblici più di 100 capi di bestiame grosso (bovini, asini e cavalli) e 500 di
quello minuto (pecore o capre). I terreni intorno Roma furono quindi caratterizzati da una vasta
presenza di proprietà contadine: piccoli appezzamenti della grandezza di qualche iugero (un iugero
corrisponde a circa mezzo ettaro), sufficienti per mantenere una famiglia di coltivatori. Queste aree
di piccola proprietà contadina erano però intramezzate da terreni pubblici, o da terreni di proprietà
(per esempio dei templi) destinati ad uso pubblico e collettivo. Queste proprietà pubbliche o ad uso
pubblico (che nelle parti migliori potevano anche essere date in affitto) svolgevano un‟importante
ruolo economico, perché le loro zone più marginali erano utilizzate collettivamente per il pascolo
invernale degli ovini o per quello annuale dei bovini con le grandi corna (essenziali per ricavare di
buoi da destinare all‟aratura). Queste stesse parti servivano poi per la raccolta della erbe selvatiche
(di cui i romani sono tutt‟ora ghiotti) e della legna da ardere (che l‟inverno di Roma è lungo e
160
piovoso). Questa gestione pubblica e/o ad uso pubblico dei boschi e il consenso legale alla raccolta
del legnatico ha consentito di preservare il patrimonio boschivo intorno alla città, con tutti i benefici
indiretti che questo comportava (questo aspetto ci permette di dire che Roma fu la prima civiltà
arboricola della storia agraria universale). Come vedremo questo modello di suddivisione fondiaria
(per quanto strano possa sembrare in un‟epoca come la nostra, che ha un ferreo credo nel valore
delle privatizzazioni) avrà una rilevanza strategica nel favorire l‟intensificazione produttiva della
attività agricola.
I romani erano poi particolarmente attenti al miglioramento dei loro cultivar agrari e dei loro
animali d‟allevamento. Diceva Columella che i buoi si differenziavano per struttura del corpo, per
l‟indole e per il colore del mantello, non solo fra le province, ma anche fra le stesse regioni d‟Italia.
C‟erano i buoi bianchi, di piccola taglia, ma robusti in Campania; quelli bianchi o rossicci, di
grande mole, e pregiati per l‟indole e la forza, dell‟Umbria e delle altre regioni dell‟Appennino
centrale. Poi c‟erano quelli tozzi e forti dell‟Etruria e nel Lazio. I romani erano giustamente
orgogliosi dei loro bianchi buoi dalle grandi corna, conosciuti per la loro rusticità e per la forza di
trazione che avevano sulle spalle; tanto che nel mondo antico pochi sono stati i popoli che hanno
potuto contare su una forza lavoro così forte e paziente. L‟aratura e l‟erpicatura erano lavori
essenziali per preparare i campi alla semina dei cereali, ma il tempo per quei lavori era limitato,
perché durante l‟estate, i terreni delle campagne intorno a Roma, diventavano (e diventano) troppo
duri e compatti per essere arati, e bisognava aspettare che una pioggia abbondante segnasse la fine
della siccità estiva (generalmente questo avviene durante il mese di settembre-ottobre). Una volta
che i terreni entravano in “tempera” (un termine agronomico che definisce il momento ideale per
effettuare l‟aratura) bisognava predisporli velocemente per le semine (cosa che normalmente
avviene tra la fine di ottobre e i primi di novembre) in modo da anticipare le grandi piogge
autunnali che rendono i campi impraticabili ai buoi e all‟aratro. Un coppia di buoi al giogo è forte
ma lenta e l‟onere della loro alimentazione era insostenibile per le limitate estensioni delle proprietà
contadine (un bovino adulto ha bisogno –mediamente- di un ettaro di pascolo). Ecco allora
l‟importanza della ripartizione fondiaria romana (come vedete le scelte agronomiche hanno delle
logiche stringenti): i terreni migliori a proprietà privata (o affittati privatamente dalle proprietà
pubbliche) mentre le terre pubbliche più marginali a pascolo o ad uso collettivo (una forma per
poter socializzazione a abbattere il costo del sostentamento dei buoi visti come forza lavoro).
Questa ripartizione consentiva che anche i piccoli proprietari potessero disporre di un numero di
animali adulti a loro disposizione –ma pascolante sui terreni pubblici- in modo che il loro numero
fosse appropriato alla breve stagione dell‟aratura, senza che il loro sostentamento pesasse sugli
spazi coltivabili. Il sistema agricolo romano era quindi un rodato modello organizzativo, capace di
“interpretare” le esigenze agricole e i cicli della Natura. In questa logica di pianificazione rientra
anche la tecnica della fienagione. La campagna intorno a Roma ha una capacità di produzione
foraggera tra le più alte d‟Europa, ma l‟erba è sovrabbondante in primavera, sparisce in estate, si
rigenera in autunno e si riduce in inverno. Il fieno -prodotto con l‟esubero dell‟erba primaverileconsentiva alla zootecnia romana di non sottostare alla legge del minimo (credo che tutti la
conosciate), e quindi di poter mantenere un più elevato numero di bovini da carne o da lavoro. E‟ la
prima volta nella storia agraria che assistiamo all‟immagazzinamento dell‟erba (ricordate i grandi
covoni di fieno che punteggiavano fino a pochi decenni fa le campagne dell‟Italia centrale?), perché
161
finora abbiamo visto l‟immagazzinamento delle sole derrate alimentari ad uso umano, e vedremo
nei prossimi capitoli come lo sviluppo di questa tecnica diventerà determinante per la crescita
dell‟Europa medioevale.
Da quanto raccontato finora ne discende che l‟azienda agricola romana era –per sua naturapolicolturale, con varie eppur alte specializzazioni agricole e zootecniche. I terreni più marginali
erano destinati al pascolo, mentre i terreni di buona qualità, ma non irrigabili, erano seminati a
colture invernali come il grano, il farro, l‟orzo, ma anche a fave, ceci e lenticchie, cipolle (tutti
prodotti che si raccolgono prima della siccità estiva) e anche il lino (che era la fibra tessile di
elezione dei romani), campi che –prima della semina successiva- venivano fatti pascolare dalle
greggi per ottenere una abbondante concimazione e un diserbo naturale. C‟erano poi terreni
destinati a vigneti e oliveti piantumati a filari rettilinei; nell‟interspazio tra i filari si seminavano i
cultivar meno nobili (avena, ceci, veccia: alcuni utilizzabili per l‟uso umano, altri utili per
mantenere gli animali dell‟aia); anche questi erano coltivi che -raccolti prima della siccità- non
avevano bisogno di irrigazione di sostegno estiva. Infine c‟era una piccola parte (spesso vicino al
casolare) dove i romani concentravano le risorse irrigue disponibili (un vicino torrente, una fonte).
Su questa parte irrigua i contadini romani coltivavano le verdure; sia quelle invernali che quelle
estive. Potremmo dire, in parte esagerando, che romani hanno inventato l‟orto, ossia quella parte
dell‟azienda agraria destinata esclusivamente alle colture fresche stagionali. Non sottostimate
questo aspetto, perché un orto ben gestito (ossia ben irrigato e ben concimato con le deiezioni
umane e degli animali) è in grado di dare un‟abbondanza di prodotti straordinaria (100 metri
quadrati di orto –l‟equivalente di un appartamento di discreta grandezza- sono sufficienti per
assicurare prodotti freschi per tutto l‟anno ad un intero nucleo famigliare). C‟è un passo molto bello
di Orazio che descrive perfettamente lo spirito che animava molti romani antichi: “un pezzo di terra
non troppo grande, un orto con una sorgente sempre fresca vicino alla casa, e un piccolo bosco …”
E‟ anche grazie a questo modo di pensare che i romani furono il più grandi ortolani della storia
antica; un aspetto che spesso si tende ad ignorare, anche se nessun altro popolo (tranne gli Aztechi
che vedremo più avanti) ha dato all‟orticoltura il contributo apportato dai romani: carciofi, asparagi,
lattughe, broccoli, zucchine, finocchi; ancora oggi sui banchi dei mercati di mezzo mondo molte
sono le varietà di verdure che mantengono l‟appellativo “romanesco”; un aggettivo che indica in
modo inequivocabile la loro antica provenienza.
Da “Vita in Campagna” prendo un estratto dell‟articolo - Gli orti dell‟antica Roma: tecniche e
prodotti particolari- di Maurizio Ferrari.
La grande esperienza accumulata da agronomi e contadini romani sulla coltivazione degli ortaggi
aveva suggerito tecniche curiose e in diversi casi anche avveniristiche. Fra queste ultime colpisce la
pratica di un tipo di semina molto simile a quella «a nastro» dei nostri tempi: come recinzione
all‟orto era infatti preferita una siepe di rosa canina, i cui semi venivano mescolati con farina di
veccia macinata, bagnata con acqua, e successivamente spalmati su vecchie funi o corde, che poi
venivano interrate. I semi sarebbero germogliati con vigore e avrebbero dato vita a una siepe diritta,
fitta e uniforme. Interessante era la coltivazione delle zucche e dei cetrioli in luoghi poveri d‟acqua:
dopo aver scavato una fossa profonda 40-45 centimetri se ne riempiva un terzo di paglia e sopra si
162
ammucchiava uno strato di terra, paglia e letame mescolati insieme fino a raggiungere la metà della
fossa stessa. Successivamente vi si disponevano i semi e si innaffiava fino a che non fossero nati;
poi si aggiungeva a più riprese terra accompagnando la crescita delle piantine, fino al
raggiungimento dell‟orlo della fossa. In tal modo le piantine stesse sarebbero vissute tutta l‟estate
senza bisogno di grandi quantità d‟acqua. Per avere porri di maggiori dimensioni si mettevano
diversi semi in piccole garze e così si interravano; nate le piantine, si trapiantavano ponendo sotto
ognuna di esse conchiglie o cocci che facessero quasi da «letto»: in tal modo le teste dei porri si
ingrossavano sensibilmente. Per ottenere invece degli ottimi cavoli era fondamentale trapiantarli
quando avevano sei foglie, avendo cura di spalmarne le radici con letame liquido e quindi di
avvolgerle in fascette di alga. Inoltre per impedire che le piantine di rapa in estate fossero divorate
dagli insetti, si interravano i semi dopo averli cosparsi di fuliggine e bagnati oppure si consigliava
un trattamento a base di erba chiamata «sempreviva». Infine, per impedire la germinazione
precoce dell‟aglio e della cipolla, si bagnavano le loro teste con acqua tiepida salata.
Centro della vita rurale era però l‟aia (il corrispettivo zootecnico dell‟orto), sempre movimentata
dalla vita degli animali da cortile (galline, piccioni, conigli, oche) che -se gestiti con abilità e
raziocinio- erano capaci di assicurare un significativo contributo, alimentare e monetario,
dell‟economia domestica.
Spesso nei loro campi di grano, coltivati sotto gli olivi, erano presenti anche altri alberi da frutto
(per questo ho parlato di civiltà arboricola), che a loro volta spesso sostenevano delle viti a loro
“maritate”. Non ridete di questo simpatico termine tecnico, perché è proprio grazie a questa usanza
che i terreni erano coltivati a due distinti livelli di altezza, facendo in modo che con la stessa terra
si ottenesse un produzione doppia (un corrispettivo di questo metodo è l‟agricoltura delle oasi, dove
–inserendo anche la coltivazione delle palme da dattero- si arriva ad avere una produzione a tre
livelli; ma una cosa è un oasi e altra cosa è un vasto territorio tutto coltivato). Tutto questo per dire
che il sistema integrato, forte di alleanze e mutualismo reciproco, è stato uno dei presupposti che ha
contribuito a sostenere gli alti livelli produttivi raggiunti dall‟agricoltura romana.
Certo la produttività ad ettaro era minore di quella che si realizzava nelle civiltà fluviali, ma la forza
di un modello agricolo integrato consisteva proprio nel compensare quest‟apparente inferiorità. Per
prima cosa c‟è da tenere presente che l‟agricoltura romana necessitava di opere minime di
manutenzione idrica, mentre le civiltà fluviali dovevano impegnare una quantità considerevole di
lavoro (umano o animale) nella gestione del territorio e nell‟innalzamento dal piano fluviale
dell‟acqua d‟irrigazione; c‟era poi il fatto che queste civiltà erano molto più soggette alle
fluttuazioni della piovosità annuale (il terrore della Cina era un‟inondazione distruttiva) che poteva
compromettere i raccolti, mentre i romani erano in grado di pianificare al meglio la loro produzione
(un anno di basso raccolto poteva essere compensato immettendo in produzione i terreni
precedentemente destinati a maggese). E‟ questa integrazione, questa organizzazione, che –
specialmente in inverno- lasciava “libera” molta forza lavoro che assicurava a Roma il suo esercito
di contadini pronti per la guerra.
163
L‟altro aspetto determinante dell‟agricoltura romana era la pastorizia transumante (una loro antica
tradizione), che rappresentava: una grande risorsa economica e –contemporaneamente- uno
strumento perfetto d‟integrazione e di controllo delle popolazioni appenniniche. Le greggi
pascolavano nelle campagne intorno a Roma dal mese di ottobre fino al mese di maggio (quando le
piogge stagionali assicuravano dei ricchi pascoli), per poi lasciare il piano e dirigersi verso gli alti
pascoli appenninici, dove l‟erba cresce abbondante durante i mesi estivi. Questa “industria” (così fino a pochi anni fa- nella campagna intorno a Roma veniva definita la pastorizia, per via del suo
perfetto modello organizzativo) era spesso appannaggio di “imprenditori” specializzati che
facevano pascolare dei capi propri o animali presi in gestione da altri contadini per il solo periodo
estivo. Il flusso di animali transumanti che dalle campagne intono a Roma si spostava verso gli
Appennini era tale (“l‟erbal fiume silente” di dannunziana memoria) che il soldo pagato per ogni
capo rappresentava la prima voce di entrata dell‟erario romano; un aspetto economico così
significativo che il termine “pecunia” –con cui i romani designavano il denaro- discendeva
direttamente da “pecus”, la stessa radice linguistica di pecora!
Avendo a disposizione solo il pascolamento per la concimazione dei campi (per la superficie
limitata degli orti si usavano diversi tipi di stallatico o il guano degli uccelli) i romani prestarono
una grande cura al mantenimento della fertilità del suolo. Il grano si coltivava a maggese (un
modello agronomico che prevedeva un anno di coltivo a cui faceva seguito un anno di riposo),
anche se nell‟anno di riposo si potevano coltivare specie da “rinnovo”, come fave e lupini, che
venivano –ogni tanto- usati per il sovescio (il sovescio è la tecnica agronomica che comporta
l‟aratura e il successivo interramento di una intera coltura di leguminose, cosa che in termini
agronomici equivale a una abbondante concimazione di letame.
E‟ per il dettaglio prestato alle piccole cose (i romani arrivavano a calzare i loro cani e a coprire le
pecore con vesti di tela affinché i rovi non ne rovinassero il vello), per l‟applicazione di tecniche
innovative, per l‟attenta selezione delle razze (i romani sono stati grandi selezionatori), per la
capacità di adattare il loro modello alla stagionalità del territorio, per la ferrea pianificazione e per
la loro capacità di organizzazione, che i romani -oltre ad essere un popolo di guerrieri e di
legislatori- possono essere considerati anche un popolo di straordinari agricoltori. E‟ –grazie a
questo atteggiamento– unito alla fertilità della loro terra- che i romani sono riusciti ad ottenere una
produttività agricola straordinaria e prolungata nel tempo. E‟ questo insieme di comportamenti -che
mal si conciliano con l‟idea canonica del romano grossolano e militaresco-, che hanno fatto
dell‟agricoltura romana una perfetta macchina a sostegno della vita economica e politica della città.
C‟è un altro aspetto essenziale su cui dobbiamo però soffermarci: l‟agricoltore romano non era solo,
il suo ruolo sociale non era marginale o emarginato come quello di un contadino contemporaneo
(che è diventato fenomeno di puro folklore). Nessuna cultura –nel suo quotidiano dibattere sociale e
politico- ha attribuito alla vita dei campi e alla scienza della terra così tanta attenzioni quanto quelle
prestate dai romani; nessuna cultura ha visto i suoi più importanti letterati (nonché raffinati
intellettuali) discutere o riflettere così approfonditamente sui temi agricoli. Roma sta anche nei
trattati agronomici di Columella e di Varrone o di Siculo Flacco, nelle riflessioni naturalistiche di
Plinio, nel pensiero di Lucrezio, e poche opere trattano di agricoltura in maniera così poetica come
164
le Georgiche di Virgilio. Ve lo immaginate i grandi intellettuali d‟oggi scrivere su quali sono le
tecniche migliori per coltivare i campi o discutere di selezione e d‟incroci per migliorare i risultati
agronomici o zootecnici? Catone scrisse nella prefazione al suo trattato: “allorquando lodavano un
uomo … così lo lodavano: un buon agricoltore, un buon coltivatore”. Anche Varrone riprese questa
dimensione rurale della civiltà romana affermando: “non senza ragione i nostri antenati preferivano
i romani di campagna a quelli di città”. Roma monarchica e repubblicana vista come una grande e
vera civiltà rurale!
E‟ quindi la terra dove io vivo che ha fatto Roma, tanto quanto Roma ha fatto questa terra: in un
binomio tra pensiero e Natura inscindibile! Questo è uno dei grandi insegnamenti che i romani ci
hanno trasmesso: la terra vuole attenzioni e cure, ma la terra ben coltivata vuole anche scienza e
politica. Decisamente un buon insegnamento!
Ma attenti: quello che vale per i territori limitrofi alla città e per le antiche aree etrusco e latine
(ossia il centro dell‟antica romanità) non vale per il resto dell‟Italia e per alcune altre parti del
grande impero, perché i romani –pur mantenendo il modello produttivo policolturale- in molti
luoghi hanno attuato un‟occupazione spaziale del territorio che non ha avuto niente a che fare con
l‟idea – un poco romantica- del Genius Loci.
La centuriazione era il sistema con cui i romani organizzavano il territorio agricolo. Si
caratterizzava per la regolare disposizione, secondo un reticolo ortogonale, di strade, canali e
appezzamenti agricoli destinati all'assegnazione a nuovi coloni (spesso legionari a riposo). I romani
cominciarono ad utilizzare la centuriazione in relazione alla fondazione, nel IV secolo, di nuove
colonie nell'ager sabinus da poco conquistato. La legge agraria di Tiberio Gracco (uno dei due figli
di Cornelia) del 133 a.C. che prevedeva la privatizzazione dell'ager publicus a favore della plebe,
dette un grande impulso a questo modello di suddivisioni delle terre. La diffusione delle
centuriazioni fu capillare in tutta Italia ed anche in alcune altre provincie dell‟impero. La
centuriazione è tipica di terreni pianeggianti, tuttavia sono state documentate anche centuriazioni
collinari.
L'agrimensore decideva l'umbilicus che corrispondeva all‟incrocio del cardo e del decumano
principali, e in seguito tracciava i cardini e i decumani secondari. Gli assi stradali erano poi posti
paralleli ad intervalli di 100 actus (circa 3,5 km) e lo scorrere dei torrenti erano ridisegnati per
adattarli a questa impostazione. Il territorio risultava così suddiviso in superfici quadrate che erano
poi ulteriormente divise in "centurie". Ogni centuria , formata da dieci strisce distanti tra loro due
actus (71,04 m), era composta da 100 quadrati di circa 0,5 ettari, gli heredia. Ogni heredium era poi
suddiviso a metà in due iugeri di 2523 m² (la quantità di terreno che poteva essere arata in un giorno
da una coppia di buoi).
Questa impostazione ha pochi confronti al mondo, sia riguardo alla vastità dell'opera, sia in
rapporto alla persistenza della trasformazione del paesaggio per opera dell'uomo. Il frazionamento
agrario era già stata compiuto in Magna Grecia ed in Etruria, ma è solo con la conquista romana che
tale modello trova il suo massimo sviluppo, andando ad attuare uno dei più estesi piani di
colonizzazione dell'antichità. La portata ideologica di quest‟operazione includeva, grazie alle
165
migliaia di agricoltori e allevatori che avrebbero presidiato il proprio appezzamento, il pieno
controllo del territorio. Quelle che erano terre di frontiera furono trasformate in un'imponente
macchina produttiva sottratta ai boschi e ai frequenti allagamenti. L'efficacia di questa politica portò
a un pieno inserimento delle regioni di nuova conquista all'interno dell'apparato statale romano
anche attraverso l'integrazione delle genti indigene (a cui era riservata una parte del territorio) nella
rete sociale e commerciale che si stava formando, creando un paesaggio antropico così equilibrato
nel suo assetto ambientale e così razionale nell'uso da essere sopravvissuto fino ai nostri giorni.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Centuriazione
Ecco l‟altro aspetto –spettacolare, ma inquietante- del modello agricolo romano: il trasferimento
della cultura e delle pratiche militari dai campi di battaglia ai campi coltivati: una terra ridisegnata
da un reticolo di strade e di poderi ortogonali (così che le arature e le semine potessero essere
effettuate in linea retta) e alberi e vigneti disposti in fila come colonne di soldati. Una Natura
cancellata a favore di una Natura disegnata come una caserma; concettualmente asservita alla legge
del più forte. Come spesso è accaduto Roma non ha avuto freni nell‟imporre le proprie leggi e i
propri schemi comportamentali; e -occorre dire-, che nell‟idea di centuriazione c‟è purtroppo una
drammatica componente di modernità (un altro dei tanti influssi culturali che abbiamo assorbito da
Roma). Gli egizi rendevano grazie al fiume Nilo; i romani a Marte, il loro dio della guerra.
“Predatori del mondo intero, i Romani, dopo aver devastato tutto, non avendo più terre da
saccheggiare, vanno a frugare anche il mare; avidi se il nemico è ricco, smaniosi di dominio se è
povero, tali da non essere saziati né dall'Oriente né dall'Occidente, gli unici che bramano con pari
veemenza ricchezza e miseria. Distruggere, trucidare, rubare, questo, con falso nome, chiamano
impero e là dove hanno fatto il deserto, lo hanno chiamato pace”.
Questo è lo straordinario passo -e la dura accusa verso l'avidità del militarismo romanopronunciato da Calgaco (capo dei Caledoni), prima della battaglia contro l‟esercito guidato da
Giulio Gneo Gracco.
Non mi dilungo su questo tema perché ho intenzione di riprenderlo nell‟ultimo capitolo di questo
scritto, dove vedremo come: partendo dall‟arte della guerra applicata all‟agricoltura, negli anni
cinquanta del secolo scorso siamo passati ad una vera e propria guerra a bassa intensità dichiarata
alla Natura. Ma –come detto- di questo parleremo più avanti.
Ora, ho la sensazione che nel descrivere i primi secoli dell‟agricoltura romana ho detto tutte le cose
importanti che avevo da dire, ma so anche che per dare un senso esaustivo a questo discorso è
necessario analizzare altri due periodi topici dell‟agricoltura romana, quello dello sviluppo delle
aziende a gestione schiavistica e quello del modello produttivo latifondistico (che grosso modo
corrispondono al periodo dell‟impero e della decadenza di Roma). Anche perché alcuni aspetti di
questa evoluzione attraverso i secoli appaiono come un singolare metafora applicabile anche ai
nostri tempi, ma per la complessità nel descrivere questa particolare evoluzione, rimanderemo la
tematica nel prossimo capitolo.
166
L’apice e il declino
Roma era ora il cuore e il cervello di un impero che teneva sotto il suo controllo tutte le coste del
Mediterraneo e parte dell‟Asia occidentale, ma che si era progressivamente esteso fino ad occupare
una parte significativa dell‟Europa insulare e continentale (è la prima civiltà a spingere le sue
frontiere politiche e agronomiche tanto a nord). Questa espansione non solo ridisegnò l‟intera
geografia politica del mondo allora conosciuto -aprendo i nuovi territori europei al modello
statuale, culturale (oltre che di pianificazione territoriale) tipicamente romano- ma portò a dei mix
agronomici particolarmente interessanti. Ne sono prova evidente l‟ampliamento delle aree di
coltivazione della vite (che con i romani arrivò a toccare la Germania inferiore e la Britannia) e
l‟introduzione dell‟avena e della segale (cereali tipici dell‟Europa continentale ed ultimi ad essere
domesticati all‟incirca nel 2000 a. C.) nel sistema agricolo di alcune provincie romane (la semente
d‟avena venne acquisita nella preparazione delle pappe e divenne il cereale d‟eccellenza
nell‟allevamento dei cavalli, mentre la segale –nelle regioni settentrionali- divenne un valido
sostituto del grano nella panificazione); entrambi questi cereali assunsero poi un ruolo essenziale
nella produzione di alcuni distillati. Un impero che avendo occupato militarmente tutto lo spazio
socioeconomico disponibile, si era costruito dei confini senza confinanti (a sud c‟era il Sahara, a
ovest l‟oceano Atlantico, a nord gli sconosciuti paesi di Thule, a est l‟immensa steppa che lo
divideva dai lontani paesi dove si produceva la seta); solo l‟Iran dei Parti e poi dei Sassanidi era un
potenziale concorrente: temibile, ma solo per scaramucce locali nelle regioni orientali del vasto
dominio imperiale. Di questo impero-mondo Roma non rappresentava però solo il cuore e il
cervello, ma anche gli intestini e il ventre; il centro nevralgico dove tutto affluiva, tutto veniva
consumato, e assimilato dopo essere stato metabolizzato (non bisogna dimenticare che una delle
opere ingegneristicamente più significative della romanità rimane la cloaca massima e -come Don
Winsow fa dire a uno dei suoi personaggi: la civiltà è un problema di tubature!). Molto più di un
luogo dove arrivavano genti e merci di tutto il mondo Roma era ora una città mondo, l‟unica vera
città della classicità con una dimensione territoriale e una stratificazione socio-economica e
culturale paragonabile alle metropoli che oggi caratterizzano molti paesi in via di sottosviluppo.
Una città che già nei primi decenni dell‟impero si avviava a superare il milione d‟abitanti (crescerà
ancora di più), con dei sobborghi estesi ben oltre la prima cinta dell‟antiche mura serviane e anche
oltre le mura aureliane; un grande mercato di consumatori reali e potenziali, che stimolava le attività
commerciali e i produttori agricoli con richieste differenziate e viavia crescenti di prodotti raffinati,
e che grazie a questa sua funzione “consumatrice” era in grado di incidere sugli aspetti fondiari e
produttivi dei territori a lei assoggettati (cominciando dall‟agro che la circondava). E‟ opportuno
però ricordare che per consentire dei rifornimenti adeguati e facilitare i commerci prima Claudio,
poi Traiano, avevano dotato la città di un incredibile sistema portuale situato a nord della naturale
foce del Tevere, dopo aver connesso il fiume al mare attraverso lo scavo di un braccio di
collegamento artificiale. Questo sistema portuale –che poteva tenere alla fonda qualche centinaio di
navi- facilitò ovviamente l‟arrivo sulla piazza romana di molte derrate alimentari (oli, vini, cereali,
167
legumi, che potevano essere facilmente trasportati anche dalle lontane provincie), come pure di
animali destinati al consumo alimentare (che pure potevano arrivare a Roma dalle regioni limitrofe
pascolando), ma il flusso giornaliero di prodotti freschi (e di quelli ad alto valore aggiunto)
continuava ad essere assicurato dalle aziende agricole limitrofe alla capitale (non per caso abbiamo
detto che i romani furono tra i più grandi orticoltori della storia agronomica) e dai pescatori o
acquacoltori della costa tirrenica.
In questo tempo i ceti abbienti della città concentravano nelle loro mani ricchezze impressionanti
(molte frutto della corruzione, altre della diseguale redistribuzione dei redditi interni e di quelli
derivati dai saccheggi a danno dei paesi conquistati o a danno delle ricchezze dello Stato), ma al di
là di questo l‟area urbana era anche al centro di un forte attivismo dei ceti medi imprenditoriali
(persone occupate con vario ordine e grado nella gestione della complessa macchina burocratico e
militare, commercianti, impresari edili, artigiani qualificati, e individui impegnati nel campo delle
arti e dell‟intrattenimento), in un insieme variegato e votato ai piaceri corporali che aveva
progressivamente rigettato la tradizionale parsimonia caratteristica dell‟antica società romana.
Questo cambiamento sociale ed economico portò ad una crescita generalizzata della propensione al
consumo, a una richiesta crescente di beni di lusso e di raffinatezze alimentari, ad un uso ludico o
ricreativo del territorio (è l‟epoca dove molte fattorie –cambiando di proprietà- divennero eleganti
ville fuoriporta). Un insieme di atteggiamenti che, oltre ad una riduzione dell‟attitudine al risparmio
e alla modestia comportamentale, contribuì a far venir meno la funzione produttiva e sociale della
piccola proprietà contadina. I valori della Roma di Cincinnato andavano ormai tramontando!
Questa tendenza ad indirizzare il capitale finanziario verso gli investimenti fondiari fuori porta
(stiamo sempre parlando dell‟agricoltura nelle aree circostanti la grande città e le altre realtà urbane
dell‟impero) - sia di capitale fisso che mobile- portò ad un cambiamento progressivo dei paradigmi
delle antiche politiche fondiarie e al superamento della tradizionale tripartizione delle terre, con la
progressiva alienazione di quelle pubbliche. Questo voleva dire che nella mente dei romani (o delle
loro classi dirigenti) stava prendendo piede l‟idea che il venir meno della funzione sociale della
terra, indotta dalla sua “privatizzazione”, poteva produrre dei significativi vantaggi economici.
Questa scelta – tutt‟altro che neutra- finì per gettare le basi di una progressiva disfunzionalità dei
piccoli appezzamenti gestiti dai conduttori diretti, che furono privati del supporto gestionale che
l‟uso occasionale o parziale dei terreni pubblici era in grado di assicurare loro. Questo incentivò
l‟abbandono delle piccole aziende agricole (molti piccoli proprietari si trasferirono –con alterne
fortune- verso le città, accelerando –di fatto- il processo di inurbamento); un fenomeno che
comportò nel tempo la progressiva concentrazione delle terre a favore dei maggiorenti rurali o
cittadini. Ci furono delle ovvie resistenze e gli scontri tra l‟aristocrazia e la plebe caratterizzarono
una significativa parte della vita pubblica romana, ma è del tutto evidente che l‟espansione
economica generalizzata, in virtù delle politiche di conquista, e la crescita della realtà urbana (delle
realtà urbane) funzionarono da potente calamita per tutti coloro che preferirono abbandonare i
campi e cercare strade alternative di benessere e arricchimento (voglio dire con questo che il
processo di spogliazione della piccola proprietà contadina fu possibile in parte coattivamente, ma in
parte in ragione di un cambiamento dei valori sociali). L‟insieme di questi avvenimenti si manifestò
in un ampliamento progressivo della superficie delle aziende agrarie, un fenomeno chiaramente
168
legato alla progressiva scomparsa della piccola proprietà a gestione diretta e famigliare. Occorre
tener presente che l‟inurbazione (quella romana appare come una civiltà urbana anche se in realtà
la percentuale della popolazione che risiedeva nelle campagne era altissima) e la relativa riduzione
percentuale della popolazione occupata nel produrre cibo fu resa possibile dalla maggior
produttività ad ettaro di terra lavorata, dal flusso costante di schiavi sul mercato del lavoro e dalla
nascita di una vera e propria “cultura agronomica” delle popolazioni rurali (quest‟aspetto
“culturale” della vita di molte campagne ha contribuito ad aumentare la percezione di un mondo
romano “urbanizzato”). E‟ certo però che a fronte dei radicali cambiamenti della struttura fondiaria
non corrispose un cambiamento del modello produttivo che per molto tempo ancora rimase
policolturale; infatti l‟economia agraria romana entrò nell‟epoca dove il lavoro delle famiglie di
coltivatori diretti fu progressivamente sostituito da quello bracciantile o schiavistico. Questo
passaggio dalla piccola proprietà coltivatrice all‟azienda agraria di medie o grande dimensioni gestita dal proprietario o da suoi fiduciari e votata all‟uso di manodopera servile- è un momento
particolarmente importante dell‟agronomia romana, sia per i risvolti sociali, sia per i risvolti
agronomici ad esso legati.
Niente è più duttile ed efficiente del lavoro degli schiavi. Al di fuori del lavoro diretto della famiglia
contadina non esiste forma di conduzione più attenta, più sollecita e più efficiente di quella
assicurata dalla struttura gestionale e gerarchica che sovrasta e sovraintende il lavoro schiavistico
(specie se gli “schiavi” avevano le giuste motivazioni –come l‟ipotesi di una loro futura
affrancazione- per lavorare e lavorare bene). Il lavoro umano è capace di risultati produttivi e
qualitativi insuperabili, e anche oggi – nell‟età della meccanotronica e dell‟intelligenza artificialeneanche il più perfetto robot computerizzato è in grado di assicurare le performance che mani e
braccia, se uniti a occhi e cervello, sono in grado di fornire. C‟erano poi, nel passaggio tra la piccola
proprietà contadina e la grande azienda “capitalistica”, delle evidenti razionalizzazioni di scala (la
efficentazione degli acquisti, la facilitazione al credito e la migliore pianificazione delle vendite, un
più razionale e facile accesso ai mercati di consumo, una maggiore professionalizzazione degli
addetti all‟organizzazione dei lavori) che consentivano di soddisfare richieste di una platea di
consumatori sempre più attenti e sofisticati (il personaggio “borghese” di Trimalcione e la pletora
dei suoi convitati –così come descritti nel Satyricon da Petronio – rimangono gli emblemi insuperati
di questo periodo).
Si può discutere sull‟aspetto etico e sui presupposti morali che sono alla base della schiavitù (anzi,
non c‟è veramente nulla da discutere), e occorre riconoscere al cristianesimo di aver fornito i
presupposti morali e filosofici per il suo superamento (o forse fu il contrario?), ma sotto gli aspetti
prettamente produttivi, l‟economia schiavistica (in quell‟epoca e con quelle situazioni politiche
economiche) è stata in grado di assicurare il livello gestionale più alto a cui giunse l‟agricoltura
romana (il tema è strettamente collegato anche alla quantità di capitali investiti e all‟applicazione di
nuove e ampie conoscenze tecniche e culturali).
Possente forza lavoro animale, eccellente forza lavoro umana (fintantoché i romani riuscirono a
continuare la loro politica di espansione territoriale, gli uomini e le donne -e i bambini- da adibire ai
lavori coatti furono numerosi ed economici), occupazione ortogonale e in alcuni casi
169
tridimensionale del territorio, grosse risorse economiche da destinare ad investimenti produttivi (e
non solo), scienza e tecnologie applicate, fertilità intrinseca dei terreni che venivano messi a coltura
(è opportuno ricordare che i terreni coltivati rimanevano una percentuale minima della vasta
superficie dell‟impero che in molte aree appare ancora coperto da incolti, brughiere e foreste, e
questo permetteva di mettere a coltura solo le terre migliori); mai prima d‟allora la produttività
agricola del mondo antico aveva raggiunto un punto tanto alto. Ma enormi capitali e accentuati
consumi d‟elite se fanno capitalismo (o pre capitalismo), non fanno consumismo; non lo fanno non
solo perché mancava la velocità di circolazione dei capitali (che per la maggior parte venivano
investiti in beni immobili), ma perché mancava l‟attitudine e la propensione al consumo della fascia
maggioritaria della società romana, ossia quell‟attitudine (o quell‟induzione comportamentale) di
consumo edonista che è l‟architrave ideologica tipica della nostra epoca. Malgrado la produttività
raggiunta quello romano rimaneva un impero dove la maggior parte della popolazione continua a
vivere di agricoltura (Roma con i suoi quasi due milioni d‟abitanti e le altre aree urbane sono ben
poca cosa se comparate i quasi sessanta milioni di persone censite in tutto l‟impero); a questi
numeri significativi di popolazione votata all‟autoproduzione vanno poi aggiunti i ceti popolari: sia
quelli che per ragioni storico-economico erano coattivamente esclusi (gli storici dell‟antichità
romana ritengono che la percentuale degli schiavi si aggirasse tra il 20 e il 30% dell‟intera
popolazione, sia quelli che rappresentavano il vasto corpo delle persone libere ma indigenti -la
plebe- che normalmente veniva sostentato attraverso le vaste distribuzioni alimentari dell‟annona.
Bisognerà attendere ben più di un millennio prima che l‟aumento della produttività agricola –sia ad
uso alimentare che per gli altri prodotti derivati- fosse in grado di ridurre significativamente il
numero degli addetti agricoli (ossia gli autoproduttori di risorse alimentari), sia che l‟economicità
dei nuovi manufatti prodotti industrialmente, grazie anche alla scoperta e all‟uso di nuove
tecnologie da applicare nel comparto energetico, consentisse di trasformare quegli esclusi
dall‟autoproduzione -operai salariati e plebe urbana o rurale (consentitemi l‟uso di un termine che
solo apparentemente è così desueto) in operai consumatori. (n.b. : chi volesse avere una visione
lucida di questo passaggio epocale può sempre andare a riguardarsi Quemada, l‟implacabile film di
Gillo Pontecorvo).
Roma era ora arrivata al punto più alto d‟innovazione concettuale e d‟attuazione delle pratiche
produttive: l‟agricoltura era al massimo della redditività; il commercio godeva di una rete stradate e
portuale che consentiva la veloce connessioni della sua “economia-mondo” (cosa che si rivedrà solo
in epoche contemporanee); la pianificazione nell‟accesso e nella distribuzione risorse agricole era
pienamente rodata, mentre delle acque si faceva anche un uso creativo e ricreativo (mai più furono
viste tante fontane pubbliche e tante terme); l‟ingegneria -grazie all‟uso di nuovi materiali
costruttivi- aveva raggiunto dei livelli che troveranno un paragone solo con la scoperta moderna del
cemento armato e dell‟acciaio. Mai civiltà era arrivata ad un tale punto di pianificazione e di
funzionalità. Malgrado tutto questo i tempi dell‟accumulazione primigenia e collettiva, capace di
generare sia consumo che nuova accumulazione non erano ancora arrivati; il volano che poteva dare
moto circolare e continuo al sistema economico e sociale arrivò al suo afelio e –dopo un momento
d‟inerzia- cominciò a regredire: fino a portare l‟intero sistema economico e sociale romano ad un
vero e proprio collasso strutturale (di questo evento fu corresponsabile anche l‟arrivo di un nuovo e
diverso modello produttivo, come vedremo nel prossimo capitolo). Come sappiamo da quel collasso
170
economico e strutturale si salvarono l‟idea stessa della romanità (che passò come aspirazione a
diversi sistemi statuari successivi), molti aspetti culturali, la nuova religione di Stato con la sua
struttura gerarchica -presa in prestito da quella imperiale- e la sua lingua (veicolata dalla struttura
ecclesiastica) che per secoli e secoli a venire continuò a svolgere la sua funzione di strumento di
trasmissione culturale.
Di certo i romani non si risparmiarono nel tentare varie ipotesi di correzione: per prima cosa
mettendo la gestione dello Stato nelle mani del ceto militare, poi integrando nell‟esercito e nella
pubblica amministrazione i campioni di quei popoli che premevano alle loro frontiere (che è cosa
ben diversa dell‟integrare le figure preminenti delle varie provincie), ma -ancora di più- facendo
scelte rivoluzionarie sotto l‟aspetto politico-amministrativo ed etico-culturale: Diocleziano divise
l‟impero in quattro e immaginò una forma tetrarchica di governo; Costantino andò ancora oltre:
trattando la capitale dell‟impero come un alveare ormai troppo affollato e nel tentativo di pianificare
al meglio il suo equilibrio interno, decise di farne sciamare una parte (con lui in primis) per andare a
fondare una nuova Roma sulle sponde del Bosforo (un‟area dell‟impero che trasse grandi benefici
economici da questa scelta). In questa ottica di rifondazione globale Costantino arrivò a dichiarare
religione di Stato il credo di una piccola setta di origine giudaica che nella vecchia capitale
imperiale aveva il vantaggio di rappresentare una coesa minoranza. In un tempo in cui gli Dei erano
morti da un paio di secoli (credo lo abbia detto Dumas), Costantino riaffermò con forza l‟essenza
divina dell‟imperatore, ma immaginò anche utile sostenere l‟idea di uno Stato celeste Cristologico,
edificato sull‟uguaglianza tra gli uomini, sull‟espiazione della colpa e sulla remissione dei loro
peccati; unitamente ad un luogo infernale dove confinare le anime dei refrattari al nuovo ordine
morale, simile nella forma ma diverso nella sostanza dall‟Ade pagano.
Così per Costantino la rigenerazione dell‟impero passò per l‟oriente: spostandone la capitale e
acquisendone la nuova religione ufficiale. Per la prima volta il pendolo dei processi di
civilizzazione si pensava potesse tornare in aree già storicizzate.
Gli effetti di questa decisione politica furono impressionanti: la prima Roma fu coinvolta in un
vortice affannoso di cambiamenti, da cui emerse dopo alcuni secoli ideologicamente più forte di
prima; mentre la seconda Roma –dopo alcuni secoli di splendore dorato – si avviò in un lento e
accidioso declino, obnubilata da un potere sempre più pleonastico. Veicolo di tutto questo fu la
nuova religione incentrata sull‟immagine di un redentore –che acquisendo l‟ecumenismo della
tradizione romana- si espanse nei secoli ben oltre le frontiere antiche dell‟Impero, non più tramite
gli eserciti, ma grazie ai militi della nuova fede. Non è quindi per caso se il pane e il vino
mediterranei furono d‟ora in poi transustanziati nel corpo e nel sangue di Cristo, e se l‟olio ne
divenne il crisma.
Mentre queste grandi trasformazioni erano in atto l‟attività degli imprenditori agricoli romani e
italici era sempre più in affanno (anche in questo caso, forse, era il contrario); la concorrenza dei
prodotti che afferivano a prezzi molto più competitivi dalle provincie (uno egli effetti di quella
antica globalizzazione); l‟aumento del prezzo degli schiavi (crisi nel mercato del lavoro); il
decremento demografico locale legato allo spostamento di una parte dell‟amministrazione imperiale
171
(effetti del decentramento amministrativo e della riduzione della spesa pubblica) iniziarono a pesare
negativamente sulla funzionalità economica delle varie gestioni agrarie. Questa riduzione di
economicità –a dimostrazione di una crisi di obsolescenza del modello di conduzione indiretta dei
fondi- comportò dei progressivi ma radicali cambiamenti, sia nella struttura fondiaria, che del
modello produttivo. La crescita del colonnato è un aspetto tipico di questa tarda epoca romana. I
coloni andarono progressivamente a sostituire la figura dell‟imprenditore agricolo impegnato
direttamente, o tramite dei “dipendenti” salariati o schiavi (i termini hanno un loro significato
intrinseco) nella gestione dell‟azienda agraria. Questo fenomeno ha in se degli aspetti decisamente
interessanti: in un primo momento si privatizzarono le terre (contravvenendo ai suggerimenti di
Lucrezio: “della terra sia dato a nessuno la proprietà e a tutti l‟uso”); poi progressivamente si
cambiarono le figure a cui assicurarne l‟uso della terra (spaziando dalla mezzadria all‟affitto) senza
però cambiarne la proprietà. Ovviamente i nuovi conduttori erano tenuti a corrispondere al
proprietario un corrispettivo in denaro o in prodotti: si era introdotta –generalizzandola- la rendita
fondiaria, a vantaggio di pochi e a detrimento di molti. Non che la rendita fondiaria fosse
sconosciuta al mondo antico; le terre pubbliche o ad uso pubblico (quelle dei templi) erano
normalmente cedute alla gestione di altri dietro il pagamento di canoni in natura o in denaro. Ma
quelle rendite avevano tradizionalmente un uso sociale perché servivano alla redistribuzione di beni
alimentari ai ceti meno abbienti o a sostenere opere di beneficienza a favore della collettività. Ora
invece la rendita diventava “privata”, nel senso letterale della parola, perché privava i tanti a
vantaggio di pochi. La terra produttiva era ora “proprietà” di qualcuno e quel qualcuno era spesso
così lontano da quella terra quanto mai si era visto prima d‟allora (che la terra fosse di “qualcuno”
era un presupposto intrinseco di tutte le civiltà agricole, tanto quanto era un‟idea inconcepibile per
quelle culture umane che non avevano ancora conosciuto la mercificazione e la finanziarizzazione
del bene “terra” e dei suoi prodotti).
Ma quello dei cambiamenti interni alle strutture proprietarie fu solo uno dei risvolti agronomici di
quel periodo, perché nel giro di qualche tempo ad essere intaccato non fu più solo il sistema
produttivo ma il modello stesso di produzione. Plinio il vecchio sembra avere identificato il
problema nella sua famosa allocuzione: “latifundia perdidere Italiam”, traducibile come ” i latifondi
sono la perdizione dell‟Italia”. Ma ho sempre pensato che Plinio sbagliasse l‟analisi, prendendo
l‟effetto per la causa! O forse Plinio il vecchio era un lucido lettore di una realtà oggettiva dove le
classi dirigenti -per salvare se stesse- stavano gettando le basi della distruzione delle basi
economiche dell‟impero!
Quello che è certo è che negli ultimi secoli di vita della parte occidentale dell‟impero assistiamo ad
una progressiva concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani di un numero sempre più
ristretto di famiglie (con la crisi della parte occidente dell‟impero iniziò poi la sostituzione di molte
di queste proprietà a favore dell‟apparato ecclesiastico), ed è abbastanza sorprendente che questa
tendenza alla concentrazione della ricchezza possa essersi attuata senza che alcuni ceti economici –
quelli che oggi sarebbero definiti “ceti medi”- non pretendessero le giuste correzioni (come potete
capire questo discorso è particolarmente complesso e questa non vuole essere una trattazione sociopolitica). D‟altro canto la tendenza al gigantismo – spacciata come apparente ottimizzazione della
produttività - è una forma di senescenza che facilmente s‟incontra nei sistemi economici in via di
172
degenerazione (oggi stiamo vivendo lo stesso meccanismo), senza che la maggioranza delle
popolazione sia capace di rendersi conto del danno che questo comportamento produce nel medio o
lungo periodo, e anche senza che –per ovvie e miopi pulsioni- le classi dirigenti (e i loro accoliti)
facciano nulla per correggerlo. D‟altro canto l‟accusa generalizzata al latifondo pecca di grossolana
semplificazione, perché -nella realtà- il latifondo è un fenomeno prometeico, quindi sfaccettato e
complesso. Questo spiega come sia potuto perdurare in occidente fino all‟età contemporanea e
continui pervasivamente ad esser presente nelle agricolture degli altri continenti (Oceania in primis,
che certo non può essere catalogata come area sottosviluppata). Il latifondo non è solo “estensione”
(nel senso della dimensione dei fondi coltivati che può arrivare anche a decine di migliaia di ettari,
ma –ancora di più- è “semplificazione”. Il latifondo infatti è tendenzialmente monocolturale, e gli
eventuali usi secondari della terra (esempio il taglio del bosco o il pascolamento stagionale) sono
demandati ad appaltatori esterni.
Di questa concezione monocolturale abbiamo oggi esempi nelle grandi piantagioni tropicali di
alberi fruttiferi (dove l‟inquinamento da anticrittogamici può arrivare a livelli spaventosi) e nelle
vaste coltivazioni di caucciù (dove la monocultura comporta una drammatica perdita di
biodiversità). Ma esiste anche un latifondo a bassa entropia (sul concetto di entropia torneremo
profusamente più avanti) dove le relazioni tra produttività e ambiente naturale sono particolarmente
“equilibrate”: penso ad esempio agli allevamenti bovini o ovini (sempre che il bisogno di pascoli
non comporti il taglio delle foreste), dove il modello di allevamento brado assicura standard di
benessere animale e una qualità di prodotti incomparabilmente più alta che negli allevamenti
industriali.
Come vedete il tema è assai controverso e non vorrei dare l‟impressione di sottovalutare la
problematica sociale che è legata a questa forma di conduzione agraria (“terra senza uomini e
uomini senza terra” – ha scritto qualcuno). Di certo questa lenta ma inarrestabile evoluzione verso il
gigantismo semplificato comportò il totale rigetto del concetto naturalistico produttivo del “Genius
Loci” (così come la cultura etrusco-romana l‟aveva concepito). A fronte dei tanti differenti piccoli
ambiti messi sapientemente e rispettosamente a coltura c‟era ora una gestione monotona e
standardizzata del territorio, con pesanti ripercussioni economiche che sociali (Vandana Shiva dice
che: “alla monocoltura della terra corrisponde sempre una monocoltura della mente”).
Non diverse erano le condizioni dei tanti territori che erano stati occupati e centuriati
dall‟espansionismo romano. Questi territori –anche dove e quando funzionavano da sostegno
economico produttivo alle realtà civiche locali- erano di fatto totalmente inseriti nell‟economia
globalizzata tipica dell‟Impero. Non a caso erano tutti limitrofi agli assi portanti della viabilità
romana (ricordate il proverbio: tutte le strade portano a Roma?).
Il venir meno di Roma come mercato di consumo, fece venir meno anche la funzionalità di quella
pianificazione produttiva, e nei secoli successivi quei territori dovettero affrontare una completa
ristrutturazione organizzativa (per capirci, una cosa analoga alla crisi, non solo produttiva, a cui
sono stati esposti i paesi che hanno dovuto sottostare al colonialismo europeo).
173
Di questi passaggi sono stato un parziale osservatore, essendo nato in una zona dove da centinaia
d‟anni il latifondo era dominante (10.000 ettari limitrofi a Roma –divisi solo tra quattro proprietà).
Nei tempi del latifondo in questo vasto territorio vivevano stabilmente poco più di un centinaio di
persone, con una densità paragonabile a quella di un deserto; luoghi che le bonifiche dei primi del
1900 trasformarono in quattro grandi aziende a gestione capitalistica con oltre 5-6.000 braccianti.
Una ristrutturazione agraria che portò il territorio a raggiungere livelli di produttività
impressionanti, ma anche una trasformazione che mostrava i fianchi a significative debolezze
strutturali: una bonifica agraria pensata e organizzata intorno ad un canale adduttore che pescava le
acque d‟irrigazione dal Tevere; il bisogno di quell‟acqua di essere sollevata e spinta da pompe
elettriche (con dei notevoli extra-costi); la necessità di spianare e livellare tutti il terreno, di
costruire argini per i torrenti e di ridisegnare il tutto in funzione di una logica industriale applicata
all‟agricoltura. Praticamente un territorio dove niente ha più a che vedere con il concetto di Genius
loci che aveva fatto grande e potente l‟agricoltura degli antichi romani. Un modello d‟agricoltura
che solo un basso costo dell‟energia e una logica economica autarchica poteva mantenere
economica e razionale e che ora è tornato ad essere coltivato da poco più che un centinaio di
persone (e tutto questo nell‟arco di una ottantina d‟anni). Ennesima riprova che la terra e l‟acqua che prima o poi indefessamente ritorna nei suoi antichi alvei- hanno una cosa in comune: la
memoria!
174
Il tempo dei cavalli e dei cammelli
Ci sono tempi della storia che per consuetudine si definiscono “bui, oscuri”; sono quei tempi segnati
da profonde fratture e da una serie di accadimenti traumatici che fanno perdere agli uomini anche
quelle certezze che credevano incrollabili; secoli dove – il sovvertimento dell‟ordine costituitoinduce una profonda paura per un futuro segnato da un caos generalizzato e annichilente. Di questi
tempi foschi rimangono più miti che storia, perché –a posteriori- pochi sono i fatti documentati e
documentabili e molti i racconti e le superstizioni popolari. Sono i tempi dove anche il quotidiano è
pervaso dall‟irrazionale, e dove il timore permea la consuetudine. Non deve essere facile vivere
quei periodi (il caos diventa “creativo” solo nella testa di coloro che raccontano il dopo), perché gli
uomini –in certe momenti storici- percepiscono di non essere davanti ad una semplice stagione
avversa: i tempi “oscuri” possono dilatarsi per decenni, per secoli, senza che si riesca ad avvertire lo
spuntare di quei nuovi germogli sociali, economici e culturali - che finora, e chissà fino a quando,
hanno accompagnato le rinascite delle società umane. Fenomeni così intensi son successi alla
caduta delle grandi civiltà classiche dell‟Eurasia: furono quelli vissuti dagli uomini di Eridu e di
Sumer e delle distruzioni tramandate nel Diluvio; furono quelli degli uomini di Babilonia, dopo che
i dissidi fecero crollare la torre che doveva arrivare fino al cielo; o quelli che corrispondono alla
scomparsa delle civiltà minoiche, micenee o cananee, dopo all‟arrivo dei Popoli del Mare e delle
loro nuove armi forgiate dal ferro. Una cosa analoga successe agli uomini che vissero il declino e la
caduta dell‟impero romano e degli altri imperi dell‟Asia centrale. I tempi che videro le terre
coltivate calpestate da torme di cavalieri nomadi arrivati per razziare e saccheggiare.
Per noi è difficile capire la portata di questi fenomeni, noi che da centinaia d‟anni viviamo in un
mondo di campi, di villaggi e di città -popolati oggi da miliardi di persone-; un mondo dove gli
“altri” (e per altri intendo i popoli che non coltivano, ma allevano, cacciano o raccolgono)
rappresentano un‟esigua minoranza della nostra umanità; una reliquia che immaginiamo destinata a
sparire nel breve arco di qualche generazione. Ma la realtà del mondo non è sempre stata così: in
epoca classica (e mi sto riferendo all‟Eurasia) il mondo coltivato –ossia quello che allora era in
grado di sostenere le strutture statali stabili a cui noi assegniamo il ruolo di nuclei di civiltà - era
rappresentato da imperi che geograficamente si collocavano in una precisa fascia latitudinale
dell‟emisfero nord (grossolanamente tra il trentesimo e il quarantacinquesimo parallelo, a cui –per
esattezza- bisogna aggiungere la stretta e verticale valle del Nilo). E‟ strano pensare che in questa
fascia, Roma -posta alla latitudine di 41,84- fosse la più nordica delle grandi città del mondo
classico. Erano imperi assai vasti e relativamente popolati, ma fuori da quello specifico ambito
geografico (soprassedendo dall‟India e dall‟Indocina) c‟era tutto il resto del mondo; sia il vasto
mondo vuoto di uomini, che quello abitato da popoli (più o meno aggregati e più o meno
organizzati) dediti –in piccola parte alla caccia e alla raccolta- e nella maggior parte alla pastorizia
transumante. Un vasto insieme di uomini che non siamo in grado di stimare nei numeri (che
possiamo immaginare comunque significativi), capaci –se anche solo una parte si fosse messa in
movimento- di scardinare le strutture di qualsiasi antica civiltà.
175
Sarebbe bellissima una storia del mondo vista con gli occhi dei popoli nomadi, ma i nomadi non
usavano il segno per trasmettere le loro gesta, le passavano di generazione in generazione attraverso
i canti o i racconti epici -che altri hanno successivamente trascritto- componendo mitiche saghe e
epopee. Forse è in quest‟ottica che dobbiamo leggere la stesura del testo sacro degli ebrei e di
quello degli arabi; quando i due popoli smisero di vagare per il deserto il verbo si fece codice, un
insieme di leggi –inviolabili- per loro ispirate dal respiro di Dio.
Grazie però alle testimonianze degli storici latini, agli epistolari religiosi, ai testi arabi e cinesi
abbiamo modo di conoscere l‟ultimo periodo “oscuro” della nostra umanità, quello che potremmo
far cominciare (tanto banali e inutili sono queste date) dall‟arrivo degli Unni alle frontiere
dell‟Impero romano (nella seconda metà del 300 d.C.) e terminare con l‟incredibile parabola
dell‟Impero mongolo nella seconda metà del 1200 d.C. (con tutte le conseguenze geopolitiche e
agronomiche a esso collegate). Due enormi movimenti e rimescolii di popoli che aprirono e
chiusero quasi mille anni di storia che portarono a un totale ridisegno della geografia sociale,
religiosa, economica e culturale dell‟intera Eurasia. C„è però un aspetto che è opportuno precisare
(quello che mi tiene fermo su queste righe ormai da giorni): queste storie non sono unite da una
traccia comune, sono però unite da un senso che le accomuna, le assimila, e le attualizza!
Certo, l‟insieme dei fenomeni e la dimensione dell‟ambito geografico sono di una tale vastità che
appare quasi velleitario voler affrontare questo intricato nodo gordiano, e il rischio di perdere il filo
generale del discorso rappresenta una paura incombente. Ma non c‟è altra cosa da fare se non dare
un taglio ai tentennamenti e provare a scriverli!
Cominciamo costruendo una mappa mentale di questa Eurasia negli anni del tardo impero romano!
All‟estremo ovest c‟era la grande civiltà latina, quella che occupava ancora tutto il Mediterraneo
(sebbene già divisa in due realtà congiunte: la parte orientale e quella occidentale dell‟impero) e che
estendeva le sue propaggini verso il nord di un‟Europa (realisticamente ancora dominato dalle selve
e da lande incolte), lungo il corso del Nilo e verso i pianori del Medioriente. Un sistema binario
dove - dal concilio di Nicea e dalla fondazione di Costantinopoli- erano riemerse -per importanza
economica e culturale- le aree di cultura ellenistica e di lingua greca, e dove Costantinopoli stava
erigendosi come un luminoso faro di riferimento. All‟estremo oriente c‟era la Cina, che nel lungo
periodo della dinastia Han (206 a. C. – 220 d. C.) aveva spinto il suo dominio molto all‟interno
dell‟Asia Centrale, aveva organizzato il culto del confucianesimo, aveva inventato la carta e
introdotto dall‟India il buddismo; ma che dal 221 era caduta nel periodo in un periodo confuso dove
i regni si ridividevano in regni: un lungo “medioevo”, dove i centri propulsori della cultura si
spostarono verso il sud della Cina, mentre il nord era impegnato in una serie continua di lotte contro
i popoli nomadi che premono ai suoi confini. Tra queste due realtà poste all‟estremo occidente e
all‟estremo oriente, che –malgrado le loro gravi problematiche interne- restavano due colossi
politico-militari e economico-culturali, e che nella crisi generalizzata dei loro sistemi avevano
aperto degli spazi “intimi” alle nuove religioni, si collocavano altri due grandi imperi: quello
Sasanide -erede dell‟Impero partico- dove si parlava il pahlavi scritto con l‟alfabeto aramaico, si
professava il culto dualista fondato dal profeta Mani, oltre a quello monoteista fondato da
Zoroastro; e quello Kusana, dove si parlava il tocario (un‟antica lingua indoeuropea oggi non più in
176
uso), si utilizzava l‟alfabeto greco (antica reminiscenza dell‟occupazione di Alessandro il grande) e
si professava il buddismo come religione ufficiale.
Due realtà estesissime territorialmente, anche se poco coese geograficamente e culturalmente, eredi
dell‟antica presenza iranica, e di quei regni sopravvissuti al disfacimento dell‟Impero di macedone;
due vasti agglomerati che mantenevano con gli altri imperi una complessa forma di equilibrio, in
parte diplomatico in parte militare.
Immagine presa da Wikipedia ala voce: Impero sassanide, qui visto al suo apogeo. Autore Keeby101
177
Immagine presa da Wikipedia alla voce: Impero Kusana. Autore PGHCOM
Poi, in uno specifico periodo della storia dell‟Eurasia, con una intervallo ciclico il cui ritmo
andrebbe meglio esplorato, contro le frontiere di questi quattro imperi, si mossero –come magli
martellanti d‟incredibile intensità- dei popoli nomadi che arrivarono a scardinarle e ad annichilirle.
La maggior parte di questi popoli (anche per le ovvie dimensioni dello spazio geografico) proveniva
dal nord: alcuni erano indoeuropei (come gli Alani) e venivano dalle grandi steppe dell‟Europa
orientale e dell‟Asia centrale, altri venivano dai luoghi ancora più lontani; dalle parti più estreme
della Siberia o della Mongolia. Mentre –con l‟Egira, e in uno specifico momento della loro storia- si
misero in movimento anche i popoli che abitavano la Penisola Arabica, e il cozzo delle loro truppe spinte dai loro nuovi ideali e del loro nuovo credo- contro le frontiere dei vecchi imperi fu
deflagrante, e tutto l‟ordine mondiale (potremmo anche chiamarlo l‟ordine interno alla fascia
settentrionale del tropico del cancro) fu rivoluzionato. Per raccontare questa prima parte del capitolo
partiremo dagli Xiongnu e chiuderemo con i Mongoli, due popoli che si mossero sia verso l‟oriente
che verso l‟occidente.
Gli Xiongnu (o Hsiung-nu) furono una confederazione nomade di tribù di origini sconosciute di cui
abbiamo alcuni nomi e titoli translitterati in lingua cinese. Nel XVIII secolo Joseph de Guignes li
identificò con gli Unni, aprendo un dibattito molto acceso sulla loro origine che ancora non ha
trovato una definizione certa. La dinastia Qin li ritenne così pericolosi e distruttivi, che -per
proteggere la Cina dai loro attacchi- iniziò la costruzione della Grande Muraglia. Le relazioni fra le
prime dinastie cinesi e gli Xiongnu furono complesse, con ripetuti periodi di confronti militari e
intrighi alternati a scambi di tributi, commercio e matrimoni combinati a scopo politico. Alcuni
178
studiosi ritengono che durante la dinastia Han 漢 (206 a.C.-220 d.C.) gli Xiongnu fondassero un
regno nelle regioni a nord dell'impero cinese, è certo comunque che sconfissero i cinesi nel 162 A. e
che -alcuni secoli dopo- dei gruppi meridionali di Xiongnu furono cacciati dalla Cina e costretti a
migrare verso occidente. Se l‟identificazione tra gli Xiongnu e gli Unni è corretta, la loro calata
nelle pianure dell'Ucraina e della Bielorussia avvenne tra il 374 ed il 376 e si concretizzò con il
classico "effetto domino": vennero travolti dapprima Sarmati, Alani, Ostrogoti, Sciri, Rugi, quindi,
Visigoti, Eruli, Gepidi, Burgundi, Franchi, Svevi, Vandali ed Alamanni; i quali tra il 378 ed il 406
si abbatterono in massa sull'Impero romano d'Occidente. Nel frattempo un gruppo di Unni misto ad
Avari, a Turchi e a Bulgari, staccatosi dall'orda principale, mise a ferro e fuoco l'Impero sasanide di
Persia, e invase la stessa India. Nel 430 gli Unni furono impiegati da Ezio come mercenari al soldo
dell‟esercito romano per combattere i Burgundi, ottenendo come ricompensa una parte della
Pannonia. La situazione cambiò quando Attila divenne loro capo nel 445. Sotto la sua guida gli
Unni si mossero prima contro le frontiere dell‟Impero d‟oriente -costringendo Costantinopoli ad
accettare una pace umiliante-, poi verso la Gallia con un esercito che si dice fosse composto di
500.000 uomini. Qui saccheggiarono Reims, Strasburgo, Treviri, Colonia e qui li sconfisse Ezio
nella famosa battaglia dei Campi Catalaunici, con un esercito rinforzato dai Visigoti, dai Franchi e
dai Burgundi. Nel 452 Attila tornò di nuovo in Italia depredando Aquileia e Milano, dirigendo poi
le sue truppe verso Roma. Arrivato sul Po, gli venne in contro la processione papale di Leone I, che
– secondo una leggenda- fermò Attila innalzando al cielo, alta, la Croce di Cristo. E‟ invece
possibile che Attila fosse già malato o che si ritenesse soddisfatto dal tributo portatogli dal Papa; di
certo morì poco dopo nel 453 e con la sua morte si disfece l‟idea di un suo impero nomade.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Unni
Di quel tempo, e dei timori che l‟arrivo di questo popolo di cavalieri nomadi stava generando,
abbiamo una lettera di San Girolamo, che in quel momento risiedeva a Betlemme, e che terrorizzato dalla loro invasione- lasciò scritto: “proprio un anno fa, eccoti piombare su di noi, dalle
più lontane regioni rupestri del Caucaso, dei lupi. Non erano dell'Arabia, no, erano del Nord, e in
poco tempo hanno traversato immensi territori. Quanti monasteri hanno requisito! Quanti fiumi si
sono visti cambiare l'acqua in sangue umano! Branchi di prigionieri furono trascinati via. L'Arabia,
la Fenicia, la Palestina e l'Egitto sono in preda al terrore, come paralizzate. Potessi avere anche
cento lingue e cento bocche e una voce di ferro, non potrei ugualmente fare una rassegna completa
di tutti questi disastri”.
Da questo passo appare evidente la paura per l‟arrivo di un popolo di straordinari cavalieri e di
insaziabili predatori, che avevano i volti tagliuzzati, che si diceva dormissero cavalcando e che
mangiavano carne cruda scaldata tenendola sotto sella. Dopo i lunghi secoli della Pax romana
l‟arrivo di un‟orda di predatori a cavallo generò un timore così profondo da trasparire –ancora oggi
- nell‟incredibile persistenza del mito di “Attila, flagello di Dio”. Specialmente se consideriamo il
fatto che la sua parabola fu –realisticamente- di breve entità, che Ezio lo sconfisse pesantemente e
che papa Leone e Costantinopoli trovarono il modo di fermarlo o con il denaro o con la fede. Ma il
mito è tale quando è in grado di superare i secoli e le ragioni storiche; un mito è mito perché è
capace di rigenerarsi.
179
Intanto, spinti dagli Unni, irruppero alle frontiere dell‟Impero romano gli Alani (un altro popolo
nomade di provenienza iranica), che a loro volta spinsero i Vandali e molti altri popoli di origine
germanica in una fuga disordinata verso ovest, che in realtà divenne un vero e proprio progetto di
traslazione geografica (ma su queste migrazioni dei popoli germanici torneremo nel prossimo
capitolo).
Immagine presa da Wikipedia lla voce : Alani, che mostra le migrazioni degli Alani e dei Vandali fra il IV e il V secolo. Rosso: migrazioni;
Arancione: spedizioni militari; Giallo: aree d'insediamento. Autore. Abou Ben Adhem
Gli effetti dell‟immane moto sussultorio avviato dagli Xiongnu/Unni (ma la situazione non
cambierebbe neppure se l‟identificazione tra i due gruppi non fosse corretta) furono enormi. Dal
200 al 400 d.C. l‟Impero fondato dagli Han fu destrutturato, l‟Impero sasanide fu pesantemente
indebolito, l‟Impeto kushana fu cancellato completamente dalla storia e la parte occidentale
dell‟Impero romano fu distrutta (per correttezza è necessario dire che l‟Impero kushana fu occupato
dagli Unni bianchi, la cui origine è tuttora incerta). Da quel terremoto sociale, politico, culturale e
religioso si salveranno la parte orientale dell‟Impero romano (ormai diventato “bizantino”) e
l‟Impero sasanide; come se i confini del mondo classico si fossero ristretti ai tempi delle lotte tra i
Greci e gli Achemenidi. Ma passarono poco più di due secoli quando ecco apparire -dai deserti
della Penisola arabica- un‟altra confederazione di popoli, che –quando con il loro galoppo velocesi affacciò sul proscenio del Mediterraneo e dell‟Asia orientale fu capace di sconvolgere la maggior
parte delle frontiere e ad imporre una scrittura nuova all‟intera storia dell‟Eurasia e ad una parte
significativa del continente africano.
Gli arabi sono una popolazione semitica, originaria della Penisola arabica, che -a partire dal VII
secolo- acquisì una enorme rilevanza sulla scena storica mondiale. Nel VI secolo, la Penisola
arabica era abitata dagli eredi dei regni dei Sabei, del Hadramawt, del Qataban, di Awsan e dei
Minei; portatori di culture sedentarie estremamente progredite nelle conoscenze idrauliche e assai
attive nel commercio dei cosiddetti "aromata" (fra cui il famoso incenso), e dai Beduini - gli abitanti
delle steppe arabe- dediti al piccolo e grande nomadismo legato strettamente all'allevamento dei
cavalli, degli ovi-caprini e dei dromedari. All'inizio del VII secolo, Maometto –nato a La Mecca
intorno al 570- riuscì a riunire le tante popolazioni arabe in una unica entità politica, culturale e
religiosa. Il fulcro di tutto questo fu la rilevazione del Corano, che Maometto cominciò a ricevere
180
durante il digiuno del 610 e che proseguì per 22 anni fino al 632. Il Corano (in arabo: )القرآنè il
testo sacro della religione islamica, il messaggio trasmesso da Dio (Allāh) a Maometto (in arabo
Muḥammad) per un tramite angelico, su cui si fonda il culto monoteista con più fedeli al mondo.
Nel 622, il suo allontanamento verso Medina (l‟Egira), segnò l'inizio dell'era islamica. Il Profeta,
con una serie di battaglie e di conversioni, fu in grado di conquistare ampie parti del Hijàz e nel 630
occupò La Mecca; morì nel 632. I califfi, suoi successori, avviarono una fortunata e rapida
espansione territoriale, invadendo la Siria e l‟Egitto e poco dopo tutto il Magreb; nel 637
conquistarono l'impero Sasanide, vincendo la famosa battaglia di Qādisiyya, durata più di una
settimana. Nel 711, gli Arabi occuparono la Penisola iberica, ponendo fine al regno visigoto, e
passarono i Pirenei, ma nel 732 furono fermati nella battaglia di Poitiers dai Franchi di Carlo
Martello. Nel Mediterraneo gli Arabi (detti talora Saraceni) conquistarono la Sicilia e –con continue
scorrerie- depredarono le coste della Sardegna e della Corsica, della Provenza e dell‟Italia
meridionale. L'elemento arabo-berbero portò all'Occidente cristiano nuove conoscenze tecnologicoscientifiche, nuovi cultivar e nuove specie sconosciute: canna da zucchero, riso, spinaci, banane,
zibibbo, cedri, limone, arancia dolce e cotone, come pure spezie di vario tipo, quali la cannella, i
chiodi di garofano, la noce moscata, il cardamomo, lo zenzero o lo zafferano, reintroducendo nel
Mediterraneo colture che si pensa fossero state abbandonate come l'albicocco. Altri fondamentali
apporti furono nella scienza della matematica, l'algebra e la trigonometria; grazie a loro fu
introdotto il sistema decimale e il concetto di zero (elaborati in ambito indiano), e la bussola.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Arabi
Espansione del califfato __ Espansione sotto Maometto, 612-632 __ Espansione sotto il Califfato "ortodosso", 635-661 __ Espansione sotto il
Califfato omayyade, 661-750.
Immagine presa da Wikipedia alla voce: Espansione islamica. Autore DieBuche
Con l‟arrivo dei conquistatori arabi si ridisegnò completamente non solo la geografia politica del
mondo antico, ma anche quella culturale e religiosa. Il Mediterraneo mantenne la sua centralità
181
geografica ma perse per sempre la sua unitarietà; e per la prima volta delle profonde faglie lo
divisero in est e ovest, e in nord e sud (divisione in quadranti mai più colmata). Entità separate che
–in alcuni momenti- si scontreranno ferocemente. La civiltà egizia (poi greco-alessandrina) finirà
per sempre (sostituita da una cultura araba che –durante il periodo Fatimite arriverà ad altissimi
livelli), lo stesso succederà alla civiltà mesopotamica (dove i califfi Abbasidi fonderanno Bagdad);
poi con la caduta dell‟Impero sasanide si comincerà a scrivere un capitolo completamente nuovo
anche della storia dell‟Asia centrale e dell‟Iran. In tutti questi paesi la religione principale diventerà
quella mussulmana, le lingue saranno veicolate grazie all‟alfabeto arabo e si altereranno
profondamente i legami che questi vasti territori avevano con le civiltà precedenti. E mentre molti
territori del vasto mondo mussulmano troveranno una loro prolungata stabilità socio-culturale, che
nei secoli diventerà stagnazione ed esclusione dai circuiti delle idee e dei commerci (Magreb e
Penisola arabica in primis), l‟Asia centrale e parte del Medioriente si convertiranno in uno spazio
pneumatico, con gravi difficoltà a ricompattarsi intorno a strutture statali proprie o ben organizzate;
una debolezza strutturale che funzionerà da potente richiamo per gli altri popoli che decisero o
dovettero uscire dalle steppe.
I popoli turchi -così come gli Unni- erano probabilmente stanziati nell'alto corso dell'Enisej e nelle
pianure della Siberia. Il termine Türk (corrispondente al cinese tu-jue) compare per la prima volta
scritto su fonti cinesi. Il primo stato "turco" fu quello dei Göktürk (i "Turchi Celesti"), fondato in
Asia centrale due secoli dopo il collasso dell'Impero unno. Tribù certamente turche erano note in
Asia Centrale tra il VI e il X secolo; un vasto mondo turcofono di cui facevano parte gli Uiguri, i
Kirghizi, e i Turkmeni, gli Uzbechi e i Kazachi. Soldati turchi nelle file dell'esercito abbaside
emersero come feudatari di vaste aree del Vicino e Medio Oriente, e con Seljük (morto intorno
all'anno 1000) s'impadronirono dei territori abbasidi e di molte aree bizantine, fondando una
dinastia il cui ramo principale ebbe la sua residenza Isfahan, in Persia. Di fede sunnita, i Selgiuchidi
crearono in impero che si estendeva dall'Anatolia al Punjab e governava parte dell'Asia centrale, del
Vicino e del Medio Oriente dall'XI al XIV secolo: adottando la cultura e la lingua persiana
giocarono un importante ruolo nello sviluppo della tradizione culturale turco-persiana. Oggi sono
ricordati come grandi patroni della cultura, arte, letteratura e lingua persiana e sono considerati gli
antenati culturali dei Turchi occidentali; gli attuali abitanti di Azerbaigian, Turchia e Turkmenistan.
Tuttavia vi erano (e vi sono ancora) piccoli gruppi di popoli turchi che rimasero attaccati alle loro
antiche religioni sciamaniche, mentre alcuni altri divennero cristiani (per lo più nestoriani), ebrei ( i
Khazari), buddisti e zoroastriani.
Nel 1299 –con il declinare dell‟impero Selgiuchide- Osmân Ġâzî fondò in Anatolia un suo piccolo
regno indipendente. Questo fu l‟inizio di uno degli imperi più longevi e più straordinari della
storia: l‟Impero ottomano, conosciuto anche con come “ la Sublime Porta, che durò per 623 anni
dal 1299 al 1922. L'Impero ottomano fu anche uno dei più estesi e potenti del mondo: nel momento
del suo apogeo -tra il XVI e il XVII secolo, e specialmente sotto il regno di Solimano il Magnifico-,
i suoi confini si estendevano (in una realtà multinazionale, plurilingue e rispettosa delle identità
culturali e religiose) dalle periferie di Vienna e della Polonia a nord fino allo Yemen e l'Eritrea a
sud; dall'Algeria a ovest fino all'Azerbaigian a est, controllando gran parte dei Balcani, del Vicino
Oriente e del Nordafrica. Con Costantinopoli come sua capitale, l'impero fu al centro dei rapporti
182
tra oriente e occidente per circa sei secoli. La scelta di partecipare alla prima guerra mondiale a
fianco dell‟Austria e della Germania lo portò ad una umiliante sconfitta, ad un suo successivo
smembramento, e all'istituzione dell'odierna repubblica di Turchia.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Turchi
Immagini prese da Wikipedia alle voce: Impero selgiuchide (autore MapMaster) e Impero ottomano (autore Alc16)
Se con gli Unni bianchi cadde l‟impero Kushana, e con l‟arrivo delle cavallerie arabe quello
sasanide, con i turchi –prima selgiuchidi e poi ottomani- arrivò la fine anche di quello bizantino;
l‟impero millenarista, il longevo erede dell‟Impero romano d‟oriente. I tempi delle corte tuniche
greche e delle toghe erano finiti per sempre e sul mondo cominceranno a governare i popoli dai
lunghi caftani o dai comodi pantaloni di stoffa pesante. Poi, improvvisi e violenti come una
tempesta, sull‟Asia si abbatterono le invincibili cavallerie mongole, e il loro impatto sul coacervo di
stati piccoli e grandi, che si era formano con la dissoluzione dei grandi imperi precedenti, fu così
potente, che al grande blocco continentale furono strappati i polmoni.
I mongoli erano un popolo nomade che abitava più o meno nell'odierna Mongolia orientale e che gli
arabi chiamavano “tatar”, trasformato in Tartari. Nel XIII secolo essi trovarono un capo (un khan)
in grado di riunificare tutte le tribù: Genghiz Khan, uno dei più grandi conquistatori della storia,
accostabile forse solo ad Alessandro Magno. Nato come Temujin, entrò a servizio dei keraiti, una
tribù turco-mongola cristianizzata secondo il credo nestoriano. Nel 1206 fu proclamato Gran Khan,
e prese il nome di "Genghiz Khan" ovvero "Signore Universale". Da allora egli si diede a
conquistare e riorganizzare: ogni tribù (ulus, che indicava anche il patrimonio collettivo) era
indipendente, ma tutte erano sottomesse alla famiglia imperiale, il cosiddetto "casato della stirpe
aurea". Nel 1211 i mongoli conquistarono il regno turco-iranico della Corasmia e le città di
Samarcanda e Bukhara, dirigendosi poi a nord dove venne conquistato il regno della Grande
Bulgaria, la cui popolazione fu deportata. Nel 1227 il grande leader morì e suo figlio Ogödäi (1229)
fu indicato come successore. Ogödäi si diede a completare la conquista della Cina settentrionale e
della Persia, mentre suo cugino Batu, lanciò una spedizione contro l'Europa. Nel 1241 i cavalieri di
Batu Khan si erano impadroniti di un vasto territorio tra il Volga e il Mar Nero, futuro nucleo
dell'Impero dell'Orda d'Oro, e poterono riversarsi più a ovest, dove attaccarono la Polonia, la
183
Boemia e l'Ungheria. Federico II si appellò allora a tutti i sovrani cristiani per bandire una crociata e
anche papa Gregorio IX parve incline a tale soluzione.
Immagine presa da Wikipedia alla voce: Mongoli. Autore GNU
Ma fu lo stesso Batu a ritirarsi dai territori europei conquistati perché il suo esercito aveva subito
gravi perdite e perché la conquista poteva trasformarsi in una folle avanzata senza appoggi logistici.
Inoltre l'elemento che rese imminente una ritirata fu la morte di Ogödäi. Nel 1241 venne scelto
come nuovo Gran Khan Guyuk, che non riprese la campagna contro l'Europa, ma si dedicò
all'assoggettamento della Cina, dove crollò la dinastia Sung nel 1249 e venne instaurata la prima
dinastia non-cinese dell'Impero, quella mongola degli Yuan, con Khubilai come primo imperatore
mongolo-cinese di (quello di Marco Polo). Dalla seconda metà del XIII secolo l'Impero mongolo
era diviso in quattro stati federati: quello cinese, con capitale a Pechino, che durò fino al 1368
quando salì al potere la dinastia Ming. Il Khanato dell'Orda d'Oro, nel sud dell'attuale Russia, Il
Khanato Chagatai, tra lago d'Aral, Tibet e Cina, e il Khanato di Persia, ottenuto dopo la sconfitta
dell'ultimo califfo abbaside e la presa di Baghdad nel 1258.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Mongoli
Ora, dopo aver fatta questa lunga e colorata premessa (a cui per dovere di cronaca mancano le gesta
e le conquiste di Tamerlano -che in parte esulano al nostro percorso-), viene spontaneo domandarsi:
184
cosa spinse questi popoli a lasciare le loro tende o le loro iurte, ad abbandonare i loro terreni da
pascolo, le loro greggi e i loro climi? Cosa li portò a cercare nuovi territori e –nel fare questocostringersi ad affrontare eserciti potenti e strutture statali centralizzate e ben organizzate? Quale
problematiche interne agli Stati favorirono la loro conquista? E quali furono le conseguenze che il
loro arrivo comportò nelle terre conquistate? Questa serie di domande si presta, ovviamente, ad una
molteciplità di opinioni -ma premesso questo luogo comune-, credo si debba fare lo sforzo
intellettuale nel tentare delle risposte, fossero pure parziali o schematiche! Torniamo quindi su
concetti già esposti ma che è conveniente rivangare!
Molti uomini si muovono (individualmente o in gruppi) per attrazione; questo perché pensano o
sperano di incontrare in altri luoghi delle condizioni migliori per loro stessi, per le loro famiglie o
per i loro clan. Questi movimenti sono in genere volontari, e - nei paesi d‟approdo- inducono la
benevolenza o la contrapposizione a secondo le specifiche condizioni culturali, politiche ed
economiche (l‟Australia fino a pochi decenni fa incentivava i migranti, mentre ora applica delle
politiche di severa restrizione, invece Israele facilita tutti i migranti, purché siano di religione
ebraica). A contrappunto le genti (e con questo termine intendo una tribù –termine che non amo
usare- o un popolo) sono più restie a lasciare i loro luoghi d‟origine (il termine “origine” –visto i
mix genetici da cui i popoli discendono- è chiaramente relativo); se si muovono lo fanno per crisi
politiche, ecologiche, economiche come quella che sta vivendo il Medioriente in questa seconda
decade del nuovo millennio (ossia lo fanno –pianificando la scelta- perché sono costretti a farlo);
oppure si muovono perché indotti a farlo da un prolungato successo produttivo e riproduttivo
(questo è quello che succede ogni volta che dei gruppi “sciamano” -come fanno le api- per
colonizzare nuove terre). Poi –occasionalmente- ci sono quelle che possiamo chiamare vere e
proprie “fughe”; sono quegli spostamenti tumultuosi e disordinati che i popoli sono costretti a fare
sotto la spinta drammatica di razzie e invasioni di altre genti che irrompono sulle loro terre (per
esempio le migrazioni dei Germani davanti all‟arrivo dei cavalieri unni).
Ci sono però delle differenze sostanziali: i popoli contadini migrano in cerca di nuove terre da
coltivare, i nomadi –invece- aspirano a città o centri urbani da saccheggiare. I popoli contadini si
muovono lentamente al passo delle loro mandrie, su carri tirati da buoi; i nomadi arrivano veloci sui
loro cavalli, da cui – secondo Ammiano - non scendevano neppure per dormire. I popoli contadini
portano nel loro luogo d‟arrivo dei semi nuovi (intendete il concetto di seme nel senso più ampio
possibile), e proprio per questo tendono a mischiarsi con le realtà precedenti. I nomadi sono soliti
accaparrarsi quello che possono per poi tornare nelle loro steppe (i nomadi non portano con loro dei
semi, perché non seminano, portano archi e spade).
Le ragioni che inducono un popolo nomade ad intraprendere una campagna di conquista sono le
stesse di quelle che inducono le migrazioni dei coltivatori? In gran parte si: crisi politiche,
ecologiche, etc. etc., ma c‟è un aspetto che vale la pena approfondire: le società nomadiche –per
ovvie ragioni - sono molto sensibili ai cambiamenti climatici; sono società che normalmente hanno
una mortalità infantile molto più bassa di quella stanziali (le condizioni ambientali sono molto più
“sane”), ma con cicli di interparto molto più lunghi (le donne pianificano le gravidanze ogni tre o
quattro anni). Questo comportamento è teso a coniugare le difficoltà dei continui spostamenti con le
185
fatiche della gravidanza e dell‟allattamento, e ha il vantaggio di consentire un attento controllo
demografico; riuscendo così ad equilibrare il numero delle persone con le risorse alimentari e
ambientali disponibili. Un ciclo pluridecennale di buone stagioni induce un allentamento di queste
prassi comportamentali. Inverni più miti (o –se parliamo di deserti- più piovosi) significano pascoli
più abbondanti, e pascoli più abbondanti vogliono dire più nascite nelle mandrie e sotto le tende.
Quando dopo un ciclo di stagioni benevole arriva –improvviso- un ciclo di stagioni rigide o asciutte
la popolazione -di uomini e di animali domestici- deve trovare rapidamente un nuovo equilibrio. E‟
quello che con una legge generale potremmo definire “effetto mantice”: uomini e animali sono
relazionati al clima e il loro numero si espande e di riduce in rapporto ad esso con forma
matematica. In questo caso sciamare è molto meglio che morire, e i nomadi “sciamano”, con una
forza disperata e causale correlata alla specificità del ciclo ambientale. Si parte perché non ci sono
alternative, si parte lasciando le greggi a chi rimane, perché si va con le sole armi prima che anche i
cavalli stessi risentano della crisi climatica. Si va per razziare, con l‟idea –forse di ritornare- e con
l‟obbiettivo di prendere tutto quello che è possibile prendere.
La differenza sostanziale tra le migrazione di popoli coltivatori e le incursioni nomadi è nello
sfasamento temporale. I contadini pensano alle prospettive, i nomadi all‟attualità. Da una parte –se
si va- si va per sostituire e costruire, dall‟altra per predare, e le distruzioni sono connaturate a questo
andare. La conquista è un sempre un obiettivo, l‟occupazione è una possibilità! Le conquiste senza
occupazione e integrazioni sono labili, temporanee; è quello che è successo a molti popoli nomadi
che crearono imperi che si disfecero rapidamente; ma non sempre è stato così. Occupare per
governare, vuole però dire accettare un percorso di adattamento alla cultura degli “altri”; ma anche
alla loro struttura sociale, ai loro modelli produttivi, e finanche alle loro religioni (questo hanno
fatto i califfi Omayyadi, questo hanno fatto i sultani Ottomani, questo hanno fatto i Khan mongoli
della Cina. Questi percorsi di trasformazione-acquisizione sono state delle sfide complesse per dei
popoli pastori che si sono trovati a dover gestire dei popoli contadini. Spesso questo processo è
stato favorito dalle condizioni interne dei paesi conquistati: nelle provincie mediorientali
dell‟Impero bizantino, l‟anchilosata struttura di potere e il livello di tassazione imposto dalla corte
di Costantinopoli, ha decisamente favorito la penetrazione degli Arabi, che erano i nomadi
confinanti. Lo stesso è successo ai Mongoli nella Cina settentrionale, dove decenni di caos politico
li ha fatti accettare dai contadini delle campagne e dai ceti medi urbani come dei veri e propri
“pacificatori”.
C‟è sempre un momento nella storia che le civiltà smettono di essere propulsive ed includenti e
iniziano a difendere quella che pensano sia la loro cultura e quelli che credono siano i propri
confini. Questo comportamento di “difesa” tocca tutte le classi sociali, ma non sempre in modo
uguale. Ci sono state e ci sono delle società che generano al loro interno una tale condizione
d‟ineguaglianza o dove le condizioni imposte dall‟Impero sono così pesanti che l‟arrivo di altri
popoli –da alcuni, e specialmente per quelli che sono più lontani dal centro dell‟Impero- può essere
visto come una “liberazione”. Le società che si difendono (con leggi, muri o reti, non cambia il
senso della sostanza), le società che impongono ad altri popoli sottomessi le proprie leggi, o le
società che sono incapaci di sostenere dei meccanismi interni di riequilibrio economico e sociale,
denunciano il fatto di essere già entrate nel cono d‟ombra del loro declino; così irrimediabilmente si
avviano verso il futuro tracollo, per cause interne o esterne ai propri confini. Chi sta fermo, coltiva
186
(intendete in verbo in senso lato); e coltivando, immagazzina; e immagazzinando, tesaurizza, e la
tesaurizzazione eccessiva o diseguale è in grado di generare rabbia o desiderio. Un tesoro è sempre
una meta ambita! Così sono cadute le antiche civiltà classiche, anche quelle che avevano costruito
dei valli imponenti o Grandi Muraglie per segnare –anche visivamente- la divisione tra il colto (nel
suo doppio significato di colto e di cólto) e il selvaggio. Nessun “Hortus conclusus” le ha potute
salvare dagli “altri”: specie dove, l‟iniqua distribuzione delle ricchezze, la staticità delle classi
sociali e gli eccessi di privilegi, avevano indebolito la loro coesione interna.
C‟è un passo di Genghiz Khan che credo sia molto significato: “ ...Io vengo dal Barbaro Nord.
Indosso le stesse vesti e mi sfamo dello stesso cibo dei pastori di vacche e dei mandriani di cavalli.
Tutti noi facciamo gli stessi sacrifici e ci dividiamo le ricchezze. Guardo alla Nazione come a un
nuovo figlio appena nato e mi curo dei miei soldati come se fossero i miei fratelli”.
Genghiz Khan conosceva bene il suo potere personale, tanto da aver assunto il nome di “Signore
Universale”, ma il governo del suo popolo si basava su una forma di “meritocrazia” che era
lontanissima dai modelli di caste o di classi che erano tipici degli imperi stanziali. C‟erano poi altri
aspetti più prettamente contabili ma che occorre non sottovalutare. I sistemi nomadi erano soliti
applicare la tassazione non sulla terra ma sul reddito, e per i contadini vessati dai costi del
mantenimenti dell‟esercito e delle corti questo deve essere stato un grande argomento di
persuasione.
Certo le conseguenze furono enormi; gli storici stimano che le sole invasioni mongole abbiano
provocato l'estinzione di quei pastori iranici che da millenni popolavano l‟Asia centrale e parte della
Siberia, che le popolazioni cinesi a nord del fiume giallo furono ridotte del 90% (da un cinquantina
di milioni a meno di cinque), e che le devastazioni perpetrate dalle loro campagne di conquista
siano state in grado di destrutturare per sempre, o per secoli, le condizioni di una parte del mondo
arabo, dell'Asia centrale e dei principati russi. E questo discorso potrebbe essere esteso, perché –
prescindendo dai territori posti agli estremi (il territorio di Roma e il nord della Cina, che furono
saccheggiati, ma occupati per un periodo relativamente breve) tutte le aree delle antiche civiltà
fluviali (Indo, Mesopotamia ed Egitto) furono contese, occupate e da allora governate da popoli
d‟origine nomadica.
Personalmente però non credo che lo stato di crisi in cui sono precipitati questi vasti territori sia
esclusivamente relazionabile alle crudeltà di queste invasioni: certo le torri di teschi umani che i
Mongoli innalzarono lungo le direttrici delle loro penetrazioni furono agghiaccianti e capaci di
produrre un crac demografico e un danno produttivo tali da portare l‟implosione temporanea delle
strutture organizzative di vari Stati. Ma per l‟ennesima volta non bisogna fare l‟errore di prendere
un evento specifico per il tutto! Dalle campagne occasionali, per quanto spaventose e cruente, i
popoli e i territori riescono a risollevarsi (non c‟è stato olocausto al mondo peggiore della Peste
nera, eppure da quel flagello le società si ripresero in modo relativamente veloce). C‟è però un
aspetto che per onestà intellettuale credo sia opportuno sollevare: è esistita – a mio avviso- una
parziale inadeguatezza dei popoli di tradizione nomadica nel gestire le specifiche situazioni interne
di alcuni dei paesi conquistati, e questo discorso vale particolarmente per quelle aree contraddistinte
187
da condizioni ambientali molto specifiche e molto lontane da quelle della cultura nomadica (il
riferimento è ai grandi territori fluviali).
Stiamo parlando di popoli vincolati a seguire il modello di vita pastorale, l‟unico sistema produttivo
capace di relazionarli “biocenosicamente” con i territori dove per tradizione vivevano (questo vale
sia per i deserti, che per le steppe). Abituati anche ad essere aggregati in piccoli gruppi, sparsi su
vasti territori, affinché il loro peso ecologico fosse ridotto al minimo. Popoli che avevano
consuetudine di ritrovarsi solo occasionalmente, e solo nelle occasioni religiose o commerciali. Resi
forti dal valore dell‟individualismo e dei legami clanici.
Il caso più interessante da analizzare è probabilmente quello arabo. I primi califfi –con una
decisione lungimirante e con impressionante acume geopolitico- fecero di Damasco la loro capitale:
con questa decisione l‟arabo divenne la lingua franca di tutto il Medioriente (e non solo), in arabo si
trascrissero molti testi della cultura greco-alessandrina, oltre a quelli della cultura iranica. In quel
periodo, espansione territoriale e splendore espressivo –muovendosi congiuntamente- raggiunsero i
loro massimi vertici. Lo stesso si può dire successe in agronomia: gli Arabi introdussero nei paesi
da loro occupati l‟uso del dromedario, della palma da dattero e portarono con loro nuove razze di
cavalli, di asini e di ovini (quelle erano le specie vegetali ed animali legate al loro modello
produttivo). Nella loro vasta e composita Umma favorirono poi la coltivazione degli agrumi,
arrivati dalla Cina; dei pistacchi dell‟Iran; del cotone, della canna da zucchero e del riso arrivati
dall‟India; delle spezie dello Yemen. Tutte queste specie si andarono adattando perfettamente ai
climi dei paesi conquistati, ma tutte evidenziarono uno specifico fattore limitante, quello di aver
bisogno di sostanziosi apporti d‟acqua durante la stagione asciutta. Per questo la loro coltivazione
fu limitata alle oasi o ai giardini, ossia quei luoghi dove si poteva intervenire con l‟irrigazione di
falda, di cui gli arabi erano dei veri maestri di captazione e di distribuzione (ricordate i qanat?). Il
riso –che pure è oggi l‟alimento base di molti popoli arabi- e che avrebbe potuto diventare una fonte
di alta produttività cerealicola, di fatto, non fu mai pienamente sfruttato, Non parlo dei territori dove
non c‟erano le caratteristiche pedoclimatiche essenziali per la sua coltivazione, ma neppure in
Egitto, nelle pianure dell‟antica Mesopotamia, o lungo le limitate pianure dell‟Oronte e del
Giordano, dove pure le condizioni per la sua coltivazione avrebbero potuto essere eccellenti (nel
2003 l‟Egitto -con 620 mila ettari coltivati e quasi 6 milioni di tonnellate prodotte- è la
quattordicesima nazione produttrice al mondo, ed è quella che con 94 quintali ad ettaro surclassa di
gran lunga la resa di tutte le altre nazioni, seguita dagli Stati Uniti con 74 quintali ad ettaro e poi
dalla Cina con 61; in compenso la Cina con 167 milioni di tonnellate è di gran lunga il primo paese
produttore. – fonte: FAO).
Non voglio dire con questo che il riso non fu coltivato, voglio però dire che la sua coltivazione non
comportò quella riorganizzarono agronomica, culturale e sociale che aveva caratterizzato i suoi
territori d‟origine. Detto in altre parole: l‟anima individualistica e inquieta del nomade non si piegò
ai bisogni che quella specifica coltivazione impone (il riso vuole “curatori” infinitamente fedeli).
Quando però il suo processo di adattamento al clima si perfezionò e quando i popoli delle coste
europee del Mediterraneo furono in grado di bonificare i delta dei fiumi o le aree paludose che si
trovavano a meridione delle Alpi e dei Pirenei, i valenzani (con la paella) e i lombardi (con i risotti)
fecero del riso una delle basi della loro floridezza economico-culinaria. Lo stesso si può dire per il
188
cotone (che realisticamente fece la ricchezza di Damasco e di Mossul, ma che mai evolse da una
dimensione artigianale), così come la canna da zucchero (di cui il mondo arabo detenne per secoli il
monopolio); il suo prodotto derivato - i cristalli di zucchero- non uscirono mai dalla nicchia di
consumo in cui furono relegati in quanto “spezie”. Queste due specie vegetali –per ragioni
climatiche- entrarono nell‟agricoltura europea solo limitatamente in Sicilia e in Andalusia (e questo
comportò che i mercati europei furono dipendenti per molto tempo di questi prodotti), ma -quando
a distanza di alcuni secoli- furono trapiantati nelle nuove terre americane conquistate “manu
militari”, esse divennero la principale base produttiva su cui le nuove potenze europee impostarono
il loro modello capitalistico d‟agricoltura.
C‟è stata – io credo- una oggettiva difficoltà per chi proveniva dalle immense steppe siberiane o dai
deserti dell‟Arabia nel misurarsi con i bisogni e le difficoltà indotte da alcuni specifici ambiti
geografici e dalle popolazioni che li abitavano. Questo problema si è evidenziato in modo
particolare nelle regioni limitrofe i grandi fiumi del mondo antico (Nilo, Tigri, Eufrate, Oronte,
Giordano, Indo). Le condizioni agricole in cui anche oggi versa l‟antica Mesopotamia - la regione
che più di ogni altra ha subito le incursioni o le occupazioni di popoli d‟origine nomade – può
essere un esempio indicativo di questa riflessione. Così come credo ci sia stata (e c‟è) una oggettiva
difficoltà per i popoli legati alla cultura pastorale nello sviluppare un attenzione al bosco o alla
boscaglia, concepiti come spazi incolti capaci di contrastare gli eventuali processi di
desertificazione (faccio riferimento ad alcune zone del Magreb o del Sahel). Sale a questo punto
legittima una domanda: potevano dei popoli che avevano le loro radici culturali, sociali e
produttive, nelle steppe o nei deserti decidere consciamente di contrastare la steppa o il deserto?
Potevano quei popolo svestirsi facilmente dei loro abiti nomadi, lasciare le tende e le redini per
adattarsi a portare chiavi e impugnare zappe e pale? O potevano essere in grado di organizzare e
favorire il lavoro degli altri? E se si, attraverso quale complesso percorso introspettivo e con quali
conseguenze?
Anche il tabù di consumare alcolici può esser utile per continuare questo strano discorso. Senza
mettere in dubbio il valore e la saggezza intrinseca di molti tabù alimentari, occorre però dire che il
danno agronomico subito da alcuni territori a causa di questa proibizione è stato ed è evidente
(specie se consideriamo che alcuni paesi corrispondono ai territori d‟origine della vite). Certo l‟aver
deciso di vietare il consumo di vino non ha proibito la coltivazione della vite per fare uva da tavola
o zibibbo, ma è del tutto evidente che quella proibizione ha pesato negativamente - e non pocosulla produzione agricola di vari paesi, tanto quanto è evidente che quella proibizione abbia favorito
altri paesi.
Come vedete il discorso è molto delicato ed estremamente complesso, e se non tutto può essere letto
con gli occhi di un agronomo (penso per esempio ai costi sociali che devono sostenere i paesi che
“facilitano” il consumo di alcol), è comunque importante segnalare quello che potrebbe essere un
problema ancora aperto. Forse però, nella pure accesa sua conflittualità religiosa e culturale, il
mondo nato dalle occupazioni dei popoli nomadi –pur contrapponendosi tra un est e un ovest, un
nord e un sud - aveva trovato una forma di equilibrio economico e commerciale e anche culturale, o
per dire in modo ancora più corretto: aveva trovato una sua complementarità dove le varie parti
scambiavano le loro specificità. Non è allora un caso se nell‟occidente mediterraneo fino a tutto il
189
1200 d.C. il contributo dato dal vasto mondo mussulmano fu straordinario (in un complesso
rapporto di do ut des), come pure straordinario fu il contributo dato dalla dinastia cino-mongola ai
paesi dell‟Estremo oriente. Per non parlare del ruolo di ponte assunto dall‟Impero ottomano nel
momento del suo massimo splendore (si può concepire la storia del mondo senza le terrazze del
Topkapi che si affacciano sul Bosforo: con l‟Europa alle spalle e l‟Asia di fronte, e con il Mar Nero
a sinistra e il Mediterraneo alla destra?).
Ma nella storia umana gli equilibri sono sempre labili, sempre soggetti a inaspettate mutazioni.
Infatti su quelle civiltà nate intorno al Mediterraneo e -prima ancora- intorno ai grandi fiumi
dell‟antichità, da diversi secoli stava soffiando un vento nuovo; un vento che proveniva
dall‟estreme appendici occidentali e settentrionali della vasta piattaforma euroasiatica; uno spirare
prima flebile e poi pian piano sempre più potente. Un vento che sarà capace di fare di
quell‟aggregato di penisole e di isole fino allora toccate marginalmente dalla storia un insieme di
realtà culturali e produttive autonome, e di ritagliare lo spazio per un continente nuovo: l‟Europa!
(l‟unico continente che è un parte di un più vasto spazio continentale)
I tempi di Abele e delle sue mandrie – quelli in cui la storia fu dettata dagli spostamenti dei popoli
pastori – stavano finendo per sempre. Con la nascita –travagliata e complessa dell‟Europa – tutti
stavamo entrando nei tempi dominati da Caino.
190
La genesi della civiltà del burro
C‟è un aspetto del precedente capitolo che ci rivela un particolare interessante; un‟incongruenza che
tutti i lettori credo abbiano colto: a differenza di tutte le altre migrazioni nomadi, quella che portò tra il 374-376 d.C. - gli Unni dalla lontana Siberia alle frontiere dell‟Impero romano, non si risolse
con una loro vittoria, ma con un loro quasi totale annientamento. Tutto questo dopo aver ottenuto da
Ezio il possesso della provincia romana della Pannonia (in virtù dell‟aiuto prestato all‟esercito
imperiale nel contenere quegli stessi popoli che avevano contribuito a cacciare), e dopo che Attila avendo deciso di invadere la Gallia-, andò incontro alla pesante sconfitta dei Campi Catalaunici
(451 d.C.) ad opera di una coalizione formata dall‟esercito romano e da quegli stessi popoli che
aveva cacciato e precedentemente sconfitto.
Immagine presa da Wikipedia alla voce: Germani, che mostra le popolazioni germaniche ai tempi di Claudio. Autore DaniDF1995
Ecco allora l‟importanza di mettere a fuoco meglio (per quanto possibile: vista la complessità del
periodo storico) quel lasso di tempo relativamente breve che portò quest‟appendice occidente del
grande corpo continente - ad un totale rimescolio di popoli e di culture, in una serie continua di
191
incontri e di scontri, tutti volti al tentativo d‟occupare o di gestire nuove terre-. Un susseguirsi
vertiginoso d‟eventi che infine condusse al collasso dell‟impalcatura imperiale, e alla deposizione
formale - nel 476 d.C. - del giovane Romolo Augustolo (l‟ultimo romano eletto imperatore), ad
opera di Odoacre - generale che col titolo di Rex regnò sull‟Italia e sulla Dalmazia per mandato di
Giulio Nepote, imperatore d‟oriente-. Un altro protagonista effimero di questo periodo di continui
sovvertimenti, che tredici anni dopo fu sconfitto (e ucciso in un banchetto) da Teodorico, re degli
Ostrogoti.
Come facilmente comprensibile la differenza con la caduta degli imperi trattati nel precedente
capitolo è sostanziale, e –forse- sarebbe opportuno vedere l‟arrivo degli Unni come il detonatore di
una situazione già complessa e che con tutta evidenza era in atto da molto tempo. Ecco allora che –
nel panorama storico della caduta dell‟Impero romano d‟occidente- c‟è bisogno di assegnare i ruoli
di protagonisti a nuovi attori; attori che non avevano nulla a che fare con le dinamiche del
nomadismo, perché da secoli vivevano coltivando terre alle sue frontiere o addirittura compenetrati
con esso; attori che avevano già da tempo impegnato l‟esercito romano in una serie di scontri,
mentre –contemporaneamente - lo rifornivano di uomini, di quadri ufficiali e di salmerie.
Ed ecco sorgere spontanea la domanda: chi erano questi popoli che vediamo inseriti nelle funzioni
più delicate della macchina imperiale, uomini che con un moto di distacco i greci chiamavano
βάρβαρος e i romani barbarus (una parola onomatopeica che letteralmente vuole dire:
“balbuzienti”)? Chi erano queste genti che agli occhi dei romani apparivano come degli incivili –per
il loro abitare in contrade prive di città-, che possedevano un loro pantheon di divinità prettamente
maschili, e che parlavano una lingua tanto gutturale da sembrare tartaglianti? E, ancora di più, chi
erano questi uomini alti e possenti; apparentemente timidi se presi individualmente e forti quando si
muovevano in gruppi, affascinati dall‟idea della sacralità e universalità del potere romano ma attenti
a schivarne le insidie connaturate nella riverenza; uomini contro i quali gli eserciti romani avevano
già combattuto infinite battaglie e verso i quali avevano adottato differenti e complesse politiche per
ottenerne a volte il contenimento, a volte l‟assimilamento, o –se necessario- l‟auspicata
obnubilazione?
I Germani erano un insieme di popoli affini, nati dalla fusione – avvenuta nella prima metà del III
millennio a.C. nelle regioni della Scandinavia meridionale, dello Jutland e della Germania
settentrionale - tra gli originari popoli pre-indoeuropei (di probabile origine paleolitica), con dei
gruppi provenienti dall‟Europa Centrale, indoeuropeizzati nel corso del IV millennio a.C., e
portatori di nuovi modelli agricoli e di una matrice linguistica comune. Al momento del loro
insediamento -in quella che sarebbe divenuta la loro patria- questi gruppi trovarono una sviluppata
una civiltà autrice dei megaliti propri dell'Età della Pietra nordica. Non si conoscono i caratteri
etnici propri di questi antichi abitanti, ma è possibile che fossero affini a quelli delle (relativamente)
vicine genti finniche. La fusione, più o meno pacifica, di questi elementi pre-indoeuropei con i
gruppi indoeuropei provenienti da sud determinò la cristallizzazione dei Germani, questi
avvenimenti furono accompagnati dall‟abbandono delle antiche lingue a favore di quella
indoeuropea dei nuovi venuti.
192
Dal V al I secolo a.C., durante l'Età del ferro, fu costante la pressione che i Germani fecero verso il
sud e il sud-ovest, venendo a contatto (e spesso in conflitto) con i Celti e, in seguito, con i Romani.
Sebbene portatori di una civiltà più articolata, i Celti subirono l'insediamento di avamposti
germanici nel loro territorio, un fenomeno che diede origine a processi di sovrapposizione tra i due
popoli, da cui -nel lungo periodo- i Germani uscirono vincitori. L'ininterrotta frontiera dell'Impero
romano, estesa dal Mare del Nord al Mar Nero, fu invece il limes militare, politico e culturale, che
per secoli funzionò da argine alla loro costante spinta espansionista. Numerosi furono i conflitti che
si accesero nel corso dei secoli tra i Romani e i Germani, che tentarono a più riprese di penetrare nel
più ricco e organizzato territorio soggetto all'Urbe. Soltanto quando l'Impero romano cominciò a
sentire i segni della crisi ai Germani riuscì la penetrazione al di là di quel limes, anche a causa
dell‟arrivo dalle steppe di cavalieri nomadi che, superiori militarmente, cominciarono a razziare le
loro terre per istallarsi sui loro pascoli. Per tradizione storiografica le tribù germaniche vengono
suddivise in tre grandi sottoinsiemi, caratterizzati geograficamente come: occidentali, orientali e
settentrionali; ma occorre considerare che frequenti furono i mescolamenti e le ibridazioni di tribù
in formazioni nuove, che arrivavano perfino a includere elementi non germanici (e, talora, perfino
non indoeuropei).
Elaborato da Wikipedia alla voce: Germani
I Germani erano quindi un insieme composito di popoli (alcuni studiosi si sono riferiti a loro
indicandoli come: massa germanica) che da diversi secoli avevano trovato casa nelle vaste pianure e
nelle folte foreste situate a nord e a est dei confini dell‟impero e che i romani conoscevano fin dai
tempi della Repubblica, da quando i Cimbri –scesi dallo Jutland assieme ai Teutoni ed agli Ambroni
– li avevano impegnati in una sanguinosa campagna militare durata più di dieci anni- che li vide al
fine sconfitti nel 101 a.C. vicino a Vercelli, dopo aver lasciato sul campo più di 140.000 morti e
nelle mani dei mercanti romani più di 60.000 schiavi.
Erano popoli di coltivatori e allevatori particolarmente valenti (e da ciò discende l‟espansione
territoriale correlata al loro progressivo aumento demografico), capaci di esercitare una pressione
agronomica e antropica crescente sui loro territori; una capacità che li spingeva alla ricerca di nuove
terre, specie di quelle che li ricompensassero con raccolti più abbondanti delle fatiche agricole e di
quelle necessarie per ottenere ulteriori campi da mettere a coltura; popoli che –come visto- avevano
già vissuto quello che gli studiosi tedeschi chiamano “völkerwanderung” (che vuol dire:
“migrazioni di popoli"), spostandosi dalla loro patria d‟origine verso le pianure dell‟Oder e dell‟alto
Danubio e che ora tentavano di ripetere, cercando dentro le frontiere dell‟Impero, quegli spazi fertili
e miti che finora l‟occupazione romana (sarebbe meglio dire “italica”) aveva loro precluso.
Affrontando lo sforzo titanico nel cercare di sovvertire un ordine politico-culturale che regnava da
secoli e uno agronomico che era in uso da millenni (tra poco si capirà il perché di questa
affermazione), che forse non sarebbe mai riuscito senza il jolly occasionale rappresentato
dall‟arrivo degli Unni, che portò alla caduta formale dell‟Impero romano d‟occidente (che come
disse lo storico Arnaldo Momigliano: “fu una caduta con ben poco rumore”), ma non
all‟occupazione di Roma (che infatti in quel secolo fu saccheggiata due volte ma non occupata);
193
quindi alla fine del mondo classico, sostituito da un insieme di regni che –non per casualità- gli
studiosi sono soliti chiamare: romano-barbarici.
Secoli che –secondo la vulgata comune- sono descritti come “ bui, oscuri”, solo perché portatori di
una crasi apparente con l‟epoca precedente; dove gli aggettivi “bui o oscuri” vengono sempre
ammantati (e quindi percepiti) negativamente, senza mai riflettere che non c‟è gestazione possibile
senza l‟oscurità, perché –nella ferrea logica delle cose e/o della vita animale e vegetalel‟embriogenesi non vuole luce!
Immagine presa da Wikipedia alla voce: Caduta dell‟Impero romano d‟Occidente che mostra i Regni romano barbarici. Autore killingzoe
Per consuetudine – sommaria e elementare- si è soliti fare una suddivisione tra i popoli germanici,
quelli orientali (che da alcuni secoli si erano stanziati nelle pianure tra l‟Oder e la Vistola)
mettendosi in movimento –sotto la spinta degli Unni- si diressero verso le frontiere dell‟impero.
Prima si scontrarono con le difese organizzate da Costantinopoli, respinti, migrarono verso quelle
occidentali, dove –vinte le resistenze- penetrarono più o meno profondamente nelle provincie dando
vita diversi ai regni: i Visigoti in parte della Spagna e nel sud della Francia, i Burgundi nell‟alta
Provenza, gli Ostrogoti e –più tardi- i Longobardi in Italia.
Questi popoli presero dai romani l‟alfabeto e la lingua (anche se influenzarono –e non poco- vari
dialetti locali), e lasciarono la loro presenza nella genetica delle popolazioni e nella toponomastica
attualmente ancora in uso ( ho una madre che si chiama Ermelinda e ho una nonna che è nata a
Vidigulfo, e in Lombardia sono pochi i nomi e i luoghi che possono vantare un‟origine più
194
longobarda di così). Una volta arrivati in occidente, questi popoli -precedentemente ariani-, si
sottomisero all‟autorità religiosa del papa di Roma, di cui –nel tempo- divennero potenti e strenui
difensori. Tutto questo mentre i Vandali e Alani (gli unici iranici tra tutti questi), in un susseguirsi
di vicende complicatissime- passarono lo stretto di Gibilterra e andarono ad occupare i territori
limitrofi a Cartagine (da qui saccheggiarono Roma nel 455 d. C.), creando uno Stato che visse per
un periodo relativamente breve una strana forma d‟autonomia.
Tra i Germani occidentali (adottando la divisione suggerita da Tacito), gli Ingaevones -cioè gli
Angli, gli Juti e i Sassoni- migrarono verso la Gran Bretagna e la germanizzarono, costringendo i
Celti nei confini del Galles, del nord della Scozia e in Irlanda; mentre i Frisoni si insediarono nelle
terre basse della foce del Reno a cui diedero il nome. Intanto gli Istaevones -composti dai Batavi,
dagli Ubi, dai Treveri, dai Catti e dai Franchi- riunitisi in confederazione, fondarono un regno nel
nord della Gallia. La stessa cosa che fecero – tra gli Herminones - i Marcomanni, i Quadi e i
Semnoni, che -confederatisi negli Alemanni- diedero il loro nome alle terre che colonizzarono; a
differenza della confederazione degli Suebi, che in parte migrarono verso la Galizia e il nord del
Portogallo e in parte risalirono verso il nord, dando -ovviamente- il loro nome alla Svezia.
La storia dei Germani occidentali è diversa da quelli orientali: solo una parte di essi penetrarono le
frontiere dell‟impero, e solo una parte latinizzarono le loro lingue (anche se dal vecchio impero
presero in prestito l‟alfabeto, molte parole e parte della struttura linguistica): si fecero poi cristiani
con meno convinzione, ed alcuni con una ritardo di alcuni secoli, mentre continuavano a praticare
una parte dei loro culti ancestrali (penso ad esempio al culto degli alberi o dei solstizi). Erano
anch‟essi popoli di agricoltori e di grandi allevatori e con le loro conoscenze agricole –come
vedremo tra poco- dettero un impulso essenziale nello sviluppo dei successivi modelli produttivi
agricoli.
L‟insieme di questi accadimenti - fatte le debite tare- ci consente di assistere alla
destrutturalizzazione dell‟antico mondo romano e di seguire la sua successiva trasformazione in
territori e/o istituzioni autonome. Proprio a partire da questo periodo cominciamo a possedere dei
documenti, pervenutici in originale, che sono in grado di darci un quadro diretto della situazione:
come la donazione fatta da Odoacre il 18 marzo 488 trascritta su alcuni fogli di carta di papiro
conservati a Napoli e Vienna; o la lettera di San Gregorio Magno dove il papa scrive: “Su, in alto
nel cielo si vedevano segni spaventosi: lance di fuoco, schiere di uomini in armi, rosseggianti, verso
il nord. Ed ecco che il popolo crudele dei Longobardi, come una spada sguainata, calò sulle nostre
teste arrivando dalla sua terra. La gente, che si era fatta numerosa, cresciuta come un campo di
grano, fu come falciata. Borghi distrutti, chiese date alle fiamme, monasteri saccheggiati, città
private dei loro abitanti, campagne spopolate, villaggi strasformati in ricettacoli di bestie selvagge:
ecco l‟opera dei Longobardi. Non riesco a immaginare che cosa possa succedere altrove nel mondo.
Dove noi siamo il mondo non ci preannuncia la sua fine, ce la mette davanti agli occhi “. C‟era
evidentemente un mondo, quello di Gregorio (terzo papa degli Anici, importante famiglia
senatoriale di Roma e di Costantinopoli) che -in via di dissolvimento- angosciava il grande papa,
che di certo non poteva essere accusato di pavidità personale. Nei secoli che seguiranno questa
völkerwanderung la vedremo riprodotta su altri territori dell‟Eurasia. Infatti su un‟ampia parte dei
territori abitati dai germani, svuotati dalle loro migrazioni, si insediarono gli Slavi e i Balti. Anche
195
questi erano popoli di agricoltori, e possedevano un modello agricolo parzialmente simile a quello
dei Germani.
La culla preistorica dei popoli baltici, secondo le ricerche paleogenetiche e gli studi archeologici, fu
la zona tra il mar Baltico e l'Europa centrale tra la fine dell'ultima era glaciale e l'inizio del
mesolitico, mentre la culla dei popoli slavi fu, molto probabilmente, la regione tra Cracovia ed il
Danubio. Gli slavi si espansero nella pianura ucraina del Dnepr nel VI secolo d.C. , dopo l'invasione
degli Avari. Secondo alcune vecchie teorie, l'area di formazione originale si trovava, fino alla fine
del secondo millennio a.C. vicino all'alto e medio corso del Dnepr, nell'odierna Ucraina, dove si
riteneva che si fosse stabilita un'ipotetica proto-comunità balto-slava, cioè un popolo comune che in
seguito si era scisso e aveva dato origine agli odierni balti e slavi. All'inizio del primo millennio
a.C., vari gruppi migrarono sulle coste del mar Baltico, ma non è chiaro se sia stata questa
migrazione a dare origine alle tribù baltiche. I popoli slavi (in greco: Σκλαβηνοι, in latino: Sclaveni,
in antico slavo ecclesiastico: Slověne) sono un ramo etno-linguistico dei popoli indoeuropei che
vivono principalmente in Europa, dove costituiscono circa un terzo della popolazione. A partire
dalla loro terra natia (principalmente l'Europa orientale) nel VI secolo, si sono spostati anche verso
l'Europa centrale e verso i Balcani (nei secoli recenti – collegati all‟imperialismo russo e alla nascita
ed evoluzione dell‟Unione Sovietica - molti si sono stabiliti nell'Asia settentrionale o sono emigrati
in altre parti del mondo). I popoli slavi sono tradizionalmente divisi lungo linee linguistiche in slavi
occidentali (che comprendono i cechi, gli slovacchi, i polacchi, i casciubi ed i sorbi), slavi orientali
(che comprendono i bielorussi, i russi e gli ucraini) e slavi meridionali (tra cui i serbi, i bulgari, i
croati, i macedoni, i montenegrini, i bosniaci e gli sloveni).
Elaborato da Wikipedia alle veci: Baltici e Slavi
Grossolanamente possiamo dire che gli Slavi occidentali e i Balti tennero i loro rapporti culturali
con Roma, nessuno di loro ne prese la lingua, ma acquisirono l‟alfabeto latino, assorbendone la
religione (lo fecero anche gli Sloveni e i Croati, che erano limitrofi all‟Italia), diventando nei secoli
successivi dei veri e propri “pilastri” del cattolicesimo romano; mentre gli altri popoli Slavi
acquisirono l‟alfabeto glagolitico codificato dai santi Cirillo e Metodio e successivamente il
cristianesimo ortodosso, questo grazie all‟opera di evangelizzazione pianificata da Costantinopoli
(e una parte di loro ne divenne uno strenuo difensore).
Certo sono pochi i documenti che ci sono pervenuti, e ancora meno i documenti utili ad illustrare la
realtà agronomica di quel vasto agglomerato di isole e penisole su cui si andrà sviluppando la futura
identità europea; anche se -proprio quella successiva evoluzione – ci permette di descriverne alcune
linee evolutive: proviamoci!
E‟ sicuramente corretto affermare che da tempo Roma mancava dei mezzi materiali, economici e
militari (oltre al costante adeguamento demografico) che le erano necessari per mantenere
funzionale ed efficiente (e potremmo dire: latina) la sua lunga frontiera orientale. Gli economisti
dicono che l‟impero viveva una profonda fase deflazionistica, da cui –ad atollo- emergevano alcune
aree particolari (quelle che corrispondevano ai centri di decentramento militare e amministrativo
dell‟apparato imperiale). Tutto questo mentre alle frontiere fremeva un vasto assembramento di
196
popoli che dal rapporto osmotico con il grande Stato aveva tratto significativi vantaggi: sia perché
le stesse frontiere rappresentavano dei presidi economici (erano servite da una rete funzionale
d‟infrastrutture), sia per il continuo scambio di uomini, d‟idee, che di modelli produttivi.
Non dimentichiamoci che l‟occupazione della Britannia, della Germania inferiore (quella più a
nord, secondo la mappa mentale romana) o dei confini più orientali della Pannonia e della Dacia
erano legate più ad un‟idea difensiva o a quella dello sfruttamento delle materie prime, che non ad
una specifica volontà di pianificazione produttiva di quei territori. Questo poteva dire che i
rifornimenti delle legioni dipendevano –in parte- anche dai commerci che passavano attraverso le
frontiere.
Ma, per una volta, lasciamo stare il punto di vista tradizionale – quello che si concentra sul
decadimento dell‟economia romana- ed proviamo invece a mettere a fuoco la realtà economica
(che ovviamente coincide in gran parte con quella agronomica) dei popoli germanici di cui abbiamo
appena parlato, perché d‟ora in avanti saranno loro i veri protagonisti di quel mondo contemporaneo
che comincia ora a muovere i suoi primi passi decisi.
A detta della voce pubblicata su Wikipedia (nell‟estratto rielaborato poco sopra) i popoli preindoeuropei che vivevano nelle regioni settentrionali dell‟Europa – dove per sovrapposizione si
“cristallizzeranno” i popoli germanici (ho usato la stessa terminologia di Wikipedia) -, avevano già
acquisito alcune rudimentali conoscenze delle tecniche di coltivazione della terra e di quelle
necessarie ad allevare degli animali. Io credo che si possa dubitare del fatto che questi popoli (di
probabile origine paleolitica e affini ai finnici) fossero già degli agricoltori; poiché questo
presupporrebbe che ci fossero state delle antecedenti migrazioni di popoli agricoli (acquisizione per
sostituzione), oppure che quei popoli fossero stati capaci di far nascere dei loro modelli agricoli
autonomi (cosa decisamente difficile, viste anche le negative condizioni ambientali); ma certamente
non si può dubitare del fatto che questi fossero popoli di grandi allevatori. Non dimentichiamoci che
i popoli paleo-finnici allevavano renne dal terzo millennio a. C. e che –secondo alcune ipotesi (che
in un capitolo precedente dove si parlava di renne non ho riportato)- queste tecniche di allevamento
furono messe a punto ancora prima dell‟ultima glaciazione (la stesa cosa che alcuni studiosi
pensano sia avvenuto per il cane). Rimanendo nel campo dell‟ipotesi l‟idea è molto suggestiva
(oltre che controversa), perché presupporrebbe che i meccanismi simbiotici che condussero alla
domesticazione di queste due specie fossero iniziati molto prima dei fatti accaduti nella Mezzaluna
Fertile (d‟altronde se accettiamo le ipotesi di domesticazioni locali, dovremmo anche accettare
l‟idea che alcune di esse possano essere iniziate anticipatamente). Questo vorrebbe dire che i cani, e
le renne, ci sono fedeli compagni nella caccia, e primi alleati nella pastorizia, da oltre 30-35.000
anni (ho visto pubblicata –ma non ricordo dove- una bellissima testa di renna, scolpita nell‟osso e
datata al tardo Paleolitico, provvista di una vistosa cavezza che le passava dietro le orecchie). Ma
anche prescindendo da questa teoria è comunque certo che da alcuni millenni i popoli delle renne
avevano penetrato i misteri e le sottigliezze dei meccanismi della domesticazione e dell‟arte della
produzione lattiero-casearia. Non dimentichiamo che la renna è un ruminante capace di digerire dei
pascoli poverissimi, e anche licheni e cortecce, e che il suo latte -con oltre il 30% di sostanza secca197
è un vero concentrato calorico e proteico. Un latte che –come tutti quelli dei ruminanti- può essere
manipolato grazie ai fermenti lattici per produrre formaggi e yogurt.
Sappiamo poi dagli studi di genetica delle popolazione che quelle aree centro-nord europee furono
interessate, orientativamente nel IV millennio a.C. , dall‟espansione dei nuovi modelli produttivi
agricoli elaborati nella Mezzaluna fertile e veicolati dai flussi di genti indoeuropee, probabilmente
provenienti dal bacino anatolico dell‟arco della Mezzaluna fertile, proprio da lì dove si erano gettate
le basi di una forma di biocenosi continentale -simile nelle alleanze di specie, ma diversa nella
tipologia di quelle stesse alleanze- dalla biocenosi mediterranea. Come visto in un precedente
capitolo questi popoli furono tra i primi ad acquisire quella particolare forma d‟agricoltura, e che
nel loro cammino radiale –adattandosi- furono in grado di far avanzare –adattandola- la
coltivazione dell‟orzo, del grano tenero, della spelta, delle brassiche (avete presenti i crauti o i
cavoletti di Bruxelles?) e di altri vegetali estivi a ciclo corto, ma ancora di più questi erano popoli
allevatori di animali domestici, e in modo particolare di bovini (ricordate i bucrani di Çatal Hüyük
?).
L‟incontro, la sovrapposizione e/o la sostituzione di questo nucleo centro europeo (che aveva
subito l‟arrivo o acquisito le conoscenze agronomiche degli indoeuropei di provenienza anatolica)
con quelli affini alle popolazioni paleo-finniche, e la loro successiva fusione, deve aver portato tutta
una serie di vantaggi reciproci: l‟adeguamento delle prime tecniche agricole a dei territori – che per
asprezza invernale sono relativamente assimilabili a quelli anatolici-, e l‟acquisizione –traslata ai
bovini- delle metodologie tecniche e delle finalità produttive che erano in uso nell‟allevamento
delle renne.
Ecco perché nelle terre dei grandi e temibili Uri (i bovini selvatici tipici delle foreste del nord
Europa) non incontriamo i bovini bianchi dalle grandi corna che rappresentano le razze da carne più
possenti del mondo e che popolano – ancora abbondanti- le campagne dell‟Italia peninsulare e dei
Balcani (ricordate che ho detto che la migrazione che portò l‟agricoltura nel bacino del
Mediterraneo è essenzialmente agricola e che nell‟ambito dell‟allevamento zootecnico gli animali
principali sono le pecore e le capre da latte e i bovini da carne?). Incontriamo invece – in maniera
non unica ma preponderante- quei bovini dalle corna corte che nel tempo acquisirono dei tratti
dolicomorfi (vuol dire “di forme allungate”, riferito specialmente al cranio), e che di conseguenza si
andarono specializzando nella produzione del latte: le vacche pezzate bianche e nere o bianche e
rosse (tipiche del nord d‟Europa o probabilmente portate dai Germani occidentali), o le razze a
mantello uniforme generalmente bruno che si incontrano nei territori alpini e appenninici
(probabilmente introdotte dai Germani orientali, a cui si dovrebbero aggiungere le bufale da latte ,
che –secondo lo storico Paolo Diacono- furono portate nell‟Italia peninsulare dai Longobardi del
ducato di Benevento). Certo immaginate lo choc culturale di quelle genti nordiche, che da millenni
gestivano le ombrose renne e affrontavano gli irritabili e aggressivi Uri in pericolose battute di
caccia, quando vennero a contatto con un popolo che si faceva trainare i propri carri da bovini già
domesticati e aggiogati, ma pensate anche al raffinato percorso coevolutivo che ha permesso la
traslazione delle tecniche di gestione -oltre che le finalità selettive- dalle renne a quei bovini, e che
198
ha favorito l‟esaltazione di quei caratteri morfologici, che in zootecnia si estrinsecano in caratteri
lattiferi, di cui, evidentemente, alcuni bovini erano portatori “in fieri”.
Siamo arrivati ad un punto dirimente: se le civiltà cinesi e indocinesi sono basate sulla coltivazione
del riso (e delle specie associate) e quelle delle coste mediterranee sono caratterizzate dalla triade
del grano duro, dell‟olio e del vino (a cui va aggiunto l‟allevamento degli ovo-caprini), l‟agricoltura
degli antichi popoli germanici e specialmente di quelli occidentali (e quindi quella che da loro
deriva), era (ed è) basata sulla coltivazione dei cereali da pane (alcune volte neri) e/o da birra, dei
vegetali orticoli a ciclo corto, e/o sull‟allevamento dei maiali e delle vacche da latte. Un modello
simile a quello introdotto dai Germani orientali nei paesi del sud dell‟Europa, che però rimase tal
quale solo nelle regioni alpine, subalpine e nei Pirenei, o lungo la dorsale appenninica; trovando qui
modo di compenetrarsi con i modelli agronomici mediterranei (le terre basse lombarde –dove i
Longobardi fondarono il loro regno- sono una delle zone lattifere più specializzate del mondo e
anche l‟unica zona d‟Italia dove non si coltiva la vite). Quindi, anche nelle penisole che si
affacciano nel Mediterraneo, i popoli delle regioni montane o premontane diventeranno nei secoli a
venire dei veri protagonisti; quando il vecchio modello agrario basato sulla triade mediterranea
iniziò a sentire la concorrenza di un‟agricoltura nuova, una agricoltura di gender: quella basata sul
latte delle vacche (una delle poche simbiosi che lega gli uomini al latte delle puerpere).
A questo svilupparsi di un modello agricolo nuovo, corrisponde l‟affermarsi di un tempo nuovo:
quel Medioevo, che comincerà –con lenta ma costante progressione- a trasferire il cuore pulsante
dell‟economia verso regioni lontane dal Mediterraneo. Perché il Medioevo è nordico, fatto di
focolari accesi e di castagne sulla brace, perché questo è il tempo di terra e non è più mare
L‟architrave di questi tempi nuovi è l‟alleanza tra gli uomini e le vacche da latte: per loro si
cominceranno a costruire quelle case in muratura (le stalle), che andranno a sostituire i normali
recinti o i semplici stazzi; per loro –che erano in grado di valorizzare anche i fianchi montani non
coltivabili- si arriverà a seminare dei prati (i prati –non i pascoli naturali- sono l‟esempio più
calzante di una lavoro fatto dagli uomini a servizio di una specie differente da noi). E quando,
grazie agli arabi, arriveranno dall‟Egitto e dalle pianure irrigue del Medioriente anche le leguminose
pratensi (come l'erba medica, detta anche alfa-alfa, dall'arabo “al-fal-fa”: il padre di tutti i cibi), si
inventeranno le falci fienaie e le marcite.
E‟ poi inutile dire che il contributo di una vacca da latte non si restringe solo alla produzione del
latte e dei suoi derivati: c‟è la carne; ci sono le unghie e le corna da trasformare in oggetti, c‟è la
pelle per farne cuoio, ed infine il sego per fare margarine, candele e saponi. E se ad illuminare le
notti mediterranee c‟erano le lampade ad olio e le candele di cera d‟api, quante arnie ci sarebbero
volute per illuminare le lunghe notti invernali dei popoli germanici senza ricorrere all‟uso del sego
bovino?
Ma cosa hanno di così particolare i bovini per poter svolgere un ruolo così importante? Cosa li
contraddistingue dagli altri erbivori? Proprio come i bisonti e i caribù nell‟America del nord, gli uro
e le renne in Europa, o gli yak nel Tibet (o le pecore e le capre che con varie specializzazioni sono
ora in tutto il mondo), i bovini sono forniti di un apparato digerente del tutto particolare.
199
Il sistema digerente dei ruminanti è composto da tre prestomaci (reticolo, rumine e omaso) e dallo
stomaco ghiandolare vero e proprio (abomaso). Il rumine dei bovini è il prestomaco più
voluminoso, con una capacità che supera i 200 litri, e in esso avviene la fermentazione degli
alimenti ingeriti, grazie all‟azione attuata da un insieme di microrganismi che costituiscono la
microflora (batteri), microfauna (protozoi) e le muffe del rumine. I prestomaci dei ruminanti sono
capaci di assicurare il buon funzionamento della microflora e della microfauna attraverso: il
mantenimento di un pH costante, il mantenimento di un'adeguata umidità, il rimescolamento
periodico del contenuto, l‟allontanamento dei gas grazie all‟eruttazione, e lo sminuzzamento del
foraggio più grossolano. Quest'ultima attività è assicurata dalla ruminazione, che corrisponde al
rigurgito fisiologico del bolo alimentare nella cavità orale, alla lenta e costante masticazione e al
successivo ringoio. Il materiale sminuzzato dalla ruminazione, idratato dalla saliva, fermentato e
arricchito dalla presenza e dall'attività dei microrganismi, passa poi dal rumine e dal reticolo (che
formano assieme un complesso funzionale) nell'omaso, dove viene parzialmente drenato dall'acqua,
ed infine nell'abomaso, uno stomaco assimilabile a quello degli animali monogastrici (tra cui noi),
dove iniziano le attività di digestione, operate dai succhi gastrici in ambiente acido. I microrganismi
del rumine, oltre a mantenere le condizioni anaerobiche nel rumine ( che consentono la vita alle
colonie stesse), sono in grado di rompere i legami cellulari che i comuni succhi gastrici non sono in
grado di scindere (per esempio quelli delle cellulose e delle emicellulose). I batteri del rumine
vivono in forma simbiotica con i ruminanti e coabitano e cooperano tra di loro ( è come dire che le
simbiosi non finiscono mai). I protozoi sono presenti in numero minore dei batteri, e non hanno
attività cellulosolitica ma si comportano come "micro-ruminanti" in quanto sono capaci di ingerire
particelle microscopiche di cibo, prima di venire a loro volta digeriti. Le muffe possiedono attività
cellulosolitica e sono in grado di lisare le proteine. Riescono inoltre a germogliare sulle superfici dei
vegetali, frantumandole e mettendo a disposizione degli altri microrganismi la cellulosa e altre
sostanze.
Elaborato da Wikipedia alla voce: Rumine
Per raccontare tutto questo in maniera più semplice si potrebbe dire che la Natura ha dotato i
ruminanti di uno speciale laboratorio biologico (il rumine) montato su zampe. Un laboratorio
straordinariamente efficiente, dato che consente loro di trasformare un prodotto grezzo -quale è
l‟erba- in una serie di prodotti derivati di alto valore biologico. Certo questo lo fanno tutti gli
erbivori, così come tutte le puerpere producono il latte, ma nessuna femmina non ruminante è in
grado di trasformare le erbe normali in così tanto latte. Nelle altre specie la produzione di latte è
strettamente correlata con il periodo dell‟allattamento e strettamente connessa ai bisogni del
lattante, ma questa caratteristica è totalmente superata nelle femmine dei ruminanti e specialmente
nelle femmine dei bovini, quelle che noi chiamiamo: vacche da latte. Oggi una vacca al pascolo -nei
mesi successivi al parto- riesce a produrre più di venti litri di latte al giorno (il consumo medio del
suo vitello è circa di due litri al giorno), per non parlare di una vacca gestita in un allevamento
intensivo, dove- tramite uno studiato piano alimentare- si arriva ad indurre produzioni (sempre nei
momenti di picco produttivo) che possono superare i cinquanta litri di latte al giorno; il che significa
trasformare in latte più di un decimo del suo peso corporeo, con un quantitativo giornaliero di
calorie e di proteine prodotte davvero impressionante. Questo è possibile perché i ruminanti,
sebbene ingeriscano erba, non digeriscono l‟erba tal quale, ma un pabulum che -dopo essere stato
200
ruminato e insalivato- si è trasformato in un terreno di coltura su cui far crescere e sviluppare le
colonie di flora e fauna microbica. E‟ questa fauna, questa flora e questi funghi (e non l‟erba) che
viene digerita nell‟abomaso. Potenza della biochimica!
Tutto questo ci consente di vedere il rumine non solo come un laboratorio biologico, ma come il
luogo fisico che accoglie una speciale biocenosi; anzi potremmo arrivare a dire che il rumine si
configura come una vera e propria biota (intendendo per biota il complesso di organismi vegetali, e
animali che occupano lo spazio in un ecosistema). Un ecosistema a temperatura stabile (intorno ai
37 gradi) e a tassi d‟umidità elevatissimi; una specie di serra o di ambiente tropicale dove gli
organismi sono al riparo dalle alterazioni esterne (come la luce o gli sbalzi di temperatura) e questo
permette loro dei tassi riproduttivi altissimi. E‟ grazie a questa particolare biocenosi, che i ruminanti
custodiscono nel primo dei loro quattro stomaci, che consente loro di valorizzare al massimo i
vegetali ingeriti. Ed è grazie a questa biocenosi interna che la biocenosi continentale è arrivata ad
avere una capacità di elaborazione di prodotti alimentari di alto valore biologico che sarebbe stata
impensabile in quegli ambienti naturali.
E‟ come se il laboratorio rumine –viste le particolari condizioni di funzionamento – possa rimediare
alla limitatezza dell‟azione fisica della luce del sole! Attenti; il passaggio è delicato: l‟agricoltura di
pieno campo esplica il massimo delle sue potenzialità là dove si relazionano armonicamente la
fertilità del terreno agrario, la facilità d‟accesso all‟acqua e l‟abbondanza di luce solare. Non per
caso le prime civiltà agricole si sono sviluppate nelle valli fluviali dei paesi caldi. Non per caso ho
sostenuto che solo l‟attenta valorizzazione agronomica delle risorse locali (il genius loci concepito
in forma produttiva) e l‟applicazione delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche (per
esempio l‟aratro montato su ruote), ha potuto consentire all‟agricoltura romana di inventare un
nuovo modello capace di spingersi così a settentrione. Fino all‟epoca romana era la luce (e la
temperatura che ad essa è collegata) il fattore limitante delle produzioni agricole: fatta salva la
disponibilità d‟acqua la pianificazione agricola si era espansa fino alle terre dove le stagioni erano
relativamente miti. Il che non vuol dire che non si potesse fare agricoltura anche più a nord o in
territori situati ad altimetrie più elevate, ma che quel modello agricolo non era in grado di produrre i
surplus necessari per il mantenimento di società complesse. Ora –nella stretta relazione simbiotica
che si stava elaborando tra gli uomini e i bovini (sarebbe meglio dire con le femmine dei bovini:
perché questa è la più importante simbiosi di gender)- si aprivano ad un nuovo uso tutta una serie di
terre che prima sarebbero state escluse all‟espansione delle normali biocenosi agricole. Penso a tutte
le regioni montane, ma penso anche a quelle terre basse della Lombardia di cui abbiamo da poco
parlato, o agli estuari dei grandi fiumi del nord Europa (le Fiandre. La Zelanda, la Frisia), dove
l‟eccesso d‟acqua rendeva impossibile (o molto difficile) mettere a coltura i terreni. Quelle che oggi
sono tra le regioni più ricche del mondo si presentavano ben diverse agli occhi dei popoli che per
primi le abitarono, e quella completa trasformazione non sarebbe mai stata possibile se quelle
praterie igrofile non si fossero dimostrate dei luoghi di pascoli o di prati ideali per i bovini, e se quei
bovini non avessero avuto la possibilità di trasformare quelle primitive erbe grossolane in latte
(ovviamente la produzione è correlata alla qualità del pascolo). Per avere un quadro chiaro degli
aspetti economici è opportuno sapere che un ettaro di quel pascolo consente il pieno sostentamento
di un bovino adulto e che il totale delle chilocalorie che da questo ne deriva è uno dei più elevati tra
201
tutti i tanti sistemi agricoli. Questo ha favorito la progressiva riorganizzazione produttiva di quei
territori e la loro massiccia antropizzazione successiva (oggi i quei territori – Paesi Bassi e
Lombardia – sono tra i più antropizzati d‟Europa).
E‟ grazie al perfezionamento progressivo (occorreranno ovviamente dei secoli per riqualificare in
senso produttivo e antropologico quei territori) di questa specifica biocenosi, che i popoli germanici
–o quelli che con loro si sono mischiati- hanno goduto di un modello agronomico che ha permesso
la piena utilizzazione di alcuni territori specifici, una cosa che nel tempo si è poi tradotta in
significativi vantaggi economici e demografici. Alcuni autori la chiamano la “civiltà del burro”, e
la contrappongono a quella dell‟olio; uno specifico modello che si ammanta di tutta una serie di
aspetti favorevoli e di problematiche mai apparse prima di allora: solo i popoli del burro hanno la
possibilità di ingerire un quantitativo così rilevante di proteine e grassi animali (notate che tra i
popoli del burro ci sono anche alcuni che abitano in Africa al livello della fascia sub-sahariana e
dell‟Etiopia), cosa che nel tempo ha influenzato la statura media di quelle popolazioni; solo loro
possono compensare la intrinseca carenza di vitamina D con il consumo di latte e latticini (il sole è
un catalizzatore della vitamina D e trasforma –per esposizione- la provitamina D della pelle in
vitamina D; senza questa specifica azione dei raggi solari occorre trovare il modo di ingerirla -gli
esquimesi lo fanno mangiando il fegato dei merluzzi, proprio quello che io tanto odiavo da bambino
-); solo loro –però- hanno avuto il problema di contrastare geneticamente quella che sarebbe stata
una innaturale tendenza alla colesterolemia e alle malattie cardio-vascolari.
Conosco un curioso monumento, situato in un‟azienda agricola vicino a Seattle, che rappresenta
una vacca che -molto tempo fa- fu una delle lattifere più famosa d‟America e una delle vacche più
produttive del mondo. Sul basamento c‟è riportato il motto “The foster mother of the human race”
che tradotto in italiano suona: La balia della razza umana. Un tributo che letto dai tanti popoli del
mondo che con l‟adolescenza perdono l‟enzima della lattasi può sembrare assurdo, ma che invece
calza perfettamente per coloro che hanno contribuito a far nascere -in condizioni ambientali spesso
marginali- uno dei modelli agricoli più funzionali del mondo.
202
L’orizzonte degli eventi
Siamo soliti considerare i tempi di mezzo (i medi evi) come periodi di passaggio tra qualcosa che è
morto, o sta morendo, e qualcosa che è nato, o sta nascendo; tempi segnati da un diffuso senso
d‟indeterminatezza che ingarbuglia il come e quando farli iniziare e come e quando dirli terminati.
Una indeterminatezza di date che corrisponde ad un‟inderminatezza di ruolo; tanto da farci
considerare i tempi di mezzo come angosciosi periodi di oscure pulsioni e cupi rivolgimenti
(perfetti per le serie “fantasy” televisive) anteposti all‟approdo luminoso di qualche successivo
Rinascimento.
Visti con gli occhi di un agronomo la lettura potrebbe essere originale: potremmo infatti
immaginare i tempi di mezzo come un grande deposito di materiale organico in maturazione (in
pratica una concimaia), o –se volessimo essere più eleganti- un grande albero sradicato dalla
tempesta. Nel nostro sentire comune siamo abituati a pensare allo sterco come il prodotto finale di
un complesso lavoro assimilativo e digestivo, o che vita dell‟albero sia terminata con la caduta (e
tutti lamentiamo il vuoto che la sua assenza impone al disegno del paesaggio o del bosco), quasi
ignorando che il suo tronco giacente è il luogo d‟azione di centinaia di specie che, vivendo di esso
e in esso, sono capaci di trasformarlo in nuovo fertile humus; nutrimento futuro di qualche futuro
grande albero.
Non sorprendiamoci di questa nostra “forma mentis”, perché i limiti che dimostriamo nel
comprendere i periodi più complessi della storia sono paragonabili alla nostra incapacità di
penetrare certe aspetti arcani e complessi della Natura. Prendiamo proprio l‟esempio dell‟humus
(vedi il paragrafo dedicato al terreno); di questo insieme organico comprendiamo la funzione e ne
conosciamo la composizione fisica e chimica, ma non siamo in grado di penetrarne l‟intrinseca
essenza, quella che rende vitale una cosa che cresce quando cessa la vita. Siamo esseri duali,
pensiamo alla vita e alla morte come a sfere dell‟essere in eterna e antagonistica contrapposizione;
una morte che vive e dà la vita è lontana dai nostri attuali canoni mentali. Abbiamo perso coscienza
che secondo molte culture gli uomini sono stati creati dal fango e che nel latino “homo” (il terrestre)
e “humus” (il terreno) hanno la stessa radice, che nell‟italiano “letame” discende dal latino
“laetizia”, e che nell‟inglese esiste un legame scatologico tra “man” (uomo) e “manure”(letame).
Per questo riteniamo “oscuri” i medi evi, perché i medi evi non si muovono in accordanza agli
schemi del nostro pensiero razionale, non si evolvono in forme di continuità con le epoche che li
hanno preceduti, ma delle epoche precedenti rappresentano delle misteriose ed ermetiche
“transustanziazioni” (un concetto che non a caso attribuiamo al campo della metafisica).
Di questo nostro modo di pensare ne è riprova quello che noi consideriamo l‟ultimo medioevo;
quello nato a seguito della caduta formale dell‟Impero romano d‟occidente e che -caratteristico
dell‟appendice occidentale dell‟Eurasia – è stato il brodo di coltura dal quale è poi nato il continente
Europeo; quello che ha preso forma dall‟incontro di quel coacervo di gens germaniche (e poi
baltiche e poi slave) quando queste - in modo più o meno lasso-vennero in contatto con la
pervasività del mondo greco-latino che aveva già modificato il precedente substrato di genti locali;
203
quello che ha dato struttura a quei primi abbozzi di Stati nazione, che poi –con lentezza e
innumerevoli contraddizioni- si sono evoluti fino a dare corpo allo strano continente (strano nel
senso che la sua demarcazione è molto più mentale che geografica) che, fino alla seconda metà del
secolo scorso, ha svolto un ruolo egemone nel determinare l‟ordine (o a secondo i punti di vista: il
“disordine”) mondiale. Stati che nel loro gioco costante di antagonismo, d‟occasionali alleanze, di
decostruzione e ricostruzione territoriale, hanno sviluppato le condizioni agronomiche, economiche,
politiche e culturali, per imporre al resto del mondo, forme, modi, costumi, religioni e lingue.
Il Medioevo (e qui mi riferisco al suo “oculo”, ossia il periodo che va dal quinto all‟ottavo secolo)
non è “oscuro” per assenza di fonti (non definiamo “oscuri” molti altri periodi di cui abbiamo
ancor meno testimonianze), ma perché corrisponde ad un “nigredo” della storia che per essere letto
impone di andare oltre i canonici modelli interpretativi (che ho intenzione di tralasciare), cercando
di penetrare nelle pieghe più intime degli animi umani e nei fervori del loro sentire collettivo. Tanto
che per ricercarne il suo “umore” (proprio come gli uomini del Medioevo avevano incominciato a
fare grazie agli alambicchi portati dal mondo arabo), non c‟è bisogno di lunghe disquisizioni, ma di
provare a distillarne l‟essenza.
Ecco allora un aspetto che caratterizza già il primo Medioevo europeo è la netta separazione tra il
Re e il corpo del Re. Perché –dopo gli influssi orientaleggianti che avevano permeato gli ultimi
secoli del mondo classico- questo è un tempo che vede nascere (o rinascere) una nuova costruzione
simbolica del potere, dove la figura regale non è più rivestita dal manto della sacralità ma di quello
della “carnalità”. Anche perché la sacralità non può essere scissa dalla ritualità, tanto quanto la
ritualità non è scindibile dall‟esistenza di un “palazzo” (in questo caso si deve intendere il “palazzo”
nell‟accezione data da Pier Paolo Pasolini). L‟idea del “palazzo” era però lontana dai
comportamenti aggregativi dei popoli germanici (che per lo più si riconoscevano in forme
associative claniche), anche perché –nel frattempo- si erano già gettate le basi di quello che sarà
l‟unico vero “palazzo” del Medioevo europeo, quello “edificato” intorno alla corte papale, la vera
prosecutrice dell‟antica cultura imperiale romana, della sua forma di gestione territoriale (le
diocesi), nonché della sua lingua. (tanto che anche Giustiniano -pure nell‟età d‟oro di Bisanzio –
decise di pubblicare il suo famoso codice delle leggi in latino e non in greco).
Quel “palazzo” che, poggiandosi al presunto mandato derivatogli dall‟autorità pietrina, si eleverà –
come una vera e propria “Civitate Dei”- a governare l‟etica dei popoli e delle corti europee.
Per quanto lontano oggi appaia ai nostri occhi quel ruolo svolto dalla chiesa c‟è in questa primiera
separazione delle sfere politiche e morali qualcosa di estremamente moderno, perché senza questa
non si riuscirebbe a capire l‟evoluzione successiva della cultura europea e poi di quella occidentale.
La destrutturazione del potere delle elite romane (come una rivoluzione senza rivoluzione),
accentuata anche dal trasferimento a Costantinopoli di molte famiglie senatoriali, comportò poi la
rioccupazione dei vuoti lasciati da quelle assenze (una cosa analoga era avvenuta con la ripartizione
ai germani di parte delle terre pubbliche). Di quest‟aspetto abbiamo riscontro nel cambiamento
profondo della struttura fondiaria, che da una parte vide –per necessità- il ritorno alla terra di molti
piccoli coltivatori, mentre dall‟altra comportò un significativo ampliamento del già enorme
patrimonio della chiesa, che in questi secoli fu protagonista di alcuni innovativi esperimenti di
204
gestione agraria, sia attraverso la conduzione diretta dei fondi (le “domuscultae”), sia nella colonìa
con forme particolari d‟affitto prolungato, che prevedevano l‟impegno del locatore ad effettuare dei
miglioramenti fondiari (l‟istituto dell‟enfiteusi è una delle forme di conduzione tipica di questa
epoca).
Una trasformazione che ci introduce ad un altro aspetto caratteristico del Medioevo: ossia la sua
relativa democraticità (affermazione difficile da sostenere in un periodo che vide nascere la “servitù
della gleba”). Penso però che perlomeno il primo Medioevo si possa definire come il periodo
storico dove il potere oligarchico sia stato sostanzialmente formale e il potere del “demos” (ossia
del popolo) tendenzialmente sostanziale. Esattamente al contrario di oggi: dove le democrazie sono
formali e il potere delle oligarchie sostanziale.
Questo ci conduce ad un altro aspetto tipico del Medioevo: la nascita di una socialità poggiata su
basi comunitarie, espressione di un sentimento corale di umanità solidale! Tanto che se volessimo
usare un differente metodo storiografico (volessimo dare alla chiesa cattolica l‟attestato di attenta
lettrice dei sentimenti popolari) potremmo addirittura far corrispondere l‟inizio del Medioevo con la
nascita del monachismo benedettino e farlo terminare con l‟affermarsi –in una società ormai
secolarizzata- dell‟ultimo grande movimento monastico: quello francescano.
Un “coram popoli” (forse la cosa più simile al sentito comune di quegli uomini del neolitico quando
questi si mossero per “bonificare” le selvagge valli fluviali) che ci introduce ad un altro aspetto
caratteristico del Medioevo: la capacità di erosione delle società medievali a danno degli ambienti
naturali. Questi sono infatti i secoli che videro gli uomini incontrare sulla loro strada lupi, orsi e
draghi (ne troviamo molteplici tracce nella tradizione popolare), non perché gli animali selvatici
fossero aumentati, ma semplicemente perché l‟uomo del medioevo era in grado di mettere in atto
una progressiva occupazione dei loro tradizionali territori di caccia, iniziando a coltivare molti più
ambienti naturali di quelli che erano stati occupati dall‟espansionismo agricolo romano.
Ora –fatte queste premesse- siamo in grado di oltrepassare questo “orizzonte degli eventi” della
storia (che come quello astrofisico ci proietta in un'altra dimensione delle spazio-temporale), di non
seguire quello che apparentemente è il ritorno del pendolo fattuale ad oriente (con la nascita
dell‟Impero bizantino e di quello arabo) ma di concentrarci sulla parte occidentale dell‟antico
mondo classico, l‟area da cui nacque la storia europea e con essa quella del mondo contemporaneo.
205