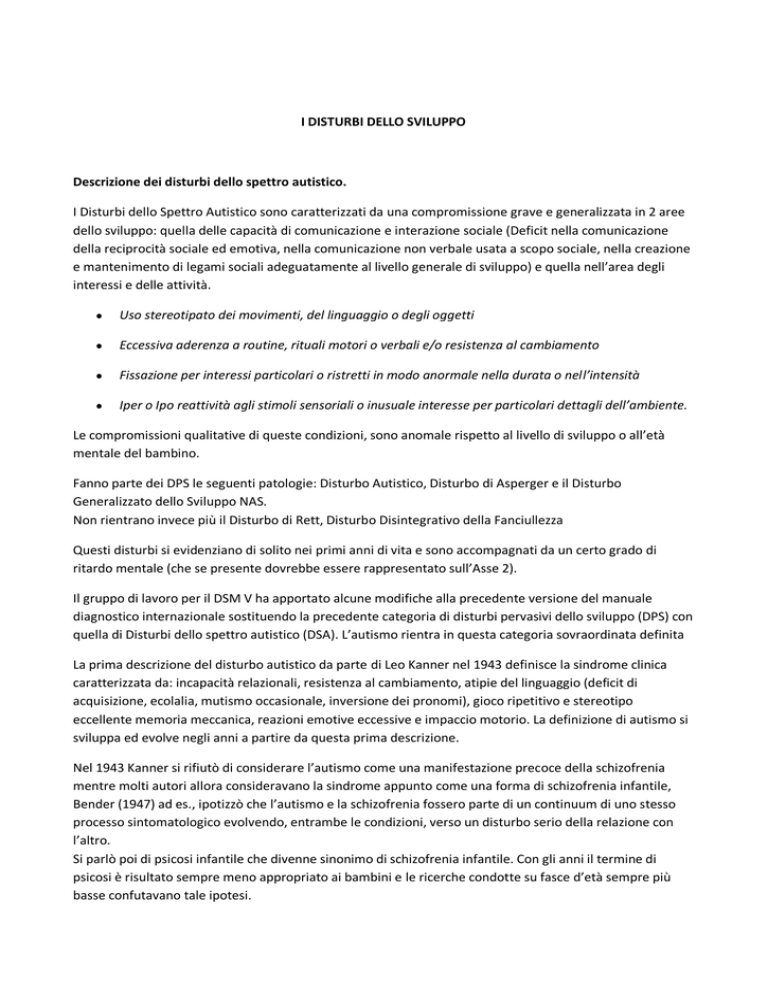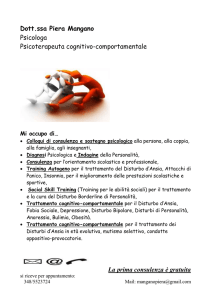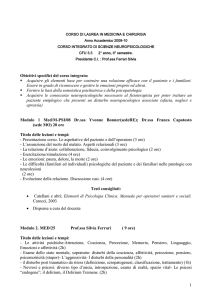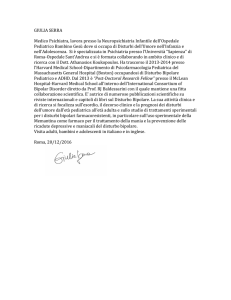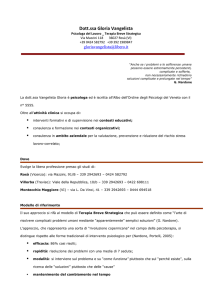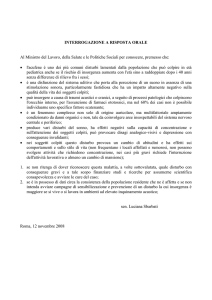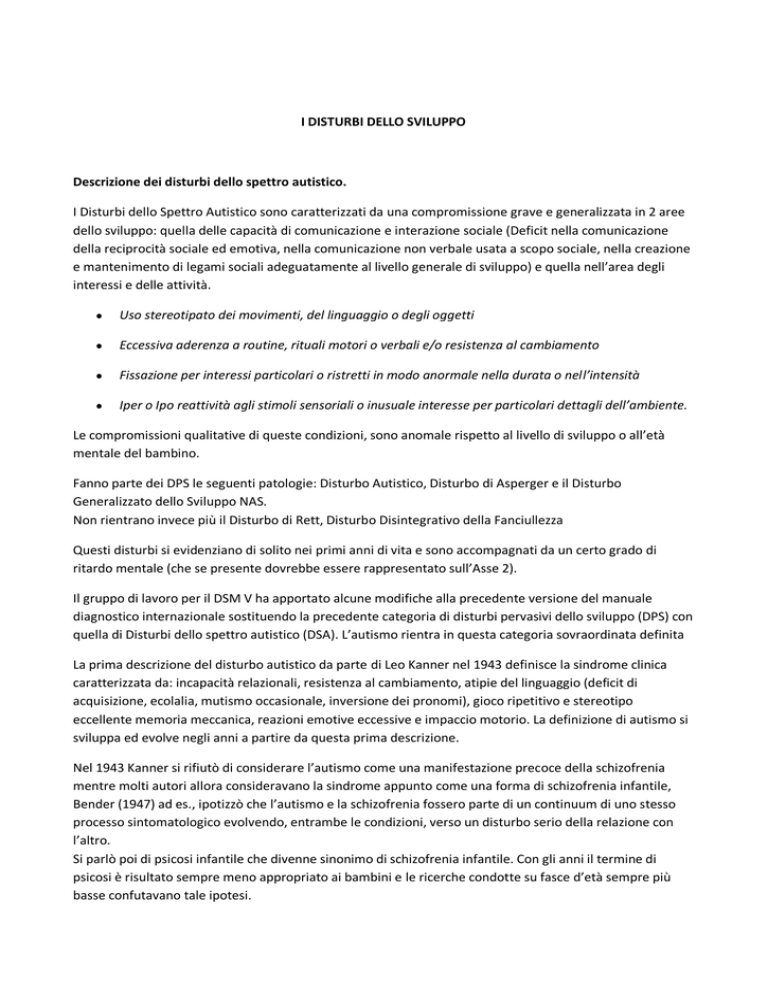
I DISTURBI DELLO SVILUPPO
Descrizione dei disturbi dello spettro autistico.
I Disturbi dello Spettro Autistico sono caratterizzati da una compromissione grave e generalizzata in 2 aree
dello sviluppo: quella delle capacità di comunicazione e interazione sociale (Deficit nella comunicazione
della reciprocità sociale ed emotiva, nella comunicazione non verbale usata a scopo sociale, nella creazione
e mantenimento di legami sociali adeguatamente al livello generale di sviluppo) e quella nell’area degli
interessi e delle attività.
Uso stereotipato dei movimenti, del linguaggio o degli oggetti
Eccessiva aderenza a routine, rituali motori o verbali e/o resistenza al cambiamento
Fissazione per interessi particolari o ristretti in modo anormale nella durata o nell’intensità
Iper o Ipo reattività agli stimoli sensoriali o inusuale interesse per particolari dettagli dell’ambiente.
Le compromissioni qualitative di queste condizioni, sono anomale rispetto al livello di sviluppo o all’età
mentale del bambino.
Fanno parte dei DPS le seguenti patologie: Disturbo Autistico, Disturbo di Asperger e il Disturbo
Generalizzato dello Sviluppo NAS.
Non rientrano invece più il Disturbo di Rett, Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza
Questi disturbi si evidenziano di solito nei primi anni di vita e sono accompagnati da un certo grado di
ritardo mentale (che se presente dovrebbe essere rappresentato sull’Asse 2).
Il gruppo di lavoro per il DSM V ha apportato alcune modifiche alla precedente versione del manuale
diagnostico internazionale sostituendo la precedente categoria di disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con
quella di Disturbi dello spettro autistico (DSA). L’autismo rientra in questa categoria sovraordinata definita
La prima descrizione del disturbo autistico da parte di Leo Kanner nel 1943 definisce la sindrome clinica
caratterizzata da: incapacità relazionali, resistenza al cambiamento, atipie del linguaggio (deficit di
acquisizione, ecolalia, mutismo occasionale, inversione dei pronomi), gioco ripetitivo e stereotipo
eccellente memoria meccanica, reazioni emotive eccessive e impaccio motorio. La definizione di autismo si
sviluppa ed evolve negli anni a partire da questa prima descrizione.
Nel 1943 Kanner si rifiutò di considerare l’autismo come una manifestazione precoce della schizofrenia
mentre molti autori allora consideravano la sindrome appunto come una forma di schizofrenia infantile,
Bender (1947) ad es., ipotizzò che l’autismo e la schizofrenia fossero parte di un continuum di uno stesso
processo sintomatologico evolvendo, entrambe le condizioni, verso un disturbo serio della relazione con
l’altro.
Si parlò poi di psicosi infantile che divenne sinonimo di schizofrenia infantile. Con gli anni il termine di
psicosi è risultato sempre meno appropriato ai bambini e le ricerche condotte su fasce d’età sempre più
basse confutavano tale ipotesi.
L’autismo è una sindrome caratterizzata dalla presenza di deficit specifici che riguardano le seguenti abilità:
la teoria della mente e la metarappresentazione
la percezione e l’espressione delle emozioni
l’attenzione condivisa
l’orientamento sensoriale e la regolazione dell’arousal
l’imitazione
il gioco simbolico
la comunicazione e il linguaggio
l’attaccamento
il comportamento intenzionale o finalistico
Spesso si rischia di includere nei Disturbi Autistici e nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo casi che presentano
nella prima infanzia difficoltà di comunicazione ed interazione che sono secondarie ad altre patologie. Ciò
comporta una serie di implicazioni sul piano della prognosi e del trattamento che rischiano di inficiare il
processo di sviluppo della patologia stessa.
Il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) prevede che la diagnosi differenziale del
Disturbo Autistico sia posta con: il disturbo di Rett, il disturbo Disintegrativo della Fanciullezza, il Disturbo di
Asperger, il Mutismo Selettivo, il Disturbo Espressivo e il Disturbo Misto del Linguaggio, il Disturbo del
Movimento Stereotipo, la Schizofrenia ed il Ritardo Mentale.
Negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli progressi nell’interpretazione dell’autismo e dei disturbi
pervasivi dello sviluppo. I dati della letteratura più recente suggeriscono che il Disturbo Autistico ha origine
da fattori organici che interferiscono nella fase dello sviluppo del Sistema Nervoso Centrale anche se non
sono state individuate specifiche disfunzioni del sistema nervoso.
I fattori biologici causa di autismo sono noti solo nel 20% dei casi; la presenza di anomalie metaboliche
sembra interessi il 5% dei casi; le ricerche sui fattori neuropatologici hanno evidenziato, in alcuni casi, la
presenza di anomalie localizzate nel cervelletto, nel sistema limbico e nella corteccia cerebrale. In altri casi
è stato evidenziato il ruolo dei fattori esogeni infettivi, tossici, farmacologici, traumatici, e vascolari.
L’indagine sui fattori genetici e sulle anomalie cromosomiche, infine, ha portato alla scoperta dell’eziologia
certa del Disturbo di Rett nella mutazione MECPZ localizzata sul cromosoma Xq28. Non vanno inoltre
sottovalute le patologie neurologiche associate alla sindrome che aggravano il quadro clinico: iper o ipotonia, turbe della coordinazione motoria, distonie, stereotipie motorie, dismorfismi, alterazioni dell’udito
(sordita’ di conduzione neurosensoriale o mista), ritardo mentale ed epilessia.
Le ricerche evidenziano pertanto che esiste una multifattorialità di cause genetiche, organiche o acquisite
precocemente che, in modi diversi, potrebbero giustificare l’insorgenza del disturbo autistico e che vanno
pertanto ulteriormente indagate.
Trattamento psicoterapeutico
Un corretto trattamento psicoterapeutico deve prevedere, probabilmente più che in altri disturbi, un
corretto ed adeguato processo di assessment che deve partire dalla rilevazione di informazioni relative alla
storia del disturbo, l’iter diagnostico e terapeutico che hanno preceduto la consultazione, argomenti relativi
alle risposte ambientali e familiari al disturbo e alle rappresentazioni genitoriali.
La valutazione del bambino deve esplorare tutte le aree dello sviluppo: l’area affettiva, cognitiva,
comunicativa, interattiva, neuropsicologica.
E’ importante effettuare un’indagine neurologica accanto alla valutazione psicodiagnostica del bambino.
L’indagine medica consente di evidenziare situazioni cliniche associate al disturbo ed e’ utile per la diagnosi
differenziale con altre condizioni mediche. Determinante e’ la valutazione psicodiagnostica in quanto al
momento una diagnosi specifica per il Disturbo Autistico e’ possibile solo su dati comportamentali.
Un’accurata valutazione psicodiagnostica richiede da parte del clinico un’osservazione prolungata che va
dalle da 4 alle 5 sedute in un setting supportivo ma non eccessivamente ricco di stimoli adatto a sollecitare
ed incoraggiare l’attività spontanea e l’interazione.
Il clinico dovrà’ osservare attentamente: l’attività spontanea, il comportamento interattivo, la
comunicazione verbale e non verbale, l’affettività o stato dell’umore (in termini di regolazione, intensità e
reciprocità), il profilo cognitivo, i comportamenti ripetitivi.
La valutazione del profilo di sviluppo relativo alle diverse abilità (linguistica, cognitiva, motoria,
visuopercettiva e così via) consente al clinico di stabilire una prognosi ed effettuare una programmazione
degli interventi.
Fra i trattamenti più efficaci sono documentati quelli di natura comportamentale e molti interventi
prevedono l’applicazione di strategie e di tecniche che si basano sui principi della psicoterapia cognitiva.
Gli obiettivi generali dell’intervento saranno: favorire la motivazione, la stabilità attentiva e il
comportamento intenzionale, il riconoscimento e la differenziazione delle emozioni, la comprensione di sé
e dell’altro, la comunicazione, il gioco e il problem-solving.
Non è prevista l’applicazione di tecniche avversive volte a ridurre quelli che in passato (trascurandone
l’aspetto funzionale ) erano definiti “comportamenti devianti”, quali le stereotipie, le ecolalie, l’auto e
l’etero-aggressività’, in quanto non riteniamo necessarie al raggiungimento di tali obiettivi le misure
punitive. La nostra esperienza clinica con bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo dimostra che in molti
casi i comportamenti devianti si riducono spontaneamente via via che migliorano le abilità di
comunicazione e di interazione con l’altro. In altri casi invece l’intervento diretto su tali comportamenti
prevede strategie piu’ complesse: il gesto sterotipato e l’uso bizzarro dell’oggetto, ad esempio, vengono
inseriti in uno spazio di condivisione, investiti di significato o integrati in una sequenza di attività ludica ove
perdono la caratteristica di devianza; i comportamenti auto ed etero-aggressivi invece vengono ridotti
aiutando il bambino ad esprimere il disagio e la rabbia attraverso modalita’ di comunicazione alternative tra
cui la verbalizzazione dei propri stati interni e l’attacco rivolto all’oggetto piuttosto che all’altro o a se
stesso.
Gli “eccessi comportamentali” sono un problema a casa, a scuola e in tutti i contesti sociali e richiedono
attenzione ovunque interferiscano con l’apprendimento e con la piena partecipazione nella famiglia e nella
comunità locale. L’esperienza clinica insegna inoltre che molti bambini autistici hanno difficoltà a trasferire
le abilita’ appena apprese in un determinato setting terapeutico in altri luoghi e ad altre persone.
Il problema della “generalizzazione delle acquisizioni” fu già riscontrato negli anni 70 e affrontato
realizzando programmi di intervento per genitori.
Un buon trattamento deve prevedere un lavoro costante e continuativo con la famiglia: ogni fase del
processo terapeutico dovrebbe essere illustrata, motivata e condivisa col genitore, il quale potrà così
sostenere le acquisizioni senza pero’ confondere il proprio ruolo genitoriale con quello di terapista.
La presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali e’ indispensabile e può essere
effettuata mediante: interventi di sostegno, il counseling, la psicoterapia individuale, di gruppo e la
psicoterapia genitore-bambino. Nelle scuole invece l’attivita’ dei i servizi dovra’ prevedere un controllo
costante dell’iter scolastico che consideri, la possibilita’ di permanenze programmate e protratte nel tempo
(specie nei casi piu’ gravi), e la realizzazione di programmi centrati sull’apprendimento. E’ importante che il
programma psicopedagogico si integri con la terapia riproponendo in classe le funzioni sulle quali la terapia
sta lavorando.
Descrizione del disturbo dell’Apprendimento
I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) riguardano un gruppo di disabilità in cui si presentano
significative difficoltà nell’acquisizione e utilizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo.
La principale caratteristica di questa categoria è proprio la “specificità”, ovvero il disturbo interessa uno
specifico e circoscritto dominio di abilità indispensabile per l’apprendimento (lettura, scrittura, calcolo)
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Ciò significa che per avere una diagnosi di dislessia,
il bambino non deve presentare deficit di intelligenza, problemi ambientali o psicologici, deficit sensoriali o
neurologici.
La Dislessia è una disabilità specifica dell’apprendimento caratterizzata dalla difficoltà ad effettuare una
lettura accurata e/o fluente. Il bambino, all’inizio del percorso di scolarizzazione, mostra difficoltà a
riconoscere le lettere dell’alfabeto, a fissare la corrispondenza fra segni grafici e suoni e ad automatizzare
tale processo di conversione. Tale difficoltà si ripercuote sull’apprendimento scolastico e sulle attività di
vita quotidiana che richiedono la lettura di testi scritti
La Disortografia è un disturbo specifico che riguarda la componente costruttiva della scrittura, legata quindi
agli aspetti linguistici, e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico.
Il bambino disortografico presenta una difficoltà nell’applicare le regole di conversione dal suono alla
parola scritta e quindi a riconoscere i suoni che compongono la parola, a individuare le regolarità o
irregolarità ortografiche e a individuare il corretto ordine con cui questi elementi si compongono.
La Disgrafia riguarda la componente esecutiva, grafo-motoria (scrittura poco leggibile); si riferisce alla
difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. Il bambino disgrafico può presentare una cattiva
impugnatura della penna o matita, poca capacità di utilizzare lo spazio nel foglio, difficoltà nel produrre
forme geometriche e nella copia di immagini, alternanza tra macro e micrografia.
La Discalculia riguarda la difficoltà a comprendere ed operare con i numeri e la difficoltà automatizzare
alcuni compiti numerici e di calcolo. Il bambino discalculico può presentare difficoltà nella cognizione
numerica (meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, capire il valore posizionale delle cifre,
associazione numero quantità, eseguire calcoli a mente) nelle procedure esecutive (lettura, scrittura, messa
in colonna dei numeri) e di calcolo (recuperare i risultati delle tabelline, recupero dei fatti numerici e
algoritmo del calcolo scritto.
Si tratta dunque di disturbi distinti ciascuno con una propria fisionomia ma che spesso nella pratica clinica
risutano spesso associati fra loro.
La diagnosi di dislessia, disgrafia e disortografia, di discalculia, viene fatta in seguito ai risultati di test
specifici volti ad accertare lo stato degli apprendimenti delle abilità strumentali, il funzionamento cognitivo,
neuropsicologico ed emotivo.
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) costituiscono una delle patologie più frequentemente inviate
ai servizi del territorio. La prevalenza nella popolazione italiana è stimata tra l’2,5% ed il 3,5% (ISS, 2011). La
rilevanza dell’argomento è dovuta oltre che alla sua alta prevalenza, anche alle conseguenze che questi
disturbi determinano a livello individuale, traducendosi spesso in abbassamento del livello scolastico
conseguito e conseguente riduzione della realizzazione delle proprie potenzialità sociali e lavorative.
Tra le cause sono state principalmente indagati i fattori genetici e quelli acquisiti (sofferenza cerebrale
precoce, lesioni di varia natura, ritardi maturativi, ecc.).
L’esperienza clinica e i dati riportati da numerose ricerche suggeriscono che i disturbi specifici
dell’apprendimento altre che tra loro si presentano frequentemente associati a disturbi emotivi e
comportamentali. La comorbilità fra i disturbi specifici dell’apprendimento e disturbi di tipo internalizzanti
o esternalizzanti è, secondo i dati presenti in letteratura, tra il 25-50%. Le categorie diagnostiche
maggiormente riscontrate riguardano il deficit di attenzione e iperattività; il disturbo oppositivoprovocatorio; i disturbi della condotta; il disturbo depressivo; i disturbi di ansia. L’evoluzione è condizionata
da vari fattori quali: la gravità del disturbo specifico, le associazioni tra difficoltà di scrittura, lettura e
calcolo, il livello cognitivo e metacognitivo, la presenza di un disturbo psichiatrico, il tipo di compromissioni
neuropsicologiche, la precocità e adeguatezza degli interventi e le risposte ambientali.
Quali i segnali?
Già dall’ultimo anno di scuola materna è possibile individuare una vulnerabilità nell’acquisizione delle
specifiche competenze dei bambini: difficoltà meta fonologiche (es. denominazione di parole; scorretta
identificazione dei suoni iniziali e finali delle parole; segmentazione – es. dividere in sillaba la parola – e
fusione fonemica – es. unire le sillabe per formare una parola -), di linguaggio, motricità fine (es.
impugnatura della penna, difficoltà nella manipolazione di piccoli oggetti, difficoltà nell’utilizzo delle forbici
dei pennelli, ecc) e coordinazione visivo-motoria (es. difficoltà nel disegno spontaneo e su copia,
ricomposizione di puzzle, ecc.) possono costituire importanti indici di rischio.
L’ingresso nella classe prima elementare è di solito cruciale per l’individuazione dei bambini che potrebbero
sviluppare questo tipo di disturbo. Sono spesso insegnanti e genitori a segnalare tali difficoltà.
E’ necessario, nella fase diagnostica, indagare gli aspetti neuropsicologici e quelli emotivi (indicare fattori di
vulnerabilità e fattori protettivi) ed impostare un intervento adeguato. Trascurare la relazione tra disagio
psicologico e DSA risulta rischioso considerando il fatto che i DSA hanno un notevole impatto sia a livello
individuale, sia a livello sociale. Diagnosi accurata e l’intervento precoce costituiscano fattore prognostico
positivo sia sul piano scolastico, sociale e psicologico (comorbilità psichiatrica). Spetta al clinico operare
un’accurata diagnosi differenziale e impostare un adeguato piano di trattamento.
Trattamento
Gli interventi devono interessare sia il trattamento del disturbo specifico, attraverso operatori specializzati
e programmi mirati, che l’organizzazione emotivo-relazionale. Questi ragazzi mostrano una grande
sofferenza psicologica legata ai vissuti delle loro carenze; tali vissuti possono incidere pesantemente
sull’autostima e la motivazione ad apprendere.
Spesso accade che il loro funzionamento sociale all’interno del gruppo classe risulta più problematico; il
sentirsi incompetenti nell’apprendere può comportare un sentimento di inferiorità nelle interazioni tra
pari, che man mano diventano sempre più sporadiche. Inoltre il percorso scolastico di questi soggetti è
frequentemente segnato da ripetiti insuccessi, gli insegnanti e i genitori possono attribuire questi esiti ad
una mancanza di impegno, colpevolizzandoli come oppositivi, pigri, non interessati. Dal canto suo se il
ragazzo percepisce che le sue difficoltà non gli vengono riconosciute, per proteggersi evita i compiti e/o
mette in atto comportamenti disturbanti, con conseguente degenerazione delle relazioni con gli adulti.
In questa situazione possono attivarsi scambi disfunzionali in cui l’attivazione di cicli viziosi rende più
difficile capire la natura del deficit specifico, comprendere i rapporti tra i disturbi dell’apprendimento e il
disagio emotivo sottostante ai problemi comportamentali e adattavi e la gestione degli interventi.
La terapia cognitiva-comportamentale è un intervento utile per prevenire certi disagi psicologici
nell’ambiente scolastico e familiare e per trattare specifici problemi psicopatologici che possono
evidenziarsi a seguito di una valutazione psicodiagnostica.
Disturbo della condotta
La categoria diagnostica del DSM-IV di Disturbo della Condotta (DC) si applica a quei bambini che
manifestino comportamenti antisociali sia “covert” (inganni e raggiri, danneggiamento di oggetti e
proprietà, calunnie, ecc.) che “overt” (insulti, sfide e aggressioni fisiche).
L’età di esordio di solito predice gli esiti ultimi di tale patologia, tant’è che il DSM-IV riflette tale assunzione,
distinguendo due categorie di DC, una ad esordio in età infantile e una ad esordio nel periodo
adolescenziale.
Per porre diagnosi di DC il bambino o l’adolescente devono esibire aggressività persistente e/o
comportamenti antisociali per almeno 6 mesi e tali comportamenti devono implicare menomazione nel
funzionamento sociale e lavorativo/scolastico.
I bambini con DC ad esordio precoce sono solitamente più aggressivi, manifestano menomazioni nel
funzionamento più marcate e hanno maggiori problemi temperamentali, cognitivi e neuropsicologici,
hanno spesso una storia familiare per tale disturbo, provengono da ambienti familiari peggiori e hanno
maggiori problemi sociali rispetto ai soggetti con DC ad esordio adolescenziale (Moffitt e Caspi, 2001).
La prognosi per i bambini con DC ad esordio precoce non di rado è negativa.
La diagnosi di DC ad esordio precoce è molto più diffusa tra i bambini rispetto alle bambine. Il DC ad esordio
adolescenziale è meno grave e tende a coincidere con i problemi che emergono in adolescenza, sia nel
contesto familiare che nel gruppo dei pari.
Disturbo della Condotta
A – Una modalità di comportamento ripetitiva ed persistente in cui i diritti fondamentali degli altri o le
principali norme o regole societarie appropriate per l’età vengono violati, come manifestato dalla presenza
di tre (o più) dei seguenti criteri nei 12 mesi precedenti, con almeno un criterio presente negli ultimi 6 mesi:
Aggressioni a persone o animali
spesso fa il prepotente, minaccia, o intimorisce gli altri;
spesso dà inizio a colluttazioni fisiche;
ha usato un’arma che può causare seri danni fisici ad altri (per es., un bastone, una barra, una
bottiglia rotta, un coltello, una pistola)
è stato fisicamente crudele con le persone;
è stato fisicamente crudele con gli animali;
ha rubato affrontando la vittima (per es.: aggressione, scippo, estorsione, rapina a mano armata)
ha forzato qualcuno ad attività sessuali.
Distruzione della proprietà
ha deliberatamente appiccato il fuoco con l’intenzione di causare seri danni;
ha deliberatamente distrutto proprietà altrui (in modo diverso dall’appiccare il fuoco).
Frode o furto
è penetrato in un edificio, un domicilio, o un’automobile altrui;
spesso mente per ottenere vantaggi o favori o per evitare obblighi (cioè, raggira gli altri);
ha rubato articoli di valore senza affrontare la vittima (per es., furto nei negozi, ma senza scasso;
falsificazioni).
Gravi violazioni di regole
spesso trascorre fuori la notte nonostante le proibizioni dei genitori, con inizio prima dei 13 anni di
età;
è fuggito da casa di notte almeno due volte mentre viveva a casa dei genitori o di chi ne faceva le
veci (o una volta senza ritornare per un lungo periodo);
marina spesso la scuola, con inizio prima dei 13 anni di età.
B – L’anomalia del comportamento causa compromissione clinicamente significativa del funzionamento
sociale, scolastico, o lavorativo.
C – Se il soggetto ha 18 anni o più, non sono soddisfatti i criteri per il Disturbo Antisociale di Personalità.
Trattamento psicoterapeutico
L’intervento cognitivo-comportamentale per i bambini e gli adolescenti con problemi di condotta e di
aggressività è basato su un modello socio-cognitivo scientificamente fondato, relativo alle modalità di
elicitazione della rabbia nei bambini con PAC e ai processi attraverso i quali questa sfocia in risposte
aggressive. Nel modello in questione si opera una distinzione tra i deficit cognitivi, che si riferiscono a
inabilità in specifiche attività cognitive, e le distorsioni cognitive, che si riferiscono, invece, alle percezioni
erronee e/o disfunzionali dei soggetti con problemi di aggressività.
Tale modello socio-cognitivo rende evidente il fatto che, quando il bambino incontra uno stimolo
potenzialmente attivante la rabbia, sono soprattutto i processi di percezione e di valutazione che questi
compie ad influenzare le sue reazioni emozionali e fisiologiche, piuttosto che l’evento in quanto tale.
Queste percezioni e valutazioni possono essere accurate o inaccurate e, in larga parte, sono influenzate
dalle iniziali aspettative del soggetto, che filtrano la percezione della situazione e orientano l’attenzione
selettiva a specifici aspetti, o stimoli, dell’evento attivante. Se il bambino ha interpretato l’evento come
minaccioso, provocatorio o frustrante, egli sperimenterà un’attivazione neurovegetativa intensa e
successivamente ingaggerà in un set di attività cognitive, dirette a decidere circa un opportuno corso di
azione per rispondere all’evento stesso, altamente influenzate dalla valutazione iniziale e dal
relativoarousal.
L’arousal interno, infatti, ha un’interazione reciproca con i processi di valutazione del bambino, dal
momento che egli deve interpretare ed etichettare le connotazioni emotive di tale attivazione
neurovegetativa e, inoltre, a causa del fatto che l’accresciuta attivazione emotiva focalizza l’attenzione del
bambino soprattutto sugli stimoli associati con possibili minacce, egli tenderà molto frequentemente a
sentirsi arrabbiato. Questi tre insiemi di attività interne – (1) percezione e valutazione, (2) attivazione
neurovegetativa e (3) problem-solving interpersonale – contribuiscono alle risposte comportamentali del
bambino e alle successive conseguenze che egli elicita da parte dei coetanei e degli adulti e che sperimenta
internamente come auto-valutazioni. Le reazioni da parte delle altre persone possono poi diventare degli
eventi stimolo, che danno vita ad un nuovo ciclo, attraverso circuiti di feedback, diventando ricorrenti unità
comportamentali, collegate tra loro
Non di rado può essere utile concentrare l’attenzione sulle cognizioni dei genitori e degli insegnanti
piuttosto che su quelle dei bambini. In generale, i genitori possono fare attribuzioni pessimistiche riguardo
al locus of control del problema, la sua stabilità e la sua possibile risoluzione. Per esempio, le madri di
bambini con problemi comportamentali tendono a credere che la causa (e di conseguenza la soluzione)
delle difficoltà del figlio riguardi il bambino e non il genitore o l’interazione tra l’uno e l’altro. Le attribuzioni
materne, infatti, tendono a focalizzarsi su caratteristiche stabili e disposizionali del bambino, come
spiegazione primaria delle sue difficoltà. Le madri potrebbero pensare, per esempio, (a) che i loro bambini
siano responsabili dei loro comportamenti; (b) che il bambino intenzionalmente si comporti male
manifestando rabbia o ripicche/dispetti nei confronti dei genitori e (c) che i problemi del bambino siano
relativamente non modificabili o incontrollabili.
In altre parole, i genitori dei bambini con tali problemi potrebbero non accettare facilmente la premessa
che le loro pratiche genitoriali abbiano giocato un ruolo importante nello sviluppo dei problemi o che
possano essere usate per modificare l’attuale situazione. Inoltre, alcuni genitori non si sentono competenti
o capaci di fronteggiare il comportamento del bambino e sperano che il terapeuta si assuma la piena
responsabilità di aiutare il figlio. In altri casi, alcuni genitori ritengono che i problemi del bambino siano
totalmente causati da loro, perché non sono bravi genitori.
Le attribuzioni genitoriali negative e pessimistiche sono da tenere in debito conto, dal momento che, non
solo generano stati emotivi negativi nei genitori (per esempio rabbia e frustrazione), ma li inducono anche
ad assumere delle pratiche disciplinari fallimentari o peggiorative.
Disturbo Oppositivo Provocatorio
La diagnosi di Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) si applica a bambini che esibiscono livelli
di rabbia persistente ed evolutivamente inappropriata, irritabilità, comportamenti provocatori e
oppositività, che causano menomazioni nell’adattamento e nella funzionalità sociale. Un bambino al quale
viene posta questa diagnosi, deve mostrare tali sintomi in maniera persistente per almeno 6 mesi e i
sintomi devono causare menomazione nel funzionamento personale e sociale. Una storia precoce di DOP è
spesso presente in bambini che vengono successivamente diagnosticati come Disturbo della Condotta (DC).
Il DOP emerge solitamente in maniera più precoce (di solito intorno ai 6 anni) rispetto al DC (età di esordio
intorno ai 9 anni). Ad ogni modo, molti bambini vengono diagnosticati come DOP in età preadolescenziale.
Disturbo Oppositivo Provocatorio
A – Una modalità di comportamento negativistico, ostile e provocatorio che dura da almeno 6 mesi,
durante i quali sono stati presenti 4 (o più) dei seguenti criteri:
spesso va in collera;
spesso litiga con gli adulti;
spesso sfida attivamente o si rifiuta di rispettare le richieste o regole degli adulti;
spesso irrita deliberatamente le persone;
spesso accusa gli altri per i propri errori o il proprio cattivo comportamento;
è spesso suscettibile o facilmente irritato dagli altri;
è spesso arrabbiato e rancoroso;
è spesso dispettoso e vendicativo.
B – L’anomalia del comportamento causa compromissione clinicamente significativa del funzionamento
sociale, scolastico o lavorativo.
C -I comportamenti non si manifestano esclusivamente durante il decorso di un Disturbo Psicotico o di un
Disturbo dell’Umore.
D – Non sono soddisfatti i criteri per il Disturbo della Condotta, e, se il soggetto ha 18 anni o più, non
risultano soddisfatti i criteri per il Disturbo Antisociale di Personalità.
Trattamento psicoterapeutico del Disturbo Oppositivo Provocatorio
L’intervento cognitivo-comportamentale per i bambini e gli adolescenti con problemi di condotta e di
aggressività è basato su un modello socio-cognitivo scientificamente fondato, relativo alle modalità di
elicitazione della rabbia nei bambini con PAC e ai processi attraverso i quali questa sfocia in risposte
aggressive. Nel modello in questione si opera una distinzione tra ideficit cognitivi, che si riferiscono a
inabilità in specifiche attività cognitive, e le distorsioni cognitive, che si riferiscono, invece, alle percezioni
erronee e/o disfunzionali dei soggetti con problemi di aggressività.
Tale modello socio-cognitivo rende evidente il fatto che, quando il bambino incontra uno stimolo
potenzialmente attivante la rabbia, sono soprattutto i processi di percezione e di valutazione che questi
compie ad influenzare le sue reazioni emozionali e fisiologiche, piuttosto che l’evento in quanto tale.
Queste percezioni e valutazioni possono essere accurate o inaccurate e, in larga parte, sono influenzate
dalle iniziali aspettative del soggetto, che filtrano la percezione della situazione e orientano l’attenzione
selettiva a specifici aspetti, o stimoli, dell’evento attivante. Se il bambino ha interpretato l’evento come
minaccioso, provocatorio o frustrante, egli sperimenterà un’attivazione neurovegetativa intensa e
successivamente ingaggerà in un set di attività cognitive, dirette a decidere circa un opportuno corso di
azione per rispondere all’evento stesso, altamente influenzate dalla valutazione iniziale e dal relativo
arousal.
L’arousal interno, infatti, ha un’interazione reciproca con i processi di valutazione del bambino, dal
momento che egli deve interpretare ed etichettare le connotazioni emotive di tale attivazione
neurovegetativa e, inoltre, a causa del fatto che l’accresciuta attivazione emotiva focalizza l’attenzione del
bambino soprattutto sugli stimoli associati con possibili minacce, egli tenderà molto frequentemente a
sentirsi arrabbiato.
Questi tre insiemi di attività interne – (1) percezione e valutazione, (2) attivazione neurovegetativa e (3)
problem-solving interpersonale – contribuiscono alle risposte comportamentali del bambino e alle
successive conseguenze che egli elicita da parte dei coetanei e degli adulti e che sperimenta internamente
come auto-valutazioni. Le reazioni da parte delle altre persone possono poi diventare degli eventi stimolo,
che danno vita ad un nuovo ciclo, attraverso circuiti di feedback, diventando ricorrenti unità
comportamentali, collegate tra loro.
Non di rado può essere utile concentrare l’attenzione sulle cognizioni dei genitori e degli insegnanti
piuttosto che su quelle dei bambini. In generale, i genitori possono fare attribuzioni pessimistiche riguardo
al locus of control del problema, la sua stabilità e la sua possibile risoluzione. Per esempio, le madri di
bambini con problemi comportamentali tendono a credere che la causa (e di conseguenza la soluzione)
delle difficoltà del figlio riguardi il bambino e non il genitore o l’interazione tra l’uno e l’altro. Le attribuzioni
materne, infatti, tendono a focalizzarsi su caratteristiche stabili e disposizionali del bambino, come
spiegazione primaria delle sue difficoltà. Le madri potrebbero pensare, per esempio, (a) che i loro bambini
siano responsabili dei loro comportamenti; (b) che il bambino intenzionalmente si comporti male
manifestando rabbia o ripicche/dispetti nei confronti dei genitori e (c) che i problemi del bambino siano
relativamente non modificabili o incontrollabili.
In altre parole, i genitori dei bambini con tali problemi potrebbero non accettare facilmente la premessa che
le loro pratiche genitoriali abbiano giocato un ruolo importante nello sviluppo dei problemi o che possano
essere usate per modificare l’attuale situazione. Inoltre, alcuni genitori non si sentono competenti o capaci
di fronteggiare il comportamento del bambino e sperano che il terapeuta si assuma la piena responsabilità
di aiutare il figlio. In altri casi, alcuni genitori ritengono che i problemi del bambino siano totalmente causati
da loro, perché non sono bravi genitori.
Le attribuzioni genitoriali negative e pessimistiche sono da tenere in debito conto, dal momento che, non
solo generano stati emotivi negativi nei genitori (per esempio rabbia e frustrazione), ma li inducono anche
ad assumere delle pratiche disciplinari fallimentari o peggiorative.
Disturbo dell’attaccamento
Il sistema motivazionale dell’attaccamento è sotteso da un programma comportamentale innato che
riguarda primati ed esseri umani (Bowlby), cha ha lo scopo di aumentare la possibilità di protezione e
sopravvivenza dell’individuo.
Le caratteristiche dell’attaccamento precoce giocano un ruolo cruciale nel determinare condizioni
protettive o nel rappresentare fattori di rischio per lo sviluppo psicopatologico in età evolutiva.
Un attaccamento sicuro implica un maggior adattamento all’ambiente mentre modelli disfunzionali
dell’attaccamento (attaccamento insicuro-evitante, attaccamento insicuro-resistente, attaccamento
disorganizzato) o modelli atipici rendono difficile l’adattamento psicosociale.
La caratteristica principale dei modelli di attaccamento atipici è rappresentata da una marcata incoerenza
dei diversi comportamenti rispetto a una strategia definita per garantirsi la vicinanza alla madre.
I disturbi dell’attaccamento segnalano un disturbo globale del sentimento di protezione e sicurezza del
bambino e si sviluppano all’interno di relazioni gravemente patologiche in cui risulta alterata la funzione
fondamentale del sistema dell’attaccamento: la possibilità che il bambino possa sperimentare un senso di
sicurezza interno.
In questo quadro clinico sono sempre presenti altri disturbi psicopatologici: ritardi dello sviluppo, disturbi
della nutrizione, etc.
I bambini mostrano una capacità ridotta di rispondere in modo adeguato sia sul piano emozionale sia su
quello sociale e perciò risultano gravemente compromesse le competenze sociali.
Esordio: prima dei 5 anni.
I principali indicatori di un disturbo dell’attaccamento sono la socialità indiscrminata (bambini che si
affidano volentieri alle cure di chiunque e non protestano nel separarsi dalla propria figura di
attaccamento) e l’isolamento.
Sono presenti in letteratura diverse categorie di “disturbo dell’attaccamento”:
1. Distorsioni della base sicura
2. Disturbi di assenza di attaccamento (bambino non mostra una preferenza per un adulto che lo
accudisce)
3. Disturbo reattivo dell’attaccamento (DSM IV)
4. Disturbo da attaccamento interrotto (rottura dell’attaccamento. Afflizione, lutto, cordoglio)
1. Distorsione della base sicura
disturbo dell’attaccamento con comportamenti che mettono in pericolo il bambino (il
comportamento di esplorazione non è controbilanciato dalla ricerca di vicinanza della figura di
attaccamento. Bambino può mostrare una serie di comportamenti pericolosi in presenza del
caregiver – esempio: buttarsi nel traffico)
disturbo dell’attaccamento con esplorazione inibita e ricorso eccessivo alla vicinanza
disturbo dell’attaccamento con vigilanza e compiacenza eccessive
Disturbo dell’attaccamento con inversione di ruolo (eccessiva preoccupazione per il benessere
emotivo del caregiver)
2. Disturbi da assenza di attaccamento
assenza di attaccamento con ritiro emozionale (grande inibizione dei comportamenti di ricerca di
conforto, manifestazione degli affetti, ricerca di aiuto, cooperazione)
assenza di attaccamento con socievolezza indiscriminata (bambino cerca interazioni sociali con
persone estranee senza la discriminazione e la reticenza proprie dei bambini in questa fascia d’età)
3. Disturbo reattivo dell’attaccamento
di tipo inibito (ritiro)
di tipo disinibito (eccessiva socievolezza)
Il decorso del disturbo varia in funzione dei fattori individuali del bambino e delle importanti influenze dei
contesti e delle risorse che si possono attivare.
Si possono osservare, negli anni successivi, problemi con i pari, iperattività e comportamenti distruttivi.
Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (DDAI) è uno dei più comuni disturbi
neurocomportamentali e si manifesta, nella prima infanzia, principalmente con due classi di sintomi: un
evidente livello di disattenzione e una serie di comportamenti che denotano iperattività e impulsività.
Questo disturbo è considerato ora una condizione eterogenea potenzialmente cronica, che presenta
sintomi rilevanti e problematiche associate che vanno a colpire diversi aspetti funzionali della vita di tutti i
giorni.
Sintomi del disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività
I sintomi relativi alla disattenzione si riscontrano soprattutto in bambini che, rispetto ai propri coetanei,
presentano un’evidente difficoltà a rimanere attenti o a lavorare su uno stesso compito per un periodo di
tempo sufficientemente prolungato.
Solitamente questi soggetti non riescono a seguire le istruzioni fornite, sono disorganizzati e sbadati nello
svolgimento delle loro attività, hanno difficoltà nel mantenere la concentrazione, si fanno distrarre molto
facilmente dai compagni o da rumori occasionali e raramente riescono a completare un compito in modo
ordinato.
Quando sono in classe sembrano disorientati e, spesso, passano da un’attività all’altra senza averne
completata alcuna, si guardano continuamente attorno, soprattutto durante lo svolgimento di compiti, ma
anche durante la proiezione della trasmissione tv preferita, ciò accade però soprattutto nei momenti in cui
tali attività risultano noiose e ripetitive.
I bambini con iperattività – impulsività giocano in modo rumoroso, parlano eccessivamente con scarso
controllo dell’intensità della voce, interrompono persone che conversano o che stanno svolgendo delle
attività, senza essere in grado di aspettare il momento opportuno per intervenire; i genitori e gli insegnanti
li descrivono sempre in movimento e sul punto di partire, incapaci di attendere una scadenza o il proprio
turno.
Inoltre sembrano non sufficientemente orientati al compito e faticano a pianificare l’esecuzione delle
attività che vengono loro assegnate.
Le manifestazioni di iperattività e impulsività sembrano essere attribuibili ad una difficoltà di inibizione dei
comportamenti inappropriati che i bambini con disturbo dell’attenzione esprimono con agitazione,
difficoltà a rimanere fermi, seduti o composti quando viene loro richiesto.
Studi epidemiologici indicano che il 3-7% dei bambini in età scolare e il 4-5% degli adolescenti e dei giovani
adulti, rientra nei criteri del disturbo da deficit di attenzione stabiliti nel DSM-IV-TR con una proporzione
che va da 2:1 a 9:1 tra maschi e femmine.
I soggetti affetti da DDAI presentano delle difficoltà nei seguenti campi relativi all’attenzione e alle funzioni
neuropsicologiche: soluzione dei problemi, abilità di pianificazione, grado di allerta e di attenzione,
flessibilità cognitiva, attenzione mantenuta, inibizione delle risposte automatiche, memoria di lavoro non
verbale.
I risultati di recenti studi neurofisiologici sostengono l’ipotesi che il DDAI comporta un’ipofunzionamento
dei sistemi catecolaminergici e in particolar modo di quelli che agiscono nella corteccia prefrontale,
evidenziando quindi l’importanza del ruolo che i circuiti dopaminergici fronto-striati assumono nella
patofisiologia del disturbo.
Nonostante la visione precedentemente prevalente che descriveva il DDAI come un disordine limitato alla
prepubertà, studi prospettici condotti su campioni clinici hanno dimostrato che il DDAI deve essere
considerato un disturbo cronico.
Tale disordine, se non trattato, espone al rischio di sviluppo successivo (adolescenza, adulti) di condotte
antisociali, abuso di sostanze, difficoltà attentive, familiari, interpersonali ed educative.
E’ ormai chiaro che due terzi dei bambini con DDAI continuano a mostrare segni di tale patologia nelle età
successive, tali da rendere cronico tale disturbo.
Trattamento psicoterapeutico del disturbo da Stress Post Traumatico
I trattamenti cognitivo-comportamentali, unitamente alla somministrazione di stimolanti, sembrano
essere il trattamento elettivo. Tuttavia, rimangono ancora numerosi dubbi circa gli effetti degli
psicostimolanti sui soggetti con difficoltà di attenzione e iperattività; soprattutto è difficile comprendere e
giustificare il 20%-30% di persone che non rispondono positivamente al trattamento farmacologico: per
spiegare questi dati trova sempre più considerazione l’ipotesi che esistano sottotipi di DDAI, diversi da
quelli riportati nel DSM-IV, che reagiscono in modo differente agli psicostimolanti. A ciò bisogna aggiungere
che numerosi sono anche gli effetti collaterali, quali insonnia, anoressia, cefalea, mal di stomaco e più in
generale disturbi gastrointestinali conseguenti all’assunzione (prolungata o meno) del farmaco.
A partire dagli anni ’70, con la diffusione di numerose pubblicazioni, sono comparsi diversi training
cognitivo-comportamentali per i bambini con DDAI.
Il trattamento cognitivo-comportamentale va indirizzato simultaneamente verso tutte le aree che
risultano essere compromesse e riguardare pertanto le varie dimensioni implicate nel disturbo (cognitiva,
emotivo-affettiva, comportamentale, relazionale).
Le procedure di intervento più comuni tengono conto delle difficoltà del bambino nel valutare
attentamente quali siano i passi necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi e nel controllare la
qualità del proprio lavoro durante la sua esecuzione. Per tale ragione queste procedure propongono, oltre
alla gestione delle contingenze (rinforzi e punizioni), prevista anche nei programmi di natura squisitamente
comportamentista, l’insegnamento di varie tecniche tra cui le autoistruzioni verbali, il problem-solving e lo
stress “inoculation training” (consapevolezza e controllo delle emozioni in situazioni stressanti).
Di frequente, inoltre, i genitori che possiedono poche strategie di gestione del comportamento del figlio
misinterpretano i comportamenti del bambino, hanno nei loro confronti aspettative negative e valutano i
comportamenti problematici come intenzionali. A ciò si aggiunge la frustrazione con cui vivono la
sensazione di perdita di controllo del ruolo del genitoriale.
Per tale ragione, uno degli scopi prioritari dell’intervento è quello di modificare la rappresentazione
mentale che hanno del bambino, aiutandoli a focalizzare sui propri sentimenti, atteggiamenti e risposte
comportamentali.
Tra gli scopi dell’intervento con i genitori è possibile indicare:
L’individuazione degli stati mentali rispetto all’attaccamento e i corrispondenti pattern
comportamentali di accudimento
L’accresceimento della capacità di negoziare in presenza di conflitti e controversie
La costruzione di una comunicazione efficace
La pianificazione di interventi comuni
La promozione di regole educative attraverso la contrattazione delle contingenze e del rinforzo.
Disturbo della Fobia Scolare
Quando si parla di rifiuto scolare si fa riferimento ad un disturbo in cui il livello di ansia e di paura ad
andare e restare a scuola sono tali da compromettere in modo significativo una regolare frequenza
scolastica e causare sequele a breve e lungo termine.
Le conseguenze possono riguardare lo sviluppo emotivo, sociale, le acquisizioni scolastiche, difficoltà nei
rapporti con la famiglia. In seguito si possono avere difficoltà lavorative e può aumentare il rischio di
un’importante compromissione della salute mentale della persona.
Il rifiuto scolare non va confuso con l’assenza ingiustificata da scuola, quest’ultimo è un comportamento in
cui è assente l’ansia e la paura eccessiva di frequentare la scuola e spesso è associato a comportamenti
antisociali e alla mancanza di interesse per la propria formazione scolastica. Il ragazzo che soffre di rifiuto
scolastico può assentarsi dalla scuola fin dall’inizio della giornata, o può recarsi a scuola e poi, dopo poche
ore, chiedere di tornare a casa.
Durante le ore scolastiche il bambino resta a casa, un ambiente fidato e sicuro, può dedicarsi in modo
sereno ad altre attività tra cui svolgere i compiti.
Tale disturbo riguarda l’1-5% dei ragazzi in età scolare senza differenze di genere, dai dati presenti in
letteratura sembra più frequente in alcuni delicati cambiamenti evolutivi quali l’inserimento nella scuola
elementare (5-6 anni) e il passaggio alle scuole medie (10-11 anni).
Il disturbo si caratterizza per i seguenti comportamenti problematici e sintomi somatici:
elevata reazione di ansia nel momento in cui esce da casa o giunge davanti alla scuola, al punto da
presentare sintomi da panico;
manifestazione di un ampia serie di sintomi somatici (vertigini, mal di testa, tremori, palpitazioni,
dolori al torace, dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, dolori alle spalle, dolori agli arti);
il livello di angoscia può essere elevato fin dalla sera prima e il bambino può riposare male, il sonno
può essere disturbato da incubi o risvegli notturni
Altri disturbi che possono associarsi al rifiuto scolastico sono l’ansia da separazione, l’ansia generalizzata, la
fobia sociale, la fobia specifica, gli attacchi di panico, il disturbo post traumatico da stress, la depressione, il
disturbo della condotta, il disturbo oppositivo-provocatorio, il disturbo da deficit di attenzione-iperattività, i
disturbi specifici dell’apprendimento.
Tra i fattori che maggiormente incidono nel predisporre e scatenare un rifiuto della scuola troviamo quelli
ambientali. I sintomi possono iniziare in seguito ad eventi di vita stressanti che si sono verificati a casa o a
scuola, tra cui la propria malattia o di un membro della famiglia, la separazione tra i genitori, la separazione
transitoria da uno dei genitori, relazioni conflittuali nella famiglia, un legame disadattivo con uno dei
genitori, problemi con il gruppo dei pari o con un insegnante, il ritorno a scuola dopo una lunga
interruzione o vacanza.
I dati disponibili in letteratura rispetto a fattori biologici, derivati dagli studi sulla famiglia e i gemelli,
suggeriscono che ci potrebbe essere una vulnerabilità biologica per lo sviluppo di problemi emotivi, tra cui il
rifiuto scolastico. I fattori scatenanti possono essere molteplici ma ciò che maggiormente interessa dal
punto di vista terapeutico è correggere i fattori di mantenimento del disturbo.
E’ chiaro che attraverso i comportamenti di evitamento o di fuga da eventi spiacevoli si ottiene una
riduzione dell’ansia, a questo si aggiunge il rinforzo positivo che il bambino riceve nello stare a casa. In
letteratura molta attenzione viene data al profilo di funzionamento del bambino per le implicazioni cliniche
e terapeutiche che hanno le variabili di mantenimento.
Secondo “il modello funzionale” il rifiuto di andare a scuola assume appunto un significato funzionale per il
bambino.
A seconda dello scopo perseguito,sono quattro profili funzionali che si possono rilevare:
i bambini che evitano oggetti o situazioni che provocano ansia generale o un senso generale di
affettività negativa;
i bambini che non vanno a scuola per fuggire da situazioni sociali avversive o situazioni di
valutazione;
i bambini che rifiutano la scuola per ottenere attenzione dalle figure significative;
infine i bambini che ricercano rinforzi positivi tangibili fuori dalla scuola.
Trattamento psicoterapeutico
La terapia cognitiva-comportamentale si è dimostrata molto efficace per i disturbi di ansia, numerosi sono
i dati disponibili in letteratura rispetto a molteplici studi controllati. Nello specifico il trattamento cognitivo-
comportamentale da utilizzare con bambini che rifiutano la scuola si basa sui fattori di mantenimento che
emergono con l’analisi funzionale. In generale l’intervento è individualizzato e prevede vari step e tecniche,
in questo percorso graduato sono coinvolti i genitori e la scuola.
All’inizio è utile un apporto psicoeducativo per comprendere la natura e il processo dell’ansia, per poi
identificare i pensieri disfunzionali (rispetto a sé, gli eventi, le attività, la separazione dalla figura di
attaccamento) verso cui promuovere una ristrutturazione cognitiva. Il ritorno a scuola può essere graduale
e concordato, nei tempi e nelle modalità, con gli insegnanti e il personale scolastico. Il protocollo di
intervento cognitivo-comportamentale basato sull’analisi funzionale è stato utilizzato in molti lavori, i cui
risultati hanno mostrato l’utilità di tale trattamento, vista l’eterogeneità di problemi che possono causare il
disturbo. L’efficacia della terapia cognitiva-comportamentale è stata dimostrata in termini di riduzione
dell’ansia, aumento del senso di autoefficacia personale e ripresa della frequenza scolastica.
Cos’è “l’umore”
Il termine oggi viene utilizzato nel linguaggio comune per indicare una disposizione d’animo o un
atteggiamento interiore ma può essere interessante ricordare come quest’impostazione derivi ancora
dall’antica teoria di Galeno che ipotizzava quanto il temperamento (inteso come l’insieme delle
caratteristiche specifiche d’una persona) potesse dipendere da un miscuglio d’umori. Proponeva
conseguentemente quattro temperamenti: collerico, sanguigno, flemmatico e melanconico. La sua
speculazione si basava sull’impostazione ippocratica dei quattro umori fondamentali: sangue dal cuore,
flemma dal cervello, bile bianca dal fegato, bile nera dalla milza.
Oggi, il livello d’approfondimento sia medico che psicologico impone delle declinazioni più precise, almeno
del punto di vista diagnostico.
Per comprendere il significato del concetto “umore” è utile partire da alcune constatazioni di base. In
medicina e in psicologia, l’umore è inteso come lo stato emozionale interno d’un individuo, ossia l’insieme
delle disposizioni affettive e istintive che determinano il tono prevalente dell’attività psichica. Questo stato,
peraltro caratterizzato da dinamismo, è in grado di condizionare la qualità e l’intensità dei vissuti
dell’individuo, come anche le funzioni cognitive, comportamentali e volitive.
Deve essere sempre ricordato che l’umore d’un soggetto, anche in condizioni di sufficiente benessere
complessivo (soddisfazione soggettiva e qualità della vita), presenta delle oscillazioni fisiologiche che
dipendono da parametri psicobiologici, da stimoli provenienti dal mondo esterno o da contenuti del mondo
interno.
Il tono dell’umore presenta ovviamente variazioni sia quantitative, sia qualitative. Non è possibile trattare il
concetto d’umore senza ricordare che è strettamente collegato a quello di “emozioni”, le quali, in
psicologia, vengono descritte secondo tre focalizzazioni: quella soggettiva, quella comportamentale e
quella fisiologica. Deve essere questo punto evidenziato che mentre la terza focalizzazione permette delle
misurazioni oggettive, le prime due richiedono il contributo attribuzionale da parte del soggetto al centro
delle riflessioni.
Cosa sono i “disturbi dell’umore”?
Sono delle alterazioni del tono affettivo e del comportamento interpretabili come una risposta esagerata
alle emozioni che si affrontano quotidianamente.
In ambito psicologico clinico, ossia quello dedicato non solo all’osservazione dei fenomeni ma soprattutto
al loro trattamento in chiave terapeutica, il termine umore è spesso alternato o sostituito con quello di
“Timia”. In questo caso viene maggiormente dato l’accento allo stato globale dell’umore, soprattutto in
chiave psicopatologica, esplorandolo e valutandolo secondo una bipolarità che scorre dalla timia depressa
(definita anche depressione dolorosa) all’agitazione maniacale (euforia espansiva).
In altri termini, nel momento in cui le condizioni d’una persona si presentano rilevantemente alterate si
può presentare delle deflessioni (come nelle condizioni depressive) o delle esaltazioni (come nella mania e
nell’ipomania).
A livello di primo inquadramento diagnostico sono distinti gli “episodi d’alterazione dell’umore” (Episodio
Depressivo Maggiore, Episodio Maniacale, Episodio Misto ed Episodio Ipomaniacale), dai “disturbi
dell’umore” (Disturbi Depressivi, Disturbi Bipolari, Disturbo dell’Umore Dovuto a Condizione Medica
Generale e Disturbo dell’Umore Indotto da Sostanze).
Epidemiologia dei disturbi dell’umore
I disturbi dell’umore possono assumere forme molteplici e, considerando la presenza di rilevanti fattori
endogeni e una mancanza di serie storiche incisive, un’analisi epidemiologica ortodossa è difficile.
Sono però evidenziabili alcune informazioni chiave. La depressione è uno dei più comuni disturbi psichici
(circa 10% della popolazione adulta ha sofferto d’uno o più episodi di depressione maggiore nel corso della
vita). Numerosi studi segnalano quanto il rischio di malattia sia più elevato nei familiari di pazienti depressi
(1,5-3 volte in più). La distribuzione nei due sessi è condizionata dall’età: negli adulti e negli adolescenti il
rapporto maschi:femmine è di 1:2; nei bambini il rapporto maschi:femmine è di 2:1
Se si considera il momento dell’esordio dei disturbi si nota che circa il 50% dei pazienti manifesta un
disturbo depressivo prima di 40 anni, senza un definito disturbo di personalità premorboso.
Eziologia dei disturbi dell’umore
L’eziologia è una branca disciplinare che cerca di costruire modelli circa i fattori che causano la formazione
d’una malattia.
La ricerca medica, superando la visione psichiatrica classica, ha per ora evidenziato almeno tre aree di
riflessione:
VISIONE MEDICO-BIOLOGICA
Genetica
Per una parte dei disturbi sembra esserci una base genetica: il rischio di malattia è più elevato nei famigliari
di pazienti depressi.
A fronte di marcata complessità ed eterogeneità del fenomeno, si afferma che la componente genetica
non è dunque da ritenersi determinante.
Sistema neuroendocrino
Sono stati documentati:
-
Iperattività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene
-
Ipoattività dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide
-
Ipoattività dell’asse ipotalamo-ipofisi
Sistema immunitario
In psiconeuroendocrinoimmunologia, secondo il modello olistico, si evidenzia l’esistenza di rapporti fra vita
emotiva, sistemi neurotrasmettitoriali, sistema endocrino e immunità.
Nei pazienti depressi è accertata la diminuzione dell’efficacia della risposta immunitaria.
Questi richiami confermano le relazioni corpo/mente ma non sono sufficientemente declinate dal punto di
vista psicologico.
Questo secondo campo di studio ha evidenziato che allo stato attuale è irrealistico cercare di isolare un
singolo tratto o singolo gruppo di tratti di personalità predisponenti. Altrettanto improponibile è anche
l’evidenziare un unico meccanismo psicologico esplicativo.
Di certo è osservabile una ricca variètà di fattori psicologici che possono essere identificati come alla base
dei disturbi dell’umore. In particolare, da qualche tempo si è evidenziato com’esistano alcuni tratti definibili
come “Personalità premorbosa” in correlazione potenziale con il disturbo depressivo. Questa condizione è
caratterizzata da:
-
tendenza ossessiva, perfezionismo
-
ambizione e tendenza a vivere la realtà competitivamente in modo quasi compulsivo
tratti di personalità dipendente e alla ricerca continua d’approvazione sociale, gratificazioni esterne,
conferme
-
personalità orale
-
personalità istrionica
-
bassi livelli di autostima e tendenza all’autocritica
Esistono poi delle visioni psicologiche specifiche, direttamente derivate dalla pratica psicoterapeutica e
socioriabilitativa:
VISIONE PSICOLOGICO CLINICA
Teoria psicodinamica
Sono ipotizzate delle analogie tra lutto e depressione (Abraham e Freud)
Vissuti di perdita (sia concrete che simboliche) e di colpa possono facilitare esperienze depressive
Prospettiva sistemico relazionale
Meccanismi equilibratori di tipo micro e macrosociale possono influenzare la regolazione affettiva e quindi
umorale
Spesso il soggetto depresso viene portato dalle dinamiche familiari ad assumere ruoli di vittima sacrificale
e di capro espiatorio.
Approccio psicosociale
La relazione madre/bambino è riconosciuta come fondamentale per lo sviluppo di un senso di sicurezza e
fiducia, propedeutico ad un orientamento positivo nei confronti delle esperienze di vita.
In una logica multidimensionale è certo :
il ruolo degli eventi stressanti recenti sull’insorgenza della depressione (eventi che ruotano intorno
all’esperienza della perdita: morte del coniuge, separazione, divorzio)
l’effetto potenzialmente ricostruttivo dei fresh start events, eventi molto positivi ed imprevisti che
riaccendono l’interesse per il futuro, incidendo in modo rapido verso una risoluzione della condizione
depressiva.
Al termine di questa breve carrellata dovrebbe apparire evidente quanto, pur in presenza d’ipotesi
eziologiche ben strutturate, la ricerca scientifica deve ancora riuscire a comporre un quadro unitario
sufficientemente completo.
Informazioni di base su diagnosi, prognosi e terapie
Diagnosi e prognosi
La diagnosi medica è di solito irrinunciabile, anche allo scopo di escludere con certezza la presenza d’una
depressione secondaria legata a cause biologiche.
La diagnosi psicologica può basarsi sul colloquio clinico come anche sull’utilizzo di scale questionari e test
proiettivi,
Difficile semplificare i decorsi. In maniera del tutto indicativa è possibile segnalare che normalmente un
episodio di depressione senza trattamento dura dai 6 ai 13 mesi, trattato dura 3 mesi. Se la terapia è
interrotta prima dei 3 mesi spesso riprendono i sintomi depressivi.
In molte situazioni, anche supportate da trattamenti clinici, è elevata la possibilità di ricadute dopo un
primo episodio, anche con progressiva riduzione degli intervalli liberi. Il consumo d’alcool e di droghe è
possibile fattore di rischio circa la ricorrenza di successivi episodi depressivi.
Sono frequenti le complicanze, talvolta anche con rischio suicidario (soprattutto in compresenza di attacchi
di panico, uso di sostanze, e di sintomi quali deliri, allucinazioni, insonnia, elevati livelli di ansia).
Non deve poi essere dimenticato che il quadro clinico può assumere almeno quattro decise specificità in
base al ciclo di vita del soggetto: bambino, adolescente, adulto, anziano.
Terapie
La terapia dei disturbi deve discendere da una prima analisi della rilevanza del fenomeno, anche dal punto
di vista dell’adattamento sociale. Un approfondimento medico può evidenziare come utili trattamenti
basati sulla farmacologia antidepressiva (antidepressivi triciclici o atipici, stabilizzanti dell’umore)
Dal punto di vista dell’intervento psicologico, il counseling può essere opportuno nelle situazioni meno
gravi, ma nella maggioranza delle situazioni può essere necessario un orientamento di tipo
psicoterapeutico, spesso combinato con un trattamento farmacologico.
Non è disponibile uno studio comparato decisivo sull’efficacia dei diversi interventi psicoterapeutici. Gli
approcci che maggiormente rivendicano specificità nell’ambito di questi interventi sono soprattutto la
terapia cognitivo-comportamentale, quella psicodinamica breve e quella interpersonale. Altre voci
richiamano l’utilità d’un intervento integrato che consideri in maniera globale i sette livelli: fisiologico,
emozionale, nominativo, normativo, razionale, teorico, transpersonale.
Ansia: i principali disturbi d'ansia
L'ansia, presa a se', e' un fenomeno del tutto normale in quanto e' un'emozione che prepara ed attiva
l'organismo in situazioni che potrebbero essere pericolose.
Diviene invece un disturbo emotivo spiacevole quando lo stato di allarme e paura e' "esagerato" rispetto ai
reali pericoli o se i pericoli non ci sono affatto.
In questo caso l'ansia non e' adattiva, ma diventa un problema che puo' rendere la persona incapace di
controllare le proprie emozioni e di affrontare anche le situazioni piu' semplici.
Il disturbo d'ansia puo' essere un disagio psicologico a se' stante oppure un sintomo di altri disturbi
psicologici (ad es. depressione).
Puo' manifestarsi a livello emotivo come attesa con apprensione, preoccupazione ed insicurezza,
anticipazione di eventi negativi, e a livello somatico con aumento del ritmo cardiaco, sudorazione, spasmi
muscolari, pallore, tremori, vertigini, e nei casi piu' estremi reazioni di fuga, immobilizzazione, sensazione di
soffocamento o di costrizione toracica.
I disturbi d'ansia sono tanti, ne elenchiamo alcuni:
Attacchi di panico: episodi brevi e improvvisi di ansia e terrore caratterizzati da sensazione di
soffocamento, dolore al petto e paura di morire.
Fobia: paura estrema e non razionale nei confronti di situazioni od oggetti che non sono in realta' pericolosi
per la persona.
Esistono diversi tipi di fobia, i principali sono: Agorafobia; Fobia sociale; Claustrofobia; Ipocondria;
Araconofobia; Ornitofobia; Acrofobia; ...
Disturbo ossessivo-compulsivo: caratterizzato da idee fisse ed irrazionali e da comportamenti ripetitivi o
azioni mentali con lo scopo di prevenire o ridurre uno stato d'ansia.
Disturbo acuto da stress: sensazioni di ansia e sintomi dissociativi (per meno di un mese) dopo che la
persona ha vissuto un evento traumatico (aggressione, rapimento, violenza, disastro, morte di un familiare
...).
Disturbo post-traumatico da stress: sensazioni di paura ed orrore persistenti nel tempo (per piu' di un
mese) dopo che la persona ha vissuto un evento traumatico (aggressione, rapimento, violenza, disastro,
morte di un familiare ...).
Disturbo d'ansia generalizzata: stato permanente di allarme senza che vi sia un reale pericolo e paura che
succedano cose negative.
I Disturbi dei comportamenti alimentari
I disturbi alimentari sono comportamenti inadeguati che riguardano l'assunzione del cibo.
Un normale atteggiamento e' costituito dal mangiare per soddisfare le proprie esigenze nutrizionali,
attraverso la soddisfazione dello stimolo della fame.
Le persone affette da disturbo alimentare, al contrario, possono continuare a mangiare anche se si sentono
sazie, o smettere di mangiare nonostante siano sottonutrite.
Spesso non avvertono questi normali stimoli (fame e sazieta'), e nel caso in cui li avvertano, sentono la
necessita' di soddisfare altri bisogni attraverso il loro comportamento alimentare.
Principali disturbi del comportamento alimentare
I principali disturbi del comportamento alimentare sono:
anoressia: la persona tende a mangiare poco o nulla, dicendosi sazia e cercando di dimagrire di molto oltre
la soglia della normalita'.
bulimia: la persona mangia grosse quantita' di cibo, per poi indurre il vomito.
obesità: una persona viene definita obesa quando il tessuto adiposo e' in eccesso e diviene causa di
malattie, oppure quando il sovrappeso aumenta la possibilita' dell'insorgere di malattie o ne aggrava la
situazione.
Disturbi di Personalità: che cosa sono
Come personalità, detto in maniera breve e forse semplicistica, si intende l'insieme delle caratteristiche e
dei modi con cui la persona interagisce con gli altri, affronta le cose, pensa e vede il mondo e ciò che accade
attorno a se'.
Ogni persona ha particolari caratteristiche (tratti di personalità), e questi tratti si adattano flessibilmente
alle diverse situazioni modellandosi nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni, a seconda delle circostanze.
La persona con disturbi di personalità invece, presenta alcuni tratti in modo particolarmente accentuato e
rigido anche quando le situazioni o le circostanze richiederebbero atteggiamenti diversi o più opportuni.
Per esempio, una persona con disturbo istrionico di personalità, ha costantemente bisogno di attenzione
ed assume un atteggiamento sempre seduttivo e provocante anche in momenti inopportuni, senza rendersi
conto che in molti casi questo comportamento potrebbe essere imbarazzante per chi gli stà accanto.
Coloro che presentano questi disturbi, non si rendono conto di quanto e' particolare il loro modo di essere,
e mentre gli altri li possono vedere e categorizzare come "strani", "paranoici", "esaltati", a seconda del
disturbo, essi si vedono perfettamente normali, perche' per loro quello e' il normale modo di agire.
Molte persone possono essere definite "particolari" per il loro carattere, a volte magari esuberante ed
eccentrico oppure puntiglioso, o aggressivo, ma viene definito disturbo di personalità solo se quando e'
persistente e crea vere difficoltà sia per la persona stessa che per chi la circonda.
Disturbi di personalità - caratteristica principale: comportamento bizzarro
Disturbo paranoide di personalità: chi soffre di questo disturbo pensa che gli altri tramino alle sue spalle
per ingannarlo. E' sospettoso e convinto che vi siano complotti contro di lui anche se non c'e' nessuna
prova a riguardo.
Disturbo schizoide di personalità: chi soffre di questo disturbo e' una persona solitaria, a cui sembra non
importare delle relazioni con gli altri. Raramente prova piacere, ha poche espressioni ed appare senza
emozioni.
Disturbo schizotipico di personalità: chi soffre di questo disturbo e' una persona eccentrica e sente di
avere poteri extrasensoriali o di essere particolarmente intuitiva.
Disturbi di personalità - caratteristica principale: emotività
Disturbo borderline di personalità: chi soffre di questo disturbo e' molto impulsivo ed instabile sia nelle
relazioni con gli altri, sia nell'immagine che ha di se'. Cambia spesso opinione ed obiettivi.
Disturbo istrionico di personalità: chi soffre di questo disturbo e' una persona seduttiva, teatrale, sempre
alla ricerca di attenzioni. Spesso cerca di attrarre tramite l'aspetto fisico.
Disturbo narcisistico di personalità: chi soffre di questo disturbo si sente grandioso, perfetto, e ricerca
dagli altri lodi ed ammirazioni, come se gli fossero dovuti data la sua superiorità.
Disturbo antisociale di personalità: chi soffre di questo disturbo e' una persona manipolativa, che viola i
diritti degli altri senza provare sensi di colpa. E' spesso una persona irresponsabile e violenta.
Disturbi di personalità - caratteristica principale: ansia
Disturbo evitante di personalità: chi soffre di questo disturbo si sente timido, inadeguato. E' ipersensibile
alle critiche e per questo evita di avere rapporti sociali.
Disturbo dipendente di personalità: chi soffre di questo disturbo ha grosse difficoltà a prendere decisioni e
sente il forte bisogno di essere accudito.
Disturbo ossessivo compulsivo di personalità: chi soffre di questo disturbo e' un perfezionista, sente il
bisogno di controllare tutto e di essere estremamente preciso ed ordinato.
Disturbi Psicologici: il disturbo del controllo degli impulsi
La principale caratteristica dei disturbi del controllo degli impulsi e' la forte tentazione, il desiderio
incontrollabile di compiere un'azione pericolosa per se stessi o per qualcun altro.
Questa e' la definizione di impulsivita', durante la quale la persona sente crescere dentro di se' una
tensione che trova sfogo solamente dopo aver compiuto l'azione, allora si calma e contemporaneamente
puo' provare senso di colpa e rimorso per l'azione compiuta.
Principali disturbi del controllo degli impulsi:
GAP - Gioco d'azzardo patologico: il comportamento di gioco viene definito patologico quando diventa
persistente, e la persona non riesce piu' a controllare l'impulso a giocare.
Disturbo esplosivo intermittente: incapacita' di resistere agli impulsi aggressivi.
La persona compie gravi azioni aggressive in una situazione che non giustifica tali azioni.
Cleptomania: impulso incontenibile ed irresistibile a rubare oggetti senza un bisogno/motivo preciso.
Solitamente questi oggetti non hanno valore economico.
Piromania: episodi ripetuti di appiccamento volontario del fuoco.
Questi episodi avvengono sotto un impulso irrefrenabile a cui la persona non riesce a resistere.
Tricotillomania: abitudine incontrollabile di tirare fino a spezzare peli e capelli, provocandone una notevole
perdita.
I disturbi psicotici - Le varie forme di psicosi
I disturbi psicotici (psicosi), hanno come caratteristica predominante i sintomi psicotici, che sono:
deliri, allucinazioni, linguaggio o comportamento disorganizzato o catatonico (la persona puo' rimanere
immobile per molto tempo, e poi avere improvvisi scatti di agitazione che sembrano essere senza motivo,
puo' fare resistenza senza scopi precisi, rimanere muta oppure nella stessa posizione per piu' tempo, fare lo
stesso movimento continuamente, imitare quello degli altri o ripetere macchinosamente le parole sentite
da altre persone).
I disturbi psicotici comportano una perdita dei confini dell'io (incapacita' di distinguere tra cio' che e' dentro
e cio' che e' fuori) e la capacita' di giudizio della realta' e' compromessa.
C'e' quindi un'alterazione tra il mondo interno della persona ed il mondo esterno, che non viene visto come
in realta' e'.
Principali Disturbi Psicotici:
Schizofrenia: la persona e' incapace di riconoscere il reale da quello che e' solo immaginato.
La patologia influisce quindi sulla capacita' di comunicare, pensare correttamente e gestire le emozioni.
Disturbo delirante: uno o piu' deliri non bizzarri che durano almeno un mese.
Solitamente nel disturbo non compaiono allucinazioni visive o auditive, ma possono comparire quelle tattili
od olfattive se riguardano il tema del delirio.
Disturbo schizofreniforme: ha gli stessi sintomi della schizofrenia ma puo' non essere presente un
deterioramento del funzionamento sociale e lavorativo e la durata del disturbo e' inferiore rispetto alla
schizofrenia (per diagnosticare la schizofrenia, essa deve durare da almeno 6 mesi, questo disturbo dura
invece da 1 a 6 mesi).
Disturbo schizoaffettivo: in questo disturbo sono presenti i sintomi della fase attiva della schizofrenia
insieme ad un episodio di alterazione dell'umore.
Questi devono essere preceduti o seguiti da 2 settimane almeno di deliri o allucinazioni senza pero' sintomi
della sfera affettiva.
Disturbo psicotico breve: disturbo psicotico che dura piu' di un giorno ma svanisce entro 1 mese.
Disturbo psicotico condiviso: il disturbo psicotico si dice "condiviso" quando avviene ad una persona che e'
influenzata da un altra che ha un delirio simile.
Disturbi somatoformi: ipocondria, somatizzazione, conversione ...
I disturbi somatoformi riguardano problemi fisici (come la malattia di un organo o un malessere comunque
fisico) senza che vi sia pero' una causa organica.
I disturbi somatoformi sono quindi di origine psicologica ed e' per questo che la diagnosi viene fatta molto
tempo dopo dalla comparsa, dopo cioe' che si sono scartate tutte le cause mediche.
I disturbi somatoformi si suddividono in:
Disturbo da dismorfismo corporeo: e' la preoccupazione eccessiva per una parte del proprio corpo senza
che in realta' ci sia davvero un difetto.
La persona si focalizza su una parte di se che reputa non accettabile, brutta, e da cambiare.
Ipocondria: e' la convinzione di essere gravemente malati nonostante che dagli accertamenti medici non
risulti nessuna malattia.
La persona se ne convince interpretando i sintomi in maniera errata, e continua a pensarlo anche di fronte
all'evidenza che non si tratta di malattia.
Disturbo Algico: Detto anche "dolore psicogeno", la persona con disturbo algico puo' avvertire dolore in
piu' parti del corpo, schiena, addome, testa e collo sono le parti del corpo piu' comuni dove la persona
avverte dolore.
Il disturbo puo' essere acuto o cronico a seconda della durata.
Disturbo di conversione: Il disturbo da conversione riguarda le funzioni motorie volontarie oppure sensitive
e non sono spiegati da condizioni mediche.
La persona con questo disturbo presenta sintomi pseudo-neurologici come alterazione dell'equilibrio,
paralisi, difficolta' a deglutire, sensazione di nodo alla gola e incapacita' di parlare, incapacita' di urinare.
A livello sensitivo possono esserci sordita', cecita' ed allucinazioni, perdita della sensibilita' tattile e del
senso del dolore, insensibilita' alla temperatura.
Nei casi piu' gravi possono esservi convulsioni o attacchi simili all'epilessia.
Disturbo da somatizzazione: La persona con disturbo da somatizzazione (isteria, come veniva definito una
volta), avverte dolori fisici in piu' parti del corpo e per molto tempo senza che in realta' ci siano cause
organiche.
Il disturbo da somatizzazione presenta anche sintomi pseudo-neurologici come alterazione dell'equilibrio,
paralisi, difficolta' a deglutire ecc...
Pseudociesi: Chiamata anche gravidanza isterica, si parla di pseudociesi quando una donna presenta i
sintomi fisici e psicologici della gravidanza, senza che questa ci sia.
I sintomi piu' comuni, oltre alla ferma convinzione di essere incinta sono: irregolarita' mestruali – aumento
del peso - sensazione che il feto si muova – ingrossamento e secrezione del seno.
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
LE TAPPE DELLO SVILUPPO EVOLUTIVO
CAP I
Dal determinismo alla probabilità
I modelli
La psicologia è stata a lungo dominata da modelli di spiegazione di tipo deterministico ed
unicausale. Essi, per quanto messi in discussione ormai da tempo a livello teorico, sono entrati
talmente nel nostro quotidiano modo di pensare
e di spiegare il comportamento, da
continuare ad essere, più o meno consapevolmente, utilizzati.
I modelli deterministici sembrano infatti offrire una risposta certa ed esauriente a domande di
grande rilevanza, non solo teorica, ma anche pratica: perche una persona si comporta in un
certo modo? Quale sarà lo sviluppo di un bambino a partire da certe esperienze? Che peso
hanno i primi anni di vita sullo sviluppo futuro?
La risposta dei modelli deterministici e unicausali, per quanto confortante e consolatoria, è
però del tutto illusoria ed infondata, a causa della sua estrema semplificazione. Essa è
incapace, nella sua predittività meccanica, di comprendere le vicissitudini del comportamento
umano ed ancora meno è capace di spiegare la sua evoluzione nel tempo. Per queste ragioni, i
modelli unicausali e deterministici sono non solo teoricamente errati, ma potenzialmente
dannosi. Essi, possono infatti dare luogo a giudizi e scelte assoluti, dominati da una logica
meccanicistica che non lascia spazio alla modificazione e al cambiamento. Notiamo, anzitutto,
che il determinismo e la unicausalità sono inscindibilmente connessi. Infatti, il determinismo
ritiene di poter spiegare in modo certo e prevedibile il comportamento umano, e nel far ciò è
costretto a ricorrere ad una o pochissime cause, che diventano la sola spiegazione dell’agire
dell’uomo. I modelli deterministici sono perciò necessariamente unicausali, mentre i modelli
multicausali sono, altrettanto necessariamente, probabilistici.
La critica ai modelli deterministici è venuta, fin dagli inizi del nostro secolo, dalle scienze
fisiche.
Da un lato la psicologia è una scienza “giovane”, ammessa tardi nel novero delle discipline
scientifiche. Questa maggiore vulnerabilità ha fatto si che molto psicologi si aggrappassero ai
modelli deterministici delle scienze forti, senza accorgersi che essi, venivano sottoposti a
critica serrata ed erano via via abbandonati. D’altro lato, la stessa immensità del compito che si
presentava agli psicologi- comprendere e spiegare il comportamento umano- ha condotto
molti studiosi a limitare l’analisi ad aspetti molto circoscritti, dimenticando la complessità del
quadro generale. Si è così preferito isolare alcuni nessi causali ritenuti certi e prevedibili. Le
critiche delle scienze fisiche al determinismo sono riconducibili alla considerazione che,
quando vi sono numerose variabili in gioco e quando queste sono in reciproca interazione
lungo il tempo, non è possibile predire in modo sicuro che cosa accadrà dopo un certo numero
di interazioni. Il numero di modificazioni reciproche è infatti talmente elevato da rendere il
problema praticamente intrattabile e da non consentire predizioni certe. È quanto avviene nei
sistemi complessi, all’interno dei quali non è possibile fare previsioni di tipo deterministico, se
non per le prime due o tre influenze; dopo si possono soltanto fare delle previsioni
probabilistiche, tanto migliori quando più solido è il modello teorico di base e quanto maggiori
sono le informazioni disponibili.
Ovviamente, la numerosità e la complessità delle variabili che sono coinvolte nel
comportamento umano, fin dal giorno del concepimento, sono infinitamente superiori a quelle
di qualunque fenomeno di tipo fisico. Agiscono infatti sia variabili di tipo biologico che variabili
di tipo ambientali. La stessa struttura biologica dell’uomo, a sua volta, è il prodotto di miriadi
di influenze sia di tipo genetico che di tipo ambientale. Il comportamento umano è dunque il
risultato di un’incalcolabile reciproca influenza lungo il tempo, vale a dire dal concepimento
alla morte, di variabili diverse, riconducibili sia al patrimonio innato ed alla struttura biologica,
sia alle influenze ambientali ed all’apprendimento. Se la fisica ha buone ragioni per rifiutare il
determinismo in nome della pluralità delle variabili, la psicologia ne ha infinitamente di più,
anche soltanto invocando il numero delle influenze biologiche ed ambientali e le loro
reciproche interazioni nel tempo.
Eppure, la pluralità delle influenze all’interno di un sistema complesso non è l’unica ragione
per cui non è possibile un approccio deterministico in psicologia. Esiste un’altra ragione,
ancora più decisiva e convincente, che deriva dalla specificità dell’organizzazione cognitiva
dell’uomo. L’uomo possiede infatti una mente attiva, che rielabora le informazioni, capace,
attraverso il pensiero, di svincolarsi dalle contingenze biologiche ed ambientali. La possibilità,
specificamente umana, di costruire una rappresentazione cognitiva della realtà e di se stesso,
sulla quale poi riflettere e ragionare, permette all’uomo di non essere determinato, nelle sue
azioni, dalle influenze biologiche ed ambientali.
Continuità e discontinuità lungo lo sviluppo
La psicologia ha dunque ottime ragioni per rifiutare il determinismo, e non è un caso che siano
stati proprio gli psicologi dello sviluppo i primi a metterlo in discussione. Chi studia l’evoluzione
del bambino nel tempo - dalla nascita all’adolescenza ed ancor più all’età adulta - sa bene
quanto le rigide predizioni possano essere sconfessate, e quanto lo sviluppo di un bambino
possa avvenire in modo del tutto imprevedibile, smentendo le previsioni, ottimistiche oppure
pessimistiche, che erano state fatte a partire da certe condizioni. Perché ciò avvenga è spesso
oscuro. Un aspetto che i modelli deterministici avevano profondamente trascurato, è
dell’importanza del presente. Basti pensare alla convinzione, purtroppo ancora diffusa, che
entro il terzo anno di vita si sia già deciso tutto per quanto riguarda il carattere del bambino ed
il suo modo di relazionarsi agli altri adolescente e da adulto. Si stabilisce così un nesso causale
di rigida continuità tra i primi anni di vita e l’età adulta che salta completamente tutte le
esperienze intermedie. Ne deriva una svalutazione e un’indifferenza nei confronti del
presente, ossia delle esperienze attuali che il bambino sta facendo, le quali interagiscono
invece con il passato e possono contribuire a modificarne l’orientamento in modo decisivo.
Non esiste una continuità necessaria tra passato e presente, così come tra passato e futuro, né
per lo sviluppo cognitivo, né per quello affettivo o sociale. Infatti le esperienze del passato
interagiscono con quelle presenti e queste ultime possono contribuire in modo decisivo a
modificare gli orientamenti del bambino, ed a provocare perciò una diversa evoluzione, sia in
senso positivo che negativo. Tale sensibilità al cambiamento è particolarmente forte in alcuni
momenti critici, alcuni dei quali, come l’adolescenza, sono maggiormente comuni e prevedibili,
mentre altri sono del tutto personali e legati alla storia individuali di ogni bambino e do ogni
adulto. In una prospettiva è una sfida per gli psicologi e per gli educatori. Essa li chiama ad un
atteggiamento attivo, che non considera ineluttabile l’evoluzione negativa dello sviluppo del
bambino a partire dalle esperienze del passato, ma si interroga su quali possano essere gli
interventi da attuare per far sì che tale sviluppo segua una traiettoria positiva, sul piano
cognitivo, affettivo e sociale. Naturalmente, per fare degli interventi corretti, che abbiano
buona probabilità di riuscita, occorre condurre in primo luogo un’analisi approfondita della
condizione del bambino, della sua storia, delle sue capacità e potenzialità. È poi necessario
che, su questa base, vengano formulate delle ipotesi sulle possibili linee di sviluppo che il
bambino formulate delle ipotesi sulle possibili linee di sviluppo che il bambino potrebbe avere,
in modo da decidere come intervenire nel presente, a medio ed a lungo termine.
La teoria dei sistemi evolutivi
Le sei proposizioni di base riguardo alle caratteristiche che vincolano e facilitano il
cambiamento e lo sviluppo vengono così formulate da Ford e Lerner:
1. Le funzioni biologiche, psicologiche e comportamentali sono continue, e avvengono sempre
nel tempo presente;
2. Un individuo agisce sempre come un’unità collocata entro un contesto;
3. Le condizioni esistenti ai confini dell’organismo definiscono le attuali possibilità evolutive;
4. Le condizioni esistenti ai confini dell’ambiente definiscono i percorsi evolutivi attualmente
disponibili;
5. Lo sviluppo inizia sempre da ciò che esiste attualmente;
6. I cambiamenti negli stati attuali sono sempre vincolati da una gerarchia di processi di
selezione.
Il contesto e l’azione individuale
Un altro aspetto che era stato fortemente trascurato dai modelli deterministici è il contesto di
vita dei bambini. Nel tentativo illusorio di definire in modo certo leggi universali e generali
dello sviluppo, valide per tutti i bambini, i modelli deterministici hanno ignorato che lo
sviluppo avviene, in realtà in contesti ambientali profondamente diversi. Ma l’aspetto che i
modelli deterministici hanno completamente ignorato, soprattutto a livello evolutivo, è il ruolo
attivo dell’individuo. I modelli deterministici hanno infatti ipotizzato, più o meno
esplicitamente, una completa passività individuale. Secondo tali modelli, le influenze
biologiche, così come quelle ambientali, determinerebbero il comportamento, ed in tale gioco
l’individuo non svolgerebbe alcun ruolo. L’individuo è presentato come un contenitore passivo,
attraversato da forze estranee che determinano il suo comportamento, sulle quali non esercita
influenza alcuna. Gli psicologi dello sviluppo hanno evidenziato come il bambino, anche molto
piccolo, sia in grado di intervenire sull’ambiente per modificarlo, per ricercare e addirittura per
creare situazioni diverse. A anche la ricerca in campo cognitivo ha dato un contributo decisivo,
evidenziando in particolare la capacità del pensiero di svincolarsi dalle contingenze ambientali
e biologiche. È inutile sottolineare come, nella prospettiva cognitiva, più del contesto in sé è
importante il significato che il soggetto, adulto o bambino, gli attribuisce. L’esempio relativo
alle influenze della condizione economica della famiglia sullo sviluppo del bambino, cruciale
non è tanto la condizione economica familiare, anche se, ovviamente, una condizione di
povertà si tradurrà poi in minori risorse ed opportunità. Ancora più l’aspetto importante è il
modo in cui il bambino vive tale condizione ed il significato che le attribuisce, in relazione al
proprio presente e al proprio futuro. La concezione che stiamo proponendo è dunque di tipo
interazionista costruttivista, attenta all’interazione continua, lungo il tempo, tra l0individuo ed
il suo ambiente, nel presupposto che il soggetto sia attivo protagonista di tale processo
interattivo, soprattutto grazie alle proprie capacità cognitive, al di fuori delle quali la sia stessa
vita affettiva e sociale risulta incomprensibile. Le tesi che qualificano un modello interazionista
costruttivista possono, schematicamente, essere così riassunte:
a) Il comportamento è funzione di un processo interattivo continuo e multi direzionale tra
l’individuo e la situazione. La persona e la situazione corrispondono a due sistemi in
interazione e la comprensione delle loro relazioni è essenziale pe la piena comprensione delle
proprietà dell’uno e dell’altro;
b) L’individuo è protagonista attivo di tale processo interattivo e mai, anche da bambino, passivo
ricettore;
c) In tale interazione i fattori cognitivi svolgono un ruolo determinante. Ciò non implica che i
fattori emotivi siano irrilevanti, ma che la loro stessa comprensione nell’uomo non sia possibile
senza tenere conto dei processi cognitivi, che costruiscono il significato delle situazioni. Il
significato psicologico delle situazioni, non la realtà oggettiva delle situazioni in sé, è
determinante nel guidare il comportamento.
Due aspetti caratteristici del modello,, in primo luogo, lo sviluppo è considerato come il
risultato dell’azione individuale, volta a trovare la migliore realizzazione dei propri scopi e delle
proprie potenzialità, con gli strumenti cognitivi caratteristici di ogni età, in relazione alle
opportunità ed alle richieste del contesto. In secondo luogo, l’azione produce cambiamenti
non solo nell’individuo che la realizza, ma anche nel contesto di sviluppo. I cambiamenti del
contesto offrono a lavoro volta nuove opportunità per lo sviluppo, in una relazione circolare
incessante: dall’azione individuale al contesto e da quest’ultimo nuovamente all’azione
dell’individuo.
I percorsi differenziati di sviluppo
Il tema della continuità e della discontinuità è centrale nella psicologia dello sviluppo. In una
prospettiva tradizionale, esso è stato affrontato soprattutto attraverso i concetti di stadio e di
fase. Essi sono stati usati sia in senso stretto – ad esempio nel modello di Piaget relativo allo
sviluppo cognitivo e in quello di Freud relativo allo sviluppo psico-sessuale – sia in senso
ampio, per definire periodi della vita contraddistinti da qualche particolare caratteristica. In
tutti i casi, una concezione stadiale comporta che vi sia un cambiamento qualitativo nel
passaggio da uno stadio all’altro, oppure da una fase all’altra, secondo una successione che
avviene in modo fisso ed il cui motore è dato sostanzialmente dallo sviluppo biologico. Lo
stadio è concepito come una struttura unitaria, che informa tutto il modo di ragionare e tutto il
modo di agire del bambino che si trova in quel periodo. In sostanza i concetti di stadio e di
fase- pur riferendosi a teorie diverse – piagetiana e psicoanalitica- postulano un’uniformità del
funzionamento psichico dei bambini che si trovano in una certa età, indipendentemente dalle
caratteristiche dell’ambiente culturale di appartenenza, dalla specificità delle esperienze di
ognuno. Questi concetti sono stati messi profondamente in discussione in una prospettiva
probabilistica ed interazionista, attenta alla complessità delle interazioni che si realizzano tra
patrimonio genetico ed esperienza. Già Vygotskij (1930-31) aveva chiarito, con il concetto di
“zona di sviluppo prossimale”, che lo sviluppo biologico definisce l’ambito delle possibilità
dello sviluppo, la cui concreta realizzazione è demandata alle influenze culturali ed alle
opportunità offerte dalla società. Così, pur essendo ogni bambino sano dotato della capacità di
apprendere a leggere e scrivere, tale possibilità non si realizza se non nelle culture che hanno
sviluppato, nella loro storia, la lingua scritta e che dispongono di una specifica organizzazione
scolastica rivolta a tale scopo. A partire da queste osservazioni, gli studi più recenti degli
psicologi hanno evidenziato la grande variabilità sia interindividuale ch intraindividuale nello
sviluppo infantile. La variabilità interindividuale fa riferimento alle differenze di sviluppo che ,
alla stessa età e per la stessa abilità, possono essere riscontrate tra bambini differenti e che
sono riconducibili al complesso intreccio dei fattori biologici e dei fattori ambientali lungo la
storia del bambino. Diversi sono infatti gli ambienti sociali, i climi familiari, i significati
attribuiti, così come sono diverse le condizioni biologiche di ogni bambino. Il risultato
del’interazione reciproca di fattori biologici e dei fattori ambientali a partire dal concepimento
fa sì che ogni bambino sviluppi, sia sul piano cognitivo che affettivo e sociale, un certo livello di
capacità, che non è mai uguale a quello degli altri. La variabilità intraindividuale fa invece
riferimento alla differenzazione delle varie capacità all’interno dello stesso individuo. La
concezione stadiale classica ipotizzava una sostanziale unitarietà di funzionamento psichico,
per ogni stadio o fase, sia riguardo alle capacità cognitive cha a quelle affettive o sociali. Così,
secondo Piaget (1964), il bambino che si trovava nella fase preoperatoria aveva un modo
peculiare di ragionare, che riguardava tutti i campi e tutti i domini cognitivi. Gli scostamenti da
tali modalità, sia in senso cognitivo che affettivo o sociale, configuravano delle regressioni,
oppure delle fissazioni, ed erano considerati delle anomalie nello sviluppo. Riconoscere la
variabilità intraindividuale ha portato invece ad accettare che i bambini possano presentare
livelli diversi di sviluppo per quanto riguarda le varie capacità. Un bambino può essere molto
abile cognitivamente in un certo ambito, o dominio cognitivo, perche ha potuto avere in esso
un maggiore addestramento, mentre può presentare in altri domini una maggiore immaturità
o incapacità. Ancora , un bambino può mostrare un’ottima competenza sociale in certe
situazioni di relazione con i pari, mentre può mostrarsi del tutto incapace di affrontare altre.
Tali “decalage” orizzontali non hanno nulla di anomalo i di patologico, ma sono riconducibili
alla varietà delle esperienze del soggetto nei vari domini, nonché alle sue diversificate modalità
di fare fronte a compiti differenti. Il riconoscimento dell’estrema variabilità sia interindividuale
che intranindividuale nel corso dell’età evolutiva ha dunque condotto a superrare l’idea che lo
sviluppo costituisca una progressione sistematica attraverso una serie di stadi comuni a tutti i
bambini, i quali si succedono in un ordine fisso e precostituito. Non esiste un unico percorso
evolutivo uguale per tutti, e non esiste un criterio di maturità o normalità applicabile
rigidamente a tutti. Parlare di percorsi individualizzati e differenziati di sviluppo significa certo
abbandonare un concetto rassicurante, quale quello di stadio, che permetteva si incasellare e
valutare il comportamento del bambino. Psicologo ed educatore servono capire su quali fattori
favorenti, oppure potenzialmente dannosi, possano intervenire, nel presente, per modificare
la traiettoria di sviluppo con uin modello astratto di normalità, valido per tutti, si tratta
insomma di chiedersi quanto un certo percorso sia adattivo, oppure disattivo, per quello
specifico, ,i in quello specifico contesto.
I percorsi evolutivi probabilistici
La crescita psicologica è stata spesso descritta come una progressione sistematica attraverso
una serie di stadi comuni a tutti, che si succedono secondo un ordine precostituito: ciascuno di
essi avvicina il bambino alla maturità, rappresentata dal funzionamento adulto. Ci si è
soprattutto concentrati sui principi universali dello sviluppo, piuttosto che sulle differenze
individuali. La teoria freudiana, ad esempio, aveva evidenziato gli stadi psicosessuali: orale,
anale, fallico, di latenza e genitale. Piaget, invece, aveva sottolineato la progressione dei
meccanismo cognitivi, dallo stadio senso motorio, attraverso quello preoperatorio e concreto,
fino allo stadio delle operazioni formali (in cui diviene attivo il ragionamento logico),
dall’adolescenza in poi. Kohlberg estese l’approccio allo sviluppo morale. Ma le “grandi” teorie
non permettono di inquadrare in maniera adeguata lo sviluppo errale. Basandosi sugli stadi,
esse implicano una predittività meccanica, che non tiene conto del ritmo dinamico del
cambiamento, del suo estendersi nel tempo e del grado di variabilità individuale. Inoltre, tali
teorie partono dal presupposto ce esista un unico percorso evolutivo uguale per tutti e che ci
sia una punto finale coincidente con la maturità.
CAP II
La raccolta dei dati iniziali
La centralità del bambino e della sua storia
Assumendo come dato indiscutibile la centralità del bambino e ritenendo di conseguenza che
tutto quanto avviene a scuola dovrebbe essere a lui riferito. L’insegnante deve compiere due
tipi di operazioni, orientate temporalmente in modo opposto. Il primo tipo è orientato verso il
passato e consiste nella raccolta di dati relativi all’evoluzione personale del bambino, alla sua
storia, agli apprendimenti e alle capacità di cui già dispone, alle teorie ingenue che si è
costruito. Lo scopo di queste operazioni consiste nel delineare il profilo cognitivo del bambino
stesso che, come richiama il significato della parola “profilo”, ha carattere individuale e riflette,
in accordo con la teoria delle intelligenze multiple, il diverso possesso delle competenze
intellettuali e delle relative abilità. Il secondo tipo di operazioni dovrebbe essere la naturale
conseguenza del primo: è la programmazione. Gli studi Vygotskij riguardanti l’apprendimento
prescolastico e scolastico, hanno ormai reso impossibile a ogni insegnante ignorare la storia,
soprattutto cognitiva, del bambino. Ma come devono essere raccolte le informazioni su questa
storia? Il primo elemento, sottolineato da molti psicologi, si riferisce al fatto che lo sviluppo del
bambino, e in particolare l’acquisizione di molti concetti, ripercorre, in forma ovviamente più
veloce, le tappe attraverso le quali gli esseri umani conseguirono gli stessi apprendimenti. Il
secondo elemento, ancora più significativo, è relativo alla “casualità” degli apprendimenti che
il bambino realizza nei primi anni di vita, casualità analoga a quella che consentì alla specie
umana di acquisire quelle competenze che costituirono la base del successivo sviluppo delle
civiltà.
Il bambino come sistema non lineare
Regolarità e casualità, quindi, ma non determinismo. Come la nozione di sistemi non lineari
consente di comprendere. Un sistema non lineare è contraddistinto dalla presenza di
biforcazioni, in presenza delle quali si verifica una scelta. I nodi costituiscono invece gli “eventi
critici”, i quali pongono l’individuo di fronte alla necessità di operare la scelta, che è sempre di
carattere binario: o si sceglie la possibilità che si presenta o non la si sceglie. Ciascuna scelta
comporta a propria volta una biforcazione, e così via. Le biforcazioni si caratterizzano per la
sensibilità: << piccole variazioni nei casi di un sistema conducono alla scelta preferenziale di un
ramo piuttosto che di un altro>>. Non è quindi possibile né prevedere con certezza il futuro,
pur conoscendo la situazione iniziale, né ricostruire in modo esaustivo la storia passata, perché
è impossibile prevedere o ricostruire nella sua totalità il gioco dei diversi fattori, influenzati
fortemente dal caso. Questi concetti permettono quindi di chiarire i limiti dalle operazioni
richiamate poco sopra: nessuna diagnosi potrà mai essere ritenuta definitiva. Nessuna
programmazione potrà mai prevedere con assoluta certezza il percorso di apprendimento e di
sviluppo di un bambino. Riconoscere l’incidenza del caso nel comportamento umano in
genere, e in quello del bambino in particolare, significa imparare a ragionare in termini di
probabilità. Ma vuol dire anche rendersi conto che probabilità non è sinonimo di impossibilità
assoluta di predittività. La statistica ci ha insegnato, infatti, che con il concetto di probabilità gli
eventi si possono o non si possono verificare secondo un ventaglio di possibilità che va da zero
a cento: zero corrisponde all’impossibilità di qualsiasi previsione cento al determinismo, cioè
alla certezza. Ogni insegnante, se riflette in merito, si rende conto che l’efficacia della propria
azione si colloca in punti diversi di questa linea da 0 a 100 a seconda dell’incidenza di una serie
di elementi: il contesto sociale e culturale nel quale insegna; gli anni di esperienza; la
preparazione(specie di tipo psicologico; la padronanza di capacità e strumenti di osservazione.
Tutti questi elementi contribuiscono ad affinare le capacità intuitive dell’insegnante, le sole
che lo mettono davvero in grado, nel contesto concreto e quotidiano della classe, di affrontare
tutte quelle situazioni assolutamente imprevedibili che, proprio in quanto tali, richiedono
risposte efficaci, il più possibile immediate.
Il Profilo Iniziale
La delineazione del profilo iniziale del bambino costituisce, una delle operazioni
professionalizzanti più profonde. Essa significa infatti:
a) Superare il concetto del “capaci e meritevoli”, che misura pur sempre lo sviluppo sulla base
dei risultati ottenuti dai migliori. Nella società di oggi non interessano le capacità definite in
modo arbitrario, ma lo sviluppo del talento che ciascuno possiede, perché il talento di tutti è
necessario all’interesse generale.
b) Riconoscere che il bambino che fa il proprio ingresso a scuola è un individuo competente, non
una tabula rasa.
c) Assumere la scuola come ambiente all’interno del quale i bambini realizzano esperienze (di
apprendimento, di socializzazione, ecc.) che ne modificano le caratteristiche.
d) Pensare al bambino come ad un essere unico e irripetibile.
L’insegnate, cioè, deve diventare un “lettore” del bambino e regolare la propria azione sulla
base di tre necessità. <<Studiare, per capire, per assumere decisioni>>.
La Significatività dei Dati
Si rende necessario lavorare su un aspetto finora non sufficientemente considerato: quello
della significatività o non significatività dei dati. Certamente, la selezione dei contenuti e
l’identificazione dei nodi concettuali “forti” di ciascuna disciplina costituiscono il necessario
presupposto per il suo insegnamento, ma a nostro avviso occorre prima identificare criteri
generali, indipendenti dal contenuto. Per ora ci sembra sufficiente evidenziare come il profilo
iniziale e la programmazione debbano essere costruiti identificando:
1) I dati più direttamente correlati all’apprendimento, e particolarmente: a) gli apprendimenti
primari (percezione, categorizzazione, linguaggio, capacità di risolvere i problemi, ecc.)
esistenti nel bambino fin dalle età più precoci, i quali <<generano e controllano le diverse
risposte comportamentali agli stimoli ambientali>>; b) gli apprendimenti secondari, legati a
contenuti specifici e resi possibili dai primi.
2) I dati relativi alla storia del bambino, e precisamente gli eventi critici che sono stati all’origine
di cambiamenti di direzione nel corso dello sviluppo.
La Preistoria degli Apprendimenti
Vygotskij sottolineava che “Ogni materia di insegnamento con la quale il bambino ha a che fare
nella scuola ha la sua preistoria”.
a) Sottolineare l0importanza della preistoria degli apprendimenti non vuol dire accertarne il
possesso da parte di tutti gli alunni: fortunatamente, la maggioranza degli alunni dispone di
tali apprendimenti.
b) Constatare l’inadeguato possesso di tali apprendimenti non deve tradursi in una semplice
legittimazione della situazione esistente: al contrario, deve indurre alla predisposizione di
attività e di esercizi che permettano al bambino di colmare le lacune.
Gli Eventi Critici
Da parte di alcuni insegnanti si mette talvolta in discussione l’importanza di acquisire la
conoscenza di eventi, specie se fortemente traumatici, avvenuti nel passato del bambino. La
scusa che viene addotta è che <<occorre dare al bambino la possibilità di ricominciare
daccapo>>. Hayden, insegnante americana di scuola speciale, descrive in un suo romanzo un
caso emblematico dei rischi che può comportare l’ignoranza di certi fatti del passato del
bambino:
<<[…] sai, abbiamo pensato che per Kevin era meglio ricominciare tutto da capi, in clinica. Non
la si può certo chiamare un’infanzia felice, la sua. Gli erano già capitate talmente tante cose
brutte che gli altri si erano già fatti un sacco di preconcetti su di lui. Insomma, non si era mai
visto un ragazzo al quale fossero andate storte più cose che a lui. E nessun voleva più
occuparsene. Non c’era nessuna speranza. Così si è pensato di cancellare ogni cosa e farlo
ricominciare da capo. Solo perché dimenticasse il suo passato, prima di essere ricoverato. Il
fatto è, Marlys, che Kevin non l’ha mai dimenticato il suo passato>>.
CAP III
TEORIE DELL’APPRENDIMENTO
Dai dati iniziali alla programmazione: caos, probabilità, contingenza.
LA SCUOLA COME SISTEMA CAOTICO
Non c’è dubbio che la maggior parte degli insegnanti sottoscriverebbe senza indugi
l’affermazione secondo la quale una classe è un “sistema caotico”. A nostro avviso è la notizia
di “caos”, strettamente connessa a quella di “probabilità”, a prospettare nuove modalità di
interpretazione dei fenomeni pedagogici.
Gli aspetti che i diversi autori evidenziano come caratteri dei sistemi caotici sono i seguenti: a)
piccole cause possono avere grandi effetti; b) si tratta di sistemi nei quali il tempo che occorre
per tornare in uno stato in cui si siano già trovati in passato è immenso; c) il comportamento
appare casuale, ma in realtà la complessità e l’imprevedibilità nascono dal fatto che siamo
costretti ad ignorare un gran numero di libertà nascoste.
Tali elementi fanno sì che <<in un sistema caotico […] il comportamento [venga] pesantemente
influenzato dal più piccolo disturbo, cosicché non c’è speranza di poter fare previsioni se non a
brevissimo raggio>>. Sapere che esiste la dipendenza sensitiva dalle condizioni iniziali (o
“effetto farfalla1”) e che essa agisce non soltanto sui fenomeni meteorologici o fisici, ma
1
L’espressione “effetto farfalla” fu coniata nel 1961 da un metereologo americano, Edward Lornz. Egli stava tentando
di prevedere il tempo attraverso l’uso del computer e quindi di un sistema matematico. Inserendo i dati riguardanti le
condizioni iniziali e facendo partire il programma, si sarebbero dovute leggere le previsioni finali. Del tutto
altresì su quelli umani, permette sia di comprendere questi ultimi sia di non abbandonarsi allo
sconforto.
Sarebbe tuttavia profondamente errato ritenere che il comportamento dei bambini sia del
tutto casuale e, soprattutto, che sia casuale anche il loro apprendimento, giungendo così alla
conclusione dell’intuibilità della programmazione.. Si tratta semmai di ragionare sui limiti della
diagnosi iniziale, sui limiti di programmazione e, in particolare, ancora una volta, di ragionare
sul tempo.
Che cos’è il tempo necessario?
Il concetto di “tempo necessario” fu elaborato da Carrol in riferimento alla considerazione che
il grado di apprendimento è una funzione del rapporto tra tempo impiegato ad apprendere e
tempo necessario ad apprendere. In particolare, il tema è concesso alle ricerche effettuate
dalla crono psicologia sui ritmi di apprendimento scolastico.
La crono psicologia, rifacendosi all’esistenza di ritmi biologici che regolano il funzionamento di
ogni individuo, ha in particolare sottolineato come ogni bambino possieda una dimensione e
un’organizzazione temporale che occorre rispettare. Non è pertanto possibile manipolare i
tempi di apprendimento e imporre ritmi che siano in contrasto con l’ “orologio personale” del
bambino. Il problema del tempo necessario e quello dei ritmi scolastici costituiscono un
aspetto scarsamente indagato dagli insegnanti, anche se tra i loro poteri c’è anche quello di
dirigere e scandire il tempo scolastico, attraverso l’organizzazione di esperienze nel tempo.
LE FASI DELL’APPRENDIMENTO
Pur essendo consapevoli che una rigida distinzione in fasi è artificiosa e non corrisponde al
modo in cui effettivamente il bambino apprende, indirizzare l’attenzione su ciascuna di queste
fasi è però utile nel momento in cui l’insegnante prepara il proprio lavoro e quindi esperimenta
mentalmente ciò che potrà verificarsi nella realtà.
Fase di acquisizione
casualmente, egli constatò che era sufficiente cambiare in misura minima le cifre decimali dei dati iniziali per ottenere
risultati finali completamente divergenti. I piccoli errori iniziali si gonfiavano cioè in breve tempo. Utilizzando una
metafora, si poteva affermare che era sufficiente il battito d’ali di una farfalla in Brasile per creare un tornado che, nel
giro di una settimana, avrebbe devastato il Texas. L’ “effetto farfalla” da quel momento stette ad indicare
l’impossibilità di fare previsioni se non a brevissimo raggio, essendo impossibile conoscere tutte le influenze che
gravano sul sistema considerato.
La realizzazione di un nuovo apprendimento chiama in gioco una serie di condizioni e di
aspetti:
a) L’analisi delle conoscenze de delle abilità pregresse richieste dal nuovo apprendimento,
unitamente alla definizione di quali di queste conoscenze e abilità sono già in possesso degli
alunni. Non è sufficiente conoscere che cosa il bambino sa in generale: se si vuole che egli
proceda spostando gradualmente verso l’alto la propria zona di sviluppo potenziale occorre
precisare le capacità, le competenze, le informazioni su cui i nuovi apprendimenti si
costruiscono.
Non
bisogna
infatti
dimenticare
che
apprendimento
vuol
dire
<<accumulazione, perché le esperienze che si fanno, generalmente, non svaniscono nel nulla,
non vengono cancellate da quelle successive (non del tutto); ma si accumulano, si
influenzano e si modificano a vicenda>>. Ciò diventa possibile solo se si evitano al bambino
due esperienze negative: la noia, che si verifica allorché gli si propone qualcosa che è già
padroneggiato, e l’ansia, come conseguenza di richieste eccessive.
b) L’analisi delle condizioni che favoriscono o rendono difficile l’esercizio dell’attenzione. Se è
vero che non è possibile costringere qualcuno a stare attento (in quanto la postura fisica
denota attenzione può corrispondere a una mente che vaga in tutt’altro luogo), è anche vero
che nell’ambito della scuola elementare occorre educare a prestare attenzione, in quanto
senza di essa non può esserci apprendimento. La collocazione dei diversi soggetti nell’aula
(atta a favorire il contatto oculare tra insegnante e alunni), i tempi di durata delle attività,
l’uso di immagini, l’uso di oggetti concreti, la formulazione precisa delle consegne, sono
alcuni dei fattori favorenti l’attenzione che devono essere pensati in anticipo.
c) Lo stile di insegnamento utilizzato, comprende in sé le diverse metodologie, che devono
essere molteplici per venire incontro agli stili cognitivi dei diversi bambini. In particolare,
l’insegnate deve riflettete sul peso che ha nel proprio stile la componente verbale. Anche se
essa rimane lo strumento principale per veicolare informazioni, deve essere accompagnata,
in misura tanto maggiore quanto più i bambini sono piccoli, da strumenti fondati sulla
visualizzazione e sull’attività. Lo stile di insegnamento non può pertanto essere rigido.
d) Le modalità di utilizzazione degli strumenti e, in particolare, di quelli che il bambino deve
imparare a padroneggiare e che hanno lo scopo di ampliare il raggio della sua attività. Ci sono
strumenti riconosciuti facilmente come tali: i libri, le immagini, il dizionario, l’enciclopedia. Ce
ne sono altri non considerati strumenti, ma che invece possiedono la caratteristica di
allargare il sistema delle attività del bambino e quindi il campo dei comportamenti: in primo
luogo il linguaggio, orale e scritto.
e) La sequenzialità dei contenuti presente, che non deve essere di tipo estrinseco ma deve
rispettare il rapporto tra ciò che il bambino sa già e ciò che di nuovo deve sapere. L’incidenza
degli apprendimenti precedenti su quelli successivi, che sta all’origine della nozione di
“apprendimento significativo”, deve essere considerata però non soltanto in senso positivo,
come elemento facilitante, ma altresì nei possibili aspetti negativi, come si verifica nel caso di
automatismi acquisiti che diventa difficile abbandonare.
f)
L’organizzazione del contesto sociale. Assumendo come punto di partenza l’affermazione di
Vygotskji, secondo cui <<il bambino si appropria delle forme sociali del comportamento e le
trasferisce su se stesso […] trasformando le relazioni sociali in funzione psichiche>>, occorre
riflettere su quali apprendimenti vengono conseguiti più facilmente nel contesto della classe
e quali invece all’interno di piccoli gruppi. Le ricerche dei post-vygotskiani hanno messo in
evidenza come i compagni svolgano una preziosa azione di regolazione e controllo.
Anche per quanto riguarda il contesto sociale occorre rammentarsi che interviene il principio
della zona di sviluppo potenziale: i contributi dei compagni devono cioè collocarsi all’interno di
essa per poter essere efficaci. Questo
conduce a considerare la negatività, ai fini
dell’apprendimento, sia delle classi o dei gruppi omogenei, costituiti secondo il livello delle
prestazioni, sia delle classi o dei gruppi in cui le differenze di capacità e competenze tra gli
alunni sono troppo ampie. In entrambi i casi risulta infatti estremamente difficile che gli alunni
mettano in atto quei processi di osservazione e di imitazione che la biologia e la psicologia
hanno considerato come modalità primarie di apprendimento.
g) La cura per la dimensione estetica. Fabbri sottolinea che <<quando impariamo, quando
conosciamo, esiste sempre in noi un progetto estetico, anche se inconscio, che ci fa costruire
e mettere in relazione quanto stiamo facendo secondo dei modelli che possiedono un loro
fascino, che sembrano rispondere a certi giudizi di gusto>>. Se questo elemento è
importante per un adulto, lo è in misura ancora maggiore per un bambino: egli non è
disponibile a occuparsi di ciò che non è bello, che non è piacevole a vedersi. L’incidenza della
dimensione estetica nell’apprendimento dei bambini è collegata alla percezione sin estetica,
la quale, come segnala Werner, costituisce uno degli aspetti dell’indifferenziazione che
caratterizza le prime fasi dello sviluppo infantile. Quanto più il bambino è piccolo, tanto più
sensazioni visive, uditive, tattili, gustative saranno fuse insieme. Ciò significa, allora,
attenzione per i colori, per le forme (ricordando che le forme tondeggianti sono correlate a
una disposizione positiva), per le dimensioni, per i caratteri, per gli spazi sul foglio: quanto di
più lontano, tra l’altro, possa esserci da una fotocopia in bianco e nero, troppo spesso
utilizzata nel lavoro didattico.
Fase di elaborazione
Costituisce la fase che più di ogni altra necessita di una programmazione accurata. Se è vero
infatti che essa richiama processi che si svolgono all’interno della mente del bambino, e che
sono quindi difficilmente osservabili, è altrettanto vero che essi si verificano solo se sussistono
una serie di condizioni esterne, su cui l’insegnante può avere la possibilità di intervenire.
Sull’elaborazione degli apprendimenti l’insegnante può intervenire in forma più o meno
indiretta e con modalità diverse, ma in modo accuratamente programmato, attraverso:
a) L’assegnazione di esercizi. L’esercizio non ha soltanto lo scopo di obbligare il bambino alla
ripetizione e quindi fissare l’apprendimento. Soprattutto, non deve essere finalizzato
soltanto alla verifica del conseguimento dell’apprendimento. Se accuratamente graduato nel
livello di difficoltà, e se davvero rappresentativo del percorso di apprendimento realizzato,
esso richiede di ripensare a ciò che è stato appreso, di creare relazioni nuove tra le diverse
nozioni, di trasferire l’apprendimento in un contesto diverso.
L’esercizio, demonizzato dalla didattica fondata sull’apprendimento per scoperta, ha subito
una rivalutazione grazie alla psicologia cognitiva: <<C’è una serie di sacrosanti esercizi che un
tempo venivano fatti fare ai bambini e che oggi erroneamente non vengono più proposti. Far
fare certi esercizi, rendendoli ovviamente il più sopportabili possibili, è una delle poche
garanzie di democraticità della nostra scuola, perché è la condizione che permette
effettivamente, alla lunga, di porre tutti i bambini sullo stesso piano.
b) L’assegnazione di compiti a casa. La finalità del compito sta proprio nel costringere il
bambino a ritornare su quanto ha imparato a scuola. Essa può però essere raggiunta solo se il
compito può essere svolto autonomamente dal bambino, senza l’intervento del genitore. I
lavori a casa dovrebbero essere individuati già nel momento in cui si programma il lavoro.
c) L’organizzazione della giornata scolastica, sia nella direzione della successione delle attività,
sia in quella dell’alternanza di pause e momenti di attività. Gli studi sulla fatica scolastica
hanno evidenziato alcuni aspetti che risultano in correlazione con le modalità di
funzionamento del cervello. In particolare hanno sottolineato l’esigenza che: 1) nel corso
della giornata scolastica vengano alternate attività il più possibile diverse tra loro (ad
esempio attività linguistiche, attività matematiche e attività artistiche); 2) si tenga conto non
solo dell’attività in sé, ma anche del tipo di impegno intellettivo richiesto al bambino, che è
correlato sia all’età, sia al livello di padronanza raggiunto; 3) si rispettino i limiti
dell’attenzione e quindi si prevedano adeguati momenti di pausa, nei quali il bambino non sia
impegnato in nuovi apprendimenti ma possa rielaborare quelli realizzati in precedenza.
d) L’utilizzo della ridondanza, affinché più facilmente si costruiscano rapporti tra ciò che è già
noto e ciò che si presenta come nuovo, favorendo così il ritorno a quanto è stato appreso.
Dal punto di vista didattico la ridondanza è riferita a due modalità diverse di intervento: 1)
l’utilizzazione di forme di presentazione diverse per lo stesso contenuto; 2) il riferimento a
contesti di esperienza molteplici e differenziati, ma tutti mirati a conseguire lo stesso
obiettivo.
e) L’espressione di quanto appreso in forma verbale, utilizzando soprattutto il linguaggio scritto,
che obbliga in misura maggiore del linguaggio orale ad esplicitare i nessi che sussistono tra i
fenomeni e le informazioni.
Fase di conservazione
Chiama in gioco i diversi tipi di memoria e le strategie di memorizzazione. Nonostante gli
insegnanti siano consapevoli del fatto che la memoria non sia un sistema unico e distinguano
quanto meno tra memoria che utilizza criteri logici, memoria visiva e memoria uditiva, altre
specificazioni sono pressoché ignorate. Preoccuparsi della memorizzazione dovrebbe voler dire
in primo luogo orientare l’azione didattica secondo tre linee direttrici che partono dalla
considerazione delle caratteristiche di funzionamento della memoria.
a) La memoria non è un magazzino, anche se a livello scientifico si parla di “stoccaggio” delle
informazioni. Il motivo è semplice: la memoria funziona secondo un criterio che è
esattamente l’opposto di quello di un magazzino, dove l’aumentare della merce riduce lo
spazio vuoto disponibile. Al contrario, nella memoria l’aumento delle informazioni comporta
un aumento della possibilità di ricordare altre informazioni. La memorizzazione non è quindi
soltanto un problema di quantità e non ci si deve preoccupare unicamente del numero di
informazioni. Ciò non significa però ignorare l’importanza anche numerica delle conoscenze
ritenute in memoria, poiché ad una loro maggiore numerosità corrisponde una rete più
complessa di connessioni.
b) Non esiste un nuovo apprendimento che sia completamente nuovo: ogni apprendimento si
fonda su conoscenze ed esperienze preesistenti. Le conoscenze e le esperienze precedenti
influenzano infatti il nuovo apprendimento, sia nel caso in cui l’insegnante le prenda in
considerazione esplicitamente, sia nel caso in cui non vi dedichi alcuna attenzione. Ma
ignorare il patrimonio conoscitivo di cui il bambino è in possesso significa più facilmente
constatare difficoltà o fallimenti. Da questa consapevolezza, discendono due esigenze: 1)
compiere un esame preventivo e il più possibile accurato delle conoscenze, delle abilità, delle
capacità che il nuovo apprendimento dà per presupposte e, di conseguenza, verificarne
l’esistenza nei bambini; 2) dedicare tempo ad attività di richiamo che consentano, per
l’appunto, di riportare alla luce ciò che il bambino sa già.
c) Capacità di memorizzazione e linguaggio sono strettamente interrelati. Per comprendere
l’importanza di questa relazione è sufficiente considerare che, nel momento in cui il bambino
acquisisce il linguaggio, diventa anche capace di ricordo consapevole. Dal punto di vista
didattico la relazione dovrebbe ovviamente essere intesa in senso biunivoco: aver acquisito
efficaci strategie di memorizzazione consente di disporre di un linguaggio più ricco e
strutturalmente più complesso; all’inverso, la padronanza del linguaggio consente una
memorizzazione migliore.
Non bisogna però dimenticare che è la padronanza dei concetti che fa veramente la differenza,
perché memoria e linguaggio non possono esercitarsi sul vuoto.
Su questi presupposti si dovrebbe poi inserire l’attenzione per le forme specifiche di memoria
che vengono attivate in rapporto ai diversi contenuti. La memorizzazione non consiste nel
depositare in un luogo del cervello gli apprendimenti realizzati. La memorizzazione interviene
in ogni momento del processo di apprendimento, che quindi deve essere pensato e
organizzato a priori in modo da favorire l’utilizzo della memoria. Ciò significa:
1) Tenere presenti i limiti della memoria di lavoro (o memoria a breve termine). La sua durata,
molto limitata, dovrebbe indurre l’insegnante ad organizzare in modo adeguato l’alternanza
degli stimoli e delle pause, le quali in questo caso sono finalizzate all’elaborazione, ma alla
possibilità di mettere in rapporto gli elementi nuovi con le conoscenze già possedute;
2) Considerare l’importanza della memoria lessicale, chiamata in gioco ogniqualvolta il bambino
debba apprendere una parola nuova. Le parole nuove vengono apprese più facilmente se
vengono considerate come “oggetti” e quindi analizzate e rappresentate anche visivamente,
in riferimento alla forma, al suono, alle sensazioni che producono. L’attenzione per la
memoria lessicale è quindi importante non soltanto nell’apprendimento di una lingua
straniera, ma anche nell’apprendimento delle discipline. Essa infatti è correlata
all’acquisizione del linguaggio di ogni contesto disciplinare, che deve essere non soltanto
corretto ma anche specifico. L’incidenza che la memoria lessicale possiede su tutti gli
apprendimenti induce infine anche a comprendere che la capacità del bambino di ripetere
quanto ha appreso, utilizzando le stesse parole, costituisce una fase indispensabile per
appropriarsi dei contenuti, quindi segnala il primo livello di padronanza.
3) Dedicare attenzione alla memoria procedurale, la quale non interviene soltanto per gli
apprendimenti percettivi e motori, ma è direttamente chiamata in causa anche nei processi
che portano alla padronanza della serie di azioni implicate nella realizzazione di un
apprendimento. Le procedure di lettura necessarie per poter apprendere da un testo scritto,
quelle messe in atto per risolvere i problemi matematici, quelle che permettono di redigere
un testo scritto coerente, devono poter essere padroneggiate a livello di automatismo, ma
devono , in precedenza, essere oggetto di insegnamento specifico.
4) Fare ricorso, il più possibile, alle memorie sensoriali, le quali, ad eccezione della memoria
visiva e di quella uditiva, presentano una durata limitata, ma consentono di utilizzare
molteplici canali di apprendimento e, soprattutto, permettono di effettuare l’analisi di
quanto viene presentato da molteplici punti di vista.
5) Curare in modo particolare l’organizzazione del contenuto da apprendere, al fine di rendere
possibile al bambino l’utilizzazione della memoria semantica, cioè di quel sistema di memoria
che fa ricorso alle connessioni, alle inferenze, ai ragionamenti, alla categorizzazione secondo
criteri logici. La memoria semantica è quella che richiama più fortemente il patrimonio di
conoscenze già esistente nel bambino, in quanto, fondandosi sui significati, presuppone che il
soggetto metta in rapporto quello che sa già con quello che è nuovo.
6) Preoccuparsi di insegnare al bambino anche le strategie mentali specifiche necessarie per
memorizzare quantità via via più ampie di informazioni. Ci pare opportuno richiamare
l’attenzione su quella che consideriamo la strategia più importante: la selezione delle
informazioni, cioè la capacità di distinguere ciò che è essenziale da ciò che non lo è.
Fase di recupero
Identifica il problema delle verifiche dell’apprendimento realizzato, le quali consistono, in
realtà, nella verifica delle capacità di recupero in memoria ciò che è stato imparato.
Sarebbe opportuno insegnare ai bambini che il recupero intenzionale di quanto si è imparato
richiede che prima siano stati costruiti e lasciati “indizi” (quasi come i sassolini di Pollicino) che
consentano di rifare il percorso. Questo vuol dire, ad esempio:
a) Utilizzare una specie di “segnaletica” che corra a lato dei testi e che consenta di evidenziare
le parole e i concetti chiave;
b) Insegnare a costruire gli schemi e le mappe dei contenuti, i quali attraverso la disposizione
sul foglio delle diverse informazioni, permettono anche di esplicitare le relazioni esistenti tra
i concetti e di stabilire tra essi delle gerarchie;
c) Avviare alla tecnica del prendere appunti che, nel caso dei bambini di scuola elementare,
significa in primo luogo curare la velocità della scrittura e insegnare a selezionare le
informazioni;
d) Insegnare che non si devono memorizzare tutte le parole ma per l’appunto, soltanto gli
indizi.
A fondamento della capacità di recupero sta quindi la capacità di effettuare la sintesi dei
contenuti e di mettere in atto procedure di espansione a partire da quanto è stato
memorizzato. Diventa chiaro ancora una volta come il bambino di scuola elementare non
possa assolutamente essere autonomo in questi processi ma necessiti della guida
dell’insegnante.
CAP IV
Possibili interventi nelle situazioni educative complesse
Gestire l’opposizione e il conflitto nelle situazioni educative
I bambini che creano più difficoltà agli insegnanti (o agli operatori per l’infanzia in generale)
per la gestione della classe (o degli asili e ludoteche in generale) sono solitamente quelli
che non rispettano le regole, non danno retta agli adulti e pretendono di fare come pare a loro.
E in più si oppongono e reagiscono malamente ai tentativi di mettere limiti al loro
comportamento, disturbano il lavoro della classe, provocano i compagni e creano situazioni di
scontro fisico e a volte di rischio per l'incolumità loro, dei compagni e a volte anche degli
adulti. Questo tipo di problemi è concentrato di solito nelle scuole elementari (con i piccoli in
generale), meno nelle scuole medie e nelle superiori (dove la problematica assume diversi
connotati).
Si tratta essenzialmente di due tipi di situazioni.
In un caso sono bambini con handicap psichico e relazionale, riconosciuto in base alla L 104/92
e seguiti di solito con insegnante di sostegno educatore scolastico e altri interventi. Si tratta
per lo più di bambini diagnosticati come autistici, con ritardo mentale più o meno complicato
da disturbi neurologici o da problematiche psicosociali (adozione, affidamento, ecc). In questo
caso il disturbo comportamentale fa parte di un quadro clinico di difficoltà globali, e
solitamente sono bambini 'certificati' per la Legge 104, con insegnanti e educatori di sostegno.
Nell'altro caso si tratta di bambini con normale intelligenza e sviluppo ma con comportamento
refrattario a regole e limiti alla loro volontà, incapaci o indisposti a frenare i loro impulsi. Vi si
può aggiungere, ma non sempre una difficoltà di apprendimento che complica ulteriormente
le cose e che può variamente essere interpretata come causa o effetto delle difficoltà
comportamentali. Questo tipo di bambini all'inizio non sono 'certificati', ma molto spesso dopo
alcuni anni di guerre scolastiche vengono anch'essi classificati fra gli 'handicap' in base alla L
104, per avere a scuola adulti in più di supporto, cosa resa possibile solo dalla famigerata
'certificazione'. Anche in questo caso a volte, ma non sempre, le cose sono complicate da
aspetti psicosociali, marginalità, immigrazione, adozione, disagi familiari.
Le situazioni descritte sopra, dell'uno e dell'altro caso, sono fra le più difficili da gestire, per la
scuola e per tutti gli operatori del settore, spesso indipendentemente dal fatto che ci sia o
meno la certificazione e le persone in più di sostegno. Una complicazione è che si creano
spesso scontri o vere e proprie guerre fra scuole, famiglie, a volte anche i servizi ASL e si rischia
talora uno spiacevole scaricabarile con accuse e messe in colpa reciproche che non fa che
complicare le cose.
Come evitare di complicare ulteriormente la situazione e come trovare le modalità più utile e
funzionali per affrontare la situazione col minor danno per tutti e poi con dei risultati positivi,
memori della regola fondamentale in medicina: primo non nuocere ?
Resta beninteso che le situazioni di entrambi i tipi visti sopra necessitano di interventi specifici
per approfondire la conoscenza dei problemi e la loro risoluzione, ove possibile. Ciò richiede
l'intervento di servizi di npi/psicologia dell'età evolutiva per interventi extrascolastici,
psicoterapici ed educativi, volti a favorire lo sviluppo del bambino, la sua maturazione e il
superamento di tali comportamenti.
Nel frattempo e contemporaneamente - nell'attesa (a volte un po' miracolistica) che gli
interventi esterni diano i loro frutti - la scuola si trova a dover affrontare i comportamenti
negativi cercando di salvare capra (il bambino in questione) e cavoli (il resto della classe),
evitando se possibile risposte peggiorative della situazione che talvolta vengono messe in atto.
Per questo è necessaria di solito un'opportuna consulenza alla scuola per affrontare al meglio
le varie situazioni critiche che possono crearsi, senza detrimento né degli altri alunni né del
soggetto in questione, e nemmeno degli operatori, che sono in una situazione di stress
accentuato dalla situazione attuale globale della scuola nei confronti della società.
Occupandoci qui dei casi del secondo tipo (poiché per i primi è necessaria una conoscenza
clinica approfondita), cioè di bambini che non presentano disturbi neuropsichiatrici specifici,
c'è da dire che sono, anche queste, situazioni che durano a lungo, almeno alcuni anni, di solito,
con alti e bassi, ed è necessario per le scuole e per le strutture che accolgono i bambini quindi
resistere ed attrezzarsi a un impegno di lunga durata. La fatica richiesta è compensata di solito
da un miglioramento che segue alla maturazione del ragazzo o ad altri cambiamenti esterni
favorevoli. E' realistico aspettarsi dei miglioramenti, spesso anche macroscopici, ma solo a
distanza di tempo e dopo aver resistito a lungo. Se la scuola e le strutture riescono a resistere
alle diverse sollecitazioni dirette o indirette, fornendo un contenitore resistente ed adeguato,
e senza farsi distruggere o trascinare in reazioni distruttive, la prognosi è di solito positiva.
Per ottenere ciò le varie strutture devono però potersi organizzare opportunamente per
reggere alle situazioni che si presentano, sia quelle abituali, di routine, per così dire, che quelle
impreviste, di emergenza. Qui di seguito tentiamo di trovare alcuni suggerimenti per aiutare ad
affrontare tali situazioni.
Direi che operativamente, per affrontare i problemi suddetti, è opportuno differenziare due
aspetti, quelli di routine e quelli di emergenza.
La routine è importante per organizzare il lavoro nel modo più opportuno per le persone
coinvolte e interessate, e per prevenire le complicazioni possibili; le situazioni di emergenza
sono quelle che scatenano crisi e a volte conseguenze gravi e sono pertanto da imparare a
contenere nel modo migliore possibile.
E' una questione di previsione di quanto può accadere, di organizzazione per prevenirlo e di
procedure utili a contenerlo.
Le situazioni che talora si creano sono a volte di emergenza, almeno nel vissuto di chi vi
partecipa, e come tali sono fortemente ansiogene.
Gli insegnanti e gli operatori potranno dire che non era questo il lavoro che pensavano di fare
ma si può considerare che ogni lavoro può avere le sue emergenze e richiede una preparazione
per affrontarle. Si tratta di dare una preparazione di base, qualcosa di simile a quanto viene
fatto anche nelle scuole per preparazione ad eventuali calamità, esercitazioni antincendio, di
evacuazione, ecc. Anche ai passeggeri sugli aerei o sulla navi vengono date simili istruzioni e
l'equipaggio deve possederle in modo ben più sicuro dei passeggeri.
Si tratta quindi di essere preparati ad affrontare le 'emergenze comportamentali' che possono
verificarsi nella scuola, negli asili e nelle ludoteche proprio come le emergenze di altro tipo,
terremoti, incendi, ecc.
E' opportuno quindi prima di tutto che le persone coinvolte acquisiscano una certa
competenza a intervenire in tali situazioni. Più o meno come le persone che lavorano
nell'ambito di situazioni di rischio e emergenza (protezione civile, ecc): la prima cosa che viene
insegnata è a valutare lucidamente la situazione, individuare le priorità e le necessità, e
applicare procedure già predisposte, se possibile. Tutto ciò permette solitamente di contenere
l'ansia dilagante che può precipitare comportamenti di panico nelle persone e aggravare le
situazioni.
L'informazione e la preparazione sono importanti per dare agli operatori gli strumenti per
intervenire con sicurezza e contenere l'ansia, prima di tutto in se stessi e poi negli altri. Questo
può essere fatto essenzialmente in due modi: o tramite corsi di aggiornamento estemporanei,
esterni alla situazione, cui poi riportare le competenze formatesi; o tramite gruppi di lavoro in
cui discutere l'esperienza propria e di colleghi, con incontri a cadenza periodica che
permettono di seguire nel tempo i casi in osservazione. O con entrambi.
Più che l’entità dei comportamenti e rischi è la non previsione e la non preparazione ad
affrontare le cose che crea ansia e costituisce la maggiore difficoltà.
Occorre invece tener conto che la presenza di bambini che possono dare problemi di questo
tipo è ormai ampiamente prevedibile e dall’esperienza degli ultimi anni lo è in modo crescente.
In mancanza di una adeguata preparazione e organizzazione per affrontare l'emergenza e le
difficoltà, il rischio è di fare confusione, farsi prendere da ansia e reazioni emotive non
sufficientemente pensate, e complicare le cose già complicate.
La rimostranza prevalente degli operatori, al di là dell’incolumità fisica, è di non poter
contemporaneamente occuparsi del bambino e del resto della classe e la soluzione richiesta è
quindi l'insegnante di sostegno o di ulteriore personale, ma se questo non pone questioni per
le strutture private le pone per quanto riguarda le norme della Legge 104. Ma la presenza di
insegnanti di sostegno o di operatori per l’infanzia, come abbiamo avuto esperienza varie
volte, spesso non risolve i problemi e non evita le emergenze.
Fondamentale è il concetto che le strutture devono organizzarsi per affrontare e poter
contenere le situazioni che si creano al loro interno, chiarendo compiti, spazi di competenza,
procedure e modalità, in modo che gli operatori sappiano di base come affrontare le varie
situazioni che possono presentarsi.
Uno dei problemi che emergono più spesso è quello dei contatti scuola/struttura - famiglia: a
questo proposito è opportuno che si crei una buona collaborazione fra le strutture, la famiglia
e i servizi esterni, ma occorre stabilire i limiti delle reciproche competenze, per evitare
interferenze e intrusioni.
In particolare un elemento critico è quello delle comunicazioni tra i diversi interlocutori. Non
c'è di peggio che comunicazioni improvvisate, estemporanee, magari sull'uscio o davanti a tutti
o ai bambini stessi; tanto meno chiamate urgenti durante l'orario scolastico per chiedere
l'intervento dei genitori o semplicemente per informarli seduta stante di quanto sta
avvenendo. Ciò crea solo disagio ulteriore, confusione, svalutazione reciproca e conflitti.
Occorre prevedere modalità di comunicazione di routine e di emergenza, considerando però
che non tocca ai genitori intervenire nella scuola, né avrebbero competenze e capacità per
farlo.
Spesso dalla scuola (ma anche nelle strutture private) viene posta l'esigenza di 'uniformare le
regole' fra casa e famiglia. Si può dire che è un falso problema, l'unica regola importante è che
"comandano gli adulti", a casa i genitori, a scuola gli insegnanti, nelle strutture private gli
operatori per l’infanzia. Che vuol dire che sono gli adulti che hanno la responsabilità della
situazione e devono 'governarla'.
Non occorrono altre regole particolari. Piuttosto il problema è non confondere questa regola, il
principio di autorità e responsabilità, che vale per gli adulti, con la questione di "far sentire
l'autorità degli adulti ai bambini": è l'esperienza che mostrerà ai bambini che gli adulti
comandano e sono responsabili, e che li farà riconoscere come autorità, non le spiegazioni, le
prove di forza o le punizioni. Le violazioni andranno ovviamente sancite, qualsiasi legge
prevede delle sanzioni, ma secondo il regolamento, non come reazioni emotive dell'adulto
all'accaduto. Questo è un aspetto cui occorre dare una particolare importanza, e cozza con la
tendenza dei recenti anni a 'comprendere' e 'accogliere' il bambino, frutto forse di
un'eccessiva psicologizzazione (sbagliata, per di più) che ha fatto inflazionare il termine
'sofferenza psichica', stravolgendone il significato. Più che di 'sofferenza', cui si appellano
spesso molti insegnanti e operatori, preoccupati di usare metodi educativi più giusti e
adeguati, è meglio parlare di 'fatica' di adattarsi, di imparare, di contenere desideri ed impulsi.
La fatica si affronta allenandosi, esercitandosi, un po' alla volta, e l'effetto è quello di
rinforzarsi e fare meno fatica una volta allenati.
Fondamentale è la collaborazione fra famiglia, scuola, strutture varie, servizi, la conoscenza
delle reciproche responsabilità e dei propri spazi, ma senza invasioni di campo, con la
consapevolezza inoltre di potere e dovere solo fare del proprio meglio, ma non di più. Nessuno
ha la ricetta miracolosa o la bacchetta magica.
Gli obiettivi devono essere realistici e progressivi. Primo la sicurezza per tutti, il
comportamento sugli aspetti essenziali, poi via via gli aspetti educativi e infine di
apprendimento.
Molto spesso questa semplice organizzazione di base, che richiede però un forte impegno di
tutti permette di reggere la situazione in attesa che la maturazione del bambino, gli interventi
posti in atto all'esterno, e quanto di più, permettano che la maturazione porti a superare le
difficoltà.
Sintesi:
Routine: chiarire compiti scopi regole e limiti, e possibili sanzioni (Regolamento)
Situazione di Difficoltà: modalità comunicative e relazionali per prevenire le crisi
Emergenza (violenza o minaccia di violenza, fuga, altro): definizione di procedure di
comportamento per affrontare la crisi.
Operatori in gioco e spazi di competenza: personale scolastico a scuola, famiglia all’esterno.
Non violare confini e rispettive competenze e responsabilità
Procedure previste da utilizzare nelle varie situazioni: intervento di direttore, o vice- o
colleghi, inserimento 'contenitico' in classe o gruppi di bambini più grandi
In caso di crisi incontenibile: definire a chi rivolgersi, dentro la scuola, all’esterno (118, forza
pubblica, pompieri, ecc)
Chiarimento di responsabilità, competenze e spazi
Modalità di comunicazione fra operatori e famiglia, per routine, difficoltà, emergenza:
comunicazione urgente solo per trasporto in ospedale del bambino. Altrimenti comunicazioni
su canali predefiniti, privati - non davanti a tutti - con periodicità definita, in modo che la
famiglia è informata e può prendere le sue misure, predefinite, col bambino.
Fra scuola e bambino interessato: rassicurazione e contenimento nell’emergenza, colloquio di
chiarificazione a freddo: la spiegazione di base al ragazzo del comportamento dell’operatore e
dello scopo è fondamentale. Lo scopo durante la crisi è tranquillizzarlo non criticarlo o punirlo.
L’operatore dovrebbe poter contenere le sue reazioni emotive (ansia, paura, rabbia) che
possono precipitare comportamenti sbagliati. La conoscenza e la preparazione serve anche a
questo.
La definizione delle varie procedure può essere fatta da un team scuola/famiglia/servizi sulla
base delle conoscenze generali e delle caratteristiche particolari della scuola, ecc.
Ci sono dei miti duri a morire. Quello della pace come bontà, come armonia, come volersi bene
è uno dei più duri in assoluto. È un mito deleterio, perché sostanzialmente autodistruttivo, che
contiene al suo interno un’impossibilità operativa che lo rende del tutto inutile sul piano
pratico e storico. L’educazione alla pace è un movimento che parte da lontano. Fin dagli inizi
del XX secolo si hanno delle tracce, dei reperti documentari, però sempre con questo fervore
filantropico. L’educazione alla pace finiva con l’attenere al rafforzamento delle zone di luce
dell’essere umano e quindi a tutto ciò che riguardava il miglioramento dei buoni sentimenti.
L’analisi di Franco Fornari, forse lo psicanalista che a livello internazionale ha lavorato di più sui
temi della pace recuperando la tradizione freudiana e kleiniana, ci ha permesso di evidenziare
come questo tipo di posizione fosse fisiologicamente ingestibile, nel senso che conteneva in sé
la sua sostanziale negazione. Negazione dettata dal fatto che è proprio sul terreno della bontà
e dei buoni sentimenti che la cultura di guerra, o comunque le ragioni della violenza, si
raccolgono maggiormente. Il guerriero, il mafioso, il terrorista, l’integralista religioso sono
assolutamente convinti di aderire a una causa il cui scopo è la permanenza di quei valori che gli
antagonisti stanno mettendo in discussione. Questi valori riguardano sostanzialmente il senso
di appartenenza affettivo, ma possono anche essere valori subliminali di tipo ideologico, così
com’è stato per alcuni terroristi, o in tante guerre di liberazione, e implicano un’adesione
incondizionata e fortissima dell’individuo. Questi valori possono riguardare l’ambito della
famiglia, della madre patria, del proprio gruppo, del proprio clan, della propria causa (nei
gruppi di carattere ideologico). C’è comunque sempre un richiamo primario a una simbiosi e a
una fusionalità gruppale di appartenenza che implica la disponibilità dell’individuo al sacrificio
supremo, ovviamente anche al sacrificio di sé, pur di far trionfare i valori in cui crede. Sono gli
stessi valori che vengono predicati da chi fa dell’educazione alla pace un territorio di
enfatizzazione dei buoni sentimenti. Il caso più eclatante è senz’altro quello della mafia, dove
addirittura attività oggettivamente criminali vengono gestite come attività appartenenti al
proprio clan e sotto la componente eticovaloriale della famiglia. Tante volte il termine
“famiglia” sostituisce addirittura quello di mafia. Perciò combattere la mafia sul terreno dei
buoni sentimenti è quantomeno ridicolo e grottesco. Non si tratta soltanto di un adeguamento
passivo e conformistico, così come ci avevano segnalato gli studi di Salomon Asch, di Stanley
Milgram, e poi le riflessioni puntuali della filosofa ebraica Hanna Arendt, ma proprio di una
motivazione psichica che si legittima sulla base di un fortissimo senso di appartenenza, anche
etnica e di sangue, che non solo consente, ma addirittura enfatizza nell’individuo la
disponibilità a creare, come dice Fornari, una cultura paranoica dell’altro, come se fosse l’altro
la causa di ogni male. È difficile, in interviste a militari o comunque a individui impegnati in
azioni non soltanto belliche, ma violente in generale (si pensi ad esempio ai tifosi ultras), non
notare come le loro azioni abbiano un richiamo preciso a delle componenti più grandi, a delle
finalità ideali, a dei sentimenti che vanno al di là del particolare o a una presunta malvagità
personale.
Tale tipo di distorsione della realtà produce, sul piano strettamente educativo, delle difficoltà
relazionali e gestionali facili a immaginarsi.
Possiamo definire queste difficoltà col termine di prescrizioni impossibili, ossia porsi obiettivi
che da un punto di vista della realtà risultano assolutamente incompatibili. Si tratta di strategie
di gestione dei problemi basate sulla banalizzazione la cui logica è sostanzialmente la
seguente: “il problema verrà risolto quando non ci sarà più il problema”. Da un punto di vista
strettamente logico questo è una sorta di tautologia, ma sotto il profilo di gestione dei
problemi nella realtà, purtroppo questa strategia basata sul buon senso ha ancora un
fortissimo impatto. Lo registriamo anche a livello educativo. È diffusa per esempio l’idea che i
litigi fra i bambini scompariranno quando i bambini smetteranno di litigare, oppure quando
tutti si vorranno bene, o quando anche i più agitati saranno tranquilli, i disturbatori non
disturberanno più, i timidi parleranno, e via di seguito, in una lunga serie di autoprescrizioni di
tipo formativo che sono, se non in casi eccezionali, di impossibile raggiungimento. Purtroppo
spesso queste prescrizioni diventano anche obiettivi didattici.
Nell’ambito dei temi che stiamo trattando troviamo programmazioni educative in cui fra gli
obiettivi viene incluso quello di evitare litigi fra i bambini. A partire da questo esempio
possiamo fare una serie di considerazioni che ruotano attorno alla inevitabilità di certi
fenomeni, comportamenti e situazioni. Esiste una mitologia percettiva legata alla pace come
armonia che non consente di affrontare le situazioni di perturbazione, di conflittualità, di
aggressività e di tutto quello che succede nel momento in cui la divergenza entra a far parte
della relazione interpersonale. Da questo punto di vista è chiaro che le prescrizioni impossibili
generano ansia, in quanto irraggiungibili, generano uno stato di tensione permanente, di
insoddisfazione, uno stato talvolta di frustrazione. Oggi riscontriamo spesso tra gli educatori un
senso di sconforto in relazione alle difficoltà relazionali che si presentano anche soltanto nel
gestire la disciplina, come se il contrasto fosse imputabile al contenuto, e non al processo.
Certi fenomeni sono fisiologici: componenti di ordine e di disordine appaiono imprescindibili; il
problema è come affrontarli, con che spirito, con che atteggiamento. Il problema non sono
tanto le situazioni in sé, quanto lo spirito con cui l’educatore cerca di affrontarle. Ciò vale per i
genitori, per gli insegnanti. Oggi c’è una forte enfasi sulle difficoltà genitoriali nell’ambito della
gestione dei preadolescenti e degli adolescenti, ma può essere che il problema non risieda
tanto nelle difficoltà delle caratteristiche dei giovani, che peraltro risultano oggi ben più vicini
ai genitori che non le generazioni precedenti, quanto nella difficoltà da parte del genitore di
collocarsi in un contesto relazionale problematico e viverlo come una dimensione che possa
comunque avere senso. È necessaria una decontrazione emotiva, accettando la dimensione di
perturbazione come componente essenziale e normale della relazione stessa. In questo modo
l’ansia che le prescrizioni impossibili generano si abbassa, diventa più facile allora introdurre
elementi positivi dentro situazioni che apparentemente risultano distruttive.
Si arriva pertanto alla necessità di affrontare la questione della pace sotto un profilo
completamente diverso rispetto a quella che è stata finora la cultura del buon senso. Se la
pace è stata considerata antitetica rispetto al conflitto, e il conflitto visto come guerra, come
devastazione, come combattimento armato (sono queste sostanzialmente le definizioni che
compaiono su tutti i dizionari) un nuovo modo per affrontare le possibilità di una pace che sa
essere qualcosa di concreto e operativo, è sottoporre sotto il profilo epistemologico il termine
e la concezione stessa di pace a una ristrutturazione semantica, culturale e psichica.
Recentemente si è sviluppato un filone di ricerca, specialmente in ambito educativo, che
considera la pace coerente con il conflitto. La pace è conflitto, in quanto permette di
mantenere la relazione anche nella divergenza. In quest’ottica la guerra spesso assume le
sembianze di un tentativo paradossale e ossessivo di ristabilire la pace intesa come un
elemento di aconflittualità, di ordine e di assenza di divergenze, contrasti e diversità. Questo lo
abbiamo registrato con molta enfasi e anche con molta ripugnanza nell’ambito di quelle che
oggi si definiscono “guerre etniche”, che appaiono come un tentativo psicotico di ristabilire un
ordine che passa attraverso l’eliminazione totale della perturbazione che l’altro procura con la
sua presenza.
L’educazione alla pace tenta di proporre un’idea di pace come conflitto, e quindi una nuova
mappa per attraversare questi territori. Una mappa che abbia questo orientamento preciso,
assumere il conflitto come un elemento generativo, un elemento creativo, una risorsa
all’interno della costruzione di una serie di relazioni che non possono prescindere dal
valorizzare e contenere la diversità. È chiaro che in questo tipo di lavoro emerge la difficoltà
nel decentrarsi, nel capire le ragioni altrui, nell’accettare la divergenza. Sta in questo la sfida
dell’educazione alla pace, nel creare le condizioni affinché il rapporto possa alimentarsi non
solo nella simpatia ma anche nella discordanza e nella diversità. È una sfida enorme ma
imprescindibile all’interno di una società che diventa sempre più densa di complessità etniche
e sociali, in cui i cambiamenti sono molto rapidi, in cui l’ingresso di immigrati procura
continuamente ventate di fisiologiche perturbazioni.
L’educazione alla pace non significa altro che un processo di apprendimento di un’arte della
convivenza più raffinata della semplice tolleranza, del semplice controllo della diversità.
Un’arte della convivenza che diventa un addestramento continuo, incessante, una vera e
propria alfabetizzazione che ci porti ad acquisire al livello primario, relazionale, la capacità di
stare dentro il conflitto e la diversità come un momento di crescita, e non più come un fattore
di paura o di minaccia.
Le vere relazioni umane consentono il conflitto, ossia il confronto, lo scambio, la divergenza e
l’opposizione. I genitori che non consentono l’opposizione a se stessi da parte dei figli,
trattandoli come amichetti con cui cercare una continua complicità, impediscono agli stessi
figli di mettersi alla prova e di usare la relazione con gli adulti come banco di prova del proprio
valore, come territorio di esplorazione e di apprendimento. La formula “so-stare nel
conflitto”implica proprio l’accettazione della necessità che la relazione rappresenti l’occasione
per ciascuno di esprimere parti di sé, e liberare le proprie dimensioni più vere e più profonde,
che solo nelle relazioni conflittuali possono venire alla luce. L’educazione autoritaria negava
questa possibilità con la formula “o con le buone o con le cattive”, e imponeva un’unica logica
-in genere unilaterale- che era la logica del raddrizzare, cercando delle facili scorciatoie che in
qualche modo escludessero il conflitto. Oggi viviamo un altro tipo di situazione: spesso e
volentieri gli educatori rinunciano a ogni tipo di confronto, rinunciano al loro potere educativo,
accontentandosi di una facile dimensione di accondiscendenza reciproca, che però non
consente la crescita. Non esistono ricette, modalità preconfezionate nelle relazioni, ma esiste
una necessità di vivere la relazione in ambito educativo e di assumere questa relazione anche
conflittuale come una sfida che porta all’apprendimento di competenze, e permette alle nuove
generazioni di mettersi alla prova.
Troppo spesso il discorso sul conflitto è stato impostato nel senso della soluzione, senza
rendersi conto che tanti conflitti sono di per sé irrisolvibili. Gli esperti distinguono fra conflitti
riducibili e irriducibili: molti conflitti sono irriducibili, cioè non hanno possibilità di
cambiamento. L’alfabetizzazione al conflitto affronta questo tipo di situazione non tanto sotto
il profilo della soluzione, ma sotto il profilo della gestione: come possiamo gestire le situazioni
che non hanno una prospettiva di cambiamento vero e proprio, e che racchiudono in sé un
elemento di negazione dello sviluppo di una soluzione? La velleità di soluzione del conflitto
nasconde comunque e quasi sempre una velleità totalizzante, fatta di risposte esatte, di
normativizzazione, che può portare anche a delle conseguenze nefaste. Per contro, la
dimensione trasformativa ci permette, in un contesto di problematicità, di cercare le
condizioni affinché questa situazione possa creare meno danni possibili e possa eventualmente
evolversi in senso positivo. L’individuo, specialmente l’educatore, deve rafforzare la capacità di
stare dentro il conflitto, di non pensare sempre alle soluzioni. Vediamo tanti insegnanti
indeboliti anche nei confronti dei “casi difficili” a scuola a causa della loro difficoltà a
trattenere l’ansia della soluzione. Il loro desiderio di tornare in una condizione di ordine e di
stabilità, il desiderio insomma che le cose tornino al loro posto li indebolisce.
Oggi l’educatore deve saper convivere con le situazioni dissonanti, con l’informalità più che
con la formalità.
Una volta c’erano i galatei, che prescrivevano i comportamenti giusti, oggi non esistono più: è
l’educatore che aiuta nella crescita, ponendosi come riferimento per i più piccoli. Nell’ambito
dell’alfabetizzazione al conflitto questo diventa assolutamente inevitabile.
Il primo passo è: Ricorda che il conflitto è un problema da gestire non una guerra da
combattere. Questo primo punto riguarda il tema della percezione, e propone una
ristrutturazione percettiva e semantica volta a cogliere il conflitto come una situazione da
gestire. Detto così può sembrare un obiettivo fin troppo scontato, ma in realtà, specialmente
in ambito educativo, succede spesso che gli educatori siano più propensi ad abolire il conflitto
contrastando direttamente chi lo porta che non cercando di affrontare la situazione. È più
facile per l’educatore, spesso e volentieri, annichilire il soggetto che porta il problema che non
affrontare il problema stesso. Questo primo passo fornisce all’educatore l’occasione di
cambiare la prospettiva, prendere atto dell’esistenza di una situazione critica e cercare di
affrontarla.
Il secondo passo dice: Conta fino a dieci prima di agire. Questo passo riguarda la dimensione
temporale, la capacità di aspettare il momento giusto, prendere tempo, evitare le reazioni
impulsive e compulsive. È un’indicazione di grande utilità tattica e strategica. Tutte le volte che
si può evitare una reazione immediata si rafforza la possibilità che una provocazione possa
essere trasformata in un’esperienza di apprendimento. Inoltre prendere tempo consente
all’educatore di spostare il conflitto da una logica reattiva a una logica di comunicazione, intesa
come livello simbolico della relazione, in cui si passa all’elaborazione del problema. La
comunicazione è già una ritualizzazione del conflitto. Troppo spesso in ambito scolastico si
lavora immediatamente sulla comunicazione. Non va dimenticato che quando si arriva alla
comunicazione il conflitto, in quanto problema, è già in fase di definizione. La competenza al
conflitto riguarda la capacità di spostare il conflitto sul piano della comunicazione. In ambito
educativo molti ragazzini hanno difficoltà, da questo punto di vista, e vanno aiutati
sistematicamente ad andare oltre la loro tendenza alla reazione immediata e spesso brutale.
Il terzo passo dice: Non fare muro contro muro. Questo ci ricorda il momento trasformativo
del conflitto, la possibilità di elaborare la provocazione in senso non simmetrico, trovando una
strada diversa da quella che la provocazione suggerisce. È un momento sdrammatizzante:
quando c’è tensione il primo passo da fare è abbassare il livello della tensione, consentire la
decantazione, evitare l’avvitamento e il frequente deragliamento dai contenuti stessi del
conflitto. Questo è un fenomeno che compare in ogni tipo di conflitti, anche in quelli familiari.
Immaginiamo, ad esempio, che un marito risponda alla moglie, irritata perché lui ha rovesciato
il caffè sulla tovaglia pulita, che lei non è pettinata bene. In situazioni del genere siamo di
fronte alla logica del muro contro muro, in cui gli antagonisti vogliono prevalere ad ogni costo,
privilegiando le strategie di superiorità rispetto alle strategie di negoziazione.
Il quarto punto è: Rispetta i contenuti del conflitto. Questo punto è strettamente collegato al
punto precedente, e invita a evitare le “risposte tangenziali”, molto diffuse nella
comunicazione conflittuale distorta. Quando non si riesce ad assumere il problema in quanto
tale, ma si rimanda sempre a un quadro generale, a una situazione precedente, a un contesto
di antipatia o simpatia personale, si ricorre a risposte tangenziali. Questo atteggiamento
implica un senso di manipolazione. In ambito educativo, il ragazzo o la ragazza che propone
qualcosa che ha un forte contenuto perturbativo, se affrontato debitamente gli consente di
sentirsi riconosciuto. La risposta tangenziale è invece umiliante, perché non riconosce all’altro
la possibilità di proporre dei contenuti conflittuali, e impedisce all’altro di proporre una propria
visione delle cose. Questo punto è importante perché riguarda il riconoscimento di se stessi,
che, in senso ontologico, ci riguarda tutti. Ciascuno di noi nel momento in cui non coglie nella
comunicazione il rispetto di ciò che ha espresso avverte la sensazione di fastidio che sta
creando all’altro.
Il quinto punto riguarda un tema fortemente pedagogico: Evita il giudizio stigmatizzante;
sperimenta la critica costruttiva. Ci sono due dimensioni nella gestione educativa del conflitto
particolarmente importanti: la dimensione dell’ascolto e la dimensione del contenimento.
Questa è la dimensione dell’ascolto. Il giudizio è il contrario dell’ascolto. Giudicare in senso
stigmatizzante implica umiliare, ma allo stesso tempo è vero che in molte occasioni è
necessario esprimere un consiglio, un’indicazione, un suggerimento, o anche un ordine. Come
si può fare? Esistono strategie basate sulla “critica costruttiva”, una modalità di porgere
all’altro una serie di osservazioni senza suscitare un senso di minaccia, senza che l’altro si senta
giudicato. Presenta varie fasi: la prima è chiedere permesso; le altre fasi riguardano la gestione
del problema, che mira a mantenere la critica sul problema e non sulla persona. È un
atteggiamento diverso: porgere la critica in modo che l’altro non si senta invaso.
L’ultimo punto dice: Sappi dire di no, quando occorre. Nell’ambito dell’educazione alla pace
molti hanno sempre sostenuto che fosse molto più pericolosa una posizione di passività, di
conformismo, che non una posizione di divergenza e di critica attiva e creativa. Il saper dire di
no è una competenza essenziale in un contesto di crescita sui temi dell’educazione alla pace.
Saper dire di no vuol dire staccare la spina, evitare un’adesione conformista a delle procedure
che possono danneggiare. I ragazzi si trovano spesso coinvolti in gruppi dentro ai quali possono
svilupparsi azioni o comportamenti lesivi nei confronti degli altri (si pensi a fenomeni come il
bullismo, le bande, i gruppi di ultras, basati sull’omertà e sulla sottomissione). Saper dire di no
vuol dire mantenere sempre la propria idea, il proprio punto di vista, conoscere il proprio
valore. Nel rapporto educativo, gli educatori devono assumere la capacità di dire di no,
tollerando anche la frustrazione che questo dire di no comporta nei ragazzi, per uscire da un
rapporto di amichevolezza che rischia di essere molto pericoloso. Dire di no significa assumersi
una responsabilità adulta, il che non coincide con l’assumere un atteggiamento negativo
continuo, sistematico, ma un atteggiamento opportuno nei contesti adeguati. Questo aiuta i
ragazzi ad assumere lo stesso atteggiamento nel momento in cui si trovano in situazioni in cui
dire di no potrà salvaguardarli anche personalmente (ad esempio evitare di salire su un’auto
con l’autista ubriaco, di notte, dopo la discoteca).
Per concludere
L’educazione alla pace è un processo di alfabetizzazione relazionale nel cuore dei processi
sociali del nostro tempo, per garantire agli attori sociali, a partire da quelli che sono i
protagonisti dei momenti formativi, la capacità di leggere, di riconoscere e di produrre una
cultura che sappia vivere il conflitto come un potenziale di crescita. È un processo che nasce
nella relazione. Non si tratta di insegnare contenuti pacifisti, ma di riconoscere la possibilità di
uno scambio continuo con l’altro. L’educazione alla pace ha la necessità di rivedere sempre i
contenuti che vengono trasmessi da una generazione all’altra, specialmente nell’ambito dei
temi legati al nazionalismo, al razzismo, all’intolleranza, ma non va dimenticato che il razzismo
e l’intolleranza sono comunque delle consegne che agiscono a livello relazionale, in termini
subliminali, e non di trasmissione diretta. In quest’ottica assume un’importanza fondamentale
la formazione degli educatori, una formazione nuova che sappia incidere sulle capacità di
relazionarsi delle nuove generazioni in una logica di alfabetizzazione al conflitto.
Psicomotricità
Il termine psicomotricità indica l'insieme delle dottrine e pratiche terapeutiche che riguardano la reciproca
integrazione delle funzioni psichiche con quelle motorie, quali elementi fondamentali del comportamento
dell'uomo. Questi due tipi di funzioni, infatti, che si presentano rudimentali alla nascita, evolvono in stretta
interdipendenza e via via si differenziano e si specializzano, mantenendo però sempre connessioni e legami
profondi. La complessa unione psicomotoria può essere compromessa, durante lo sviluppo infantile o
nell'età adulta, sia da patologie neurologiche sia da turbe psichiche e dell'umore, dando così origine ai
disturbi psicomotori. L'ambito proprio della psicomotricità, caratterizzato dalle sue patologie e dalle
relative modalità terapeutiche, è stato definito da esponenti della neuropsichiatria e della psicologia
evolutive in ambiente di lingua francofona negli anni Cinquanta e Sessanta del 20° secolo. Da tale
interpretazione sono derivate fondamentalmente una valorizzazione delle esperienze corporee nello
sviluppo infantile e una concezione antropologica che riconosce l'importanza della corporeità non solo nel
processo educativo ma in tutte le età dell'uomo.
sommario: 1. Il corpo nella psicologia genetica, nella psicoanalisi e nella fenomenologia. 2. La definizione
dei disturbi psicomotori. 3. Il vissuto psicomotorio. 4. L'approccio terapeutico. 5. L'educazione
psicomotoria. □ Bibliografia.
1. Il corpo nella psicologia genetica, nella psicoanalisi e nella fenomenologia
L'aspetto genetico della psicologia è stato preso in considerazione dagli psicologi H. Wallon e J. Piaget. Già
dagli anni Venti del 20° secolo, Wallon parla di sindromi e di tipi psicomotori, ma i suoi contributi più
rilevanti per lo sviluppo della concezione psicomotoria derivano dall'aver posto in evidenza il ruolo della
tonicità muscolare e della postura nello sviluppo delle relazioni e della personalità. L'emozione è studiata
con riferimento alle concomitanti modificazioni del tono e della postura - per es. gli atteggiamenti corporei
generalizzati od orientati, come la mimica - che costituiscono una fondamentale modalità di rapporto. Le
reazioni tonico-emozionali sono infatti per Wallon i primi indicatori della vita psichica. Anche l'iniziale
fusione affettiva tra la madre e il bambino si esprime mediante fenomeni motori che rivelano come, nella
relazione, la postura corporea 'si impregna' delle caratteristiche posturali materne. Inoltre, la qualità di
questo dialogo corporeo ed emozionale ha una notevole importanza per l'organizzazione delle
configurazioni del carattere. Tale concezione del legame del tono muscolare e della postura con fenomeni
emozionali accompagnerà costantemente la psicomotricità nei suoi sviluppi.
Più o meno nello stesso periodo Piaget descrive dettagliatamente lo sviluppo cognitivo del bambino. I primi
stadi dell'evoluzione dell'intelligenza sono chiamati fino all'età di 2 anni sensomotori e successivamente,
fino a 6 anni, preoperatori. In essi il ruolo dell'azione e del movimento è fondamentale: gli schemi di azione
motoria sono considerati l'equivalente delle operazioni logiche che si svilupperanno solo successivamente,
al punto che Piaget considera il pensiero un'azione interiorizzata. Anche l'acquisizione delle condotte
simboliche risulta favorita da esperienze motorie. Concorrono alla funzione simbolica attività come
l'imitazione e il gioco, nelle quali nel 'far finta di' l'oggetto esterno è utilizzato in funzione delle immagini
interiori del bambino. Mentre per Wallon l'imitazione favorisce il passaggio da uno stadio iniziale di fusione
tonico-emozionale tra mamma e bambino a uno stadio di successivo riconoscimento della propria
estraneità all'altro, Piaget sottolinea l'importanza dell'imitazione nel costituire le rappresentazioni
simboliche. Entrambi, poi, mettono in rilievo che, nell'imitazione, il modello esterno viene rappresentato
mediante un adeguamento posturale del corpo e, più in generale, indicano che l'attività motoria e la psiche
sono due aspetti di uno stesso processo evolutivo di adattamento attivo e costruttivo al proprio ambiente.
Dal punto di vista psicoanalitico, il corpo è inteso come luogo sia di manifestazione sintomatica dei conflitti
psichici (per es. con il meccanismo della somatizzazione v. psicosomatica), sia di origine di tensioni ed
eccitazioni che hanno i loro esiti sul piano psichico. S. Freud parla di Io corporeo (l'Io è, delle tre istanze
psichiche - Io, Es e Super-Io -, quella che presiede all'adattamento al mondo esterno e alla conseguente
costruzione dell'unitarietà della persona) per designare quella parte dell'Io che deriva dalle percezioni del
corpo, in modo particolare quelle che originano dalla superficie di questo. Il corpo è tuttavia soprattutto il
corpo degli orifizi e delle mucose, che media il rapporto fra interno ed esterno, e che produce, con
l'elaborazione psichica dell'eccitazione somatica, le fantasie inconsce di rapporto. Altri autori di ambito
psicoanalitico, fra i quali M. Klein, R. Spitz, D.W. Winnicott, W. Reich, hanno poi contribuito a elaborare
ulteriormente l'importanza della corporeità nello sviluppo psichico. Tra questi, Reich considerò anche la
componente muscolare, evidenziando la correlazione tra disturbi emozionali a sfondo conflittuale e
alterazioni dell'assetto muscolare. La psicoanalisi, in sostanza, ha messo in luce l'importanza del vissuto
corporeo nelle prime determinanti fasi dello sviluppo del bambino e ha proposto un superamento
dell'aspetto anatomofisiologico, trattando così di un corpo immaginario, prodotto dall'elaborazione
psichica inconscia senza approfondire, proprio in virtù della sua autodefinizione, le risorse corporee del
movimento e dell'azione nella relazione con l'altro e con il mondo esterno, aspetto che è invece
fondamentale nell'approccio psicomotorio. Per la fenomenologia di M. Merleau-Ponty la motricità è
centrale nel costituire il rapporto fra lo spazio corporeo e lo spazio esterno, nella percezione degli oggetti,
nel modo di muoversi nel mondo e, di conseguenza, nel rivelare il significato che ha il mondo per noi.
Merleau-Ponty parla di 'corpo-proprio', che non è solo il corpo a sé stante, separato dal mondo, e
nemmeno solo il corpo soggettivo che ognuno percepisce. Dall'incontro tra il corpo e il mondo nasce il
corpo-proprio, e ciascuno dei due non ha significato se si prescinde dall'altro. Un oggetto è percepito in
relazione al corpo, e il corpo si muove nel mondo. La motricità, lungi dall'essere un'ancella della coscienza
che trasporterebbe il corpo nello spazio, rivela invece sia i significati degli oggetti sia lo spazio espressivo
del corpo. La psicomotricità deve molto all'approccio fenomenologico: il movimento è rivelatore non solo
degli atteggiamenti individuali, ma soprattutto dell'inscindibile legame fra l'uomo e l'Universo in cui vive e
che fa proprio. Per la psicomotricità, come per la fenomenologia, il mondo esterno è incorporato nel nostro
agire. La terapia psicomotoria consiste infatti proprio nel ripercorrere le tappe attraverso cui il movimento
si è plasmato nel mondo, per ricostituire le fratture tra corpo e mondo che si possono osservare in molte
patologie.
2. La definizione dei disturbi psicomotori
Uno dei primi disturbi psicomotori analizzati è stato quello definito come sindrome di débilité motrice a
partire dal 1909 da E. Dupré, attraverso lo studio della motricità infantile da un punto di vista neurologico.
Sulla base di tale approccio, che rappresenta il punto di partenza del discorso psicomotorio, la débilité
motrice veniva descritta come una serie di disturbi comprendenti alterazione dei riflessi, sincinesie
(movimenti 'spuri' attivati in concomitanza di normali movimenti), goffaggine dei movimenti volontari,
paratonie (difficoltà a rilasciare contrazioni muscolari volontarie), instabilità, tic, mioclonie (contrazioni
muscolari improvvise e ripetute) e balbuzie. Con la débilité motrice Dupré individuava uno stato patologico
causato non da lesioni cerebrali focali, bensì da un arresto di maturazione del sistema nervoso.
L'indicazione di una causa neurologica non attribuibile a un danno anatomico circoscritto rappresentava
anche, secondo Dupré, un tentativo di superare il modello anatomoclinico di ispirazione positivistica, per il
quale l'alterazione di una funzione doveva trovare il corrispettivo in una specifica alterazione anatomica
localizzata. Dupré sottolineava invece il parallelismo tra funzioni psichiche e motorie, che si presentano
come i due lati di una medaglia. Un tratto caratteristico della débilité motrice era infatti la contemporanea
presenza di infantilismo motorio, di deficit intellettivi e di alterazioni del carattere. La débilité motrice di
Dupré venne riesaminata e criticata a fondo da J. de Ajuriaguerra, dalla cui revisione emergono i capisaldi
del campo psicomotorio sotto l'aspetto clinico e terapeutico. Basandosi sui risultati di un'approfondita ed
estesa indagine neurologica infantile, de Ajuriaguerra e G. Bonvalot-Soubiran (1959) dimostrarono che la
casistica di Dupré non era stata esaminata nella sua evoluzione longitudinale, metodologia fondamentale in
ogni indagine neuropsichiatrica infantile. Inoltre, sotto la categoria débilité motrice erano state incluse
manifestazioni di diversa eziologia, comprese alcune forme di encefalopatia. De Ajuriaguerra studiò
sistematicamente, nella loro evoluzione a partire dalla nascita, il tono muscolare, i riflessi e le sincinesie in
assenza di encefalopatie, dimostrando che lo sviluppo del tono e della motricità è intimamente fuso con lo
sviluppo emozionale, dell'orientamento, del gesto e del linguaggio. Egli definì pertanto la nuova categoria
dei troubles psycomoteurs, nei quali rientrano: 1) la debilità motoria, in cui la goffaggine e le difficoltà a
realizzare l'azione sono correlate con sentimenti di disagio del bambino nel suo stare al mondo; 2)
l'instabilità psicomotoria, contrassegnata da labilità dell'attenzione, motricità incontrollata e ipervigilanza,
che sono caratteristiche tipiche del periodo tra i 2 e i 3 anni, e che hanno perciò fatto pensare a una specie
di 'permanenza' del bambino in questo stadio di sviluppo; 3) i disordini della realizzazione motoria,
consistenti in disprassie contraddistinte da una seria mancanza di abilità nel compiere le azioni quotidiane,
nel regolare le sequenze ritmiche e nell'organizzare lo spazio; 4) certi tic e la balbuzie; 5) un'abnorme
persistenza e alterazione di abitudini motorie infantili quali dondolii e movimenti ritmici. I troubles
psycomoteurs presentano inoltre i seguenti tratti distintivi: non derivano da un danno organico evidente;
nello stesso soggetto si manifestano variabili nella forma, intensità e durata, perché sono legati alle
sollecitazioni ambientali e relazionali; mostrano un carattere espressivo quasi caricaturale e una
somiglianza con le reazioni primitive di contatto, rifiuto, aggressività, passività.
Essi definiscono un quadro di disturbi denotato da una stretta dipendenza da fattori affettivi e relazionali,
consentendo inoltre la 'lettura' di una componente comunicativa: possono infatti segnalare stati di disagio
e intensificarsi o ridursi in relazione al senso che il soggetto vive nell'azione che compie. Rispetto al
parallelismo di Dupré, qui l'idea portante è che le funzioni psichiche e motorie siano non già due aspetti di
uno stesso fenomeno, bensì funzioni diverse seppur profondamente integrate. Nelle manifestazioni
espressive toniche e posturali le funzioni psichiche e motorie non sono mai separate. Con la definizione dei
troubles psycomoteurs l'ambito del controllo tonico ed emozionale è stato posto al centro
dell'organizzazione relazionale e dell'adattamento all'ambiente, diventando una chiave di lettura di
problematiche evolutive anche al di là delle manifestazioni che definiscono la sindrome dei troubles
psycomoteurs. L'intervento psicomotorio si cimenta in tal modo anche su altre patologie sia di tipo
relazionale sia conseguenti a lesioni riguardanti il sistema nervoso.
3. Il vissuto psicomotorio
La psicomotricità riconosce alcune categorie del vissuto corporeo su cui agire, quali il tono muscolare, la
postura, il movimento, le relazioni con lo spazio e il tempo, la percezione di sé e il rapporto con gli oggetti
esterni. Esse costituiscono il terreno dell'azione psicomotoria, un po' come il terreno di psicoterapie più
tradizionali è costituito dal materiale verbale-immaginativo. Si potrebbe dire, per semplificare, che
comprendere e modificare le categorie del vissuto corporeo, isolabili sul piano teorico, anche se
intimamente intrecciate nell'esperienza soggettiva, è il compito specifico dello psicomotricista. Dalle
premesse storiche e teoriche cui si è fatto fin qui riferimento discende che l'aspetto importante per lo
psicomotricista non è tanto la descrizione di queste categorie con il linguaggio della chinesiologia, bensì la
loro modellabilità nell'azione. Tra queste categorie viene riconosciuta un'importanza primaria, sia durante
lo sviluppo sia nel rapporto terapeutico, al tono muscolare, cui si è già accennato, come tessuto della
relazione. Il bambino emerge gradualmente da uno stato di ipertono neonatale e da un'elevata reattività
muscolare generalizzata e le variazioni di questo 'fondo tonico' costituiscono la prima risposta all'ambiente.
Inizialmente si assiste alla semplice comparsa di alternanze tra stati di allarme e di riposo, accompagnati da
variazioni del tono, ma ben presto lo stato tonico si arricchisce di modulazioni più specifiche, per es. in
risposta alle cure materne, attraverso le quali si instaura un dialogo tra madre e figlio basato su stati tonico-
emozionali. Tale 'dialogo tonico' è importante per modellare e differenziare le risposte del bambino. Su
questa trama si svilupperanno prima le relazioni affettive di accettazione e di rifiuto, di dipendenza e
autonomia, poi le sfumature delle relazioni più evolute e gli atteggiamenti verso il mondo esterno. Come
affermano E. Berti, F. Comunello e G. Nicolodi (1988): "Il tono può allora essere definito il principio
informatore della relazione del soggetto con il mondo, ciò che trasforma una posizione in postura,
determina l'organizzazione e la qualità del movimento e, tramite questo, informa delle connotazioni
affettive con cui sono vissuti il tempo e lo spazio" (pp. 66-67).
Altra importante categoria si riferisce alla postura, nella sua funzione di interfaccia con il mondo. In
psicomotricità è utile stabilire la differenza tra posizioni e posture. Se una posizione è univocamente
definita dalla disposizione relativa dei segmenti corporei, le posture, oltre a essere caratterizzate da una
certa posizione del corpo, sono anche determinate da un certo tono muscolare. Ne consegue che il tono,
riflettendo la situazione comunicativa con il mondo, conferisce alla posizione corporea connotazioni
espressive e affettive trasformandola in postura. Le posture assumono perciò un duplice valore: nella loro
realizzazione tonica veicolano la componente relazionale, mentre la spazialità del corpo con cui si
modellano produce forme che hanno una componente segnica. Così, per es., una posizione di apertura
corporea e di disponibilità può essere confermata o meno dalla componente tonica con cui si realizza.
Questa duplice modalità comunicativa, spaziale e tonica, permette di lavorare sugli aspetti di coerenza,
contraddizione e paradosso del vissuto corporeo. Fondamentale è poi il movimento, la cui definizione non è
facile, se non si vuole rischiare di banalizzarlo, da una parte, o di fare delle vuote allegorie, dall'altra. Certo,
il movimento è vita, e la qualità e l'organizzazione del movimento sono indicatori di come e quanto il corpo
sia composto nella sua unitarietà e quanto sia efficace il suo armonizzarsi con il mondo esterno. Il
movimento è la 'melodia cinetica' con cui si disegnano le concatenazioni delle figure motorie; la
modulazione tonica che questa richiede evidenzia il confine tra ciò che è trattenuto e impedito e ciò che è
naturalmente espresso e realizzato. Le possibili alterazioni del movimento - inibito, contratto, frenetico,
afinalistico, stereotipato -, quando non siano imputabili a patologie neurologiche, denunciano le fratture
del corpo con il mondo. Se il coreografo fa disegnare le figure della danza con il movimento, lo
psicomotricista intende aiutare il soggetto a esprimere le figure della sua danza personale, agevolando il
superamento di blocchi, timori, impedimenti relazionali. Riguardo poi alle relazioni con lo spazio e il tempo,
è necessario prima di tutto dire che il tempo di cui si occupa la psicomotricità non è il tempo della fisica,
cioè quello lineare e che preesiste agli eventi che vi succedono: è invece il tempo psicologico, che si
struttura intorno agli eventi e alla loro distanza. Ne esistono varie forme e rappresentazioni: ciclico, lineare,
compresso, dilatato, rituale, biologico. Esso si struttura in relazione alle seguenti alternanze:
assenza/presenza, attesa/compimento, ricordo/progetto. La patologia dell'organizzazione temporale
presenta un'estesa gamma di alterazioni che vanno dalle difficoltà a ritmare le azioni fino alla ripetizione
ossessiva di gesti e rituali, con i quali si tenta di riempire i vuoti o di rimediare all'angoscia. Questa sorta di
riempimento artificiale del tempo, in effetti un suo svuotamento, si coglie come stallo e fallimento del
desiderio e dell'attesa. La ricostruzione di una corretta organizzazione temporale permette anche il
recupero sia delle coordinazioni motorie più elementari sia dei codici più evoluti, quali i linguaggi simbolici.
Anche lo spazio, come il tempo, oltre a essere descritto dalla fisica, può assumere una dimensione
psicologica. Lo spazio è anzitutto uno spazio vissuto, potremmo dire abitato: come il tempo, non preesiste a
chi lo abita ed è carico di valenze affettive e simboliche. Per converso, modificare l'esperienza dello spazio
vissuto si traduce in modificazioni delle dinamiche psichiche, ed è questo il piano su cui lavora lo
psicomotricista. L'azione che collega lo spazio corporeo con lo spazio extracorporeo struttura un'esperienza
in cui si fondono gli aspetti affettivi e cognitivi. Ciò è testimoniato anche dai giochi dei bambini. Si prenda in
considerazione, per es., il gioco del nascondersi: con esso si sperimenta una gamma di rapporti con l'altra
persona - all'altro ci si sottrae e allo stesso tempo si vive l'attesa di essere ritrovati e riconosciuti - e
contemporaneamente si struttura una rappresentazione dello spazio. Ma il dialogo tonico che intercorre
tra la madre e il bambino è già a tutti gli effetti un'esperienza dello spazio in cui si fondono gli aspetti
affettivi e cognitivi. Dalla qualità di queste coerenze affettive e cognitive dipenderanno le modalità con le
quali ci si può rappresentare il mondo e con cui ci si può muovere in esso.
4. L'approccio terapeutico
Prima ancora che si fossero sviluppate, a opera di psicomotricisti dei decenni successivi, terapie
psicomotorie volte alle problematiche dell'identità, già nel 1962 lo stesso de Ajuriaguerra sosteneva che "le
terapeutiche psicomotorie che agiscono e modificano la componente fisica corporea sono di fatto anche
delle attività psicoterapiche" (p. 489). Con il tempo, la terapia psicomotoria è venuta a definirsi anche come
terapia relazionale a mediazione corporea. Le sindromi per le quali è indicato il trattamento psicomotorio si
possono attualmente raggruppare in tre categorie: 1) turbe dello sviluppo psicomotorio e disordini
psicomotori (disturbi tonico-emozionali; inibizione e instabilità psicomotoria; ritardo dello sviluppo
psicomotorio; turbe dello schema corporeo, della lateralizzazione, dell'organizzazione spaziotemporale); 2)
disordini della programmazione e della realizzazione motoria (disprassie; incoordinazione motoria e
gestuale); 3) disturbi dello sviluppo psichico (turbe dell'adattamento emozionale e relazionale, e della
rappresentazione corporea; disordini di personalità e di identità; ritardo mentale). Per questi disturbi
l'intervento psicomotorio si affianca a trattamenti di altro tipo. Mentre il terreno su cui lo psicomotricista
lavora sono le categorie psicomotorie, e in particolare l'assetto tonico-posturale, lo strumento d'intervento
è l'azione. Si tratta, in realtà, di un'interazione, organizzata in una sorta di narrazione. L'azione può anche
assumere il ruolo di intermediazione tra la vita immaginaria del bambino e la realtà condivisa. Il lavoro
terapeutico tramite l'azione non è impostato sul sintomo, né sullo svelamento delle sue cause nascoste, ma
si mantiene sul terreno del rimodellamento e della plasmabilità tonica dell'espressività del corpo. Questo
modellamento del vissuto psicomotorio mediante l'azione ha anche un'altra caratteristica: propone una
dimensione di scoperta, di invenzione, di gioco, intendendo con ciò quell'ambito creativo dell'esperienza
non precostituita, quel luogo magico in cui la realtà viene reinventata ma non negata.
Prendiamo come esempio semplice di approccio terapeutico una sequenza di lavoro sul fondo tonico,
operata tramite la mimica facciale. Il caso trattato è quello di un bambino con seri problemi di identità, che
non riconosce la sua immagine allo specchio e prova verso di essa sentimenti di ostilità. Mentre la guarda,
la sua mimica e la sua voce rivelano quanto l'immagine riflessa gli sia estranea: contro di essa produce
smorfie di ostilità che ritrova rimandate dallo specchio come presenza ostile nei suoi confronti. Allora lo
psicomotricista, accanto al bambino, propone anch'egli l'immagine del proprio volto allo specchio, facendo
delle smorfie in risposta alle smorfie del bambino, ma in una situazione di gioco che pian piano fa decantare
l'ostilità e l'estraneità. Il bambino, infatti, riconosce il volto del terapeuta e ne segue con interesse le
alterazioni. Occorre sottolineare che la tonicità e la mimica del volto del terapeuta si identificano e si
distinguono al contempo rispetto alle smorfie di estraneità del bambino. La tonicità del viso del bambino è
pian piano raccolta dalla tonicità del viso del terapeuta e le deformazioni del volto di quest'ultimo, che non
sono percepite come ostili, diventano oggetto di interesse. Anche il bambino prova, ora faccia a faccia con il
terapeuta, a giocare con lui alle smorfie. L'ostilità della percezione estranea di sé si riformula nel piacere di
deformare il volto, in accordo con quello del terapeuta, che diventa lo specchio non più deformante ma di
conferma della propria immagine. Il lavoro sul tono è in questo caso servito per creare una situazione di
condivisione, in cui i tratti del volto del bambino si impregnano dei tratti e della tonicità positiva del volto
dell'altro. Un intervento di tipo psicoterapeutico avrebbe proposto, con la mediazione della parola, la
descrizione delle emozioni legate alla percezione di parti di sé minacciose o estranee, tentando una
ricomposizione unitaria delle parti separate e ostili. Anche lo psicomotricista cerca di ricomporre
l'unitarietà delle parti separate, il volto proprio e quello estraneo del bambino, ma lo fa sul terreno del
modellamento tonico, mediante l'espressività corporea. Gli stessi principi di fondo, applicati con un
adeguamento delle proposte relazionali e del materiale, sono stati estesi a pazienti adulti che presentano
difficoltà di relazione con la loro corporeità. Il trattamento psicomotorio, che in questi casi avviene perlopiù
in gruppo, ha dimostrato la sua efficacia nel miglioramento della percezione di sé e delle proprie emozioni e
nell'utilizzo del corpo nel rapporto con gli altri. Alcuni principi della psicomotricità si trovano anche in altre
pratiche, quali la danzaterapia, il rilassamento e l'eutonia, l'espressione corporea. La pratica della
psicomotricità, pur valorizzando la spontaneità e la scoperta, non è improvvisazione. Essa richiede
materiali, spazi, tempi e regole che non possono essere qui esaurientemente descritti. Accenniamo solo alla
sala di psicomotricità e ai materiali di cui è dotata, che devono consentire una piena attivazione del
movimento, delle sensazioni cinestesiche, del senso dell'equilibrio. Vi si devono trovare perciò piani a
diverse altezze e inclinazioni, materassi per permettere arrampicate, scivolate, cadute, rotolamenti; oggetti
con cui realizzare costruzioni e luoghi simbolici con valenze affettive (come cubi e parallelepipedi di
materiale espanso di varie dimensioni), e poi palle, teli, corde, bastoni. Vi sono anche strumenti sonori e
materiale per disegno e modellaggio. Il ruolo e l'atteggiamento del terapeuta, che è il perno del processo
terapeutico, costituiscono una componente fondamentale: nel lavoro terapeutico è necessario che la sua
presenza e il suo modo di avvicinarsi non siano sentiti come imposti. Per fare questo il terapeuta deve
conoscere bene la propria componente corporea tonico-posturale e di relazione. La sua formazione non è
fatta solo di acquisizioni di conoscenze e di tecniche di intervento: egli deve fare anche un approfondito
lavoro sulla sua corporeità, indicato come 'formazione personale'.
5. L'educazione psicomotoria
Non si può, infine, non fare un cenno all'aspetto educativo di cui è investita la psicomotricità. Superando la
visione tradizionale e riduttiva dell'educazione fisica, è oggi riconosciuto anche dai programmi della scuola
materna italiana che il campo di esperienza della corporeità e della motricità contribuisce alla crescita e alla
maturazione complessiva del bambino, promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo inteso
come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva,
comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa. A esso ineriscono
inoltre quei contenuti di natura segnica, i cui alfabeti sono indispensabili per l'espressione soggettiva e la
comunicazione personale interculturale. La psicomotricità è certamente terapia, ma fondamentalmente è
una concezione educativa. Stabilito che il repertorio tonico e posturale illustrato dalle categorie del vissuto
psicomotorio è un sistema di significazione, l'educazione psicomotoria è mirata ad attivare, arricchire,
ampliare quel repertorio, allo stesso modo in cui nelle discipline educative si fa esercizio di altri repertori e
altri codici. Tuttavia, non si tratta semplicemente di attivare un'educazione accanto ad altre: coltivando il
repertorio psicomotorio si tende infatti a modificare e migliorare trasversalmente, da parte del bambino,
tutte le altre modalità, non solo di relazione ma anche, più in generale, di acquisizione di nozioni ed
esperienze, di esplorazione del mondo e di sé. L'educazione psicomotoria ha inoltre una funzione
preventiva nei confronti dell'insorgere o del consolidarsi di difficoltà comunicative e relazionali.