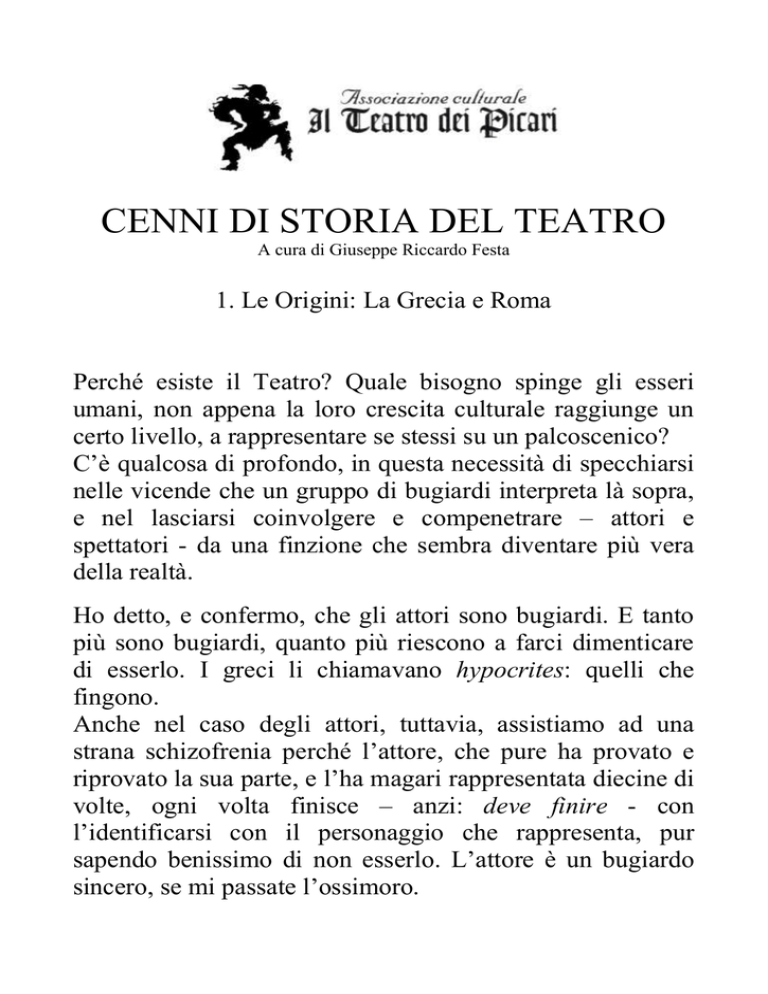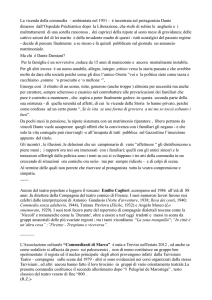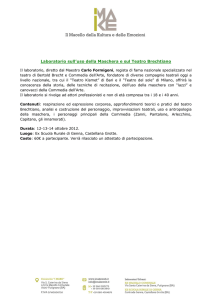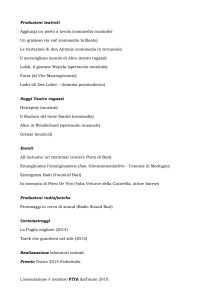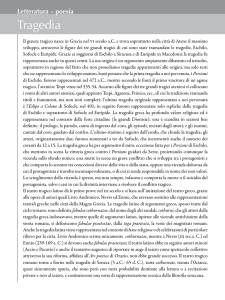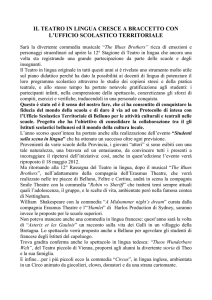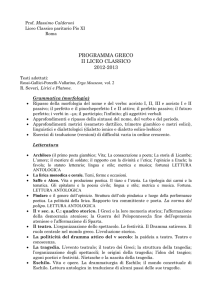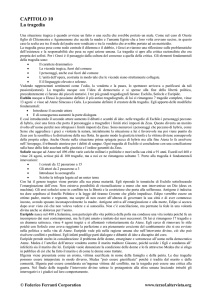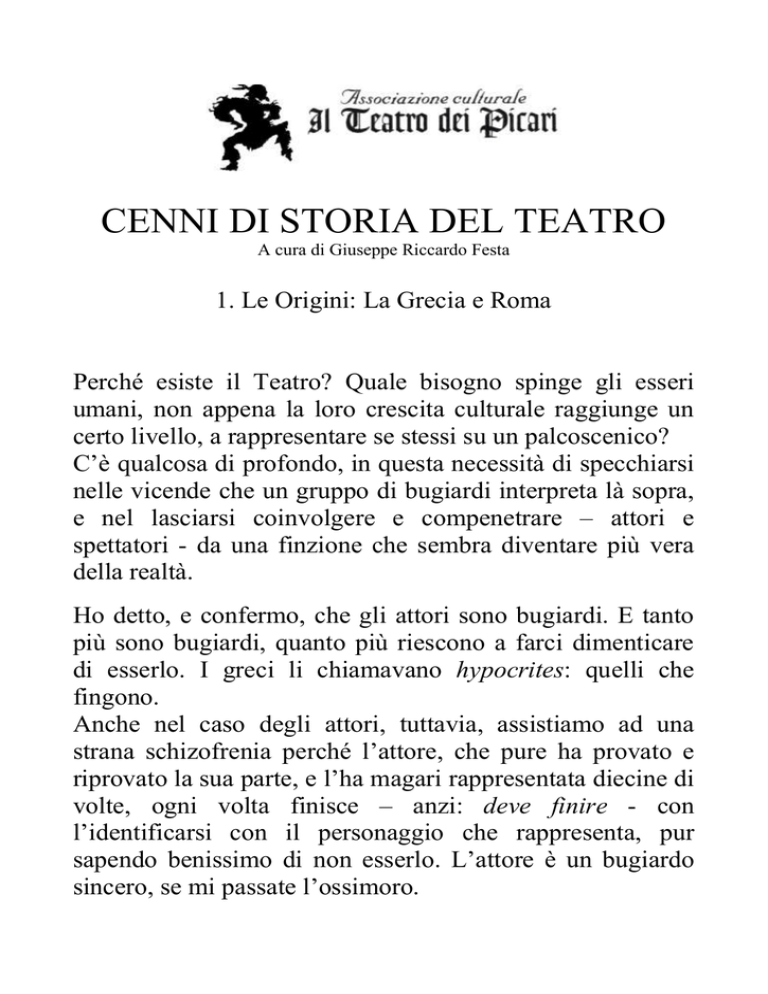
CENNI DI STORIA DEL TEATRO
A cura di Giuseppe Riccardo Festa
1. Le Origini: La Grecia e Roma
Perché esiste il Teatro? Quale bisogno spinge gli esseri
umani, non appena la loro crescita culturale raggiunge un
certo livello, a rappresentare se stessi su un palcoscenico?
C’è qualcosa di profondo, in questa necessità di specchiarsi
nelle vicende che un gruppo di bugiardi interpreta là sopra,
e nel lasciarsi coinvolgere e compenetrare – attori e
spettatori - da una finzione che sembra diventare più vera
della realtà.
Ho detto, e confermo, che gli attori sono bugiardi. E tanto
più sono bugiardi, quanto più riescono a farci dimenticare
di esserlo. I greci li chiamavano hypocrites: quelli che
fingono.
Anche nel caso degli attori, tuttavia, assistiamo ad una
strana schizofrenia perché l’attore, che pure ha provato e
riprovato la sua parte, e l’ha magari rappresentata diecine di
volte, ogni volta finisce – anzi: deve finire - con
l’identificarsi con il personaggio che rappresenta, pur
sapendo benissimo di non esserlo. L’attore è un bugiardo
sincero, se mi passate l’ossimoro.
E così lo spettatore si lascia trascinare dalla finzione della
realtà, mentre l’attore si lascia compenetrare dalla realtà
della finzione.
La rappresentazione teatrale nasce in Europa in Grecia, con
la tragedia, e trova la sua origine in motivazioni religiose.
La stessa parola tragedia, ovviamente greca, trae origine,
chi l’avrebbe mai detto, da tragos, un’altra parola greca,
che significa montone: il montone che veniva sacrificato a
Dioniso. Dioniso è il dio del vino e dell’ebbrezza, che ci
spinge a cercare la verità attraverso l’ombra, scendendo
nelle tenebre, e scandagliando l’io profondo. A Dioniso,
durante le celebrazioni a lui dedicate, in aggiunta al
sacrificio del montone, il tragos che dicevamo prima,
veniva dedicato un racconto cantato, chiamato ditirambo,
un canto corale dal carattere festoso, tipicamente dedicato
al culto di Dionisio. Così ne parla Aristotele nell’Ars
Poetica:
Sorta dunque da un principio di improvvisazione - sia la
tragedia che la commedia, l’una da quella che guidavano il
ditirambo, l’altra da coloro che guidavano i cortei fallici
che ancora oggi rimangono in uso in molte città - a poco a
poco crebbe perché i poeti sviluppavano quanto in essa
veniva manifestandosi, ed essendo passata per molti
mutamenti la tragedia smise di mutare quando ebbe
conseguito la propria natura.
Insomma il ditirambo andò a mano a mano evolvendosi
fino a perdere ogni rapporto con la divinità ed il suo culto
ed assumere una sua autonomia, trasformandosi nel
2
racconto dialogato tra un coro e un uomo, nel quale sono
espressi i temi universali dell’infrazione della Legge, della
caduta, e del riscatto attraverso il dolore e la catarsi.
Notate che questi concetti, mutatis mutandis, appartengono
anche al cristianesimo, che con le antiche religioni ha molti
più punti di contatto di quanto non gli piaccia ammettere:
l’idea di catarsi, per esempio, è alla base della nascita del
purgatorio, con le sue fiamme, appunto, purificatrici.
Con il tempo nel ditirambo si perse il rapporto con Dioniso,
ma non il retrogusto religioso, se vogliamo dir così, che
questa funzione svolgeva: la tragedia, come rito di consapevolezza e di purificazione collettiva, affidava all’arte
della scena, della musica e del canto l’espressione della
religiosità e della cittadinanza politica.
La funzione profonda dello spettacolo teatrale, nell’antica
Grecia, è dunque catartica: assistere alla rappresentazione
dei vizi e delle virtù – soprattutto dei vizi – della propria
società permette di liberarsi delle angosce e dei sensi di colpa, diventa una sorta di liberatoria confessione collettiva. E
anche se nel tempo, come abbiamo appena visto, la rappresentazione teatrale si è svincolata dalle sue radici religiose;,
non ha perso quella valenza profonda che è alla base della
sua stessa esistenza, conservando, nell’antica Grecia, un
profondo significato di comunione civile e sociale.
La parola tragedia, quando la associamo all’antica Grecia,
evoca automaticamente tre nomi: quelli di Eschilo, Sofocle,
ed Euripide, per mezzo dei quali si compie l’evoluzione
della tragedia dalla forma più elementare e schematica,
ancora legata, appunto, alle sue origini religiose, verso una
3
più compiuta rappresentazione dell’essere umano nelle sue
complesse e molteplici sfaccettature psicologiche, a livello
sia sociale che individuale.
Eschilo nacque ad Eleusi nel 525 a.C. e morì settantenne a
Gela, in Sicilia, nel 456. È il più antico autore di tragedie
del quale ci siano pervenute opere complete ed è anche
l’iniziatore di questo genere nella sua forma matura.
Combatté contro i persiani nelle battaglie di Maratona, nel
490 a.C., di Salamina (480 a.C.) e di Platea.
A proposito della battaglia navale di Salamina, argomento
della tragedia I Persiani, la tradizione vuole che nello
stesso giorno, sulla stessa isola, sia nato Euripide; e nello
stesso periodo, si dice, il giovane Sofocle intonava i primi
peana (il peana è un canto di vittoria).
Ci sono momenti come questi, nella storia delle arti, in cui
l’umanità dà il meglio di sé: in Europa, ad esempio, è
successo col rinascimento italiano, in pittura, architettura e
scultura, e nel periodo d’oro che va dal Seicento alla fine
dell’Ottocento con la musica.
Alcune opere di Eschilo, come I Persiani o Sette contro
Tebe, devono molto alle sue esperienze militari. Ma a parte
questo, l’attenzione alle vicende sociali e politiche del suo
tempo emerge come caratteristica della sua produzione,
almeno la poca che ce ne rimane. Eschilo, tra i grandi poeti
greci classici, fu il solo testimone dello sviluppo della
democrazia ateniese, cui fa cenno in Le Supplici, che
contiene il primo riferimento che sia giunto fino ad oggi di
una forma di governo definita “potere del popolo”.
4
Un altro esempio: Nelle Eumenidi parla della creazione
dell’areopago, un tribunale incaricato di giudicare gli
omicidi.
L’opera più famosa di Eschilo è l’Orestea, la trilogia
dedicata alle vicende di Oreste, figlio di Agamennone, che
uccise la madre Clitemestra ed il suo amante Egisto, i quali
a loro volta gli avevano ammazzato il padre al ritorno dalla
guerra di Troia. Anche qui Eschilo si focalizza sui problemi
sociali: Oreste ha fatto bene a vendicare il padre, ma ha
fatto anche male ad uccidere la madre, ragion per cui è
perseguitato dalle Erinni, dee vendicatrici; ma arrivato in
Atene - che implicitamente è indicata come sede della
giustizia - grazie all’intervento di Atena e di Apollo trova
finalmente pace, e le Erinni si trasformano in Eumenidi, dee
benevole protettrici della concordia.
Già prima di Eschilo la tragedia aveva assunto, in Atene,
un’importanza fondamentale, tanto che ogni anno vi aveva
luogo un Agone, la prima forma di concorso teatrale, nel
quale si confrontavano i migliori autori, col vincitore che ne
riceveva onori e gloria.
Eschilo, che agoni ne vinse diversi, è comunque, di fatto, il
padre della tragedia antica a causa delle innovazioni che
introdusse nella sua struttura. Fu lui a far apparire sul palco
anche un secondo attore: in precedenza nell’azione interveniva insieme al coro un solo attore per volta. Fu una vera
rivoluzione nello stile espressivo della tragedia. Da questo
momento fu infatti possibile non solo esprimere la narrazione tramite dialoghi (aumentando il coinvolgimento emotivo del pubblico e la complessità espressiva), ma anche
iniziare un percorso che, col tempo, avrebbe permesso alla
5
tragedia di rappresentare lo svolgimento di azioni anziché
limitarsi a raccontare scene statiche. Questa innovazione,
ovviamente, ridimensionò l’importanza del coro che in
precedenza, dall’orchestra, era costantemente la controparte
all’attore e svolgeva la funzione fondamentale di spiegare
gli antefatti: vedremo fra poco quanto ciò fosse necessario,
in un contesto che imponeva le tre unità di tempo, luogo e
azione.
Ho accennato all’Orestea, ed al fatto che è una trilogia. In
effetti tutta la produzione Eschilea era costituita da trilogie,
una forma che egli impose al teatro ateniese, pur se fino a
noi una sola di esse, appunto l’Orestea, è giunta integra con
le sue tre tragedie: Agamennone, Le Coefore e Le Eumenidi.
Sul piano della compiutezza narrativa, questa strutturazione
tripartita permetteva di narrare anche vicende complesse,
che si svolgevano in momenti e luoghi differenti: in una
sola tragedia questo non sarebbe stato possibile. Una regola
ferrea del teatro antico, infatti, impone le tre unità che
dicevo un momento fa: di tempo, di luogo, e di azione.
Tutto deve accadere in un unico luogo, in un’unica sequenza cronologica e secondo uno sviluppo lineare degli eventi.
Per noi, oggi, abituati al cinema che ci sballottola fra le
galassie e i secoli, e ai flash-back e ai cambi di scena, la
regola è incomprensibile, a tal punto che se non siamo
adeguatamente preparati ci riesce difficile sopportare
l’esecuzione di una tragedia che rispetti le tre unità; ma
allora essa era inderogabile. Quando c’era bisogno di raccontare qualcosa che accadeva altrove, allora si utilizzava
l’artificio dell’Araldo, che giungeva sulla scena a narrare
6
l’accaduto e giustificava o determinava lo sviluppo della
vicenda; il coro, come ho già detto, raccontava gli antefatti.
Un altro artificio tipico del teatro antico, risolutivo anche
nella stessa Orestea, è quello famoso del deus ex machina,
che noi definiamo con questa formula latina, ma in realtà
nasce col teatro greco. Il deus ex machina interviene di
solito alla fine della vicenda: si tratta di una divinità che,
quando la situazione sembra ormai senza sbocchi e priva di
vie d’uscita, risolve tutto e porta a compimento la vicenda.
Era detto ex machina in quanto sbucava fuori grazie ad un
artificio tecnico, di solito emergendo da una botola. La
locuzione è poi diventata proverbiale per interventi fortunosi – e soprattutto artificiosi, estranei alla logica della
vicenda – grazie ai quali si risolvono, appunto, situazioni
apparentemente insolubili.
Nel teatro a noi più vicino l’esempio più famoso di deus ex
machina – anche se la macchina non c’è - è l’inviato del re
che, alla fine del Tartuffe di Molière, risolve la situazione
consentendo un lieto fine altrimenti impensabile.
Tornando a Eschilo, delle novanta opere, che si dice avesse
scritto, fino a noi ne sono giunte solo sette: oltre
all’Orestea, I Persiani, che racconta la disperazione dei
Persiani, appunto, dopo la sconfitta di Salamina; il
Prometeo incatenato, inno all’orgoglio del titano che osa
sfidare Zeus con chiari riferimenti al potere ed alla sua
legittimità; Le supplici, dedicata alla sacralità delle leggi
dell’ospitalità e infine i Sette contro Tebe, storia dell’odio
fra Eteocle e Polinice, i figli di Edipo che si contendono il
potere sulla città e finiscono per uccidersi tra loro in
7
conseguenza della maledizione scagliata contro di loro dal
padre. Tutte queste opere erano parte di trilogie legate, delle
quali però non ci sono giunte le parti restanti.
E veniamo a Sofocle, che nacque nel 495 o nel 496 a.C. a
Colono, nei pressi di Atene. In quanto figlio di un ricco
ateniese proprietario di schiavi, ebbe un’ottima educazione,
tanto che a 15 anni poté dirigere il coro che dopo la vittoria
di Salamina intonò il peana di cui abbiamo già parlato. La
sua carriera di autore tragico ebbe presto successo: a 27
anni conquistò il suo primo trionfo in un agone gareggiando
con Eschilo. In tutto ottenne 24 vittorie, e fu secondo in
tutte le altre occasioni.
Fu amico di Pericle e ricoprì importanti cariche politiche e
militari, sempre stimatissimo dai concittadini tanto che,
quando la statua del dio Asclepio fu trasferita da Epidauro
ad Atene, fu designato ad ospitarla nella sua casa finché
non fosse stato pronto il santuario destinato al dio. Nelle
sue funzioni pubbliche, contribuì all’elaborazione della
costituzione dei Quattrocento.
Si sposò con Nicostrata, ateniese, che gli diede un figlio,
Iofone. Si dice che, poco prima della sua morte, Iofone gli
intentò un processo per una questione d’eredità, in pratica
accusandolo di essere ormai rimbambito. Ma la semplice
lettura dell’ultima ultima opera del padre mise fine al
processo: chi aveva scritto versi così non poteva essere
fuori di testa, secondo i giudici.
Sofocle morì nel 406 a.C. e la sua ultima tragedia, Edipo a
Colono, fu rappresentata postuma, lo stesso anno, in segno
di grande onore.
8
Proseguendo nell’opera di rinnovamento – di fatto, di invenzione - della tragedia, avviata da Eschilo, ed anche
contrastando lo stesso Eschilo, che sconfisse in più di
un’occasione negli agoni poetici annuali, Sofocle abolì
l’obbligo della “trilogia legata”, introdusse nella tragedia il
terzo attore e portò da dodici a quindici il numero dei
coreuti, ossia dei componenti del coro. L’introduzione del
terzo attore, che superava la rigida contrapposizione di due
posizioni antitetiche, avrebbe avuto come conseguenza una
maggiore articolazione dei rapporti interpersonali ed una
nuova scioltezza dinamica del ritmo teatrale; fu ancora
Sofocle, infine, ad introdurre l’uso delle scenografie: fino
allora sul palco, oltre al coro ed agli attori, non c’era
assolutamente niente.
Sofocle scrisse, secondo la tradizione, ben centoventitré
tragedie, di cui ci però restano solo Antigone (442 AC),
Aiace, Edipo re, Elettra, Filottete (409 AC), Le Trachinie
ed Edipo a Colono (406 AC).
L’attenzione di Sofocle, più che ai problemi sociali, è
rivolta a quelli intimi, i più reconditi e inconfessabili della
natura umana; valga, come esempio ampiamente esplicativo, la storia di Edipo, che nello stesso tempo svela l’ineluttabilità del fato e soprattutto, come poi Freud avrebbe
messo in evidenza, descrive in forma allegorica il dramma
dell’uomo che vorrebbe uccidere il padre e sostituirlo
accanto alla madre, e nello stesso tempo si odia per il fatto
di provare questo desiderio. Sofocle descrive eroi immersi
in un mondo di contraddizioni insanabili, di conflitti con
forze inevitabilmente destinate a travolgerli.
9
Il suo contributo originale allo sviluppo della tragedia greca
sta quindi nell’accentuazione dell’umanità dei personaggi,
che dalla loro vana lotta contro il fato ricevono una piena
dimensione umana, portatori di un destino che ne è la
dannazione e, contemporaneamente, la gloria.
Con una netta divergenza rispetto a quelli di Eschilo, i cori
tragici sofoclei si defilano dall’azione, della quale sono
semplici spettatori e commentatori. È di Sofocle l’introduzione del monologo come forma chiusa all’interno della
tragedia, che permette all’attore di mostrare la sua abilità, e
al personaggio di esprimere compiutamente i propri pensieri. La psicologia dei personaggi si approfondisce, emerge
una analisi inedita della realtà e dell’uomo. Sofocle, profondamente pessimista, toglie enfasi ai personaggi per accentuarne la drammaticità, in un mondo che vede ingiusto e
privo di luce.
Esempio tipico del suo pensiero è il coro che nell’Edipo a
Colono afferma che «la sorte migliore è non nascere». Gli
eventi che schiacciano le esistenze degli eroi non sono in
alcun modo spiegabili o giustificabili: in questo possiamo
vedere l’inizio di una sofferta riflessione sulla condizione
umana, ancora attuale nel mondo contemporaneo.
Euripide, infine.
Come abbiamo visto, la tradizione vuole che Euripide sia
nato a Salamina, lo stesso giorno in cui ebbe luogo la famosa battaglia, da una famiglia ateniese rifugiata sull’isola per
sfuggire ai Persiani. Il suo nome verrebbe dall’Euripe, il
canale marino dove si svolse la battaglia. Stando al commediografo Aristofane, che lo detestava, diversamente dai suoi
10
due illustri predecessori Euripide avrebbe avuto umili
origini; ma a smentire le tesi di Aristofane, sta il fatto che
ebbe un’educazione e una cultura raffinata, acquisita presso
sofisti come Protagora, che non sarebbe stata possibile
senza una condizione agiata; i sofisti si facevano pagare
profumatamente, per le loro lezioni.
Si dice inoltre che Euripide raccolse una ricca biblioteca,
una delle prime di cui si abbia notizia e che partecipò a
giochi ginnici, ove fu incoronato almeno una volta.
Contemporaneo di Socrate, ne divenne amico. Si propose
pubblicamente negli agoni come tragediografo a partire dal
455 a.C. ed ottenne con la sua prima opera, Pleiadi, il terzo
premio.
Presto fu popolare, a tal punto che secondo Plutarco nel 413
a.C., nel corso della guerra del Peloponneso, dopo il disastro navale di Siracusa, i prigionieri ateniesi in grado di
recitare una tirata di Euripide furono rilasciati. Verso il 405
a.C. si ritirò a Magnesia, poi in Macedonia, alla corte di
Archelao, dove morì. Solo dopo la sua morte, tanto per
cambiare, la Grecia riconobbe la sua grandezza e le sue
opere divennero famose. Gli ateniesi gli dedicarono nel 330
a.C. una statua di bronzo nel teatro di Dioniso.
Euripide si distingue dai due drammaturghi che lo precedono per la sperimentazione tecnica presente in quasi tutte
le sue opere e per la maggiore attenzione nella descrizione
dei sentimenti, di cui analizza l’evoluzione col mutare degli
eventi narrati.
La struttura della tragedia euripidea è molto più variegata e
ricca di novità di quella del passato, soprattutto per effetto
11
di nuove soluzioni drammatiche, di un maggiore utilizzo
del deus ex machina e della progressiva svalutazione del
ruolo drammatico del coro, che in Euripide accentua la
funzione di pausa, anziché di sviluppo dell’azione, che già
aveva avuto da Sofocle. Anche lo stile risente dello sforzo
di rompere con la tradizione, come dimostrano l’inserimento di parti dialettiche che allentino la tensione drammatica, e l’alternanza delle modalità narrative.
La novità assoluta del teatro euripideo è comunque rappresentata dal realismo col quale tratteggia le dinamiche
psicologiche dei suoi personaggi. L’eroe descritto in queste
tragedie non è più il risoluto protagonista dei drammi di
Eschilo e Sofocle, l’uomo unidimensionale che poi tornerà,
ad esempio nel teatro di Byron, Schiller e Alfieri; al contrario, l’eroe di Euripide è spesso una persona problematica ed
insicura, non priva di conflitti interiori, le cui motivazioni
inconsce il poeta porta alla luce ed analizza.
Proprio lo sgretolamento del tradizionale modello eroico
porta alla ribalta, in Euripide, la figura femminile. Le
protagoniste dei suoi drammi, come Andromaca, Fedra e
Medea, sono le nuove figure tragiche del drammaturgo, il
quale ne tratteggia sapientemente la tormentata sensibilità e
le pulsioni irrazionali (almeno nell’ottica maschile), che si
scontrano con il mondo della ragione.
Euripide esprime le contraddizioni di una società in mutamento: nelle sue tragedie spesso le motivazioni personali
entrano in profondo contrasto con le esigenze del potere e
con i vecchi valori fondanti della città greca. La sua Medea,
ad esempio, arriva ad uccidere i propri figli pur di non
12
sottostare al matrimonio di convenienza di Giasone con la
figlia del re.
Delle 92 tragedie da lui scritte ce ne sono giunte solo 17,
che non a caso hanno tutte protagoniste femminili, come ad
esempio Le Baccanti, Medea, Le Troiane, Ifigenia in Aulide
ed Ifigenia in Tauride.
Parliamo un attimo di critica teatrale. Il primo a studiare
analiticamente il fenomeno teatro su un piano più strettamente artistico è stato Aristotele, che al riguardo ha parlato
di mimèsi, cioè di imitazione: imitazione di gesta alte ed
epiche, con la tragedia, e di vicende volgari con la commedia.
Perché giustappunto, ora passiamo a parlare di commedia.
Quando parla di vicende volgari, nella commedia, Aristotele non pensa al significato negativo del termine, ma a
quello etimologico: la commedia imita e rappresenta vicende che non appartengono alla storia o al mito, ma alla gente
comune.
A questo proposito, smentendo clamorosamente – pensate
un po’ - proprio Aristotele, vorrei richiamare la vostra attenzione su un momento dell’Odissea, il famoso poema
epico, la cui origine è sicuramente anteriore al X secolo
AC.
Il momento del quale vorrei parlarvi lo si legge nell’Ottavo
Libro dell’Odissea: Ulisse è stato finalmente liberato da
Calipso, con una zattera che poi Nettuno ha fatto naufragare
è arrivato nell’Isola dei Feaci, e dai Feaci è stato accolto e
13
ospitato; ora, durante un banchetto, il cantore Demodoco
sta raccontando una storia.
Una storia che riguarda sì gli dèi, ma non ha assolutamente
niente di epico.
È la storia di Venere, la dea dell’amore, che tradisce il
marito zoppo, Vulcano, col dio della guerra Marte. Ma il
Sole, che vede tutto perché s’intrufola dappertutto, si accorge della tresca e la va a raccontare al marito cornificato; il
quale va su tutte le furie ma invece di fare scenate elabora
una vendetta astuta: se ne va nella sua officina e prepara
una rete tanto solida quanto invisibile, che poi sistema sul
letto di casa sua; dopodiché si allontana, ma di poco, fingendo invece di partire per una terra lontana; e subito Marte
va a proporre a Venere, che è sì dea ma notoriamente è
anche un po’ mignotta, di approfittare della sua assenza; di
nuovo il Sole fa da delatore e avverte Vulcano, il quale fa
scattare la sua trappola; e i due amanti restano bloccati senza possibilità di movimento; a questo punto il marito tradito
fa un baccano indiavolato, ma non per il suo onore tradito:
vuole indietro da Giove i tesori che gli ha dato per comperarsi la moglie, e un sostanzioso risarcimento da Marte.
Accorrono tutti gli altri dei – solo i maschi, le dee si vergognano della situazione – i quali si scompisciano dalle risate:
uno dice a Marte che non gli è servito a niente essere il più
agile e veloce degli dèi, se uno sciancato come Vulcano ha
potuto bloccarlo; Apollo chiede a Mercurio se gli piacerebbe trovarsi in quella situazione, e Mercurio risponde che per
farsi un giretto con Venere affronterebbe anche situazioni
peggiori.
14
Solo Nettuno resta serio, e chiede a Vulcano di liberare
Marte, facendosi garante per il pagamento del debito; sulle
prime Nettuno resiste, ma alla fine cede, ma solo perché
Nettuno promette di pagare di tasca sua qualora Marte, una
volta liberato, se la squagliasse.
La lettura di questo episodio, evidentemente del tutto estraneo alla storia di Ulisse, dei suoi ritorni e delle sue vendette, mi ha lasciato di stucco: è evidentemente un canovaccio,
la trama di una commedia, con personaggi che richiamano
irresistibilmente la Commedia dell’Arte, anche se è nato
duemila anni prima della Commedia dell’Arte ed è inserito
in un poema epico, che dalla Commedia dell’Arte è lontano
anni luce. Ma è un fatto che nel sole delatore è facile
riconoscere il primo germe della maschera di Brighella;
Marte è il futuro Miles Gloriosus, dal quale discenderanno
tutti i capitani della Commedia dell’Arte; Venere è una
Colombina un po’ sopra le righe, Vulcano è Pantalone,
avaro e impotente; Mercurio uno Zanni e Apollo Arlecchino; e il serioso Nettuno può ben essere l’antenato del
Dottore.
possiamo tranquillamente pensare, insomma, che la commedia, nell’antica Grecia, aveva un suo spazio già molto,
molto prima che Aristofane deliziasse gli ateniesi con le sue
opere.
La commedia si pone di fronte alla tragedia come rovescio
della stessa medaglia, portando nel teatro quell’ambivalenza che è propria della natura umana: la tragedia ci mostra
l’uomo che indossa la corazza dell’eroe; la commedia ce lo
mostra quando si soffia il naso, o scivola sulla buccia di
15
banana e cade sul sedere. È lo stesso uomo, solo che lo
vediamo da due angolazioni diverse.
Sono dunque vicende, quelle della commedia, nelle quali
non troviamo eroi dall’indefettibile purezza ideale, o dominati da rovinose e incontrollabili passioni, né, sull’opposto
versante, eroi negativi dominati dalla maledizione delle
proprie pulsioni assolute; e non ci sono, nella commedia,
dèi implacabili e vendicativi, che segnano il destino dei
protagonisti fin dalla loro nascita, o benéfici dèi salvatori,
che intervengono al momento giusto per risolvere finalmente la situazione.
Nella commedia tutto questo non c’è, ma non per questo la
commedia è lontana dalla realtà. E se è vero che il teatro è
specchio della verità della condizione umana, allora possiamo dire che mentre la verità della tragedia mostra i vertici
della virtù o il più profondo dell’abiezione dell’animo umano, la verità della commedia, più modestamente, si colloca
nel mezzo: là dove pulsano passioni meno sublimi, forse,
ma non per questo meno umane: l’amore, l’avarizia, il desiderio, l’astuzia, la meschinità; e i desideri della gente comune, che se la deve cavare senza sperare che intervenga
un dio a cavarla d’impiccio.
Ma la commedia, così vicina alla realtà di tutti i giorni, una realtà che non appartiene all’assoluto un po’ teorico cui
tende la tragedia – finisce col rivelarsi pericolosa, per
l’ordine costituito, perché di questa quotidianità mette in
luce, ammiccando, anche i protagonisti: non personaggi remoti nel tempo e nello spazio, ma persone e situazioni vere,
di cui gli spettatori hanno esperienza: così, ne Le nuvole,
16
Aristofane mette apertamente alla berlina le rarefatte – e
secondo lui speciose - elucubrazioni intellettuali di Socrate
e dei suoi seguaci, e in Gli Acarnesi, scritta nel bel mezzo
della Guerra del Peloponneso, attacca senza complimenti la
politica di Pericle.
Aristofane nacque ad Atene intorno al 450 AC, figlio di un
Filippo,che possedeva delle terre nell’isola di Egina, dove
il futuro commediografo trascorse la giovinezza. Altri
autori suoi contemporanei si dedicarono alla commedia, ma
lui è l’unico del quale ci siano pervenute delle opere
complete. Gli agoni non si svolgevano solo fra autori di
tragedie, ma riguardavano anche le commedie; ed
Aristofane vinse il suo primo agone nel 427 AC, con una
commedia, I Banchet-tanti, che non ci è pervenuta, nella
quale ridicolizzava il nuovo sistema educativo.
Una cosa va chiarita subito: Aristofane era un conservatore.
Le sue commedie più feroci polemizzano con Euripide, che
osava modificare le forme e i contenuti della tragedia, e che
tratta con disprezzo da villan rifatto; e soprattutto con Socrate, che considera un ciarlatano.
Operò principalmente durante il periodo della Guerra del
Peloponneso, tragico per Atene, che da dominatrice della
Grecia si ridusse, con la definitiva sconfitta del 404 a.C., a
potenza dimezzata, sottoposta al controllo di Sparta, dopo
che la peste, raccontata da Tucidide, aveva decimato la sua
popolazione. Dopo la sconfitta ridimensionò la passione
politica e scrisse commedie d’argomento sociale e di
costume.
17
Ma questo avvenne, appunto, dopo la fine della guerra.
Durante la guerra scrisse commedie che puntavano il dito
contro i corrotti e i potenti, e soprattutto contro la guerra
stessa. In un’altra opera giovanile, di cui non abbiamo che
frammenti, attacca un demagogo che per potere e denaro
era pronto a sfruttare le città alleate, un certo Cleone, il
quale a sua volta lo accusò di alto tradimento ma evidentemente senza successo, visto che, nel 425 a.C., Aristofane
poté rappresentare la già citata Gli Acarnesi, un’ardente
arringa contro la guerra, vincitrice del primo premio alle
Lenee, un altro concorso teatrale. È, questa, la sua prima
commedia di cui abbiamo il testo integrale.
L’anno successivo Aristofane continuò i suoi attacchi
contro Cleone, del quale fece il personaggio centrale de I
Cavalieri, stigmatizzandolo senza pietà come demagogo.
Nelle Nuvole si fa beffe degli ammiratori incondizionati di
Socrate, il padre della filosofia moderna, che lui però
descrive come mezzo filosofo naturalista e mezzo sofista,
cattivo educatore della gioventù, cui insegna il Discorso
Ingiusto che permette di vincere in ogni dibattito: il filosofo
è descritto come un pericolo da scacciare, bruciandone la
scuola (nella commedia il Pensatoio). Questa visione che
Aristofane ha di Socrate getta un’ombra sulla sua figura,
anche in considerazione della condanna a morte che colpì il
filosofo nel 399 a.C.
Le Vespe tratta un tema di attualità, in una città così litigiosa come Atene, mostrando come la giustizia spesso non
è che un commercio e una manipolazione (le “vespe” sono i
giudici popolari).
18
Ne La Pace il protagonista, Trigeo, vola fino a un cielo abbandonato perfino dagli dei, disgustati, per liberare Pace
dalle grinfie di Polemos, la guerra, con l’aiuto di tutti i
Greci e con gran disperazione dei fabbricanti di armi e degli
altri mestatori. La commedia è piena di speranza per
l’avvenire: fu scritta nel momento in cui Sparta ed Atene
negoziavano la Pace di Nicia, 421 a.C.
Ci sono pervenute, poi, anche Gli uccelli, commedia del
414 a.C., che descrive la fuga di due ateniesi dai litigi e
dalle beghe in cui è piombata la città. I due, per trovare la
pace vanno a vivere tra gli uccelli; le Tesmoforiazuse,
ovvero Le donne alla festa di Demetra, ove viene messo
alla gogna il tragediografo Euripide, dipinto come misogino, in un’estesa parodia delle sue opere; la Lisistrata, la
sua commedia più celebre, incentrata su un vero e proprio
sciopero del sesso da parte delle donne della Grecia intera,
guidate appunto da Lisistrata (il nome stesso la dice lunga:
significa distruttrice di eserciti) per spronare i propri mariti
alla pace; Le rane in cui lo stesso dio del teatro, Dioniso, si
reca all’Aldilà per scegliere un poeta che con i suoi consigli
possa salvare la città di Atene dall’incombente rovina
(poeta che sarà non Euripide, recentemente deceduto, bensì
il vecchio, più “sano” e non degenerato Eschilo).
Infine l’ultimo Aristofane, nell’Atene degli inizi del IV sec.
mise in scena Le Ecclesiazuse, ovvero Le Donne all’Assemblea, in cui, con una sorta di colpo di stato comunista, le
donne prendono il potere esautorando i deboli mariti e
infine, nel 388 a.C., l’ultima commedia pervenutaci, il
Pluto, che narra il recupero della vista da parte del dio cieco
19
della ricchezza il quale, da allora in poi, avrebbe premiato
solo quanti se lo meritassero.
La morte, probabilmente, colse Aristofane di lì a poco.
Prima di spostarci in Italia, diamo ora un’occhiata al luogo
deputato ad ospitare le rappresentazioni teatrali.
Quello dell’edificazione di un teatro è considerato uno dei
maggiori esiti dell’architettura, tanto nell’antica quanto nella civiltà moderna. A voler essere proprio scrupolosi, l’inizio dell’architettura teatrale non coincide con le prime
manifestazioni teatrali di cui si abbia conoscenza.
Se si ritiene che il rapporto tra un evento spettacolare ed il
pubblico che vi assiste sia condizione sufficiente per il
compimento di un evento teatrale, allora vanno inserite in
questa categoria anche manifestazioni che hanno poco a che
vedere col teatro nel senso comune del termine, come le
parate militari, la retorica a fini propagandistici e le
celebrazioni religiose.
Già alcuni testi sacri dell’antico Egitto, ad esempio quello
che racconta la morte e la risurrezione del dio Osiride, sono
scritti in forma dialogica e probabilmente erano pensati per
la rappresentazione. Questa eventuale rappresentazione sarebbe tuttavia avvenuta nell’ambito dell’edificio religioso, e
non in un luogo progettato appositamente per la messinscena.
Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, perché è
facile individuare una finalità spettacolare anche in certe
celebrazioni solenni di tutte le religioni, che in ambito
cristiano trovano la massima esaltazione nelle funzioni più
solenni, specie della Chiesa Ortodossa, con i luoghi di culto
20
che richiamano molto da vicino ambienti teatrali: le navate
come parterre, l’abside come palcoscenico, l’altare come
scenografia.
Torniamo al mondo del teatro propriamente detto.
Prima della civiltà greca sono pochi gli edifici teatrali
progettati espressamente per questo scopo: potrebbero
rientrare in questa categoria alcuni spazi dei palazzi della
civiltà minoica, come il cortile delle feste del palazzo di
Festo a Creta. Si trattava di uno spiazzo circondato per tre
lati da gradinate che potevano ospitare fino a cinquecento
persone venute ad assistere alle danze, alle cerimonie o alle
tauromachie che vi si svolgevano.
Nella Grecia antica il teatro nasce come semplice spiazzo
per il pubblico per poi diventare uno spazio delimitato (circolare o a trapezio) attrezzato con panche di legno, e giungere infine, tra il V e il IV secolo AC, ad essere un’opera
architettonica vera e propria. Il teatro greco rimane comunque sempre una struttura a cielo aperto. Già nei più antichi
teatri si ritrovano le tre parti essenziali:
la cavea (koilon), la nostra platea, a pianta circolare o
ellittica nella quale sono disposte le gradinate, suddivise in settori, con i sedili di legno; in genere la cavea è
addossata ad una collina per sfruttarne il pendio naturale;
la scena (skené), costruzione a pianta allungata, disposta perpendicolarmente all’asse della cavea, inizialmente semplice e in legno, quindi sempre più complessa e abbellita da colonne, nicchie e frontoni, situata
ad un livello più alto dell’orchestra con la quale comu-
21
nica mediante scale. Nel teatro greco il fondo è sempre
aperto, con il panorama naturale che fa da fondale;
l’orchestra (orkhestra), circolare, collocata tra il piano
inferiore della cavea e la scena, è lo spazio centrale del
teatro greco, riservato al coro: noi oggi lo chiamiamo
golfo mistico e ci piazziamo, giustappunto, l’orchestra,
che a questo spazio deve il suo nome.
Fra i teatri greci di cui ci rimangono notevoli testimonianze
vi sono il teatro di Dioniso ad Atene, di Segesta, di Siracusa, di Delfi, di Epidauro, di Taormina.
Gli antichi Romani utilizzano il modello del teatro greco,
apportandovi però alcune modifiche essenziali. Il primo
teatro interamente in muratura della città di Roma è quello
di Pompeo, del 55 a.C. Le gradinate semicircolari della
cavea poggiano ora su archi e volte in muratura, non sul
dorso di una collina, e sono collegate alla scena con loggiati
laterali. Questo permette all’edificio del teatro, finalmente
autonomo, di avere una collocazione più flessibile – non
legata, appunto, alla presenza di una collina, come in
Grecia - e di dotarsi di una facciata esterna ornata e monumentale. La facciata della scena è innalzata a numerosi
piani e decorata, fino a diventare frons scenae, proscenio.
L’uso della scena diventa più complesso per l’uso di macchinari teatrali. Compare il sipario, che durante la rappresentazione si abbassa in un apposito incavo, mentre al di
sopra del pubblico il velario, di derivazione navale, è utilizzato per riparare gli spettatori dal sole.
Il fondo della scena, diversamente da quello greco, è chiuso, anche in conseguenza della collocazione del tutto diver22
sa che il complesso ha nel contesto architettonico complessivo della città.
I Romani, quando edificavano una città o ne colonizzavano
una già esistente, si preoccupavano subito di marcarla con
segni caratteristici: terme, acquedotti, circhi e teatri. Ragion
per cui sono numerosissimi i teatri romani sparsi in tutta
Europa. Oltre a quello di Pompeo, a Roma, che abbiamo già
citato, ricordiamo quello di Pompei (di forme ancora molto
vicine a quelle greche), e ancora a Roma quello di Marcello; e quelli di Ostia, di Napoli, di Ercolano, di Pozzuoli e di
Fiesole; e numerosi in giro per l’Europa e l’Africa settentrionale.
Ed eccoci, dunque, a parlare del teatro a Roma.
Creando le loro colonie in Italia i Greci trovarono popolazioni il cui livello di civiltà era bassissimo in rapporto al
loro, e comunque si comportarono con la spocchia tipica di
chi a torto o a ragione si ritiene superiore: la parola barbaro, non dimentichiamolo, l’avevano inventata loro, riferendosi alle lingue diverse alla loro.
Dunque portarono in Italia tutti i loro costumi e tutte le loro
abitudini, ivi incluso il teatro: gli Italici, inclusi i Romani,
impararono da loro i rudimenti dell’attività teatrale: in questa, come in innumerevoli altre cose, la Grecia, anche dopo
che Roma l’ebbe conquistata manu militari, fu poi maestra
dei suoi conquistatori: Graecia capta ferum victorem cepit
dice Orazio: la Grecia, conquistata, conquistò il suo rozzo
conquistatore. A nulla valsero le resistenze e gli anatemi dei
vari Catoni: i Romani, venuti in contatto con una cultura
raffinata ed evoluta come quella greca, ne furono incantati,
23
soprattutto ovviamente i patrizi, che presero a proteggere e
incoraggiare tutte le attività artistiche, ivi incluse quelle
teatrali.
Ma già prima, gli influssi del teatro greco si erano fatti
sentire.
Le popolazioni indigene della Campania si appropriarono
della farsa in voga nelle colonie della Magna Grecia, il
fliace, che elaborarono trasformandolo nell’atellana, ed inventando personaggi che finiranno per diventare modelli di
riferimento per tutto il teatro successivo: Maccus, lo sciocco sbeffeggiato; Bucco, il grasso ciarlatano; Pappus, il vecchio babbeo; Dossennus, il saccente astuto e affamato.
A Roma l’atellana si fonde con la Satura, o Satira, diventando exodium atellanum: una breve farsa a canovaccio,
d’argomento spesso osceno e ammiccante, recitata dopo la
fine delle rappresentazioni ufficiali.
I Romani non erano democratici. La classe dominante non
sopportava critiche, e quindi, ben altrimenti che in Atene,
queste commedie erano prive di riferimenti all’attualità politica. Erano concentrate su vicende più vicine alla realtà
quotidiana del popolo, o, se si preferisce, della plebe.
Grande collettore delle farse atellane, che trasforma in
commedie ricche di intrecci, colpi di scena e caratterizzazioni, è Tito Maccio Plauto, il cui stesso nome è uno sberleffo: Maccio, l’abbiamo appena visto, è uno dei personaggi
della commedia atellana; e plauto si diceva di chi aveva i
piedi piatti. Ai normali ingredienti dell’atellana, Plauto
aggiunge la fantasmagoria del gioco di parole e della parodia, più un qualcosa che trasforma le sue commedie in
24
modelli assoluti. E infatti le ventuno sue commedie che ci
sono pervenute sono servite, per secoli, come fonte
d’ispirazione per i teatranti di tutta Europa, inclusi un certo
William Shakespeare e un tale Francesco Facciolli.
Nelle commedie di Plauto ricorre uno schema fisso: c’è
prima di tutto un giovane (adulescens) che si innamora di
una ragazza. Il suo sogno d’amore incontra sempre dei problemi a realizzarsi, diversi a seconda della donna di cui si
innamora: se è una cortigiana deve trovare i soldi per sposarla, se invece è onesta l’ostacolo è di tipo familiare.
Ad aiutarlo a superare le varie difficoltà sono il servus
callidus (servo scaltro) o il parassita (squattrinato che lo
aiuta in cambio di cibo) che con vari inganni e trabocchetti
riescono a superare le varie difficoltà ed a far sposare i due.
Nell’ambito del teatro drammatico Roma non ha lasciato
un’eredità altrettanto importante quanto quella legata alla
commedia. L’unico autore del quale ci sono rimaste opere
non frammentarie è Seneca, che si rifà a modelli
greci,rielaborati però in un’ottica fortemente condizionata
dalla sua struttura mentale, fondamentalmente orientata alla
morale della filosofia stoica, secondo la quale tutto nel
mondo è male e la saggezza sta nell’isolarsene e nel vivere
lontano dalle passioni. Quasi a dimostrare la malvagità del
mondo, le tragedie di Seneca traboccano di sangue, stupri,
incesti e consimili piacevolezze; non è per giunta nemmeno
certo che le sue opere fossero destinate alla rappresentazione.
L’avvento del cristianesimo e la caduta dell’impero romano vedono decadere l’importanza del teatro – e a maggior
25
ragione della commedia – come momento di aggregazione
sociale e di confronto emotivo.
La nuova morale non vede di buon occhio che l’uomo individui nei propri comportamenti – ciò che appunto la commedia rappresenta - la causa e la conseguenza delle sue vicende, che, al contrario, deve interpretare come manifestazione di un più alto disegno, di un piano divino.
A partire dal quinto secolo, ogni attività teatrale viene
quindi bandita, e i teatri scompaiono.
L’attività teatrale, tuttavia, sopravvive: compagnie di saltimbanchi si aggirano per le fiere, recitando su palchi di
fortuna e mescolando alla recitazione giochi di prestigio e
acrobazie. Vivono una vita precaria, col rischio di essere
arrestati e giustiziati senza tanti complimenti; e quando
muoiono, non è loro concessa la sepoltura in terra consacrata. Un destino, questo, che alle ossa degli attori sarà perpetuato fino al diciottesimo secolo.
Tuttavia la Chiesa, che scaccia il teatro dal suo portone, lo
fa rientrare dalla sacrestia. Durante tutto il medio evo è
invalso l’uso di narrare in forma prima dialogica, poi scenica, gli eventi della vita e della morte del Cristo, in specie
durante la settimana santa. L’uso nasce in Italia, con le sacre rappresentazioni, e si diffonde in tutta Europa: in
Francia le sacre rappresentazioni sono chiamate mystères
(dal latino ministerium, servizio), in Spagna autos sacramentales, in Inghilterra miracle plays.
E la storia si ripete: così come era accaduto ai riti dionisiaci, poco a poco queste rappresentazioni diventano sempre più autonome rispetto alla liturgia nella quale erano ori26
ginariamente inserite, più elaborate e, soprattutto, si
svincolano dall’originaria lingua latina, per essere eseguite
nelle lingue dei paesi ove erano rappresentate.
Nasce così il teatro nazionale, differenziato e caratterizzato
secondo i luoghi, ma ovunque fortemente imbevuto di valori etici e morali cristiani; da una costola delle sacre rappresentazioni, inoltre, sarebbe nato anche il teatro d’opera.
27